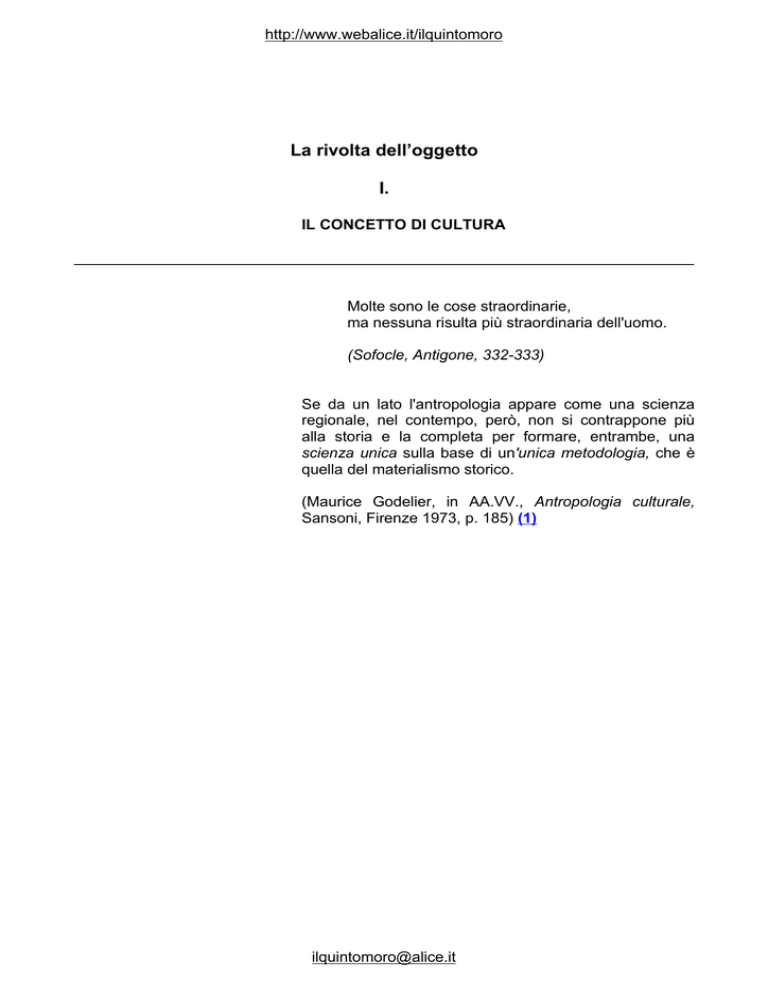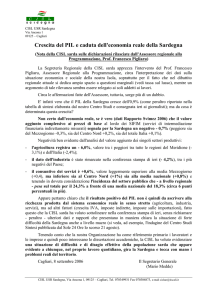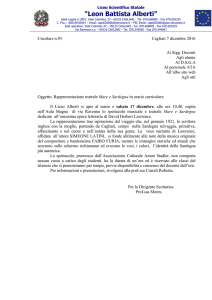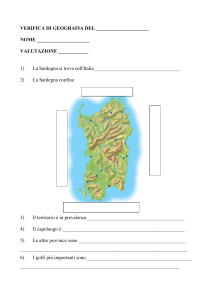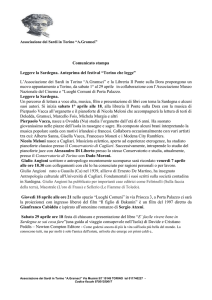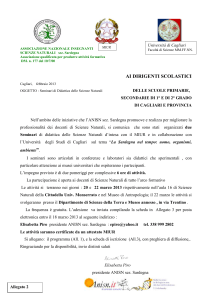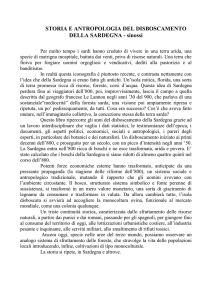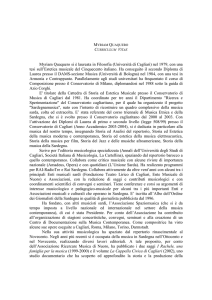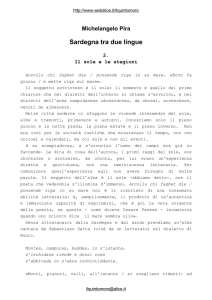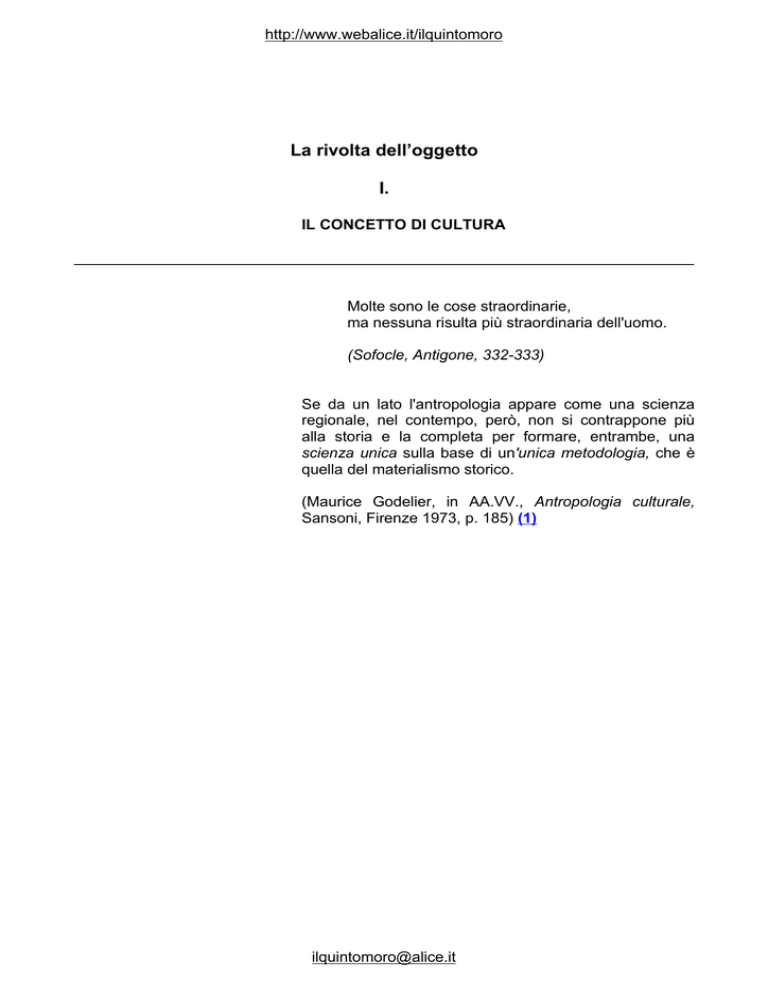
http://www.webalice.it/ilquintomoro
La rivolta dell’oggetto
I.
IL CONCETTO DI CULTURA
________________________________________________________________________
Molte sono le cose straordinarie,
ma nessuna risulta più straordinaria dell'uomo.
(Sofocle, Antigone, 332-333)
Se da un lato l'antropologia appare come una scienza
regionale, nel contempo, però, non si contrappone più
alla storia e la completa per formare, entrambe, una
scienza unica sulla base di un'unica metodologia, che è
quella del materialismo storico.
(Maurice Godelier, in AA.VV., Antropologia culturale,
Sansoni, Firenze 1973, p. 185) (1)
[email protected]
http://www.webalice.it/ilquintomoro
1.1. I’UOMO INCOLTO NON ESISTE.
«Cultura» è un termine di alta frequenza e di notevole ambiguità. Il disagio di chi si
trova nella necessità di usarlo deriva dall'impossibilità di evitare oscillazioni di significato
incontrollabili. Di qui l'opportunità di una premessa che, pur schematica, non sarà breve e,
pur lunga, non sarà esauriente. Si spera soltanto che possa almeno servire a mettere in
guardia dalle insidie che si accompagnano all'uso corrente del termine. Per sfuggire
almeno in parte all'ambiguità si farà spesso uso di termini più puntuali come media, fonti
normative, lingua, codici, livelli culturali, modi di produzione, soggetti sociali, messaggi.
La prima e forse ultima, la più ampia e insieme la più specifica e tecnica accezione del
sostantivo «cultura» e dell'aggettivo «culturale» è quella risultante dall'opposizione di
questi due termini a «natura» e «naturale». È l'assunzione della parola in questo
significato che giustifica affermazioni come queste: ciascuno di noi è uomo grazie al fatto
di vivere in una cultura, o, che è lo stesso, grazie al fatto di avere una cultura, alla cui
elaborazione, trasmissione, conservazione e innovazione si partecipa e dalla quale si è
istituiti, attraversati, abitati. Tuttavia non si deve credere che il confine tra natura e cultura
sia segnato nettamente, come ha dimostrato Lévi-Strauss. I rapporti tra l'antropologia
fisica e quella culturale sono più intrecciati di quanto non venga normalmente rilevato.
Tuttavia non ci occuperemo di questi intrecci (2).
L'uomo perfettamente incolto non esiste. Lo si è cercato nelle montagne del Tibet: non
avendolo trovato neppure lì, lo si è chiamato «abominevole», a scanso di equivoci. «La
difesa, la nutrizione, il movimento nello spazio, tutti i bisogni fisiologici e spirituali vengono
soddisfatti indirettamente per mezzo di artefatti perfino nelle forme più primitive della vita
umana. L’uomo di natura, il Naturmensch, non esiste» (3) . Tuttavia capita spesso di sentir
dire di qualcuno che è «incolto» o addirittura «totalmente privo di cultura». Ma anche
espressioni come queste, se e quando hanno un senso, non possono essere intese come
negazioni della proposizione generale. Generalmente riflettono un tentativo di misurare la
quantità di cultura posseduta dall'uomo di cui si parla, il percorso da lui fatto per
allontanarsi dallo stato naturale. Il termine cultura in questi enunciati sta a significare o una
determinata cultura o un certo livello di cultura. Si tratta di iperboli che trasmettono un
giudizio di valore sulla specifica cultura o sul livello di cultura dell'uomo di cui si parla e
implicitamente del gruppo al quale quest'uomo appartiene.
[email protected]
http://www.webalice.it/ilquintomoro
1.2. L’ETNOCENTRISMO TRA NATURA E CULTURA.
Su espressioni iperboliche come queste delle quali ci stiamo occupando sono state
costruite ipotesi aberranti di negazione delle qualità umane agli esclusi, agli estranei, ai
portatori di cultura altra dalla propria. Le vie concrete dell'etnocentrismo sembrano infinite
come quelle del Signore. E le più sofisticate sono le più pericolose.
L’etnocentrismo dei primitivi non si mascherava dietro le cortine fumogene
dell'evoluzionismo, che applicando affrettatamente alla civiltà e al progresso umano i
principi dello sviluppo organico ha per lungo tempo annullato la distinzione tra evoluzione
organica ed evoluzione sociale e culturale, fino a prestarsi alla produzione di arsenali
teorici per il razzismo. «Questa distinzione - talmente ovvia che in passato sembrava
eccessivamente banale farla notare - è stata in buona parte offuscata (scriveva fin dal
1917 Alfred L. Kroeber) (4) negli ultimi cinquant'anni dall'influenza esercitata sulle menti
contemporanee dalle opinioni relative all'idea di evoluzione organica. Si può addirittura
fondatamente affermare che questa confusione è stata maggiore, e più diffusa, tra coloro
che quotidianamente si dedicano allo studio e alla scienza che non tra il resto della
popolazione ». Come spiegare il paradosso di una scienza che inganna i suoi adepti più di
quanto il buon senso non inganni «il resto della popolazione» se non con la maggiore
prossimità della prima ai luoghi e gruppi sociali che potevano (e possono) trarre vantaggio
dall'uso di quell'inganno?
Non esiste un'unica cultura umana a sviluppo lineare (e tanto meno esisteva proprio
quando da questo erroneo presupposto si credeva di trarre motivi di legittimazione del
colonialismo), ma esistono (e soprattutto esistevano) culture concrete e specifiche
derivanti dall'uso concreto e specifico che l'uomo in società ha fatto e continua a fare delle
sue qualità naturali e acquisite.
I greci quando chiamavano barbari (balbuzienti) quelli che non comprendevano e non
parlavano la loro lingua, non intendevano negare il fatto che i barbari avessero anch'essi
una lingua sia pure a loro avviso un po' legata in bocca e un'altra lingua (come sistema di
segni) sia pure sempre a loro avviso imperfetta nella mente. Intendevano semplicemente
affermare, anche in questo modo, la propria superiorità sui barbari. Certo è che il loro
etnocentrismo, al confronto con quello praticato in tempi a noi più vicini della
«superevoluzione» colonialista e razzista, sembra fatto di rose e fiori, come si suol dire.
Ad una condanna astratta dell'etnocentrismo è tempo che si sostituisca una rigorosa
distinzione degli usi concreti di questo atteggiamento di «istintiva» difesa della coesione
del gruppo di appartenenza e dunque della propria identità storica, entrambe (coesione e
identità) rese possibili dalla cultura, quale che sia, che il gruppo si e data e dunque dal
fatto che il gruppo (é tale in quanto) si è data una cultura, cioè ha fatto determinati usi
concreti, accumulativi per dire storici, non naturali, «arbitrari» (5) nel senso assunto dal
termine nella linguistica moderna, delle qualità-capacità naturali (sistema nervoso centrale
e sue estensioni) e di quelle ulteriori, acquisite attraverso quegli usi.
S’è detto «difesa istintiva», non però per imputare l'atteggiamento etnocentrico alla
«natura» umana (dove del resto già l'aggettivo segnerebbe una contraddizione irriducibile
col sostantivo), ma per riferirci ad una «necessità» storico-politica connessa strutturalmente al momento in cui un gruppo sociale entra in contatto con un altro, gruppo.
«L’etnologo, che lo voglia o no (e ciò non dipende dà una sua decisione), ammette nel suo
discorso le premesse dell'etnocentrismo nel momento stesso in cui è impegnato a
condannarlo. Questa è un'irriducibile necessità, non è una contingenza storica e dobbiamo
considerarne con attenzione tutte le implicazioni. Ma se nessuno può sfuggire a questa
necessità e se quindi nessuno è colpevole di arrendersi ad essa, ciò non vuol dire che tutti
i modi di arrendersi sono ugualmente accettabili» (6).
[email protected]
http://www.webalice.it/ilquintomoro
Il confine tra natura e cultura nel momento in cui l'uomo e chiamato dalla necessità
storica del contatto tra due culture a ridefinissi è difficile da tracciare. L'etologo (7) tenderà
a fare più spazio alla natura e all'istinto di difesa del proprio «territorio» presente nell'uomo
come negli animali; l'antropologo culturale tenderà ad allargare lo spazio della cultura
dell'efficacia del modello culturale o del codice acquisito. Ma se teniamo ben ferma la
distinzione tra qualità naturali e loro uso concreto, storico, filo di Arianna che consente
l'uscita dal labirinto dell'antropologia fisica allo spazio aperto dell'antropologia culturale,
saremo sempre capaci, in presenza dei concreti comportamenti, in presenza degli usi
concreti di quelle tali qualità, di operare ulteriori distinzioni (opposizioni/associazioni) di
comportamenti individuali e sociali non sottraibili alla cultura; il che in questo caso è come
dire alla libertà e alla responsabilità dell'uomo.
Lo «scandalo» scientifico dell'etnocentrismo, universale in quanto presente in tutte le
culture, e tuttavia nelle sue manifestazioni concrete non imputabile alla natura, è da
assimilare a quello costituito dalla proibizione dell'incesto (alla quale è da avvicinare, io
credo, anche per ragioni che vanno ben al di là dell'analogia e che anzi fanno pensare ad
una omologia) e può trovare scioglimento allo stesso modo (8). Fino a quando non
avremo spostato l'attenzione sui modi concreti di praticare l'etnocentrismo, come si è fatto
per i modi concreti di attuare la proibizione dell'incesto, non faremo seri passi in avanti.
Resteremo impigliati nella condanna moralistica o nell'accettazione metafisica
dell'etnocentrismo, a seconda che lo si imputi ad un errore o perversione della storia o
della natura; e non faremo passi avanti nell'approfondimento della conoscenza né delle
qualità naturali, né delle concrete responsabilità storiche dell'uomo. E infine non
troveremo la saldatura tra natura e cultura.
[email protected]
http://www.webalice.it/ilquintomoro
1.3. FUNZIONI E STRUMENTALIZZAZIONI DELL'ETNOCENTRISMO.
Se l'innatismo chomskyano (9) ha sfondato qualche muro che si opponeva allo sviluppo
della linguistica moderna, senza nulla togliere alla storicità delle lingue, non vedo perché
l’antropologia che già ha potuto con l'assunzione del metodo e di conquiste della
linguistica risolvere importanti problemi dello studio della parentela e in particolare del
codice degli atteggiamenti e problemi di lettura dei miti (10), debba fermarsi a mezza
strada nella riflessione sulle relazioni tra quel che dell'uomo è dovuto alla natura e quel
che è dovuto alla cultura. Niente, per fare un solo esempio culturale impedisce di
recuperare all'antropologia i contributi della polemologia psicoanalitica di un Franco
Fornari (11). L’etnocentrismo può essere studiato come fenomeno «antergico» nel senso
dato al termine da Ruth Benedict in antropologia e sviluppato da Fornari in psicoanalisi
(12), come fenomeno di attaccamento collettivo all'Es, di non riconoscimento dell'altro da
sé e dunque dell'Io, e avente anche un senso positivo in quanto fenomeno di affioramento
(statu nascenti) della coscienza dei tratti distintivi dell'Io collettivo, nel momento (storico
ovviamente) della scoperta dell'altro da sé, fino a ribaltarsi (col progredire del contatto con
l'altro verso l'integrazione) in fenomeno «sinergico» A mettere in moto il processo è, non
v’è dubbio, un evento storico vissuto dall'uomo nella pienezza delle proprie qualità naturali
e acquisite. Il momento decisivo è appunto quello della «scoperta» dell'altro. In esso
l'etnocentrismo produce antergia nei confronti dell'altro e sinergia nei confronti del proprio
gruppo; si scopre la coerenza di forma e funzione della cultura di appartenenza; si
scoprono forme e strutture della cultura altrui, ma non se ne riconoscono le funzioni e in
particolare la funzione primaria che è appunto quella di legare insieme i soggetti del
gruppo.
Alla cultura altra, in questa fase, non si concede il tout se tient. Perché mai? Perché il
riconoscimento metterebbe in discussione le ragioni e la scala di coesione del proprio
gruppo e dunque la propria identità. La scoperta di un altro gruppo totalizzante (dove vi
sia reale differenza di culture e non soltanto di livelli è implicita una totalità) mette in forse
la legittimità del carattere totalizzante della propria cultura e dunque del proprio gruppo e
della propria identità. Ne deriva la necessità di tentare (in forma pacifica o violenta) di
scomporre gli elementi costitutivi dell'identità totalità altrui, riducendoli ad elementi privi di
senso (non codificati) nella misura in cui li si rigetta nel caos (e di vita nella misura in cui li
si «fa fuori»), e invece forniti di senso solo nella misura in cui li si accoglie, li si comprende
(nel proprio codice sottraendoli all'altro), forniti sì di senso, riconosciuti si come significanti,
ma in virtù di una loro ricodificazione nel sistema segnico dei proprio gruppo-cultura-lingua
etc.
Diciamocelo più rozzamente: non si è ancora riflettuto abbastanza sulle ragioni, funzioni
e significati della «sveglia al collo». Certo la lettura psicoanalitica non può rendere
immediatamente conto del perché del concreto manifestarsi dell'etnocentrismo in forme
sinergiche o antergiche. A suo modo anch'essa privilegia la analisi strutturale sincronica,
anche in presenza di elementi pertinenti all'evenemenziale. Per spiegare la prevalenza di
antergia o sinergia si deve chiamare in causa la storia specifica dei gruppi in contatto e dei
loro rapporti. Ma ciò nulla toglie al valore delle acquisizioni psicoanalitiche e delle analisi
strutturali, ne tanto meno le oppone alle acquisizioni della storiografia.
Quel che appare subito evidente è che, mentre il colonialismo (in tutte le sue forme,
anche in quelle più sofisticate) strumentalizza l'etnocentrismo verso l'antergia, le forze
storiche antagoniste devono privilegiare rapporti sinergici tra di loro (lavoratori di tutto il
mondo unitevi, popoli oppressi di tutto il mondo unitevi).
I rapporti sinergici sono possibili soltanto a partire dal momento in cui due gruppi si
riconoscono simmetricamente come elementi di una stessa totalità ulteriore (almeno
[email protected]
http://www.webalice.it/ilquintomoro
possibile) opponibile ad un terzo gruppo. Questo è il caso della metà Cera e della metà
Tugaré del, villaggio Bororo (13), che realizzano la loro complementarità anche nello
scambio delle donne (e dunque degli uomini) nei matrimoni e nel corpus dei loro miti.
L’etnocentriamo praticato da gruppi ad alta accumulazione storico-culturale a danno di
gruppi a bassa accumulazione chiamati anche «società fredde» (14), incapaci di difendersi
perché mancanti di estensioni che abbiano potenziali di violenza o semplicemente di
energia pari a quelli di cui dispone l'aggressore, è vissuto ai livelli bassi del gruppo
colonialista come occasione di superamento e ricomposizione dell'antergia interna (di
alienazione di essa sull'altro), ma dai livelli alti è vissuto come occasione di rafforzamento
e ridefinizione dell’oppressione sugli strati bassi dello stesso gruppo.
Si vuol mettere in guardia da ogni ottimismo armonista circa i fenomeni sinergici; non di
rado, anzi forse quasi sempre, essi sono più apparenti, mitici, ideologici, che reali. Se la
complementarità dei Cera e dei Tugaré è analizzata da Levi-Strauss come un mito e
definita «una vana prosopopea» (15) atta a mascherare la reale divisione del villaggio
Bororo non in due metà territoriali ma in tre gruppi sociali stratificati (superiore, medio e
inferiore, all'interno di ciascuno dei quali avvengono gli scambi matrimoniali fra le due
metà), che cosa dovremmo dire del mito sinergico (l'ideologia nazionale) che spinge il
piccolo borghese meridionale a credere di appartenere allo stesso gruppo (quello italiano)
del presidente della Fiat e/o della Confindustria? Occorre una buona dose di ingenuità per
considerare ancora oggi le connotazioni territoriali più importanti di quelle sociali, per
privilegiare il dislocarsi dei gruppi sull'asse orizzontale dello spazio, anziché il loro
dislocarsi sull'asse verticale della stratificazione sociale.
Tra l'avv. Agnelli che detiene la proprietà della Fiat, s'appropria del plusvalore, sì sposta
da un capo all'altro dei mondo in aereo privato, parla l'inglese non meno bene che
l'italiano, può far cadere un governo etc. da una parte, e l'operaio della Fiat che produce il
plusvalore, possiede sì un'utilitaria ma per andare e venire da casa al luogo di lavoro,
parla sì e no l'italiano etc., dall'altra parte, la comunanza di cultura, anche se sono
entrambi nati a Torino, è, ancora e sempre una « vana prosopopea», una mistificazione
ideologica. Tra i due non c'è comunanza di cultura nella misura in cui non c'è comunanza
di codici, di messaggi, di media, di solidarietà sociale, anche a prescindere dal loro diverso
potere normativo.
Tra i due prevalgono non i fenomeni sinergici ma quelli antergici; il che è come dire la
lotta. Uno è istituito, attraversato e abitato dalla cultura della borghesia, l'altro da quella
della sua classe nel senso forte del termine. Tuttavia, né l'una né l'altra cultura sono da
esaminare come culture globali di un'etnia; soltanto nel loro insieme esse costituiscono
una cultura in senso globale, caratterizzata dalla pratica della lotta di classe.
[email protected]
http://www.webalice.it/ilquintomoro
1.4. FOLKLORE E LOTTA DI CLASSE DOPO LA SVOLTA GRAMSCIANA.
Il dato emergente degli studi antropologici che in questi ultimi decenni sviluppano le
osservazioni di Gramsci sul folklore (da Cirese a Lombardi Satriani) (16) è l'attenzione ai
modi e ai rapporti di produzione. Seguendo l'indicazione gramsciana si studia il folklore
come «concezione del mondo e della vita», implicita in grande misura, di determinati strati
(determinati nel tempo e nello spazio) della società, in contrapposizione (anch'essa per lo
più implicita, meccanica, oggettiva) con le concezioni del mondo ufficiali» (Gramsci) (17).
Le misure di rivolta dell'oggetto dell'antropologia, cioè di crescita della consapevolezza
storica, politica e culturale delle classi strumentali e subalterne sono ormai tali da rendere
esplicita la contrapposizione di cui parlava Gramsci. La cultura operaia coincide ormai con
la pratica della lotta di classe in termini espliciti. Il problema del nostro tempo non è più
quello di strappare alla cultura ufficiale il riconoscimento del fatto che non esistono uomini
privi di cultura, che «tutti sono filosofi» (18) come diceva Gramsci, che il folklore etnico o di
classe è testimonianza di una determinata cultura (19). A questo punto il problema è
quello dei rapporti che il contatto tra culture, reciprocamente riconosciutesi come tali, deve
generare, e dunque dei contenuti e delle forme da dare alla cultura del nostro tempo, e dei
soggetti sociali cui spetta questo compito conteso.
Se è perfettamente legittimo il parlare di «cultura dei vasellame cardiale» da parte
dell'archeologo e del paletnologo (20) in presenza di insediamenti umani che non hanno
lasciato di sé testimonianze più significative, trovo ingiustificato la riduzione della
complessa e tutta presente cultura del nostro tempo ora a questo ora a quell'altro
elemento caratterizzante (l'automobile, la radio, la TV, l'aereo, il motorino etc. per quanto
riguarda i media; il plurilinguismo per quanto riguarda i codici; il marxismo e il
democratismo per quanto riguarda i messaggi; la classe operaia o il terzo mondo per
quanto riguarda i soggetti sociali). Insomma, il parlare di «cultura dell'automobile» è
suggestivo ma anche fortemente riduttivo almeno fino a quando una catastrofe planetaria
(la cultura della diossina) (21) non avrà cancellato tutti gli altri elementi non enumerabili
dei quali la nostra cultura si compone.
[email protected]
http://www.webalice.it/ilquintomoro
1.5. IL MATERIALISMO STORICO PER UNA RIDEFINIZIONE DEL CONCETTO DI
CULTURA.
Il problema del collegamento tra la nozione tyloriana di cultura e quella marxiana è al
centro di un dibattito tra Cirese, Carla Pasquinelli, Giulio Angioni, Piergiorgio Solinas e
Pietro Clemente (22). Cirese propone che provvisoriamente, in attesa di una ridefinizione
collegiale del termine cultura, si indichi con cultura 1 il concetto tyloriano, con cultura 2
quello di concezione del mondo (gramsciano) e con cultura 3 quello di universo segnico o
simbolico; da parte sua però rifiutandosi di «rinunciare ad un concetto che consenta di
ristabilire la connessione tra manualità e intellettualità», pur sentendo «la fecondità di un
altro concetto che nelle azioni e nei prodotti - siano essi materiali o intellettuali tende a
identificare quegli aspetti che costituiscono l'espressione di certi modi di concepire e di
vivere il mondo». Ed aggiunge: «Né mi sentirei di identificare manualità con struttura e
intellettualità con sovrastruttura, con sovrastruttura, ma piuttosto tenderci a vedere così nella
struttura come nella sovrastruttura un aspetto che in mancanza di meglio direi effettuale o
addirittura 'cosico' (di produzione e scambio), ed uno di comunicazione o 'segnico’. Dal che nasce,
pur se in modi che non esito a riconoscere ancora inadeguati, la sottolineatura dell'importanza del
terzo modo di intendere la cultura, quello che appunto ne collega il concetto all'universo della
comunicazíone e dei segni, e che mi pare possa trovare un forte ancoraggio materialistico neì
molti riferimenti marxiani al linguaggio» (23). La tesi di Cirese è facilmente integrabile con quella
dell'omologia del produrre sostenuta da Rossi-Landi.
Il concetto designato come cultura 3 da Cirese è molto prossimo - mi pare - all'ipotesi formulata
da Umberto Eco: «l'intera cultura dovrebbe essere studiata come un fenomeno di comunicazione
fondato su sistemi di significazione» (24).
Per concludere: sviluppando le implicazioni della linea Cirese Rossi-Landi e le implicazioni
dell'ipotesi di Eco (ma si potrebbe dedicare un intero libro ai supporti filologici derivanti sia da studi
linguistici sia da studi marxisti) sembra possibile formulare una definizione della cultura che la
ponga come il prodotto complessivo dell'accumulazione del lavoro sia materiale sia intellettuale (e
dunque facendo cadere questa dicotomia), come l'insieme dei rapporti che gli uomini intrattengono
fra di loro e col mondo (l'insieme del loro lavoro di comunicazione e di scambio) e dunque, in
termini più espliciti e più specifici come:
A) l'insieme dei media naturali e acquisiti dei quali può disporre il sistema nervoso centrale
dell'uomo uti singulus e uti societas (cioè le fonti normative) e la distribuzione dei media tra gli
individui e tra i gruppi sociali;
B) l'insieme dei rapporti che si istituiscono tra i sistemi nervosi centrali individuali e tra le fonti
normative sociali, cioè tra i soggetti che codificano l'uso concreto da farsi dei media naturali e
acquisiti e che concretamente realizzano una comunicazione e uno scambio codificati, ponendosi
come soggetti alternativamente di emissione e di ricezione di messaggi e di di oggetti-segno;
C) l'insieme dei rapporti fra i codici di comunicandone, e di scambio che l'uomo (il suo sistema
nervoso centrale e le fonti normative sociali) sì è dato attraverso l'uso concreto delle proprie
estensioni fisiche naturali e acquisite (le capacità fonatorie sono naturali; la riduzione delle
fonazioni ad unità discrete opponibili, e dunque significanti, è creata dall'uomo), e dunque anche
l'insieme dei rapporti fra i messaggi (fra questi compresi gli oggetti-segno) accumulati nell'uso
concreto dei media e dei codici per il soddisfacimento dei bisogni di comunicazione e di scambio,
cioè sociali.
La cultura sta al complesso del lavoro di comunicazione e scambio come la lingua sta al
complesso del lavoro di comunicazione «linguale-verbale». Sulle qualità della lingua incidono e si
riflettono i media usati (fonazione, scrittura, stampa, radio, cinema, televisione etc.), i messaggi di
maggiore diffusione, i soggetti (il loro numero, il loro grado di istruzione, le distanze geografiche e
sociali ecc.) che la parlano. Il valore complessivo di una cultura sociale coincide con quello della
[email protected]
http://www.webalice.it/ilquintomoro
propria società. In quale accezione sia qui usata la nozione di valore risulterà più chiaro in seguito.
Anche le sociologie e le antropologie che si pretendono avalutative di fatto non lo sono. Infatti
almeno il privilegiamento della avalutazione è da esse posto come un valore, detto «scientifico»,
evidentemente con riferimento ad una epistemologia affermante la c.d. neutralità delle scienze,
che soprattutto nel campo di quelle umane altro non è che la rinuncia alla critica dei valori costituiti.
La scienza neutra altro non è se non l'uso che la conservazione fa della scienza. Il valore del quale
qui si parla è quello quantificabile, di scambio, risultante dalla quantità di lavoro incorporato in una
cultura.
Pertanto lo studio di una cultura deve tendere alla individuazione per quanto possibile delle
specificità che la caratterizzano nel tempo e nello spazio quanto ai media, quanto alle fonti
normative e ai soggetti, quanto ai codici e ai messaggi verbali e «cosici».
L’uso corrente del termine cultura oscilla tra due poli: quello eccessivamente inclusivo,
totalizzante e unificante proprio dell'etnologa; e quello eccessivamente esclusivo (riduttivo) proprio
del riferimento ai «valori superiori della cultura» generalmente identificati nei codici e
messaggi dei. gruppi egemoni e in definitiva riferito alla «tradizionale concezione della
cultura come fatto d’élite», anche se, come vedremo meglio in seguito, è necessario
precisare subito che la stessa «cultura colta» cessa, in misure crescenti, di essere
patrimonio di ristretti gruppi privilegiati per essere acquisita e ulteriormente «lavorata»
anche da grandi masse popolari nella stessa misura dell'organizzarsi di queste sul terreno
della politica attraverso i partiti, dell'economia attraverso i sindacati e dell'istruzione
attraverso la partecipazione al controllo dell'uso dei gradi strumenti di comunicazione
(dalla scuola ai mass-media).
Non pare che nell'analisi dei fatti culturali si possa prescindere dalla loro connotazione
(25) sociale (cioè dall'individuazione dei soggetti sociali che li pongono in essere o che in
essi sono coinvolti). Il significato di un evento o anche di un assetto culturale varia a
seconda dei gruppi sociali che lo vivono. Già Gramsci aveva fatto qualche osservazione
illuminante in proposito (26) allontanandosi sensibilmente per esempio dal giudizio
crociano sulla poesia popolare. Le idee dominanti nella Sardegna interna nei primi decenni
del secolo, vale a dire nel periodo meglio conosciuto da Gramsci, non coincidevano
esattamente con quelle nazionalmente dominanti. Lo scarto fra le une e le altre svelava
quanto meno la presenza nell'Isola di uno strato sociale localmente dominante,
differenziato, anche se in ultima istanza subalterno, rispetto a quello dominante sul piano
nazionale. Affioravano persino velleitari progetti di indipendenza nazionale sarda, intesi ad
accentuare la differenziazione culturale (non si vuole entrare per il momento nella
questione assai dibattuta in questi ultimi anni - 1974-76 se sia mai esistita o stia per
esistere una «nazione sarda»; per ora è, sufficiente tener presente che la questione è
oggetto di dibattiti politico-culturali e che questo avrà pure qualche motivazione cadente
nel territorio proprio delle indagini dell'antropologia).
Le classi subalterne (e a maggior ragione quando la vertenza presenta anche
inscindibili elementi etnico-territoriali), nella misura in cui organizzano il loro antagonismo,
recuperano anche elementi della loro cultura tradizionale, oltre che della cultura delle
classi dominanti, ma li connotano in modi specifici e, nella misura della propria crescita, ne
fanno elementi di resistenza e in prospettiva di egemonia alternativa.
È da ricordare che Gramsci a proposito del folklore distingue il giudizio positivo che se
ne può dare quando esso è contrapposto alla concezione ufficiale-borghese, da quello
negativo che deve colpire il folklore quando questo si contrapponga alla concezione
marxista (o della classe operaia) del mondo e della storia. È questa la ragione
dell'oscillazione del giudizio (positivo-negativo) di Gramsci, come ha dimostrato Cirese.
Gramsci avrebbe riconosciuto nel folklore « una forma spontanea di quello ‘spirito di
scissione' da lui definito come il 'progressivo acquisto della coscienza della propria
personalità storica’» (27), autorizzando a «considerare almeno il ‘folclore progressivo' o 'di
[email protected]
http://www.webalice.it/ilquintomoro
protesta' come una manifestazione di istinto di classe intendendosi ovviamente per
istinto... un'acquisizione storica primitiva elementare e non un fenomeno biologico» (28).
I limiti negativi del folklore emergerebbero quando alla rappresentazione dello stato di
fatto segue «la tensione tra lo stato di fatto e la meta a cui si tende» (Cirese); è allora che
quei limiti emergono sia in rapporto alle concezioni ufficiali della borghesia sia e di più nel
rapporto con le qualità formali della concezione marxista.
[email protected]
http://www.webalice.it/ilquintomoro
1.6. L'OGGETTO FOLKLORICO PRENDE LA PAROLA (PER RIDEFINIRSI COME
CULTURA TOUT COURT).
In questo libro il termine «folklore» non sarà usato (tranne che nelle citazioni), anche se
si tratta di un libro sulla Sardegna cioè su una regione europea quant’altre mai ricca
(considerata dalla cultura osservante) di quel che comunemente profani e addetti ai lavori
sogliono chiamare appunto «folklore». Si dà però il caso che molto di quel che per altri è
folklore, per me e per la maggior parte dei sardi sia niente di meno che cultura,
differenziata e specifica quanto si vuole ma pur sempre cultura. Udire la stazione radio di
Cagliari definire «folkloristici» elementi importanti della cultura sarda (costumi, balli, canti,
riti funebri, poesie, norme giuridiche, proverbi) indigna per il distacco, la distanza che si
sottintende tra valori della cultura osservante e valori della cultura osservata. La boria
della cultura osservante è sottintesa (ma anche benintesa) proprio nell'uso del termine
«folklore» riferito alla cultura osservata.
Qualsiasi canto sardo non è più folkloristico dell'opera lirica, del disco di maggior
successo del momento: allora perché non si parla di folklore anche a proposito della
Traviata? Esiste un folklore parlamentare, forense, accademico, medico etc., ma nessuno
si sogna di dire che questo folklore sia la cosa più interessante del parlamento, dei palazzi
di giustizia, delle università e della medicina, cioè di ridurre questi a quello. Alla cultura
sarda accade invece di essere quasi sempre presentata e talvolta studiata come folklore.
Rifiuto questa operazione classista e colonialista, non soltanto in quanto sardo partecipe
della «rivolta dell'oggetto», ma anche e soprattutto in quanto studioso. Ben a ragione
Cirese nel 1963 scriveva: «A voler fare sul serio con le tradizioni sarde, bisogna dar retta a
un sardo come Giuseppe Dessì: lasciar da parte i “volantini reclamistici" diffidare di tutto
ciò che presenti l'isola "come una riserva di pellirosse", rendersi conto che la Sardegna
che conta conoscere "non è quella dei costumi sgargianti che partecipa alle cavalcate e
alle parate di ogni genere, ma quella vestita di fustagno"»; oggi dovremmo dire di blujeans. «Occorre - aggiungeva Cirese - rifuggire dal mito, quali che siano le sue forme, e
ridurre alla storia tutto quello che il colorismo ‘folklorstico' e l'esaltazione o il disprezzo ambedue irrazionali - dell’arcaico e del primitivo vorrebbero sottrarle. Occorre superare
l'inciampo che sempre oppone - per il suo fascino a buon mercato o per la stucchevole
retorica – il romanticismo in ritardo che parla ancora di anima e di etnos, e guardare
Invece alle tradizioni sarde (come del resto a tutte le tradizioni 'popolari') per ciò che
realmente sono: aspetti ed espressioni di una condizione storica» (29).
Quel che oggi dobbiamo vedere è l'impatto della tradizione col rapido mutamento
indotto e autonomo; il passaggio dal. privilegiamento della storia come conservazione
delle strutture
alla storia come mutamento. E dobbiamo fare questo anche in
riferimento al passato, perché, come scriveva ancora Cirese, la condizione storica della
Sardegna «si inquadra in una trama di rapporti esterni»anche nel passato, «ma conserva
una spiccata fisionomia a sé perché i modi di vita interni, la discontinuità delle relazioni
con il mondo extra-isolano, la mancata o ritardata partecipazione ad alcune rivoluzioni
culturali decisive nella storia del continente, hanno dato all'isola un ritmo peculiare autonomo o almeno solitario - di conservazione, rielaborazione e sviluppi» (30). Di qui il
carattere fortemente conservativo, il quale «fa sì che le tradizioni sarde presentino una
complessa arcaicità e una compattezza interna superiori a quelle che ci offrono le altre
regioni italiane» (30).
Oggi la parola folklore ha come primi referenti e generalmente in essi si esaurisce: i
dischi di Maria Carta, la sfilata di Sant’Efisio a Cagliari la Cavalcata Sarda di Sassari, la
festa del Redentore a Nuoro (insomma quel che sia Lombardi Satriani sia Laternari
chiamano rispettivamente «fagocitazione consumistica del folklore» e «folklore
menzogna», (o tutt'al più rinvia a categorie accademiche esoteriche). Il riferente che
[email protected]
http://www.webalice.it/ilquintomoro
Gramsci disoccultava nell'uso del termine «folklore» è cresciuto troppo (in termini di
coscienza storica e politica di sé) per non lasciare la vecchia placenta e prendere il nome
che gli spetta: «cultura delle classi strumentali e subalterne, e/o di interi popoli oppressi,
visione del mondo e della vita»; lasciando che il termine «folklore» resti solo a designare
l'uso mistificato della cultura non solo delle classi subalterne ma anche delle classi
dominanti e dirigenti: così i costumi sardi della Costa Smeralda come le parrucche dei
lords inglesi (ora che il presidente degli Stati Uniti, Carter, si presenta alla televisione in
maglione e prima che anche questo modo di vestire sia diventato folkloristico), insomma
gli elementi culturali anacronistici, il cui valore non sia definibile dai significanti contermini
nella sincronia, ma richieda un rinvio ad un altro stadio sincronico o ad un altro sistema
segnico, del quale non si voglia riconoscere il valore.
I tentativi di imporre le distinzioni tecniche giustamente operate all'interno del folklore
non rimediano ai guasti derivanti l'uso «sbagliato» (ma in quanto diffuso ormai prevalente
e dunque ormai non più erroneo ma corretto) del termine. A capovolgere il significato di
quest’ultimo non sono sufficienti neppure le distinzioni (per altro datate e non potrebbe
essere altrimenti) di Antonio Gramsci, che non potevano tener conto di acquisizioni
importanti dell'etnologia e dell'antropologia successive al periodo in cui egli scriveva le sue
«Osservazioni sul folklore» o anche precedenti e coeve ma da lui non conosciute.
Insomma: dobbiamo trarre tutte le implicazioni necessarie dell'attacco gramsciano al modo
sbagliato di osservare i fenomeni cosiddetti folklorici. Si deve proprio a Gramsci il merito
di aver avvertito la necessità di ribaltare l'atteggiamento critico verso la cultura delle classi
strumentali e subalterne allora tutte occultate e «misconosciute» sotto l'etichetta del
folklore.
Purtroppo è invece capitato anche a Gramsci di avere dei «nipotini», cosa che
certamente egli non desiderava. «Sulle sue spalle» si crede per esempio di far gravare (e
non sembra operazione impossibile per chi voglia attenersi soltanto alla lettera degli scritti
gramsciani) i discorsi sul cosiddetto «folklore di protesta», che nel momento e nelle
condizioni di isolamento in cui Gramsci scriveva poteva tollerare una camicia di Nesso
oggi insopportabile. Oggi il parlare di «folklore di protesta» serve a prendere le distanze
dalla «protesta», condannarla perché espressa in forme diverse da quelle privilegiate dal
dominio e; anche soltanto dalla «cultura osservante». Si dice «folklore di protesta» per
sottintendere (perché si intenda) «protesta folkloristica», priva di qualcosa di essenziale: la
dignità culturale. E così facendo si contribuisce a incanalare la protesta stessa verso
forme appunto folkloriche o peggio propriamente folkloristiche prive di efficacia e appunto
di dignità.
Il folklore sardo, inteso come estensione dell'esotico, del primitivo, del diverso da
connotare - sia pure in modo ambiguo e talvolta anche esplicito - come negativo,
culturalmente limitato e «allontanato» nello spazio e/o nel tempo, non mi interessa più di
quanto mi interessi il fatto che l'appello dei deputati nel gergo parlamentare si denomini
«chiama» o più di quanto mi interessi il medico che, pur indossando non una tunica ma un
camice, si attenga ai consigli di Ippocrate sul modo di aggiustarsi gli indumenti personali
nell'atto di sedersi accanto al paziente.
Yambo Ouloguen (31) si chiede il perché della presenza di una «etnologia africana fatta
dai bianchi» e dell'assenza di «un'etnologia francese fatta dai negri». È tempo che i
rapporti tra cultura osservata e cultura osservante si ribaltino; e dunque che l'oggetto
prenda la parola per definirsi rispetto a se stesso, dunque per ridefinirsi autonomamente
come cultura tout court.
Devo confessare il mio sospetto che tra i nipotini di Antonio Gramsci non pochi abbiano
come testo preferito quello di padre Antonio Bresciani, Dei costumi dell'isola di Sardegna
comparati con gli antichissimi popoli orientali che è del 1850.
[email protected]
http://www.webalice.it/ilquintomoro
Poiché, ripeto, i significati assunti dal termine folklore sono troppo ambigui o nella
migliore delle ipotesi troppo tecnico-accademici, considero il termine «evitando» in un
testo nel quale si parlerà del contatto fra culture e/o fra diversi livelli di un continuum
culturale in Sardegna. Non presupponiamo nel lettore la conoscenza di quel che scriveva
Padre Bresciani, né delle quisquilia osservate nell'Ottocento e nel Novecento da
viaggiatori appesantiti da «pregiudizi» più gravi di quelli che pretendevano di scoprire nei
sardi. Con un articolo intitolato «Gli scopritori», apparso sull'«Avanti!» del 24 maggio 1916
già il giovane Gramsci ridicolizzò, ma non per sempre a quanto pare, questa genia di
perditempo: il bersaglio era Mascagni che, «reduce» da un breve viaggio in Sardegna,
pretendeva di averne capito molto, ma Gramsci di passata dava una zampata a Giuseppe
Sergi (32), del quale scriveva: «in quindici giorni sbafa una quantità di banchetti, misura
una cinquantina di crani, e conclude per l'infermità psico-fisica degli sciagurati sardi» (33).
Il corredo di autori che consigliamo a chi non abbia u’esperienza diretta e prolungata
della Sardegna ma abbia interesse a capirne qualcosa non solo non include padre
Bresciani, ma neppure la Deledda delle ricerche sulle Tradizioni popolati di Nuoro per la
rivista delle «Tradizioni popolari italiane» (34) diretta da Angelo De Gubernatis.
Quando diciamo cultura sarda intendiamo riferirci, tuttavia, non alle opere degli autori
più frequentemente citati, che pure hanno fatto cultura (quella cosiddetta di messaggio)
ma agli strumenti, alle fonti normative, ai codici (in particolare a quelli linguistici), alle
istituzioni educative vissuti dalle masse.
È sempre da tener presente però che senza il lavoro e l'impegno degli studiosi e degli
scrittori, citati e non citati ma letti, sardi e non sardi, che si sono occupati della Sardegna in
modo esplicito (35) o anche solo in modo implicito, senza la cultura di messaggio non
sarebbe possibile andare molto lontani nel viaggio che ogni sardo (e ogni uomo)
intraprende dalla conoscenza esecutiva in direzione della conoscenza critica della cultura
nella quale (si) istituisce il senso della propria vita.
[email protected]
http://www.webalice.it/ilquintomoro
NOTE
(1) Per quanto riguarda le implicazioni teoriche della proposta di Godelier v. anche
MAURICE GODELIER e LUCIEN SEVE, Marxismo e strutturalismo, Einaudi, Torino 1970.
(2) V. ANDRÉ LEROIGOURHAN, Il gesto e la parola. Einaudi, Torino 1977; GIORGIO
PRODI, Le basi materiali della significazione, Bompiani, Milano 1977; CLAUDE LÉVISTRAUSS, il primo cap. de Le strutture elementari della parentela, Feltrinelli, Milano 1972,
a cura di A. M. CIRESE; JAQUES DERRIDA, Struttura, segno e gioco nel corso delle
scienze umane, in AA.VV., La controversia sullo strutturalismo, Liguori, Napoli 1975, pp.
353-387.
(3) Così B. MALINOWSKI alla voce Cultura redatta nel 1931 per l'Encyclopaedia of the
Social Scienze (McMillan Co., New York, vol. IV, pp. 221-45), riprodotta in Il concetto di
cultura, a cura di Pietro Rossi, Einaudi, Torino 1970, p. 136.
(4) Cfr. ALFRED L. KROEBER, Antropologia dei modelli culturali, il Mulino, Bologna
1974 e 1976, p. 26. Il saggio citato è del 1917, The Superorganic, del quale Francesco
Remotti nell'introduzione scrive: « può... essere considerato come uno degli atti di.
fondazione della moderna antropologia culturale, in quanto contiene la discussione forse
più radicale e approfondita del concetto di cultura che sia stata compiuta nel primo
ventennio del Novecento» (op. Cit., p. 9). Malinowski e in genere tutti gli etnologi quando
parlano di «artefatti» si riferiscono a quelli cosiddetti, materiali. Si tenga presente però che
anche i messaggi verbali sono degli artefatti materiali, avanti una loro specifica fisicità
(quella acustica, registrabile). Cfr. in questo senso il saggio di Ferruccio Rossi-Landi, Il
linguaggio come lavoro e come mercato, Bompiani, Milano 1968.
(5) L’acquisizione decisiva del concetto di arbitrarietà del segno linguistico è merito di
FERDINAND DE SAUSSURE, Corso di linguistica generale, tradotto e commentato da
Tullio De Mauro in Italia soltanto nel 1963, Laterza, Bari (d'ora in poi CLG). La prima
edizione del CLG è del 1916.
(6) DERRIDA, op. Cit., pp. 359-360.
(7) V. per tutti KONRAD LORENZ, Il cosiddetto male, Il Saggiatore, Milano 1969 (e
Garzanti 1974); DESMOND MORRIS, La scimmia nuda, Bompiani, Milano 1968; A.
LEROI-GOURHAN, Op. cit.,; HUBERT e MABLE FRINGS, La comunicazione animale,
Boringhieri, Torino 1971.
(8) Le ragioni della proibizione dell'incesto sono state chiarite, forse definitivamente, da
Claude Lévi-Strauss ripetutamente; cfr. Francesco Remotti, I sistemi di parentela,
Einaudi, Torino 1973, in particolare il cap. sulla ricostruzione del pensiero antropologico su
Esogamia e proibizione dell'incesto, pp. 73-112. V. anche Bronislaw Malinowski, Sesso e
repressione sessuale tra i selvaggi, Boringhieri, Torino 1969, dove, a p. 175 e segg., egli
discute e critica la teoria freudiana (Totem e tabù) sulla «causa primordiale della cultura».
Totem e tabù è pubblicato da Boringhieri, Torino 1969. Inoltre C. Lévi-Strauss, Le
strutture elementari della parentela, cit. e Antropologia strutturale, Il Saggiatore, Milano
1969. In particolare si tenga presente la ragione dell'apparizione dello zio materno, in
questa struttura elementare, come datore della sposa e, dunque, come garante per la
società del rispetto della proibizione dell'incesto. L'etnocentrismo è una norma
[email protected]
http://www.webalice.it/ilquintomoro
fondamentale intesa a promuovere e a difendere la coesione del gruppo, come la
proibizione dell'incesto è intesa a garantire l'apertura del gruppo allo scambio con gli altri.
(9) Per quanto riguarda l'innatismo di N. Chomsky da tener presente tutta l'opera di
questo autore, pubblicata in Italia da Boringhieri. Cfr. in particolare, L’analisi formale del
linguaggio, vol. I, e l'introduzione di Giulio Lepschy, p. 14: «La competenza linguistica per
Chomsky non può essere che una caratteristica innata, specifica del genere umano».
Chomsky parla di «attrezzatura innata, che un bambino usa imparando una lingua» (p.10).
Ricorrendo ad un paragone con i computers può forse dirsi che per Chomsky è innato
l'hardware (il ferro, l'attrezzatura); è storico invece, cioè acquisito, cioè culturale il software
(il programma che si dà al computer). Per una critica al pensiero di Chomsky cfr. La
grammatica generativa - Introduzione a Chomsky di Jos Nivette; e inoltre Charles F.
Hockett, La linguistica americana, Bari 1970, p. 55 e segg. A prescindere da Chomsky v.
Jagjit Singh, Teoria dell'informazione - Linguaggio e cibernetica, Mondadori, Milano 1969.
(10) V. le opere di Lévi-Strauss già citate e la serie Mytologiques: Il crudo e il cotto,
Milano 1966; Dal miele alle ceneri, Milano 1968; Le origini delle buone maniere a tavola,
Milano 1971; L'uomo nudo, Milano 1974; Razza e storia e altri saggi di antropologia,
Torino 1967; Il pensiero selvaggio, Milano 1964; Tristi Tropici, Milano 1965, tutte
pubblicate dalla casa ed. Il Saggiatore.
(11) V. Psicoanalisi della situazione atomica, Milano 1970 e altri scritti apparsi sul
Corriere della Sera e su Tempi Moderni. Inoltre l'introduzione di Giorgio Celli al citato libro
di Lorenz, con riferimento esplicito a Fornari e altra bibliografia. V. anche Ruth Benedict,
Patterns of Culture, traduzione it., Milano 1960.
(12) Cfr. l'articolo di F. Fornari apparso sul Corriere della Sera del 19 maggio 1976.
(13) Cfr. Lévi-Strauss, Tristi tropici, cit. pp. 189-229.
(14) Per una buona ricostruzione del pensiero di Lévi-Strauss sulle società fredde, oltre
che le sue opere, Cfr. FRANCESCO REMOTTI, Lévi-Strauss, Struttura e storia, Torino
1971 e in particolare l'apposito capitolo P. 288 e segg.
(15) Cfr- Lévi-strauss, Tristi Tropici, cit., p. 229: «Sotto la maschera delle istituzioni
fraterne, il villaggio bororo si riduce in ultima analisi a tre gruppi, che si sposano sempre
fra di loro. Tre società, senza saperlo, resteranno per sempre distinte e isolate, prigioniere
ciascuna di un orgoglio dissimulato ai loro stessi occhi da istituzioni menzognere, cosi
ciascuna è la vittima incosciente di artifici ai quali non può più attribuire un oggetto. I
Bororo hanno un bell'ostentare i loro sistemi in una vana prosopopea: come già altri, del
resto, essi non sono riusciti a smentire questa verità: la rappresentazione che una società
fa dei rapporti fra i vivi e i morti si riduce ad uno sforzo per nascondere, abbellire
«giustificare, sul piano del pensiero religioso, le relazioni reali che prevalgono fra i vivi».
(16) Per la comprensione di questo testo è più che abbondante la bibliografia indicata di
volta in volta. Sono da tener presenti i seguenti saggi di Cirese: Folklore e antropologia,
Palumbo, Palermo 1972; Cultura egemonica e culture subalterne, Palumbo, Palermo
1971; Intellettuali, folklore, istinto di classe, Einaudi, Torino 1976. V. anche Ernesto De
Martino, Il mondo magico, Boringhieri, Torino 1973; Furore, simbolo, valore, Il Saggiatore,
Milano 1962; Sud e magia; Luigi M. Lombardi Satriani, Menzogna e verità nella cultura
[email protected]
http://www.webalice.it/ilquintomoro
contadina del Sud, Guida, Napoli 1971; Luigi M. Lombardi Satriani, e Mariano Meligrana,
Diritto egemone e diritto popolare, Quale cultura, Vibo Valentia 1975.
(17) A. GRAMSCI, Osservazioni sul folclore nella ed. crit. dei Quaderni del carcere,
Einaudi, Torino 1975, pp. 2311-2312 (in Letteratura e vita nazionale, Torino 1953, p. 215,):
«Si può dire che finora il folclore è stato studiato prevalentemente come elemento
pittoresco (... ). Occorrerebbe studiarlo invece come 'concezione del mondo e della vita' ...
» segue la frase citata; il testo cosi prosegue: « ... concezioni ufficiali (o in senso più largo,
delle parti colte delle società storicamente determinate), che si sono successe nello
sviluppo storico. (Quindi lo stretto rapporto tra folclore e 'senso comune' che è il folclore
filosofico). Concezione del mondo non solo non elaborata e asistematica, perché il popolo
(cioè, l'insieme 'delle classi subalterne e strumentali di ogni forma di società finora esistita)
per definizione non può avere concezioni elaborate, sistematiche e politicamente
organizzate è centralizzate nel loro sia pur contraddittorio sviluppo, ma anzi molteplice;
non solo nel senso di diverso e giustapposto, ma anche nel senso di stratificato dal più
grossolano al meno grossolano, se addirittura non deve parlarsi di un agglomerato
indigesto di frammenti di tutte le concezioni del mondo e della vita che si sono succedute
nella storia, della maggior parte delle quali, anzi, solo nel folclore si trovano i superstiti
documenti mutili e contaminati». C'è evidentemente in questa pagina un superamento
della concezione idealistica della Weltanschauung, pur mancando ancora una chiara
individuazione del rapporto codici sociali-messaggi individuali; poiché il concetto
gramsciano di concezione del mondo e della vita è più vicino al concetto di codice sociale
è difficile accettare alla lettera l'idea che si tratti di concezione «non elaborata e
asistematica» (i codici sono sempre sistematici ed elaborati dalla società), la si deve
accettare nello spirito gramsciano e cioè in questo significato: la concezione del mondo e
della vita implicata dal folclore non è programmata, scaturisce dalla ripetizione
inconsapevole di atti (in senso giuridico), parole (in senso linguistico) gesti 3 frasi, percorsi
che producono norme pur non disponendo di una propria autonoma e organica egemonia.
(18) Cfr. Il materialismo storico e la filosofia di Benedeíto Croce, Torino 1949, p. 3 (ed.
critica p. 1375): «Tutti sono filosofi, sia pure a modo loro, inconsapevolmente, perché
anche solo nella minima manifestazione di una qualsiasi attività intellettuale, il 'linguaggio',
è contenuta una determinata concezione del mondo». Un'analisi che accerta l'esatto
valore semantico del lessico e dei giudizi gramsciani sul folclore è quella compiuta da A.
M. Cirese in Intellettuali, folklore e istinto di classe, Torino 1976, p. 104 e più avanti pp.
121-126; si tratta della relazione al convegno internazionale di studi gramsciani tenutosi a
Cagliari nel trentesimo anniversario della morte. Implicitamente vi si trova una risposta
alla critica mossa a Gramsci da L. Althusser (cfr. L. Althusser e E. Balibar, Leggere il
capitale, Feltrinelli, Milano 1976, pp. 341-345) di «tendere costantemente a ridurre ed
assimilare completamente» il rapporto specifico che la filosofia intrattiene con le scienze
«quasi a una semplice differenza formale, la 'filosofia' 'alla concezione del mondo'».
Ovviamente il discorso è da approfondire e sviluppare in altra sede.
(19) Del concetto di cultura ovviamente si sono occupati, da sempre, non solo gli
antropologi ma anche i filosofi. Qui ovviamente si privilegiano le elaborazioni dei primi. La
più nota definizione è quella etnologica proposta da Edward Burnett Tylor fin dal secolo
scorso nel quadro dell'impostazione evoluzionistica degli studi appunto etnologici: «La
cultura, o civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, è quell'insieme complesso che
include la conoscenza, le credenze, l'arte, la morale, il diritto e qualsiasi altra capacità e
abitudine acquisita dall'uomo come membro di una società». Cfr. Pietro Rossi, Il concetto
di cultura (con scritti di Tylor,. Boas, Lowie, Kroeber, Malinowski, Murdoch, Linton,
[email protected]
http://www.webalice.it/ilquintomoro
Bidney, Kluckhohn, Herskovits), Torino 1970, p. 7. V. anche C. Kluckhohn e A. L.
Kroeber, Il concetto di cultura, Bologna 1972; Edwar Sapir, Cultura, linguaggio e
personalità, Einaudi, Torino 1972 (a cura di G. Mandelbaun, introduzione di Giulio
Lepschy), Storia dell'antropologia, Il Mulino, Bologna 1972.
Da una definizione prossima a quella di TyIor prende le mosse Marcuse per Note sulla
ridefinizione della cultura, in Cultura e società, Einaudi, Torino 1969, p. 268 e segg. La
cultura sarebbe il «complesso delle specifiche credenze. conquiste, tradizioni etc. che
costituiscono il background 'sfondo'. di una società». L'analisi marcusiana si incentra sul
rapporto oppositivo fra il background (la cultura) e il ground (il terreno), che egli sottrae - si
vedrà perché - alla cultura, che a lui «appare come il complesso degli obiettivi (o dei valori)
morali, intellettuali, ed estetici, che una società considera come , lo scopo
dell'organizzazione».
Ora, se la scomposizione del concetto di cultura tyloriano compiuta da Boas (v. Pietro
Rossi, op. cit.) costitui un passo avanti, quella di Marcuse appare un passo indietro, che
porta non tanto ad un privilegiamento dei valori superiori della cultura quanto
all'esaurimento di questa in quelli. Attraverso la distinzione fra cultura e civiltà materiale
(lavoro intellettuale -lavoro manuale, giorno festivo-giorno lavorativo, otium-lavoro, regno
della libertà - regno della necessità, Pensiero non operativo-pensiero operativo, scienze
sociali-scienze della natura, fino a porre la dicotomia spirito -natura) Marcuse ripropone
categorie idealistiche, pervenendo alla teoria dell'estinzione degli studia humanitatis, che
sarebbero stati assorbiti ed espunti dalle scienze del comportamento con la conseguente
mortificazione dei valori superiori della cultura e dunque con la negazione di questa. Di
qui anche il suo privilegiamento dell'università preposta alla gestione dei valori superiori
della cultura e garante del loro non mescolarsi (e «non estinguersi») nei valori generali
della cultura (v. Le origini dell'università, testi a cura di Girolamo Arnaldi, Il Mulino,
Bologna 1974; Pietro Piovani Morte (e trasfigurazione dell'università, Napoli 1969).
Nonostante tutto Marcuse opta per la cultura e «è sempre stata privilegio di una piccola
minoranza, mera questione di, ricchezza, tempo e buona fortuna - per usare parole sue -.
Per le masse popolari sottosviluppate i 'valori superiori' della cultura sono sempre stati
mere parole e vuote esortazioni, illusioni e inganni, nel migliore dei casi erano speranze ed
aspirazioni che rimasero inappagate». Le conclusioni di Marcuse sembrano esattamente
opposte a quelle di Gramsci. Infatti Marcuse scrive (p. 286): «L'integrazione dei valori
culturali nella società costituita sopprime l’alienazione della cultura della civiltà matetiale,
appianando così la tensione fra il 'dover essere' e l' 'essere' (che è una tensione reale e
storica), fra il futuro e il presente, libertà e necessità». Si tratta invece di una distinzione
insopprimibile perché ha la sua radice strutturale nella dialettica codici-messaggi, oltre che
nella dialettica delle fonti normative di classe. il problema è se il diritto al messaggio debba
essere ancora riservato ad una minoranza privilegiata o debba essere restituito a tutti
(posto che Marcuse privilegia i messaggi e gli autori, da lui posti come antitesi, mentre i
codici si assimilerebbero alla tesi) se, come Marcuse ritiene la funzione dialettica e dunque
rivoluzionaria spetta al messaggio artistico, la cui forza - come sappiamo dalle acquisizioni
della linguistica artistico, e dello strutturalismo (cfr. Roland Barthes, Il grado zero della
scittura, Lerici, Milano 1960; Elementi di semiologia, Einaudi, Torino 1966 e Saggi critici,
Einaudi, Torino 1966; Il piacere del gesto, Einaudi, Torino 1975) - è misurata dalla forza
della sua individualità e dunque dal suo scarto rispetto al codice (il prevalere di
quest'ultimo misurerebbe invece il contrarsi delle «dimensioni» dell'uomo). In tal modo si
afferma l'esigenza di mantenere la scissione tra valori superiori della cultura dalla civiltà
materiale; infatti nella misura in cui questa li incorporerebbe, quelli perderebbero la loro
forza dialettica. Per Gramsci invece, se io non fraintendo il complesso del suo pensiero,
l'appropriarsi da parte dei produttori della civiltà materiale (cioè da parte della classe
[email protected]
http://www.webalice.it/ilquintomoro
operaia) dei valori più alti e dei ruoli della cultura colta è un elemento decisivo della
crescita (non dell'estinzione) della forza dialettica.
Per quanto riguarda la coppia oppositiva cultura colta-cultura in senso antropologico cfr.
Edgar Morin, L'industria culturale, Il Mulino Bologna 1967 (vi si sostiene la tesi che la
diffusione dei messaggi anche della cultura colta crea una rivoluzione planetaria di portata
antropologica, crea finalmente una cultura mondiale sincretica). V. anche Jacques Berque,
Verso una cultura mondiale, Dedalo, Bari 1968. Maria Solimini (Scienza della cultura e
logica di classe, Dedalo, Bari 1974), sottolíneato il carattere acerbo dei tentativi di fondare
una scienza della cultura, afferma la necessità (pp. 143-144) di far fronte «alla varietà dei
sistemi di produzione dei messaggi» mediante «la costruzione di modelli tecnici generali
che possano essere applicati nella determinazione della specificità storica dei processi di
formazione dei codici». A mio modo di vedere, è appunto questo uno degli obiettivi
essenziali dell'antropologia culturale; e le scienze dell'uomo - in particolare la linguistica hanno già percorso un lungo tratto della strada che conduce al conseguimento di questo
obiettivo.
(20) V. per tutti Gordon Childe, Preistoria della società europea, Sansoni, Firenze 1966,
terza edizione pp. 60-61; a proposito degli australantropiani si può parlare di cultura dei
Chopper, con riferimento al loro stereotipo tecnico (cfr. Leroi-Gourhan, Op. Cit., pp.
110-111).
(21) cfr. Umberto Eco, articolo sul «Corriere della Sera» del 17 agosto 1976.
(22) Cfr. A. M. Cirese, op. cit., 1976, p. 121 e segg.; Giulio Angioni, Rapporti di
produzione e cultura subalterna, contadini in Sardegna, EDES, Cagliari 1974, p. 26 e
segg.
(23) A, M. Cirese, op. cit., 1976, pp. 126-127.
(24) Cfr. Umberto Eco, Manuale di semiotica generale, Bompianì, Milano 1975, 0.8.l.,
p. 36. Eco, a p. 8, dichiara che dopo questo libro accetterà «discussioni sui limiti e sulle
possibilità della semiotica solo sulla base» del medesimo, che riformula «secondo linee
architettoniche più precise», le ipotesi dei suoi libri precedenti.
(25) Il termine è usato, oltre che nel valore corrente, anche in, quello più specifico
meglio definito da Roland Barthes, Elementi di semiologia, cit., cap. IV.
(26) Osservazioni riprese e sviluppate da Cirese, sia in Cultura egemonica e culture
subalterne, Palumbo, Palermo 1971, sia in Intellettuali etc., 1976, cit., pp. 119-120.
(27) Cirese, op. cit., 1976, p. 88.
(28) Ibidem.
(29) Cfr. A. M. Cirese, Sardegna: folklore - mito e realtà storica, nel vol. Sardegna
dell'enciclopedia «Tuttitalia» della SADEA (Sansoni e De Agostini), Firenze 1963, p. 82.
Questo libro sarà più avanti citato come Sardegna 1963.
(30) Cfr. Cirese 1969, ibidem. V. anche in generale Vittorio Lanternari, Folklore e
dinamica culturale, Liguori, Napoli 1976; Luigi M. Lombardi Satriani, Folklore e Profitto,
Firenze 1976; Menzogna e verità della cultura contadina, cit.
[email protected]
http://www.webalice.it/ilquintomoro
(31) Lettre à la France négre, Edmond Nalis éditeur, Paris 1968, p. 10.
(32) Del Sergi i veda La Sardegna, Torino 1907. L'adesione al giudizio gramsciano
sull’antropologia positivista non deve far dimenticare la necessità di distinzioni all'interno di
questa scuola e la ricchezza dei dati presi in considerazione dagli autori positivisti. I giudizi
del Sergi sono infatti da distinguere e in qualche caso da opporre nettamente a quelli di
altri autori come Cesare Lombroso (L’uomo delinquente Roma 1876) e Alfredo Niceforo
(La delinquenza in Sardegna, Palermo 1897 ed ora in ed. anastatica, Della Torre, Cagliari
1977; Italiani del Nord e italiani del Sud, Torino 1901) e anche, per altro verso, quelli di
Paolo Orano (Psicologia della Sardegna, Cagliari 1919). In questo libro non si
riprendono le critiche alla scuola positivista per non sfondare porte ormai da tempo
aperte.
(33) V. l'articolo in Sotto la Mole 1916-1920, Torino 1972, pp. 1481-150; oppure in
Antonio Gramsci e la questione sarda, a cura di Guido Melis, ed. Della Torre, Cagliari
1976, p. 81.
(34) Anno II, fascicolo I, Roma 1894. Le ricerche della Deledda sono ora raccolte in
volume a sé da Fernando Pilia e pubblicato con, utili premesse dello stesso Pilia e di
Francesco Alziator dalla Editrice 3T, Cagliari 1972 (edizione anastatica).
(35) Di tutti questi autori si parlerà nel corso del libro. Per molti di essi sembra tuttavia
opportuno dare sin d'ora qualche informazione. Il primo riferimento è alle considerazioni
specifiche di Gramsci su questioni sarde, che Però sono sempre da inquadrare nel
complesso del suo pensiero, come è stato più volte osservato da Umberto Cardia (per es.,
in recensione all'antologia gramsciana curata da Guido Melis). Sul Gramsci sardo vedi
bibliografia anche più avanti. Gli scritti nei quali Gramsci fa riferimento esplicito alla
Sardegna sono raccolti nella citata antologia di Guido Melis. V. però anche Giuseppe
Fiori, Vita di Antonio Gramsci, Laterza, Bari 1966, particolarmente ricco sulla formazione
sarda di Gramsci, la cui biografia, prima dì questo libro, appariva priva di infanzia e di giovinezza (egli sembrava balzato armato dal cervello della classe operaia torinese come
Minerva da quello di Giove). Si rimanda per il resto alla bibliografia gramsciana sempre in
movimento, come tutti ben sanno. Sul Gramsci sardo si vedano gli interventi di P. Togliatti,
citati più avanti, il discorso tenuto da Enrico Berlinguer a Cagliari nel 40' anniversario della
morte e Luciano Gruppi, Gramsci e la Sardegna, in «Archivio sardo» del movimento
operaio, contadino e autonomistico, Cagliari, n. 4-5, dicembre 1975, pp. 259-266.
Una figura che ha fortemente agito nella storia e nelle coscienze della Sardegna per
oltre cinquant'anni è Emilio Lussu, del quale vengono ripubblicati ora anche gli scritti da lui
non raccolti in volume e vengono regolarmente ristampati da Einaudi gli ormai «classici»
Un anno sull'Altipiano e Marcia su Roma e dintorni. V. anche: Il cinghiale del diavolo e
altri scritti sulla Sardegna, a cura di Simonetta Salvestroni, Einaudi, Torino 1976; Per
l'Italia dall'esilio, Della Torre, Cagliari 1975 (a cura di Manlio Brigaglia); Essere a sinistra (a
cura del Collettivo Lussu), Mazzotta, Milano 1976; Camillo Bellieni, Emilio Lussu, Il
Nuraghe, Cagliari 1926; Manlio Brigaglia, Emilio Lussu e «Giustizia e Libertà», Della
Torre, Cagliari 1976.
Tutto questo libro risulterà attraversato anche da ipotesi nate dalla frequentazione della
persona e degli scritti di Antonio Pigliaru, anche se, ovviamente, i riferimenti espliciti
saranno al Codice della vendetta barbaricina come ordinamento giuridico (1959), ora in Il
banditismo in Sardegna (Giuffrè, Milano 1975,), un «classico» della demologia giuridica
(Lombardi Satriani). È da tener presente tutta l'intensa attività svolta da Pigliaru come
[email protected]
http://www.webalice.it/ilquintomoro
organizzatore degli intellettuali sardi e in particolare come direttore della rivista sassarese
«Ichnusa» (v. M. Pira, Che cos'è stato Pigliaru per la cultura in Sardegna, in Antonio
Pigliaru, Politica e cultura, a cura di Manlio Brigaglia, Salvatore Mannuzzu e Giuseppe
Melis Bassu, Gallizzi, Sassari 1971 pp. 9-18); il volume contiene gli editoriali di Pigliaru e
l'indice della rivista. Si vedano anche A. Pigliaru, Quaderno segreto e La piazza e lo Stato,
ed. di jchnusa, Sassari 1961.
Punti di riferimento dell'intellettualità sarda in questi ultimi trent'anni sono stati anche
numerosi uomini politici che, come Renzo Laconi, Umberto Cardia, Paolo Dettorí, Pietro
Soddu, Sebastiano Dessanay, Michele Columbu, Armando Congiu e altri - non si vuol fare
un elenco dei primi della classe -, hanno associato alla ricerca sulla specificità politica
della Sardegna quella delle specificità culturali. Fa parte di questi intellettuali politici anche
Giovanni Lilliu, archeologo e paletnologo, autore di La civiltà dei Sardi, ERI, Torino 1963,;
La degradazione storica della società barbaricina, in « Autonomia Cronache» (n. 2 del
marzo 1968, Sassari); Liberiamoci, due discorsi poco ortodossi, Cagliari 1970; Un giallo
del sec. XIX in Sardegna: gli idoli fenici, estratto di «Studi Sardi» (vol. XXIII, anno 1974,
Sassari 1975). Resoconto di mezza legislatura, Sassari 1972; Resistenza e autonomia,
Cagliari 1970; Dal «bétilo» aniconico alla statuaria nuragica, Gallizzi, Sassari 1977.
La migliore introduzione alle problematiche della Sardegna interna messe in luce dal
banditismo è in Manlio Brigaglia, Sardegna perché banditi, Roma 1971 (edizioni Leader
Milano) da me recensito in « Rinascita Sarda», anno VII, n. 14,18. Brigaglia, che di fatto
ha raccolto l'eredità di Pigliaru come Organizzatore degli intellettuali sardi militanti (ma non
assorbiti con netta prevalenza nel lavoro dei partiti), viene formando nell’ateneo di Sassari
un gruppo di giovani storici molto attivi e rigorosi. Egli ha intanto pubblicato i citati libri su
Emilio Lussu e numerosissimi saggi, v. La Sardegna dal periodo fascista all'autonomia
regionale, in Boscolo, Brigaglia, Del Piano,La Sardegna conteporanea, Della Torre,
Cagliari 1974.
Altri autori che introducono nel vivo dei problemi della Sardegna interna qui privilegiata
sono: Franco Cagnetta, Banditi a Orgosolo, Guaraldi, Rimini-Firenze 1976; Giuseppe Fiori,
La società del malessere, Laterza, Bari 1968; Sonetàula (romanzo sulla presa di
coscienza del mutamento socio-culturale da parte di un bandito), Canesi, Roma, s.d.;
Gonario Pinna, Il pastore sardo e la giustizia (Cagliari 1967); Antologia dei Poeti dialettali
nuoresi (Cagliari 1969); La criminalità in Sardegna (Cagliari 1970) (l’autore attinge alla sua
vastissima esperienza di penalista barbaricino filtrata da lunghi studi criminologici); Ignazio
Pirastu, Il banditismo in Sardegna, Editori Riuniti, Roma 1973.
Per le ricerche storiche sono da segnalare, più le opere che si troveranno citate anche
Più avanti, Alberto Boscolo, Il feudalismo in Sardegna, Fossataro, Cagliari 1967; Salvatore
Sechi, Dopoguerra e fascismo in Sardegna, Einaudi, Torino 1969; Luigi Bulferretti, Il
riformismo settecentesco in Sardegna, Fossataro, Cagliari 1966; Lorenzo Del Piano,
Antologia della questione sarda, CEDAM 1966; Carlino Sole LA Sardegna di Carlo Felice
e il problema della terra, Cagliari 1967 Giancarlo Sorgia, La Sardegna nel 1848 e la
polemica sulla fusioe, Fossataro, Cagliari 1968; Girolamo Sotgiu, Il Movimento operaio in
Sardegna(1890-1915), Fossataro, Cagliari 1974; Alle Origini della questione sarda,
Cagliari 1967 (v. anche M.Pira, Recensione su «Il Giornale», Cagliari, 1 -15 marzo 1967.
pp. 22-24); Questione sarda e movimento operaio, Cagliari 1969.
Pur non avendo alcuna pretesa di completezza un elenco come questo non può
trascurare almeno come ponte dalla geografia alla storia e alla sociologia, Maurice Le
Lannou, Pátres e Paysans de la Sardaigne, Tours 1941, Per le ricerche sociologiche:
Pietro Crespi, Analisi sociologica e sottosviluppo economico, Milano 1963; Marcello Lelli,
Proletariato e ceti medi in Sardegna, De Donato, Bari 1975; Bachisio Bandinu e Gaspare
Barbiellini Amidei, Il re è un feticcio, Rizzoli, Milano 1976; Giulio Angioni, op. cit, e Sa
laurera - Il lavoro contadino in Sardegia (EDES, Cagliari 1976; Clara Gallini, I rituali
[email protected]
http://www.webalice.it/ilquintomoro
dell’argia, CEDAM, Padova 1967 e Il consumo del sacro, I.aterza, Bari 1972; Luca Pinna,
La famiglia esclusiva terza, Bari 1971 (influenzato da E. C. Banfield, Una comunità del
Mezzogiorno, Il Mulino, Bologna 1971: vengono individuate le specificità negative del
familismo della Società logudorese e messe in ombra le funzioni positive strutturali);
Gavino Musio, La cultura solitaria, Il Mulino, Bologna 1971 (tentativo interessante di analisi
della cultura della Sardegna più interna in chiave benedictiana e pisco-analitica che merita
ulteriori- ricerche). Da segnalare infine le ricerche del gruppo Rudas-Puggioni-Camba in
«Rivista Sarda di criminologia» ruotanti intorno ai nessi criminalità-pastoralità, isolamentopastoralità-malattie mentali. Su F. Alziator, come su altri autori non citati a questo punto,
v. più avanti.
Un quadro sia pure soltanto indicativo degli autori che hanno segnato la cultura sarda
nell'ultimo trentennio non può non includere gli scrittori che pologico-narrativa dei vissuto.
li riferimento non è soltanto a quelli hanno dato della realtà sociale e culturale dell'isola la
rappresentazione antropologico-narrativa del vissuto. Il riferimento non è soltanto a quelli
che hanno avuto il merito di risolvere i problemi che la rappresentazione di questa realtà
pone alla narrativa e alla scrittura, ma anche a qulli che pur non avendo conseguito
risultati estetici riconosciuti dal pubblico italiano al quale si rivolgevano per il fatto di
scrivere in lingua italiana, tuttavia hanno svelato documenti che interessano l'antropologo.
Sulla narrativa sarda in apposita sede sarà magari da riprendere e ridefinire il discorso che
aveva avviato Antonio Pigliaru con la recensione al romanzo di Giuseppe Zuri (Un dodge
a fari spenti, Rizzoli, Milano 1962) su «Ichnusa» del 1962 n. 6 (Un bilancio della nuova
narrativa sarda).
Di Giuseppe Dessi che ha raccontato soprattutto la Sardegna meridionale più
europeizzata, al di là delle opere di narrativa, sono da riprendere talune escursioni nella
saggistica, come l'articolo (L’altra faccia della Sardegna) scritto per il numero speciale del
«Ponte» dedicato alla Sardegna nel 1950, o l'introduzione a Sardegna una civiltà di pietra
(libro fotografico firmato oltre che dallo stesso Dessi, da Pigliaru e da Franco Pinna), edito
dalla LEA nella serie «Italia Nostra» nel 1961: v. su di esso M. Pira Verso l'alfabeto, nella
rivista «Il Bogino», n. 7 del 1962, Cagliari, pp. 89-96.
Proprio nel rileggere recensioni ai libri di Zuri, di Salvatore Cambosu (Miele amaro,
Vallecchi, Firenze 1954, dolente mosaico della vita della Sardegna interna), di Fiori
(Sonetàula e La società del malessere), di Michele ColomBu (L’aurora è lontana, Ed.
Leader, Milano 1968), di Maria Giacobbe (Diario di una maestrina, Laterza, Bari 1957;
Piccole cronache, Laterza, Bari 1961; Le radici, Della Torre, Cagliari 1977); di Francesco
Masala (Quelli dalle labbra bianche, Feltrinelli, Milano ed ora Della Torre, Cagliari 1977), di
Paride Rombi (Perdu, Mondadori, Milano 1950, che apri la stagione dell'adesione dei
narratori sardi al neorealismo), di Antonio Cossu (Il riscatto e I figli di Pietro Paolo,
pubblicati da Vallecchi, Firenze nel 1969 e nel 1966), ma anche di autori che non hanno
circolato come Bachisio Zizi e Guido Cuileddu (e che costituiscono un rimorso per la
disattenzione con cui sono stati pubblicati e accolti) vedo emergere l'esigenza di un
discorso critico che valga ad individuare gli elementi che li accomunano come se fossero
un libro unico, di un luogo e di un tempo unitari, perché il campo incomincia già a
cancellare certe caratteristiche che si imputavano ai singoli autori ed emergono le
concordanze e le omogeneità di tono e di linguaggi indotte dai contenuti culturali che si
volevano rappresentare.
Non ho dimenticato Gavino Ledda e il suo Padre padrone, col quale però sembra avere
inizio un discorso diverso da quello al quale si accennava per gli autori citati prima. Proprio
perciò l'ho lasciato fuori da un elenco che appare già chiuso; fuori perché; Possa aprirne
un altro, che a mio avviso però rischia di morire con lui e con le strumentalizzazioni che il
suo libro consente da parte della cultura osservante proprio nel momento e per il modo in
cui questa gli apre le porte del successo (e del «caso») e del cinema.
[email protected]
http://www.webalice.it/ilquintomoro
[email protected]