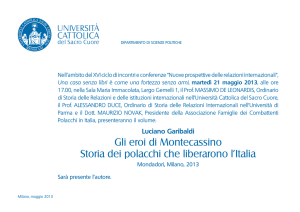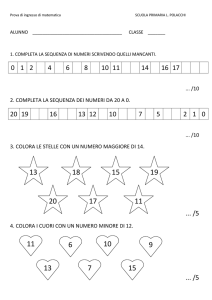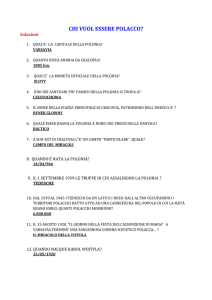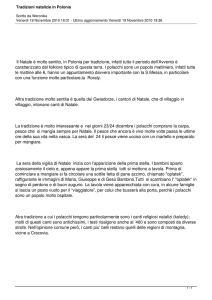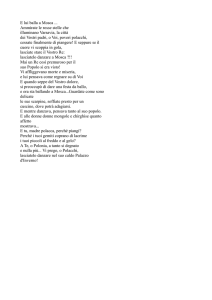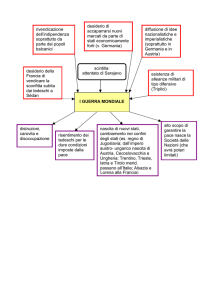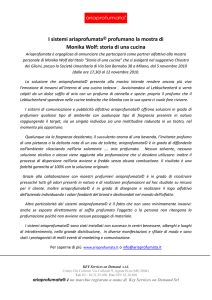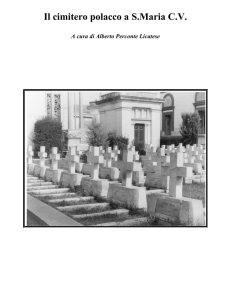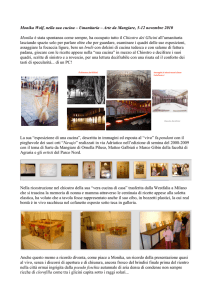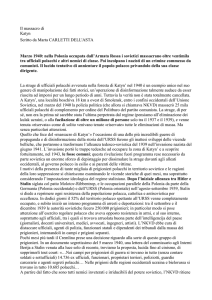L’impero zarista prima e quello sovietico poi hanno creato piccole nebulose di minoranze oppresse e perseguitate: tartari di Crimea, curdi, ingusci e
ceceni del Caucaso, tedeschi del Volga, greci del Mar Nero. E ancora: bud-
Lemki, così diversi
così colpevoli
MINORANZE
testo e foto di Monika Bulaj
disti calmucchi, ebrei esiliati in Siberia, mingreli, caraiti o basmac’. Si sa
molto poco di questi popoli, come si sa poco dei lemki, russo-ortodossi che
per secoli hanno abitato fra Polonia, Slovacchia e Ucraina
uando volo di notte tra la Siberia e
l’Europa centrale, e solo qualche luce
interrompe il buio sterminato sotto di
me, ripenso all’arcipelago dei popoli perduti
dell’Est. Popoli annientati, chiusi nei gulag,
deportati, dispersi, criminalizzati da Stalin e,
prima, dalla Russia zarista. Una geografia
affascinante, che per secoli ha disegnato piccole nebulose ai margini delle nazioni dominanti, e poi d’un tratto venne spazzata via
nel secolo totalitario. Tartari di Crimea,
curdi, ingusci e ceceni del Caucaso, tedeschi
del Volga, greci del Mar Nero. Che ne sappiamo di loro? Niente, talvolta nemmeno il
nome. Niente dei buddisti calmucchi, spediti
in Siberia dalle basse terre del Volga; niente
degli ebrei esiliati in Siberia in una terra di
nome Birobizhan; niente mingreli, caraiti o
basmac’.
Non ne sapevo nulla nemmeno io, quando
vent’anni fa andai alla ricerca dei lemki –
detti anche ruteni – russo-ortodossi che per
secoli avevano abitato fra Polonia, Slovacchia
e Ucraina. Non potevo immaginare fino a
che punto Varsavia ai tempi di Stalin avesse
perseguitato questo popolo colpevole di essere troppo diverso. Un popolo colpevole, come
molti altri, di rovinare il gioco ai geometri
delle etnie, incaricati di dividere i popoli a
Q
60
compartimenti stagni bene ordinati e ostili
fra loro, affinché il Potere potesse più facilmente comandare attraverso la discordia.
Partii, con tanto entusiasmo e incoscienza,
senza immaginare che quella ricerca mi
avrebbe cambiato la vita e disegnato nella
mia mente una geografia completamente
diversa dello spazio eurasiatico.
Capii subito che stavo cercando delle ombre.
Relitti di mondi estinti. Capii che anche i
polacchi, gli ucraini, i tedeschi – oltre ovviamente agli ebrei – erano stati deportati a
milioni. Anche gli armeni, gli zingari, i
curdi, o i bulgari di Crimea. Ma la loro
massa critica li aveva risparmiati dalla cancellazione totale. Questi, invece, non esistevano quasi più. Non avevano avuto nemmeno la capacità di resistenza dei Ceceni. Capii
che per sapere di loro avrei dovuto parlare
con gli ultimi vecchi, quelli che avevano
conosciuto l’invasione tedesca e la repressione sovietica. Era l’unico modo per sapere
qualcosa di questo popolo di guaritori-sciamani, cantastorie e bevitori di leggenda. Ecco
come li ho conosciuti, nel 1988, millenario
della Russia cristianizzata, quando per la
prima volta dall’inizio del comunismo – da
Kiev fino a Novgorod – le campane delle
chiese poterono suonare a distesa.
MINORANZE
chiodi, alla stregua greca. C’è anche un mucchio di croci, rotte, con un nido d’uccello in
mezzo. Solo dopo un attimo mi rendo conto
che sono in un cimitero, e che tutto è stato
demolito, sparso sistematicamente. Come
una forza immane, come una grande iracondia, come se ci fosse bisogno di una valida
ragione per compiere un tale scempio.
Terra dei lemki, un pugno di terra.
L’attraversi in due ore con la macchina.
Qualche valle scava cautamente montagne
piatte, qualche fiume rotola le pietre a nord,
fino alla Vistola. Le chiese in legno con gli
angeli scoloriti dalle piogge sprofondano
nella terra. I meli inselvatichiti, i campanili
vuoti stesi per terra; una manciata di casolari, di alcuno sono rimaste solo le mura dai
tronchi marci e le finestre vuote che inquadrano il prato con l’erba alta.
Jan Paszko di Bartne è un ex-prigionero di
Jaworzno, una filiale di Auschwitz che è
stata l’ultimo campo di concentramento
costruito dal Terzo Reich. Erano terminati i
MoniKa Bulaj
L’ angelo
Jan Paszko è un lemko e la terra dei
lemki è un pezzo di Bisanzio ficcato sul confine tra la Polonia e la Slovacchia. Il vento
sferza con una pioggia gelida, la strada è
divenuta un torrente. Lui se ne sta con l’acqua fino alla cintola, come niente fosse, a
torso nudo, insaponato. Ride di sé, di noi,
della pioggia. Odora di sapone grezzo, legna
bruciata, sterco di vacca, foglie marce. Indica
un azzurro casolare fumante sulla collina,
perché tra un po’ scomparirà nella nebbia.
Quella è la sua casa.
Oltre, nel campo c’è un angelo di pietra con
la testa mozzata. Le ali sono accuratamente
ripiegate sulle spalle. Sul prato, nei cespugli,
tra i radi alberi della boscaglia, le braccia
rotte dei Salvatori indicano, salutano, minacciano, spuntano dalla terra, irose come monconi di esercito sterminato in tronco. I piedi
dell’unico Cristo che si è salvato con tutte le
estremità perché colato col ferro, sono
inchiodati separatamente alla croce, con due
LEMKI, COSÌ DIVERSI COSÌ COLPEVOLI
I valichi
I lemki hanno ricevuto una batosta in
ogni guerra. Tutti i dominatori li hanno
guardati come “diversi”. Polacchi, ucraini,
austriaci, tedeschi, russi. Loro si considerano
come i curdi in Turchia o i “Pellerossa
d’Europa”. La loro complessa identità è stata
strumentalizzata per decenni, con l’avallo di
teorie pseudo-scientifiche, in un vortice di
follie nazionaliste, guerre e paure. Per il
sospetto di alleanze con l’agonizzante zarismo, gli austriaci, nel 1914, li condussero al
campo di Thalerhof, che si copre della fama
di essere stato il primo campo di concentramento d’Europa. In ogni ruteno gli austriaci
volevano vedere una spia. Del resto da
tempo la Russia piaceva ai ruteni. Non poteva essere altrimenti: qui, sul valico di
Dukielska, apparse lo zar in persona, quando
nel 1849 trascinava sul Danubio il suo esercito per affogare nel sangue l’insurrezione
ungherese, i barbuti preti ortodossi cospargevano l’esercito col fumo di odorose resine,
con la croce d’oro benedivano i ruteni, li
buttavano caramelle, cantavano in basso profondo un fervido “alliluja”, la cui eco si
MoniKa Bulaj
processi a Norimberga, e la Polonia comunista – oltre ai propri cadaveri e alle città rese
polvere – aveva ereditato baracche, filo spinato ad alta tensione, celle di isolamento,
kapò, tifo e pidocchi. Con questo sistema
concentrazionario intatto, Varsavia aveva
imparato da Stalin come risolvere, un volta
per tutte, la questione delle minoranze. Era il
1945, lo stesso anno in cui il Parlamento
comunista approvava la legge sulla “commemorazione del Martirio del Popolo Polacco e
di Altri Popoli ad Auschwitz”.
Come Paszko, anche altri prigionieri di
Jaworzno sbattuti là per il solo fatto di essere di origine lemka e di abitare a cavallo dei
Carpazi, ci mostrano sulle spalle cicatrici dei
pestaggi, documenti ingialliti con le impronte digitali e una foto da cui ci guardano occhi
spalancati dal terrore. “Dì anche solo una
parola e ritornerai”, gli avevano detto al
momento della liberazione. I sopravvissuti
tacquero per quarant’anni. Ed è a me che per
la prima volta in vita loro – dopo aver chiuso
accuratamente le finestre come se le spie
fossero ancora in ascolto – mostrano i segni
tremendi dell’inferno.
MINORANZE
New Bedford e Nantucket” – scrisse
Zygmunt Haupt – portarono nelle valli radio
scricchiolanti e notizie dal mondo.
Ma ogni volta gli eserciti marciavano nei
valichi.
Dopo la Prima guerra mondiale a Lemko è
rimasto il gusto per l’etere rubato agli ospedali da campo, più forte della vodka, che provocava fantastiche visioni, e poi i cadaveri
austriaci, ungheresi, russi e tedeschi, e i
combattenti di entrambe le parti: polacchi,
cechi e ruteni. L’operazione di Gorlice fu una
delle battaglie più sanguinose della Prima
guerra mondiale; sui campi rimasero 60.829
corpi insepolti, secondo lo scrupoloso rapporto del “reparto sepolcrale”, ovvero il
Kriegsgraberabteilung des K. und K.
Militarkommandos Krakau, secondo un’opinione comune, la migliore unità funzionante
dell’esercito austro-ungarico.
L’ultima iniziativa della frantumatesi
monarchia – titanica, se contare progetti,
denaro, materiali edili e piantine – sarà la
costruzione di 365 cimiteri con la collaborazione di artisti di spicco provenienti da
Cracovia, Praga, Budapest e Vienna.
MoniKa Bulaj
spandeva tra le montagne come un grido. I
soldati dello zar Nicola, oltre alle baionette
portarono le icone con San Nicola, il santo
adorato dai lemki, e non colpirono nessuno
con il knut, non li impiccarono al crocevia,
non stuprarono le fanciulle (lo zar ci teneva
al buon nome tra i fratelli slavi e per la violenza sui ruteni minacciò di morte i soldati).
Sebbene la terra dei lemki sia appena una
stretta fascia del boscoso pettine dei Carpazi
tranciato da alcuni valichi, sebbene sia soltanto un vicolo di storia, la strada cieca che
adesso s’impantana tra i cespugli, proprio
questa geografia sarebbe divenuta la sua
maledizione.
Nelle profonde valli si può scomparire per
secoli, tessere la lana, suonare le campane
per le nuvole, riverire le icone, gettare i carboni ardenti nell’acqua, gridare le profezie
sugli uccelli di ferro, che voleranno per il
cielo e getteranno sulla gente delle uova
mortali. Si può infilzare il guscio dell’uovo
su un bastoncino e metterlo tra lo steccato
per scacciare l’invidioso malocchio. Gli abitanti di Los, innamorati dei cavalli, allevatori
di cavalli, ladri di cavalli, “come i balenieri di
LEMKI, COSÌ DIVERSI COSÌ COLPEVOLI
rante il buon imperatore.
Da qua, per l’appunto, dal valico Lupkowski
è passato il più grande esercito della Seconda
guerra mondiale. Dietro a questo rimasero
per terra migliaia di fibbie con la scritta
“Gott mit uns”, migliaia di corpi sputati alla
primavera dai campi disgelati, “urla selvagge
che nelle notti inseguivano il carro, schiamazzi e rumori. Rimbombavano dietro alle
spalle, schiacciavano il pane sul carro”. Di
questo disordine ora nessuno avrà più la
testa per occuparsene.
“Animuccia, via da me”
Nel 1945 migliaia di giovani lemki tornavano ai casolari costruiti con lunghi tronchi
separati da argille rosse, blu e gialle.
Tornavano dai lavori forzati del Terzo Reich,
perché i contadini ariani che combattevano
sul fronte di tutto il mondo si occupavano
della definitiva soluzione delle questioni
ultime, mentre in Germania erano rimaste le
donne sole e i campi da seminare. Tornavano
dalla prigionia tedesca perché nel ’39 avevano combattuto in difesa della patria. Dalla
MoniKa Bulaj
Vincitori e vinti giaceranno in fraterna pace
tra sarcofaghi pseudo-egizi, vialetti serpeggianti in mezzo all’edera, anfiteatri dove
meditare sul destino di entrambe le parti in
lotta, torri in stile folcloristico, croci, nei
quali chiunque poteva vedere con brama l’anima: il simbolo della Passione, oppure gli
emblemi slavi del culto pagano miracolosamente risorti dall’aldilà. Con serietà mortale
si discuteva allora nei salotti della pervinca:
induce alla meditazione e si fa più abile di
una rosa capricciosa. I cimiteri di Gorlice
sono probabilmente l’ultimo esempio di
umanesimo dell’epoca scomparsa irrimediabilmente.
Tra i lemki fu destinato a durare in eterno
anche il mito del buon imperatore (e dei cattivi funzionari), nonostante preti e insegnanti lemki massacrati a Thalerhof. “Non è
vero che nella stessa Vienna e nelle piccole
stazioncine dell’Europa centrale, l’imperatore in persona ascoltava pretese e lamentele
dei contadini? Non chiedeva ‘Come va a
Bartne, signor Madzik?’” Ancora nel 1958,
un contadino a rischio della vita portò via
dalla casa in fiamme un’oleografia raffigu-
MINORANZE
ubriaconi accaniti. “I lemki venivano da noi
dopo il mercato a bere un tè e la guardavano
in estasi; allora suo padre le gridava – vai,
vai dai tuoi lemki, perché lei li amava da
morire”, mi racconta nel 1992 Ester, sorella
di Maria, nella lontana Anversa. Finì la
guerra e Maria uscì per fare un salto alla sua
osteria. Fu fucilata sulla soglia. Uscì per l’ultima passeggiata in centro il farmacista a
Grybow. Fu accoltellato.
Strano, brutto tempo. “Ci siamo mossi per
cinque anni in un mondo di sguardi pieni
d’odio, di denti stretti, carichi di gesti e di
voci che svegliano l’orrore”, scriveva
Ryszard Kapuscinski. “La guerra continuava
dentro di noi”.
I lemki tornarono dunque ai casolari dalle
strisce colorate. Non li colpì né l’Olocausto
(dal greco:”il sacrificio totalmente bruciato”), né la Shoah (dall’ebraico:”Disgrazia”),
né il Porrajmos (nella lingua zigana:”Grande
divoratore”), né l’Holodomor (in ucraino:
”Morte pestilenziale per carestia”, ovvero
epidemia di fame, come se l’avesse portata
un’aria malsana, come se la fame si potesse
contrarre), né i Pogrom (dal
MoniKa Bulaj
Slovacchia perché vicina, e attaccando alle
scarpe gli zoccoli a rovescio portavano di
contrabbando sale e sigarette. Da Berlino,
perché li aveva rapiti come volontari (ma
non erano pure fratelli ruteni?) l’esercito
sovietico che incalzava verso Occidente in
una nuvola di polvere. Da Auschwitz, perché sopravvissuti.
Altri – gli ebrei – vennero fuori dalle soffitte
e dagli armadi. O dalle fosse, come Izrael
Aster di Rymanow, che per oltre un anno e
mezzo, nutrito dagli amici polacchi, se ne
stette sotto terra come una talpa, ripetendo
ogni mattina come un mantra, che poi di
sicuro il mondo sarebbe stato migliore. Poi
c’era Cracovia, spari, urla, la rabbia della
folla polacca, “Hanno ucciso un bimbo per
del pane azzimo”, “Che il sangue di Cristo
cada sulle loro teste”, solai, un treno, corpi
immobili degli amici ebrei allineati lungo i
binari – Izrael saltò, ci riuscì, cadde, scomparve. Uscì Maria Furher dal nascondiglio,
“la bella Maria dell’osteria di Grybow” dicevano gli habitué polacchi, “bella come la
Madonna”, dicevano i lemki, e così coraggiosa che non faceva entrare nel locale gli
LEMKI, COSÌ DIVERSI COSÌ COLPEVOLI
neve. Infine una volta lo zar Nicola I fu qui:
c’erano croci d’oro e incensi. Partirono oltre
centomila. Si chiamava “l’evacuazione nello
spirito di reciproci interessi polacco-sovietici
e nello spirito dell’idea di nazione uniforme”.
Nel Paese dei Soviet aprirono i vagoni, li
buttarono nelle steppe, con le mani scavavano delle buche per nascondersi dal freddo,
dell’erba facevano pane. “Quattordici famiglie tornavano dal Mar Nero, per quattro
mesi camminarono accanto ai carri trascinati
da cavalli e mucche, pagando le tangenti a
soldati, impiegati, doganieri, e alle imperversanti bande. Giunti nel nostro villaggio, la
milizia li ha acchiappati, derubati e così
com’erano buttati sui camion, cacciati senza
capre, mucche, vestiti, senza figli, come capitava, come bestie destinate a macello”. Agli
altri, sulla nuova frontiera polacco-ucraina,
piombavano i vagoni e li rimandavano da
dove erano venuti, anche nei lager, per la
fuga dal paradiso.
Quelli che tornavano dai lavori forzati, dalla
prigionia, da Berlino, dal contrabbando, trovavano il pane bruciato nel forno e la casa
MoniKa Bulaj
russo:”Distruzione”, “un colpo forte che si
ripete”). Non li distrussero, sebbene ferirono
terribilmente, la Prima e Seconda guerra
mondiale, né ciò che vi fu nel mezzo, non
era ancora giunto il momento. Non li colpirono i crimini in Volinia del 1942 e 1943,
questa volta compiuti ai polacchi dai suoi
vicini ucraini, né la sanguinosa vendetta dei
polacchi sugli ucraini della nuova frontiera
polacca stabilita nella conferenza di Yalta.
Non li toccarono i sogni di un’Ucraina libera, dalla Vistola al Don. I lemki avevano una
propria lingua, propri preti, proprie icone e
propri miti. La fine giunse dopo Hiroshima,
quando l’Europa provava ad imparare la
pace.
Nel 1945 a Bartno miserò un Madzik sulla
sedia del campo, uno di quei Madzik che
andavano dall’imperatore a Vienna a perorare la causa. Lo misero tra la folla dei vicini
per fare agitazione. Mormorò tra sé e sé
“Animella, esci da me” e gridò ai lemki che
nella Russia Sovietica c’era il paradiso. In
tutti i paesini dei lemki spiegavano, minacciavano, promettevano, mettevano sulle alte
tribune, cadevano volantini dal cielo come
MINORANZE
MoniKa Bulaj (2)
vuota derubata. Quelli che sono rimasti nelle
campagne perché si sono intestarditi, nascosti, sono stati cacciati due anni più tardi
verso le terre occidentali, questa volta senza
promesse ma sotto scorta armata.
Per i lemki da quel momento il tempo si
dividerà in prima e dopo il 1947.
Quell’alba di luglio del ’47 gli hanno lasciato
due ore per buttare sul carro tutti i loro
beni. I lemki prendevano pezzi di aratro, un
libro, una icona, o si sedevano sulla soglia, in
silenzio, come presi da qualche pazzia. Gli
rovesciavano i carri. Gli buttavano le donne
nei fiumi, “per una lavata delle puttane rutene”. Nel fiume Ropa galleggiavano le tavole
di tiglio con le icone della Madonna
Hodigitria, in greco: ”Quella che condurrà”.
Jaroslaw Trochanowski, futuro musicista,
aveva cinque anni e contava i cerchi di fumo
dalla macchina a vapore e raccontava al
padre tornato dal campo tedesco, che erano
le anime dei morti che li seguivano in fretta.
Quali? Quelle von-zu dall’armata imperiale
che aveva solo 17 anni e solo quella parola
come lancia con bandiera e in premio eterno
riposo? O le anime sterminate dai nazisti nei
boschi della famiglia del rabbino Ben Sijon
Halberstam di Bobowa, il quale aveva sposato con tanto rumore negli anni trenta la
figlia Hana con il talmudista di Tarnów, e gli
suonava una banda di ebrei travestiti da
ulani, cracoviani e montanari? Forse li seguiva l’anima di Amoz folle in dio, il prete ortodosso mancato, che si trascinava per i paesini
per predicare i sermoni in versi, e scomparve
un inverno Dio solo sa dove? I vagoni frenavano improvvisamente e le mucche fratturavano le gambe alle donne che le mungevano
tra sterco, fango e pioggia. Lo chiamavano
“lo stipamento dei ruteni”. A Jaworzno,
punto di comunicazione vicino ad
Auschwitz, comodo e controllato alla perfezione dai nazisti negli ultimi anni, selezionavano nei treni – contadini, preti, donne, adolescenti – per il lager. A Jaworzno, oltre il
filo elettrico, tenevano anche prigionieri i
criminali di guerra tedeschi “da loro tutto
era pulito, silenzioso, ordinato, nessuna cella
di punizione né kapò”, raccontava Paszko. I
tedeschi guardavano con meraviglia i ruteni
moribondi. Nel frattempo le famiglie dei
deportati proseguivano a ovest, 300 km in
due settimane. Nei carri bestiame nascevano
i bambini. Piotr Karlak di Kunkowa fu fortunato, venne al mondo nell’ospedale accanto
alla stazione. Le infermiere polacche volevano comprarlo, lusingavano i suoi occhi neri,
infilavano i soldi alla partoriente, spiegavano
alla madre ammutolita: “Tanto il vostro
popolo va allo sterminio”.
Gusci
“Era un crimine efferato”, mi disse Jerzy
Nowosielski, pittore di icone, scrittore e professore all’Accademia delle Belle Arti di
Cracovia, “inflitto senza ragioni, gratuito”.
Che cosa potevano opporvi? Avevano i gusci
delle uova infilati nello steccato e “acqua del
Giordano”, per la quale saltavano dal ponte
nel fiume congelato appena il prete ortodosso tirava via la croce dorata dal buco del
ghiaccio. Con l’acqua santa spruzzavano le
nuvole in arrivo perché non portassero dei
fulmini. Avevano le briciole del pane santo
di Pasqua che avvolgevano nell’asciugamano
bianco e mettevano tra gli zoccoli del cavallo,
così che sopra ci passasse la prima aratura
primaverile. Avevano dei canti.
Emilia Jakubiec, la fattucchiera che abita alla
fine della strada a Blechnarka, là dove finisce
la Polonia, contenta della visita, ammazza la
67
LEMKI, COSÌ DIVERSI COSÌ COLPEVOLI
gallina per il brodo e poi butta i carboni
ardenti contando da dieci alla rovescia.
Perché questo? Sorride timidamente. “Se
oggi la gente avesse le conoscenze di una
volta, come ce le ho io, con i malocchi avrebbero distrutto tutto il mondo!”
“Andavano dagli stregoni”, racconta
Jakubiec, e loro avevano la soluzione per
tutto. Potevano fare e disfare. Fare male e
opporvisi. Potevano erigere una diga contro
il male, prenderlo in giro, confonderlo, dirigerlo su un albero, su un fazzoletto o su un
cespuglio. “Facevano anche il male, ma non
così male come desiderava la gente”, racconta Michal Buriak di Polany, sulla soglia della
sua casa dalle strisce blu. Mettevano ordine
tra le anime perse e vaganti dei morti, perché i paesi ne erano pieni; di tanto in tanto
come in qualche orchestra straniera risuonavano con i campanelli tra i cespugli “una
musica così terribile, un così bel canto, come
ora su quelle diverse radio. Belle voci, prima
e seconda, cantavano con tutte le voci”.
Proprio quelle erano l’unico pericolo reale.
Si attaccavano ai vivi, intrecciavano pensieri
e sogni, portavano fuori strada. Come rimedio il padre “ordinò di bere un decotto di
codino di topo, ma solo il tronco, senza radici. O di mattola che cresce nelle paludi”, mi
dice la figlia di uno dei più famosi stregoni
ruteni dall’oltre frontiera, slovacco
Keckovec.
Esisteva pure il male impersonale, non
intenzionale, non voluto, celato nello sguardo, nei pensieri incontrollati, nell’improvviso
stupore o desiderio. Dietro ogni malattia dell’uomo o della mucca si celava qualche causa,
la quale si doveva trovare e nominare per
ricreare ordine. Ogni lemko sapeva: l’equilibrio tra l’uomo e la natura è terribilmente
fragile. Basta poco, niente, perché il mondo
va in rovina, nei paesini dove la gente e gli
animali abitano la stessa casupola separata
dalla fragile parete e terra battuta; i conigli
in inverno mordono le dita ai bambini e la
cosa più difficile è sopravvivere fino alla primavera.
Ponticello sul fiume
“L’ortodossia fu la prima al mondo, appena dopo Cristo o forse ancora prima di
Cristo”, dichiara all’alba Emilia, buttandomi
dentro la tazza con il latte pezzi di pane di
segale.
Le chiese dovevano stare vicino alle case,
68
allora ce n’erano a centinaia. Torrette esili,
campanili barocchi, elmi a punta, mezzelune
orientali e croci russe si affollavano, salivano
il cielo a gradi, come questi monti. Da nessuna parte costruivano così. Migliaia di tegole
di legno brillavano nella pioggia, scurivano
nella tempesta, come squame di un gigantesco pesce. Qui s’incontravano l’Occidente e
l’Oriente, il barocco attolico e i monasteri
della Bucovina. Le donne portavano nei
grembiuli le pietre dal fiume per le fondamenta. Gli uomini tagliavano gli alberi,
“facevano la colletta, vendevano l’ultima
mucca, ma la chiesa ci doveva essere”. Erano
strane chiese: da lontano sembravano schooner (velieri a tre alberi) o tre dervishi
roteanti in svolazzanti sottane e volà. Erano
attorniate dalle enormi querce che dovevano
attirare su di loro i fulmini.
“A est da Cracovia c’è un ponticello sul piccolo fiume che divide i due mondi, uno
occidentale, che vuole accompagnare e creare la storia e orientale che esprime il mistero”, scriveva Nowosielski, saggista e iconografo che dedicò tutta la vita per contagiare
MINORANZE
Mater Misericordiae, per i crocifissi dei
gesuiti, insostituibili per cacciare via dai
paesi i demoni. I “vecchi polacchi” (nelle
terre dei lemki abitavano da secoli insieme i
ruteni, i polacchi, gli ebrei, gli zingari)
ammiravano la liturgia orientale, si meravigliavano: “calano i sipari, scoprono ori, fumi,
canti, da voi è bello come al teatro”, dicevano.
I “nuovi polacchi”, quelli con cui lo Stato ha
deciso di ripopolare le scomode zone di frontiera affinché non ci fosse più nessun
Oriente, nessuna sorpresa etnica (degli ebrei
e zingari si è occupata “la scopa della storia”)
non si meravigliavano più di nulla, in una
hanno messo un toro e dopo è caduta da
sola. Ridipingevano Cristo sulle croci nei
bivi, ma solo fino alle ginocchia, sopra i piedi
attaccati separatamente per renderlo un po’
cattolico. Con difficoltà mettevano le radici
nella terra, dove l’orzo cresce a malapena e
le patate ruzzolano come pietre fino al torrente. Soltanto alcuni preti cattolici hanno
intuito che le chiese rutene sono un miracolo e che la direzione della liturgia latina dopo
la riforma si adatta perfettamente alle porte
MoniKa Bulaj (2)
i cattolici polacchi con il batterio dell’ortodossia. …
“Il barbaro non si accorge di questa frontiera”.
Dietro il ponticello, laddove il filioque sparisce dal Credo, i più pesanti fronti delle due
guerre mondiali del XX secolo hanno
distrutto appena qualche decina di chiese.
Dopo la Seconda guerra mondiale furono
distrutte dai polacchi a centinaia.
Prendevano fuoco facilmente, perché di
legno, una parte è caduta in rovina da sola.
Migliaia di icone dal valore inestimabile
viaggiavano nelle borse dei diplomatici verso
gli antiquari dell’Europa occidentale. Erano
strane icone, dipinte da maestri anonimi su
commissione, caso inconsueto, non di monaci o vescovi ma di montanari analfabeti
tagliati dal mondo. Avevano in sé non solo
Bisanzio, ma anche la dolcezza del Barocco
polacco: le dita della Madonna sostenevano
delicatamente l’orlo del vestito, le guance
rosate, i tratti dei volti degli apostoli ingrossati, il rossore contadino. Accanto ai santi
bizantini si troverà su di loro il posto per
sette spade nel cuore di Maria, per la Pietà
secondo Michelangelo, per la cattolicissima
LEMKI, COSÌ DIVERSI COSÌ COLPEVOLI
regali e che ufficiando la messa guardando i
fedeli, s’insegna ai fedeli di guardare l’iconostasi, talvolta – amarla.
Il villaggio Polany, dicembre 1988, mille
anni dopo il battesimo del santo principe
Vladimir nel Dniepr. Davanti alla monumentale chiesa ortodossa giace una bara
nella neve. Jan Galczyk è riuscito ad erigere
sotto la chiesa la croce del giubileo, e tre
mesi dopo è morto. La chiesa di San
Giovanni Crisostomo a Polany è vista da
lontano, costruita nello stile di Kiev, sulla
pianta del crocifisso greco, monumentale, di
pietra – doveva durare secoli. Fu l’orgoglio
dei lemki. Durante la guerra i cannoni russi
hanno rotto il tetto e per anni la riempivano
le piogge, come un pentolone. Jan Galczyk
aveva nove figli ma l’ho stesso ha chiesto il
credito, ha comprato le tegole e il zinco e di
tasca propria ha ristrutturato la chiesa. Ai
lavori ultimati, i cattolici non permiserò ai
lemki di entrarvi dentro, hanno rotto le serrature e hanno messo i loro catenacci, hanno
distrutto l’iconostasi, hanno sacrilegato il
sancto sanctorum, hanno picchiato il prete
ortodosso. I ruteni hanno pregato per 22
anni sotto lo steccato, e sotto lo steccato un
pugno di lemki ha celebrato la panachida,
una preghiera funeraria ortodossa per l’anima di Galczyk.
ridendo come un bambino, della chiesa, del
futuro Papa, come se fosse il migliore degli
scherzi. È una torrida estate del 1991, sta
sulla soglia, appoggiato alla falce, senza
camicia, racconta. Ha gli occhi azzurri come
gli occhi degli angeli nella chiesa che ha salvato. Deportato nei campi di lavoro dai nazisti, dal ’45 cominciò a fuggire senza tregua.
Dal fattore tedesco, dal campo di prigionia,
dalla prigione nazista, dai soldati dell’armata
rossa che gli miserò l’uniforme, gli ficcarono
l’arma nelle mani. A casa non trovò nessuno,
avevano deportato la famiglia nei kolkoz,
nell’Ucraina orientale. Li riuscì a raggiungere, ma dopo qualche giorno nel kolkoz
dovette scappare di nuovo, ora lo cercava il
KGB. Scappò fino in Polonia. Ma il villaggio
era vuoto, tutti i lemki deportati a ovest. “Là
in cambio nuvole, terra e cielo, le mani afferravano il vuoto”. Tornò, a dispetto di decreti,
pattuglie, rettate. Di notte cantava a squarciagola per non addormentarsi, perché solo
di notte poteva pascolare le pecore nel suo
campo.
I lemki tornavano, da soli o con le famiglie,
falsificarono i passaporti, corruppero impiegati, cambiarono le finali rutene dei cognomi
in polacche, prendevano residenze false.
Stefania Felenczkowa tornò cinque volte, con
cinque bambini: lavava i pannolini nel fiume
Ropa, li asciugava sulla pietra, la polizia la
cacciò via, si nascose alla stazione ferroviaria,
purché non la registrassero in occidente.
“Senza marito, perché l’uomo portavano
subito in prigione, e alle femmine cosa possono fare?” Guardava come le demolivano la
casa. Anche agli zingari, che erano scampati
allo Sterminio, non fu concesso di tornare
nelle montagne. In fin dei conti uno zingaro
è uno zingaro. Furono deportati insieme ai
lemki, come ai lemki gli hanno vietato il
ritorno con un decreto. “Eppure un giorno lo
dovranno capire”, dice Jan Paszko di Bartno,
della più lunga campagna lemka, che a poco a
poco si arrampica sulla valle, “che non si può
fare niente, affinché in un Paese tutti siano
uguali. Hanno gli aerei, hanno tutto e volano
non so dove, ma non hanno preso questa
proprietà, questa sfera terrestre, questa campagna celeste, non l’hanno presa e non la
prenderanno, benché siano così furbi”.
Tornavano
Nel paese di Owczary, in una piovosa
notte autunnale del ’49 due giovani turisti
con gli zaini vanno per il paese e chiedono di
poter pernottare. Nessuno risponde, sebbene
presso ogni colono polacco ci sia la luce accesa e si sentano delle voci. Szymon Wasylczak
invita degli sconosciuti per la notte, e l’ospitalità, come capita dai lemki, sarà regale.
Wasylczak è un lemko, che c’è l’ha fatta a
tornare, prova adesso a trasformare una stalla abbandonata in una casa. Mancano le finestre, le porte, il tetto è bucato, ma oltre a
questo si trova vicino alla chiesa e la si può
sorvegliare giorno e notte: “È proprio un
miracolo”. Il miracolo ha una splendida iconostasi barocca, che fa gola a molti. Gli ospiti
di Wasylczak sono preti; il più giovane scrive
il suo nome in ricordo sul quaderno del
lemko: “Karol Wojtyla”. “Ci fu un tuono, un
rimbombo, acqua come se venisse giù il
cielo, il fiume straripava ma ciononostante
Le finestre nere
nessuno gli ha aperto”, Szymon Wasylczak
Nikifor da Krynica, pittore-mendicante,
scrolla la cenere con un dito e racconta,
in cravatta, col cappello schiacciato e la cami70
MINORANZE
Quando i suoi quadretti comparvero per
l’ennesima volta nelle migliori gallerie di
Parigi, il governo polacco gli diede un cognome polacco, sebbene avesse il proprio nome
lemko. In compenso non gli diedero la croce
sulla tomba.
Ci rimane il suo mondo, immobile e vuoto,
infantile e innocente. I colori dei casolari
costruiti con i tronchi separati da fasce colorate di argilla, geometrie delle uova di
Pasqua. Marrone, rosso, verde, giallo, azzurro, quadretti, zig-zag, punti e linee.
MoniKa Bulaj
I leoni
A Bobowa, ai piedi della più alta montagna-cimitero dei Carpazi, il fiume Bianco
serpeggia e brilla nel sole. In cima, in mezzo
ai larici alti, sulle lapide ebraiche salvate, si
dimenano con fantasia con le code i leoni. “Il
leone è segno di grande forza”, mi spiega
Leja Haberman. È il marzo del 2007 e Leja è
venuta da Israele con la famiglia sulla tomba
di un tzadiq di Bobowa. Ai piedi ha delle ciacia indurita dallo sporco come l’acciaio,
batte e grosse calze infeltrite, in testa una
dipingeva da mattino a sera – in totale si
parrucca di capelli bianchi. Mi prega di ritrosono raccolte alcune decine di migliaia di
vare il suo atto di nascita negli uffici polacquadri e ognuno diverso – sul cartone, sulle chi. “Sono nata in Polonia nel ottobre del
scatole di cioccolatini, sulla carta da imbal1939, erano già entrati i tedeschi. So che non
laggio, nei moduli degli uffici austriaci,
dovrei, ma guarda, sono viva!” La madre di
polacchi, tedeschi, russi. Nei suoi quadretti
Leja durante la guerra si fece passare per la
puniva i colpevoli, elevava gli umiliati,
moglie di un ufficiale dell’Armata Nazionale
migliorava il mondo: al candelabro ebraico
ucciso dai russi. Delle contadine polacche in
aggiunse due braccia separate, di scorta, alzò un paesino non lontano da Jedwabny si prei tetti, ampliò i fasci di cupole nelle chiese, le sero cura con commozione della sottile bionprotese con ali di aquile onnivedenti, molti- dina con una bambina dagli occhi azzurri. Il
plicava le file di case, le girava di sbieco
nipote di Leja dagli occhi azzurri, boccoli
verso la luce, affinché brillassero del colore,
imponenti e pallido come carta, chassid
creò delle aiuole, boschi, giardini, arabeschi e come la nonna, come il bisnonno Moshe
nobilitava tutto con la sagoma di un persoHaim, come la bisnonna Gitle, salta vicino a
naggio ieratico: principe o ministro, vescovo noi di pietra in pietra, canticchiando a voce
o generale, dai re, zar, sovrani, imperatori,
alta in polacco: “Buongiorno signori, grazie,
santi. Anche lui si innalzò, salì nei cieli, lui,
scusi, salute, arrivederci, buon viaggio”.
figlio balbuziente di una donna di servizio
Leja accarezza con la mano le lapidi. I musi
divenne un Maestro, un amico personale di
dei leoni di Bobowa mi sono familiari.
San Nicola, con il dito alzato comandò l’ePaffuti come i volti degli angeli lemki. In
sercito di lettere e parole sparse nei quadret- fondo sono stati scolpiti da questa stessa areti.
naria. La forma del muso della bestia, come
Quando lo deportarono perché lemko, quindi l’espressione degli angeli ruteni, è nato sulle
spia, traditore del popolo polacco che spuvalli sull’argine dei Carpazi, poco sotto la
tando nei colori sul muretto dipingeva le
superficie terrestre.
mappe strategiche del confine per i nemici
della patria – ricoprì di vernice nera le finestre delle sue chiese ortodosse. Anche lui
tornò, tornò tre volte a piedi, fino al recinto
a Krynica, logoro da dove e come, chi lo sa.
71