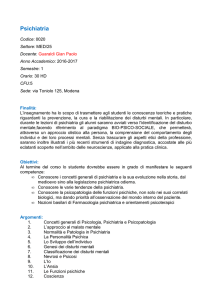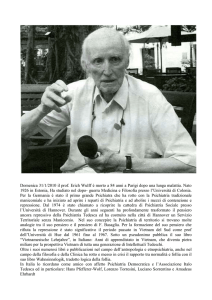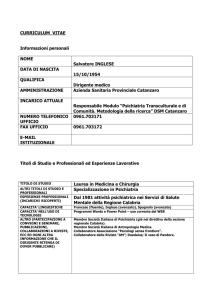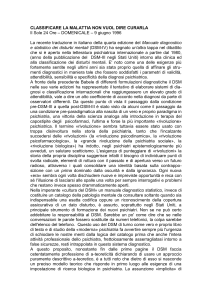L’ESPERIENZA LOMBARDA.
DAI TRENTACINQUE ANNI DELLA LEGGE 180 ALL’APPLICAZIONE
SUL CAMPO DEL MODELLO INTEGRATO A cura di Giuseppe Sabucco Le altre sezioni di questo numero della rivista sono in gran parte dedicate allo stato del
dialogo tra psicoanalisi e psichiatria, psichiatri e psicoanalisti. In questa sezione abbiamo chiesto un
aiuto per poter indagare quel rapporto più «in soggettiva». Si tratterà, cioè, del punto di vista di due
psichiatri non-psicoanalisti che hanno guardato e continuano a guardare alla psicoanalisi come un
interlocutore rilevante, pur non essendo psicodinamica la loro principale formazione di base; di uno
psicoanalista psichiatra che ricopre un ruolo apicale in un Dipartimento di salute mentale; di una
psichiatra che ha partecipato alla trasposizione operativa – sul campo, appunto – di un modello di
intervento pensato e insegnato da uno psicoanalista che alla psichiatria ha dedicato una straordinaria
attenzione. Il punto di vista indagato dalle interviste che seguono ha anche una collocazione nello
spazio e nel tempo. I colleghi intervistati appartengono tutti al sistema sanitario della Lombardia,
regione che alla psichiatria ha finora dedicato – soprattutto nei tre passati decenni – un buon livello
di attenzione, e la loro testimonianza copre l’arco di tempo che ha fatto seguito alla legge nazionale
numero 180 del 13 maggio 1978, la «legge 180» (alla quale verrà dedicata ampia attenzione nella
prima intervista).
Per quanto riguarda il vostro relatore, dirò che gli elementi di maggiore sorpresa nei colloqui,
pur in presenza di rilievi critici franchi e puntuali, sono stati da una parte il livello di stima e di
attesa verso la psicoanalisi che ancora permea la psichiatria non unilateralmente «biologica», da
un’altra parte la profondità dei cambiamenti che s’intravedono sull’orizzonte della psichiatria, dai
quali la psicoanalisi potrebbe rimanere assai sorpresa; dall’altra parte ancora la coerenza e la
profondità con cui un modello mutuato da concezioni psicoanalitiche si è potuto trasfondere nel
lavoro di équipe multiprofessionali, anche iconograficamente lontane dall’immagine consueta della
psicoanalisi – la stanza, il lettino, la privatezza. Le radici (anti-istituzionale e psicodinamica) della «legge 180»:
1
2
3
storia, relazioni, prospettive. Intervista con Arcadio Erlicher e Leo Nahon 1 All’intervista ha collaborato anche la collega Angela Gesuè, psicoanalista e membro ordinario della SPI, che fa parte
dell’équipe del Progetto A, struttura pubblica dedicata alla cura e alla ricerca sui problemi dell’adolescenza, di San
Donato Milanese, e che del relatore è la consorte.
2 Direttore del Dipartimento di Salute Mentale «Niguarda» di Milano.
3 Direttore della Struttura complessa «Psichiatria 3» di Niguarda, Milano.
1 Le due radici della legge su cui si fonda l’assistenza psichiatrica in Italia sono quella basagliana
(la liberazione del paziente dallo stigma e dal giogo istituzionale) e quella psicodinamica (la sua
liberazione dall’oggettivazione, soprattutto quella biologizzante di stampo medico-positivista).
Nell’ambito del tema che caratterizza questo numero della nostra rivista, il rapporto attuale tra
psicoanalisi e psichiatria, c’è da chiedersi che vicenda e che sviluppo hanno avuto queste due
matrici della legge. Che storia e che vicissitudini hanno avuto singolarmente e fra di loro? Quali
sono i problemi che affrontano attualmente? Che prospettive attendibili possono avere per il
futuro? La legge 180 compie nel 2013 i trentacinque anni d’età. Anche oggi, nonostante le adolescenze
protratte che caratterizzano la nostra epoca, questa è considerata l’età della piena maturità per gli
uomini e le donne di cultura occidentale. Per cominciare vi chiederei, immaginando che la legge
sia una persona, come direste che è cresciuta, e che persona è diventata. Erlicher – Per adattarmi al tipo di domanda, direi che é diventata adulta, nel senso che la fase di
crescita e d’incertezza, rispetto alla possibilità di una sua applicazione e di un suo estrinsecarsi in
una rete di servizi, sia passata. In fondo la legge 180 è molto «asciutta» rispetto alle indicazioni sul
tipo di articolazione di servizi prevista per il sistema sanitario psichiatrico pubblico. È cresciuta ed è
diventata adulta attraverso una serie successiva di provvedimenti e di scelte politico-amministrative
che hanno definito un quadro, una rete di servizi che l’hanno materializzata, dai quali è difficile
pensare ad un ritorno indietro in sé, ad una visione dell’assistenza psichiatrica più centralizzata, con
la riproposizione di strutture più autoritarie e più centrate sull’esclusione. C’è stato un periodo in
cui la polemica era centrata sulla possibilità di un ritorno indietro e di una cancellazione della legge,
ma, al di là di alcune iniziative che hanno più del folcloristico e che non intaccano la visione
generale, questo mi sembra che sia stato superato. La «180» è una legge che prendeva atto di un
mutamento di carattere politico-culturale del nostro Paese, che non era più confrontabile con quello
prebellico, con un assetto normativo, costituzionale, culturale e politico completamente diverso. In
questo senso, non vedo l’alternativa di un ritorno al passato. Quello che si è consolidato, è cresciuto
ed è diventato adulto è anche questa concezione «sanitarizzata» della malattia mentale – che ha
anche degli aspetti problematici, naturalmente –, con il tentativo di normalizzarla, di equipararla
all’interno della sanità. Di conseguenza la malattia mentale è una malattia come le altre, con le sue
specificità, ma comunque rientra in un contesto sanitario. Il valore della volontarietà del trattamento
si è sviluppato in tutto l’ambito sanitario, dove é valorizzata la capacità contrattuale del paziente,
l’esistenza di suoi propri diritti. Anche in psichiatria si sono sviluppati i movimenti associativi dei
malati e dei familiari come è avvenuto nelle altre discipline sanitarie. Si tratta di una crescita
culturale che ha riguardato tutta la nostra società verso i sistemi sanitari, di cui la psichiatria fa parte
a pieno titolo. Quello che invece mostra segni di usura, probabilmente, sono le realizzazioni concrete. Penso che il
modello organizzativo attuale debba essere rivisto, prendere atto di alcune criticità e del
cambiamento della domanda e dei fenomeni sociali. Il modello organizzativo é più fragile, invece,
più soggetto a necessità di cambiamento. Per la realizzazione di questo cambiamento si evidenziano
tutte quelle dinamiche che ci sono quando sono richiesti cambiamenti: resistenze, inerzie, conflitti
tra chi vuol cambiare e chi al cambiamento si oppone. 2 Tu separeresti quindi le difficoltà di tipo organizzativo dalle difficoltà di tipo ideologico-culturale.
Indietro non si torna. Erlicher – Direi più che ideologico, culturale. Forse negli anni del ‘78 e negli anni immediatamente
successivi era più ideologico lo scontro sulla «180». L’aspetto ideologico fa capolino quando vi
sono alcune polemiche e discussioni un po’ di retroguardia, provocate da iniziative che
apparentemente vogliono riproporre modelli del passato, ma che hanno carattere più di
provocazione che di sostanza. Mi riferisco ad esempio alla proposta di riforma della Legge
psichiatrica presentata in parlamento in questa fase finale di legislatura, la cosiddetta proposta di
legge Ciccioli, che sia per il momento della proposta, sia per i suoi contenuti, è di dubbia fattibilità.
L’iniziativa mi appare più un atto di propaganda di una parte politica piuttosto che la volontà di
introdurre concretamente proposte migliorative. Mi pare che per il successo di simili iniziative
manchi un terreno culturale e istituzionale che le possa sostenere. La «180» è cresciuta perché si è
consolidata la sua congruità con la temperie politico-culturale attuale, mentre i suoi modelli
organizzativi sono invece modelli che mostrano dei limiti a fronte di un profondo cambiamento che
c’è stato nella nostra società, che ha determinato un cambiamento anche nella domanda di salute e
nel modo in cui si esprime il disagio psichico e la malattia mentale. Nahon – Sono d’accordo con quello che dice Arcadio. Mi veniva da pensare alla «180» come a una
personalità multipla, oggi rispetto a quando è nata – con una carica sicuramente ideologica e, in
qualche modo, eversiva, di rottura sia della cultura che dell’organizzazione.
Quella psichiatrica era un’Italia organizzata in manicomi, la psichiatria italiana era soprattutto un
insieme di manicomi; a trentacinque anni di distanza è un’organizzazione in servizi molto più
territorializzati, molto più articolati, che sicuramente devono ancora prendere atto di un cambio
della domanda – e questo è un processo sempre lento. Tuttavia, oggi, la «180» alberga dentro di sé
qualunque psichiatria, anche quella più custodialistica. Nel senso che i servizi in Italia sono dentro
una cornice normativa che ormai la «180» non rappresenta più che tanto. La «180» norma il
4
trattamento sanitario obbligatorio e la perdurante assenza dell’ospedale psichiatrico «formale» .
Sulla costruzione dei servizi e su come gestire i servizi c’è un mosaicismo per cui se tu vai a Napoli
trovi un servizio psichiatrico ospedaliero di diagnosi e cura di un certo tipo, e se vai a Pavia c’è un
SPDC di un altro tipo. Come tale, comprensibilmente, una legge non può far funzionare le cose in
maniera completamente omologa dappertutto; restano diversi linguaggi pratici, diverse culture
specifiche eccetera. Oggi la «180» è un grande vestito indossabile da molti corpi, da molti modi di fare psichiatria.
Senz’altro, culturalmente, la «180», che all’inizio veniva identificata con Basaglia, ha perso questa
connotazione radicale, ed è stato bene, anche se una parte dei basagliani di allora la vedevano come
legge «arretrata», anche perché concretamente la «180» è stata una legge di mediazione tra parti
della psichiatria accademica molto forti, che hanno dovuto deglutire il boccone, e un movimento
che stava nascendo, ma che era minoritario. È stata un’importante operazione di mediazione.
4 Ricordo che, infatti, il «nome» amministrativo della legge era «Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e
obbligatori» – Nota del relatore.
3 Culturalmente, la «180» contiene tante culture psichiatriche. Tutto sommato facilita una coesistenza
tra diverse psichiatrie, può anche facilitarne il dialogo: resta la legge che fonda un ambiente
terapeutico pensato in un certo modo a livello di Paese – che è una cosa importante. In Paesi
civilissimi e progreditissimi dal punto di vista della riflessione scientifica, istituzionale o
psicoanalitica, come l’Inghilterra, se si va a vedere il Bedlam Hospital piuttosto che il Maudsley
Hospital (ora entrambi parte del South London and Maudsley NHS Foundation Trust, che è legato
all’Institute of Psychiatry), si vedono ospedali da cinquecento letti, col reparto aperto e col reparto
chiuso: ho visitato questi posti pochi anni fa e sono ancora come i migliori tra i manicomi che
avevamo anche noi, con i pazienti che escono dal reparto in orari programmati e che vanno al
laboratorio dove si fa l’ergoterapia o l’arteterapia con la creta; con pazienti che vengono tenuti sette
giorni chiusi e poi, se va bene, passano al reparto semiaperto, eccetera. Insomma, un modello
organizzativo da cui è difficile pensare che la riflessione psichiatrica possa sganciarsi, perché è vero
che spesso il contenitore determina il contenuto. Questo in Italia è interessante: ci sono una serie di
contenitori molto più aperti, ma che, pur essendo tali, tentano di avere anche la funzione di
contenimento. Non so se essendo cresciuta a trentacinque anni la legge 180 sia ancora fertile; in teoria lo speriamo.
Non so che tipo di sviluppi potrà ancora avere; credo che uno sviluppo importante sia di affrancarsi
un po’ dai vincoli legislativi. Le leggi sono importanti, però è ben curioso che la psichiatria sia
l’unica disciplina sanitaria che ha una sua legge o delle sue leggi – anche se in parte è
comprensibile, perché c’è il problema della restrizione della libertà. Forse ci sono altre discipline
mediche che hanno delle loro leggi (le leggi sulla tubercolosi, o sulle malattie infettive), però
storicamente la psichiatria ha sempre avuto leggi nazionali: in Italia nel 1904 e poi ancora nel 1968,
ma non solo. Anche negli Stati Uniti ci sono sempre stati dei Mental Health Act o delle Mental
Health Law. Questa è una caratteristica interessante: la psichiatria è una disciplina della medicina
che per ora ha sempre avuto una sua legge separata. Prendiamone atto e cerchiamo di capire che
cosa questo significa. Erlicher – Vorrei fare qualche osservazione sulla «personalità multipla della “180”», che è un
concetto interessante, però lo correlerei all’evoluzione che ha avuto la legislazione sanitaria nel
nostro Paese negli ultimi trent’anni. La «180» ha una sua modernità «strutturale», non di contenuto,
ma formale, perché è una legge cornice. Infatti norma le libertà individuali – e questo è inevitabile
che lo faccia lo Stato nazionale, credo – e la questione dei manicomi, fondamentalmente.
L’evoluzione della sanità nel suo insieme in Italia è stata quella di un forte decentramento regionale,
e quindi di una forte autonomia regionale nell’organizzazione del sistema sanitario, compreso
quello psichiatrico. Forse il fatto di avere una legge psichiatrica nazionale ha «omogeneizzato»
maggiormente la psichiatria rispetto ad altre discipline, che si sono più frantumate o
disomogeneizzate rispetto a un modello centralizzato. È stata dunque una protezione, la legge nazionale? Erlicher – Sì, ha garantito una certa coerenza, pur nella diversità delle organizzazioni, perché se si
va a vedere le organizzazioni regionali sono relativamente diverse tra loro. Credo che oggi ci
troviamo di fronte ad un fenomeno – non so se transitorio o costitutivo di un’inversione di tendenza
4 – per il quale le varie vicende del nostro Paese stanno spingendo verso un ritorno indietro rispetto
alle autonomie regionali, verso una maggiore centralizzazione della gestione pubblica, compresa
quella del sistema sanitario, per contrastare la corruzione diffusa, per riuscire a guidare il Paese in
dissesto economico verso lidi più tranquilli. L’idea e la politica che in questo momento tende a
prevalere è quella di un rafforzamento del centralismo nazionale, e quindi è possibile, anche se non
so quali saranno i prossimi provvedimenti sanitari che verranno assunti dal governo in carica, che ci
sia l’intenzione di promulgare una legge costituzionale di revisione del Titolo Quinto della
Costituzione, che a sua volta era stata la revisione costituzionale che aveva rafforzato le autonomie
regionali, in particolare in campo sanitario. Poiché abbiamo attraversato una fase politica di forte
decentramento regionale, anche la «180» nella sua applicazione periferica è diventata una sorta di
personalità multipla. Perché il contenuto della «180» era modesto nella sua estensione; era forte nei
principi poiché si occupava di questioni molto forti: la libertà (e, per converso, la coazione) della
cura per i malati di mente, e l’ospedale psichiatrico. Orientava verso la volontarietà della cura; però
poi non dava indicazioni di tipo pratico, salvo la limitazione al ricovero in ospedale psichiatrico.
Era una legge cornice. Ma anche la revisione apportata al Titolo Quinto della Costituzione riservava
allo Stato centrale la competenza solamente di leggi cornice in ambito sanitario. Il futuro potrebbe
prendere una piega diversa. È possibile che ci sia una tendenza ad una nuova centralizzazione delle
decisioni, compresi gli aspetti organizzativi. Forse questa «personalità multipla», con le sue
ricchezze ed i suoi limiti, sarà ridimensionata. Mi sembrano interessanti e centrali nel vostro discorso questi due concetti della «personalità
multipla della legge 180», e della necessità di contestualizzarla nella storia della legislazione
italiana. Tuttavia ho l’impressione che nel corso del tempo la «180» si sia anche ‘ammalata’, nel
senso che una delle sue concezioni portanti, quella della continuità che deve essere assicurata al
rapporto tra l’istituzione di cura ed il paziente psichiatrico – la continuità terapeutica – si sia
assai affievolita un po’in tutte le forme organizzative nelle quali la legge si è espressa. Per lo meno
qui in Lombardia, ci sono stati elementi di natura contabile (per esempio la scarsa valorizzazione
economica delle visite psichiatriche), ed alcune iniziative di natura organizzativa (l’estensione
dell’orario di apertura dei servizi ambulatoriali a parità di organico, anche su pressione di
organizzazioni dei familiari dei pazienti), che hanno reso frettolosi ed aritmici i colloqui fra
curante e curato. Se per far sì che il mio intervento resti economico, io psichiatra devo effettuare
mediamente una visita ogni quarto d’ora o giù di lì, e se per garantire un ambulatorio aperto dieci
o dodici ore al giorno ci dovrò stare quasi sempre come unico medico presente, così che le mie
visite raramente saranno al riparo dagli imprevisti che richiedano l’attenzione di un medico, temo
che la continuità terapeutica rimanga poco più che un flatus vocis. Soprattutto per le patologie
gravi, e per il tipo d’intervento che al riguardo insegnano le scuole di orientamento psicodinamico,
questo potrebbe essere un punto dolente. Nahon – Non credo che il paradigma della continuità sia messo più che tanto in questione Casomai,
una delle cose che si criticano è un eccesso di rigidità applicativa, e più che nella «180», nei modelli
organizzativi di servizi territoriali. Il fatto che il paziente sia vincolato a dover essere seguito
sempre dalla stessa équipe, che non abbia una possibilità di scelta – che invece gli statuti regionali
garantiscono al cittadino che deve farsi curare per una malattia non psichiatrica – ha una ragione
5 organizzativa, ha un suo senso: non puoi andare dall’altra parte della città a fare una visita
domiciliare, se il tuo paziente è così lontano. Così ha senso che ci sia un vincolo territoriale, perché
questo – che promana dalla «180» – dovrebbe potersi tradurre in un vincolo terapeutico di
affiliazione quantomeno allo stesso gruppo di curanti. Questo mi pare che sia abbastanza
salvaguardato. Invece, il problema del tempo di visita amministrativamente consentito è in effetti un
problema cogente. Erlicher – È anche vero, però, che ci sono delle istanze che, partendo dal diritto di scelta, che
peraltro è garantito costituzionalmente oltre che per gli statuti regionali, si sposano con una visione
che tende a valorizzare le specializzazioni, gli interventi specialistici su patologie particolari e
specifiche, che utilizza per giustificare e per validare questa visione i temi della valutazione degli
esiti, i temi di carattere epidemiologico, la rilevante crescita di peso della psichiatria biologica e
farmacologica. Nella formazione degli psichiatri della nostra generazione era quasi ovvio avere anche una
formazione di carattere psicodinamico di vario orientamento, mentre oggi non lo è per niente, nel
senso che questa scelta è esclusivamente personale, casuale e minoritaria, poco riconosciuta a
livello dell’organizzazione dei servizi. Quindi l’orientamento, la formazione che l’università dà in
generale è più orientata ad una psichiatria «biologica», in senso lato, che nel migliore dei casi offre
nel processo di formazione anche la possibilità di conoscere e sperimentare la psichiatria di
comunità, quella dei servizi pubblici di salute mentale. Non intendo qui evidenziare responsabilità
accademiche, che pure ci sono, ma piuttosto dell’area di competenza della disciplina psicoterapica e
psicanalitica in particolare che non ha saputo tenere il passo rispetto ad alcune domande ed
evoluzioni che ci sono state in ambito scientifico. Non si è sottoposto a critica la questione
dell’autoreferenzialità delle pratiche terapeutiche e dei suoi risultati, si è trascurato il tema della
ricerca delle prove d’efficacia. Né si è curato a sufficienza e per tempo questo filone di ricerca che
alcune scuole hanno invece perseguito, con la ricaduta di ottenere una certificazione quasi
monopolistica dell’efficacia del modello psicoterapeutico proposto. In realtà ciò è legato al fatto che
per prime hanno capito l’importanza di prove di efficacia, di studi di efficacia, e quindi hanno
potuto produrre degli studi più o meno convincenti di questo genere, cosa che invece altre scuole –
e la Società di psicoanalisi in particolare, con atteggiamento snobbistico – hanno evitato fino a
qualche tempo fa. Adesso mi pare che questo stia un po’ cambiando. In quello che dici mi sembra siano individuabili due possibili vie di critica, perché un conto è la
questione dell’efficacia e degli esiti, che effettivamente in campo psicoanalitico è particolarmente
complicata. Cito solo un esempio per intenderci. È vero che non ci sono molti studi sull’efficacia
dei trattamenti psicoanalitici – parlo della psicoanalisi nella sua metodologia classica –, ma
un’obiezione che ho visto avanzare da chi si è occupato di questa faccenda è che quando si va a
5
cercare un trattamento analitico di tipo canonico non è facile trovarlo , perché il metodo analitico
ha una struttura ideale, rispetto alla quale i trattamenti reali possono deviare parecchio. Perciò
5 Si veda per esempio la polemica tra Horst Kächele e Fred Bush nelle Psychoanalytic controversies, volume 91-1
dell’International Journal of Psycho-Analysis, 2010, in particolare a pagina 55.
6 non è così semplice definire cosa si va a verificare. Mi sembra diversa, invece, la critica rispetto
all’autoreferenzialità, poiché in tal caso il problema è la capacità di dialogo della psicoanalisi con
le altre discipline, è questa mi sembra meno legata alla difficoltà dell’oggetto e più legata ad un
errore di concezione che probabilmente è stato fatto. La psicoanalisi ha avuto a lungo un
atteggiamento molto problematico, per esempio, rispetto alle terapie farmacologiche. C’è stato un
6
periodo di tempo in cui erano francamente osteggiate, anche in situazioni gravi . Nahon – Questo è stato un primitivismo culturale per fortuna poco diffuso, e risalente a tanti anni
fa. Se qualcuno attaccasse ancora il trattamento dei disturbi psichiatrici maggiori perché vengono
utilizzati dei farmaci, o se sostenesse che «la vera terapia è quella della parola, e solo della parola»
si squalificherebbe da sé. Dato che parliamo di incontri tra psicoanalisti e psichiatri, devo dire che
non ho conosciuto psicoanalisti-psichiatri che osteggiassero le terapie farmacologiche. C’è stata e
c’è ancora purtroppo una semplificazione culturale; però vedere adesso il trattamento farmacologico
in antitesi col trattamento psicologico è peggio di un primitivismo culturale, è segno di scarsa
professionalità: la presunta purezza del metodo viene difesa mettendola in primo piano rispetto alle
esigenze cliniche del paziente. Questi atteggiamenti sono a volte diffusi tra gli psicologi, che non
conoscendo il razionale della psicofarmacologia ne negano l’utilità in generale. Chi lavora sul campo, per così dire, non lo ritrova più. Nahon – Nel cervello delle persone forse sì. Erlicher – Dici che sul piano teorico lo trovi ancora? Gesuè – Noi veniamo da una situazione in cui la figura di psichiatra-psicoanalista più diffusa era
quella abituata ad una integrazione degli interventi, e mi riferisco all’insegnamento della Clinica
universitaria di De Martis e Petrella, ma anche alla figura di Zapparoli. È per questo che sono stato assai sorpreso di avere trovato segni di ostracismo ai farmaci nella
letteratura psicoanalitica fino all’inizio degli anni ‘70, anche da parte di autori che per altri versi
ho molto amato. E rimane vero che il dialogo con le altre forme d’intervento psicologico, per
esempio quello sistemico di terapia della famiglia, non è stato molto praticato. Nahon – No, c’era un po’ di atteggiamento snobistico o addirittura esclusivista. Venendo all’oggi, il
problema è che noi tutti stiamo di fatto superando certi dualismi insensati del passato, come
psicogenesi/sociogenesi, oppure biogenesi/psicogenesi. Chi guarda le cose con serenità vede che le
neuroscienze in realtà stanno confermando sperimentalmente, scientificamente, alcune intuizioni
psicoanalitiche, o in generale psicodinamiche: guardate solo alle evidenze sul trauma, delle cui
conseguenze abbiamo i «vetrini», per così dire, con le immagini della tomografia ad emissione di
positroni; oppure all’esistenza di una mente inconscia, concetto che è ormai di dominio neuro 6 Alcuni esempi in questo senso si possono trovare, in questo stesso numero di Psiche, nell’articolo «Psicoanalisi e
patologia schizofrenica».
7 biologico, che va certamente modulato, ma che ha molti punti di contatto con le intuizioni
freudiane. In realtà, chi guarda con attenzione lo sviluppo del nostro sapere specifico vede che queste due
polarità si vanno incontrando. Quella che stava in mezzo, la psichiatria di comunità, che aveva una
sua autonomia, ma era radicata in entrambe queste discipline, tutt’oggi può accogliere contenuti
provenienti dalla psicoanalisi – o comunque da una visione dinamica della mente – così come delle
evidenze biologiche, farmacologiche, che ormai sono quasi incontrovertibili. Il rischio è che poi ci
siano dei riduzionismi culturali, terribili, che sembrano prevalere oggi in campo biologico, perché
tutto sommato la psicoanalisi ha avuto un processo di apertura culturale, di desiderio di nuovi
setting cui applicarsi, che è stato salutare e che ha in parte contagiato ed aiutato il mondo dei
servizi. Potrebbe essere un momento molto felice questo, e direi che «incontrarsi e dirsi addio» no, neanche
per idea. Adesso è proprio il momento di stringere il legame, che si possa fortificare l’incontro, e
scoprire radici sempre più comuni, anche se con linguaggi diversi. Il sapere sulla mente tende ad
essere complesso, composto, però possibilmente a unificarsi. Certo, ci sarà sempre chi, in maniera
riduttiva, dirà «è solo una malattia del cervello», come diceva Griesinger nell’‘800, o «è una
malattia dei neuroni», o dei neurotrasmettitori, come si rischia di dire oggi. Sono posizioni che
purtroppo esistono, che pesano per esempio nell’accaparramento di risorse, perché tutta la ricerca
farmacologica, enfatizzando unicamente l’aspetto biologico, attrae molte risorse. Però, che noi ci
occupiamo delle persone e non dei loro neuroni, o comunque ci occupiamo dei neuroni attraverso le
persone, questo mi sembra non solo che vada rivendicato, ma che nel sapere assodato degli
psichiatri già ci sia. Erlicher – Credo che chi ha avuto una formazione di tipo più biologico, attraverso questa
formazione oggi non può non cogliere le convergenze che ci sono tra una dimensione ed un
approccio di tipo psicodinamico e un approccio di tipo biologico, genetico. Tuttavia, se queste due
dimensioni mostrano da un lato delle convergenze, dall’altro le ricadute delle nuove conoscenze
genetiche nella pratica clinica sono insignificanti. Molta strada è ancora da compiere per tradurre in
applicazione clinica queste nuove conoscenze. I progressi in campo psicofarmacologico sono stati
modesti in relazione agli orizzonti che promettono le ricerche genetiche. I motivi sono molteplici:
dalla complessità intrinseca della materia, agli scarsi investimenti, ai relativamente modesti ritorni
economici che possono avere queste ricerche che non sono le più sponsorizzate. Per contro andiamo
verso una visione dei problemi psicopatologici estensiva. Le caratteristiche dimensionali del
prossimo DSM che esce sono tali che una delle critiche che cominciano a farsi a questo strumento è
proprio il rischio di estendere il concetto di malattia a gran parte della popolazione, a gran parte di
comportamenti e vissuti che fino ad ora non avevano valenza di patologia. Nahon – È il rischio della psichiatrizzazione, come si diceva una volta. Erlicher – I potenziali clienti dei trattamenti psichiatrici sembrano ampliarsi, il mercato si espande;
l’offerta non altrettanto, da nessun punto di vista. L’offerta rimane più o meno stabilizzata,
qualitativamente. 8 Ma il ‘mercato’ si espande realmente? C’è più gente che chiede l’aiuto dello psichiatra? Erlicher – Sì. Dai dati che noi abbiamo c’è più gente che chiede aiuto allo specialista per quei
disturbi così detti psichiatrici comuni, nell’area dell’ansia e della depressione non grave, che è
comunque una patologia importante, perché diffusa, invalidante e provoca sofferenze. Se vedi i dati
epidemiologici dei nostri servizi regionali degli ultimi anni, le classi di patologia in crescita sono
queste, mentre tutto il resto è stabile o in lieve decremento. C’è un lieve decremento della
schizofrenia a vantaggio del disturbo bipolare – una diagnosi che si fa di più di quanto si facesse
quando noi eravamo più giovani. Oppure del disturbo di personalità borderline, che si sostituisce
parzialmente a quella di schizofrenia. La schizofrenia declina, anche perché un certo tipo di
espressione patologica viene classificata in un altro modo. Però si tratta di un nucleo diagnostico
che rimane relativamente costante. Anche i disturbi di personalità, che nella quotidianità clinica dei
servizi pubblici di salute mentale sembrerebbero diffondersi e incrementarsi, dalle rilevazione
epidemiologiche risultano in realtà quantitativamente costanti. Pure, si tratta di una diagnosi molto
discutibile, a volte aleatoria. Quello che cresce, come domanda ai servizi, e quindi presumibilmente
7
come sofferenza della popolazione, sono i disturbi psichiatrici «comuni» . Nahon – Che vuole dire, secondo me, anche un aumento della capacità di riconoscere certi disturbi
da parte di nuove fasce della popolazione, e aumento della capacità di riconoscere i disturbi d’ansia
e dell’umore da parte dei medici di medicina generale. Tutto sommato, una certa diffusione di una
cultura psichiatrica appropriata, che porta nuove fasce di popolazione a cercare nuovi aiuti per
patologie che verosimilmente sono sempre esistite, ma sono state in passato meno riconosciute. C’è
una popolarizzazione, una democratizzazione di una richiesta di aiuto psichiatrico, che riguarda non
le patologie psicotiche maggiori e protratte, ma proprio le situazioni che partono dal disagio
esistenziale fino ai disturbi strutturati da ansia, ai disturbi depressivi conclamati, o ai disturbi
somatoformi, che cominciano a venire più individuati anche dai medici di base. Prima di prescrivere
cinquanta esami, mandano dallo psicologo – o dal neurologo, perché mandare dallo psichiatra fa
ancora paura. Ho l’impressione che, malgrado il rischio di atteggiamenti limitati a «protocolli &
linee guida» – perché tutta la Medicina, dovendosi pur giustamente basare sull’evidenza, rischia
ormai di ridursi a linee guida e protocolli –, si senta l’esigenza di salvare l’aspetto artistico della
Medicina. E credo che la psichiatria sia una delle discipline più «artistiche», nel senso che deve
usare la fantasia e non solo il dato protocollare e l’Evidence Based Medicine. Questa è molto
importante, ma non puoi restarci appiccicato. Il rischio è questo, ed è un rischio contro il quale
l’arricchimento culturale anche di derivazione psicodinamica è vitale per la psichiatria. La maggiore consapevolezza dell’esistenza di disturbi di tipo psichico (d’ansia, somatoformi
eccetera) coincide anche con un buon mantenimento, a livello di cultura generale del Paese, quale
manifestazione di una cultura diffusa nel Paese, della consapevolezza dell’esistenza di
un’interiorità, che gli esseri umani hanno un mondo interno? O non c’è una «meccanizzazione»
7 Ci si riferisce ai disturbi affettivi e d’ansia, che non si strutturano in una depressione grave, quali la distimia, gli
attacchi di panico, i disturbi dell’adattamento, i disturbi somatoformi; o i disturbi del comportamento alimentare, che
acquisiscono una notevole rilevanza.
9 anche di questo, nel senso che il disturbo morale, il disturbo psicologico viene invece pensato come
qualcosa che abbia una sua meccanica su cui bisogna intervenire, ma non coincide con
un’interiorità che ha i suoi problemi? Nahon – È una domanda che è quasi una risposta. Erlicher – Ci sono tutti e due gli aspetti, credo. Sarò un po’ semplicistico, ma mi viene da pensare
che nell’Africa centrale d’ipertensione e d’infarto ne muoiono pochi, l’Alzheimer non c’è, ed anche
di malattie oncologiche ce ne sono poche. Perché i problemi che hanno quelle popolazioni sono la
sopravvivenza, le malattie infettive, la mortalità perinatale e così via. Noi non abbiamo più quel tipo
di problemi, e quindi cresciamo in una condizione di relativo benessere, di relativa affluenza un po’
tutti, e da questo punto percepiamo questi stati di sofferenza che sono legati alle difficoltà, ai riti
relazionali, a tutto quello che è correlato alle relazioni interpersonali. Da un lato c’è probabilmente
una crescita culturale, una maggiore conoscenza dell’esistenza di questi fenomeni psicologici e,
quindi, una maggiore capacità di percezione del malessere esistenziale di cui ansia e depressione
rappresentano gli indicatori; dall’altro c’è una spinta del mercato e di una sotto-cultura che, invece,
un po’ mercantilizza, un po’ pubblicizza, un po’ banalizza questa componente della vita delle
persone. Ci sono un po’ entrambe le cose. Però è anche vero che c’è una maggiore consapevolezza
di questi problemi, che è legata ad aspetti anche culturali (il cinema, la letteratura ecc.), che è più a
portata delle persone. Si può dire, allora, che i pazienti sono più disponibili, più alla portata di pensare al loro malessere
in termini psicologici – come a un disturbo di un’interiorità magari poco conosciuta, magari poco
concettualizzata, ma in qualche modo intuita – di quanto non faccia un pensiero dominante,
attraverso una certa propaganda di tipo mercantile? Nahon – Questo sì. Il che non vuol dire che sia così diffusa la nozione di «mondo interno» e che sia
così alla portata di mano, perché è una nozione «difficile». Mi viene in mente che l’altra nozione di
mondo interno, che invece è assai popolare e che assomiglia in qualche modo, è quella del mondo
religioso, che in qualche modo rimanda a una coscienza interiore come dimensione autonoma
rispetto alla vita quotidiana, sociale, ed alla vita biologica. Quella è più nota perché c’è il
catechismo e perché c’è un appello a qualche cosa che hai dentro di te e che devi «curare». Non è
esattamente la stessa cosa di sapere postulare l’esistenza di un mondo interno in termini psichici,
che è una concezione avanzata. Fortunatamente, come diceva Arcadio, siamo aiutati dalla
letteratura, dal buon cinema. In questo c’è un progresso. Secondo me ci sono anche degli psichiatri che non hanno la nozione del mondo interno: questo è il
dramma. Alcuni nuovi psichiatri vengono addestrati a prescindere dall’esistenza di un mondo
interno, ma questo succede in tutto l’orbe terrestre. Questo probabilmente è anche legato a un
passato di autoreferenzialità di chi diceva: il mondo interno lo conosciamo noi, siamo noi che
abbiamo la topografia, ed è una topografia complicatissima, più complicata del mondo delle
molecole delle neuroscienze. Ne abbiamo il monopolio conoscitivo 10 Nahon – In certi scritti c’è stata una riflessione psicoanalitica quasi esoterica, e questo ha
allontanato dalla nozione di mondo interno come qualche cosa che riguardi la vita quotidiana delle
persone. Una domanda sul futuro. C’è l’organizzazione attuale dei servizi, e c’è la nuova domanda. Questo
cambiamento della domanda come può – e come dovrebbe – essere accolto dall’organizzazione?
Che problemi si possono porre, rispetto a quanto abbiamo detto finora? Erlicher – Mi riallaccio alla domanda precedente, che riguardava quale livello di consapevolezza le
persone hanno della presenza del mondo interno, in che modo percepiscono e vivono una sofferenza
e un disagio, che probabilmente era vissuto anche in passato, ma era altrimenti connotato, e
comunque non esitava in richieste d’aiuto di tipo sanitario, men che meno psichiatrico. Siamo di fronte, tutto sommato, a una popolazione che è cambiata, che è in evoluzione. Che
esprime la sofferenza in modi nuovi e con consapevolezze diverse da prima. All’interno di questa
tendenza generale ci sono poi dei target specifici: fasce di popolazione che hanno acquisito anche
una maggiore consapevolezza identitaria nel nostro modo di concepire i rapporti sociali. I giovani e
gli adolescenti sono una di queste. È una fascia – ed una fase della vita – che ha attirato l’attenzione
delle famiglie e degli operatori sanitari, e anche di altri apparati istituzionali, per cui è diventata una
popolazione che esprime una sofferenza, nei confronti della quale riteniamo in quanto psichiatri di
poter dare un apporto, un aiuto, di avere degli strumenti per aiutare, ma che non viene a farsi curare,
non viene ai servizi, e se ne sta lontana. Per tanti motivi, intrinseci, e anche connessi
all’organizzazione che hanno i servizi. È un’area di domanda potenziale, verso la quale dobbiamo
immaginare delle strategie per poter fornire quell’aiuto che siamo in grado di dare. C’è il problema
dei disturbi psichiatrici comuni, che interessano una parte ampia della popolazione. Una delle poche
indagini epidemiologiche che ci sono state in Italia è stata fatta qualche hanno fa’ fa vedere
l’aumento della prevalenza e dell’incidenza nella popolazione di questi disturbi. Poi c’è, in questo
momento, l’espressione psicopatologica condizionata dai fenomeni transculturali, connessa ai flussi
migratori. Una popolazione già ampia che sarà sempre più consistente, che esprime disturbi
psichiatrici consueti: le psicosi piuttosto che i disturbi affettivi gravi. E poi un elemento molto
diverso da quello che noi vedevamo, e in parte affrontavamo negli anni ‘70 – e di cui la psichiatria
«si era liberata» negli anni successivi con la delega totale ad altre professioni, ai servizi per le
tossicodipendenze – è quello appunto della dipendenza e dell’abuso da sostanze. Il consumo di
sostanze riguarda, da un lato, ancora una volta l’età adolescenziale, con rischi importanti che
interferiscono con lo sviluppo, e dall’altro in generale il comportamento d’abuso di alcol e di
sostanze che riguardano una popolazione adulta più ampia, tra cui le popolazioni immigrate.
Un’articolazione della psicopatologia su popolazioni che si sono andate un po’ trasformando
rispetto a vent’anni fa, nei confronti della quale i servizi devono ripensare l’approccio, l’intervento,
le competenze. Nahon – Una delle cose che la nuova organizzazione dei servizi psichiatrici, ma soprattutto una
mente organizzativa della psichiatria deve prendersi in carico è senz’altro questo nuovo esercito di
«dannati della terra», come diceva Fanon, dei consumatori di sostanze, che è una cosa che altera
11 tutto il quadro della psicopatologia, la innesca, la slatentizza e la rende stabile. una cosa spaventosa,
sia come numero, sia come intensità. L’altro grande problema dello studio della mente, del cervello e della mutazione sociale che ha a
che fare con il mutamento antropologico proprio della nostra società è il problema degli anziani, il
problema della demenza. Perché gli anziani dementi sono una popolazione che cresce più di ogni
altro segmento: i grandi anziani sono quelli che hanno un tasso di crescita relativo maggiore di
qualunque altro segmento cronologico di popolazione, come è sotto gli occhi di tutti. Queste
persone che stanno sempre di più in grandi ‘giacimenti’ (che si chiamino case di riposo, RSA
eccetera) sono le nuove popolazioni manicomiali. Sono persone messe in questi letti o in queste
seggiole davanti alla televisione, di cui – a proposito di oggettivazione – l’unica cosa che non si
riesce a smettere di fare è di oggettivarli. Bene che vada li lavi, li pulisci, non stanno più nell’urina e
nelle feci, però sono una popolazione di morti viventi, perché non è ancora diffusa l’idea che la
mente in spegnimento degli anziani, anche non dementi, anche quelli che hanno un un «mild
cognitive impairment», sia una mente di cui prendersi cura. Una dementia præcox tardiva …. Nahon – Esatto. È come se non ci fosse un linguaggio, una possibilità di rappresentazione, e questi
sono i nostri genitori, siamo noi tra un certo numero di anni… Certo, esiste la psicogeriatria, per
fortuna si comincia ad occuparsene, ma questo è un orizzonte che la psichiatria trascura. Erlicher – I servizi tendono a «difendersi» da queste persone, come dagli abusatori di sostanze, che
dovrebbero rivolgersi ad altri servizi, ad altre competenze. Nahon – Sono popolazioni che «non ci competono». L’umanità tende notoriamente ad avere degli
atteggiamenti emarginanti nei confronti di una parte di se stessa, e costantemente questo si
riproduce. Mi ricordo una volta, quando ero studente, nel reparto di Neurologia i neurologi che
dicevano: «Ah, ma questo è psichiatrico: via!». Adesso gli psichiatri dicono: «Ah, ma questo è
demente, ma questo è tossicodipendente: via!». È una catena: si cerca sempre qualcuno da
escludere, da lasciare per ultimo. Questo fatto – che ci sia sempre una fetta di umanità, ma anche
una fetta di mondo-interno-rappresentato-da-qualcuno che viene messo ai margini – è un processo
che rinasce sempre sotto i nostri occhi, e di cui la psichiatria anti-istituzionale, la psichiatria che
lottava perché i processi di esclusione e di emarginazione fossero limitati, si era accorta da tempo.
Però adesso cambiano i soggetti – anche se poi il malato psichiatrico non è trattato come un
fiorellino neanche oggi. C’è ancora una gran deriva sociale e antropologica che colpisce il paziente
psichiatrico grave. Però si spostano le popolazioni mandate alla deriva. La Sragione, per dirla alla Foucault, prende altre direzioni. La Ragione che domina un’epoca,
nella deriva della sua definizione, definisce necessariamente anche gli esclusi. Nahon – Esattamente. Ed è spaventoso che colpisca, nel caso degli anziani, i nostri padri e le nostre
madri, il che vuol dire noi in un domani non tanto lontano, perché con l’allungarsi della vita media
queste patologie si presenteranno sempre di più. 12 Erlicher – Mi viene in mente che uno dei grandi limiti attuali della psichiatria istituzionale – o di noi
psichiatri che la interpretiamo concretamente – è la perdita della dimensione anti-istituzionale. La
nostra generazione di psichiatri costituisce l’ultimi rappresentante di una consapevolezza antiistituzionale del nostro operare. Quando parlo di queste cose con i colleghi più giovani, anche
validissimi, non hanno questo tipo di sensibilità. Non hanno mai lavorato in manicomio, che è stato
un grande maestro. C’è la differenza tra chi ha lavorato in manicomio e chi non vi ha mai lavorato.
La psichiatria ha perso quella carica anti istituzionale, non abbiamo saputo riconoscere l’elemento
«istituzionale» post manicomiale nella rete dei servizi che abbiamo costruito. Quando mi capita di
fare lezione in università, a Milano, agli operatori della riabilitazione psichiatrica, utilizzo la
metafora della «rete» dei servizi, dove per «rete» si può intendere una struttura che sostiene e
supporta, ma anche una struttura che rinchiude, che avviluppa (la tela del ragno). Dobbiamo
lavorare in maniera dialettica su queste due polarità: attenzione a non avviluppare e rinchiudere,
usare la rete per sostenere. Con la difficoltà ulteriore che, per storia, normativa e per stato delle
cose, la psichiatria ha il compito del controllo e del contenimento sociale, che è dato dalle norme,
dalla consuetudine e dalla storia della disciplina, e che è dato probabilmente anche dai limiti della
disciplina in rapporto alla gravità posta dai problemi dei pazienti. Però, se riusciamo a mantenere
questa consapevolezza del nostro giocare tra queste due dimensioni del contenimento e del
controllo, e del sostegno, nel cercare di criticare in termini dialettici la dimensione istituzionale, che
comunque noi proponiamo e agiamo, credo che questo costituirebbe già una elemento rilevante. Ho
l’impressione che questo sia un elemento fortemente critico dell’attuale riforma psichiatrica,
dell’attuale contesto culturale e operativo della psichiatria post «180». Il pericolo che, non conosciuta, l’istituzione si riformi. Nahon – E anche nelle maniere più primitive e più grezze. E la fascia in cui è più possibile che si riformi, sono gli anziani. Nahon – Per gli anziani si è già riformata. Poi c’è questa grande «istituzione diffusa», fatta di
prigionieri autoimprigionatisi che sono i tossicodipendenti e gli abusatori di sostanze. Non ci sono
più tanti morti come ai tempi dell’«epidemia» di eroina, ma c’è un’altra forma di decimazione: la
cosa si cronicizza, e ci sono i consumatori di sostanze che cominciano a quindici anni e sono a
sessantacinque anni ancora attivi. Come la manicomiofilia di un tempo: i pazienti che volevano annidarsi dentro l’istituzione. Nahon – Esatto. Sono tossicofilici e tossicodipendenti autoincarcerati. Una cosa molto interessante
è che questa tendenza collima con una caratteristica della Medicina, che oggi tende a cronicizzare
tutto come modello di guarigione. Il cancro si guarisce? Sì, ma in molti casi perché va avanti per
quindici anni: un linfoma va avanti, sempre in cura. Però è un modello di guarigione completamente
diverso da quello passato della malattia infettiva che, per lisi o per crisi, finiva. Di HIV non si
muore quasi più: viene cronicizzato a vita. Questi sono processi molto interessanti; per fortuna che
13 ci sono e non si muore più; però creano nuove dipendenze, nuove istituzioni diffuse, e questa
appartenenza a vita alla cura. In qualche modo inciderà sul soggetto.
Gesuè – Forse è importante non solo l’appartenenza alla cura, ma a quale cura. Si può distinguere
tra una cura ed un internamento. In fondo, quella per i vecchi puliti, ma abbandonati, non è una
cura, mentre se con i mezzi a disposizione si riesce a fare vivere un affetto da HIV – ma direi anche
un paziente psichiatrico grave, che non «guarisce» neanche lui – nel miglior modo possibile, questa
è una cura. Nahon – Tuttavia i confini sono molto labili. Gesuè – Conserverei alla parola «cura» il valore buono del prendersi cura, anche al di fuori
dell’idea di guarire. Riprendendo l’adagio di un clinico dell’ ‘800, Freud diceva: io l’ho curato, dio
l’ha guarito. Credo che Basaglia intendesse la stessa cosa. Erlicher – Secondo me è utile anche porre attenzione a una certa semantica. Che so, la «gestione». È
diversa, può essere diversa dalla cura. Il problema è se ci prendiamo cura, o se facciamo gestione. Rebus bene gestis, i bambini si curano.
Ci si prende cura di un bambino. Poi lui cresce. Nahon – Tu intendi la «care» del «caregiver», colui che si prende cura del suo caro, oppure del suo
cliente, perché anche una badante può essere una magnifica persona che si «prende cura». Però
nello scenario di massa rischiamo di vedere rinascere un’istituzione che rende inanimate le persone,
che diventa gestione e puro contenimento, nel senso di tenere lì, confinare. E questa è una cosa che
molte articolazioni della nostra società tutto sommato non vedono di malocchio. Credo di poter illustrare i termini del problema con un esempio di famiglia. È stato necessario
affiancare a mia mamma, che è una temeraria ultra ottantenne, una badante che prevenga i
pericoli e che allerti noi figli se è il caso. Naturalmente, lei non sopporta la badante, perché è la
sua istituzione. È vero che la badante serve alla mamma, perché vigila letteralmente sulla sua
sopravvivenza, ma è anche vero che questo serve a noi figli perché ci solleva da compiti di
sorveglianza che richiederebbero di riorganizzare le nostre vite. Erlicher – In questo episodio c’è un «prendersi cura», che è quello della badante che si prende cura,
e c’è la tua «gestione» della situazione in maniera che, tutto sommato, va bene alla sua vita e a te. Nahon – Però è anche un prendersi cura procurare una badante alla madre! Ho proposto l’esempio perché mi sembra illustri bene la natura intrinsecamente ambigua della
situazione: io provvedo a fare in modo che, a te mamma, non capiti nulla di male, ma nello stesso
momento provvedo anche a riparare me dal crescere delle tue esigenze, a «confinarle». Fuori di
metafora, mi pare che occorra ripristinare uno sguardo allenato a distinguere i due piani del
discorso, perché c’è una naturale tendenza – se non stai attento, se non sei avvertito – a scivolare
14 dalla «cura» alla «gestione». In termini psicodinamici, occorre rimanere consapevoli
dell’ambivalenza che connota le relazioni di dipendenza come quella, peraltro più reciproca di
quanto non si creda, tra curante e curato. Gesuè – Visto che questo è un incontro con degli psichiatri sul tema «incontrarsi o dirsi addio»,
chiederei per finire quali elementi favoriscono l’incontro e quali elementi potrebbero preludere ad
un addio. Mi è sembrato di cogliere nel vostro discorso principalmente due elementi. Ci si incontra
se aumenta la ricerca sull’efficacia delle terapie psicodinamiche in senso esteso. L’altra cosa che
sembra molto importante è il linguaggio: i giovani non sanno che cos’è il mondo interno, voi
psicoanalisti potreste contribuire a trasmetterglielo, ma l’importante è che vi spieghiate e che la
smettiate di usare linguaggi esoterici. Nahon – Il discorso reciproco è quanto gli psichiatri devono fare per incontrarsi. Anche gli
psichiatri dovrebbero sapere andare incontro ad una forma d’ascolto che non sia la pura
registrazione sintomatica o la pura fenomenologia clinica. Credo che lo psichiatra debba chiedersi
che cosa succede nella testa della persona che ha di fronte, non solo in termini neuro-chimici, ma in
termini dinamici, in termini di pensiero, in termini di affetti, in termini di sensazioni e di sentimenti.
Se no, che psichiatra è? Questo non è affatto scontato che accada. Se lo psichiatra fa questo, allora
può fare meglio anche la parte di gestione comunitaria, che a volte è una «gestione», a volte è una
vera capacità di prendersi cura, e non solo, ma anche di organizzare la società perché si prenda cura
della propria parte più debole. Che poi è un elemento di civiltà. Una comunità che sa prendersi cura
della propria parte più debole – per esempio i propri malati psichiatrici – è una comunità più
evoluta, che può aiutare i suoi malati attraverso i suoi psichiatri con i suoi luoghi della cura e con un
sapere che sia il più ampio possibile. È un dovere in capo alla comunità psichiatrica quello di
accedere ad uno sguardo e ad un linguaggio dinamico. 15 INCONTRARSI O DIRSI ADDIO? INTERVISTA A MICHELE STUFLESSER 8
D. Seguendo il tema di questo numero di Psiche, «Incontrarsi o dirsi addio», nell’intervista ad
Arcadio Erlicher e Leo Nahon ho cercato di indagare la relazione tra psichiatria e psicoanalisi,
guardandola dal lato dello psichiatra. Tu, come membro ordinario (e con funzioni di training) della
nostra Società psicoanalitica, sei radicato nell’identità psicoanalitica come lo sei in quella di
dirigente di un importante Dipartimento della psichiatria lombarda, e dunque mi aspetto che ci
aiuti a vedere quella relazione con lo sguardo dello psicoanalista… R. … Allora comincerei dalla neo-istituzionalizzazione. Questo problema c’è. Se è vero che la
«legge 180» è stato il frutto di un movimento anti-istituzionale, inteso come anti-segregazione od
omologazione, il tema è: oggi come oggi, si può parlare ancora di fenomeni di neoistituzionalizzazione? Il tema lo ha tracciato un po’ Leo Nahon parlando degli anziani. D. Non solo degli anziani. Sia Nahon che Erlicher hanno discusso delle nuove forme di
istituzionalizzazione «sociale», in particolar modo le tossicomanie. Entrambi concordano di non
vedere il rischio di un ritorno dell’istituzione concreta, fatta di mura e di segregazione materiale
come l’avevamo conosciuta al tempo dei manicomi, poiché culturalmente non reggerebbe più. Però
segnalano nuove forme di segregazione, immateriali e diffuse, nei comportamenti, soprattutto da
dipendenza, nelle appartenenze migratorie eccetera. R. Secondo me c’è un’altra situazione, più subdola, che chiamerei di «turismo psichiatrico», il
wandering, dove certi pazienti passano da una comunità terapeutica all’altra rimanendo
sostanzialmente invariati sul piano psicopatologico, riproponendo spesso vecchi temi come quello
della dipendenza. La dipendenza dall’Istituzione spesso collude con le difese psicotiche del paziente
e talvolta della famiglia, può coincidere con un atteggiamento rassegnato degli operatori, arrivando
a spogliare il paziente della sua vita psichica, degli affetti, pensieri, desideri vissuti come fonte di
sofferenze. Uno dei problemi che non viene affrontato – in questo caso dalle Aziende sanitarie
locali, cui spetterebbe – è quello della verifica di come lavorano queste comunità, che sono quasi
tutte private. È qui che facilmente si annida questa sorta di «turismo» istituzionale, per cui queste
comunità diventano contenitori di emarginazione sociale, di disabilità psichica. D. Il fenomeno che stai descrivendo mi sembra diverso dall’idea, che Zapparoli proponeva invece
positivamente, di organizzare «circuiti della cura», dove i diversi passaggi individuassero i diversi
bisogni che può esprimere la condizione psicotica. R. È molto diverso. Io penso a quei pazienti gravi, cronici, che finiscono per girare continuamente
all’interno dello stesso circuito in maniera ripetitiva, che si tratti di un paziente «revolving door» o
di quelli che si chiamano «alti utilizzatori dei servizi». 8 Psicoanalista, membro Ordinario con funzioni di Training della SPI, psichiatra, Direttore del DSM dell’Azienda
Ospedaliera di Sesto san Giovanni, Milano.
16 D. Quello che caratterizza il fenomeno è l’assenza di progetto. R. Oltre all’assenza di un progetto, la ripetizione, la coazione a ripetere all’infinito. Sulla psichiatria volevo dire due cose. La prima è che un conto è parlare di psichiatria, dove
ognuno può avere un concetto in testa, un altro è parlare di salute mentale. Per esempio, il Piano per
la salute mentale della Regione Lombardia del 2004 ha introdotto dei cambiamenti notevoli, non
solo sul piano – ricordato nell’intervista ad Erlicher e Nahon – dei vincoli di bilancio, ma anche nel
modo di concepire la psichiatria, o per meglio dire la salute mentale. Insomma è stata una sorta di
«rivoluzione scientifico-culturale» che però non è nata dal basso, e che ha avuto ed ha tutt’ora
difficoltà e resistenze ad essere applicata nella sua interezza. Ricordo che, all’epoca, uno dei
funzionari regionali estensori del Progetto mi raccontò sconsolato che in una delle sue presentazioni
del piano a Bergamo aveva avuto la sensazione che non solo nessuno avesse capito nulla, ma che
non volesse capire. Una resistenza fortissima. E mi disse una cosa che allora mi aveva molto
colpito: che secondo lui chi aveva fatto un’analisi (lui era tra questi) si era dimostrato molto più
duttile e aperto. Mi aveva molto colpito perché io, che ho fatto fatica ad assimilare e a
metabolizzare quel progetto dentro di me, alla fine mi ci sono in qualche modo riconosciuto molto
più di alcuni collaboratori che anche oggi, a distanza di quasi dieci anni, fanno fatica a coglierne lo
spirito. Faccio un esempio: per cercare di introdurre un approccio terapeutico-riabilitativo che
tenesse cono dei differenti quadri clinici, a seconda della psicopatologia e dei bisogni espressi dal
paziente, il piano prevede differenti modalità di cura: la presa in carico – l’assunzione in cura – la
consulenza. Questo ha un suo senso nell’ambito del lavoro istituzionale; tenta non già di prendere in
carico chiunque, ma di valutare l’opportunità di un certo tipo di approccio piuttosto che un altro, a
seconda dei bisogni espressi, della psicopatologia, del contesto eccetera, introducendo procedure di
differenziazione. Tuttora non sempre viene applicato, per molte ragioni che non è il caso di
affrontare in questa sede. Parlare di Salute Mentale per come viene intesa la psichiatria di comunità
qui in Lombardia significa tenere conto anche dei nuovi protagonisti della scena psichiatrica: le
associazioni dei familiari, le cooperative profit e no-profit, i Comuni, i distretti delle Asl. eccetera,
cioè di tutta una serie di agenzie o, come si chiamano oggi, di stakeholders che hanno voce in
capitolo e con cui bisogna fare i conti. Ciò rende ancora più complessa e complicata la vita
istituzionale, proprio per questi intrecci, non solo di carattere clinico e psichico, ma anche
organizzativo, politico e istituzionale. D. Che hanno a che fare con il «campo»: nelle patologie gravi non ti puoi occupare solo del
paziente. Queste – le associazioni dei familiari eccetera – sono alcune delle forme in cui si declina
il campo terapeutico nei casi gravi. R. Però impongono allo psichiatra una disponibilità ed una visione della salute mentale più aperta e
flessibile, non autoreferenziale, come hanno già evidenziato Erlicher e Nahon. Una delle critiche
che viene fatta alla psicoanalisi (che continua comunque ad avere un grosso peso) è proprio questa:
di essersi in qualche modo ritirata sull’Aventino quando invece c’era bisogno di apportare anche un
contributo del pensiero psicoanalitico. E non solo del pensiero: una delle riflessioni che dovremmo
fare non riguarda solo l’efficienza e l’efficacia, ma proprio il fatto che ci siamo un po’ ritirati sul
17 piano dell’operatività quotidiana. Non solo a livello medico, ma anche a livello di attività
multiprofessionale. Questo è un vuoto che abbiamo lasciato, mentre penso, invece, che sul piano
classico-tradizionale, delle supervisioni, del comprendere e del capire, il nostro è tuttora un ambito
molto richiesto. Resta il fatto che siamo più carenti, rispetto ad altri modelli teorici, circa il «che
fare». La seconda cosa che intendevo dire è che la psichiatria, specie quella ospedaliera, è una branca del
sapere umanistico che si declina in termini più medici, ormai, mentre l’attività territoriale, intesa
anche come capacità di interagire con queste agenzie nuove cui ho accennato prima, fa già parte di
un aspetto molto più sociale. Esso è molto più legato al soggetto, ai suoi bisogni e ai bisogni della
famiglia, rispetto ad una psichiatria arroccata ormai sempre di più sugli aspetti medici, oggettivabili,
e assai meno legati al contesto. In questa seconda accezione la salute mentale comporta una
competenza che amplia lo spettro più squisitamente medico, che in questi ultimi anni si è sviluppato
in maniera straordinaria, anche attraverso le neuroscienze e l’utilizzo di nuovi farmaci, apportando
aspetti sicuramente positivi. Sono il primo a riconoscere che dare bene i farmaci è assolutamente
prezioso, specie al giorno d’oggi; però non basta. D. Senti che c’è una scissione tra i due livelli? Te lo chiedo perché nell’intervista ad Erlicher e
Nahon l’esigenza di intervenire su più piani sembrava più scontata, ed i due colleghi sembravano
meno preoccupati di una psichiatria neo-medicalizzata ed arroccata. Un po’ come se tu dicessi che,
per l’esperienza che hai, la psichiatria ha una deriva per la quale tende a tornare davvero allo
stadio dello specialista chiuso nello studio. R. Più che ad una scissione penso ad un privilegiare interventi più semplici, rapidi, meno
coinvolgenti e confinati in uno studio. Sul piano epidemilogico, se andiamo a vedere i numeri, gli
9
interventi prioritari nei reparti e nei Centri psico-sociali sono i colloqui psichiatrici individuali e gli
interventi psicofarmacologici. Potrei dirti anche il perché. Ho una mia opinione in proposito, legata
alla stanchezza, alla demotivazione, alla riduzione delle risorse, all’appiattimento, alla routine che
gli operatori psichiatrici attraversano, e penso abbia origini diverse ed articolate cui non è estraneo,
a mio parere, anche questo modello della «180», nella sua declinazione organizzativa. Sono
convinto che il modo con cui questo modello di unità operativa psichiatrica è stato immaginato
trentacinque anni fa’ sia obsoleto e probabilmente superato. Non regge più il confronto con le nuove
patologie, con le risorse limitate, con l’esigenza di un cambiamento notevole e complesso. D. L’usura del modello avrebbe creato una frattura tra il momento psichiatrico più medicalizzato
ed il momento più legato ai problemi psicologici, sociali ed assistenziali. R. Penso che vi abbia contribuito. C’è da dire che lavorare in una grande città come Milano è più
difficile e complesso che in una realtà limitrofa come quella in cui opero io (Sesto San Giovanni).
Non voglio dire che sia più facile, però è più semplice articolare gli interventi sociali, collaborare
con la altre agenzie territoriali, quando si tratta per esempio di casi complessi e multiproblematici,
9 È il nome che in Lombardia hanno le strutture ambulatoriali di salute mentale [Nota del relatore].
18 di pazienti anche violenti, antisociali, con o senza abuso di sostanze, dei cosiddetti «non responder»,
oppure di pazienti che non intendono assolutamente rivolgersi ai servizi. In questi casi, come dico
spesso, non rimanere soli all’interno del contesto attuale è fondamentale. Questo comporta
ovviamente un lungo e capillare lavoro di sensibilizzazione, collaborazione ed integrazione con le
principali agenzie che operano sul territorio nel campo della salute mentale. Allora è possibile
indire una riunione con le forze dell’ordine per parlare, come mi è successo e mi succede tuttora, di
quei quindici o venti casi «problematici», alti utilizzatori dei servizi, con gravi comportamenti
aggressivi, allo scopo di trovare una idonea condotta condivisa. Questo fa parte del lavoro
nell’ambito della salute mentale, quello che Erlicher e Nahon definiscono «psichiatria di comunità». D. La Community Care R. La Community Care. Dove secondo me uno dei passaggi importanti, che non è stato molto
assimilato, è la capacità dello psichiatra di uscire da una mentalità autoreferenziale – e questo non
vale solo per lo psichiatra-psicoanalista, ma anche per lo psichiatra «ortodosso» – ed essere capace
di dialogare con le varie istanze presenti. Faccio l’esempio delle Associazioni dei Familiari.
Ricordo quando i familiari invece di essere vissuti come possibili e potenziali collaboratori
venivano visti e sentiti in maniera persecutoria come elementi di disturbo: oggi come oggi sarebbe
assolutamente antiscientifico pensare una cosa del genere. Penso anche alla capacità di integrazione
dei Cps. con le cooperative profit e no-profit che lavorano sul territorio. Per esempio, a Sesto San
Giovanni abbiamo la Colce (cooperativa lotta contro l’emarginazione), che è una cooperativa
abbastanza nota e che si occupa di pazienti psichiatrici da tempo, e collabora insieme a noi da anni.
Dodici anni fa insieme al Comune abbiamo attivato un progetto di assistenza domiciliare da parte di
una équipe psicopedagogica per i casi più disperati, quelli che rifiutano le cure, non intendono
recarsi nei servizi, non assumono le terapie, oppure hanno una comorbilità internistica invalidante
eccetera. Forse è stato in tal senso uno dei primi progetti innovativi in Regione. Penso che ci sia uno
stacco tra la psichiatria intesa come disciplina medica – perché così è, introdotta com’è dentro gli
ospedali –, con tutta una serie di requisiti, procedure e regole che è tenuta a rispettare come facente
parte dell’istituzione ospedaliera, e una psichiatria come community care. Quando la psichiatria era
gestita dalla Provincia non esistevano queste finalità così squisitamente legate al contesto
ospedaliero; viveva secondo me il suo periodo migliore. Mentre oggi, tra gli altri aspetti che
condizionano lo psichiatra, c’è il gravame di una serie di incombenze burocratico-amministrative,
oltre che cliniche, talmente vaste ormai da condizionare quello che ho sempre considerato
l’elemento fondante, e cioè la relazione con i pazienti, sia in termini di tempo, sia in termini di
profondità, di capacità di ascolto, di individuazione di un setting appropriato. Anche io sono
dell’idea che questo potrebbe essere un momento buono per rimodulare i rapporti tra psichiatria e
psicoanalisi, perché siamo in una situazione di crisi enorme, non solo della psichiatria, ma anche
della Sanità in genere, delle risorse; quindi un momento anche per una ri-alfabetizzazione, una
riformulazione dei concetti, degli stili di buona prassi, che passi attraverso il recupero dell’abbiccì,
con l’ascolto, la relazione, il dare un senso alla sofferenza del paziente e alle nostre risposte.
Nell’intervista a Erlicher e Nahon mi sembrava che voi parlaste un po’ poco degli operatori, dello
psichiatra: ormai l’età media degli psichiatri è tra i 55 anni e su. La nostra generazione ha avuto un
numero elevato di psichiatri, e ora ci sono molte équipe che sono anziane, spesso affaticate e al
19 limite del burn-out, e non possono andare in pensione. D. Non ci sono abbastanza giovani? R. Se fai un concorso, hai difficoltà a trovare degli psichiatri, almeno in Lombardia. In altre regioni
non so. D. Ne sono stati formati pochi? R. Ne sono stati formati pochi in linea con i nuovi standard europei. Ormai da un po’ di tempo, da
quando è stato istituito il numero chiuso a Medicina, la legge nazionale ha recepito gli standard
europei. Credo che in Milano – intendendosi per Milano anche l’Università Bicocca di Monza – non
siano più di sette o otto i nuovi psichiatri che escono dalla scuola di specialità in un anno; al
massimo dieci. Immagina per tutta la Lombardia. Io stesso ho avuto problemi a trovare qualcuno
per i Progetti Innovativi finanziati dalla Regione. Quando bandisci un concorso di ruolo i giovani,
forse per la situazione di crisi, ora si presentano in maggior numero, ma qualche anno fa’ no.
I concorsi andavano deserti, e i giovani psichiatri preferivano un’attività più articolata, però privata.
Esercitavano un po’ privatamente, facevano delle consulenze eccetera, preferendo questo all’attività
istituzionale classica con le guardie e tutto il resto. Tanto è vero che si parla per il 2013 di libera
circolazione dei medici in Europa. Se vogliamo parlare di giovani, mi chiedo se la psichiatria non
sia diventata meno attraente per loro. Pensiamo solamente all’ambiguità del compito: da un lato
impegnarsi per un’esistenza piena del paziente e dall’altro fare i conti con il controllo della
devianza; pensiamo alla conflittualità dell’ identificarsi sia con l’aggressore, la società, che con
l’aggredito, il paziente. Non dimentichiamo anche quanto sei tenuto molto spesso a fare i conti
dentro di te con emozioni molto coinvolgenti, e a tratti travolgenti – il famoso burnt out. D. Quello del mandato sociale era un problema che avevamo anche noi, tuttavia. Il mandato
sociale da una parte e quello del confronto con le emozioni massicce. Però ai nostri tempi erano
persino elementi di attrazione, per certi versi. R. Erano altri tempi, e poi noi eravamo in analisi. Immagina invece oggi un giovane con maggiori
possibilità di scegliere: perché dovrebbe essere attratto da una disciplina che manca di riferimenti
scientifici, culturali, ideali, politici solidi e costanti? Una disciplina tra l’altro che è trattata in
maniera molto ambigua dai media, con un consenso sociale oscillante, perché da un lato lo
psichiatra ha un consenso collettivo e sociale ed è vissuto come figura benefica e salvatrice quando
svolge la sua funzione assistenziale e terapeutica, però contemporaneamente come figura oscura,
inquietante e un po’ persecutoria quando svolge la funzione più legata al «tenere pulite le strade»,
come diceva De Martis. Una funzione più normativa, penso ad esempio al trattamento sanitario
obbligatorio. Ho la sensazione che le vocazioni ci sono, ma sono ridotte. Se penso ai tempi della
nostra specialità, noi eravamo una quarantina, mentre oramai quando ti chiamano a fare lezione di
psichiatria ti trovi di fronte a cinque o sei specializzandi, non di più. E poi do una grande
responsabilità all’Università, che non prepara a sufficienza il giovane psichiatra a fare i conti con la
realtà che si troverà di fronte. Penso che l’università debba sì svolgere la sua funzione formatrice,
20 ma fornendo al giovane psichiatra elementi clinici e di funzionamento istituzionale, con cui poi farà
i conti nella realtà. D. Un problema sottolineato da Erlicher e Nahon nella loro intervista è che gli studi attuali
consentono che si diventi psichiatri senza necessariamente sapere che cos’è una psiche, senza
avere la nozione di «mondo interno». Ed è notevole che lo segnalino due colleghi che pure non
sono di prevalente formazione psicodinamica. R. Quante volte diciamo che una delle carenze più grosse che abbiamo nell’espandere il pensiero
psicoanalitico è che non abbiamo più psicoanalisti docenti in Università! Tranne l’eccezione di
Pavia, è proprio una rarità. Questo è un aspetto importante. D. Anche perché in quel tipo di insegnamento – universitario ma non solo: penso a Pavia, ma
penso anche alla scuola di Zapparoli – c’era una lezione opposta riguardo alla frattura che la
psichiatria, come la Medicina, mostra verso la dimensione sociale del proprio intervento, frattura
che tu prima hai segnalato. In quegli insegnamenti l’équipe era una, anche se era
multiprofessionale, ed il compito di «leggere» l’équipe era demandato a chi la dirigeva, agli
psichiatri di formazione psicodinamica, ma soprattutto era un compito collettivo. R. È un po’ diverso. Tu parli dell’équipe, ma io non sono di questa idea oggi, pur rimanendo un
solido sostenitore dell’équipe multiprofessionale psichiatrica così come insegnataci da De Martis,
Petrella, Zapparoli e Correale, per citare solo degli italiani. Penso che quel tipo di funzionamento di
équipe multiprofessionale lo si ha sì, ma solo in certi momenti della vita di una équipe psichiatrica e
con certi pazienti. Io parlavo in realtà di un campo anche più esteso. Tu ti fermi a degli operatori
che sempre nel campo strettamente psichiatrico lavorano; io parlo invece di un campo più ampio.
Quando dico che nella community care i protagonisti della scena psichiatrica ormai sono anche le
cooperative, le Associazioni, i Comuni eccetera, è perché quando tu, per esempio, hai un paziente
che ha bisogno del servizio sociale, devi interloquire con il Comune. Adesso ci sono i «tavoli della
salute mentale», più o meno bene frequentati, ma ai quali – faccio l’esempio di Sesto – siedono
funzionari dei Comuni, i medici di medicina generale, i rappresentanti delle cooperative sociali
profit e no-profit, le associazioni dei familiari, il volontariato e noi. Quello è un banco di prova per
imbastire dei progetti che in qualche modo attraversano tutti quanti: per esempio sono nati in questo
modo la «residenzialità leggera», piuttosto che gli inserimenti lavorativi, o altri progetti ancora, che
vedono come protagonisti della scena psichiatrica, della salute mentale, interlocutori sociali più
diversificati ed ampi. Tutto questo avviene nel solco della «salute mentale». Tu ti riferisci invece
all’équipe multidisciplinare, ma questo è un altro aspetto, che rimane un elemento molto importante
nella vita di un servizio psichiatrico, ma con una connotazione diversa. Sono convinto che oggi
l’équipe così come la intendiamo come gruppo coeso, coerente, «come un’orchestra che suona
all’unisono», si declini in questo modo solo in alcune situazioni. In altre può esservi una condizione
più fluida e flessibile dove, oltre al singolo operatore, può prevalere un transfert sufficientemente
buono sulla struttura istituzionale. D. L’evoluzione che delinei sarà dunque verso una estensione del campo, che non sarà più il campo
21 istituzionale, di un’istituzione psichiatrica qualunque essa sia, ma un campo sociale, dove i
fenomeni hanno una valenza che supera le possibilità del campo istituzionale e coinvolgono in
maniera così allargata da richiedere la creazione di un campo sociale. R. Credo che i casi paradigmatici siano i gravi Disturbi di personalità Borderline e Antisociale.
Sono quadri clinici che spesso presentano bisogni complessi e articolati, e richiedono il contributo
di una rete assistenziale non solo psichiatrica. Questi pazienti sono in costante aumento. I dati
epidemiologici sono chiari: c’è una diminuzione dei quadri psicotici schizofrenici ed un aumento,
oltre alle cosiddette patologie comuni (ansie, depressioni, disturbi dell’alimentazione eccetera), dei
disturbi di personalità con o senza abuso, dove l’abuso non è più quello classico, ma sempre di più
vediamo dipendenze come le ludopatie o il gioco d’azzardo. D. Erlicher e Nahon indicavano queste come le nuove forme di istituzionalizzazione, perché il
soggetto «si incarcera» nel comportamento patologico. R. Ah, questo sì! Ma tornerei ai disturbi di personalità. Ai tempi della nostra formazione medica si
diceva che «l’addome è la tomba del chirurgo»: io penso che il disturbo di personalità sia la
«pancia» nostra, perché finisce per tirare fuori dall’operatore psichiatrico tutto il peggio di sé – o il
meglio, a seconda –, soprattutto perché il paziente borderline è capace di farti vivere emozioni
molto intense, continuamente variabili e disturbanti. E anche perché, come nel caso dell’addome, è
caotico l’insieme di sintomi, sindromi, quadri morbosi che ne caratterizzano la diagnosi
differenziale. E tutti contemporanei, nello stesso momento, dalla ipervalutazione al rifiuto di ogni
attività o intervento, all’aggressività, alla seduttività, al farti sentire come un salvatore, salvo subito
dopo come carnefice, o addirittura come vittima. Sono convinto che, insieme a quello degli
adolescenti, questo sia un quadro clinico che lo psichiatra trova molte difficoltà a curare. Curare
queste persone con strumenti che si usano solitamente per i pazienti psicotici o bipolari non serve.
Ecco perché esse spesso appartengono a quei casi cosiddetti revolving door che frequentemente
transitano attraverso le varie strutture psichiatriche, quasi sempre rifiutando e/o interrompendo il
percorso terapeutico. Questo sarebbe un campo fruttuoso per la psicoanalisi, per la capacità del
pensiero psicoanalitico di creare una relazione con questi pazienti. 10
Parlando un po’ più di psicoanalisi, ho scritto nel dibattito spiweb
che tu puoi lavorare
psicoanaliticamente oggi in base anche al contesto in cui ti trovi, ma in base anche al livello di
potere che ricopri e quindi alla libertà decisionale ed operativa. Quando un’Istituzione
particolarmente complessa appare irrigidita difensivamente per i compiti estremamente numerosi di
carattere clinico, culturale, organizzativo, politico, e finisce per essere ingabbiata burocraticamente,
l’innovazione può passare attraverso iniziative di carattere pilota e sperimentale. Piccoli gruppi, che
possibilmente non siano strutturati, ma siano flessibili e aperti, con cui promuovere progetti
innovativi anche con un pensiero psicoanalitico forte. Sono quindi favorevole nel contesto attuale
alle «nicchie ecologiche», con l’idea che è da lì si possano contaminare anche altre aree. Nel mio
caso, ho costituito un gruppo di psicologia clinica che funziona bene, integrando varie figure
10 In Campoli G., Carnaroli F. (2012). Psicoanalisi e Servizi, quale incontro? Spiweb, pp. 53-56.
22 professionali e vari modelli teorici. E poi vi è la supervisione: ancora molto utile dove esiste un
humus, un contesto, un gruppo che condivida l’idea di fare una supervisione insieme. D. Quando dici che occorre che ci sia anche del potere effettivo per le figure di formazione
psicoanalitica in psichiatria, lo intendi allora esercitato in questi ambiti un po’ particolari delle
nicchie ecologiche? R. Anche. D. Forse è un po’ difficile proporre che i dirigenti di dipartimento siano psicoanalisti. R. Lo penso anch’io, non è un percorso né semplice né facile per uno psicoanalista. Credo che ci sia
comunque un modo individuale per declinare una funzione psicoanalitica. Io mi occupo delle
situazioni più gravi ed impegnative, e cerco di portare avanti una funzione di testimonianza rispetto
a quello in cui credo: la centralità della relazione, l’ascolto, il setting. Credo molto in questa
necessità di sporcarsi le mani: sono uno dei primari che fa ancora clinica, eccome, sia sul territorio
11
che in ospedale. Ho in mente un articolo di Schmuel Erlich del 2003 sull’area di frontiera e la
psicoanalisi – ma anche l’articolo molto bello di Winnicott sull’uso dell’oggetto -, dove Erlich dice
non solo di farsi usare, ma di «darsi in pasto» agli altri. Afferma che, come dice Freud, per
interiorizzare un oggetto devi anche permettere che questo oggetto venga attaccato e in certi casi
anche distrutto – «rimanendo vivo» (Winnicott). Nel forum su spiweb cui ho accennato è emersa
l’importanza di occuparsi psicoanaliticamente del contenitore istituzionale. È fondamentale; da
molti anni mi occupo delle dinamiche di équipe, della comunicazione tra settori ed aree diverse
dell’attività psichiatrica, dell’importanza di individuare quelle che sono le situazioni più
problematiche, più mortifere. Non ho mai avuto molti strumenti di incentivazione, oltre a quelli
formativi, di confronto e di stimolo ad una certa mobilità. Sono stato tra i primi a prevedere la
possibilità di una rotazione del personale, superando ostacoli di ogni tipo, ma riuscendo ad
utilizzare tale prassi, sempre molto pensata, condivisa e a piccoli passi, come possibile forma di rivitalizzazione dell’operatore e del servizio. D. Alludi alla rotazione del personale tra le varie strutture. R. Esatto. Ciò che si può perdere in continuità terapeutica, si riacquista in un nuovo clima in équipe.
Ho nell’Unità operativa di psichiatria che dirigo un’équipe molto orientata al sociale, a Sesto, l’ex
Stalingrado d’Italia, molto nutrita ed orientata positivamente ai fenomeni sociali, meno clinicomedica. Invece ho un altro Cps, più piccolo, che ha avuto per lungo tempo la supervisione di
Zapparoli, e ciò è palpabile e percepibile ancora a distanza di tanti anni, anche se magari sono
rimasti pochi operatori di quell’epoca. È un po’ come se si sedimentasse un clima, come dice
Chianese: «Il clima non è qualcosa di vago; è un insieme di atti, eventi e scelte e soprattutto è lo
11 Erlich S. (2003). Working at the frontier and the use of the analyst: Reflections on analytical survival. Int. J.
Psychoanal., 84, 235-247.
23 12
stile che anima questi atti, eventi e scelte» . Quindi non una cosa vuota, ma legata ad un modo di
porsi, di procedere, di mettersi in discussione e di mettere in discussione il proprio operato. Anche
se, paradossalmente, questa seconda è l’équipe che difensivamente ha avuto più difficoltà, ad
aprirsi, ad uscire dalle strette mura del Cps. per fare un’attività un po’ più legata all’unità operativa,
all’attività dipartimentale, tendendo a difendere un po’ troppo il proprio orticello. Ma la capacità di
ascolto, la capacità di immedesimarsi nel paziente, la capacità di seguirlo, è sicuramente valida. Ora
siamo alle prese con una nuova cultura della valutazione e della verifica che Regione Lombardia
fortemente sponsorizza. Sono stati proposti una serie di indicatori, ahimè molto organizzativiistituzionali (quanti pazienti, quante volte eccetera), però interessanti. La Regione è riuscita, grazie
alle banche dati utilizzate, a darci un quadro delle attività svolte nelle varie unità operative della
Lombardia. Sono riusciti, a fronte di cinquanta indicatori (che vanno da quante volte vedi il
paziente schizofrenico, a quando hai chiesto un elettrocardiogramma al paziente che è in cura con
atipici – questi sono gli indici clinici –, da quanti giorni ci metti a vedere un paziente che chiede la
prima visita, a quanti giorni – più o meno di quindici – da quando viene dimesso dall’ospedale), a
fornire un grafico attraverso il quale è possibile individuare quali sono le unità operative – tra le
sessantadue che credo siano nella Regione – che a seconda degli indicatori sono in un range
normale-accettabile, e quali meno. È interessante perché è possibile il confronto, quell’idea di
benchmarking che non si è mai sviluppata, che manca completamente. E che è molto difficile da
introdurre, perché alimenta sospetti ed interpretazioni di ogni genere. Noi psicoanalisti abbiamo una buona capacità di discussione clinica e di confronto, siamo gli esperti
della relazione. Questo mi consente di parlare un po’ della psicoanalisi. Sulla psicoanalisi sono
abbastanza ottimista. Pessimista fino a qualche tempo fa. Ottimista perché vedo che anche
l’istituzione psicoanalitica si sta movendo; penso però che dovrebbe avere il coraggio di uscire.
Mentre l’attività scientifica all’interno del nostro Centro Milanese di Psicoanalisi è ricca ed
articolata, è venuto il momento di studiare operativamente di fare un’esperienza all’esterno, nei
servizi. Peraltro vi sono una serie di colleghi, che si occupano già di pazienti adulti o di bambini e
adolescenti nelle istituzioni di cura gratuitamente, o a prezzi agevolati. Si tratterebbe solamente di
trasformare questo tipo di esperienza da privata, individuale e soggettiva, a istituzionale,
permettendo di fare un’esperienza pilota, sperimentale, in un tempo dato, per vedere quale tipo di
riflessione poter fare per poi restituire ai colleghi. D. Mi sembra anche che accarezzi l’idea di qualcuno che, uscendo dall’istituzione psicoanalitica,
assuma la responsabilità di qualche funzione dell’istituzione psichiatrica pubblica per vedere cosa
succede …. R. Esattamente. Ma anche solamente per conoscere. Ci sono già dei colleghi che lo fanno, a titolo
gratuito. Questi, se riconosciuti istituzionalmente dal Centro, potrebbero fornire una panoramica
della vita delle istituzioni psichiatriche. Questa scelta si legherebbe anche all’opportunità di una
maggiore partecipazione alla vita delle istituzioni psichiatriche di cura, fornendo idee e
suggerimenti. Come dicevo, penso che ormai l’organizzazione attuale della psichiatria sia obsoleta;
12 Da una comunicazione letta ad un Convegno sulla «legge 180» organizzato dalla SPI a Roma nel 2005.
24 si sta andando verso gli ospedali «ad intensità di cura». Auspico un’organizzazione, un dispositivo,
che potrebbe anche essere un dipartimento di salute mentale, il più ampio possibile, dove magari
davvero fossero rappresentate tutte le figure professionali, dallo psichiatra, allo psicologo, al
neurologo, allo psicoanalista eccetera, che visitano tutti i pazienti, dal bambino all’anziano,
attivando una funzione di ascolto – se vuoi di interpretazione, di valutazione – collegiale. Credo che
qui il pensiero psicoanalitico potrebbe dire molto. Il soggetto avrebbe oltretutto il vantaggio di
essere visitato in modo globale, complessivo e prospettico, che poi è lo spirito del nuovo DSM-V. Il
nuovo DSM-V sta per uscire molto in ritardo perché è stato molto contestato a tutti i livelli in
America, proprio perché eccessivamente psichiatrizzante, da un lato; però, dall’altro, proprio perché
dimensionale, recupera il valore clinico del terapeuta ed il valore globale del paziente. È ciò che noi
stessi attuiamo già quando, senza badare alla diagnosi, ci prendiamo cura della sofferenza di
qualsiasi persona. Accettiamo che all’interno di un quadro apparentemente nevrotico ci siano anche
delle componenti psicotiche, o viceversa. Non ci scandalizziamo che all’interno di una situazione
borderline ci siano anche delle condizioni depressive. Bene, la psichiatria, col nuovo DSM-V, sarà
dimensionale, quindi comporterà una sorta di rivoluzione diagnostico-terapeutica, avvalorata dalle
neuroscienze, dalle nuove tecniche di neuro-imaging (Pet eccetera), grazie alle quali in effetti si è
visto che la compromissione recettoriale è spesso sovrapponibile tra le varie forme cliniche.
L’aspetto culturale più interessante è che ciò recupera ed è in linea con il pensiero psicoanalitico.
Direi un ritorno al quadro clinico legato alla soggettività del paziente e alla sua vita, e un recupero
di una funzione clinica centrale del terapeuta. Si pensi solo a come cambierà lo stile farmacologico
e psicofarmacologico: non vi sarà più «questo è uno schizofrenico, tapum! Antipsicotico». Vedo in
questi aspetti la possibilità di una partecipazione della psicoanalisi che può portare un gran
contributo scientifico. Una critica: la cultura scientifica ormai si sviluppa in certe istituzioni, in certe società scientifiche,
che però hanno solidi e fortissimi agganci con la politica istituzionale. Noi siamo ormai, come
psicoanalisti, una società grande e forte, e non ci manca l’esperienza di cosa significa fare politica
istituzionale e insieme psicoanalisi. Ne abbiamo, secondo alcuni di noi, pure troppa: «ah, questo è
potere, non è psicoanalisi». Però che in qualche modo ci si debba attrezzare per dialogare con questi
ambiti, con questi contesti politici attraverso i quali si fa cultura, è a mio avviso ineludibile. Mi
viene in mente che uno degli obiettivi principali, che condivido moltissimo, da parte del nuovo
Esecutivo Nazionale è quello di creare dei poliambulatori psicoanalitici. Se si vuole fare una cosa
simile, questa scelta appare inevitabile. Sarebbe importante, per esempio, anche entrare
nell’organizzazione formativa della Regione. Questi sono territori che noi dobbiamo imparare a
coltivare e ad attraversare. Lo aveva fatto Zapparoli tramite consulenti che si erano formati con lui, come ricorda Barbara
Pinciara nell’intervista che anche lei mi ha rilasciato. Il modello di Zapparoli qui in Lombardia è
stato organizzativamente forte perché persone formate alla sua scuola sono poi diventate tecnici di
riferimento della Regione. Penso che anche a livello nazionale la SPI dovrebbe impegnarsi in questa direzione. Ripensare a una «politica verso la Politica» dell’istituzione psicoanalitica. 25 Assolutamente. E che in qualche modo giochi le sue carte anche nell’ambito dei luoghi dove si fa
cultura e nasce la possibilità di farla. Zapparoli aveva un modello; noi abbiamo dalla nostra un
pensiero di formazione. Pensiamo a tutte le strutture psichiatriche, ai gruppi di lavoro che ci sono:
come lavorano? Solo attraverso i cognitivisti? Noi dobbiamo dialogare con i cognitivisti – io lo
faccio, ormai il mercato degli psicologi offre prevalentemente cognitivisti – ma poi? Queste sono un po’ le osservazioni che faccio e che un domani sarà inevitabile prendere in
considerazione. Se si tratta di un «incontrarsi per dirsi addio», anch’io concordo di no. Questo è un
momento buono, secondo me. Mi sembra che evochi più la responsabilità che abbiamo noi: se ci dicessimo addio non sarebbe
tutta «colpa» degli altri. Ripeto: dobbiamo avere il coraggio di confrontarci, di lasciarci contagiare anche solo come
esperienza pilota, anche se questo provocherà grosse resistenze. È vero anche che la nostra
istituzione ha dimostrato notevoli elementi di cambiamento negli ultimi tempi. A tutti i livelli:
pensiamo all’emendamento per l’estensione delle analisi dei candidati ai membri Ordinari della SPI.
Secondo me è arrivato il momento di fare piccole esperienze pilota anche all’esterno nei servizi.
Insisto: frequentare i servizi psichiatrici non significa fare un’esperienza totalmente nuova. Vuol
dire riconoscere alle persone che lo fanno già, sia a livello materno-infantile, che a livello
adolescenziale, che a livello degli adulti, una connotazione istituzionale: non più Tizio o Caio che
lavora nel Cps. come supervisore, ma il Centro Milanese di Psicoanalisi che fa questa esperienza,
attraverso alcuni suoi soci che dopo qualche tempo, mettiamo un anno, riflettono su di essa per
capire se è stata utile oppure no. Questo permetterebbe di toccare con mano, di fare davvero
un’esperienza viva di quello che è la psichiatria oggi. Altrimenti il rischio è di farlo sempre un po’
in maniera mediata e tendenzialmente distante. Inoltre si tornerebbe ad avvicinare la psicoanalisi
alla psichiatria attuale dal di dentro, quindi recuperando una opportunità di pensiero non solo sul
rapporto tra psichiatria e psicoanalisi oggi, ma anche alle prospettive che abbiamo di fronte nel ripensare un modello di collaborazione reciproca di fronte alle nuove esigenze. La spending revue
farà il resto: quando va in pensione un primario, non lo sostituiranno. E come faranno? Un grande dipartimento, come fanno in altre specialità. La figura del primario è destinata a sparire.
Ecco perché bisogna in qualche modo esserci: è importante per recuperare quantomeno un sapere
pluralista, multiprofessionale, che sia in grado insieme agli psicoanalisti di elaborare un pensiero
condiviso. Non più «io vedo solo la laringe». L’intensità di cura non prevede questo. Questi nuovi
ospedali, basati su di un modello di organizzazione del lavoro che per prima ha adottato la Toyota e
poi si è diffuso anche nelle varie sanità in altri paesi, prevede di ottimizzare le risorse e di
razionalizzarle. Hanno ambiti molto ampi dove si dividono le persone a seconda del livello di
acuzie (acuto, subacuto e passibile di dimissione). Sarà un infermiere iperspecializzato a gestire
l’acuzie, chiamando successivamente lo specialista. Per dire, l’ortopedico non si troverà più a
lavorare in ortopedia, ma fianco a fianco ad altri chirurghi, otorino eccetera. Secondo me, avere uno
26 sguardo anche su questo, sulle possibili future forme organizzative della psichiatria è importante. Ci
permetterebbe di esserci, di capire, partecipare. Giovani candidati mi scrivono chiedendomi «Come
facciamo? Siamo disperati», perché avevano avuto dalle loro aziende sanitarie pubbliche un aut aut,
poiché la spending revue, la legge Balduzzi, ha introdotto un’ulteriore restrizione alla libera
professione intramœnia, per riportare i medici all’interno degli ospedali integralmente. Ciò non è
avvenuto in tutte le Regioni ed in tutte le Aziende ospedaliere, ma è prevedibile, se la SPI, se noi
non ci facciamo sentire, che la vita dello psichiatra-psicoanalista all’interno dell’istituzione pubblica
sarà sempre più difficile. 27 Il «modello integrato» in azione. Dialogo con Barbara Pinciara 13 Il 5 ottobre 2012, presso l’Istituto per lo studio e la ricerca sui disturbi psichici (ISeRDiP – Onlus)
di Milano, è stato presentato il libro Il Centro di Psicologia clinica, Giancarlo Zapparoli e la
saggezza clinica (Dialogos Edizioni, 2012). Gli autori, Clotilde Gislon e Giuseppe De Luca,
ricostruiscono la storia, i principi ed i metodi di questo organismo, che la Provincia di Milano ha
sostenuto per oltre mezzo secolo, e che ha avuto un influsso notevole sulla costruzione del sistema
integrato dei servizi e sulla formazione degli operatori nel campo della salute mentale, non solo in
Lombardia. Vorrei ripercorrere la storia di ciò che Zapparoli ha insegnato, di persona e attraverso i suoi
scritti, per una psichiatria assistita dalla psicoanalisi, ma guardando dalla particolare angolatura
di chi, come te, si è occupata dell’applicazione diretta e viva di quegli insegnamenti nella
quotidianità della clinica dei servizi psichiatrici della Regione Lombardia. Una prima notizia
interessante è che Zapparoli stesso aveva promosso delle iniziative in Regione …. Più che altro, erano stati alcuni suoi allievi che, divenuti primari, avevano diffuso il modello
dell’integrazione funzionale. Mi vengono in mente i nomi di colleghi quali Bertoglio, Cerati,
Cocchi, Guerrini, oltre a me, il compianto Lanzara, ed altri ancora. Inoltre, di recente si è avviata
un’iniziativa formativa presso tutti i Dipartimenti di salute mentale della Lombardia per diffondere,
attraverso l’idea del case management 14, un lavoro orientato in questo modo: l’utilizzo della
psicoanalisi modificata all’interno dell’istituzione. Attualmente chi promuove questa iniziativa? Sempre gli stessi allievi del Professore. Io faccio parte di questo gruppo e mi occupo delle ore
d’insegnamento sugli aspetti clinici. Zapparoli aveva lavorato anche con gli infermieri, così ora c’è
un responsabile del Comparto 15, che si occupa di tutto il lavoro d’insegnamento anche su questo
versante. Analoghe iniziative riguardavano il gruppo degli o delle assistenti sociali. C’erano quindi
13 Già dirigente di Dipartimento di salute mentale dell’Azienda ospedaliera di Lecco (LC) e docente presso l’ISeRDiP
e IREF (Istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica), ha partecipato in qualità di esperto
alla Commissione regionale della Lombardia per la stesura del Piano regionale di salute mentale, e ha rappresentato la
Regione in qualità di esperto al seminario presso il Ministero della salute per la stesura del Piano sanitario nazionale,
nella parte riguardante la Psichiatria.
14 Il case management è in sostanza l’assegnazione ad ogni paziente di un professionista (letteralmente: il «gestore del
caso») che sappia valutare i suoi bisogni, la pianificazione della terapia, l’implementazione dei servizi e la revisione
periodica dello stato di avanzamento della cura, garantendo all’assistito l’erogazione dei servizi nel miglior modo
possibile, sia dal punto di vista dell’efficacia sanitaria che da quello dell’ottimizzazione economica. Con i pazienti
psichiatrici gravi il ruolo assume una particolare responsabilità organizzativa, relazionale e di mediazione micro e
macro-sociale.
15 Si tratta del responsabile del così detto Servizio per il Comparto, che è l’organizzazione gerarchica che, nell’ambito
di un dipartimento di salute mentale, presiede a tutte le figure che sono educatori, educatrici, assistenti sociali,
infermiere ed infermieri, e che hanno una gerarchia separata. In pratica, l’amministrazione del personale non medico e
non psicologico.
28 diverse figure dedicate all’intera équipe psichiatrica, a procedere e trasmettere un metodo di lavoro
che tenesse conto delle strategie di derivazione psicoanalitica. Zapparoli valorizzava l’idea dell’analisi del controtransfert quale elemento fondamentale per
capire il paziente attraverso il meccanismo dell’ identificazione proiettiva. Il paziente ti fa
sperimentare emozioni che, se tu impari a leggere, poi ti permettono di restituire messaggi correttivi
profondi, che non si fermano all’analisi del comportamento. Con la sua consueta e semplice
terminologia, il Professore chiamava questo processo «analisi di noi stessi», e cercava di passarlo
anche ad operatori, che potevano essere gli infermieri, gli educatori, eccetera, che non erano
necessariamente stati analizzati, ma che imparavano a leggere i messaggi del paziente anche
attraverso un altro codice, quello della lettura delle emozioni. Ha introdotto quindi un lavoro
d’insegnamento a pioggia, un po’ su tutte le figure professionali. Nell’integrazione delle parti scisse
dei pazienti – che sono scissi per definizione nel caso degli schizofrenici o dei portatori di gravi
disturbi della personalità, inclusi nel cluster A e B del DSM – potevano essere utilizzate tecniche di
questo tipo. Il messaggio era proprio: portiamo la psicoanalisi – non quella sul lettino, ovviamente,
ma quella «senza divano» di Racamier – dentro i servizi dell’assistenza psichiatrica. È lo stesso
lavoro che avevano fatto Bouvet e Racamier in Francia, infatti Zapparoli cita spesso Racamier nei
suoi libri. I primi libri di Zapparoli 16 risentivano di più della sua cultura psicoanalitica, e per certi versi
erano meno utilizzabili nella pratica clinica quotidiana della Psichiatria; ma gli ultimi – che erano in
fondo l’esito di tutte le supervisioni e di tutti i suoi rapporti con pazienti molto gravi – erano facili a
leggersi anche per gli operatori. Per tutti gli operatori, perché Zapparoli lavorava anche sulla pari
dignità delle funzioni, cercava di rompere la gerarchia rigida – lo psichiatra onnipotente, che
capisce tutto e decide da solo, mentre tutti gli altri non possiederebbero un’originalità a livello
diagnostico, nel modo di porsi, nell’autonomia di ruolo professionale. Il messaggio di Zapparoli era
rivolto a tutti, e questo è stato secondo me un grande cambiamento. Ma in primo luogo c’era il
rispetto del paziente. Come saprai Zapparoli si esprimeva spesso per ‘spot’, e all’inizio aveva definito il paziente
come «il nostro datore di lavoro», perché se non ci fossero i malati non ci sarebbe neanche chi li
cura. In seguito l’ha definito «il nostro insegnante», e in questo caso il messaggio indicava che era il
materiale clinico portato dal paziente quello che avrebbe dovuto indirizzare il trattamento, non la
posizione onnipotente dell’operatore: sono io che capisco tutto, e quindi determino da solo il
trattamento. «So tutto perché ho già imparato come stanno le cose e come si devono condurre i giochi …» Sì. Zapparoli promuoveva un sapere esperienziale non predeterminato, ma in rapporto con il
paziente. La terza definizione, che ha cominciato ad usare negli ultimi suoi libri, è che i pazienti
sono «portatori di un’altra filosofia di vita», che a me pare un discorso molto poetico e che va
contro lo stigma. Per le dinamiche della loro mente gli psicotici sono diversi, l’intensità delle loro
16 Ci si riferisce qui a La psicoanalisi del delirio (1982, Milano, Bompiani) e a Paranoia e tradimento (1992, Torino,
Boringhieri).
29 emozioni è diversa, gli aspetti normativi ed il rispetto delle regole possono essere diversi; però essi
meritano il rispetto e l’ascolto che si deve ad una vera alterità. Zapparoli suggeriva anche il rispetto tra tutti gli operatori, con il concetto della pari dignità
delle funzioni: ad esempio, non sono più io psichiatra che dico all’assistente sociale «trova un
lavoro a questo paziente», come se l’assistente sociale fosse un o una trovarobe. L’operatore, con le
conoscenze derivanti dal suo ruolo professionale, farà in modo di arrivare ad una diagnosi sui
bisogni sociali irrisolti del paziente – che è un cittadino con gli stessi diritti degli altri, ma è
semplicemente meno capace di esprimere i propri bisogni in modo chiaro. Se un’assistente sociale,
che lavora in Comune, ha in genere di fronte un cittadino bisognoso cui dare soddisfazione, e
pertanto basta che sia competente nel proprio ruolo, l’assistente sociale in psichiatria deve avere
qualcosa in più. Occorre che abbia la stessa capacità relazionale degli altri membri dell’équipe, per
poter capire quello che Zapparoli chiamava lo «schizofrenese», la ‘lingua’ particolare che
caratterizza ogni psicotico. Occorre conoscere la sua lingua per condurre un paziente onnipotente ad
accettare la pensione d’invalidità: infatti, non posso dire che procurandogli la pensione gli metto
contemporaneamente l’etichetta di invalido, ma, ad esempio, poiché si tratta di un paziente che
potrebbe essere attento ad un risarcimento per la persecuzione che è convinto di subire, gli dovrò
veicolare l’aiuto attraverso il riconoscimento delle sofferenze legate alla persecuzione, e quindi, in
qualche modo, all’idea di poter essere risarcito. Poi ci sono anche i pazienti «irrisarcibili», come
diceva il Professore. Ma in ogni caso si deve sempre pensare ad un discorso che sia comprensibile
per il malato. Questa impostazione rende in qualche modo tutti i rapporti molto più simmetrici, perché
tende a ridimensionare le asimmetrie gerarchiche e di ruolo. Viene spontaneo chiedersi che cosa
possa tenere insieme l’organizzazione del lavoro, cosa possa fare in modo che queste pari dignità
non finiscano per entrare in un conflitto in cui ciascuno s’impadronisce del ‘governo’ del suo
pezzettino, frantumando l’insieme. Questa è un po’ la differenza tra la collaborazione, dove in una équipe che collabora ci
possono essere dei professionisti capaci nel loro ruolo professionale, ma c’è un’organizzazione ad
orticello, senza che si sviluppi comunicazione, e l’integrazione, che è invece un processo, dove il
minimo comun denominatore dovrebbe essere proprio lo sviluppo della capacità relazionale
dell’équipe. Occorre quindi tener conto del materiale che ciascun operatore porta e mette in comune
nella discussione del caso, perché tutti si possano integrare tra di loro – il che non vuole dire
disconoscere, per esempio, l’abilità di chi per esperienza e per capacità è più in grado di svolgere
questa funzione di integrazione. Tutti dovrebbero essere capaci di mettere in atto l’ ascolto
empatico, di utilizzare l’identificazione proiettiva come meccanismo, e quindi cogliere una
comunicazione elettiva con il paziente; poi – nel gioco delle proiezioni frazionate, che per
definizione è prodotto dal paziente scisso – ogni operatore viene investito di una parte, che a volte è
anche sintonica con il proprio modo di essere, nel senso che entrambi entrano in risonanza emotiva.
Se io leggo del materiale clinico in un modo e un collega lo legge in un altro, è solo mettendoli
insieme e lavorando insieme sul caso, che si riesce ad avere una visione più completa nella pari
dignità delle funzioni. Ma l’integrazione, come si è detto, è un processo, e certamente è un processo
difficile, perché le capacità integrative di un’équipe, che dipendono in parte dall’integrazione dei
30 singoli operatori, evolvono con il tempo, con il lavoro, con le supervisioni. In équipe si
sperimentano dinamiche molte primitive, sappiamo che nei gruppi emergono elementi più primitivi
di quanto accada nella terapia individuale. La mia domanda era in questo senso: nell’esperienza che hai tu, chi governava questa
integrazione? Il più capace. Per questo dico che gli psichiatri, che avevano tradizionalmente il potere, hanno
fatto molta fatica a ‘mollare’ il loro vantaggio di ruolo. Però, svolgere nel tempo un lavoro di
coesione, di promozione del rispetto per i colleghi e per il paziente, e di riconoscimento delle sue
parti espresse nel materiale clinico, ha permesso a chi per esperienza era più capace – ci sono anche
i talenti naturali – di trovare un suo spazio per essere ascoltato e per promuovere il processo
d’integrazione. In passato, per esempio, dal momento che lo psichiatra era di fatto l’unico ad avere
riconosciuta la responsabilità professionale – del resto a noi medici insegnavano a tenere conto
della responsabilità fin dal primo giorno del corso di laurea, mentre ai non medici faceva gioco
mettersi sotto l’ala protettrice del «tanto c’è lo psichiatra» -, c’erano delle équipe, in cui lo
psicologo era escluso dalle prime visite, mentre lo psicologo è comunque un laureato e, se ben
formato, è anche in grado di riconoscere, dove occorra, l’intervento dell’altro ed introdurlo. Certi
pazienti, se il servizio ha una flow chart di ingresso troppo rigida, non si riesce ad agganciarli: chi,
onnipotente com’è, convinto di essere perseguitato e non cosciente di malattia, va volentieri dallo
psichiatra? A che pro? È più facile che riconosca un malessere dovuto alla persecuzione e si
avvicini inizialmente allo psicologo. Sarà poi lo psicologo che, se valuterà come necessario
l’utilizzo di farmaci, veicolerà opportunamente l’intervento dello psichiatra. Tutto ciò comporta una
certa elasticità. Questo non vuol dire che non ci siano anche pazienti – gli «irrisarcibili», come si è detto – che
è necessario prendere e contenere perché altrimenti, non essendo idonei all’autoconservazione,
possono far del male a se stessi o agli altri. In tal caso, prima si procede con il contenimento
strutturale, anche ricorrendo se necessario ai Trattamenti Sanitari Obbligatori. Poi, però, è
opportuno procedere dal punto di vista psicologico. Per esempio, se un paziente abbandona la cura,
perché ideologicamente devo essere contraria a promuovere un TSO? Perché non avvertirlo prima
che se interromperà l’assunzione di farmaci o non si presenterà a fare l’iniezione periodica di
flufenazina, lo andrò a prendere? Allora il TSO ha un significato. È ben diversa l’evoluzione se il
paziente abbandona, si ripresenta in toto la patologia, il malessere, le anomalie del comportamento e
tutti i guai possibili ed immaginabili, e solo allora mi sento in dovere di andarlo a riprendere. In
questo caso c’è solo una sorta di tela di Penelope, fai e disfi senza dare dei limiti. Noi psichiatri, e forse anche gli psicoanalisti, abbiamo fatto un po’ l’errore negli anni passati
di cogliere elettivamente l’aspetto patologico della psicosi nell’anomalia della gestione delle
emozioni, del vivere le emozioni. Abbiamo trascurato l’assenza degli aspetti normativi ed i
problemi della relazione con il suo rappresentante, il padre, che può essere «schizofrenogeno»
quanto la madre, può essere assente o «forcluso», come ha evidenziato Lacan. È fondamentale
lavorare sulle emozioni, ma lo è altrettanto lavorare sugli aspetti normativi delle regole, altrimenti il
paziente non impara ad accettare il limite, se non viene contenuto. Promuovere un TSO all’interno
di un progetto, di un programma, in un’ipotesi di lavoro, ha un senso; farlo perché non c’è chiarezza
31 e si aspetta che il paziente incorra in una ricaduta, non ce l’ha. Il messaggio necessario è che ti allei
con il paziente anche sul contenimento, perché l’essere contenuto è un suo bisogno ed una
necessità. L’importante – si diceva nel testo, scritto dagli infermieri per gli infermieri, intitolato
L’infermiere psichiatrico 17 – è di non usare la violenza contro la violenza. Il contenimento non è
violenza, è sostegno. Un altro aspetto importante è il così detto «diritto a delirare», un elemento fondante della
cosmogonia Zapparoliana: solo il paziente che sta meglio, che ha un Io un po’ più stenico, può
abbandonare difese molto primitive per assumerne di più funzionali. Altrimenti, se per esempio si
forzano le cose con una eccessiva terapia neurolettica, non solo viene meno l’alleanza, ma si lascia
il paziente come un «re nudo», senza le sue difese, e lo si può indurre a sperimentare quei momenti
tragici di lucidità, propri dello schizofrenico, nel corso dei quali il rischio suicidario, con la
percezione della sua condizione di impotenza, diventa maggiore. Questo Zapparoli intendeva
quando in uno dei suoi aforismi prestava al paziente il lamento di Augusto, «Varo, ridammi le mie
legioni!». Rappresentava bene la delusione catastrofica, insieme alla grandeur imperiale. Rappresentava anche il «mi hai lasciato scoperto, senza le difese». Interpretare il sintomo
come una difesa non vuole dire – come pensano i detrattori del modello – «Beh, allora lasciamo i
pazienti come sono». Facciamo in modo che sia il paziente, più sicuro nel suo benessere, a lasciare
difese così primitive, per assumerne di più funzionali. Noi lo accompagniamo semplicemente in
questo percorso sempre un passo indietro, non lo spingiamo in quello che per il paziente è il baratro,
il pericolo, l’angoscia della frammentazione. Alla fine il delirio serve a tenere in piedi l’onnipotenza
megalomanica, perché se il paziente di colpo viene in contatto con l’impotenza di una vita di
solitudine, di fallimento eccetera, la finestra è a un passo. Allora è meglio pensare di essere Gesù
Cristo sceso dalla croce, che un poveretto che nella vita ha combinato poco più di nulla. Basti
pensare all’apparente assurdità del contenuto del delirio della vecchietta che si sente perseguitata
dalla Mafia. Anche nella sofferenza c’è onnipotenza: nella persecuzione, infatti, sono comunque
oggetto d’interesse, altrimenti sarei una vecchietta sola e di certo, senza la stampella costituita dal
delirio, incapace di far fronte alla vita. Il rispetto delle difese è perciò un altro dei capisaldi della
teoria Zapparoliana: non c’è più solamente il DSM-IV-TR con la diagnosi articolata in sei assi – che
è necessario, nessuno intende negarlo –, ma si procede anche a una diagnosi di fusionalità, a
valutare l’intensità della simbiosi, se questa è generalizzata, ambivalente o focale. Affrontando
questo aspetto tratto anche gli oggetti di simbiosi, cioè i familiari: perché non possono essere più
utilizzati, ad esempio perché sono ormai troppo vecchi e devono essere preparati all’«esecuzione
testamentaria» – altro spot zapparoliano -, cioè a lasciare in cura il figlio malato all’équipe che, non
essendo mortale, svolge una funzione per sempre. Devo poi procedere con la diagnosi di funzionalità, capire come funziona quel paziente, che
bisogni specifici ha, che deficit relazionali ha. Se non faccio tutto questo, il signor Mario Rossi,
schizofrenico, diventa uguale al signor Giovanni Bianchi, schizofrenico; ma l’originalità
17 Gnocchi et al., Bollati Boringhieri, 1991.
32 dell’individuo, e come proporgli un trattamento personalizzato, necessariamente si perde. È l’individualità che viene omogeneizzata. Sì. Però, entrare in una relazione più profonda fa anche molta paura. Bisogna che l’équipe sia
addestrata, perché poi diventi un punto di riferimento. Zapparoli diceva: quando si diventa, da
spettatore ad attore del delirio, e si diventa l’oggetto di persecuzione, è molto gravoso. Se non c’è
circolazione di comunicazioni, di intenti, di pensieri – la condivisione nell’integrazione appunto -,
l’operatore si sente isolato di fronte alla psicosi ed alla paura di entrare in contatto più stretto con il
paziente schizofrenico, sentendosi quello che teme di aver pescato la donna di picche. Ci sono due cose, in quello che stai dicendo, che sono per me di particolare interesse. La
prima. Mi sembra di capire, a questo punto, che la responsabilità di chi dovrà indirizzare il ‘gioco’
nella direzione giusta è quella di curare bene che circolino le informazioni nell’équipe, e curare in
qualche modo che venga mantenuto l’atteggiamento rispettoso verso pazienti e colleghi di cui hai
parlato sopra. In qualche modo, delinei una figura d’autorità, non nel senso di detentore di
maggior potere, ma di autorevolezza, che lo renda garante che il processo evolva bene. Nella tua
esperienza, nelle situazioni di fatto che tu hai incontrato sul lavoro, chi l’ha potuta rivestire? Chi ha meglio assorbito il modello sono stati i primari, che hanno accettato di svolgere anche
la funzione di professional. Io credo – senza compiacimento narcisistico, ma ne sono abbastanza
convinta – che quelli come me, che hanno lavorato con il modello, si sono prestati volentieri a
svolgere questa funzione parziale dell’oggetto onnipotente, soprattutto all’inizio della relazione con
lo schizofrenico, che richiede di impersonare questa parte. Anche se adesso siamo invasi, purtroppo,
da esigenze di natura organizzativa, burocratica, dagli aspetti pur importantissimi del controllo della
«qualità», si dovrebbe comunque essere messi in grado di salvaguardare questa funzione di punto di
riferimento clinico. Per esempio, un genitore onnipotente, che è necessario prendere come coterapeuta perché altrimenti, se escluso, boicotterebbe qualunque intervento, deve potersi confrontare
– anch’egli angosciato dai vissuti della sottostante impotenza -, con un’altra figura «onnipotente». Il
primario dovrebbe poter impersonare questa parte, potendosi ritagliare degli spazi clinici e
professionali. Nel gioco psicodinamico delle proiezioni frazionate, il paziente può così disporre di diverse
alternative. Entra in contatto con l’oggetto onnipotente, ma anche con l’oggetto meno qualificato,
che è definito così nel nostro lessico, ma in realtà è qualificatissimo: infermiere, educatore o
assistente sociale, comunque una figura che è vissuta come più generica, in quanto non ha la ‘psi’
davanti. Perché lo psichiatra è «lo strizzacervelli» per antonomasia, e nessuno ci va volentieri –
tanto più un paziente è grave, tanto meno gli si avvicina -, in quanto detiene un importante potere
custodialistico, perché è colui che può promuovere i TSO, è quello che prescrive i farmaci, che può
decidere di trattenere il paziente in reparto. Già lo psicologo è una figura un poco più soft anche
nell’immaginario collettivo. Ma certamente in un paranoico molto spaventato l’oggetto meno
pericoloso è l’infermiere o l’educatore. Entrare in contatto con un operatore così fa meno paura e
risulta pertanto più facile aprire la via all’aggancio ed al trattamento. 33 Infatti, nella mia esperienza di comunità, le notizie più importanti su un paziente erano spesso
fornite dalle donne delle pulizie. La seconda questione che mi interessa approfondire – ed è anche
il motivo per cui la redazione di Psiche ha pensato a te come interlocutore per l’intervista, data
questa tua esperienza pratica – è la questione degli interventi «non-psico» del modello bio-psicosociale, cioè la questione dei farmaci, cui hai già accennato, e degli interventi di tipo sociale. Che
tipo di ‘convivenza’ si stabiliva tra le tre componenti del «modello integrato» alla Zapparoli. Per
esempio il rapporto con i farmaci come è stato nella tua esperienza? La letteratura insegna che, se il paziente interrompe le terapie farmacologiche, le ricadute
sono molto più frequenti, ed io sono sempre stata determinata in questa direzione, quando avevo
l’intuizione che c’era un’opportunità di cura, ovviamente sempre nel contesto di una relazione di
ascolto con il paziente. A questo proposito, ho vissuto in prima persona un’esperienza tragica,
all’inizio della mia carriera. Dove lavoravo allora, c’era un infermiere proveniente dal vecchio
manicomio, che aveva la consuetudine di «allungare» la terapia, di aggiungere cioè psicofarmaci, a
dosi non prescritte, al caffè da distribuire ai pazienti. Se c’era un reparto agitato, di sua iniziativa,
aumentava i dosaggi dei farmaci prescritti. Un giorno, il primario ed io siamo andati nella cucina del servizio, dove era rimasto del caffè
ancora caldo. L’abbiamo bevuto insieme agli altri due infermieri. L’infermiere ‘avvelenatore’
naturalmente aveva declinato l’invito, con la scusa di avere la gastrite, dopo avere cercato in tutti i
modi di dissuaderci a bere il caffè rimasto, dicendoci che l’avrebbe fatto di nuovo. Ma a tutti
sembrava uno spreco buttare un caffè ancora caldo e fumante. Dopo di che è successo un disastro,
perché un infermiere ha avuto un episodio di acatisia ed è finito in pronto soccorso, l’altro ha avuto
un torcicollo spastico. Il primario ed io pensavamo di avere l’influenza, perché ci calavano le
palpebre, non riuscivamo a stare svegli e sentivamo un profondo malessere, che è durato per tutto il
pomeriggio. Siamo andati dunque in Medicina, dove ci hanno sottoposto a controlli, ma nessuno
pensava di certo ad un’intossicazione da farmaci. In seguito si è fatta mente locale che spesso i
pazienti si lamentavano di effetti collaterali, non giustificabili con i dosaggi correttamente prescritti,
e questo accadeva con una certa frequenza, guarda caso sempre quando c’era in turno il vecchio
infermiere manicomiale, tanto da promuovere un’ispezione dei Nuclei Anti Sofisticazione. Non è
stato possibile dimostrare materialmente le responsabilità dell’infermiere, però è stato allontanato
dal reparto ed il problema non si è più ripresentato. Prima di questo episodio, banalizzavamo quando i pazienti si venivano a lamentare di un
«tremore nei muscoli», oppure di essere costretti «a camminare sempre», perché i dosaggi che erano
ufficialmente prescritti erano bassi. Però, da allora, ho un grandissima considerazione e rispetto
quando un paziente mi dice di avere effetti collaterali. Quell’episodio è stato fondante per me, mi ha
permesso di empatizzare con i pazienti ed in un certo senso devo ringraziare l’infermiere
avvelenatore, anche se è stata un’esperienza che non augurerei a nessuno. L’infermiere con
l’acatisia raccontava di avere le gambe che non stavano più ferme: inquietante. Tutti abbiamo
sperimentato un senso di inquietudine profonda, che non avremmo mai immaginato. Io credo che la cura farmacologica sia necessaria, perciò anche dopo quei fatti ho continuato a
combattere, magari per un’ora intera, per convincere un paziente che ne avesse bisogno ad assumere
il dosaggio minimo, perché arrivare a dare il farmaco è già una forma di contenimento, anche se lo
dai in misura minima. Il paziente si sente accolto, se capisce l’intenzione del medico, e poi gli
34 psicologi possono lavorare sulla riduzione dei vissuti persecutori, connessi all’assunzione. In
fondo, come si detto, anche nell’immaginario collettivo, la gente comune considera gli psicofarmaci
delle droghe – e in un certo senso lo sono, essendo sostanze psicoattive. A parte i soggetti che ne
abusano, perché ingollerebbero anche il flacone che li contiene, normalmente è difficile dare anche
a persone più sane degli psicotici degli psicofarmaci, se non forse le benzodiazepine. Il vissuto
collettivo è quello. Figurarsi a uno che non si considera malato. Ma se si elabora bene questo
problema con il paziente, vedi che tutte le resistenze, inizialmente massicce, diminuiscono un po’ e
si sdrammatizzano. Alla fine bisogna avviare un processo di contrattazione, e questo permette anche
al paziente di sentire di avere un ruolo più attivo nella propria cura. Ma questo è possibile perché si
è imparato un metodo. I farmaci attuali non sono più così tossici, però ..... Prima nessuno si poneva
il problema d’iniziare a prescrivere un dosaggio basso, di tenere monitorati gli effetti collaterali.
Ricordo che qualcuno aveva escogitato la «neurolettizzazione rapida»: nel giro di due o tre giorni si
arrivava a cento milligrammi di aloperidolo, una cosa folle. Poi si è scoperto che tra gli effetti
collaterali del farmaco c’era l’allungamento del tratto Q-T dell’elettrocardiogramma e che poteva
essere molto pericoloso, qualcuno avrebbe potuto rimetterci la vita. Queste cose le abbiamo dovute
rivedere ben bene. Un giovane paziente psicotico, che aveva attraversato un’esperienza del genere prima di
arrivare al servizio dove lavoravo, mi aveva chiesto seriamente se a mio giudizio lo facessero
apposta per spaventare i pazienti. Come dargli torto? Tuttavia, sono sempre stato sorpreso da
quanto sia impervia e come nascosta da una nebbia la nozione che il primo significato degli
psicofarmaci dovrebbe essere quello di ridurre la sofferenza, in qualunque forma si manifesti, e
possibilmente liberare i pazienti dall’angoscia. Se intendi il farmaco in questo modo, penso che
puoi convincere il paziente ad investire positivamente la sua cura. Se fai così, tra l’altro, scopri che
i farmaci sono efficaci anche dal punto di vista simbolico, perché piccole dosi mantenute nel tempo,
insieme alla periodica «visita di controllo», finiscono per funzionare come una specie di «copertina
di Linus», qualcosa che il paziente tiene per sé e che lo lega a te in un rapporto di sostegno, dove il
farmaco funziona – se è lui a funzionare – anche a dosaggi molto contenuti, che non hanno nessuno
degli effetti ed incidenti che tu hai ben descritto. Un rapporto dove tu stabilisci anche una relazione di fiducia, quella che Zapparoli chiamava
«la prova della credenza» 18. Allora le cose funzionano. Secondo me, il paziente intuisce se tu hai
18 Fondare l’intervento di cura sulla fiducia nel valore della comunicazione (verbale e non) del paziente schizofrenico
potrebbe apparire come uno scivolamento verso una inversione di ruolo: è il terapeuta, frastornato dal cozzo con la
psicosi, che si fa ‘curare’ dal paziente. Zapparoli rende evidente che non è così attraverso il concetto di credenza. La
parola assomma almeno due significati: uno ha a che fare con la fiducia e la persuasione, l’altro indica un mobile da
cucina, cui il nome deriva dal fatto che in epoca medievale proprio su questo mobile dei servi chiamati scalchi
assaggiavano i cibi del loro signore per dargli credenza che non fossero avvelenati. Zapparoli adopera la metafora di
questa antica usanza per nominare la funzione con cui l’analista fornisce al paziente psicotico, ascoltandolo, la
possibilità di strutturare un rapporto di fondamentale fiducia con l’oggetto di bisogno. L’idea che l’estrema vulnerabilità
del paziente costituisca un elemento centrale nella clinica della schizofrenia è coerente con la concezione dell’Io
psicotico in Zapparoli, per la fragile omeostasi del quale quasi ogni intervento può essere ‘veleno’. Da qui l’esigenza di
curare, prima di ogni altra cosa, la fondazione di un solido rapporto di fiducia tra lo psicotico ed i curanti. Alla luce di
tale esigenza, le prescrizioni di Zapparoli insegnano come portare massima considerazione e rispetto verso le
manifestazioni del paziente, e come rispondere per quanto possibile in modo semplice e controllabile – che non vuol
35 lo scopo di ridurre la sofferenza, o quello di fare – diciamo – una prevaricazione. Gli inconsci
‘chiacchierano’, no? Hai raccontato come si è tradotto nella pratica dei servizi il pensiero di Zapparoli, come è
riuscito in qualche modo ad avere un riconoscimento sul piano della politica sanitaria regionale;
abbiamo accennato all’esordio del nostro lavoro in quell’orizzonte; e poi? Che vicende ha
attraversato il modello integrato finora? E che prospettive pensi che possa avere per il futuro? Inizialmente tutti avevano un gran fervore, perché erano gli anni del post ‘68 (anche se la
«Legge 180» è del 1978), e quindi c’era una curiosità diversa, i manicomi si dovevano chiudere, si
andava sul territorio, ci si viveva un po’ come dei pionieri e tutto quello che era aggregazione,
scambio, confronto, desiderio di cambiare lo stile relazionale aveva un richiamo molto forte, dopo
c’è stato veramente un periodo di blocco e di dispersione. Adesso ci sono enormi difficoltà perché è
un periodo storico di crisi. Anche le tutele di cui la psichiatria godeva, come il fondo particolare del
5% che ogni azienda sanitaria locale lombarda doveva riservarle, e che non doveva essere intaccato
da usi impropri (perciò era disponibile per la formazione, per le sostituzioni di personale), un fondo
dedicato che era un po’ un argine intoccabile, sono state abolite. Vado in giro per il mio lavoro formativo sul case management promosso dalla Regione, e
sento raccontare che ci sono servizi con un bassissimo ricambio di operatori. C’è gente che pensava
di andare in pensione a 55-57 anni e non può più – e quando sei svuotato e demotivato è molto
difficile. Eppure deve assicurare la presenza e fare i turni di guardia, perché le associazioni dei
familiari hanno voluto le guardie attive sia in ospedale che nei centri psico-sociali, e bisogna stare lì
fino alle otto di sera anche in posti dove mi ricordo che la gente mangiava alle sette, e nessuno si
sognava di venire al centro alle otto. Questo va a detrimento del lavoro di «rete» interna. Se io devo
sostenere tutte le sere una doppia guardia, questo mi impedisce poi le riunioni tra operatori, che non
sono un optional. La discussione del caso è l’elemento fondante, è lo strumento con cui gli operatori
si confrontano. Non puoi procedere con le riunioni quotidiane in micro équipe per la discussione del
caso ed i necessari aggiornamenti; al massimo promuovi quelle più allargate per elaborare gli eventi
tragici, gli eventi sentinella, suicidi o aggressioni. Ma ti devi poter trovare: il passaggio delle
consegne è fondamentale, non basta la comunicazione al volo in corridoio, altrimenti non c’è spazio
per la necessaria riflessione. Poi c’è stato tutto il discorso della valorizzazione degli interventi, che è
diventava una sorta di persecuzione: «quindici minuti per il controllo farmacologico», recita il
tariffario, e non un minuto di più. Questo si cala ovviamente sulle resistenze degli operatori, perché
lavorare così è a cottimo, ma è meno impegnativo dal punto di vista emotivo profondo che
impegnarsi in una vera relazione. C’è stato un periodo di decadenza. Quando è cominciato, a tuo avviso? Se dovessi ricordare un avvenimento che nella tua
esperienza è stato antesignano della crisi, quale indicheresti? dire compiacente. L’atteggiamento verso il paziente, dunque, lungi dall’essere un’inversione di ruolo è una
fondamentale esigenza strategica, conseguente alla concezione metapsicologica su cui è fondato tutto il discorso del
Modello integrato.
36 Quando è cominciata la tortura di tutta questa burocrazia, che ha impegnato molte delle
energie. Anche il discorso del controllo della qualità, che è importante se lo fai in un certo modo,
diventava talmente prioritario – e riunioni per questo, e riunioni per quest’altro – che il rapporto con
il paziente passava in secondo piano. Non era più la clinica a determinare l’organizzazione, ma
viceversa: l’organizzazione determinava la clinica. È stato un errore fondamentale. Forse il 2006 è
stato l’anno di inizio di tutto questo; poi è andato peggiorando. La psichiatria è comunque una branca particolare. Puoi avere un chirurgo o un endoscopista
ottimo, dal punto di vista della manualità e della capacità, che magari è disturbato nel carattere ed
ha un rapporto poco funzionale con il paziente, però fa il suo intervento, il contatto dura poco,
arrivederci e amici come prima. Ma uno psichiatra o un operatore disturbato, che non fa un lavoro
quotidiano di rivisitazione, non può lavorare, perché la relazione con il paziente nel nostro caso è
fondamentale. Invece noi sappiamo che il disturbo narcisistico tra gli operatori è quello più diffuso.
Si dice anche che il futuro DSM-V intenda eliminare questa diagnosi dal manuale, perché è così
‘normale’ nella popolazione che non si potrebbe più considerare patologia. Però con i colleghi
disturbati bisogna fare una scelta, perché se metto un operatore che non sa entrare in relazione, è
come avere un chirurgo senza mani, e a nessuno verrebbe in mente di fare operare un chirurgo
senza mani. In questo caso l’équipe serve perché l’operatore potrebbe svolgere alcune funzioni che non
implicano particolari capacità relazionali, mentre qualcun altro lo vicaria in questo? Per esempio
potrebbe occuparsi della distribuzione dei farmaci, mentre qualcun altro pensa al resto? Però anche i farmaci, se li presenti come una sfida tra te e il paziente, non è che aiuti molto .... In tal caso quel che dici implica un’idea ancora più forte: l’équipe in qualche modo è un
luogo di cura del gruppo di operatori. Ah, sì! O almeno di contenimento di certe istanze. Senza arrivare al caso di Lorenzo
Bignamini, il collega che è stato ucciso con la balestra da un collega psichiatra schizofrenico. Lì c’è
stato un passarsi la patata bollente finché il più salvifico è rimasto con la famosa donna di picche in
mano, perché gestire da solo un collega schizofrenico può costare la vita. Un’équipe integrata
funzionante avrebbe detto, in quel caso, che un oggetto onnipotente – che non sarà quello che entra
in relazione con te paziente – assume la funzione gerarchica del contenimento, mentre gli altri
cercheranno di entrare in una relazione più vicina. Un operatore così gravemente malato non può
lavorare in psichiatria. Mi ricordo che per allontanare un infermiere che faceva approcci con le
pazienti sulla base di un delirio erotico sono state necessarie molte discussioni con i dirigenti del
Comparto 19. Per fortuna casi così eclatanti sono pochi, però può capitare vi siano operatori troppo
rigidi e incapaci di entrare in una proficua relazione terapeutica. A quei tempi c’erano anche diatribe tra coloro che avevano una formazione organicistica e
quelli che erano di formazione psicoanalitica. Zapparoli ha lavorato molto anche sull’integrazione
19 Vedi la terza nota in questa intervista.
37 delle diverse scuole di pensiero. Il suo messaggio era: si comincia dalle parti scisse del paziente e si
arriva all’integrazione dell’équipe, all’integrazione del lavoro di «rete», cioè il lavoro delle
assistenti sociali, che comporta l’integrazione con famiglia e con le varie agenzie del sociale. Con il riferimento al concetto di «rete» mi sembra che tocchi anche il terzo fronte
dell’intervento che il modello integrato promuove contro il tripode bio-psico-sociale, da cui
scaturirebbe la psicosi, cioè quello relativo al livello «sociale». Questo passaggio è fondamentale, perché se non costruisci la rete tra le figure disponibili per
il caso finisci per affrontarlo con una mancanza enorme. Per esempio il recupero della famiglia, la
costruzione di una «mappa dei poteri» nell’ambiente che circonda il paziente, gli aspetti dei bisogni
sociali insoddisfatti eccetera. L’integrazione viaggia a molti livelli, ed è un processo continuamente
dinamico. Non è solo la buona collaborazione di persone, che, come si è detto, sono capaci e
competenti nel loro ruolo. È qualcosa di molto più profondo e sottile, che impegna anche tante
energie. L’alternativa è la frustrazione del pensare che «tanto i nostri pazienti non si curano, che
arrivano tutti alla cronicità». Anche se solo riesci a promuovere un progresso dalla simbiosi preambivalente alla simbiosi focale, a quella che Pao chiamava la «guarigione sociale» del disturbo
schizofrenico, la qualità della vita del paziente migliora notevolmente, perché significa aiutarlo ad
ampliare i suoi spazi vitali, a contenere gli aspetti persecutori nella «stanza del delirio», e
permettere che l’Io residuale non psicotico possa accedere alla riabilitazione e alla risocializzazione.
Non guarirà secondo un concetto ideale di guarigione, ma sicuramente starà molto meglio, e
l’obiettivo è il benessere del paziente nel rispetto delle regole. Se lavoriamo per ridurre la
sofferenza, il paziente si allea con noi, altrimenti è uno scontro tra titani: l’onnipotenza del curante
(il furor sanandi, il velleitarismo terapeutico) contro l’onnipotenza del paziente. Questi sono i
messaggi trasmessi da Zapparoli, secondo me forti, qualche volta non compresi. In che senso? Mi ricordo il primo incontro con il Professore di una équipe dove lavoravo come aiuto
medico. All’inizio capivamo pochissimo delle supervisioni. Il Professore diceva delle cose talmente
avanti rispetto alle nostre conoscenze, che ci sembrava un mezzo folle. Tante volte erano in gioco le
nostre resistenze: lui proponeva qualcosa e gli operatori attaccavano la proposta. Ricordo una volta
che ad un assistente sociale ha controbattuto: «Senta, Lei è nella merda, perché con questo paziente
non sa che cosa fare; io Le do una mano per uscire dalla merda, e Lei vuol tirare dentro me». Che è
un’analisi delle resistenze così immediata .... Avevamo persino pensato di interrompere le
supervisioni, ma poi andando avanti nel tempo abbiamo capito. Poi, secondo me, nel tempo si è
modificato anche Zapparoli, ed alla fine è diventato più didattico. Per lo meno i libri, che all’inizio
erano poco comprensibili, troppo scritti in ‘psicanalese’, sono diventati l’epilogo di tutte le sue
esperienze di supervisione e della conoscenza approfondita del lavoro con gli operatori del servizio
pubblico. Adesso cosa succederà? Che futuro si prospetta per il «modello integrato»? 38 Questa è una bella domanda. Nell’ultima iniziativa promossa dalla Regione tutti i
Dipartimenti sono stati coinvolti. Accanto ai corsi è stata prevista anche una fase locale con
discussione dei casi gravi in équipe. Perciò si sta cercando di diffondere nuovamente il messaggio
dell’integrazione, di una prospettiva psicodinamica, cioè di tutto questo lavoro importantissimo che
non si può improvvisare. Occorre formarsi, occorre praticarlo, occorre in qualche modo crederci, e
si sta cercando di ridare vita e di rivalutare la prospettiva della relazione, dopo quel momento di
burocratizzazione organizzativa. Però ci sono alcuni gruppi di lavoro molto chiusi, dove si fatica,
dove ti guardano con l’aria di dire «ma da dove vieni?». Certamente la formazione universitaria
questo nostro messaggio non lo trasmette. Lo propagandano paradossalmente più le scuole di
specializzazione per gli psicologi che quelle della psichiatria. E un primario che ha più una
formazione di tipo farmacologico-organizzativo favorisce meno la preparazione tesa verso
l’integrazione. Ci sono altre èquipe dove vedi, da come presentano i casi, dalle osservazioni che
fanno, che invece è il paziente al centro del processo. Ma soprattutto il bisogno di questo tipo di
visione lo senti negli operatori del Comparto, perché contiene un messaggio che parla di cose
concrete, di quelle con cui gli operatori non medici e non psicologi si scontrano tutti i giorni. È una
scena molto differente se tu vai a fare una visita domiciliare, hai un tuo campo osservatorio delle
relazioni tra il paziente e la famiglia e riporti la tua esperienza ad un responsabile o ad un gruppo
che ti risponde, «caspita! Queste sono cose importanti. Vediamole, mettiamole insieme», da quella
in cui l’altro obietta «Ma no, è venuto in studio e non c’era nessun problema in famiglia, gliel’ho
chiesto» e si ferma a quel suo pezzetto d’esperienza. Una differenza abissale. Rispetto alla quale i giovani hanno bisogno di una formazione continua. In qualche modo, sembra che in Regione – nonostante che la Regione Lombardia non sia
certo in odore di progressismo – c’è consapevolezza della necessità di rimettere in funzione questa
prospettiva. E se lavori sulle famiglie crei un’alleanza anche con le associazioni dei familiari, che
comunque hanno un loro peso, anche politico – sia per ragioni elettorali, sia per la loro presenza
nella consulta regionale per la psichiatria. E sono un alleato importante anche sul piano clinico,
perché nel discorso dell’integrazione e della rete non puoi trascurarle, almeno per le patologie
psicotiche – il nevrotico sa bene come arrivare e chiedere da sé. Devo dire che le organizzazioni dei
familiari hanno appoggiato moltissimo questo discorso della condivisione e dell’integrazione, e
nella cura del paziente psicotico ne sono state un po’ i promotori all’interno della Regione, insieme
agli psichiatri che hanno avuto questa formazione. Negli anni del fervore, se avevi la fortuna di
avere un collega di formazione sistemica, allora quello lavorava sulle famiglie, ma se non l’avevi il
lavoro sulle famiglie, che è fondamentale, non veniva affrontato. Adesso, grazie anche alla rete con
le associazioni dei familiari e al fatto che hanno voce in capitolo, non puoi più ignorarli e metterli
da parte. In qualche modo ci hanno ‘costretto’ all’integrazione. Se prendi la madre come co-terapeuta in un caso di simbiosi ambivalente, ti metti in una
posizione di apparente subalternità, come quella di uno che offre una consultazione. In realtà tieni
39 conto della realtà clinica, perché in fondo la madre è colei che non può stare senza suo figlio, e
l’idea che tu possa essere quello che ‘ruba’ i bambini – come le assistenti sociali nel vissuto
fantasmatico della gente, nel caso dei servizi per i minori – è una cosa intollerabile. Non puoi
entrare come un carro armato in un caso di simbiosi; devi aiutare ad allentarla fornendo due oggetti
simbiotici sostitutivi, di modo che la madre, come co-terapeuta appunto, possa confrontarsi con
l’oggetto onnipotente psichiatra – per iniziare la triangolazione, il lavoro di allentamento -, e il
figlio può essere accompagnato dall’infermiere in un percorso di adeguamento a spazi vitali più
ampi ed a una vita più consona che l’essere chiuso in casa, in quella specie di spazi bui e grevi di
persecuzione che osservi spesso nel pregresso della cura. Quindi il futuro del modello integrato, almeno qui in Lombardia, ha questi due santi
protettori: dei tecnici, consulenti della Regione, che hanno mantenuto questa visione, e l’appoggio
che viene indirettamente dalle associazioni dei familiari. Sì. E poi dalle nuove concezioni quali il case management, che non è specifico della
psichiatria, e quella della «rete», che nemmeno è specifica. Se crei alleanze con i Comuni, anche in
un momento di povertà di risorse come l’attuale, qualche alternativa in più per rendere più vigorosi
i tuoi mezzi la trovi sempre. A marzo del 2013 chiuderanno gli ospedali psichiatrici giudiziari,
ufficialmente, poi ci sarà un processo di adeguamento più lento. Ma i pazienti che compiono reati, o
che comunque hanno un discontrollo dell’impulsività grave, dove li metti, se non crei comunità ad
alta protezione che sappiano contenere e curare pazienti di quella portata? E adesso non si tratta più
del vecchio schizofrenico che delirando vedeva la faccia del diavolo nel vicino, e quindi per
difendere la propria vita lo assaliva. Adesso il caso più frequente è quello del paziente borderline
spurio, con tratti psico-socio-patici o quello che fa uso di sostanze: bombe con la miccia accesa. C’è un cambiamento della patologia, che è connesso al cambiamento sociale: gli accessi e gli
esordi schizofrenici sono diminuiti rispetto a questi tipi di patologie, e se gli operatori non sono
formati a trattare i disturbi di personalità complessi si troveranno disarmati. Se non si crea la rete
con i servizi per le tossicodipendenze o per l’alcolismo, si continuerà a palleggiarsi i pazienti. La
rete deve essere stretta con protocolli d’intesa – anche con i carabinieri! – che siano molto chiari sul
chi fa cosa e dunque distribuire i compiti secondo le competenze. Questi protocolli sono anche
previsti: l’attuale Piano regionale per la salute mentale è stato fatto come è fatto non solo sulla
scorta di quello nazionale, ma anche perché ci hanno lavorato dentro molti degli allievi che erano
della scuola di Zapparoli, che hanno portato il suo messaggio e le loro competenze. Sembra che un punto critico sia anche la formazione universitaria. L’università ha spesso questo difetto di non essere calata nel tessuto dell’operatività. Magari è
in grado di fornirti un buon farmacologo, che è bene invitare a farti l’aggiornamento, però sulla
veicolazione del farmaco non è che lavorino molto. A loro interessa relativamente. Chi invece
lavora sul campo deve mettere insieme conoscenze e nozioni scientifiche con una capacità operativa
clinica fondamentale. Non puoi escludere né le une, né l’altra. In qualche modo dovrebbe far parte delle competenze bio-farmacologiche (che sembrano
40 quelle che l’università prevalentemente insegna) ciò che tu hai chiamato «la veicolazione» del
farmaco, cioè l’introdurre in modo dinamicamente significativo il farmaco nella storia, nella vita e
nella rete di rapporti del paziente. Soprattutto nella rete dei rapporti familiari. Faccio un esempio: le madri ambivalenti, nella
simbiosi ambivalente, sono quelle che rivelano allo psichiatra che il figlio ha sputato i farmaci,
perché ne hanno trovato le compresse qui o là sparse per casa; poi però, a casa, leggono al figlio i
‘bugiardini’ dei farmaci, e per un po’ il figlio non prenderà più neanche un’aspirina, perché sui
bugiardini dei farmaci sono elencati tutti i possibili rischi che creano paura. È il problema della
medicina difensiva, che «per pararsi legalmente la schiena» deve scrivere «tutto»,
indipendentemente dal livello di discernimento del probabile destinatario della cura. In casi simili è
chiaro che non basta prescrivere. Se hai un buon primario, che fa anche il professional, cioè si
assume anche la gestione di alcuni aspetti clinici, per esempio nel confermare autorevolmente la
prescrizione, questo ti protegge in qualche modo, infatti è più facile essere spontaneo nella relazione
con il paziente. Se invece ti bacchetta perché l’importante è fare prestazioni, perché l’importante è
rispondere al Direttore Generale – dovere ovvio, ma che non può essere l’unico indirizzo operativo
–, lavori a cottimo e perdi il senso della creatività del nostro lavoro. Rimango convinta che questo
sia il lavoro più bello del mondo, però negli ultimi anni ero affaticata da tutti gli obblighi
burocratici, pur cercando di porvi un po’ argine. Cercavo un gruppetto di operatori mentalmente più
capaci di fare queste cose, che ne assorbisse in parte il peso e consentisse a quelli più capaci di
relazionarsi di operare con i pazienti. Un’altra funzione: la protezione rispetto all’amministrazione. Un gruppetto di quelli, che hanno un taglio più ossessivo – in senso buono – e sono ‘portati’ a
svolgere questi compiti con successo. Valorizzi ciascuno negli aspetti che gli riescono meglio. La
funzione del «modello integrato» è anche questo. Rimane comunque un argine che dovresti poter
affidare alla selezione. I concorsi a tempo determinato aiutano in questo, a selezionare persone che
abbiano una buona stabilità mentale, indipendentemente dalla scelta di fare una professione
psichiatrica. Il tempo determinato ti dà la possibilità di valutare meglio. Se uno ha rispetto per il
paziente, attitudine per questo lavoro, ha voglia di formarsi, di confrontarsi con gli altri, lo puoi
capire sul campo. Ho creduto in queste cose, e spero che chi ha lavorato con me abbia in fondo
questo vissuto di essere stato considerato, di avere fatto un buon lavoro. 41