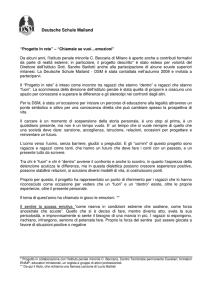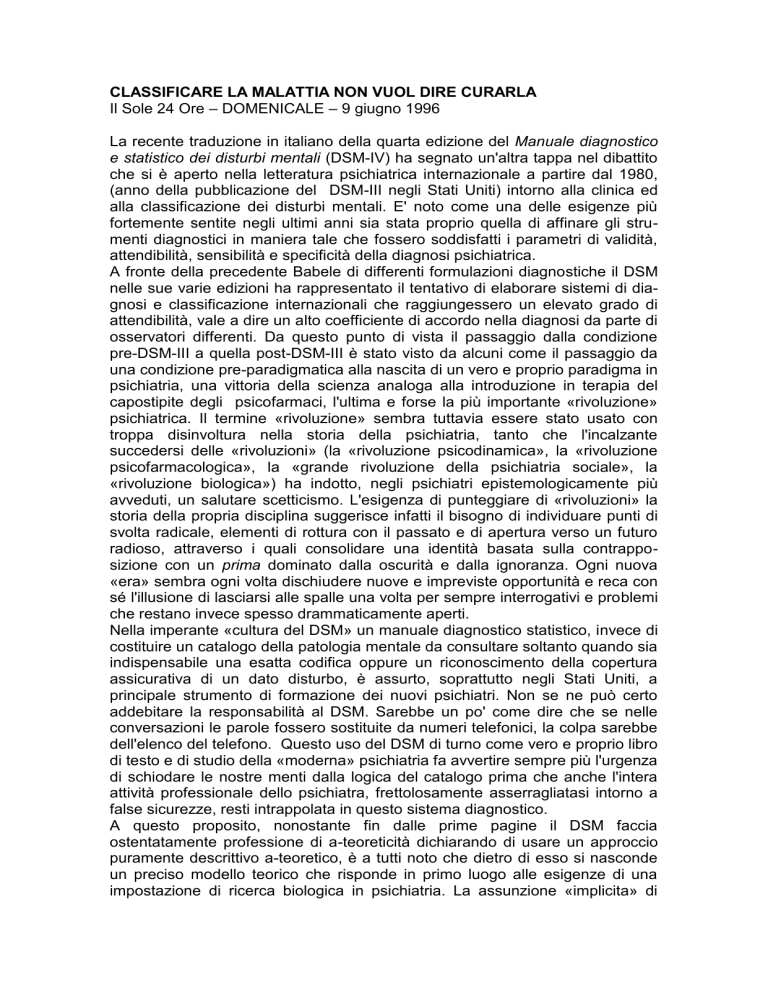
CLASSIFICARE LA MALATTIA NON VUOL DIRE CURARLA
Il Sole 24 Ore – DOMENICALE – 9 giugno 1996
La recente traduzione in italiano della quarta edizione del Manuale diagnostico
e statistico dei disturbi mentali (DSM-IV) ha segnato un'altra tappa nel dibattito
che si è aperto nella letteratura psichiatrica internazionale a partire dal 1980,
(anno della pubblicazione del DSM-III negli Stati Uniti) intorno alla clinica ed
alla classificazione dei disturbi mentali. E' noto come una delle esigenze più
fortemente sentite negli ultimi anni sia stata proprio quella di affinare gli strumenti diagnostici in maniera tale che fossero soddisfatti i parametri di validità,
attendibilità, sensibilità e specificità della diagnosi psichiatrica.
A fronte della precedente Babele di differenti formulazioni diagnostiche il DSM
nelle sue varie edizioni ha rappresentato il tentativo di elaborare sistemi di diagnosi e classificazione internazionali che raggiungessero un elevato grado di
attendibilità, vale a dire un alto coefficiente di accordo nella diagnosi da parte di
osservatori differenti. Da questo punto di vista il passaggio dalla condizione
pre-DSM-III a quella post-DSM-III è stato visto da alcuni come il passaggio da
una condizione pre-paradigmatica alla nascita di un vero e proprio paradigma in
psichiatria, una vittoria della scienza analoga alla introduzione in terapia del
capostipite degli psicofarmaci, l'ultima e forse la più importante «rivoluzione»
psichiatrica. Il termine «rivoluzione» sembra tuttavia essere stato usato con
troppa disinvoltura nella storia della psichiatria, tanto che l'incalzante
succedersi delle «rivoluzioni» (la «rivoluzione psicodinamica», la «rivoluzione
psicofarmacologica», la «grande rivoluzione della psichiatria sociale», la
«rivoluzione biologica») ha indotto, negli psichiatri epistemologicamente più
avveduti, un salutare scetticismo. L'esigenza di punteggiare di «rivoluzioni» la
storia della propria disciplina suggerisce infatti il bisogno di individuare punti di
svolta radicale, elementi di rottura con il passato e di apertura verso un futuro
radioso, attraverso i quali consolidare una identità basata sulla contrapposizione con un prima dominato dalla oscurità e dalla ignoranza. Ogni nuova
«era» sembra ogni volta dischiudere nuove e impreviste opportunità e reca con
sé l'illusione di lasciarsi alle spalle una volta per sempre interrogativi e problemi
che restano invece spesso drammaticamente aperti.
Nella imperante «cultura del DSM» un manuale diagnostico statistico, invece di
costituire un catalogo della patologia mentale da consultare soltanto quando sia
indispensabile una esatta codifica oppure un riconoscimento della copertura
assicurativa di un dato disturbo, è assurto, soprattutto negli Stati Uniti, a
principale strumento di formazione dei nuovi psichiatri. Non se ne può certo
addebitare la responsabilità al DSM. Sarebbe un po' come dire che se nelle
conversazioni le parole fossero sostituite da numeri telefonici, la colpa sarebbe
dell'elenco del telefono. Questo uso del DSM di turno come vero e proprio libro
di testo e di studio della «moderna» psichiatria fa avvertire sempre più l'urgenza
di schiodare le nostre menti dalla logica del catalogo prima che anche l'intera
attività professionale dello psichiatra, frettolosamente asserragliatasi intorno a
false sicurezze, resti intrappolata in questo sistema diagnostico.
A questo proposito, nonostante fin dalle prime pagine il DSM faccia
ostentatamente professione di a-teoreticità dichiarando di usare un approccio
puramente descrittivo a-teoretico, è a tutti noto che dietro di esso si nasconde
un preciso modello teorico che risponde in primo luogo alle esigenze di una
impostazione di ricerca biologica in psichiatria. La assunzione «implicita» di
questo modello di riferimento rischia tuttavia di apparire - soprattutto nella sua
applicazione clinica - soltanto la caricatura di una disciplina scientifica.
L'insistenza quasi maniacale sulla oggettività, sulla attendibilità e sulla
operazionalizzazione ad oltranza della diagnosi si è rivelata una sorta di
maquillage che ha la pretesa - «scimmiottando» presunti canoni di scientificità di dare uno statuto scientifico forte a questa psichiatria, finendo invece per rivelarne la miseria. Nonostante i dati di cui fino ad oggi disponiamo, ad esempio
nel campo della ricerca sulla schizofrenia, configurino al massimo uno sketch e
non certo un modello esplicativo nel senso pieno del termine, troppo spesso i
dati ricavati dalle ricerche nel campo delle neuroscienze vengono
indebitamente generalizzati e presentati come verità assolute suscettibili di
dirette e risolutive ricadute applicative.
«Nei loro momenti di sincerità gli stessi psichiatri dubitano che le loro esposizioni puramente descrittive meritino il nome di scienza. I sintomi che
compongono questi quadri morbosi sono sconosciuti per quanto riguarda la loro
origine, il loro meccanismo e i loro reciproci legami; ad essi non corrisponde
alcuna dimostrabile alterazione dell'organo anatomico della psiche, oppure vi
corrispondono alterazioni dalle quali non si può trarre alcun chiarimento».
Queste parole sono state scritte da Sigmund Freud nel lontano 1915 ma sono
ancora assai vicine alla nostra esperienza se in una recentissima rassegna
sulle cause della schizofrenia Heinz Häfner ha scritto che la conoscenza dei
fattori che causano la più grave malattia mentale non ha fatto grandi progressi
dai primi anni del secolo: «i dati di cui oggi disponiamo sono ancora
frammentari e senza chiara connessione reciproca». Chi oggi non vuole tenere
conto o peggio ignora tutto questo e pretende - spesso con una certa
tracotanza - di presentare come risolti problemi che non lo sono è quindi aggiungeva Freud - soltanto un «briccone che dà più di ciò che ha».
Molti dei disturbi elencati nel DSM vengono invece presentati come delle vere e
proprie entità di natura, che emergono come Atena armata di tutto punto dalla
testa di Zeus, senza alcun rimando o nesso significativo con la vita psichica,
relazionale e sociale del soggetto. Rimanere abbagliati dal gioco di specchi
generato da una nosografia soltanto «descrittivo-comportamentale» fa perdere
di vista il nodo costituito dal rapporto tra fenomeni psicopatologici, struttura
profonda della personalità, disposizione biologica, storia di vita ed ambiente.
Non tenere conto di tutto questo significa più o meno esplicitamente svalutare il
rapporto con il paziente o addirittura rischiare di perdere la capacità stessa di
parlare con lui, nascondendosi dietro scale di misurazione attraverso le quali
rilevare comportamenti che fungano da criteri per così dire «oggettivi» di
inclusione o di esclusione per un determinato disturbo. Se è vero che i nostri
pazienti tentano spesso di dirci qualcosa che noi non riusciamo a capire, il
timore è che questa estrema possibilità di ascolto possa ulteriormente
decadere. Infatti, come si dice, non c'è peggior sordo di chi non vuole (o non
può più) sentire.
Mario Rossi Monti
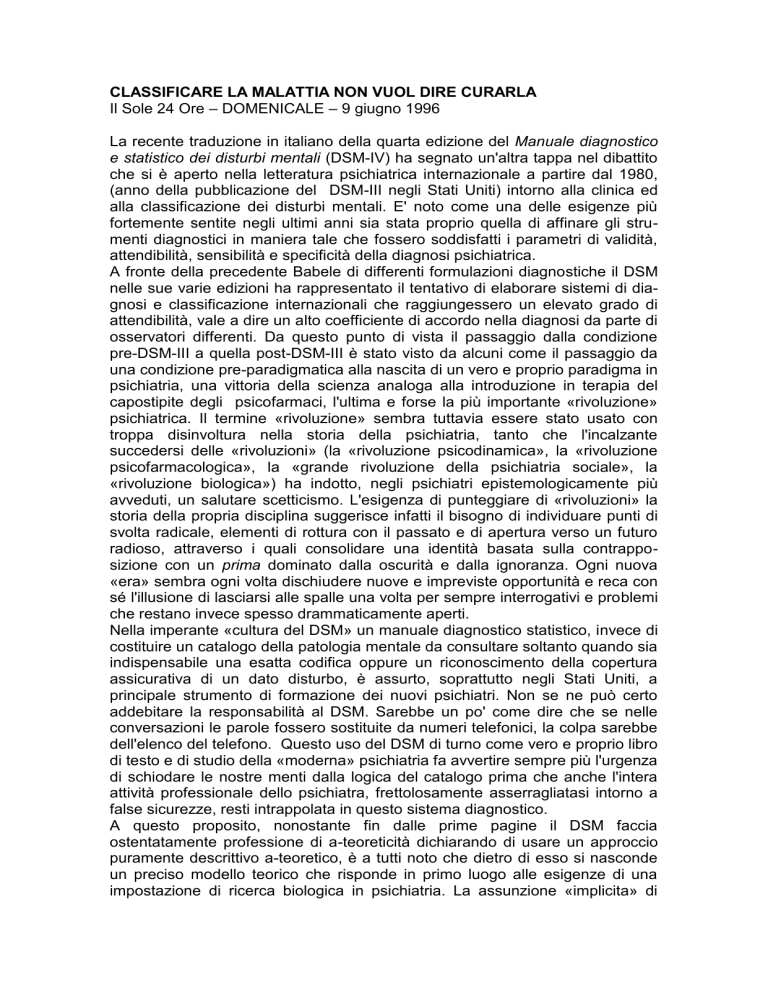

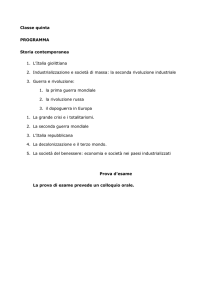
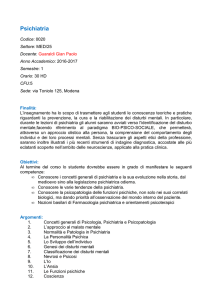

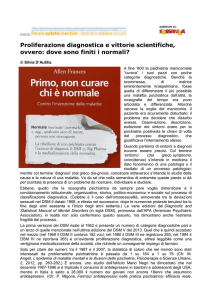
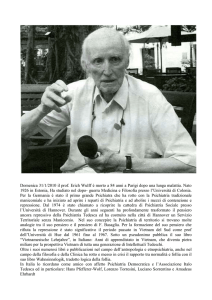
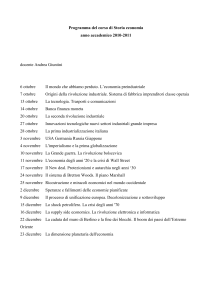



![4 RONCORONI [Sola lettura] [modalità compatibilità]](http://s1.studylibit.com/store/data/003477816_1-f72a41a031db7d959ec8d6afa70878eb-300x300.png)