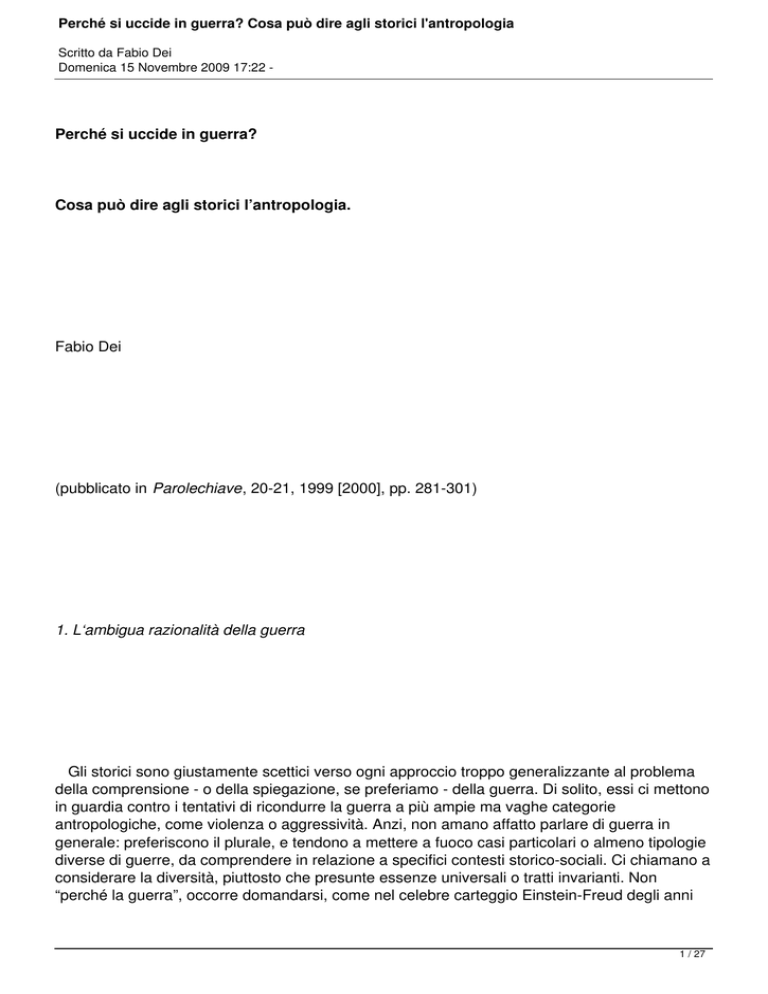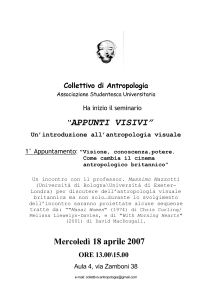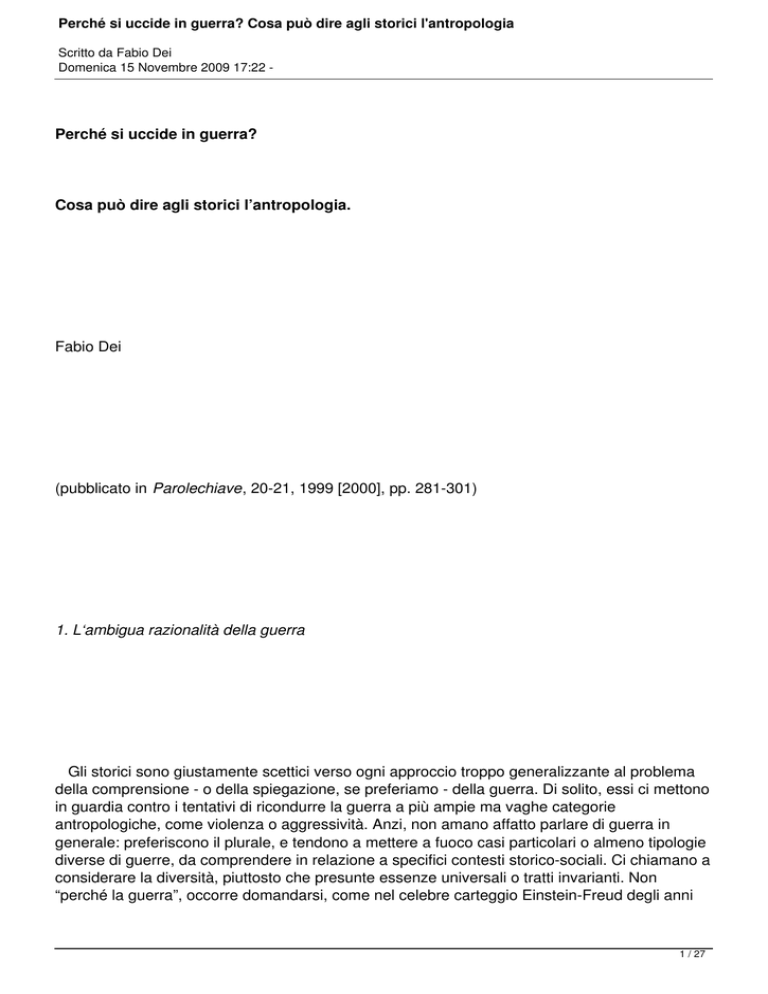
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
Perché si uccide in guerra?
Cosa può dire agli storici l’antropologia.
Fabio Dei
(pubblicato in Parolechiave, 20-21, 1999 [2000], pp. 281-301)
1. L‘ambigua razionalità della guerra
Gli storici sono giustamente scettici verso ogni approccio troppo generalizzante al problema
della comprensione - o della spiegazione, se preferiamo - della guerra. Di solito, essi ci mettono
in guardia contro i tentativi di ricondurre la guerra a più ampie ma vaghe categorie
antropologiche, come violenza o aggressività. Anzi, non amano affatto parlare di guerra in
generale: preferiscono il plurale, e tendono a mettere a fuoco casi particolari o almeno tipologie
diverse di guerre, da comprendere in relazione a specifici contesti storico-sociali. Ci chiamano a
considerare la diversità, piuttosto che presunte essenze universali o tratti invarianti. Non
“perché la guerra”, occorre domandarsi, come nel celebre carteggio Einstein-Freud degli anni
1 / 27
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
Trenta, ma perché quella particolare guerra, in quel luogo e in quell'epoca, condotta da quei
particolari attori sociali che le attribuiscono quei particolari significati, e così via. In questo
senso, gli storici stanno tendenzialmente dalla parte della celebre concezione del Vom Kriege
di Clausewitz: assumendo la fondamentale razionalità politica della guerra, ritengono che
spiegarla significhi ricostruire le condizioni in senso lato politiche che producono ogni singolo
conflitto.
Tuttavia, lo stesso Clausewitz riconosceva la presenza, nella guerra, di un'altra e assai più
oscura dimensione, che definiva in termini di “attrito”. La guerra è una macchina programmata e
guidata dalle limpide ragioni degli Stati: ma è una macchina pesante che, una volta avviata,
tende costantemente a sfuggire al controllo, a muoversi autonomamente secondo una propria
logica. Forse, sarebbe meglio dire, tende all'assenza di una vera e propria logica, giacché il suo
procedere sembra dominato da elementi di imprevedibilità, irregolarità, disordine. Come ha
notato Daniel Pick nella sua importante rassegna sul pensiero della guerra tra Ottocento e
Novecento (1993: 53), per Clausewitz la guerra ha qualcosa in comune con l'ambigua creatura
del dottor Frankenstein: in essa si manifesta una forza distruttiva, capricciosa e in ultima istanza
anarchica, che sovverte le proprie stesse originarie finalità e rischia di volgersi contro la volontà
razionale che l'ha originata. Vi sarebbe dunque nella guerra una fondamentale ambivalenza: e
l'arte militare consiste proprio, per Clausewitz, nella capacità di controllare gli elementi di attrito,
soggiogando il “mostro” alle positive ragioni che lo hanno creato.
D'altra parte, questa caratterizzazione ambivalente non è tipica soltanto dell'opera di
Clausewitz: come ha mostrato Pick, essa è presente in modo costante e quasi ossessivo in
gran parte degli intellettuali che negli ultimi due secoli hanno teorizzato sulla guerra, sul
versante sia bellicista che pacifista. A fronte della razionalità strumentale che la muove, la
guerra lascia emergere e scatena elementi oscuri e irrazionali, attingendo a uno strato molto
profondo e molto arcaico dell'animo umano. Vi è in essa un “primato di forze ignote e
inconoscibili, [...] nettamente al di là del regno delle decisioni umane”, per usare le parole di
Tolstoj (cit. in Pick 1993: 51). Mentre la razionalità strumentale ha a che fare con i particolari
contesti storici, questa seconda dimensione sembra piuttosto rimandare alla natura umana,
all'ordine del biologico o dell'istintuale, e in ogni caso dell'universale. In breve, sembra sfuggire
alla storia, presentandosi anzi come il limite stesso contro il quale si scontra la razionalità
storica (intesa sia come possibilità di comprensione da parte dello storico, sia di plasmazione
da parte dell'attore sociale, sia esso statista, condottiero o che altro).
Sarebbe però un errore considerare quest' “altra” dimensione della guerra come una mera
invenzione del pensiero speculativo, o di inclinazioni romantiche ed estetizzanti, cioè di
un'intelligenza radicalmente non-storica delle vicende umane. Ad imbattersi in essa, anzi, sono
spesso gli storici migliori, quelli che più profondamente si immergono nei contesti locali, nella
concretezza delle situazioni belliche, nelle pratiche umane di cui la guerra è fatta. Essi si
2 / 27
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
trovano spesso di fronte comportamenti individuali e collettivi non interamente riconducibili né
alla razionalità politica né a quella strettamente militare e strategica della guerra, per quanto
terribile essa possa rivelarsi.
Le manifestazioni della violenza fisica hanno tipicamente a che fare con tutto ciò. E' vero che
la violenza fa parte dell'essenza stessa della guerra, e viene consapevolmente mobilitata per le
finalità razionali che muovono i soggetti belligeranti. E tuttavia, essa sembra tenacemente
resistere a una integrale spiegazione di tipo contestuale, almeno per due motivi. Da un lato,
nelle pratiche concrete di guerra troviamo spesso un “di più” di violenza, in senso sia
quantitativo sia qualitativo, non richiesto e non giustificato da necessità politiche o strategiche di
alcun tipo. Dall'altro lato, le modalità di manifestazione della violenza in contesti storici anche
radicalmente diversi presentano analogie tanto sinistre quanto significative. Sembra quasi
possibile costruire una fenomenologia universale o meta-storica di certi atti di guerra, come il
combattimento, la fuga e la caccia, il massacro - l'operazione tentata ad esempio nel Saggio
sulla violenza
di W. Sofski (1996), con esiti discutibili ma senza dubbio impressionanti.
2. “Un fondo limaccioso”
Nello studiare specifiche pratiche di violenza ci troviamo cioè di fronte a elementi che
sfuggono a una spiegazione contestuale e che propongono al contempo palesi rimandi
intercontestuali. Alcuni esempi assai significativi di messa a fuoco di questo problema ci
vengono dalla più recente storiografia italiana, che ha affrontato il tema della violenza negli anni
della Seconda Guerra Mondiale in modo nuovo e attraverso un approccio che potremmo
chiamare etnografico. Vorrei riferirmi brevemente a un paio di casi. A proposito degli eccidi di
civili compiuti in Toscana dalla Wermacht in ritirata, nell'estate del 1944, alcuni studiosi hanno
cercato di rappresentare (fra l'altro, attraverso l'uso cruciale delle fonti orali) la dimensione
esperienziale e soggettiva del massacro, dal punto di vista dei sopravvissuti come da quello
3 / 27
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
degli esecutori. Ne sono risultati resoconti di grande impatto anche emotivo, che ci pongono di
fronte all'orrore del massacro nella sua concretezza, attraverso i frammenti visivi, olfattivi e
acustici della memoria dei superstiti. Da tali resoconti la ferocia e la crudeltà degli uccisori non
può non apparire spropositata, eccessiva, sia pure a fronte di chiare motivazioni strategiche
dell'esercito tedesco. Ma è anche una ferocia che in qualche modo suona sinistramente
familiare: è come se i soldati tedeschi seguissero un copione fin troppo noto, non solo perché
già sperimentato nei territori orientali, come nel caso della famigerata divisione Hermann
Goering, ma perché messo in scena più e più volte nei secoli. I resoconti delle stragi naziste
che emergono dai lavori di Paggi (1996, 1997), Pezzino (1997), Contini (1997) e altri si
discostano solo per dettagli dalla descrizione per così dire ideal-tipica del massacro tentata da
Sofsky (1996: 149sgg.), che pure si basa su fonti prevalentemente moderne. Per dirla con
quest'ultimo autore, “cambiano le vittime e i carnefici, cambiano le armi e il teatro degli eventi.
Nondimeno la natura del massacro rimane immutata” (Ibid.: 152). Il motivo, a suo parere, è che
in esso la violenza “gode di libertà assoluta”, agisce secondo una propria logica
indipendentemente dalle finalità e dalle ragioni che la innescano:
L'uniformità dei massacri non dipende dall'identità degli scopi, ma dalla dinamica universale
della violenza assoluta [...] E' la violenza stessa che detta il corso degli eventi. L'eccesso
dell'azione collettiva si svincola dalle intenzioni politiche o sociali (Ibid.: 153)
La “dinamica universale della violenza assoluta” è un concetto discutibile e difficile da accettare
per gli storici (e non solo per loro). Anch'essi, tuttavia, non possono fare a meno di confrontarsi
con il problema che pone Sofski, ammettendo l'insufficienza di spiegazioni meramente
funzionaliste dei massacri. Claudio Pavone, discutendo l'eccidio di Civitella val di Chiana
(Arezzo), parla di
una linea di sotterranea tendenza alla violenza che sussiste anche nelle società che noi, con
eccessivo ottimismo, avevamo considerato ormai irreversibilmente civilizzate. Questo
4 / 27
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
limaccioso fondo, che può portare l'umanità a compiere eccessi ed orrori come quelli operati dai
tedeschi, era stato occultato dal monopolio della violenza legale che lo Stato moderno si è
attribuito (Pavone 1996: 18-9).
Questo monopolio si spezza in situazioni come quelle della guerra civile o guerra totale, che
sospendono le condizioni del processo di civilizzazione e lasciano “emergere quel fondo torbido
e violento” (Ibid.). L'uso ripetuto degli aggettivi “torbido” e “limaccioso” da parte di Pavone, che
è storico limpidamente razionalista, è significativo. Beninteso, il sostrato di cui egli parla non è
una “natura umana” che si sostituirebbe a una cultura momentaneamente sospesa. Pavone
insiste anzi sulle specifiche condizioni culturali che producono il “ritorno” del massacro, in
particolare sulla consapevole promozione dei valori della violenza da parte del nazismo. Anche
nel suo celebre libro «sulla Resistenza egli aveva posto il problema di quel “«di più» di
violenza, quel di più del quale i reduci di tutte le guerre preferiscono non parlare”, e che
riguarda il campo fascista come quello resistenziale (Pavone 1991: 427). Non si tratta di un
semplice problema di crudeltà e sadismo, egli afferma: sul piano della comprensione
storiografica occorre invece cogliere “le strutture culturali di fondo che sostengono le due parti
in lotta, così da chiedersi perché le une siano più adatte delle altre a selezionare i crudeli e i
sadici e a far emergere con tutta evidenza al livello dei comportamenti politicamente rilevanti le
più oscure pulsioni dell'animo umano” (Ibid.). Resta tuttavia il problema di come considerare un
tale “sostrato torbido” che pesca tra le più “oscure pulsioni dell'animo” e che sfugge al contesto
storico collocandosi apparentemente in una dimensione, se non naturale, almeno di
lunghissima durata: si tratta semplicemente una nozione-limite, attorno alla quale l'analisi
storiografica può solo girare, disegnandone per così dire i contorni in negativo, oppure è
qualcosa che può esser “chiarita” dalla storiografia o da altre discipline?
Più netta in questo senso è la posizione di Leonardo Paggi, che si sofferma più volte sulla
natura per molti aspetti “rituale” e “sacrificale” del massacro nazista e parla, anch'egli, di
“riemergenza di sostrati profondi” (1996: 69). Paggi si trova nella eccezionale situazione di
esercitare l'intelligenza storica su un evento - l'eccidio di Civitella, appunto - di cui, bimbo di tre
anni, è stato diretto testimone. Ciò lo porta ad approfondire con forza particolare il problema
dell'esperienza soggettiva del massacro, e della sua rielaborazione nella memoria. Per quanto
non tralasci alcun tentativo di interpretazione storica e contestuale, egli è attratto dalle profonde
strutture antropologiche e psicologiche che il massacro va a toccare, sia dal punto di vista degli
assassini che da quello delle vittime, e tenta di darne conto in termini di nozioni come “rito
sacrificale” e “pulsione di morte”. Il massacro nazista, scrive, “si configura anche come risultato
di una «eredità arcaica», come collasso dei sistemi di autocoercizione, come emergenza di
comportamenti e significati quasi in via di principio sbrigativamente estromessi dal nostro
presente”. In altre parole, nel bel mezzo di una guerra tipicamente moderna, condotta sulla
5 / 27
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
base di un impianto di razionalità strumentale e tecnica senza precedenti, si apre un abisso che
porta dritti allo stato arcaico - si sarebbe tentati di dire selvaggio - dell'umanità. E' qui che per
Paggi diviene possibile, anzi necessario, innestare la comprensione antropologica o
psicoanalitica sul tronco di quella storiografica:
Si apre qui il terreno di una antropologia del massacro, ancora tutta da fare, che difficilmente
potrà evitare di misurarsi - credo - con il grande tema dei riti sacrificali di morte, che segnano
profondamente, in senso sincronico e diacronico, tutta la storia della cultura umana (Paggi
1996: 8).
Un altro autore che, sia pure con toni diversi, ha affrontato direttamente questo tipo di
problema è Gabriele Ranzato. Un suo recente volume studia un caso di linciaggio nella Roma
appena liberata del 1944: Donato Carretta, ex direttore delle carceri di Regina Coeli,
collaborazionista minore tardivamente passato dalla parte del movimento di liberazione, viene
ucciso da una folla inferocita radunata per assistere a un processo: il suo cadavere viene
scempiato e infine appeso a testa in giù davanti all’ingresso del carcere. Ranzato, dopo una
acutissima analisi dell’evento, dei suoi protagonisti de delle loro motivazioni, riconosce infine di
trovarsi di fronte a un fenomeno non comprensibile - almeno, non pienamente - in termini di
agire razionale e di categorie meramente politiche; uno di quei “fenomeni che scompaginano le
carte della pretesa razionalità della politica” (Ranzato 1997: 203). L’autore mette a fuoco in
particolare due elementi. Da un lato, il linciaggio si configura come un'eplosione di violenza di
massa apparentemente irrazionale, sia per i modi estremi della sua manifestazione che per
l'oggetto cui si rivolge: per quanti pretesti si possano trovare per questa violenza, essa non ha
alcuna causa o motivazione razionale in senso stretto. Dall'altro lato, Ranzato sottolinea la
qualità particolare del linciaggio: non solo la spietata crudeltà degli esecutori, ma soprattutto
quella che potremmo chiamare la sintassi simbolica della violenza messa in atto, il suo
articolarsi secondo modalità formali che richiamano riti di rovesciamento del potere tipici delle
società di antico regime. Cosa spinge la folla ad agire? Chi o che cosa guida la folla ad un
comportamento ritualizzato che, come aveva scritto un commentatore dell'epoca, non si vedeva
a Roma dai tempi di Cola di Rienzo, e che con il linciaggio di Cola presenta sconcertanti
analogie? (Ibid.: 127-8). 6 / 27
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
Ancora una volta, si aprono problemi la cui soluzione sembra spingere risolutamente al di
fuori del particolare contesto storico. Ranzato offre una risposta complessa e articolata, che non
è qui possibile discutere nei dettagli. Ma anch'egli, come Pavone e Paggi, mette a fuoco il
fenomeno del riemergere di un sostrato culturale arcaico, che sembrava definitivamente
soffocato dal processo di civilizzazione; e anch'egli ritiene necessarie, per la soluzione di
questo enigma, ampie aperture interdisciplinari, in grado di individuare elementi che restano
invisibili all'indagine empirica dello storico. Se il linciaggio di Carretta ci mostra comportamenti
sociali guidati da regole di cui gli attori stessi sono (individualmente e collettivamente)
inconsapevoli, per comprenderlo abbiamo bisogno di far riferimento a qualcosa come
l'inconscio o le strutture antropologiche: E' evidente [...] che attraverso la falla lasciata aperta dall'ammissione di una presenza
dell'inconsapevole nella spiegazione politica dell'evento di cui ci siamo occupati, passano altri
saperi: la psicologia, l'antropologia e, in sede di indagine storiografica, una storiografia più
aperta al contributo di queste discipline anche per quel che riguarda lo studio degli avvenimenti
dell'età contemporanea (Ibid. 203).
3. Fra Hobbes e Rousseau
Antropologia, psicoanalisi, scienze umane sono dunque chiamate in causa da storici dell'età
contemporanea, per la comprensione di eventi di guerra e di violenza che presentano un
enigmatico “di più”, quantitativo e qualitativo, rispetto a quanto la razionalità contestuale
consentirebbe di aspettarsi. Questo appello a un approccio interdisciplinare è assai coraggioso
e innovativo. Per quanto riguarda l'antropologia culturale, viene così superata la tradizionale
tendenza a riservarle lo studio delle società senza Stato - il che equivale talvolta a dire “naturali”
o “senza storia” e dunque soggette a un determinismo generalizzante e nomotetico, laddove le
società statuali o moderne sarebbero di esclusiva competenza di un approccio individuante o
idiografico, dunque della storiografia. Questa divisione del lavoro, peraltro, è stata spesso ben
7 / 27
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
accetta agli stessi antropologi, perché coerente con la dominante impostazione epistemologica
della loro disciplina. Il che giustifica ampiamente le cautele espresse da Ranzato, secondo cui
le maggiori difficoltà all'integrazione, alla compenetrata collaborazione di psicanalisi, politica,
antropologia e storia, dipendono in gran parte dalla loro scarsa flessibilità, o meglio dalla rigidità
e pretesa onnicomprensività di molte teorie che si sviluppano nel loro ambito. Integrazione
presuppone infatti rinuncia alle ambizioni totalizzanti, a quelle chiavi interpretative che appaiono
tanto più esplicative di tutto, quanto più si allontanano dai fatti (Ibid.: 204).
Ranzato si riferisce alla teoria del capro espiatorio di René Girard come esempio di approccio
sì suggestivo e stimolante, ma tanto astratto e speculativo da non riuscire plausibilmente a
calarsi nella concretezza di un preciso caso storiografico. La sua osservazione, tuttavia, si
applica in effetti a un ampio ventaglio di approcci socio-antropologici. Il che ci riporta a quanto
osservato in precedenza, circa la tendenza a spiegare la dimensione non immediatamente
politico-razionale della guerra in termini di ipotesi universalistiche, di appelli a caratteristiche
generali della natura umana. Una volta esaurite le spiegazioni razionali, non resta che
riconoscere che “l'uomo è una belva”, o, per usare la più solenne e famosa formulazione di
Einstein, che “l'uomo alberga in sé il bisogno di odiare e di distruggere” (Einstein-Freud 1933:
291). E non resta che rivolgersi agli specialisti di una scienza dell'uomo che getti luce sulle più
recondite profondità della sua vita psichica e della sua costituzione antropologica, assunte
come invarianti che fanno da sfondo alla storia più che esserne prodotte. E' appunto quello che
fa Einstein quando decide di interpellare Freud sul problema “perché la guerra?”, ritenendo la
domanda in ultima analisi “un enigma che può essere risolto solo da chi è esperto nella
conoscenza degli istinti umani” (Ibid.). Freud, da parte sua, accetta il ruolo di esperto degli istinti
nonché dell'evoluzione culturale, e offre in risposta una piccola summa degli aspetti più
speculativi della sua intera opera. Certo che l'uomo alberga in sé una innata aggressività, e
persino una pulsione di morte. Questa non si può abolire: si può soltanto cercare di deviarla o
scaricarla (la celebre teoria “idraulica”), o di interiorizzarla trasformandola così in vincolo
morale, affinché non sfoci nella guerra ma in comportamenti socialmente accettabili.
Il carteggio Einstein-Freud è tipico del clima culturale della prima metà del secolo, e del
rapporto che in esso si instaura tra scienze umane e senso comune. Da un lato, vi è la diffusa
8 / 27
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
convinzione che antropologia e psicoanalisi possano dare risposte scientifiche e
oggettivamente valide a eterni quesiti morali o religiosi: ad esempio la natura del male, la
fondamentale bontà o cattiveria degli uomini, i legami esistenti tra sessualità e aggressività, e
così via. Dall'altro lato le scienze umane, quando escono dal loro specifico ambito di indagine e
si avventurano su questi terreni, quasi sempre non possono far altro che riproporre e
accreditare le buone vecchie storie del senso comune, e in particolare una qualche variante dei
miti di Hobbes e Rousseau sull'originaria natura morale degli esseri umani. La già citata
rassegna di Pick (1993) mostra in modo assai convincente la continuità, tra Ottocento e
Novecento, delle teorie scientifiche su guerra e aggressività con le relative elaborazioni della
letteratura, dell'ideologia e del senso comune.
Dunque, possono le scienze umane rispondere adeguatamente alle richieste che gli storici
pongono loro? Possono davvero dirci qualcosa di interessante su quel “substrato” oscuro,
arcaico e irriducibile al contesto che la guerra sembra invariabilmente riportare alla luce? Non
vorrei soffermarmi qui in una discussione della psicoanalisi della guerra, se non per constatare
la sua palese e persistente difficoltà a passare da penetranti interpretazioni della condotta e
della vita psichica individuale e familiare a teorie sulla cultura e sulla società. Se le speculazioni
meta-psicologiche di Freud, da Totem e tabù a Perché la guerra, hanno svolto un importante
ruolo culturale e sono ancora oggi interessanti, è in virtù della loro natura mitopoietica e
letteraria, non del valore scientifico o del radicamento nell'indagine empirica. (Lo stesso Freud
sembra ammetterlo quando scrive ad Einstein: “Lei ha forse l'impressione che le nostre teorie
siano una specie di mitologia, neppure lieta in verità. Ma non approda forse ogni scienza
naturale a una sorta di mitologia?”; in Einstein-Freud 1933: 100). E lo stesso si può dire di molti
suoi successori, nella misura in cui continuano a misurarsi con teorie generali sulla guerra e con
il problema della sua origine o fondazione. Difficile ad esempio trovare un uso all'interno della
comprensione storiografica (o antropologica, se è per questo) per la tesi di Franco Fornari,
autore negli anni '60 di un fortunato libro sulla psicoanalisi della guerra, secondo il quale essa
rappresenta “una istituzione sociale volta a curare angosce paranoicali e depressive esistenti
[...] in ogni uomo” (1966: 14).
Ma che dire dell'antropologia culturale? Sarebbe ragionevole pensare che il suo sviluppo
novecentesco come scienza empirica, radicata in rigorose metodologie di ricerca, l'abbia
portata a offrire risposte più solide e convincenti rispetto alle antiquate speculazioni. E' difficile
dire se sia davvero così. Si può cominciare con l'osservare come l'antropologia culturale
moderna abbia studiato relativamente poco il fenomeno della guerra, per almeno due motivi. Il
primo è l'ovvia difficoltà ad applicare alla guerra il metodo principe della ricerca etnografica l'osservazione partecipante. Il secondo consiste nel fatto che gli antropologi hanno avuto più
facilmente accesso a società “pacificate”, prive di guerra semplicemente perché la loro
organizzazione militare e la loro eventuale bellicosità sono state soffocate dal potere coloniale.
Il che spiega la quasi totale assenza della guerra in molte delle più classiche monografie
etnografiche. Nonostante questo, il problema della guerra (insieme a quello connesso, ma
evidentemente non coincidente, della violenza) è stato al centro di una letteratura specializzata,
9 / 27
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
non particolarmente ampia ma dotata di una certa compattezza (si veda una vasta bibliografia
in Ferguson-Farragher 1988, e rassegne antologiche in Riches 1986, Haas 1990 e
Reyna-Downs 1997). Vediamone, in estrema sintesi, alcuni tratti.
4. L’antropologia della guerra
Si tratta in primo luogo di studi monografici su singole popolazioni: l'esempio più tipico è forse
rappresentato dai lavori di Napoleon Chagnon (1968) sugli amazzonici indios Yanomami,
presentati come emblema di un popolo guerriero e violento, costantemente impegnato in raid
assassini condotti tra villaggi nemici. Per altro verso, sul versante per così dire rousseauviano,
assai noti sono alcuni studi su popolazioni pacifiche (tipicamente piccole comunità egalitarie e
non competitive di cacciatori e raccoglitori o orticoltori), come quelli di Jean Briggs (1970) sugli
eschimesi o di Colin Turnbull (1961) sui pigmei Mbuti dello Zaire (monografie dai titoli assi tipici
come Never in Anger, The Harmless People etc.; se ne veda una rassegna in Knauft 1987). Un
secondo filone di studi riguarda prevalentemente l'antropologia fisica, e consiste in analisi di
reperti paletnologici volte a determinare la presenza di pratiche di violenza letale intraspecifica o
di vera e propria guerra in età preistorica (si veda Martin-Frayer 1997 per una recente rassegna
e valutazione di questo tipo di indagine).
In terzo luogo, l'antropologia della guerra consiste in studi di tipo comparativo e teorico, volti a
produrre generalizzazioni e a scoprire nessi causali in relazione al fenomeno della guerra tra
quelli che un tempo si dicevano i “primitivi”. Questo interesse è maturato soprattutto in ambito
statunitense, tra autori vicini al neo-evoluzionismo, all'ecologia culturale e, in molti casi, alla
sociobiologia. Le domande cui essi sono interessati riguardano l'origine e le cause della guerra,
e soprattutto la correlazione fra l'intensità e la frequenza delle guerre e determinate condizioni
ecologiche, economiche (popoli cacciatori e agricoltori, nomadi o sedentari) e sociali (sistemi di
discendenza patri- e matrilineari, sistemi di potere, stratificazione sociale e così via; v. Ferguson
1990, 1994, 1997). Tipico di questo approccio è ad esempio il lavoro dei coniugi Ember che,
all'interno del programma Human Relations Area Files, hanno tentato una immane
comparazione tra centinaia di culture etnograficamente registrate, estraendone dati passibili di
analisi quantitativa e di generalizzazioni statisticamente significative (Ember-Ember 1982,
1997). Occorre infine citare gli studi sulla violenza intraspecifica e sui raid guerreschi tra i
10 / 27
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
primati, che il neo-evoluzionismo e la sociobiologia considerano assai rilevanti anche in
prospettiva etnologica (v. fra gli altri Manson-Wrangham 1991, Wrangham-Peterson 1996).
Ora, in che misura questi studi rispondono alle domande sopra sollevate? Riescono
veramente a sostituire un sapere oggettivo ed empiricamente fondato alle generiche
speculazioni sulla belva umana o sul buon selvaggio? Mi pare vi sia da dubitarne. Proprio
l'impostazione naturalistica dell'antropologia della guerra, la sua ossessione per la
quantificazione e per la scoperta di leggi generali, la allontanano dalla concretezza e
complessità dei contesti empirici. I “dati” sono costantemente semplificati al fine di renderli
misurabili e utilizzabili statisticamente: la realtà etnografica cui siamo posti di fronte è fatta,
come nel caso degli Ember, di frequenze temporali delle guerre, di incidenza statistica delle
morti violente, e così via. Tali quantificazioni assumono prima di tutto una impossibile oggettività
dei fatti etnografici, depurati del tutto della dimensione del significato e di quella della storia. A
meno di non pensare all'etnografia come a una sorta di entomologia, è chiara la dipendenza dai
quadri interpretativi dei dati anche più semplici: perfino contare il numero di morti violente, o la
percentuale di maschi che hanno partecipato all'uccisione di qualcuno, o delle persone che
hanno perso un consanguineo per atti violenti – alcuni degli indicatori che Chagnon usa per gli
Yanomami - non sono operazioni banali e scontate. Quando ci caliamo solo un po' più a fondo
nel contesto etnografico, possiamo accorgerci quanto questi dati siano interpretati, e scoprire
che un diverso quadro interpretativo potrebbe produrre “dati” assolutamente divergenti. E’ il
caso appunto di Chagnon, le cui simpatie sociobiologiche sono sfociate in una
rappresentazione etnografica non solo non oggettiva, ma fortemente ideologizzata e per molti
assolutamente fuorviante (v. Albert 1989). In secondo luogo, anche prendendo per buone le procedure di quantificazione, le “scoperte”
raggiunte su questa base sono empiricamente controverse e piuttosto deludenti sul piano
teorico. Se ne possono sintetizzare i risultati con le parole che Brian Ferguson usa in chiusura
di un recente volume su guerra e violenza nella preistoria:
Se c'è chi crede che violenza e guerra non esistessero prima dell'avvento del colonialismo
occidentale, o dello Stato, o dell'agricoltura, questo volume dimostra che si sbaglia.
Ugualmente, se c'è chi crede che tutte le società umane siano state afflitte da violenza e
guerra, e che queste ultime siano state sempre presenti nella storia evolutiva dell'umanità,
questo volume dimostra che si sbaglia (Ferguson 1997: 321)
11 / 27
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
Si dimostra cioè, se ce ne fosse stato bisogno, che i miti del buon selvaggio e dell’ homo
homini lupus
sono, per l'appunto, dei miti, e che la realtà della guerra è troppo varia e multiforme per essere
ingabbiata in semplici categorie. Andar oltre è pericoloso e controverso, sia in termini di
generalizzazioni empiriche che di ipotesi esplicative. Basta scorrere la letteratura per accorgersi
come non vi sia accordo sui punti più fondamentali e, apparentemente, più fattuali. Ad esempio,
in che misura è diffusa la guerra tra le società non gerarchizzate e prive di potere centrale,
considerate le più evolutivamente arretrate? I pareri sono assai discordi. E’ piuttosto noto il
punto di vista di Pierre Clastres, secondo il quale la guerra è una condizione permanente e
necessaria dell’esistenza delle società senza Stato, e solo le condizioni di forzata pacificazione
imposte dal colonialismo impedirebbero agli antropologi di rendersene conto (“Se l’etnologia
non parla della guerra è perché non è possibile parlarne dal momento che le società primitive,
quando divengono oggetto di studio, sono ormai avviate lungo la strada della trasformazione,
della distruzione e della morte: come potrebbero mai dar mostra della propria libera vitalità
guerriera?”; Clastres 1997: 30). Questa tesi, che Clastres assume come autoevidente, è
sostanzialmente suffragata dai dati degli Ember, secondo i quali, “in assenza di poteri esterni
che impongano la pacificazione, la guerra è quasi onnipresente nelle registrazioni etnografiche”
(Ember-Ember 1997: 5). Ma tali dati sono decisamente contestati da altri ricercatori, che
sottolineano l’esistenza di numerose società semplici sostanzialmente pacifiche e prive di
un’ideologia guerriera - un pacifismo primario, per così dire, che non v’è motivo,
contra
Clastres, di considerare come un simulacro prodotto dall’oppressione imperialista (v. fra gli altri
Ferguson 1997: 330-2, e Knaupf 1987, 1991; quest’ultimo autore sottolinea tuttavia la
correlazione tra assenza di guerre esterne e alta percentuale di violenza letale interna al
gruppo).
Ciò che colpisce in queste discussioni, informate da una retorica scientista e da costanti
richiami all’oggettività e alla neutralità dei fatti, è la totale impossibilità di risolverle sul piano
empirico. Non solo nessun dato particolare potrebbe mai smentire tesi così generali o schemi
comparativi di tale ampiezza; ciò che più importa, ogni dato etnografico impiegato è di per sé
controverso, e non è possibile il controllo diretto delle fonti. La gran massa di fatti integrati nelle
tabelle della Human Relations Area Files, ad esempio, semplicemente non può esser verificata
in modo indipendente: accettare o osteggiare le generalizzazioni che ne sono tratte dipenderà
da motivi largamente culturali e non scientifici in senso stretto. Il che è uno stato di cose
normale per l’etnografia: solo che ne andrebbero riconosciute le conseguenze epistemologiche.
Lo stesso vale per le teorie esplicative elaborate dall’antropologia della guerra. Seguendo un
utile schema di Clastres, possiamo sintetizzarle suddividendole in tre tipi: teorie naturaliste,
12 / 27
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
teorie economiciste e teorie dello scambio. Le prime sono le teorie che radicano la guerra in
una generica propensione umana all’aggressività e alla violenza, considerate come dati naturali
o proprietà zoologiche che hanno avuto - e che hanno ancora, eventualmente - un ruolo
fondamentale nell’adattamento della specie. E’ la prospettiva sostenuta con forza dall’etologia
e, con accenti diversi, dal neo-evoluzionismo e dalla sociobiologia. Clastres (1997: 33) ne vede
la formulazione più tipica in uno dei capolavori dell’etnologia novecentesca, Il gesto e la parola
di Leroi-Gourhan: un’opera che legge i principali problemi della contemporaneità in termini di
divario tra evoluzione biologica ed evoluzione sociale dell’umanità. “Il comportamento
aggressivo – scrive Leroi-Gourhan – fa parte della realtà umana almeno a partire dagli
Australantropi e l’accelerata evoluzione del sistema sociale non ha cambiato in nulla il lento
sviluppo della maturazione filetica” (1964-5: 199-200). La guerra moderna sarebbe allora lo
sbocco inevitabile di istinti e tendenze che si impongono in quanto adattive, ma per le quali non
vi sono più spazi (se non fortemente surrogati: p.es. gli sport) nella normale vita economica e
sociale. Le teorie economiciste fanno risalire la necessità della guerra per i primitivi alla scarsità di
risorse, e dunque alla concorrenza fra gruppi per accaparrarsi beni necessari alla
sopravvivenza. Anche in questo senso, la guerra avrebbe una funzione adattiva: le teorie
ecologiche, o quelle del materialismo culturale alla Marvin Harris, che stabiliscono strette
correlazioni fra la presenza-assenza di guerra e la quantità di proteine disponibili nell’ambiente,
confinano strettamente con quelle naturaliste. Clastres classifica anche l’approccio marxista
nella categoria delle teorie economiche, dandone una valutazione ferocemente critica e, a me
pare, semplicistica. Coglie tuttavia bene un punto che accomuna il marxismo e molte teorie
naturalistiche: la necessità di assumere, come postulato di filosofia della storia, la miseria
dell’economia primitiva, senza la quale essa non potrebbe servire da punto di partenza di un
processo di costante sviluppo delle forze produttive. Assunto, questo, che Clastres critica con
forza, richiamandosi alle analisi di Sahlins sulle società primitive come società dell’abbondanza
e del loisir, nelle quali un tempo ridottissimo della vita individuale viene dedicato alla
produzione.
Infine, le teorie che Clastres definisce dello scambio sono quelle di tipo sociologico: in
particolare, egli si riferisce a Lévi-Strauss e ad un singolo passo della sua opera in cui si
afferma che “gli scambi commerciali rappresentano guerre potenziali pacificamente risolte, e le
guerre sono il risultati di transazioni sfortunate” (Clastres 1997: 40). La guerra non avrebbe
dunque carattere primario, ma sarebbe il sottoprodotto o l’indesiderata conseguenza di più
generali strutture sociologiche. All’elenco andrebbe forse aggiunta la teoria che lo stesso
Clastres (con un po’ troppa enfasi) contrappone alle precedenti, basata sull’idea di guerra come
meccanismo di protezione dell’autonomia e dell’interno livellamento delle società senza Stato:
13 / 27
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
La guerra primitiva è manifestazione di una logica centrifuga, una logica della separazione
che si esprime periodicamente attraverso il conflitto armato. La guerra serve a mantenere ogni
comunità nel proprio stato di indipendenza politica; finché c’è guerra, c’è autonomia […] La
guerra è la più significativa forma di esistenza della società primitiva nella misura in cui
quest’ultima si distribuisce sul territorio in unità sociopolitiche eguali, libere e indipendenti: se i
nemici non esistessero, bisognerebbe inventarli (Ibid.: 63).
5. Storiografia e antropologia
Se c’è qualcosa che accomuna questi approcci teorici, è la loro tendenza a restare ancorati a
questioni troppo generali o generiche sul perché della guerra o sulla sua origine. Non intendo
negare valore specifico agli studi che ho troppo rapidamente passato in rassegna; colpisce
tuttavia la sproporzione tra le loro esigenze di radicamento empirico e l’enormità – direi quasi
metafisica – delle domande che si pongono. Nell’approccio sociologico di Clastres e nel
raffinato evoluzionismo di Leroi-Gourhan, non meno che nel materialismo culturale o nella
sociobiologia, si avverte la presenza di una Grande Teoria dalle aspirazioni totalizzanti; si
avverte ancora qualcosa della pretesa ottocentesca di rispondere con il linguaggio della scienza
alle domande ultime della religione e dell’etica sul bene, sul male, sul destino dell’umanità. Non
possiamo allora stupirci se ci troviamo di fronte argomenti come il seguente, in difesa di una
spiegazione sociobiologica della violenza:
Gli attributi delle persone e di altri animali sono stati plasmati da una storia di selezione che
ha promosso l’adattamento […] Le uniche alternative alle spiegazioni darwiniane delle proprietà
adattive degli organismi sono miti religiosi consapevolmente inventati. Gli sforzi di “confutare” la
sociobiologia sono dunque futili: sarebbe come cercare di confutare l’antropologia stessa
(Daly-Wilson 1987: 483).
14 / 27
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
Sociobiologia a parte, tutto ciò ci riporta alle cautele espresse da Gabriele Ranzato verso le
ambizioni totalizzanti delle scienze sociali, verso la loro inguaribile tendenza a ricercare “chiavi
interpretative che appaiono tanto più esplicative di tutto, quanto più si allontanano dai fatti”.
Dunque, dobbiamo concludere che l’antropologia culturale non è attrezzata per rispondere alle
richieste e alle aperture di credito da parte degli storici? Che non è pronta a integrarsi con la
storiografia in un progetto di comprensione della guerra e della violenza della nostra epoca?
Naturalmente, il punto è un altro. Gli studi specialistici di antropologia della guerra si sono
mantenuti all’interno dei più stretti e tradizionali confini della disciplina, individuando come
proprio oggetto la guerra in società semplici o primitive e trattando queste ultime come entità
quasi-naturali, immerse nel tempo eminentemente non-storico dell’evoluzione. Hanno dunque
consapevolmente evitato ogni rapporto sia con la contemporaneità sia con la dimensione
storica – oltre che, per scelta di metodo, con la soggettività degli attori sociali e con quella che
potremmo chiamare la dimensione “significativa” della guerra. In quasi tutti gli studi citati i nativi
- guerrieri o pacifisti che siano - non parlano, proprio come le farfalle e gli scimpanzé: sembrano
troppo occupati con i propri attributi adattivi e con le strategie di promozione dei propri geni. Questo non è un buon punto di partenza: ma l’antropologia culturale è naturalmente anche
altro. C’è semmai da chiedersi perché gli indirizzi di taglio comprendente e interpretativo, in
linea di principio più promettenti della sociobiologia, si siano occupati così poco dei temi della
guerra e della violenza (con rare eccezioni: v. ad esempio Robarchek 1990). In ogni caso, c’è
un lavoro tutto da fare in questa direzione, valutando le possibilità interpretative di
un’antropologia che abbia rinunciato una volta per tutte a inseguire origini, essenze, leggi
generali e grandiosi schemi esplicativi. Occorre anche fare attenzione a un trabocchetto
nascosto nella chiamata in causa da parte degli storici: il rischio di contrapporre troppo
nettamente la dimensione “antropologica”, come essi la chiamano, alla contingenza storica e
contestuale, relegando così l’antropologia al ruolo di disciplina residuale e subalterna, di ultimo
rifugio per quelle spiegazioni che non si riescono a trovare nell’analisi strettamente
storiografica. Gli storici, abbiamo visto, hanno talvolta a che fare con fenomeni di dilatazione dei
contorni spazio-temporali degli eventi; sanno quanto insidioso sia uscire dal contesto, e
chiedono l’aiuto di quella guida autorizzata – per quanto malfidata – che è l’antropologia. Usano
il termine “antropologia” come se alludesse a qualcosa che sta al di là della storia – invitando
per così dire gli antropologi a un peccato per loro fin troppo familiare. A questa provocazione,
essi possono rispondere senza perdersi solo a patto di restare saldamente ancorati al contesto
storico, accettandone per intero la specificità e la complessità.
15 / 27
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
Per tornare al problema iniziale: lo scandalo storiografico di una violenza eccessiva e arcaica,
che contrasta con le stesse finalità razionali della guerra, sembra aprire lo spazio all’intelligenza
antropologica. Ma quest’ultima non può assumere la forma di una risposta generale alla
domanda “perché si uccide in guerra?”. L’antropologia non è specializzata negli oscuri recessi
dell’animo umano, o nella “dinamica universale della violenza assoluta” – non più di quanto lo
siano la storia, la biologia o, se è per questo, il senso comune. Ha semmai qualcosa da dire sul
piano delle piccole domande, dell’analisi dei microcontesti, delle strategie culturali locali. Se può
aggiungere qualcosa al sapere storico, è mettendo in gioco peculiari metodi di indagine e
categorie interpretative maturate all’interno di una tradizione intellettuale che di “scandali” etici
ed epistemici, come si esprimeva Ernesto de Martino, si è nutrita da sempre. Il caso, sopra
citato, degli studi sugli eccidi nazisti di civili è uno dei pochi che abbia finora visto incursioni
antropologiche di questo tipo, con il tentativo di chiarire le modalità eminentemente culturali di
costruzione della memoria da parte dei sopravvissuti (si veda in particolare Pasquinelli 1996,
nonché gli atti in parte ancora inediti del convegno In memory. Per una memoria europea dei
crimini nazisti
, Arezzo, 22-24 giugno
1994). Vorrei concludere richiamando un altro esempio di scandalo storiografico – anzi, lo scandalo
per eccellenza della storiografia contemporanea. Gli studi sulla Shoah sono centrati attorno al
problema che qui ci interessa: come trattare una dimensione orrifica della guerra, che sembra
mantenere un margine irriducibile di inesplicabilità a fronte di ogni possibile, per quanto ampio,
criterio di razionalità politica. In particolare il recente dibattito sulla soggettività degli esecutori
della Shoah, aperto nell’ultimo decennio dagli storici americani Cristopher Browning e Daniel J.
Goldhagen, coinvolge massicciamente le categorie dell’interpretazione antropologica. Che tipo
di esseri umani erano i massacratori dei campi di sterminio o delle fosse comuni? Come hanno
potuto compiere in modo tanto zelante azioni contrarie a principi etici apparentemente
elementari e universali? Com’è noto, Browning (1992) ritiene che i massacratori siano “uomini
comuni”, spinti verso un comportamento mostruoso dalle circostanze storiche (l’ideologia
nazista, il regime totalitario, le pressioni della situazione bellica) unitamente ai meccanismi
universali della conformità di gruppo e dell’obbedienza all’autorità. Goldhagen (1996) preferisce
invece parlare di “tedeschi comuni”, e ritiene che causa necessaria e sufficiente dello sterminio
sia la peculiare ideologia antisemita del nazismo.
Mi interessa qui solo rilevare come Goldhagen faccia diretto ed esplicito richiamo
all’approccio antropologico nella impostazione stessa del suo argomento. La Shoah ci appare
oggi inesplicabile, egli afferma, perché noi diamo troppo facilmente per scontato il presupposto
di una comune umanità dei tedeschi nel periodo nazista: li supponiamo simili a noi, o almeno al
modo in cui noi amiamo rappresentarci - “figli sobri e razionali dell’Illuminismo, non guidati dal
pensiero magico ma radicati nella realtà oggettiva” (Goldhagen 1996: 29). Dovremmo, al
contrario, guardare ai tedeschi partendo dal presupposto di una loro radicale alterità : guardarli
16 / 27
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
cioè
con l’occhio critico dell’antropologo che sbarca in una terra sconosciuta, aperto all’incontro
con una civiltà radicalmente diversa dalla propria e consapevole di dover elaborare
interpretazioni che non si adattano al suo senso comune, o persino lo contraddicono, per poter
capire la struttura di quella civiltà (Ibid.: 16).
Qui Goldhagen sembra enunciare un programma di ricerca relativista. Intende partire dal
“rifiuto dell’universalità del nostro «senso comune»” (Ibid.), mettere in discussione il
presupposto dell’affinità fra quella società e la nostra. Ciò che rende la cultura tedesca degli
anni ’30 radicalmente “altra” è appunto l’antisemitismo, nella sua peculiare variante
eliminazionista, che gode in essa dello status di modello culturale o cognitivo – concetto che
Goldhagen mutua dall’antropologia cognitiva e da autori come D’Andrade, Lakoff e Harré. Un
modello cognitivo è un insieme di assunti che forniscono la struttura della “conversazione” di
ogni società (Ibid.: 36). Tali assunti non sono semplicemente opinioni condivise: sono la base
comune a partire dalla quale le opinioni stesse possono venir espresse. Non sono oggetto di
dubbio o di certezza: sono il perno sul quale i giudizi di dubbio o certezza si incardinano.
Rappresentano dunque un prisma attraverso cui guardare il mondo, nel quale ogni membro di
una cultura è per così dire imprigionato, di cui non può neppure rendersi conto se non uscendo
dalla propria cultura. Così Goldhagen può affermare (Ibid.: 41) che gli ebrei non sono soltanto
valutati secondo i principi e le norme morali di quella cultura, ma divengono costitutivi
dell’ordine morale stesso e degli elementi cognitivi fondamentali che delineano il campo del
sociale e dell’etico. L’antisemitismo non sarebbe dunque solo un aspetto di una visione del
mondo, ma il cardine stesso attorno al quale quella visione ruota.
Goldhagen ha subìto un gran numero di critiche, fattuali e concettuali, da parte degli storici.
Ma raramente ci si è soffermati a valutare l’impianto antropologico della sua argomentazione. I
problemi antropologici che Goldhagen solleva sono reali e importanti: d’altra parte, è palese è il
fatto che egli se ne serve in modo superficiale e strumentale. Ad esempio, il concetto di modello
culturale che egli usa è decisamente semplicistico e superato dal punto di vista
dell’antropologia cognitiva. Goldhagen assume un eccessivo grado di coerenza interna del
modello, e sottovaluta sistematicamente la sua elasticità e le possibilità di divergenza
17 / 27
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
individuale (Hinton 1998: 12). Inadeguata e ingenua, ancora, è la sua discussione del
relativismo e della incommensurabilità tra sistemi etico-culturali; altrettanto ingenua la sua
concezione delle credenze (antisemite) come unica causa dell’azione genocida, concezione
che ignora la complessità dei rapporti tra ragioni, motivi e cause del comportamento.
Può darsi che la riflessione maturata dall’antropologia culturale su questi temi possa risultare
di qualche aiuto alla comprensione. Ciò che stupisce è il quasi totale silenzio mantenuto dagli
antropologi, di fronte a un dibattito che pure ha varcato i confini specialistici e ha avuto una
certa risonanza nell’opinione pubblica (l’unica eccezione di cui sono a conoscenza è Hinton
1998); silenzio che contrasta, per tornare a un punto precedente, con la quasi maniacale
attenzione alle variazioni percentuali negli episodi di morte violenta in società formate da poche
centinaia di individui. Certo, ogni disciplina ha i suoi percorsi privilegiati, e l'antropologia
procede attraverso un “giro lungo” che la porta lontano dal centro, verso i più sperduti “angoli di
mondo”. E’ anche vero, però, che la Shoah ci pone di fronte ai limiti estremi della variabilità
culturale e morale degli esseri umani, di fronte a quella che Primo Levi chiamava “una
gigantesca esperienza biologica e sociale”. C’è da chiedersi se la scienza dell’uomo e della
diversità culturale possa ignorare tutto questo.
Riferimenti bibliografici
Albert, B.
1989 “Yanomami «violence»: inclusive fitness or ethnographer's representation?”, Current
Anthropology
18 / 27
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
, 30 (5): 637-40
Brigg, J. L.
1970 Never in Anger: Portrait of an Eskimo Family, Cambridge, Cambridge University Press
Browning, C.
1992 Ordinary Men. Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland, New York,
Harper-Collins [trad.it.
Uomini comuni.
Polizia tedesca e “soluzione finale” in Polonia
, Torino, Einaudi, 1995]
Chagnon, N.
1968 Yanomamo: The Fierce People, New York, Holt, Rinehart and Winston
19 / 27
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
Clastres, P.
1997 Archeologie de la violence, Paris, Editions de l’aube (trad. it. in Archeologia della
violenza
, Roma, Meltemi,
1998: 25-67)
Contini, G.
1997 La memoria divisa, Milano, Rizzoli
Daly, M. - Wilson, M.
1987 “Comment on B.M. Knauft”, Current Anthropology, 28 (4): 482-3
Einstein, A. - Freud, S.
1933 Warum Kriege?, Paris (trad. it. “Perché la guerra?”, in S. Freud, Opere 1930-1938,
Torino, Boringhieri, 1979: 287-303)
20 / 27
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
Ember, C. R. - Ember, M.
1982 “Statistical evidence for an ecological explanation of warfare”, American Anthropologist,
84: 645-49
1997 “Violence in the ethnographic record: Results of cross-cultural research on war and
aggression”, in Martin-Frayer 1997: 1-20
Ferguson, R. B.
1990 “Explaining War”, in Haas ed. 1990: 22-50
Ferguson, R.B. (ed.)
1994 Warfare, Culture and Environment, Orlando, Academic Press
21 / 27
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
Ferguson, R. B. - Farragher, L.
1988 The Anthropology of War: A Bibliography, New York, Harry Frank Guggenheim
Foundation Fornari, F.
1966 Psicoanalisi della guerra, Milano, Bompiani
Goldhagen, Daniel J.
1996 Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust, New York, A. Knopf
[trad.it.
I volenterosi
carnefici di Hitler
, Milano, Mondadori, 1997]
Haas, J. (ed.)
1990 The Anthropology of War, Santa Fe, School of American Research Press
22 / 27
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
Hinton, A. L.
1998 “Why did the Nazis kill? Anthropology, genocide and the Goldhagen controversy”, Ant
hropology Today
, 14 (5):
9-15
Knauft, B.
1987 “Reconsidering violence in simple human societies”, Current Anthropology, 28: 457-99
1991 “Violence and sociality in human evolution”, Current Anthropology, 32: 391-428
Manson, J.H. - Wrangham, R.W.
1991 “Intergroup aggression in chimpanzees and humans”, Current Anthropology, 32 (4):
369-90
23 / 27
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
Martin, D. L. - Frayer, D. W. (eds.)
1997 Troubled Times. Violence and Warfare in the Past, Langhorne, PA, Gordon and Breach
Paggi, L. (a cura di)
1996 Storia e memoria di un massacro ordinario, Roma, Il Manifesto
1997 La memoria del nazismo nell’Europa di oggi, Firenze, La Nuova Italia Pasquinelli, C.
1996 “Memoria versus ricordo”, in Paggi 1996: 111-29
24 / 27
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
Pavone, C.
1991 Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Torino, Bollati
Boringhieri
1996 “La violenza e le fratture della memoria”, in Paggi 1996: 15-23
Pezzino, P.
1997 Anatomia di un massacro. Controversia sopra una strage tedesca, Bologna, Il Mulino Pick, D.
1993 War Machine. The Rationalization of Slaughter in the Modern Age, New Haven, Yale
University Press (trad.it.
La guerra nella cultura
contemporanea, Bari, Laterza, 1994)
Reyna, S.P. - Downs, R.E. (eds.)
25 / 27
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
1994 Studying War: Anthropological Perspectives, Langhorne, PA, Gordon and Breach
Sofsky, W.
1996 Traktat über die Gewalt, Frankfurt a.M., Fischer Verlag (trad. it. Saggio sulla violenza,
Torino, Einaudi, 1998)
Ranzato, G.
1997 Il linciaggio di Carretta, Roma 1944. Violenza politica e ordinaria violenza, Milano, Il
Saggiatore
Riches, D. (ed.)
1986 The Anthropology of Violence, Oxford, Blackwell
26 / 27
Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia
Scritto da Fabio Dei
Domenica 15 Novembre 2009 17:22 -
Robarchek, C.
1990 “Motivations and material causes: on the explanation of conflict and war”, in Haas ed.
1990: 56-76
Turnbull, C. M.
1961 The Forest People, Garden City, Natural History Press (trad. it. I pigmei. Il popolo della
foresta
, Milano, Rusconi,
1979)
Wrangham, R. - Peterson, D.
1996 Demonic Males. Apes and the Origins of Human Violence, London, Bloomsbury
Publishing
27 / 27