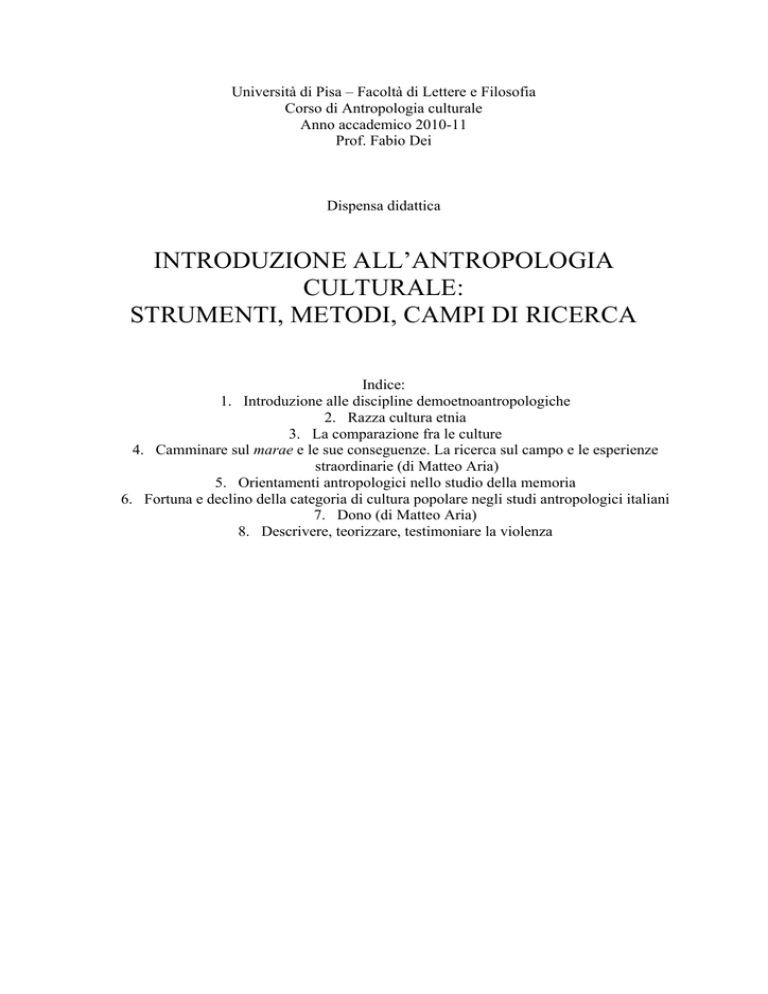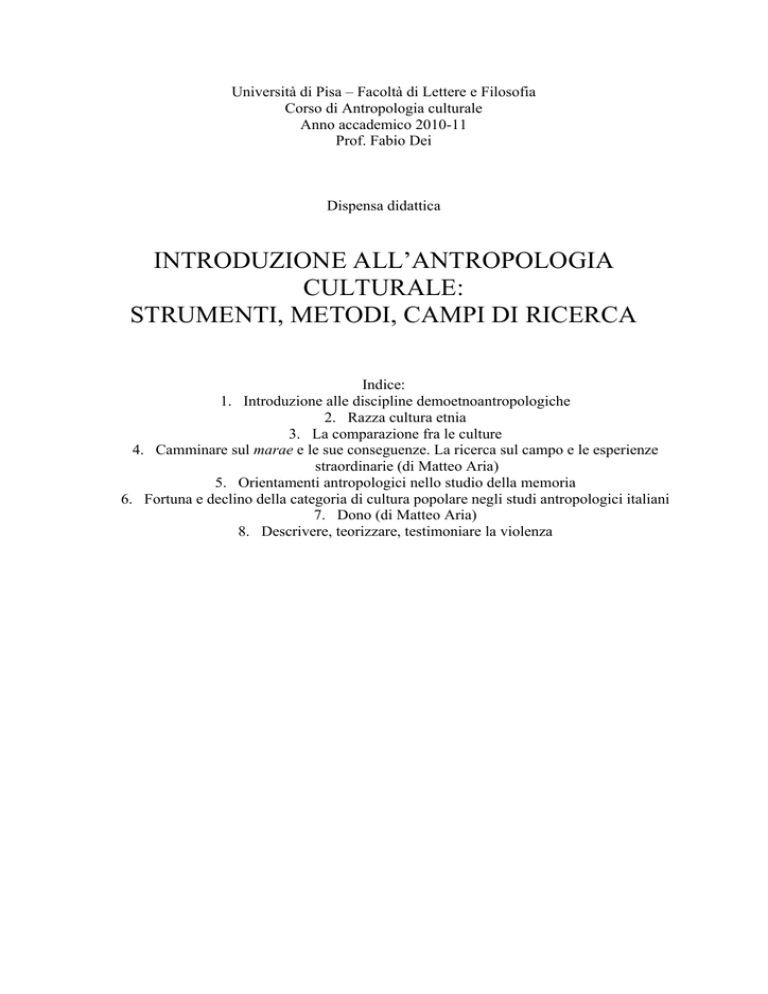
Università di Pisa – Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di Antropologia culturale
Anno accademico 2010-11
Prof. Fabio Dei
Dispensa didattica
INTRODUZIONE ALL’ANTROPOLOGIA
CULTURALE:
STRUMENTI, METODI, CAMPI DI RICERCA
Indice:
1. Introduzione alle discipline demoetnoantropologiche
2. Razza cultura etnia
3. La comparazione fra le culture
4. Camminare sul marae e le sue conseguenze. La ricerca sul campo e le esperienze
straordinarie (di Matteo Aria)
5. Orientamenti antropologici nello studio della memoria
6. Fortuna e declino della categoria di cultura popolare negli studi antropologici italiani
7. Dono (di Matteo Aria)
8. Descrivere, teorizzare, testimoniare la violenza
1. INTRODUZIONE ALLE DISCIPLINE
DEMOETNOANTROPOLOGICHE
1. Cosa significa M-DEA/01?
Lo studente di una Facoltà umanistica che si imbatte, nel proprio ordinamento didattico, nella sigla
M-DEA/01, la troverà forse piuttosto misteriosa; e resterà magari ancora più perplesso di fronte
allo scioglimento dell’acronimo: M-DEA significa “discipline demoetnoantropologiche”. Questa
denominazione un po’ astrusa riprende e combina i nomi dei tre principali insegnamenti di questo
settore scientifico-disciplinare, che sono:
- Antropologia culturale
- Etnologia
- Demologia o Storia delle Tradizioni Popolari.
Si tratta di tre scienze umane e sociali il cui oggetto è, sia pur vagamente, indicato dall’etimologia:
studio dell’uomo e delle culture umane, nelle loro articolazioni etniche e nelle loro espressioni
popolari. Il concetto di cultura è fondamentale per la definizione di queste discipline. In
antropologia, diversamente dal linguaggio comune, parlando di cultura non si intendono soltanto gli
alti prodotti del lavoro intellettuale, come l’arte, la letteratura e così via; si intende piuttosto il
complesso degli elementi non biologici attraverso i quali i gruppi umani si adattano all’ambiente e
organizzano la loro vita sociale. Fanno parte ad esempio della cultura gli attrezzi e le tecniche del
lavoro, le istituzioni sociali, le forme della parentela, il linguaggio e i modi della comunicazione, le
conoscenze, i valori e le credenze, i gesti e le più piccole pratiche quotidiane, e così via. Di fatto, è
impossibile definire la cultura attraverso un elenco: del concetto sono state proposte numerosissime
definizioni, ed è un punto sul quale torneremo.
Occorre però sottolineare la distinzione tra aspetti biologici e culturali: per quanto nella nostra
vita siano inestricabilmente intrecciati, essi sono tuttavia oggetto di scienze diverse. Le
caratteristiche e l’evoluzione biologica della specie umana sono studiati dall’antropologia fisica, che
nella classificazione accademica italiana è detta “Antropologia” senza ulteriori aggettivi, ed
appartiene al settore scientifico-disciplinare L-BIO/08. Si tratta di una disciplina imperniata sui
saperi delle scienze naturali, laddove l’antropologia culturale, come vedremo, si muove in una
dimensione vicina a quelle della storia e della filosofia, giungendo spesso a rifiutare esplicitamente
l’impiego di metodologie naturalistiche. Per quanto se ne auspichi spesso e giustamente
l’integrazione, i due ambiti disciplinari – biologico e culturale – restano distanti e dialogano poco, a
causa delle basi scientifiche e delle esperienze di ricerca assai diverse che caratterizzano i loro
praticanti. Avremo tuttavia modo di vedere, in vari capitoli di questo libro, quanto sia difficile e
ambiguo separare in modo netto l’ambito del “biologico” da quello del “culturale”: anzi, è proprio
questa separazione che può impedirci di sciogliere alcuni fra i più importanti problemi
dell’antropologia. .
Tornando al settore DEA, i tre elementi che lo compongono non si differenziano oggi in modo
netto, anche se rimandano a tradizioni di studio distintive. Con “Etnologia” ci si riferisce
prevalentemente a studi settoriali su specifici popoli e culture in ogni parte del mondo;
“Demologia” indica lo studio della cultura popolare e tradizionale nella nostra stessa società; nell’
“Antropologia culturale”, infine, l’accento è posto su ampi approcci di tipo teorico e comparativo.
La questione è ulteriormente complicata dal fatto che sul piano internazionale questi termini
vengono usati con significati leggermente diversi: ad esempio in Francia è “Ethnologie” a indicare
di solito l’intero ambito disciplinare; in Gran Bretagna prevale la denominazione “Social
Anthropology”. “Demologia”, poi, è un termine solo italiano, e quasi dappertutto si usa il termine
“Folklore” a indicare sia gli studi sia il loro oggetto. In ogni caso, si tratta di distinzioni che oggi
hanno poco senso, a fronte del processo di globalizzazione e dei mutamenti storici radicali dei
contesti in cui gli antropologi si trovano a lavorare. Questo ci porta però a introdurre alcuni
riferimenti storici, senza i quali è impossibile chiarire l’identità delle discipline DEA.
2. L’origine dell’antropologia culturale
E’ nella seconda metà dell’Ottocento che l’antropologia culturale si organizza come autonoma
disciplina scientifica, con specifici insegnamenti universitari e un proprio peculiare statuto
epistemologico. Di solito si fa corrispondere la sua “nascita” con il 1871, anno di pubblicazione di
un libro di E.B. Tylor, dal titolo Primitive Culture, che definisce e mette a fuoco il campo di studi
della nuova scienza – la cultura, appunto. Naturalmente, si tratta di una data convenzionale. Alcuni
antropologi amano retrodatare le proprie origini, vedendo precursori in varie epoche della storia del
pensiero: da Erodoto, a un filosofo come Montaigne, alla Societé des observateurs de l’homme.
Altri, al contrario, pensano che non si possa parlare di una antropologia moderna prima del
Novecento, prima cioè dello sviluppo di quelle metodologie di ricerca sul campo che diverranno nel
XX secolo tratto distintivo della disciplina. Resta il fatto che sul piano istituzionale l’antropologia
culturale si costituisce negli ultimi decenni dell’Ottocento, prima all’interno della scuola
evoluzionista britannica e poi in altri paesi europei e negli Stati Uniti. E’ il periodo del positivismo,
della grande fiducia nella scienza e nel progresso, e di uno sviluppo capitalistico visto come
inarrestabile. E’ il periodo del trionfo dei nazionalismi e del colonialismo. I ceti dominanti europei
si considerano punta di diamante di una civilizzazione irresistibilmente proiettata verso il futuro,
separata dal resto del mondo dall’irreversibile spartiacque della modernizzazione.
In questo clima, l’antropologia si definisce come la scienza di ciò che l’Europa si è lasciata alla
spalle, di ciò che non ha superato lo spartiacque. Il titolo del libro di Tylor ne definisce
puntualmente il campo: al concetto di cultura si aggiunge, appunto, l’aggettivo “primitiva”. Rispetto
ad altre scienze umane, come la sociologia, l’antropologia si caratterizza per lo studio dei
“primitivi” – cioè proprio di quei gruppi, non toccati dalla modernità, che sono al tempo stesso
oggetto del dominio e della violenza coloniale. Ad essi sono in qualche modo assimilati i ceti
subalterni delle stesse società occidentali, in particolare il mondo contadino, illetterato e calato in
forme di vita tradizionali, spesso viste come vere e proprie “sopravvivenze” della cultura primitiva.
Gli studi di folklore si presentano dunque come paralleli e complementari a quelli etnologici,
impegnati sul fronte dei “dislivelli interni” di cultura piuttosto che su quelli “esterni”.
Occorre subito notare come tutto ciò sia all’origine di una tensione intellettuale che dominerà,
senza mai sciogliersi interamente in un senso o nell’altro, tutti i futuri sviluppi della disciplina. Da
un lato, parlare di cultura dei primitivi significa contrapporsi a un senso comune che li considera
semplicemente come “bestiali” e privi di ogni cultura; significa rivendicarne la comune umanità,
mostrare anzi come siano più vicini a “noi” (all’Inghilterra vittoriana, ad esempio) di quanto ci
piace pensare. In questo senso, l’antropologia sta fin dall’inizio dalla parte dei “primitivi”, contro il
razzismo biologico che ne afferma l’inferiorità congenita e contro il dominio coloniale che ne fa un
puro oggetto d’amministrazione. Fin dall’inizio, almeno in un certo senso, l’antropologia si schiera
contro i pregiudizi etnocentrici che assolutizzano la “nostra” versione dell’umanità e distorcono in
caricatura quella degli altri.
Dall’altro lato, tuttavia, questo dominio - e la violenza con cui si esercita - non possono non
influenzare a fondo le stesse categorie epistemologiche della disciplina. Quest’ultima può pensare i
primitivi solo a partire da una fondamentale assunzione di disuguaglianza, tanto più profonda
quanto più implicita, che ne plasma le categorie intepretative. Si è persino parlato, in proposito, di
una “violenza epistemologica” insita nelle forme di rappresentazione, oggettivazione e
classificazione degli “altri” che l’antropologia sviluppa fino alla fine del ventesimo secolo. Ciò non
significa però che la storia dell’antropologia culturale possa esser letta (come pretenderebbe qualche
semplicistica attuale critica) come una sorta di riflesso o copertura ideologica dell’imperialismo.
Come detto, l’ambivalente relazione con il colonialismo è invece un elemento di tensione che
percorre l’intera vicenda del pensiero antropologico (come altri aspetti della cultura, della
letteratura e dell’arte contemporanea), e ne determina gli elementi di chiusura come quelli di
ricchezza e di potenzialità critica.
3. Vocazione per la diversità
Come detto, questa definizione dell’oggetto di studio (le culture “primitive”), e le partizioni
disciplinari che ne derivano, non hanno più alcun senso negli scenari contemporanei. Nel contesto
della globalizzazione, è ovvio che non esistono più “primitivi”, cioè popoli che vivrebbero
letteralmente nel passato evolutivo; ed è chiaro che gli antropologi non possono più considerarsi le
avanguardie della cultura “moderna” che per prime esplorano le culture di lontani esotici popoli,
“riportandole a casa” sotto forma di descrizioni etnografiche. E’ difficile pensare oggi
all’antropologia come a una scienza in cui “Noi” studiamo gli “Altri”. Ci troviamo di fronte a
situazioni sociali in cui chi siamo “Noi” e chi sono gli “Altri” non è mai chiaro. Come vedremo
meglio più avanti, non è possibile parlare di “culture” come di entità compatte e dai confini ben
definiti, e per di più coincidenti con un “popolo” e un “territorio”.
Ciò non significa tuttavia che le differenze culturali non esistano più. Al contrario: la
globalizzazione per certi versi le moltiplica, pur frammentandone e mischiandone i contesti. Ora, in
questa situazione l’antropologia culturale continua a definirsi in base alla sua vocazione per lo
studio delle differenze. Se c’è qualcosa che accomuna le origini ottocentesche con gli studi attuali è
per l’appunto questa vocazione. Qualunque sia l’oggetto di ricerca – i più lontani angoli di mondo o
casa propria, per così dire - la comprensione antropologica non può fare a meno di passare
attraverso il prisma della diversità culturale. Gli antropologi hanno coniato vari concetti per
esprimere questa loro caratteristica. Claude Lévi-Strauss ha ad esempio usato l’immagine di un
regard éloigné, lo sguardo da lontano proprio di chi si pone professionalmente nel ruolo di estraneo;
Clyde Kluckhohn ha parlato del metodo antropologico come di un “giro lungo”, contrapposto al
“giro breve” delle forme di conoscenza puramente speculative e che comunque non si pongono il
problema del confronto con la diversità. L’antropologo italiano Francesco Remotti ha ripreso questa
espressione in un importante libro, mostrando una fondamentale contrapposizione nella storia del
pensiero occidentale: da una parte quegli approcci, da Platone a Cartesio a Kant, che attraverso
l’analisi del nostro modo di pensare cercano di distallare un concetto assoluto di razionalità;
dall’altra parte gli approcci che, da Erodoto a Montaigne al secondo Wittgenstein, pensano di poter
definire la razionalità solo passando attraverso la molteplicità empirica delle consuetudini locali,
dunque non assolutizzando il nostro punto di vista ma mettendolo costantemente alla prova della
diversità. Pur non senza ambiguità (insite nella propria origine positivistica), l’antropologia si
schiera dalla parte di questo giro lungo, tentando anzi di sistematizzare e di trattare scientificamente
quei raffronti comparativi che la filosofia o la letteratura usavano in modo più occasionale e
impressionistico.
Da qui l’importanza che la comparazione riveste fin dall’inizio nel pensiero e nelle pratiche di
ricerca antropologiche. Comparazione non significa necessariamente “metodo comparativo”,
nell’accezione ingenuamente naturalistica che al termine attribuivano gli studiosi ottocenteschi –
convinti di poter compiere le più ardite (e spesso improbabili) generalizzazioni comparative fra
tratti culturali appartenenti ai contesti storici e sociali più distanti, e di poter estrarre da esse leggi
universali dello sviluppo culturale. Come vedremo, molti indirizzi novecenteschi hanno
esplicitamente polemizzato con un simile uso incontrollato del metodo comparativo. Tuttavia,
l’atteggiamento comparativo non scompare mai dalla conoscenza antropologica, manifestandosi
magari in forma implicita nelle stesse più elementari forme della descrizione etnografica, oppure in
grandi sistemi formalizzati come gli Human Relations Area Files creati da George Murdock negli
anni ’40 (un gigantesco archivio di dati etnografici ricondotti a formati standard, con la pretesa di
registrare e di rendere comparativamente analizzabili tendenzialmente tutte le culture del mondo).
L’irresistibile attrazione per la diversità sta anche alla base di una vocazione intrinsecamente
critica dell’antropologia nei confronti della propria stessa società e cultura. Il confronto con l’altro
costringe a una continua revisione e ampliamento delle nostre categorie, di ciò che nel nostro senso
comune si dà normalmente per scontato. In fondo, il compito dell’antropologia è sempre quello di
mostrare che quanto ci sembra ovvio e naturale non lo è affatto. Il confronto con il diverso ci fa
vedere le cose che ci sono familiari sotto una luce diversa, che le rende in qualche modo “strane”; ci
fa vedere quello che di solito non vediamo proprio perché lo abbiamo costantemente sotto gli occhi
(ecco il senso dello “sguardo da lontano”). Soprattutto, questo “estraniamento” ci suggerisce che le
nostre istituzioni e i nostri modi di vivere non sono gli unici possibili, e non necessariamente i
migliori. Ernesto de Martino, uno dei fondatori della moderna antropologia italiana, chiamava
“scandalo etnografico” questo incontro-scontro con una diversità che manda in corto circuito i
nsotri sistemi categoriali, e ci costringe a rivederli in un processo di costante “ampliamento della
nostra consapevolezza storiografica”. Vedremo, nei capitoli successivi, come l’analisi di alcune
pratiche sociali “primitive” e apparentemente bizzarre ci costringa a ripensare e a vedere in modo
nuovo e fortemente critico alcuni dei fondamenti stessi della nostra vita sociale.
4. La ricerca sul campo.
Se la vocazione per la differenza culturale caratterizza costitutivamente l’antropologia, non ne è
tuttavia esclusiva: è anzi un tratto che la disciplina condivide con importanti tradizioni del pensiero
filosofico e del lavoro artistico e letterario. Per distinguere l’antropologia occorre allora introdurre
un altro suo tratto peculiare, vale a dire la dimensione della ricerca sul campo. Quali che siano i
problemi teorici che si pone, l’antropologia tenta di rispondervi attraverso indagini empiriche che
passano attraverso, appunto, l’esperienza del fieldwork o lavoro di campo. Il modello classico di
fieldwork antropologico si viene definendo con le prime scuole novecentesche, in particolare quelle
anglosassoni, ed è legata ai nomi di padri fondatori della disciplina come Franz Boas negli Stati
Uniti e Bronislaw Malinowski in Inghilterra. Gli antropologi vittoriani non erano invece ricercatori
sul campo. Ritenevano che la raccolta dei dati empirici e il lavoro teorico di analisi e comparazione
dovessero restare separati, affidati a persone con diversi ruoli e competenze. Svolgevano dunque il
loro lavoro non “sul campo” ma in biblioteca, utilizzando come fonti i resoconti di viaggiatori,
naturalisti, missionari, funzionari coloniali – persone quasi sempre senza una preparazione specifica
ma che erano stati in contatto con lontane culture e ne avevano scritto. Dal loro punto di vista, il
diretto impegno dello studioso su un terreno specifico di ricerca avrebbe contrastato con il respiro e
l’ampiezza del lavoro comparativo. Ma ovviamente la loro “antropologia da tavolino”, come i loro
successori spregiativamente la chiameranno, aveva l’inconveniente di poggiare su dati incerti,
raccolti in modo spesso dilettantesco e privi di ogni seria attendibilità scientifica.
Nelle scuole novecentesche, al contrario, la figura del teorico e quella del ricercatore sul campo si
fondono in modo inestricabile, dando vita alla peculiare figura dell’antropologo – che
nell’immaginario collettivo si presenterà come uno strano ibrido, per metà erudito accademico e per
metà viaggiatore romantico e avventuroso. Il manifesto programmatico di questa nuova figura si
trova in un libro che Malinowski pubblica nel 1922, con l’evocativo titolo Argonauts of Western
Pacific (Argonauti del Pacifico occidentale). Studioso polacco ma di formazione inglese,
Malinowski aveva condotto negli anni della prima guerra mondiale una approfondita ricerca presso
l’arcipelago melanesiano delle Trobriand, di cui il libro costituisce un primo resoconto monografico
(lo ritroveremo presto perché si tratta di un testo incentrato sulla descrizione del kula ring, un
complesso sistema di scambio cerimoniale di oggetti preziosi ampiamente discusso da Mauss nel
Saggio sul dono). Nell’introdurre la sua ricerca, Malinowski rivendica la necessaria compresenza
nel lavoro antropologico delle due dimensioni finora distinte: la preparazione teorica e
metodologica, da un lato, e dall’altro la diretta esperienza vissuta della cultura che si intende
studiare. Senza la prima dimensione, l’osservatore non saprebbe osservare: non disporrebbe cioè
della capacità di individuare i tratti rilevanti di un contesto culturale, non saprebbe trasformare in
“documenti” o “dati” la semplice esperienza vissuta. D’altra parte, senza l’esperienza di
partecipazione diretta il teorico non comprenderebbe mai veramente un’altra cultura, non ne
coglierebbe gli elementi “imponderabili”, non potrebbe entrare in rapporto empatico con essa.
Occorre allora vivere all’interno di una comunità, condividerne la quotidianità, entrare in rapporti
personali e ravvicinati con i suoi membri, partecipare alle più importanti pratiche sociali.
Malinowski conia l’espressione “osservazione partecipante” per indicare questo stile di ricerca.
Come spesso accade, è un’immagine ancor più delle parole a fissarne il senso: la fotografia che apre
il libro di Malinowski e che ci mostra la sua tenda piantata nel bel mezzo del villaggio indigeno. Io
sono stato là fra di loro, vuole dirci Malinowski, e questo mi autorizza a parlarne. L’etnografo, con
la sua “mobilità” geografica e culturale, si presenta così come la perfetta (forse l’unica) figura di
mediatore culturale, che mette in rapporto due mondi destinati altrimenti a non incontrarsi.
Questo stile di osservazione partecipante diventerà lo standard per molte generazioni successive
di antropologi. Esso implica una permanenza prolungata e intensiva sul terreno, non inferiore a un
anno e condotta a stretto contatto con gli indigeni: ciò significa tagliare i rapporti con altri
occidentali e vivere un’esperienza di radicale estraniamento dalla propria cultura di provenienza
(esperienza che può provocare nei ricercatori vere e proprie crisi esistenziali; è il caso dello stesso
Malinowski, come sarà testimoniato, con un certo “scandalo” negli ambienti antropologici, dalla
pubblicazione postuma del suo diario di campo). In questo tipo di ricerca, occorre imparare il
linguaggio locale e studiare non solo un aspetto della cultura, ma la vita sociale nel suo complesso:
dagli aspetti economici, a quelli politici, alle strutture della parentela, alle pratiche religiose e così
via. Nessun aspetto potrà infatti esser compreso se non collocato nel contesto complessivo
(approccio “olistico”). Inoltre, l’accento sulla partecipazione vissuta non deve far dimenticare
l’importanza dell’impiego di particolari strumenti metodologici: ad esempio gli schemi genealogici,
le interviste strutturate (con l’accurata scelta di informatori privilegiati) e la loro trascrizione, alla
schedatura dei manufatti, la documentazione fotografica, per finire con la redazione delle note e del
diario di campo – forse il più tipico e distintivo strumento dell’indagine antropologica.
Il modello di fieldwork tracciato da Malinowski è rimasto a lungo lo standard di riferimento per
molte tradizioni antropologiche. Anch’esso, però, non è sopravvissuto alle trasformazio*ni degli
ultimi decenni. Troppo diverse sono oggi le condizioni dell’incontro etnografico perché sia ancora
possibile immaginare l’antropologo come eroe solitario che, con la sua tenda e il suo diario di
campo, esplora una cultura intatta nella sua autenticità. Qualunque sia il campo che sceglie,
l’antropologo lo trova oggi già “pieno” di altri saperi specialistici, di mass-media globali, di turisti,
quasi sempre anche di antropologi nativi. Lo stesso concetto di “campo”, pensato nella fase classica
sul modello di luoghi circoscritti e compatti (l’isola, la riserva indiana, il villaggio), rischia di venir
meno. La singola località non può più essere l’unità privilegiata d’analisi, quando la cultura e le
persone circolano con l’ampiezza e la rapidità delle comunicazioni globalizzate: l’equazione un
territorio – un popolo – una cultura non funziona più, e le etnografie “multisito” divengono sempre
più la norma. Inoltre i recenti dibattiti epistemologici hanno contribuito a scuotere la fiducia
nell’oggettività della rappresentazione etnografica, rendendo meno rigidi i requisiti della ricerca e
aprendo la strada a nuove configurazioni dei rapporti tra l’esperienza soggettiva di campo e la sua
restituzione nella scrittura antropologica.
Nondimeno, anche se in forme nuove e più variabili, la ricerca sul campo continua ad essere il
nucleo centrale delle discipline DEA. I problemi che esse si pongono non sono talvolta diversi da
quelli messi a fuoco dalla filosofia, e forse dalla letteratura e dall’arte. Ciò che caratterizza la
risposta antropologica è però il fatto di passare attraverso il “campo”, cioè attraverso l’immersione e
la condivisione di pratiche sociali, nonché attraverso il rapporto diretto e il dialogo con le persone
che ne sono protagoniste.
5. Le partizioni disciplinari
Distinzione fra diversi specialismi antropologici in relazione a:
a) aree geografico-culturali. (Il modello classico di fieldwork sopra tratteggiato, con i requisiti della
lunga permanenza, la necessità di imparere la lingua etc., implica che uno studioso, nella sua
carriera, non può divenire esperto di più di una o due aree culturali, tre in casi eccezionali).
Africanisti, oceanisti, americanisti, europeisti, studiosi dell’India, del Medio Oriente, del
Mediterraneo etc., condividono magari basi e problemi teorici ma si costituiscono come specialismi
diversi, con i loro specifici strumenti di comunicazione scientifica (riviste, convegni, associazioni
etc.). Rari sono i casi di studiosi che si siano cimentati in più di una di queste grandi partizioni geoculturali.
b) aspetti della cultura. Per quanto l’antropologia persegua come detto un approccio olistico, nel
quale i diversi aspetti di una cultura si illuminano a vicenda, è assai frequente che gli studiosi si
specializzino in ambiti specifici della vita socioculturale. Nella fase classica della disciplina, tali
ambiti sono rappresentati principalmente da:
- parentela, matrimonio, vita familiare
- economia (incluse le forme del lavoro e gli aspetti della cultura materiale)
- stratificazione sociale, forme della politica e del potere
- linguaggio
- religione e magia (rituali, miti, pratiche simboliche)
- l’ambito estetico.
Oltre a queste grandi partizioni, si sono costituiti specialismi antropologici ancora più specifici: ad
esempio
- l’antropologia medica, che studia le variazioni culturali delle concezioni e delle pratiche
relative a corpo, salute, malattia, guarigione
- l’etnoscienza, che studia le forme di saperi naturalistici e i processi cognitivi che ad essi si
accompagnano
- l’antropologia psicologica, che studia le variazioni interculturali nella definizione del
concetto di persona, nella costituzione dei ruoli sociali e di genere, nella manifestazione
delle emozioni
- l’etnografia della conversazione, che si concentra sulle analisi delle microinterazioni
linguistiche e comunicative;
L’elenco potrebbe continuare. A questi specialismi disciplinari ne vanno aggiunti poi altri che, con
l’ampliarsi degli orizzonti delle discipline DEA mettono a fuoco oggetti nuovi, legati ad esempio
alla modernizzazione e al mutamento culturale, come l’antropologia urbana, l’antropologia del
turismo, quella dello sport, dell’educazione, dei media, della violenza.
Deve essere anche menzionata una suddivisione in specialismi riguardo alle fonti o ai tipi di
rappresentazione culturale che gli studiosi scelgono di privilegiare. Ad esempio, l’ antropologia
museale è oggi una delle branche più importanti e più compatte della disciplina. Lo stesso si può
dire per l’antropologia visuale, che privilegia l’analisi delle fonti iconiche e modalità fotografiche o
filmiche di documentazione e rappresentazione etnografica. Si parla anche di antropologia
letteraria (uso di opere di letteratura come fonti per la conoscenza di una cultura, ma anche impiego
di risorse antropologiche nella critica letteraria), antropologia storica (impiego di strumenti
antropologici nell’analisi di fonti storiografiche). Da notare che invece l’espressione antropologia
filosofica indica una tradizione di studi più prettamente filosofica e non appartiene all’ambito DEA;
il suo insegnamento è infatti incluso nel raggruppamento scientifico-disciplinare di “Filosofia
morale” (M-FIL/03).
Infine, una notazione sul diffuso impiego dell’espressione antropologia applicata: con questa
denominazione ci si riferisce a studi che non hanno una finalità puramente conoscitiva, ma sono fin
dall’inizio pensati in relazione a interventi di tipo economico e sociale, in particolare come supporto
alla elaborazione di progetti di cooperazione internazionale.
6. A cosa serve l’antropologia.
Sbocchi professionali specifici:
- mediazione culturale (nella scuola, nella sanità, nei servizi sociali);
- cooperazione internazionale, gestione dei conflitti;
- conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale etnografico (musei).
7. I grandi indirizzi teorici
(mi limito a ricordare quelli discussi nella lezione di mercoledì 15,mindicando alcuni dei nomi
degli autori e dei concetti basilari discussi):
- scuola evuluzionista britannica: Edward B. Tylor, James G. Frazer; unità intellettuale del
genere umano, concezione al singolare della “cultura umana”, metodo comparativo, ricerca
dell’origine dei fenomeni culturali (es. animismo come origine della religione),
sopravvivenze, stadi dello sviluppo culturale (es. magia-religione-scienza), poligenesi dei
fatti culturali simili, intellettualismo e individualismo metodologico;
- scuole diffusioniste: monogenesi, interesse per i percorsi di diffusione dei tratti culturali da
un’unica area d’origine
- scuola sociologica francese (Emile Durkheim, Marcel Mauss): rappresentazioni collettive,
radicamento sociale dei fatti culturali, apertura di una prospettiva funzionalista
- particolarismo storico: Franz Boas e la fondazione della moderna scuola antropologica
nordamericana. Anti-evoluzionismo, scetticismo verso la comparazione culturale a vasto
raggio, ricerca sul campo e centralità degli aspetti linguistici. Determinismo culturale vs.
determinismo psico-biologico (l’esempio del libro di Margaret Mead sull’adolescenza a
Samoa)
- funzionalismo inglese. B. Malinowski e la già ricordata ricerca alle Trobriand. Approccio
sincronico (vs. diacronico) e olistico. Alfred Radcliffe-Brown e lo struttural-funzionalismo:
cultura come entità organica. Spiegare un tratto culturale equivale a capire in che modo
sostiene e preserva la struttura sociale. Edward Evans-Pritchard: gli studi della stregoneria
fra gli Azande e del sistema segmentario tra i Nuer. Assenza della dimensione storica nelle
rappresentazioni funzionaliste, che si trovano in difficoltà a dar conto dei fenomeni di
mutamento culturale (ma reintroduzione della comprensione storica a partire proprio
dall’ultimo Evans-Pritchard)
- strutturalismo. Claude Lévi-Strauss e l’analisi delle “strutture elementari della parentela” e
dei miti amerindiani. Influenza della linguistica strutturale. I diversi aspetti della cultura
come costruzioni generate a partire da profonde (e inconsce) matrici cognitive, governate
dai principi elementari dei sistemi cibernetici (logica binaria), che l’analisi strutturale
puòscoprire penetrando l’apparente eterogeneità e caotica varietà delle loro manifestazioni
empiriche.
- Antropologia interpretativa. Clifford Geertz. L’essere umano come “animale che produce
significati”. L’esempio dello “strizzare l’occhio”: l’impossibilità di una descrizione
oggettiva che non passi attraverso i significati che gli attori sociali stessi attribuiscono alle
loro pratiche. Etnografia come interpretazione di interpretazioni.
RAZZA, CULTURA, ETNIA.
0. Premessa
I tre termini che danno il titolo a questo intervento hanno svolto un ruolo fondamentale nei modi
in cui il Novecento ha pensato la diversità umana. Più precisamente, mi riferisco qui al tipo di
diversità che, per l'appunto, è difficile definire se non riferendosi circolarmente a quei concetti
stessi; che non è ad esempio diversità di genere (maschile-femminile), di generazione (giovanianziani), di classe (borghesi-proletari). La diversità di volta in volta denominata razziale, culturale o
etnica (le tre nozioni si sovrappongono in parte ma non coincidono, come vedremo) è marcata
dall'appartenenza, quasi sempre data per nascita, a gruppi umani caratterizzati dalla collocazione
geografica, da peculiarità somatiche, linguistiche e religiose, dalla condivisione di tradizioni o
percorsi storici in grado di produrre (ma anche questo termine, come vedremo, è controverso)
identità collettive. Razza, cultura, etnia sono stati i perni concettuali di altrettanti modi di concepire
questa diversità; e le tradizioni di pensiero che tali nozioni fondano sono ancora oggi un riferimento
essenziale (non importa se in positivo o in negativo) per comprendere i nuovi problemi che la
diversità ci pone.
In questo intervento, di cui sottolineo la natura didattica e non specialistica, vorrei dapprima
esaminare separatamente le tre nozioni, tracciandone una breve storia e discutendo le rispettive
implicazioni filosofiche, etiche e politiche. Nella seconda parte, mi concentrerò sui modi in cui,
nella seconda metà del Novecento, un discorso "culturalista" e uno "etnicista" hanno soppiantato
quel discorso "razzista" sulla diversità che affondava profonde radici nell'Ottocento e che aveva
raggiunto la sua massima e drammatica realizzazione pratica nella Shoah. Vedremo come
culturalismo ed etnicismo, pur superando definitivamente molti tratti del pensiero razzista, ne
ereditano alcune caratteristiche, e non sono comunque esenti da tensioni e contraddizioni interne,
tanto da poter fondare ideologie e pratiche di segno decisamente neo-razzista. Porrò infine il
problema se, a fronte di tali difficoltà e contraddizioni, sia oggi possibile continuare a utilizzare sia concettualmente che politicamente - i concetti di identità etnica e identità culturale in una
prospettiva antirazzista.
1. Razza
Com'è noto, il termine “razza” ha una storia relativamente recente. Lo si trova usato a partire dal
Cinquecento per indicare una discendenza, una schiatta, quello che in antropologia si chiamerebbe
un lignaggio. L'etimologia è abbastanza incerta: probabilmente dal latino (gene)ratio. Ma solo nel
secolo scorso il termine ha assunto l'attuale significato - un gruppo umano caratterizzato da
specificità sia somatiche sia intellettuali e comportamentali che si suppongono fondate
biologicamente e trasmesse per via ereditaria. La nozione di razza si afferma nell'Ottocento come
strumento concettuale di una riflessione sull'origine del genere umano in cui il linguaggio
scientifico si sostituisce progressivamente (anche se in modo non certo indolore) a quello religioso;
e, dall'altra parte, come fulcro di una concezione etico-politica dei rapporti tra Occidente e resto del
mondo che ha nel colonialismo il suo correlato pratico1 .
1
Sulle elaborazioni ottocentesche del concetto di razza si vedano fra gli altri G. Gliozzi (a cura di), La scienza della
razza nell'età moderna, Torino, Loescher, 1986; M.Harris, L’evoluzione del pensiero antropologico. Una storia della
teoria della cultura, trad. it. Bologna, Il Mulino, 1971, capitoli 3-5; M.F.A. Montagu, La razza. Analisi di un mito,
trad.it. Torino, Einaudi, 1966. Per una utile e recente sintesi storica si veda anche D. Petrosino, Razzismi, Milano, Bruno
Mondadori, 1999, pp. 17 sgg.
La diffusione del termine razza fa dunque tutt'uno con quella delle dottrine razziste, che intorno
alla metà dell'Ottocento dominano il pensiero antropologico e vengono elaborate in Europa e negli
Stati Uniti in grande varietà. La più celebre di esse è probabilmente quella del francese conte de
Gobineau, che nel 1856 pubblica il Saggio sull'ineguaglianza delle razze umane. I punti cardine di
questo testo, che godrà di grande diffusione, possono esser così schematizzati 2 :
- la biologizzazione o naturalizzazione di ogni tipo di differenza tra culture o civiltà umane;
- l'affermazione di una gerarchia rigida fra le razze, che vede naturalmente ai vertici la razza
bianca ;
- l'orrore per la mescolanza tra le razze.
La superiorità della razza bianca sarebbe dimostrata non solo dai risultati della civiltà occidentale,
ma anche e soprattutto da fattori estetici, come la bellezza, la giusta proporzione delle membra, la
regolarità dei tratti del volto. La bellezza fisica appare come segno inequivocabile d'elezione un'idea che Gobineau condivide con precedenti autori che avevano tentato classificazioni
naturalistiche dei gruppi umani. Fra gli altri, lo stesso Linneo un secolo prima (1758) aveva
proposto una tipologia di sub-specie umane, basata essenzialmente sul colore della pelle ma in cui si
confondevano tratti fisici, mentali, sociali e culturali, pensata come una scala che conduceva dalle
scimmie al "gradino più alto" dell'uomo europeo. Non sfiora neppure questi pensatori l'idea - che
per noi è oggi senso comune - della relatività dei giudizi estetici e dei criteri di bellezza fisica.
Gobineau ritiene che la razza bianca, che ha creato una civiltà e una morale superiore, in virtù del
suo stesso successo sia minacciata dagli incroci con le altre razze, che ne contaminano e
impoveriscono il patrimonio genetico. Egli è un tipico pensatore reazionario ottocentesco, nemico
acerrimo della tradizione illuminista, che tenta soprattutto di opporsi all'idea della perfettibilità degli
esseri umani. Il destino di ciascun gruppo umano è segnato dalla razza di appartenenza: nulla può
esser modificato. Non solo egli non crede nel progresso, ma la sua visione è tendenzialmente
degenerativa : la storia implica mescolamenti fra le razze che ne minano l'autenticità . La civiltà
greca e quella romana erano ad esempio superiori alla civiltà attuale dell'Europa, per Gobineau,
perché le rispettive popolazioni erano razzialmente più pure. La decadenza della razza bianca non
può esser fermata. Già oggi, scrive Gobineau, essa è composta solo da ibridi: e "la parte di sangue
ariano, suddivisa già tante volte, che ancora resiste nelle nostre contrade e che è la sola a sostenere
l'edificio della nostra società, ogni giorno s'incammina verso il termine estremo del suo
riassorbimento" 3 .
Ma nel razzismo ottocentesco c'è un altro filone che si distanzia dal pessimismo reazionario e
dalla visione degenerativa di Gobineau, e che per certi versi affonda le radici nel retaggio
illuminista e nel positivismo ottocentesco, con tutta la sua fiducia nel progresso, nella perfettibilità
degli esseri umani e in politiche di ingegneria biologico-sociale. E' un filone di pensiero che troverà
piena espressione nelle teorie evoluzioniste, traendo in particolare alimento dall'opera di Darwin e
di Herbert Spencer. Darwin e l'evoluzionismo mettono fine alla lunga disputa tra teorie
monogenetiche e poligenetiche delle razze, che tanto spazio aveva avuto nella prima metà
dell'Ottocento e che ereditava le discussioni cinquecentesche sulla natura - umana o meno - degli
indios americani 4 . L'umanità ha un'origine comune, e le differenze attualmente riscontrabili sono
dunque frutto di un processo di evoluzione o involuzione influenzato da circostanze storiche,
condizioni ambientali e altri fattori "esterni"? Oppure, al contrario, le differenze attuali rimandano a
origini diverse, dunque a peculiarità "interne" e irriducibili? L'evoluzionismo da un lato accredita la
2
J.A. de Gobineau, Sull’ineguaglianza delle razze, trad. it Milano, Rizzoli, 1977: per una ricostruzione complessiva del
pensiero di Gobineau si veda F. Castradori, Le radici dell’odio. Il conte de Gobineau e le origini del razzismo, Milano,
Xenia, 1991
3
cit. in R.Gallissot. A.Rivera, L’imbroglio etnico, Bari, Dedalo, 1997, p.104
4
Testi fondamentali per la ricostruzione del dibattito sulla diversità dal XVI al XVIII secolo sono quelli di T. Todorov,
La conquista dell’America, trad. it. Torino, Einaudi, 1992 e Noi e gli altri, trad. it Torino, Einaudi, 1991. Una rassegna
ancora molto utile è quella di G. Gliozzi, La scoperta dei selvaggi. Antropologia e colonialismo da Colombo a Diderot,
Milano, Principato, 1971. Per i rapporti tra evoluzionismo biologico e culturale nell’Ottocento v. G.W.Stocking, Razza,
cultura e evoluzione. Saggi di storia dell’antropologia, trad.it. Milano, Il Saggiatore, 1985
teoria monogenetica; dall'altro, tuttavia, sembra legittimare le convinzioni poligenetiche nel
carattere naturale e irriducibile della diversità. L'origine è unica, e le differenze si forgiano nel
percorso evolutivo, nelle modalità di adattamento all'ambiente dei diversi gruppi umani. Ma ciò non
abbatte la classificazione gerarchica delle razze: anzi, paradossalmente, la rafforza. Se tutte hanno la
stessa origine, i diversi risultati storici che esse ottengono dipendono da un miglior adattamento, da
una supremazia sul piano della naturale legge per la sopravvivenza. Si conferma dunque una
gerarchia, per di più legittimata da una legge naturale, che in quanto tale è da un lato "oggettiva" e
dall'altro "buona" o "giusta".
Da metà Ottocento fino a buona parte del Novecento, fondamentali convinzioni razziste (pur con
accenti e sensibilità diverse) accomuneranno il pensiero reazionario e quello progressista, la cultura
cristiana e quella scientifica e secolarizzata, le pratiche sociali conservatrici e quelle riformatrici. Il
razzismo conserva qualcosa di entrambe le tradizioni di pensiero. Per un verso, l'idea di differenze
tra gli esseri umani saldamente radicate nella biologia fa parte delle reazioni ottocentesche alla
modernità, all'egalitarismo rivoluzionario; ha inoltre a che fare con il consolidamento delle relazioni
di potere coloniali. Per l'altro verso, poggia invece sul prestigio acquisito dalla scienze naturali,
sulla convinzione di poter giungere attraverso i loro metodi a una conoscenza integrale degli esseri
umani e della loro vita culturale e spirituale, e infine sull'ideale tipicamente illuminista della
perfettibilità. Contrariamente a Gobineau, i razzisti progressisti ritengono di poter influire
sull'evoluzione delle razze umane attraverso una programmazione scientifica. Le politiche
biologiche appaiono ad alcuni una delle vie possibili verso l'utopia.
E' questo il punto che più mi interessa sottolineare. Nell'Ottocento la conoscenza scientifica
soppianta progressivamente altre forme di autorità (come la tradizione o l'autorità religiosa nelle
società di antico regime) nella determinazione di gerarchie e di principi di ineguaglianza tra gruppi
umani. Ma la fondazione così fornita a tali gerarchie è più assoluta e rigida che in passato, dal
momento che le differenze naturali non sono modificabili come quelle morali o religiose. Per
l'antisemitismo, ad esempio, questo fa una grande differenza. L'antisemitismo tipico del Novecento,
che porterà all'ideologia e alla pratica nazista e alla Shoah, si innesta appunto su una definizione
"scientifica" della razza di taglio ottocentesco, reinterpretando in termini nuovi una lunga tradizione
di pregiudizio religioso. Per quest'ultimo, la differenza dell'ebreo è bensì radicale, ma trova un
limite almeno teorico nella conversione. Per quanto colpevole di gravissime persecuzioni,
l'antisemitismo cristiano avrebbe potuto difficilmente concepire l'idea dello sterminio totale, inteso
come eliminazione dalla faccia della terra di un determinato patrimonio genetico 5 .
Nel nazismo, il razzismo scientifico si salda con un'ideologia profondamente reazionaria e
antimodernista. Ma anche il razzismo progressista diffuso nei paesi democratici fonda pratiche di
ingegneria biologica, come l'eugenetica, che stanno probabilmente alla base delle più disastrose
manifestazioni contemporanee del razzismo. Com'è noto, è legata al nome di Francis Galton la
formulazione dei principi dell'eugenetica: perché non aiutare l'evoluzione naturale, favorendo la
riproduzione degli organismi migliori e impedendo di riprodursi a quelli più deboli o difettosi?
Sono finalità progressiste e di miglioramento sociale, anche se spesso mischiate a venature di
razzismo conservatore, quelle che promuovono le varie esperienze eugenetiche o di biologia
razziale che, nel ventesimo secolo, coinvolgono molte democrazie liberali come gli Stati Uniti o fin nel secondo dopoguerra - la Svezia. Si tratta in molti casi di esperienze di sterilizzazione forzata
di individui considerati svantaggiati o disadattati, supposti portatori di geni deboli o difettosi 6 .
5
G.L. Mosse, Il razzismo in Europa dalle origini all'Olocausto, trad.it. Milano, Mondadori, 1992. Per la storia
dell’antisemitismo, riferimento fondamentale è l’opera di L,. Poloiakov, Storia dell’antisemitismo, 4 voll, trad. it.
Firenze, La Nuova Italia, 1974-1990; una buona sintesi divulgativa è R. Finzi, L’antisemitismo, Firenze, Giunti, 1997.
Per una discussa ma efficace discussione delle radici dell’antisemitismo nazista v. D.J. Goldhagen, I volenterosi
carnefici di Hitler, trad. it. Milano, Mondadori, 1997, parte prima. Sulla “razzializzazione” delle differenze tra
“bianchi” e “negri” v. il recente contributo di A. Smedley, “«Race» and the construction of human identity”, American
Anthropologist, 100 (3), 1998.
6
Si veda una recente rassegna di questi esperimenti in G. Moriani, Il secolo dell’odio, Venezia, Marsilio, 1999
Considerato in questa prospettiva, l'hitleriano progetto eutanasia, che portò alla fine degli anni '30
all'eliminazione fisica di centinaia di migliaia di devianti e di "inadatti", è solo la manifestazione
estrema di una tendenza assai più largamente diffusa. Nel dopoguerra prevarrà un'immagine del
nazismo come mostruosità unica e irripetibile della storia. In realtà, le politiche biologiche che esso
persegue (e alle quali assegna importanza decisiva) non sono affatto uniche nel contesto culturale di
quegli anni: il nazismo ne rappresenta una peculiare declinazione totalitaria, che si distingue per il
carattere estremo, per l' "eroico" rifiuto di accettare compromessi con quei sentimenti umanitari che
l' "uomo nuovo" deve imparare a lasciarsi alle spalle.
Secondo una affascinante - anche se a mio parere parziale e poco equilibrata - interpretazione
storiografica, la natura profonda dei regimi totalitari del XX secolo e dei principali orrori che ne
accompagnano la storia rimanda proprio a una matrice progressista e illuminista. "Gli orrori del XX
secolo derivano dai tentativi pratici di creare la felicità, l'ordine di cui la felicità aveva bisogno, e il
potere totale necessario a instaurare quell'ordine", scrive ad esempio Zygmunt Bauman, uno degli
autori più rappresentativi di questo punto di vista 7 . La Shoah, i genocidi e le politiche razziali del
XX secolo non contraddicono dunque la modernità, non sono buchi neri in un processo di
civilizzazione che va in direzione opposta: ne sono anzi la conseguenza, il prodotto, in molti sensi.
Intanto, in un ovvio senso tecnologico, poiché la modernità produce armi dal potenziale distruttivo
senza precedenti; quindi, in un senso amministrativo-burocratico, poiché solo una forte burocrazia
di tipo moderno è in grado di attuare pratiche di ingegneria sociale, nonché di produrre quella
deresponsabilizzazione morale degli individui che è condizione dello sterminio di massa; infine, in
senso politico e culturale, poiché le ideologie che producono genocidi, quelle totalitarie, germinano
storicamente dall'illuminismo, dalle aspirazioni utopiche a una società ideale e totalmente
controllata dalla ragione e dalla scienza. E' su questo sfondo sinistro che si può leggere la vicenda
contemporanea del concetto di razza.
2. Cultura
Anche il concetto cosiddetto scientifico di cultura si sviluppa e diviene di uso comune nella
seconda metà dell'Ottocento, contemporaneamente all'affermarsi dell'antropologia culturale come
autonoma disciplina di studi. Gli antropologi intendono per cultura non solo gli "alti" prodotti
dell'intelletto, come arte, letteratura o scienza, ma l'insieme di tutte quelle pratiche, usi,
consuetudini e conoscenze, per quanto banali e quotidiane, che una comunità umana possiede e
attraverso le quali si adatta all'ambiente e regola le proprie relazioni sociali. Gli antropologi
ottocenteschi, beninteso, sono tutti in qualche misura influenzati dalle teorie razziste: tuttavia, essi
tengono fermo il presupposto della fondamentale unità intellettuale dell'intero genere umano, e sono
interessati allo studio della cultura come elemento di differenziazione tra i gruppi. In termini
evoluzionistici, la cultura è l'insieme degli elementi non biologici o somatici di adattamento
all'ambiente. L'evoluzione culturale è il prolungamento di quella biologica, e si sostituisce
progressivamente (anche se mai del tutto) ad essa nel determinare le caratteristiche dei gruppi
umani, le loro modalità di sviluppo e differenziazione.
Pur non facendo strettamente dipendere le differenze culturali da differenze naturali
(biologiche, razziali) l'antropologia culturale ottocentesca non rinuncia all'idea di gerarchizzazione
delle culture. Come si spiega la diversità culturale a fronte della originaria unità intellettuale del
genere umano? La risposta sta nell'ipotizzare un unico processo di evoluzione culturale, che si
muove però a velocità diverse in diverse parti del mondo e per diversi gruppi umani. La differenza è
riletta in termini di avanzamento-arretratezza del processo evolutivo, di stadi successivi di un unico
grande sviluppo culturale. I popoli "primitivi" stanno attraversando uno stadio evolutivo precedente;
dunque, per quanto cronologicamente contemporanei delle civiltà più avanzate, sono situati
letteralmente in un tempo passato rispetto ad esse.
7
Z. Bauman, “I campi: Oriente, Occidente, Modernità”, in M. Flores, a cura di, Nazismo, fascismo, comunismo.
Totalitarismi a confronto, Milano, Bruno Mondadori, 1998, p. 18
Tale concezione contrasta con le forme più crude del razzismo, ma resta compatibile con alcune
delle sue funzioni ideologiche, in particolare con la legittimazione del dominio coloniale e con la
giustificazione dell'ordine imperialista del mondo. I rappresentanti della civiltà occidentale antropologi, imprenditori, ufficiali coloniali - stanno per così dire sul punto più alto di una piramide
da cui possono guardare tutto il resto del mondo, certi di una superiorità che li pone per definizione
dalla parte della verità e della giustizia. Il corso dell'evoluzione è segnato. Gli altri sono come noi,
certo, ma solo nel senso in cui lo sono dei bambini che vanno educati e aiutati a crescere - anche
con severità, quando ce n'è bisogno. L'equazione primitivi-bambini è centrale nell'immaginario
antropologico ottocentesco, e rappresenta la variante culturalista del razzismo, il prezzo pagato al
rifiuto del determinismo biologico.
Si ha un mutamento radicale rispetto a questo quadro con gli sviluppi novecenteschi
dell'antropologia, e con la relativa affermazione di un concetto pluralista e relativista di cultura. Lo
sviluppo della ricerca sul campo e di una nuova sensibilità etnografica, insieme al crollo di molte
delle certezze positivistiche dell'Ottocento, fa dell'antropologia un potentissimo strumento di critica
all'etnocentrismo, alle pretese cioè della cultura europea di valere da metro di giudizio assoluto per
tutte le altre. Quelli che per l'Ottocento erano assiomi, appaiono ora come pregiudizi. Laddove per
l'evoluzionismo studiare la diversità culturale era un modo per riaffermare con forza sempre
maggiore la superiorità dell'Occidente moderno, per la nuova sensibilità antropologica diviene un
modo per contestarne e relativizzarne le pretese. All'immagine di una gerarchia piramidale di gruppi
umani, che procedono a velocità diverse su un unico percorso di sviluppo culturale, si sostituisce
quella di un mondo suddiviso in una irriducibile pluralità di culture, intese come entità autonome,
ben distinte e di uguale dignità, classificabili in modo non gerarchico e per certi aspetti non
commensurabili.
Per il modernismo antropologico del nuovo secolo, le valutazioni negative delle altre culture sono
per lo più conseguenza della incapacità di comprendere il funzionamento di codici linguistici,
estetici, morali semplicemente diversi da quelli che ci sono più familiari. Da qui il principio del
relativismo culturale: non si possono formulare giudizi etici, estetici e (in una variante) anche
cognitivi al di fuori di un contesto culturale, poiché è il contesto culturale a stabilire i criteri di
riferimento. Ciò che è bello o brutto, attraente o disgustoso, desiderabile o indesiderabile, giusto e
ingiusto, e in un certo senso persino vero e falso, dipende dal contesto culturale, e non ci sono
criteri esterni e neutrali di tipo sovra-culturale. Ogni tentativo di stabilire simili criteri è in definitiva
etnocentrico. (Si può notare, per inciso, come questo atteggiamento sia erede di una tradizione
scettica e anti-universalista presente nel pensiero occidentale fin dai suoi esordi, sia pure in modo
minoritario; ma è solo nel Novecento che tale tradizione trova uno sbocco in termini di sapere
positivo sulla diversità culturale) 8 .
Lo sviluppo dell'antropologia moderna, in definitiva, potrebbe esser descritto come un
progressivo approfondimento della critica anti-etnocentrica. Lo stesso concetto di etnocentrismo
diviene un fondamentale strumento interpretativo. Se ne ha una prima celebre definizione da parte
del sociologo americano William Graham Sumner, ai primi del secolo:
"Il punto di vista secondo il quale il gruppo a cui si appartiene è il centro del mondo
e il campione di misura cui si fa riferimento per giudicare tutti gli altri, nel linguaggio
tecnico va sotto il nome di etnocentrismo [...] Ogni gruppo esercita la propria fierezza
e vanità, dà sfoggio della sua superiorità, esalta le proprie divinità e considera con
disprezzo gli stranieri. Ogni gruppo pensa che i propri costumi (folkways) siano gli
8
v. F. Remotti, Noi primitivi. Lo specchio dell’antropologia, Torino. Bollati Boringhieri, 1990. Per un’analisi in chiave
filosofica del passaggio dalla “cultura” evoluzionista alle “culture” dell’antropologia novecentesca, v- P. Rossi, Cultura
e antropologia Torino, Einaudi, 1983
unici ad essere giusti, e prova soltanto disprezzo per quelli degli altri gruppi, quando vi
presta attenzione" 9 .
Questo atteggiamento è per così dire naturale e universale, e anche utile alla coesione di un
gruppo sociale, ma porta facilmente, dice Sumner, a "esagerare, ad accentuare i tratti particolari che
appartengono ai propri costumi e che distinguono un popolo dagli altri". Quando ciò accade, il
naturale atteggiamento etnocentrico si trasforma in pratiche discriminatorie verso gli altri.
L'etnocentrismo sarà teorizzato in termini assai simili da altri importanti antropologi, quali fra gli
altri l'americano Melville Herskowitz e il francese Claude Lévi-Strauss. Anch'essi riconoscono
l'universalità dell'atteggiamento etnocentrico, ma vedono un segno distintivo del progresso culturale
nella capacità di tenerlo sotto controllo, di combatterlo nelle sue forme esasperate, promuovendo
non la contrapposizione ma la tolleranza e il dialogo tra le diverse culture. Lévi-Strauss è autore
della famosa formulazione secondo la quale barbaro è anzitutto colui che crede nella barbarie - uno
slogan rappresentativo, anche nelle sue implicazioni paradossali, della sensibilità antropologica
moderna 10 .
Il lessico antropologico, che interpreta la diversità tra gruppi umani in termini di culture
autonome e distintive, e la sensibilità ai temi dell'etnocentrismo e del relativismo culturale, si
diffondono e divengono senso comune nella seconda metà del secolo. Tale diffusione avviene anche
come reazione al lessico e alla sensibilità razzista, screditati definitivamente dagli esiti cui erano
stati condotti dal nazismo. Il tentativo nazista di instaurare un ordine del mondo su base razziale, e
le pratiche genocide che ne seguono, destano profonda impressione nell'opinione pubblica
internazionale e portano al progressivo abbandono delle teorie razziste in senso stretto - quelle che
mirano a una gerarchizzazione dei gruppi umani sulla base di caratteristiche genetiche.
Parallelamente, anche gli sviluppi della biologia e della genetica contribuiscono all'abbandono della
nozione classica di razza, nonché delle teorie sulla determinazione razziale dell'intelligenza e dei
tratti comportamentali 11 . Dopo la seconda guerra mondiale, repentinamente, la parola "razzismo"
assume una connotazione negativa - laddove, fino a tutti gli anni '30, veniva usata in senso positivo,
come sinonimo di politiche progressiste di miglioramento della specie umana, e di difesa delle
popolazioni superiori dalla contaminazione. Ciò non significa che vengano abbandonate idee e
pratiche di tipo fondamentalmente razzista, anche se espresse e sostenute con un altro tipo di
linguaggio. Ma su questo tornerò più avanti.
3. Etnia
Negli ultimi anni, etnia è il termine prevalentemente usato per esprimere differenze tra gruppi
umani, intese come differenze in qualche modo pre-politiche, cioè precedenti, più profonde o
almeno indipendenti dalle suddivisioni politiche in Stati. Sentiamo parlare di conflitti etnici, di
identità etniche, di pulizia etnica. I mass-media hanno cominciato a far largo uso di questo termine
(accanto qualche volta al termine "tribale", quando oggetto del discorso sono realtà africane), che è
progressivamente entrato nel linguaggio comune. Vediamo di approfondirne il significato.
Il termine ha origine nel greco "ethnos", che indica un aggregato di individui distinto da proprie
caratteristiche 12 (nota: Bernardi, ....) In greco, ethnos è usato prevalentemente per indicare gruppi
altri e diversi, in modo cioè sostanzialmente discriminatorio, nello stesso senso in cui gli stessi greci
9
W.G. Sumner, Folkways, Boston,. 1906, trad. it. Costumi di gruppo, Milano, 1962, p. 5
C. Lévi-Strauss, “Razza e storia”, trad. it. in Razza e storia e altri studi di antropologia, Torino, Einaudi, 1967, p. 106
11
Per un quadro aggiornato delle discussioni interne alle scienze naturali v. S. J. Gould, Intelligenza e pregiudizio.
Contro i fondamenti scientifici del razzismo, trad.it. Milano, Il Saggiatore, 1998
12
B. Bernardi, “Il fattore etnico: dall’etnia all’etnocentrismo”, Ossimori, 4, 1994, pp. 13-36; v. anche A. Rivera,
“Etnia-etnicità”, in R. Gallissot, A. Rivera, L’imbroglio etnico, cit., pp. 77-98
10
e i romani parlavano di barbari. Con questo senso discriminatorio il termine passa nelle traduzioni
greche della Bibbia e nel linguaggio del Nuovo Testamento, e da qui nelle lingue europee moderne.
Nel linguaggio biblico e neotestamentario, ethne designa i non ebrei e i non cristiani, gli altri,
dunque. Nelle lingue europee moderne, come italiano, inglese o tedesco, il derivativo ethnici si
afferma con l'accezione spregiativa di pagani; quando il cristianesimo si identificherà con l'intera
società occidentale, l'accezione negativa si estenderà a tutti i non occidentali.
Un uso neutrale dei termini etnici, nel senso dell'etnologia (cioè descrizione e studio delle
caratteristiche sociali e culturali di qualsiasi raggruppamento umano), si afferma progressivamente
solo a partire dall'Ottocento, con lo sviluppo appunto dell'antropologia e delle scienze umane.
Nell'uso attuale del termine i due sensi si intrecciano strettamente. Tende a prevalere l'accezione
antropologica, che in sostanza definisce come etnia un gruppo che condivide un insieme di elementi
culturali, quali la lingua, la religione, certi usi e costumi eccetera (l' eccetera è necessario, perché
l'elenco può difficilmente esser esaurito). Tuttavia, questo uso neutrale e descrittivo si carica spesso
di connotazioni valutative e discriminatorie: noi usiamo sempre l'aggettivo etnico (conflitti,
identità) per gli altri, e in specie in riferimento a realtà minoritarie all'interno di un singolo Statonazione, o a realtà che storicamente si collocano al di fuori di chiare identità nazionali e statali. Noi
non siamo mai "etnici", e non lo è mai la grande cultura, quella dominante. Etnici sono gli altri, i
più arretrati o i più poveri, le minoranze.
Ora, il rischio principale che corrono le nozioni di etnico e di etnia, come del resto la nozione di
cultura, nel loro passare dal linguaggio specialistico delle discipline sociali al linguaggio politico e
al senso comune, è la reificazione. L'aggettivo etnico, e ancor più il sostantivo etnia, tendono a esser
letti secondo il modello delle cartine politiche degli atlanti: colori diversi punteggiano un mondo
suddiviso in entità compatte e autonome, dalla consistenza quasi naturale, esclusive e distintive.
Come si può appartenere a uno e ad un solo Stato, così si appartiene a una sola etnia-cultura. Più
che come un processo costantemente in divenire, l'appartenenza culturale ed etnica è intesa come
proprietà immutabile di un gruppo umano e di tutti gli individui che ne fanno parte.
Di questa tendenza alla essenzializzazione o reificazione, peraltro, l'antropologia non è affatto
innocente. Per una serie di ragioni, che sono al contempo epistemologiche, di metodo, teoriche e
ideologiche), essa ha fornito un'immagine eccessivamente statica, compatta e "divisionista" delle
culture, e di conseguenza delle etnie. Si potrebbe dire, con un paradosso, che l'antropologia ha
naturalizzato le culture, ci ha abituato a pensarle come cose che esistono prima e indipendentemente
dai processi storici, da un lato, e dall'altro dagli individui che ne fanno parte, i quali sarebbero quasi
imprigionati al loro interno. I paradigmi che l'antropologia classica ha fornito per pensare la
diversità culturale sono quelli dell'isola, della riserva indiana, del deserto, del villaggio isolato nella
giungla; tutti modelli che accentuano l'esclusività, la compattezza interna, i confini netti, la staticità,
e nascondono gli elementi di continuo mutamento, di scambio reciproco, di sincretismo, che
caratterizzano invece la vita culturale 13 .
Ora, ammesso (e non concesso) che questo modello divisionista fosse adeguato alle realtà
esotiche e "primitive" classicamente studiate dall'antropologia, esso non è certo adeguato alla realtà
attuale di un pianeta dominato da processi di globalizzazione, da flussi comunicativi e di
circolazione di persone, merci e idee senza precedenti. La situazione economica, politica e culturale
di questa fine secolo fa saltare completamente la coerenza del modello classico. Dar conto delle
differenze e delle identità culturali di oggi a partire dalla nozione relativistica di etnie-culture
originarie e autentiche è implausibile. L'antropologia ha dovuto rivedere in profondità la propria
attrezzatura teoretica e, da alcuni decenni, si è impegnata in un processo di critica o decostruzione
proprio dei concetti di cultura, etnia, identità. Oggi si riconosce comunemente che le realtà sociali
indicate da tali termini non hanno nulla di essenziale o autentico, e sono sempre il frutto di
13
Si vedano su questo punto U. Fabietti, L’identità etnica, Roma, NIS, 1995 e C. Geertz,
locali. Cultura e politica alla fine del ventesimo secolo, Bologna, Il Mulino, 1999
Mondo globale, mondi
contingenti processi storici e dinamiche politiche, spesso meno antichi e profondi di quanto si
creda 14 .
Nel senso comune e nel linguaggio dei media, tuttavia, l'uso reificato decisamente persiste.
Quando si parla di conflitti etnici, come nel caso della ex-Jugoslavia, o di guerre "tribali", come si
continua a dire per i contesti africani, con termine ancor più equivoco, si presuppone uno scontro fra
realtà etniche chiare e distinte, che preesistono al conflitto attuale e anzi ne sono la causa. Si assume
una essenza etnica più reale e più forte di ogni vicenda politica: un po' come se le appartenenze
etniche fossero lo sfondo immutabile sul quale si articolano le contingenti e mutevoli faccende della
politica. Non si prende abbastanza in considerazione la possibilità che, almeno in parte, il discorso
etnico, i sentimenti di appartenenza, il senso delle differenze siano la conseguenza e non la causa
dei conflitti.
4. Razzismo differenzialista
Ora, la tendenza alla reificazione dei termini etnici e culturali rischia di produrre una nuova
assolutizzazione delle differenze, e finisce per avvicinarne l'uso a quello del vecchio concetto di
razza. In particolare, il rischio è che il discorso etnico-culturale sia usato strumentalmente come
supporto o giustificazione "scientifica" di pratiche di discriminazione che potremmo a pieno titolo
chiamare razziste. Vorrei citare tre esempi di un simile uso strumentale, limitandomi però - per
motivi di spazio oltre che di compentenza - a discutere solo l'ultimo. Il primo esempio riguarda il
caso già ricordato dei conflitti etnici nella penisola balcanica. Qui la propaganda nazionalista quella serba in modo e con forza particolare - ha fatto perno su una presunta irriducibilità
dell'appartenenza etnica, ponendola alla base di rivendicazioni territoriali e di strategie di controllo
politico. Ciò che più colpisce, nel caso della ex-Jugoslavia, è la facilità con cui le istanze identitarie,
in sé per così dire innocenti, sono sfociate in strategie biopolitiche molto vicine a quelle del
nazismo, con la pratica sistematica della deportazione di massa, del massacro, e di quella peculiare
forma di violenza che è il cosiddetto "stupro etnico" 15 .
Il secondo esempio, molto meno drammatico ma di altrettanta evidenza nell'ultimo decennio del
Novecento, è quello dei regionalismi. Possiamo considerare il caso del leghismo italiano come
emblematico dell'uso strumentale delle categorie dell'identità etnico-culturale. Un movimento nato
in tempi assai recenti, attorno a rivendicazioni di ordine essenzialmente politico-economico, ha
sentito il bisogno di una legittimazione ideologica che facesse riferimento alle essenze etniche
“irriducibilmente” diverse del Nord e del Sud. Lo ha fatto attraverso grossolane operazioni di
invenzione della tradizione, improvvisando improbabili rituali e richiamandosi a presunte radici
"celtiche": con l'effetto di trasformare una rete di differenze socio-culturali che sono indubbiamente
reali nella immaginosa e antistorica creazione di un'essenza padana 16 .
Il terzo esempio, che vorrei brevemente discutere, riguarda certe forme odierne di ideologia e
pratica razzista, in particolare quello che viene comunemente definito neorazzismo differenzialista
o fondamentalismo culturale. Come detto, la vecchia accezione del termine razzismo si può dire
oggi, nella seconda metà del XX secolo, sostanzialmente esaurita, insieme ad alcune sue
14
Il dibattito degli ultimi venti anni su etnia ed etnicità è molto ampio e di difficile definizione. Fra i testi disponibili in
lingua italiana, rimando per una sintesi teorica a L. Li Causi, “Ridimensionare l’etnia? Note metodologiche sul
fenomeno etnico”, Ossimori, 6, 1995, pp. 13-19, e all’antologia curata da V. Maher, Questioni di etnicità, Torino,
Rosenberg & Sellier, 1994. Per quanto riguarda lo smascheramento del carattere recente e “inventato” di molte
tradizioni etniche, grande influenza ha esercitato il volume curato dagli storici E.J.Hobsbawm-T.Ranger, L’invenzione
della tradizione, trad.it. Torino, Einaudi, 1987
15
Una pratica, quest’ultima, che lo stesso nazismo non praticava, per la peculiarità del suo pensiero razzista,
ossessionato dal timore della contaminazione; v. in proposito V. Nahoum-Grappe, “L’uso politico della crudeltà e
l’epurazione etnica in ex-Jugoslavia (1991-1995)”, in F. Heritier (a cura di), Sulla violenza, trad.it. Roma,
Meltemi,.1997, pp.190-227.
16
V. R. Biorcio, La Padania promessa, Milano, Il Saggiatore, 1997
conseguenze - come l'orrore per la mescolanza biologica tra le razze e dunque per i matrimoni misti,
l'idea di poter costruire gerarchie di popoli sulla base di caratteristiche biologiche ed ereditarie. E'
oggi impensabile per qualsiasi attore politico - non importa quanto xenofobo o antisemita - adottare
un linguaggio anche lontanamente imparentato a quello hitleriano, impregnato di metafore sugli
ebrei come agenti infestanti, bacilli portatori di contagio e di impurità che devono essere distrutti
per la buona salute della società intesa come un organismo. Ma da dove vengono allora le idee
odierne di pulizia etnica ? Quali basi culturali fondano gli atteggiamenti discriminatori verso gli
immigrati, le politiche xenofobe, il pregiudizio, la discriminazione - fatti sociali che non sono certo
scomparsi insieme al concetto biologico di razza?
Al posto del vecchio razzismo biologico si è affermata una forma di neo-razzismo, o, come alcuni
studiosi lo chiamano, razzismo differenzialista 17 . Questa concezione, paradossalmente, riesce a
volgere a sostegno di pratiche razziste proprio le tradizioni culturali che nel Novecento più si sono
opposte al razzismo - come il discorso culturalista ed etnicista sopra descritto. La nuova destra
xenofoba non parla più di razze e di differenze naturali ma di culture o etnie, per indicare le radici
storiche e culturali che tengono insieme un popolo e lo distinguono da altri. Non si rivendica più la
superiorità di alcuni popoli e culture su altre. Si accetta il principio del relativismo culturale, che
come abbiamo visto è l'esatto opposto dell'etnocentrismo e per certi versi del razzismo: ogni cultura
ha valore in sé, non può esser giudicata sulla base di criteri appartenenti a un'altra cultura: e tutte le
culture del mondo hanno uguale dignità e in linea di principio uguale importanza.
Ma, proprio sulla base di questi principi di apertura e tolleranza, si giunge a riaffermare l'antica
esigenza xenofoba. Proprio per il valore intrinseco di ciascuna cultura; proprio perché la vita di
ognuno di noi, i nostri valori, le nostre convinzioni morali sono radicate in una ben precisa identità
culturale - per tutti questi motivi, le culture e le identità non devono essere confuse e mescolate.
Occorre preservarne l'integrità e l'autenticità di fronte alla confusione, al mescolamento, e anche di
fronte al rischio dell’omologazione che investe il mondo contemporaneo. Questo punto affonda le
radici in alcune formulazioni antropologiche anche di grande prestigio, come quelle di Lévi-Strauss,
che ha sostenuto la necessità di un certo grado di "sordità" reciproca fra le culture; se la diversità
culturale è il bene massimo da preservare per l'umanità, poiché il progresso stesso è consentito non
dalla prevalenza di una cultura su tutte le altre, ma dalla compresenza di molte culture diverse,
allora occorre certo favorire il dialogo e lo scambio, ma anche difendere le rispettive identità e
confini, evitare contaminazioni troppo profonde che facciamo perdere appunto il senso della
diversità. L'omologazione culturale, il caotico mescolamento, sembrano per Lévi-Strauss i massimi
pericoli della contemporaneità 18 . La sua posizione, opportunamente forzata, è stata utilizzata dai
movimenti contrari all'immigrazione in molti paesi europei. Un ruolo di avanguardia in questa
direzione è stato svolto dalla cosiddetta nuova destra francese, con il contributo di teorici piuttosto
sofisticati come Alain de Benoist, secondo il quale "tutti i popoli devono preservare e coltivare le
17
Questa definizione è stata esplorata in modo particolarmente sistematico nell’opera dello studioso francese PierreAndré Taguieff; si vedano P.-A. Taguieff, La forza del pregiudizio. Saggio sul razzismo e l’antirazzismo, trad. it.
Bologna, Il Mulino, 1988 e, per una più sintetica esposizione, Il razzismo. Pregiudizi, teorie, comportamenti, trad. it.
Milano, Cortina, 1999. Per la nozione – per certi versi analoga – di “fondamentalismo culturale v. V. Stolcke,
“Talking culture. New boundaries, new rethorics of exclusion in Europe”, Current Anthropology, 36 (1), 1995, pp. 124
18
Posizioni espresse con forza particolare in C. Lévi-Strauss, Lo sguardo da lontano, trad. it. Torino, Einaudi, 1984,
Prefazione e cap. 1, e che rivedono criticamente quanto sostenuto precedentemente dallo stesso autore nel daggiod egli
anni ’50 “Razza e storia”, cit. Per una stimolante discussione dei rapporti tra il “primo” e il “secondo” Lévi-Strauss v.
C. Geertz, “Gli usi della diversità”, trad.it. in La società degli individui, III (8), 2000. Per una feroce critica di segno
“antirazzista” a Lévi-Strauss si veda M.G.O’Callaghan - C. Guillamin, “La moda «naturalistica» nelle scienze umane”,
trad. it. In Democrazia e diritto, XXIX (6), 1989, pp. 181-202. V. anche G. Riccardo, “Immagini dell’etnologia e
immagini della società. A proposito di alcune letture del razzismo contemporaneo”, Problemi del socialismo, 21, n.s.,
1989, pp.45-59 e F. Dei, “Giudizio etico e diversità culturale nella riflessione antropologica”, in R. De Vita (a cura di),
Società in trasformazione ed etica, Siena, 1992, pp. 53-79
proprie differenze", e "l'immigrazione è condannabile perché attenta all'identità della cultura di
accoglienza così come all'identità degli immigrati" 19 .
Il motto di questi movimenti, tradotto in linguaggio comune, potrebbe essere : "noi non siamo
razzisti, ma pensiamo che, per il bene comune, ognuno se ne dovrebbe restare a casa propria". I
movimenti migratori di massa, come quelli dall'Africa verso l'Europa, producono sradicamento e
perdita delle identità culturali, sia per gli ospitanti che per gli ospiti. La chiusura delle frontiere,
dunque, è necessaria per proteggere entrambi. L'argomento dell'inuguaglianza biologica è sostituito
dall'assolutizzazione delle differenze tra le culture. Accade così che la separazione e la xenofobia
possono esser sostenute in nome di valori come la tolleranza, il rispetto dell'altro e della sua
dignità, il diritto alla differenza, senza bisogno di parlare né di razze né di superiorità-inferiorità.
Se torniamo per un attimo al caso dei Balcani, possiamo trovare delle analogie. Milosevic è stato
paragonato a Hitler. Si può osservare nel nazionalismo serbo qualche affinità con il pangermanismo
e il nazionalismo tedesco (e non solo tedesco) della prima metà del secolo; c'è anche in comune una
certa mistica della terra se non del sangue, e la tendenza a radicare in gloriose tradizioni storiche,
più o meno inventate e deformate, il presunto destino della patria. Ma è interessante notare che in
questo caso l'odio, la discriminazione e la pulizia etnica non si accompagnano a un linguaggio
esplicitamente razzista, ad affermazioni di superiorità e inferiorità, limitandosi a rivendicare la
differenza, a pretendere una segregazione integrale dei popoli che rispecchi la presunta assoluta
differenza etnico-nazionale. Ciò non significa che ciò che accade ed è accaduto sia meno terribile.
5. Caratteri distintivi dei neorazzismi
Dunque, il neorazzismo si fonda oggi su nuove basi ideologiche, che si confondono con
argomenti a favore della tolleranza, del relativismo, nonché con i richiami, di per sé giusti, alla
valorizzazione delle identità culturali delle comunità umane. Ciò rende più difficile riconoscere
oggi il razzismo, come atteggiamento sia ideologico sia pratico, rispetto alle sue più classiche ed
evidenti manifestazioni che il senso comune generalmente condanna, dal nazismo al Ku Klux
Clan. Non solo: diviene più complesso anche capire che cosa voglia dire essere antirazzisti, come in
linea di principio la gran parte di noi aspira ad essere. Vorrei concludere l'intervento con alcune
osservazioni su questi punti.
Prima di tutto, come riconoscere un razzismo che non si dichiara come tale? E' facile prendere
posizione, ed esempio, di fronte al "Manifesto della razza" del 1938 che invitava "gli italiani a
proclamarsi francamente razzisti" 20 . Oggi nessuno (con eccezioni irrilevanti) si proclama
francamente tale, né gruppi politici e culturali né individui; ciò non significa che non circolino
largamente atteggiamenti ideologici e comportamenti pratici che presentano forti continuità con il
razzismo classico, autorizzandoci a usare ancora questo termine (piuttosto che sostituirlo
semplicemente con "pregiudizio", xenofobia" e simili 21 ). Dobbiamo riconoscere questi
19
Cit. in R. Gallissot - A. Rivera, L’imbroglio etnico, cit., pp. 183, 187
Sulle elaborazioni scientifiche del razzismo nell’Italia fascista si vedano R. Maiocchi, Scienza italiana e razzismo
fascista, Firenze, La Nuova Italia, 1999 e G. Israel - P. Nastasi, Scienza e razza nell'Italia fascista, Bologna, Il Mulino,
1998
21
Peraltro, a fronte della più comune rilettura in chiave etnica delle antiche differenze razziali, è importante rilevare la
persistenza di una dinamica opposta: vale a dire, la tendenza a razializzare le differenze etniche e culturali. Questo
fenomeno è stato rilevato spesso negli Stati Uniti, dove le categorie razziali prevalenti, quelle di “bianco” e “nero”, sono
spesso proiettate su un mosaico etnico molto più vario e complesso. Questo è uno dei motivi che ha spinto l’attuale
antropologia americana a restituire centralità alla nozione di razza. Un motivo parallelo ha a che fare col sostegno di
molti antropologi alle strategie politiche delle minoranze di colore o afro-americane le quali, nel denunciare il
persistente razzismo della società statunitense, rivendicano in positivo l’appartenenza razziale, sottolineandone i
demarcatori somatici. A parere di molti, l’antirazzismo americano della seconda metà del secolo ha percorso una strada
sbagliata, trasformando gli USA in un società “cieca ai colori” (color blind): questa indifferenza alle caratteristiche
somatiche, il “fare come se non ci fossero”, è in realtà un modo di nascondere le profonde sperequazioni che ancora
dividono gli afro-americani dai bianchi; dunque, una più effettiva pratica antirazzista ha oggi bisogno di recuperare e
20
atteggiamenti e comportamenti al di sotto della veste culturalista sotto cui si presentano; d'altra
parte, non possiamo prendere troppo alla leggera l'imputazione di razzismo, attribuendola
ciecamente a ogni discorso o atto politico che affronti criticamente il problema della diversità e del
rapporto con gli "altri". Non ha molto senso considerare ipso facto razzista, ad esempio, ogni
politica di controllo sull'immigrazione, o di limitazione allo sviluppo demografico per i paesi in via
di sviluppo - un errore nel quale i movimenti antirazzisti si lasciano talvolta trascinare, come
vedremo tra breve.
Dunque, quali sono i punti in comune tra vecchio e nuovo razzismo, tra il razzismo biologico,
gerarchizzante e "universalista" della prima metà del secolo e quello culturale, differenzialista e
relativista della seconda metà? Una delle teorie più sistematiche avanzate in risposta a questa
domanda è quella dello studioso francese Pierre-André Taguieff, che individua tre atteggiamenti
intellettuali e tre tipi di pratiche come denominatori comuni, rispettivamente, dell'ideologia e del
comportamento razzista.
Partiamo dalle basi ideologiche. La prima di esse è per Taguieff la
categorizzazione essenzialista degli individui o dei gruppi, che implica la riduzione
dell'individuo allo statuto di un qualsiasi rappresentante del suo gruppo di appartenenza
o della sua comunità d'origine elevata a comunità di natura o d'essenza, fissa e
insormontabile. Nascere tali, significa essere e dover rimanere tali 22 .
In altre parole, l'appartenenza a una categoria produce un giudizio aprioristico e totalizzante su
un individuo, a cui sono associati immediatamente tutti gi attributi stereotipi della categoria. Così
funzionava il termine "ebreo" nella cultura tedesca degli anni '30 e '40, o il termine "negro" in
società (formalmente o di fatto) di apartheid ; così, anche se con conseguenze meno drammatiche,
tendono a funzionare oggi da noi i termini "immigrato", extracomunitario", "albanese", e così via.
Non è ad esempio razzista constatare gli alti tassi di criminalità fra certe categorie di immigrati; lo è
considerare qualcuno criminale per il fatto di appartenere a quelle categorie. Taguieff coglie qui un
punto importante: la sua definizione ha tuttavia bisogno di una integrazione. La riduzione degli
individui a "essenze" è infatti un meccanismo assai diffuso nella vita sociale, in riferimento a ogni
tipo di alterità e diversità, e su ordini di grandezza molto diversi: "i milanesi", "i romani", "gli
americani", oppure "i politici", o "gli juventini" e così via. Perché tale meccanismo assuma carattere
razzista occorre sia in gioco qualcos'altro, e cioè un'asimmetria di potere. In altre parole, razzista è
l'essenzializzazione di una categoria debole o subalterna da parte di gruppi o individui relativamente
privilegiati, che vedono in essa, a torto o a ragione, una minaccia per la propria posizione. Questo
punto è colto efficacemente in un'altra celebre definizione di razzismo, proposta dal sociologo
Albert Memmi. Il razzismo è a suo parere
l'enfatizzazione, generalizzata e definitiva, di differenze, reali o immaginarie, che
l'accusatore compie a proprio vantaggio e a detrimento della sua vittima, al fine di
giustificare i propri privilegi o la propria aggressione. 23
affinare la percezione del colore. In alcuni movimenti culturali, come il cosiddetto “afrocentrismo”, questa riscoperta
della razza rischia di assumere la forma paradossale di un modello invertito di determinismo biologico: l’origine
africana, visibile nel colore della pelle anche se non percepita storicamente, sarebbe il nucleo portante dell’identità
culturale, fondando particolari propensioni e capacità. Per un richiamo radicale (e a mio parere non privo di ambiguità)
dell’antropologia culturale alla riflessione e all’uso politico del linguaggio razziale si vedano i saggi raccolti in un
recente numero monografico dell’autorevole rivista American Anthropologist: F.Harrison (a cura di), “contemporary
issue forum: Race and racism”, American Anthropologist, 100 (3), 1998.
22
P.-A. Taguieff, Il razzismo, cit. , p. 64
23
A. Memmi, Il razzismo, trad.it. Genova, Costa & Nolan, 1989; cit. in R. Gallissot – A.Rivera, L’imbroglio etnico, cit.,
p. 180
Il senso comune è pieno di enfatizzazioni ed essenzializzazioni, etniche e non: questi sono anzi i
meccanismi retorici fondamentali per alcuni generi di discorso, come l'umorismo. Si pensi agli
stereotipi sui tedeschi efficienti ma troppo rigidi, sugli statunitensi spacconi e presuntuosi, sui
giapponesi conformisti e maniacali e così via. Se questi stereotipi sono innocui, lo stesso non si può
dire di quelli, largamente correnti nell'Italia di oggi, sugli albanesi violenti, fannulloni, pretenziosi.
Gli enunciati "i tedeschi sono tutti uguali" e "gli albanesi sono tutti uguali", pur identici nella
sintassi, hanno implicazioni razziste profondamente diverse.
Tornando a Taguieff, il secondo ingrediente ideologico del razzismo (che presuppone il primo) è a
suo parere la stigmatizzazione. Una volta categorizzati secondo una presunta immutabile essenza,
gli "altri" possono esser stigmatizzati, cioè subire un processo di esclusione simbolica, imperniato
sulla "creazione di un certo numero di stereotipi negativi" 24 . Ad essi si attribuiscono difetti
congeniti, "tare", impurità di vario tipo, qualità pericolose che li rendono minacciosi. Il "nemico"
viene disumanizzato, demonizzato, bestializzato, e ciò crea una distanza psicologica e morale che
spiega anche le manifestazioni di violenza, nonché il peculiare rapporto vittime-carnefici che
caratterizza gli eccidi nazisti come i pestaggi degli immigrati di colore. Una conseguenza della
stigmatizzazione è la mixofobia, cioè la paura della mescolanza e dell'ibridazione, che spesso si
manifesta attraverso un linguaggio patologizzante, con l'ossessione di un "contagio" metaforico o
reale - con il che si torna nelle immediate vicinanze del linguaggio hitleriano e dell'antisemitismo
nazista.
Il terzo elemento caratterizzante del razzismo viene chiamato da Taguieff "barbarizzazione", e
consiste nella "convinzione che certe categorie di esseri umani non siano civilizzabili (e dunque,
come presupposto, che non siano civilizzate), che non siano perfettibili, non siano educabili,
convertibili, assimilabili" 25 . Taguieff sostiene che la teoria della inuguaglianza biologica tra le razze
è solo una incarnazione storica di questa tendenza, che può manifestarsi attraverso altri linguaggi e
teorie. Si tratta del più altro grado di distanziamento e esclusione dell'altro: in quanto "barbaro",
esso non è solo diverso, inferiore, pericoloso, ma rappresenta l'antitesi stessa della civiltà: è colui
che non riconosce i valori fondamentali, che non rispetta le distinzioni centrali all'esistenza stessa
della civiltà. La barbarizzazione implica l'impossibilità di ogni assimilazione, e dunque apre la
strada a politiche eliminazioniste, di radicale separazione xenofoba e persino di genocidio.
Dal punto di vista degli atteggiamenti pratici, Taguieff distingue tre tipi o livelli di azioni
logicamente giustificabili dalla precedenti condizioni, anche se non ne sono la necessaria
conseguenza. Si tratta in primo luogo delle pratiche di segragazione, discriminazione, espulsione; in
secondo luogo, di forme dirette di persecuzione e di violenza essenzialista (diretta cioè contro una
categoria in quanto tale), e infine del genocidio, cioè dello sterminio di tutti i rappresentanti di una
categoria di popolazione 26 . Come si vede, sembra quasi che Taguieff abbia costruito il suo schema
teorico ricalcando i livelli successivi della persecuzione nazista contro gli ebrei. Rispetto alle
interpretazioni che considerano la Shoah come un unicum storico, egli sembra però pensare che i
nazisti non abbiano che condotto alle estreme - e per certi versi logiche - conseguenze un
atteggiamento ideologico e pratico assai più diffuso; che, dunque, il genocidio sia sempre inscritto,
come possibilità, nei livelli di base della discriminazione razzista.
Naturalmente, Taguieff non sostiene che le pratiche di persecuzione violenta siano semplici
conseguenze di convinzioni teoriche o ideologiche. Le cose sono più complesse. Da un lato, infatti,
le idee e i comportamenti razzisti non insorgono da soli nella testa della gente, e possono esser
ricondotti a una serie di cause "strutturali" (economiche, sociali, politiche, etc.). Dall'altro, anche sul
piano soggettivo, lo sviluppo di atteggiamenti razzisti non discende semplicemente da "credenze" o
convinzioni politiche, e neppure da dinamiche psicologiche più o meno universali. Citando ancora
Memmi, si può dire che l'atteggiamento razzista ha tutta la complessità e la profondità di un'
"esperienza vissuta", nella quale esperienze personali di vita, emozioni e passioni, credenze,
24
P.-A. Taguieff, Il razzismo, cit., pp. 64-5
Ibid., p. 66
26
Ibid., pp. 67-8
25
interessi economici, convinzioni politiche, ragioni e impulsi irrazionali, influenza della cultua di
massa e dell'immaginario sociale e così via si legano in un groviglio difficile da districare 27 (v.
Taguieff p. 69).
6. Antirazzismo.
Abbiamo visto prima come le mutate basi ideologiche del razzismo rendano più difficile non solo
riconoscerlo, ma anche opporvisi coerentemente. L'antirazzismo corre oggi due tipi di rischi. Il
primo è quello di usare gli stessi strumenti ideologici e culturali del neorazzismo differenzialista; il
secondo è il rischio di riprodurre gli stessi meccanismi di essenzializzazione, stigmatizzazione e
barbarizzazione che, come detto, caratterizzano il razzismo stesso. Partiamo anche qui da Taguieff,
autore che più di ogni altro ha gettato le basi di una critica - per quanto costruttiva - all'antirazzismo
contemporaneo.
L'antirazzzismo classico, impregnato di culturalismo e di differenzialismo, non può
più funzionare da dispositivo critico efficace, dal momento che le sue tesi e
argomentazioni tendono a confondersi con quelle del neorazzismo, differenzialista e
culturale. Di qui, la presa di coscienza della necessità di ripensare l'antirazzismo e di
abbandonare la funzione rituale e il significato strettamente commemorativo di
quest'ultimo. 28
L'argomento è chiaro, anche se espresso in modo forse troppo radicale. Non è affatto detto che
tutto l'antirazzismo classico, elaborato in risposta alle teorie sull'inuguaglianza biologica e sul
naturale ordine gerarchico delle razze, sia da buttare; non è detto che i vecchi argomenti culturalisti
e relativisti siano colpevoli di "connivenze" con il razzismo per il solo fatto di esser stati
strumentalmente usati dai nuovi teorici della xenofobia. Tuttavia, il problema che Taguieff pone è
reale: i vecchi argomenti non bastano più, e risultano anzi fortemente ambigui. L'antropologia
culturale, che per buona parte del secolo è stata baluardo dell'antirazzismo relativista, risente
particolarmente di tutto ciò. I testi classici che essa ha opposto al razzismo, da Modelli di cultura di
Ruth Benedict a Razza e storia di Lévi-Strauss, rischiano di divenire oggi armi nelle mani del
"nemico". Che fare, dunque?
Mi si consenta di proseguire con una ulteriore citazione da Taguieff:
L'antirazzismo non può limitarsi all'indignazione morale retrospettiva e all'anatema
commemorativo se non per squalificarsi, collaborando alla propria scomparsa per la
mancanza di "razzisti" conformi all'identikit consueto. Né i Gobineau né gli Hitler
possono oggi esser trovati lì dove li si cerca, e i nuovi razzisti non somigliano più a
queste figure del passato. L'antirazzismo militante deve finalmente cessare di
commettere degli errori tattico-strategici, il principale dei quali è quello di sbagliare
nemico, di non identificare il nuovo vero nemico, e di continuare a prendere come
propri obiettivi i luoghi ripugnanti della memoria. 29
Anche qui, il tono di Taguieff mi pare eccessivo. Egli sottovaluta forse il ruolo della memoria del
passato e della celebrazione rituale: se è la memoria della Shoah ciò a cui si riferisce parlando di
"indignazione morale retrospettiva" e di "anatema commemorativo", mi pare che non ne comprenda
il giusto peso. Il fatto che la memoria del passato non sia sufficiente non implica che non sia
necessaria: troppo spesso la cronaca ci rammenta come quelle "figure del passato" non siano poi
27
Ibid., p. 69
Ibid., p. 50
29
Ibid.
28
così lontane (dal caso Haider alle periodiche “scoperte” della vitalità del neonazismo in Europa).
Ma credo che il rischio di sbagliare nemico cui Taguieff fa cenno abbia un altro e più importante
significato: si riferisce al rischio, per l'antirazzismo, di mettere in atto le stesse procedure di
stigmatizzazione, di costruzione di un nemico assoluto e astratto - il "razzista" - tipiche del pensiero
razzista stesso.
Il "razzista" diviene figura negativa centrale di un grande mito repulsivo, seguace del Male
assoluto, in un modello dicotomico che interpreta le vicende del mondo come scontro tra un Male
assoluto e un Bene assoluto. Si sviluppa cioè un antirazzismo dogmatico, cui si aderisce su base
meramente ideologica e rituale. In uno scritto precedente a quello finora citato, Taguieff scriveva
che
è un paradosso ormai comune dell'antirazzismo il fatto che i suoi sostenitori rovescino
sull'avversario "razzista" i modi di rappresentazione e di stigmatizzazione che gli attribuiscono. Si
pensi a espressioni come "Sporco razzista !", o come in Francia si è talvolta detto, "Gasiamo i
lepenisti!". Gli spiriti antirazzisti sono impregnati di razzismo. 30
Il rischio non è dunque solo combattere nemici che non ci sono più, ma anche scegliersi nuovi
nemici su basi puramente ideologiche. Mi pare si tratti di un rischio estremamente reale per un certo
antirazzismo militante, troppo preoccupato di dividere il mondo in buoni e cattivi. Ma è un rischio
anche per l'analisi culturale del razzismo. Un solo esempio. Un importante filone di studi degli
ultimi decenni è l'analisi retorica del discorso razzista. Dovendo scoprire un razzismo dissimulato e
non esplicito, gli studiosi mettono a punto sofisticati strumenti d'indagine e vanno a cercarne le
manifestazioni nei luoghi apparentemente più innocenti, nelle strutture della "conversazione"
quotidiana, nei messaggi delle news televisive o della pubblicità, nell'umorismo o nei giornaletti per
bambini, nei libri di testo scolastici e così via. 31 I risultati sono molto interessanti: un discorso
comune che per lo più si dichiara antirazzista risulta di fatto impregnato di stereotipi, di pregiudizi,
di valutazioni essenzialiste e stigmatizzanti verso gli altri (soprattutto, per quanto riguarda Italia ed
Europa, verso gli immigrati "extracomunitari"). Valutazioni meno crude ed esplicite, ma in
definitiva non troppo diverse da quelle che dominavano l'immaginario collettivo in epoca
colonialista.
Ogni studio che ci mostra la diffusione, in estensione come in profondità, di questo sostrato di
pregiudizi, non manca di stupirci, e di mettere in crisi la nostra poco fondata convinzione di vivere
all'interno di una cultura aperta, tollerante, sempre pronta a rispettare e valorizzare l'alterità. Tutto
quanto può scalfire questa ingenua e autoindulgente immagine di noi stessi è certamente salutare.
Tuttavia, vi sono in questi studi degli aspetti discutibili: almeno due di essi saltano immediatamente
agli occhi. Il primo problema è per così dire la forza eccessiva degli strumenti analitici messi in
campo: essi funzionano troppo bene, e riescono a scoprire razzismo dietro ogni tipo di discorso.
Nulla può resistervi. I messaggi che si presentano esplicitamente come antirazzisti sono i preferiti
di questo tipo di analisi: applicando ad essi interpretazioni ancor più raffinate, si dimostra come la
loro struttura retorica profonda sia connotata da un più essenziale razzismo. Le analisi compiute da
van Dijk sulla conversazione quotidiana e sulle notizie giornalistiche e televisive riguardanti
l'immigrazione sono appunto di questo tipo: assai penetranti da un lato, ideologiche e pregiudiziali
dall’altro. Partendo dall’assunto che l’intero universo della comunicazione di massa e della
conversazione quotidiana è un meccanismo di trasmissione di pregiudizi razziali, funzionali alle
politiche xenofobe dei governi democratici, è possibile dimostrare che qualsiasi discorso preso in
30
P.-A. Taguieff, “Riflessioni sulla questione antirazzista”, trad. it. in Problemi del socialismo, 2, n.s. 1989, p.26
L’autore probabilmente più rappresentativo di questo filone di studi è probabilmente Teun A. van Dijk, di cui si può
vedere in traduzione italiana Il discorso razzista. La riproduzione del pregiudizio nei discorsi quotidiani, Messina,
Rubbettino, 1994. Nel panorama antropologico italiano sono importanti i lavori di Clara Gallini, Giochi pericolosi.
Frammenti di un immaginario alquanto razzista, Roma, Manifestolibri, 1996 e Paola Tabet, La pelle giusta, Torino,
Einaudi, 1997.
31
esame ha finalità razziste, palesi o nascoste. Non c’è limite alle possibilità dell’interpretazione: anzi,
quanto più un discorso si proclama antirazzista, più subdola e profonda è la sua intenzione razzista.
Ci si può chiedere se sia possibile almeno immaginare un messaggio - un articolo di giornale, un
servizio televisivo - che non risulti razzista secondo quel metodo interpretativo: e ho l'impressione
che la risposta sarebbe negativa. In altre parole, si dà l’avvio alla caccia al discorso razzista senza
stabilire in anticipo i requisiti minimi di un discorso non-razzista. Inoltre, come in molti sistemi
teorici “chiusi”, ogni critica alle interpretazioni proposte può esser respinta sulla base di
un’attribuzione di razzismo (proprio come si usava deridere come “borghesi” le critiche al
marxismo, o attribuire le obiezioni alla psicoanalisi alle “resistenze inconsce” degli interlocutori).
Se è così, tralasciando ogni considerazione di validità epistemologica, si può almeno dire che questa
non sembra una strada molto promettente per riconoscere i "veri nemici".
Il secondo problema posto dall'analisi del discorso razzista è la sua tendenza a non distinguere
diversi livelli del pregiudizio: in particolare, a porre sullo stesso piano l'etnocentrismo e il razzismo
vero e proprio, i pregiudizi depositati nel linguaggio dagli enunciati consapevolmente e
aggressivamente discriminatori. E' vero che la distinzione può essere poco chiara in molti casi, e
che i pregiudizi più profondi e pericolosi sono spesso proprio quelli più invisibili e inconsapevoli,
incardinati in usi linguistici considerati come "naturali". E' vero anche che il richiamo a naturali
tendenze etnocentriche può essere usato come giustificazione di reali atteggiamenti discriminatori.
E tuttavia, non si può far coincidere l'analisi del discorso razzista con il rilevamento degli aspetti
etnocentrici della nostra cultura, non foss'altro perché questi ultimi sono troppo numerosi e
pervasivi. La cultura occidentale (come molte altre) si è costituita storicamente attorno alla
distinzione di un ambito della "civiltà" da quello della "barbarie", della "normalita" dalla
"anormalità", del "buon gusto" dal "cattivo gusto" e così via. Tali distinzioni, che informano
profondamente la nostra esperienza quotidiana del mondo e della socialità e stanno alla base di
grandi apparati simbolici, non hanno ovviamente nulla di "naturale": si sono anzi costituite in stretta
relazione con la storia dell'Occidente e con le sue pratiche di dominio sugli altri. Hanno certamente
a che fare con secoli e forse millenni di discriminazione e persecuzione, con il colonialismo, lo
schiavismo, il razzismo. La loro diffusione ci dice molto sulla storia dell'Occidente (per inciso,
questa stessa categoria è ovviamente etnocentrica); ma la stessa profondità del loro radicamento le
rende inadatte a distinguere nell'attualità gli atteggiamenti razzisti da quelli non razzisti.
Prendiamo un esempio. L'opposizione bianco-nero è per noi densa di connotazioni estetiche,
morali ed emotive strettamente collegate ai temi della diversità etnica e potenzialmente razziste. Al
bianco si associano la purezza, l'innocenza, il bene, al nero il male, il peccato, la sporcizia e
l'impurità, la paura. Si minacciano i bambini con storie sull' "uomo nero"; si rappresenta il diavolo
come un essere nero o scuro, e così via. E' ovvio che tali connotazioni sono prodotti di popoli di
pelle chiara che storicamente hanno sottomesso e sfruttato popoli di pelle scura; ed è altrettanto
evidente che questo ampio sistema di rimandi simbolici si proietta oggi sui nostri rapporti con gli
immigrati di colore. E' importante analizzare quanto a fondo agiscano questi meccanismi nel nostro
linguaggio e nel nostro senso comune, che in virtù di questa consapevolezza possono mutare con
relativa rapidità e farsi, per così dire, politicamente più corretti. Ma l'ampia diffusione di simili
connotazioni simboliche non può da sola rappresentare un indicatore di razzismo ideologico nel
senso di Taguieff, cioè di meccanismi di riduzione essenzialista degli altri, di stigmatizzazione e di
barbarizzazione; tanto meno, può rappresentare un indicatore di razzismo pratico, vale a dire di
dominanti tendenze all'esclusione, alla segregazione, alla persecuzione violenta.
In altre parole, le analisi del discorso razzista sembrano usare talvolta reti a maglie troppo strette,
che catturano ogni tipo di pesce, e non sono in grado di discriminare il "vero nemico" da quegli
atteggiamenti che, ispirati da un reale rispetto verso gli altri e da sentimenti autenticamente
egalitari, non riescono tuttavia ad affrancarsi da quella rete di pregiudizi etnocentrici che pervade in
profondità il nostro linguaggio e il nostro immaginario.
7. Abbandonare l’identità culturale?
Per concludere, vorrei tornare all'antropologia culturale. Principale sostenitrice, per gran parte del
Novecento, dell'approccio differenzialista e relativista contrapposto al razzismo biologico e
gerarchizzante, l'antropologia sta oggi attraversando un periodo di profonda revisione concettuale e
teoretica. La sua idea di un mondo suddiviso in un numero finito, per quanto ampio, di unità etnicoculturali discrete, distintive, simmetriche e per certi aspetti eticamente incommensurabili (nel senso
di irriducibili a criteri di giudizio sovra-culturali), non sembra più un buon modello per pensare la
diversità. Proprio mentre le categorie di "etnia" e "cultura" entravano a far parte del senso comune,
l'antropologia ne sviluppava una profonda critica - in parte come reazione al loro uso strumentale in
funzione neorazzista, in parte per la loro inadeguatezza di fronte ai fenomeni della globalizzazione e
del meticciato culturale che caratterizzano la fine del ventesimo secolo. Negli ultimi vent'anni, gli
studi antropologici si sono prevalentemente preoccupati di contrapporsi alle concezioni essenzialiste
e naturalistiche di etnie e culture. Non esistono essenze etniche e culturali pure e oggettive,
rintracciabili per così dire in natura. Se l'antropologia ha accreditato a lungo questo punto di vista,
per una propria distorsione epistemologica, si tratta oggi di recuperare il terreno perduto e di
decostruire tali concetti; si tratta cioè di mostrare come le identità etniche e culturali risultino
sempre da processi storicamente contingenti, siano il frutto di pratiche sociali consapevolmente
guidate da agenti particolari in riferimento a particolari interessi.
Gli esempi sopra considerati - conflitti etnici, leghismo, razzismo differenzialista - non
rappresenterebbero usi anomali, degenerati o meramente strumentali del vocabolario dell'etnicità. Si
tratterebbe anzi di casi tipici e rivelatori. Alcuni agenti sociali vogliono far credere alla presenza di
differenze etniche astoriche e irriducibili, che determinerebbero inevitabilmente strategie e conflitti
politici. L'antropologia, con il suo linguaggio culturalista, è a lungo caduta in questo tranello,
accreditando ingenuamente le pretese etniche. Si tratta oggi di cambiare rotta, riconoscendo un
ordine delle cose esattamente inverso: interessi e conflitti in senso lato politici determinano
l'accentuazione e persino la creazione di strategie di differenziazione etnica. Per riprendere
un'affermazione di Ugo Fabietti, non di etnie o identità etniche è corretto parlare, bensì di "processi
di etnicizzazione voluti o favoriti dall'esterno oppure dagli stessi gruppi che competono, in
determinate circostanze sempre circoscrivibili sul piano storico, per l'accesso a determinate risorse
materiali e simboliche" 32 . In altre parole: non esistono identità etniche pure e autentiche, e il
linguaggio dell'etnicità rappresenta sempre una vernice ideologica che copre più profonde e
strutturali dinamiche di tipo economico e politico.
Ma di fronte a questa critica o auto-critica, ormai ampiamente diffusa nel discorso antropologico,
si aprono due possibili e molto diversi atteggiamenti. Da un lato, la critica sembra sfociare nella
completa dissoluzione del linguaggio dell'etnia e della particolarità culturale nel linguaggio
dell'ecomomia politica, considerato come l'unico reale. Le rivendicazioni etniche e identitarie non
sarebbero altro che strategie consapevolmente e strumentalmente adottate all'interno di scontri di
potere e di controllo delle risorse economiche. Per quanto gli attori sociali avvertano come reale la
propria o l'altrui etnicità, ne siano cioè investiti cognitivamente ed emotivamente, essa mantiene
nondimeno carattere di "falsa coscienza" - non fa parte delle condizioni strutturali che determinano i
conflitti e i comportamenti sociali, delle condizioni che in definitiva muovono la storia.
Dall'altro lato, tuttavia, la critica alla naturalizzazione dell'identità etnica non contrasta
necessariamente con la valorizzazione delle peculiarità culturali locali, e con la convinzione della
loro irriducibilità rispetto al lessico politico-economico. Alcuni antropologi - come Clifford Geertz,
per citare il nome più noto - pensano che sia vero esattamente il contrario: e cioè che per
comprendere le complesse vicende del mondo attuale, con i processi di globalizzazione economica
e culturale da un lato, e dall'altro l'esplosione di vecchi e nuovi particolarismi locali di tipo etnico,
politico e religioso, occorra integrare le classiche categorie della politica con quelle dell'analisi
culturale. In questa prospettiva le differenze culturali, per quanto disperse caleidoscopicamente e
32
U. Fabietti, L’identità etnica, cit., p.19
non riducibili a identità compatte, stabili ed esclusive, mantengono una loro concretezza
antropologica. L'esser nati in un certo luogo, parlare una lingua, credere in una religione e così via
non sono residui di particolarismo che vengono a turbare la razionalità della sfera politica: sono
invece elementi antropologicamente costitutivi di cui la teoria politica deve imparare ad occuparsi.
Scrive dunque Geertz che abbiamo bosogno di una nuova politica:
una politica che nell’autoaffermazione etnica, religiosa, di razza, linguistica o regionale
non veda una mancanza di ragionevolezza arcaica o innata, da reprimere e da superare,
una politica che non tratti questi generi di espressione collettiva come una spregevole
follia o un abisso buio, ma sappia invece affrontarli come affronta la disuguaglianza,
l’abuso di potere e altri problemi sociali. 33
Dunque, si configura una fondamentale contrapposizione tra chi ritiene che l'analisi politica debba
affinarsi sviluppando una sensibilità antropologica per le differenze e le identità culturali, e chi, al
contrario, pensa che l'antropologia stessa debba esser depurata dal linguaggio vago ed equivoco
dell'identità, per volgersi alle più concrete e reali dinamiche di potere che regolano i rapporti tra
gruppi umani. Questa contrapposizione, che mi sembra dominare l'attuale dibattito antropologico,
poggia su modi radicalmente diversi di intendere il soggetto della cultura e della storia, vale a dire
l'agente umano. Da un lato si presuppone un agente umano astratto, universale, tendenzialmente
cosmopolita, mosso da una razionalità in senso lato economica, rispetto alla quale ogni
rivendicazione locale di identità appare come residuo di irrazionalità oscurantista e strumentale.
Dall'altro, si sottolinea l'irriducibile pluralità delle culture e delle appartenenze etniche come
costitutiva della soggettività umana: si pensa a una comunità che, come scriveva Lévi-Strauss, si
realizza non in astratto ma all'interno e per la mediazione di culture particolari. 34
Trovo, per concludere, che tutto questo ci riporti a ridosso del problema di una nuova fondazione
teorica dell'antirazzismo. Quest'ultimo è oggi dibattuto tra un quadro di riferimento universalista e
uno relativista - o perlomeno, come si è espresso Geertz, "anti-anti-relativista". 35 I sostenitori della
prima ipotesi reagiscono al razzismo differenzialista assumendo un modello forte di comune
umanità come riferimento; il dialogo, la tolleranza e il rispetto tra gruppi, etnie, culture diverse
possono fondarsi solo sul comune riconoscimento di principi etici universali, come i fondamentali
diritti umani. Questa prospettiva assume la sostanziale uniformità morale di tutti gli esseri umani, e
interpreta i particolarismi come ostacoli storicamente contingenti che soggetti interessati
frappongono al progetto di una integrale eguaglianza. Così ogni autocompiacimento particolaristico,
ogni valorizzazione delle differenze e ogni "politica del riconoscimento" 36 , non importa con quanta
buona fede siano sostenute, finiscono per apparire politicamente regressive o oggettivamente filorazziste: un principio, questo, che porta talvolta alla condanna dell'intera disciplina dell'antropologia
culturale e, ancora più a monte, delle principali tradizioni di pensiero scettico e anti-universalista 37 .
Il problema, con questo approccio, è chi e come stabilisce i principi universali che fondano la
comune umanità. Come mettere d'accordo gli universalismi concorrenti di culture diverse? Come
formulare principi universali in modo non-etnocentrico, oppure convincere gli altri che il nostro
etnocentrismo è migliore del loro? Può sembrare si tratti di astrusità filosofiche, ma non è così.
Basta considerare qualche esempio di rapporti pratici e di convivenza fra culture - cristiane e
islamiche, poniamo - per convincersene. In linea di principio, il riconoscimento della diversità pone
limiti ai principi universali (i quali, per definizione, non possono accettare eccezioni);
33
C. Geertz, Mondo globale, mondi locali, cit., p. 52
C. Lévi-Strauss, Razza e storia, cit., p. 107
35
C. Geertz, “Anti-anti-relativismo”, trad it in Il mondo 3, 1 (2), 1994, pp. 72-86
36
Per un approfondimento della nozione di politica del riconoscimento si veda J. Habermas – C. Taylor,
Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento , trad. it. Milano, Feltrinelli, 1998
37
Una posizione tanto radicale quanto densa di ambiguità in questo senso mi appare quella di V. Stolcke,
“Talking culture. New boundaries, new rethorics of exclusion in Europe”, cit.
34
l'universalismo intransigente, d'altra parte, pone limiti inevitabili alla tolleranza per i
particolarismi 38 . Dovremmo allora chiederci se sia possibile costruire un antirazzismo in grado di
salvare al contempo l'istanza universalistica e la politica del riconoscimento; in grado di non
rinunciare all'impegno per la universalizzazione di fatto di certi diritti, e neppure all'ideale di una
comune umanità integralmente realizzata, senza per questo ignorare il fatto che non esistono
"cittadini del mondo", e che le persone vivono all'interno di condizioni locali caratterizzate talvolta
da grumi irriducibili di differenze culturali.
38
Si veda su questi punti A. Santiemma (a cura di), Diritti umani. Riflessione e prospettiva antropologica, Roma,
Editrice Universitaria La Goliardica, 1999.: in particolare, per una critica agli assunti universalisti, il saggio d P.
Clemente, “La muffa la sentono gli stranieri. Qualche nota perplessa sui «diritti umani» degli immigrati”, ivi, pp. 57-74.
LA COMPARAZIONE FRA LE CULTURE
(edito in P. Clemente, C. Grottanelli, a cura di, Comparativa/mente, Firenze, SEID, 2009, pp. 10544)
0 . [Introduzione]
L’antropologia è una forma di sapere intrinsecamente comparativo. Si basa sul principio che per
conoscere noi stessi (o più in generale, secondo la sua etimologia, gli “esseri umani”) non basta
guardarsi dentro, attraverso un metodo introspettivo di tipo cartesiano. Occorre invece volgere lo
sguardo fuori da noi e lontano da noi, verso persone e gruppi sociali diversi, e mettere a confronto la
loro razionalità, la loro morale, i loro rapporti politici e istituzionali con i nostri. Maggiore è la
diversità, maggiore potrà essere lo spettro della nostra comprensione. E’ il metodo che è stato
chiamato del “giro lungo” o della “via esterna” – in contrapposizione al “giro breve” e alla “via
interna” che caratterizzano invece, da Platone a Kant e oltre, l’approccio speculativo dominante
nella filosofia occidentale (Kluckhohn 1949, Remotti 1990).
Certo, in un’accezione così generale, il giro lungo e lo stile comparativo non sono affatto
invenzioni dell’antropologia: sono invece radicati in una tradizione di pensiero che risale perlomeno
ad Erodoto. L’antropologia cerca però di uscire dall’uso generico e impressionistico della
comparazione e di farne un metodo scientifico. Insieme al concetto di cultura, il metodo
comparativo è infatti il cruciale punto di partenza dell’antropologia al momento del suo costituirsi
in disciplina scientifica, nella seconda metà dell’Ottocento; e, in tutta la sua storia, resterà uno dei
principali temi di discussione e, spesso, di scontro metodologico. Quali sono le condizioni e i limiti
(spaziali, storici, socio-culturali) della comparazione? Che cosa si può comparare – vale a dire,
quali sono le appropriate “unità” del processo comparativo? Ai risultati della comparazione si può
attribuire il valore di generalizzazioni, di spiegazioni e persino di leggi scientifiche? Attorno a
questi problemi le diverse scuole antropologiche si sono profondamente divise, teorizzando e
soprattutto praticando versioni molto diverse del metodo comparativo. Nella prima parte di questo
capitolo ripercorreremo alcuni momenti cruciali del dibattito sulla comparazione nella storia degli
studi antropologici. Nella seconda parte, faremo invece il punto sullo stato attuale della discussione
e sugli usi della comparazione nella produzione etnografica ed antropologica contemporanea.
PARTE PRIMA
1.1 [Le basi del metodo comparativo]
Come detto, il metodo comparativo rappresenta lo strumento principe della prima grande scuola
antropologica, quella tardo ottocentesca di ispirazione evoluzionista. E’ attraverso la comparazione
che gli antropologi dell’epoca pensano di poter trasformare la loro disciplina in una vera e propria
scienza, in grado di andar oltre la pura descrizione dei fenomeni culturali e di scoprire le leggi che
ne regolano il funzionamento e lo sviluppo. In cosa consiste dunque il metodo comparativo? Prima
del suo uso antropologico, esso era stato sviluppato tra XVIII e XIX secolo almeno in due grandi
ambiti disciplinari: da un lato le scienze naturali, dall’altro gli studi di linguistica storica e di storia
delle religioni. Partiamo dalle prime. Scienze come la biologia, la geologia e la paleontologia si
erano completamente rifondate tra Settecento e Ottocento sulla base di un progetto di ricostruzione
della “storia naturale” del pianeta e delle specie viventi, individuandone l’origine e ripercorrendo i
processi di sviluppo evolutivo che avevano condotto alle forme attuali. Per un progetto del genere,
il grande problema era ovviamente la mancanza o almeno la scarsità di documentazione riguardante
il passato. Come si esprimeva il geologo Charles Lyell, la storia del mondo viene registrata in modo
imperfetto . Tema, questo, ripreso da Charles Darwin come fondamento epistemologico della teoria
evoluzionista. “For my part, following Lyell’s metaphor, I look at the natural geological record, as
history of the world imperfectly kept, and written in a changing dialect; of that history we possess
the last volume alone, relating only to two or three countries. Of this volume, only here and there a
short chapter has been preserved; and of each page, only here and there a few lines” (Darwin 1861;
v. Fabiam 1983, pp. 11-14).
Dunque, in un lungo e continuativo processo di sviluppo, noi troviamo tracce solo di pochi
momenti, dispersi nel tempo e nello spazio, che danno l’impressione di discontinuità e impediscono
di “leggere il testo”. Come riempire i vuoti? Come in un gigantesco crittogramma, possiamo partire
dall’analisi dei dati più completi per ricavare un codice, da applicare poi alle parti meno
documentate (i precedenti volumi, secondo la metafora darwiniana). Si possono così rendere
intelligibili dati in sé dispersi e frammentati. Ciò implica però dei presupposti fondamentali: in
primo luogo, il presupposto cosiddetto “uniformista”, secondo il quale il corso dell'evoluzione
segue alcune grandi leggi che restano invariate nel tempo, e si attua in modo graduale e
continuativo. Inoltre, il principio per cui l'evoluzione non si articola in catene di singoli e irripetibili
eventi, ma in fasi o stadi che sono dappertutto gli stessi. E’ questo il fondamento del metodo
comparativo: dati provenienti da ogni punto del tempo e dello spazio possono essere accostati e
gettar luce gli uni sugli altri, completarsi a vicenda, in quanto parte di un unico grande disegno.
E’ importante tener conto di due aspetti di questo uso della comparazione, che influenzeranno
enormemente l’antropologia. Il primo è la struttura tabulare del tempo evolutivo. Il tempo non è il
capriccioso incedere di una storia sempre incerta e irripetibile, ma l’uniforme svolgimento di una
successione logicamente fondata di fasi. Solo che fra il trascorrere cronologico del tempo e lo
sviluppo logico-evolutivo non vi è perfetta coincidenza, e può accadere che nello stesso momento
storico convivano fasi diverse dell’evoluzione. Questo è un punto cruciale nella biologia
darwiniana, che può inferire i più antichi capitoli della storia naturale a partire dall’osservazione di
specie attuali che appaiono però evolutivamente arretrate, o anche soltanto di tratti morfologici
degli organismi viventi che sembrano non avere alcuna funzionalità attuale e giustificarsi soltanto in
relazione a fasi evolutive precedenti. Un ruolo analogo giocherà, nell’antropologia ottocentesca, lo
studio dei “primitivi attuali”, considerati come testimonianze viventi di più antichi stadi
dell’evoluzione culturale, nonché lo studio delle sopravvivenze (survivals), cioè tratti presenti nelle
culture attuali ma spiegabili solamente in riferimento al passato (l’uso di coprirsi la bocca quando
sbadigliamo è un esempio semplice ed efficace del concetto ottocentesco di sopravvivenza. Non c’è
nessuna spiegazione apparente per questa norma di comportamento nella cultura moderna: essa si
spiegherebbe invece in riferimento all’antica credenza magico-religiosa e al connesso timore che
l’anima possa uscire dal corpo attraverso gli orifizi. Scomparsa la credenza con il progredire
dell’evoluzione culturale, è tuttavia rimasto l’uso protettivo privato del suo valore funzionale, come
un vero e proprio fossile).
Dunque, il presente è costellato di segni del passato, che si nascondono sotto la più immediata
superficie delle cose, oppure nelle lontananze geografiche (come le Galapagos per Darwin o, per gli
antropologi, gli aborigeni australiani, considerati all’epoca le popolazioni più primitive – dunque
evolutivamente più distanti - al mondo). Al tempo tabulare corrisponde, come ha osservato J.
Fabian, una tendenza a comprendere certe differenze naturali o culturali nel mondo attuale in
termini di relazioni temporali (prima/dopo, arretratezza/progresso): cosicché “dispersal in space
reflects directly, which is not to say simply or in obvious ways, sequence in Time” (Fabian 1983, p.
12). E’ questa corrispondenza delle relazioni spaziali e temporali che consente l’ottica comparativa
di larghissimo (praticamente infinito) respiro che l’evoluzionismo impiega. Un secondo importante
aspetto di un metodo comparativo così inteso è la sua aspirazione a scoprire relazioni causali fra i
fenomeni. L’accostamento di fatti provenienti da luoghi e tempi diversi produce generalizzazioni, e
da queste si può risalire per via induttiva a rapporti causali e infine alle grandi leggi che guidano lo
sviluppo evolutivo. La comparazione fonda così un sapere di carattere nomotetico, che parte da fatti
particolari per giungere alla scoperta di leggi universali. In realtà, nel campo dei fenomeni culturali
lo stabilire relazioni causali è molto più complesso che nel campo naturalistico, per la maggiore
difficoltà di tenere sotto controllo le variabili. Tuttavia, il comparativismo antropologico sarà
fortemente permeato da istanze causaliste: e, come vedremo, le critiche che esso riceverà sono
prevalentemente critiche al suo linguaggio causale e deterministico. Anche nei grandi dibattiti
novecenteschi, la comparazione sarà sistematicamente associata a un’idea di scienza nomotetica; al
contrario le metodologie idiografiche (che pensano cioè l’antropologia come un sapere su contesti
localmente e storicamente situati, non generalizzabili e non riconducibili a leggi universali)
tenderanno a scartare la comparazione. Un equivoco, questo, dagli effetti disastrosi: come vedremo
oltre, metodo comparativo e approccio causalista non sono necessariamente coestensivi.
Come detto, oltre alle scienze naturali, il metodo comparativo viene sviluppato tra Settecento e
Ottocento anche nell’ambito degli studi linguistici, filologici e storico-religiosi. Anche in questo
caso, la comparazione è lo strumento che dovrebbe permettere di ovviare alle lacune nella
documentazione del passato. In particolare, il boom della linguistica comparativa è legato
all’affermarsi dell’ipotesi indoeuropea: all’idea cioè di una lingua originaria da cui sarebbero
storicamente scaturiti il greco e il latino, il celtico, il gotico e il sanscrito. Mancando qualsiasi
documentazione di una simile lingua, essa può esser ricostruita per illazione solo attraverso la
sistematica comparazione delle lingue esistenti o comunque documentate, in cerca di somiglianze
che non potrebbero esser spiegate se non da una comune derivazione. Suggerita per la prima volta
nel 1786 da W. Jones, l’ipotesi indoeuropea si afferma largamente nell’Ottocento; e l’operazione
svolta per la linguistica viene replicata per altri campi della cultura. Soprattutto gli studiosi che si
occupano di mitologia e di materiali storico-religiosi, come Max Müller, rappresenteranno una
importante cerniera tra filologia storico-comparativa e antropologia.
La matrice filologica del metodo comparativo è contigua a quella naturalistica, ma se ne
differenzia per alcuni aspetti. In entrambi i casi la comparazione è volta a scoprire un’origine
lontana e nascosta dei fenomeni. Tuttavia, nelle scienze naturali la ricerca dell’origine sta alla base
della formulazione di relazioni causali e di leggi universali di sviluppo, mentre negli studi filologici
l’obiettivo è l’interpretazione di testi, il chiarimento del significato di forme di espressione
simbolica. In questo secondo caso, gli accostamenti comparativi sono posti al servizio di
un’ermeneutica testuale più che di una logica della scoperta o della dimostrazione di una teoria
scientifica. Si tratta di finalità dalle implicazioni epistemologiche molto diverse (anche se nel
contesto positivistico del tardo Ottocento l’istanza interpretativa si maschera sotto un linguaggio
scientista). L’antropologia le eredita entrambe, il che sta alla base di una tensione interna alla
disciplina che ancora oggi è lontano dall’essere sciolta.
1.2. [Il metodo comparativo in antropologia]
L’antropologia culturale adotta dunque il metodo comparativo da un ampio spettro di discipline,
sia scientifiche sia umanistiche, e ne esplora le possibilità fino ai limiti estremi. Lo applica infatti a
ogni tipo di fenomeno culturale, non accontentandosi di raffronti mirati e circoscritti, e spingendo
invece il livello di generalizzazione al di là di ogni confine spaziale e temporale. La comparazione
che interessa agli antropologi ottocenteschi è di scala universale. Al principio uniformista essi
aggiungono quello dell’unità intellettuale del genere umano (contro i pregiudizi razzisti che
caratterizzano invece buona parte della cultura dell’epoca). Ma se gli esseri umani sono dotati della
stessa attrezzatura cognitiva, in ogni tempo e in ogni luogo, e se l’evoluzione segue sempre la stessa
linea di sviluppo, come si spiegano allora le differenze culturali? Come si spiega, ad esempio, lo
spettacolare scarto tra le più avanzate culture occidentali e quelle dei popoli cosiddetti “primitivi”?
La risposta è semplice: si tratta di differenti velocità evolutive. I “primitivi di oggi” si collocano in
una fase più arretrata dell’evoluzione culturale: vivono nello stesso tempo storico della civiltà
vittoriana, ma in un diverso tempo evolutivo. E proprio questo ne assicura la comparabilità. Anzi, in
virtù di questa concezione tabulare del tempo, i primitivi di oggi corrispondono all’umanità arcaica,
e ci forniscono quelle informazioni sul passato che i documenti storici e archeologici non possono
mettere a disposizione.
Per questi motivi, la comparazione evoluzionista non ha bisogno di esercitarsi all’interno di
contesti omogenei e ben definiti: al contrario, accostare tratti culturali provenienti dai più distanti ed
eterogenei contesti garantisce risultati più significativi e di più ampio profilo teorico.
L’evoluzionismo si distingue in ciò dagli studi di orientamento diffusionista. Anche questi ultimi
usano la comparazione al fine di scoprire le origini di un certo fatto culturale; seguono tuttavia la
tesi della monogenesi, secondo cui fatti culturali simili hanno sempre una ed una sola origine, dalla
quale discendono attraverso processi di trasmissione nel tempo e nello spazio. La comparazione ha
qui lo scopo di delineare processi storici di diffusione, nel tentativo di risalire fino all’ipotetico
punto originario. La somiglianza morfologica tra due fatti culturali segnala la possibilità di una
relazione storica, che dev’essere dimostrata ricostruendo una catena di trasmissione con il maggior
numero possibile di anelli intermedi. L’evoluzionismo, al contrario, crede nella possibilità della
poligenesi, cioè della nascita indipendente di fatti culturali simili, semplicemente in virtù del
principio di uniformità. La comparazione non ha allora nessun bisogno di attenersi a criteri di
contiguità spazio-temporale. Se si scoprono analogie, senza che vi sia la possibilità di contatto e
trasmissione culturale, allora ci saremo avvicinati a qualcosa di molto profondo e molto universale.
Prendiamo l’esempio delle credenze religiose, uno dei temi che più affascina e preoccupa
l’antropologia ottocentesca. Come nasce la religione? Il problema è posto in tutta la sua ampiezza
già nel primo grande libro che nel 1871 segna la nascita dell’antropologia culturale, Primitive
Culture di E.B. Tylor. Per rispondere, Tylor procede più o meno così: prende un gran numero di
credenze religiose dai più svariati contesti storico-sociali (dalle culture “primitive” alle civiltà
antiche e classiche alla contemporaneità) e si chiede se c’è qualche elemento che tutte queste
diverse credenze hanno in comune, una sorta di massimo comun denominatore dell’atteggiamento
religioso. Crede di riconoscere questo elemento comune nell’idea di anima, e ne conclude che l’
“animismo” è lo stadio originario, da cui tutte le altre forme di religione si sono evolute. Su questa
base, può disporre l’universo delle credenze religiose in un ordine morfologico, da quelle più
“semplici” a quelle più complesse: e poiché l’evoluzione procede dal semplice al complesso,
l’ordine logico o morfologico deve corrispondere a quello cronologico o storico. Gran parte del
libro di Tylor è così dedicato alla ricostruzione congetturale dei processi di sviluppo che portano da
uno spoglio e primitivo animismo, attraverso una complicata serie di stadi intermedi, fino alle più
“evolute” forme di monoteismo delle culture occidentali.
Dello stesso tipo è il lavoro che altri studiosi dell’epoca compiono a proposito del matrimonio
(J.F. McLennan), delle forme della parentela e della famiglia (L.H. Morgan), delle forme giuridiche
(H.S. Maine) e così via. Ma il vero e proprio tour de force di questo comparativismo universalista è
probabilmente The Golden Bough di James G. Frazer, un’opera uscita in diverse e sempre
accresciute edizioni tra il 1890 e il 1913, fino ad assumere dimensioni enciclopediche (ma nota oggi
soprattutto nella edizione abbreviata del 1922). Qui il punto di partenza non è (almeno in
apparenza) un problema teorico, ma l’interpretazione di una enigmatica usanza documentata da
autori classici nella Roma tardo-imperiale: la carica di “re del bosco”, sacerdote di un tempio di
Diana, poteva essere ottenuta sfidando a duello e uccidendo il precedente sacerdote. Per
comprendere il senso di questa pratica rituale, e di una serie di suoi elementi che sarebbe qui troppo
lungo dettagliare, Frazer intraprende un percorso comparativo di incredibile ampiezza, allinenando
centinaia e centinaia di “usanze” o “credenze” simili documentate nelle civiltà antiche, nelle culture
primitive, nel folklore europeo dell’età moderna e contemporanea. Ne risulta l’affresco di una
concezione magica del mondo, al cui centro sta il complesso mitico-rituale dell’uccisione e
resurrezione di un dio (o di un re divino) che rappresenta la forza vitale e la fecondità della natura,
la cui riproduzione ciclica deve essere aiutata magicamente. Le tesi frazeriane sulle origini magiche
della cultura umana hanno lo stesso livello di generalità speculativa di quelle di Tylor. Ma il suo
modo di procedere è in parte diverso. Le sue comparazioni sono vere e proprie pratiche
interpretative. Accostando casi simili tratti dai contesti più diversi, egli crea configurazioni di senso
che mostrano i fenomeni in una luce nuova. Ad esempio, nell’analizzare le feste del fuoco
largamente diffuse nella cultura popolare europea, le pone accanto alle pratiche sacrificali del
mondo antico, ai riti primitivi di fertilità, al tema del capro espiatorio e così via, costruendo grandi
catene di somiglianze e differenze che ridefiniscono il significato dell’oggetto iniziale, portandoci a
vederlo in una nuova luce. Questi accostamenti comparativi, occorre insistere, avvengono su base
analogica e non storico-filologica. Il loro scopo non è documentare processi reali di circolazione
culturale, ma scoprire le profonde configurazioni di senso che si celano sotto la superficie di
pratiche e oggetti culturali apparentemente banali e insignificanti. Attraverso il metodo
comparativo, noi possiamo giungere a vedere l’ombra del sacrificio umano dietro le gioiose feste
del fuoco, i temi della morte e della resurrezione dietro i più innocenti costumi natalizi o
carnevaleschi, e così via. E’ questo aspetto della comparazione antropologica che, come vedremo,
affascinerà la psicoanalisi e le avanguardie artistiche e letterarie del Novecento, che lo porranno al
centro stesso della loro poetica (Dei 2001).
1.3 [La comparazione modellizzante di Marcel Mauss]
Troviamo un uso della comparazione di scala universale in un’altra grande scuola: quella francese
comunemente definita come “sociologica”, che ha in Emile Durkheim il leader e in Marcel Mauss il
principale esponente sul terreno antropologico. Soprattutto Mauss, in molti dei suoi saggi più
famosi, utilizza e raffronta materiali tratti dai resoconti di etnologi, dalle culture classiche e da
molte culture antiche, sia europee che orientali, con un’ampiezza che sembra avvicinarlo al metodo
degli evoluzionisti. A differenza di questi ultimi, tuttavia, la straordinaria erudizione e la vastità dei
riferimenti non è messa al servizio della ricerca delle origini, né della dimostrazione di grandi leggi
di sviluppo. Il metodo di Tylor o Frazer consisteva nell’allineare il maggior numero possibile di
esempi (o “prove”) a sostegno di semplici tesi o passaggi argomentativi. Ad esempio, si vuole
mostrare come a un certo stadio dello sviluppo culturale sia diffusa la credenza nell’anima come
animale che risiede nel corpo e che in certe situazioni critiche potrebbe sfuggire attraverso gli
orifizi. Si enuncia la tesi e si procede quindi a “dimostrarla” allinenando decine o centinaia di
esempi presi da ogni parte del mondo, da ogni epoca e da ogni tipo di fonti o testimonianza. Ciò
che conta è il numero degli esempi: il che spiega il format tipico dei libri degli evoluzionisti, che è
quello del trattato di dimensioni tendenzialmente enciclopediche. Mauss scrive invece saggi
relativamente brevi, nei quali gli accostamenti comparativi non rispondono mai a una logica
puramente cumulativa; essi sono volti piuttosto a rendere possibile l’analisi di una istituzione
culturale come sistema.
Possiamo comprendere meglio questo punto riferendoci a quello che è considerato il capolavoro
di Mauss, un testo del 1924 intitolato Essai sur le don. Qui viene analizzata una tipologia di
pratiche sociali o “prestazioni totali”, come l’autore le definisce, basate sul “dono” di oggetti di
prestigio e sull’obbligo di ricevere e ricambiare ciò che viene offerto. Mauss procede analizzando
esempi mirati di istituzioni di questo tipo, tratti da numerose aree culturali: parte con la Polinesia e
la Melanesia, soffermandosi in particolare sul fenomeno del kula ring descritto da Malinowski nelle
isole Trobriand; passa quindi alle culture indiane del nord-ovest americano, dedicando ampio spazio
all’istituzione del potlach descritta da Boas fra i Kwakiutl. Ancora, procede analizzando il tema del
dono (scambio in cui “si fondono persone e cose”) nel diritto romano antico, nel diritto indiano
classico, in quello germanico, in quello celtico e cinese, concludendo con osservazioni sul destino
del dono nelle società occidentali contemporanee. Dunque anche Mauss, come Tylor e Frazer, fa “il
giro del mondo”; e anch’egli vuol mostrare l’universalità del tema del dono nelle culture umane, e
anzi affermare una tesi generale sull’ “evoluzione sociale”, secondo cui le “prestazioni totali”
dominano le culture e il diritto arcaico, lasciano delle tracce nella civiltà romana e in molte culture
indoeuropee, e sono infine abbandonate nella modernità, con la netta distinzione tra diritti reali e
diritti personali e quella fra obbligazione e dono (Mauss 1924, pp.240-1). Ma, come detto, gli
accostamenti comparativi non sono affatto pensati come un accumulo di “prove”. La loro funzione
è quella di evidenziare tratti del fenomeno culturale del dono che non emergerebbero interamente da
un unico caso empirico. Ad esempio, il kula melanesiano fa risaltare il tema del prestigio sociale
connesso al temporaneo possesso di certi beni che non sono soggetti a baratto o commercio; il
potlach degli indiani nordamericani mostra il prestigio insito nello “spreco”, cioè nella distruzione
rituale e socialmente ostentata di beni di grande valore economico; la credenza maori nello hau (lo
spirito della cosa donata) mette in evidenza l’obbligo di contraccambiare i doni ricevuti e le
sanzioni che l’infrazione di questo obbligo può comportare. E così via. Nessun caso etnografico
metterebbe da solo in luce tutti gli elementi che invece contribuiscono a definire il dono come
sistema culturale: la combinazione comparativa consente invece di scorgere il sistema nella sua
completezza.
Si può obiettare che in questo modo il “dono” che Mauss descrive non è un fenomeno reale, ma
una pura costruzione teorica. In effetti è proprio così: Mauss procede astraendo dai casi etnografici
delle caratteristiche che vanno a costituire un modello. Nella prospettiva sociologica aperta da
Durkheim o da Max Weber, la costruzione di simili modelli (o idealtipi, come li definiva Weber) è
lo strumento principale delle scienze sociali e l’obiettivo delle procedure comparative.
Naturalmente i modelli non si sostituiscono alla realtà empirica, ma si proiettano nuovamente su di
essa consentendo (se il modello funziona) di vederne e comprendere caratteristiche che resterebbero
altrimenti nascoste o in secondo piano. Il successo della categoria maussiana di dono nelle scienze
sociali novecentesche dimostra se non altro la grande fecondità euristica del modello. Partendo da
esso, vale a dire da un concetto astratto elaborato su base comparativa, alcuni autori contemporanei
hanno potuto ad esempio mostrare la pervasività delle pratiche di dono nelle società occidentali di
oggi, penetrando al di sotto delle ideologie ufficiali che leggono tutte le relazioni economiche nei
termini del duplice sistema del mercato e dello stato (Godbout 1992).
1.4 [la critica al metodo comparativo nell’antropologia novecentesca]
Col Saggio sul dono ci siamo spinti fino agli anni ’20 del Novecento. Facciamo un passo indietro,
per constatare come, a parte Mauss, le maggiori scuole antropologiche all’inizio del XX secolo si
caratterizzano per una decisa reazione critica contro il metodo comparativo nella sua accezione
universalista. Mi riferisco in particolare alla scuola nordamericana del “particolarismo storico”, il
cui capostipite è Franz Boas, e agli studi britannici di orientamento funzionalista che fanno capo a
personaggi come Bronislaw Malinowski e Alfred R. Radcliffe-Brown. Sono da un lato le pratiche di
ricerca, dall’altro gli orientamenti teorici ad allontanare questi studi dalla comparazione di tipo
universalista. Per quanto riguarda la ricerca, la nuova antropologia si lega indissolubilmente alla
pratica della ricerca sul campo. Gli evoluzionisti ottocenteschi erano per lo più studiosi “da
tavolino”: essi differenziavano nettamente il loro ruolo di teorici e comparativisti da quello dei
ricercatori sul campo, i quali si riteneva non avessero bisogno di una particolare formazione
scientifica e dovessero limitarsi a osservare e descrivere le forme culturali in modo neutrale e
oggettivo. Nel Novecento le due figure si saldano invece strettamente insieme. Per comprendere
un’altra cultura non basta averne conoscenza dall’esterno, attraverso altrui testimonianze: occorre
invece viverla dall’interno, parlarne direttamente il linguaggio, comunicare con i suoi membri,
avere esperienza delle sue istituzioni. D’altra parte, questa conoscenza diretta richiede una rigorosa
formazione scientifica: per fare etnografia bisogna sapere dove e come guardare, ed essere in grado
di trasformare pure esperienze vissute in fonti e documenti. La ricerca sul campo, nella versione che
Malinowski chiamava “osservazione partecipante”, diviene il canone metodologico della nuova
antropologia. Si tratta di una ricerca che privilegia lo specialismo areale, e che produce una scrittura
di tipo monografico. I libri di antropologia abbandonano il format del trattato comparativo per
assumere quello della monografia etnografica: vale a dire la descrizione e l’analisi non più di un
tratto culturale specifico (p.es. la religione, o ancor più in dettaglio un certo tipo di credenza o
rituale) nelle più svariate culture, ma di un unico contesto socio-culturale considerato in tutti i suoi
aspetti, dall’economia, alle relazioni sociali, ai sistemi simbolici.
Contesto è anche la parola chiave sul piano degli orientamenti teorici. E’ vero che la scuola
americana e quella britannica muovono da assunti e metodologie assai diverse. La prima sviluppa
un approccio idiografico alle culture, sostenendo la necessità di studiarle nella loro unicità e
peculiarità storica; la seconda è interessata all’analisi sociologica dei sistemi culturali come entità
sincroniche in qualche modo sottratte al tempo storico. Entrambe rivolgono tuttavia un’analoga
critica al comparativismo universalista. Non accettano in primo luogo le finalità stesse della
comparazione di tipo ottocentesco, cioè la ricerca di ipotetiche origini e la formulazione di leggi
generali dello sviluppo culturale. Ma soprattutto, sostengono che non è possibile comparare tratti
culturali avulsi dal loro contesto di appartenenza. Infatti il significato di un tratto (un oggetto, una
istituzione, una pratica, una forma simbolica) non può esser stabilito se non in riferimento al più
complessivo sistema culturale di cui fa parte. La somiglianza morfologica, che per gli evoluzionisti
fondava le catene comparative, da sola non ha alcun valore: oggetti simili possono rivestire
significati completamente diversi in diversi contesti: solo un’etnografia specifica e mirata lo può
stabilire.
Boas marcava questo punto già in un famoso articolo del 1896, “The Limitations of the
Comparative Method of Anthropology”, facendo notare come ad esempio le maschere in alcune
culture servono come travestimento protettivo nei confronti degli spiriti; in altre sono indossate per
terrorizzare le persone o gli spiriti stessi; in altre ancora per commemorare i morti; e così via ( Boas
1896, p.132, cit. in Harris 1968, p. 348). La somiglianza degli oggetti non garantisce in sé la
possibilità della generalizzazione: cosicché comparare le maschere non è possibile senza comparare
le intere culture di riferimento. Allo stesso modo, Malinowski rifiuterà il concetto di sopravvivenza:
solo l’incomprensione del significato o della funzione di un oggetto o di una pratica (si pensi ancora
all’esempio dello sbadiglio) nel suo contesto attuale può farlo considerare come un inerte fossile. La
somiglianza con oggetti del passato nasconde in realtà profondi mutamenti di significato
(Malinowski 1944, p. 37 sgg.).
Queste posizioni si collocano nel quadro di una più complessiva reazione delle scienze sociali
all’evoluzionismo, agli eccessi speculativi e alle generalizzazioni prive di solide basi empiriche che
lo avevano caratterizzato. Si pone adesso l’accento sul rigore della documentazione etnografica,
contro le troppo grandi e troppo facili teorizzazioni. Il metodo comparativo, fino ad allora punto di
forza dell’antropologia culturale, diviene semmai fonte di imbarazzo, apparendo ai più la caricatura
di un approccio scientifico. E’ significativo il giudizio espresso da Ruth Benedict, una delle più
importanti allieve di Boas, sul Golden Bough di Frazer: “Opere come Il ramo d’oro e i normali
volumi di etnologia comparata sono esami analitici di elementi separati, e ignorano tutti gli aspetti
dell’integrazione culturale […] Il risultato finale dell’esposizione è una specie di mostro di
Frankenstein con un occhio destro preso dalle isole Figi, un occhio sinistro dall’Europa, una gamba
dalla Terra del fuoco e una da Tahiti, e dita delle mani e dei piedi da regioni ancor più diverse”
(Benedict 1934, pp. 54-5). In definitiva, la basilare fallacia del metodo comparativo sta nel
comparare “fatti” che secondo i moderni standard etnografici sono assolutamente privi di valore
documentario. Non è tuttavia la comparazione in sé ad esser rifiutata a priori. Del resto, il giudizio
appena citato si trova in un libro, Patterns of Culture, che segna il deciso ritorno della stessa
tradizione particolarista boasiana a un’antropologia dalle grandi ambizioni comparative. Di che tipo
di comparazione si tratta, dunque?
1.5 [La comparazione di insiemi culturali]
Se “contesto” è la parola chiave della nuova antropologia, la comparazione non potrà fare a meno di
assumere i “contesti” come unità d’analisi. Mentre non ha senso raffrontare singoli tratti avulsi dal
sistema culturale di cui fanno parte, è invece utile e produttivo analizzare comparativamente e in
modo mirato due o al massimo tre-quattro tali sistemi, laddove naturalmente si disponga di una
documentazione etnografica adeguata. In particolare, una simile comparazione su base olistica
consente di utilizzare il metodo delle variazioni concomitanti, codificato nell’Ottocento da Stuart
Mill e applicato da Durkheim e Weber agli studi sociali. Tra gli anni ’20 e gli anni ’50, tali metodi
sono largamente impiegati, in modo più o meno formalizzato, in molti ambiti dell’antropologia. Gli
esempi più noti vengono probabilmente dagli studi cosiddetti di “cultura e personalità”, che
lavorano sul rapporto fra tratti culturali e caratteristiche psicologiche. Vediamone qualche aspetto.
Occorre intanto considerare che nei primi decenni del secolo l’antropologia si batte per affermare
i temi del relativismo e del determinismo culturale in un clima che è invece fortemente permeato da
idee razziste e dalla tendenza ad attribuire a cause “naturali” (biologiche o psicologiche) i
comportamenti umani. Ora, un simile programma relativista trova nella comparazione un
formidabile strumento. Mostrare con esempi tratti da altre culture che certi tratti comportamentali
(ad esempio l’espressione dei sentimenti, il ricorso alla violenza, le differenze di ruolo legate al
genere e all’età, e così via) non sono universali ma variano storicamente e culturalmente, è già di
per sé una confutazione del determinismo biologico o psicologico; lo è ancora di più la
dimostrazione che tali variazioni si collegano a ben precise differenze nei sistemi socio-culturali.
Qui la comparazione può assumere due forme. Può trattarsi di un semplice raffronto che
l’antropologo istituisce tra la cultura da lui/lei studiata e la propria (ovvero quella dei suoi lettori),
oppure di un accostamento formalizzato fra più unità culturali. Un esempio celebre ed efficace del
primo tipo è quello di Malinowski che, partendo da osservazioni sulla vita familiare dei
trobriandesi, giunge a mettere in discussione la teoria freudiana del complesso edipico. Com’è noto,
per Freud il rapporto ambiguo con il padre, caratterizzato da amore e timore, emulazione e rivalità,
sta alla base della costituzione psicologica degli individui (almeno dei maschi), e rappresenta la
base delle nevrosi da un lato, dall’altro di formazioni culturali come la religione. Malinowski nega
l’universalità di questa teoria, considerandola valida solo in relazione al contesto storico-sociale in
cui Freud lavorava (la Vienna, o se si preferisce l’Europa, di fine Ottocento). Alle Trobriand,
caratterizzate da un sistema di discendenza matrilineare, semplicemente non esistono le condizioni
socioculturali per il manifestarsi del complesso edipico. L’ambivalente figura freudiana del padre si
scinde qui in due distinte figure: da un lato il genitore naturale, del cui gruppo di parentela il figlio
non fa parte, e che ha con lui un rapporto di affetto non autoritario e non repressivo, dall’altro lo zio
materno, al cui gruppo il bambino appartiene e che esercita su di lui l’autorità, l’imposizione delle
regole e il controllo sociale (Malinowski 1927). La comparazione mostra dunque come Freud abbia
sì colto in modo geniale un aspetto della propria cultura, non rendendosi però conto di quanto esso
fosse radicato in una specifica configurazione socio-culturale (la famiglia moderna e la discendenza
patrilineare).
Rivolto contro l’universalismo psicologico è anche Coming of Age in Samoa di Margaret Mead
(1928), uno dei più famosi libri di antropologia del periodo prebellico. Si tratta di una monografia
etnografica sulle isole Samoa, in cui l’intento comparativo è fin dall’inizio trasparente. Anch’essa
allieva di Boas, la Mead parte per le Samoa con l’intento di dimostrare una tesi ben precisa: il
carattere socialmente e culturalmente determinato delle crisi adolescenziali, vale a dire delle
difficoltà di integrazione e dei comportamenti spesso violenti e devianti che caratterizzavano
l’adolescenza americana dell’epoca, e che gli psicologi interpretavano in relazione a problemi
psicofisici di portata universale. Tutto il libro tende a porre in netto contrasto l’esperienza
esistenziale samoana (e in specie del gruppo di giovani ragazze con cui la Mead lavora) con quella
statunitense. La prima è dominata da un’etica della tranquillità, dall’assenza di comportamenti
autoritari e repressivi nei confronti dei giovani, e soprattutto da ruoli sociali fortemente determinati
fin dalla nascita, che non creano ansie e rivalità riguardo al conseguimento di status; la seconda, al
contrario, è dominata da un’ossessione per il raggiungimento di status sociali più elevati, e pone i
giovani in costanti situazioni di competizione e conflitto, di stress, di scelte difficili da compiere. Ne
consegue l’insorgere di ansie, disturbi psicologici, reazioni violente e abnormi nella società
americana; tutti elementi che, secondo la Mead, sono assenti nella società samoana. Per inciso, gli
stessi dati etnografici della Mead saranno successivamente messi in discussione, e altri studiosi
sosterranno che Samoa non è una società così immune da ansie, frustrazioni, violenza. Ma qui
interessa semplicemente rilevare l’uso della comparazione per dimostrare la dipendenza delle
variabili psico-comportamentali da quelle socio-culturali.
Questa strategia apre una corrente di studi che sono comunemente detti di “cultura e personalità”,
interamente basata sulla correlazione comporativa fra tratti psicologici e differenze culturali. Il già
ricordato libro di Ruth Benedict, Patterns of Culture (1934), ne è uno dei risultati più
rappresentativi, e mostra all’opera un metodo comparativo diverso da quello della Mead o di
Malinowski, più complesso e formalizzato. La tesi della Benedict è che ogni cultura, all’interno
delle vaste possibilità del comportamento e dei tratti caratteriali degli esseri umani, ne sceglie e
privilegia alcuni scartandone altri; per mezzo dell’inculturazione (dalle pratiche di allattamento e
svezzamento, all’educazione, alle cerimonie di iniziazione alla vita adulta etc.) vengono plasmate
delle configurazioni psico-culturali, che sono in qualche modo incommensurabili da cultura a
cultura. Pur non determinando in senso meccanico il comportamento e il modo di essere di tutti i
membri di una determinata cultura, queste configurazioni costituiscono una “personalità di base”
che è una sorta di terreno comune, e che è chiaramente riconoscibile nelle istituzioni, nelle relazioni
sociali e nelle produzioni simboliche. A dimostrazione di questa tesi, la Benedict analizza tre
società “primitive”, le cui personalità di base sono contrapposte sulla base di una terminologia
psicologica, e poste in relazione con una serie di caratteristiche culturali distintive. Particolarmente
suggestiva è la contrapposizione fra la personalità “apollinea” degli indios Zuñi del New Mexico,
tutta volta al controllo delle emozioni, alla cerimonialità delle relazioni pubbliche e alla condanna
degli eccessi, e quella “dionisiaca” di altri gruppi amerindi, come i Kwakiutl della costa americana
nord-occidentale, che valorizza invece le esperienze violente ed estatiche e la trasgressione dei
limiti usuali della quotidianità (Benedict 1934, p. 84). I Kwakiutl sono categorizzati anche come
“megalomani”, in virtù della loro ossessione per il conseguimento di status e per gli eccessi di
consumo e distruzione evidenziati da un rito come il già citato potlach; mentre gli abitanti dell’isola
melanesiana di Dobu sono diagnosticati come “paranoici” in quanto “tetri e musoni”, con rapporti
sociali “consumati dalla gelosia, dal sospetto e dal risentimento” (ibid., p. 171). L’autrice presenta
questa come una comparazione organica fra “culture come coerenti organizzazioni di
comportamento”, contrapponendola allo “sguardo d’insieme a tutto il mondo” che caratterizzava il
vecchio metodo comparativo. Non si può però fare a meno di notare come le sue tipizzazioni
psicologiche, per quanto suggestive, appaiano oggi non meno ingenue delle speculazioni
evoluzioniste.
Più cauto e controllato è l’uso della comparazione olistica nella social anthropology britannica,
dove il metodo delle variazioni concomitanti è applicato al rapporto fra sistemi simbolici e struttura
sociale. Ad esempio, fra anni ’40 e ’50 numerosi studi cercano di usare questo approccio nella
analisi del grande tema della stregoneria, considerata, sulla scia dell’opera di Evans-Pritchard, come
forma di espressione e risoluzione del conflitto sociale. Se è possibile dimostrare comparativamente
che, in aree socio-culturali omogenee, le credenze nella stregoneria variano parallelamente al
variare di tratti del sistema sociale, sarà confermato il ruolo funzionale che la stregoneria svolge, e il
fenomeno risulterà dunque “spiegato”. Prendiamo, seguendo un classico testo di S.F.Nadel (1952),
due popolazioni nigeriane, i Nupe e i Gwari: le due hanno sistemi sociali e credenze nella
stregoneria assai simili, ma per i primi le streghe sono solo donne, per i secondi indifferentemente
donne o uomini. C’è una variabile sociale in grado di spiegare questa differenze specifica? Nadel la
individua nel fatto che fra i Nupe le donne, praticando autonomamente il commercio, si sono
arricchite e hanno acquisito potere, creando una situazione di conflitto fra sessi che non esiste
invece fra i Gwari. Dal momento che è un assioma della social anthropology che la stregoneria sia
connessa alle ansie determinate dal conflitto sociale e dalla necessità di regolarlo, ecco che la
variabile sociale e quella culturale entrano in un rapporto causale, che la comparazione fa risaltare
rispetto al “caso di controllo” negativo.
Vale la pena soffermarsi su questa argomentazione, per notare come il metodo della variazioni
concomitanti non “scopre” il valore funzionale della stregoneria; al contrario, anzi, lo presuppone e
ne è reso possibile. Nadel finge di usare una procedura induttiva, ma in realtà conosce in anticipo la
risposta, e da essa risale all’indietro fino a individuare le variabili rilevanti nei dati di partenza. Se
non sapessimo fin dall’inizio che la stregoneria è un’espressione del conflitto e una difesa che la
società mette in atto contro i suoi possibili effetti disgreganti, l’intera argomentazione non avrebbe
senso e, soprattutto, sarebbe impossibile attribuirle valore causale. In altre parole, la scoperta delle
cause è già implicita nelle premesse. Questa è una caratteristica frequente della comparazione
antropologica, che non per questo, tuttavia, costituisce un mero inganno. Lo stesso Nadel, nel
costruire in forma induttiva la propria argomentazione, riorganizza i materiali etnografici in modo
da gettare nuova luce su alcune loro interne caratteristiche. Ed è qui che il suo contributo produce
un incremento di conoscenza. La procedura comparativa non può scoprire nulla di nuovo, ma non
lascia intatti i dati su cui si esercita: li arricchisce e li rende più densi, ovviamente se si tratta di una
buona comparazione. Fingendo di lavorare sul piano dell’astrazione e della generalizzazione
causale, agisce in realtà su quello della stessa descrizione etnografica.
1.6 [La comparazione quantitativa]
Questi ultimi esempi riguardano il tentativo, emerso nella parte centrale del Novecento, di costruire
modelli di comparazione fra insiemi socio-culturali complessi all’interno di aree relativamente
omogenee. Ma anche in questo periodo lo “sguardo d’insieme a tutto il mondo”, come lo definisce
la Benedict, non scompare affatto dalle prospettive antropologiche. Non pochi studiosi si sentono
insoddisfatti dei risultati raggiunti dagli indirizzi particolaristici e relativistici che, pur
richiamandosi al rigore scientifico, avevano allontanato la disciplina dal modello nomotetico delle
scienze naturali avvicinandola piuttosto alla storia e agli studi umanistici. Essi ritengono: a) che per
dirsi scienza (e non storiografia, o pura letteratura descrittiva) l’antropologia debba recuperare gli
obiettivi della generalizzazione e della formulazione di leggi; b) che una scienza dell’uomo non
possa limitarsi allo studio di singole e separate culture, ma debba tentare una ricostruzione
complessiva dell’evoluzione culturale della specie; c) che, anche in campi più settoriali e specifici
dell’antropologia, compito della disciplina sia la ricerca degli universali culturali; d) che tutto ciò
debba necessariamente passare attraverso la quantificazione dei dati e l’uso di forme ampie e
sistematiche di comparazione transculturale. Questi obiettivi sono fatti propri, da un lato, da
indirizzi neoevoluzionisti vicini alla biologia e all’antropologia fisica che, sulla base di un
programma radicalmente antiumanistico, spiegano la cultura in termini di comportamenti adattivi,
sottoponendola agli stessi criteri di analisi che vigono nello studio dell’evoluzione naturale.
L’ecologia culturale, il materialismo culturale, e più di recente l’ecologia comportamentale o
sociobiologia sono i più noti fra questi indirizzi, che fanno largo uso di tecniche di comparazione
riprese dalla biologia o dall’archeologia ma che non discuterò qui, perché pongono problemi di
ordine assai diverso da quelli fin qui affrontati.
Dall’altro lato, la problematica della comparazione universalista e su larga scala viene ripresa
anche all’interno degli approcci socio-culturali all’antropologia. L’esempio più noto e per così dire
più spettacolare è probabilmente quello del Cross-Cultural Survey fondato negli anni ’30 da George
Murdock presso la Yale University, conosciuto poi, dal 1949, con la denominazione di Human
Relations Area Files (HRAF) e tuttora in corso (http://www.yale.edu/hraf). Si tratta del tentativo di
costruire un colossale archivio di un gran numero di culture (se fosse possibile, tutte le culture del
mondo) descritte in modo uniforme e standardizzato, in modo da consentirne la comparabilità e
soprattutto la permeabilità a forme di analisi statistica. Le culture attualmente descritte nei files
sono quasi 400. La descrizione è organizzata per mezzo di un soggettario codificato secondo un
sistema decimale (Cultural Materials Codes), composto da 88 voci a loro volta suddivise in
sottocampi, che intendono coprire tutti gli aspetti di una cultura, dalla demografia all’economia,
dall’architettura alla religione e così via. Ad esempio, una ricerca del codice 584 porterà a
informazioni sulle modalità di organizzazione del matrimonio in tutte le società descritte; il codice
778 conterrà informazioni su luoghi e oggetti considerati sacri; e così via.
L’interesse sul piano documentario di una simile organizzazione dei materiali è indubbia. Ma quali
operazioni comparative rende possibile questa forma di schedatura? Come detto, Murdock e i suoi
seguaci sono interessati principalmente alla formulazione di correlazioni statistiche, viste da un lato
come indicazioni di relazioni causali, dall’altro come indicatori in grado di suscitare
approfondimenti della ricerca in una particolare direzione. Prendiamo due esempi dell’uso degli
Human Relations Area Files, uno classico e uno più recente. Il primo è uno studio di Beatrice
Whiting (1950), che analizza il rapporto tra pratiche di magia nera (sorcery, distinta nella tradizione
anglosassone dalla witchcraft o stregoneria in base alla volontarietà dell’attacco magico e all’uso di
riti specifici) e modalità di composizione sociale dei conflitti in 50 società non occidentali.
L’autrice suddivide le 50 società in due parti, a seconda della presenza o assenza di un’autorità
superiore con il compito di risolvere i conflitti e punire i reati. Tra le 25 società prive di una simile
autorità politico-giuridica, la magia nera è definita “importante” in 24 casi, dunque la quasi totalità;
tra le 25 che ne sono dotate, la magia nera è “importante” solo in 11 casi. Su base statistica si può
dunque stabilire un nesso fra presenza di credenze, timore e accuse di sorcery da un lato, e dall’altro
assenza di strumenti istituzionali di risoluzione dei conflitti. Si può allora supporre che la sorcery
costituisca di per sé un mezzo di risoluzione dei conflitti, ovvero che la paura di essa rappresenti
uno strumento di controllo sociale (cit. in Borowski 1994, p. 81).
L’esempio più recente riguarda il lavoro di Carol e Mervin Ember su guerra e violenza.
Utilizzando i dati del HRAF, i coniugi americani pongono in relazione la frequenza delle guerre
nelle varie culture con altre variabili, quali ad esempio l’inserimento in sistemi di alleanze e di
rapporti commerciali, la frequenza di carestie, la frequenza di disastri naturali, la densità
demografica, il tipo di sistemi politici etc. Per le società preindustriali, la principale correlazione
che ne ricavano è quella fra guerra e calamità naturali come siccità o alluvioni. Come spiegano
questo dato? “It seems that people, particularly in nonstate societies, may try to protect themselves
against future disasters by going to war to take resources from enemies” (Ember-Ember 1992, p.
242). In altre parole, la mancanza di fiducia nel futuro e il timore di inattesi disastri spingerebbero
ad andare in guerra per accaparrarsi risorse che, non si sa mai, potrebbero sempre servire. Un punto
corroborato, secondo gli Ember, dall’assenza di una correlazione significativa tra frequenza delle
guerre e carestie ricorrenti e dunque prevedibili.
Come commentare queste conclusioni? In entrambi i casi si potrebbero porre infiniti problemi
metodologici su come i materiali etnografici e storici sono stati ricondotti a numeri confrontabili su
una tabella, espungendone completamente la dimensione del “significato”; così come si potrebbe a
lungo discutere sulla legittimità delle unità di comparazione, le “culture” considerate come entità
autonome e chiuse su se stesse (se queste unità si influenzano a vicenda, è chiaro che il valore delle
correlazioni va perduto). Ma anche dando per buona la metodologia, colpisce la povertà delle
conclusioni raggiunte. Nel caso della magia, la correlazione proposta è assai ragionevole ma è
tutt’altro che una scoperta: come nel già discusso caso di Nadel, la conclusione dimostra
semplicemente l’interpretazione di magia e stregoneria che l’etnografia non quantitativa aveva già
ampiamente mostrato. Inoltre il rapporto fra le due variabili correlate, pervasività della sorcery e
presenza/assenza di istituzioni per la risoluzione dei conflitti, è spiegato con il ricorso a ipotesi di
tipo psicologico o di senso comune (la paura della magia come motivazione alla conformità
all’ordine sociale), che non hanno nulla di scientifico o di misurabile. Ciò vale a maggior ragione
per la tesi degli Ember, che mi sembra sfiorare il ridicolo nella sua pretesa di far passare per grandi
verità nomotetiche delle assolute banalità. A interpretarla nel modo più favorevole, la loro
conclusione equivale a dire che le guerre vengono combattute per motivi economici e per l’accesso
alle risorse – una tesi ampiamente discussa e altrettanto ampiamente criticata in ambito
antropologico. Anche qui, nessuna teoria collega i due elementi della correlazione, se non l’idea
che “per proteggersi anticipatamente da questi disastri che distruggono le risorse alimentari
potrebbe essere vantaggioso accaparrarsi i beni dei nemici sconfitti”(Ember-Ember 1997, p. 9).
Cioè, le motivazioni degli uomini che muovono la guerra riguardano la paura di possibili alluvioni
o carestie? La sproporzione fra la grande complessità storica, politica e generalmente umana della
guerra e la banalità della presunta spiegazione scientifica è sconcertante, e può solo ricordare certe
ingenuità ottocentesche, quelle che spingevano Wittgenstein a commentare: “nei libri per le scuole
elementari sta scritto che Attila intraprese le sue grandi guerre perché credeva di possedere la spada
del dio del tuono” (Wittgenstein 1967, p. 28). Non c’è nulla di male nell’analisi statistica e
nell’approccio nomotetico: solo che qui siamo di fronte a una loro caricatura. Cosicché non sembra
poi ingiustificato il fatto che Edmund Leach, rigorosissimo e misurato antropologo della tradizione
britannica, parlasse di questo tipo di comparazione come “tabulated nonsense” (cit. in Holy 1987, p.
3) .
1.7 [Storicismo e strutturalismo]
Per concludere questa sommaria tipologia storica di forme della comparazione antropologica,
occorre almeno accennare al ruolo della comparazione nello strutturalismo e nello storicismo.
Quest’ultimo termine è per la verità inusuale nel dibattito antropologico. Mi riferisco qui all’uso che
ne ha fatto l’etnologo e storico delle religioni italiano Ernesto de Martino, che fra anni ’40 e ’60 ha
cercato di rifondare su basi appunto storicistiche lo studio delle culture, contrapponendosi
all’approccio “naturalistico” prevalente nelle grandi scuole internazionali. Per naturalismo de
Martino intende la riduzione degli eventi umani a “cose”, oggetti cui applicare le procedure
classificatorie e generalizzanti tipiche delle scienze naturali; e intende anche quell’aspetto
particolare dell’etnocentrismo che consiste nell’avvicinarsi alle altre culture dando per scontata la
concezione del mondo propria della nostra scienza o del nostro senso comune. Nello studio dei
fenomeni magico-religiosi, dei quali de Martino prevalentemente si occupa, proprio questi sono
stati a suo parere i grandi e pregiudiziali errori delle discipline sociali di tradizione positivistica; lo
storicismo che gli oppone è basato sulla comprensione individuante dei fenomeni culturali (inclusi
quelli “primitivi” o folklorici) nella loro unicità e dinamicità storica.
In apparenza, la comparazione è del tutto esclusa da un simile approccio, poiché sembra
implicare le procedure oggettivanti, classificatorie, astrattive proprie del naturalismo. Di fatto, però,
de Martino ne fa ampio uso. Si è tentati di dire che come antropologo non può farne a meno. Ad
esempio, la comparazione appare nel bel mezzo dell’intelligenza storicista nella sua opera più
famosa, La terra del rimorso, uno studio sulla pratica pugliese del tarantismo, un tradizionale
rituale di guarigione coreutico-musicale che implica possessione e trance estatica. De Martino è
interessato prevalentemente a ricostruire la storia del rituale, collocandolo nella tensione fra cultura
egemonica e cultura subalterna che percorre l’età moderna e contemporanea. Ma è al contempo
colpito dalle analogie con analoghi rituali estatici documentati in altre epoche storiche e in altre aree
culturali: ad esempio i culti orgiastici del mondo classico, e un’ampia serie di culti e riti diffusi in
ambito mediterraneo, africano e afro-americano, come zar, condomblé, vodu. Ci sono molti temi
comuni, tanto che sembrerebbe trattarsi di esempi di una stessa pratica; ed ovviamente la
comunanza ha a che fare con contatti culturali solo parzialmente documentati. Ma de Martino ci
pone in guardia sull’uso da fare di questi raffronti comparativi: non dobbiamo correre il rischio di
ridurre il fenomeno del tarantismo a un “tipo” etnologico o a un antecedente storico, considerandolo
come una semplice sopravvivenza oppure come un esempio fra i tanti di una classe di fenomeni
culturali da spiegare nella sua generalità. A cosa serve allora comparare? La risposta di de Martino
è che serve appunto a evidenziare “la originalità storica del tarantismo” (1961, p. 187), la sua
irriducibile autonomia. In altre parole, sono le differenze che contano molto più delle similarità –
diversamente da quanto accade nelle forme più classiche di comparazione. Le somiglianze sono
palesi, ma de Martino non è interessato a formulare a partire da esse un sapere universalistico. Al
contrario, parte dalla constatazione di una comunanza culturale (riconducibile per lui alla
comunanza di esperienze esistenziali elementarmente umane) e usa la comparazione per meglio
delineare le peculiarità storiche dello specifico fenomeno che sta studiando. Un punto di vista che
mi sembra di poter estendere anche ad altri autori e correnti che, nella seconda metà del Novecento,
hanno privilegiato l’approccio storico e individuante in contrapposizione a quello generalizzante e
naturalistico. E’ il caso dell’antropologia cosiddetta interpretativa, per la quale, come è stato scritto,
“lo scopo principale della ricerca comparativa…è di facilitare la nostra comprensione dei significati
culturalmente specifici, vale a dire identificare o focalizzare la specificità culturale”. Ciò significa
(ed è un punto su cui tornerò più avanti), che “si rovescia completamente la relazione fra
descrizione e comparazione propria dell’antropologia positivistica, nella quale lo scopo ultimo di
ogni descrizione era raccogliere fati per l’analisi interculturale” (Holy 1987, p. 10).
Con le differenze, più che con le similarità, ha a che fare anche lo strutturalismo, la corrente
fondata da Claude Lévi-Strauss che ha esercitato una enorme influenza sull’antropologia e sulle
scienze sociali fra gli anni ’50 e gli anni ’70. I motivi sono però molto diversi – anche perché lo
strutturalismo si contrappone per molti versi allo storicismo e mira per l’appunto a una conoscenza
generalizzante e non legata alle contingenze storiche. Il punto cruciale riguarda l’identificazione
dell’oggetto primario dell’analisi culturale. Per Lévi-Strauss tale oggetto non consiste in singoli
tratti, e neppure in “culture organiche” o in “strutture sociali”, ma in sistemi semiotici i cui confini
non coincidono necessariamente con quelli di singole culture o società. Pensiamo ad esempio allo
studio della mitologia amerindia, un tema cui Lévi-Strauss dedica alcune delle sue opere più
importanti. I miti sono per lui il prodotto di una facoltà ordinatrice dell’intelletto che si esprime per
mezzo di una logica non astratta ma “concreta”, che fa uso cioè di elementi dell’esperienza
quotidiana come operatori simbolici. Il miele, i giaguari, i pappagalli ara, i cacciatori e tutti gli altri
simboli che sono combinati in forma narrativa in una narrazione mitologica sono da intendersi
dunque in relazione a un codice, che per Lévi-Strauss è in definitiva un codice cibernetico – guidato
ciooè da una logica binaria, procedente per disgiunzioni oppositive. Ora, per comprendere il codice
non è mai sufficiente analizzare un solo mito, e neppure il corpus mitologico presente in un solo
gruppo. Nei suoi lavori sugli indios amazzonici, Lévi-Strauss (1964) procede attraverso progressive
estensioni comparative, disponendo i testi mitologici come in un gioco a incastro, nel quale nessuno
è autosufficiente ma ciascuno contiene degli elementi che possono servire a capire gli altri. E’ solo
attraverso i confronti comparativi che si rivela la sintassi dell’intero sistema.
In questo caso il confronto resta all’interno di un’area omogenea come quella amazzonica, ma il
metodo strutturale non ha di per sé bisogno di restare entro confini areali. In un altro dei suoi più
suggestivi scritti, Lévi-Strauss (1952) cerca di comprendere la figura di Babbo Natale
nell’occidente contemporaneo ponendola in relazione con alcuni suoi antecedenti storici e con
alcuni rituali degli indiani del sud-ovest degli Stati Uniti, nei quali i katchina, spiriti di antenati,
tornano sulla terra ciclicamente per compiere cerimonie e per punire o premiare i bambini. Qual è il
senso di un simile accostamento “esotizzante”? Lévi-Strauss non intende ridurre Babbo Natale né
agli antecedenti né a una tipologia generalizzante. Parte invece dalla identificazione di alcuni trattichiave della sua simbologia (i bambini come mediatori fra generazioni e come elementi di
passaggio tra vita e morte, tra mondo terreno e aldilà), e cerca di chiarire meglio la sintassi dei riti
natalizi accostandoli ad altri che sembrano appartenere allo stesso ambito semantico, che sembrano
cioè volti a elucidare le stesse strutture dell’esperienza umana e sociale. Non ha qui alcuna
importanza la contiguità storica o socio-culturale fra Babbo Natale e i katchina: la loro
comparazione serve a chiarire la struttura logica dei riti, i quali, nonostante la loro distanza,
sottendono analoghe procedure ordinatrici e plasmatrici dell’esperienza.
PARTE SECONDA
2.1 [La comparazione nell’antropologia interpretativa]
Questa sommaria e incompleta carrellata storica ha inteso mostrare in primo luogo che
l’antropologia culturale ha conosciuto una grande varietà di pratiche comparative, senza che alcun
metodo condiviso e standardizzato sia riuscito ad affermarsi. Anzi, col termine comparazione si
sono intese procedure molto diverse di analisi e trattamento dei materiali etnografici, difficilmente
riconducibili a unità. Abbiamo anche visto come attorno al problema della comparazione si siano
divise due diverse idee della disciplina: l’una più vicina al modello delle scienze naturali, che ha
creduto nella comparazione come strada maestra per conseguire una conoscenza di tipo nomotetico,
generalizzabile e oggettivamente verificabile; l’altra di tipo più umanistico, scettica verso la
formulazione di leggi generali e volta piuttosto a un sapere etnografico denso e individuante. La
prima proiettata su una scala universalista e interessata a rilevare i tratti comuni alle diverse culture;
la seconda immersa nell’irriducibilità dei contesti storico-locali, e maggiormente interessata alle
differenze. Queste due prospettive si sono alternate nella storia degli studi, o hanno convissuto in
una tensione tutto sommato fruttuosa.
Negli ultimi decenni, con l’affermarsi dell’antropologia interpretativa e (come viene talvolta un
po’ impropriamente chiamata) postmodernista, la prospettiva storico-particolarista sembra aver di
nuovo prevalso. Come conseguenza, la problematica comparativista è passata almeno in parte in
secondo piano; già alla fine degli anni ’80 si notava un radicale crollo del termine “comparazione”
negli indici delle riviste scientifiche o dei manuali di antropologia (Holy 1987, pp. 6-7), e oggi la
tendenza pare ancor più accentuata. Non che la comparazione non sia usata in una forma o
nell’altra; solo che, rispetto agli anni ’60-’70, sta un po’ meno al centro delle preoccupazioni
metodologiche. Il suo posto è stato preso dal problema della costituzione del sapere etnografico
stesso: più che chiedersi come trattare comparativamente i dati, le scienze sociali interpretative
tornano a chiedersi come i dati stessi si producono. Al centro della loro riflessione stanno i problemi
della ricerca sul campo e delle sue condizioni in senso lato “politiche”, della trasformazione
dell’esperienza di ricerca in scrittura, del rapporto tra soggettività dell’osservazione partecipante e
oggettività della descrizione etnografica. Lo scetticismo nei confronti della qualità “oggettiva” dei
dati non supporta certo la fiducia nella comparazione formalizzata. Se la rappresentazione
etnografica è una forma di sapere così delicato e controverso, “politicamente” conteso e
“retoricamente” plasmato, prodotto in modo più artistico che scientifico, frutto dei negoziati sempre
provvisori tra i significati dei “nativi” e quelli dell’antropologo, non sembra possibile farne la
materia prima per operazioni di generalizzazione e astrazione. Rischiamo di cadere nello stesso
vecchio errore degli evoluzionisti: procedure comparative in massimo grado ambiziose ma
esercitate su dati privi della minima attendibilità etnografica. Si possono al massimo comparare le
esperienze, non gli oggetti etnografici - come fa Clifford Geertz, che in uno dei suoi più recenti
lavori ci presenta una comparazione sistematica di Marocco, Giava e Bali sulla base del fatto che
sono stati i suoi tre terreni di ricerca, e dunque può raffrontarli – lui solo – tenendo conto della
complessità della formazione della conoscenza etnografica (Geertz 1995).
Tutto ciò non significa affatto che la comparazione non sia praticata nell’antropologia di oggi,
inclusa quella interpretativa. Anzi, la sfiducia verso la formalizzazione e la standardizzazione
metodologica apre la strada a un uso più libero di svariate modalità comparative. Nelle pagine che
seguono, cercherò di individuarne alcune, discutendo a) l’uso della comparazione come risorsa
descrittiva; b) l’uso comparativo dei case-studies; c) le ricerche di impostazione transculturale c)
alcune forme di ripresa del metodo comparativo classico; d) infine, i nuovi problemi che la
globalizzazione apre alla comparazione antropologica.
2.2. [Comparazione e descrizione]
I manuali classici insistono sulla distinzione fra due fasi della ricerca sociale: da un lato la
raccolta dei dati, dall’altro il loro trattamento. La prima fase può includere ricerca sul campo,
spoglio di materiali d’archivio e altre modalità di rilevazione o produzione di fonti, nonché la
presentazione di questi dati in forma puramente documentaria; la seconda si riferisce alle varie
forme di analisi, e trova nella comparazione il suo momento principe. Questi due momenti, per
quanto possano intrecciarsi sul piano pratico, sono concepiti come rigorosamente separati sul piano
epistemologico e normativo: rispondono a regole diverse di validità, e si collocano rigidamente in
successione cronologica nel processo di ricerca. Prima si rilevano e si presentano i dati, poi li si
analizza e semmai li si compara con altri. I dati rappresentano, sempre secondo questa concezione
classica, l’aspetto più solido della conoscenza conseguita: le ipotesi interpretative possono mutare,
venir confutate e abbandonate, ma i “fatti” restano la loro base permanente. Il presupposto
positivistico di questo punto di vista, cioè la separazione tra fatti e teoria, è un vero e proprio filo
rosso nella storia dell’antropologia: se c’è qualcosa che accumuna evoluzionismo ottocentesco,
scuola boasiana e moderna antropologia sociale è proprio questo. Già Frazer riteneva che le teorie
esposte nei suoi libri rappresentassero un traballante castello di ipotesi, forse destinate a crollare, ma
che invece i fatti da lui raccolti fossero destinati a durare nel tempo. Boas, come abbiamo visto,
richiamava al rigore documentario in contrapposizione a eccessivi ardimenti teorici. E RadcliffeBrown, nel momento di maggior fortuna del funzionalismo socioantropologico, si spingeva a
pensare questi due momenti della ricerca come correlati a discipline radicalmente diverse:
“…l’antropologia, lo studio delle società primitive, comprende sia le indagini di tipo storico che
quelle volte alla generalizzazione. Le prime includono l’etnografia e l’etnologia, le seconde sono
note con il nome di antropologia sociale, che è una branca speciale della sociologia comparativa.
Noi auspichiamo quindi che gli obiettivi e i metodi dei due tipi di ricerche rimangano distinti”
(Radcliffe-Brown 1952, p. 145). Questo appello arriva in conclusione di un saggio dedicato proprio
al metodo comparativo, che il maestro britannico considerava tanto ineliminabile dall’idea del
sapere antropologico quanto nettamente distinto dai problemi della rappresentazione storicoetnografica.
Questa suddivisione discende da una fiducia nell’oggettività dei dati e nella loro autonomia
rispetto alle categorie teoriche che oggi, dopo quasi un secolo di epistemologia post-empirista, non
possiamo più avere. Ma, ciò che più conta, la dicotomia tra sapere nomotetico e idiografico tracciata
da Radcliffe-Brown non descrive affatto il modo in cui si produce (ed è sempre stato prodotto) il
sapere antropologico. Non è difficile oggi riconoscere, alla luce dei dibattiti interpretativi, quanto al
livello apparentemente basilare e “innocente”della descrizione etnografica svolgano una parte
importante la teoria in generale e, più in particolare, la comparazione. Non solo nel senso che un
eventuale progetto comparativo influenza fin dall’inizio la presentazione dei dati, e in qualche caso
persino la loro raccolta (è chiaro ad esempio che, se si lavora all’interno della cornice delle Human
Relations Area Files, si tenderà a produrre fatti etnografici di un certo tipo, con un certo format, in
modo da renderli adeguati alla forma della procedura comparativa che li attende). Ma, più in
generale, il punto è che la comparazione rappresenta una fondamentale risorsa descrittiva di cui
nessuna impresa etnografica sembra poter fare a meno.
Nel tentativo di rappresentare una cultura “aliena”, l’etnografo fa costantemente ricorso (in modo
più o meno esplicito) a raffronti e analogie con elementi della propria cultura, o meglio di quella
che condivide con i suoi lettori. Per far comprendere l’atteggiamento dei trobriandesi di fronte alle
collane e ai bracciali dello scambio cerimoniale kula, oggetti di grande prestigio che sono trattenuti
solo temporaneamente dal possessore e devono esser sempre di nuovo scambiati, Malinowski
(1922, cap. 3.3) li raffronta alle coppe e ai trofei sportivi; e per rappresentare il nesso fra
l’ammirazione reverenziale per questi oggetti e la loro inutilità pratica, rammenta ai suoi lettori il
culto britannico per i gioielli della corona. Lévi-Strauss (1962, cap. 8), nel descriverci i churinga
degli aborigeni australiani, oggetti sacri rappresentativi del passato mitico dei gruppi sociali, li
accosta a ciò che per noi sono gli archivi storici. Meyer Fortes, un grande esponente della scuola
funzionalista britannica, intitola un suo saggio sulla religione dei tallensi “Oedipus and Job in West
African Religion” (Fortes 1959). Si tratta di tre esempi molto diversi. La comparazione di
Malinowski fa semplicemente notare al lettore come ciò che in apparenza sembra strano e persino
irrazionale, cioè dedicare grandi sforzi e investimenti sia economici sia emotivi nel possesso
temporaneo di cose inutili, è qualcosa di ben conosciuto anche nella nostra società, nelle nostre
pratiche di vita. Perché dovremmo trovare strano il kula melanesiano e non i nostri tornei sportivi
volti all’aggiudicazione di una coppa, che viene poi orgogliosamente esibita? Sullo sfondo
dell’accostamento con le coppe o con i gioielli della Corona c’è poi anche un punto teorico
decisivo per l’autore, vale a dire la critica ai modelli utilitaristi di agente razionale - quelli fondati su
un’idea di homo oeconomicus che imposta tutte le sue azioni in vista di un profitto o di un’utilità
pratica.
La comparazione di Lévi-Strauss è più complessa: l’accostamento tra churinga e archivi è
spiazzante, è qualcosa che il lettore non si aspetterebbe. Non è un semplice accostamento empirico,
ma presuppone un forte modello interpretativo. Churinga e archivi storici avrebbero in comune non
solo il fatto di rappresentare il passato, ma, nel linguaggio strutturalista, la capacità di inscrivere
l’ordine della diacronia in quello della sincronia. Sarebbero cioè punti di articolazione fra
l’esperienza dello spazio e quella del tempo, dotati entrambi di una particolare qualità rituale. Si
tratta dunque di una comparazione che ci mostra in una luce diversa gli stessi archivi, spiazzando il
nostro senso comune, o meglio consentendoci di guardare più in profondità dentro noi stessi:
“quando un’usanza esotica ci attira a dispetto (o a cagione) della sua apparente singolarità, il motivo
generalmente sta nel fatto che ci suggerisce, come fosse uno specchio deformante, un’immagine
familiare che riconosciamo confusamente come tale senza però riuscire a identificarla” (Lévi-
Strauss 1962, p. 260). Per quanto riguarda Fortes, è interessato a discutere la religione dei tallensi
come un sistema di riflessione etica sul posto dell’uomo nell’universo e sul suo rapporto con
potenze superiori. Le figure di Edipo e Giobbe gli servono a costruire una cornice di significato che
appaia ai lettori familiare e immediatamente comprensibile, compensando l’effetto di “stranezza”
della teologia nativa. Edipo è per lui rappresentativo del tema del Fato, Giobbe del tema della
giustizia divina – due elementi che ritiene dominanti nel pensiero dei tallensi come in tutte le
religioni-filosofie dell’Africa occidentale. La comparazione ha un effetto fortemente universalista,
poiché suggerisce che analoghe preoccupazioni morali fondano il pensiero e la vita degli esseri
umani, al di là di pur enormi differenze culturali.
Si tratta di tre esempi diversi l’uno dall’altro, ma caratterizzati dall’uso della comparazione come
risorsa descrittiva. In tutti e tre i casi, la comparazione non viene dopo l’identificazione dell’oggetto
etnografico, ma contemporaneamente, fa anzi parte di questa identificazione. Lo spazio del sapere
etnografico si mostra qui come intrinsecamente comparativo. Ciò è particolarmente evidente nel
caso della religione, dove lo stesso più basilare livello di traduzione dei termini nativi è altamente
problematico. Quando traduciamo questi termini con “Dio”, “spiriti”, “anima” e così via stiamo
ovviamente accostandoli a significati che fanno parte della nostra storia culturale; non
diversamente, quando usiamo termini come “mana”, “totem”, “tabu”, presi da culture specifiche e
promossi a una valenza più generale, stiamo istituendo implicite comparazioni. Né sarebbe possibile
fare diversamente: i concetti “alieni” possono essere almeno in parte compresi solo a partire
dall’accostamento con concetti che ci sono già familiari, che già fanno parte della nostra vita.
2.3 [I case-studies]
Naturalmente, nel rivolgere l’attenzione a queste procedure esplicitamente o implicitamente
comparative, non stiamo più parlando di comparazione come di uno speciale metodo scientifico, ma
come di una procedura tipica del linguaggio ordinario, che si colloca su un piano non molto diverso
da quello della similitudine, della metafora e di altre figure retoriche. Dunque, una strategia
discorsiva che ha segnato fin dall’inizio la produzione antropologica e continua a svolgere in essa
un ruolo decisivo. Ma che ne è di forme più esplicite e sistematiche di comparazione?
Nell’antropologia di oggi la comparazione sistematica prende soprattutto una forma che potremmo
definire come accostamento di case-studies. Il case-study è un metodo di ricerca tipicamente
individuante, che prende in esame monograficamente una realtà specifica ma, a partire da essa,
tenta di far emergere categorie interpretative di più ampio interesse. E’ un metodo che non mira
affatto a produrre dati in forma comparabile; eppure, l’accostamento di più case-studies dedicati a
una medesima problematica può produrre un effetto di “accerchimento” del tema in questione dagli
effetti illuminanti. La diffusione di questo stile di lavoro nella produzione antropologica
internazionale è visibile nel format stesso dei libri che vengono pubblicati. La “monografia
etnografica”, cioè l’ampio resoconto di ricerca che tenta di rappresentare tutti o almeno alcuni dei
più rilevanti aspetti di una cultura, non è più oggi il principale genere di libro in campo
antropologico. Un ruolo centrale è invece svolto dalle raccolte di saggi che affrontano una
particolare tematica attraverso, appunto, un’ampia varietà di case-studies.
Farò un esempio da un campo di cui mi sono personalmente occupato, quello dell’antropologia
della violenza. Negli ultimi due decenni l’antropologia culturale ha cominciato ad affrontare
sistematicamente il problema delle violenze di massa che hanno caratterizzato il ventesimo secolo,
dagli stermini coloniali, alle guerre mondiali, ai genocidi, alle guerre cosiddette etniche, al
terrorismo su larga scala. Questi drammatici eventi, al di là dei motivi storici specifici che li hanno
prodotti, pongono profondi problemi di natura antropologica, sia che cerchiamo di comprendere il
comportamento (in apparenza “disumano”) dei carnefici, sia che ci poniamo dal punto di vista delle
vittime. Ad esempio, le esplosioni di violenza sono una sorta di uscita dalla cultura oppure
rispondono a orientamenti culturali? Come comprendere i patterns ricorrenti di violenza di massa,
talvolta decisamente ritualizzata, che si ritrovano in modo quasi universale nei più diversi contesti?
In che modo le comunità colpite da eccidi e violenze di massa riescono a eleborare il lutto, e in che
modo viene costruita una memoria pubblica degli eventi traumatici? E ancora: quali questioni etiche
e conoscitive si pongono all’antropologo che si trovi a lavorare in contesti scossi dalle guerre e dalle
violenze o dalle loro memorie? Problemi di questo tipo invitano naturalmente ad approcci di tipo
comparativo: si avverte con forza la limitatezza di un’analisi che si limiti a studiare e a spiegare i
singoli casi isolatamente. Eppure si avverte anche il rischio di generalizzazioni semplicistiche, che
apparirebbero tanto più banali (come già notato per gli Human Relations Area Files) a fronte della
drammaticità e dell’immenso impatto morale degli eventi in questione. Inoltre, su un piano più
pratico, la vastità delle conoscenze storiografiche che ciascun evento mette in gioco rendono
impossibile a un singolo studioso, o anche a una piccola équipe, abbracciare con sufficiente
competenza il quadro d’insieme. Come conciliare dunque sguardo d’insieme e peculiarità
storiografica?
La risposta è consistita, appunto, nel raffronto tra case-studies unificati da cornici molto generali
di spunti problematici e di categorie interpretative. Dall’inizio degli anni ’90 ad oggi, i principali
contributi del dibattito internazionale a questi temi sono costituiti da raccolte di saggi storicoculturali o etnografici che affrontano problemi analoghi ma a ridosso di contesti diversissimi. Si
possono contare decine di pubblicazioni antologiche, numeri monografici di riviste, atti di convegni
in cui si trovano allineati, uno dopo l’altro, contributi riguardanti le “guerre sporche” dell’America
Latina, il terrorismo in Irlanda e nei Paesi Baschi, i genocidi del Ruanda e della ex-Jugoslavia, le
guerre civili africane, i conflitti etnico-religiosi nel Sud-est asiatico, la Shoah, i massacri di civili
durante la Seconda Guerra Mondiale – e l’elenco potrebbe continuare a lungo. Spesso sono aspetti
ancora più specifici a costituire l’oggetto dei case-studies: la memoria della guerra civile in un
villaggio greco, la politica della memoria tra le famiglie dei desaparecidos argentini, i bambinisoldato in Mozambico, e così via (per una più sistematica introduzione al tema rimando a Dei
2005). Non si tratta di comparazione formalizzata, ma neppure di contributi autonomi e separati.
Senza alcuna pretesa di generalizzazione, c’è però un intreccio di categorie interpretative, una
giustapposizione delle storie narrate e dei loro attori, tanto da poter leggere i diversi casi come un
unico testo.
2.4 [Analisi quantitativa e qualitativa nella ricerca tranculturale]
Non mancano, nel quadro dell’antropologia contemporanea, ricerche comparative più
formalizzate e basate su metodologie di tipo quantitativo e sperimentale. Non mi riferisco tanto alle
prospettive neoevoluzioniste o sociobiologiche, sui cui limiti e sulla cui sostanziale estraneità al
versante cultrale dell’antropologia mi sono già espresso; quanto, piuttosto, a ricerche di taglio
transculturale (cross-cultural) che impiegano strumenti di rilevazione o misurazione empirica
suscettibili di analisi in termini statistici o comunque quantitativi. Si tratta di metodologie maturate
soprattutto nell’ambito di scienze sociali come la sociologia e la psicologia, nei loro tentativi di
applicare alla dimensione transculturale strumenti di ricerca inizialmente elaborati in riferimento
alle società occidentali. Ad esempio, cosa succede se cerchiamo di usare con persone socializzate in
culture diverse test psicologici come quelli per la misurazione del quoziente d’intelligenza, o test
reattivi come quello di Rorschach (l’interpretazione delle macchie d’inchiostro); oppure, ancora,
questionari sull’adesione a certi valori, come la lealtà, l’amore per i bambini, la pietà filiale e così
via? E’ chiaro che questi strumenti di rilevazione sono stati inizialmente costruiti sulla base di
indicatori e parametri tarati su una “normalità” propria di una particolare cultura (tanto che spesso
risultano difficilmente generalizzabili anche all’interno dello stesso mondo occidentale), che non
funzionano dunque in culture diverse. Così, la misurazione del “quoziente d’intelligenza” avviene
attraverso l’esecuzione di performance intellettuali di natura prevalentemente logico-formale,
implicando abilità che non sono affatto universali e che non sono coltivate, poniamo, nelle culture
africane tradizionali. Gli studi sull’amore per i figli o per i genitori si basano su indicatori
socialmente determinati, che risultano inservibili in società che dettano o ritengono accettabili
norme di comportamento diverse – per cui uno stesso atto può assumere significati opposti.
La sociologia e la psicologia transculturale hanno elaborato complessi e assai interessanti
metodologie per eliminare simili fonti di errore: vale a dire per tarare gli strumenti di rilevazione,
con gli opportuni adattamenti locali, in modo da produrre dati omogenei sul piano trans-culturale
(van der Vijver 2002). Dal punto di vista dell’antropologia, proprio le fonti di errore sono forse
l’aspetto più interessante, in quanto indicatori di diversità. I settori della disciplina più inclini a
questo tipo di ricerca sono l’antropologia psicologica e cognitiva, l’antropologia medica,
l’etnopsichiatria – cioè, gli studi che hanno a che fare col rapporto tra condizioni culturali e
caratteristiche individuali. In tali settori, è possibile combinare strumenti di rilevazione diagnostica
e persino setting sperimentali assai rigorosi con raffinate analisi interpretative dei problemi di
traduzione interculturale. Per l’antropologia medica, ad esempio, la comparazione transculturale
non è solo una fra le possibili metodologie da adottare: è invece centrale e indispensabile per il suo
progetto di mostrare l’azione della cultura laddove le scienze biomediche vedono solo processi
naturali di portata universale. Le discrepanze che le categorie nosologiche della moderna
biomedicina incontrano quando sono usate in altre società sono il segno inequivocabile che “siamo
in presenza della cultura”, come si esprimono Arthur Kleinman e Byron Good, due noti esponenti
della scuola medico-antropologica nordamericana. Un caso in cui tali discrepanze si mostrano in
modo particolarmente clamoroso, studiato da questi due autori, è quello della depressione. La
moderna psichiatria definisce questa malattia in base a una serie ben definita di sintomi (sia
comportamenti, sia percezioni di sofferenza da parte del paziente), i quali cessano di risultare validi
appena fuori da confini culturali molto ristretti. Basta pensare al grado di variabilità dei sentimenti
che costituiscono la “disforia”, il principale indicatore della depressione (tristezza e malinconia,
senso di infelicità e di vuoto, assenza di motivazioni e di piacere per le attività sociali, etc.). Vi sono
culture che ad esempio valorizzano in termini religiosi o morali questi sentimenti, considerandoli
segno di saggezza o di profondità: è il caso di alcune società buddiste, per le quali “una consapevole
disforia è il primo passo verso la salvezza”, mentre al contrario provare piacere per le attività
mondane è visto come radice della sofferenza. Vi sono società che valutano positiviamente
l’espressione piena e drammatica di sentimenti di tristezza e dolore; altre che, al contrario, invitano
a celare questi sentimenti e a presentare in pubblico un self calmo e privo di increspature
(Kleinman-Good 1985, p.3). Non si tratta solo di esprimere in modo diverso gli stessi sentimenti.
Possiamo invece pensare che le esperienze stesse sono diverse: mancano chiari equivalenti
semantici, ed è questo che rende così difficile la traduzione interculturale dei criteri diagnostici. In
altre parole, “descrivere cosa significa essere addolorato o malinconico in un’altra società ci porta
immediatamente ad analizzare differenti modi di essere persone in mondi radicalmente differenti”
(Ibid.). Tutto ciò non esclude tuttavia forme sistematiche di rilevazione empirica delle
sintomatologie su scala transculturale: le rende anzi necessarie. Il grande problema che gli
antropologi così come gli psichiatri transculturali si pongono – quello della relatività o universalità
della categoria stessa di disturbo depressivo – ha bisogno non di soluzioni di principio, ma di
risposte empiriche circostanziate, che sappiano combinare all’analisi epidemiologica e statistica una
adeguata sensibilità etnografica.
Un secondo esempio di ricerche transculturali di taglio empirico e sperimentale, che vorrei
brevemente discutere, riguarda il campo dell’antropologia cognitiva e linguistica. Si tratta dei
celebri studi sulla percezione e sulle denominazioni dei colori, svolte a partire dagli anni ’60 da
Brent Berlin e Paul Kay. Il problema che questi antropologi si ponevano è il seguente. Le lingue e le
culture umane riconoscono e nominano i colori in modi radicalmente differenti: varia il numero di
colori primari che sono individuati (da due a undici) e variano i modi di stabilire confini tra i settori
dello spettro cromatico. Ora, queste variazioni sono arbitrarie e puramente dipendenti dai contesti
locali, oppure si può riconoscere al di sotto di esse un modello cognitivo e percettivo unitario?
Berlin e Kay, lavorando comparativamente su novantotto lingue (venti per analisi diretta e
settantotto attraverso resoconti già editi), hanno ritenuto di poter individuare appunto alcune
caratteristiche comuni nella formazione dell’area semantica relativa ai colori. Le differenze sono
tutt’altro che incoerenti, e si dispongono invece attorno ad un pattern preciso. Prima di tutto,
“ciascuno dei termini di colore principali in tutte le lingue era riconducibile ad uno fra undici colori
di riferimento” (Kay 2001, p. 54). In altre parole, al linguaggio si imporrebbe una universale
modalità percettiva che tende a scomporre la gamma cromatica secondo determinate unità
percettive: sono dunque queste ultime a determinare il significato dei termini di colore. In secondo
luogo, esisterebbe una precisa progressione evolutiva nello sviluppo e nella differenziazione dei
termini di colore. Si parte, nei linguaggi meno “ricchi”, da una differenziazione essenziale tra due
soli colori fondamentali, che sono bianco/nero (o chiaro/scuro), e si procede poi ad ulteriori
scomposizioni secondo un ordine regolare. Quando viene introdotto un terzo termine, quasi
invariabilmente sarà il rosso; seguiranno verde e giallo, e quindi nell’ordine blu, marrone, viola,
rosa, arancio e grigio (Ibid.). Berlin e Kay presentano la loro ricerca come una confutazione del
relativismo linguistico (rappresentato dalla cosiddetta tesi Sapir-Whorf, secondo la quale le visioni
del mondo sono sottodeterminate dalle categorie linguistiche); un punto su cui è tuttora aperta una
discussione serrata. Resta il fatto che si tratta di un esempio importante di comparazione
trasculturale, che si è imposto come decisivo nel campo degli studi sul colore; il suo punto di
maggior forza sta proprio nella delimitazione del campo d’indagine, che consente di definire in
modo preciso ed operativo gli indicatori empirici delle nozioni studiate.
2.5 [Il ritorno del metodo mitico]
Cambiamo completamente scenario. Per quanto possa apparire paradossale, l’orizzonte
interpretativo riapre spazi di praticabilità anche per il metodo comparativo di scala universale, che
l’antropologia aveva abbandonato già dagli inizi del XX secolo in nome del rigore scientifico. Nella
letteratura recente, l’esempio forse più significativo e per certi versi spettacolare di uso del metodo
comparativo è rappresentato dal libro di Carlo Ginzburg, Storia notturna. Una decifrazione del
sabba (1990). Ginzburg è uno storico con forti interessi per l’antropologia, che si è dedicato fin
dall’inizio della sua carriera allo studio dei processi per stregoneria nell’età moderna. In particolare,
ha centrato il suo lavoro sul seguente problema: le credenze nella stregoneria che emergono dalle
accuse e dalle confessioni (estorte con la tortura, è bene ricordare) documentate negli atti dei
processi sono di origine colta o popolare? In altre parole, rappresentano una ideologia ufficiale
elaborata e imposta dalla Chiesa e dal Tribunale dell’Inquisizione, oppure riflettono, sia pure in
modo distorto, un autentico sostrato di cultura popolare? La storiografia classica propende per la
prima ipotesi, mentre Ginzburg, fin dai suoi primi lavori, tenta di districare dal complesso intreccio
ideologico un filone di credenze e pratiche folkloriche, sostanzialmente pagane e non derivate dalla
cultura egemonica.
In Storia notturna, in particolare, l’autore tenta di rintracciare le origini folkloriche di uno dei
principali nuclei dell’ideologia stregonesca, quello del sabba, il raduno notturno delle streghe che,
nella versione cristiana, incontrano e rendono omaggio al Diavolo. Il problema che Ginzburg deve
affrontare è ovviamente la carenza di documentazione. Per definizione, la cultura che resta
documentata nelle fonti scritte è quella ufficiale; la cultura folklorica, trasmessa per via orale e
spesso osteggiata dalle classi dominanti, non viene registrata e sembra condannata all’oblio. Ma non
è esattamente così: anche la cultura dei “vinti” lascia tracce di sé, e queste tracce possono essere
seguite, sia pure con grande difficoltà e con la necessità, appunto, di “decifrarle”. Dove non arriva
la documentazione diretta, può arrivare un metodo indiretto basato sulla comparazione. Ginzburg
procede così: individua una serie di nuclei tematici presenti nel complesso del sabba, come ad
esempio il volo notturno, l’estasi, il mascheramento da animali etc., e passa a rintracciare temi
analoghi in una vastissima documentazione mitografica, folklorica, storico-religiosa. Il libro si
sviluppa come un gigantesco gioco di domino, dove catene di mitemi o “figure” si collegano tra
loro lungo il duplice asse della sequenzialità cronologica e della somiglianza morfologica, con un
effetto di progressivo ampliamento dell’orizzonte storico-geografico. La tesi di Ginzburg è che il
sabba rappresenta una tarda formulazione di una serie di temi e motivi che rimandano in ultima
analisi all’esperienza della trance sciamanica e al nucleo immaginativo del viaggio nel mondo dei
morti. Ma ogni nesso diretto fra sciamanismo e sabba è scomparso: fra i due si estende un intero
universo di produzioni culturali nel quale la più cauta filologia o i più prudenti approcci contestuali
non riescono a procedere, e dove invece solo il metodo comparativo riesce ad aprirsi la strada.
Storia notturna ha subito molte critiche, sia riguardo la sua metodologia complessiva sia in
relazione a specifiche questioni filologiche: ma ha senz’altro avuto il merito di dimostrare il fascino
e la fecondità della comparazione su vasta scala – nonché la sua legittimità, qualora la si disincagli
dalle ingenue premesse positivistiche ed evoluzioniste che ne hanno segnato la nascita. Ginzburg si
rende conto delle scomode somiglianze tra il suo metodo e quello di opere come The Golden
Bough, e si cautela avvertendo che “il mio Frazer ha letto Wittgenstein” (1989, p. 189 nota). Il
riferimento è qui alle osservazioni critiche che il filosofo austriaco ha mosso proprio a The Golden
Bough, in un testo che ha molto influenzato l’antropologia contemporanea (Wittgenstein 1967) .
Wittgenstein è estremamente critico nei confronti delle “superstizioni” positiviste di Frazer, verso la
sua ossessione per la ricerca delle origini e la sua tendenza a considerare “errori” le credenze
religiose dei primitivi. Al tempo stesso, tuttavia, è affascinato dal metodo comparativo e dagli
accostamenti che esso propone, nei quali vede un significato al di là degli obiettivi esplicativi che
Frazer assegna loro. Depurati dall’ipotesi evolutiva, tali accostamenti possono esser letti come
forme di “rappresentazione perspicua” (übersichtliche Darstellung), secondo il termine coniato
dallo stesso Wittgenstein: cioè modalità di presentazione dei materiali che lasciano emergere i loro
nessi interni attraverso la ricerca di anelli intermedi e rendono visibili le “somiglianze di famiglia”
che li accomunano. Il concetto di rappresentazione perspicua non è certo per Wittgenstein una
metodologia della ricerca sociale o della comparazione antropologica (si colloca invece, nella
riflessione del filosofo, nella dimensione della percezione estetica): tuttavia è un modo efficace per
pensare gli accostamenti comparativi di larga scala al di fuori del quadro esplicativo
dell’evoluzionismo o del diffusionismo. Se faccio notare la somiglianza fra un cerchio e un’ellisse,
dice Wittgenstein, non è per affermare che l’uno è nato dall’altro: o meglio, l’ipotesi evolutiva è
solo un modo di presentare i dati, di mostrare una loro relazione - che resta però una relazione
interna. E’ la relazione interna che fonda la plausibilità delle ipotesi esteriori di collegamento
(evoluzione, diffusione), non viceversa.
Sono queste “relazioni interne”, mi sembra di poter dire, che muovono la stessa ricerca di
Ginzburg, e che rappresentano un problema irrinunciabile per l’antropologia – che pure, come
conseguenza della critica agli eccessi del relativismo, si è a lungo interdetta la possibilità di
parlarne. E’ la “compattezza morfologica” dei materiali su cui lo storico lavora a suggerirgli ipotesi
di ricostruzione di nessi cronologici e geografici (“mi ero servito dell’indagine morfologica come di
una sonda, per scandagliare uno strato profondo altrimenti inattingibile”; ibid., p. xxx). Proprio per
reazione ai “limiti soffocanti” del funzionalismo contestualista, le scienze sociali contemporanee
ritengono dunque legittimo “riproporre alcune domande formulate da Frazer, senza accettarne le
risposte” (ibid., p. 184 nota). Questa linea d’indagine è complessa non solo per la delicatezza
metodologica, ma anche perché richiede una erudizione amplissime e di tipo interdisciplinare
(sempre più rara alla luce degli odierni processi formativi, inclini all’ultraspecialismo); la si trova
raramente praticata, e difficile è prevederne i futuri sviluppi.
2.6 [Comparazione e globalizzazione]
C’è un ultimo punto che mi sembra importante toccare. Comunque la si intenda, la comparazione
antropologica presuppone l’esistenza di entità culturali distinte e relativamente autonome, che cioè
esistono indipendentemente l’una dall’altra. La diversità è il dato iniziale, a partire dal quale si
possono operare raffronti per scoprire eventuali elementi di contatto, universali antropologici,
origini comuni nel tempo o nello spazio. Soprattutto la comparazione di tipo contestuale si basa sul
dogma dell’esistenza di un certo numero di unità culturali discrete e nettamente definite: si tratti
delle 4 culture di Ruth Benedict, o delle 186 su cui i coniugi Ember basano le loro generalizzazioni
statistiche su guerra e violenza, occorre che le unità di comparazione restino ben distinte e non si
confondano l’una con l’altra. Ora, nel dibattito antropologico degli ultimi decenni, questo concetto
di cultura come essenza esclusiva e distintiva di un popolo o di un gruppo sociale è stato posto
radicalmente in discussione. Le culture, si è detto, sono per certi versi invenzioni degli stessi
antropologi, che sono servite loro a introdurre cesure e discontinuità in quello che si può invece
definire il continuum delle differenze culturali. Questa sottolineatura della discontinuità poteva
almeno apparire plausibile quando i campi di studio dell’antropologia erano le remote isole
oceaniche, le riserve indiane, le cosiddette “tribù” africane, e piccoli gruppi umani relativamente
isolati e compatti; ma certo non lo è più nella moderna società globalizzata, in un mondo dalle
dimensioni ridotte in virtù delle tecnologie di comunicazione, con una circolazione senza precedenti
di persone, oggetti, idee. La dimensione antropologica della globalizzazione e le sue conseguenze
sulle concezioni classiche di cultura e di identità o appartenenza culturale sono al centro di un
ampio dibattito, cui non posso qui neppure accennare. Il problema che interessa è, semmai, che ne è
della comparazione tra culture se non vi sono più culture? Che aspetto può assumere la
comparazione antropologica nel villaggio globale?
Occorre rimarcare subito un punto. Contrariamente ad alcune sue semplicistiche letture, la
globalizzazione culturale non si presenta solo come un processo di omologazione che afferma una
monocultura mondiale (ad esempio quella occidentale o “capitalistica” promossa dai grandi mezzi
di comunicazione di massa) distruggendo al tempo stesso le differenze tradizionali. In parte ciò
avviene; ma al tempo stesso i processi di circolazione e le nuove potenzialità comunicative hanno
l’effetto di dar voce alle diversità culturali, di farne esplodere di nuove, di innescare una
molteplicità di processi di differenziazione. Molte culture “tradizionali”, ad esempio, hanno trovato
per mezzo del turismo o dei mass-media una nuova vitalità e nuovi motivi di valorizzazione e di
rivendicazioni distintive. Il villaggio globale sembra poter contenere molti mondi locali. Si dirà che
queste differenze sono “inautentiche” o di seconda mano rispetto a quelle tradizionali: ma sappiamo
oggi che la purezza e autenticità di queste ultime era stata esagerata dagli antropologi stessi. Le
differenze che percorrono la globalità, tuttavia, non si lasciano inquadrare facilmente all’interno di
insiemi omogenei e organici, e soprattutto non coincidono affatto con le classiche unità di analisi
antropologica (un territorio, un popolo, un linguaggio, una cultura): sono invece caleidoscopiche, si
intrecciano secondo percorsi inaspettati seguendo flussi migratori, mercati e mode culturali,
rivendicazioni politiche e religiose. Gli individui e i gruppi le mobilitano attivamente più che
subirle in modo passivo. Non è raro oggi trovare le culture tradizionali consapevolmente promosse
e seguite fra gruppi di immigrati dispersi nei più lontani paesi che non in madrepatria.
Quali sono dunque, in questa situazione, le unità di comparazione? La risposta è complessa, e
probabilmente variabile a seconda delle tematiche studiate. Si possono però indicare un paio di
elementi, che mi sembrano caratterizzare in generale le possibilità di procedure comparative
nell’antropologia del XXI secolo. Il primo punto, in sé banale, è che la comparazione dovrà
prendere in esame non tanto insiemi dati di differenze, quanto i processi della loro costituzione. Gli
individui o i gruppi sociali non possono più esser considerati come inerti “portatori” di cultura –
dunque “informatori”, come si era soliti definirli fino a non molto tempo fa; essi ne sono piuttosto i
creatori. Compito di una etnografia e di un’antropologia della contemporaneità è documentare
questi processi di creazione (talvolta è possibile farlo in tempo reale) e raffrontarne modalità e
risultati. Il secondo punto ci pone di fronte a una sorta di inversione rispetto alle procedure della
comparazione classica. Queste ultime partivano da differenze nettamente segnate, cercando di
risalire alla profondità di universali antropologici o, come si è detto, di origini comuni nello spazio
o nel tempo. Oggi partiamo dal dato di flussi culturali compatti che percorrono il mondo intero,
come quelli diffusi dai mass-media e dall’industria culturale, e da questa unitarietà dobbiamo
scoprire le modalità di costituzione delle differenze. Ad esempio, si può dire che in quasi tutto il
mondo il gioco del calcio ha soppiantato molti sport o giochi tradizionali; che, ugualmente, la
televisione e in particolare generi come soap operas, telenovelas o cartoons hanno soppiantato le
forme della tradizione orale, la fiabistica, la narrativa popolare. Dunque, una monocultura avrebbe
spazzato via una molteplicità di forme culturali locali, producendo una colossale omogeneizzazione
antropologica. Eppure, se ci poniamo sul piano della dettagliata osservazione etnografica, possiamo
accorgerci che il gioco del calcio, le soap operas o i film di Walt Disney si sono diffusi con
modalità assai disuguali, adattandosi ai contesti locali e agli specifici gruppi sociali che ne sono
praticanti o fruitori. La cultura di massa è una sorta di materia prima che si impone globalmente,
certo, ma che viene anche costantemente plasmata in modi peculiari, in nuove configurazioni di
differenze. Nella sua circolazione globale, si “indigenizza” in una molteplicità di usi e significati
locali.
Ho citato lo sport e la televisione perché negli ultimi anni sono stati al centro di una notevole
attenzione in prospettiva transculturale. Cosa significa vedere una soap opera, magari la stessa, in
paesi diversi o fra diversi gruppi sociali? Le contadine egiziane che guardano Beautiful vedono la
stessa cosa delle casalinghe americane o delle filippine emigrate in Europa come collaboratrici
domestiche? E cosa vede nelle telenovelas sudamericane l’appassionato pubblico dei paesi dell’Est
europeo? Il “testo” originario si fa strada verso i particolari spettatori filtrato da traduzione e
doppiaggio, dall’inserimento in diversi palinstesi, ma soprattutto dal contesto di fruizione e dal
background socioculturale degli spettatori stessi. E’ chiaro come si apra qui un grande terreno
comparativo che, come detto, procede in senso inverso rispetto al metodo comparativo classico:
laddove quest’ultimo ricercava il testo originario o archetipico sotteso alla disseminazione di storie
diverse, nello studio della cultura di massa si parte dal testo originario per scoprire
etnograficamente i modi in cui esso si scinde in molte storie diverse (Allen 1995).
E, se passiamo da un genere culturale prevalentemente femminile a uno prevalentemente
maschile, non racconta una infinità di storie anche la diffusione globale dello spettacolo calcistico?
Il gioco è indubbiamente lo stesso, con regole codificate da una Federazione internazionale, e una
platea globale di spettatori assiste in televisione ai grandi eventi come i campionati del mondo. Ma
le articolazioni culturali locali di questo sport globale sono numerosissime. Recenti pubblicazioni
sul tema, ad esempio, mettono a confronto contesti e “casi” diversi quali il culto argentino per
Maradona, la natura “multirazziale” del calcio in Brasile, il nesso fra calcio, politica e violenza
etnica in Camerun e Sierra Leone, il rapporto tra calcio e stregoneria in Tanzania, il rapporto tra
calcio e politiche identitarie in paesi come le isole Mauritius, Yemen, Malta, l’intreccio tra tifo
sportivo e dinamiche autonomiste in Irlanda del Nord e nei Paesi Baschi, e così via (ArmstrongGiulianotti 1997, 2001). Il metodo è anche qui quello dei case-studies: l’orizzonte comparativo fa
emergere da un lato gli aspetti di globalizzazione, per cui nessun contesto è mai chiuso
ermeticamente su se stesso, e d’altra parte la grandissima varietà di significati simbolici che il calcio
può prestarsi a veicolare in situazioni locali che non sono mai fotocopie l’una dell’altra.
Questi esempi, fra i tanti che si potrebbero citare, mostrano come la globalizzazione non cancelli
affatto le possibilità della comparazione antropologica, e apra anzi nuovi e stimolanti orizzonti. Si
noti che nei casi discussi ciò che viene analizzato e comparato non sono tanto i “testi” (la partita di
calcio o la soap-opera come “oggetti” culturali), quanto le pratiche della loro fruizione da parte di
persone e gruppi sociali specifici. Queste pratiche sono accessibili solo attraverso lo spessore opaco
e scarsamente formalizzabile della ricerca qualitativa, cioè dell’etnografia. Tutto ciò sembra
ulteriormente rafforzare le linee di tendenza che ho cercato di mostrare nel corso dell’intero
capitolo, e cioè che, da un lato, la pratica comparativa è e resta al centro dell’intera impresa
antropologica; dall’altro lato, che è sempre più improbabile la sua riduzione a un metodo unitario,
formalizzato, generalizzante. Abbandonate certe illusioni scientiste, la comparazione antropologica
del XXI secolo potrà riconoscere con maggior franchezza la sua natura di “acto de invención, un
procedimiento para imaginar que no dipenda da un catáclogo de reglas”; un atto che “viene de la
práctica, se aprende en ella, es un arte…No hay un modo de procedimiento sino toda una gama de
determinaciones concretas y vuelos de pensamiento que dan respuestas estratégicas a particulares
problemas” (Lisón Tolosana 2001, p. 22)
Riferimenti bibliografici
- Allen, Robert C., ed., 1995, To be continued…Soap Operas Around the World, London, Routledge
- Armostrong, Gary – Giulianotti, Richard, eds., 1997, Entering the Field. New Perspectives on
World Football, Oxford, Berg
- Armostrong, Gary – Giulianotti, Richard, eds., 2001, Fear and Loathing in World Football,
Oxford, Berg
- Benedict, Ruth, 1934, Patterns of Culture, New York, Mentor
- Boas, Franz, 1948 [1896], “The Limitations of the Comparative Method of Anthropology”, in F.
Boas, Race, Language and Culture, New York, MacMillan, pp. 271-304
- Borowski, Robert, “Enhancing the comparative perspective”, in R. Borowski, ed., Assessing
Cultural Anthropology, New York, McGraw-Hill, pp. 77-83
- Darwin, Charles, 1861, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, 3rd ed., London,
Murray
- Dei, Fabio, 2001, “Método mítico y comparación antropológica : Frazer y The Golden Bough
cien años después, in C.Lisón Tolosana (ed.), Antropología: Horizontes comparativos, Granada,
Editorial Universidad de Granada, pp. 39-65
- Dei, Fabio (a cura di), 2005, Antropologia della violenza, Roma Meltemi
Editorial Universidad de Granada, pp. 39-65
- De Martino, Ernesto, 1961, La terra del rimorso, Milano, Il Saggiatore
- Ember, Carol R. - Ember, Marvin, 1992, “Resource Unpredictability, Mistrust, and War. A Cross
Cultural Study”, Journal of Conflict Resolution, 36 (2), pp. 242-62
- Ember, Carol R. – Ember, Marvin, 1997, “Violence in the Ethnographic Record: Results of CrossCultural Research on War and Aggression”, in D.L. Martin, D.W. Frayer, eds., Troubled Times.
Violence and Warfare in the Past, Amsterdam, Gordon and Breach
- Fabian, Johannes, 1983, Time and the Other. How Anthropology Makes Its Object, New York,
Columbia University Press
- Fortes, Meyer, 1959, Oedipus and Job in West African Religion, Cambridge, Cambridge
University Press
- Frazer, James G., 1922, The Golden Bough. A Study in Magic and Religion, abridged ed., London,
MacMillan
- Geertz, Clifford, 1995, After the Fact. Two Countries, Four Decades, One Anthropologist,
Cambridge (Mass.), Harvard University Press
- Ginzburg, Carlo, 1989, Storia notturna. Una decifrazione del sabba, Torino, Einaudi
- Godbout, Jacques T., L’esprit du don, Paris, Éditions La Découverte
- Harris, Marvin, 1968, The Rise of Anthropological Theory. A History of Theories of Culture, New
York, Crowell
- Holy, Ladislav, 1987, “Description, Generalization and Comparison: Two Paradigms”, in L. Holy
(ed.), Comparative Anthropology, Oxford, Blackwell, pp. 1-21
- Kay, Paul, 2001, “Color”, in A. Duranti (ed.), Key Words in Language and Culture, Oxford,
Blackwell, pp. 52-7
- Kleinman, Arthur – Good, Byron, 1985, “Introduction: Culture and Depression”, in A.Kleinman –
B. Good, eds., Culture and Depression. Studies in the Anthropology and Cross-Cultural Psychiatry
of Affect and Disorder, Berkeley, University Of California Press, pp. 1-33.
- Kluckhohn, Clyde, 1949, Mirror for Man, New York, McGraw-Hill
- Lévi-Strauss, Claude, 1952, “Le père Noël supplicié”, Les Temps modernes, mars, 1573-1590
- Lévi-Strauss, Claude, 1962, La pensée sauvage, Paris, Plon
- Lévi-Strauss, Claude, 1964, Mythologiques 1. Le cru et le cuit, Paris, Plon
- Lisón Tolosana, Carmelo, 2001, “De Anthropologica comparatione”, in C. Lisón Tolosana, ed,
Antropología: Horizontes comparativos, Granada, Editorial Universida de Granada, pp. 9-22
- Malinowski, Bronislaw, 1922, Argonauts of Western Pacific, London, Routledge and Kegan Paul
- Malinowski, Bronislaw, 1927, The Father in Primitive Psychology, London, Kegan Paul
- Malinowski, Bronislaw, 1944, A Scientific Theory of Culture and Other Essays, Durham,
University of North Carolina Press
-Mauss, Marcel, 1924, “Essai sur le don, forme et raison de l’échange dans les sociétés
archaiques”, Année Sociologique, 1 (n.s.), 1923-24, poi in M.Mauss, Sociologie et anthropologie,
Paris, PUF, 1950
- Mead, Margaret, 1928, Coming of Age in Samoa, New York, William Morrow
- Nadel, Siegfried F., “Witchcraft in Four African Societies”, American Anthropologist, 54 (19; pp.
18-29
- Radcliffe-Brown, Alfred R., 1952, “The Comparative Method in Social Anthropology” (Huxley
Memorial Lecture 1951), Journal of the Royal Anthropological Institute, 81, pp. 15-22
- Remotti, Francesco, 1990, Noi, primitivi. Lo specchio dell’antropologia, Torino, Bollati
Boringhieri
- Van der Vjiver, F., 2002, “Cross-cultural research methods”, International Encyclopedia of the
Social and Behavioural Sciences, Amsterdam, Elsevier, vol. 2, pp. 2999-3003.
- Wittgenstein, Ludwig, 1967, “Bemerkungen uber Frazers The Golden Bough“, Synthese, XVII,
pp. 233-53
CAMMINARE SUL MARAE39 E LE SUE
CONSEGUENZE.
La ricerca sul campo e le esperienze straordinarie.
di Matteo Aria
(una versione di questo testo è pubblicata in C. Gallini, G. Satta, a cura di, Incontri etnografici.
Processi cognitivi e relazionali nella ricerca sul campo, Roma, Meltemi, 2007).
L’antropologo e le esperienze straordinarie
La ricerca sul campo e la conseguente immersione prolungata in un’“altra cultura” hanno talvolta
portato gli etnografi ad imbattersi in vicende, in narrazioni e in esperienze soggettive che sono
state definite come straordinarie (Young e Goulet 1994), anomale (Mcclenon e Nooney 2002) o
estatiche (Fabian 2001, Goulet 2007). I sogni, le visioni, le premonizioni e altre percezioni non
ordinarie di questo tipo hanno posto i ricercatori di fronte al rischio di veder messe in discussione
le proprie certezze epistemologiche, ontologiche e morali, ma al contempo hanno rappresentato per
alcuni un significativo momento di coinvolgimento e di trasformazione necessario per accedere ad
una comprensione più profonda della società studiata40 .
È in particolare a partire dai primi anni Settanta che, all’interno dei resoconti antropologici sulla
stregoneria e sulle pratiche rituali, si sono moltiplicate le testimonianze di studiosi che hanno avuto
accesso alle conoscenze condivise delle popolazioni indagate attraverso stati alterati di coscienza o
esperienze paranormali (Goodman 1972, Harner 1973, Myerhoff 1974, Laughlin-D'Aquili 1974,
Owen 1981). Come è emerso ancor più chiaramente nella letteratura prodotta negli anni successivi
(Favret Saada 1977, Peters 1981, Grindal 1983, Stoller e Olkes 1987, Jackson 1989, E.Turner
Blodgett, Kahona e Benwa 1992), non si tratta più di dar conto degli episodi straordinari raccontati
dai propri informatori e di individuare dei modelli funzionalisti, strutturalisti o simbolici che
permettono ad un osservatore, empatico ma distaccato, di spiegare le strane credenze ed esperienze
di un altra cultura. Gli antropologi non appaiono più “intoccabili”, né impermeabili a quello che
accade intorno a loro 41 . Iniziano invece a raccontare di aver visto con i propri occhi (Edith Turner
1994: 83) e soprattutto di aver sentito con il proprio corpo (Grindal 1983: 60) fenomeni
assolutamente incredibili o inspiegabili che sovvertono il proprio modo di concepire la realtà.
Che fare dinanzi a simili eventi, scioccanti e al contempo imbarazzanti? Come interpretarli? Quale
contributo possono dare alla conoscenza scientifica? In che modo influiscono sul rapporto tra
"soggetto" e "oggetto" della ricerca?
39
Il marae può essere sommariamente descritto come la tradizionale struttura in pietra all’aperto polinesiana dove
avvenivano, fino all’avvento del cristianesimo nei primi decenni dell’Ottocento, le pratiche cerimoniali di mediazione
tra il mondo degli uomini e quello degli dei.
40
All’inizio degli anni Settanta si sviluppano parallelamente i contributi antropologici allo studio degli stati alterati di
coscienza e dei fenomeni paranormali (Lang 1974, Angoff e Barth 1974 e Van de Castle1974).
41
Secondo Young l’antropologia è stata a lungo dominata da «un’attitudine imperialista che ha permesso agli
antropologi di descrivere serenamente le strane credenze ed esperienze dei loro informatori, ma di scioccarsi quando
sono colpiti da un esperienza straordinaria. Se sono i nativi che raccontano di vedere gli spiriti ciò viene accettato e
ordinato attraverso precisi schemi interpretativi che spiegano come tale narrazione rientri nella struttura della società
studiata. Se è invece l’antropologo a vederli tale esperienza non è considerata come un dato antropologico appropriato
e di conseguenza non è analizzata»(1994: 167).
Da un lato tali esperienze straordinarie possono essere considerate come episodi fortuiti, irripetibili
e incontrollabili che riguardano la sfera soggettiva e intima del ricercatore e dunque ininfluenti (o
perturbativi) al fine dell’elaborazione oggettiva dei dati e alla costruzione di una corretta
metodologia di ricerca. Da questo punto di vista porle all’interno dei resoconti etnografici si rivela
molto spesso non solo inutile, ma anche dannoso per il ricercatore che può essere indotto o a
concentrare troppo l’attenzione sul sé, allontanandosi inevitabilmente dalla comprensione
dell’alterità di cui vuol dar conto, o, viceversa, a rimanere intrappolato negli orizzonti culturali dei
soggetti studiati, perdendo così la propria vocazione specialistica.
Dall’altro lato si può invece ritenere necessario esplicitare le esperienze vissute e passarle al vaglio
della riflessione scientifica proprio perché costituiscono un elemento ineliminabile della ricerca
etnografica che permette di entrare in contatto con quelle parti più significative del sapere e del
discorso indigeni, altrimenti inaccessibili. Riconosciuta l’utilità dell’esperienza straordinaria e
coinvolgente si pone il problema di come giungere alla sua comprensione. L’antropologo può
allora scegliere di ricorrere alle proprie griglie concettuali capaci di spiegare le stranezze
dell’accaduto, oppure può sostenere che siano proprio queste esperienze a offrire dei validi banchi
di prova per allargare la propria consapevolezza dei limiti inerenti alle categorie analitiche con cui
osserva e giudica le culture aliene. Il mettersi in discussione non significa in questo caso
necessariamente abbandonare il proprio modo di ordinare la realtà, ma aprirsi (come direbbe
Winch) ad altre possibilità di dare senso al mondo.
In ogni caso, uno degli aspetti più problematici per l’etnografo che scelga di avventurarsi nel
campo delle esperienze straordinarie riguarda il ritorno a casa e il difficile e scomodo compito di
convincere gli altri che i propri resoconti sono accurati, veritieri e significativi per la disciplina.
Come hanno fatto notare Young e Goulet (1994: 8), il ricercatore, sia che decida di «sopprimere
l’esperienza straordinaria, minimizzando la minaccia», sia che l’accetti come valida, trasformando
i propri schemi intellettuali, può decidere – e ciò si verifica nella maggior parte dei casi - di non
raccontare agli altri ciò che è accaduto. La scelta prevalente del non dire e la rinuncia a mettersi
pubblicamente in discussione sono dovute, a loro avviso, «alla paura dell’ostracismo», ossia al
timore di andare incontro alle severe critiche dei propri colleghi, propensi a giudicare le vicende
narrate come meri prodotti dell’immaginazione soggettiva e dunque privi di qualunque valore
conoscitivo scientifico. Tale preoccupazione è ancor più giustificata se non si possiedono gli
strumenti che permettono di padroneggiare ciò che è stato vissuto e di tradurlo “in modo credibile”
ad una comunità accademica tradizionalmente diffidente e scettica. È stato, però, lo stesso
ostracismo, così ben radicato nella disciplina, che ha a lungo impedito una seria e approfondita
analisi critica di simili fenomeni straordinari e di conseguenza l’elaborazione di un corpus coerente
di concetti specifici per affrontarli in modo adeguato. L’antropologia ha, infatti, tradizionalmente
giudicato con sospetto questo tipo di esperienze, perché, come hanno sostenuto Stoller e Olkes
(1987: IX-XII) e Tedlock (1991: 71-72), le ha ritenute responsabili di una possibile deriva verso
«le credenze superstiziose della mente» che porta a rigettare la ragione e la conoscenza scientifica,
e ad aprirsi al peggior rischio in cui il ricercatore occidentale può imbattersi: il farsi nativo. La
diffidenza si è ulteriormente acutizzata all’inizio degli anni Settanta in reazione alle finzioni
letterarie di Carlos Castaneda (Grindal 1983: 78) e al diffondersi di orientamenti controculturali
che hanno romanticamente assunto l’incontro etnografico come apertura al sacro e all’alterità
radicale (Dei 1996: 357). Le rappresentazioni etnografiche che hanno insistito sulle esperienze
straordinarie sono state così a maggior ragione considerate come non scientifiche e relegate ai
margini della disciplina. A tale “ostracismo si accompagna la consolidata propensione
dell’antropologia a mettere fra parentesi la soggettività per perseguire un distacco oggettivante in
grado di trasformare l'esperienza in dato. Da questo punto di vista tutte le narrazioni personali
dell’etnografo, e non solo quelle straordinarie, sono state giudicate come non necessarie,
autoindulgenti, banali se non addirittura eretiche (Pratt 1986: 31), proprio perché tradizionalmente
l’etnografia è il resoconto degli altri e delle loro visioni del loro mondo. Di conseguenza, sono
state a lungo omesse dai resoconti etnografici, o comunque ricondotte ad una dimensione
soggettiva della ricerca, rigidamente separata dal piano oggettivo dei dati.
Sono stati, però, gli importanti ripensamenti critici introdotti dall’antropologia interpretativa e
dialogica che, capovolgendo le impostazioni classiche e concedendo agli aspetti autobiografici
della ricerca sul campo un ruolo fondamentale nella costruzione del sapere etnografico, hanno
offerto agli studi sulle esperienze straordinarie nuove possibilità teoriche e metodologiche.
“L’ermeneutica del comportamento” vs l’antropologia dell’esperienza
Lo scandalo seguito alla pubblicazione dei diari di campo di Malinowski ha influenzato ha
contribuito ad aprire, come è noto, un fecondo dibattito epistemologico sulla natura della
comprensione antropologica, che ha spinto gli antropologi a porre maggiore attenzione al rapporto
tra i dati e l’esperienza soggettiva compiuta sul campo e a ritenere la soggettività non tanto un
impaccio da cui liberarsi quanto una delle condizioni necessarie per la conoscenza etnografica. I
primi anni Ottanta, con le riflessioni critiche avviate da Writing Culture, hanno segnato in questo
senso un momento particolarmente significativo nel panorama degli studi anglosassoni che ha
visto emergere, all’interno di un comune orientamento ermeneutico, due differenti modi
d’intendere la ricerca sul campo e la complicata relazione tra l’immedesimarsi e il comprendere. È,
infatti, con la pubblicazione del volume The Anthropology of Experience curato da Bruner e
Turner (1986) che si è resa più evidente la distinzione tra la prospettiva interpretativa e “anti
empatica” di Clifford Geertz, e quella “esperenziale” e partecipativa di Victor Turner.
Per il primo, di fronte al «venir meno dell’einfuhlen» - così come testimoniato dai diari di
Malinowski - ma pressati dalla costante necessità di «rimanere fedeli all’ingiunzione di vedere le
cose dal punto di vista dei nativi» (1988: 74), gli antropologi possono ugualmente arrivare al
verstehen se si sbarazzano delle suggestioni magiche del mettersi nella pelle degli altri, esaltate
invece dall’empatia (1986: 373 e 1988: 74). A suo avviso non possiamo vivere la vita degli altri
popoli, né tanto meno percepire quello che loro percepiscono. Ne consegue che non si giunge alla
comprensione antropologica introducendosi nelle coscienze dei propri interlocutori, ma solo
attraverso l’analisi delle loro espressioni (1986: 373), ascoltando e interpretando cosa ci
raccontano della propria vita. Geertz ci rivela che «il trucco sta nel capire cosa loro pensano di
stare facendo» e non nell’immaginare di essere qualcun altro per poi analizzare cosa si pensa.
Occorre invece ricercare e analizzare le forme simboliche – parole, immagini, istituzioni,
comportamenti - nei termini in cui le persone si rappresentano a se stesse e agli altri (1988: 75). Il
suo è così un invito a non immedesimarsi, a «non entrare in una sintonia di spirito troppo stretta
con il proprio informatore», ad assumere una “giusta distanza” – «restare nascosti ai margini del
bosco per osservare ciò che accade» (2005: 13-14), - per poter ottenere una conoscenza
significativa della realtà che s’intende investigare.. L’astenersi dal partecipare, il rimanere sulla
soglia, permette a Geertz di sostenere, nel suo intervento che chiude The anthropology of
Esperience, l’idea di un “ermeneutica del comportamento”, che, come ha fatto notare Bruner
(1986: 4), presuppone di assumere proprio la prospettiva dell’osservatore esterno che descrive e
interpreta le azioni di qualcun altro.
Turner, invece, ispirandosi al concetto diltheyano di Erlebnis, propone una antropologia
dell’esperienza centrata sullo studio non solo delle rappresentazioni e dei testi, ma soprattutto delle
pratiche e delle performance, da realizzarsi attraverso la condivisione dell’azione, strumento
indispensabile per la sua comprensione 42 .
42
Brumer (1986), ripercorrendo il pensiero di Dilthey, ha sottolineato come una condizione insuperabile risiede nel
fatto che si può fare esperienza della propria vita, ma non possiamo mai conoscere completamente quelle degli altri.
Per trascendere i limiti dell’esperienza, che è individuale, occorre interpretare e comprendere le espressioni: le
rappresentazioni, le performance, le oggettivazioni e i testi. Le espressioni vengono definite da Brumer come
incapsulamenti dell’esperienza degli altri e da Turner come secrezioni cristallizzate delle esperienze della vita umana.
A loro avviso comprendiamo le espressioni degli altri popoli sulla base della nostra esperienza e della nostra
autocomprensione. La comprensione presuppone l’esperienza che è culturalmente costruita.
Pur consapevole dei limiti dell’esperienza - irriducibilmente individuale - e dell’impossibilità di
vivere la vita degli altri, Turner ritiene che l’etnografo non si debba limitare a intervistare le
persone al di fuori del contesto rituale o pratico in cui sono implicati o a studiarne i comportamenti
come uno spettatore che assiste ad una rappresentazione. Pensa invece che per giungere al
significato di certe pratiche sia indispensabile prendervi parte insieme ai suoi attori ed accedere a
quella esperienza emotiva, cognitiva e intersoggettiva di coinvolgimento che caratterizza il teatro
come il rituale 43 . È nel contesto del partecipare insieme ai propri interlocutori, di essere nel mezzo
alle attività sociali messe in scena, che l’etnografo è costretto aprirsi a dimensioni esistenziali
diverse da quelle che gli sono più familiari, sospendendo per quanto possibile i propri
condizionamenti culturali e le proprie nozioni di ciò che è reale e razionale (1985:205). Così
facendo, ci si allontana dalla concezione dell’etnografia come osservazione (Fabian 1979: 26) e si
abbraccia quella della partecipazione che permette al ricercatore, resosi totalmente vulnerabile non
solo all’impatto con un’altra cultura, ma anche alle intricate esistenze di coloro che sono stati
assunti a oggetto di studio, di giungere ad una conoscenza mentale e sensoriale di ciò che
realmente accade intorno a lui e agli altri (Turner 1985: 205). In determinate situazioni la
conoscenza etnografica sembra così possibile solo grazie alla partecipazione radicale e alla
“vulnerabilità” e non attraverso la distanza e il distacco.
Le posizioni teoriche a cui giunge l’antropologia dell’esperienza turneriana si ritrovano nelle
ricerche degli anni Settanta di Favret-Saada (1977), che costituiscono un altro fondamentale punto
di riferimento per i successivi studi sulle esperienze straordinarie. Alla luce delle sue esperienze di
campo sulla stregoneria nel Bocage (Normandia), l’etnologa francese ritiene che l’unico modo per
giungere alla comprensione di certe pratiche e di certe credenze segrete e sotterranee, sia quello di
diventarne protagonista in prima persona, subendo tutti gli effetti che questo comporta. È solo
dopo essere stata stregata, e successivamente adottata come “antistregona” capace di togliere il
male, che Favret-Saada, trasformatasi in informatrice di se stessa, riesce ad accedere a
quell’insieme di conoscenze di cui i nativi non parlano e che gli scienziati sociali non sono in
grado di cogliere. La confortevole e sicura postura dell’etnografo che come osservatore esterno
cerca di vedere le cose dal punto di vista dei nativi, è in questo caso impossibile. Nel mondo della
stregoneria del Bocage, infatti, «parlare non è mai per informare» (1977: 26) perchè la parola non
è sapere, ma è sempre potere, ed «è letteralmente incredibile informare un etnografo, ossia
qualcuno che assicura di non voler fare alcun uso di queste parole che riceve» (1977: 26). Per
questo, «quando la parola è la guerra, è necessario praticare un’altra etnografia» (1977: 30)
Occorre allora situarsi all’interno del discorso magico, viverlo sul proprio corpo ed essere così in
grado di cercare dentro di sé quei significati altrimenti inaccessibili.
Queste nuove prospettive testimoniano ciò che Tedlock ha definito come «lo slittamento
dall’osservazione partecipante all’osservazione della partecipazione» (1991: 69), a cui si
accompagna una riformulazione della visione classica della ricerca sul campo come iniziazione.
Teorizzare la necessità di un’apertura soggettiva a forme di esperienza radicalmente aliena, per
poter sentire – e quindi comprendere - ciò che gli altri sentono e vivono, implica l’ineluttabilità
della profonda trasformazione – “l’essere cambiato da” - a cui il ricercatore va incontro durante il
suo lavoro sul campo. La conoscenza etnografica diviene possibile solo se si è capaci di passare
attraverso le tre fasi tipiche di ogni rito di passaggio: l’abbandono iniziale del proprio ruolo di
antropologo, la susseguente immersione totalizzante in un altro sistema di vita (la stregoneria), e il
conclusivo (e non sempre facile) ritorno, attraverso il racconto della propria esperienza in un libro
di antropologia.
Antropologia dell’esperienza straordinaria: dallo straordinario all’estasi
I contributi di Turner e di Favret-Saada hanno consentito alla riflessione antropologica sulle
esperienze straordinarie di acquisire una nuova legittimità e di dotarsi di validi strumenti
43
Come hanno mostrato Goulet e Miller (2007), in questa prospettiva è implicita l’idea che il corpo diventi
estremamente significativo nell’interazione con gli altri.
concettuali che hanno permesso di superare le intemperie e gli imbarazzi provocati dall’“effetto
Castaneda”. È, infatti, a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta che si viene
progressivamente affermando, all’interno dell’antropologia nordamericana, una nuova corrente di
studi denominata Experiential Approach (o antropologia dell’esperienza straordinaria), impegnata
a comprendere, a interpretare e ad analizzare scientificamente le esperienze straordinarie narrate
dagli informatori o vissute direttamente dagli stessi ricercatori. In questo spazio epistemologico i
sogni, le visioni e altri fenomeni inspiegabili, vengono considerati come dati reali indispensabili
alla conoscenza antropologica e non come prodotti dell’immaginazione e delle credenze
irrazionali. Di conseguenza, non solo non vengono più omessi dai resoconti etnografici ma, come
attestano i lavori di Peters (1981) sull’estasi e la guarigione in Nepal, di Stoller e Olkes (1987)
sulla stregoneria Songhai, di Lederman (1991) sullo sciamanismo malese e di E. Turner –
Blodgett - Kahona e Benwa (1992) sulla guarigione in Africa, diventano i punti privilegiati per
accedere alla cultura altra.
Nel 1994, la pubblicazione del volume Being changed by cross-cultural encounter. The
anthropology of extraodinary experience, curato da Young e Goulet, ha permesso di compattare e
rendere visibile l’ampia letteratura sulle esperienze non ordinarie, e di elaborare un quadro teorico
e metodologico adeguato a collocarle all’interno della riflessione antropologica.
Le prospettive che emergono sono varie e disuguali in quanto a serietà e spessore. In alcuni
interventi si manifesta in modo esplicito la forte disposizione dell'antropologo a provare
un'esperienza straordinaria, che spesso viene attivamente ricercata nel quadro di interessi più
esistenziali che scientifici. Come commenta Dei, «si ha così spesso l'impressione, che le visioni
narrate (non diversamente dai prototipi di Castaneda) appartengano più al contesto della cultura
psichedelica della West Coast che non a quello delle culture tradizionali a cui fanno riferimento»
(1996: ). I curatori del libro, invece, impegnati a definire cosa si debba intendere per “esperienze
straordinarie” 44 , non hanno solo cercato di far chiarezza sui possibili fraintendimenti
terminologici, distanziandosi da facili ingenuità misticheggianti e da scorciatoie irrazionalistiche 45 ,
ma hanno anche messo in evidenza i giudizi dogmatici e le categorie etnocentriche con cui sono
state spiegate le “verità degli altri”. Secondo Young e Goulet (1994) le visioni e i fenomeni
anomali che possono prendere forma negli incontri transculturali, permettono all’etnografo sia di
costruire delle rilevanti interazioni sociali con i popoli studiati, sia di accedere ad un differente
modo di percepire la realtà e di sviluppare una nuova consapevolezza critica delle proprie griglie
interpretative. A loro avviso lo sconvolgimento che si attua in questi momenti spesso drammatici,
se accettato e vissuto fino in fondo, porta il ricercatore sul campo a mettere in discussione la
nozione stessa di realtà, così com’è stata teorizzata [all’interno delle scienze sociali] dalla
tradizione scientifica occidentale e ad aprirsi a nuove visioni che si avvicinano «all’idea di realtà
multiple così com’è stata formulata da Mead, Schutz, e Goodman» (1994: 9). Tale teoria
fenomenologica (Schutz 1967), riletta dai curatori in modo talvolta troppo riduttivo e semplicistico
rispetto alla sua complessità, non implica che la realtà stessa sia multi-dimensionale, ma che se ne
possa fare esperienza in modi differenti, che dipendono dal tempo, dallo spazio e dalle circostanze.
Le esperienze straordinarie riportate nel libro, come vedere gli spiriti (E.Turner), partecipare ad un
rituale di possessione, acquisire i poteri di uno sciamano (Guédon 1994), assistere alla
riapparizione di un morto (Goulet 1994), non significano per Young e Goulet entrare in contatto
con un’altra dimensione della realtà, ma aprirsi a aspetti precedentemente ignorati o repressi.
L’esperienza straordinaria, infatti, non è altro che il normale risultato di una attiva partecipazione
alle performance rituali e sociali attraverso cui le realtà sono generate o costituite.
44
I curatori precisano che il concetto stesso di esperienze straordinarie è un concetto situato e relativo allo sguardo
dell’osservatore occidentale, dato che in molte delle società studiate tali esperienze sono considerate ordinarie
45
Secondo Goulet e Young i fenomeni in questione non devono essere definiti come paranormali o soprannaturali,
perchè tali espressioni portano con sé una distinzione tra ciò che è reale tra ciò che è reale e ciò che non lo è, tra ciò che
è normale e ciò che è anormale, che tende ad allontanare il tema trattato da ogni seria considerazione intellettuale
All’interno di questo orientamento condiviso, confluiscono posizioni che interpretano gli stati
alterati di coscienza, i sogni e le visioni verificatesi nella relazione etnografica in modo
differente 46 . Per Edith Turner (1992, 1994 e 1996), come per Stoller e Olkes (1987: 229), la via da
seguire è quella di accettare il racconto nativo di ciò che è accaduto e far proprie le credenze e i
fenomeni che il nostro sistema di conoscenza considera ridicoli. D’Aquili (1979) e Laughlin
(1994), ritengono invece che per spiegarli in modo soddisfacente sia indispensabile ricorrere al
linguaggio e alle categorie scientifiche attraverso un nuovo modello neurologico che definiscono
come lo strutturalismo bioenergetico. Altri ancora (Obeyesekere 1990, Young 1994, Coffey 1999
...) si schierano su posizioni intermedie sostenendo che gli antropologi dovrebbero prendere sul
serio questo tipo di esperienze senza però limitarsi alle spiegazioni date dai nativi. Secondo questa
prospettiva, le posizioni come quelle di Stoller e Olkes si rivelano incapaci di distinguere
l’esperienza dalla struttura interpretativa al cui interno acquisisce il suo significato. Ciò non
significa, però, rigettare i fenomeni e le esperienze narrate dagli altri o vissute dagli antropologi.
Per riuscire ad essere «uno con loro e non uno di loro» (Obeyesekere 1990: 11) 47 , occorre
abbandonare temporaneamente l’incredulità, seguire i resoconti delle esperienze straordinarie e le
spiegazioni che ne vengono date, e infine collocarli in connessioni illuminanti con quelli che
Geertz ha definito come concetti lontani dall’esperienza 48 .
Per Goulet (1994:) e per Yuong (1994: 191), tuttavia, il metodo ermeneutico di tradurre i
significati da un sistema ad un altro non è di per sé sufficiente per realizzare una buona etnografia.
A loro avviso, infatti, le impostazioni interpretative ed etnometodologiche, teorizzando la necessità
di un distanziamento dai soggetti studiati, precludono la possibilità di considerare come dati validi
alcune esperienze straordinarie che permettono invece «l’istaurarsi di un piano comune tra le
proprie visioni scientifiche del mondo e quelle di coloro che vedono la realtà in modo differente»
(Young 1994:191). Goulet sostiene a questo proposito che l’etnografo, oltre a seguire la pratica
turneriana della “partecipazione radicale”, deve rivelare ai suoi interlocutori i propri sogni e le
proprie esperienze straordinarie, prestando attenzione alle interpretazioni che gli vengono offerte.
Questo perchè gli studiosi immersi in una società e in un linguaggio altro dal proprio, possono
iniziare a sognare e a pensare attraverso i simboli e le categorie della cultura in cui si sono venuti a
situare. La narrazione di queste vicende personali e la discussione con gli attori locali permette
così di accedere ad una più profonda comprensione di alcuni aspetti significativi della cultura in
cui si è immerso.
Negli ultimi anni all’interno dell’antropologia dello straordinario si è assistito a quello che può
essere definito come un progressivo slittamento dallo straordinario all’estatico, in cui si stempera
l’interesse per gli interrogativi e le spiegazioni di ordine fenomenologico e al contempo si attenua
la preoccupazione di superare l’ostracismo accademico nei confronti delle esperienze straordinarie.
Allontanandosi dalle suggestioni e dagli imbarazzi delle etnografie «appartenenti al genere
apprendista stregone» (Marcus e Fischer 1986: 136) e vinto il rischio di farsi nativi, la riflessione si
è spostata sui prerequisiti che consentono la conoscenza etnografica. Partendo dalla ormai
consolidata certezza epistemologica che l’autobiografia è una condizione dell’obbiettività
etnografica, intesa come frutto dell’interazione tra l’antropologo e i suoi interlocutori (Fabian
2000) 49 , si è concessa maggiore attenzione agli impatti esercitati sul ricercatore dai contesti sociali,
46
Mcclenon e Nooney (2002), passando in rassegna quaranta esperienze anomale riportante da sedici antropologi,
hanno messo in evidenza l’esistenza di tre differenti tipi di reazioni a questi eventi: la razionalizzazione, la
razionalizzazione parziale e, in ultimo, il suo rifiuto che implica l’accettazione delle spiegazioni paranormali.
47
Analogamente Obeyesekere ha sostenuto che si comincia a comprendere un’altra cultura non in base ai dati
accumulati, ma quando è si è in grado di relazionarsi dialogicamente con propri informatori, «in modo tale che le loro
azioni diventino per me comprensibili come le mie per loro» (199: 226).
48
Young (1994: 191-192) a questo proposito sostiene la necessità d’individuare dei meta-modelli in grado di
comprendere le visioni degli informatori e quelle di un pubblico scientifico
49
Barth è stato tra i primi ha sottolineare come la permanenza prolungata sul campo produca non solo osservazioni ma
anche concettualizzazioni e intuizioni che sono una creazione a più mani realizzata dagli antropologi e dai loro
interlocutori nel processo di interazione (1992: 65)
politici, ed economici in cui si viene a trovare. Soffermare lo sguardo su questi aspetti porta a
rendere più comprensibili i processi conoscitivi e le circostanze in cui divengono operativi 50 .
Fabian è stato il primo a sostenere come «nella maggior parte dei casi la ricerca etnografica esprima
il meglio di sé quando siamo fuori dalla nostra mente, quando ci lasciamo andare e dimentichiamo i
nostri impegni di ricerca. [...] In breve c’è un lato estatico della ricerca sul campo che dovrebbe
essere annoverato tra le condizioni necessarie alla produzione della conoscenza» (2001: 31).
Secondo tale prospettiva il ricercatore sperimenta questo lato estatico nel momento in cui, messa da
parte temporaneamente la tensione a ottenere i dati che si era prefissato, si apre alla possibilità di
entrare profondamente nel mondo in cui è ospitato 51 . Come sostengono Goulet e Miller, è attraverso
questi cruciali momenti esperienziali che si rende possibile la comprensione antropologica, perché
si ridefiniscono le relazioni con gli altri, si approfondiscono le proprie abilità a interagire con loro in
modo più significativo e si sollevano importanti quesiti epistemologici e ontologici (2007: 3) 52 .
Secondo questo punto di vista la conoscenza sembra dover [necessariamente] passare attraverso
delle fasi liminali, che comportano il momentaneo abbandono della postura razionale e distaccata
dell’osservatore per abbracciare la prospettiva del “conoscere attraverso il perdersi”. Per Fabian,
l’estasi come l’empatia, la comunicazione e il dialogo, allo stesso modo dell’età, del genere, della
classe sociale e delle relazioni di potere, devono essere tenuti in considerazione quando riflettiamo
criticamente su ciò che ci permette di comprendere gli altri nel momento in cui interagiamo con loro
(2000: 280). L’estasi non deve essere intesa come un comportamento irrazionale, erratico e
d’evasione perchè, come precisa, «non è un tipo di comportamento che si adotta, ma una qualità
dell’azione e dell’interazione umana che crea un terreno comune per l’incontro con l’altro» (2000:
8). Non rappresenta così un ostacolo alla produzione etnografica, ma ne costituisce il suo
prerequisito fondamentale. È la condizione, suggeriscono Goulet e Miller, che ci permette di
avventurarci nel viaggio etnografico, trasportandoci in territori incerti e facendoci entrare realmente
in un’altra forma di vita. Il suo valore epistemologico è realmente colto quando scopriamo, mentre
ci abbandoniamo, che siamo anche in grado di elaborare impreviste abilità di fare esperienza della
realtà. L’estasi non è il contrario logico e teoretico del controllo, ma diventa la sua negazione
pragmatica ed esistenziale (Goulet e Miller 2007: 8).
Alla luce di ciò, gli etnografi esperenziali si sforzano di scrivere i resoconti delle loro esperienze
personali sul campo, non solo cercando di evitare l’accusa di essere narcisisti e di ricevere il
rimprovero dei nativi: “Basta parlare di te, parliamo di me”, ma muovendo nuovamente delle
precise critiche alla posture distanzianti dell’antropologia interpretativa geertziana.
Per Goulet e Miller tale prospettiva, nell’associare «il muoversi tra gli altri in modo furtivo per
evitare di essere scoperti» con l’obiettività scientifica o la chiarezza interpretativa – come emerge, a
loro avviso, più volte nell’opera di Geertz (1971 e 2005) -, sottende non solo il controllo di sé ma
anche degli altri. È una metodologia in cui il ricercatore guarda sempre dall’esterno, attraverso
procedure che impediscono la condivisione di esperienze. Di conseguenza la domanda da porsi è
quale tipo di conoscenza si realizza se si resta così lontano dagli altri? Quale tipo di racconto
proverrà dagli intervistati che parlano a qualcuno che non ha esperienza? Rifacendosi a Turner e
contrapponendolo a Geertz, Goulet e Miller ritengono che gli antropologi esperenziali debbano
invece riflettere sulle conoscenze che si producono partecipando attivamente alle performance in
atto. L’esperienza non è fine a se stessa, ma è vista come strumento che permette di apprendere
direttamente ciò di cui la gente parla quando descrive la propria esperienza vissuta. Imparare
50
Come sinonimo di parte estatica della ricerca sul campo viene utilizzato il termine di partecipazione radicale al
mondo degli altri, che implica l’adozione delle prospettive epistemologiche ed etiche dei nativi come strumenti
indispensabili di conoscenza.
51
Un concetto non troppo dissimile da quello espresso da Fabian può essere ritrovato anche nella nozione di
“perduzione” di Piasere (2002: 56).
52
In modo analogo, Amanda Coffey (1999, 33) ritiene che l’esclusione dai resoconti etnografici delle intuizioni
raggiunte attraverso la parte estatica della ricerca sul campo è infondata e dannosa per lo sviluppo della disciplina.
significa necessariamente partecipare - non solo ascoltando e parlando ma anche agendo insieme - e
trasformarsi (2007: 8).
Camminare sul marae
Alla luce di questa ampia letteratura – di cui in questa sede ho potuto dar conto solo in modo
parziale - e degli interrogativi emersi vorrei tornare a riflettere su una delle vicende non
propriamente ordinarie che hanno segnato la mia ricerca sul campo e soprattutto le successive
scelte di scrittura 53 .
All’inizio del settembre del 1999 ebbi l’opportunità di soggiornare in Polinesia Francese come
skipper a bordo di un cabinato di quindici metri. Un gruppo di charteristi l’aveva noleggiato per
veleggiare tra le lagune dell’Arcipelago della Società. Dopo ventuno giorni di lavoro, decisi di
fermarmi per una settimana di vacanza e di riposo tra Raiatea e Tahaa. Al tempo, a parte le
caratteristiche nautiche e meteorologiche, e la letteratura sui vagabondi dei mari del Sud,
conoscevo pochissimo della Polinesia Francese, anche perché le mie ricerche antropologiche si
erano fino ad allora svolte in Africa 54 . Insieme a Chiara, che con me aveva condiviso le fatiche e le
gioie del lungo charter, decisi di visitare l’isola con lo scopo di giungere fino al marae di
Taputapuatea, che ci era stato descritto da più parti come un grande cumulo di pietre privo di
fascino. Questo genere d’informazioni così pessimistiche rispecchiano bene quel senso comune
condiviso da molti “occidentali”, secondo cui la Polinesia è meravigliosa per i suoi tramonti, per le
sue acque cristalline e per l’ospitalità degli abitanti, ma è anche altrettanto vuota e triste per
“l’assenza di cultura” e di memoria, e perché, a parte qualche riedizione buona solo per i turisti in
viaggio di nozze, tutto quel passato, che aveva invitato alla fuga molti artisti, scrittori e
vagabondi 55 , sembra essere andato irrimediabilmente perduto. Di “vero” e di “autentico” non
resterebbe più niente e il viaggio a Taputapuatea ne sarebbe stata una conferma.
Grazie ad un passaggio offertoci dal postino dell’isola, raggiungemmo velocemente il marae. Lo
scenario era assai desolante. Camminai a lungo sulle pietre delle differenti piattaforme, convinto di
trovarmi di fronte ad un luogo “vuoto”, “senza vita”, senza pathos. Se a quel tempo avessi letto
Les Immémoriaux di Segalen o gli scritti di Buck sui “Vichinghi del Pacifico”, avrei pianto anch’io
su queste mute rovine, per un passato forse glorioso, ma sicuramente irrimediabilmente perduto.
Tornati nella piccola pensione dove alloggiavamo, decidemmo di fare un’escursione sul fiume
circostante e raccogliemmo dei fiori di zucca, i frutti dell’albero del pane (uru) e altri ortaggi con
cui preparammo la cena. Ero contento sia della giornata passata che delle settimane precedenti,
trascorse a destreggiarmi tra i groppi tropicali e i pericoli della barriera corallina, assaporando le
gioie di una navigazione a lungo desiderata. Questo quadro così idilliaco fu turbato
improvvisamente da un crescente disagio che avvertii pochi minuti dopo aver finito di mangiare.
Cominciai, infatti, a sentirmi male, senza riuscire a capire cosa mi stesse succedendo. La testa fu
inaspettatamente avvolta in tristi e tormentati pensieri, che man mano si fecero sempre più
devastanti, tanto da non riuscire più ad arginarli. Avevo la sensazione che quello stato non fosse
passeggero: non ne comprendevo le ragioni, ma contemporaneamente ero ossessionato dal timore
che non ne sarei più uscito. A nulla valsero i tentativi di Chiara di tranquillizzarmi, anzi avevo
l’impressione che le sue mani protese verso di me diventassero sempre più grandi e più nere.
Tralascio la descrizione delle mie successive fasi allucinatorie. Ricordo che con gran fatica riuscii
a addormentarmi. La mattina seguente le mie condizioni continuavano ad essere molto precarie.
Ero perseguitato da pensieri ricorrenti, spesso senza senso. Uno in particolare non mi dava tregua:
«Se mi si presenta un testimone di Geova alla porta di casa, cosa devo fare? Dedicargli tempo e
53
Il racconto che qui presento fa parte del libro........
Tra il 1995 e il 1997 avevo condotto delle ricerche sui pescatori Nzema del Ghana Sud-Occidentale, all’interno della
Missione Etnologica Italiana in Ghana, guidata dal Professor Mariano Pavanello.
55
Melville, Gauguin e Brel, per citare, in ordine cronologico, solo alcuni dei più noti.
54
ascolto, permettendogli di entrare in casa, oppure sbarazzarmene velocemente con le classiche
frasi del caso?».
Sorpreso e stremato dalla ricorrenza di questo strano e incessante ritornello mentale, mi diressi
insieme a Chiara alla banchina del porto, per imbarcarci alla volta di Tahaa e far visita a Madame
Taipo, una rubiconda ed espansiva coltivatrice di vaniglia che abitava nel distretto di Haamene e
che si era offerta di ospitarci per alcuni giorni. Appena sbarcati ci incamminammo lungo una
strada sterrata e polverosa, dove per più di un’ora non incontrammo alcuna macchina, finché
comparve, in senso opposto alla nostra direzione, un camioncino che distribuiva alcuni generi
alimentari. Al volante c’era una giovane donna polinesiana, che, avvicinatasi, ci chiese dove
fossimo diretti. Saputo il nostro itinerario, ci disse che Madame Taipo era sua cugina e si offrì di
accompagnarci. Iniziammo una lunga e vivace conversazione, che ebbe però una brusca
interruzione quando le raccontai dell’escursione fatta il giorno precedente a Taputapuatea e della
mia camminata sulle pietre del marae. La donna fermò di colpo il furgone, mi guardò, mi chiese se
stessi bene e se la notte avessi avuto dei problemi. Non potei che rivelarle le vicende della sera
prima e il mio persistente stato confusionale. La cugina di Madame Taipo mi disse, preoccupata,
che non solo non si doveva andare a Taputapuatea da soli, ma che soprattutto non si poteva
camminare sul marae, perché era un luogo tutt’altro che morto e abbandonato. Era invece un luogo
tapu, “carico di mana”, che molto probabilmente “si era impossessato di me” 56 . Aggiunse, inoltre,
che una delle manifestazioni di questo «stato di possessione» era rappresentata sia dai «deliri
mentali», sia dalle visioni di grandi mani nere. Era assolutamente necessario che per tre giorni di
seguito facessi delle abluzioni con dell’acqua dove erano state fatte bollire delle foglie di ti’ 57 .
Questo era l’unico modo per purificarmi e per “staccarmi” dal mana, altrimenti le conseguenze
avrebbero potuto essere terribili.
Arrivati a destinazione, Madame Taipo, informata immediatamente dalla cugina dell’accaduto, si
preoccupò di andare a cogliere le foglie necessarie e nei giorni successivi preparò le infusioni
affinché mi potessi «liberare dal mana di Taputapuatea». Strano a dirsi, ma la donna che ci aveva
dato queste precise indicazioni per proteggermi dai possibili effetti nefasti del mana, era una
Testimone di Geova 58 . Da allora cominciai a parlare dell’accaduto alle persone con cui riuscii a
stabilire delle relazioni. Cercai di approfondire le vicende che mi erano capitate, domandando cosa
mi potesse essere successo, se fosse vero che non si doveva camminare sul marae e se, oltre ai
bagni con gli infusi di ti’, fosse necessario fare qualcos’altro. Le mie indagini non proseguirono a
lungo perché, di lì a qualche giorno, rientrai in Italia.
Negli anni successivi la Polinesia, il marae di Taputapuatea, il mana e i tapu rimasero un ricordo
opaco di qualcosa che avevo lasciato incompiuto, fino a quando vinsi un dottorato in Scienze
antropologiche e analisi dei mutamenti culturali all’Università di Napoli l’Orientale. Approfittai
dell’occasione per elaborare un progetto di ricerca sulla relazione tra il turismo e la tradizione nella
rivalorizzazione del marae di Taputapuatea. In veste di antropologo, potei così tornare a Tahiti e a
56
Nella società tradizionale tahitiana i concetti di mana e di tapu erano elaborati all’interno del sistema di controllo
politico e sociale, di cui parlerò più avanti. Entrambi continuano oggi ad essere frequentemente utilizzati, trascinando
con sé, come ha osservato Levy, anche i significati di un tempo: «Il mana è qualcosa che viene usato oggi per designare
il potere o l’autorità personale. Può significare potere secolare, come il mana del governo territoriale, o essere legato ad
un potere soprannaturale: il mana che permette ad un uomo d’influenzare gli spiriti. Gli effetti nefasti prodotti da
un’infrazione o violazione di un tapu, come l’attraversamento di un confine interdetto, sono ritenuti spesso derivanti dal
mana» (1973: 158). In realtà, a suo avviso, anche se il mana di una persona o di un oggetto è spesso indicato come il
responsabile immediato di determinate malattie e sciagure, vi è frequentemente la consapevolezza che alle sue spalle
siano individuabili gli spiriti degli antenati o quelli legati ad un luogo particolare. Levy attesta, inoltre, come persista e
sia molto diffusa la convinzione che la violazione degli antichi luoghi sacri, il loro inadeguato rispetto, come il
“disturbare” le pietre antiche, producano sanzioni soprannaturali inevitabili.
57
Il ti’ (cordyline fruticosa) è una pianta dalle larghe foglie verdi (o rosso-verdi) diffusa in tutto il Pacifico, dalle
Hawaii, alla Cina fino alla Papua Nuova Guinea. Generalmente è fatta crescere intorno alle case e ai luoghi di culto.
58
Come ho potuto constare nella mia ricerca sul campo, i testimoni di Geova, come gli Avventisti del Settimo Giorno,
sono, tra le numerose congregazioni cristiane presenti, le più intransigenti nei confronti sia degli antichi culti e dei
costumi pre-europei, sia della loro recente riscoperta, dietro a cui vedono celarsi il ritorno di Satana.
Raiatea nel settembre del 2003. La narrazione della camminata sul marae e delle sue conseguenze
divennero uno degli elementi che caratterizzarono lo strutturarsi della relazione etnografica.
Gli studi a Parigi e a Londra mi avevano reso consapevole dell’importanza del marae di
Taputapuatea non solo per le isole della Polinesia Francese, ma anche per tutti gli arcipelaghi di
quello che nel Pacifico è conosciuto come il grande triangolo polinesiano 59 . Il suo carattere
internazionale è dovuto al fatto di essere narrato e vissuto come la mitica Hawaiki, grande madre
di tutte le isole, la terra di origine della grande migrazione dei popoli polinesiani, il luogo da cui
tutti partirono. Dopo un lungo periodo di abbandono, seguito ai contatti con gli europei e alla
conversione al cristianesimo nei primi decenni dell’Ottocento, nel 1995 il marae di Taputapuatea
fu di nuovo immaginato come una stella che orientava gli itinerari e guidava i pellegrinaggi alle
sorgenti dei Maori della Nuova Zelanda, degli Hawaiani e dei Polinesiani delle Isole Cook e di
Rapa Nui. In quell’anno, infatti, da queste isole – mete dell’emigrazione di un tempo – una nuova
generazione di navigatori attraversò, a bordo delle proprie piroghe tradizionali, il Grande Oceano
per ritornare a Taputapuatea e partecipare ad una cerimonia che doveva segnare la ritrovata unità
di tutti i popoli dispersi del grande triangolo polinesiano. Per riflettere su questo evento, e più in
generale per approfondire il tema del recupero delle tradizioni, decisi di incontrare Raymond
Graffe, conosciuto non solo come uno dei principali protagonisti della riscoperta del passato, ma
anche per aver svolto un ruolo decisivo nella manifestazione del 1995. In tale occasione si era,
infatti, assunto il compito di togliere i tapu – che da tempo immemorabile impedivano a tutti i
popoli partiti da Taputapuatea di ritornare – rendendo così possibile lo svolgersi della cerimonia.
Durante la prima conversazione che ebbi con lui al Service du Patrimoine et de la Culture di
Tahiti, oltre a presentargli gli intenti della mia ricerca, gli raccontai quello che mi era accaduto
quattro anni prima a Taputapuatea. Gli precisai come quelle vicende avessero rappresentato per me
una delle spinte iniziali per comprendere e per conoscere i marae, il mana, i tapu e coloro che vi si
relazionavano.
Da principio Graffe si mostrò perplesso perché, come mi disse, «sono tanti i turisti e gli
Occidentali che ci camminano sopra senza che gli sia successo niente. I problemi di solito
riguardano le donne, che non devono attraversarlo». Cambiò, poi, atteggiamento e cominciò a
pormi molte domande. Mi chiese se prima di andare a Taputapuatea avessi visitato qualche altro
marae. Vi avevo camminato a torso nudo? A che ora era accaduto? Quali piattaforme avevo
attraversato? Ero salito sull’ahu? Mi accompagnava una guida tahitiana? Avevo litigato con
qualcuno? Avevo detto o pensato qualcosa di cattivo?
Di fronte alla mia memoria frammentaria, imprecisa e opaca, e ai miei molti “non ricordo”, Graffe
mi domandò se il giorno dopo ero disposto ad andare con lui davanti al mare «a fare una cosa
insieme». Gli risposi che sarei partito per Raiatea il pomeriggio stesso e che non potevo rimandare
il viaggio. Graffe mi suggerì allora di ritornare a Taputapuatea, cercando di ri-camminare negli
stessi luoghi dove ero stato quattro anni addietro. Prima di compiere questa azione, però, sarei
dovuto andare sulla spiaggia davanti al marae per:
Raccogliere dei fiori dagli alberi, che crescono lì nei pressi, da offrire allo squalo, il dio dell’Oceano. Devi
restare lì davanti senza immergerti, ma ripensando al percorso che avevi fatto e a tutti i cattivi pensieri di
allora. A quel punto devi entrare in acqua immergendoti completamente, anche con la testa, donando al dio
dell’Oceano, insieme ai fiori, tutto quello che è accaduto quel giorno.
Dovevo poi uscire dall’acqua senza voltare le spalle al mare e quindi ricamminare sul marae.
Graffe non mi dette spiegazioni su quello che mi era accaduto, né io gliele chiesi, ma rimasi un po’
perplesso riguardo alle pratiche cerimoniali che mi aveva suggerito. Mi imbarcai il pomeriggio
stesso sul cargo Vaeanu, che tre volte alla settimana collega Tahiti con le Isole Sottovento 60 , alla
59
Tale rappresentazione mitica ha ai vertici le Hawaii, la Nuova Zelanda e Rapa Nui (l’isola di Pasqua), e al centro
Raiatea e le Isole della Società.
60
Nella parte occidentale, tra i 15° e i 18° di latitudine Sud e i 148° e i 154° di longitudine Ovest, l’arcipelago delle
Isole della Società, dove ho condotto le mie ricerche, è composto da quattordici isole (di cui sei disabitate), divise a loro
volta tra le cinque isole Sopravvento (Moorea, Tahiti, Mehetia, Maiao e Tetiaroa) e, a settecento chilometri più a Nord
volta di Raiatea, dove giunsi poco prima dell’alba del giorno successivo. Sulla banchina del porto
cominciai a scambiare alcune parole con una coppia di tahitiani, Malona e Anne Marie Teura,
anch’essi scesi dal Vaeanu e diretti a Tahaa, dove abitavano. La conversazione si fece ben presto
molto intensa e Malona mi disse di essere un indipendentista, sostenitore di Oscar Temaru 61 , ma
allo stesso tempo di aver fatto il militare per diciotto anni nei reparti d’assalto della Marina
Militare Francese. Aveva poi deciso, nel 1993, di andare anticipatamente in pensione per accudire
la mamma malata e tornare a vivere nella sua terra a Faaaha 62 . Aveva costruito la propria casa su
quello che definì come il marae école, dove Hiro, l’eroe leggendario, il grande navigatore, il
fondatore di Taputapuatea, era cresciuto e aveva appreso tutte le sue infinite conoscenze e astuzie.
Conosciuti i motivi della mia ricerca e la storia della mia camminata a Taputapuatea, Malona, con
uno sguardo severo a lui assai abituale, mi invitò ad andare per un po’ di tempo ospite loro nella
valle di Faaaha. Quando gli raccontai dei suggerimenti fornitemi da Raymond Graffe, mi disse che
lo conosceva bene, ma le sue indicazioni non avevano alcun peso perché:
Graffe è uno di Tahiti e ha il potere solo sui marae che sono laggiù. Su Taputapuatea non ha alcuna
autorità. Se devi fare qualcosa a Taputapuatea è necessario che sia qualcuno di là a guidarti.
Questo incontro fu l’inizio di un’amicizia importante e profonda che orientò, poi, gran parte delle
mie ricerche. Trascorsi, infatti, molto tempo, durante la mia permanenza alle Isole Sottovento,
insieme a Malona e alla sua famiglia, nelle terre dove coltivano la vaniglia, i cocchi e “il rapporto
con gli antenati”. La mia permanenza nella valle fu segnata da sogni e visioni (v. Aria 2007, pp.
255-308) e dalle successive interpretazioni e narrazioni di Malona che mi permisero di addentrarmi
nell’universo dei tapu, degli animali protettori e uccisori, dei marae di adorazione e dei loro spiriti
guardiani altrimenti inaccessibile.
Fu invece Jean Mere che, pochi giorni prima della mia partenza da Raiatea, mi accompagnò e mi
guidò a Taputapuatea per ripercorrere insieme la camminata di un tempo. Lo incontrai la prima
volta al comune di Avera, dove mi ero recato per presentarmi ufficialmente al sindaco e ai suoi
collaboratori, dopo che il Ministero della Cultura aveva annunciato, via fax, la mia presenza
sull’isola. Conosciuti i motivi della mia visita, decise di trasferirsi in un’altra stanza, dove
cominciammo a discutere. Jean mi paragonò ad un’anziana donna francese, protagonista con le sue
visioni e con i suoi viaggi ipnotici delle recenti scoperte di alcuni marae della valle alle spalle di
Taputapuatea, e a Jérôme, uno svizzero trentaseienne, che da circa un anno si era trasferito a vivere
a Raiatea ed era impegnato a creare l’associazione internazionale Le Monde Sacré, carica di visioni
fortemente influenzate dalla mistica new age. Jean Mere affermò, infatti:
Sono delle persone come la “metropolitana”, come Jérôme e come te, che hanno dei legami. Forse in
un’altra vita siete stati polinesiani. Questa è la forza che vi spinge a cercare le radici. È bizzarro che avete
ricevuto delle cose, nonostante non siate di qua. Ci sono delle persone per cui è facile. È come se fossero
state scelte per ricevere. L’ambizione che avete è forte. Forte in voi è la volontà di conoscere la cultura
polinesiana, come se fosse qualcosa che è già in voi, ma avete bisogno delle persone che vi aiutino a
sentire, che vi guidino. Oggi ci sono molti metropolitani 63 europei che vengono per conoscere, perché
hanno avuto delle sensazioni. Ne ho conosciuti molti quando facevo la guida al marae di Taputapuatea, che
mi hanno detto che erano venuti a Raiatea per conoscere questo marae, perché avevano avuto queste
sensazioni.
Mi spiegò, però, che «non sempre quello che accade è positivo, anzi spesso si verificano delle
tragedie perché Taputapuatea è allo stesso tempo un luogo fortemente interdetto e inaccessibile in
molte sue parti a chi viene da fuori, siano essi originari dei distretti e delle isole vicine, o
dell’Europa».
Ovest, le nove isole Sottovento (Tahaa, Raiatea, Bora Bora, Huahine, Maupiti, Tupai, Maupihaa, motu one e Manuale),
dove “sopra” e “sotto” sono riferiti alla propria posizione rispetto direzione del vento prevalente sud-orientale.
61
Oscar Temaru, leader del partito indipendentista della Polinesia Francese Tavini Huiraatira, è dal 2004 il presidente
del governo della Polinesia Francese.
62
Faaaha è uno dei distretti dell’isola di Tahaa.
63
Il termine metropolitano è impiegato generalmente dagli abitanti di queste isole per definire i francesi che non sono
residenti in Polinesia Francese, ma che vi giungono per restare solo un periodo limitato.
Dopo avermi narrato alcune tristi vicende accadute agli stranieri che non avevano rispettato il
marae, Jean tornò a parlare del nostro incontro, dicendomi:
Quando sei arrivato ho avuto una sensazione, per questo sono venuto verso di te e ti ho accompagnato. Io
non racconto a tutti, non dico niente a coloro che utilizzano queste conoscenze per la propria gloria. Spesso,
ci sono dei momenti in cui la gente viene e io non riesco a dire, a far uscire niente. Non è perché non
voglio, ma perché non me la sento. Se non mi esce niente... io sono un po’ superstizioso, allora vuol dire
che gli antenati non vogliono condividere con le persone che ho davanti. Con te non è stato così.
Senza che gli ponessi alcuna domanda, iniziò allora a parlarmi di tutti i marae della valle di Opoa e
della storia di Taputapuatea. Alla fine del suo lungo racconto disse che sarebbe stato necessario
tornare insieme al marae di Taputapuatea e che mi avrebbe aiutato nelle mie ricerche. Dopo quel
primo incontro ci rivedemmo molte volte e l’ultima domenica della mia permanenza sull’isola
ripercorremmo insieme i luoghi su cui avevo incautamente camminato quattro anni prima.
Al termine del nostro lungo “pellegrinaggio”, Jean mi disse: «Sei stato accettato e questo vuol dire
che farai un buon uso di ciò che hai appreso, altrimenti ci sarebbero stati dei segni contrari».
Dovevo così interpretare le conseguenze della camminata del 1999 come un segno che ero stato
scelto e che avevo una missione da compiere: «I nostri antenati hanno voluto mettersi in contatto
con te perché tu parli, perché tu diffonda, come è accaduto a me».
Di tutt’altro avviso fu invece Tavana Salmon, il grande rivale di Graffe nella gestione della messa
in scena della antica cultura ma’ohi, che conobbi nella sua casa, costruita su dei pali di fronte al
mare, a pochi chilometri dal distretto di Papara (nell’isola di Tahiti). Il nostro primo incontro
s’incentro prevalentemente sulle menzogne che, a suo dire, caratterizzavano costantemente
l’operato di Raymond Graffe, e che si ripresentavano anche nelle azioni riparatrici che mi aveva
consigliato di svolgere a Taputapuatea. Mi disse, però, che «il marae Taputapuatea è veramente
pericoloso ed è interdetto camminarci sopra, ma se non sei polinesiano, non è grave. I Tahitiani
dopo essere stati sul marae di solito si buttano in mare per purificarsi, per impedire di essere
attaccati» e per potersi così separare dal mondo degli spiriti con cui sono entrati in contatto. Per
sottolineare la gravità dell’infrazione di certi tapu sul camminare, aggiunse: «Alle Hawaii nessuno
può entrare liberamente nel marae. Tutti i marae sono restaurati e le persone che vi si avvicinano
non possono mangiare un panino se non ad un chilometro di distanza. Sono pieni di targhe e di
cartelli con scritto: vietato». I marae, a suo avviso, non erano solo dei luoghi tuttora viventi, ma
erano anche molto pericolosi:
I più potenti e cattivi sono quelli di Tahaa e di Maupiti. Io li rispetto, so che quando mi avvicino ad un
luogo molto sacro c’è qualcosa che mi avverte e mi allontano. Io so parlare loro, so come donare le offerte
ai marae e quello che c’è da espiare. Quando un tauh’a consacra il marae e la grande pietra viene messa
sopra. Le persone e i tauh’a allora dicono: “Tutto resta là!” Che vuol dire che lo spirito e il potere sono
sempre là, che vanno sempre nutriti e che è molto pericoloso.
Nonostante la potenza del marae di Taputapuatea, Tavana Salmon mi disse: «Non penso che ti sei
ammalato a causa del marae, altrimenti lo vedevo subito». Tra quello che mi era successo e la mia
passeggiata sul marae, non poteva esserci una relazione, perché, nonostante fosse proibito
camminare su quelle pietre, che erano tutt’altro che un mucchio di vecchi sassi, «il tauh’a tahitiano
non può uccidere i missionari, solo lo stregone bianco può uccidere i bianchi, solo lo stregone
maori può tatuare o uccidere i maori, e così vale anche per te, ed è per questo che ti dico che non ti
puoi essere ammalato a causa di questa cosa. Hai pensato così, ma ti sei sbagliato». A differenza di
ciò che aveva sostenuto Jean Mere, secondo Tavana Salmon il mana dei marae era radicato in un
luogo specifico e trasmetteva i suoi effetti solo a coloro che vi appartenevano. Chi invece era hotu
painù, cioè straniero, non ne poteva «essere toccato».
Le mie esperienze non ordinarie vissute a Raiatea e a Tahaa mi hanno così spinto a entrare in una
“forma di vita” e a cercare di comprenderne le regole, agendo al contempo sulla mia percezione
del mondo e- analogamente a quanto indicato da Goulet e Miller (2007)- coinvolgendomi
direttamente attraverso il corpo, la mente e i sogni. Se, come ha osservato Rosaldo in sintonia con
gli antropologi esperenziali precedentemente trattati, «rifarsi alla propria esperienza personale
come categoria analitica, significa correre il rischio di vedere rifiutate le proprie affermazioni»
(1989: 49), nel mio caso il timore era di apparire immerso in una sorta di egocentrismo mistico e
iniziatico o di esibire un ipersoggettivismo sterile e incapace di prendere distanza (da me e dagli
altri) e quindi di comprendere Da questo punto di vista la paura dell’ostracismo evocata da Young
e Goulet (1994) ha condizionato a lungo le mie riflessioni su cosa poteva essere lecito dire e
scrivere. La scelta dell’epormi e del raccontare è stata presa, però, senza conoscere l’abbondante
letteratura sulle esperienze straordinarie, ma con la consapevolezza che la narrazione della
camminata sul marae poteva essere interpretata come uno strumento performativo che mi aveva
permesso di costruire e di vivere dei legami, a volte conflittuali e altre volte empatici, con coloro
con cui avevo condiviso gran parte della mia esperienza di ricerca. Attraverso di essa si sono
stabiliti “tratti d’immedesimazione” indispensabili alla comprensione reciproca e alla conoscenza
di quelle realtà altrui, che, in alcuni casi, mi hanno portato a scontrarmi con le parti della storia e
della cultura che generalmente “non possono uscire”, che non possono essere mostrate e che sono
state, al contempo, seppellite dalla dilagante convinzione che le tradizioni siano andate perdute per
sempre. Allo stesso tempo le reazioni e le interazioni prodotte dal racconto e “dentro di esso” sono
state tra loro assai diverse. Ne sono emersi differenti modi d’interpretarmi, di accogliermi e di
spiegarmi, che non solo rispecchiano le specifiche strade intraprese da ciascuno dei miei
interlocutori nel recuperare il proprio passato e nel relazionarsi con gli stranieri, ma che attestano
anche la lotta per legittimare la propria autorità di parola e di posizione.
Tutto ciò riflette infine l’interesse della mia ricerca, volta a dar voce alle politiche e alle poetiche
dei celebri senza memoria, che sono stati a lungo ignorati dagli studiosi perché ritenuti eredi
“impuri” di quel passato “autentico” che avrebbero dimenticato per sempre.
Le “mie esperienze straordinarie” mi hanno consentito di entrare in un universo di significati e di
seguire il percorso narrativo e retorico che ha permesso a Malona Teura, Raymond Graffe e Jean
Mere di riscoprire il proprio rapporto con gli antenati. Da questo punto di vista il racconto della
camminata sul marae ha rappresentato una strategia performativa e teatrale da me messa in atto per
costruire una relazione, per comprendere e per immergermi nei modi con cui gli stessi Malona
Teura, Raymond Graffe e Jean Mere danno ordine e senso al mondo e alla vita (Winch 1964, p.
154).
BIBLIOGRAFIA
Coffey, A.
1999 The Ethnographic self. Fieldwork and the Representation of Identity, London, Sage.
D'Aquili, E. G. et al.
1979 The spectrum of ritual, New York, Columbia University Press.
Dei, F.
1996 Antropologia dell’esperienza straordinaria, AM rivista della Società Italiana di antropologia
medica, 1, pp.355-360.
Fabian,
2001 Ethnographic Objectivity Revisited: From Rigor to Vigor,
Favret-Saada, J.
1977 Le mots, la mort, les sorts. La sorcellerie dans le Bocage, Paris, Gallimard.
Fernandez, J.
1991 "Afterword. The study of divination", in P.M. Beck (ed.), African divination
systems. Ways of knowing, Bloomington, Indiana University Press; 213-21.
Geertz, C.
1986 Making Experience, Authoring Selves. In: Turner, V.; Bruner, E. . The Anthropology of
Experience. Urbana, University of Illinois Press, 1986: 373-380.
Grindal, B.T.
1983 "Into the heart of Sisala experience: witnessing death divination, Journal of
Anthropological Research, 39 (1): 60-80
Harner, M.J.
1973 Hallucinogens and shamanism, New York, Oxford University Press
Laughlin, C. D. - D'Aquili, E.G.
1974 Biogenetic structuralism, New York, Columbia University Press
Laughlin, C. D.
1994 "Psychic energy and transpersonal experience: A biogenetic structural account
of the Tibetan Dumo yoga practice", in Young-Goulet 1994: 99-134.
Lederman, C.
1991 Taming the wind of desire: Psichology, medicine, and aesthetics in Malay
shamanistic performance, Berkeley, University of California Press.
Marcus e Fischer
1986 Anthropology as Cultural Critique, Chicago, Chicago University Press
Myerhoff, B.G.
1972 The Peyote Hunt. The sacred journey of the Huichol indians, Ithaca, Cornell
University Press.
Obeyesekere, G
1990 The Work of the Culture. Symbolic Transformation in Psycoanalysis and Anthropology,
Chicago, The University of Chicago Press.
Peters, L
1981 Ecstasy and Healing in Nepal, Malibu, Undena
Schutz, A.
1967 La fenomenologia del mondo sociale, trad. It. Bologna, Il Mulino
Stoller, P.
1989 Fusion of Worlds: An Ethnography of Possession among the Songhay of Niger,
Chicago, Chicago University Press.
Stoller, P. - Olkes, C.
1987 In Sorcery's Shadow. A Memoir of Apprenticeship Among the Songhay of Niger,
Chicago and London, University of Chicago Press.
Tedlock, B.
1991 From Participant Observation to the Observation of Participation: The Emergence
of Narrative Ethnography, Journal of Anthropological Research, Vol. 47, No. 1, pp. 69-94.
Tedlock, D.
1990 Days from a dream almanac, Urbana, University of Illinois Press.
Turner, E.
1994 "A visible spirit form in Zambia", in Young-Goulet 1994: 71-95.
Turner, V.
1985 On the edge of the bush: Anthropology as experience, Tucson, University of Arizona Press
Young, D. E. - Goulet, J.-G. (eds.)
1994 Being changed by cross-cultural encounters. The anthropology of
extraordinary experience, Peterborough, Canada, Broadview Press
Winch, P.
1964 “Comprendere una società primitiva”, trad. it. in F. Dei, A.Simonicca, a cura di, Ragione e
forme di vita, Milano, Angeli, 1990.
ORIENTAMENTI ANTROPOLOGICI
NELLO STUDIO DELLA MEMORIA.
(edito in Novecento, 10, 2004 [2005], pp. 27-46)
0. Premessa
In questo articolo cercherò di rispondere all’invito di “Novecento” a riflettere sullo stato degli
studi riguardanti la memoria nell’antropologia e nelle scienze sociali, e su come, attorno al nodo
della memoria, si possa ripensare oggi il rapporto di queste discipline con la storia. E’ un compito
particolarmente gradito ma anche difficile, per almeno due motivi. Il primo riguarda la grande
proliferazione di studi su questo tema nel recente dibattito internazionale: una quantità e una varietà
che rendono difficile costruire un quadro bibliografico e una mappa degli indirizzi teorici e di
ricerca di qualche sistematicità. Il secondo motivo riguarda il fatto che, in molti lavori
contemporanei sulla memoria, si perdono quasi completamente i tradizionali confini delle
discipline: gli apporti della psicologia, dell’antropologia o della sociologia, della storia, come
vedremo, si fondono fino a risultare non più distinguibili. Soprattutto quando in discussione sono
concetti quali memoria sociale o culturale, non ha molto senso pensare di affrontarli dal punto di
vista dell’antropologia, piuttosto che da quello della storia o di altre scienze umane: e tuttavia, ciò
significa che per comprenderli occorre confrontarsi con intere, e spesso molto ampie, tradizioni
disciplinari.
In questa sede, mi pare utile proporre una rassegna di indirizzi di studio e di orientamenti
bibliografici, con la segnalazione di alcuni temi rilevanti emersi nel recente dibattito internazionale
– senza alcuna pretesa, è superfluo specificarlo, di completezza. Inizierò dalla constatazione che,
nel dibattito sulla memoria nella seconda metà del Novecento, due acquisizioni sono
progressivamente emerse come centrali. In primo luogo, il riconoscimento che la memoria non è un
singolo e specifico fenomeno o facoltà psichica: al contrario, in ciò che noi comunemente
intendiamo per memoria, si intrecciano processi, individuali e sociali, di tipo diverso e non
riconducibili a unità. In secondo luogo, uno spazio sempre maggiore è stato assegnato dalla ricerca
alla dimensione sociale e culturale della memoria, più che a quella puramente individuale; per
meglio dire, a partire almeno dall’opera di Maurice Halbwachs, si è cercato di mostrare come anche
i processi individuali di memoria siano inevitabilmente plasmati da una dimensione “collettiva” e
abbiano a che fare non solo con eventi psichici ma anche con pratiche (comportamenti e discorsi)
situate nello spazio delle relazioni e delle istituzioni pubbliche.
1. Sistemi di memoria.
Occorre intanto delimitare come oggetto di analisi storica e antropologica la memoria a lungo
termine, i cui meccanismi di funzionamento sembrano del tutto diversi da quella a breve termine.
Con quest’ultima espressione gli psicologi intendono la capacità di richiamare informazioni appena
assunte nel giro di pochi secondi. La psicologia cognitiva ha elaborato modelli piuttosto complessi
di funzionamento della memoria a breve termine: in particolare, essa viene a sua volta distinta da
una memoria a brevissimo termine, o memoria sensoriale, consistente nella capacità immediata di
gestione degli stimoli esterni, i quali divengono memoria a breve termine solo quando siano stati
selezionati dall’attenzione. Memoria sensoriale e memoria a breve termine sarebbero ricomprese,
secondo una diversa terminologia, nella memoria di lavoro, costituita, secondo le teorie di A.D.
Baddeley 64 , da una “centrale esecutiva” con funzioni di direzione dell’attenzione e da due
“servosistemi”, un circuito fonologico (dove sono trattate le informazioni linguistiche) e un blocco
per appunti spazio-visuale (per l’immagazzinamento e il trattamento dell’informazione visuale e
64
A.D. Baddeley, La memoria di lavoro, trad. it. Milano, Cortina, 1990 (ed. orig. 1986) ; Id., La memoria umana.
Teoria e pratica, trad. it. Bologna, Il Mulino, 1992 (ed. orig. 1990)
sensoriale). E’ interessante notare la tendenza – più propriamente, la necessità – di descrivere tali
meccanismi cognitivi per mezzo di metafore tratte dall’ambito delle pratiche sociali: la memoria
come attività di immagazzinamento sembra la metafora portante della teoria degli anni ’60, il
“centro di controllo” connesso a servosistemi specifici si afferma successivamente, mentre dagli
anni ’80-’90 diviene dominante il linguaggio della programmazione informatica.
Il concetto di memoria a lungo termine indica invece la capacità di ritenere informazioni per un
tempo superiore ai pochi secondi che caratterizzano la memoria di lavoro. Si è soliti suddividere la
memoria a lungo termine, sulla base dei lavori di E. Tulving65 , in tre diversi sistemi: la memoria
procedurale, quella semantica e quella episodica. La prima consiste in capacità o competenze
incorporate, che operano quasi sempre in modo implicito e che spesso non sono facilmente
verbalizzabili. Molte attività basate su tecniche del corpo, dallo svolgere determinati lavori,
all’andare in bicicletta, al digitare sulla tastiera di un computer, presuppongono una memoria di
questo tipo, che viene acquisita in modo lento e progressivo e che difficilmente, o comunque in
tempi assai lunghi, può esser dimenticata. Si tratta di una componente fondamentale del concetto
antropologico di cultura, se è vero, come scrive Paul Connerton, che la nostra esistenza sociale ha
una natura “essenzialmente corporea” 66 .
La memoria semantica consiste nel nostro sapere generale sul mondo, e contiene sia una
“enciclopedia”, sia i segni e le regole che permettono l’uso e la comprensione del linguaggio. Come
afferma Tulving, essa “registra non le proprietà percettive degli stimoli, ma piuttosto i loro referenti
cognitivi” 67 . La memoria episodica, infine, registra eventi o episodi, collocabili con relativa
precisione in termini spazio-temporali, di cui il soggetto ha avuto esperienza. Per questo nesso con
l’esperienza diretta, viene talvolta definita memoria personale o autobiografica – anche se è un
problema controverso nella psicologia cognitiva se memoria episodica e autobiografica siano
coestensive: vi sono infatti in quest’ultima elementi non strettamente episodici e, d’altra parte, non
tutte le fonti della memoria episodica risalgono a reali esperienze biografiche.
Memoria semantica ed episodica sono congiuntamente definite anche come memoria dichiarativa,
in quanto mirano a rappresentare il mondo o il passato – in contrapposizione alla memoria abituale
o procedurale, che rappresenta il requisito di abilità pratiche e non ha obiettivi rappresentativi. La
prima aspira alla verità ed è di solito formulabile verbalmente, la seconda aspira all’efficacia e,
come detto, è di solito incorporata in tecniche del corpo di cui non si ha consapevolezza linguistica.
Parzialmente sovrapposta alla distinzione dichiarativa-procedurale è quella tra memoria esplicita e
implicita. Quest’ultimo concetto è stato introdotto dalla psicologia sperimentale per dar conto di
quei casi in cui si è influenzati da un’esperienza passata senza essere consapevoli di ricordare (come
negli esperimenti sul priming, in cui l’apprendimento di certi stimoli risulta migliore quando vi sia
stata una precedente esposizione, non ricordata esplicitamente, a quegli stessi stimoli). La memoria
implicita riguarda non solo abilità procedurali incorporate, ma anche episodi e stimoli verbali,
iconici, sensoriali: il lavoro con persone colpite da amnesia suggerisce trattarsi di un sistema
mnestico che funziona in modo indipendente da quello della memoria esplicita 68 .
Rientra in quest’ambito problematico anche il concetto di memoria involontaria, coniato, com’è
noto, da Marcel Proust a proposito del celebre episodio della madeleine che apre La ricerca del
tempo perduto: uno stimolo, in questo caso gustativo, che apre improvvisamente un intero scenario
di ricordi dimenticati, con un forte alone affettivo e l’immediata associazione a immagini e a
65
E. Tulving, “Episodic and semantic memory” in E. Tulving, D. Donaldson (eds.), The Organization of memory, 1972;
E. Tulving, Elements of episodic memory, Oxford University Press, 1983. Com’è stato notato, questa tripartizione
ricalca quella stabilita dalla filosofia di inizio secolo tra memoria abituale o operativa, memoria proposizionale e
memoria dei ricordi; v. John Sutton, “Memory”, in Stanford Encyclopedia of Phylosophy, 2003,
66
Paul Connerton, Come le società ricordano, trad. it. Roma, Armando, 1999 (ed. orig. 1989), p. 89
67
Tulving, “Episodic and semantic memory”, cit., p. 386
68
Daniel L. Schachter, Alla ricerca della memoria. Il cervello, la mente e il passato, trad. it. Torino, Einaudi, 2001 (ed.
orig. 1996), p. 169 sgg.
luoghi 69 . La psicologia sperimentale rivolge invece scarsa attenzione al tema psicoanalitico del
rimosso. La psicoanalisi, in effetti, problematizza non tanto le modalità cognitive di acquisizione
della memoria, quanto le dinamiche psichiche che consentono o impediscono l’accesso alla
memoria, oppure consentono un accesso in forme oblique e distorte; oppure, ancora, producono
“fantasie”, cioè ricordi di episodi non realmente accaduti. Si tratta di una cornice che rende il
rapporto col passato assai più complesso e mediato rispetto al modello dell’immagazzinamento e
recupero di informazioni.
2. Memoria come processo interpretativo.
Questi modelli di sistemi di memoria elaborati dalla psicologia sperimentale sono per lo più basati
sulla “misurazione” di performance mnemoniche in situazioni controllate di laboratorio, secondo
una metodologia che si fa risalire allo psicologo tedesco Hermann Ebbinghaus. Lavorando a cavallo
tra Ottocento e Novecento, quest’ultimo ideò un metodo di studio del lavoro della memoria
consistente nella ripetizione di sillabe senza senso da parte di soggetti individuali – con l’obiettivo
di isolare il funzionamento della memoria “pura” da “contaminazioni” di ordine contestuale,
relative alle conoscenze pregresse e al mondo vitale dei soggetti stessi. In questo isolamento
consiste la forza del metodo ma al contempo, ovviamente, la sua debolezza, dal momento che non è
affatto chiaro quanto i modelli costruiti in laboratorio possano dirci sull’uso della memoria in
contesti di vita reale. Nella psicologia novecentesca, a questo orientamento metodologico se ne
oppone uno centrato invece sulla osservazione di contesti pragmatici e socioculturali reali di uso
della memoria, che ha il suo riferimento classico nell’opera di Frederic C. Bartlett. Docente a
Cambridge negli anni ’30, Bartlett sostiene una visione che oggi chiameremmo “interpretativa”
della memoria, concependola come uno “sforzo verso il significato” (an effort after meaning): vale
a dire, “non come la capacità di immagazzinare dati passati, ma come un processo di ricostruzione
che, partendo dagli interessi e dalle conoscenze presenti del soggetto, tenta di ricostruire a posteriori
il significato del ricordo” 70 .
L’orientamento di Bartlett, poco seguito intorno alla metà del secolo, quando gli studi psicologici
erano dominati dal comportamentismo, ha ispirato successivamente alcuni orientamenti di ricerca
che hanno assegnato un ruolo metodologico centrale all’osservazione delle modalità pratiche di uso
della memoria in contesti di vita quotidiana, in contrapposizione agli esperimenti di laboratorio. Di
particolare importanza il lavoro di Ulrich Neisser, fondatore di un approccio cosiddetto “ecologico”
alla ricerca sulla memoria – espressione che si riferisce appunto alla necessità di collegare le
prestazioni mnemoniche al contesto pratico di vita in cui esse sono impiegate, proprio quel contesto
che la ricerca di laboratorio mira invece ad eliminare 71 . Questa metodologia apre la psicologia
cognitiva all’analisi delle componenti sociali, culturali e storiche della memoria: un punto decisivo,
sul quale mi soffermerò tra un istante.
Vorrei prima osservare come l’approccio di Bartlett, così come quello ecologico o pragmatico di
Neisser, attribuiscano centralità a fenomeni che hanno importanti implicazioni per la storiografia e
69
Giovanna Leone, La memoria autobiografica. Conoscenza di sé e appartenenze sociali, Roma, Carocci, 2001, pp. 50-
1.
70
G. Leone, La memoria autobiografica, cit., p. 80. L’opera principale di Bartlett è Remembering, del 1932 (trad. it.
F.C. Bartlett, La memoria. Studio di psicologia sperimentale e sociale, Milano, Angeli, 1974). L’idea di un rapporto di
determinazione inversa tra passato e presente non era peraltro nuova alla riflessione umanistica: ne è un interessante
esempio quanto Italo Svevo scriveva ai primi del secolo: “Il presente dirige il passato come un direttore d’orchestra i
suoi suonatori. Gli occorrono questi e quei suoni, non altri. E perciò il passato sembra ora tanto lungo ora tanto breve.
Risuona o ammutolisce. Nel presente riverbera solo quella parte ch’è richiamata per illuminarlo o per offuscarlo” (cit.
in Aleida Assmann, Ricordare. Forme e mutamenti della memoria culturale, trad. it. Bologna, Il Mulino, 2002 [ed. orig.
1999], p. 18).
71
Di Neisser è disponibile in traduzione italiana il volume Psicologia cognitivista, Firenze, Giunti, 1976 (ed. orig.
1967); ma il testo probabilmente più rappresentativo dell’approccio ecologico è U. Neisser (ed.), Memory Observed:
Remembering in Natural Contexts, San Francisco, Freeman & Co., 1982. V. anche G. Cohen, Memory in the Real
World, London, Lawrence Erlbaum.
l’antropologia, vale a dire quelli della falsa memoria e delle distorsioni del ricordo. Si tratta di
aspetti del funzionamento della memoria che non possono esser interpretati come pura perdita o
incompletezza di informazioni, bensì come il prodotto di attive strategie di ricostruzione del passato
sulla base non solo delle esperienze e del sapere presente, ma di strutture di senso. Bartlett ha
introdotto il concetto di schema per indicare simili strutture relativamente stabili e resistenti
all’oblio, sulle quali i ricordi si innestano e si plasmano; la ricerca cognitiva più recente preferisce
parlare di copioni (scripts), un termine che sottolinea maggiormente la natura narrativa delle
strutture, che tendono a configurarsi come sequenze di eventi attorno ai quali le informazioni si
organizzano. Schemi e copioni svolgono una funzione di filtro rispetto alla possibilità di integrare
esperienze o contenuti della memoria a breve termine nella memoria a lungo termine; ma, ciò che
più conta, essi sembrano in grado di plasmare i ricordi in configurazioni coerenti. E’ in questo
quadro della costruzione di narrazioni significative sul passato che i fenomeni dei “falsi” ricordi,
delle distorsioni e dello stesso oblio vanno compresi.
Questa prospettiva è piuttosto diversa da quella psicoanalitica, la quale suppone invece che il
ricordo reale (ad esempio, un evento traumatico) continui ad esistere, intatto, nelle profondità della
psiche, schermato tuttavia da elaborazioni secondarie che lo rendono invisibile o irriconoscibile. La
distorsione e il falso ricordo rappresentano una forma patologica, i cui prototipi possono essere
riconosciuti nel sintomo nevrotico e nel lavoro onirico. Il percorso analitico di scavo e decifrazione
(si pensi alla pervasività delle metafore archeologiche nel discorso freudiano) è in grado di riportare
alla superficie il ricordo reale, dissolvendo le coperture di superficie. Nella prospettiva cognitivista,
invece, non si può parlare di un ricordo “reale” che sarebbe celato dal ricordo falso o dall’apparente
oblio: il lavoro di plasmazione degli schemi o degli scripts è costitutivo del normale
funzionamento della memoria, e non esiste al di fuori di esso (se non nella sperimentazione di
laboratorio) un livello di maggiore autenticità, di ricordi-copia perfettamente fedeli all’originale.
Tuttavia, la psicologia cognitiva riprende dalla psicoanalisi alcune idee chiave sui meccanismi che
guidano il lavoro degli schemi: ad esempio lo spostamento e la condensazione. Neisser ha
introdotto il concetto di memoria “repisodica” (repisodic) per indicare la tendenza a ricordare più
eventi analoghi come se si trattasse di un unico episodio: una strategia di condensazione che
produce un ricordo in sé falso, il quale conserva tuttavia un fondamentale elemento di verità72 .
Dovremmo forse chiamare questi ricordi non tanto falsità quanto finzioni, nel senso del termine
che Clifford Geertz usa per definire le descrizioni etnografiche nel loro rapporto con la “realtà”:
qualcosa di costruito, di modellato attraverso strategie rappresentative (prevalentemente linguistiche
e retoriche) alle quali non si applica facilmente la dicotomia vero/falso 73 . E’ ovvia la rilevanza di
questi temi per le discipline che fanno uso di fonti orali: essi influenzano a fondo il problema della
verità della testimonianza e del suo rapporto con il sapere storico o etnografico. In sostanza, ed è un
punto sul quale tornerò più avanti, la consapevolezza del carattere “costruito” delle memorie, in
particolare di quelle autobiografiche, ci impedisce di assumere le testimonianze in un’ottica realista,
spingendoci invece ad esaminarne la configurazione retorica e discorsiva e la contestualizzazione
pragmatica: a cercare di capire, in altre parole, quanto sono influenzate da modelli narrativi, dalla
72
Neisser ha studiato questa strategia della memoria a proposito del caso della testimonianza resa al processo Watergate
da un collaboratore di Nixon, John Dean: le sue deposizioni, confrontate con prove documentali oggettive,
dimostravano che egli univa in singoli episodi una serie di fatti e informazioni che appartenevano a situazioni fra loro
slegate. Gli episodi riferiti erano fattualmente falsi, mai avvenuti: tuttavia, si trattava di “drammatizzazioni” che
rappresentavano in modo esemplare la sequenza di eventi reali, il “significato” delle vicende indagate. Come commenta
Giovanna Leone (I confini della memoria. I ricordi come risorse sociali nascoste, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1998,
p. 15), “questo ricordo va considerato non come un errore di trascrizione, ma come una rielaborazione creativa, che
permette di cogliere il succo dell’intera sequenza, seppure espresso in un ricordo formalmente ‘sbagliato’”. V. U.
Neisser, “John Dean’s memory: A case study”, Cognition, 9, 1981, pp. 1-22. Per un’ampio esame dal punto di vista
psicologico dei problemi della falsa memoria v. D.L. Schacter (ed.), Memory Distortion. How Minds, Brains and
Societies Reconstruct the Past, Harvard, Harvard University Press, 1995.
73
C. Geertz, Interpretazione di culture, trad. It. Bologna, Il Mulino, 1987 (ed. orig. 1973), p. 53
situazione comunicativa in cui emergono, dalle finalità in senso lato “politiche” dei narratori, e così
via.
Negli anni ’90, il problema dei falsi ricordi è però emerso nell’attualità politica, oltre che nel
dibattito scientifico, in relazione a un altro tipo di testimonianza, quella giudiziaria. In particolare
negli Stati Uniti si sono sviluppate accese dispute attorno alla cosiddetta “sindrome da personalità
multipla”, un disturbo psichico di natura dissociativa che insorgerebbe in individui che hanno subìto
e rimosso abusi sessuali nell’infanzia (quasi sempre in ambito familiare), i quali vengono
“ricordati” in seguito a trattamento analitico o psichiatrico. Sulla base di questi ricordi traumatici,
molti pazienti hanno intentato cause giudiziarie contro loro stessi familiari, e ciò ha evidentemente
portato in primo piano il problema della attendibilità di una memoria “recuperata”, e della
possibilità che, sia pure con la totale buona fede degli interessati, simili memorie siano indotte sulla
base di modelli “narrativi” condivisi dallo psichiatra e da un più ampio ambiente culturale di
appartenenza 74 . Nel 1992 è stata fondata negli Stati Uniti una False Memory Syndrome Foundation,
che riunisce genitori colpiti, o che intendono cautelarsi, da accuse sulla base di memorie recuperate
a seguito di trattamento psichiatrico. Una controversia politica e mediale che ha coinciso con “la
polarizzazione tra psicologi clinici che difendevano la necessità e la validità del memory recover e
gli psicologi cognitivisti [...] i quali mostravano, sulla base di risultati sperimentali, quanto
facilmente si possano provocare ricordi sbagliati mediante gli effetti della comunicazione
posteriore” 75 .
3. Memoria collettiva.
Ciò che interessa di più sottolineare, tuttavia, è un altro punto; la concezione bartlettiana della
memoria come “sforzo verso il significato”, come attiva interpretazione del passato sulla base di
schemi psicologici connessi alla vita concreta del presente, apre la strada alla considerazione degli
aspetti sociali del ricordare. In questa prospettiva, e ancor più in quella ecologica, l’atto psichico del
ricordare non può essere inteso separandolo dal contesto del mondo vitale e delle pratiche
comunicative, che è per definizione un contesto sociale e culturale. Gli stessi concetti di schema e
script non possono esser concepiti, in una prospettiva ingenuamente empirista, come proprietà della
mente individuale: essi si riferiscono piuttosto a un elemento strutturante che preesiste al pensiero
individuale e che trae forme e contenuti dalla dimensione della cultura. E’ questa la cerniera, o
meglio ancora il punto di profonda saldatura, fra lo studio psicologico della memoria e gli studi
storici e sociali.
E’ su questo punto di giuntura che insiste il contributo di un altro importante studioso, questa
volta di provenienza sociologica, che può esser considerato il precursore degli studi sociali della
memoria. Mi riferisco naturalmente a Maurice Halbwachs, seguace di Durkheim scomparso nel
1945 nel lager di Büchenwald, e autore di tre importanti libri sul tema della memoria 76 . Per lungo
tempo largamente ignorato, soprattutto in Italia, Halbwachs è oggi al centro di una rinnovata
attenzione anche al di fuori degli studi strettamente sociologici. L’idea centrale del suo lavoro è
74
Ipotesi, questa, resa assai probabile dal fatto che la MPD ( Multiple Personality Disorder ) è un classico esempio di
ciò che gli antropologi chiamano culture-bound syndrome, cioè una malattia presente solo in uno specifico contesto
culturale. L’MPD è infatti stata diagnosticata massicciamente negli Stati Uniti negli ultimi 15-20 anni, e sembra del
tutto assente da ogni altra epoca e cultura medica. Si veda in proposito la discussione contenuta in Ian Hacking, La
riscoperta dell’anima. Personalità multipla e scienze della memoria, trad. it. Milano, Feltrinelli, 1996 (ed. orig. 1995) e
Paul Antze, “Telling stories, making selves: Memory and identity in Multiple Personality Disorder”, in P.AntzeM.Lambek (eds.), Tense Past. Cultural Essays in Trauma and Memory, New York-London, Routledge, 1996, pp. 3-24.
Si veda anche il cap. 9, “Guerre della memoria”, in D. L. Schachter, Alla ricerca della memoria, cit., pp. 269-306
75
Gerald Echterhoff, “Falso ricordo (false memory)”, in Nicolas Pethes-Jens Ruchatz (a cura di), Dizionario della
memoria e del ricordo, trad. it. Milano, Bruno Mondadori, 2002 (ed. orig. 2001), pp. 190-91.
76
I quadri sociali della memoria, trad. it. Napoli, Ipermedium, 1997 (ed. orig. 1925); La memoria collettiva, trad. it.
Milano, Unicopli, 1996 (ed. orig. postuma 1950, ma scritto negli anni ’30); Memorie di Terrasanta, trad. it. Venezia,
Arsenale, 1988 (ed. orig. La tipographie légendaire des Evangelis en Terre Sainte, 1941).
l’applicazione al campo della memoria del concetto durkheimiano di “rappresentazione collettiva”,
intesa come una categoria del pensiero che precede l’elaborazione individuale e che è radicata nelle
istituzioni e nelle pratiche sociali. Durkheim, Mauss e altri esponenti della scuola francese avevano
letto in questa direzione numerose forme di quello che si chiamava allora il “pensiero primitivo”,
dalla religione, alla magia, alle forme più elementari di classificazione del mondo naturale. Il loro
programma era di rottura radicale con l’empirismo socio-antropologico, che pensava di poter
dedurre le credenze e le istituzioni culturali dai processi speculativi della mente individuale, ma
anche con il razionalismo kantiano, le cui categorie venivano di fatto relativizzate e ricondotte a un
più fondamentale determinismo sociale.
Halbwachs tenta di spingere questo programma sociologico fin all’interno della psicologia,
dunque proprio sul terreno in apparenza più prossimo alla dimensione puramente individuale. L’atto
individuale del ricordare è a suo parere possibile solo sulla base di “quadri sociali” (cadres sociaux)
che sono logicamente antecedenti a qualsiasi singolo ricordo. Tali quadri non si limitano a
selezionare i ricordi: piuttosto, li producono. Halbwachs rovescia infatti la filosofia della memoria
prevalente nella Francia di inizio secolo, quella di Bergson, secondo la quale tutte le esperienze di
un individuo sono sempre presenti sotto forma di ricordi latenti o inconsci nella sua mente, senza
che nulla si perda mai veramente. A suo parere, al contrario, non c’è nulla che propriamente si
“conserva”, e i ricordi sono ricostruzioni sempre orientate sul presente:
… al di fuori del sogno il passato, in realtà, non ricompare allo stesso modo, anzi tutto
sembra indicare che esso non si conserva affatto, a meno che non lo si ricostruisca a
partire dal presente. […] I quadri collettivi della memoria non sono costituiti dalla
combinazione dei ricordi individuali, non sono delle semplici forme vuote dove i
ricordi, venuti da altrove, si inseriranno, ma sono, al contrario, esattamente gli strumenti
di cui la memoria collettiva si serve per ricomporre un’immagine del passato che si
accordi in ogni epoca con il pensiero dominante nella società77 .
In questo passo si coglie anche la differenza rispetto al concetto bartlettiano di “schema”,
qualcosa di più simile a una “forma vuota” in cui ricordi venuti da altrove trovano (o non trovano,
venendo quindi eliminati) una loro collocazione. I quadri sociali non sono pure strutture cognitive:
hanno invece un forte contenuto di senso, una “sostanzialità” che corrisponde a quella del gruppo
sociale cui si riferiscono. Infatti, come nota Paolo Jedlowski in una densa introduzione all’edizione
italiana di La memoria collettiva, nell’ottica di Halbwachs “ricordare, per un individuo, corrisponde
a riattualizzare la memoria di un gruppo sociale cui egli appartiene o ha appartenuto in passato” 78 . Il
che significa che la memoria del gruppo è in qualche modo più reale – perlomeno sociologicamente
– della memoria individuale (anche se la memoria individuale, soprattutto nelle società complesse,
può sovrapporre al proprio interno più quadri sociali, dal momento che ogni individuo appartiene a
molteplici e differenziati gruppi, come la famiglia, i pari età, la cerchia professionale, quella
associativa etc.).
Qui la riflessione di Halbwachs apre una linea di ricerca assai diversa da quella cognitivista – pur
condividendone, come si è detto, alcuni punti di partenza. Halbwachs è interessato prevalentemente
alle funzioni sociali della memoria: la vede come un aspetto delle pratiche sociali, non come un loro
prerequisito. La memoria esprime la solidarietà fra l’individuo e il gruppo o i gruppi sociali cui
appartiene. Il che significa, in altre parole, che il ricordare è una pratica performativa e non
puramente rappresentativa, la cui logica si intreccia cioè con quella delle altre pratiche sociali e in
senso lato politiche. Significa, inoltre, che la memoria interna, cioè i meccanismi psichici del
ricordare, non può esser studiata separatamente dalla memoria esterna, vale a dire da quei
dispositivi tramite i quali le società incorporano tramite una codificazione simbolica la memoria del
77
78
M. Halbwachs, I quadri sociali della memoria, cit., p. 3
P. Jedlowski, “Introduzione”, in M. Halbwachs, La memoria collettiva, cit., p. 26
passato in oggetti, in luoghi o in pratiche; dispositivi che includono le tecnologie comunicative,
dalla scrittura a Internet, i processi di monumentalizzazione, i rituali celebrativi e commemorativi.
E’ vero, come nota lo stesso Jedlowski 79 , che Halbwachs non è particolarmente interessato a una
sistematica storia delle tecnologie di esteriorizzazione della memoria, di conservazione e
riproduzione di immagini del passato tramite oggetti materiali: tuttavia, la sua opera apre lo
scenario per una simile storia e antropologia delle forme concrete e mutevoli che la memoria
assume nelle società. Uno scenario che finirà per saldarsi con quelli aperti dalla psicologia sociale, e
sul quale si avventureranno nuovi indirizzi di studio soprattutto nell’ultimo quarto del Novecento.
Nei paragrafi che seguono, vorrei esplorare tre aspetti di queste analisi sociali della memoria, o,
meglio ancora, indagini sulla memoria come fenomeno sociale: l’indirizzo di analisi del discorso, le
indagini empiriche sui rituali celebrativi e quelle sull’incorporazione della memoria in luoghi e
oggetti materiali.
4. La costruzione linguistica del ricordo.
L’analisi del discorso, come gli indirizzi della sociologia di orientamento fenomenologico
(interazionismo simbolico, etnometodologia), tende a considerare le pratiche quotidiane di
interazione fra le persone come l’unica realtà sociologica che è possibile descrivere in modo
oggettivo. I costrutti e le astrazioni teoriche di cui ci serviamo normalmente nella vita quotidiana
non fondano quelle interazioni, ma ne sono il prodotto; il che vale anche per i concetti utilizzati
dalle scienze sociali, come “società” o “cultura”, e dalla psicologia, come “mente” o, appunto,
“memoria”. La psicologia sociale giunge ad assumere questo punto di vista riprendendo e
radicalizzando le posizioni di Bartlett. Per quest’ultimo, come abbiamo visto, la memoria non è il
ripescaggio di informazioni in un magazzino “interno”, ma l’attiva costruzione di resoconti del
passato sulla base di schemi culturali condivisi; e tuttavia, questa attività costruttiva avviene
comunque all’interno della testa delle persone. L’analisi del discorso, invece, colloca la memoria
“là fuori”, all’interno delle pratiche discorsive e simboliche quotidiane e di precise circostanze
comunicative, prescindendo da ogni ipotesi sull’esistenza di “facoltà” o processi mentali e di entità
interne quali i “ricordi”, concepiti come oggetti da immagazzinare e ritirar fuori al momento giusto.
I “ricordi”, in questa chiave, sono un sottoprodotto del nostro modo di parlare del passato.
E’ curioso come a Bartlett si richiamino oggi sia gli approcci cognitivisti, come quello
rappresentato da Neisser, sia quelli che potremmo definire socio-costruzionisti. I due approcci si
contrappongono sul piano del riconoscimento del proprio oggetto di studio: il cognitivismo è
interessato a processi mentali che per l’orientamento etnometodologico sono finzioni discorsive.
Occorre infatti chiarire che l’analisi del discorso intende il linguaggio in modo radicalmente antirealista: esso è uno strumento di gestione, di creazione e mantenimento delle relazioni sociali, prima
ancora che una forma di rappresentazione del mondo. Secondo la lezione di Wittgenstein, il
significato delle parole consiste nel loro uso. Ciò può apparire controintuitivo, dal momento che
siamo abituati a un uso del linguaggio in cui certe parole rappresentano certe cose: occorre però
considerare che ciò accade “solo all’interno di forme di vita sociale già costituite da modi di parlare
in cui queste parole sono usate” 80 . Seguire fino in fondo questo approccio richiede al ricercatore,
nella tradizione fenomenologica, di sospendere l’assunzione di una serie di categorie che fanno
parte dell’ordinario orizzonte della propria esperienza in quanto attore sociale. Tutti viviamo
all’interno di mondi “naturali” che sono di fatto costituiti dalle nostre ordinarie pratiche linguistiche
e relazionali: tanto più è profonda questa costituzione, tanto più difficilmente riusciamo a uscirne e
a coglierla come oggetto di descrizione sociologica. Il costruzionismo sociale richiede dunque uno
sforzo di estraniamento che presenta importanti affinità con l’esperienza antropologica. Il passo
forse più difficile da accettare è la rinuncia a utilizzare l’idea di un soggetto stabile e di una coerente
79
Ibid., p. 27
J. Shotter, “The social construction of remembering and forgetting”, in D. Middleton - D. Edwards (eds.), Collective
Remembering, London, Sage, 1990, p. 121
80
e continuativa “esperienza vissuta” come risorse della propria comprensione dei fenomeni mentali e
sociali. Ciò che prendiamo normalmente come un assunto, deve esser visto come un problema: il
problema del
perché, in questo momento della storia, noi immaginiamo noi stessi in un certo modo:
pensiamo di esistere fin dalla nascita come individui isolati e separati, di racchiudere al
nostro interno un “pensiero” o una mentalità” contrapposta a un mondo materiale a sua
volta privo di ogni processo mentale. Ciò vale anche per i nostri ricordi: nella nostra
esperienza del ricordare (o, perlomeno, in ciò che noi diciamo la nostra esperienza del
ricordare) sembra che facciamo sempre riferimento a qualcosa che sta dentro di noi,
come un’immagine o un’impressione, un oggetto di qualche tipo 81 .
Mi sembra difficile accusare queste posizioni, come fa Giovanna Leone in un suo pur ottimo
libro sulla memoria autobiografica, di “scarsa attenzione per la soggettività individuale”82 : al
contrario, la soggettività è posta al centro di un programma di ricerca, di cui è però l’oggetto e non
la risorsa o assunto implicito. La psicologia sociale riprende qui pienamente l’insegnamento di
Goffman, secondo il quale l’Io contemporaneo è il prodotto e non la condizione dei microrituali
dell’interazione che costellano la nostra vita quotidiana; e apre uno scenario che si interseca, fino a
risultarne indistinguibile, con quello dell’antropologia culturale. Quest’ultima non mira soltanto a
studiare le forme esteriorizzate e pubbliche di memoria, in contrapposizione a quelle interne e
private, secondo un approccio che manterrebbe ferma l’autonomia di entrambe. L’antropologo
Maurice Bloch, ad esempio, critica quegli approcci alla memoria esterna che la vedono come una
semplice estensione evolutiva della memoria interna, allo stesso modo in cui gli utensili sono una
estensione (o una esteriorizzazione, nel linguaggio di André Leroi-Gourhan) della mano. In questo
modo, si assumerebbe in modo acritico l’esistenza di una memoria interna, pura rispetto ai
condizionamenti storici e sociali, e si guarderebbe alle istituzioni culturali come ad una specie di
hard disk che aumenta le capacità di immagazzinamento al di là di quanto è possibile all’individuo.
Occorre invece, sostiene Bloch, considerare come l’influenza sociale operi all’interno stesso delle
facoltà mnemoniche individuali; il che implica capire che la produzione fenomenologica della realtà
degli stati di cose passati (dei ricordi) è “largamente influenzata dalla storia, o per meglio dire dalla
visione che le persone hanno di sé nella storia e, attraverso le nozioni di persona e di luogo, dalle
loro varie concezioni dell’etica e delle intenzioni” 83 . In altre parole, vi sono molte possibili folk
psychologies (concezioni della persona, del suo rapporto con la società e con la storia, delle sue
motivazioni all’agire) che influenzano il significato che il ricordare ha nelle varie culture: e con esse
la psicologia, non meno che l’antropologia, non può fare a meno di confrontarsi.
Il problema della discourse analysis non consiste dunque nella scarsa attenzione al livello
soggettivo del ricordare, poiché essa mira a una integrazione metodologicamente nuova del livello
individuale e di quello sociale. Sul piano epistemologico, semmai, il costruzionismo radicale si
scontra con il problema della verità. Se ogni resoconto sul passato è una costruzione plasmata dalle
esigenze di senso del presente, e guidata da criteri non di esattezza rappresentativa ma di efficacia
pragmatica, che ne è del problema della verità fattuale e oggettiva del ricordo? Non rischiamo di
sostituire al concetto di verità quello di accordo consensuale, con le difficoltà e i paradossi, sia
81
Ibid., pp. 121-2
G. Leone, La memoria autobiografica, cit., p. 30
83
M. Bloch, “Internal and external memory: different ways to be in history”, in P.Antze – M.Lambek (eds.), Tense
Past, cit., p. 217. L’obiettivo esplicito della crititca di Bloch è il celebre libro di Jack Goody, L’addomesticamento del
pensiero selvaggio, trad. it. Milano, Angeli,
uno studio del ruolo della scrittura come dispositivo mnemonico, e del
suo ruolo nella plasmazione delle forme del pensiero razionale. La più classica trattazione del ruolo della memoria
esterna nel quadro più generale dell’evoluzione umana, vista come sequenza di successive esteriorizzazioni che liberano
progressivamente la mano dal peso delle funzioni biologiche e del lavoro materiale, e la mente dal peso della
memorizzazione interna, è probabilmente quella offerta da A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, trad. it. Torino,
Einaudi, 19 (ed. orig. ), vol. II.
82
epistemologici sia etici, che ciò implicherebbe? Non sentiamo forse tutti l’importanza decisiva di
mantenere separato il piano della verità oggettiva – “come sono andate veramente le cose” – da
quello dell’utilità o funzionalità di una certa versione degli eventi, o del consenso comune su di
essa? E non è forse su questa separazione che si basa la storia, in quanto conoscenza
scientificamente fondata del passato?
Qui si aprono naturalmente problemi riguardanti lo statuto epistemologico del sapere storico, che
porterebbero molto lontano e implicherebbero tipi diversi di considerazione (p.es. la natura e la
varietà delle fonti impiegate, i modi del loro trattamento critico, le regole della costituzione della
narrazione storiografica come “genere” distinto da rievocazioni del passato nel discorso comune) 84 .
L’analisi del discorso forse trascura la possibilità che in ogni resoconto del passato prodotto in
“buona fede” (ma il concetto di “buona fede” è di per sé assai problematico, e presuppone una
trasparenza e una autonomia della coscienza individuale difficile, come abbiamo appena visto, da
assumere) vi sia una autentica istanza rappresentativa, una irriducibile pretesa di affermare la verità
oggettiva.
Tuttavia, senza bisogno di spingerla alle sue estreme conseguenze epistemologiche, l’analisi del
discorso ci mostra al di là di ogni dubbio come l’istanza rappresentativa e quella pragmatica siano
inestricabilmente mischiate nel discorso quotidiano (se non in quello storiografico); e come
l’appello alla “verità oggettiva” sia proprio una delle principali strategie retoriche impiegate per far
prevalere una versione su un’altra. Ciò apre programmi di ricerca di grande interesse sulle pratiche
del ricordare insieme. Ne è un esempio il lavoro di Middleton e Edwards dedicato all’analisi
linguistica e relazionale della diffusa pratica domestica del guardare gli album fotografici di
famiglia. Siamo abituati a pensare a questa attività come a una contemplazione di ricordi già
compiutamente e stabilmente presenti nella memoria individuale dei membri della famiglia, con le
foto che servono da richiami o esche per l’estrazione di materiali mnemonici solidamente
immagazzinati. Questi autori mostrano in modo assai convincente, sulla base dell’analisi
etnografica, come al contrario sia qui in gioco la costruzione cooperativa – e talvolta conflittuale e
negoziata – dei ricordi; come anzi, soprattutto per i bambini, si tratti di situazioni in cui si impara a
ricordare, vale a dire si acquisiscono le regole del gioco linguistico e delle reazioni emotive
associate al “ricordare insieme” e alla rappresentazione del passato comune 85 .
La metodologia impiegata in queste analisi tende a mettere in luce le strategie retoriche, nonché i
microcontesti di potere, nel cui quadro si interpretano fonti (le foto e i souvenir, ad esempio) per
sostenere particolari versioni del racconto del passato. E’ un’analisi che può applicarsi non solo ai
contesti di vita quotidiana, ma anche alle situazioni di produzione formalizzata di memoria, come
quello giudiziario o quello storiografico. La concezione stessa delle fonti orali e della
“testimonianza”, ad esempio, muta fortemente qualora si assuma il punto di vista della etnografia
della conversazione. Per quest’ultima, le narrazioni autobiografiche prodotte dai testimoni non solo
sono costruzioni interpretative che ricostruiscono selettivamente il passato per mezzo di strategie
retoriche e del riferimento a generi o modelli che danno forma al racconto; di più, esse sono il
prodotto del contesto comunicativo in cui vengono “raccolte”, vale a dire della relazione linguistica
e “politica” fra narratore e ricercatore. La pragmatica dell’incontro etnografico, in altre parole,
influenza ciò che viene detto e il suo significato in misura assai maggiore di quanto la pur raffinata
metodologia della storia orale di solito riconosca 86 Ciò non rende meno importanti le fonti orali per
84
Rimando in proposito a F. Dei, “La libertà di inventare i fatti: antropologia, storia, letteratura”, Il gallo silvestre, 13,
2000, pp. 180-96
85
David Middleton, Derek Edwards, “Conversational remembering; A social psychological approach”, in D.
Middleton, D. Edwards (eds.), Collective Remembering, cit,, p. 3 sgg.; Degli stessi autori si veda anche “Conversational
remembering and family relationships: How children learn to remember”, Journal of Social and Personal
Relationships, 5, 1988, pp. 3-25.
86
Si vedano ad esempio le considerazioni metodologiche in Giovanni Contini, Alfredo Martini, Verba manent. L’uso
delle fonti orali per la storia contemporanea, Roma, NIS, 1993, pp.12 sgg., e in Alessandro Portelli, “Problemi di
metodo. Sulla diversità della storia orale”, in C. Bermani (a cura di), Introduzione alla storia orale, vol. I, Roma,
Edizioni Odradek, 1999, pp. 149-66: in questi contributi il problema della produzione congiunta del significato da parte
la conoscenza storica ed etnografica: ci rende però consapevoli della particolare complessità del
trattamento critico che esse richiedono quando vengono assunte come documenti, e della
molteplicità di piani ermeneutici cui rinvia la loro interpretazione.
5. Oggetti e riti commemorativi
“Per fissarsi nella memoria di un gruppo, una verità deve presentarsi sotto la forma concreta di un
avvenimento, di una figura personale o di un luogo”, scrive Halbwachs in Memorie di Terrasanta 87 .
In quest’opera del 1941, egli studia attraverso la documentazione storica la complessa vicenda del
riconoscimento e della ricostruzione, dopo le Crociate, di una “topografia leggendaria” che risulta
dal compromesso tra la fisicità reale dei luoghi e dei percorsi dei pellegrinaggi, da un lato, e
dall’altro la tradizione teologica e l’immaginario cristiano medioevale. I luoghi santi sono il
principale terreno di plasmazione di un passato che gioca un ruolo cruciale per l’identità e per la
memoria culturale cristiana.
Agli antropologi, abituati a lavorare in società senza scrittura, l’incorporazione della memoria in
luoghi e oggetti è abbastanza familiare. Ne sono un classico esempio le “vie dei canti” della
mitologia australiana, percorsi naturali costellati dalle tracce lasciate dagli antenati o eroi culturali,
rievocate attraverso performance coreutiche e musicali. Il paesaggio è qui la materia prima in cui si
inscrive il passato, e costituisce la vera e propria struttura della memoria collettiva. A proposito
degli Aranda, l’etnologo T.G.H. Strehlow scriveva negli anni ’40 che
le montagne, i ruscelli, le sorgenti e gli stagni non sono per lui aspetti del paesaggio
piacevoli o interessanti. Ognuno fu creato da uno degli antenati da cui egli discende. Nel
paesaggio che lo circonda, legge la storia dei fatti e delle gesta degli esseri immortali
che venera […] Tutto il paese è per lui come un albero genealogico antico e sempre
vivo 88 .
Claude Lévi-Strauss, commentando questo passo nella sua opera forse più importante, vi scorge
un esempio della capacità del “pensiero selvaggio” di integrare la storia all’interno di un ordine
spaziale, di ricomprendere la diacronia all’interno della sincronia. Un ulteriore esempio di questa
modalità di trattamento del tempo e della storia, da parte dei sistemi (sociali e intellettuali) che egli
definisce classificatori, è rappresentato dai churinga. Si tratta di oggetti rituali, anche in questo caso
australiani, che rappresentano il corpo fisico di un antenato, detenuto dalla persona vivente che ne è
ritenuta la reincarnazione; sono tenuti usualmente nascosti e usati solo in occasioni cerimoniali. La
loro funzione, per Lévi-Strauss, è quella di “rendere vero, in forma tangibile, l’essere diacronico
della diacronia entro la sincronia stessa” 89 : essi sono una manifestazione diretta e materiale del
passato all’interno del presente. Per farli apparire meno esotici, Lévi-Strauss li raffronta ai moderni
archivi, non tanto per le conoscenze che in essi sono contenute, ma per la loro materialità, la loro
natura di oggetti che ci mettono direttamente in contatto con la “pura storicità”. Se gli archivi
andassero distrutti una volta che le fonti sono state tutte pubblicate, egli osserva, noi non
di narratore e ricercatore è affrontato con chiarezza, ma non inquadrato nella cornice sociolinguistica ed
etnometodologica propria dell’etnografia della conversazione. Il che implica il rischio di sopravvalutare la
“trasparenza” del discorso del testimone. Per una recente discussione in chiave costruttivista del ruolo del contesto di
ricerca nella produzione di narrazioni autobiografiche, si vedano gli articoli di K.Tschuggnall, H. Welzer, “Rewriting
memories: Family recollections of the National Socialist past in Germany”, e di Alessandra Fasulo, “Hiding on a glass
roof, or a commentator’s exercise on ‘Rewriting memories’”, entrambi in Culture and Psychology, 8, 2002, pp. 132-45,
146-52.
87
Cit. in Ugo Fabietti,Vincenzo Matera (a cura di), Memoria e identità. Simboli e strategie del ricordo, Roma, Meltemi,
1999, p. 40
88
Cit. in Claude Lévi-Strauss, Il pensiero selvaggio, trad.it. Milano, Il Saggiatore, 1964, p. 263 (ed. orig. 1962; il testo
di Strehlow è del 1947)
89
Ibid., p. 258
perderemmo alcuna conoscenza, ma il passato resterebbe privo del suo “sapore diacronico”: sarebbe
pensabile ma non fisicamente testimoniato 90 .
Sia gli archivi che i churinga incorporano dunque la memoria di un gruppo sociale, in un senso
che va ben al di là delle specifiche informazioni che veicolano: ne sono i materiali portatori, e
questo fa di loro degli oggetti in qualche modo sacri, da conservare e maneggiare con modalità
rituali. L’accostamento tra churinga ed archivi trova tuttavia un limite nella fondamentale
distinzione che lo stesso etnologo francese avanza tra due modelli di società, contrapposte proprio
intorno al modo di considerare il tempo passato e di elaborazione sociale della memoria. Da un lato
vi sono le società “calde”, come quella occidentale moderna, che “interiorizzano risolutamente il
divenire storico per farne il motore del loro sviluppo”; dall’altro le società “fredde”, che
“cercano…di annullare, in modo quasi automatico, l’effetto che i fattori storici potrebbero avere sul
loro equilibrio e la loro continuità”. Un obiettivo conseguito non attraverso l’impossibile negazione
del divenire storico, ma attraverso la sua ammissione “come una forma senza contenuto: c’è sì un
prima e un dopo, ma il loro solo significato è di riflettersi l’un l’altro” 91 . In altre parole, il presente è
visto come la costante ripetizione di eventi già accaduti e agiti dagli antenati in un passato mitico. Il
tempo è concepito in modo circolare più che vettoriale, e si presta dunque particolarmente ad essere
inscritto nell’ordine spaziale, sincronico e stabile del mondo materiale, sotto forma di elementi del
paesaggio o di oggetti duraturi; oppure, nell’ordine altrettanto stabile e metastorico del rituale.
La contrapposizione tra società fredde e calde è uno dei tentativi tramite cui gli studi sociali hanno
cercato di dar conto di una fondamentale trasformazione della memoria sociale nel passaggio dalla
tradizione alla modernità. Alcuni autori l’hanno riletta in termini di differenza tra oralità e scrittura
come modalità prevalenti della comunicazione sociale. Nel primo caso la memoria ha una coerenza
rituale, è cioè depositata in riti (e in narrazioni mitologiche ad essi strettamente legate) che si
tramandano secondo il principio di una integrale e meccanica ripetizione; nel secondo si può parlare
di una coerenza testuale che apre lo spazio dell’esegesi e dell’interpretazione 92 . L’idea chiave in
queste e simili teorie è che la modernità, in virtù della discontinuità che istituisce nei confronti del
passato, sviluppi una consapevolezza della storicità, del trascorrere inesorabile e irreversibile del
tempo, che sarebbe sconosciuta alle culture tradizionali, immerse invece in un tempo genealogico o
strutturale 93 dominato dal mito dell’eterno ritorno. Proprio questo senso di discontinuità con il
passato, avvertito sul piano storico generale come su quello generazionale e autobiografico, pone un
problema di ricostruzione della memoria tramite istituzioni e pratiche sociali specifiche.
Un’idea analoga sta anche alla base della distinzione proposta da Pierre Nora tra milieu de la
mémoire e lieux de la mémoire, che sta alla base del suo noto progetto di studio sistematico dei
luoghi della memoria francese 94 . Nora, per la verità, ha in mente una discontinuità che si produce
negli ultimi due secoli nella cultura di massa: ma il concetto su cui lavora resta quello del passaggio
da una comunità che vive un tempo circolare ed è costantemente immersa nella memoria, tanto da
90
Ibid., p. 262.
Ibid., pp.254-5
92
La rilettura delle contrapposizioni tra pensiero selvaggio e addomesticato, o fra società fredde e calde, in termini di
evoluzione della scrittura, è sostenuta ad esempio da Jack Goody, L’addomesticamento del pensiero selvaggio, trad. it.
Milano, Angeli, 19 (ed. orig.). Di coerenza rituale e testuale parla Jan Assman nel suo importante lavoro sulla memoria
culturale (La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche, trad.it. Torino,
Einaudi, 1997 (ed. orig. 1992), vedendone degli esempi nelle antiche culture, rispettivamente, egiziana ed ebraica.
93
La più classica trattazione antropologica del tempo “strutturale” è probabilmente quella di Edward E. EvansPritchard, I Nuer: un’anarchia ordinata, trad. it. Milano, Angeli, 1985 (ed. orig. 1940), p. 160: nella società pastorale
africana dei Nuer, “la storia valida termina a un secolo e la tradizione…ci porta indietro soltanto a dieci o dodici
generazioni nella struttura del lignaggio”, così che “la distanza tra l’inizio del mondo e il giorno d’oggi rimane
inalterata. Il tempo, in tal modo, non è un continuum, ma una relazione strutturale costante tra due punti: la prima e
l’ultima persona in una linea di discendenza agnatica […] Al di là del ciclo annuale, il calcolo del tempo è una
concettualizzazione della struttura sociale e i punti di riferimento sono una proiezione nel passato delle relazioni attuali
fra gruppi di persone”.
94
Pierre Nora, “Entre mémoire et histoire. La problematique des lieux”, in P. Nora (sous la direction de), Les lieux de
mémoire, vol. I, Paris, Gallimard, 1984
91
non percepirla come problema e da non essere neppure consapevole della sua esistenza, a una
comunità che vive un tempo vettoriale ed è ossessionata dallo sfuggire inesorabile del tempo,
organizzando la propria cultura attorno alla produzione di memoria. Una dicotomia così netta è
difficilmente sostenibile, così come quella tra società calde e fredde. In realtà, le scienze sociali
contemporanee tendono oggi a un deciso scetticismo nei confronti di tutte quelle categorie che
assolutizzano la distanza fra “modernità” e “tradizione” (incluso freddo e caldo, oralità e scrittura e,
come per Nora, memoria vissuta e consapevolezza storica): vedono anzi nel concetto stesso di
tradizione una proiezione etnocentrica dell’autoconsapevolezza della modernità. Sistematicamente,
le indagini etnografiche (ma potrei aggiungere, credo, anche quelle storiche) su società
“tradizionali” mostrano una complessità irriducibile al modello sociologico – anche e soprattutto in
relazione alle concezioni del tempo e alla gestione sociale della memoria 95 .
Nondimeno, il concetto di “luogo di memoria” si è dimostrato straordinariamente fecondo, per la
capacità di aprire nuovi scenari alla comprensione della struttura simbolica degli spazi sociali e
delle pratiche celebrative e commemorative – in contesti “moderni” come in quelli “tradizionali”.
Sviluppando fino in fondo le intuizioni di Halbwachs, lo studio della memoria collettiva dei gruppi
sociali ha abbandonato il terreno delle “rappresentazioni” mentali o puramente discorsive, per
praticare vasti progetti di etnografia degli spazi pubblici e del loro “arredo” simbolico, e, al
contempo, delle pratiche rituali di tipo commemorativo. Gli ultimi anni hanno così visto una grande
fioritura di studi su monumenti, musei, memorial, denominazioni di luoghi e strade, elementi del
patrimonio culturale, raduni, cortei e manifestazioni celebrative, festival, tradizioni più o meno
inventate, film e programmi televisivi. Jay Winter ha parlato di un “boom della memoria” nella
storiografia contemporanea, sostendendo che, sia nel mondo anglosassone sia in molte scuole
europee, il tema della memoria è divenuto “il concetto centrale attorno al quale si organizzano gli
studi storici, una posizione un tempo occupata dalle nozioni di razza, classe, e gender” 96 . Qualcosa
di simile si potrebbe dire per antropologia, sociologia e psicologia sociale, discipline nelle quali la
memoria non rappresenta più soltanto un tema teorico di rilievo, ma diviene spesso il motivo
strutturante della stessa ricerca empirica. Anzi, come accennato, in molti studi recenti i confini
disciplinari divengono difficilmente distinguibili: è come se scegliere la memoria come asse
portante della ricerca costringesse non tanto a un’apertura interdisciplinare, quanto a una vera e
propria rottura delle partizioni classiche del sapere umanistico.
6. Memoria ufficiale e vernacolare.
Se la distinzione di Nora tra “ambiente” e “luoghi” di memoria, o tra comunità vivente della
memoria e commemorazioni del passato storico, è in sé assai dubbia, essa suggerisce però la
presenza di diversi livelli o modalità di costruzione pubblica della memoria, che vanno meglio
precisate. Possono risultare più utili in questa chiave distinzioni come quella formulata da Assman
tra “memoria comunicativa” e “memoria culturale”, intese come modalità che non si succedono
evolutivamente ma coesistono in ogni compagine sociale. La prima è basata principalmente sulla
comunicazione orale quotidiana e su un ambito relazionale relativamente ristretto (famiglia,
comunità locale, gruppi associativi), ha un basso grado di istituzionalizzazione e gerarchizzazione
(non vi sono cioè membri del gruppo che per principio detengono maggiori diritti interpretativi), e
95
Per una critica assai radicale su questi punti a Nora, accusato di “ignoranza storica e pregiudizio”, si veda Elizabeth
Tonkin, Raccontare il nostro passato. La costruzione sociale della storia orale, trad. it. Roma, Armando, 2000 (ed.
orig. 1992), p. 166.
96
Jay Winter, “The generation of memory: Reflections on the ‘Memory Boom’ in contemporary historical studies”,
Bulletin of the German Historical Institute, 27, 2002, p. 1 (http://www.ghi-dc.org/bulletin27F00/b27winterframe.html).
A questo boom Winter ha dato del resto il suo notevolissimo contributo con un celebre testo sui monumenti della
Grande Guerra: J. Winter, Il lutto e la memoria. La Grande Guerra nella storia culturale europea, trad. it. Bologna, Il
Mulino, 1998 (ed. orig. 1995). Si vedano anche i contributi raccolti in J. Winter, E. Sivan (eds.), War and Remembrance
in the Twentieth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
risale indietro nel tempo per poche generazioni: più indietro vi è solo un indistinto passato che tende
a trascorrere nell’oblio. La memoria culturale si determina quando un evento del passato supera
questa barriera dell’oblio ed entra nel patrimonio di ricordi istituzionalizzati di una comunità. Alla
caducità del tempo, essa contrappone dunque elementi di permanenza e di stabilità, che
rappresentano fattori di identificazione di un gruppo, consentendogli – in senso durkheimiano – di
percepirsi come un’unità. La memoria culturale è dunque fortemente istituzionalizzata, legata alle
forme di potere, gestita da specialisti o professionisti, e tende a costituire un “canone” di ciò che nel
passato è prezioso, fondativo, esemplare. Nelle culture antiche studiate da Assman tale canone ha
carattere “sacro”, è cioè separato dal sapere e dalle pratiche ordinarie e quotidiane: ma la sua
funzione sociale resta analoga anche all’interno di culture secolarizzate 97 .
Troviamo qui la contrapposizione tra una memoria istituzionale e formalizzata e una che
potremmo chiamare popolare o quotidiana; un punto chiarito ancora meglio da un’altra coppia di
concetti, memoria “ufficiale” e “vernacolare”. John E Bodnar, nel contesto di uno studio sul
patriottismo e la memoria pubblica americana del Novecento, ha formulato così queste nozioni:
La memoria pubblica emerge al punto di intersezione fra espressioni culturali ufficiali e
vernacolari. Le prime derivano dagli interessi di leader o autorità culturali a tutti i livelli
della società, in posizioni di preminenza in piccole città o in comunità etniche, oppure
nelle burocrazie educative, governative o militari. Questi leader sono accomunati
dall’interesse per l’unità sociale e per la continuità delle istituzioni esistenti, e dalla
lealtà allo status quo. […] La cultura ufficiale si fonda su una riaffermazione della realtà
in termini ideali, evitando la complessità e l’ambiguità: essa presenta il passato su basi
astratte, sacrali e senza tempo […] Dall’altra parte, la cultura vernacolare rappresenta
una gamma di interessi particolari, che affondano le radici in parti dell’insieme sociale.
I difensori di tali culture sono numerosi, e mirano a proteggere valori e a riaffermare
visioni della realtà derivate da esperienza diretta in piccole comunità, piuttosto che
dalle comunità “immaginate” di una vasta nazione. […] Le espressioni vernacolari
trasmettono il senso di come la realtà sociale è avvertita, non come dovrebbe essere. La
loro stessa esistenza è una minaccia per la natura sacra e atemporale delle espressioni
ufficiali 98
Nonostante una certa ambiguità nella nozione di “vernacolare”, e la assunzione per nulla
scontata di una omogeneità della cultura “ufficiale”, questa impostazione del problema introduce
opportunamente l’elemento del conflitto nella comprensione dei luoghi e delle pratiche della cultura
ufficiale. Questo è un progresso importante rispetto alle più classiche nozioni di schemi o quadri
sociali della memoria, che Bartlett e Halbwachs sembravano intendere come ampi scenari di
condivisione, espressione dell’unità del gruppo sociale e non delle sue fratture interne. Luoghi,
oggetti e riti della memoria si configurano dunque non come meccaniche strategie di affermazione
di valori identitari indiscussi e obbligatori, ma come scenari di confronto, di contestazione, di
negoziati fra “voci”, interessi e interpretazioni diverse. Essi sono sì espressione del potere, ma in un
senso che include le dinamiche conflittuali che percorrono il tessuto sociale sull’asse egemoniasubalternità.
Il “memory boom” di cui parla Winter si è occupato però prevalentemente del livello istituzionale
e egemonico, concentrandosi in particolare sulle strategie della memoria usate dagli Stati-nazione in
età contemporanea per costruire un consenso e un senso di identità e appartenenza di massa. Su
97
Jan Assman, La memoria culturale, cit. passim; v. anche Dietz Bering, “Memoria culturale”, in N. Pethes, J. Ruchatz
(a cura di), Dizionario della memoria e del ricordo, cit., pp. 316-19.
98
John E. Bodnar, Remaking America. Public Memory, Commemoration, and Patriotism in the Twentieth Century,
Princeton, Princeton University Press, 1992, pp. 14-15; si veda anche S. M. Rowe, J.V. Wertsch, T. Y. Kosyaeva,
“Linking little narratives to big ones: Narrative and public memory in history museums”, Culture and Psychology, 8
(1), 2002, pp. 96-112.
questo piano, l’interesse per il concetto di memoria si è saldato con l’influenza di studi come quelli
di Mosse sulla nazionalizzazione delle masse e di Hobsbawm e colleghi sull’invenzione della
tradizione 99 . Secondo una diffusa interpretazione, il modello di memoria culturale che oggi ci è più
familiare, legata a un’ampia identità nazionale (o alla sua immaginazione), nasce con le grandi
rivoluzioni moderne, l’americana e la francese. Prima, quelle che si registrano sono memorie
puramente locali oppure memorie dinastiche di respiro cosmopolita. Sono le rivoluzioni, con il loro
culto di un “nuovo inizio” e con il loro senso di rottura con il passato, a dar luogo a espressioni
topografiche e rituali di memoria in grado di coinvolgere la totalità dei “cittadini”. Monumenti,
parate militari e civili, raduni di massa, comizi nei luoghi pubblici più rappresentativi, bandiere e
inni nazionali, insieme al dispiegamento di un’ampia gamma di simboli dalla forte capacità di
coinvolgimento emotivo, sono gli strumenti che consentono l’immaginazione di una comunità
moderna, secondo la celebre espressione di Benedict Anderson: gli strumenti che consentono a
persone lontane, che non si sono mai viste né sentite, di considerarsi legate da un medesimo passato
e da una memoria comune 100 . Questo processo raggiungerà il suo apice nella mobilitazione
militare di massa in occasione delle grandi guerre, soprattutto della Prima Guerra Mondiale, e nelle
celebrazioni di vittoria o di lutto che ad esse fanno seguito.
Questa plasmazione nazionalista di una memoria comune presuppone ovviamente, al tempo
stesso, una condivisione di oblio. Un oblio non solo nei confronti del passato (ad esempio delle
divisioni che contrastano con l’attuale senso di unità), come nella citatissima espressione di Ernest
Renan 101 , ma anche di componenti del presente che non sono viste come fondanti del più profondo
nucleo identitario. Le minoranze etniche, le donne, le classi lavoratrici entrano raramente a far parte
delle memorie ufficiali della nazione, né sono soggetti attivi delle pratiche simboliche di
commemorazione: questo ruolo è per lo più riservato alle élites maschili. Colpisce particolarmente
l’assenza delle donne, alle quali in età moderna non si erigono monumenti, e il cui ruolo è
prevalentemente allegorico (come nelle immagini della Libertà o delle Repubbliche), o di gestione
del lutto per i morti delle guerre. John Gillis fa notare ad esempio come in Francia e Inghilterra, con
l’eccezione della regina Vittoria, gli unici monumenti eretti a donne riguardino figure dei tempi
pre-moderni. La modernità sembra ricordare le donne solo per il loro impersonale ruolo di mogli e
madri, e non per le loro specifiche azioni e personalità 102 .
7. I luoghi della memoria oltre il nazionalismo.
La fase classica delle politiche celebrative nazionaliste esalta dunque la memoria pubblica
istituzionale, lasciando in secondo piano le memorie private e vernacolari, almeno nella misura in
cui non si collocano nel quadro della grande narrazione nazionale (la biografia e la storia locale, in
questo quadro, acquistano senso solo come declinazioni particolaristiche della “storia patria”). Si
tratta tuttavia di una fase che sembra progressivamente esaurirsi nella seconda metà del XX secolo.
Una serie di fattori politici e culturali indeboliscono il ruolo dello Stato nazione, che non è più
l’esclusivo detentore dei mezzi di comunicazione e degli strumenti per la costruzione di
immaginazione comunitaria. La religione civile degli Stati-nazione, che venerano sé stessi
attraverso il proprio passato, è messa in discussione dai disastri della Seconda guerra mondiale; e i
movimenti degli anni ’60 indirizzano la loro critica proprio alle istituzioni fondanti la memoria
99
Gorge L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse. Simbolismo politico e movimenti di massa in Germania (18151933), TRAD. IT. Bologna, Il Mulino, 1975 (ed. orig. 1974); E.J. Hobsbawm, T. Ranger (a cura di), L’invenzione della
tradizione, trad. it. Torino, Einaudi, 1987 (ed. orig. 1983).
100
V. John R. Gillis, “Memory and identity: The history of a relationship”, in J. R. Gillis (ed.), Commemorations. The
Politics of National Identity, Princeton, Princeton University Press, 1994, p. 7.
101
“L’oblio, e dirò perfino l’errore storico, costituicono un fattore essenziale nella creazione di una nazione”; E. Renan,
Che cos’è una nazione, trad. it. Roma, Donzelli, 1993, p. 7 (ed. orig. 1882).
102
J. R. Gillis, “Memory and identity…”, cit., pp. 11-12.
culturale del nazionalismo (esattamente come la rivoluzione borghese l’aveva rivolta ai luoghi e ai
tempi sacri della Chiesa e dell’Antico Regime). Inoltre la globalizzazione, la creazione di “sfere
pubbliche diasporiche”, come le chiama l’antropologo Arjun Appadurai, il flusso di “immagini in
movimento che incrociano spettatori deterritorializzati” 103 , aprono nuove possibilità per la
costituzione di memorie e identità
trasversali, cosmopolite o etniche, transnazionali o
particolaristiche. La memoria culturale si fa assai più complessa rispetto alla descrizione di Assman:
non è più controllata strettamente da specialisti accreditati, non si concentra in luoghi e spazi ben
delimitati: nei decenni finali del Novecento, si presenta come ulteriormente secolarizzata e come
“più democratica”.
Contemporaneamente, la polverizzazione e desacralizzazione della vita pubblica, insieme
all’etica fortemente individualista della società tardo-moderna, conducono a una personalizzazione
delle pratiche di memoria. Coltivare memorie autobiografiche e familiari, in precedenza prerogativa
dei ceti aristocratici o delle élites alto-borghesi, diviene un fenomeno di massa. I diari, le
celebrazioni dei compleanni e degli anniversari di famiglia, la raccolta e periodica consultazione di
fotografie o di videoriprese, la conservazione sistematica di archivi personali (con epistolari, vecchi
quaderni di scuola, documentazione di viaggi e altri eventi significativi), le collezioni di souvenir queste e altre pratiche rievocative e rivolte al passato sono cospicuamente presenti nella
quotidianità della vita privata e domestica nel mondo contemporaneo.
E’ come se, indebolendosi le forme pubbliche e istituzionali della memoria culturale, la funzione
del ricordare ricadesse più direttamente sugli individui, i quali si sentono obbligati a registrare, a
collezionare, a salvare il più possibile i ricordi dalla loro caducità. “Mai in passato si è ricordato e
collezionato così tanto, e mai il ricordare è stato così compulsivo”, scrive ancora Gillis 104 . Si
conserva di tutto, e in questo siamo aiutati dallo sviluppo delle tecnologie di registrazione e di
archiviazione delle informazioni: con la diffusione di magnetofoni, videocamere, personal computer
e supporti digitali a basso costo diviene possibile realizzare archivi personali e familiari di grande
ampiezza. Nell’incertezza su cosa sia più importante ricordare, si può registrare e mettere da parte
tutto, e ci sentiamo in dovere di farlo, come se le nostre esperienze perdessero autenticità se non
lasciano traccia in un supporto archiviabile. In una certa misura, si vive in funzione della futura
memoria: si cercano cioè, ad esempio nell’ambito del turismo, certe esperienze allo scopo di poterle
poi ricordare, rievocare, narrare.
Questa diffusione e polverizzazione delle pratiche di memoria, che saturano la vita quotidiana di
individui e famiglie, ha a che fare con la più generale natura diffusa e privata della ritualità nel
mondo contemporaneo. I piccoli rituali della quotidianità, come ha mostrato Erving Goffman,
possono essere ancora letti secondo la chiave durkheimiana della “produzione del sacro”. Solo che
il sacro non è in questi casi la società, la comunità nella quale l’individuo tendenzialmente si
annulla fondendosi con gli altri, ma lo stesso self individuale. Alla narrazione nazionale del passato,
come origine del significato della storia, si sostituisce la moltitudine delle narrazioni
autobiografiche, tendenzialmente tutte registrabili e raccoglibili in un unico grande archivio, che
attraverso la rete può divenire immediatamente accessibile a tutti.
In qualche modo, dunque, la grande corrente di studi sulle politiche e le poetiche della memoria
dei moderni Stati-nazione finisce per ricongiungersi con gli interessi per la cultura popolare, per le
pratiche vernacolari e quotidiane di gestione del ricordo: due livelli che è sempre più difficile tenere
oggi distinti. Così come è difficile tenere distinti, per riprendere un punto toccato in apertura di
questo articolo, gli approcci, le metodologie, gli strumenti concettuali, di diverse discipline.
8. L’uso pubblico di memoria e identità.
103
Arjun Appadurai, Modernità in polvere. Dimensioni culturali della globalizzazione, trad. it. Roma, Meltemi, 2001
(ed. orig. 1996), p. 17
104
“Memory and identity..:”, cit., p. 14
Vorrei concludere questa rassegna accennando ad alcuni rilevanti problemi che emergono dalle
correnti di studio fin qui esaminate – problemi che avrebbero naturalmente bisogno di una
trattazione di ben altra ampiezza. Intanto, se è vero che viviamo oggi in uno scenario mnestico
post-nazionale, saturo di autobiografia e di oggetti, luoghi e discorsi della memoria tanto
frammentati quanto pervasivi, ciò sembra creare un problema, come si è espresso Charles Maier 105 ,
di “eccesso di memoria”. Rischiamo un po’ di assomigliare a Funes, il personaggio di J.L. Borges
dalla memoria ipertrofica, che ha “più ricordi da solo di quanti non ne avranno avuti gli uomini tutti
insieme, da che mondo è mondo “, e che “due o tre volte aveva ricostruito una giornata intera; non
aveva mai esitato, ma ogni ricostruzione aveva richiesto un’intera giornata” 106 . Funes è citato
spesso come esempio della necessità dell’oblio; ma l’immagine della sua mente “come un deposito
di rifiuti” si presta bene anche a rappresentare il nostro ambiente di memoria, ingombro da icone del
passato formato usa e getta.
L’eccesso di memoria riguarda però anche la produzione storiografica e antropologica. Abituate a
lavorare in regime di relativa scarsità di fonti, queste discipline non si trovano a loro agio in scenari
di fonti sovrabbondanti, in universi archivistici che non potranno mai esser controllati in modo
integrale. Ma soprattutto, ciò che più conta, storia e antropologia sono inevitabilmente coinvolte nei
processi sociali di produzione di memoria: anzi, all’interno del discorso pubblico esse godono di
uno statuto privilegiato – in quanto produttrici scientificamente accreditate di resoconti sul passato,
sulla tradizione, sull’identità culturale. Storici e antropologi sono gli specialisti di quella memoria
culturale che, per altri versi, è invece il loro oggetto di studio. Lo dimostra il loro frequente
coinvolgimento (soprattutto degli storici: il ruolo pubblico degli antropologi è almeno in Italia assai
meno importante) come arbitri o periti tecnici in casi di conflitti nella memoria sociale: ad esempio,
nelle situazioni di “memoria divisa” che ancora oggi dibattono le comunità colpite da eccidi
nazifascisti nell’Italia del ’43-’45. Mentre gli storici studiano la memoria divenendo consapevoli dei
complessi processi culturali tramite i quali essa si costruisce e si plasma, e dunque della sua natura
politicamente e retoricamente strutturata, essi sono chiamati nell’arena pubblica e istituzionale a
testimoniare la semplice e assoluta “verità”, a farsi interpreti di una versione tecnica (cioè non
politica) e oggettiva (cioè non retorica) del passato. In questo ruolo, si trovano fra l’altro a
“competere” con altre figure di portatori o specialisti della memoria, in particolare con quella del
“testimone”, divenuta centrale nello scenario mediatico degli ultimi decenni. Annette Wieviorka, in
un brillante saggio, ha mostrato l’emergere progressivo del testimone come figura-chiave nella
memoria culturale dell’Occidente – un fenomeno legato soprattutto alla memoria della Shoah e
databile, a suo parere, a partire dal processo Eichmann. Wieviorka ha insistito sulla profonda
tensione che si determina fra il sapere e il discorso del testimone e quelli dello storico: la
prospettiva soggettiva, autobiografica ed empatica del primo può rappresentare una fonte per il
secondo, che deve tuttavia trascenderla per conseguire un punto di vista generale, collettivo,
criticamente analitico. Il processo di Gerusalemme inaugura il sogno di una storia costruita come
somma di autobiografie, come “giustapposizione di racconti d’orrore”; e Wieviorka si chiede se
“questa volontà di non pensare in termini generali, o in termini collettivi, non rappresenti in realtà la
negazione stessa della storia. Essa distruggerebbe proprio quell’operazione intellettuale che consiste
nel costruire un racconto e che chiamiamo, per l’appunto, fare storia” 107 .
Per un antropologo è difficile accettare una così severa riserva nei confronti della prospettiva
soggettiva del testimone, e una divaricazione così netta fra la prospettiva autobiografica e quella
storica: quest’ultima, secondo la tradizione epistemologica della disciplina, non può essere
raggiunta se non passando per la prima. Tuttavia il problema che Wieviorka pone è reale: ella si
riferisce al rischio che lo spettacolo del racconto emotivamente partecipato delle esperienze di vita
si sostituisca a un sapere del passato costruito in modo scientifico, che sia cioè possibile sottoporre
105
C. Maier, “Un eccesso di memoria? Riflessioni sulla storia, la malinconia e la negazione”, Parolechiave, 9, 1995, pp.
29-43y
106
Jorge Luis Borges, “Funes, o della memoria”, in Finzioni, trad. it. Milano, Mondadori, 1980 (ed. orig. 1944), p. 90
107
A. Wieviorka, L’era del testimone, trad. it. Milano, Cortina, 1999 (ed. orig. 1998), pp. 105-6
a costante critica e falsificazione secondo criteri condivisi dalla comunità degli studiosi. La grande
sofferenza che emana dai racconti dei sopravvissuti alla Shoah, come i testimoni del processo
Eichmann, può esser considerata come sintomo di autenticità e “verità” della narrazione del passato,
ma anche come un muro di fronte al quale il metodo storiografico non può che infrangersi 108 . E
questo problema sembra porsi con grande forza nello scenario mediale attuale, caratterizzato
appunto dalla spettacolarizzazione dell’intimità biografica e in particolare della esperienza del
dolore. Per inciso, si può ritenere che anche il dibattito odierno sul revisionismo storico risenta di
questa modalità della memoria, confondendo il problema della comprensione di percorsi
autobiografici legati al fascismo (“i ragazzi di Salò”) con il problema del giudizio storico.
Nel loro ruolo di specialisti nella gestione pubblica della memoria, storici e antropologi si
trovano inoltre coinvolti in un ulteriore dilemma, relativo al tema dell’identità. Memoria e identità
sono strettamente legate. Com’è evidente, quella che un gruppo sociale percepisce come propria
identità si concretizza nelle produzioni – discorsive, monumentali, rituali – della sua memoria
collettiva; d’altra parte, il modo in cui la memoria viene pubblicamente costruita e gestita dipende
in larga misura da quella stessa percezione di identità, dai significati, dai valori, dalle finalità che si
ritengono fondamentali indicatori di appartenenza. Elaborato e sostenuto nel corso del Novecento
dall’antropologia, il concetto di identità culturale è da alcuni decenni al centro di una radicale
revisione critica all’interno della disciplina. Pur nato da una irrinunciabile istanza anti-etnocentrica,
il concetto è stato reificato, inteso come una sorta di proprietà sostantiva dei gruppi sociali –
qualcosa che si può ad esempio”perdere”, “recuperare”, una qualità inscritta nei “caratteri”
personali o nel patrimonio culturale. Una simile idea essenziale di cultura si è ampiamente diffusa
dal discorso delle scienze sociali a quello comune, politico e mediale. Ci si raffigura il mondo come
naturalmente diviso in una molteplicità finita di unità culturali discrete, dai confini più o meno netti
e stabili; un immaginario che si lega strettamente alle strategie di autolegittimazione del moderno
Stato-nazione. Richard Handler, un antropologo che ha spinto assai in profondità la critica all’idea
stessa di identità culturale, parla in proposito di
una diffusa teoria della cultura e della società che sostiene una ideologia nazionalista
globalmente egemonica. In questa prospettiva, le nazioni sono immaginate come oggetti
o cose naturali che esistono nel mondo reale. In quanto oggetti naturali, esse possiedono
una identità unica, che può esser definita in relazione a precisi confini spaziali,
temporali e culturali 109
L’odierna critica antropologica si appunta sul fatto che tali identità “naturali” sono in realtà
costruite in base a interessi ed esigenze del contesto presente, e si salda con la discussione che
abbiamo cercato di seguire sul concetto di memoria sociale: fino a riconoscere che “siamo
costantemente impegnati a rivedere le nostre memorie per adattarle alle nostre attuali identità”, nel
quadro di “complesse relazioni di classe, di genere e di potere che determinano ciò che viene
ricordato (o dimenticato), da chi, e a quale scopo” 110 .
Non solo: nata come “innocente” strumento di auto-riconoscimento e immaginazione di comunità
nazionali, l’ideologia identitaria diviene progressivamente sostegno di politiche di esclusione e
aggressione; in epoca di globalizzazione, la troviamo all’opera nel quadro di movimenti xenofobi e
neorazzisti, di fondamentalismi culturali di vario tipo, e soprattutto nei fenomeni della violenza
108
Come nota Wieviorka (Ibid., p. 100), neppure l’avvocato difensore di Eichmann osava contestare la veridicità e la
pertinenza delle numerosissime testimonianze che intervengono nel processo, tanto forte è la loro intensità emotiva ed
etica. Eppure proprio quelle testimonianze pongono problemi riguardo l’ “autenticità” della memoria, se è vero che già
Hannah Arendt notava l’assenza in esse della “capacità di distinguere tra ciò che l’interessato aveva vissuto sedici o
forse vent’anni prima e le cose che aveva letto e udito e immaginato nel frattempo” (H. Arendt, La banalità del male.
Eichmann a Gerusalemme, trad. it. Milano, Feltrinelli, 1999 (ed. orig. 1963), p. 231.
109
R. Handler, “Is ‘identity’ a useful cross-cultural concept?”, in J.R. Gillis (ed.), Commemorations, cit., pp. 28-29
110
J R. Gillis, “Memory and identity”, cit., p. 3
cosiddetta etnica e dei genocidi – dalla Shoah alla ex-Jugoslavia 111 . Il problema è dunque: in quale
misura storici e antropologi coinvolti nelle pratiche di costruzione, gestione, valorizzazione della
memoria e dell’identità pubblica si fanno “complici”, per quanto inconsapevolmente, delle
ambiguità etico-politiche, oltre che epistemologiche, dell’ideologia nazionalista? In che misura il
lavoro sul patrimonio culturale, sulla tradizione folklorica, sugli archivi scritti o orali,
apparentemente mosso da motivazioni innocenti e da alti e puri ideali culturali, si può rivelare
dipendente da presupposti ideologici che supportano un ordine egemonico, un potere dagli effetti
discriminatori? E’ quanto sostiene un’ampia letteratura che, a partire dagli anni Ottanta, ha
“decostruito” il concetto di patrimonio culturale (heritage) e le pratiche di tutela e di rivendicazione
identitaria ad esso legate, mostrandone i nessi strettissimi con le politiche nazionaliste e insistendo
sugli effetti deleteri dell’esportazione su scala globale del modello euro-americano dei beni culturali
come icone della identità di gruppo:
In tutto il mondo, il patrimonio culturale risponde a comuni esigenze e incorpora tratti
comuni. Ma esigenze e tratti sono definiti sulla base di una gelosia sciovinista. Ci
confrontiamo gli uni con gli altri corazzati all’interno di identità, le cui somiglianze
ignoriamo o non vogliamo vedere, inventando o distorcendo invece le differenze per
sottolineare la nostra superiorità. Esaltando le nostre eredità ed escludendo quelle degli
altri, creiamo una situazione endemica di rivalità e conflitto 112 .
Anche qui si manifesta il difficile rapporto che storici e antropologi intrattengono con le pratiche
sociali di costruzione della memoria e dell’identità: protagonisti direttamente coinvolti in tali
pratiche da un lato, in quanto “specialisti” del passato o dell’identità culturale, dall’altro distaccati e
critici osservatori. La storia, come osserva Assman, è una fra le molte forme di produzione di una
memoria pubblica, differenziandosi semmai per il suo carattere “freddo” da quelle “culture del
ricordo” i cui contenuti sono sempre in stretta relazione con l’identità del gruppo che ricorda 113 .
Essa è allora stretta in un duplice rischio: il rischio di appiattirsi sulle auto-rappresentazioni e sulle
istanze identitarie egemoniche e, inversamente, quello di un distacco critico che separa
completamente il ricercatore dalla partecipazione alle politiche culturali della società in cui vive. Se
entrambi questi approdi sono inaccettabili, non v’è tuttavia alternativa a muoversi all’interno della
tensione che essi definiscono. Partecipare alle pratiche di costruzione della memoria pubblica e del
patrimonio culturale, restando consapevoli dei complessi meccanismi che li costituiscono
retoricamente e politicamente nel presente, è il difficile compito che accomuna oggi, a me pare,
storici e antropologi.
111
La letteratura antropologica sul nesso tra la violenza etnica e le politiche di identità del moderno Stato-nazione è
assai estesa. Per una visione d’insieme rimando ai contributi raccolti in A.L. Hinton (ed.), Genocide. An
Anthropological Reader, Oxford, Blackwell, 2002; A.L. Hinton (ed.), Annihilating Difference. Anthropology and
Genocide, Berkeley, California University Press, 2002. Per una formulazione sintetica e ormai in qualche modo classica
della tesi che attribuisce alle ideologie identitarie e culturaliste un’ampia parte di responsabilità nella violenza e nelle
pratiche di pulizia etnica si veda A. Appadurai, “Dead certainty: Ethnic violence in the era of globalization”, Public
Culture, 10 (2), 1998, pp. 225-47. Per un mio più ampio commento su questa letteratura, rimando a F. Dei,
“Antropologia del genocidio”, Parolechiave, numero monografico dedicato a “Occidentalismo”, in corso di stampa.
112
David Lowenthal, “Identity, heritage, and history”, in J. Gillis (ed.), Commemorations, cit., p. 41. Questo autore ha
dedicato alla critica dell’heritage alcuni importanti studi, tra i quali Past is a Foreign Country, Cambridge, Cambridge
University Press, 1985, e The Heritage Crusade and the Spoils of History, Cambridge, Cambridge University Press,
1998; v. anche P.Gathercole, D.Lowenthal (eds.), The Politics of the Past, London, Unwin Hyman, 1990. In campo
strettamente antropologico, l’analisi delle implicazioni nazionaliste del patrimonio culturale è stata sviluppata
soprattutto dall’antropologia critica nordamericana: particolarmente significativo lo studio di Richard Handler sul
Quebec (Nationalism and the Politics of Culture in Quebec, Madison, Wisconsin University Press, 1988). Per
un’applicazione di un simile approccio al contesto italiano v. Berardino Palumbo, L’Unesco e il campanile.
Antropologia, politica e beni culturali in Sicilia orientale, Roma, Meltemi, 2003.
113
J. Assman, La memoria culturale, cit., p. 18
FORTUNA E DECLINO DELLA
CATEGORIA DI CULTURA POPOLARE
NEGLI STUDI ANTROPOLOGICI
ITALIANI
(una versione tedesca di questo saggio è uscita in Jahrbuch fur Europaeische Etnologie, 5,
2010)
1. Introduzione e piano espositivo.
Nei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale l’antropologia culturale conosce in Italia un
significativo sviluppo, incentrato attorno all’interesse per la cultura popolare e a un paradigma
teorico tratto dall’opera di Antonio Gramsci. Nei Quaderni del carcere, Gramsci aveva suggerito di
considerare il folklore in termini di cultura delle classi subalterne. Questa mossa sembrò poter
rifondare radicalmente una tradizione di studi che si era collocata fino ad allora in un ristretto
quadro di positivismo filologico, e che durante il ventennio fascista si era prestata a fiancheggiare le
iniziative di propaganda populista del regime e le sue avventure coloniali. Tra gli anni ’50 e ’70 il
nuovo paradigma produce una ricca letteratura etnografica sulle forme della cultura popolare
tradizionale e soprattutto contadina, proponendone interpretazioni nuove rispetto al passato e
costruendo forti legami con il dibattito antropologico internazionale.
Tutto ciò accade, tuttavia, negli stessi decenni che vedono un rapido e impetuoso processo di
modernizzazione, caratterizzato da industrializzazione diffusa nelle regioni del Centro-Nord, da
inurbamento e spopolamento delle campagne, da diffusione delle nuove tecnologie comunicative;
dunque, dalla scomparsa di quel mondo contadino che era da sempre l’oggetto privilegiato degli
studi folklorici. Le forme della cultura rurale tradizionale divengono sempre più marginali – sempre
più confinate in un passato di cui si può fare magari storia ma non etnografia. Il paradigma
gramsciano imporrebbe di volgere lo sguardo verso nuove forme di cultura delle classi subalterne,
ad esempio quelle della classe operaia o dei ceti medio-bassi urbani. Qui gli antropologi si trovano
però di fronte ad un nuovo e complesso dilemma. Nei contesti industriali, urbani e “moderni” le
classi subalterne non producono un proprio folklore specifico e distintivo, ma per lo più consumano
i prodotti dell’industria culturale. Le premesse teoriche imporrebbero allora di rivolgere l’attenzione
alla cultura di massa, o perlomeno alle modalità del suo consumo. Ma l’antropologia italiana non
accetterà di compiere questo passo, per una serie di motivi che discuteremo oltre. La cultura di
massa sarà vista come estranea al folklore – per certi versi, verrà anzi contrapposta ad esso in
quanto inautentica, artificiosa, oppressiva e repressiva, portatrice di istanze egemoniche. A questo
atteggiamento contribuisce l’ampia ricezione nella cultura italiana delle teorie critiche sull’industria
culturale, in specie quelle della Scuola di Francoforte; ma anche il timore di perdere la specificità
degli studi antropologici e folklorici, che indirizzandosi su un oggetto “moderno” rischierebbero di
“annegare” nell’indistinto campo della sociologia delle comunicazioni di massa.
Tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80 si sviluppa un ampio dibattito sui confini e sulla natura
della cultura popolare in una società post-contadina; un dibattito che tuttavia non troverà sbocchi e
soluzioni comunemente accettate, finendo per porre gli studi italiani in una situazione di empasse. Il
paradigma gramsciano si esaurisce progressivamente, e così l’interesse per una teoria generale della
cultura popolare. Le reazioni sono diverse. Alcuni studiosi e scuole si indirizzano verso esperienze
di ricerca più propriamente etnologiche in aree extraeuropee, saldandosi a filoni di studio francesi e
anglosassoni. Altri, continuando a interessarsi di cultura “popolare”, si concentrano sulle forme di
rappresentazione museografica di tratti della cultura contadina e artigiana; oppure sulla tutela e
valorizzazione di un patrimonio di generi tradizionali (feste, forme di spettacolo) che si sono
mantenuti o sono stati talvolta reinventati nel contesto attuale. Queste pratiche intellettuali sono
spesso assai raffinate sul piano epistemologico e metodologico, e hanno una forte consapevolezza
riflessiva riguardo la natura “costruita” del proprio oggetto. Tuttavia si accontentano di lavorare sui
temi classici consegnati dalla tradizione folklorica (la tradizione orale formalizzata, il lavoro
contadino, le feste e i riti rurali del ciclo dell’anno), abbandonando l’aspirazione a una teoria
generale della cultura popolare e a una sua più ampia rappresentazione etnografica.
In questo saggio, seguirò alcuni passi di questo percorso dell’antropologia italiana dalla metà del
Novecento ad oggi. In conclusione, cercherò di mostrare come una coerente interpretazione del
paradigma gramsciano spingerebbe invece oggi a riformulare una visione della cultura popolare che
tenga conto dei processi di circolazione globale e di comunicazione di massa, sforzandosi di
riconoscere al loro interno una sempre mobile frattura fra egemonico e subalterno.
2. Folklore, etnografia, “popolaresca”: gli studi sulle tradizioni culturali dall’Ottocento al
fascismo.
Nel 1911, per il cinquantennale dell’unità d’Italia, si tenne a Roma una ambiziosa Esposizione
Universale. Tra le principali iniziative, vi fu una Mostra Etnografica delle Regioni, organizzata da
Lamberto Loria, una eclettica figura di viaggiatore e intellettuale che aveva aperto pochi anni prima
a Firenze il primo museo etnografico italiano. La mostra era volta a rappresentare
il documento vivo della spontanea vita popolare, negli usi, abitudini, fogge, negli
utensili e negli strumenti del lavoro […] Nessun paese può, quanto il nostro, offrire
tante varietà e così tenace persistenza di tradizioni locali, tradizioni manifestatesi con
bellezza di colori, di poesia e anche di musica 114 .
Mentre si celebrava l’unità politica, la Mostra intendeva ricordare le caleidoscopiche differenze
culturali ancora presenti nel paese: assumendole tuttavia non come limite ma come ricchezza o
come diremmo oggi “bene culturale”, accanto ai più prestigiosi beni archeologici e storico-artistici.
Come questi ultimi, anche i beni etnografici erano pensati come oggetto di una specifica disciplina
scientifica. Alla Mostra si affianca infatti un ampio Congresso di Etnografia, cui partecipano molti
antropologi, storici delle religioni, linguisti e folkloristi; un congresso che mostra la vivacità di un
settore culturale apparentemente in piena espansione, attento ai dibattiti e alle correnti internazionali
e impegnato su un ampio fronte di ricerche empiriche.
Mai prima l’etnografia e il folklore avevano ricevuto in Italia un così vistoso riconoscimento
pubblico – e per certi versi, mai più lo riceveranno dopo. La Mostra e il Congresso del 1911
rappresentano il culmine di una lunga stagione di studi di impronta positivistica. Nella seconda
metà dell’Ottocento, molti studiosi in campo umanistico (come Alessandro D’Ancona e Costantino
Nigra) si erano dedicati alla raccolta e all’analisi della poesia e della narrativa popolare. Verso la
fine del secolo, soprattutto con il lavoro di Giuseppe Pitrè, l’interesse dei folkloristi si amplia fino
ad includere una più ampia gamma di tratti culturali: le feste e gli spettacoli, il lavoro e la cultura
materiale, la medicina e la religione popolare, le cerimonie del ciclo dell’anno e della vita. Nascono
società di studi, riviste specialistiche, musei e collezioni, nonché specifici insegnamenti universitari
(inaugurati dallo stesso Pitré a Palermo sotto la denominazione di “Demopsicologia”).
Vi sono dunque le condizioni per il consolidamento del campo di studi etnografico; sottratto
all’approccio puramente filologico della folkloristica ottocentesca, esso sembra indirizzarsi con
decisione verso il più vasto ambito delle scienze sociali, anche attraverso fecondi rapporti con le
114
Rassegna Illustrata dell’esposizione, 6/2010, p. xii; cit. in S. Puccini, Itala gente dalle molte vite, Roma, Meltemi,
2005, pp. 16-7
principali scuole europee. Tuttavia, ciò non accadrà. La Prima Guerra Mondiale interrompe
bruscamente questa stagione creativa. Negli anni Venti e Trenta, poi, due fattori di diverso ordine
interverranno a bloccare lo sviluppo di forme moderne di etnografia e antropologia. Il primo fattore
è l’influenza culturale dello storicismo idealistico di Benedetto Croce. Implacabile critico del
positivismo, Croce diffida di ogni pretesa “naturalistica” nella conoscenza dei fenomeni umani e
sociali: vale a dire, di ogni studio che intenda applicare i metodi delle scienze naturali a un ambito
che si presta invece esclusivamente a una intelligenza storica. Colpevoli di questo equivoco sono
soprattutto le scienze sociali, che Croce svaluta come pseudo-scienze, forme di sapere prive di
autonomia epistemologica. Sociologia e antropologia sono dunque messe da parte; ma anche
folklore ed etnografia appaiono al più come discipline meramente documentarie, ancillari rispetto
alla storia e di basso profilo teorico.
Il secondo fattore che contribuisce allo stallo della ricerca antropologica nel periodo fra le due
guerre è l’affermazione del fascismo. Le politiche autarchiche del regime isolano la cultura italiana
dai più vivaci contesti internazionali, in particolare dai dibattiti francesi e anglosassoni.
Praticamente nulla arriva dei fermenti che altrove stanno profondamente mutando le scienze umane.
La cultura italiana si provincializza; il discorso antropologico, oltre a risultare marginale, si attarda
su un paradigma evoluzionista (che peraltro, agli occhi dello storicismo, non può che confermarne
l’ingenuità). D’altra parte il fascismo, analogamente a quanto accade in Germania con le politiche
culturali naziste, è interessato ad appropriarsi del folklore sul piano ideologico. La valorizzazione
della tradizione regionale è un punto di forza delle politiche fasciste di educazione di massa e
costruzione del consenso. Ciò significa da un lato ripresa o invenzione di feste tradizionali, come ad
esempio le Feste dell’Uva in occasione della vendemmia, intese come riti partecipativi di massa;
dall’altro, lo sviluppo di una ideologia ruralista e conservatrice, volta ad esaltare i valori chiave del
regime come il nazionalismo, la devozione cattolica, la concezione della donna come madre e
casalinga. Questa politica fu svolta da una apposita istituzione, l’OND (Opera Nazionale
Dopolavoro), che stabilì stretti legami con il campo degli studi e della ricerca folklorica.
Alcuni dei principali studiosi del periodo, come Raffaele Corso e Giuseppe Cocchiera, aderirono
esplicitamente al fascismo, giungendo persino alla fine degli anni ’30 a sostenerne l’ideologia
razzista e a giustificare con argomenti “antropologici” le sue pretese coloniali. Altri, come Paolo
Toschi, videro nell’attenzione delle istituzioni una possibilità di consolidamento della disciplina,
che poteva essere sfruttata pur mantenendo autonomia scientifica. Speranza, quest’ultima, che
doveva dimostrarsi illusoria. Di fatto, la folkloristica italiana fu quasi interamente inglobata
nell’apparato ideologico del regime (fino ad accettare di cambiare la propria stessa denominazione
in “popolaresca”, evitando per ragioni di autarchia l’uso del termine sassone “folklore”) 115 . Fu
costituito un Comitato Nazionale Italiano per le Arti Popolari (CNIAP), nel quale il ruolo degli
studiosi era decisamente subalterno a quello dei politici.
La rivista Lares, fondata da Loria nel 1912 e interrotta con la Grande Guerra, riprese le
pubblicazioni nel 1930 divenendo strumento di questa visione pesantemente ideologizzata del
folklore: fino a impegnarsi nel sostegno alle politiche della razza (anche attraverso un gemellaggio
con la tedesca Zeitschrift für Volkskunde, nel 1939). “Si vedono rispecchiati nella millenaria
tradizione del nostro popolo i caratteri genuini inconfondibili della razza italiana. Lo studio delle
tradizioni popolari si potenzia quindi in un rinnovato interesse e plasma, oltre tutto, il suo vero
valore sotto l’aspetto politico e sociale”. In queste righe scritte dal direttore Paolo Toschi su Lares
nel 1938 si manifesta, in modo che difficilmente potrebbe essere più esplicito, la metamorfosi
fascista del folklore – e, al tempo stesso, l’esaurimento dell’impresa scientifica che la Mostra e il
Congresso del 1911 avevano fatto sperare.
3. Il paradigma gramsciano
115
Su questo punto si vedano Stefano Cavazza, Piccole Patrie. Feste popolari fra regione e nazione durante il
fascismo, Bologna, Il Mulino, 1997; Roberto Cipriani, “Cultura popolare e orientamenti ideologici”, in R. Cipriani, a
cura di, Sociologia della cultura popolare in Italia, Napoli, Liguori, 1979, pp. 13-57
In effetti, dopo la Seconda guerra mondiale l’interesse per la cultura popolare ripartirà su basi
completamente nuove. Per la verità, un filone di interesse erudito e classificatorio di impianto
positivista per le “tradizioni popolari” non si esaurirà mai completamente, soprattutto sul piano
della ricerca locale; tuttavia, altre saranno le linee-guida teoriche. La prima tra queste consiste in
alcune paginette di “Osservazioni sul folclore” che Antonio Gramsci scriveva nelle carceri fasciste,
negli stessi anni in cui i folkloristi istituzionali si dedicavano all’esaltazione della razza e
dell’impero.
Com’è noto, i Quaderni del carcere furono pubblicati a partire dal 1948, ed esercitarono una
grande influenza sulla cultura italiana dell’epoca (e, successivamente, sugli indirizzi marxisti e
postcoloniali internazionali). In essi, Gramsci offriva un’ampia visione sia della storia e della
cultura italiana che degli scenari economico-politici mondiali, alla luce di una originale
interpretazione della teoria marxista. L’aspetto forse più innovativo del suo approccio consiste nel
sottolineare la complessità degli apparati culturali attraverso i quali le classi dominanti esercitano il
loro potere. Gramsci si lascia alle spalle il determinismo meccanicistico con cui il marxismo
classico affrontava i rapporti tra “struttura” e “sovrastruttura”: intende invece il dominio di classe
come un ampio e capillare processo di “egemonia”, che investe il ruolo dei ceti intellettuali e forgia
in profondità (e in modi spesso non lineari e contraddittori) tutti gli aspetti della vita culturale –
inclusa la cultura, la consapevolezza e la soggettività delle stesse classi subalterne. Nella sua
visione, ogni aspetto della cultura – dalla letteratura all’arte, dalle avanguardie più colte alla cultura
popolare e di massa – si apre a un’analisi storico-politica; e, al tempo stesso, l’emancipazione delle
classi subalterne può apparire come un progetto in certa misura culturale ed educativo.
Come detto, alcune pagine dei Quaderni sono dedicate al folklore; un tema la cui importanza
consiste nel segnalare scarti o dislivelli nel campo culturale che hanno a che fare con le differenze
di classe. Gramsci parte da una netta seppur rispettosa critica alla tradizione di studi erudita e
classificatoria, che “raccoglie” il folklore come “materiale pittoresco” sulla base di un ambiguo e
indifferenziato concetto di popolo. Occorrerebbe invece studiarlo, egli afferma, come
«concezione del mondo e della vita», implicita in grande misura, di determinati strati
(determinati nel tempo e nello spazio) della società, in contrapposizione (anch’essa per
lo più implicita, meccanica, oggettiva) con le concezioni del mondo «ufficiali»…che si
sono succedute nello sviluppo storico 116
Il popolo (cioè “l’insieme delle classi subalterne e strumentali di ogni forma di società finora
esistita”) non può avere – per definizione – concezioni del mondo elaborate, sistematiche e
organizzate. Le risorse per produrre questa elaborazione sono infatti nelle mani dei ceti dominanti.
Per questo il folklore si configura come
agglomerato indigesto di frammenti di tutte le concezioni del mondo e della vita che si
sono succedute nella storia, della maggior parte delle quali, anzi, solo nel folclore si
trovano i superstiti documenti mutili e contaminati 117 .
In altre parole, il folklore si costituisce per “caduta” di elementi residuali e talvolta fossilizzati della
cultura alta. Fin qui, la caratterizzazione è negativa. Il folklore è un insieme disorganico, chiuso e
angusto, che merita di esser studiato solo per poterlo meglio combattere e superare. Finché
l’orizzonte culturale delle classi dominate vi resterà impigliato, esse saranno condannate alla
subalternità e nessun processo emancipativo potrà scattare. Ma non è tutto. In altri passi del testo
116
Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, a cura di V. Gerratana, Torino, Einaudi, 1975 (Quaderno 27, vol. III, p.
2311)
117
Ibid., p. 2312
gramsciano il folklore non è soltanto un deposito inerte di disorganiche sopravvivenze: esso è anche
in grado di.esprimere
una serie di innovazioni, spesso creative e progressiste, determinate spontaneamente da
forme e condizioni di vita in processo di sviluppo e che sono in contraddizione, o
semplicemente diverse, dalla morale degli strati dirigenti” 118 .
In quanto “riflesso delle condizioni di vita culturale del popolo”, il folklore manifesta dunque una
differenza irriducibile rispetto al progetto culturale egemonico: ne rappresenta il limite, ne segnala
la parzialità e introduce se non altro la potenzialità di un’alternativa.
Vi è una tensione interna al pensiero gramsciano sul folklore. Da un lato agglomerato indigesto,
fardello di cui liberarsi lungo la strada della emancipazione dei ceti subalterni; dall’altro, oggettiva
espressione di una resistenza alle strategie egemoniche, forma di cultura non puramente inerte o
fossilizzata ma capace di svilupparsi creativamente e in direzioni progressiste. Del resto, in altri
suoi scritti come le Lettere, Gramsci propone valutazioni sempre assai positive della cultura locale e
popolare (ad esempio, insiste sull’importanza del dialetto nell’educazione scolastica, sulla funzione
espressiva dei canti e del teatro popolare, e così via119 ). Si può ipotizzare che egli intendesse
distinguere una cultura popolare viva, dinamica e storicamente presente da quella pittoresca, arcaica
e residuale raccolta (o meglio “prodotta”) dagli stessi studi folklorici. In effetti, come vedremo
meglio più avanti, nulla in Gramsci sembra legittimare l’idea di una “scienza” che assuma il
folklore come proprio oggetto isolandolo dal più complessivo processo culturale 120 .
Tuttavia, le Osservazioni furono lette come una possibile nuova fondazione degli studi sulla cultura
popolare. In particolare, due aspetti del discorso gramsciano furono decisivi. Il primo è
l’indentificazione del “popolo” con le classi subalterne. Per quanto scontato in una prospettiva
marxista e più in generale sociologica, questo passo rappresentò una rottura radicale rispetto alle
precedenti concezioni romantiche (il popolo-nazione come entità misticamente collettiva) ed
evoluzioniste (il popolo come “primitivi interni”, deposito di sopravvivenze arcaiche). Da
collezione erudita di “antichità”, l’etnografia della cultura popolare si trovò proiettata a pieno titolo
nel cuore del sapere storico-sociale e persino della pratica politica. Il secondo aspetto più influente
riguarda appunto il potenziale anti-egemonico del folklore: studiarlo e valorizzarlo può apparire una
pratica progressista, un modo di dar voce ai ceti subalterni e di contribuire alla loro educazione ed
emancipazione. È curioso osservare, dalla prospettiva odierna, come in soli dieci anni si sia passati
da un folklore conservatore, volto ad esaltare i valori fascisti della guerra, della razza e della
sottomissione della donna, a un folklore contestativo e rivoluzionario, implicitamente socialista. Un
salto mortale che rimanda all’aspro clima politico del tempo, certo, ma che testimonia anche di un
radicale mutamento di paradigma.
4. Ernesto De Martino e le “plebi rustiche del Mezzogiorno”
Il tema del folklore progressivo richiede di introdurre un altro protagonista della ripresa postbellica,
indiscusso padre fondatore della moderna antropologia italiana, vale a dire Ernesto De Martino. Di
formazione filosofica e storico-religiosa, De Martino fu tra gli allievi di Benedetto Croce. Nei suoi
primi scritti degli anni ’40, si dedicò alla critica dei presupposti “naturalistici” dell’etnologia
classica e al tentativo di una sua rifondazione in senso storicista. Nel volume Il mondo magico,
edito nel 1948, propose un originale approccio al tema del pensiero magico e delle pratiche rituali,
118
Ibid., p. 2313
Si veda su questo punto Giovanni M. Boninelli, Frammenti indigesti, Roma, Carocci, 2007.
120
Ho cercato di sviluppare meglio questo punto in Fabio Dei, “Un museo di frammenti. Ripensare la rivoluzione
gramsciana negli studi folklorici”, Lares, LXXIV (2), 2008, pp. 445-66
119
considerate nell’ottica di una heideggeriana “presenza” (in-der-Welt-sein) che nel mondo arcaico
rischia di smarrirsi e trova nella magia una forma di collettiva protezione o riscatto 121 .
De Martino comincia a occuparsi di cultura popolare negli anni successivi, influenzato da
Gramsci e dal marxismo ma soprattutto dalle esperienze di ricerca e di attivismo politico che
compie nel Mezzogiorno d’Italia. Frequenta aree rurali della Lucania e della Puglia come dirigente
dei partiti socialista prima e comunista poi, e sviluppa un forte interesse per la cosiddetta “questione
meridionale” – considerandola nei suoi aspetti culturali oltre che in quelli strettamente economici.
Il “sottosviluppo” del Sud restava in quegli anni un inconcepibile scandalo per un paese
risolutamente avviato a intraprendere la strada della modernizzazione. Era un problema
difficilmente gestibile anche dai partiti della sinistra, che puntavano sulla classe operaia delle grandi
città del Nord come soggetto dinamico e trasformatore, ed avevano difficoltà a confrontarsi con
masse di contadini analfabeti, isolati dal punto di vista comunicativo e immersi in una
Weltanschauung magico-religiosa.
Questo disagio era stato espresso molto bene da un romanzo che conobbe grande fortuna
nell’immediato dopoguerra, Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Medico e intellettuale
torinese, Levi era stato confinato nel 1935 per la sua attività antifascista in un villaggio lucano; nel
libro, edito nel 1945, descrive la sua esperienza come una sorta di incontro antropologico con una
alterità radicale. La piccola società del paese è rappresentata come fuori dalla storia, sospesa in una
dimensione di miseria, immobilità e fatalismo e in una “mentalità primitiva” in cui la realtà si
confonde inestricabilmente con le rappresentazioni magico-religiose. La primitivizzazione dei
contadini del Sud fu assai criticata dalla sinistra marxista, perché l’insistenza su questioni di
“mentalità” rischiava di nascondere le condizioni storiche e materiali dell’arretratezza e
dell’oppressione 122 . Critiche condivise da De Martino, che tuttavia era interessato ad evidenziare la
dimensione culturale della “questione meridionale” contro un troppo schematico determinismo
economico. Il che apriva la possibilità di studiare la cultura, il folklore e la religione delle “plebi
rustiche del Mezzogiorno” non come una collezione di tratti arcaici e pittoreschi, bensì come
aspetti centrali della loro condizione storica e sociale.
È quanto De Martino cerca di fare nelle tre grandi monografie sul Mezzogiorno che pubblica tra la
fine degli anni ’50 e i primi anni ’60, dedicate rispettivamente alle pratiche del lutto e al pianto
rituale 123 , alla fenomenologia magica popolare in Lucania 124 , e infine – in quello che è
probabilmente il suo capolavoro – al complesso mitico-rituale del tarantismo, una forma di culturebound syndrome diffusa nel Salento (Puglia) e curata attraverso riti collettivi di tipo coreuticomusicale 125 . In queste opere di grande respiro, il mondo magico-religioso dei contadini poveri
appare come tutt’altro che irrazionale o residuale: De Martino ne mostra in modo assai convincente
la natura di dispositivo di radicamento esistenziale e di protezione della “presenza” in un mondo
dominato dall’incombere quotidiano della miseria e dell’oppressione. Non manca inoltre di porre in
costante relazione le pratiche popolari e subalterne con lo sviluppo storico del discorso egemonico.
I due livelli ridefiniscono costantemente l’uno rispetto all’altro i propri confini: tanto che la
persistente vivacità dell’elemento magico e del paganesimo sincretico, evidente ad esempio nel
culto miracolistico dei santi o della Vergine, può esser letto come una forma di resistenza alla forza
di penetrazione della cultura dominante (sia quella della Chiesa che quella dello Stato secolare
moderno).
Ne emerge quindi una valorizzazione di quanto alla folkloristica positivista appariva come pura
sopravvivenza di superstizioni e pregiudizi arcaici. La religione e la magia popolare sono razionali
e persino efficaci: svolgono bene il lavoro della cultura, che è quello di tener radicati gli esseri
121
Ernesto De Martino, Il mondo magico, Torino, Einaudi, 1948.
Per una ricostruzione di questo dibattito si veda P. Clemente, M.L. Meoni, M. Squillacciotti, Il dibattito sul folklore
in Italia, Milano, Edizioni di Cultura Popolare, 1980
123
E. De Martino, Morte e pianto rituale, Torino, Boringhieri, 1958
124
Id., Sud e magia, Milano, Feltrinelli, 1959
125
Id., La terra del rimorso, Milano, Il Saggiatore, 1961
122
umani nel mondo. Lo fanno, per De Martino, attraverso un meccanismo di “destorificazione”. In
una quotidianità dominata dalla minaccia del negativo, rito e mito aprono una dimensione
metastorica che conferisce sicurezza, permettendo di “stare nella storia come se non ci si fosse”.
D’altra parte, proprio in ciò consiste il limite storico della magia: essa protegge esistenzialmente le
comunità subalterne mentre, al tempo stesso, le tiene confinate fuori dalla storia. Vale a dire, fuori
dalla possibilità di risolvere i loro problemi nella dimensione della politica, attraverso un reale
processo emancipativo. Per questo De Martino finisce per auspicare in ultima analisi la scomparsa e
il superamento del proprio stesso oggetto di studio: la magia lucana o il tarantismo pugliese sono
istituti di riscatto esistenziale che tengono tuttavia i ceti rurali intrappolati nelle condizioni reali
della propria oppressione. Per De Martino, come peraltro per Gramsci, nella rivoluzione non c’è
posto per la magia. L’emancipazione richiede la conquista, da parte delle classi subalterne, dell’alta
cultura.
Eppure, in alcuni scritti, De Martino apre alla possibilità di un uso progressivo del folklore. Nelle
sue attività sia politiche che di ricerca si imbatte spesso in canti popolari e altre forme
dell’espressione orale che sono creativamente modificati per esprimere contenuti di protesta e di
supporto alle lotte contadine 126 . Un folklore apparentemente immobile e fossilizzato dimostrava qui
vitalità, capacità di dar voce a quella che i marxisti chiamavano allora “coscienza di classe”. Nel
“folklore progressivo” De Martino vedeva la soluzione al dilemma posto da Gramsci – se e in che
modo le classi subalterne possono usare una propria distintiva e oppositiva cultura nella lotta per la
liberazione. Fra l’altro, questa convinzione lo portava a valorizzare esperienze di confine tra cultura
alta e popolare, come quella di Rocco Scotellaro, il poeta-contadino lucano che rappresenta un’altra
figura-chiave del meridionalismo postbellico, e la cui opera Contadini del Sud costituisce un
pionieristico esempio di uso delle storie di vita nell’analisi sociale 127 .
Per la verità, lo stesso De Martino non coltivò a lungo la nozione di folklore progressivo. Tuttavia
essa ebbe larga influenza, non solo nel campo della ricerca ma anche e soprattutto in quello della
produzione culturale e artistica. Ad un uso contestativo e politicamente impegnato di forme
espressive della tradizione popolare si dedicarono a partire dagli anni ’50 vari progetti artistici,
come Cantacronache, il Nuovo Canzoniere Italiano e I dischi del sole. In essi era centrale l’idea di
una produzione culturale dal basso, fondata su una diretta presa di parola dei ceti subalterni, e al
tempo stesso una idea brechtiana di spettacolo popolare come forma di educazione e presa di
coscienza delle masse. Un tema che cercherò di chiarire nella prossima sezione.
5. “Elogio del magnetofono”: Gianni Bosio e la storia dal basso
Nella prospettiva che abbiamo visto finora aprirsi, un aspetto cruciale è la posizione engagé assunta
dal ricercatore. Studiare la cultura popolare non è come raccogliere farfalle: nel far emergere tratti
distintivi dei ceti subalterni, il ricercatore necessariamente partecipa alla battaglia educativa e
politica per la loro emancipazione. Il nuovo folklorista, per usare la celebre espressione di Gramsci,
si fa dunque “intellettuale organico” alle classi subalterne. È ancora De Martino ad esprimere con
la massima efficacia questo biunivoco rapporto tra conoscenza e impegno, quando scrive, a
proposito del suo lavoro in Salento:
Io entravo nelle case dei contadini pugliesi come un 'compagno', come un cercatore di
uomini e di umane dimenticate istorie, che al tempo stesso spia e controlla la sua
propria umanità, e che vuol rendersi partecipe, insieme agli uomini incontrati, della
fondazione di un mondo migliore, in cui migliori saremmo diventati tutti, io che cercavo
e loro che ritrovavo 128 .
126
E. De Martino, “Intorno a una storia del mondo popolare subalterno”, Società, V (3), 1949, pp. 411-35; Id., “Note
lucane”, Società, VI, (4), pp. 650-67.
127
Rocco Scotellaro, Contadini del Sud, Bari, Laterza, 1954
128
E. De Martino, “Etnologia e cultura nazionale negli ultimi dieci anni”, Società, IX (3), 1953, p. 319
Questo “rendersi partecipe” consiste in primo luogo nel “dar voce” ai contadini poveri del Sud,
operando una mediazione altrimenti impossibile fra il livello subalterno e quello egemonico. “Non
ci abbandonare tu che sai, tu che puoi, tu che vedrai” – dice un vecchio contadino a De Martino: o
almeno questa è la storia che lui racconta 129 , una sorta di mito d’origine dell’intellettuale organico.
La poetica e la politica del “dar voce” sta al centro degli interessi per la cultura popolare tra anni
’50 e ’60, ispirando molte altre esperienze che tentano di coniugare la passione etico-politica con
una nuova visione della storia e delle scienze umane. E ciò non vale soltanto nell’“arretrato”
Mezzogiorno. Nell’Italia del Nord occorre almeno ricordare il lavoro di Gianni Bosio, singolare
figura di intellettuale, politico e organizzatore di cultura che persegue il progetto radicalmente
anticrociano di una storia dal basso. Scomparso prematuramente all’età di 48 anni, Bosio non ha
lasciato opere di ampio respiro, ma una serie di scritti e soprattutto un’attività di ricerca sul
territorio che hanno fatto scuola 130 . Particolarmente influente è stato il suo “Elogio del
magnetofono”, testo introduttivo a una raccolta di fonti orali che esprime una poetica (per non dire
un metodo) che sarà condiviso da generazioni di studiosi:
L’avvio degli studi sulla cultura del mondo popolare e proletario segna col
magnetofono una datazione nuova. Il magnetofono documenta la presenza costante
della cultura oppositiva la quale proviene non soltanto dalla obiettiva presenza storica
delle classi popolari e della classe operaia, ma anche dalle forme di consapevolezza […]
La possibilità di fissare col magnetofono modi di essere, porsi e comunicare (così come
la pellicola permette di fissare in movimento feste riti e spettacoli) ridona alla cultura
delle classi oppresse la possibilità di preservare i modi della propria consapevolezza,
cioè della propria cultura. 131
Bosio, diversamente da De Martino, lavorava in contesti contadini e operai con consolidate
tradizioni di organizzazione politica e sindacale; il che lo portava ad accentuare il tema della
“consapevolezza”, cioè delle forme culturali assunte dalla coscienza di classe. Il carattere
progressivo non era per lui una occasionale eccezione; anzi l’esplicito impegno oppositivo e di
protesta rispondeva ad una interna logica di sviluppo creativo del folklore. Bosio era interessato
molto di più ai fenomeni di trasformazione che a quelli di permanenza. E sembrava non esservi per
lui soluzione di continuità tra la registrazione “sul campo” di canti o performance di teatro popolare
e l’organizzazione di spettacoli destinati al pubblico “colto” delle città, nei quali i motivi della
tradizione si fondevano con i repertori socialisti o anarchici e con canzoni di protesta attualizzanti.
È il caso di “L’altra Italia”, rassegna della “canzone popolare e di protesta vecchia e nuova”, dello
spettacolo “Ci ragiono e canto”, dei concerti del Nuovo Canzoniere Italiano e della importante serie
discografica “I dischi del sole”: tutte iniziative degli anni ’60, fondative di quello che potremmo
chiamare il folk politicamente impegnato, un genere ancora oggi ben vivo e che ha trovato in Ivan
Della Mea, cantante e intellettuale recentemente scomparso, il suo più denso interprete 132 .
L’immagine dell’ “intellettuale rovesciato”, con cui Bosio titola la sua più importante raccolta di
saggi 133 , esprime perfettamente il rapporto tra cultura popolare e mondo engagé della ricerca di
quegli anni. Il magnetofono è lo strumento magico che consente di invertire il rapporto tra cultura
“alta” e “bassa”, che spinge l’intellettuale a imparare dalle classi subalterne e non (o non solo) a
insegnare. Si apre qui una intensa stagione di lavoro sulle fonti orali. La diffusione di mezzi di
129
Ibid.
Una scuola rappresentata soprattutto dall’Istituto Ernesto De Martino, fondato a Milano dallo stesso Bosio nel 1966 e
ancora oggi operante (con sede a Sesto Fiorentino) come centro di ricerca e archivio di fonti orali
131
Gianni Bosio, “Elogio del magnetofono”, in Id, L’intellettuale rovesciato, Milano, Edizioni Bella Ciao, 1975, pp.
169-81 (ed. orig. 1970)
132
Per una accurata ricostruzione della biografia di Bosio e delle sue iniziative culturali si veda Cesare Bermani,
“Gianni Bosio: cronologia della vita e delle opere”, http://www.iedm.it/bio_bosio.php (7-02-2010)
133
Gianni Bosio, L’intellettuale rovesciato, Milano, Edizioni Bella Ciao, 1975 (ed. orig. 1967)
130
registrazione audio a costi relativamente accessibili fa intravedere nuove e sterminate possibilità
documentarie. Queste sono relative da un lato alle forme classiche della tradizione orale, come il
canto e la fiaba; per quest’ultima, ad esempio, si svolge tra il 1968 e il 1972 - per iniziativa della
Discoteca di Stato - una grande campagna di raccolta in tutte le regioni italiane 134 , che apre a una
più vasta visione della narrativa orale popolare anche al di là del genere fiabistico in senso stretto.
Dall’altro lato, le possibilità documentarie del magnetofono si estendono ai racconti di guerra e
della Resistenza, alle storie di vita, alla fenomenologia della vita quotidiana. Si tratta spesso di
iniziative locali, mosse da passione etico-politica e non sempre supportate da competenze
metodologiche; mancano standard tecnici condivisi, così come criteri comuni di conservazione,
catalogazione e trattamento delle fonti. Prevale però il carattere “eroico” di un’impresa che viene
percepita come di radicale rottura rispetto al passato.
Non è solo l’antropologia a “scoprire” le fonti orali, ma ovviamente anche la storia. E anche nella
storiografia la nozione di cultura popolare ha grande fortuna soprattutto a partire dagli anni ’60. Le
fonti di questo interesse erano molteplici: fra le altre, la “storia dal basso” delle classi subalterne
proposta da marxisti inglesi come Eric Hobsbawm e Edward P. Thompson, e l’ampia influenza
della scuola francese delle Annales, con la sua insistenza sui temi della vita quotidiana, delle
“mentalità” e delle strutture di lunga durata. Come sottolineava Carlo Ginzburg in un testo scritto
nel 1979 135 , nei 15-20 anni precedenti la cultura popolare era stata quasi una moda nella storiografia
internazionale: una moda arrivata in Italia in modo non sistematico, ma che si era solidamente
innestata, appunto, nei dibattiti aperti dai testi gramsciani e dal tipo di antropologia praticata da De
Martino. Proprio Carlo Ginzburg è stato il principale (o almeno il più noto) interprete dell’interesse
storico per il popolare, in particolare nei suoi primi lavori come I Benandanti, del 1966, e Il
formaggio e i vermi, pubblicato 10 anni dopo 136 . Lavorando su fonti del XVI secolo, Ginzburg
tentava di delineare un sostrato di cultura popolare e subalterna distintivo e resistente rispetto alla
cultura egemonica, e che poteva però rivelarsi indirettamente solo attraverso l’esame di documenti
egemonici, come i verbali dei processi dell’Inquisizione. Proprio questa necessità di leggere le fonti
per così dire in traslucido, interpretando il non detto e lavorando sulle incongruenze del discorso
egemonico, accentua il contrasto fra le due culture e fa immaginare che i frammenti subalterni oggi
ancora accessibili fossero parte di un insieme organico e strutturato. Certo, il lavoro sulle fonti
storiche è assai diverso da quello sulle fonti orali contemporanee: eppure fra i due si è potuto
stabilire un rapporto forte, ed è persino possibile rivendicare una fondamentale unità del campo di
studi 137 .
6. Alberto M. Cirese e il consolidamento della nuova demologia.
Abbiamo visto finora quanto poco si possa separare la storia degli studi dalla più generale storia
politica e sociale in cui si colloca. Questo vale a maggior ragione per il periodo cui siamo arrivati,
gli anni ’60. Qui il dibattito sul folklore ha ormai preso le sembianze della passione per la “storia
dal basso” e per il progetto di dar “voce” (letteralmente, attraverso il magnetofono) alle classi
subalterne; a loro volta tali passioni e tali progetti si alimentano dei fermenti sociali, delle ideologie
politiche, delle trasformazioni culturali dell’epoca. E non è solo il clima del Sessantotto a farsi
134
Discoteca di Stato, Tradizioni orali non cantate; primo inventario nazionale per tipi, motivi o argomenti, a cura di
A. M. Cirese e L. Serafini,Roma, Ministero dei beni culturali e ambientali, 1975.
135
Si tratta della introduzione alla traduzione italiana al volume di Peter Burke, Cultura popolare nell’Europa moderna,
Milano, Mondadori, 1979, pp. i-xv
136
C. Ginzburg, I benandanti. Ricerche sulla stregoneria e i culti agrari tra Cinquecento e Seicento, Torino Einaudi,
1966; Id., Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del Cinquecento, Torino, Einaudi, 1976.
137
Lo ha sostenuto Gian Paolo Gri a proposito proprio del tema dei Benandanti, rinvenendo nella tradizione orale del
Friuli attuale temi assai vicini a quelli documentati da Ginzburg per il ‘500 (G.P. Gri, “Fonti orali di oggi per la storia di
ieri? Il caso dei Benandanti”, in C. Bermani, a cura di, Introduzione alla storia orale. Storia, conservazione delle fonti e
problemi di metodo, vol. 1, Roma, Odradek, 1999, pp. 191-209.
sentire: come vedremo, le discussioni sulla cultura popolare saranno ugualmente influenzate (sia
pure in modi obliqui) dai mutamenti economici e demografici, dall’accentuata mobilità sociale, dal
rapido incremento dei livelli di istruzione, dalla diffusione del consumo e della cultura di massa.
Restiamo però ancora un po’ nell’ambito della definizione accademica del campo di studi. De
Martino muore improvvisamente nel 1965. Per quanto avesse costantemente lavorato sulla cultura
popolare, non si era mai sentito o dichiarato un folklorista (forse anche in contrapposizione ad
alcuni folkloristi suoi contemporanei, come Paolo Toschi, che si attardavano in una visione
puramente filologica, positivista e “pittoresca” della disciplina) Per De Martino, la cultura popolare
non definiva una disciplina: era semmai un ingrediente fondamentale di un sapere che di volta in
volta definiva come etnologico, storico-religioso o storico tout court.
Dopo di lui, verso la fine degli anni ’60, alcuni studiosi sentono invece il bisogno di dare nuova
sistematicità e unità allo studio della cultura popolare, recependo le impetuose ma talvolta caoticihe
innovazioni postbelliche, ma al tempo stesso stabilendo una continuità con una tradizione
folklorica italiana risalente almeno al romanticismo ottocentesco. Il principale interprete di questa
esigenza è probabilmente Alberto M. Cirese. Figlio d’arte (il padre Eugenio era poeta dialettale e
editore di una rivista di tradizioni popolari molisane, La lapa), Cirese è studioso di ampio respiro:
pratica il campo del folklore regionale (occupandosi in particolare di canti e proverbi), ma è molto
attivo anche nel dibattito politico-culturale attorno al meridionalismo ed è tra i primi a traghettare in
Italia importanti indirizzi dell’antropologia internazionale (in particolare la semiotica e lo
strutturalismo, curando tra l’altro la traduzione italiana di Le strutture elementari della parentela di
Lévi-Strauss). Per quanto la sua produzione fra gli anni ’60 e ’70 sia vasta e influente, il suo testo
più noto è probabilmente un manuale, dal titolo Cultura egemonica e culture subalterne 138 , su cui si
sono formate intere generazioni di antropologi in Italia (inclusa quella di chi scrive, studente alla
fine degli anni ’70). Manuale che, come spesso accade, meglio della produzione saggistica riesce ad
esprimere un paradigma teorico, una intera concezione di una disciplina.
Già il titolo del manuale è programmatico. Cirese ritiene la pubblicazione delle “Osservazioni sul
folclore” di Gramsci il “momento teorico determinante” per il rinnovamento degli studi demologici
italiani:
l’impostazione marxista di Gramsci opponeva allo storicismo idealistico il
ristabilimento del legame tra fatti culturali e fatti sociali che viceversa Croce aveva così
recisamente negato; liquidava in modo definitivo le ibride eredità della nozione
romantica del «popolo-anima» o «popolo-nazione»,…ed introduceva una
determinazione storico-sociale precisa: quella del «popolo-classi subalterne», inteso
ovviamente come «variabile storica» 139 .
Cirese era convinto che la definizione gramsciana potesse offrire una rigorosa delimitazione
dell’oggetto di studio della rinnovata disciplina, che preferiva chiamare “demologia” (un termine
che col tempo diventerà la denominazione ufficiale nell’insegnamento universitario, pur
sopravvivendo fino ad oggi anche la precedente etichetta “Storia delle tradizioni popolari”). Ed era
anche convinto che, come accade nelle rivoluzioni scientifiche, il nuovo paradigma fosse in grado
di riassorbire il vecchio: in altre parole, il corpus di studi folklorici dell’Ottocento e della prima
metà del Novecento poteva essere utilmente integrato all’interno della più complessa e raffinata
visione aperta da Gramsci. Cirese riformula i principi gramsciani attraverso la teoria dei “dislivelli
interni di cultura”: riferendoci “ai comportamenti e alle concezioni degli strati subalterni e periferici
della nostra stessa società” ci troviamo di fronte a dislivelli culturali interni, mentre con dislivelli
esterni intendiamo il rapporto con le “società etnologiche o «primitive»”140 . Una definizione da cui
scaturisce una chiara delimitazione delle discipline: l’etnologia studia i dislivelli esterni, la
138
Alberto M. Cirese, Cultura egemonica e culture subalterne, Palermo, Palumbo, 1971
Ibid, p. 218
140
Ibid, p.10
139
demologia quelli interni. Più precisamente, quest’ultima studia la diversità culturale che si
accompagna alla diversità della condizione sociale: diversità nella quale “si manifesta la disuguale
partecipazione dei diversi strati sociali alla produzione ed alla fruizione dei beni culturali” 141 .
Accurato lettore di Gramsci, Cirese evita di stabilire un rapporto troppo meccanico e deterministico
tra appartenenza di classe e livelli culturali; è attento, come diremmo oggi, a non essenzializzare la
cultura subalterna. Parla piuttosto di fatti culturali “popolarmente connotati”, dove “connotazione”
indica un “rapporto di solidarietà” tra aspetti della cultura e gruppi sociali o classi 142 . La sua è
dunque una definizione relazionale. Se un oggetto è popolare o no dipende dal suo posizionamento
nella dinamica egemonico-subalterno all’interno di un preciso contesto storico: può anche accadere
che il medesimo “fatto culturale” risulti egemonico in un contesto e popolare in un altro (ad
esempio il pianto rituale, oggetto di studio di Cirese come di De Martino, è egemonico nella società
omerica ma subalterno nel Mezzogiorno italiano di oggi).
Tuttavia, come detto, Cirese è anche preoccupato di delimitare la disciplina sulla base di un oggetto
peculiare e distintivo; il che lo porta a sovrapporre alla definizione relazionale una più essenziale o
sostantiva. La prima spingerebbe a studiare non un “oggetto” specifico, ma le dinamiche storiche
che producono la frattura egemonico-subalterno; vale a dire, i processi di differenziazione e le
relazioni fra classi nella produzione e nel consumo culturale. La seconda definizione spinge invece
a porre al centro dell’attenzione alcuni “fatti culturali”, che poi in buona parte coincidono con quelli
studiati dalla tradizione folklorica. Questi “fatti” costituirebbero una “cultura” popolare che può e
deve esser studiata in modo autonomo e separato rispetto a quella egemonica. Cirese rafforza
questo punto quando afferma degli studi demologici che “tra tutti i comportamenti e le concezioni
culturali essi isolano e studiano quelli che hanno uno specifico legame di «solidarietà» con il
«popolo» (in quanto distinto dalle «élites»)” 143 .
Cirese adotta qui una epistemologia naturalistica, secondo la quale ogni scienza deve “isolare” con
chiarezza un proprio oggetto (sul quale compiere operazioni di descrizione, classificazione,
generalizzazione). Ma naturalmente isolare certi fatti culturali dalla dinamica storica complessiva
che attribuisce loro una connotazione egemonica o popolare è proprio quanto la teoria gramsciana
vieta di fare. Cirese conclude il suo manuale esortando gli studi demologici – a “fare in conti – e
non genericamente – con la realtà socio-culturale contemporanea, con le forze e le ideologie che la
animano…, trasformandosi in conseguenza” 144 . Al tempo stesso, sembra però convinto che
l’oggetto della demologia sia costituito essenzialmente dai repertori tradizionali del folklore
contadino. Una contraddizione, o almeno una tensione, che come vedremo si farà pesantemente
sentire negli sviluppi degli anni successivi.
7. La questione della cultura operaia.
Verso la fine degli anni ’70, la rifondazione della demologia sulla base del “paradigma” gramsciano
è largamente condivisa nel panorama degli studi italiani. Sono anni di intenso sviluppo della
disciplina, sia nel campo della ricerca che in quello dell’insegnamento universitario. Beninteso, gli
orientamenti e gli stili di ricerca sono tutt’altro che compatti: vi è anzi una geografia accademica
complessa e frastagliata, che sarebbe impossibile restituire qui anche solo per tratti fondamentali.
Ad esempio, la scuola di Cirese si differenzia piuttosto nettamente dagli studiosi, specie
meridionalisti, che più direttamente si riconoscono nell’eredità di De Martino; quest’ultima è a sua
volta frammentata, e combinata in diversi studiosi con dosi diverse di marxismo, strutturalismo,
semiologia (è il caso di figure come Clara Gallini, Annabella Rossi, Luigi M. Lombardi-Satriani,
Antonino Buttitta, Elsa Guggino). Ulteriori orientamenti sono quelli più influenzati
dall’antropologia culturale anglosassone, per lo più antistoricisti e vicini alla sociologia (una
141
Ibid, p. 12; corsivo nell’originale.
Ibid, pp. 13-4.
143
Ibid. p.13; corsivo mio.
144
Ibid., p. 310; corsivo nell’originale.
142
tradizione aperta in Italia da Tullio Tentori). Vi sono poi singole figure di studiosi, scarsamente
riconducibili a schieramenti, che sviluppano gli interessi per la cultura popolare in relazione a
specifici ambiti tematici – come Vittorio Lanternari e Alfonso Di Nola per l’antropologia della
religione, Tullio Seppilli per l’antropologia medica, Diego Carpitella e Roberto Leydi per
l’etnomusicologia.
Questa generazione di studiosi nati per lo più negli anni ’20 e ’30, pur con accenti molto diversi,
sembra tuttavia condividere il progetto della nuova demologia, ed è accomunata dal considerare la
questione della cultura popolare come fulcro della tradizione antropologica italiana. Nel 1980 nasce
una nuova rivista antropologica, La ricerca folklorica (che esce ancora oggi e ha rappresentato
un’esperienza significativa in un panorama editoriale ricco ma frammentato e sempre molto
precario); il primo numero è dedicato appunto a “La cultura popolare. Questioni teoriche”. Il
direttore, Glauco Sanga, aveva proposto ad alcune decine di studiosi, soprattutto antropologi ma
anche filosofi, storici e sociologi, di rispondere a un questionario che enunciava i principali
problemi aperti nel dibattito sul “paradigma gramsciano”. Tutti davano per scontato che si trattasse
di un tema condiviso, che accomunava orientamenti teorici diversi e sul quale si misuravano i
rapporti dell’antropologia con le altre discipline e con il grande campo – certamente egemone nella
cultura e nell’accademia italiana del tempo – del marxismo 145 .
Il questionario, dopo un rapido accenno ai problemi sollevati dal concetto di cultura per la
molteplicità delle sue accezioni, si sofferma sulla nozione di popolo. Accettando la
caratterizzazione gramsciana del popolo come classe, come si configura la “cultura del popolo”? Si
tratta di una entità unitaria, legata alla qualità subalterna di tale cultura, oppure si dovrà pensare che
ad ogni ceto sociale corrisponde una particolare cultura, e dunque che le culture subalterne sono
molte? 146 Il questionario si sofferma sulla questione cruciale della classe operaia: “Va o no
collocata nell’ambito della cultura popolare? Se si esclude la cultura operaia l’ambito della cultura
popolare viene ridotto alle classi precapitalistiche residuali, recuperando in pieno l’elemento della
tradizione, in misura sostanziale quello dell’oralità, e recuperando la teoria dell’antico” 147 . In altre
parole, escludere la cultura operaia garantisce la continuità con la tradizione folklorica. Ma – si
chiede il questionario – si può applicare il concetto moderno di classe alle realtà rurali
precapitalistiche, per le quali si invocano invece spesso nozioni interclassiste come quelle di
“mentalità”? E d’altra parte, se si considera la cultura operaia parte integrante del campo di studi
demologico (coerentemente con la definizione di popolo come classe), sorgono altre difficoltà. È
possibile attribuire ad essa quel carattere di alterità, quella natura peculiare e distintiva che si è soliti
attribuire alla cultura contadina tradizionale?
Dobbiamo considerare la cultura popolare come “altra” rispetto a quella egemone,
facendo prevalere il criterio della distinzione, e secondo alcuni anche della
contrapposizione (oggettiva o anche soggettiva)? O dobbiamo preferire una concezione
dinamica, che veda nei contatti tra culture diverse momenti di integrazione e di
scambio, regolati dalla dialettica egemonia/subalternità? 148
145
A rafforzare questa impressione contribuiscono due numeri della prestigiosa rivista Problemi del socialismo, usciti
l’anno precedente e dedicati a “Orientamenti marxisti e studi antropologici italiani. Problemi e dibattiti” (15 e 16,
1979), anch’essi in buona parte incentrati attorno al problema della cultura popolare.
146
“Introduzione”, La ricerca folklorica, 1 (1980), p.3.
147
Ibid, p. 4.
148
Ibid. Il riferimento alla “contrapposizione oggettiva o anche soggettiva” della cultura popolare rinvia alla tesi del
folklore come cultura di contestazione, che per la sua stessa esistenza segnala i limiti della cultura egemone e che
contiene perlomeno in germe l’istinto di classe. A cavallo fra anni ’60 e ’70, questa prospettiva era stata sviluppata in
particolare in alcuni lavori di L. M. Lombardi-Satriani (Il folklore come cultura di contestazione, Messina, Peloritana,
1966; Menzogna e verità nella cultura contadina del Sud, Napoli, Guida, 1972; Antropologia culturale e analisi della
cultura subalterna, Rimini, Guaraldi, 1974).
In altre parole, sia pure forzando un po’ le parole del questionario: ha senso considerare quella
operaia come una cultura in senso antropologico – cioè autonoma, “altra”, compatta e demarcata da
confini relativamente netti? Queste qualità sembravano appartenere alla cultura contadina, in virtù
del suo isolamento geografico, comunicativo e sociale. Ma non è questo il caso per il mondo
operaio, specie in quella fase della sua storia caratterizzata dall’accesso al consumo e ai mezzi di
comunicazione di massa e da confini sempre più sfumati rispetto ad altri segmenti sociali come i
ceti medio-bassi. Questi aspetti appaiono cruciali al questionario, che li riunisce sotto due
“delicatissime questioni: che rapporto c’è tra popolo e ceti medi? […] Che rapporto c’è tra cultura
popolare e comunicazione di massa?”. Il che porta lucidamente a concludere:
Accogliere l’impostazione gramsciana, che vede come essenziale il momento
dell’assunzione di un fatto culturale e come non rilevante il momento della produzione
non significa forse mettere in discussione l’autonomia della cultura popolare e
ridimensionarne in qualche misura l’alterità, per concentrare l’attenzione sui
meccanismi della dinamica culturale all’interno di una societa complessa, considerata
come un tutto interagente, con una sola storia e non come una somma di parti (la
cultura egemone e la sua storia più la cultura subalterna e la sua storia)? 149
Il questionario di La ricerca folklorica, mentre finge di porre domande ad ampio spettro partendo da
un nucleo teorico condiviso, mette a fuoco una contraddizione profonda che mina quello stesso
nucleo. La visione gramsciana non legittima affatto l’assunzione di una “cultura subalterna” come
sfera separata e autonoma, che possa rappresentare l’oggetto distintivo di una scienza specifica.
L’illusione ottica di questa possibilità deriva dal guardare al mondo contadino come paradigma
della subalternità: in questo caso, le sue condizioni di relativo isolamento portano la frattura
egemonico-subalterno a prendere le sembianze di un’alterità culturale in senso antropologico. Ma
non appena si volga lo sguardo a realtà industriali e urbane, caratterizzate da confini sociali più
fluidi e dalla diffusione mass-mediale di contenuti culturali, le cose cambiano. A quel punto, non è
più possibile ricomprendere la vecchia disciplina folklorica sotto le nuove insegne. Tra uno studio
classificatorio dei repertori della tradizione contadina e una teoria della cultura popolare nella realtà
contemporanea si apre una irreversibile disgiunzione.
.
8. Cultura popolare e cultura di massa.
Gli antropologi che rispondono al questionario di La ricerca folklorica girano largamente attorno a
questa contraddizione, apparentemente senza volerla affrontare. In pochi rispondono in modo
diretto alle domande del questionario. Guido Bertolotti, ad esempio, si rende conto che
l’identificazione dei contadini come portatori per eccellenza della cultura popolare ha creato una
sorta di illusione prospettica. Per questo autore, la centralità contadina sarebbe una conseguenza
dell’origine meridionalistica degli studi italiani – una osservazione interessante che però inverte
forse la causa e l’effetto. Il mezzogiorno rurale e “arretrato” è stato visto come luogo privilegiato
della demologia in virtù di una certa concezione della cultura popolare. In ogni caso, Bertolotti fa
notare come il ruralismo folklorico si è col tempo trasformato in una “pesante ipoteca” per gli studi
di cultura popolare: una ipoteca “che ha ridotto le possibilità di cogliere i violenti processi di
trasformazione della società italiana, e di contribuire in modo specifico al dibattito sul mutamento
che sociologi ed economisti hanno assai più consapevolmente affrontato” 150 .
Ma è soprattutto Pietro Clemente, da allievo di Cirese, a entrare nel vivo della teoria dei dislivelli
interni. Già in un articolo di poco precedente aveva sostenuto la necessità di un “ridimensionamento
del concetto di folklore, carico di implicazioni arcaicizzanti e ruraliste, e l’assunzione del
149
150
Ibid.
Guido Bertolotti, “Verso un’antropologia delle società complesse”; La ricerca folklorica, 1, 1980, p. 18
proletariato industriale (nella sua faccia subalterna) dentro l’area di interesse demologico” 151 . Nel
dibattito su La ricerca folklorica Clemente scrive: “Credo che non abbia giustificazione espungere
dallo studio delle classi subalterne la classe operaia industriale; proponendo semmai per
l'assunzione alla demologia di un 'versante' specifico della vicenda del proletariato: quello della
vita quotidiana, della routine, dei livelli primari della organizzazione…” 152 . La prospettiva che
propone è quella del “cannocchiale sulle retrovie” – dove retrovie è da intendere come richiamo non
tanto agli aspetti “progressisti” dello status operaio (le lotte sindacali, o la funzione di guida
rivoluzionaria che il marxismo-leninismo assegna a questa classe), quanto “la vita familiare, la riproduzione della esistenza collettiva, i modi del permanere, innovarsi, ibridarsi delle ideologie, i
circuiti culturali che mantengono (mi pare) una certa peculiarità anche nell’epoca dei massmedia” 153 .
Clemente vuole qui trarre fino in fondo le conseguenze della visione gramsciana della demologia:
una disciplina che dovrebbe allontanarsi decisamente dalle “implicazioni arcaicizzanti e ruraliste”
del folklore per sconfinare in una antropologia della dimensione quotidiana dei ceti subalterni
contemporanei. Una mossa quasi ovvia, potremmo oggi dire, viste le premesse. Eppure di questa
svolta non c’è grande traccia nella ricerca di quegli anni. L’attenzione alla cultura operaia è
praticamente inesistente, e le forme culturali di massa restano un oggetto opaco, presente nella
consapevolezza degli studiosi ma inafferrabile, difficile da aggredire sul piano della teoria come su
quello del metodo. È vero che la stessa rivista La ricerca folklorica dedica pochi anni dopo, nel
1983, un numero al tema “Cultura popolare e cultura di massa”, a cura di Amalia Signorelli 154 . Nei
numerosi contributi presentati nel fascicolo, l’accento è prevalentemente posto sulla critica alla
visione interclassista della cultura di massa, e alle capacità di resistenza opposta ai media e
all’industria culturale da parte delle tradizioni locali e delle istanze subalterne. Sono presentate
ricerche assai interessanti sui modi in cui la “modernizzazione” si insinua all’interno di forme della
tradizione, quali le feste e i riti contadini, i movimenti religiosi carismatici, le pratiche del lutto, le
leggende e la narrativa orale. Ma è come se l’antropologia fosse legittimata a occuparsi di cultura di
massa solo per i modi in cui essa interviene a modificare il suo oggetto classico, oppure lo assorbe
nei propri prodotti (come nel caso di film, pubblicità, programmi televisivi che incorporano tratti
del folklore contadino). Sembrano invece assenti dal panorama italiano degli studi i riferimenti alla
prospettiva che in quegli stessi anni veniva sviluppata – a partire proprio da una rilettura di Gramsci
– dai cultural studies inglesi: vale a dire uno studio delle culture subalterne basato sull’etnografia
del consumo della cultura di massa tra gli strati popolari.
In realtà la “nuova demologia” italiana sembra preoccupata soprattutto di demarcare con nettezza il
proprio oggetto e il proprio campo di studi da quello della cultura di massa. In modo più o meno
esplicito, gli antropologi e i demologi sentono i contorni della cultura di massa come un confine
invalicabile: superarlo significherebbe tradire le fondamentali motivazioni che li spingono a
studiare, ma anche a tutelare e valorizzare, la cultura popolare. Le motivazioni di questo
atteggiamento sono almeno di tre ordini. Il primo ordine è quello accademico: assumere a proprio
oggetto la cultura di massa sarebbe una mossa rischiosa per l’autonomia della disciplina:
avvicinandosi pericolosamente al terreno della sociologia, della semiotica e delle scienze della
comunicazione mass-mediale, resterebbe schiacciata dalla loro preponderanza quantitativa. Un
secondo ordine di motivazioni ha a che fare con l’influenza delle teorie critiche dell’industria
culturale, come quella francofortese, molto forte negli anni ’70. Autori come Adorno e Marcuse
sono assai letti, e l’idea che il consumo culturale di massa costituisca una forza ideologica al
servizio del dominio e una forma di anestetizzazione delle coscienze è in quel decennio un luogo
comune intellettuale. Se il folklore è almeno in qualche misura espressione di una coscienza di
151
Pietro Clemente,
Pietro Clemente, “Il cannocchiale sulle retrovie. Note su problemi di campo e di metodo di una possibile
demologia”, La ricerca folklorica, 1, 1980, p. 40
153
Ibid.
154
La ricerca folklorica, 7, 1983
152
classe, questa qualità non può certo appartenere ai prodotti dell’industria culturale, i quali si
impongono semplicemente al “popolo” che ne subirebbe passivamente la forza egemonica. Se la
“vera” cultura popolare dev’essere studiata e valorizzata, è proprio in contrasto al consumo
culturale di massa.
Il che conduce a un terzo e connesso ordine di motivazioni. Per gli intellettuali, la cultura di massa
è al tempo stesso oggetto di critica teorico-politica e di disgusto estetico, nel senso sociologico che
a questo termine attribuiva Pierre Bourdieu. Una caratteristica cruciale dell’Italia degli anni ’60 e
’70 è l’accesso di larghe fasce di popolazione giovanile, anche quella di origine contadina e operaia,
all’istruzione superiore e universitaria e a pratiche di consumo culturale nel campo della musica, del
teatro, del cinema e dell’arte. Una parte importante degli italiani sceglie di investire in capitale
culturale; una parte non lo farà, investendo piuttosto in altre forme di consumo vistoso, in beni di
lusso e nei simboli di status promossi dai media. Differenti strategie che creano nel paese una
frattura antropologica molto profonda, che sta fra l’altro alla base delle odierne insanabili divisioni
politiche. I nuovi “ceti medi riflessivi” che così si formano centrano le proprie strategie distintive,
appunto, sulla raffinatezza dei consumi culturali. È una raffinatezza che si può manifestare a molti e
diversi livelli, che hanno però in comune il “disgusto” per gli aspetti seriali, artificiosi, in autentici e
kitsch della cultura di massa.
Gli intellettuali guidano questo movimento di estetica sociale. Per alcuni di loro l’alternativa
all’industria culturale consiste nelle tradizioni della grande arte, letteratura e musica, in specie nelle
loro elitarie manifestazioni di avanguardia. Per altri, in genere quelli meno radicati in forme
accreditate di “nobiltà” o in “rendite di posizione” culturale, l’alternativa può consistere
nell’autentica spontaneità del folklore e della tradizione contadina. È in questa chiave che il “folk”
assume un valore distintivo rispetto ai modelli di consumo promossi dai media: le case coloniche e
l’arredamento in stile “rustico”, considerati come spazzatura fino a pochi anni prima, divengono
agognati simboli di status; il canto, il teatro e le feste popolari sono oggetto di riletture e
riproposizioni che si saldano con lo spettacolo d’avanguardia. È in questa cornice di significati
sociali che la stessa demologia si trova ad agire e a demarcare un certo tipo di oggetti culturali.
9. L’antropologia culturale italiana oggi: quale spazio per la cultura popolare?
Le vicende dello specialismo disciplinare si intrecciano qui con quelle di una storia socio-culturale
dell’Italia degli ultimi decenni del ‘900: un punto su cui occorrerebbe andare ben oltre questi
sintetici accenni. Sta di fatto che la demologia nasce attorno a una cruciale tensione sia teorica che,
per così dire, poetica. Da un lato vi è la fondazione teorica gramsciana, che la spingerebbe a
concentrarsi sui mutamenti culturali più recenti, cercando di seguire le nuove articolazioni della
frattura egemonico-subalterno attraverso una etnografia della vita quotidiana dei ceti popolari e
delle pratiche del consumo di massa. Dall’altro, vi sono invece la poetica e la politica della tutela e
della valorizzazione di tratti culturali tradizionali, rappresentativi di una diversità e meglio ancora di
una resistenza rispetto alla penetrazione dei media e dell’industria culturale: ad esempio le pratiche
terapeutiche magico- religiose, i canti popolari e le varie forme di improvvisazione e gara poetica, il
teatro e le feste di origine contadina. Questi non sono solo fenomeni del passato, certo: sono spesso
vivi e creativi, nel quadro di processi di persistenza e di revival che tuttavia interessano realtà
minoritarie o marginali, potremmo dire persino elitarie, lontane comunque da una dimensione
veramente “popolare”.
Questa tensione irrisolta finisce per indebolire la stessa categoria di “cultura popolare”. Se alla fine
degli anni ’70 essa appariva il centro unificante dell’antropologia italiana, nonché il principale
tramite dei suoi rapporti con la storia, con la sociologia e la semiologia, a partire dagli anni ’80 la
situazione cambia. I tentativi di definire e demarcare il “popolare” sembrano condurre in vicoli
ciechi, oppure fuori dai confini invalicabili della disciplina; di conseguenza, sia la ricerca che
l’elaborazione teorico-metodologica vanno in cerca di altri centri di gravità. Quali sono questi
nuovi elementi di aggregazione? In primo luogo, nel quadro antropologico italiano assumono
sempre maggiore importanza le ricerche di etnologia extraeuropea: una conseguenza, questa, delle
più forti relazioni internazionali e della maggiore accessibilità dei più lontani terreni. Rispetto agli
anni ‘70, oggi si è probabilmente invertito il rapporto tra chi pratica forme di fieldwork
extraeuropeo e gli studiosi di “dislivelli interni”; da larga maggioranza, questi ultimi sono divenuti
una minoranza intimorita, che si tiene decisamente sulla difensiva e non sembra più credere in uno
statuto forte del proprio campo. Così, le discussioni sulla demarcazione del “popolare” sono
accuratamente evitate; lo stesso vale per il rapporto tra differenze culturali e appartenenze sociali.
Problemi che rischiano per così dire di far mancare il terreno sotto ai piedi.
Gli sviluppi della demologia hanno dunque imboccato altre direzioni. La strategia è stata quella di
continuare a porre al centro dell’attenzione gli oggetti “classici” della disciplina, in particolare le
feste locali e religiose, le performance di spettacolo legate alla tradizione folklorica, le forme
dell’espressione orale. Questi “oggetti” sono stati però collocati in quadri interpretativi innovativi e
spesso assai raffinati, influenzati dai dibattiti sull’invenzione della tradizione, dalla decostruzione
del concetto di cultura operata dall’antropologia critica e postcoloniale, dagli approcci riflessivi alla
descrizione etnografica. Queste influenze, forti soprattutto a partire dagli anni ’90, hanno da un
lato portato alla rinuncia di ogni ricerca di autenticità: a proposito di pratiche come le feste, le forme
religiose carismatiche o le performance di tradizione orale, gli studi hanno piuttosto sottolineato le
capacità di rinnovamento e la tendenza ad intrecciarsi con le dinamiche della cultura mediale e
globalizzata. Dall’altro lato, l’attenzione dei demologi si è spostata sulle pratiche di
rappresentazione e patrimonializzazione della tradizione. In particolare, a partire da una
pionieristica opera dello stesso Cirese 155 , si è sviluppato un cospicuo filone di antropologia
museale, che ha trovato i suoi punti di forza non solo nelle università ma anche e soprattutto in una
rete di musei etnografici locali. Piccoli ma spesso allestiti con grande finezza e consapevolezza
epistemologica, questi musei sono oggi riuniti nella vivace associazione SIMBDEA 156 – il cui
presidente, Pietro Clemente, ha teorizzato attraverso la formula del “terzo principio della
museografia” uno stile espositivo radicalmente antirealista, volto ad evocare le risorse immaginative
dello spettatore più che a produrre discorsi compiuti di ordine classificatorio o narrativo 157 . Alle
pratiche museali si è inoltre accompagnata una riflessione sui processi di patrimonializzazione della
tradizione e dei beni etnografici, in dialogo critico con le politiche culturali dell’UNESCO relative
ai “tesori viventi” e al “patrimonio intangibile” 158
Non è qui possibile approfondire neppure per grandi linee questi sviluppi. Vorrei solo sottolineare
che, malgrado la loro ricchezza, si tratta di studi che continuano ad assumere la tradizione contadina
e folklorica come oggetto distintivo dell’approccio demologico o antropologico. Certo, è una
tradizione considerata non come pura persistenza ma nelle sue relazioni con i contesti
contemporanei di mutamento; e, d’altra parte, come forma di resistenza alla deculturazione prodotta
dallo strapotere dei media e del consumo di massa. Non è che la demologia si chiuda alla società
mediale e globalizzata. Al contrario: ma è come se i meccanismi della cultura di massa potessero
esser legittimamente affrontati solo attraverso il prisma delle forme più classiche del folklore. Pena
lo scadimento in una generica “sociologia” – un timore assai diffuso fra gli antropologi italiani, che
deriva forse dalla percezione di schiacciamento da parte di una disciplina più giovane che si è
costruita però un potere accademico assai più grande.
155
A.M. Cirese, Oggetti, segni, musei. Sulle tradizioni contadine, Torino, Einaudi, 1977
“Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici”, costituita nel 2001 (www.simbdea.it)
157
P. Clemente, E. Rossi, Il terzo principio della museografia. Antropologia, contadini, musei, Roma, Carocci, 1999. In
questa linea occorre citare anche il lavoro di Vincenzo Padiglione, allestitore di alcuni musei decisamente
d’avanguardia nella regione Lazio e direttore della rivista AM. Antropologia museale, periodico che esce dal 2002 e
rappresenta il principale strumento di dibattito in quest’area degli studi.
158
Per un quadro del dibattito su questo tema si veda AA.VV., Il patrimonio culturale, numero monografico di
Antropologia Annuario (Roma, Meltemi), 7, 2006. Per una assai dibattuta critica in chiave di antropologia politica ai
processi di patrimonializzazione v. B. Palumbo, L’Unesco e il campanile, Roma, Meltemi, 2003.
156
Tutto questo fa perdere di vista, in definitiva, l’obiettivo teorico attorno al quale la nuova
demologia si era costruita fra anni ’60 e ’70: vale a dire l’ambizione di porre in relazione le
differenze culturali con quelle sociali, e il tentativo di seguire l’articolazione (e la linea di frattura)
egemonico-subalterno ben oltre la dissoluzione del mondo contadino tradizionale, all’interno dei
mutamenti culturali contemporanei. In conclusione di questa sintetica ricostruzione storica, vorrei
chiedermi se è possibile e opportuno recuperare oggi una centralità della categoria di cultura
popolare, in un quadro di studi focalizzato sulle pratiche della quotidianità e sulle forme del
consumo di massa. Negli ultimi vent’anni, sia l’antropologia che la sociologia culturale e qualitativa
hanno prodotto in Italia studi di taglio etnografico su aspetti della cultura di massa, quali lo
spettacolo sportivo, il turismo, il consumo della televisione, della musica e del cinema, le pratiche
alimentari, la cultura materiale e l’uso degli oggetti ordinari in ambito domestico, le “culture della
rete” e le pratiche comunicative legate ad Internet. Queste ricerche sono spesso pensate come ambiti
tematici specialistici e separati l’uno dall’altro, accomunati semmai da generiche e ambigue
etichette come “antropologia del contemporaneo” o delle “società complesse” (come se tutte le
società studiate dall’antropologia non fossero “complesse” e”contemporanee”). Di solito non viene
percepita alcuna continuità tra tali studi e quelli folklorici. È come se si trattasse di oggetti
completamente diversi, piuttosto che di manifestazioni storicamente differenziate di uno stesso
campo – vale a dire forme della cultura quotidiana di ceti popolari. A questa incomunicabilità
contribuisce la distanza degli impianti teorici e metodologici. Mentre la demologia, nella sua
definizione ciresiana, aveva come punti di forza il marxismo, la semiologia e lo strutturalismo, gli
attuali studi di antropologia della cultura di massa poggiano piuttosto sugli approcci interpretativi di
stampo geertziano, oppure su una qualche forma di “teoria delle pratiche” nella linea Bourdieu-De
Certeau. E ancora, mentre la prima tendeva a produrre repertori documentari e filologici, i secondi
puntano piuttosto sull’etnografia in profondità di singoli casi.
Riallacciare questa recente stagione di ricerche al nucleo forte della tradizione demologica, vale a
dire al nodo gramsciano della frattura egemonico-subalterno, è la scommessa teorica che a mio
parere ci sta oggi di fronte. Ciò significherebbe recuperare il terreno perduto rispetto ad altri
indirizzi, come i cultural studies anglosassoni, che hanno usato Gramsci per costruire una solida
cornice interpretativa della cultura di massa; e significherebbe altresì restituire al campo degli studi
demologici in Italia una compattezza e forse una originalità che sembra oggi lontana. In definitiva,
la scommessa è quella di arrivare a pensare cose apparentemente inconciliabili - il teatro contadino
e le partite di calcio, i canti popolari e le soap-operas, le fiabe tramandate oralmente e quelle di
Walt Disney, i pellegrinaggi e le gite turistiche, la medicina dei guaritori e quella New-Age all’interno di una medesima cornice interpretativa.
DONO
di Matteo Aria
(pubblicato in Antropologia Museale, 22, 2009, pp. 39-41)
Per lungo tempo occultato, relegato a retaggio di un passato irrimediabilmente estinto, il dono è
stato negli ultimi anni oggetto di una riscoperta pluridisplinare che ha coinvolto e entusiasmato
filosofi, critici letterari, economisti, sociologi, storici e teologi. Da esclusivo campo d’indagine
degli etnologi, impegnati sulla scia di Mauss (1924) a evidenziarne l’importanza nello studio delle
società arcaiche e tradizionali, il dono è divenuto un tema “attuale” largamente dibattuto all’interno
delle scienze sociali contemporanee. A partire dalla crisi dello strutturalismo e delle altre grandi
narrazioni, e con il crollo definitivo dei sogni socialisti, un numero crescente di studiosi è tornato a
riflettere sulle complessità sociali, politiche ed etiche del donare per riscoprire la dimensione
simbolica e non utilitaria dell’agire sociale o, al contrario, per riaffermare la validità universale
delle teorie dell’azione razionale e dell’individualismo metodologico. Nell’ambito di questa
diffusione oltre i confini classici della riflessione antropologica, il problema della definizione del
dono rispetto allo scambio e all’ambigua dialettica tra interesse e gratuità, tra reciprocità e assenza
di restituzione, ha costituito una delle questioni centrali attorno alla quale si è catalizzata un’intera
stagione culturale. L’analisi dell’abbondante letteratura prodotta permette di distinguere tre
principali risoluzioni.
Da un lato, assimilato alla logica dell’interesse, il dono è stato ridotto allo scambio equivalente, o
rigettato perchè offuscamento ideologico che maschera le più profonde e strutturali “ragioni”
economiche e politiche. In questo ambito possono essere collocate anche le recenti prospettive
utilitariste di alcuni economisti e sociologi (Akerloff 1984; Camerer 1988) che, impegnati a
espandere il paradigma microeconomico ad un’ampia varietà di campi sociali, hanno spiegato la
consistente presenza del dono all’interno delle società capitalistiche come fatto economico
funzionale allo sviluppo del mercato[1].
Dall’altro, costruendosi in opposizione al concetto di mercato, ha rappresentato l’elemento chiave
per una critica epistemologica radicale “all’imperialismo della scienza economica neoclassica” e, da
un punto di vista etico-politico, l’ultimo baluardo delle alternative alla logica di profitto del
capitalismo. Sono state in particolare le riflessioni critico-letterarie ed estetiche di Hyde (1979) e i
successivi contributi sociologici di Cheal (1988) e dei ricercatori francesi facenti capo al
movimento detto M.A.U.S.S.[2] a riproporre la validità degli insegnamenti maussiani per
sottolineare il divario irriducibile tra lo scambio mercantile (emanazione del logos) che aliena i
contraenti, e il dono (manifestazione dell’eros) che esprime e crea i legami sociali. A partire dagli
anni Novanta del secolo scorso le prospettive antiutilitariste di Caillé (1989) e di Godbout (1992),
hanno riaffermato la centralità della sfera del dare, ricevere e ricambiare nelle società occidentali
contemporanee, individuandone l’essenza nel suo porsi a uguale distanza dall’egoismo e
dall’altruismo. Per i teorici della “Revue du M.a.u.s.s.” il dono, ibrido tra interesse e disinteresse,
obbligatorietà e libertà, si contrappone al mercato e allo stato in quanto i beni e i servizi circolano al
servizio del legame senza garanzia di restituzione. Parallelamente si distingue dalla pura gratuità e
dalla carità cristiana, perché è motivato dal “desiderio del legame” e contiene in sé la rivalità e
l’ostilità proprie del competere in generosità.
Infine, la prospettiva volta a svincolare il dono dalla reciprocità e dall’aspettativa di ritorno ha
messo in evidenza sia i possibili avvelenamenti e perversioni presenti in molte relazioni
asimmetriche e unilaterali (Starobinski 1994), sia le connessioni con la semantica dell’amore
agapico (Boltanski 1990), con l’ideologia del “dono puro” o “perfetto” (Belk 1996) e con la
generosità illimitata descritta da Levinas. All’interno di questa tensione verso un radicale
trascendimento dell’utile, si inscrive la critica decostruzionista di Derrida (1991) agli aspetti
economicisti della teoria maussiana, incapace di distinguere il dono dallo scambio. Secondo
Derrida, per essere tale il dono deve affrancarsi da ogni complicità, non solo con la logica
utilitarista dello scambio economico, ma anche con quella maussiana dello scambio simbolico,
respingendo ogni forma di restituzione sia immediata che differita nel tempo[3].
Prospettive analoghe si sono alternate anche all’interno dell’evoluzione del pensiero antropologico
sul dono. Alla scoperta, nell’etnografia di Malinowski (1922) e nelle riflessioni socioantropologiche
di Mauss, della realtà del “dono arcaico” che sconfessava inequivocabilmente le astratte e fallaci
teorie sull’universalità dell’homo oeconomicus, è seguita per oltre quarant’anni la sua progressiva
marginalizzazione a favore del concetto di reciprocità e della teoria dello scambio. Le differenti
letture da parte di Firth (1929) e di Lévi-Strauss (1950) del celebre Saggio sul dono, mostrando i
limiti e gli errori della riflessione maussiana sullo hau, ne hanno rigettato la spiegazione “mistica”
per elaborare un’interpretazione in un caso economicista e nell’altro strutturalista del “dare, ricevere
e ricambiare”. All’interno dell’antropologia sociale britannica il principio di reciprocità - inteso
come sequenza senza fine di scambi simmetrici ed equivalenti tra individui volti al proprio
tornaconto personale - è diventato il meccanismo regolatore che assicurava il funzionamento e la
stabilità di quelle società sprovviste di sistemi giuridici e di autorità politiche centralizzate. Si è così
affermato un orientamento consonante ai modelli della scienza economica formalista focalizzati sul
calcolo e sulla massimizzazione dell’utile. Nell’impostazione di Lévi-Strauss invece, il carattere
eversivo e sbilanciato del dono-potlach, esaltato da Mauss come da Bataille perchè capace di
rendere evidenti i limiti della razionalità economica e del principio di utilità, si è eclissato
all’interno di un approccio oggettivista che, abbandonando l’indeterminatezza e le complessità delle
nozioni maussiane sull’intreccio tra libertà e obbligo, e tra interesse e disinteresse, ha finito per
“schiacciare” il dono sullo scambio simmetrico.
La sovrapposizione di queste due nozioni ha cominciato a essere messa in discussione all’inizio
degli anni Settanta attraverso alcuni contributi di Bourdieu (1972) e di Sahlins (1972), che hanno
influenzato in modo significativo e antitetico l’ampia e diversificata produzione bibliografica degli
ultimi venticinque anni. Il primo, nel tentativo di sviluppare una scienza generale dell’economia
delle pratiche, ha favorito una lettura orientata a sottolineare le continuità della relazione tra il dono
e la merce[4], mentre il secondo, avvicinando Mauss a Polanyi e a Marx, ne ha permesso un’
interpretazione dicotomica[5].
A partire dai primi anni Ottanta si è assistito ad un generale ripensamento delle categorie fino ad
allora impiegate, che ha portato ad una significativa rivalorizzazione dello “spirito del dono” e della
relazione tra le persone e le cose. La rielaborazione di queste nozioni maussiane in termini di
alienabilità e inalienabilità degli oggetti e dei relativi differenti modi di concepire le persone, ha
permesso di criticare radicalmente l’essenzialismo della norma di reciprocità e la sua eccessiva
enfasi posta sulla razionalità economica definita attraverso valori occidentali. All’interno di questo
comune ritorno a Mauss e al dono liberati da ogni connotazione strutturalista ed economicista, il
dibattito antropologico contemporaneo si è, a mio avviso, articolato intorno a tre principali
orientamenti teorici a cui sono corrisposti altrettanti campi di ricerca: la prospettiva “discontinuista”
degli studi sul dono melanesiano; l’approccio culturale “continuista” volto a addomesticare
antropologicamente le merci e l’organizzazione capitalistica occidentale; le riflessioni sulle pratiche
asimmetriche che non prevedono restituzione, proprie delle indagini etnografiche indiane.
Nel primo caso l’attenzione si è focalizzata sulla persistenza delle “tradizionali” culture o economie
del dono, intese non come sopravvivenze arcaiche ma come prodotti storici, frutto delle interazioni
con il colonialismo e capaci paradossalmente di espandersi in un mondo dominato dalla produzione
e dallo scambio mercantile. In questo ambito Gregory (1982), rileggendo Mauss attraverso Marx, ha
individuato nel Saggio sul dono la centralità del concetto di inalienabilità che gli ha permesso di
distinguere in modo netto le economie di mercato - dove le persone e le cose assumono la forma
sociale di oggetti - da quelle del dono - dove sono entrambe personificate. Weiner (1992) a sua
volta, ha mostrato il ruolo universale di quei possessi che, come indicato da Mauss, non possono
essere facilmente dissociati dal loro proprietario originario, ma devono essere trasmessi solo
all’interno del proprio gruppo e sono, pertanto, il fondamento delle identità collettive e
individuali[6].
Nel secondo, l’interesse si è concentrato sul mostrare come le riletture del testo maussiano e della
stretta connessione tra gli oggetti e le relazioni sociali non sono solo importanti per lo studio delle
culture tradizionali, ma offrono anche dei validi strumenti per indagare le società capitalistiche
industriali. In sintonia con le riflessioni di Bourdieu (1972) sulle connessioni tra il dono e le
pratiche economiche, Appadurai (1986) e Marcus (2002), orientati a estendere la riflessione
antropologica agli ambiti di pertinenza della scienza economica[7], hanno contrapposto alla
dicotomia dono-merce, una visione capace di coglierne gli elementi comuni[8]. La parallela
rivendicazione della presenza del dono in tutte le società (Carrier 1995) ha permesso invece di
interpretarlo come uno dei significativi ambiti di produzione e manifestazione della cultura popolare
all’interno della società di massa, da studiare anche attraverso le etnografie delle pratiche
quotidiane.
Nel terzo, gli studi indiani di Parry (1986) e di Laidlaw (2000) hanno criticato sia la rigida
separazione tra il dono e le merce, sia le prospettive “continuiste” incapaci di scorgerne le
differenze. Le pluralità delle forme e dei significati del dono sono stati invece interpretati come
espressione di specifici contesti storici, politici, religiosi e culturali. Le loro etnografie hanno infatti
evidenziato l’esistenza e l’importanza sociale di doni che, a differenza di quelli maussiani, non
creano obblighi, non sono personali e non costruiscono legami sociali. Si tratta di pratiche rare che
esprimono però la tensione comune a tutti i sistemi religiosi verso il supremo valore delle donazioni
anonime della carità e della filantropia.
[1] In modo ancora più radicale e provocatorio, l’economista americano Gilder (1981) ha utilizzato
Mauss e Bataille per realizzare una legittimazione postmoderna del capitalismo contemporaneo che,
al pari delle società primitive, ha come centro morale e pulsione vitale il modello del dono.
[2] Il M.A.U.S.S è l’acronimo di Movimento Antiutilitaristico delle Scienze Sociali
[3] Le dissertazioni di Derrida sul dono come figura dell’impossibile e come perdita assoluta e
incondizionata sono state all’origine di un intenso ripensamento filosofico e critico-letterario
interessato da una parte a riproporre criticamente la riflessione di Bataille sul sacrificio, sulla
poesia e sulla morte come archetipi di una dépense antiutilitaria, e dall’altra a riscoprire una feconda
tradizione di studi non antropologici sul dono che da Seneca arriva, attraverso Emerson e Nietzche,
fino a Heidegger.
[4] Le ricerche di Bourdieu sulle pratiche del dono a partire dal caso etnografico della Kabilia
hanno per la prima volta aperto uno squarcio nella dominante interpretazione strutturalista del
Saggio di Mauss, individuando nella temporalità la linea di distinzione tra il dono e lo scambio. Per
Bourdieu (1972), infatti, la prospettiva lévistraussiana focalizzata sulla relazione di reciproca
equivalenza tra il dono e il controdono si rivela incapace di distinguere lo scambio di doni dal
baratto - dove il dono e il controdono sono condensati nello stesso istante - o dal prestito - regolato
dagli atti legali. L’oggettivismo di Lévi-Strauss ignora o abolisce il fatto che “in tutte le società, a
rischio di costituire un’offesa, il controdono deve essere differente e differito, dato che la
restituzione immediata di un oggetto equivale molto chiaramente ad un rifiuto” (Bourdieu 1972, p.
283).
[5] Sahlins (1972) se da un lato ha rappresentato il momento culminante del paradigma
antropologico della reciprocità e dello scambio riletti in chiave antiformalista, dall’altro ha
contribuito a decretarne il superamento attraverso la rivalorizzazione delle idee maussiane sullo hau
e sulla relazione tra le persone e le cose. Ha, infatti, riconosciuto la validità della riflessione sullo
spirito incarnato del donatore maori perchè capace di cogliere come tratto essenziale delle
prestazioni totali interclaniche l’intima relazione tra le persone e le cose. L’indissolubilità tra gli
uomini e gli oggetti materiali è propria di un mondo (quello primitivo) in cui la sfera sociale e
quella economica non sono mai completamente separabili. L’hau rappresenta così la più valida
esemplificazione di questo intreccio che segna al contempo anche la differenza con lo scambio
mercantile, fondato sulla netta distinzione tra i beni e le persone e sull’autonomia dell’economico.
[6] Godelier (1996) ha sviluppato questo spostamento dalla circolazione alla conservazione
avvicinando il dono al sacro e ponendo come presupposto di ogni società la triplice distinzione tra
oggetti sacri inalienabili e inalienati, doni inalienabili ma alienati e merci alienabili e alienate.
[7] Marcus (2002) ha sostenuto la possibilità dell’antropologia di indagare il capitale finanziario
contemporaneo e le sue mentalità. Appadurai (1986) ha utilizzato Bourdieu per evidenziare gli
aspetti culturali i dilemmi morali dei processi economici della globalizzazione.
[8] L’impostazione continuista proposta da Appadurai è volta da un lato a sottolineare la
dimensione culturale degli scambi contro il riduzionismo economicista, e dall’altro a individuare, in
opposizione alle semplificazioni sostantivistiche, la presenza del calcolo in tutti i tipi di transazioni
dei beni.
BIBLIOGRAFIA
Akerlof, G. A., 1984, Gift exchange and Efficiency-Wage Theory: Four views, «The American
Economic Review», 74 (2), pp.79-83.
Appadurai, A., 1986, “Introduction: commodities and the politics of value”, in A. Appadurai, a
cura, The Social Life of the Things: Commodities in Cultural Perspective, Cambridge, Cambridge
University Press, pp. 3-63.
Belk, R. W., 1996, “The perfect gift”, in C. Otnes, R. F. Beltramini, a cura, Gift Giving: A Research
Anthology, Bowling Green, Bowling Green State University Popular Press, pp. 59-84.
Bourdieu, P., 1972, Esquisse d’une théorie de la pratique. Précède de trois études d’ethnologie
kabyle, Genève, Droz (trad. it. 2003).
Caillé, A., 1989, Critique de la raison utilitaire, Paris, La Découverte (trad. it. 1991).
Camerer, C., 1988, Gift as Economic Signals and Social Symbols, «The American Journal of
Sociology», 94, pp. 183-184
Carrier, J., 1995, Gifts and Commodities: Exchange and Western Capitalism since 1700, New York,
Routledge Chapman and Hall.
Derrida, J., 1991, Donner le temps, Paris, Galilée (trad. it. 1996).
Firth, R., 1929, Primitive Economics of the New Zealand Maori, London, Routledge.
Godbout, J. T., 1992, L’esprit du don, Paris, La Découverte (trad. it. 1993).
Godelier, M., 1996, L'énigme du don, Paris, Fayard.
Gregory, C. A., 1982, Gifts and Commodities, London, Academic Press.
Hyde, L., 1979, The Gift: Imagination and the Erotic Life of Property, New York, Vintage Books
(trad. it. 2005).
Laidlaw, J., 2000, A Free Gift Makes no Friends, «The Journal of the Royal Anthropological
Institute», 6 (4), pp. 617-634.
Lévi-Strauss, C., 1950, “Introduction à l’ouvre de Mauss”, in M. Mauss Sociologie et
anthropologie, Paris, PUF, pp. I-LII (trad. it. 1965).
Malinowski, B., 1922, Argonauts of the Western Pacific, London, Routledge & Kegan Paul (trad.it.
1973).
Marcus,G. E., 2002, “The gift and Globalization” in E. Wyschogrod, J. J. Goux, E. Boynton, a cura,
The Enigma of Gift and Sacrifice, New York, Fordham University Press, pp. 38-49.
Mauss, M., 1924, Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques,
«L’Année Sociologique», 1, pp. 30-186 (trad. it. 1965).
Parry, J., 1986, The Gift, the Indian Gift and the 'Indian Gift', «Man», 21 (3), pp. 453-473.
Sahlins, M. D., 1972, Stone Age Economics, Chicago, Aldine; trad. it. 1980.
Starobinski, J., 1994, Largesse, Paris, Réunion des Musées Nationaux (trad. it. 1995).
Weiner, A. B., 1992, Inalienable Possessions: The Paradox of Keeping-While-Giving, Berkeley,
University of California Press.
DESCRIVERE, TEORIZZARE,
TESTIMONIARE LA VIOLENZA
(Pubblicato come introduzione al volume Antropologia della violenza, a cura di F. Dei, Roma,
Meltemi, 2005)
La letteratura etnografica e il dibattito antropologico internazionale degli ultimi 15-20 anni si sono
caratterizzati per una diffusa attenzione al tema della violenza di massa. Singolarmente trascurata
nelle più classiche fasi degli studi (sia pure con rilevanti eccezioni), la violenza sembra trovarsi oggi
al centro della riflessione antropologica; non solo come “nuovo” oggetto, o come una ulteriore
“antropologia speciale”, ma come campo decisivo per i complessivi scenari teorico-epistemologici
della disciplina, così come per i problemi legati al suo “uso pubblico” e all’etica della ricerca e
della scrittura. Questo volume presenta ai lettori italiani una scelta di saggi che di tale dibattito sono
in qualche modo rappresentativi, sia per la rilevanza degli autori che per la varietà dei temi trattati.
Nelle pagine introduttive, cercherò di ricostruire per grandi tratti il contesto in cui la moderna
antropologia della violenza si sviluppa, discutendo alcuni fra i numerosi problemi che essa solleva.
1. Perché la violenza?
Il Novecento, il secolo in cui la scienza antropologica è diventata adulta e ha conosciuto il suo
massimo sviluppo, è stato anche un’epoca di guerre, genocidi e violenze di massa di straordinarie
dimensioni e intensità. L’appellativo di “secolo delle tenebre” (Todorov 2001) è forse unilaterale ed
eccessivo; ma è indubbio che l’applicazione della razionalità tecnologica e amministrativa agli
obiettivi dello sterminio di grandi masse di persone è stata senza precedenti. Inoltre, il grado
altissimo di violenze e atrocità ha prodotto uno stridente e scandaloso contrasto con le
autorappresentazioni in termini di progresso e di civiltà in cui la cultura novecentesca si è a lungo
cullata. Ma di tutto ciò nella letteratura antropologica non c’è praticamente traccia. Inutilmente, o
quasi, si sfoglierebbero gli autori più classici o le riviste più prestigiose in cerca di riferimenti alla
Shoah, a Hiroshima, alle carneficine delle due guerre mondiali – fenomeni che pure hanno scosso
l’opinione pubblica e la coscienza contemporanea, modificando profondamente quella che ben
potremmo chiamare l’autopercezione antropologica della contemporaneità.
Ancora più sorprendente è la scarsità dei riferimenti alle violenze subite dai popoli cosiddetti
indigeni – il principale e caratterizzante soggetto di studio della disciplina. Almeno da Malinowski
in poi gli antropologi si sono posti l’obiettivo prioritario di “salvare” – descrivendole
etnograficamente – le culture diverse e “primitive” che rischiavano di scomparire; ma hanno quasi
sempre trascurato il fatto che questa scomparsa era il frutto non solo dell’inarrestabile incedere della
civiltà e del progresso, ma anche e soprattutto di politiche palesemente etnocide, talvolta di vere e
proprie pratiche di sterminio, da parte dei poteri coloniali. Il “moderno assalto globale degli statinazione contro popolazioni tribali di piccola scala e autosufficienti”, con i suoi effetti spesso
devastanti e con sistematici episodi di violenza e atrocità, e con un numero di vittime che nel secolo
d’oro dell’imperialismo si conta nell’ordine delle decine di milioni (Bodley 1992, p. 37), è un
macro-fenomeno storico che gli antropologi hanno avuto sotto gli occhi senza apparentemente
riuscire a vederlo, e comunque senza tematizzarlo nei loro lavori.
Molti critici contemporanei, soprattutto nell’ambito dei post-colonial studies, vedono in questo
silenzio un sintomo di complicità, perlomeno passiva, dell’antropologia. Ė un giudizio che a me
sembra quantomeno parziale in termini di storia delle idee, e sul quale tornerò oltre. Si può intanto
osservare che la mancata tematizzazione della violenza è strettamente legata alle principali
condizioni pratiche ed epistemologiche del lavoro antropologico novecentesco. Sul piano pratico,
sia per ragioni di sicurezza che per l’esplicita proibizione delle autorità locali o coloniali, gli
antropologi lavorano spesso in aree pacificate, nelle quali il conflitto non è presente o perlomeno
non si manifesta apertamente; e abbandonano il terreno quando le condizioni si fanno difficili. Ma
anche quando guerra e violenza si manifestano apertamente, è raro che esse emergano alla
superficie dei resoconti etnografici. Se ne parla magari nei diari di campo, nei corridoi delle Facoltà,
e al massimo nelle prefazioni di monografie dedicate a più comuni temi antropologici, sempre però
dando per scontato che si tratta di elementi estranei al vero nucleo scientifico della disciplina. Il
caso forse più noto, e certamente emblematico, di questo atteggiamento è costituito dal lavoro di
Evans-Pritchard fra i Nuer, condotto in un periodo di forte tensione fra questi ultimi e il governo del
Sudan anglo-egiziano, per conto del quale l’antropologo conduceva la sua ricerca. A tali conflitti
egli fa cenno soltanto nell’introduzione alla sua fortunata monografia del 1940, nel contesto di una
esposizione delle difficoltà incontrate nella ricerca sul campo, e attribuite principalmente alla
“intrattabilità” di carattere dei Nuer. “Al momento della mia visita – scrive – essi erano
particolarmente ostili perché la sconfitta recente e le misure adottate dal governo per assicurarsi la
loro sottomissione finale avevano suscitato profondo risentimento”. Il livello di tensione è
testimoniato dall’unico episodio di cui Evans-Pritchard riferisce: “un giorno, all’alba, truppe
governative circondarono il nostro campo, lo perquisirono per cercare due profeti che avevano
capeggiato una recente rivolta, e portarono via alcuni ostaggi minacciando di prenderne molti altri,
se i profeti non fossero stati consegnati”. Con una buona dose di understatement, l’antropologo
commenta di essersi sentito “in una posizione equivoca”, e di aver deciso poco dopo di lasciare il
villaggio (Evans-Pritchard 1940, p. 44) 159 .
Di tutto ciò non v’è altro cenno nel resto del libro. Perché Evans-Pritchard non sente il bisogno, o
l’obbligo, di tematizzare una situazione di guerra e violenza che palesemente domina la vita del
popolo presso cui si trova, e che inevitabilmente sottodetermina l’incontro etnografico? L’obiettivo
dell’antropologia, dal suo punto di vista, è descrivere e spiegare le normali strutture sociali e
159
La rilevanza di questo passo de I Nuer dipende non solo dall’importanza dell’autore e dallo statuto di classico che il
libro si è guadagnato, ma anche dal fatto che negli anni Ottanta queste pagine sono divenute emblema dei limiti del
realismo etnografico, ed oggetto di feroci critiche da parte degli autori del movimento di Writing Culture (si veda in
particolare Rosaldo 1986, p. 132 sgg. e, per una difesa di Evans-Pritchard, Free 1991).
istituzioni culturali del popolo studiato: l’organizzazione ecologico-economica, la parentela, il
sistema politico, la religione, e così via. L’antropologia che Evans-Pritchard rappresenta è
interessata cioè a cogliere caratteristiche strutturali, indipendenti dagli episodi e dalla contingenza
storica. Rispetto a queste finalità, i conflitti possono apparire puri elementi di disturbo che, oltre ad
ostacolare un regolare fieldwork, sconvolgono l’ordinario andamento della vita indigena e non
consentono di coglierne, appunto, la normalità 160 . Quello che a noi oggi appare come un
atteggiamento reticente e irriflessivo, che nasconde al lettore le condizioni politiche dell’incontro
etnografico, era per l’antropologia classica un requisito di pertinenza disciplinare, nonché di
oggettività e di dovuto distacco scientifico.
In altre parole, sono state le condizioni della produzione antropologica descritte come “realismo
etnografico” – con la tendenza a non tematizzare il carattere storicamente e politicamente situato
della ricerca – a ostacolare la visibilità dei fenomeni della violenza, e a impedire un loro
riconoscimento come problemi centrali della rappresentazione culturale e del dibattito teorico.
Questo riconoscimento è infatti iniziato proprio nel momento in cui le convenzioni del realismo
etnografico hanno cominciato a incrinarsi. La svolta riflessiva che ha investito l’antropologia a
partire dagli anni ’80, per quanto tutt’altro che pacificamente accolta e causa di infinite discussioni,
ha profondamente cambiato il modo di fare etnografia: o meglio, il modo di intendere il rapporto tra
scrittura etnografica e ricerca, tra la soggettività dell’esperienza di campo e l’oggettività della
rappresentazione culturale. E’ vero che la sperimentazione di nuove forme di autorità etnografica,
sbandierata negli anni ’80 da autori come James Clifford e George Marcus, è rimasta qualcosa di
assai vago; tuttavia l’imperativo di tematizzare, piuttosto che nascondere, le condizioni soggettive e
politiche della ricerca, nonché le retoriche rappresentative adottate, si è diffuso in modo ampio e
irreversibile.
Gli antropologi che si sono trovati a lavorare in contesti dominati dalla violenza, dunque, non
hanno più potuto fingere di ignorarne gli effetti sul loro campo di studio e sul proprio stesso ruolo
di ricercatore. Del resto, nello stesso periodo (più o meno, l’ultimo quarto di secolo), altre
condizioni hanno contribuito a far emergere in primo piano il problema della violenza etnica e
politica. Non mi sembra irrilevante il fatto che protagonista di questa stagione degli studi sia stata
una generazione di antropologi formatasi negli anni ’60, nel clima della contestazione studentesca,
dei movimenti di liberazione antiimperialista, dell’opposizione alla guerra in Vietnam, di ampia
diffusione di una cultura pacifista e dei movimenti per i diritti umani. Sono anche gli anni in cui
160
Nell’antropologia classica, gli unici lavori che tematizzano esplicitamente la violenza sono infatti quelli che la
considerano non come un fenomeno storico ma come una caratteristica strutturale delle “società primitive”. Penso ad
esempio all’opera di Clastres (1977), che vede una condizione di guerra permanente come necessaria all’esistenza delle
società senza Stato; o a una tradizione di studi neoevoluzionisti e sociobiologici che spiegano naturalisticamente la
guerra in termini di strategia adattiva e di selezione del patrimonio genetico (per un quadro di tali approcci v. Knauft
1987, 1991; rimando anche a Dei 1999, pp. 290-4, per una valutazione critica degli approcci naturalistici
all’antropologia della guerra). Per certi versi pionieristica per il suo accento sull’uso sistematico del terrore, ma legata
comunque all’idea della violenza politica come caratteristica strutturale di società premoderne (in senso weberiano), è
l’opera di E.V. Walter (1969). L’antologia curata da D. Riches (1986) segnala l’apertura di un sistematico interesse
antropologico per la violenza, senza tuttavia ancora aprirsi a quelli che saranno i temi predominanti del dibattito degli
anni ’90.
nella cultura occidentale emerge progressivamente la memoria della Shoah come tema portante
della coscienza contemporanea, e le figure della vittima e del testimone divengono emblemi della
soggettività tardo-moderna (Wieviorka 1998). Molti di questi studiosi, in aperto contrasto con gli
ideali di distacco e neutralità scientifica che avevano guidato generazioni precedenti, hanno cercato
di coniugare il rigore della ricerca scientifica con la passione dell’impegno etico-politico –
sostenendo anzi che il primo non è veramente tale se non fa i conti (“riflessivamente”, appunto) con
il secondo. Al centro di questo impegno non poteva non collocarsi la denuncia e l’analisi delle
forme di sopraffazione e violenza – sia quella palese sia quella “simbolica” connessa alle forme del
potere e ai relativi campi del sapere, secondo la lezione di teorici in questi anni assai influenti come
Foucault e Bourdieu. Ciò non significa affatto, o almeno non necessariamente, trasformazione
dell’antropologia in una disciplina militante (un esito, come vedremo, auspicato invece da una delle
autrici di questo volume; v. Scheper-Hughes 1995): significa però una profonda trasformazione
dell’agenda teorica e del modo stesso di concepire il compito della rappresentazione etnografica.
Un terzo grande ordine di motivi, ancora, contribuisce all’inevitabile incontro di antropologia e
violenza nell’ultima parte del Novecento. Mi riferisco ai mutamenti nella natura delle guerre e della
violenza che affligge molte parti del mondo, soprattutto dopo la fine della Guerra Fredda. I conflitti
regionali cosiddetti a “bassa intensità”, così come gli scontri etnici o religiosi, le “guerre sporche”
latino-americane e la violenza di stato, la pratica sistematica del terrorismo cancellano
progressivamente il confine tra guerra e non guerra, tra militari e civili, tra “normalità” dei rapporti
sociali e straordinarietà o emergenza dello stato di guerra. Nei conflitti di fine secolo, come è noto,
la gran parte delle vittime (tra ottanta e novanta per cento) si conta fra i civili; il monopolio statale
della violenza si allenta a favore della proliferazione di gruppi paramilitari; colpire e terrorizzare le
popolazioni non è più un effetto collaterale, ma l’obiettivo stesso delle strategie belliche e dei nuovi
metodi di combattimento (Kaldor 1999, pp. 15-18, 117; v. anche Lutz 1999, p. 610). In ciò gioca un
ruolo anche la diffusione di particolarismi e di politiche dell’identità etnica, che trapassano in alcuni
casi in pratiche sistematiche di pulizia etnica e talvolta di vero e proprio genocidio, come nei due
casi paradigmatici del Ruanda e della ex-Jugoslavia, discussi in alcuni saggi di questo volume.
La violenza assume dunque un carattere più diffuso nel tempo e nello spazio, penetra a fondo nella
quotidianità, inverando la citatissima ottava tesi sulla filosofia della storia di Walter Benjamin - “La
tradizione degli oppressi ci insegna che lo "stato di emergenza" in cui viviamo non è più l’eccezione
ma la regola”. Anche un’antropologia tutta concentrata sulle strutture piuttosto che sugli eventi non
può più fare a meno di ignorarla. Anche perché la natura etnica dei conflitti e il loro intrecciarsi con
politiche dell’identità chiamano direttamente in causa le categorie antropologiche di analisi, in
alcuni casi, come vedremo, persino accusate di complicità nella costruzione di una cultura di
discriminazione e di terrore. Si deve anche considerare, fra le differenze rispetto alle condizioni
classiche della ricerca, che nel contesto tardo-moderno l’etnografo non è più solo sul campo, ma
lavora accanto a giornalisti, troupes televisive, attivisti della cooperazione internazionale e dei diritti
umani che proprio sui fenomeni di violenza dirigono la loro attenzione. Secondo alcuni (Avruch
2001, p. 645), è stato proprio l’impatto del movimento dei diritti umani ad esercitare un’influenza
decisiva sugli sviluppi dell’antropologia contemporanea – in particolare, con la grande diffusione di
relazioni sulle violazioni di diritti, i tentativi di dar voce alle vittime, la circolazione di
testimonianze spesso assai dense sul piano etnografico.
Se una simile influenza è plausibile, è però anche vero che l’antropologia ha mantenuto un
rapporto spesso assai critico nei confronti delle organizzazioni umanitarie, nelle cui politiche ha
scorto assunti etnocentrici e una scarsa comprensione delle culture locali (v. ad esempio Malkki
1996). La cultura umanitaria e buona parte del discorso mediale sembrano considerare le
manifestazioni della violenza nel mondo contemporaneo come legata a sacche di arretratezza, alla
permanenza di una barbarie e di una irrazionalità che stridono scandalosamente rispetto alle
conquiste della civiltà. Vi è alla base di ciò quella visione progressista della storia cui Benjamin
reagiva, al culmine dell’aggressione fascista all’Europa, parlando di stato di emergenza
permanente. “Lo stupore perché le cose che viviamo sono ‘ancora’ possibili nel ventesimo secolo è
tutt’altro che filosofico. Non è all'inizio di nessuna conoscenza, se non di quella che l'idea di storia
da cui proviene non sta più in piedi”. Al contrario, il filosofo tedesco esortava a “giungere a un
concetto di storia che corrisponda a questo fatto”, cioè alla consapevolezza di un’emergenza come
regola e non come eccezione (Benjamin 1955, p.76). In qualche modo, aggiungendo “cultura” a
“storia”, questo è il programma dell’antropologia contemporanea, che non solo attribuisce
significati alla violenza, ma cerca di comprenderla come costitutiva di una teoria della società e
della cultura.
2. Scrivere la violenza
Lo sviluppo di una sistematica attenzione alla violenza avviene dunque in relazione, da un lato, ai
mutamenti delle condizioni strutturali nelle quali il lavoro antropologico ha luogo, dall’altro alla
svolta riflessiva della disciplina e alla “crisi della rappresentazione” che la investe. Chi decide di
affrontare questo campo si trova così di fronte, in primo luogo, al problema di come scrivere la
violenza. I modelli discorsivi classici, dalle trasparenze etnografiche di Evans-Pritchard ai cristalli
semiotici di Lévi-Strauss, sembrano poco appropriati; né vengono molto in aiuto le vaghe formule
postmoderne che suggeriscono rappresentazioni dialogiche e polifoniche. Ciò che occorre ripensare
è il presupposto usuale della scrittura etnografica, che – classica o postmoderna – si pone l’obiettivo
di scoprire e restituire un ordine culturale, l’ethos di una società, la profonda coerenza di un modo
di vita. È proprio quest’ordine che viene disintegrato nelle situazioni di violenza radicale.
Soprattutto nelle “nuove guerre” di fine XX e inizio XXI secolo, la distruzione delle più basilari
strutture antropologiche non è più soltanto un effetto collaterale dei combattimenti, ma un obiettivo
consapevolmente perseguito. Le operazioni di pulizia etnica, come osserva Mary Kaldor (1999, p.
116), mirano a rendere un territorio inabitabile, non solo colpendone l’organizzazione produttiva,
ma anche “istillando ricordi insopportabili sulla patria di un tempo oppure profanando tutto ciò che
ha un significato sociale”: ad esempio “attraverso la rimozione dei punti di riferimento fisici che
definiscono l’ambiente sociale di particolari gruppi di persone”, oppure “la contaminazione
attraverso lo stupro e l’abuso sessuale sistematico…o mediante altri atti di brutalità pubblici e molto
visibili”.
L’antropologa Carolyn Nordstrom, a proposito delle sue esperienze in Sri Lanka e in
Mozambico, parla di guerre in cui il controllo del territorio è perseguito disseminando paura,
brutalità e assassinio. La “cultura del terrore” che ne risulta si basa sulla “forzata decostruzione
delle realtà accettate nella vita quotidiana, in modo da disabilitare i sistemi basilari di significato e
di conoscenza, quelli che definiscono i mondi della vita delle persone e rendono comprensibile
l’azione [...] Se la cultura fonda la società, e la società fonda la costruzione sociale della realtà,
allora disabilitare le cornici culturali equivale a disabilitare, per la popolazione civile, il senso stesso
di una realtà vivibile, nonché la capacità individuale di agire…” (Nordstrom 1992, p. 261). Se
l’obiettivo della scrittura antropologica è farci cogliere il punto di vista dei nativi, cioè ricostruire la
compattezza fenomenologica del loro mondo, di fronte alla violenza radicale si tratta piuttosto di
restituire il senso della dissoluzione di un mondo culturale. E’ come se l’etnografo, abituato a
cercare di seguire faticosamente la via che porta al significato, dovesse adesso ripercorrerla a
ritroso. E in questo tornare indietro la stessa nozione di “ragione etnografica” viene messa in
discussione. Nordstrom nota come il tentativo di capire le ragioni della guerra e della violenza “si
avvicini pericolosamente all’obiettivo di rendere la guerra ragionevole”, e rischi di fatto di “mettere
a tacere la realtà della guerra” (1995, p. 138). Dunque, la ricerca di significati e ragioni della
violenza contrasterebbe profondamente con l’obiettivo etnografico di comprendere il ruolo della
violenza nel mondo-della-vita degli attori sociali.
Qui tocchiamo un punto importante. Si può ben sostenere, naturalmente, che in quanto attività
umana la violenza è una pratica significativa e governata-da-regole come tutte le altre, e che
comprenderla equivale a scoprire tali regole e significati; se pensassimo che comprendere equivalga
a perdonare, confonderemmo “l’idioma disciplinare delle scienze sociali con il linguaggio
quotidiano” (Abbink 2000, pp. xii-xiii). Ma l’argomento sollevato da Nordstrom mette proprio in
discussione l’adeguatezza del normale linguaggio delle scienze sociali, con i suoi effetti distanzianti
e generalizzanti, con la sua ricerca di un coerente insieme di motivi, ragioni, cause 161 . Un ulteriore
problema si pone per quegli etnografi che lavorano in contesti dominati dalla violenza di stato, dove
le atrocità, le torture e la repressione sono al tempo stesso supportati e celati da un ordine discorsivo
normalizzante, che le mostra appunto come ragionevoli e necessarie (ad esempio presentando il
terrore come contro-terrore; v. Chomski 2004). Alcuni autori, in particolare M. Taussig, hanno
avvertito il rischio di parlare del terrore con un linguaggio eccessivamente contiguo a quello che il
terrore copre – contiguo se non nei contenuti, almeno nella forma di un ordine discorsivo
161
Peraltro, sembra eccessivo e inutile spingere questa critica fino al concetto stesso di ragione, come fa Nordstrom, o
contro la tendenza antropologica alla “ricerca del senso”. Quest’ultima oscurerebbe i concreti “individui che vivono,
soffrono e muoiono, i quali sono la guerra”; e le ragioni, di fronte alle questioni di vita e di morte, sono rimpiazzate da
una “cacofonia di realtà” (1995, p. 137). A parte la vaghezza di quest’ultima formula, non è chiaro dove stia la
contraddizione fra la ricerca del senso e il metodo etnografico della studiosa, centrato sulla raccolta di storie individuali
e sull’analisi del simbolismo della violenza e di quello della resistenza quotidiana. Proprio il suo sforzo di attingere la
realtà soggettiva del dolore, del “disfacimento del mondo” e i tentativi di ricostruirlo con i mezzi della cultura
testimonia a favore di una nozione di comprensione antropologica come elucidazione delle ragioni e dei significati che
rendono umane certe pratiche. Cfr. anche Nordstrom 1997, 2004, Finnström 2001.
conciliante, di una asettica chiusura nelle convenzioni accademiche, di un realismo che normalizza
lo status quo. La complicità è reale, non soltanto simbolica, dal momento che il fatto stesso di
parlare della violenza (ad esempio la diffusione di un repertorio di storie di atrocità) è parte
integrante della “cultura del terrore”, è anzi ciò che le permette di funzionare. Il legame
indissolubile di violenza e ragione che fonda lo Stato moderno (il “discorso della ragione come
guanto di velluto che nasconde il pugno d’acciaio”) è per Taussig 162 all’origine dell’inevitabile
aporia in cui cadono i tentativi delle scienze sociali di parlare della violenza. Aporia che prende la
forma di mimesi tra la rappresentazione e ciò che viene rappresentato163 .
Costruire un controdiscorso, scrivere del terrore contro il terrore, diventa allora una faccenda
assai complicata, che richiede – almeno per Taussig - una sovversione delle convenzioni
compositive e della “poetica del bene e del male” radicata nel discorso egemonico; per accostarsi
invece a quella poetica dello sciamanismo e della guarigione cui fa cenno in conclusione del saggio
qui presentato, e che svilupperà nella sua più nota monografia (Taussig 1987). Ne risulta una
scrittura frammentaria, discontinua, più evocativa che analitica e peraltro non sempre facile da
seguire – soprattutto nelle opere degli anni Novanta. Non tutti gli etnografi sono, come Taussig,
ossessionati dalla compenetrazione tra discorso e potere, e dai tranelli mimetici di una violenza che
può infiltrarsi nelle forme stesse della sua rappresentazione e persino della sua denuncia. Tutti sono
però alla ricerca di forme di scrittura adeguate a restituire la particolare tensione fra aspetti
epistemologici, emozionali ed etici della propria esperienza di ricerca. I problemi sollevati
dall’etnografia della violenza non sono forse diversi da quelli che caratterizzano oggi l’etnografia
tout court; si manifestano però in modo più accentuato e spesso decisamente drammatico. Ad
esempio, la classica tensione malinowskiana fra l’esperienza di partecipazione soggettiva del
ricercatore, da un lato, e dall’altro le esigenze di oggettività della rappresentazione, cambia aspetto
quando il ricercatore è coinvolto in esperienze di altissimo impatto emotivo, di terrore, di rabbia, di
odio che annullano ogni possibile margine di distacco scientifico.
Ancora, uno dei problemi sollevati dalla svolta riflessiva dell’antropologia – il diritto
dell’etnografo di parlare in nome dei soggetti della sua ricerca – assume qui caratteristiche
peculiari. Non si tratta solo del fatto, ormai ampiamente affermato dalla tradizione dei cultural e
postcolonial studies, che la presa di parola antropologica per conto degli “Altri” si fonda su
presupposti di potere non analizzati, collocando i prodotti antropologici nell’ambito del discorso
coloniale. Il posizionamento politico e discorsivo degli etnografi della violenza è più complesso e
ambiguo di quello classico analizzato da critici come E. Said e G. Chakrabarti Spivak. In molti casi,
la “presa di parola” è concordata con gli attori sociali, i quali possono vedere nel rapporto con
l’etnografo, nella scelta di affidare alla sua scrittura informazioni riservate, segrete o magari
162
1992, p. 115. Questo tema è di fatto l’asse portante dell’intera opera dello studioso, che esplora il nesso violenzaragione-stato in una serie assai compatta di volumi degli anni ’80 e ’90 (Taussig 1983, 1987, 1992, 1993, 1997, 1999).
163
A proposito dei resoconti di Handenburg e Casement sulle atrocità coloniali nel Putumayo, discussi nel saggio qui
presentato, Taussig osserva come, per quanto critici nell’intenzione, essi “presuppongono e rafforzano quegli stessi
rituali dell’immaginazione coloniale cui gli uomini soccombevano torturando gli indiani. Nel loro cuore immaginativo,
queste critiche erano complici con ciò a cui si opponevano” (Taussig 1987, p. 133). Sulla stessa linea si collocano le
osservazioni mosse da Taussig alla poetica conradiana di Cuore di tenebra.
strettamente intime, un importante ritorno comunicativo e pragmatico. I terroristi nord-irlandesi che
concordano con l’etnografo le modalità di scrittura di un libro a loro dedicato (Sluka 1989, 1995a); i
parenti dei desaparecidos argentini che confidano nel ricercatore, straniero e scientificamente
obiettivo, perché si faccia portatore di una denuncia che in patria non riesce a farsi sentire (Robben
1995); i rifugiati che vedono nell’intervista biografica una legittimazione della loro storia e un
riconoscimento del loro status (Malkki 1995a), sono solo alcuni fra gli esempi di un rapporto non
unilaterale, di un complesso negoziato tra gli “interessi” dell’etnografo e quelli dei suoi
interlocutori.
Il problema che si pone è di tipo diverso, e riguarda la messa in scena dello spettacolo del dolore e
della sofferenza. Proprio per la sua pretesa di mantenersi vicina all’esperienza vissuta, di mostrare
la violenza non nella genericità delle sue “ragioni politiche” ma negli effetti sui corpi e sulle
soggettività degli attori sociali, l’etnografia lascia emergere in primo piano i dettagli delle atrocità e
i tormenti della memoria di chi è sopravvissuto. Questo sguardo ravvicinato, sia sull’orrore della
violenza fisica e della tortura, sia sull’umiliazione e la disperazione di persone colpite alle basi
stesse della propria dignità e dei propri affetti, produce per il lettore un effetto irriducibilmente
ambiguo. La descrizione puntigliosamente dettagliata delle sevizie subite dagli indios del
Putumayo, nel saggio qui presentato di Taussig, ne è un esempio; non meno forti e disturbanti sono
i resoconti delle scene di genocidio, degli stupri e delle torture eseguite pubblicamente, delle
mutilazioni dei corpi che punteggiano le etnografie delle “nuove guerre” contemporanee. Da un
lato, lo shock emotivo che tutto ciò provoca può diventare strumento di testimonianza e di
denuncia: la scrittura consegue il suo scopo scuotendo e indignando il lettore, e combattendo così
quell’indifferenza che troppo spesso ha accompagnato le violenze di massa nella modernità.
Dall’altro lato, tuttavia, lo spettacolo ravvicinato della violenza può suscitare effetti pornografici e
voyeuristici, e la scrittura etnografica degenerare in una messa in scena in cui corpi e anime afflitti
sono arbitrariamente e talvolta oscenamente esposti nella loro più profonda intimità 164 . Ci si chiede
allora se la trasparenza etnografica sia un atteggiamento moralmente legittimo di fronte alla
sofferenza, e se l’indignazione militante non possa troppo facilmente trapassare in morbosità: tanto
più all’interno di un contesto comunicativo e mass-mediale che ci ha fin troppo abituati allo
sfruttamento delle immagini di violenza e alla penetrazione morbosa dell’intimità emotiva a fini di
audience e di successo commerciale (Sontag 2003, p. 83 sgg.). Non è forse immorale usare quel
dolore per sostenere la nostra impresa rappresentativa? Non sarebbe più corretto e rispettoso tacere,
164
Un esempio tanto noto quanto drammatico di questa ambiguità è rappresentato da una foto di Kevin Carter,
vincitrice nel 1993 del premio Pulitzer: una bambina sudanese denutrita, crollata a terra con un avvoltoio appostato a
pochi passi di distanza. La foto, di grande impatto comunicativo, ha svolto un ruolo importante nel mobilitare
l’opinione pubblica internazionale attorno ai problemi della carestia provocata in quegli anni nel Sudan meridionale
dalla guerra civile. D’altra parte, la stessa realizzazione della foto sembra implicare profondi problemi etici. Lo stesso
fotografo ha raccontato di aver atteso venti minuti che l’avvoltoio spiegasse le ali. Non ha forse strumentalizzato la
situazione, anteponendo la ricerca di un’immagine di successo all’imperativo dell’aiuto? Inoltre, la diffusione mediale
della foto non finisce per spettacolarizzarla, rendendo la stessa sofferenza della bambina una forma di intrattenimento?
Il dilemma è reso più drammatico dal suicidio, nel 1994, dello stesso autore della foto – un suicidio che, come hanno
commentato A. e J. Kleinman (1997, p. 7), sembra disintegrare la dicotomia morale tra soggetto e oggetto di quella foto,
fondendo le rispettive sofferenze.
ritrarre lo sguardo in nome di una pietà che non è forse del tutto compatibile con la ragione
etnografica? Naturalmente, tacere non serve però a portare testimonianza, a rendere o almeno a
chiedere pubblicamente giustizia per le vittime.
Il confine tra i due aspetti dell’etnografia della violenza – testimonianza e spettacolo, denuncia e
pornografia – non è mai ben definito. N. Scheper-Hughes e P. Bourgois (2004, p. 1) lo fanno
dipendere dalla capacità di tener conto delle “dimensioni sociali e culturali” che conferiscono
significato alla violenza, non limitandosi a rilevarne i soli “aspetti fisici”. Ma per lavori
antropologici questa è poco più di una tautologia. Più che dalla natura del testo (o dalle intenzioni
dell’autore), la risoluzione in un senso o nell’altro dell’ambiguità sembra dipendere da effetti di
lettura e dalle diverse sensibilità dei lettori. E’ curioso che uno stesso autore, ad esempio il già
citato Taussig, possa esser considerato da alcuni come ossessivamente volto a sottolineare “il
perverso erotismo della violenza estrema” (Avruch 2001, p. 643); da altri (e a mio parere più
sensatamente), come portatore, “con la sua capacità di raffigurare il terrore visceralmente”, di “una
istanza morale contro il potere esercitato nelle sue forme più grottesche” (Green 1995, p. 107).
Una possibile uscita dall’ambiguità può consistere in una etnografia centrata attorno alle voci
dirette dei testimoni, in grado di aggirare (almeno in apparenza) i rischi di effetti estetizzanti e
voyeuristici. In effetti, questa strategia è cospicuamente presente nella letteratura recente – a fronte
di un uso assai limitato delle fonti orali nella tradizione etnografica anglosassone. L. Green (1995,
p. 108) sintetizza questo atteggiamento nella formula dell’ “antropologo come uno scriba, che
documenta fedelmente le storie narrate dalla gente, ciò che essi hanno visto, sentito, annusato,
toccato, interpretato e pensato”. Qui sorgono tuttavia nuove difficoltà. Intanto, quando i testimoni
sono i perpetratori della violenza piuttosto che le vittime, la posizione morale del ricercatore si fa
ancora più complessa ed equivoca. Ciò accade in numerosi lavori sul terrorismo o su gruppi di
guerriglia (dove gli interlocutori sono quasi sempre al tempo stesso esecutori e vittime) 165 , sulla
violenza di stato, o su crimini comuni in contesti non bellici. La tensione fra le convinzioni e il
senso di giustizia dell’etnografo, da un lato, e dall’altro la sua propensione professionale a
empatizzare con gli informatori e a guardare il mondo dal loro punto di vista, si fa qui fortissima. Le
riflessioni di A. Robben (1995) sulle interviste ai militari argentini responsabili della “guerra
sporca”, su cui tornerò oltre, ne sono un esempio. Ancora più forte, per l’ampio uso di trascrizioni
di intervista e per il dilemma morale consapevolmente sollevato dall’autore, è il lavoro di P.
Bourgois (1995) sugli stupri di gruppo nei quartieri portoricani di New York. Lo spazio lasciato al
racconto diretto ed esplicito dei violentatori lascia emergere per intero il loro inquietante universo
morale, e produce un profondo effetto etnografico e pornografico al tempo stesso 166 .
165
Si vedano ad esempio i lavori sui guerriglieri sick di J. Pettigrew (1995) e C.K. Mahmood (1996), quelli sui
terroristi nord irlandesi di Feldman (1991, 2000) e Sluka (1995a, 1995b), sul contesto israelo-palestinese di
Swedenburg 1995 e Bornstein 2001.
166
Il lavoro di Bourgois (1995; v. anche Bourgois 1996) è incentrato su un gruppo di spacciatori di crack portoricani.
L’autore fa un lungo periodo di osservazione partecipante: diventa loro amico, ci fa sentire le loro voci, ricostruisce una
cultura subalterna la cui violenza esteriore è sottodeterminata dalla violenza emarginante e discriminante della cultura
egemonica. Ma l’empatia e la solidarietà politica dell’etnografo vacillano quando i suoi amici iniziano a raccontargli
degli stupri di gruppo che compiono abitualmente. Per quanto disgustato, continua a fare il suo lavoro, e ci offre le voci
narranti degli stupratori, con il loro gusto da bravata, i loro risolini, le usuali patetiche giustificazioni (“è quello che lei
Il problema della voce dei testimoni ha però una dimensione più ampia, che riguarda anche le
vittime stesse e che è stato messo a fuoco in primo luogo dagli storici. La storiografia
contemporanea sulla Shoah, ad esempio, ha guardato con un certo disagio al ruolo crescente assunto
nei media dalla narrazione autobiografica come strumento principale di rappresentazione degli
eventi. Se la storia di vita e la memoria individuale sono fonti importanti per il sapere storico, esse
non possono tuttavia sostituirlo e rendersi del tutto autonome, come sembra accadere in quella che
A. Wieviorka ha chiamato “l’era del testimone”. Ora, contrapporre nettamente il discorso storico e
la testimonianza biografica, il primo rivolto alla ragione e alla ricerca critica della verità, la seconda
al “cuore” e alla costruzione del senso (Wieviorka 1998, pp. 153-54), è una semplificazione
inaccettabile dal punto di vista antropologico. I dubbi sollevati da Wieviorka e da altri storici sono
però tutt’altro che infondati. Non si tratta tanto di deplorare il carattere parziale e soggettivo della
testimonianza e della memoria. Il perseguimento dell’ “imparzialità” sembra non avere molto senso
in contesti di violenza estrema; e passare attraverso il piano degli effetti soggettivi della violenza e
del terrore è indispensabile, come abbiamo visto, per un approccio che si voglia definire etnografico
(ne è un ottimo esempio il saggio di V. Das incluso in questo volume).
Ciò che occorre evitare è però l’assolutizzazione delle versioni testimoniali come rappresentazioni
realistiche della verità. Il lavoro antropologico sulle storie di vita, così come gli studi psicologici
sulla memoria individuale e collettiva, ci mostrano la complessità delle procedure di plasmazione
culturale del ricordo autobiografico, di fusione tra esperienze personali e modelli culturali diffusi 167 .
Ciò rende i racconti testimoniali documenti di inestimabile valore antropologico, senza che tuttavia
il discorso etnografico stesso si possa esaurire in essi o nascondersi dietro la loro autorità. Il rischio
del ventriloquismo etnografico denunciato in un famoso passo di C. Geertz (1988, p. 145) si fa qui
particolarmente forte; così come peraltro si fa forte, se non insormontabile, la difficoltà di
sottoporre a critica delle fonti e ad esercizi di distaccato scetticismo i racconti drammatici ed
emotivamente esplosivi delle vittime di violenza estrema. Ancora una volta, l’impatto con il dolore
e la sofferenza, oltre che con l’implicita o esplicita richiesta di solidarietà e partecipazione umana,
sembra paralizzare l’atteggiamento “scientifico” e porre in questione le più consolidate forme di
scrittura.
Vorrei far notare la prossimità tra questi problemi e quelli posti dal dibattito storiografico ed
epistemologico sulle modalità di rappresentazione della Shoah – un ambito con il quale
l’antropologia ha finora dialogato troppo poco. Anche in questo caso, sono centrali i dilemmi etici
voleva”), la loro “cosmologia”. Ci troviamo immersi in un universo di relazioni sociali, di rapporti uomo-donna, di
principi morali particolarmente rivoltanti, e la distaccata testimonianza etnografica sconfina a tratti nella pornografia più
oscena. Assai inquietante è anche il contributo dell’antropologa americana Cathy Winkler (1991, 1995), che descrive
uno stupro da lei stessa subito cercando di utilizzare le tecniche di osservazione etnografica, dunque con una
sconcertante attenzione per il dettaglio, e con il tentativo di capire e restituire il punto di vista dell’aggressore. Sono
ricostruiti i gesti, i dialoghi, l’atteggiamento dello stupratore, il terrore della vittima. Per l’autrice, questo racconto è
evidentemente una delle risposte possibili al trauma: oggettivare se stessi e le proprie emozioni, riconquistare la
padronanza della situazione, e anche raccogliere elementi che possano servire ad ottenere giustizia. Per il lettore, è una
costante e dolorosa oscillazione fra l’identificazione narrativa con la vittima e una sorta di effetto morbosamente
pornografico, l’impressione di star assistendo a qualcosa che non si dovrebbe vedere, perlomeno non così da vicino.
167
Per una più approfondita discussione del rapporto tra ricordo individuale e sociale, in relazione a una ricerca sulla
memoria degli eccidi nazifascisti di civili nella Toscana del 1944, rimando a Dei 2005.
sollevati dalla rappresentazione della sofferenza e quelli relativi al rapporto tra scrittura ed eventi
estremi. Quale forma espressiva consente di parlare legittimamente della Shoah – nel senso di
restituire la natura terribile e peculiare dell’evento, e rispettare al contempo la memoria delle
vittime? Come Adorno sosteneva che è barbaro fare poesia dopo Auschwitz, non potremmo
considerare ugualmente inappropriata sul piano etico la scrittura saggistica e accademica, con il suo
sfoggio di erudizione, le sue note a piè di pagina, il suo compiacimento intellettualistico (Kellner
1994, p. 409)? L’oggettivazione e il distanziamento storiografico non contrastano forse con le
istanze della memoria e del lutto? E, soprattutto, il medium ordinante e normalizzante della scrittura
non tradisce di per sé l’essenza estrema della pratica genocida, che consiste proprio nello spezzare
l’ordine e la normalità culturale? Come osserva J. Young (1988, p. 16), “una volta scritti, gli eventi
assumono l’aspetto della coerenza che la narrativa necessariamente impone loro, e il trauma della
loro non assimilabilità è superato” – laddove è proprio la traumatica straordinarietà ciò che la
testimonianza intenderebbe restituire.
Sulla base di queste premesse, il dibattito si concentra sul realismo come strategia di
rappresentazione. Si sostiene da un lato la necessità di rappresentare la Shoah attraverso uno stile
“fattuale”, che conceda il meno possibile alla costruzione letteraria e agli interventi esplicitamente
autoriali 168 . Dall’altra, si obietta che quando la realtà stessa diventa così estrema e aberrante,
straordinaria rispetto al contesto culturale comune, un semplice linguaggio fattuale non è più in
grado di restituirne la qualità. Il primo argomento è molto forte: l’esperienza della Shoah
segnerebbe il limite invalicabile oltre il quale non può spingersi la decostruzione postmoderna
dell’oggettività e della verità storica. Come pensare di mettere in discussione la fondamentale realtà
dell’evento, o meglio, come accettare la possibilità di una medesima “infondatezza” di più versioni
narrative, ad esempio quella dei carnefici e quella delle vittime? La ripugnanza morale per gli esiti
relativistici del decostruzionismo, potenzialmente di supporto alle tesi negazioniste, ha spinto molti
autori in questa direzione 169 ; e l’argomento è spesso ripreso nella letteratura etnografica sulla
violenza. Di fronte all’enormità delle stragi, delle torture e degli stupri, e alla profondità della
sofferenza incontrata, sembra intollerabile l’idea di una pluralità di versioni possibili degli eventi e
della dipendenza dell’idea stessa di verità da finzioni retoriche 170 .
Tuttavia, come detto, la letteratura etnografica è ben lontana dal seguire modelli di scrittura
cronachistica e fattuale. Al contrario, proprio lo sforzo di cogliere la verità ultima della violenza,
l’autenticità di una esperienza straordinaria e non convenzionale, spinge i ricercatori verso forme di
168
Si vedano ad esempio le posizioni del filosofo B. Lang (1990), che ammette solo la possibilità di una cronaca
fattuale degli eventi della Shoah, condannandone ogni resa attraverso un linguaggio figurato e stilizzato, o attraverso
forme narrative e di emplotment, colpevoli di introdurre un significato e un’intenzione autoriale estranee all’autentico
contesto del genocidio e irrispettose dell’esperienza delle vittime. Sul piano etico, è come se un persistente lutto
imponesse di tenere sotto stretto controllo l’impulso all’espressione artistica e creativa, a favore di uno stile impersonale
in cui il linguaggio è per quanto possibile trasparente.
169
Fondamentali sono i saggi raccolti in Friedlander (ed.) 1992, e in particolare la discussione fra H. White e C.
Ginzburg (per la traduzione italiana dei loro due testi v. White 1999 e Ginzburg 1992)
170
“Chi sostiene un’idea dell’etnografia come puro racconto pone l’autorità degli studiosi (sia pure involontariamente)
al servizio dei sinistri tentativi di negare l’Olocausto, la «guerra sporca» latino-americana e altri recenti episodi di
distruzione organizzata. Attraverso la lente postmoderna, essi divengono semplicemente «racconti» o «finzioni», il che
è repellente in termini sia intellettuali che morali..:” (Suárez-Orozco, Robben 2000, p. 12 nota).
scrittura varie e complesse – di tono più modernista che realista, con ampio uso di riflessioni
soggettive e di estratti di diari e note di campo, con lo stretto intreccio tra narrazioni di eventi e
sollecitazioni teoriche e interpretative, la giustapposizione di contesti ottenuta attraverso i frequenti
riferimenti letterari. Un’analisi in questo senso del corpus etnografico prodotto dagli anni ’90 ad
oggi sarebbe estremamente interessante. Il piano etnografico non è tuttavia centrale nei saggi di
questo volume, che mirano piuttosto a costruire una cornice teorica in cui inquadrare i fenomeni
della violenza di massa contemporanea. Nel resto dell’introduzione, vorrei discutere appunto alcuni
aspetti del dibattito teorico.
3. Identità e violenza
Un tratto peculiare delle “nuove guerre”, forse il tratto peculiare, è la loro connessione con politiche
dell’identità, vale a dire con “movimenti che muovono dall’identità etnica, razziale o religiosa per
rivendicare a sé il potere dello stato” (Kaldor 1999, p. 90). Nel linguaggio giornalistico e
nell’opinione pubblica occidentale, si è infatti parlato prevalentemente di conflitti etnici o, nel caso
dell’Africa, tribali, intendendo con questo che:
a) i gruppi in conflitto sono definiti sulla base di un’appartenenza e di vincoli pre-politici, cioè
della condivisione di certi tratti razziali e culturali (il “sangue”, la lingua, la religione, etc.)
concepiti come patrimonio antichissimo e primordiale;
b) le cause del conflitto, al di là di specifiche contingenze storiche, sono da individuarsi in odii
ancestrali tra gruppi etnici, che covano costantemente sotto la cenere per emergere
periodicamente in modo esplosivo.
In molti casi, una simile concezione primordialista dell’appartenenza e del conflitto è
esplicitamente sostenuta e usata come forza ideologica e strumento di consenso dalle parti in lotta:
un caso paradigmatico è naturalmente quello della ex-Jugoslavia, dove i diversi nazionalismi hanno
alimentato la guerra sostenendo che i croati non possono vivere insieme ai serbi, questi non possono
vivere insieme ai musulmani e così via, rivangando presunti motivi di divisione che si perderebbero
nella storia.
Ora, laddove non assuma tinte decisamente razziste, una simile concezione dell’appartenenza
sembra poggiare su categorie antropologiche quali cultura, tradizione, identità. Più di ogni altra
scienza, l’antropologia si è battuta nel corso del Novecento per l’affermazione dell’idea di culture
compatte, autonome e distintive, di pari dignità e tendenzialmente incommensurabili, come
patrimonio dei diversi popoli. L’elaborazione di una nozione pluralista e relativista di “culture” è
avvenuta nel quadro di un deciso impegno antietnocentrico, sul piano epistemologico come su
quello etico-politico. Impegno volto al riconoscimento della dignità delle culture cosiddette
“primitive”, nonché alla valorizzazione e salvaguardia della diversità culturale a fronte
dell’omologazione prodotta dall’imperialismo e dalla occidentalizzazione. Il discorso sulle culture e
sulle identità, plasmato all’interno dello specialismo disciplinare, ha incontrato resistenze ma è
lentamente entrato a far parte del linguaggio comune. In questo passaggio i concetti si sono però
fortemente reificati: culture e identità sono state intese come essenze più o meno immutabili, quasinaturali, non costruite nella storia e nei rapporti politici ma date prima e indipendentemente dalla
politica e dagli eventi storici. Inoltre il loro segno è progressivamente cambiato: se ne sono
appropriati ideologie xenofobe e fondamentaliste, aggressivi nazionalismi e regionalismi,
movimenti volti più al mantenimento del privilegio che al riconoscimento delle differenze. Una
volta naturalizzati, tali concetti sono stati posti a fondamento di politiche di pregiudizio e
intolleranza – in una parola, di un atteggiamento neo-razzista, in un’epoca in cui il razzismo
classico di impronta biologica, screditato dall’uso fattone dal nazismo, non sembrava più
sostenibile.
A questi usi pubblici dell’identità culturale ha fatto riscontro una radicale critica (o autocritica) da
parte degli studi antropologici. Nel dibattito disciplinare degli ultimi decenni del Novecento ha
giocato un ruolo centrale la revisione del concetto di cultura, secondo linee argomentative molto
note che è qui appena il caso di rammentare. Da un lato, si è reagito alla essenzializzazione della
identità culturale, insistendo sulla sua natura di costrutto teorico o di finzione retoricamente
prodotta all’interno della scrittura etnografica: non una peculiarità dell’oggetto, dunque, ma una
modalità dello sguardo antropologico. Dall’altro lato, si è cercato di mostrare che le rivendicazioni
identitarie, laddove si diffondono in determinati contesti storico-sociali, lo fanno in relazione a
precisi interessi o conflitti di potere, ai quali forniscono un supporto ideologico. Ne risulta che i
discorsi dell’identità possono accompagnare i conflitti, ma non ne sono la causa: non rappresentano
condizioni prepolitiche dei rapporti tra gruppi umani, e dai rapporti politici sono invece determinati.
“Quando gli uomini entrano in conflitto non è perché hanno costumi o culture diverse, ma per
conquistare il potere, e quando lo fanno seguendo schieramenti etnici è perché quello dell’etnicità
diventa il mezzo più efficace per farlo” (Fabietti 1995, p. 151). Nelle sue forme più radicali,
l’autocritica antropologica giunge a denunciare le basi stesse dell’impresa disciplinare, cioè il
discorso sulle differenze culturali, in quanto correlato ideologico delle strategie di potere nei
confronti dell’Altro: dal momento che non esistono differenze culturali date, il discorso che
pretende di descriverle contribuisce in realtà alla loro costruzione e perpetuazione. La differenza
sarebbe dunque l’altra faccia della disuguaglianza e del dominio: e un’antropologia critica dovrebbe
porsi come obiettivo non quello di scrivere sulle culture e sulle differenze ma di scrivere contro di
esse (Abu-Lughod 1991).
L’argomento che si delinea è abbastanza chiaro. Le politiche dell’identità sono uno strumento
della violenza; l’antropologia ha contribuito in modo determinante a forgiare un discorso su identità
e differenze culturali; di conseguenza, l’antropologia è oggettivamente complice della violenza. Per
meglio dire, è una di quelle “discipline della violenza” che accompagnano – secondo l’analisi di
Foucault – l’esercizio del potere nel regime della modernità. Nella letteratura recente sulla violenza,
diversi contributi sono stati dedicati a queste forme di complicità. Ne è un esempio l’intensa
discussione di N. Scheper-Hughes, nel saggio qui presentato, del ruolo ambiguo dell’antropologia
nello sterminio degli indiani californiani – chiaramente visibile nel singolare rapporto tra Alfred
Kroeber e Ishi, l’ultimo sopravvissuto di un silenzioso ma implacabile etnocidio. Di particolare
interesse sono inoltre i lavori sul supporto delle scienze umane ai programmi razzisti e genocidi del
nazismo e di altri regimi totalitari (Dow-Lixfeld 1994, Conte-Essner 1995, Linke 1997, 1999,
Arnold 2002, Shaff 2002); nonché le ricostruzioni degli atteggiamenti intellettuali e delle prese di
posizione istituzionale dell’antropologia accademica di fronte alla scomparsa progressiva dei popoli
indigeni, causata in modo talvolta involontario, ma più spesso volontariamente e consapevolmente,
dall’imperialismo occidentale (Bodley 1990, 1992, Maybury-Lewis 2002). Nel leggere questi
lavori, siamo in effetti colpiti dalla facilità con cui consistenti settori ed esponenti di spicco della
disciplina abbiano aderito a ideologie di regime, e abbiano assunto posizioni di più o meno aperta
giustificazione delle pratiche genocide. Ciò vale non solo per il nazismo e per i contesti totalitari,
ma anche per le grandi tradizioni antropologiche dei paesi liberali. Di fronte all’evidenza dei
genocidi indigeni, queste ultime li hanno per lo più accettati come una condizione inevitabile dell’
“incontro” fra civiltà e culture diverse, contribuendo, come scrive John Bodley (1992, p. 47), a
“mascherare la dimensione politica della violenza contro i gruppi tribali”. Questo autore sintetizza
così le posizioni delle diverse scuole antropologiche in proposito:
Gli antropologi sono stati ovviamente consapevoli del destino dei gruppi tribali. Per
un secolo, essi sono stati a guardare mentre un gruppo dopo l’altro veniva sterminato
dalle politiche governative, senza fare tuttavia alcun tentativo per fermare la violenza,
dal momento che la prevalente teoria evoluzionistica considerava naturale e inevitabile
la scomparsa dei gruppi tribali. Con il declino dell’evoluzionismo, gli antropologi hanno
scoperto che la teoria funzionalista facilitava “l’intervento scientifico” nel processo di
conquista, aiutando a ridurre, ma non a eliminare, la violenza della conquista politica.
Gli antropologi dello sviluppo in contesto postcoloniale hanno teso ad accettare la
conquista delle aree tribali interne in stati indipendenti come un inevitabile progresso
del processo di costruzione nazionale (Ibid.).
Ma non si tratta solo del mancato o troppo tiepido impegno politico dei singoli antropologi o delle
loro associazioni. Come detto, è la stessa epistemologia della disciplina, il suo apparato concettuale,
il suo modo di rappresentare, classificare, oggettivare e astrarre (Comaroff, Comaroff 2003) gli
“altri” che al tempo stesso presuppone e sostiene la politica del dominio violento. In ambito
evoluzionista, ciò è passato soprattutto attraverso l’idea di progresso e la primitivizzazione
dell’altro; nella fase relativista, attraverso la reificazione delle culture e il sogno di una loro
descrizione e classificazione universale – un censimento o anagrafe antropologica globale, in grado
di incasellare ogni differenza e di renderla disponibile al controllo di un’unica intelligenza, la
nostra. Come nell’analisi dell’orientalismo di Said (1978), il discorso antropologico incorpora ed è
reso possibile da quegli stessi presupposti che, sul piano dell’azione politica, producono
l’oppressione e la violenza. Non è questione dunque di buona volontà dei singoli studiosi: la
disciplina non è riformabile, secondo tale concezione, e può esser solo completamente rifondata a
partire da una prospettiva antiegemonica.
L’ambito dei post-colonial studies lega strettamente l’interesse per la violenza con questo
approccio radicalmente critico all’intera tradizione antropologica. Portare in primo piano la
violenza, soprattutto quella che percorre l’asse egemonia-subalternità (nel senso sia di violenza di
classe che di relazioni internazionali neo-imperialiste), farebbe esplodere le contraddizioni interne
all’antropologia classica, colpendo quello che è forse il suo principale nucleo epistemico – la
necessità di nascondere dietro una maschera culturalista la natura politica, oppressiva e in ultima
analisi genocida dell’ “incontro” con gli altri. A mio parere questo tipo di critica, per quanto
ineludibile, va accolto con molte cautele. In primo luogo, non trovo giustificata la sua pretesa di
rovesciare la tradizione ermeneutica o interpretativa dell’antropologia in nome di un
neomaterialismo tutto volto a identificare le cause “reali” dei fenomeni storici al di sotto delle
“apparenze” sovrastrutturali (la cultura, il significato). In secondo luogo, mi pare che occorra
distinguere l’analisi dei presupposti retorico-politici del discorso antropologico da un giudizio
storico ed etico sulla disciplina – una confusione, questa, che ha caratterizzato anche alcune letture
di Said. Le denunce di complicità rivolte all’antropologia accademica non sembrano tener conto dei
contesti storici in cui essa si sviluppa. Occorre chiedersi quale ruolo abbia svolto il discorso
antropologico, nelle varie fasi del suo sviluppo, in relazione al senso comune e alle posizioni
prevalenti dell’opinione pubblica o di altre scienze. Storicizzando, possiamo forse formulare un
giudizio più prudente e articolato, senza fare di ogni erba un fascio. Possiamo constatare, ad
esempio, come l’antropologia si sia in prevalenza caratterizzata per la promozione di una sensibilità
antietnocentrica a fronte di istituzioni politiche e di un’opinione pubblica apertamente razzista;
come abbia sostenuto le ragioni della comprensione e del dialogo contro quelle del puro dominio
economico e militare 171 .
Lasciando per il momento sullo sfondo questa discussione, quel che è certo è che molti
antropologi contemporanei hanno reagito alle interpretazioni di senso comune delle nuove guerre
contestandone la natura e l’origine specificamente etnica, e denunciando la strumentalizzazione che
del discorso etnico e identitario fanno alcune parti in conflitto. I saggi di J. Bowen e di R. Hayden
qui presentati sono esempi chiari e molto netti di questa reazione antropologica all’interpretazione
etnicista sostenuta dalla maggior parte dei media. Entrambi sostengono che i conflitti cosiddetti
etnici sono il prodotto di scelte politiche compiute dall’alto e non del naturale scontro fra identità
precostituite. Bowen sviluppa un argomento generale, in riferimento a una pluralità di casi ma con
l’attenzione particolarmente rivolta a Ruanda e Balcani; Hayden si concentra sulla ex-Jugoslavia,
sottolineando il ruolo cruciale dei nazionalismi e della loro convinzione (non solo serba e croata)
che un’aggregazione statale sia possibile solo su base etnica. Il rapporto tra eventi politici, violenza
e quella che potremmo chiamare realtà antropologica dei territori interessati è qui capovolta
rispetto all’interpretazione comune. Non abbiamo a che fare con strutture antropologiche
(separazioni etniche, divisioni identitarie) che rendono impossibile la convivenza e l’accordo
politico e che, venuto meno l’oppressivo dominio comunista (Balcani) o coloniale (Africa),
esplodono producendo disgregazione politica e conflitti violenti. Al contrario, la violenza è l’unico
modo in cui i nazionalismi possono imporre il proprio modello ideale di uniformità etnica su una
realtà sociale e su strutture antropologiche che sono ormai divenute multietniche. Vittime reali per
171
Per un approfondimento di questa argomentazione rimando a Dei 2004a.
comunità immaginate, appunto, come si esprime Hayden parafrasando la celebre formula di
Benedict Anderson.
Se l’argomentazione dei due saggi è nel complesso convincente, ci sono però alcuni aspetti che
meriterebbero di essere approfonditi. D’accordo, le appartenenze etniche non sono mai
precostituite, e producono conflitti solo dove vengano spinte in questo senso dall’ “alto”, vale a dire
dai leader politici e da campagne propagandistiche che fanno leva su sentimenti di paura e odio.
Ma queste analisi lasciano in secondo piano il problema antropologico forse più importante, vale a
dire una valutazione del reale grado e dei motivi della diffusione del sentimento di appartenenza
etnica. Hayden, come detto, imposta la sua argomentazione attorno al contrasto tra i modelli di
purezza etnica “immaginati” e promossi dai nazionalismi e la “cultura vivente” dei territori
jugoslavi – vale a dire le strutture antropologiche realmente diffuse. Queste ultime sarebbero state
dominate, fino al crollo del comunismo, dalla eterogeneità, dal mescolamento, da pratiche
quotidiane che rendevano sempre più irrilevante la questione dell’appartenenza etnica. Proprio il
solido radicamento di una “realtà della vita” così difforme dai modelli essenzialisti avrebbe reso
necessario il ricorso alla violenza estrema della pulizia etnica. Ora, questa tesi di un
multiculturalismo realizzato nella “cultura viva” della Jugoslavia sarebbe tutta da dimostrare sul
piano empirico ed etnografico: non possono bastare i riferimenti statistici di Hayden al crescente
numero di matrimoni misti e di cittadini che nei censimenti si dichiaravano “jugoslavi” piuttosto
che appartenenti a un’etnia particolare172 . Ma, se anche così fosse, come potrebbe spiegarsi il
grande consenso, anche elettorale, suscitato dai movimenti e dalle idee nazionaliste? E soprattutto,
come potrebbe spiegarsi l’apparente facilità con cui si è trascorsi dalla tranquilla convivenza
all’odio e a una inaudita pratica di violenza? Il controllo dei mezzi di comunicazione di massa,
l’adesione di buona parte del mondo intellettuale, le campagne propagandistiche, gli effetti
devastanti della crisi economica sono fattori chiave, certo, per il successo del nazionalismo più
sciovinista e per lo scatenamento dei conflitti: ma possono bastare, da soli, a dar conto della
formazione di un così vasto appoggio e di una così immediata adesione ai progetti di pulizia etnica?
E’ difficile pensare che tutto sia potuto avvenire così rapidamente senza solide basi nella “cultura
vivente” di quei territori 173 .
172
Oltretutto, i dati che Hayden riporta potrebbero esser letti in opposizione alla sua tesi. Se è vero che nel dopoguerra
questi indici di integrazione sono in progresso, si tratta tuttavia di un progresso molto lento. Le percentuali restano
basse, mostrando la persistenza nella gran parte della popolazione di un forte senso di appartenenza etnico-nazionale
(cfr. in proposito Botev-Wagner 1993, secondo i quali “l’omogamia etnica è stata e rimane la norma in quella che era la
Jugoslavia”, paese in cui “l’integrazione etnica non si è mai realizzata”; v. anche Simic 1994). Anzi, il senso di
appartenenza etnico-nazionale è stato probabilmente rafforzato, come nota Bowen, dalla politica di integrazione
titoista, basata sulla circolazione dei dirigenti politici e statali, che portava ad associare il potere con la diversità etnica,
l’oppressione politica con una sorta di occupazione straniera. Per un’ampia rassegna di posizioni in proposito v.
Kideckel-Halpern 1993.
173
Che l’ideologia nazionalista, concepita come ancestrale o come artificiosamente imposta dai leader, sia la “causa”
della guerra è una tesi fortemente avversata anche dagli studiosi croati dell’Istituto di Etnologia e Folklore di Zagabria,
autori di numerosi contributi di etnografia della guerra (v. Čale Feldman, Prica, Senjković 1993; Jambrešić Kirin,
Povrzanović 1996; Povrzanović 2000). Un contributo nettamente schierato contro la tesi di un’origine “dall’alto” della
pulizia etnica è quello di M. Bax (2000). Per altri contributi antropologici sulla guerra jugoslava, si vedano Denich
1994, Bringa 2002, Nahoum-Grappe 1997, Marta 1999, Maček 2001, Cushman 2004.
Qualcosa di simile si può affermare per il Ruanda. Si può ripetere all’infinito, e con ogni ragione,
che hutu e tutsi non esistono come etnie, e che la loro contrapposizione è frutto delle politiche
coloniali; e si può mostrare quanto il loro reciproco odio, tutt’altro che atavico, derivi da una serie
di atti politici recenti e sia frutto, più che causa, della violenza (Vidal 1997, Fusaschi 2000, p. 124
sgg.). Nondimeno, gli uomini comuni che nell’aprile 1994 impugnarono il machete vivevano in un
mondo fondato sull’opposizione hutu-tutsi, o persone-scarafaggi, opposizione che sembrava godere
dello statuto di un presupposto ontologico, mai messo in dubbio neppure per un istante. La
propaganda radiofonica e le strutture di partito hanno reso organizzativamente possibile il
genocidio, ma hanno trovato terreno fertile, e volenterosi carnefici senza nessuna incertezza su chi
fosse il nemico da fare a pezzi. Hanno cioè trovato una “realtà vivente”, una struttura antropologica
di base nella quale il genocidio era fin dall’inizio una possibilità concreta. L’antropologia non può
trascurare il problema delle modalità della costituzione di un sentimento di appartenenza e di
contrapposizione etnica così forte. E’ scontato che si tratti di un sentimento e di una
contrapposizione storicamente creati e non “naturali”: ma una volta ribadito questo punto, tutto il
lavoro di interpretazione della visione del mondo locale, dei significati attribuiti all’identità hutu e a
quella tutsi, resta ancora da fare.
Trasportati dalla corretta critica alle visioni essenzialiste dell’identità etnica, Bowen e Hayden
eccedono nel ricondurre ogni aspetto delle politiche identitarie a pura ideologia inculcata dall’alto.
La capacità dei leader di “convincere” e “persuadere” la gente a odiare e uccidere sembra la
condizione necessaria e sufficiente del genocidio; e un simile argomento porta a trascurare la
profondità del radicamento storico di appartenenze e divisioni, il grado di consolidamento della
memoria o del sentimento etnico. Quest’ultimo ha una propria autonomia come ambito di
motivazione di comportamenti individuali e collettivi, come elemento costitutivo delle soggettività
che sono protagoniste dei genocidi 174 . Per quanto inestricabilmente intrecciato alla politica, non è
neppure integralmente riducibile ad essa. Questa irriducibilità è fondamentale per la prospettiva
antropologica, poiché è la stessa che si dà fra modelli culturali e astratta razionalità. Se pensassimo
di poter dissolvere senza residui l’opaco spessore della cultura nella trasparenza della ragione
utilitarista o economica, l’antropologia perderebbe in effetti la propria ragion d’essere. Se la nostra
disciplina serve a qualcosa di fronte alla complessità del mondo contemporaneo (e della sua
violenza), il suo contributo consiste nell’integrare l’universalismo della teoria politica pura con una
sensibilità per le peculiarità locali – aprendo la teoria politica, come si esprime C. Geertz (1999), al
lessico eterogeneo e impreciso delle differenze culturali.
174
Nella recente etnografia sulla violenza, questo punto è stato espresso nel modo forse più incisivo da E. Valentine
Daniel in un’ampia monografia dedicata alla memoria degli scontri etnici in Sri Lanka. Daniel lavora sulle costruzioni
identitarie e sulle relative rappresentazioni del passato (o forme di memoria etnica) di tre diversi gruppi, e insiste sul
fatto che la critica anti-essenzialista non deve spingere l’antropologia a ignorare la realtà storica di queste costruzioni:
“nell’eccitazione di scoprire che non ci sono altro che costruzioni, si è appiattita la cultura a una sola dimensione e si è
perso di vista quanto le differenti costruzioni culturali possano differire in quanto a resistenza e a grado di latenza (o
profondità, come qualcuno preferirebbe chiamarla)” (Daniel 1996, p. 14). Considerazioni non dissimili a proposito
delle identità religiose in India sono svolte da S. Kakar (1996), pur nel quadro di un’etnografia profondamente diversa,
informata da una sensibilità psicoanalitica più che strettamente antropologica. Sulle radici etniche del “fratricidio” nello
Sri Lanka si veda anche l’importante lavoro di S.J. Tambiah (1991).
4. Violenza, stato e il continuum genocida
Dunque, la relazione causale che molti antropologi istituiscono fra pratiche amministrative dello
Stato-nazione, politiche identitarie e violenza appare troppo schematica e determinista. Si teorizza
talvolta una “violenza intransitiva, che può operare concettualmente prima di manifestarsi
nell’azione” (Bowman 2001, p.27), presente in ogni istituzione promotrice di confini e identità: “la
violenza non è una performance nel corso della quale una entità compatta (una persona, una
comunità, uno Stato) viola l’integrità di un’altra; piuttosto, essa consiste nel processo stesso che
genera tali identità compatte per mezzo della inscrizione di confini” (Ibid., p. 28). Una
enunciazione come questa, a parte l’enigmatica inclusione del concetto di persona, sembra
considerare la costruzione di comunità e identità sociali come una artificiosa e interessata forzatura
rispetto a uno “stato naturale” di assenza di confini e, per così dire, di afflato universale
dell’umanità dal quale la violenza sarebbe assente. Un assunto, questo, spesso implicitamente
presente nelle posizioni di una critical anthropology tutta volta a indicare l’origine della
disuguaglianza e della violenza nello Stato, in particolare nel moderno Stato-nazione e nelle sue
politiche identitarie 175 . Ora, è evidente che sul piano storico non si può stabilire un nesso esclusivo
e causale tra stato-nazione, politica della differenza-identità e violenza: proprio l’antropologia ci
mostra la presenza di questi ultimi due elementi al di fuori della forma statuale. D’altra parte, in
relazione al contesto contemporaneo, attribuire le cause della violenza e della discriminazione a un
fattore così generale come lo stato non ha molto senso, e non ci pone in grado di distinguere società
più o meno violente (al loro interno e nei confronti di altre); né ci consente di valutare, nelle forme
“moderne” di gestione del potere, il rapporto e la tensione tra gli aspetti repressivi, da un lato, e
dall’altro il riconoscimento dei diritti e della dignità degli individui (ancora una volta, e in varia
misura, interni ed esterni). Pensare al nazismo, al nazionalismo balcanico o alla carneficina
ruandese come al disvelamento della vera natura delle istituzioni della modernità o del liberalismo
può essere un’utile provocazione, ma è di certo una prospettiva parziale, mossa da esigenze più
ideologiche che analitiche.
Lo stesso vale per la nota affermazione di J.L.Amselle (1990, p. 35) sul genocidio come
“paradigma identitario più efficace della nostra epoca”. Una definizione che equipara senz’altro la
violenza assoluta con le tensioni identitarie, identificando in queste ultime il “male” del secolo – e
trascurando così altri fattori, come il totalitarismo (dal nazismo al nazionalismo hutu, le politiche
dell’identità divengono genocide quando si combinano con regimi totalitari). Del resto, secondo una
diffusa tesi storiografica (Sternhell 2001), le radici culturali del fascismo e del nazismo stessi
starebbero nell’antiuniversalismo romantico, nelle filosofie, come quella herderiana, che vedono
175
Si veda ad esempio l’autorevole e citatissmo saggio di Verena Stolcke, Talking culture, che si chiude con un vero e
proprio anatema contro lo Stato. Ogni discorso sulla diversità culturale, ella afferma, implica disuguaglianza e
discriminazione, ed è dunque da condannare – eccetto che in una società genuinamente democratica ed egalitaria,
afferma l’autrice, chiedendosi retoricamente “se questo sia possibile nei confini del moderno stato-nazione, o, se è per
questo, di ogni forma di stato” (Stolcke 1995, p.13). Sfortunatamente, Stolcke non ci dice nulla di più sulla utopia nonstatuale e cosmopolita al cui servizio l’antropologia dovrebbe a suo parere porsi.
come protagonista della storia la comunità umana localmente situata più che l’astratta e disincarnata
ragione universale dell’illuminismo. Il che renderebbe equivoca e sospetta, e potenzialmente
genocida, quella sensibilità per la differenza che caratterizza l’intera tradizione del pensiero
antropologico, nella quale Amselle in effetti non sa vedere altro che gli aspetti classificatori ed
essenzialisti e che riduce a puro strumento del potere coloniale – e addirittura, esagerandone
l’importanza, a “uno dei fondamenti della dominazione europea sul resto del pianeta” (Ibid., pp. 4142): “l’intento etnologico deve essere visto essenzialmente come il modo di realizzare praticamente
il potere dei dominatori, modo che sfocia a sua volta nella etnologia come disciplina” (p. 44).
Eccoci dunque di nuovo al tema della complicità. Oltre che assai semplicistica sul piano della storia
delle idee, questa tesi stabilisce una serie di equazioni discutibili: l’antiuniversalismo antropologico
fa tutt’uno con le politiche identitarie dello stato-nazione; e queste ultime sono assunte a cause
principali della violenza genocida. Siamo così portati a trascurare il problema veramente
importante: e cioè, perché all’interno di un mondo fortemente interconnesso, percorso, certo, da
sentimenti identitari plasmati dalle politiche degli stati-nazione, si determinino talvolta le
condizioni di pratiche genocide.
Tuttavia, per quanto la critical anthropology indulga sovente in semplificazioni e scorciatoie
teoriche difficilmente accettabili, il problema del nesso tra la violenza di massa contemporanea e le
discipline di controllo dello stato moderno è importante e profondo. In questo volume, esso è colto
nel modo più pieno da Nancy Scheper-Hughes attraverso la nozione di “continuum genocida”,
riferita a quelle violenze quotidiane, nascoste e spesso autorizzate che si praticano “negli spazi
sociali normativi: nelle scuole pubbliche, nelle cliniche, nei pronto soccorso, nelle corsie
d’ospedale, nelle case di cura, nei tribunali, nelle prigioni, nei riformatori e negli obitori pubblici.
Questo continuum rinvia alla capacità umana di ridurre gli altri allo status di non-persone, di mostri
o di cose”, per mezzo di varie “forme di esclusione sociale, disumanizzazione, spersonalizzazione,
pseudo-speciazione e reificazione che normalizzano il comportamento brutale e la violenza verso
gli altri”.
L’antropologa statunitense è tornata spesso su questo tema negli ultimi anni – fra l’altro, curando
insieme a Philippe Bourgois un’antologia dal significativo titolo Violence in War and Peace
(Scheper-Hughes, Bourgois 2004), che raccoglie e affianca in modo provocatorio resoconti e
interpretazioni dei grandi genocidi e delle piccole violenze incastonate nella normalità quotidiana.
La sua carriera di ricercatrice l’ha portata a confrontarsi sistematicamente con quest’ultimo tipo di
situazioni: dal suo primo lavoro su un villaggio irlandese, caratterizzato da una socialità patogena
che rendeva la vita impossibile a certe categorie di persone sfociando in un alto tasso di disturbi
psichici (Scheper-Hughes 2000b [1980]), ai più recenti studi sulla mortalità infantile nelle
baraccopoli brasiliane (1992) e sul commercio internazionale di organi (Scheper-Hughes 2000a,
2001, 2004; Scheper-Hughes, Wacquant 2002). Ciò che caratterizza queste e analoghe forme di
violenza strutturale è il legame con istituzioni e forme di potere volte a preservare privilegi, da un
lato, e dall’altro la tendenza a esercitarsi secondo le linee di una classificazione gerarchica di
individui e gruppi, colpendo quelli che sono considerati in qualche modo come non pienamente
umani (la strategia della “pseudospeciazione”, secondo l’espressione di E. Erikson 176 ; ScheperHughes, Bourgois 2004, p.21). Sono tali caratteristiche che accomunano, per qualità, questa
violenza a quella che si manifesta nei grandi genocidi del ventesimo secolo 177 .
Le categorie interpretative che la studiosa utilizza insistono appunto in questa direzione: è il caso
della nozione di “crimini di pace”, che Franco Basaglia aveva introdotto nel 1975 in riferimento alle
pratiche repressive delle istituzioni totali, ma anche a tutte quelle forme di disciplinamento dei corpi
e delle menti che cancellano la dignità di individui stigmatizzati trattandoli come non-persone
(Basaglia, Ongaro Basaglia 1975). Gli stessi meccanismi di distruzione dell’identità personale
descritti da Primo Levi in relazione ai lager nazisti sembrano manifestarsi nel pieno della normalità
quotidiana, producendo una violenza strisciante e invisibile – non solo perché praticata all’interno
di istituzioni chiuse, ma perché legata a uno sfondo di consuetudine che rende difficile percepirla
come tale. Beninteso, Scheper-Hughes non trascura le differenze tra i grandi genocidi e quelli
“piccoli e invisibili”, come li definisce: e anzi, enuncia una serie di condizioni storicamente
collegate ai primi, che consentono cioè al “potenziale genocida” di trasformarsi in atto.
I genocidi sono spesso preceduti da sconvolgimenti sociali, da un declino radicale delle
condizioni economiche, da disorganizzazione politica, da cambiamenti culturali
improvvisi che mettono in crisi i valori tradizionali e diffondono anomia e assenza di
norme. Anche i conflitti tra gruppi che competono per il controllo di risorse materiali
come terra o acqua, talvolta, possono trasformarsi in eccidi di massa – se combinati con
sentimenti sociali che negano la basilare umanità degli avversari (Scheper-Hughes,
Bourgois 2004, p. 14)
Si può notare che tali condizioni sembrano contraddire la teoria del continuum, dal momento che
legano gli eventi genocidi alla rottura della normalità istituzionale e politica, alla disgregazione
dell’apparato statale. Ma allora, è il potere statale o la sua assenza a produrre il genocidio? Una
domanda che ci riporta alle note tesi di Annah Arendt sulla contrapposizione tra potere e violenza:
lontano dal rappresentare la diretta espressione del potere, la violenza “compare dove il potere è
scosso” (Arendt 1969, p. 61). Il potere, scrive la filosofa, fa parte dell’essenza di tutti i governi:
non così la violenza, la quale da sola non può mai fondare un potere (ibid., pp. 54-7). Le sue
osservazioni critiche sono assai pertinenti rispetto all’impianto teorico dell’odierna critical
anthropology: “equiparare il potere politico all’ «organizzazione della violenza» ha senso soltanto
se si segue la valutazione data da Marx dello Stato come strumento di oppressione nelle mani della
classe dominante”, cosicché “l’insieme della politica e delle sue leggi e istituzioni [sarebbero] pure
176
Sul nesso tra pseudo-speciazione e conflitti etici v. Tambiah 1989
Per l’altro curatore del volume, P. Bourgois, il continuum della violenza si manifesta anche in modo più netto nella
difficoltà di tracciare netti confini tra la guerra e la quotidianità. Soprattutto nel suo lavoro su El Salvador, egli insiste
sulle modalità con cui la violenza della guerra civile trapassa in un dopoguerra che è solo apparentemente di pace, e in
cui le politiche neoliberiste impongono ai contadini poveri sofferenze non minori di quelle del passato. La violenza
bellica e quella strutturale, in definitiva, apparirebbero come due facce di un ordine mondiale di ingiustizia che, dopo la
fine della guerra fredda, apparirebbe nella sua più profonda natura oppressiva (Bourgois 2001; v. Farmer 200 per una
analoga prospettiva a proposito di Haiti).
177
e semplici sovrastrutture coercitive, manifestazioni secondarie di altre forze sottostanti” (ibid. pp.
37-8).
Tornando a Scheper-Hughes, tutto ciò non inficia tuttavia l’idea di continuità fra crimini di pace e
di guerra. La continuità riguarda infatti la qualità specifica della violenza genocida e le motivazioni
soggettive degli esecutori. A proposito di queste ultime, l’antropologa insiste sul fatto che non
esiste alcun impulso specifico per la violenza di massa, la quale è semplicemente incardinata “nel
senso comune della vita sociale quotidiana”, e preparata dalle più diffuse istituzioni e sentimenti
sociali (Scheper-Hughes, Bourgois 2204, p. 22). Un punto che sembra del resto corroborato dagli
studi sugli “uomini comuni” protagonisti della Shoah (Browning 1992), e dalle ricerche di
psicologia sociale che mostrano come le aspettative di ruolo o una situazione di eteronomia o
obbedienza all’autorità siano presupposti sufficienti a fondare comportamenti violenti e
prevaricanti 178 . Ciò che manca invece nell’analisi di Scheper-Hughes è la dimensione storica.
Intendo dire che la tesi della continuità potrebbe essere riformulata nei termini di una genealogia
della violenza genocida che ha caratterizzato il ventesimo secolo. E’ questo il tema di un recente
studio di Enzo Traverso (2002) che analizza le origini della violenza nazista, riconducendole a una
serie di fenomeni centrali in quella che potremmo chiamare la costituzione antropologica della
modernità. Si tratta in gran parte di radici ottocentesche, che ancorano il nazismo (ma anche ampia
parte della violenza genocida del ventesimo secolo) alla “storia dell’Occidente, all’Europa del
capitalismo industriale, del colonialismo, dell’imperialismo, della rivoluzione scientifica e
tecnologica, l’Europa del darwinismo sociale e dell’eugenismo, l’Europa del «lungo» XX secolo
concluso nei campi di battaglia della prima guerra mondiale” (Traverso 2002, p. 22).
Il nesso tra tutti questi diversi elementi e la fenomenologia della violenza che caratterizza
Auschwitz (con le peculiari trasformazioni antropologiche del lager e la pianificata esecuzione dello
sterminio su scala industriale) ha a che fare con i rapporti tra potere, corpo e tecnologia. Traverso
prende avvio dall’introduzione della ghigliottina, che apre un’epoca di “morte seriale” in cui la
mediazione dell’apparato tecnico attenua la responsabilità morale dell’uccisore; prosegue
analizzando lo sviluppo ottocentesco di istituzioni “chiuse” come le caserme, le prigioni, le
workhouses o istituti di lavoro forzato e le stesse fabbriche – “tutti luoghi dominati dallo stesso
principio di chiusura, di disciplina del tempo e del corpo, di divisione razionale e di
meccanizzazione del lavoro, di gerarchia sociale e di sottomissione dei corpi alle macchine” (p .37).
Importanza cruciale Traverso attribuisce (seguendo in ciò le tesi della stessa Hannah Arendt)
all’esperienza della conquista e della dominazione coloniale, in particolare di quella conquista
dell’Africa che ha accompagnato lo sviluppo del capitalismo industriale: in essa trovano per la
prima volta una sintesi storica il razzismo, che declassa certi gruppi umani in nome delle obiettive
verità della scienza, l’amministrazione e la burocrazia moderne e il massacro razionalmente
178
I lavori più noti in questo campo sono quelli di S. Milgram (1974) e P. Zimbardo; quest’ultimo autore è intervenuto
fra l’altro sul recente caso delle torture americane nel carcere iracheno di Abu Ghraib, sostenendo che la forte
propensione alla violenza e alla crudeltà è determinata dal contesto stesso della prigione, in cui un gruppo di individui
esercita un potere assoluto e socialmente legittimato su un altro gruppo (Zimbardo 2004; v. anche
http://www.prisonexp.org/links.htm). Per un’ampia discussione delle posizioni della psicologia sociale sul problema
della violenza v. E. Staub (1989) e la recente rassegna di M. Ravenna (2004).
pianificato (p. 66). Infine, decisivi appaiono gli sviluppi della pratica militare che troveranno il loro
culmine nella Grande Guerra, con la formazione di eserciti di massa composti da soldati-macchina
sul modello del lavoro fordista, nei quali il valore della vita umana perde radicalmente di significato
e l’epica della gloriosa morte in battaglia viene sostituita dalla banalità della “morte anonima di
massa” (p. 102).
Nel costruire una simile genealogia della violenza nazista, Traverso intende attribuire quest’ultima
alla storia dell’Occidente contemporaneo, senza per questo vedere nel nazismo il “naturale
compimento” di questa storia o la sua “essenza profonda”. Si tratta piuttosto di condizioni sul cui
sfondo la violenza genocida diviene possibile:
La ghigliottina, il mattatoio, la fabbrica fordista, l’amministrazione razionale così come
il razzismo, l’eugenismo, i massacri coloniali e quelli della Grande Guerra hanno
modellato l’universo sociale e il paesaggio mentale entro i quali è stata concepita e
messa in atto la «Soluzione finale»; ne hanno creato le premesse tecniche, ideologiche e
culturali; hanno edificato il contesto antropologico nel quale Auschwitz è stato possibile
(p. 180).
Questo “contesto antropologico” ha forse a che fare con la tesi del continuum della violenza di
Scheper-Hughes, con l’idea di uno stretto rapporto tra crimini di guerra e crimini di pace. E’ un
simile contesto che rende sensato stabilire una relazione tra la Shoah e, poniamo, la catena di
montaggio oppure la scortesia dell’infermiera di una casa di riposo che tratta i suoi assistiti come
non-persone. La dimensione genealogica conferisce maggiore profondità a questa tesi,
disancorandola al tempo stesso da un banale e astorico radicalismo che vede nella violenza
genocida una diretta e quasi automatica manifestazione delle istituzioni dello stato moderno, o del
“potere” in generale (una tentazione da cui la stessa Scheper-Hughes non appare sempre esente). Il
contesto antropologico fabbricato dalla storia degli ultimi due secoli crea le condizioni per una
peculiare qualità della violenza di massa, ma pone al contempo le basi per pratiche sociali
completamente diverse, guidate ad esempio dalla pace, dal rispetto e dal riconoscimento dell’altro.
Le stesse istituzioni di cui si denuncia la complicità nel trasmettere i sentimenti sociali che
preparano gli stermini, tra cui Scheper-Hughes include, oltre all’esercito, anche la famiglia, la
scuola, le chiese e gli ospedali (Scheper-Hughes, Bourgois 2004, p. 22), contengono anche le
potenzialità della pace e della giustizia sociale. In quale direzione esse vengano spinte è un
problema che riguarda la nostra responsabilità e le nostre scelte etico-politiche. In questo senso, è
difficile sottrarsi al richiamo che Scheper-Hughes ci rivolge nel saggio di questo volume: quello a
saper riconoscere una potenzialità genocida anche in noi stessi, e ad esercitare una costante
“ipervigilanza difensiva” anche verso le sue forme meno visibili e meno direttamente riconoscibili.
5. La sintassi della violenza.
Vorrei tornare adesso al tema portante del rapporto tra violenza e costruzioni identitarie,
considerando la discussione profonda e raffinata che ne propone Arjun Appadurai, nella sua opera
principale Modernity at Large e in alcuni saggi degli ultimi anni 179 . Anche per l’antropologo
indiano il punto di partenza è il rifiuto delle tesi primordialiste. Non è il permanere di un’antica
conflittualità radicata nelle appartenenze locali che fonda i conflitti etnici: al contrario, questi ultimi
vanno compresi nel quadro delle trasformazioni indotte dalla globalizzazione e soprattutto in
relazione al fenomeno del culturalismo – definito come “deliberata mobilitazione delle differenze
culturali al servizio di più vaste politiche nazionali o transnazionali” (Appadurai 1996, p. 32).
Appadurai rivolge una serrata critica a quella teoria politica che vede le appartenenze primordiali
come residui premoderni, fattori d’inerzia che ostacolano il pieno dispiegamento della razionalità
politica (lo stato) ed economica (il mercato) della modernità. Al contrario, sottolinea come “la
creazione di sentimenti primordiali, lungi dall’essere un ostacolo per lo stato modernizzatore, si
situa vicino al centro del progetto del moderno stato nazionale”, come strumento di controllo e di
consenso (ibid., p. 188); e come l’esplosione di tali sentimenti rappresenti una delle principali
reazioni dello stato agli elementi di crisi che oggi lo percorrono a fronte dei processi di
globalizzazione.
Tuttavia, Appadurai si rende conto che non basta considerare questi fenomeni come ideologie
imposte dall’alto, e si interroga proprio su come essi possano plasmare a fondo la costituzione
antropologica – culturale, emozionale e corporea - di determinati gruppi sociali. Se è in definitiva
un’ampia motivazione politica a muovere le pratiche sociali, essa va però compresa nella sua
capacità di inscriversi nell’esperienza fisica e psichica dei soggetti coinvolti, “fino nell’intimità
degli attori sociali incarnati” (ibid., p. 191). Non si tratta di ricondurre la politica ai sentimenti
primordiali, ma di seguire semmai il percorso inverso, leggendo questi ultimi sullo sfondo di
foucaultiane cornici di potere e disciplina. Dunque, “la sfida è riuscire a catturare la frenesia della
violenza etnica senza ridurla al nucleo universale e banale dei sentimenti profondi e primordiali.
Dobbiamo preservare la sensazione della furia psichica e incarnata così come l’intuizione che i
sentimenti coinvolti nella violenza etnica […] acquistano senso solo entro vasti conglomerati di
ideologia, immaginazione e disciplina” (ibid., p. 192). Se in questa dichiarazione programmatica
l’accento di Appadurai cade sull’opposizione al primordialismo, oggi sembra di dover piuttosto
sottolineare l’altra esigenza, quella di una comprensione che preservi il senso della “furia psichica e
incarnata” che nella violenza si esprime; esigenza, come detto, tanto trascurata quanto cruciale per
una prospettiva che possa ancora dirsi antropologica.
L’originalità della soluzione di Appadurai sta nel tentativo di legare la “furia” della violenza etnica
non a certezze identitarie ataviche, bensì alle incertezze che il mondo contemporaneo porta
costantemente ad esperire a proposito delle identità nostre e altrui. Mentre la gente in tutto il mondo
si sente sempre più definita in termini di macro-identità inventate dagli stati nazionali, i criteri per
determinare l’appartenenza o meno ad esse di specifici individui o gruppi sono sempre meno chiari.
Soprattutto, sempre meno chiaro è se i nostri vicini, la gente che ci vive accanto, fa parte di “noi” o
degli “altri”. Le mappe corporee e caratteriali così tipiche del repertorio dei nazionalismi,
179
Di particolare rilievo il saggio “Dead certainty” (Appadurai 1998), che non è inserito in questa antologia solo perché
una sua traduzione italiana è attualmente in corso, sempre presso l’editore Meltemi, nel quadro di un volume
monografico dello stesso Appadurai.
classificando ogni individuo sotto la sua grande categoria etnica, non sembrano più consentire un
sicuro riconoscimento. Questa incertezza diviene cruciale in situazioni di aperto conflitto, in cui il
“nemico” può nascondersi fra noi; qui l’esperienza quotidiana è dominata, sostiene Appadurai, dalla
sindrome dell’infiltrato, dell’agente segreto, della falsa identità – dalla possibilità che la realtà non
sia mai ciò che sembra. In altre parole, si costituiscono universi morali dominati dall’orrore per
l’indeterminazione e per la confusione categoriale – da quella stessa ansia cognitiva per la “materia
fuori posto” che Mary Douglas ha posto alla base dei sistemi simbolici e del concetto di tabu.
Qui sta per Appadurai la chiave di comprensione di quelle peculiari forme di violenza che
caratterizzano i conflitti “etnici” contemporanei: una violenza che si compie fra persone che hanno
spesso in precedenza vissuto fianco a fianco, negli stessi spazi sociali e in rapporti di vicinato e
persino amicizia, e che implica d’altra parte forme di brutalità fisica straordinariamente crudeli, con
una qualità che potremmo quasi definire rituale. Queste forme di violenza sono un modo per
estrarre “certezza” da una situazione di angosciosa incertezza; non per eliminare le anomalie, come
nei sistemi simbolici analizzati da Douglas, ma per dare forzatamente ordine a una realtà in cui
l’anomalia è divenuta la regola. Appadurai ha qui in mente in modo particolare i materiali discussi
da Liisa Malkki nel suo importante lavoro su gruppi di hutu rifugiati in Tanzania dal Burundi a
seguito dei massacri etnici del 1972 (Malkki 1995a). Lavorando sulle narrazioni dei rifugiati,
Malkki mostra come esse costituiscano nel loro complesso un corpus condiviso di rappresentazioni
del passato di natura, come la studiosa si esprime, “mitico-storica”: vale a dire, un insieme di
racconti volti a produrre un ordine morale e classificatorio, che costruiscono un passato esemplare e
fondano al tempo stesso il senso dell’esistenza nel contesto presente (quello del campo profughi, in
questo caso, particolarmente interessante perché in esso si costruisce un’immaginazione di
appartenenza nazionale senza alcuna delle condizioni usuali che ad essa si accompagnano, come
territorialità, istituzioni statuali etc.; v. anche Malkki 1995b, 1996). Questa mito-storia è focalizzata
sulla continua “esplorazione, reiterazione e sottolineatura dei confini tra sé e gli altri, hutu e tutsi,
bene e male”. Le due categorie principali, hutu e tutsi, sono identificate per mezzo di “astratte
qualità morali”: i tutsi incorporano il male, la pigrizia, la bellezza, il pericolo e la “malignità”, gli
hutu esattamente l’opposto (ibid., p.54). A loro volta, queste qualità morali si connettono a “mappe
corporee” che dettagliano le differenze fisiche tra hutu e tutsi – un punto sul quale il discorso dei
rifugiati insiste in continuazione, esprimendo la necessità di evitare ogni ambiguità nella distinzione
categoriale (p. 78).
E’ la stessa Malkki a suggerire il nesso tra queste mappe di riconoscimento basate su dettagli
fisiologici e qualità caratteriali, da un lato, e dall’altro le “mappe necrografiche” attraverso le quali
gli hutu descrivono i dettagli dei massacri e della violenza, le tecniche di uccisione, di mutilazione,
di manipolazione del corpo del nemico. Queste sono percepite come dotate di un chiaro valore
simbolico: forme di umiliazione e deumanizzazione dei nemici etnici che insistono proprio sulle
peculiarità loro assegnate dalle rappresentazioni cosmologiche condivise. Una pratica atroce come
quella di impalare donne e uomini con lunghi fusti di bambù, dalla vagina o dall’ano fino alla
bocca, è percepita ad esempio come una violazione del corpo dei “bassi” hutu da parte di un
sostituto simbolico degli “alti” tutsi (p. 92); e si potrebbe inversamente osservare il significato
simbolico dell’uso del machete nel genocidio ruandese dei tutsi nel 1994, compiuto appunto con lo
strumento principale di quell’agricoltura che i tutsi non saprebbero praticare perché troppo pigri. Gli
stessi assassini hutu che hanno raccontato la loro esperienza a Jean Hatzfeld hanno osservato
l’analogia tra il “tagliare” nel lavoro dei campi e il “tagliare” a pezzi i corpi dei tutsi nelle paludi
dove questi si rifugiavano: “il gesto era simile”, anche se molto più faticoso e la sensazione “meno
scontata” (Hatzfeld 2003, p. 69). Gli stessi testimoni riportano la frequente pratica di tagliare le
gambe delle vittime, “accorciandole” secondo una sorta di legge del contrappasso: “se un uccisore
crudele acchiappava una vittima un po’ alta tra i canneti, poteva anche colpirla alle gambe,
all’altezza delle caviglie per esempio, o anche alle braccia, e lasciarla lì, accorciata, senza darle il
colpo di grazia” (ibid., p. 153).
Questa percezione dei significati simbolici di specifiche forme di atrocità, sostiene Malkki, non è
soltanto presente nei resoconti mitico-storici, ma nella stessa esecuzione della violenza. In altre
parole, le pratiche concrete di crudeltà e violenza si strutturano già secondo una consapevolezza
mitico-storica, appaiono “stilizzate e mitologicamente significative fin dalla loro messa in atto”
(Malkki 1995a, p. 94). Appadurai, per tornare a lui, riprende con forza queste osservazioni
collegandole al tema dell’incertezza identitaria. In una situazione in cui i corpi, della vittima come
dell’assassino, sono potenzialmente ingannevoli e rischiano di tradire le stesse cosmologie che
dovrebbero invece fondare, i riti atroci dei massacri si presentano come “forme brutali di
disvelamento del corpo – forme di vivisezione, tecniche per esplorare, marcare, classificare e
immagazzinare i corpi di quelli che possono essere i nemici ‘etnici’ ” (Appadurai 1998, p.291). In
definitiva, Appadurai si avvicina ancor più di Hayden all’idea della violenza come tecnica per
“immaginare una comunità”: essa consentirebbe infatti di rendere concretamente e sensorialmente
presenti quelle imprecise astrazioni che sono le etichette etniche di vasta scala. “Le più orribili
forme di violenza etnocida sono meccanismi per produrre persone a partire da quelle che
resterebbero altrimenti etichette diffuse e di vasta scala, efficaci ma non localizzate”. In ciò, la
violenza genocida manifesta una qualità autenticamente rituale, nel senso tecnico che a questo
termine è attribuito dalla tradizione antropologica che fa capo a Van Gennep. I riti producono
persone attraverso performance che agiscono sui corpi – anche se in questo caso ci troviamo di
fronte a una orribile inversione del ciclo della vita di Van Gennep, che si trasforma in un vero e
proprio “ciclo della morte” (p. 296).
Il grande merito della teoria di Appadurai consiste dunque nel radicare la violenza in modelli
culturali e categoriali profondi, che plasmano ai livelli più basilari la percezione dei corpi e le
pratiche della quotidianità – contro la tesi che ne riconduce le cause al puro indottrinamento
ideologico. In questo modo, Appadurai apre la strada a un’analisi della sintassi simbolica di
specifiche pratiche di sopraffazione e crudeltà, che non sono viste come pura esplosione di furore
“bestiale” e pre-culturale ma come governate da codici che solo un ampio approccio antropologico
è in grado di cogliere. Non poche obiezioni si potrebbero tuttavia muovere al punto di vista espresso
dallo studioso indiano. Provo ad articolarne due che mi sembrano importanti. In primo luogo, l’idea
che l’orrore per la confusione categoriale sia la forza che muove e struttura simbolicamente la
violenza (una forza intesa non come fattore storico generale ma come motivazione incarnata negli
attori sociali) sembra contrastare con un fatto che emerge dalla letteratura disponibile sugli
esecutori stessi della violenza: questi ultimi sembrano a loro volta sperimentarla come pratica di
dissolvimento dell’ordine culturale, delle categorie del mondo ordinario. Dai tedeschi del
battaglione 101 di C. Browning, ai già citati hutu intervistati da J. Hatzfeld, agli archetipici
massacratori rappresentati da W.Sofski (1996, pp. 156-60), l’inaudita prossimità con la morte – con
i suoi più spaventosi dettagli fisici – non può non trascinare gli assassini fuori da qualunque ordine,
in uno stato che a posteriori non riescono a ricordare come pienamente reale. Gli uccisori vivono
una situazione di liminarità, caratterizzata da elementi pressoché universali quali l’effervescenza
emotiva, la forte coesione di gruppo o senso di communitas, il consumo di alcolici e la ricerca di
stati alterati di coscienza 180 . Più che nella riparazione di una normalità quotidiana minacciata dalle
anomalie, essi sono impegnati nella distruzione radicale di un ordine sulla spinta del sogno di
fondarne uno nuovo.
Un secondo problema sollevato dalla teoria di Appadurai riguarda l’universalità della sintassi rituale
della violenza. Se, come egli afferma, “colpire e mutilare i corpi etnicizzati è uno sforzo disperato
di restituire validità ai contrassegni somatici dell’alterità, a fronte delle incertezze sollevate dalle
definizioni dei censimenti, dai mutamenti demografici e linguistici che rendono le appartenenze
etniche sempre meno corporee o somatiche, e più sociali ed elettive” (1998, p. 297) – dovremmo
allora poter considerare il simbolismo di questa violenza come peculiare e distintivo dei conflitti più
recenti, collocati nel contesto della globalizzazione e della crisi dello stato-nazione classico, di cui
rappresenterebbero una sorta di colpo di coda. Sembra invece di trovarci di fronte a modalità
simboliche meno specifiche e più universali. La bestializzazione del corpo, le inversioni categoriali
cui le vittime sono sottoposte, la violazione delle sfere più protette di intimità personale e familiare
fanno parte di un repertorio ben noto, ampiamente dispiegato nel corso di diverse epoche e contesti
storico-culturali. Si ha l’impressione che la crudeltà esercitata sul corpo dell’altro possa assumere
solo una serie limitata di forme, ricalcando in negativo il limitato numero di universali
antropologici: le caratteristiche strutturali dello schema corporeo, il divieto dell’incesto,
l’opposizione natura-cultura si mostrano nella fenomenologia della violenza come in un grottesco
controluce.
180
In quest’ottica sono da leggersi una serie di comportamenti particolarmente sconcertanti degli esecutori, come la
derisione e la spettacolare umiliazione delle vittime, e gli scherzi e battute scambiate in proposito con i compagni, a fine
giornata. Questo è uno dei punti di dissidio nella celebre discussione fra C. Browning e J. Goldhagen sugli uomini
comuni del Battaglione 101: le loro testimonianze parlano spesso di momenti di socialità festiva che seguivano i
massacri, nel corso dei quali alcuni si vantavano delle uccisioni compiute o le prendevano a oggetto di macabri scherzi.
Browning ritiene impossibile che si tratti di veri festeggiamenti, e li interpreta come segno dell'ottundimento della
sensibilità, dell'abbrutimento di chi era contrario al massacro o almeno ne era turbato. Goldhagen, al contrario, afferma
che l'allegria è allegria, e che essa si spiega solo col fatto che i tedeschi non consideravano delittuosi quegli eccidi.
“Quella non era gente abbrutita e insensibile: scherzavano su azioni che ovviamente approvavano, e alle quali avevano
preso parte con evidente piacere” (1996, p. 562 nota). L’ipotesi di comportamenti legati a una situazione liminale
sembra più plausibile delle interpretazioni dei due storici, i quali sembrano considerare il problema dell’espressione
delle emozioni in una dimensione puramente psicologico-individuale.
Al di là di questi dubbi, il tentativo di autori come Malkki e Appadurai di decifrare la sintassi della
violenza ponendola in rapporto con cosmologie locali e con tensioni sociologiche inscritte nelle
soggettività e nei corpi è di grande forza, e apre un percorso di analisi della violenza peculiarmente
antropologico. Su questa linea si colloca una crescente letteratura, dalla quale vorrei estrarre due
ulteriori esempi. Ancora in relazione al genocidio ruandese del 1994, l’antropologo medico
Christopher Taylor (2002) ha sostenuto l’esistenza di un potente nesso tra le concezioni tradizionali
di corpo, salute e malattia e le più cruente modalità della violenza genocida. In sintesi, nella
medicina popolare la salute è vista come un libero trascorrere di fluidi vitali attraverso il corpo,
mentre la malattia è dovuta a “blocchi” che impediscono ai fluidi di scorrere. Secondo Taylor,
questa idea fondamentale ha plasmato in profondità le concrete manifestazioni di violenza,
funzionando come una sorta di “schema generativo” – ancora una volta, attraverso una inversione di
senso che trasforma una cosmologia vitale in un macabro ordine della morte. Questo modello
culturale sembra a Taylor connesso, ed esempio, all’ampio ricorso delle milizie hutu ai blocchi
stradali: istituiti al di là di ogni reale funzione strategica o razionalità politica, questi ultimi
divenivano luoghi privilegiati di uccisione e di esercizio del potere (p. 163). L’idea di “bloccare” i
movimenti si manifesta anche nella grande diffusione di ferite inferte alle vittime alle gambe, ai
piedi e ai tendini di Achille – anche in questo caso, pratica non spiegabile in una logica utilitaristica
(impedire alle vittime la fuga), giacché venivano colpite in questo modo anche persone inferme,
anziani e bambini molto piccoli. Si manifesta qui un potere associato, in termini simbolici, alla
“capacità di ostruire” (p. 164). Infine, strettamente legata all’immaginario dei flussi e dei blocchi è
la pratica dell’impalamento.Visti come “blocking beings”, al pari di minacciose figure stregonesche
della tradizione, i tutsi ostruiscono l’unità cosmologica della nazione hutu, e meritano l’ostruzione
del loro corpo con un palo o una lancia. Il che ricorda da vicino le metafore predilette da Hitler sugli
ebrei come batteri o agenti patogeni che infettano il corpo della società tedesca: cambia solo il
modello medico-culturale sottostante. Per quanto le interpretazioni di Taylor appaiano a tratti
forzate, è convincente la sua proposta di leggere i macabri dettagli della violenza come messaggi
inscritti sui corpi delle vittime. “I torturatori non si limitavano a uccidere le loro vittime,
trasformandone invece i corpi in potenti segni in risonanza con un habitus ruandese” (p. 168) –
come accade con l’inquietante macchina di tortura della Colonia penale di Kafka, che inscrive a
sangue la sentenza sul corpo del condannato.
Un approccio analogo è proposto da Robert L. Hinton (1998a) a proposito dei massacri dei
Khmer Rossi in Cambogia. Qui il modello culturale tradizionale individuato come rilevante è quello
della “vendetta sproporzionata”, una sorta di sistema di valori onore-vergogna secondo cui chi
subisce un torto sviluppa un inestinguibile rancore e perde la faccia finché non riesce a procurare al
suo nemico un danno assai maggiore. L’idea della vendetta sproporzionata è una specie di sfondo
etico della società cambogiana tradizionale, presente nei miti e nelle narrazioni esemplari che
riguardano la socialità quotidiana: in esse si suggerisce costantemente che l’unica possibile
riparazione a un’offesa all’onore sia la completa distruzione del nemico e persino della sua
discendenza familiare – al fine di prevenire ulteriori contro-vendette che si propagherebbero
all’infinito. Ebbene, Hinton suggerisce che tale modello abbia plasmato le motivazioni e i
comportamenti dei Khmer Rossi, i quali avrebbero implicitamente equiparato l’oppressione di
classe (la povertà dei contadini, la mancanza di rispetto nei loro confronti) a un’onta morale,
indirizzando il risentimento verso i ceti urbani. La loro educazione politica era interamente
improntata allo sviluppo di rabbia e odio verso gli oppressori, e la “lotta di classe” interpretata nei
termini delle tradizionali virtù guerriere. La vendetta dei poveri contro i ricchi, dei ceti rurali contro
quelli urbani, era il tema ricorrente della propaganda comunista, e mediava sul piano motivazionale
l’idea stessa di rivoluzione e di fondazione di una società nuova.
Anche in questo caso, è chiaramente la propaganda ad accendere l’odio e a spingere a una
violenza estrema legittimata come “giustizia” storica; ma l’ideologia non potrebbe far presa se non
innestandosi su modelli tradizionali che la rendono assimilabile sul piano etico e su quello delle
pratiche sociali. La tesi è plausibile, e suggerisce interessanti orizzonti di ricerca anche in relazione
ad altri contesti. Tuttavia, Hinton non sembra considerare un punto essenziale: nella cultura
tradizionale, il modello mitico della vendetta spropositata fonda in realtà una pratica quotidiana in
cui essa non si attua. I valori di onore, vergogna e vendetta fanno parte di un sistema di regole
relazionali che rendono possibile una convivenza civile e non violenta (per quanto possano
implicare un alto grado di violenza simbolica, soprattutto sessuale e generazionale). Il problema, per
la Cambogia come per altri casi di eccidi di massa, è capire come sia possibile la transizione da tale
civile convivenza alla cultura della morte e del terrore; come, dunque, i modelli culturali che
usualmente mediano e gestiscono il conflitto possano trasformarsi nel loro opposto, sostenendo
pratiche che fanno esplodere le strutture sociali 181 .
6. L’antropologia della violenza tra epistemologia ed etica.
Sono giunto a quel rituale momento in cui si dice che i limiti di un’introduzione non consentono
di approfondire altri e importanti aspetti dell’argomento in questione. Ciò è particolarmente vero in
questo caso. Vorrei perlomeno segnalare tre di questi ulteriori temi sollevati dai saggi qui raccolti,
concludendo con alcune osservazioni su un punto già toccato in precedenza, vale a dire il
complicato rapporto fra la dimensione conoscitiva e quella etica di un’antropologia della violenza.
a) Violenza e genere. Il primo punto su cui occorre insistere, sollevato esplicitamente nel saggio di
Veena Das ma centrale nell’intero dibattito contemporaneo, è la dimensione di genere della
violenza. Abbiamo visto, nel precedente paragrafo, che la violenza agisce seguendo a ritroso il
lavoro della cultura. Non si limita a distruggere materialmente i corpi, ma procede disfacendo
181
La tesi di Hinton sembra fra l’altro poco coerente con quella sostenuta dallo stesso autore in un precedente articolo
(1996), in cui la violenza dei massacri cambogiani è interpretata alla luce della nozione di “dissonanza psico-sociale”:
gli eccessi e le forme altrimenti inspiegabili di accanimento persecutorio sarebbero la risposta al conflitto fra gli
imperativi aggressivi dei Khmer rossi e i valori di solidarietà (l’ “etica della gentilezza”) largamente diffusi nella
società cambogiana tradizionale. Un analogo approccio è proposto da Hinton (1998) anche in relazione al problema
della “crudeltà inutile” nello sterminio nazista degli ebrei: i valori del nazismo non potevano non confliggere con più
universali imperativi morali, generando così una dissonanza che si manifesta in comportamenti abnormi.
sistematicamente le costruzioni culturali del corpo, dell’identità personale, della socialità primaria;
individua le più radicate fedeltà culturali come punti critici da colpire nella costruzione del terrore.
E’ dunque chiaro che il terreno dell’identità sessuale e di genere, e l’ambito ad essa connesso delle
relazioni familiari e di parentela, è il suo terreno elettivo – specialmente nei casi di attacco
sistematico e consapevole a popolazioni civili basato sulla diffusione di una cultura del terrore, per
usare ancora l’efficace formulazione di Taussig. In questi casi, dal Ruanda ai Balcani, dalle guerre
sporche latino-americane agli odierni conflitti “civili” africani (e diversamente, almeno per certi
fondamentali aspetti, dalla Shoah) la violenza si attua come spettacolo del terrore, e mira a colpire
le colonne portanti di ciò che è culturalmente significativo, potendo penetrare, diversamente da ogni
altra forma di comunicazione simbolica, fin dentro il corpo, nei recessi più profondi delle sfere di
intimità personale. In queste strategie gioca ovviamente un ruolo-chiave lo stupro. Se esistono tratti
universali nel congegno anti-culturale della violenza, lo stupro sicuramente è uno di essi. Come è
noto, si tratta di una forma di violenza che paradossalmente produce senso di colpa nella vittima.
Non solo colpisce ai livelli più profondi la dignità personale; messo in scena pubblicamente, fa
esplodere il livello più basilare delle relazioni sociali, sconvolge i sentimenti di fiducia, protezione,
rispetto reciproco su cui esse si fondano. Come nel caso degli “stupri etnici” nei Balcani, la
violazione del corpo femminile diviene addirittura il principale strumento, simbolico e biologico al
tempo stesso, di affermazione di un’identità razziale – quasi una grottesca caricatura di quelle tesi
sociobiologiche che pensano di poter spiegare ogni comportamento umano in relazione all’obiettivo
della massimizzazione della capacità riproduttiva.
Lo stupro è anche la forma di violenza che in modo più netto collega i due ambiti dei crimini di
guerra e dei crimini di pace. Per quanto i suoi significati culturali possano esser diversi nei due
contesti, le indubbie continuità ci spingono a pensare alla violenza sulle donne come a una sorta di
“valore aggiunto” nel quadro delle violenza di massa. Del resto, a parte la diretta aggressione
sessuale, sono molti i modi in cui le donne divengono bersaglio particolare nelle “nuove guerre” e
nelle strategie del terrore. Queste ultime rendono spesso semplicemente impraticabili i ruoli sociali
e quelle che potremmo chiamare le posizioni morali delle donne, ad esempio impedendo di seguire
l’imperativo protettivo della funzione materna. I racconti di donne costrette ad assistere, impotenti,
alle violenze subite dai figli rappresentano quasi sempre il culmine della drammaticità nei resoconti
dei massacri. Per converso, questo fa sì che le donne giochino spesso un ruolo fondamentale nelle
forme di resistenza. Il caso paradigmatico è probabilmente quello delle madri argentine di Plaza de
Mayo, un movimento il cui grande impatto si è basato proprio sulla rivendicazione delle
caratteristiche attribuite alla donna dall’ideologia ultraconservatrice della giunta militare: il
sentimento (apparentemente pre-politico) materno, il diritto-dovere di proteggere e piangere i figli
(Robben 2000). Come mostra Veena Das, è comunque “lavoro delle donne” la ricucitura di un
universo di valori quotidiani che si trova lacerato da eventi traumatici violenti – nel caso della sua
ricerca, la Spartizione Indiana del 1947.
b) Memoria traumatica. Nella gran parte dei casi, il lavoro antropologico sulla violenza si fonda
sulle memorie di testimoni degli eventi (le vittime sopravvissute, i familiari degli uccisi, più
raramente gli esecutori). Gli antropologi si trovano cioè di fronte a racconti di persone che devono
fare i conti con un lacerante e spesso inestinguibile trauma esistenziale, che le ha colpite nel proprio
corpo, negli affetti più cari, nei più basilari principi di socialità. I contesti di ricerca sono quelli di
individui e comunità impegnate a elaborare un lutto per il quale la cultura tradizionale non offre
risposte adeguate; impegnate a ricostruire un senso del passato a partire dai brandelli irrelati di una
memoria insopportabile; impegnate a ristabilire un minimo di equilibrio psichico e sociale, una
possibilità di esistenza in ambienti che spesso non sono più i loro (ad esempio campi profughi,
centri di accoglienza per rifugiati, nuovi insediamenti più o meno provvisori). Il problema
dell’antropologia della violenza finisce così per coincidere in larga parte con il problema della
memoria traumatica – in un’accezione del termine che implica non solo dinamiche psichiche
individuali ma anche processi socio-culturali. E’ un terreno (come, più in generale, quello dello
studio della memoria culturale) su cui l’antropologia ha bisogno di recuperare un rapporto forte con
la psicologia e la psicoanalisi (Antze, Lambek 1996, Robben, Suárez-Orozco 2000). L’agenda di
ricerca che si apre è di grande ampiezza. Si pone prima di tutto il problema di un’analisi retorica dei
racconti di testimonianza, che vanno considerati da un lato nella loro natura performativa, dall’altro
nel loro intreccio con repertori narrativi e codici culturali presenti nella tradizione. Queste
narrazioni culturalmente plasmate giocano un ruolo di primo piano nella trasmissione
intergenerazionale non solo della memoria ma dello stesso trauma – un punto, quest’ultimo,
ampiamente studiato in relazione alle generazioni di “figli della Shoah”. La psicoanalista Yolanda
Gampel (2000, p. 59) ha coniato il termine radioattività per esprimere il modo in cui le esperienze
traumatiche si insediano nella costituzione psichica degli individui, continuando ad agire molto
tempo dopo che gli eventi sono conclusi, e penetrando, appunto, anche nelle generazioni successive.
Peraltro, qui non è il solo livello delle narrazioni culturalmente accreditate ad agire: anzi, la
memoria della violenza radicale sembra agire in un’area psichica in cui le parole non esistono (il
“reale” lacaniano), configurandosi come un ineffabile o indicibile che si rivela attraverso immagini,
emozioni, espressioni corporee.
Lo studio della memoria traumatica si configura dunque da un lato come tentativo di comunicare
con le soggettività ferite - un compito particolarmente delicato sul piano etico, dal momento che il
classico obiettivo etnografico dell’ “estrarre informazioni” non può qui andar disgiunto da un
obiettivo terapeutico (si veda in proposito il lavoro degli etnopsichiatri con i rifugiati e le vittime di
tortura; Beneduce 1999). Dall’altro lato, lo studio della memoria ci porta invece verso un’etnografia
delle forme pubbliche di elaborazione del lutto, delle rappresentazioni simboliche e delle pratiche
rituali che sono mobilitate a tal fine. Le commemorazioni e le celebrazioni degli eventi più
drammatici, nonché la costituzione di monumenti, musei o luoghi consacrati alla memoria, sono tra
le principali pratiche attraverso cui una comunità cerca di far “trascendere nel valore” un cattivo
passato, collocandolo in una narrazione storica (o in un modello mitico) in grado di conferire senso
al presente 182 . L’elaborazione del lutto si intreccia spesso, talvolta anche molto tempo dopo la fase
più intensa delle violenze, con il perseguimento della giustizia: vale a dire con attività istituzionali,
sostenute sul piano nazionale o internazionale, volte ad accertare giuridicamente le responsabilità e
a punire i colpevoli. Si può dire anzi che lo svolgimento di processi e il riconoscimento istituzionale
(non solo storico e morale) delle responsabilità è una delle condizioni essenziali per il superamento
del trauma. Ma la giustizia non può che esser praticata in forme di compromesso. La società
“normalizzata” che esce dalla violenza è infatti sempre profondamente divisa e conflittuale, per
effetto delle stesse dinamiche della violenza, che si dimostrano invariabilmente capaci di prolungare
il loro effetto dirompente “molto a lungo dopo che i massacri sono finiti e firmati i trattati di pace”
(Suárez-Orozco, Robben 2000, p. 5; Suárez-Orozco 1990). Com’è stato osservato per l’America
Latina, si verificano profonde spaccature sociali fra “quanti non vogliono ricordare e coloro che non
possono dimenticare”, nutrite da “risentimenti residui per i differenti prezzi pagati nei confronti del
terrore” (Viñar, Ulriksen Viñar 2001, p, 213). La memoria stessa è destinata così a restare divisa,
terreno di manifestazione di conflitti rispetto ai quali la giustizia deve cercare mediazioni. Molti
casi recenti, dalla commissione d’inchiesta argentina sui desaparecidos (CONADEP; SuárezOrozco 1992, p. 236 sgg.) alla Commissione per la verità e la riconciliazione del Sudafrica (Wilson
2000, 2001 Ross 2003a, 2003b), mostrano il complesso rapporto che si instaura tra le istanze
strettamente giudiziarie, quelle di obiettiva ricostruzione storica e quelle di “riconciliazione”
nazionale. Il che significa complesso rapporto tra giustizia, verità e politica (Wilson 2003, Flores
2005, p. 115 sgg.). “Scrivere la storia” e “fare giustizia”, per quanto attività governate da propri
interni criteri di coerenza e oggettività, possono allora rivelarsi come momenti di un complesso
rituale di transizione tra regimi politici, che sottodetermina - come ha sostenuto il giurista Ruti
Teitel (2001, pp. 272-3) - la rivelazione della conoscenza della verità.
c) Violenza e diritti umani. Il saggio di Talal Asad ci introduce in uno scenario di riflessione ancora
diverso, concernente il carattere storicamente e culturalmente determinato di ciò che noi intendiamo
per violenza - in particolare di ciò che percepiamo come “trattamento crudele, inumano e
degradante”, in riferimento alla formulazione con la quale la Dichiarazione dei diritti umani del
1948 condanna la tortura e analoghe forme di crudeltà. Asad prende una posizione nettamente
critica nei confronti del linguaggio universalizzante dei diritti umani. Non solo quest’ultimo è cieco
di fronte alla varietà delle pratiche culturali; di più, le sue pretese di solidarietà ecumenica celano
l’affermazione di un modello di individualità o di agente razionale che è fortemente e acriticamente
etnocentrico, che affonda anzi le radici nel dominio coloniale dell’Occidente sul resto del mondo. Il
saggio procede mostrando le ambiguità e le palesi contraddizioni della nozione di “trattamento
crudele, inumano e degradante”: una nozione illuminista che, paradossalmente, è stata spesso
imposta con la forza e con l’uso di sanzioni violente alle culture colonizzate. Particolarmente
182
Le celebrazioni rituali e la “politica dei monumenti” sono al centro negli ultimi anni di una vasta produzione
storiografica ed etnografica. Si vedano fra l’altro l’importante lavoro di J. Winter (1995) sulle commemorazioni della
Grande Guerra, e i contributi raccolti in Gillis, a cura, 1994 e Lorey, Beezlet, a cura, 2002. Per una discussione del tema
nel quadro di un più ampio approccio all’antropologia della memoria rimando a Dei 2004b.
interessante è per Asad il contrasto tra la condanna della crudeltà e la sua legittimazione in alcuni
ambiti della modernità: da un lato quello della guerra, che si combatte con armi sempre più
sofisticate ed efficaci nel distruggere i corpi e produrre sofferenza, dall’altro l’ambito delle pratiche
sadomasochiste, dove infliggere e subire sofferenza è accettato come libera scelta di adulti
consenzienti. Ciò mostrerebbe, a suo parere, in che misura la proibizione di crudeltà e tortura sia
sottodeterminata da una certa concezione (politica ed epistemica al tempo stesso) di individuo e di
“civiltà”, rispetto alla quale si definisce lo stesso significato della percezione del dolore, e se ne
stabiliscono le “quantità” ammissibili.
Il saggio di Asad si colloca nel quadro dell’attuale dibattito antropologico sui diritti umani, con
l’assunzione di una posizione decisamente relativista da parte dell’autore – il quale si preoccupa
peraltro di precisare la natura intellettuale e non morale (o pratica) del suo scetticismo verso il
linguaggio universalista dei diritti. Ma è davvero possibile mantenere questa distinzione? Se li
accostiamo a resoconti dettagliati di torture, da quelli del Putumayo cui ci introduce Taussig fino ai
recenti casi di Abu-Ghraib, non rischiano di apparire futili le sottili distinzioni di Asad? Non c’è
forse nella pratica della tortura una immediata (universale, forse) riconoscibilità? Come potremmo
sbagliarci riguardo il significato di quegli atti di sopraffazione violenta che usano l’altrui corpo
come strumento per la costruzione del terrore? In effetti l’argomentazione di Asad si focalizza sulla
nozione liberale di “diritti umani” e sul significato del provare e infliggere dolore nella società
contemporanea; e certo efficace è la sua critica alla formulazione “trattamento crudele, inumano e
degradante”, con la quale la dichiarazione del 1948 tentava di dare una formulazione più ampia del
concetto di tortura. Ma così il saggio finisce per perdere di vista il tema della tortura come
strumento di un potere che (forse per la sua imperfezione, come suggerisce Hannah Arendt) si
esercita per mezzo della violenza e del terrore. E’ questo tipo di peculiari relazioni fra esseri umani
che va messo a fuoco per capire la tortura, quelle relazioni di cui ci parlano le immagini di AbuGhraib o quelle del quasi dimenticato Salò di Pasolini (fra l’altro, in entrambi i casi si manifesta un
nesso con la pornografia sadomasochista che getta una luce diversa sullo stesso accostamento
proposto da Asad).
Quale teoria ci aiuta a distinguere le relazioni sociali o i sistemi politici che implicano la tortura da
quelli che la escludono? E’ evidente che categorie come modernità o Occidente non servono molto
a capire tutto ciò. La tortura non ha mai prosperato così bene come nella modernità, specialmente
all’interno di quelle che si autodefiniscono come missioni civilizzatrici. Neppure la frattura
democrazia-totalitarismo sembra decisiva, così come altre categorie politiche care al liberalismo.
Asad cerca appunto di evidenziare paradossi e contraddizioni del discorso moderno e liberale. Nella
linea della critical anthropology, vuol mostrare come l’astratta morale del liberalismo – e la
dichiarazione universale dei diritti umani che ne è espressione – non sia in grado di tener fuori dalla
modernità le pratiche “crudeli e degradanti”; e come, anzi, i principi su cui tale morale si fonda
(l’universalità come correlato dei rapporti capitalistici di produzione e dunque del dominio di
classe; Turner 1998, p. 344) ne ricreino costantemente le condizioni. Ma nella modernità, e per certi
versi nelle democrazie liberali, coesistono cose molto diverse: guerre sempre più distruttive e
movimenti pacifisti e non violenti, torturatori di ogni tipo e attivisti per i diritti umani. Si tratta solo
di ambiguità interne, come pare ad Asad, o di facce antagoniste e alternative? Una teoria della
violenza, mi pare, si dovrebbe misurare anche sulla capacità di aiutarci a discernere fra queste
diverse opzioni della modernità o del liberalismo; e non può limitarsi a considerare la dichiarazione
dei diritti umani come una ingenua e ipocrita copertura delle reali contraddizioni che muovono la
storia.
Torniamo così a chiederci se per un’antropologia della violenza sia possibile separare la discussione
“intellettuale”, come si esprime Asad, da un impegno pratico (politico, etico). Il problema viene
esplicitamente posto in molta letteratura etnografica, in termini di inevitabile coinvolgimento
personale del ricercatore e di umana solidarietà nei confronti delle vittime. Ma raramente la
tensione fra i due aspetti della conoscenza e dell’impegno viene portata fino alle sue conseguenze
più significative. Chi lo fa è ancora una volta Scheper-Hughes, secondo la quale la testimonianza
etnografica della violenza conduce necessariamente verso una concezione militante della disciplina.
Nel già ricordato recente lavoro con P.Bourgois sulla violenza in guerra e in pace, parla
dell’antropologo come di una persona “responsabile, riflessiva, moralmente o politicamente
impegnata”, che sappia “prender parte quando necessario e rifiutare i privilegi della neutralità”
(Scheper-Hughes, Bourgois 2004, p. 26). Rispetto alla situazione etnografica classica, nei contesti
di violenza diviene impossibile ottenere e mantenere ogni forma di “distanziamento” dagli
interlocutori: “che tipo di osservazione partecipante, che tipo di testimonianza oculare è appropriata
di fronte al genocidio e alle sue conseguenze, o anche soltanto di fronte alla violenza strutturale e
all’etnocidio? Quando l’antropologo diviene testimone di crimini contro l’umanità, la pura empatia
scientifica non basta più” (p. 27). L’atteggiamento del distacco trapassa troppo facilmente in quello
dello spettatore, e persino del complice. Semplicemente, non si può evitare di schierarsi – il che
significa porre la propria competenza e il proprio sapere al servizio di una causa, rovesciando una
intera tradizione di disimpegno accademico ma restando fedeli a quello che per Scheper-Hughes è il
“mandato originario” dell’antropologia:
schierare saldamente noi stessi e la nostra disciplina dalla parte dell’umanità, della
salvezza e della ricostruzione del mondo –anche se possiamo non esser sempre sicuri di
cosa ciò significhi e di cosa ci venga richiesto in momenti particolari. In ultima analisi,
possiamo solo sperare che i nostri celebrati metodi della testimonianza empatica e
impegnata, dello “stare con” e dello “stare là”, per quanto possano apparire vecchi e
stanchi, ci forniscano gli strumenti necessari per fare dell’antropologia una piccola
pratica di liberazione umana (ibid.)
La formulazione è abbastanza appassionata ma anche abbastanza modesta da risultare convincente.
Nessuno negherebbe un qualche grado di impegno nei confronti delle persone di cui si
rappresentano ( o si “studiano”) le sofferenze; resta tuttavia aperto il problema di quali valori e
obiettivi rappresentano le fedeltà ultime dell’antropologo. Quelli della conoscenza o quelli della
partecipazione? Dell’epistemologia o della politica? Per quanto non necessariamente in contrasto,
questi obiettivi hanno diversa natura e possono trovarsi a confliggere anche in modo estremamente
drammatico. Scheper-Hughes parte dall’implicito presupposto che la verità è rivoluzionaria, e che la
denuncia delle sopraffazioni e il sostegno alle vittime facciano tutt’uno con la ricerca
dell’oggettività 183 . Questo può essere anche vero in ultima analisi, ma i percorsi del rigore
metodologico e scientifico e quelli della solidarietà politica sono spesso assai diversi. Il problema si
pone soprattutto in relazione alla principale fonte dell’antropologia della violenza, cioè i racconti
delle vittime sopravvissute e dei testimoni diretti. L’epistemologia ci spinge a praticare verso questi
racconti una critica delle fonti: ad esempio, a non assumerli immediatamente come resoconti
realisti, a studiarne le forme di costruzione retorica e di adesione a modelli culturali, eventualmente
a farne risaltare le interne inconsistenze e così via. Ma questo rigore metodologico non serve ai fini
della solidarietà, e può anzi risultare controproducente sul piano pratico e politico (si pensi ai
racconti dei rifugiati e dei richiedenti asilo; v. Daniel-Knudsen 1995), e intollerabile sul piano etico:
che senso hanno le sottigliezze analitiche di fronte a persone che hanno subito violenze e lutti
terribili? Di fronte alla loro tragedia e alla loro sofferenza, che importanza ha come la raccontano?
L’atteggiamento critico sembra voler negare la verità assoluta di quelle esperienze; la sofisticazione
teoretica sembra del tutto fuori posto, quasi immorale, a fronte della semplice enormità del Male e
del Dolore che traspirano da quelle biografie.
Nell’etnografia della violenza, questo punto è espresso con grande efficacia da Antonius Robben,
in un intenso testo (1995) di riflessione su una ricerca condotta in Argentina sulla memoria dei
crimini della giunta militare. Robben intervista tre categorie di persone: militari coinvolti più o
meno direttamente nei crimini, ex-guerriglieri e parenti dei desaparecidos. Avverte con forza la
tendenza di tutte e tre queste componenti a tirare e far schierare il ricercatore dalla propria parte, a
chiedergli di condividere la propria visione del mondo: e conia per questa tendenza la nozione di
“seduzione” (nel senso etimologico del termine) etnografica. Quest’ultima si manifesta in modo
particolarmente drammatico nel rapporto con i parenti delle vittime. Robben si sofferma ad esempio
sul suo incontro col padre di uno scomparso, un ragazzo della Gioventù Peronista rapito nel 1976 a
diciassette anni. L’uomo racconta dei suoi tentativi di avere notizie del figlio, attraverso contatti con
ufficiali dell’esercito. Il climax del suo racconto è l’incontro con un colonnello, in servizio attivo,
che ha promesso attraverso la mediazione di amici di dargli informazioni:
Dopo che gli ebbi raccontato tutto, [il colonnello] disse: “Guardi, immagini che suo
figlio abbia il cancro [… ] e si trovi in una sala operatoria dove ci sono un macellaio e
un dottore: preghi che sia il dottore a operarlo”. Quest’uomo aveva infilato un pugnale
nella mia ferita e lo rigirava dentro di me. “Mi scusi, signore – dissi – ma lei sa
183
Una convinzione che è implicitamente o esplicitamente condivisa da molte etnografie contemporanee della violenza.
Si veda ad esempio il lavoro sui guerriglieri sick di C.K. Mahmood (1996), che teorizza un’etnografia “partigiana” e
“militante”, e in cui la ricercatrice dichiara di porsi al servizio dei suoi interlocutori ex-guerriglieri, per “salvare” la loro
voce e contribuire così ai loro obiettivi politici e ideologici – finalità ultima, questa, della ricerca, in contrapposizione
all’ “oggettivismo” degli studi accademici e dell’antropologia classica. Ci si può chiedere fino a che punto, con tali
premesse, ci troviamo ancora di fronte a un libro di antropologia (l’autrice dichiara persino di aver rivisto il testo sulla
base delle “correzioni” ideologiche dei suoi interlocutori; v. Dusenbery 1997 per una critica a questi aspetti); ma
soprattutto, si può notare la contraddizione tra, appunto, la critica all’oggettivismo accademico e la pretesa, più volte
riaffermata dall’autrice, di parlare in nome della “verità” (v. anche Mahmood 2001).
qualcosa?” . “No, no, sto solo soppesando le possibilità e facendo una supposizione”.
Avrei voluto prenderlo per la gola e strangolarlo; […] per la prima volta in vita mia
provavo il desiderio di uccidere qualcuno […] perché ero disperato. Non può
immaginare con quanta soddisfazione mi disse quelle cose. E lei dovrebbe analizzare il
fatto che quell’uomo era in servizio attivo (ibid., pp. 92-3).
“Ma io ero incapace di analizzare”, commenta Robben. Il testimone lo ha “incorporato nel suo
tormento”; le domande di approfondimento che avrebbe voluto fare gli si spengono sulle labbra, e
può solo “condividere in silenzio il dolore di quest’uomo” (ibid., p. 93). Se questa partecipazione
può essere fondamentale per la comprensione della natura degli eventi studiati, essa implica tuttavia
grandi rischi. Quando il ricercatore è sopraffatto dall’emozione, e sente di non poter fare
nessun’altra domanda, perché non c’è nient’altro da chiedere di fronte all’enormità della tragedia,
allora rischia di non esser più ricercatore. “In questi momenti di completo collasso della distanza
critica tra i due interlocutori, perdiamo ogni dimensione dell’impresa scientifica” (ibid., p. 94);
quest’ultima implica per l’appunto distanza, scetticismo, lucidità e obiettività, valori diversi rispetto
a quelli della solidarietà morale e politica (v. anche Robben 1996, che rilegge il problema della
seduzione etnografica alla luce dei concetti psicoanalitici di transfert e controtransfert).
Malgrado le apparenze, le posizioni espresse da Scheper-Hughes e Robben non sono alternative.
Esprimono invece una tensione alla quale il lavoro antropologico non può sfuggire. Robben pensa
che dalla seduzione etnografica ci si debba programmaticamente difendere: ma sa bene, lui per
primo, che cederle almeno per un po’ è una condizione della comprensione – soprattutto quando ciò
che ci interessa non è una pura conoscenza fattuale, ma il significato della violenza nella memoria e
nella vita delle persone. Per quanto riguarda Scheper-Hughes, anche il suo appello all’impegno può
difficilmente essere eluso; ricordandosi però che l’antropologo può forse dare il suo piccolo
contributo alla “liberazione umana” continuando a fare il suo mestiere, e non trasformandosi in un
attivista politico tout court. Il che significa continuare a seguire le regole del metodo, della critica
delle fonti, del rigore argomentativo; e anche mantenere quella certa dose di distacco da immediate
finalità pratiche che è sempre requisito del lavoro scientifico, e di cui il vituperato disimpegno
accademico non è che un’espressione. In altre parole, comprensione critica, partecipazione morale e
impegno politico possono magari coesistere nella stessa persona, ma sono destinati a non fondersi
mai completamente gli uni negli altri: nella loro costante tensione, vorrei suggerire, risiede la forza
particolare del lavoro antropologico.
Riferimenti bibliografici
Abbink, J., 2000, “Preface: Violation and violence as cultural phenomena”, in G. Aijmer,
J.Abbink, a cura, Meanings of Violence. A Cross-Cultural Perspective, Oxford, Berg, pp. xi-xvii.
Aijmer, G., Abbink, J., a cura, 2000, Meanings of Violence. A Cross-Cultural Perspective, Oxford,
Berg.
Amselle, J. L., 1990, Logiques Metisses, Paris, Payot ; trad. it. 1999, Logiche meticce, Torino,
Bollati Boringhieri.
Antze, P., Lambek, M., a cura, 1996, Tense Past. Cultural Essays in Trauma and Memory, LondonNew York, Routledge.
Appadurai, A., 1996, Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization, MinneapolisLondon, University of Minnesota Press; trad. it. 2001, Modernità in polvere, Roma, Meltemi.
Appadurai, A., 1998, Dead certainty. Ethnic violence in the era of globalization, «Public Culture»,
10 (2), pp. 225-47
Arendt, H., 1969, On Violence, New York, Harcourt, Brace; trad.it. 2001, Sulla violenza, Parma,
Guanda.
Arnold, B., 2002, “Justifying genocide: Archaeology and the contruction of difference”, in
A.L.Hinton, a cura, Annihilating difference, Berkeley University of California Press, pp. 95-116
Avruch, K., 2001, Notes toward ethnographies of conflict and violence, «Journal of Contemporary
Ethnography»; 30 (5), pp. 637-48
Basaglia, F., Ongaro Basaglia, F., a cura, 1975, Crimini di pace, Torino, Einaudi
Bax, M., 2000, Planned policy or primitive Balkanism? A local contribution to the ethnography of
the war in Bosnia-Herzegovina, «Ethnos», 65 (3), pp. 317-40
Beneduce, R., 1999, Mente, persona, cultura. Materiali di etnopsicologia, Torino, L’Harmattan
Italia.
Benjamin, W., 1955 Schriften , Frankfurt, Suhrkamp Verlag; trad. it. 1976, Angelus Novus, Torino,
Einaudi.
Bodley. J. H., 1992 “Anthropology and the politics of genocide”, in C. Nordstrom, J.A.Martin, a
cura, The paths to domination, resistance, and terror, Berkeley, University of California Press, pp.
37-51.
Bornstein, A., 2001, Ethnography and the politics of prisoners in Palestine-Israel, «Journal of
Contemporary Ethnography», 30 (5), pp. 546-74
Botev, N., Wagner, R., 1993, “Seeing past the barricades: Ethnic intermarriage in Yugoslavia
during the last three decades”, in D. E. Kideckel, J. M. Halpern, a cura, Special issue: War among
the Yugoslavs, «The Anthropology of East Europe Review», 11 (1-2), pp. 29-38.
Bourgois, P., 1995, In search of respect: Selling crack in El Barrio, New York, Cambridge
University Press.
Bourgois, P., 1996, Confronting anthropology, education, and inner-city apartheid, «American
Anthropologist», 98 (2), pp. 249-58.
Bourgois, P., 2001, The power of violence in war and peace. Post cold-war lessons from El
Salvador, «Ethnography», 2 (1), pp. 5-34.
Bowman, G., 2001, “The violence in identity”, in B.E. Schmidt, I.W. Schröder, a cura,
Anthropology of Violence and Conflict, London, Routledge, pp. 25-46.
Bringa, T., 2002, “Averted gaze: Genocide in Bosnia-Herzegovina, 1992-1995”, in A.L.Hinton
(ed.), Annihilating difference, Berkeley, University of California Press, pp. 194-225.
Browning, C. R., 1992, Ordinary men. Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in
Poland, New York, Harper Collins; trad. it. 1995, Uomini comuni. Polizia tedesca e «soluzione
finale» in Polonia, Torino, Einaudi.
Čale Feldman, L., Prica, I., Senjković, R., a cura, Fear, death, and resistance. An ethnography of
war, Croatia 1991-92, Zagreb, Institut of Ethnology and Folklore Research, Matrix Croatica, X
Press.
Chomski, N., 2004, “The new war against terror”, in N.Scheper-Hughes, P. Bourgois, a cura,
Violence in war and peace, Oxford, Blackwell, pp. 217-23
Clastres, P.,1977, “Archeologie de la violence” , «Libre», 1 ; trad. it. 1998, Archeologia della
violenza, Roma, Meltemi.
Comaroff, Jean, Comaroff, John, 2003, Ethnography on an awkward scale. Postcolonial
anthropology and the violence of abstraction, «Ethnography», 4 (2), pp. 147-79
Conte, E., Essner, C., 1995, La quête de la race. Une anthropologie du nazisme, Paris, Hachette ;
trad.it. 2000, Culti di sangue. Antropologia del nazismo, Roma, Carocci.
Cushman, T., 2004, Anthropology and genocide in the Balkans, «Anthropological Theory», 4 (1),
pp. 5-28
Daniel, E. V., 1996, Charred Lullabies. Chapters in an Anthropography of Violence, Princeton,
Princeton University Press.
Daniel, E. V., Knudsen, J.C., a cura, 1995, Mistrusting Refugees, Berkeley, University of California
Press.
Das, V., 1985, Anthropological knowledge and collective violence: the riots in Delhi, November
1984, «Anthropology Today», 1 (3), pp. 4-6.
Das, V., a cura, 1990, Mirrors of Violence: Communities, Riots, and Survivors in South Asia, Dehli,
Oxford University Press.
Das V., Kleinman, A., Ramphele, M., Reynolds, P., a cura, 2000, Violence and Subjectivity,
Berkeley, University of California Press.
Das, V., Ramphele, M., Reynolds, P., a cura, 2001, Remaking a World: Violence, Social Suffering,
and Recovery, Berkeley, University of California Press.
Dei, F., 1999, Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l’antropologia ,
«Parolechiave», 20-21, pp. 281-301.
Dei, F., 2004a, Antropologia e genocidio, «Parolechiave», 31, pp. 185-204.
Dei, F. 2004b, Antropologia e memoria. Prospettive di un nuovo rapporto con la storia,
«Novecento», 10, pp. 28-46.
Dei, F., 2005, “Introduzione. Poetiche e politiche del ricordo”, in P.Clemente, F.Dei, a cura ,
Poetiche e politiche del ricordo. Memoria pubblica degli eccidi nazifascisti in Toscana, Roma,
Carocci, pp. 9-48.
Denich, B., 1994, Dismembering Yougoslavia: Nationalist ideologies and the symbolic revival of
genocide, «American Ethnologist», 21 (2), pp. 367-90.
Dow, J. - Lixfeld, H.,1994, The Nazification of an academic discipline. Folklore in the Third Reich,
Bloomington, University of Indiana Press.
Dusenbery, V.A., 1997, Political violence and the politics of ethnography, «American
Anthropologist», 99 (4), pp. 831-33.
Evans-Pritchard, E.E., 1940, The Nuer, Oxford, Oxford University Press; trad. it. 1975, I Nuer.
Un’anarchia ordinata, Milano, Angeli.
Fabietti, U., 1995, L’identità etnica, Roma, Nuova Italia Scientifica
Farmer, P., 1997, “On suffering and structural violence: A view from below”, in A. Kleinman, V.
Das, M.Lock, a cura, Social Suffering, Berkeley, University of California Press, pp. 261-84.
Feldman, A., 1991, Formations of Violence: The Narrative of the Body and Political Terror in
Northern Ireland, Chicago, University of Chicago Press.
Feldman, A., 2000, “Violence and vision: The prosthetics and aesthetics of terror”, in V. Das et al.,
a cura, Violence and Subjectivity, Berkeley, University of California Press, pp. 46-78
Finnström, S., 2001, In and out of culture. Fieldwork in war-torn Uganda, «Critique of
Anthropology», 21 (3), pp. 247-58.
Flores, M, 2005, Tutta la violenza di un secolo, Milano, Feltrinelli.
Free, T., 1991, The politics and philosophical genealogy of Evans-Pritchard’s The Nuer, «Journal
of the Anthropological Society of Oxford», 22 (1), pp. 19-39.
Friedlander, S., a cura, 1992, Proibing the limits of representation. Nazism and the “Final
Solution”, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
Fusaschi, M., 2000, Hutu-Tutsi. Alle radici del genocidio rwandese, Torino, Bollati Boringhieri.
Gampel, Y., 2000, “Reflections on the prevalence of the uncanny in social violence”, in A.Robben,
M. Suárez-Orozco, a cura, Cultures under Siege, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 4869.
Geertz, C., 1988, Works and Lives. The Anthropologist as Author, Stanford, Stanford University
Press; trad. it. 1990, Opere e vite, Bologna, Il Mulino.
Geertz, C., 1999, Mondo globale mondi locali. Cultura e politica alla fine del ventesimo secolo,
Bologna, Il Mulino.
Gillis, J. R., a cura, 1994, Commemorations. The politics of national identity, Princeton, N.J.,
Princeton University Press.
Ginzburg, C., 1992, Unus testis. Lo sterminio degli Ebrei e il principio di realtà, «Quaderni
Storici», 80, pp. 520-48.
Goldhagen, D.J., 1996, Hitler’s willing executioners. Ordinary Germans and the Holocaust, New
York, A. Knopf; trad.it. 1997, I volenterosi carnefici di Hitler. I tedeschi comuni e l’Olocausto,
Milano, Mondadori.
Green, L., 1995, “Living in a state of fear”, in C.Nordstrom, A. Robben (eds.), Fieldwork Under
Fire. Contemporary Studies of Violence and Survival, Berkeley, University of California Press, pp.
105-27.
Green. L., 1999, Fear as a Way of Life, New York, Columbia University Press.
Jambrešić Kirin, R., Povrzanović, M., a cura,1996, War, exile, everyday life. Cultural perspectives,
Zagreb, Institute of Ethnology and Folklore Research.
Hatzfeld, J., 2003, Une saison de machettes, Paris, Seuil; trad. it. 2004, A colpi di machete, Milano,
Bompiani.
Hayden, R.,1993, “The triumph of chauvinistic nationalisms in Yugoslavia: Bleak implications for
anthropology”, «Anthropology of East Europe Review», 11 (1-2)
(http://condor.depaul.edu/~rrotenbe/aeer/aeer11_1/hayden.html)
Hinton, A.L.,1996, Agents of death: Explaining Cambodian genocide in terms of psychosocial
dissonance, «American Anthropologist», 98 (4), pp. 818-31.
Hinton, A.L., 1998a, A head for an eye: Revenge in the Cambodian genocide, «American
Ethnologist», 25 (3), pp. 352-77.
Hinton, A.L., 1998b, Why did the Nazis kill? Anthropology, genocide and the Goldhagen
controversy, «Anthropology Today», 14 (5) : 9-15.
Hinton, A.L., a cura, 2002a, Genocide. An Anthropological Reader, Oxford, Blackwell.
Hinton, A.L., a cura, 2002b, Annihilating Difference. The Anthropology of Genocide, Berkeley,
University of California Press.
Kakar, S.,1996, The Colors of Violence. Cultural Identities, Religion, and Conflict, Chicago,
University of Chicago Press.
Kaldor, M., 1999, New and old wars. Organized violence in a global era, Cambridge, Polity Press;
trad.it. 2003, Le nuove guerre. La violenza organizzata nell’età globale, Roma, Carocci.
Kellner, H., 1994, ‘Never again’ is now, «History and Theory», 33 (2), poi in K. Jenkins, a cura,
1997, The Postmodern History Reader, London-New York, Routledge, pp. 397-412.
Kideckel, D.E., Halpern, J.M., a cura, 1993, Special issue: War among the Yugoslavs, «The
Anthropology of East Europe Review», 11 (1-2).
Kleinman, A., Kleinman, J., 1997, The appeal of experience, the dismay of images: Cultural
appropriations of suffering in our times, in A. Kleinman, V. Das, M. Lock, a cura, Social Suffering,
Berkeley, University of California Press, pp. 1-23.
Kleinman, A., Das, V., Lock, M., a cura, 1997, Social Suffering, Berkeley, University of California
Press.
Knauft, B., 1987, Reconsidering violence in simple human societies, «Current Anthropology», 28
(4), pp. 457-99.
Knauft, B., 1991, Violence and sociality in human evolution, «Current Anthropology», 32 (4), pp.
391-428.
Lang, B., 1990, Act and Idea in the Nazi Genocide, Chicago, University of Chicago Press.
Linke, U.,1997, Gendered difference, violent imagination: Blood, race, nation, «American
Anthropologist», 99 (3), pp. 559-73.
Linke, U., 1999, Blood and Nation: The European Aesthetic of Race, Philadelphia, University of
Pennsylvania Press.
Lorey, D. E., Beezley, W, H., a cura, 2002, Genocide, Collective Violence, and Popular Memory.
The Politics of Remembrance in the Twentieth Century, Wilmington, De., Scholarly Resources.
Lutz, C., 1999, Ethnography at the war century’s end, «Journal of Contemporary Ethnography», 28
(6), pp. 610-19.
Maček, I. , 2001, “Predicament of war: Sarajevo experiences and ethics of war”, in B.E. Schmidt,
I.W. Schröder, a cura, Anthropology of Violence and Conflict, London, Routledge, pp.197-224
Mahmood, C.K.,1996, Fight for Faith and Nation: Dialogues with Sick Militants, Philadelphia,
University of Pennsylvania Press.
Mahmood, C.K., 2001, Terrorism, mith, and the power of ethnographic praxis, «Journal of
Contemporary Ethnography», 30 (5), pp. 520-45.
Malkki, L.H., 1995a, Purity and Exile: Violence, Memory, and National Cosmology among Hutu
Refugees in Tanzania, Chicago, University of Chicago Press.
Malkki, L.H., 1995b, Refugees and ‘exile’: from ‘Refugees studies’ to the national order of things,
«Annual Review of Anthropology», 24, pp. 495-523.
Malkki, L.H.,1996, Speechless emissaires: Refugees, humanitarianism, and dehistoricization,
«Cultural Anthropology», 11 (3), pp. 377-404.
Marta, C., 1999, Guerre etniche: metafora del nostro tempo?, «Parolechiave», 20-21, pp. 259-79.
Maybury-Lewis, D., 2002, “Genocide against indigenous peoples”, in A.L. Hinton, a cura,
Annihilating difference, Berkeley, University of California Press, pp. 43-53.
Milgram, S., 1974, Obedience to authority, New York, Harper and Row; trad. it. 1975, Obbedienza
all’autorità, Milano, Bompiani.
Nahoum-Grappe, V.,1997, “L’uso politico della crudeltà: l’epurazione etnica in ex-Iugoslavia
(1991-1995)”, in F. Heritier, a cura, Sulla violenza, Roma, Meltemi, pp.190-227.
Nordstrom, C.,1992, “The backyard front”, in C. Nordstrom, J.A. Martin, a cura, The paths to
domination, resistance and terror, Berkeley, University of California Press, pp. 260-274.
Nordstrom, C.,1995, “War on the front lines”, in C. Nordstrom, A.Robben, a cura, Fieldwork
Under Fire. Contemporary Studies of Violence and Survival, Berkeley, University of California
Press, pp. 129-53.
Nordstrom, C., 1997, A Different Kind of War Story (Ethnography of Political Violence),
Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
Nordstrom, C., 2004, Shadows of War: Violence, Power, and International Profiteering in the
Twenty-First Century, Berkeley, University of California Press.
Nordstrom, C., Martin, J. A., a cura, 1992, The Paths to Domination, Resistance, and Terror,
Berkeley, University of California Press.
Nordstrom, C., Robben, A.C.G.M., a cura, 1995, Fieldwork Under Fire. Contemporary Studies of
Violence and Survival, Berkeley, University of California Press.
Povrzanović, M., 2000, The imposed and the imagined as encountered by Croatians war
ethnographers, «Current Anthropology», 41 (2), pp.151-62.
Ravenna, M., 2004, Carnefici e vittime. Le radici psicologiche della Shoah e delle atrocità sociali,
Bologna, Il Mulino.
Riches, D., a cura, 1986, The anthropology of violence, Oxford, Blackwell.
Robben, A. C. G. M.,1995, “The politics of truth and emotion among victims and perpetrators of
violence”, in C. Nordstrom, A.Robben, a cura, Fieldwork Under Fire. Contemporary Studies of
Violence and Survival, Berkeley, University of California Press, pp. 81-103.
Robben, A. C. G. M.,1996, Ethnographic seduction, transference and resistance in dialogues about
terror and violence in Argentina, «Ethos», 24 (1), pp. 71-106.
Robben, A. C. G. M., 2000, “The assault on basic trust: disappearence, protest and reburial in
Argentina”, in A.Robben, M. Suárez-Orozco, a cura, Cultures under siege, Cambridge, Cambridge
University Press, pp.70-101.
Robben, A.C.G.M., Suárez-Orozco, M.M., a cura, 2000, Cultures Under Siege. Collective Violence
and Trauma, Cambridge, Cambridge University Press.
Rosaldo, R., 1986, “From the door of his tent: the fieldworker and the inquisitor”, in J.Clifford,
G.E. Marcusa cura, Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography, Berkeley, University
of California Press, pp. 77-97; trad. it. 2001, “Sulla soglia della tenda: l’etnografo e l’inquisitore”,
in J.Clifford, G.E.Marcus, a cura, Scrivere le culture, Roma, Meltemi, pp. 119-44.
Ross, F. C., 2003a, Bearing witness: Women and the Truth and reconciliation commission in South
Africa, London, Pluto.
Ross, F.C., 2003b, On having voice and being heard: Some after effects of testifying before the
South African Truth and reconciliation commission, «Anthropological Theory», 3 (3), pp. 325-41
Said, E., 1978, Orientalism, New York, Pantheon Books; trad. it . 1991, Orientalismo, Torino,
Bollati Boringhieri.
Scheper-Hughes, N.,1992, Death Without Weeping. The Violence of Everyday Life in Brazil,
Berkeley, California University Press.
Scheper-Hughes, N., 1995, The primacy of the ethical: Propositions for a militant anthropology,
«Current Anthropology», 36 (3), pp. 409-40.
Scheper-Hughes, N., 2000a, The global traffic in organs, «Current Anthropology», 41 (2), pp. 191224.
Scheper-Hughes, N., 2000b, Saints, Scholars and Schizophrenics. Mental Illness in Rural Ireland,
Berkeley, University of California Press (ed. orig. 1980).
Scheper-Hughes, N., 2001, Il traffico di organi nel mercato globale, Verona, Ombre Corte.
Scheper-Hughes, N., 2004, Parts unknown. Undercover ethnography of the organs-traffic
underworld, «Ethnography», 5 (1), pp. 29-73.
Scheper-Hughes, N., Bourgois, P., 2004, “Introduction: Making sense of violence”, in N.ScheperHughes, P.Bourgois, a cura, Violence in War and Peace, Oxford, Blackwell, pp. 1-31.
Scheper-Hughes, N., Bourgois, P., a cura, 2004, Violence in War and Peace. An Anthology, Oxford,
Blackwell.
Scheper-Hughes, N., Wacquant, L., a cura, 2002, Commodifying Bodies, London, Sage; trad.it.
2003, Corpi in vendita. Interi e a pezzi, Verona, Ombre Corte.
Schmidt, B.E., Schröder, I.W., a cura, 2001, Anthropology of Violence and Conflict, London,
Routledge.
Shaff, G.E., 2002, “Scientific racism in service of the Reich: German anthropologists in the Nazi
era”, in in A.L.Hinton, a cura, Annihilating difference, Berkeley University of California Press, pp.
117-34.
Simic, A., 1994, The Civil War in Yugoslavia: Do Ostensibly High Rates of Intermarriage Obviate
Ethnic Hatreds as a Cause?, «Anthropology of East Europe Review», 12 (2)
(http://condor.depaul.edu/~rrotenbe/aeer/aeer12_2/simiclet.html).
Sluka, J.A., 1989, Hearths and Minds, Water and Fish. Popolar support for the IRA and INLA in a
Northern Irish Ghetto, Greenwich, JAI Press.
Sluka, J. A., 1995a, Reflections on managing danger in fieldwork: Dangerous anthropology in
Belfast, in C. Nordstrom, A.Robben, a cura, Fieldwork Under Fire. Contemporary Studies of
Violence and Survival, Berkeley, University of California Press, pp. 276-94.
Sluka, J.A., 1995b, Domination, resistance and political culture in Northern Ireland’s catholicnationalist ghettos, «Critique of Anthropology», 15 (1), pp. 71-102.
Sluka, J.A., a cura, 2000, Death Squad: The Anthropology of State Terror, Philadelphia, University
of Pennsylvania Press.
Sofski, W., 1995, Traktat über die Gewalt, Frankfurt am Main, Fisher Verlag; trad. it. 1998, Saggio
sulla violenza, Torino, Einaudi.
Sontag, S., 2003, Regarding the Pain of Others, New York, Farrar, Straus and Giroux; trad. it.
2003, Davanti al dolore degli altri, Milano, Mondadori.
Staub, E., 1989, The roots of evil. The origins of genocide and other group violence, Cambridge,
Cambridge University Press.
Sternhell, Z., 2001, “Dall’illuminismo al fascismo: riflessioni sul destino delle idee nella storia del
XX secolo”, in M. Flores, a cura, Storia, verità, giustizia, I crimini del XX secolo, Milano, Bruno
Mandadori, pp. 44-65.
Stolcke, V., 1995, Talking culture. New boundaries, new rhetorics of exclusion in Europe, «Current
Anthropology», 36 (1), pp. 1-24.
Suárez-Orozco, M., 1990, Speaking of the unspeakable: Towards a psychosocial understanding of
responses to terror,«Ethos», 18 (3), pp. 353-83.
Suárez-Orozco, M., 1992, “A grammar of terror: Psychocultural responses to state terrorism in
dirty war and post-dirty war Argentina”, in C. Nordstrom, J.A. Martin, a cura, The paths to
domination, resistance, and terror, Berkeley, University of California Press, pp. 219-59.
Suárez-Orozco, M. M., Robben A.C.G.M., 2000, “Interdisciplinary perspectives in violence and
trauma”, in A.Robben, M. Suárez-Orozco, a cura, Cultures Under Siege. Collective Violence and
Trauma, Cambridge, Cambridge University Press, pp.1-41.
Swedenburg, T., 1995, “With Genet in the Palestinian field”, in C. Nordstrom, A.Robben, a cura,
Fieldwork Under Fire, Berkeley, University of California Press, pp. 25-40
Tambiah, S.J., 1989, Ethnic conflict in the world today, «American Ethnologist», 16 (2), pp. 33549.
Tambiah, S.J., 1991, Sri Lanka: Ethnic Fratricide and the Dismantling of Democracy, Chicago,
University of Chicago Press.
Taussig, M., 1983, Devil and Commodity Fetishism in South America, Chapel Hill, NC, University
of North Carolina Press.
Taussig, M.,1987, Shamanism, Colonialism, and the Wild Man, Chicago, Chicago University Press.
Taussig, M., 1992, The Nervous System, London-New York, Routledge.
Taussig, M., 1993, Mimesis and Alterity, London-New York, Routledge.
Taussig, M., 1997 The magic of the State, London-New York, Routledge.
Taussig, M., 1999 Defacement: Public Secrecy and the Labor of the Negative, Stanford, CA,
Stanford University Press.
Taylor, C. C., 2002, “The cultural face of terror in the Rwandan genocide of 1994”, in A.L.Hinton,
a cura, Annihilating Difference. The Anthropology of Genocide, Berkeley, University of California
Press, pp. 137-78.
Teitel, R., 2001, “Giustizia di transizione come narrativa liberale”, in M. Flores, a cura , Storia,
verità, giustizia. I crimini del XX secolo, Milano, Bruno Mondadori, pp.262-77.
Todorov, T., “Il secolo delle tenebre”, in M. Flores, a cura, Storia verità giustizia. I crimini del XX
secolo, Milano, Bruno Mondadori, pp. 1-8.
Traverso, E., 2002, La violenza nazista. Una genealogia, Bologna, Il Mulino.
Turner, T., 1998, “Diritti umani, sofferenza umana: il contributo dell’antropologia ad una politica
di emancipazione culturale”, trad. it. in A. Santiemma, a cura, Diritti umani. Riflessioni e
prospettive antropologiche, Roma, EuRoma, pp.336-60.
Vidal, C., 1997, “Il genocidio dei ruandesi tutsi: crudeltà voluta e logiche di odio”, in F. Heritier, a
cura, Sulla violenza, trad. it. Roma, Meltemi, pp.228-55.
Viñar, M., Ulriksen Viñar, M., 2001, “Dal Sudamerica: terrorismo di Stato e soggettività”, in M.
Flores, a cura, Storia, verità, giustizia: i crimini del XX secolo, Milano, Bruno Mondadori, pp. 20421.
Walter, E.V., 1969, Terror and resistance: A study of political violence, with case studies of some
primitive African communities, New York, Oxford University Press.
White, H., 1999, Storia e narrazione, Ravenna, Longo
Wieviorka, A., 1998, L’Ére du témoine, Paris, Plon ; trad. it. 1999, L’era del testimone, Milano,
Cortina.
Wilson, R.A., 2000, Reconciliation and revenge in post-apartheid South Africa. Rethinking legal
pluralism and human rights, «Current Anthropology», 41 (1), pp. 75-98.
Wilson, R.A., 2001, The politics of truth and reconciliation in South Africa: Legitimizing the postapartheis state, Cambridge, Cambridge University Press
Wilson, R.A., 2003, Anthropological studies on national reconciliation processes,
«Anthropological Theory», 3 (3), pp. 367-87.
Winkler, C., 1991, Rape as social murder, «Anthropology Today», 7 (3), pp. 12-14.
Winkler, C. (with Penelope J. Hanke), 1995, “Ethnography of the ethnographer”, in C. Nordstrom,
A.Robben, a cura, Fieldwork under fire, Berkeley,University of California Press, pp. 155-84.
Winter, J., 1995, Sites of memory, sites of mourning. The Great War in European cultural history,
Cambridge, Cambridge University Press; trad. it. 1998, Il lutto e la memoria. La Grande Guerra
nella storia culturale europea, Bologna, Il Mulino.
Young, J., 1988, Writing and re-writing the Holocaust. Narrative and the consequences of
interpretation, Bloomington, Indiana University Press.
Zimbardo, P. G., 2004, “A situationist perspective on the psychology of evil: Understanding how
good people are transformed into perprtrators”, in A. Miller, a cura, The social psychology of good
and evil: Understanding our capacity for kindness and cruelty, New York, Guilford, pp. 21-50.