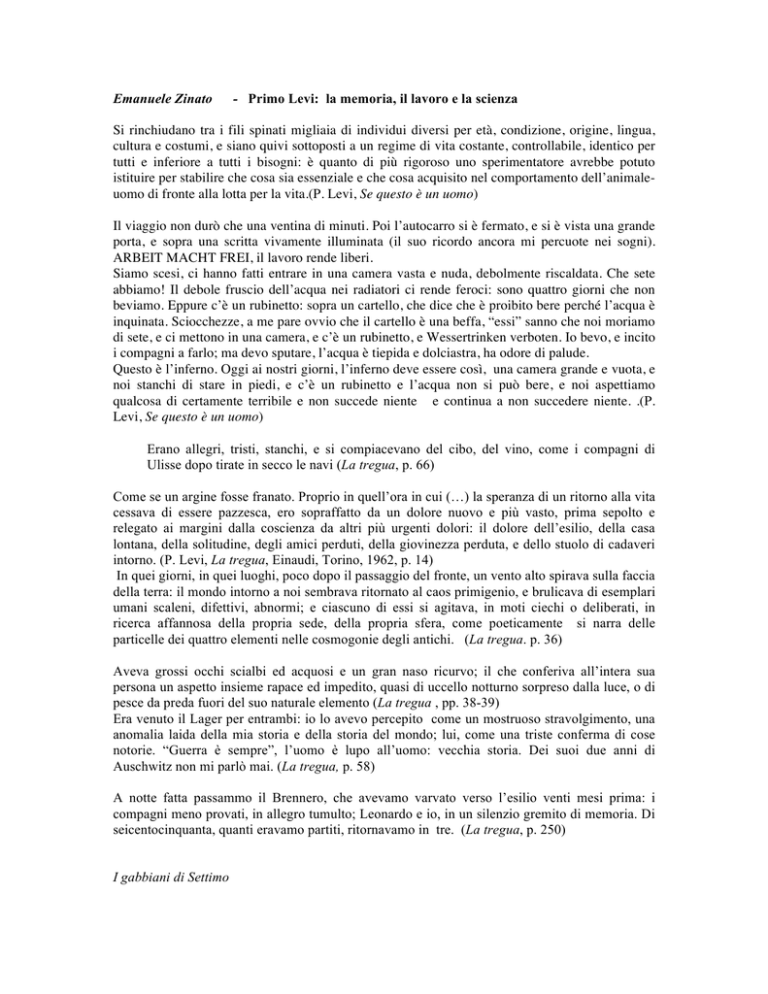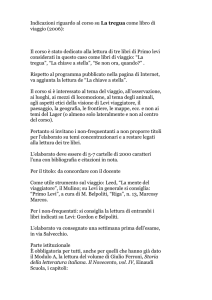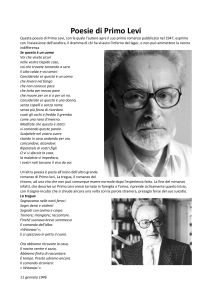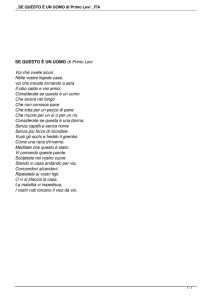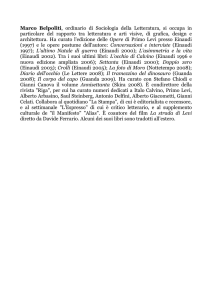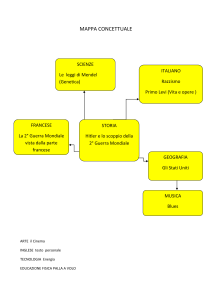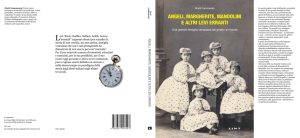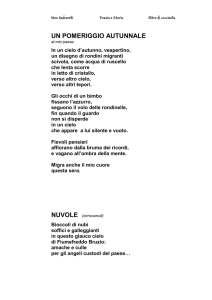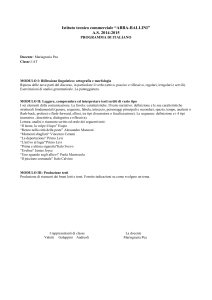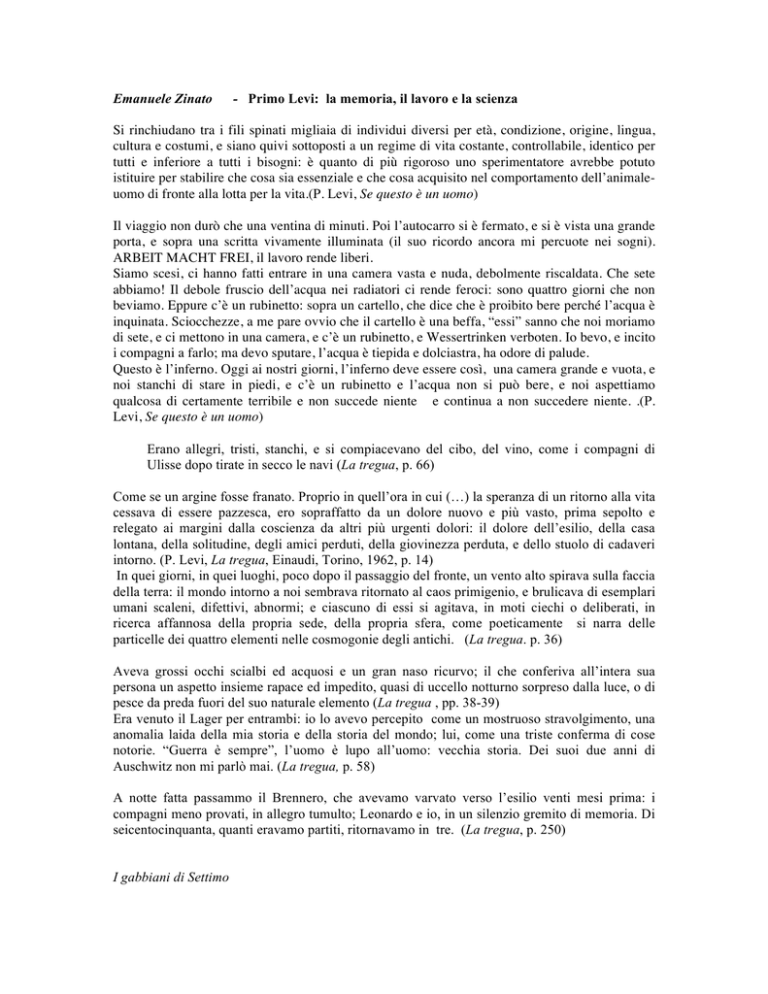
Emanuele Zinato
- Primo Levi: la memoria, il lavoro e la scienza
Si rinchiudano tra i fili spinati migliaia di individui diversi per età, condizione, origine, lingua,
cultura e costumi, e siano quivi sottoposti a un regime di vita costante, controllabile, identico per
tutti e inferiore a tutti i bisogni: è quanto di più rigoroso uno sperimentatore avrebbe potuto
istituire per stabilire che cosa sia essenziale e che cosa acquisito nel comportamento dell’animaleuomo di fronte alla lotta per la vita.(P. Levi, Se questo è un uomo)
Il viaggio non durò che una ventina di minuti. Poi l’autocarro si è fermato, e si è vista una grande
porta, e sopra una scritta vivamente illuminata (il suo ricordo ancora mi percuote nei sogni).
ARBEIT MACHT FREI, il lavoro rende liberi.
Siamo scesi, ci hanno fatti entrare in una camera vasta e nuda, debolmente riscaldata. Che sete
abbiamo! Il debole fruscio dell’acqua nei radiatori ci rende feroci: sono quattro giorni che non
beviamo. Eppure c’è un rubinetto: sopra un cartello, che dice che è proibito bere perché l’acqua è
inquinata. Sciocchezze, a me pare ovvio che il cartello è una beffa, “essi” sanno che noi moriamo
di sete, e ci mettono in una camera, e c’è un rubinetto, e Wessertrinken verboten. Io bevo, e incito
i compagni a farlo; ma devo sputare, l’acqua è tiepida e dolciastra, ha odore di palude.
Questo è l’inferno. Oggi ai nostri giorni, l’inferno deve essere così, una camera grande e vuota, e
noi stanchi di stare in piedi, e c’è un rubinetto e l’acqua non si può bere, e noi aspettiamo
qualcosa di certamente terribile e non succede niente e continua a non succedere niente. .(P.
Levi, Se questo è un uomo)
Erano allegri, tristi, stanchi, e si compiacevano del cibo, del vino, come i compagni di
Ulisse dopo tirate in secco le navi (La tregua, p. 66)
Come se un argine fosse franato. Proprio in quell’ora in cui (…) la speranza di un ritorno alla vita
cessava di essere pazzesca, ero sopraffatto da un dolore nuovo e più vasto, prima sepolto e
relegato ai margini dalla coscienza da altri più urgenti dolori: il dolore dell’esilio, della casa
lontana, della solitudine, degli amici perduti, della giovinezza perduta, e dello stuolo di cadaveri
intorno. (P. Levi, La tregua, Einaudi, Torino, 1962, p. 14)
In quei giorni, in quei luoghi, poco dopo il passaggio del fronte, un vento alto spirava sulla faccia
della terra: il mondo intorno a noi sembrava ritornato al caos primigenio, e brulicava di esemplari
umani scaleni, difettivi, abnormi; e ciascuno di essi si agitava, in moti ciechi o deliberati, in
ricerca affannosa della propria sede, della propria sfera, come poeticamente si narra delle
particelle dei quattro elementi nelle cosmogonie degli antichi. (La tregua. p. 36)
Aveva grossi occhi scialbi ed acquosi e un gran naso ricurvo; il che conferiva all’intera sua
persona un aspetto insieme rapace ed impedito, quasi di uccello notturno sorpreso dalla luce, o di
pesce da preda fuori del suo naturale elemento (La tregua , pp. 38-39)
Era venuto il Lager per entrambi: io lo avevo percepito come un mostruoso stravolgimento, una
anomalia laida della mia storia e della storia del mondo; lui, come una triste conferma di cose
notorie. “Guerra è sempre”, l’uomo è lupo all’uomo: vecchia storia. Dei suoi due anni di
Auschwitz non mi parlò mai. (La tregua, p. 58)
A notte fatta passammo il Brennero, che avevamo varvato verso l’esilio venti mesi prima: i
compagni meno provati, in allegro tumulto; Leonardo e io, in un silenzio gremito di memoria. Di
seicentocinquanta, quanti eravamo partiti, ritornavamo in tre. (La tregua, p. 250)
I gabbiani di Settimo
Di meandro in meandro, anno per anno,
I signori del cielo hanno risalito il fiume
Lungo le sponde, su dalle foci impetuose.
Hanno dimenticato la risacca e il salino,
Le cacce astute e pazienti, i granchi ghiotti.
Su per Crespino, Polesella, Ostiglia,
I nuovi nati più risoluti dei vecchi,
Oltre Luzzara, oltre Viadana spenta,
Ingolositi dalle nostre ignobili
Discariche, d’ansa in ansa più pingui,
Hanno esplorato le nebbie di Caorso,
I rami pigri fra Cremona e Piacenza,
Retti dal fiato tepido dell’autostrada,
Stridendo mesti nel loro breve saluto.
Hanno sostato alla bocca del Ticino,
Tessuto nidi sotto il ponte di Valenza
Tra grumi di catrame e lembi di polietilene.
Han veleggiato a monte, oltre Casale e Chivasso,
Fuggendo il mare, attratti dalla nostra abbondanza.
Ora planano inquieti su Settimo Torinese:
Immemori del passato, frugano i nostri rifiuti.
9 aprile 1979
La bambina di Pompei
Poiché l’angoscia di ciascuno è la nostra
Ancora riviviamo la tua, fanciulla scarna
Che ti sei stretta convulsamente a tua madre
Quasi volessi ripenetrare in lei
Quando al meriggio il cielo si è fatto nero.
Invano, perché l’aria volta in veleno
È filtrata a cercarti per le finestre serrate
Della tua casa tranquilla dalle robuste pareti
Lieta già del tuo canto e del tuo timido riso.
Sono passati i secoli, la cenere si è pietrificata
A incarcerare per sempre codeste membra gentili.
Così tu rimani tra noi, contorto calco di gesso,
Agonia senza fine, terribile testimonianza
Di quanto importi agli dèi l’orgoglioso nostro seme.
Ma nulla rimane fra noi della tua lontana sorella,
Della fanciulla d’Olanda murata fra quattro mura
Che pure scrisse la sua giovinezza senza domani:
La sua cenere muta è stata dispersa dal vento,
La sua breve vita rinchiusa in un quaderno sgualcito.
Nulla rimane della scolara di Hiroshima,
Ombra confitta nel muro dalla luce di mille soli,
Vittima sacrificata sull’altare della paura.
Potenti della terra padroni di nuovi veleni,
Tristi custodi segreti del tuono definitivo,
Ci bastano d’assai le afflizioni donate dal cielo.
Prima di premere il dito, fermatevi e considerate.
20 novembre 1978
Meleagrina
Tu, sanguecaldo precipitoso e grosso,
Che cosa sai di queste mie membra molli
Fuori del loro sapore? Eppure
Percepiscono il fresco e il tiepido,
E in seno all’acqua impurezza e purezza;
Si tendono e distendono, obbedienti
A muti intimi ritmi,
Godono il cibo e gemono la loro fame
Come le tue, straniero dalle movenze pronte.
E se, murata fra le mie valve pietrose,
Avessi come te memoria e senso,
E, cementata al mio scoglio, indovinassi il cielo?
Ti rassomiglio più che tu non creda,
Condannata a secernere secernere
Lacrime sperma madreperla e perla.
Come te, se una scheggia mi ferisce il mantello,
Giorno su giorno la rivesto in silenzio.
30 settembre 1983
DELEGA
Non spaventarti se il lavoro è molto:
c’è bisogno di te che sei meno stanco.
Poiché hai sensi fini, senti
Come sotto i tuoi piedi suona cavo.
Rimedita i nostri errori:
C’è stato pure chi, fra noi,
S’è messo in cerca alla cieca
Come un bendato ripeterebbe un profilo,
E chi ha salpato come fanno i corsari,
E chi ha tentato con volontà buona.
Aiuta, insicuro. Tenta, benché insicuro,
Perché insicuro. Vedi
Se puoi reprimere il ribrezzo e la noia
Dei nostri dubbi e delle nostre certezze.
Mai siamo stati così ricchi, eppure
Viviamo in mezo a mostri imbalsamati,
Ad altri mostri oscenamente vivi.
Non sgomentarti delle macerie
Né del lezzo delle discariche: noi
Ne abbiamo sgomberate a mani nude
Negli anni in cui avevamo i tuoi anni.
Reggi la corsa, del tuo meglio. Abbiamo
Pettinato la chioma alle comete,
Decifrato i segreti della genesi,
Calpestato la sabbia della luna,
Costruito Auschwitz e distrutto Hiroschima.
Vedi: non siamo rimasti inerti.
Sobbarcati, perplesso;
Non chiamarci maestri.
24 giugno 1986
Ho visto Venere bicorne
Navigare soave nel sereno.
Ho visto valli e monti sulla Luna
E Saturno trigemino
Io Galileo, primo fra gli umani;
Quattro stelle aggirarsi intorno a Giove,
E la Via Lattea scindersi
In legioni infinite di mondi nuovi.
Ho visto non creduto, macchie presaghe
Inquinare la faccia del Sole.
Quest’occhiale l’ho costruito io,
Uomo dotto ma di mani sagaci:
Io ne ho polito i vetri, io l’ho puntato al Cielo
Come si punterebbe una bombarda.
Io sono stato che ho sfondato il Cielo
Prima che il Sole mi bruciasse gli occhi.
Prima che il Sole mi bruciasse gli occhi
Ho dovuto piegarmi a dire
Che non vedevo quello che vedevo.
Colui che m’ha avvinto alla terra
Non scatenava terremoti né folgori,
Era di voce dimessa e piana,
L’avvoltoio che mi rode ogni sera
Ha la faccia di ognuno
(P. Levi, Sidereus Nuncius, 1984)
Mi piacerebbe che in tutte le facoltà scientifiche si insistesse a oltranza su un punto: ciò che
farai quando eserciterai la professione può essere utile per il genere umano, o neutro, o
nocivo. Non innamorarti di problemi sospetti. Nei limiti che ti saranno concessi, cerca di
conoscere il fine a cui il tuo lavoro è diretto. Lo sappiamo, il mondo non è fatto solo di
bianco e di nero e la tua decisione può essere probabilistica e difficile: ma accetterai di
studiare un nuovo medicamento, rifiuterai di formulare un gas nervino.
Che tu sia o no un credente (...) se ti è concessa una scelta non lasciarti sedurre
dall'interesse materiale o intellettuale, ma scegli entro il campo che può rendere meno
doloroso e meno pericoloso l'itinerario dei tuoi compagni e dei tuoi posteri. Non
nasconderti dietro l'ipocrisia della scienza neutrale: sei abbastanza dotto da saper valutare
se da ciò che stai covando sguscerà una colomba o un cobra o una chimera o magari nulla."
(Primo Levi, Per non covare il cobra (1984) , in Opere, Einaudi, p. 993).
Tutti sanno come vive un corsaro, un avventuriero, un medico, una prostituta. Di noi chimici
trasmutatori di materia, un mestiere di ascendenza illustre, non c’è molta traccia e mi sembrava
giusto “turare il buco”. Così è nato Il sistema periodico. E’ indubbiamente una provocazione il
titolo e l’aver dato a ogni capitolo, come titolo, il nome di un elemento. Ma mi sembrava
opportuno sfruttare il rapporto del chimico con la materia, come i romantici dell’800 hanno
sfruttato il “paesaggio”: elemento chimico-stato d’animo, come paesaggio-stato d’animo. Perché,
per chi lavora, la materia è viva: madre e nemica , neghittosa e alleata, stupida, inerte, pericolosa
a volte, ma viva come ben sapevano i fondatori che lavoravano da soli, misconosciuti, senza
appoggi con la ragione e la fantasia.(…) Al mio mestiere devo la vita. Non sarei sopravvissuto ad
Auschwitz, se dopo dieci mesi di dura manovalanza non fossi entrato in un laboratorio, dove ho
continuato a fare il manovale, ma al coperto. (…) E la chimica mi ha fornito argomento per un
libro e per due racconti. Me la sento in mano come un serbatoio di metafore: più lontano è l’altro
campo, più la metafora è tesa. (…) Anche il mio chimico ha dunque una lunga ombra simbolica;
misurandosi con la materia attraverso successi e insuccessi, è simile al marinaio di Conrad, al suo
misurarsi col mare. E’ simile anche ad un cacciatore primitivo. Alla sera quando disegna la
formula di struttura della molecola che domani dovrà costruire, compie lo stesso rito propiziatorio
del cacciatore di Altamira che 50 mila anni fa disegnava sulle pareti delle caverne l’alce o il
bisonte che il giorno dopo avrebbe dovuto abbattere: per appropriarsene, far suo l’antagonista.
Gesti sacrali ambedue. Sono quasi sicuro che l’esperienza del chimico sia la stessa del remoto
passato dell’uomo, guidata dallo stesso intento che lo conduceva a intraprendere la lunga strada
che lo avrebbe portato alla civiltà. (Lo scrittore non scrittore, Conferenza per l’Associazione
Culturale Italiana, 19 novembre 1976)
“Sa, non è per il padrone. A me del padrone non me ne fa mica tanto, basta che mi paghi
quello ch’è giusto e che coi montaggi mi lasci fare alla mia maniera. No, è per via del
lavoro: metter su una macchina come quella, lavorarci dietro con le mani e con la testa
per dei giorni, vederla crescere così, alta e dritta, forte e sottile come un albero, e che poi
non cammini, è una pena: è come una donna incinta che le nasca un figlio storto o
deficiente, non so se rendo l’idea.”
La rendeva, l’idea. Nell’ascoltare Faussone si andava coagulando dentro di me un
abbozzo di ipotesi, che non ho ulteriormente elaborato e che sottopongo qui al lettore: il
termine “libertà” ha notoriamente molti sensi, ma forse il tipo di libertà più accessibile,
più goduto e più utile al consorzio umano, coincide con l’essere competenti nel proprio
lavoro, e quindi nel provare piacere a svolgerlo. (La chiave a stella, Einaudi, Torino,
1978)
Le avevo davanti agli occhi, le mani di Faussone: lunghe, solide e veloci, molto più
espressive del suo viso (…) Mi avevano richiamato alla mente lontane letture darwiniane,
sulla mano artefice che, fabbricando strumenti e curvando la materia, ha tratto dal torpore
il cervello umano, e che ancora lo guida e stimola e tira come fa il cane con il padrone
cieco. (La chiave a stella, Einaudi, Torino, 1978)
La sovrappopsizione di una rudimentale volontà (o iniziativa) della macchina sulla volontà (o
iniziativa) umana: la quale peraltro, nell’atto di guidare attraverso il traffico cittadino, deve in
qualche modo essere debilitata e depressa. Monto acconciamente, a questo proposito, è stato
ricordato dagli autori il “clinamen” degli epicurei..(…)
E’ di pochi giorni addietro l’osservazione di Beilstein, che ha potuto dimostrare e fotografare
tracce evidenti di tessuto nervoso nella tiranteria dello sterzo della Opel-Kapitain: tema che ci
ripromettiamo di trattare diffusamente in un prossimo articolo.
Cladonia rapida in Vizio di forma, ora in P. Levi, Opere, I, a c. di M. Belpoliti, Einaudi, Torino,
1997, p. 445