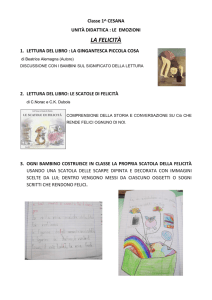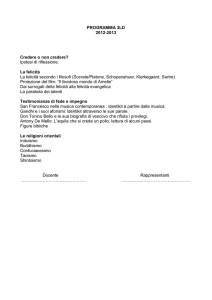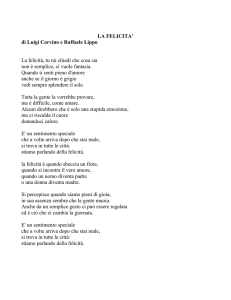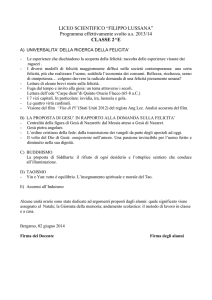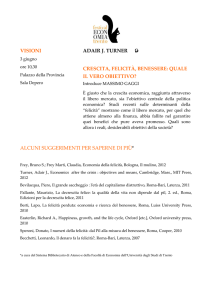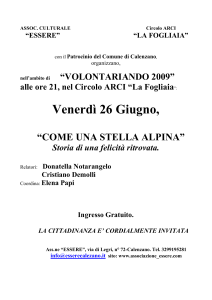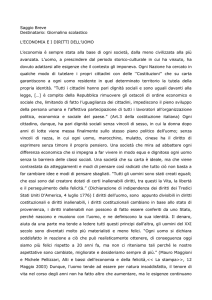L’INFINITA RICERCA DELLA FELICITA’
È utile chiedersi se si è felici?
di Cristiana Bullita
Nella Repubblica, Platone, per bocca di Socrate, disquisisce sulla dimensione sociale della felicità:
«Noi non fondiamo il nostro stato perché una sola classe tra quelle da noi create goda di una speciale felicità,
ma perché l’intero stato goda della massima felicità possibile».
La felicità collettiva garantisce al singolo uno stato di benessere più pieno e durevole di quello promesso dalla
felicità individuale, ma troppo spesso viene sottovalutata. Spetta alla politica, nel senso più alto del termine,
il solo senso che gli è proprio, realizzare il bene comune e quindi favorire una felicità diffusa.
«Nessuno mi può costringere ad essere felice a modo suo (come egli cioè si immagina il benessere degli altri
uomini), ma ognuno può ricercare la sua felicità per la via che a lui sembra buona, purché non rechi
pregiudizio alla libertà degli altri di tendere allo stesso scopo, in guisa che la sua libertà possa coesistere con
la libertà di ogni altro secondo una possibile legge universale (cioè non leda questo diritto degli altri)».
(I. Kant, Sopra il detto comune - questo può essere giusto in teoria ma non vale per la pratica)
In Immanuel Kant felicità e libertà costituiscono un binomio inscindibile, per il singolo e per la società. Una
prima formulazione politica dello stesso binomio è rintracciabile nella Dichiarazione d’indipendenza
americana del 4 luglio 1776, in cui per la prima volta viene esplicitato un «diritto al perseguimento della
felicità», che i coloni non potevano certo concepire sganciato dalla libertà di costituirsi come entità politica
autonoma.
Tuttavia della felicità a noi interessa in particolar modo la dimensione individuale, ed è soprattutto in quella
che il sapere assume una valenza strategica. Nell’Eutidemo di Platone, Socrate asserisce che solo la
conoscenza dà la felicità:
«Poiché tutti desideriamo essere felici, ed è apparso che diveniamo tali usando le cose e servendocene
rettamente e che la scienza è lo strumento che procura il retto uso e la buona fortuna, bisogna, sembra, che
tutti gli uomini in ogni modo s’impegnino in questo, a divenire quanto più è possibile sapienti: o no?».
(Platone, Eutidemo)
Apprendere il “retto uso” delle cose ci rende felici, al contrario dell’abuso e degli stravizi.
Aristotele ripropone il pensiero del maestro e, nella prima parte del Protrettico, sostiene che la felicità si
consegue con la conoscenza della verità. Nel decimo libro dell’Etica Nicomachea ribadisce la tesi con
un’efficace concatenazione argomentativa. La felicità per Aristotele è eudaimonia (letteralmente: essere in
compagnia di un buon demone): uno stato di pienezza spirituale che nulla ha a che vedere con il denaro, con
il piacere dei sensi, con il potere, e che rappresenta il fine essenziale della vita. Esso si consegue con l’attività:
infatti l’azione è preferibile all’inerzia (come, sul piano ontologico, l’esistenza è superiore alla non esistenza).
Tra le attività umane, quella contemplativa è la migliore:
«Infatti è la più alta (giacché l’intelletto è la più alta di tutte le realtà che sono in noi e gli oggetti dell’intelletto
sono i più elevati); inoltre, è la più continua delle nostre attività: infatti, possiamo contemplare in maniera
più continua di quanto non possiamo fare qualsiasi altra cosa».
La felicità ci viene dall’esercizio della «cosa più divina che è in noi», ossia l’intelletto, il quale, impegnato nella
palestra della scienza, genera serenità e pace:
«La filosofia ha in sé piaceri meravigliosi per la loro purezza e stabilità, ed è naturale che la vita di coloro che
sanno trascorra in modo più piacevole che non la vita di coloro che ricercano».
(Aristotele, Etica Nicomachea)
«Non si è mai troppo giovani o troppo vecchi per la conoscenza della felicità», è l’incoraggiante incipit della
lettera di Epicuro a Meneceo. Il filosofo ellenistico, utilizzando argomenti di stringente razionalità, ci spinge
a credere che la paura degli dei, della morte e del dolore sia ingenua e vana e che il piacere sia facilmente
raggiungibile. C’invita alla moderazione e a soddisfare i bisogni naturali e necessari ignorando quelli superflui
e potenzialmente dannosi.
Kant rovescia la morale eudaimonistica di Aristotele e di Epicuro: la felicità non è un fine in sé e il bene sommo
è rappresentato dall’unione di virtù e felicità, che però è inattingibile in questa dimensione spaziotemporale.
Una felicità piena e vera si potrà godere esclusivamente in un aldilà in cui essa sia effettivamente
commisurata alla virtù di ciascuno. La dimensione oltremondana diviene postulato della ragion pratica e
speranza di molti, non solo filosofi.
Per Kant la morale impone non di agire in vista del conseguimento della felicità terrena (pur possibile e, anzi,
auspicabile) ma di seguire il dovere-per-il-dovere, che ci rende degni della felicità:
«È altrettanto necessario ammettere in base alla ragione – rispetto al suo uso teoretico – che ciascuno abbia
diritto di sperare la felicità, nella stessa misura in cui si è reso degno di essa con il suo comportamento, e che
quindi il sistema della moralità sia inscindibilmente congiunto – soltanto però nell’idea della ragione pura –
con quello della felicità».
(I. Kant, Critica della ragion pura)
La felicità a cui Kant allude non può essere frutto di un imperativo ipotetico del tipo: “Rispetta la legge morale,
così sarai felice”. Tale monito è infatti la negazione stessa della morale kantiana che, per sua natura, è
incondizionata e si esplica in un secco tu devi! Nessuna promessa di felicità ci viene da Kant, il quale anzi
osserva che nel nostro mondo virtù e felicità spesso divergono. Tuttavia l’uomo può ragionevolmente
aspirare ad essere felice soltanto se agisce in conformità alla legge morale.
Come si diceva, spesso l’idea di felicità rimanda immediatamente a una dimensione individuale e provvisoria:
siamo felici nel preciso momento in cui constatiamo di aver superato un esame, quando squilla il telefono e
sul display leggiamo proprio quel nome, quando il nostro idolo segna un gol… Si tratta di magici istanti apicali,
di un’ebbrezza tanto intensa quanto fugace.
C’è chi cerca la felicità in un’ingannevole evasione dalla grigia monotonia della provincia:
«Andava ripetendosi: "Ho un amante! Ho un amante!" e questa idea la deliziava come se le avessero
promesso una seconda adolescenza. Finalmente avrebbe posseduto quelle famose gioie che dà l'amore,
quella febbre di felicità che non sperava più di provare».
(G. Flaubert, Madame Bovary)
Emma, subito dopo l’adulterio, scopre nello specchio «occhi tanto grandi, così neri e profondi» che quasi non
sembrano i suoi. Occhi che finalmente rivelano «la felicità raccontata dai poeti», ovvero «quel mondo
meraviglioso ove tutto è passione, estasi, delizia».
Quanto dura questa felicità? A ben guardare, nel pozzo nero di quegli occhi già si scorge l’ombra di un nuovo
dolore, superiore alla gioia che l’illusione d’amore ha saputo generare.
«Si era felici in quel dato momento, infelici due minuti dopo; e, non sempre si era felici o infelici per una
buona ragione […] Certo, c’erano stati momenti in cui si poteva dire: allora ero felice e, con maggiore certezza
ancora: allora ero infelice […] ma tra questi istanti si stendevano intere regioni, le quali non erano che
esistenza. […La felicità era] una parola che non aveva alcun rapporto con l’ingannevole, scaltro, iridescente
gioco della vita. Voler rispondere [alla domanda sulla felicità] era un’impresa disperata, come tentare di
comprimere le acque di un lago dentro una dura sfera solida. Quel lago era la vita […] impossibile da
appallottolare in una sfera dura e solida, tanto piccola da tenersi in una mano: proprio quel che pretendeva
di fare la gente quando voleva sapere a ogni costo se la vostra vita era stata felice o infelice»
(V. Sackville-West, Ogni passione spenta)
Nell’incertezza dell’esistenza si cerca rassicurazione in una formula. Ma la vita è un gioco iridescente che non
ammette semplificazioni binarie. Talvolta nel gusto intenso e unico della felicità ci pare d’individuare una
nota amara, un vago senso di colpa. Oppure gridiamo pazzi di gioia e intanto confidiamo a noi stessi l’assoluta
inconsistenza dell’evento che l’ha scatenata.
«Domandatevi se siete felici e cesserete di esserlo. L’unica soluzione è di considerare obiettivo della vita non
la felicità ma qualche fine esterno ad essa».
(J. Stuart Mill, Autobiografia)
John Stuart Mill sa bene che la vera felicità non ammette individualismi ed egoismi; infatti possiamo sperare
d’incontrarla solo sulla via accidentata che quotidianamente percorriamo inseguendo obiettivi diversi e
condivisi: giustizia sociale, lavoro, cultura. Oltretutto «è sempre una bella cosa poter soddisfare dei desideri
che coincidono con i nostri» (V. Sackville-West). Purtroppo però spesso l’ipocrisia ammanta l’azione di una
magnanimità scadente: non lo fo per piacer mio…
«Ho domandato a Isabelle se era felice:
“Visto che non mi pongo nemmeno la questione, immagino che la risposta debba essere sì”.
In ogni caso, al mattino si sveglia con piacere. Questa mi sembra una buona definizione di felicità”.
[…]
“Sei felice?”
“Ecco, questa è proprio una delle tue domande tipiche. Per me non ha nessun senso.”
“Allora vuol dire che non sei felice”
In tono aggressivo, ha detto:
“La mia vita mi conviene perfettamente”».
(S. De Beauvoir, Una donna spezzata)
Monique interpella l’amica e la figlia a proposito della loro felicità. Evidentemente non ha letto SackvilleWest, e nemmeno Stuart Mill…
La nostra vita “ci conviene perfettamente”? Un’affermazione perentoria in tal senso non potrebbe non
suscitare qualche perplessità. Dunque la felicità è impossibile?
Concludo citando l’ultimo coro dell’Edipo:
«Non far stima
che beato sia veruno degli effimeri, se prima
scevro d'ogni orrido male - non sia giunto al dí fatale».
Non dire di un uomo che è felice finché non è morto. Perché il peggio può sempre accadere. Oppure, perché
non esiste una beatitudine completa e compiuta se non Altrove (ma questa lettura mi pare il flebile sussurro
di una religiosità clandestina).
Perciò noi siamo sempre disposti ad accontentarci di una felicità effimera ed estemporanea, dei brandelli di
gioia che talvolta, del tutto imprevedibilmente, riusciamo a strappare al tempo lento e severo della vita.