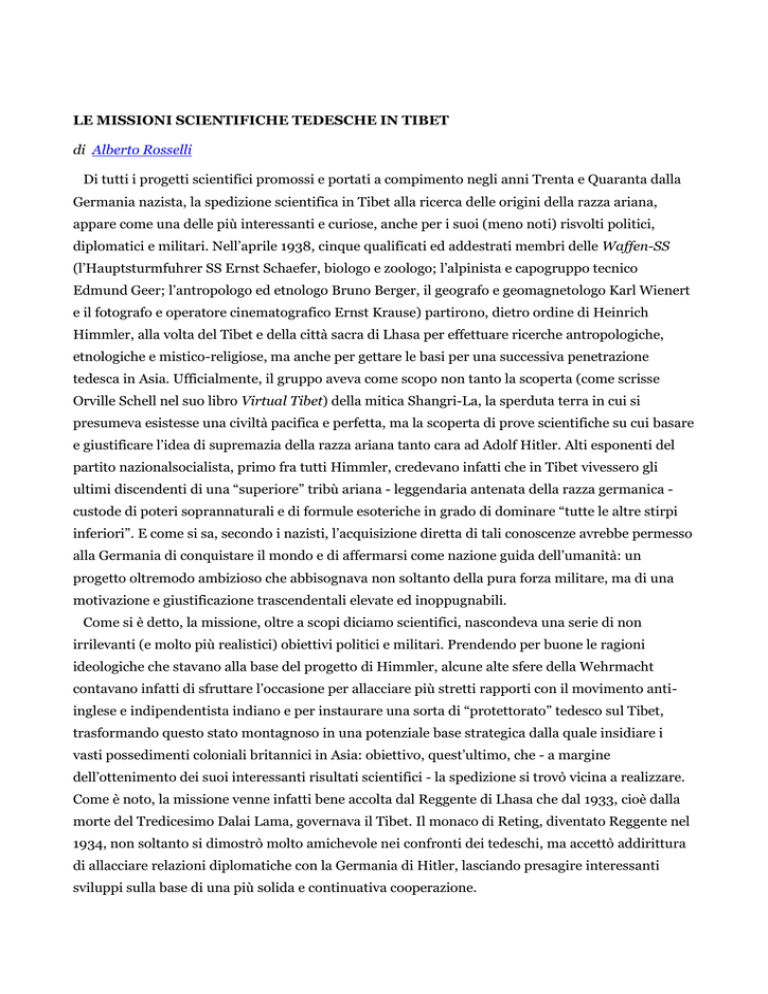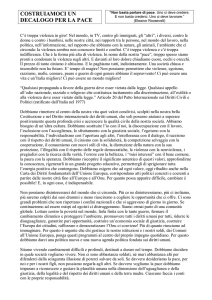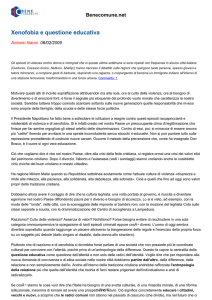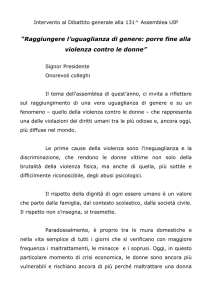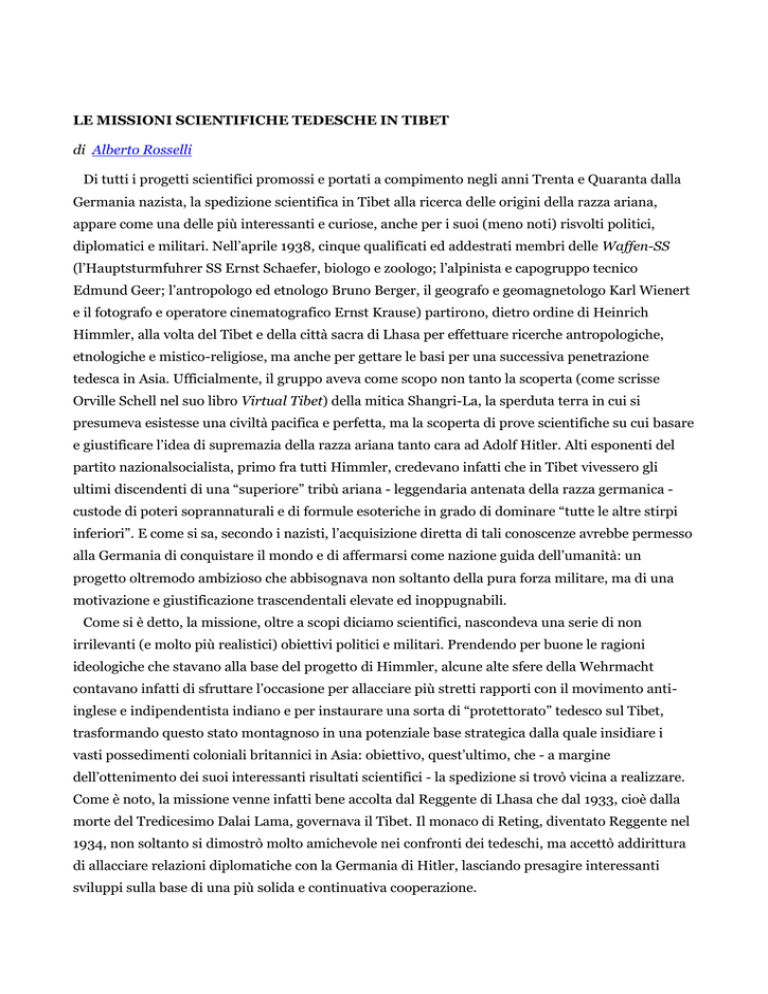
LE MISSIONI SCIENTIFICHE TEDESCHE IN TIBET
di Alberto Rosselli
Di tutti i progetti scientifici promossi e portati a compimento negli anni Trenta e Quaranta dalla
Germania nazista, la spedizione scientifica in Tibet alla ricerca delle origini della razza ariana,
appare come una delle più interessanti e curiose, anche per i suoi (meno noti) risvolti politici,
diplomatici e militari. Nell’aprile 1938, cinque qualificati ed addestrati membri delle Waffen-SS
(l’Hauptsturmfuhrer SS Ernst Schaefer, biologo e zoologo; l’alpinista e capogruppo tecnico
Edmund Geer; l’antropologo ed etnologo Bruno Berger, il geografo e geomagnetologo Karl Wienert
e il fotografo e operatore cinematografico Ernst Krause) partirono, dietro ordine di Heinrich
Himmler, alla volta del Tibet e della città sacra di Lhasa per effettuare ricerche antropologiche,
etnologiche e mistico-religiose, ma anche per gettare le basi per una successiva penetrazione
tedesca in Asia. Ufficialmente, il gruppo aveva come scopo non tanto la scoperta (come scrisse
Orville Schell nel suo libro Virtual Tibet) della mitica Shangri-La, la sperduta terra in cui si
presumeva esistesse una civiltà pacifica e perfetta, ma la scoperta di prove scientifiche su cui basare
e giustificare l’idea di supremazia della razza ariana tanto cara ad Adolf Hitler. Alti esponenti del
partito nazionalsocialista, primo fra tutti Himmler, credevano infatti che in Tibet vivessero gli
ultimi discendenti di una “superiore” tribù ariana - leggendaria antenata della razza germanica custode di poteri soprannaturali e di formule esoteriche in grado di dominare “tutte le altre stirpi
inferiori”. E come si sa, secondo i nazisti, l’acquisizione diretta di tali conoscenze avrebbe permesso
alla Germania di conquistare il mondo e di affermarsi come nazione guida dell’umanità: un
progetto oltremodo ambizioso che abbisognava non soltanto della pura forza militare, ma di una
motivazione e giustificazione trascendentali elevate ed inoppugnabili.
Come si è detto, la missione, oltre a scopi diciamo scientifici, nascondeva una serie di non
irrilevanti (e molto più realistici) obiettivi politici e militari. Prendendo per buone le ragioni
ideologiche che stavano alla base del progetto di Himmler, alcune alte sfere della Wehrmacht
contavano infatti di sfruttare l’occasione per allacciare più stretti rapporti con il movimento antiinglese e indipendentista indiano e per instaurare una sorta di “protettorato” tedesco sul Tibet,
trasformando questo stato montagnoso in una potenziale base strategica dalla quale insidiare i
vasti possedimenti coloniali britannici in Asia: obiettivo, quest’ultimo, che - a margine
dell’ottenimento dei suoi interessanti risultati scientifici - la spedizione si trovò vicina a realizzare.
Come è noto, la missione venne infatti bene accolta dal Reggente di Lhasa che dal 1933, cioè dalla
morte del Tredicesimo Dalai Lama, governava il Tibet. Il monaco di Reting, diventato Reggente nel
1934, non soltanto si dimostrò molto amichevole nei confronti dei tedeschi, ma accettò addirittura
di allacciare relazioni diplomatiche con la Germania di Hitler, lasciando presagire interessanti
sviluppi sulla base di una più solida e continuativa cooperazione.
Ma a questo punto occorre fare un passo indietro per mettere in luce le motivazioni profonde che
ben prima della missione del 1939 avevano spinto diversi studiosi tedeschi a ricercare gli antichi e
presunti legami culturali e le affinità elettive che a loro parere univano i destini di due popoli
apparentemente tanto distanti come quello tibetano e germanico.
Già a partire dai primi anni Trenta, i nazisti avevano iniziato a mutuare dalla antica civiltà
indiana - per i loro cerimoniali - simboli e linguaggi di particolare significato, appropriandosene e
adoperandoli per giustificare e motivare la loro oscura e in qualche modo bizzarra filosofia politica
ed esoterica pangermanica a sfondo razziale. Non a caso, Hitler, fino dai suoi primi scritti, aveva
innalzato il termine “ariano” (parola derivante dal sanscrito arya, che significa “nobile”) ad
attributo unico ed intangibile di una stirpe e di una cultura germanica pagana antecedente per
contenuti gloria e meriti a tutte le altre. Nei Veda, le antiche scritture indu, il termine “ariano” si
riferisce infatti ad una razza dalla pelle chiara proveniente dall’Asia Centrale che in epoche molto
remote riuscì a soggiogare le popolazioni dalla pelle più scura (i Dravidiani) abitanti il vasto
subcontinente indiano. Ma ben prima dell’avvento del nazismo, alcuni studiosi tedeschi ed europei
avevano sostenuto diverse ipotesi al riguardo. Tra il 2000 e il 1500 a.C. una migrazione multi
direzionale di un popolo indo-europeo dell’Asia centrale si sarebbe mossa verso l’India e l’Europa
portando con sé i germi di una cultura superiore: supposizione destinata, successivamente, ad
infiammare le menti degli studiosi nazisti che, tuttavia, non riuscirono mai a dimostrare che queste
tribù indo-europee fossero in realtà gli “ariani” già citati dai famosi Veda.
Tra l’Ottocento e i primi del Novecento noti personaggi, fra cui Joseph de Maistre e Joseph
Arthur de Gobineau, cercarono (seppure attraverso teorie e tesi diverse), di manipolare il mito di
una pura razza ariana dalla pelle chiara, vantandone la superiorità e trasferendone i requisiti in
quella nordica e tedesca. Non a caso fu proprio l’identificazione tra gli ariani del secondo millennio
a.C. e il popolo tedesco a conferire agli alfieri del nazionalismo tedesco la convinzione che la
Germania fosse l’unica nazione al mondo ad avere diritto ad affermarsi con la forza sugli altri
popoli. Le teorie circa la supremazia della razza ariana contribuirono di conseguenza a fomentare
tra i tedeschi non soltanto l’antisemitismo (inteso come avversione al “diverso” non soltanto sotto
l’aspetto religioso, ma anche nel contesto di una contrapposizione discriminante etnico-biologica),
ma anche ogni altra sorta di reazione xenofoba, intesa come la repulsione contro altre “razze
etnicamente e moralmente inferiori” - vale a dire quella slava - per non parlare delle cosiddette
minoranze nomadi (gli zingari), fino ad arrivare a temere uno sconveniente “contagio di sangue”
anche da parte dei popoli latino-mediterranei.
Nel 1890, E. B. Lytton, un appartenente al movimento Rosacroce, scrisse un libro, che ebbe
notevole diffusione, circa l’ipotesi dell’esistenza di un’energia cosmica (particolarmente spiccata
negli individui di sesso femminile) chiamata Vril. Lytton parlò anche di una misteriosa società Vril:
un’aggregazione razziale fantastica formata da super-esseri umani che un giorno sarebbero emersi
dai loro nascondigli sotterranei per governare il mondo. L’immaginazione dello scrittore coincideva
con il diffuso interesse per l’occulto che i quell’epoca caratterizzava la vita culturale di certa
aristocrazia europea. Non a caso, sia in Germania che in altre nazioni europee erano fiorite molte
società segrete il cui scopo era appunto quello di aprire la strada, attraverso l’ideologia dell’occulto
e alla propaganda pagana, alla riscoperta di una fantomatica razza superiore prossima ad
esercitare, legittimamente, il suo sacro ed assoluto potere su tutta la terra. Si andava dalle sette
devote al Santo Graal a quelle che predicavano curiosi rituali infarciti di sessualità pagana, di
misticismo e di dedizione alle droghe, sull’onda di un diffuso revival delle credenze di derivazione
buddista e indù. Insomma, il misticismo esoterico nazista non era nato dal nulla, ma affondava le
sue radici più profonde in una tradizione culturale europea piuttosto consolidata che trovò nei
circoli politici e militari tedeschi molti adepti e promotori. Basti pensare al generale Karl
Haushofer (che sarebbe diventato uno dei sostenitori di Hitler) e alla sua setta esoterica Vril. Lo
scopo principale della società fondata da Haushofer (chiamata Vril in onore di Lytton) era quello di
approfondire gli studi sulle origini della razza ariana attraverso complicati lavori di interpretazione
dottrinale e curiosi cerimoniali ed iniziazioni a sfondo magico. I membri della setta, che
praticavano la meditazione per risvegliare negli adepti l’energia cosmica femminile di Vril,
pretendevano di avere diretti collegamenti con i lontani maestri tibetani, e di potere attingere a
distanza il loro sapere occulto attraverso dei medium, come la celebre Madame Blavatsky (la russa
Helena Petrovna Han), una teosofista che assicurava di essere in perenne contatto telepatico con
non specificati sacerdoti himalayani. Nel 1919, dalla società Vril ne scaturì una seconda, la Thule,
che venne fondata a Monaco dal barone Rudolf von Sebottendorf, un seguace della Blavatsky. La
società di Thule conservava il credo e le tradizioni di vari e differenti ordini e credo religiosi, tra cui
i gesuiti, i templari, l’Ordine dell’Alba d’oro, e il sufismo. La setta promosse il mito di Thule,
un’isola leggendaria (di essa ne avevano già parlato esploratori greci, come Pitea di Massilia,
l’antica Marsiglia) ubicata nel profondo Nord e un tempo popolata dalla razza padrona degli
“ariani”. Come nella leggenda di Atlantide (con la quale taluni studiosi hanno talvolta ricercato
comuni identità), in epoche remotissime gli abitanti di Thule erano stati costretti a fuggire in
seguito ad una spaventosa catastrofe sismica. Tuttavia, alcuni sopravvissuti, rifugiatisi nelle viscere
dei monti himalayani, erano riusciti a conservare e a tramandare ai posteri i loro magici poteri. Da
qui l’idea, coltivata da von Sebottendorf e dai suoi seguaci, di cercare un contatto, diretto o
medianico, con questa straordinaria razza. Con il passare del tempo, la Società di Thule aggiunse
una forte carica ideologica e politica ai suoi intendimenti esoterici, sfociando in un vero e proprio
movimento di opinione che negli anni Trenta si sarebbe poi fuso nell’ideologia nazista. Insieme con
il pugnale e le foglie di quercia, gli associati alla Thule vollero adottare come insegna guida la
svastica, simbolo di origine indiana che era stato adoperato anche dai primi gruppi neo-pagani
tedeschi. Gli associati credevano che la svastica fosse un “segno” riconducibile all’arianesimo,
sebbene nel corso dei secoli esso fosse stato usato da svariate culture e religioni. Nel corso delle sue
ricerche, il generale Haushofer (che fece anch’egli parte della Società di Thule) visitò più volte
l’Estremo Oriente. E il suo ardore nello studio indusse i vertici di Berlino a nominarlo addetto
militare a Tokyo per consentirgli un più lungo e stabile soggiorno in Asia. E’ verosimile che in
Oriente il generale abbia potuto acquisire nozioni del buddismo zen, molto diffuso nella casta
militare giapponese, e altre conoscenze di tipo religioso, etnico e antropologico. Va ricordato che i
primi studi tedeschi sul buddismo ipotizzavano l’idea di un puro, originale credo buddista perduto,
mettendo in guardia gli ariani dal cosiddetto “buddismo degenerato” e contaminato da credenze
spurie che continuava a sopravvivere all’originale. Tuttavia, sembra che il fattore “buddismo”
rivestisse nel programma studi della società Thule un ruolo di semplice elemento esotico
ornamentale, almeno se rapportato al credo della mitologia tibetana, la cui conoscenza
rappresentava l’obiettivo ultimo di una setta impaziente di dimostrare al mondo la reale esistenza
di un “mondo sotterraneo” himalaiano e quella dei sopravvissuti della mitica razza di Thule.
Alla confraternita Thule aderirono noti personaggi politici nazisti, tra cui Rudolf Hess, Heinrich
Himmler e quasi certamente lo stesso Hitler. Himmler abbracciò fin da subito il credo neopagano
della Thule, promuovendo nuove cerimonie mistiche ed arrivando a credere (secondo tradizione
indiana) di essere addirittura la reincarnazione di un re germanico del decimo secolo: nota era
infatti la sua venerazione nei confronti di Enrico I l’Uccellatore nel quale si identificava. Sembra
che il Reichsfuhrer SS fosse praticamente certo che nel sottosuolo del Tibet potessero essere
ritrovate tracce degli antichi ariani dotati di poteri sovrumani e paranormali. D’altra parte, al
tempo in cui Hitler scrisse il Mein Kampf, in Germania il mito della razza ariana era già fortemente
radicato. In un capitolo della sua opera (il XI, “Razza e Popolo”) il futuro dittatore espresse molta
preoccupazione per la continua contaminazione etnica alla quale era sottoposto il popolo tedesco.
Secondo Hitler, la pura razza ariana tedesca era stata corrotta dal prolungato contatto con il popolo
ebraico. Per Hitler, l’unica difesa contro questa commistione forzata era quella di trovare una
“fonte perenne di sangue ariano”. Alla luce di questa sua ossessiva apprensione, l’idea o meglio il
progetto di avviare un contatto con le popolazioni tibetane appariva anche a Hitler come una vera e
propria necessità. E’ da notare che, proprio per sostenere una politica di sviluppo delle ipotesi
“ariane”, il 1° luglio 1935 lo stesso Himmler (illuminato dalla lettura dell’opera del filologo e
studioso olandese di simbolismi protostorici Herman Wirth) decise di fondare - in collaborazione
con lo stesso Wirth e con Richard Walter Darré - la Deutsches Ahnenerbe - Studiengesellschaft fur
Geistesurgeschichte (Eredità tedesca degli antenati - Società di Studi per la Preistoria dello Spirito)
a capo della quale mise l’Obersturmbannfuhrer SS Wolfram Sievers, che dopo la seconda guerra
mondiale verrà processato a Norimberga. Una curiosità. E’ da notare che una delle 52 sezioni
“scientifiche” della Società si occupava degli studi esoterici e aveva tra i suoi consulenti eminenti
personaggi come Ernst Junger ed altri, completamente estranei, anzi avversi, alla cultura nazista,
tra cui il filosofo ebreo Martin Buber esperto in metafisica pura. Ciò non deve stupire più di tanto
poiché oltre alle ricerche sulla perduta Thule, sulla proto-cultura ariana e indiana, la Ahnenerbe si
occupava anche di analisi e rielaborazioni di miti, ordini e ordinamenti religiosi e culturali di varia
natura e origine, tra cui il simbolismo nordico dell’Arpa Irlandese e le credenze dei Veri Rosacroce
(ovvero dei gruppi iniziatici ancora in possesso della tradizione integrale dei Templari). Perfino gli
insegnamenti della Bibbia e della Kabala ebraica vennero setacciati per coglierne il senso
nascosto…e nella speranza (vana) di trovare giustificazioni ai concetti di razza eletta e di eredità di
razza. A tutti i membri dell’Associazione era richiesta una profonda erudizione in campo
linguistico, antropologico, geografico archeologico e cosmologico ed anche una buona conoscenza
delle metodologie Yoga e Zen considerate essenziali per penetrare determinati misteri meta-politici
e metafisici. “Ma oltre agli studi teorici - riporta André Brissaud nel suo Hitler et l’Odre Noir l’Associazione di Himmler fu molto attiva nel campo delle tradizionali spedizioni scientifiche: tra il
1935 e il 1939 ne organizzò più di 100, soprattutto in Asia, ma anche in Europa Orientale e America
del Sud, per effettuare ricerche archeologiche e studiare usi e costumi di sperdute tribù o di gruppi
etnici presumibilmente eredi di antichissime culture ormai estinte.
Nel 1938, la Ahnenerbe organizzò la prima, grande missione in Tibet, affidandone il comando al
Hauptsturmfuhrer SS Ernst Schaefer che, tra il 1930 e il 1932 e tra il 1934 e il 1936, aveva
partecipato a diverse spedizioni esplorative sia in territorio tibetano che cinese. Scopo ufficiale e in
parte autentico della spedizione era lo studio della regione e della popolazione tibetana, anche se in
realtà i nazisti avevano in mente di venire a contatto diretto con il monaco di Reting diventato
Reggente un anno dopo la morte del 13° Dalai Lama (il 14° Dalai Lama, quello attuale, nel 1938
aveva appena tre anni e sarebbe stato insediato sul trono soltanto nel 1940).
La spedizione nazista partì per nave nel maggio 1938 dal porto di Genova e circa un mese più
tardi giunse a Colombo (ex Ceylon), per poi proseguire per Calcutta, dove trovò ad accoglierla una
diffamante campagna stampa orchestrata dal governatore britannico, preventivamente istruito da
Londra (da tempo al corrente dei piani di Himmler) per creare ostacoli alla missione scientifica
tedesca. E’ da notare che nel 1935, a Calcutta, era comparsa dal nulla una rivista “culturale”, The
New Mercury, pubblicata da Sri Asit Krishna Mukherji e Sri Vinaya Datta, che sposava in qualche
modo le teorie naziste propagandate dalla Ahnenerbe. Come annota Savitri Devi nel suo L’India e il
Nazismo, la suddetta testata pubblicava ricerche su tutto ciò che poteva servire a mettere in luce
una connessione profonda, non necessariamente politica, tra la civiltà indù e quella germanica
“esistita ben prima del Cristianesimo”. Gli imbarazzanti e pericolosi contenuti del periodico
(sostenuto sottobanco dai tedeschi tramite il console generale a Calcutta Herr von Selzam) avevano
destato non poche apprensioni tra le alte sfere britanniche che, nel 1937, avevano provveduto a
sequestrare e a chiudere il The New Mercury, considerandolo uno strumento propagandistico filonazista. Senza considerare che proprio in quegli anni, il Governatorato britannico iniziava ad
affrontare la politica secessionista e filo-tedesca e filo-giapponese del carismatico leader
nazionalista indiano Shubas Chandra Bose intenzionato - al contrario di Gandhi, indipendentista
anch’egli, ma avverso all’Asse - a fomentare una grande rivolta per cacciare gli inglesi dal suo
paese.
Ma ritorniamo alla spedizione. Dopo avere ottenuto, fra mille difficoltà, il visto dalle autorità
anglo-indiane per potere soggiornare sei mesi nel Sikkim (il piccolo stato himalayano porta di
accesso naturale al Tibet), ai primi di luglio Schaefer e i suoi compagni radunarono una colonna
composta da 50 muli e da una decina di portatori, e con circa due tonnellate e mezzo di materiali e
attrezzature da campo partirono alla volta della grande e quasi inesplorata catena montuosa. Da
Gangtok, capitale del Sikkim (il cui maharaja accolse molto amichevolmente la spedizione.
Atteggiamento verosimile in un’epoca in cui molte tribù indù vedevano nell’ateo e “ariano” Hitler
un avatara - cioè un “protetto o iniziato” - di Vishnu) la colonna proseguì faticosamente per due
settimane in direzione nord, lungo stretti e ripidi sentieri frequentemente interrotti da frane e
dalle piene dei fiumi e dei torrenti ingrossati dai monsoni, fino a raggiungere la località di Thanggu
a quota 4.500 metri. Nei pressi di Gayokang, i tedeschi installarono il loro primo campo in altura,
proprio alle pendici del massiccio del Kangchenjunga, la cui cima raggiunge i 8.585 metri. Dopo
alcune settimane trascorse a studiare il territorio e le popolazioni della zona, ai primi di agosto
Schaefer e i suoi uomini vennero contattati dal principe tibetano di Doptra che li ospitò nella sua
residenza estiva assicurando ai tedeschi una scorta per raggiungere la città santa di Lhasa. Prima di
partire la spedizione effettuò però alcune ricerche zoologiche e antropologiche nella regione
montuosa del Sikkim, raccogliendo molto materiale, scattando centinaia di fotografie e filmando
centinaia di pellicola. Il 1° dicembre, infine, Schafer e i suoi compagni vennero a sapere che il
Reggente del Tibet aveva loro concesso di trascorrere due settimane a Lhasa, località che la colonna
tedesca (di cui faceva parte anche un alto ufficiale Sikkim) guadagnò dopo una lunga e faticosa
marcia il 19 gennaio 1939. Qui Schafer venne ricevuto dalle massime autorità tibetane e dal
maestro spirituale del Dalai Lama. Quest’ultimo, infatti, non era presente alla cerimonia in quanto,
data la sua giovanissima età (appena quattro anni) si trovava ancora nel suo villaggio situato nella
zona di Amdo. Lo storico incontro tra i membri della spedizione della Ahnenerbe e i dignitari locali
venne accuratamente documentato da una serie di fotografie e da alcune decine di metri di
pellicola. Era il momento che Schafer, Wienert, Berger, Krause e Geer attendevano da tempo. Per
loro si schiudeva infatti l’opportunità di stabilire con i tibetani un rapporto di amicizia e di
interscambio culturale onde verificare la validità delle ipotesi antropologiche elaborate in
Germania dai sostenitori delle teorie “ariane”. Senza considerare che prima di loro soltanto
pochissimi esploratori stranieri avevano avuto accesso alla “città proibita” himalayana. Come era
accaduto a Gangtok, dove avevano assistito alla “Danza di guerra degli Dei”, ai tedeschi venne
offerta l’occasione, assai rara, di partecipare alle celebrazioni del Capodanno lamaista, di effettuare
visite a tutti i templi della zona (tra cui quello di Potala) e di svolgere approfonditi studi sulle
caratteristiche etniche ed antropologiche della popolazione locale. I tibetani consentirono anche di
effettuare indagini sui minerali, sulla flora e sulla fauna della regione, a condizione però che per
l’abbattimento di alcune specie di uccelli non venissero usate armi da fuoco: divieto che Schafer
aggirò costruendo una grossa fionda con la quale abbatté alcuni esemplari. Sembra che tra gli scopi
scientifici della spedizione vi fosse anche la ricerca dell’Abominevole uomo delle Nevi (ovvero lo
Yeti): misterioso quadrumane di montagna che tuttavia non venne mai avvistato o catturato.
Durante le due settimane di permanenza i rapporti tra tedeschi e tibetani si strinsero al punto da
indurre i dignitari a prorogare il rientro della spedizione di Schafer fino al 19 marzo: opportunità
che consentì agli uomini della Ahnenerbe di approfondire ulteriormente le proprie conoscenze
sulla città di Lhasa e sul territorio circostante. La pattuglia, guidata da un dignitario, lasciò la “città
proibita”, ridiscese a valle e raggiunse l’avamposto inglese di Gyangtse, dopodiché Schafer esplorò
le rovine dell’antica capitale Jalung Phodrang (ormai disabitata da mille anni) e il 25 aprile, dopo
una marcia di 600 chilometri, arrivò a Shingatse, laddove risiede il nono Panchen Lama. Anche in
questa località, nei cui pressi si trova il monastero di Tashi Lhunpo, i tedeschi vennero accolti
molto bene, al punto che il Panchen Lama Ch kyi Nyima accettò di firmare un trattato di amicizia
con la Germania. Ma ormai per il gruppo di Schafer era giunta l’ora del rientro in patria. E il 19
maggio 1939, la pattuglia fece ritorno a Gyangtse, carica di diari e quaderni zeppi di informazioni
ed appunti e casse contenenti un numero incredibile di fotografie (circa 20.000), più 16.000 metri
di pellicola cinematografica in bianco e nero, duemila a colori, un gran quantitativo di materiali
agricoli, attrezzature e vestiario del luogo e ben 108 volumi di scritture buddhiste donate dal
Reggente di Lasha alla Germania di Hitler. Oltre a ciò, la missione portò con sé circa 4.000 uccelli
impagliati, cinquecento teschi di animali (taluni dei quali molto rari), alcuni esemplari di
quadrupedi di montagna vivi, piante e semi di ogni genere. Dopo avere superato i meticolosi
controlli inglesi, la colonna, composta da decine e decine di muli e portatori, ridiscese la catena
himalayana e raggiunse Calcutta da dove si imbarcò alla volta di Atene. Il 4 agosto 1939, la
spedizione - giunta a Monaco di Baviera dalla Grecia in aereo - venne accolta all’aeroporto da
Himmler e da una folta delegazione di partito. Nonostante le notevoli scoperte scientifiche
compiute dal gruppo, il risultato della missione lasciò però abbastanza insoddisfatto l’entourage del
capo delle SS che si aspettava risultati più interessanti, soprattutto sotto il profilo dell’indagine
“misterica”. Nessuno dei reperti e delle prove raccolte e catalogate con rigore e precisione dalla
spedizione poterono infatti confermare l’esattezza delle ipotesi “razziali” che negli anni precedenti
avevano galvanizzato la mente di così tanti (e qualificati) studiosi tedeschi, accecati dal credo
“ariano” e da quello nazista.
Contestualmente all’impresa di Schafer, va ricordato che, nel maggio del 1939, una seconda più
piccola spedizione tedesca condotta in Himalaya, in direzione del Nanga Parhat (metri 8.114), non
ebbe la medesima fortuna di quella di Schafer . Il 3 settembre di quell’anno, una colonna, guidata
da Peter Aufschneiter e dal campione dei giochi invernali olimpici del 1926, Heinrich Harrer, venne
sorpresa dallo scoppio della guerra spalancando ai due esploratori tedeschi i cancelli di un campo
di concentramento inglese in India settentrionale. Evasi nel 1944, dopo una rocambolesca fuga in
direzione dell’Himalaya, Aufschneiter e Harrer riuscirono però a raggiungere il Tibet e la città di
Lasha dove ottennero asilo. Nel 1951, dopo l’invasione del Tibet da parte delle armate cinesi
comuniste di Mao Tse Tung, Harrer fece ritorno a Vienna, sua città natale, mentre il suo compagno,
che nel frattempo si era sposato con un’indigena, preferì fermarsi nella remota regione asiatica.
Come è noto, qualche anno fa la vicenda di Aufschneiter e di Harrer è tornata agli onori della
cronaca attraverso la trasposizione romanzata del film “Sette anni in Tibet” del regista francese
Jean-Jacques Annaud.
Il mein kampf di Adolf Hitler
un documento storico notevole per comprendere l’epoca e le caratteristiche del
movimento fondato dal suo autore
di Luciano Atticciati
Gli anni giovanili di Hitler rappresentano qualcosa di particolarmente significativo per la
comprensione del periodo fra le due guerre. Hitler passò quegli anni a Vienna in condizioni di
grave difficoltà economica nonostante che la sua famiglia non fosse esattamente povera, una
condizione che sicuramente contribuì ad accumulare un odio profondo verso la società, la classe
borghese e le sue istituzioni. Di quel periodo il futuro führer scriverà: "il ricordo più' triste e
infelice che ho di Vienna è ricordare quella gente felice di Vienna". Dobbiamo inoltre ricordare
che Hitler era un pittore, e la sua formazione culturale quella dell’artista, e quindi una persona
tendente all’irrazionalismo con un temperamento portato a confondere il mondo della fantasia con
quello della realtà. I due elementi costituiranno una miscela come sappiamo molto pericolosa.
Hitler avrebbe potuto essere un simpatizzante dell’estrema sinistra, ma la sua origine non operaia,
sicuramente contribuì a tenerlo lontano da quella area politica. L’interesse per la politica nacque
abbastanza avanti con l’età, a trent’anni, fortemente colpito dalla sconfitta della Germania, che
come molti attribuì all’opera di tradimento di alcune categorie importanti della nazione fra le quali
la borghesia ebraica. Hitler aderì al Partito dei Lavoratori Tedeschi, un partitino abbastanza
singolare che univa al socialismo l’idea nazionalista, il programma politico del 1920 parlava infatti
di una “grande Germania”, dell’attribuzione di tutte le cariche dello stato ad autentici tedeschi, ma
anche di “statizzazione di tutte le imprese associate”, di un potere centrale forte, di assistenza
pubblica, e stabiliva che “L’attività del singolo non deve urtare contro gli interessi della comunità
ma deve applicarsi nel quadro della collettività e per il bene di tutti”. Il programma prevedeva
l’eliminazione del parlamentarismo, la soppressione di molte libertà, e infine un punto abbastanza
singolare che stabiliva la sostituzione del diritto romano con quello comune germanico,
l’eliminazione in pratica dell’ordinamento giuridico fondato sull’individuo. Interessante notare che
nel mein kampf Hitler ricorda che i nazisti avevano preso in considerazione l’idea di dare al partito
la denominazione di partito social-rivoluzionario.
Grazie alle sue grandi capacità di teatralità e di trascinatore Hitler riuscì a prendere le
redini del partito e a portarlo ad una notevole crescita di adesioni. Nel 1923 creò sconcerto la sua
presa di posizione sulla occupazione francese della Ruhr; mentre buona parte dell’opinione
pubblica e dei movimenti politici di destra manifestavano il loro senso di patriottismo, Hitler
contestava la classe dirigente del paese. Sempre in quell’anno tentò una grande iniziativa,
comunicò che era in atto un colpo di stato a Monaco (in realtà un’iniziativa non condivisa dagli altri
gruppi della destra bavarese) e invitò la gente a manifestare per le strade, si trattò sostanzialmente
di una farsa, e la polizia non trovò particolari difficoltà a fermare i manifestanti. Hitler venne
arrestato. Proprio durante la detenzione iniziò a scrivere la sua opera principale, il mein kampf,
terminata due anni dopo. I temi trattati dal libro sono numerosi, e tutti significativi, la razza, le
ragioni della disfatta tedesca, la creazione del partito nazista, l’importanza della propaganda e di
altri elementi organizzativi che sembrano ripresi dalle organizzazioni di massa della sinistra. Si
parlava inoltre delle nefandezze della borghesia, dell’ebraismo e del marxismo. Il libro al di là del
suo contenuto ideologico costituisce un documento storico notevole che contiene importanti
informazioni per capire il programma nazista, la personalità del suo autore, come anche
informazioni sulla lotta politica in quegli anni, e sui limiti dei tradizionali partiti di destra. L’opera
inoltre è abbastanza rappresentativa della sua epoca, la sua esposizione è confusionaria e
addirittura contradditoria (si parla di una alleanza con l’Italia e insieme della necessità di togliere a
questa nazione l’Alto Adige), ma anche altamente suggestiva ed efficace. In un periodo
profondamente turbato come quello in cui è stata scritta l’opera, con i tentativi insurrezionalistici
dell’estrema sinistra, la rovina economica del ceto medio a causa dell’inflazione, e l’umiliazione
tedesca provocata dalla occupazione della Ruhr, un’opera del genere non poteva passare
inosservata. L’elemento irrazionale giocò un ruolo notevolissimo nel successo personale dell’autore
e del suo movimento, le testimonianze di Albert Speer che ammise i suoi limiti in materia politica e
la sua ammirazione esaltata per quell’uomo, e quella simile di Rudolf Höss, confermano tale
situazione.
La società ideata da Hitler è una società chiusa, non solo la nazione costituiva una
entità a sé stante, come nel tradizionale nazionalismo, ma la nazione non ammetteva
differenziazioni al suo interno, e si identificava strettamente con una razza. Una razza compatta
dove gli uomini si sentivano profondamente legati fra loro, e dove c’era poco spazio per le iniziative
personali, una specie di comunismo, sia pure sui generis e antiprogressista. “Se il popolo tedesco,
nella sua evoluzione storica, avesse avuto quell’unità di gruppo che ebbero altri popoli, oggi il
Reich tedesco sarebbe padrone del mondo” scrisse parlando del mondo come si presentava allora.
Un’altra caratteristica che avvicina l’autore del mein kampf ai pensatori comunisti era la tendenza
all’utopismo, ciò che si proponeva non era un semplice cambiamento politico ma un cambiamento
della natura umana, la distruzione di un mondo per arrivare alla creazione di un nuovo mondo
caratterizzato da una società perfetta. Come altri pensatori utopisti Hitler riteneva che fosse esistito
un periodo d’oro dell’umanità, in cui gli uomini non si preoccupavano di problemi materiali ma di
migliorare le proprie qualità morali. Tale opinione era stata anche messa in luce dal sociologo
tedesco Emil Lederer, il quale affermava che per molti dei suoi fondatori, il nazismo era “un’utopia
nella quale il bene comune sarebbe venuto prima di ogni interesse egoistico”. Hitler era cosciente
che la sua idea di eliminare certe aspirazioni nell’essere umano, (fra le quali la brama del denaro), e
rendere l’uomo pienamente disciplinato era un obbiettivo non raggiungibile che lo esponeva alle
critiche, e scrisse “Non si affermi che questo è uno stato ideale che non si può attuare in realtà, e
non si attuerà mai”.
In realtà lo spazio dedicato nell’opera alla razza ariana non è molto, maggiore è quello
sulla questione ebraica. Dalla lettura del libro risulta difficile comprendere le ragioni dell’odio
verso quel popolo. Gli ebrei sono oggetto di molte accuse, ma non vi sono argomenti razionali o
prove concrete a supporto. Gli ebrei, che a volte si confondono con la classe borghese in generale,
sarebbero infidi, controllerebbero la stampa e una parte notevole della finanza, infine sarebbero i
fautori del bolscevismo, oltre che componenti della “tenaglia giudaico-massonica”. In certe parti
dello scritto il tono contro gli ebrei raggiunge livelli apocalittici, gli ebrei sarebbero “il meschino
nemico del mondo vera causa di tutte le disgrazie” e si ricorda che “l’ebreo non riesce a
organizzare ma soltanto a mettere caos”. In certe parti del libro si arriva ad una curiosa serie di
affermazioni prive di senso, gli ebrei fomenterebbero la lotta fra cattolici e protestanti, sarebbero
dietro anche ai contrasti costituzionali del 1919 sul federalismo della nuova nazione tedesca,
mentre in altra parti Hitler sosteneva che “l’ebreo faceva il comodo suo e vendeva la nostra patria
e la nostra libertà nell’alta finanza internazionale… queste sanguisughe del popolo traviano le
nostre bionde e inesperte fanciulle, distruggendo qualcosa di irreparabile”.
In molte parti il mein kampf appare come lo scritto di un agguerrito oppositore del
capitalismo. Rivolgendosi ai borghesi Hitler scrisse: “Per voi c’è un unico pensiero: la vostra
esistenza personale, e un unico Dio: il vostro denaro! Ma noi non ricorriamo a voi, ma alla
grande schiera di quelli che sono poveri poiché la loro esistenza esprima la più grande felicità
della terra, a quelli che onorano non il denaro, ma altri Dei, ai quali dedicano la loro vita”. In
altre parti si accenna ad una certa eguaglianza delle retribuzioni, ed infine si afferma: “Gia
nell’animo dei giovani bisogna imprimere la cognizione del profondo legame del nazionalismo col
sentimento della giustizia sociale”.
Il pensiero politico di Hitler appariva spesso confusionario, dove invece risultava
lucido e metteva in luce la sua originalità, era sulla questione della organizzazione di partito e sui
limiti dei partiti borghesi, qualcosa che influirà molto sul successo del suo movimento. I partiti di
destra in Germania come nel resto d’Europa erano ancora legati ad un modo di fare politica
ottocentesco, fatto di notabili riconosciuti per la loro professionalità, il loro equilibrio e il loro senso
dello stato. Le organizzazioni di massa con i loro slogan e i loro apparati propagandistici erano una
caratteristica della sinistra che non trovava riscontro nelle altre formazioni politiche, e dopo la
prima guerra mondiale con la sua grande mobilitazione di popolo, tale situazione costituiva un
grave limite. Interessante su questo tema l’opinione del sociologo tedesco Emil Lederer: “L’aspetto
nuovo decisivo portato dal fascismo – in Italia non dal principio, ma gradualmente; in Germania
invece fin dal suo inizio – è che esso si basa sulle masse… Se un sistema politico si fonda sulle
masse, come nel caso delle dittature moderne, il primo passo che compie è la creazione di un
apparato di propaganda come istituzione statale, cosa che nessun altro Stato, né assoluto né
democratico, avrebbe fatto”. Mussolini, ex leader del socialismo rivoluzionario e Adolf Hitler,
furono i leader che trapiantarono a destra i sistemi politici dell’estrema sinistra, di cui la
mobilitazione delle masse costituiva l’aspetto più importante. Nel mein kampf si legge una
interessante descrizione del clima politico di quegli anni: “mentre i partiti borghesi, nel loro
uguale grado intellettuale, formano esclusivamente un gruppo insubordinato e inabile, il
marxismo costituì col suo meno dotato materiale umano, un esercito di partito… Lo scrittorucolo
borghese invece, che esce dalla sua stanza di lavoro per presentarsi alla massa, s’ammala già per
l’odore della folla e i suoi scritti non gli sono affatto utili. Ciò che rese ben disposti al marxismo
milioni di lavoratori non è tanto lo stile dei dotti marxisti quanto l’inesauribile e veramente
formidabile opera di propaganda di decine di migliaia d’instancabili agitatori”. Hitler entrò
anche maggiormente nel dettaglio e descrisse l’atmosfera annoiata delle riunioni del Partito
Popolare e del Centro Bavarese, che stentavano ad avere presa sui cittadini, e scrisse che per
arrivare al successo, un gruppo politico doveva non limitarsi alla esposizione dei semplici
programmi politici ma far leva sul lato emozionale: “Potei io stesso sentire e comprendere con
quanta facilità il popolano si sottometta all’incanto affascinante di una potente messinscena”. Le
grandi manifestazioni naziste furono infatti caratterizzate da una grande spettacolarità che
suscitava forte eccitazione sia fra i sostenitori che fra i suoi avversari, e gli stessi comizi di Hitler
erano caratterizzati da continui incitamenti accompagnati da quella che gli psicologi chiamano una
potente comunicazione non verbale. Come ha scritto Golo Mann, la società tedesca di quel
periodo, profondamente colpita sul piano morale ed economico, risultò particolarmente
vulnerabile a questo genere di attività politica che spinse la gente a perdere fiducia in una corretta
vita politica.
KARL HAUSHOFER E LA GEOPOLITICA DEGLI ANNI TRENTA
il teorico della geopolitica vedeva affinità culturali e politiche fra Germania, Italia e Giappone,
come blocco di paesi continentali contrapposti alle potenze marittime
di Tiberio Graziani
Con la pubblicazione del testo di una conferenza del geopolitico tedesco Karl Haushofer [1],
dedicata alle affinità culturali tra l’Italia, la Germania e il Giappone, viene inaugurata, a cura delle
Edizioni all’insegna del Veltro, la collana “Quaderni di Geopolitica”. La conferenza “Analogie di
sviluppo politico e culturale in Italia, Germania e Giappone“ venne tenuta dal professore tedesco,
su invito del grande orientalista e tibetologo italiano Giuseppe Tucci [2], il 12 marzo 1937, a Roma,
presso l’Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO) [3].
Essa si inserisce, storicamente, come peraltro puntualmente evidenziato dal curatore del
Quaderno, Carlo Terracciano, nel contesto delle attività culturali volte a informare e sensibilizzare
l’intellighenzia italiana sulle opportunità e necessità, nonché problematicità, sottese all’accordo
politico-militare relativo all’asse Roma-Berlino, siglato tra Italia e Germania il 24 ottobre 1936, e a
quello antikomintern firmato, nello stesso periodo, tra Germania e Giappone. Ma testimonia
soprattutto un aspetto, ancora poco esplorato dagli storici della cultura e della politica estera
italiana, quello delle attività dell’ISMEO, ed in particolare del suo fondatore e vicepresidente,
Giuseppe Tucci - originale ed inascoltato assertore dell’unità geopolitica dell’Eurasia [4] - orientate
alla promozione di una visione culturale, geopoliticamente fondante, dei rapporti tra l’Europa e il
continente asiatico.
Un’impostazione, quella del Tucci, che si contraddistingue per essere non solo puramente
culturale, accademica e, occasionalmente, di supporto alla nuova politica dell’appena nato impero
italiano, ma per operare una sorta di svecchiamento, sia in ambito culturale che politico,
dell’ancora persistente mentalità piccolo nazionalista sabauda che, nel solco della prassi
colonialista italiana dei primi del Novecento, tentava di condizionare il nuovo corso impresso dal
governo di Mussolini alla politica estera. A questo riguardo è utile riportare l’acuta osservazione di
Alessandro Grossato che, sulla base di una lunga e profonda consuetudine con l’opera di G. Tucci,
ritiene il fondatore dell’ISMEO un vero e proprio eurasiatista ed afferma che l’espressione
“Eurasia, un continente” veniva intesa dall’orientalista marchigiano in un’accezione “soprattutto
culturale, volendo [con essa] sottolineare le grandi identità di fondo fra civiltà solo in apparenza
così distanti nello spazio e nella mentalità” [5].
Il convincimento di Tucci sulla culturale identità di fondo delle civiltà eurasiane suppone
un’adesione, da parte dello studioso italiano, a quel sistema di pensiero che interpreta le singole
culture quali autonome ed autoconsistenti manifestazioni storiche di un unico sapere primordiale e
ad esso le riconduce al fine di coglierne gli aspetti autenticamente fondativi. Il ricondurre le varie
espressioni culturali ad un’unica tradizione primordiale si traduce, sul piano della ricerca storica e
dell’analisi geopolitica, in un procedimento comparativo, che Haushofer, (inconsapevolmente e)
magistralmente, adotta e utilizza in questa breve conferenza dedicata a individuare le analogie tra
l’Italia, la Germania e il Giappone. Haushofer, pur basandosi su criteri oggettivi e “scientifici”, quali
sono quelli della geopolitica, sorprendentemente [6], perviene agli stessi risultati cui sembra essere
giunto Tucci. Il geopolitico tedesco, infatti, nella sintetica e veloce conclusione di questa
conferenza, si augura che “Possa questo modo di vedere i popoli [l’essersi cioè egli adoperato, nella
sua prolusione, a porre in piena luce le armonie e le analogie che possono facilitare la
comprensione reciproca dei grandi popoli tedesco, italiano e giapponese] superare qualunque
tempesta d’odio di razza e di classe, soprattutto tra i sostegni del futuro.”
Certo, chi è abituato a sentir parlare di Haushofer come un rappresentante del cieco e rozzo
pangermanesimo, o del cosiddetto imperialismo germanico, rimarrà stupito nel leggere questa
frase appena citata.
Sarà proprio il fallimento della naturale alleanza eurasiatica, preconizzata negli anni Trenta dagli
Haushofer, dai Tucci e dai Konoe [7], a far precipitare i popoli e le nazioni dell’intero globo in una
tempesta di cui ancora, dopo oltre sessanta anni, non si intravede la fine e che, anzi, è
continuamente alimentata dall’odierna politica neocolonialista dei governi di Washington e Londra
e dai propagandisti dello scontro di civiltà.
Il procedimento comparativo adottato da Haushofer lungi dall’appiattire le differenze tra i popoli
presi in considerazione e dallo svilirne le appartenenze etniche, in virtù della generica
appartenenza al genere umano e secondo la triste e riduttiva visione individualista, valorizza
armonicamente, al contrario, le affinità e le differenze, e le riconduce ad un’analoga condivisione,
pur con sensibilità diverse, di valori che potremmo definire ad un tempo etici ed estetici, cioè
“nobili”. Essi si esprimono, nella visione haushoferiana, sia per il Giappone, sia per la Germania,
l’Italia e la Russia in una loro precisa funzione geopolitica, quella di concorrere all’unificazione
della massa continentale e di difenderne pertanto il limes, al fine di poter sviluppare
armonicamente le potenzialità delle popolazioni che vi abitano. Si contrappongono dunque alle
“invasioni” degli uomini del mare, del commercio, della morale individualistica, del lusso e del
consumo, ai predatori delle risorse naturali.
Il testo di Haushofer si contraddistingue per la sua chiarezza e semplicità, ed in questo senso
rappresenta un documento didattico di rilevante importanza per gli studiosi di geopolitica. Da
scienziato della geopolitica, egli evidenzia gli elementi geografici che hanno influito sulla storia e
sulla politica dei tre popoli in esame, soffermandosi brevemente sulla analoga formazione delle
cellule regionali avvenuta in Germania e in Giappone, e sulla fondazione di Roma, Berlino e Tokyo,
città fondate originariamente sul confine nordest delle loro regioni, e “debitrici di una parte del
loro splendore alla circostanza che la loro posizione di margine, in origine coloniale, si rivelò più
tardi favorevolissima agli scambi ed ebbe funzione di ponte. Il flavus Tiberis, l’originaria valle di
congiunzione dell’Oder coll’Elba, e il Kwanto col ponte Nihon provvedono alle città rispettive una
posizione similmente favorevole e sono loro debitrici di analoga protezione.” Ma accanto ai dettami
del determinismo geopolitico, Haushofer sottolinea le affinità culturali tra Italia, Germania e
Giappone, che nota soprattutto nel “ghibellin fuggiasco” Dante Alighieri, araldo dell’idea imperiale,
in Chikafusa [8], un altro grande fuggiasco nonché impareggiabile autore del Jinnoshiki, e nei
Minnesaenger tedeschi “fedeli all’Imperatore e al popolo”. Altre affinità colte da Haushofer sono
quella tra lo spirito della Cavalleria occidentale e il Bushido giapponese e quella dei comportamenti
tra coloro che egli chiama gli eroi fondatori del risorgimento nazionale: Ota Nobunaga, SickingenWallestein, Cesare Borgia.
Haushofer sostiene che si possa parlare anche per il Giappone, come per l’Italia e la Germania di
un periodo romanico, gotico, rinascimentale, barocco, di un rococò, di un romanticismo e financo
di uno stile impero.
Un termine che ricorre spesso negli scritti Haushofer è quello di “destino”. E’ forse nel sintagma
“destino comune” che si esprimono più compiutamente le affinità di popoli (apparentemente) tanto
diversi sul piano culturale e etnicamente differenti su quello fisico. La coscienza di un destino
comune dei popoli e delle nazioni che vivono nel “paesaggio” eurasiatico è la sola arma che
abbiamo per sconfiggere la civilizzazione occidentalistica e talassocratica dei predoni del XXI
secolo.
Karl Haushofer (Monaco, 27 agosto 1869 – Berlino, 10 marzo 1946), fondatore della rivista
Zeitschrift für Geopolitik ed autore di numerose opere di geopolitica, fu assertore dell’unità
geopolitica della massa continentale eurasiatica. Demonizzato come ideologo del cosiddetto
espansionismo hitleriano, fu invece autenticamente antimperialista. Secondo lo studioso belga
Robert Steuckers, “la geopolitica di Haushofer era essenzialmente anti-imperialista, nel senso che
essa si opponeva agli intrighi di dominio delle potenze talassocratiche anglosassoni. Queste
ultime impedivano l’armonioso sviluppo dei popoli da loro sottomessi e dividevano inutilmente i
continenti” Robert Steuckers, Karl Haushofer in
http://utenti.lycos.it/progettoeurasia/documenti.htm. In traduzione italiana è disponibile l’opera
di Haushofer Il Giappone costruisce il suo impero, a cura di Carlo Terracciano, Edizioni all’insegna
del Veltro, Parma, 1999.
2[2][2] Giuseppe Tucci (Macerata, 5 giugno 1894 - San Polo dei Cavalieri (Tivoli), 5 aprile 1984)
ritenuto il più grande orientalista italiano del Novecento, e fra i massimi tibetologi a livello
internazionale, nel 1930 diviene docente di lingua e letteratura cinese all'Università di Napoli, e
nel 1932 insegna religione e filosofia dell'Estremo Oriente all'Ateneo di Roma. Nel 1933 fonda
l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente. “L'attenzione rivolta anche agli aspetti
politico-economici è documentata, oltre che dalle numerose pubblicazioni dell'Istituto come i
periodici Bollettino dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (1935) e Asiatica
(1936-1943), dallo specifico interesse di Tucci per la geopolitica dell'Asia in un periodo
cruciale della sua storia, e dalla sua amicizia personale con Karl Haushofer, che invita a
tenere importanti conferenze su questa materia. Tucci concentra i suoi viaggi di ricerca nella
vasta regione himalayana, quale naturale crocevia storico fra tutte le diverse culture
dell'Asia, raccogliendo sistematicamente materiale archeologico, artistico, letterario, di
documentazione storica e altro. Risultati eccezionali vengono così ottenuti dalle sue lunghe
spedizioni in Tibet fra il 1929 e il 1948, anno in cui l'Is.M.E.O. riprende in pieno la sua attività
postbellica sotto la sua diretta presidenza, destinata a durare fino al 1978. Tra il 1950 e il
1955 egli organizza nuove spedizioni in Nepal, seguite dalle campagne archeologiche in
Pakistan ('56), in Afghanistan nel ('57) ed in Iran ('59). Sempre nel 1950 avvia il prestigioso
periodico in lingua inglese East and West, e nel 1957 fonda il Museo Nazionale di Arte
Orientale di Roma. Tra i suoi numerosi ed importanti scritti ricorderemo solamente, sia i
sette volumi di Indo-tibetica (Accademia d'Italia, 1932-1942) che i due di Tibetan Painted
Scrolls (Libreria dello Stato, 1949) per la loro ampiezza documentaria, e la Storia della
filosofia indiana (Laterza, 1957) per la sua portata innovativa, specie per quanto riguarda la
1[1][1]
logica indiana. Ma Giuseppe Tucci ci ha soprattutto trasmesso la sua appassionata ed
intelligente dimostrazione dell'unità culturale dell'Eurasia, e una lucida consapevolezza del
fatto che, giunti come siamo ad un capolinea della storia, essa dovrà tradursi anche in
un'effettiva unità geopolitica.” (Alessandro Grossato, Giuseppe Tucci in
http://www.ideazione.com/settimanale/78-20-12-2002/78tucci.htm).
3[3][3] L’Istituto per il Medio ed Estremo Oriente venne fondato nel 1933 su iniziativa del
tibetologo Giuseppe Tucci e di Giovanni Gentile, che ne assunsero rispettivamente la
vicepresidenza e la presidenza, con lo scopo di “promuovere e sviluppare i rapporti culturali
fra l'Italia e i paesi dell'Asia Centrale, Meridionale ed Orientale ed altresì di attendere
all'esame dei problemi economici interessanti i Paesi medesimi”.
Nel 1995 l’Ismeo è stato accorpato all’Istituto Italo Africano (IIA) dando origine all’Istituto
Italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO), che ne ha raccolto l’eredità e gli scopi culturali nonché
la prestigiosa biblioteca.
4[4][4] Confronta Alessandro Grossato, Il libro dei simboli. Metamorfosi dell’umano tra Oriente e
Occidente Mondatori, 1999.
5[5][5] A. Grossato, op. cit. p.10
6[6][6] Haushofer venne invitato dall’ISMEO per una seconda conferenza, che si tenne il 6 marzo
1941. Il testo della conferenza “Lo sviluppo dell’ideale imperiale nipponico” è, attualmente, in
corso di stampa per le Edizioni all’insegna del Veltro.
7[7][7] “Il leader degli Eurasiani giapponesi era il principe Konoe, uno dei politici più in vista
del Giappone d’anteguerra, primo ministro dal 1937 al 1939 e dal 1940 al 1941; ministro di
Stato nel 1939; membro di gabinetto nel 1945 del principe Hikasikuni (gabinetto che firmò la
capitolazione e fu, pressoché interamente, arrestato dagli Americani). Konoe era sostenitore
della maggiore integrazione possibile con la Cina, dell’unione con la Germania ed era un
risoluto avversario della guerra contro l’Unione Sovietica (il patto di non aggressione fu
firmato quando egli era primo ministro). Konoe odiava gli Americani e si suicidò nell’autunno
del 1945 alla vigilia del suo arresto. Ancora oggi, egli gode di una grande notorietà in
Giappone e la sua personalità suscita sempre rispetto.” (da una lettera del nippologo russo
Vassili Molodiakov al geopolitico e filosofo Alexander Dughin, pubblicata in Elementy, n. 3 http://www.asslimes.com/documenti/mondialismo/giappone.htm).
8[8][8] Kitabatake Chikafusa (1293-1354), nell’opera classica (Jinnoshiki) del pensiero politico
giapponese, fissava, in coerenza con la tradizione shintoista, i principi di legittimità della
discendenza imperiale
ADOLF HITLER E IL MUFTI’ DI GERUSALEMME
Storia della strana e per molti versi ancora sconosciuta intesa che, tra il 1934 e il 1945, legò
saldamente le sorti del Movimento Arabo Palestinese capeggiato dal Gran Muftì di Gerusalemme
a quelle del nazismo e del Terzo Reich.
di Alberto Rosselli
La storia degli intensi e complessi rapporti che, tra il 1934 e il 1945, intercorsero tra il Gran
Muftì di Gerusalemme, Amin al Husseini, capo spirituale dei mussulmani palestinesi, e il leader
nazista Adolf Hitler rappresenta una delle vicende a sfondo politico-religioso più interessanti e
meno note di quegli anni.
I motivi che spinsero la più alta e venerata personalità religiosa del Medio Oriente ad unire i
propri destini a quelli del dittatore tedesco e, più in generale, alle forze dell’Asse, suscitano infatti
un’indubbia curiosità, aprendo le porte ad un dibattito che, nell’attuale contesto politico
internazionale, caratterizzato dalla recrudescenza dell’estremismo islamico antisionista e
antioccidentale, assume una valenza ancora maggiore. La condivisione dei programmi antisemiti e
la comune avversione nei confronti dei sistemi democratici furono tra gli elementi che, sessant’anni
fa, cementarono le basi di un’intesa politica e militare tra il nazismo e il Movimento Arabo del Gran
Muftì: un’alleanza di cui, tuttavia, per molti anni poco si è detto e scritto, almeno in Italia;
fors’anche a causa di quel malinteso senso di tutela e di rispetto per la seppure giusta “causa
palestinese”.
Che il Gran Muftì di Gerusalemme nutrisse molta simpatia nei confronti dell’ideologia
antisemita è cosa nota, ma assai meno lo sono i documenti e i carteggi che testimoniano, in
maniera chiara ed inoppugnabile, il tentativo condotto da Amin al Husseini e dai vertici del
nazismo per dare vita ad un vasto e articolato programma di sterminio e di lotta armata sia nei
confronti della comunità israelitica internazionale, che contro le democrazie occidentali: un piano
dal quale, sotto certi aspetti, il “principe del terrore” Bin Laden sembra avere tratto più di uno
spunto. Oggi, però, grazie all’impegno di un gruppo di storici israeliani e statunitensi e alle
testimonianze emerse dagli archivi segreti del Terzo Reich, del governo americano, inglese ed exsovietico, è possibile ricostruire con precisione (purché ne sussista la volontà, ovviamente) la trama
e il contenuto di uno dei più scellerati complotti di matrice razzista e terrorista mai progettati nel
corso del XX secolo. Dopo anni di indagini e di studi, i ricercatori dell’istituto Simon Wiesenthal di
Los Angeles sono riusciti a fare riemergere dagli archivi del controspionaggio nordamericano
buona parte della corrispondenza segreta e dei diari personali del Gran Muftì di Gerusalemme e un
certo numero di casse contenenti una voluminosa massa di documenti (in lingua araba e tedesca)
attraverso la lettura dei quali è possibile fare luce sull’intera e complessa vicenda.
Dopo la caduta del muro di Berlino, gli studiosi israeliani e statunitensi (supportati anche
da informazioni e suggerimenti forniti da colleghi inglesi, russi e serbi) hanno infatti passato al
setaccio tutto il materiale e le testimonianze relativi all’attività di Husseini e dei gruppi arabi che, a
cavallo degli anni Trenta/Quaranta, collaborarono attivamente con i nazisti. Nella fattispecie, la
documentazione fa riferimento ai numerosi dossier redatti tra il 1936 e il 1945, dalla Kripo (la
Polizia Criminale nazista) e dalla Gestapo, dalla Sezione Mediorientale dell’Abwehr (il Servizio
Segreto tedesco diretto dall’ammiraglio Wilhelm Canaris); dal Dipartimento Affari Islamici e del
“Centro Addestramento Elementi Mussulmani” delle Waffen SS (posto alle dirette dipendenze di
Heinrich Himmler); dal “Comando Operazioni Oriente” della Divisione Speciale Brandeburg; dal
Sonderstab F del generale Helmut Felmy (organismo incaricato di arruolare nella Wehrmacht
volontari mediorientali, nordafricani, ma anche transcaucasici e russo-asiatici) e dall’Arab Bureau
del dicastero degli Esteri di Joachim von Ribbentrop.
L’antisemitismo come ragione di vita
Amin al Husseini (chiamato anche Al-Haji Amin) nasce nel 1897, a Gerusalemme, da una
famiglia molto religiosa che, fino dalla più tenera età, educa il figlio secondo i più rigidi precetti
islamici. Dopo avere compiuto i suoi primi studi nella città natale, Amin li prosegue al Cairo e, in
seguito, a Costantinopoli. Nel 1910, entra nell’esercito ottomano, venendo assegnato ad una scuola
di artiglieria. Sembra che dopo le Guerre Balcaniche Husseini abbia completato in una scuola
coranica la sua preparazione culturale e religiosa. Ancora molto giovane, Amin mostra simpatie nei
confronti del Movimento Arabo che fa capo allo sceriffo de La Mecca Hussein, uno dei più
importanti vassalli della Sacra Porta. Nel 1914, in seguito ad abboccamenti con i servizi segreti
inglesi di base al Cairo e agli aiuti promessi dal Foreign Office di Londra e dal Comando Supremo
dell’Esercito inglese in Egitto, lo sceriffo inizia, infatti, a progettare una rivolta nazionalista araba
con l’intento di liberare dal giogo ottomano la regione dell’Hegiaz, posta sotto il suo governo, e le
città sante di Medina, La Mecca e Gerusalemme. Tra il 1914 e il 1918, Amin al Husseini segue e
partecipa con interesse alla lotta condotta dallo sceriffo contro i turchi, fornendo, sembra, il suo
appoggio alla causa attraverso attività segrete e di spionaggio. Nel marzo 1920, partecipa al
Congresso panarabo di Damasco che proclama l’indipendenza dell’Iraq sotto il re Abdullah e della
Siria sotto Feisal, uno dei figli dello sceriffo Hussein della Mecca. Nel successivo mese di aprile,
Amin al Husseini aderisce all’organizzazione di una sommossa antiebraica in Palestina (regione
posta sotto mandato britannico) e, in seguito alla creazione della Haganah (l’organizzazione
armata di autodifesa ebraica), contribuisce a fondare diverse bande terroristiche antibritanniche,
incominciando, nel contempo, a pianificare una strategia per “eliminare fisicamente tutti gli
elementi sionisti dal territorio mediorientale”. Nel maggio 1921, Husseini fomenta nuove
manifestazioni antisioniste in Palestina e, poco dopo, viene nominato Gran Muftì di Gerusalemme,
la più alta carica religiosa dell’islam, acquisendo subito grande prestigio e potere. Nel 1925,
favorisce segretamente la nascita dell’Associazione Armata Araba guidata dal fondamentalista
siriano Izz al-din Qassam. Nell’agosto del 1929, Husseini dà la sua benedizione ad una delle più
violente persecuzioni antiebraiche. Con l’intento di limitare il diritto di preghiera degli israeliti
presso il Muro del Pianto di Gerusalemme e le visite alla Tomba dei Patriarchi di Hebron, Husseini
sobilla nuovamente la popolazione mussulmana, contribuendo, tra l’altro, alla soppressione della
secolare comunità ebraica di Hebron.
Nel 1931, il Gran Muftì sostiene la nascita del Partito Arabo per l’Indipendenza, uno
schieramento che reclama a gran voce l’unione politico-religiosa tra Palestina e Siria, regione posta
sotto mandato francese. Nel 1933, dopo la salita al potere di Hitler in Germania, Husseini confida
ai suoi discepoli e collaboratori di “intravedere un nuovo, radioso futuro”, e predice “l’avvento di
una nuova era di libertà per i mussulmani di tutto il mondo”. Galvanizzato dai risultati delle
repressioni antiebraiche messe in atto dai nazisti, il Gran Muftì, che ormai si avvale di un folto
seguito di seguaci, scatena nuove rivolte a Jaffa, Haifa e Nablus.
Il 21 Luglio 1934, il Muftì di Gerusalemme compie il passo decisivo. Con lo scopo di stabilire
uno stretto rapporto di cooperazione con il nazismo, si reca in visita al nuovo console generale
tedesco di Palestina, Döhle. Nel corso dell’incontro, che verrà definito “molto cordiale e proficuo”,
Husseini conferma il suo incondizionato sostegno alla Germania di Hitler, domandando al
diplomatico “fino a che punto il Terzo Reich fosse disposto a sostenere il movimento arabo contro
gli ebrei”. Ricevute soltanto vaghe assicurazioni in proposito, nel 1936, Amin al Husseini invia
alcuni suoi collaboratori a Berlino per “intraprendere amichevoli contatti con i capi del
movimento nazista”. E nel contempo, in Palestina, proclama la lotta armata contro le comunità
ebraiche e le forze di occupazione inglesi, affidando il compito di dirigere la rivolta a Fawzi el
Kawakij. Quest’ultimo, nel 1941, sosterrà assieme allo stesso Muftì il fallito colpo di stato antiinglese del leader nazionalista iracheno Rashid Alì, e, successivamente, nel 1948, guiderà le truppe
arabe irregolari contro il neonato stato di Israele. In occasione dei disordini del 1936, Husseini
incita i mussulmani fondamentalisti ad attaccare anche le fazioni moderate islamiche, causando
(secondo fonti britanniche) non meno di 4.000 morti.
Informati della rivolta dal console tedesco, il ministero degli Esteri e i vertici delle Waffen
SS, iniziano a prestare maggiore attenzione all’attività del Muftì e dei suoi seguaci, pur mantenendo
nei confronti del mondo islamico un atteggiamento di sostanziale diffidenza. Nel settembre 1937,
due giovani ufficiali delle SS, Karl Adolf Eichmann (che diverrà in seguito il coordinatore supremo
della “Soluzione Finale”) ed Herbert Hagen, vengono inviati a Gerusalemme per cercare di sondare
il livello di affidabilità del Muftì e dei suoi collaboratori e, eventualmente, trovare i presupposti per
una più concreta cooperazione politico-militare. L’ordine di Hitler è infatti quello di intensificare i
rapporti tra nazismo ed islamismo radicale, ma di procedere con assoluta cautela. Pur reputando
interessante l’opportunità di agganciare al carro nazista un elemento di prestigio come il Gran
Muftì, il Führer - che non nasconde il suo disprezzo non soltanto per gli ebrei, ma anche per tutta
la razza semita - non desidera, almeno per il momento, provocare una crisi mediorientale dai
risvolti imprevedibili. Mentre i due agenti tedeschi si apprestato a partire per la Palestina, le
autorità militari inglesi, che già da tempo indagano sulle attività sovversive del Gran Muftì,
spiccano un mandato di cattura contro Amin al Husseini, costringendo quest’ultimo a darsi alla
macchia. Tuttavia, una volta giunti ad Haifa, Eichmann e Hagen riescono egualmente a contattarlo.
I colloqui segreti tra i due agenti e il Gran Muftì si rivelano abbastanza promettenti. Alla fine,
Eichmann offre ad Husseini la protezione dei servizi segreti tedeschi e la fornitura di denaro, armi,
munizioni ed esplosivi in cambio del suo impegno ad operare a fianco della Germania per debellare
il “demone sionista”, ma anche per minare le fondamenta del dominio anglo-francese in Medio
Oriente. Husseini non pone alcuna difficoltà, dichiarandosi “felice di cooperare per il trionfo di
una giusta causa”, e promette di fare del suo meglio, coinvolgendo anche i leader delle comunità
mussulmane di Siria, Transgiordania, Libano e Iraq.
Nel 1938, secondo il carteggio Wiesenthal, il nome in codice del Gran Muftì risulta già nel
libro paga dell’Abwehr II. Verso la fine dello stesso anno l’Abwehr II pianifica un programma per
inviare in Palestina, tramite navi battenti bandiera neutrale, alcune forniture di armi e munizioni
destinate alle forze di Husseini. Per motivi di sicurezza, il carico dovrebbe essere sbarcato in un
porto dell’Arabia, probabilmente Gedda. All’ultimo momento, però, l’operazione viene sospesa.
Hitler, già impegnato in Spagna, con la Legione Kondor, a fianco del generale Francisco Franco, ed
in procinto di annettere la Boemia alla Germania, preferisce evitare di inasprire ulteriormente i
rapporti con l’Inghilterra, i cui servizi segreti, tra l’altro, sono già al corrente dei legami tra i nazisti
e il Gran Muftì.
Nel settembre del 1939, all’indomani dell’invasione tedesca della Polonia, Amin al Husseini
dichiara pubblicamente di volere dare il suo esplicito sostegno al “meritevole e coraggioso
condottiero Adolf Hitler”, incitando “i mussulmani a prendere le armi a fianco della Germania
nazista”. All’inizio del 1941, dai microfoni di un’emittente segreta, il Gran Muftì invoca “il diritto
degli arabi a risolvere il problema ebraico con le stesse modalità e gli stessi mezzi adoperati dal
Führer, e lancia un proclama affinché tutti gli islamici contribuiscano con le armi al successo
delle forze dell’Asse”. Tuttavia, non potendo ancora usufruire di una protezione tedesca e temendo
di essere arrestato dagli inglesi, verso la fine del 1940, Amin al Husseini decide di fuggire in Iraq e
di muoversi per conto proprio, utilizzando il denaro che nel frattempo gli è stato inviato
dall’Abwehr. Grazie a queste risorse, egli inizia a sostenere il partito nazionalista iracheno di
Rashid Alì (compagine che, tra l’altro, controlla buona parte dell’esercito), fortemente avverso agli
inglesi e agli ebrei. E la Mesopotamia diventa così il banco di prova dell’organizzazione messa in
piedi dal Muftì con i marchi tedeschi. Rashid Alì, che sta aspettando il momento migliore per
scatenare la rivolta anti-inglese, accoglie Husseini come un fratello e lo nasconde in un rifugio
segreto, consentendogli di operare indisturbato. Tra la fine del 1940 e l’inizio del 1941, molti
funzionari iracheni stabiliscono rapporti di segreta cooperazione con l’ormai fantomatico Muftì
che, con molta abilità, continua ad eludere le ricerche della polizia e dell’esercito inglese presenti
anche in Iraq. Nell’aprile 1941, il Movimento rivoluzionario di Husseini si consolida, iniziando, tra
l’altro, a ricevere sovvenzioni in denaro anche da dall’Italia, dall’Arabia Saudita e dall’Egitto. Nel
suo rifugio segreto sotterraneo (situato, sembra, tra Baghdad e Mosul), protetto dai compiacenti
militari iracheni, il Muftì conduce una vita piuttosto agiata. Egli dispone, infatti, di un attrezzato
ufficio dotato di linea telefonica, di una potente stazione radio, di servizi e di un ampio magazzino
zeppo di armi, munizioni, viveri e medicinali. Assieme a lui lavorano almeno una dozzina di
collaboratori fidati ed altrettante guardie del corpo, quasi tutte provenienti dall’esercito iracheno.
Nella primavera del 1941, Rashid Alì, sostenuto dall’esercito nazionale e dalle cellule di Husseini,
dà inizio alla sommossa antibritannica. Rashid Alì obbliga il primo ministro iracheno, il filo-inglese
Nuri Said Pasha, a dare le dimissioni; dopodiché ordina alle sue truppe di chiudere i rubinetti delle
lunghe condotte che collegano i campi petroliferi mesopotamici al porto di Haifa e di circondare le
scarsamente presidiate basi dell’aviazione e dell’esercito inglesi. Contemporaneamente, il Muftì
lancia, attraverso un messaggio radio, la jihad (la guerra santa) contro l’Inghilterra. Nonostante il
fulmineo avvio del Golden Square o “Blocco d’Oro” (il brillante nome in codice con cui Rashid
aveva voluto battezzare la sua insurrezione), la manovra si rivela, però, intempestiva e male
architettata. Innanzitutto, perché sia Rashid Alì che il Muftì non tengono al corrente l’Abwehr circa
le loro mosse, e in secondo luogo perché le forze armate italo-tedesche, impegnate in questo
periodo in Grecia contro l’esercito inglese ed ellenico, non sono ancora in grado di intervenire con
la dovuta celerità ed incisività in Medio Oriente. Hitler e Mussolini, infatti, non potranno che
inviare agli iracheni ribelli che qualche dozzina di consiglieri, meno di cinquanta aerei da trasporto
e da combattimento e - tramite il compiacente governo francese di Vichy - un solo convoglio
ferroviario carico di armi e munizioni proveniente dalla Siria. A completare la frittata ci pensa poi il
Comando dell’esercito iracheno che, palesando un’evidente inettitudine, non riesce ad eliminare i
pochi presidi inglesi che, nell’arco di dieci giorni, vengono soccorsi da un forte corpo di spedizione
proveniente dall’Egitto e dall’India. Consolidata nuovamente la loro presenza sul territorio
mesopotamico, gli inglesi schiacciano la rivolta nazionalista irachena e costringono sia Rashid Alì
che il Muftì a fuggire. Quest’ultimo, braccato dai britannici, riesce a trasferirsi nel nord del paese da
dove - grazie al denaro e alla connivenza di ribelli mussulmani - passa in Iran e successivamente in
Turchia. Giunto ad Istanbul, Amin al Husseini si mette in contatto con alcuni agenti tedeschi che lo
aiutano a raggiungere la Germania.
Verso la metà del novembre 1941, il Muftì giunge a Berlino, dove viene accolto da
Eichmann. Questi lo introduce nei palazzi della politica, dove viene interrogato da alcuni alti
ufficiali delle SS circa il fallimento del Golden Square. Husseini non mostra alcun imbarazzo
nell’addossare tutta la colpa del disastro alla “quinta colonna ebraica che opera in Iraq”,
aggiungendo che un più concreto e sollecito sostegno da parte delle forze dell’Asse avrebbe
probabilmente evitato il grave infortunio. L’infelice osservazione del Muftì irrita non poco i
tedeschi e rischia di compromettere i futuri piani di cooperazione arabo-nazisti. Tuttavia,
Eichmann ci mette una pezza e convince il Führer a continuare ad accordare fiducia e sostegno
all’alleato. Il 20 Novembre 1941 il ministro del Esteri tedesco, Joachim von Ribbentrop, riceve il
Gran Muftì, e dal loro colloquio vengono poste le basi per il successivo incontro con Hitler.
La trascrizione della lunga conversazione tra il Muftì e Hitler venne messa a disposizione di
Husseini nel maggio 1945, in una villa nei pressi della capitale tedesca, e trasmessa all’archivio dei
servizi segreti statunitensi e successivamente a quello delle Nazioni Unite, dove rimase ben
custodita e, curiosamente, mai pubblicizzata. Intervistato sull’argomento dal quotidiano Hadashot,
lo storico e orientalista israeliano Zvi Alpeleg ha affermato che l’esistenza di questo documento
(venuto alla luce pochi anni fa, grazie alle ricerche degli uomini di Wiesenthal) era nota da tempo.
Tanto che, nel gennaio 1946, in seguito ad una fuga di notizie, il quotidiano americano New York
Times pubblicò un articolo sulla vicenda, il cui contenuto venne smentito da alcuni governi arabi,
come la Siria e l’Iraq. Guarda caso, proprio nel periodo in cui, sempre da fonte stampa
statunitense, il mondo venne a sapere che il governo di Damasco e del Cairo, con la complicità
dell’Unione Sovietica, avevano dato rifugio ad alcuni “consiglieri” provenienti dalle file delle SS e
della Gestapo. A titolo di cronaca, è ormai provato che negli anni Cinquanta, l’Unione Sovietica
abbia “fornito” allo Stato maggiore dell’esercito del dittatore egiziano Nasser un’altra “partita” di
“consiglieri” nazisti (tra cui diversi fisici e chimici esperti in missilistica e in armi chimiche e
batteriologiche) per mettere a punto armi balistiche dotate di testate atomiche, a gas o a virus, da
utilizzare contro Israele. Ancora nel 1966, questa volta secondo fonti francesi e israeliane, l’ormai
anziano Amin al Husseini si sarebbe adoperato per introdurre segretamente in Libano e in Iraq
altri “tecnici” ex-nazisti da lui conosciuti durante il suo lungo soggiorno in Germania.
Ma torniamo al colloquio del 22 novembre 1941 tra il Gran Muftì e Adolf Hitler. Nel corso
dell’incontro, durato circa un’ora e mezza, il Gran Muftì dichiarò che “gli arabi dovevano essere
considerati amici naturali della Germania…” e che “egli era pronto ad adoperarsi per convincere
tutti i mussulmani presenti in Africa Settentrionale, nell’Europa occupata e in Russia” ad
arruolarsi in una speciale Legione Araba (la Freies Arabien) al servizio della comune causa
antisionista e antioccidentale. “In questa gigantesca lotta, gli Arabi si batteranno anche per
scacciare gli anglo-francesi dal Medio Oriente e per creare i presupposti di un grande Stato
Arabo Unito, comprendente la Palestina, la Siria, il Libano, la Transgiordania e l’Iraq”. Dal canto
suo, il Führer (che, in seguito allo smacco subito da Rashid Alì, non si fidava più delle capacità
organizzative e militari dei capi arabi) assicurò che “la Germania, pur essendo decisa a richiedere
alle nazioni sue alleate (Italia, Romania, Ungheria, Bulgaria, Croazia, Slovacchia e Finlandia, ndr)
di contribuire fattivamente alla risoluzione del problema ebraico”, non riteneva ancora opportuno
“dirigere un simile appello ai popoli mediorientali e a quello iraniano, troppo strettamente
controllati dalle forze inglesi e sovietiche”.
Pur amareggiato dalle dichiarazioni del Führer, Amin al Husseini tentò, nei mesi successivi,
di persuadere sia Hitler che Mussolini a sottoscrivere un documento ufficiale con il quale “la
Germania e l’Italia si sarebbero impegnate in tempi brevi ad intervenire militarmente in Medio
Oriente per aiutare i mussulmani a scacciare gli inglesi”. Dichiarazione, questa, che i due dittatori
non sottoscrissero poiché, al momento, risultava tecnicamente inattuabile. Il Führer preferì
rinviare qualsiasi eventuale azione nella regione ad una data successiva alla conquista del Caucaso
e della valle del Nilo da parte delle forze dell’Asse. Amin al Husseini dovette quindi accontentarsi.
“In attesa dello sfondamento italo-tedesco dei fronti egiziano e caucasico - annotò sul suo diario ai mussulmani non rimane che mettersi a disposizione della Germania, partecipando alla
distruzione dei sionisti in Europa”.
Per cercare di andare incontro ad Husseini, nel 1942 i tedeschi lo posero alla direzione
dell’”Ufficio Arabo”: un ente controllato dalle SS al quale sarebbe spettato il compito di fare
propaganda antisemita e di favorire l’arruolamento dei mussulmani nella Legione Araba di cui si è
detto, ma anche nei reparti delle SS appositamente costituiti da Himmler per inquadrare elementi
bosniaci e albanesi. Questi ultimi andarono, infatti, a formare la 13ma Divisione da montagna SS
Handschar e la 21ma Divisione da montagna Skanderbeg, indossando una divisa da
combattimento abbastanza simile a quella in uso nelle sezioni analoghe tedesche. Sul capo essi
portavano il fez rosso con appuntato il teschio, mentre al posto delle consuete scritte runiche del
colletto comparvero curiosi gagliardetti con una scimitarra islamica. Va notato infine che,
nonostante il suo personale disprezzo nei confronti di tutte le religioni, Himmler concesse ai
volontari mussulmani delle due divisioni di praticare una dieta particolare vincolata ai precetti
mussulmani, di pregare pubblicamente secondo la ritualità, e di festeggiare e osservare le feste e i
digiuni imposti dal Corano.
Situato non lontano da Berlino, il quartiere generale del Muftì controllava una fitta rete di
collaboratori, sia i Europa che nel resto del mondo. Esso, infatti, estendeva la sua autorità a tutto il
Medio Oriente, e al Nord Africa, ma anche sulle più lontane regioni asiatiche abitate da minoranze
islamiche. Tra il 1942 e il 1944, il Gran Muftì lavorò intensamente, consentendo l’arruolamento
nella Legione Araba e nelle Divisioni Waffen SS di molti uomini. Grazie alla sua martellante
propaganda, attuata tramite potenti stazioni radio messe a disposizione dai tedeschi, e mediante
frequenti viaggi, decine di migliaia di mussulmani balcanici andarono a formare le nuove divisioni
di Himmler. Queste unità, divenute ben presto note per la loro ferocia, vennero spesso impiegate
nei Balcani in azioni antipartigiane e nei rastrellamenti di ebrei e zingari. Nel 1943, non meno di
50.000 mussulmani di varia provenienza risultavano presenti nelle divisioni SS o nei reparti
speciali tedeschi (1). Anche se la Legione Araba (l’unità sulla quale il Muftì contava molto in
quanto egli la considerava l’elemento costituente del suo futuro esercito) non arrivò mai a superare
gli effettivi di qualche battaglione. L’unità, contrariamente alle aspettative dei tedeschi, fornì
inoltre risultati piuttosto deludenti sia sotto il profilo disciplinare che operativo e bellico (2).
Nel corso del conflitto, molto intensa risultò anche l’azione diplomatica svolta dal Gran
Muftì. Tra il 1942 e il 1944, egli effettuò diversi viaggi per l’Europa, recandosi nelle regioni abitate
da nuclei mussulmani (Bosnia, Kosovo, Albania) per constatarne la fedeltà al Reich, e stringendo
rapporti di amicizia e cooperazione anche con i capi di movimenti parafascisti croati e serbo-cetnici
che avevano in comune un profondo odio nei confronti degli ebrei e delle democrazie occidentali.
Non solo. Sembra che nel 1942, tramite l’ambasciata giapponese di Berlino, il Muftì abbia avviato
contatti perfino con il governo di Tokyo, il cui ministero della Guerra era intenzionato a servirsi di
lui e dei suoi seguaci per fare insorgere contro gli eserciti di Ciang Kai Shek e di Mao Tse Tung le
comunità mussulmane della Cina centro-occidentale (regioni del Tarim e del Tsinghai) e per tenere
buone quelle, assai più numerose, dell’Indonesia e delle isole meridionali delle Filippine. Nella sua
veste di responsabile della supervisione della propaganda radio dell’Asse diretta verso i popoli
mussulmani, il Muftì utilizzò spesso le numerose ed efficienti emittenti radio tedesche, potendo
contare, nel 1942, su almeno sei stazioni. Ma Husseini amava molto parlare anche davanti alle
grandi folle. Nel giugno del 1943, a Berlino, in occasione di un’importante adunata nazista, il Muftì
lanciò strali contro la Dichiarazione Balfour, prendendosela, tanto per cambiare, con la
“cospirazione anglo-sassone, massonico-ebraica”. Rivolto agli alti gradi delle SS presenti, disse: “Il
trattato di Versailles non fu soltanto un disastro per voi tedeschi, ma lo fu anche per il popolo
arabo. In ogni caso, oggi sappiamo come rimettere le cose al loro giusto posto e, soprattutto, oggi
siamo tecnicamente in grado di eliminare dalla faccia della terra tutti gli israeliti”.
Tra il 1941 e il 1943, il Muftì e i servizi segreti tedeschi inviarono in Marocco, Algeria,
Tunisia, Egitto, Palestina, Siria e Trasgiordania un gran numero di opuscoli e di altro materiale
propagandistico antinglese e soprattutto antisionista. Anche quando le armate del Reich dovettero
abbandonare le steppe russe e l’Africa settentrionale, arretrando sempre più verso i confini
tedeschi, Husseini continuò a lottare, lanciando messaggi alle popolazioni mediorientali, africane e
addirittura alle minoranze arabe residenti in Asia e negli Stati Uniti, spronandole a combattere
contro il demonio sionista e plutocratico. Il 1° Marzo 1944, nel corso dell’ennesima trasmissione
radiofonica, il Muftì ebbe modo di ribadire il suo immutato odio nei confronti degli israeliti:
“Arabi! Alzatevi come un solo uomo e combattete per i vostri sacrosanti diritti. Uccidete gli ebrei
dovunque li troviate. Ammazzate, e farete cosa gradita da Allah”. Ma intanto la guerra stava
volgendo al termine e le armate di Hitler ripiegavano su tutti i fronti sotto la pressione delle forze
anglo-americane e sovietiche. Catturato nel tardo aprile del 1945 in un piccolo paese della
Germania occidentale dalle truppe statunitensi, Al Husseini venne tradotto in un carcere francese
da dove, nel 1946, riuscì però ad evadere, rifugiandosi prima al Cairo e poi a Beirut, in Libano. In
questa città egli dedicherà il resto della sua esistenza ad elaborare piani e strategie finalizzati alla
distruzione della razza ebraica e dello stato di Israele, dando, con immutata perseveranza e rabbia,
il suo sostegno materiale morale a tutti i nemici del sionismo. Venerato ma ormai messo da parte
dai più giovani e rampanti leader del terrorismo islamico, l’ex Gran Muftì di Gerusalemme Amin al
Husseini morirà nella capitale libanese il 4 luglio 1974.
FINE
NOTE:
1. Nel corso della campagna di Russia, i tedeschi ebbero modo di arruolare nelle file del loro
esercito un elevato numero di volontari mussulmani, inquadrandoli in appositi reparti. Nella
fattispecie vennero formati non meno di 10 battaglioni a cavallo calmucchi; il raggruppamento
battaglioni turchi Haroun el Rashid; nove battaglioni tartari; quattro/sei battaglioni caucasici
(formati da georgiani e azerbaigiani e dell’Abhkazia); una brigata di fanteria cosacca; due grosse
divisioni di cavalleria cosacca del Kuban e del Terek e parecchie compagnie formate da elementi
provenienti da Kazakistan, Turkmenistan, Usbekistan, Tagikistan e Kirghisistan. L’adesione
spontanea di queste minoranze alla causa nazista derivava in gran parte dalla dura, e spesso
spietata, politica di segregazione etnico-religiosa attuata nel corso degli anni Trenta dal regime
di Stalin.
2. Già a partire dal luglio del 1941, la Germania aveva intrapreso l’addestramento di speciali unità
formate da elementi arabi mediorientali e nordafricani. Poco dopo la fallita rivolta antinglese di
Rashid Alì, il Comando dell’Esercito tedesco diede incarico al generale Hellmuth Felmy di
provvedere all’addestramento di un primo nucleo di combattenti mussulmani. Felmy cercò di
inquadrare alcune centinaia di uomini, costituendo l’845° Battaglione Arabo-Tedesco. I
problemi che Felmy dovette affrontare furono però molti e diversi. A parte l’assoluta
impreparazione militare evidenziata da quel primo nucleo di volontari assai poco portati alla
disciplina, il generale notò ben presto che all’interno della truppa sussistevano anche diverse
fazioni ideologiche. Una parte degli uomini dell’845° simpatizzavano, infatti, con il partito
guidato dal nazionalista siriano Fauzi Kaikyi, un’altra si dichiarava seguace del partito
nazionalista iracheno dell’ex-primo ministro Rashid Alì, mentre una terza si dichiarava fedele al
Gran Muftì di Gerusalemme. Nell’estate del 1941, il battaglione venne trasferito in Grecia, a
Sounio, una località situata nell’estremo lembo meridionale dell’Attica, dove avrebbe iniziato il
suo ciclo di addestramento. I tedeschi scelsero questa località sia per motivi climatici che
strategici, in quanto essi pensavano di utilizzare l’unità araba in Africa Settentrionale o in Medio
Oriente (specificatamente in Palestina, Transgiordania, Siria e Iraq). Durante prima la fase di
addestramento, gli istruttori tedeschi (ufficiali che, prima della guerra, avevano soggiornato a
lungo nei paesi arabi o che durante il Primo Conflitto mondiale avevano prestato servizio in
Medio Oriente nelle file dell’Asienkorps tedesco del generale Erich von Falkenhein) impartirono
alle reclute lezioni di tedesco, insegnando poi ad esse l’uso di svariate armi ed esplosivi. I
risultati ottenuti furono però piuttosto scarsi, in quanto i volontari mussulmani, molto preparati
e determinati sotto il profilo ideologico e politico, si rivelarono in realtà piuttosto pigri,
indisciplinati, disordinati e scarsamente portati al combattimento moderno. Il 24 luglio 1941,
intanto, a Potsdam, una seconda Unità di Addestramento, la Sonderverband 288, riuscì a
mettere insieme un altro gruppo di volontari mussulmani fedeli al Muftì, inquadrandoli in uno
speciale battaglione da impiegare nella guerra nel deserto. Terminato il ciclo di addestramento,
l’unità, che in realtà non contava neanche 150 uomini, venne inviata a Bengasi, entrando a fare
parte dei reparti mobili dell’Afrika Korps del generale Erwin Rommel. In Libia, il battaglione
assunse anche la pomposa denominazione di Panzergrenadier Regiment “Afrika”. Il 26 gennaio
1942, il capitano Schober assunse il comando del raggruppamento arabo che ricevette anche
nuove uniformi colore sabbia. Sulla manica della giubba spiccava per la prima volta uno stemma
di tessuto che riportava una bandiera rosso, verde, bianca, nera, con impressa la scritta “Libera
Arabia”, sia in arabo che in tedesco. Nell’aprile del 1942, il battaglione contava 133 effettivi. Non
si hanno notizie circa l’impiego operativo di questa unità che venne affiancata da una compagnia
tedesca e da una compagnia formata da ex-legionari francesi fedeli al governo di Vichy. Ciò che
si sa è che 30 elementi considerati i meglio preparati entrarono in seguito a fare parte di una
speciale compagnia guastatori dell’esercito tedesco, addestrata per compiere incursioni in Ciad e
in Egitto, all’interno delle linee inglesi. Il 4 agosto 1942, grazie anche all’opera propagandistica
del Gran Muftì, il Comando Supremo tedesco formò un terzo battaglione arabo, la cosiddetta
Sonder Verbande 287. L’unità, che venne addestrata nel campo di Doberitz, era formata da circa
200/300 uomini e raggruppava diversi elementi tratti dall’845° Battaglione. In occasione della
grande offensiva d’estate scatenata dall’esercito tedesco sul fronte del Caucaso, il Gran Muftì
insistette presso il Comando tedesco affinché almeno un reparto arabo venisse impiegato in
quella regione, abitata in buona parte da popolazioni di religione mussulmana. E lo stesso
Hitler, che in realtà non aveva mai nutrito eccessiva fiducia nelle capacità militari degli arabi,
ritenne opportuno dare il suo benestare. E fu così che il 21 agosto, il Gruppo Speciale F (alias
Sonder Verbande 287) venne trasferito da Doberitz a Stalino (Ucraina), entrando a fare parte
della 1a Armata Panzer alla quale sarebbe spettato l’arduo compito di raggiungere e conquistare
i grandi campi petroliferi di Grozny e di Baku e di proseguire poi in direzione della Persia e della
Siria. Verso la metà di settembre, il Battaglione Arabo, adeguatamente addestrato, armato e
rinforzato da elementi tedeschi, venne trasferito nella zona d’operazioni compresa tra il fiume
Kuma e il canale del Manich, andando ad integrarsi con i reparti tedeschi appartenenti alla
16ma Divisione di Fanteria Motorizzata che controllava Elista e gli estremi capisaldi orientali
situati nella Steppa dei Calmucchi. Secondo le direttive del Comando supremo, il battaglione
arabo venne poi spostato un po’ più a sud, nella Steppa del Nogay, per andare a presidiare i nodi
di Acikulak e Urozajne. Giunto in questa regione il reparto arabo venne integrato con diversi
elementi locali di religione mussulmana, e venne attrezzato per andare ad operare all’interno
della catena del Caucaso, assieme alle truppe da montagna della 1a Armata tedesca che, nel
frattempo, avevano ricevuto l’ordine di conquistare tutti gli alti passi montani e di penetrare in
Abhkazia e in Georgia. Obiettivo che tuttavia rimase sulla carta in quanto, a metà di ottobre del
1942, i russi scatenarono una poderosa controffensiva, costringendo l’intero Gruppo A
dell’Armata Tedesca a ritirarsi, e con essa anche il reparto arabo. In seguito al ripiegamento, il
battaglione venne sciolto e parte dei suoi componenti optarono per andare a lavorare nel
servizio segreto tedesco. I rimanenti soldati vennero inquadrati in un piccolo distaccamento
acquartierato in Germania. Dopo lo sbarco anglo-americano in Nord Africa dell’8 novembre
1942, il Gran Muftì chiese al Comando germanico di impiegare in Tunisia alcuni plotoni tratti
dai tre battaglioni arabi. Nel dicembre dello stesso anno, un centinaio di volontari arabi, agli
ordini di ufficiali tedeschi, venne inviato a Palermo per poi essere trasferito, nel gennaio del
1943, a Tunisi. Giunto in Africa, il raggruppamento ricevette una nuova denominazione:
“Kommando Deutsch-Arabischer Truppen” (Commando Truppe arabo-tedesche). Al reparto
vennero affidati compiti di sorveglianza della costa tra Capo Bon e la città di Susa e di
reclutamento di volontari tunisini. Nell’aprile del ‘43, in concomitanza con le ultime operazioni
della campagna, gli arabi vennero dotati di armamento più moderno e pesante per contrastare le
avanzanti forze anglo-americane. E tra la fine di aprile e i primi di maggio, il gruppo venne
inserito nella Divisione Corazzata “Goering”, partecipando ad alcuni aspri combattimenti. Il 10
maggio, infine, gli ultimi combattenti battaglione arabo verranno catturati dagli americani e
trasferiti negli Stati Uniti, nel campo di Opaluka (Alabama), dove rimarranno, in compagnia di
altri 1.800 arabi filo-tedeschi, fino al 10 aprile 1946. I modesti risultati ottenuti dall’impiego
militare di volontari arabi, sconsigliò i tedeschi dal formare ulteriori, analoghi reparti, anche se,
nel corso della seconda metà del 1943, un centinaio di arabi vennero ancora arruolati dal 1°
Reggimento Paracadutisti tedesco e dallo speciale Gruppo Commando del tenente colonnello
Otto Skorzeny. Con l’approssimarsi della fine della guerra, il Gran Muftì dovette rinunciare al
sogno di costituire un vero Esercito Arabo in divisa tedesca e a limitare la sua azione alla pura
propaganda.
Miti dell’origine dell’uomo e dell’uomo-robot
Il mistero della vita ha sempre suggestionato l’essere umano, come l’idea di riproduzione di esseri
quasi-umani
di Maurizio Stefanini
In principio, prima del dna e dei cloni, fu il fango, e il fulmine. Genesi: “Allora Dio, il Signore, prese
dal suolo un po’ di terra e, con quella, plasmò l’uomo. Gli soffiò alle narici un alito vitale e l’uomo
diventò una creatura vivente”. Corano: “Noi creammo l’uomo dall’argilla secca, impastandola
coll’acqua”. Pure “con acqua e terra Prometeo plasmò gli uomini”, secondo Apollodoro e Ovidio.
Ma nel mito greco il creatore dell’umanità non era un dio supremo, bensì un titano ribelle, che per
giunta diede poi alla sua creatura il fuoco rubandolo all’Olimpo. Per punirlo, narra Esiodo, Zeus
“legò Prometeo dai vari pensieri con inestricabili lacci, con legami dolorosi, che a mezzo d’una
colonna poi avvolse, e sopra gli avventò un’aquila, ampia d’ali, che il fegato gli mangiasse
immortale, che ricresceva altrettanto la notte quanto nel giorno gli aveva mangiato l’uccello
dall’ampie ali”, finché l’uccellaccio non fu ucciso da Ercole. Le guide turistiche nelle Catacombe
contrappongono spesso l’immagine cristiana del defunto che si affida fiducioso a Dio a quella
pagana di Prometeo che stringe i pugni contro il cielo. Eppure Tertulliano e Agostino
considerarono Prometeo una prefigurazione del Cristo.
“Polvere sei e polvere ritornerai”, ricorda la liturgia cattolica. Ma per il Popol Vuh, libro sacro
maya, gli dei provarono sì a modellare i primi uomini di terra e fango. “Fecero un corpo, ma non
sembrava loro molto riuscito. Si spezzava, si sbriciolava, si rammolliva, si disintegrava e si
scioglieva”. Riprovarono quindi con “sculture di legno”, che però si dimenticarono dei loro creatori,
e furono così distrutti dal diluvio universale. Salvo pochi scampati, che diedero origine al popolo
delle scimmie. “E’ per questo dunque che le scimmie somigliano agli uomini: sono il segno di un
precedente tentativo di costruzione umana, di un progetto di umanità – meri manichini, mere
sculture di legno”. Infine gli dei capirono che la materia prima giusta era il mais. Lo macinarono
sette volte, lo impastarono, e generarono così i maya, “con solo mais giallo, mais bianco per la
carne”. Curiose premonizioni darwiniane si mescolano in questo mito a una polemica neanche
troppo velata contro gli inutili “uomini di terra” creati dal Dio degli invasori bianchi. Ma anche i
Black Muslims americani di oggi credono che gli europei siano il frutto di un empio esperimento
genetico compiuto 6000 anni fa dall’”erudito degli inferi” Yaqub.
Nei secoli, rabbini e cabalisti si sforzarono di penetrare il segreto dell’”alito” che aveva infuso nella
terra la vita, finché intorno all’anno 1000 Eleazar di Worms dettò una specie di “ricetta”. Subito,
presso le comunità ebraiche dell’Europa Orientale iniziarono a comparire leggende sul “Golem”,
simulacro umano di fango che alcuni sapienti rabbini avrebbero saputo animare col tracciare sulla
loro fronte i caratteri sacri alif, mem e thaw. Un millennio di tradizioni orali, libri, opere teatrali, e
film hanno costruito una complessa epopea in cui il Golem è spesso difensore degli ebrei da
pogrom e persecuzioni, ma cresce troppo, sfuggendo spesso al controllo dei suoi creatori. In questo
caso, bisogna farlo inginocchiare per cancellarli la alif dalla fronte, e ridurlo così in polvere. Nel
1958 Jorge Luis Borges scrisse su questo mito una dissacrante poesia, in cui peccato del Golem non
è d’esser ribelle, ma solo irrimediabilmente tonto. “Gli spiegava il rabbino l’universo/ (Questo è il
mio piede, questo il tuo, la corda)/ E ottenne, in capo agli anni, che il perverso/ Spazzasse almeno
la sua sinagoga/ Ma forse s’era annidato un errore/ Nella grafia o pronuncia di quel Nome/ Ché
nonostante l’insigne magia/ Non imparò a parlare il quasi uomo”. Peccato del rabbino, invece, non
è stato l’aver voluto emulare Dio, ma semplicemente l’aver voluto agire. “Lo guardava il rabbi con
tenerezza/ E orrore. Come ho potuto (Si disse)( Dar vita a questo tormentoso figlio/ Lasciando
l’inazione, che è saggezza?/ …Nelle ore di angoscia e luce vaga/ Sul suo Golem lo sguardo
soffermava./ Chi potrà dirci che cosa pensava/ Iddio guardando il suo rabbino in Praga?”.
Una ricetta per fabbricare l’uomo è anche quella del medico alchimista Paracelso, “il Lutero della
medicina” del XVI secolo. Ma qui, rispetto a Eleazar di Worms, respiriamo già un’atmosfera quasi
scientifica. “Se la fonte di vita, chiusa in un’ampolla di vetro sigillata ermeticamente, viene
seppellita per quaranta giorni in letame di cavallo e opportunamente magnetizzata, comincia a
muoversi e a prendere vita. Dopo il tempo prescritto assume forma e somiglianza di essere umano,
ma sarà trasparente e senza corpo fisico. Nutrito artificialmente con arcanum sanguinis hominis
per quaranta settimane e mantenuto a temperatura costante, prenderà l’aspetto di un bambino
umano, con tutte le membra sviluppate come ogni bambino nato di donna, ma molto più piccolo”.
Questo homunculus, sorprendente antenato della fecondazione in provetta, farà ancora capolino
nel 1832 dal “laboratorio alla maniera del Medio Evo” di Wagner, tra le pagine del Faust di Goethe.
“Ti saluto babbino! Come va? Generarmi non fu cosa da nulla. E, dunque, vieni! Su, stringimi al
cuore proprio con tenerezza. Ma non troppo, però, dacché potrebbe volare in pezzi il fragile
cristallo”.
Già da 14 anni, però, è stato scritto il Frankenstein, Prometeo moderno, dell’allora appena 21enne
Mary Shelley, moglie del famoso poeta. Fu lei stessa a raccontare come quella cupa storia fosse nata
da un incubo, dopo aver ascoltato una conversazione tra il marito e Byron sugli esperimenti del
dottor Darwin, nonno del teorico dell’evoluzione, “che aveva conservato un pezzetto di verme in un
contenitore di vetro fino a quando, per qualche straordinaria ragione, iniziò a muoversi di moto
volontario… forse un cadavere poteva essere rianimato; il galvanismo aveva dato adito a tali
possibilità”. Il suggerimento implicito del libro sarà poi esplicitato nella scarica di fulmine che nelle
trasposizioni cinematografiche dà vita ad un mostruoso collage di pezzi di cadavere. Il
Frankenstein di Mary Shelley ha sì l’intelligenza dell’homunculus, ma il corpo sgraziato e ribelle del
Golem. “Non esiste alcuna colpa, misfatto, malvagità o sofferenza che si possa paragonare alle
mie”, si lamenta il mostro.“Quando scorro la serie spaventosa dei miei peccati, non posso credere
di essere la stessa creatura i cui pensieri una volta erano colmi di visioni sublimi e trascendentali di
bellezza e della maestosità del bene”. Anima sensibile sconvolta dal rifiuto dell’umanità verso la sua
diversità, purtroppo già nella riduzione teatrale fatta nel 1823 da Richard Brinsley Peake la
“creatura” perde questa tragica complessità, per ridursi al bamboccione tutto grugniti e
barcollamenti poi travasato al cinema.
Figlia di una pioniera del femminismo e di un filosofo proto-comunista, sposa di un ribelle
anarcoide che per scappare con lei sedicenne aveva spinto la sua prima moglie al suicidio, in
Frankenstein Mary Shelley rivela però un’insospettabile vena di moralista bacchettona. Il mostro,
spiega, “era spaventoso, perché spaventoso in modo supremo sarebbe stato il risultato di ogni
tentativo umano di parodiare lo stupendo meccanismo del Creatore del mondo”. Malgrado il titolo,
Frankenstein è dunque un anti-Prometeo, la cui potente forza di suggestione lancerà tutto un filone
di variazioni sul tema dell’inevitabile catastrofe. Il dottor Moreau di Herbert George Wells, ad
esempio, è fatto a pezzi dagli animali che ha cercato di rendere umani “immergendoli in un bagno
di truce dolore” attraverso la vivisezione. Così come è fatto a pezzi dai morti che ha riportato in vita
l’Herbert Wester rianimatore di Howard Phillips Lovecraft. Naturalmente, anche i tirannosauri e i
velociraptor clonati dal dna di sangue in zanzare preistoriche conservate nell’ambra si faranno
un’allegra scorpacciata dei maldestri impiegati del Jurassic Park. Un curioso rimpianto libertario
c’è invece col Pinocchio fatto in casa dal falegname Geppetto nella fiaba di Collodi. Come il
Poligraph Poligraphovic trasformato da randagio in uomo con un trapianto di genitali nel Cuore di
cane di Bulgakov, il burattino senza fili fa danni soprattutto perché la sua artificialità lo fa troppo
ingenuo per le malizie del reale. Ma il Brave New World di Aldous Huxley è invece uno Stato
totalitario basato sull’ingegneria genetica, e pure con la fecondazione artificiale si riproducono i più
fanatici aderenti al Partito nel “1984” di George Orwell.
Naturalmente, distruggono l’umanità che li ha creati gli automi di R.U.R.: dramma del 1920 del
ceco Karel Capek che è oggi pressoché dimenticato, ma che ha dato alla letteratura e alla tecnologia
la parola “robot”. Dalla radice slava che significa “operaio”. E scappa di mano anche la Maria-robot
dell’anno 2000, immaginata nel 1927 nel film di Fritz Lang Metropolis, per non parlare poi di Hal,
il robot assassino di 2001 Odissea nello Spazio. Ma in mezzo a tanta paranoia è poi proprio il
paranoico Philip Dick a riscattare in un suo racconto la disperata voglia di umanità degli androidi
ribelli poi trasposta nel film Blade Runner. Altre immagini non convenzionali arrivano dall’ateo
Isaac Asimov, che non solo elabora le famose “tre leggi della robotica” per regolare la morale degli
androidi, ma nel Ciclo della Fondazione arriva a fare di alcuni esseri artificiali e immortali un
surrogato di Divinità, a tutela provvidenziale dell’uomo. Mentre Charles Beaumont ci descrive
invece un prete cattolico che, dopo un’angosciosa esitazione, acconsente infine a impartire
l’estrema unzione a un morente che gli ha confessato di essere un automa, dotato di autocoscienza
per colpa di un incidente di laboratorio. Allo stesso modo, il cacciatore di nazisti Wiesenthal uccide
il medico pazzo di Auschwitz Mengele nei “Ragazzi venuti dal Brasile”, bizzarro ma avvincente film
del 1978 in cui due personaggi veri sono trasfigurati in figure da duello di super-eroi. Ma impedisce
poi agli 007 israeliani di uccidere le decine di piccoli cloni di Hitler che lo scienziato demoniaco ha
clonato nelle foreste del Paraguay: “Non sono Hitler, sono solo dei bambini!”, spiega accorato.
Sono i cloni, appunto, il grande tema delle cronache di oggi. Dalla pecora Dolly, alla proposta di
ricostruzione di un mammuth, ai blitz annunciati dal professor Antinori. Come ha ricordato lo
stesso Antinori, però, “i cloni esistono già in natura”. Dalle amebe ai gemelli: vita riprodotta in altro
modo, ma sempre dalla vita. E’ un esperimento che conoscono forse solo gli specialisti, ma fu nel
1953 che lo scienziato Stanley Miller sigillò in un contenitore metano, ammoniaca, vapore acqueo e
idrogeno, atmosfera della Terra primitiva, per poi bombardarli con una scarica elettrica. Ne
vennero fuori varie molecole organiche semplici alla base della vita, anche se non ancora la vita
vera e propria. Il fango, e il fulmine…
1. Interpretazioni antropologiche della violenza,
tra natura e cultura *
.
Fabio Dei
1.
Premessa
In questo intervento vorrei discutere il problema della violenza dal punto di vista della disciplina
di studi cui appartengo, l’antropologia culturale. In particolare, mi chiederò quali strumenti
interpretativi l’antropologia possa offrire per comprendere la massiccia presenza della violenza e
della crudeltà nella storia del Novecento.
Il nostro secolo, se da un lato è stato il culmine di quello che Norbert Elias chiama il “processo di
civilizzazione”, ha dall’altro assistito ad eventi terribili come stermini, genocidi e altre forme di uso
sistematico della violenza; eventi che hanno avuto nella Shoah il punto di maggior orrore e
visibilità, almeno per l’Europa, ma che di fatto hanno costellato con regolarità l’intero corso del
Novecento e anche gli anni a noi più vicini (basterà pensare ai casi dell’Indonesia, del Vietnam,
della Cambogia, dei Balcani e del Ruanda). Non solo: la cosa più sconcertante è che tali violenze
sono state commesse da persone normali, da “uomini comuni”, per citare il titolo dell’ormai celebre
libro in cui Christopher Browning (1992) ricostruisce la carriera di assassini e massacratori di un
gruppo di tranquilli padri di famiglia amburghesi, trovatisi quasi casualmente coinvolti nelle
strategie naziste della soluzione finale.
Come comprendere questi fenomeni? Vale a dire, come rapportarli a quella che è la nostra idea
di esseri umani razionali e civilizzati? Lo studio dei massacri nazisti, o i racconti della vita nei
campi di sterminio, sembrano suggerirci la presenza - dietro tali eventi - di determinanti profonde
e in certo qual modo nascoste del comportamento umano; determinanti che non sono
semplicemente riconducibili a un contesto storico-sociale e ad una logica della situazione,
investendo invece dimensioni più generali di carattere psicologico, antropologico o persino
etologico. Per usare le efficaci e suggestive parole dello storico Leonardo Paggi,
il massacro nazista, in ragione del suo carattere passionale [...], si configura dunque
anche come risultato di una «eredità arcaica», come collasso dei sistemi di
autocoercizione, come emergenza di comportamenti e significati quasi in via di
principio sbrigativamente estromessi dal nostro presente. Si apre qui il terreno di una
analisi antropologica del massacro, ancora tutta da fare, che difficilmente potrà evitare
di misurarsi - credo - con il grande tema dei riti sacrificali di morte, che segnano
profondamente, in senso sincronico e diacronico, tutta la storia della civiltà umana
(Paggi 1996: 8)
Paggi non vuol dire semplicemente che i nazisti sono individui regrediti a un comportamento
“primitivo”. Troviamo infatti lo stesso intreccio tra dimensione storica, antropologica e
psicoanalitica studiando il punto di vista delle vittime - ad esempio le reazioni dei superstiti dei
massacri e le modalità della loro elaborazione del lutto, che non sembrano comprensibili senza il
riferimento a configurazioni culturali più ampie, a modelli universali di comportamento. E la
riflessione sui massacri è solo un esempio possibile (per quanto centrale); analoghe considerazioni
possono esser e sono state di fatto svolte a proposito di molti altri fenomeni o eventi della storia
recente. Citerò come particolarmente significative le riflessioni di Primo Levi (1986) sul lager come
società primitiva o regredita, nella quale non solo scompaiono le istituzioni e le regole di
convivenza civili, ma si consolidano con straordinaria rapidità modelli antropologici di tipo
“barbaro” e arcaico; e il recente studio di Gabriele Ranzato (1997) sul linciaggio di un ex
funzionario fascista nella Roma del 1944, che scopre il ripresentarsi di antichi modelli socioculturali in un’esplosione di furore popolare apparentemente cieca e disordinata. Naturalmente
non è qui possibile dar conto della complessità di questo tipo di riflessioni, avanzate peraltro dagli
autori con grande cautela e consapevoleza critica. Il punto che interessa è un altro: ci troviamo in
tutti questi casi di fronte a fatti i cui contorni spazio-temporali sembrano dilatarsi a dismisura di
fronte ai tentativi di comprensione storica e umana del ricercatore, il quale si trova rinviato a
dimensioni assai generali dell’essere dell’uomo nel mondo.
Questo tipo di problema - l’intreccio fra dimensione storica e antropologica - è certamente
ineludibile, ma rischia anche di condurre verso soluzioni semplicistiche e fuorvianti. Esso può
spingerci a ricercare nelle scienze umane (o nell’etologia, o persino nella biologia) delle leggi
generali del comportamento, in grado di fornire quelle spiegazioni che non riusciamo a trovare
nella semplice analisi del contesto storico. “L’uomo è una belva” è il paradigma di questo tipo di
atteggiamento esplicativo: una affermazione (fatta propria da molti teorici, sia pure in formulazioni
complesse e raffinate) che riconduce la violenza, e molti comportamenti che contrastano con una
certa nozione di civiltà, a una presunta essenza naturale degli esseri umani.
Tesi di questo tipo, per quanto siano suggestive e per quanto le si possa difficilmente dir false,
rischiano tuttavia di risultare fuorvianti; sia perché, proprio in virtù della loro estrema generalità,
esse non riescono a spiegare nulla, a dirci cioè cose che già non sappiamo; sia perché possono
sviare la nostra attenzione dal piano delle pratiche umane storicamente situate e dei loro
significati. Vorrei sostenere che l’antropologia culturale, se può portare un contributo alla
comprensione di specifiche pratiche di violenza e crudeltà, può farlo solo a patto di non sottrarsi
alla irriducibile complessità del giudizio storico, in vani tentativi di attribuire a “leggi” universali
ciò che è invece prodotto di pratiche culturali, di motivazioni in senso lato politiche, di strategie
sociali. Non è compito dell’antropologia scoprire essenze che stanno al di là della storia. Come
ogni altra disciplina sociale, essa non può fare a meno di immergersi nei contesti storici e di
accettarne tutta la complessità e la specificità.
Nella comprensione di un fenomeno intensamente etico come la violenza, lo stesso richiamo
all’oggettività della valutazione scientifico-naturalistica può risultare ambiguo: non per caso la
naturalizzazione e l’appello a un fondo di “elementarmente umano” è una delle più diffuse
strategie di giustificazione della violenza da parte di chi ne fa uso, di occultamento dei suoi
significati in senso lato politici (v. Heritier 1997: 18 sgg.).
In altre parole, del tutto indipendentemente dalle basi biologiche e istintuali dell’aggressività
studiate dagli etologi, la violenza che si manifesta nella storia e nella vita sociale non è il contrario
della cultura ma il prodotto di un certo tipo di cultura. Non è uno sfondo naturale del
comportamento umano che si manifesta quando venga meno per un momento la vernice sottile
della civilizzazione. E’ invece un atteggiamento costruito, che si apprende con l’educazione e la
socializzazione, e che sta in stretto rapporto con le forze che regolano la cosciente vita associata
degli esseri umani: il desiderio, il potere, persino la razionalità.
Esporre il punto di vista dell’antropologia culturale, peraltro, è piuttosto difficile, dal momento
che le classiche tradizioni di studio in questa disciplina hanno raramente affrontato il problema
della violenza in modo diretto. Per motivi che non è qui possibile discutere (ma si veda in proposito
Clastres 199 ), gli antropologi hanno spesso rappresentato le società “altre” di cui si sono occupati
come libere dalla guerra e da forme vistose di violenza interpersonale. Occorrerà dunque
accerchiare il problema da prospettive, per così dire, laterali. Dopo alcune ulteriori osservazioni
sui rapporti tra determinanti naturali e determinanti culturali della violenza, passerò
schematicamente in rassegna due punti di vista che l’antropologia e le scienze umane hanno
sviluppato a proposito del comportamento violento. In primo luogo, gli studi sulle istituzioni e le
pratiche culturali volte al controllo sociale della violenza; in secondo luogo, il tema della violenza
come fondazione della civiltà. Tornerò infine sulle peculiarità di un possibile approccio
antropologico a questo tipo di problemi.
Vorrei sottolineare come si tratti non di una trattazione sistematica ma di una pista di lavoro,
volta semplicemente a sollecitare successivi approfondimenti e affinamenti della riflessione.
2. Violenza tra natura e cultura.
La risposta alla domanda «perché gli uomini sono violenti?», almeno in un certo senso, è molto
semplice e scontata. Ovviamente, aggressività e violenza fanno parte della dotazione biologica e
istintuale del genere umano. Noi sentiamo il bisogno di «spiegare» il comportamento violento
perché lo vediamo come una contraddizione in relazione ai valori della cultura - di quella cultura su
cui si basa la nostra identità di esseri umani. Ma dobbiamo considerare che l’evoluzione culturale
ha avuto ed ha tempi assai più rapidi di quella biologica; cosicché, siamo in presenza di uno scarto
fra la costituzione zoologica dell’uomo e la sua cultura - intendendo qui con cultura, naturalmente,
l’insieme delle pratiche, delle idee, degli strumenti, delle istituzioni e di tutti gli elementi non
biologici attraverso i quali una comunità umana si adatta al mondo.
Scrive l’etnologo francese A.Leroi-Gourhan, in Il gesto e la parola :
L’homo sapiens è nato al tempo delle steppe per la caccia al cavallo selvatico e si è
adattato progressivamente alla locomozione seduta, in un’atmosfera di petrolio
bruciato [...]. Tutta l’ascesa delle civiltà si è realizzata con quello stesso uomo fisico e
intellettuale che faceva la posta al mammuth; la nostra cultura elettronica, che ha
appena 50 anni, si regge su un apparato fisiologico che risale invece a 40000 anni fa. Se
c’è motivo di aver fiducia nelle possibilità di adattamento, tuttavia la distorsione esiste
ed è evidente la contraddizione fra una civiltà dai poteri quasi illimitati e un
civilizzatore la cui aggressività è rimasta immutata dal tempo in cui uccidere la renna
significava sopravvivere (Leroi-Gourhan 1964-5: 464)
Sembrerebbe dunque di poter considerare la violenza e l’aggressività come limiti della civiltà retaggi di una costituzione naturale che la cultura non è riuscita ancora a modificare o soffocare, e
che riemerge, per così dire, negli interstizi della civiltà.
Ma questa sarebbe una concezione semplicistica: perché in realtà gli aspetti naturali e quelli
culturali dell’evoluzione, come ha mostrato lo stesso Leroi-Gourhan, non si sono semplicemente
contrapposti gli uni agli altri, ma si sono compenetrati. In particolare, è caratteristica peculiare
della cultura, intesa in senso antropologico, la capacità di plasmare la «dotazione naturale» degli
esseri umani - in modo tale che è difficile parlare di una pura base naturale del comportamento.
Ciò che noi consideriamo «naturale» ha spesso il carattere di una seconda natura. O, per dire la
stessa cosa in termini un po’ diversi, è all’interno di un insieme di condizioni culturali che si
determina il concetto stesso di natura - cioè, ogni cultura definisce al proprio interno la linea di
demarcazione tra ciò che è naturale e ciò che è culturale. Questa demarcazione è dunque
culturalmente plasmata.
Possiamo forse capire meglio questo punto pensando al concetto di paesaggio naturale. Noi
consideriamo come natura boschi o campagne che in realtà sono profondamente modificati
dall’intervento umano, spesso persino costruiti, e sono dunque in senso stretto paesaggi culturali.
Nondimeno, noi giustamente li contrapponiamo oggi ai paesaggi urbani, cementificati, etc. - e
usiamo le categorie di naturale e artificiale per dar senso a questa contrapposizione, che è parte
importante e cardine della nostra visione del mondo. Si può criticare questo punto di vista in
quanto arbitrario, ma non avrebbe molto senso appellarsi a una natura più pura e autentica, che
per noi non può esistere. Anche le politiche del “rinselvatichimento” e della regressione radicale
all’animalità, come sono teorizzate ad esempio da alcune frange del pensiero ambientalista, sono
scelte profondamente culturali.
Per usare un’altra metafora, possiamo immaginarci la cultura come il software per il cui tramite
dialoghiamo col mondo: un programma o un sistema operativo che ha alle spalle un hardware, il
quale pone limiti oggettivi (la capacità di memoria, la velocità del processore etc.). Ma dalle
caratteristiche dell’hardware non si può inferire molto delle caratteristiche del software. E in ogni
caso, trovandoci all’interno del programma, non possiamo sfuggirgli appellandoci per così dire a un
dialogo diretto con la macchina che lo fa girare. Inoltre, ci troveremmo di fronte ad un software
molto particolare, in grado, in tempi lunghi, di modificare le stesse caratteristiche dell’hardware
che lo sostiene, potenziando magari il processore, aggiungendo o eliminando alcune periferiche etc.
Tutto questo per sottolineare che la violenza e l’aggressività, per quanto indubbiamente radicate
nella costituzione biologica ed etologica dell’uomo, si manifestano nel comportamento umano,
all’interno di determinate civiltà e società, in modi culturalmente e storicamente plasmati. E’
questo un punto essenziale per la nostra riflessione. Il senso comune può oggi farci considerare la
violenza come un residuo - ciò che resta quando si cancelli o si azzeri momentaneamente la cultura,
la «belva dentro di noi» che talvolta riemerge alla superficie. In realtà, ciò che noi oggi
consideriamo violenza è frutto di un processo storico molto preciso e anche molto recente, di una
ridefinizione continua della linea di demarcazione tra natura e cultura.
Per riflettere su questo punto è essenziale riferirsi ai lavori di Norbert Elias, che ricostruiscono la
storia dell’Occidente nei termini di un continuo processo di spostamento della linea che demarca i
comportamenti accettati da quelli non accettati, quelli normali da quelli abnormi, e che in sostanza
accentua progressivamente gli elementi di controllo sui sentimenti, le emozioni, le scariche
pulsionali e i contatti fisici diretti tra gli esseri umani. Secondo Elias, attraverso le diverse epoche
storiche si sono formate barriere sia istituzionali che psicologiche contro la manifestazione
immediata dei sentimenti, contro i contatti fisici che non rientrino in sfere ben determinate come
quella della sessualità, dello sport o di rituali sociali estremamente controllati (il bacio, la stretta di
mano, etc.); ed è cambiato molto l’atteggiamento nei confronti della violenza. In un volume
tradotto in italiano col titolo La civiltà delle buone maniere, Elias confronta ad esempio le
manifestazioni dell’aggressività nelle moderne società occidentali con quelle che caratterizzavano il
Medioevo. Nelle prime, l’aggressività risulta fortemente controllata e attenuata, persino in contesti
come la guerra:
essa è stata condizionata, pur nel mezzo dell’azione bellica, dalla più avanzata
divisione delle funzioni, dal più accentuato legame tra i singoli individui, dalla
maggiore dipendenza degli uni dagli altri e di tutti dall’apparato tecnico; è stata limitata
e smussata da un’infinità di regole e divieti che sono diventati autocostrizioni (dunque
sono stati interiorizzati). Si è pertanto trasformata, raffinata e civilizzata come tutte le
altre forme di piacere; e soltanto nel sogno o in singole esplosioni, che registriamo
come fenomeni patologici, si riaffaccia in parte con la sua forza immediata e scatenata
(Elias 1988: 346).
Per il Medioevo, al contrario, Elias documenta il piacere di uccidere e torturare come
manifestazione di potere, e la presenza dei valori della violenza nel codice cavalleresco, che noi
associamo di solito a valori di altro tipo. E traccia un profilo psicologico dell’uomo medioevale
come dominato da sentimenti contrastanti ma fortissimi, da esplosioni improvvise di gioia e
allegria, dalla facilità di infiammarsi in reazioni di odio e aggressività:
Gli impulsi, le emozioni si manifestavano in modo più libero, più scoperto e più
diretto di quanto sarebbe avvenuto in seguito. Siamo soltanto noi, divenuti più
moderati, più misurati e più calcolatori, noi che nella nostra eonomia pulsionale
abbiamo interiorizzato in misura assai maggiore come autocostrizioni i tabù sociali, a
considerare contraddittoria - ad esempio - la grande devozione religiosa e le
manifestazioni di aggressività e di assoluta crudeltà. Nella società medioevale, chi non
sapeva amare o odiare con tutte le sue forze era destinato all’emarginazione sociale:
così come, in società successive (p.es nella vita di corte delle grandi monarchie), vi sarà
destinato chi non sarà in grado di dominare le sue passioni e celare i suoi affetti,
dimostrandosi così «civile» (Ibid.: 358).
Questi mutamenti sono legati per Elias all’affermarsi di un potere centrale (virtualmente assente
nel Medioevo) che assume il monopolio della violenza e della sopraffazione fisica, non consentendo
più ai singoli individui di esercitarla (salvo a poche persone delegate a tal scopo, come il boia, il
poliziotto, il soldato; o salvo situazioni controllate come i rituali e lo sport; ma anche nei rituali e
nello sport si assiste a un processo di progressiva civilizzazione o «sublimazione», in cui la violenza
è simbolizzata più che realmente agita).
Violenza è dunque di per sé una categoria astratta: vi sono comportamenti violenti e concezioni di
ciò che è violenza che mutano socialmente e storicamente. Ciò che è normale oppure patologico e
deviante, ciò che ha bisogno o meno di una spiegazione, cambia a seconda dei concreti contesti
culturali. Ma allora, quello che può sembrare l’insorgere di una violenza incontrollata e naturale, è
spesso di fatto un comportamento governato da regole culturalmente e socialmente approvate.
Vorrei precisare che questo punto di vista non equivale affatto all’affermazione di un assoluto
relativismo culturale. E’ del tutto evidente, come già detto, che le scelte culturali hanno luogo
all’interno di limiti stabiliti dalla “natura”, e che possono esser descritti ad esempio in termini
biologici, etologici o psicologici. Ma occorre distinguere tra tipi diversi di problemi. Una cosa è il
problema delle cause o dell’origine dell’aggressività umana, che non può esser risolto senza il
riferimento alle caratteristiche zoologiche ed etologiche della specie homo sapiens; altra cosa è il
problema della comprensione del significato di pratiche violente all’interno di specifici contesti
storici e culturali, rispetto al quale la spiegazione naturalistica è quasi sempre di per sé irrilevante.
3.
Il controllo sociale della violenza.
Ora, l’antropologia culturale è interessata per l’appunto al modo in cui gli istinti, le pulsioni, la
dotazione biologica dell’uomo è plasmata all’interno di ogni singola cultura. Per la verità, come ho
già detto, la violenza non è mai stato un soggetto centrale e cruciale nei dibattiti antopologici: sia
nel senso che raramente si è trovata al centro di grandi elaborazioni teoriche (con almeno
un’eccezione importante, su cui tornerò), sia nel senso che pochi contributi etnografici si sono
soffermati a fondo sul problema delle diverse sensibilità alla violenza e dei diversi codici di
manifestazione dell’aggressività presenti in specifiche culture (per delle recenti eccezioni si vedano
i saggi raccolti in Riches 1986 ed Heritier 1997). Tuttavia, questi problemi sono spesso implicati
nelle discussioni sui sistemi sociali e politici, sulla struttura dell’ethos o dei valori, sui rituali e sulla
religione.
In modo particolare, l’attenzione degli antropologi si è appuntata sulle modalità del controllo
sociale della violenza. L’antropologia sociale e politica classica è partita spesso dal presupposto
hobbesiano di un originario homo homini lupus: la società e le sue istituzioni, per esistere, hanno
bisogno che sia ridotto e controllato il potenziale di aggressività e violenza che ciascun individuo
porta dentro di sé, in virtù della sua costituzione biologica. Gli animali, come ci insegna l’etologia,
possiedono meccanismi di controllo e ritualizzazione degli istinti aggressivi verso i loro simili,
senza i quali sarebbe messa in pericolo forse la stessa sopravvivenza della specie, e in ogni caso la
vita sociale, l’unità del branco etc. L’uomo sembra non possedere in modo naturale simili impulsi
inibitori: dev’esser dunque la società, tramite le sue istituzioni, a fornirli. Si deve trattare di
istituzioni che consentono all’individuo di «scaricare» le sue pulsioni aggressive, incanalandole
però in direzioni che non danneggino l’ordine e la stabilità della società stessa.
Queste istituzioni potrebbero esser classificate a seconda della loro prossimità alla violenza fisica
vera e propria. Ad esempio, all’estremo più violento sta probabilmente l’istituzione della cosiddetta
«faida di sangue», presente in modo più o meno formalizzato tra molti popoli di agricoltori e
allevatori, in particolare quelli con una struttura sociale segmentaria. La faida consiste - almeno in
apparenza - nel diritto-dovere di vendicare una uccisione attraverso un’altra uccisione, secondo il
principio della legge del taglione. In realtà si tratta di una istituzione molto complessa, tipica di
società in cui manca un potere giudiziario centrale, e che stabilisce regole per la risoluzione dei
conflitti tra lignaggi che sono aperti da un omicidio. In sostanza, la tradizione accetta che i membri
di un lignaggio (gruppo di parentela) cerchino di vendicare la morte di uno di loro uccidendo
l’assassino o un membro del lignaggio dell’assassino: la seconda uccisione ristabilirebbe un
equilibrio sociale che era stato infranto dalla prima. Ma, di fatto, la vendetta non ristabilisce mai
l’equilibrio: il gruppo che la subisce tende a interpretarla come un’offesa ulteriormente squilibrante
che deve a sua volta esser vendicata, e così via - potenzialmente ad infinitum. L’istituzione della
faida consiste allora nell’apertura di una serie di trattative e contrattazioni tra i due lignaggi rivali,
con lo scopo di risolvere il «debito» possibilmente senza spargimento ulteriore di sangue, e
comunque evitando il dilagare a macchia d’olio del conflitto.
La più classica descrizione del sistema è quella contenuta in una famosa monografia etnografica
dell’inglese E.E.Evans-Pritchard, a proposito della popolazione nilotica dei Nuer (1940 ). Tra di essi
esiste una figura politica specifica, il cosiddetto «capo dalla pelle di leopardo», che non ha un
potere reale ma svolge il delicato compito di mediare nelle faide, convincendo ad esempio la parte
lesa ad accettare un compenso di tipo economico, o comunque un qualche compromesso che ponga
fine definitivamente e senza strascichi alla disputa. A noi occidentali moderni questa sembra una
strana forma di giustizia. In realtà non si tratta affatto della punizione di un crimine, come noi la
intendiamo, ma di un riequilibrio tra due segmenti sociali, che è stato rotto dal primo atto di
violenza e che dev’essere in qualche modo ripristinato. Se non si ripristina l’equilibrio, il principio
della vendetta potrebbe dilagare fino ad investire l’intera comunità.
Questo ci sembra strano, perché siamo abituati alla gestione delle sanzioni da parte del potere
centrale, e al fatto che un assassinio è un crimine eminentemente pubblico, anche se lede interessi
privati. Ma a molti popoli africani questi concezione della giustizia è estranea: a loro è sembrato
molto strano, al contrario, vedere gli amministratori coloniali imprigionare ed eventualmente
giustiziare un omicida, senza preoccuparsi del compenso da dare al gruppo che ha perso un
membro. Questa è una punizione che non risolve il problema dell’equilibrio; laddove un compenso
o persino una vendetta omicida, che non colpisca però l’autore del primo delitto, è considerata
perfettamente soddisfacente. In alcune società, come i Berberi del Nordafrica, un rigoroso
principio di equivalenza stabiliva che la faida dovesse colpire una persona dello stesso rango sociale
di quella uccisa. Cosicché, se un uomo di un gruppo uccide una donna di un altro gruppo, la
vendetta si appunterà su una donna del gruppo dell’assassino, non sull’uomo colpevole (Beattie
1964: 246. In questa ricerca di equilibrio conta il danno subito dal soggetto-gruppo, non
dall’individuo come soggetto di diritti; inoltre, non si fa nessuna distinzione tra omicidio volontario
e involontario, premeditato o colposo.
La faida di sangue è solo un esempio. Vi sono molte altre istituzioni di regolazione della violenza
che non la vietano ma si limitano a circoscriverla. Anche la storia occidentale ne conosce: basti
pensare al duello. Fra le istituzioni che più si allontanano dall’esercizio reale della violenza per
proporne una rappresentazione ritualizzata, che può però produrre effetti catartici, si può citare lo
sport. Lo stesso Elias considera lo sport moderno come una sorta di sublimazione degli istinti
aggressivi e conflittuali, che si afferma con il procedere del processo di civilizzazione - e dunque con
l’aumento dell’autocontrollo e delle inibizioni alla diretta manifestazione degli impulsi violenti.
Questo processo di controllo della violenza è sicuramente centrale nella genesi dello sport
moderno; ma riconoscere questo non vuol dire accreditare la tesi che lo sport è semplicemente una
valvola di sfogo per la «belva che è in noi». Le cose sono molto più complesse. Come chiave di
comprensione del tifo calcistico, la tesi della scarica pulsionale è assai semplicistica e banale. Il
calcio è un universo simbolico nei cui termini i tifosi possono esprimere aspetti della loro identità e
relazionarsi agli altri in modi non consentiti nella normale vita quotidiana - modi che implicano e
legittimano anche una certa dose di aggressività e violenza. Ma non c’è motivo di dire che il calcio è
socialmente utile perché scarica violenza e incanala i conflitti in direzioni sostanzialmente innocue:
potremmo altrettanto bene affermare che crea nuovi conflitti e nuove occasioni di violenza (si
vedano in proposito Dal Lago 1990, Roversi 1992 e, per una sintesi del dibattito, Dei 1992).
Tornando alla tradizione classica degli studi antropologici, l’istituzione di controllo della
conflittualità che più ha attratto il loro interesse è probabilmente la stregoneria. La stregoneria è un
insieme di credenze e pratiche sociali largamente diffuso in molte culture tradizionali di tutto il
mondo, e che come ben sappiamo ha svolto un ruolo di primo piano nella stessa storia della civiltà
occidentale. Possiamo definirla, sul piano delle rappresentazioni, come la credenza nel potere di
alcuni individui di nuocere ad altri per mezzo di poteri magici. Questi poteri, posseduti come dote
naturale o appresi attraverso un apprendistato magico, risultano in attacchi violenti di tipo
personale in grado di produrre fallimenti nella vita economica e sociale, disgrazie, malattie, morte.
Sul piano delle pratiche sociali, la stregoneria consiste in un sistema di accuse: in altre parole, essa
si manifesta socialmente quando qualcuno viene accusato di praticarla e di aver provocato tramite
essa danni particolari a particolari persone. Queste accuse seguono invariabilmente i canali
dell’invidia e della conflittualità sociale, manifestandosi ad esempio nei rapporti di vicinato, in
quelli di concorrenza economica, e così via.
In apparenza, l’insorgere delle accuse di stregoneria provoca liti e conflitti che non avrebbero di
per sé ragione di essere: a uno sguardo superficiale, ci troviamo di fronte a credenze superstiziose
che minacciano arbitrariamente rapporti sociali i quali, senza di esse, si manterrebbero tranquilli e
pacifici. In realtà, l’opinione prevalente tra gli studiosi è che la stregoneria rappresenti proprio un
sistema di risoluzione della conflittualità interna a un gruppo sociale, che ne consente l’espressione
ma permette al tempo stesso di “scaricarla” e neutralizzarne gli effetti disgreganti attraverso
comportamenti socialmente riconosciuti e legittimati. E’ ancora una volta all’opera di EvansPritchard che possiamo rivolgerci in cerca di esempi: il suo studio pionieristico sulla popolazione
africana degli Azande (1937) costituisce la più classica formulazione di questa tesi, oltre che una
insuperata rappresentazione etnografica delle credenze nella stregoneria e delle relative pratiche
divinatorie.
La tesi di Evans-Pritchard è che tali credenze siano al contempo un modo intellettualmente
soddisfacente di spiegare la sfortuna e di dare un senso all’insorgere del male, da un lato, e
dall’altro un modo di esprimere i sentimenti più negativi e distruttivi legati alla vita sociale (i timori
e le ansie, così come l’odio e le tendenze aggressive). Il linguaggio della stregoneria consentirebbe
di dare un ordine e un significato a esperienze oscure e a pulsioni disgreganti, per le quali non vi
sarebbe altrimenti alcun orizzonte di risoluzione. Non sono le rappresentazioni magiche, di per sé,
a creare conflitti: esse vanno per così dire a riempire canali conflittuali già presenti, almeno
potenzialmente, plasmandoli in modo da esser socialmente riconosciuti e, se possibile, risolti e
superati. Le pratiche divinatorie che gli Azande seguono per scoprire la presenza della stregoneria,
e per accusare qualcuno di averla esercitata (volontariamente o anche solo involontariamente),
permettono che il conflitto si manifesti apertamente senza sfociare nella violenza aperta e diretta, e
lasciano sempre aperte modalità di risoluzione contrattata e pacifica.
Su un piano un po’ diverso, si potrebbero citare molte altre istituzioni che hanno, almeno in
apparenza, una funzione catartica o di «valvola di sfogo». Tra di esse:
- le feste annuali, di cui il caso più noto è forse quello dei Saturnali romani, nelle quali si
sprigiona la carica di aggressività e di furore distruttivo che è stata repressa nel corso di un intero
anno - secondo il principio semel in anno licet insanire. Il Carnevale e il Capodanno moderni
conservano qualcosa di queste feste antiche o tradizionali - con la caduta dei freni inibitori, delle
regole di convenienza sociale, degli stutus socialmente acquisiti, e con i rituali di inversione sociale
e sessuale, etc.
- Il cordoglio in occasione del lutto. In molte culture i rituali funerari implicano manifestazioni di
violenza e furore, fino a giungere al cannibalismo rituale, alla licenziosità sessuale, a manifestazioni
agonistiche (si pensi ai funerali di Patroclo nell’Iliade, o all’istituzione del pianto rituale in molte
culture popolari dell’Europa meridionale; v. De Martino 1958 per uno studio classico di questi
fenomeni);
- i riti di iniziazione, attraverso i quali in molte società arcaiche si media ritualmente l’ingresso di
un giovane nel mondo adulto. Essi implicano spesso una decostruzione della personalità sociale del
giovane, che per così dire deve rinselvatichire prima di diventare uomo a tutti gli effetti: per cui,
durante i riti iniziatici, si incoraggia l’esplosione del furore distruttivo, con comportamenti da
animale da preda, attacchi indiscriminati rivolti contro tutti e così via (per un’analisi recente v.
Bloch 1997).
Questi sono tutti esempi di comportamenti violenti accettati e persino incoraggiati e codificati dalla
società e dalla cultura. Possiamo pensare a tali istituzioni come a recinti protetti in cui la naturale
aggressività degli individui può manifestarsi liberamente, senza mettere in pericolo il tessuto delle
relazioni sociali. O forse, più produttivamente, possiamo pensarle come modi di plasmazione
culturale dell’aggressività, in cui la violenza funziona da materiale significante nell’espressione di
codici, valori, status sociali.
Ora, possiamo chiederci, questi esempi tipici di società tradizionali ci dicono qualcosa sulle
manifestazioni della violenza nella società occidentale contemporanea? Già all’inizio degli anni ’60
Ernesto De Martino, uno dei padri fondatori degli studi antropologici italiani, esplorava
l’accostamento tra fenomeni come i riti di iniziazione o le feste di rovesciamento simbolico e le
pratiche violente eminentemente moderne che cominciavano allora a intravedersi nella subcultura
giovanile - l’azione delle bande di teppisti, le esplosioni di furore di gruppo etc. Egli notava però
come in tutti i fenomeni tradizionali l’esplosione del furore sia seguita, in modo rigidamente
codificato, da un superamento, da quella che chiamava una reintegrazione dell’ordine culturale.
L’apparente infrazione delle regole serviva in definitiva a ripristinarle con maggior forza; laddove
nei fenomeni del teppismo giovanile contemporaneo questo momento di reintegrazione sembra
mancare, e le manifestazioni di violenza sembrano seguire semplicemente la direttrice anti-sociale
e anti-culturale per eccellenza del freudiano istinto di morte.
L'accostamento proposto da De Martino (1962) fra riti di iniziazione, Saturnali e teppismo
giovanile è molto interessante e meriterebbe di esser ripreso, anche a proposito degli innumerevoli
episodi che la cronaca non manca quotidianamente di segnalarci: è un approccio interessante e
correttivo rispetto a certe semplificazioni e letture psicologiche che di questi fatti ci vengono
proposte. Si pensi a quanto ha circolato lo slogan delle «teste vuote» a proposito dei lanciatori di
sassi sulle autostrade, o degli incidenti in auto dopo la discoteca e così via. Nella prospettiva che ci
propone De Martino quelle teste sono piene, fin troppo piene, per così dire, perché riproducono
valori e schemi comportamentali che sono profondamente radicati nella cultura tradizionale
(naturalmente, una tale osservazione non mira in alcun modo a giustificare quei comportamenti,
bensì a comprenderli sulla base di un codice culturale piuttosto che su un presupposto di
imbecillità). Mi pare semmai dubbio attribuire un carattere totalmente asociale alla violenza delle
bande giovanili, dei frequentatori delle discoteche o dei tifosi del calcio. Forse il problema è che
non riusciamo a capire i nuovi codici attraverso cui la cultura giovanile si esprime, e le particolari
modalità di reintegrazione che in essi operano; non vi è reintegrazione possibile solo in quei casi in
cui il furore distruttivo o autodistruttivo assume forme irreversibili, come nella tossicodipendenza.
4.
La violenza come fondazione della società.
Molti studi antropologici mettono dunque l’accento sulle forme di controllo sociale della violenza,
elaborando varianti della teoria politica hobbesiana: è come se gli impulsi aggressivi e violenti
fossero un ingombrante fardello che gli individui si portano dietro, e che è compito delle istituzioni
comunitarie e della cultura condivisa smussare, attenuare e neutralizzare. Come a dire che violenti
sono gli individui, per una sorta di imperfezione costituzionale, ma non le società. Vi sono però
anche altri punti di vista, per certi versi contrapposti, secondo i quali la società e la cultura non
sono così innocenti, e fondano anzi la loro presa sugli individui proprio sulla gestione della
violenza. Vorrei brevemente discutere tre autori, peraltro molto noti, che esemplificano con
efficacia questa prospettiva: Frazer, Freud e Girard. Per tutti e tre questi pensatori la civiltà
contemporanea, fondata sulla rimozione della violenza fisica, è una crosta sottile che nasconde una
ben più profonda costituzione selvaggia: non solo nel senso che gli individui sono in ultima analisi
delle belve, che l’uomo è ancora quello che faceva la posta al mammuth, come dice Leroi-Gourhan,
ma nel senso che le stesse istituzioni civili si fondano su un atto originario di violenza, senza il
quale non sarebbero possibili. E che in fin dei conti, dunque, la violenza è la «verità» della società
civilizzata, che le istituzioni moderne cercano di nascondere ma che riemerge negli interstizi della
civiltà.
James G. Frazer è uno dei più famosi antropologi della scuola evoluzionista britannica; studioso
di formazione e di stampo ottocentesco, è tuttavia autore di uno dei libri che ha più influenzato la
cultura del ventesimo secolo e in particolare i movimenti modernisti, Il ramo d’oro. Si tratta di uno
studio monumentale sulle credenze e pratiche magiche e religiose diffuse tra i popoli che allora si
dicevano primitivi o selvaggi, nonché nelle culture classiche e nel folklore rurale europeo. Per
quanto pensato come trattato scientifico, Il ramo d’oro è costruito narrativamente come tentativo
di spiegare una istituzione culturale documentata da alcuni autori classici: la regola di successione
tramite duello del “re del bosco”, custode del tempio di Diana presso il lago di Nemi. Chi sfida e
uccide in duello il re del bosco gli subentra nella carica, finché non sarà a sua volta sfidato e ucciso
da qualcuno più giovane e più forte di lui. Frazer ritiene che questa cruenta regola di successione
sia volta a garantire il rinnovamento del ruolo di re o sacerdote al momento del declino della forza
fisica della persona che lo ricopre. Ciò lo porta alla scoperta di un tratto culturale caratterizzante, a
suo parere, l’intero mondo antico, le culture «primitive» e tutte le civiltà agricole: il tema mitico di
un dio, rappresentante della vegetazione, che muore e risorge, a simboleggiare la decadenza e la
rinascita del mondo vegetale e dunque delle risorse alimentari. A ciò è connessa la pratica di
uccidere ritualmente rappresentanti umani dello spirito della vegetazione, al fine di promuovere
magicamente la crescita del raccolto, e molte analoghe pratiche che hanno comunque tutte al
centro il sacrificio umano perpetrato per il benessere dell’intera comunità.
Il Ramo d’oro ha una struttura estremamente complessa, che non è qui il caso di tentare di
sintetizzare (mi permetto di rimandare a Dei 1998 per un’analisi più approfondita). Il suo filo
conduttore esplicito sono le credenze magiche e religiose, presentate come superstizioni basate su
errori intellettivi; ma il tema che domina in modo ossessivo il libro è quello del sacrificio umano,
sia che ad esser ucciso sia un re divino al declino della sua gioventù, come in alcune tradizioni
africane; oppure uno straniero che si trova a passare per i campi al momento del raccolto del grano,
come nelle tradizioni del Mediterraneo antico e nel mito greco di Litierse; un capro espiatorio, su
cui sono riversati i peccati accumulati dall’intera comunità; una ragazza addestrata e preparata,
come nei sacrifici aztechi - e così via. Il benessere della comunità si fonda su questi atti di violenza
subiti da singoli individui. E, ciò che più conta in Frazer, la cultura attuale porta il segno di questa
violenza originaria, appena sotto la superficie di innocenza e civiltà.
A leggere Frazer, si è colpiti dal fatto che moltissimi elementi della nostra cultura vengono
risemantizzati, per così dire, e rivelano sinistre e inquietanti profondità. Le feste contadine, i giochi
dei bambini, alcuni innocenti modi di dire, ci appaiono come sopravvivenze di antiche pratiche
sacrificali, nelle quali era in gioco la morte di un uomo per il bene dell’intera società. E per quanto
Frazer sia un pensatore vigorosamente razionalista e un convinto sostenitore del progresso
scientifico, la sua opera è intessuta di metafore che mostrano la debolezza e la fragilità del proceso
di civilizzazione. Quest’ultimo è rappresentato come la superficie del mare in continuo movimento,
sotto la quale si estende l’immota profondità degli abissi; come una striscia sottile di terra sotto la
quale romba un vulcano; o come un pallido cerchio di luce circondato dalle tenebre della notte. Il
vulcano, le tenebre, gli abissi sono le strutture invarianti del pensiero magico-religioso e delle
connesse pratiche di sacrificio cruento: dalla lettura del Ramo d’oro, esse appaiono come una sorta
di essenza originaria e autentica della cultura umana, che nessun progresso e nessuna scienza
riescono in definitiva a scalfire, e che anzi si ripresentano nelle modernità sotto nuove vesti. Sarà
questa idea di una essenza selvaggia che informa la stessa civiltà moderna ad affascinare il pensiero
e la letteratura modernista, che coniugherà spesso in questa chiave l’antropologia frazeriana con
la psicoanalisi.
Freud è naturalmente un autore essenziale per il problema della violenza, prima di tutto in
relazione alla nozione di pulsione di morte, cui gli stessi storici hanno talvolta fatto ricorso di fronte
allo “scandalo” dei massacri e dei genocidi. Qui interessa per la parte più propriamente
antropologica del suo lavoro, quella di Totem e tabù, dove ci racconta una specie di mito su una
violenza originaria che dei figli archetipici, per così dire, avrebbero commesso su un padre
archetipico, e che avrebbe dato origine alla religione e alla civiltà stessa. Il mito è questo (costruito
a partire da varie fonti antropologiche ma assolutamente fantasioso).
[Nell'orda primitiva] vi è solo un padre prepotente, geloso, che tiene per sé tutte le
femmine e scaccia i figli via via che crescono. Un certo giorno i fratelli scacciati si
riunirono, abbatterono il padre e lo divorarono, ponendo fine così all'orda paterna [...]
Che essi abbiano anche divorato il padre ucciso, è cosa ovvia trattandosi di selvaggi
cannibali. Il progenitore violento era stato senza dubbio il modello invidiato e temuto
da ciascun membro della schiera dei fratelli. A questo punto essi realizzarono,
divorandolo, l'identificazione con il padre, ognuno si appropriò di una parte della sua
forza. Il pasto totemico, forse la prima festa dell'umanità, sarebbe la ripetizione e la
commemorazione di questa memoranda azione criminosa, che segnò l'inizio di tante
cose: le organizzazioni sociali, le restrizioni morali e la religione (Freud 1913: 193-4).
Dopo il parricidio, nessuno dei fratelli può prendere il posto del padre, perché ciascuno lo
impedisce all'altro. La loro vita psichica, caratterizzata dall'ambivalenza (come nel caso dei
bambini e dei nevrotici, non manca di ricordarci Freud), è invasa dal rimorso e dal senso di colpa.
Quelli che erano stati i divieti imposti dal padre, i fratelli li interiorizzano sotto forma di coscienza
morale, fondando nientemeno che la società, l'etica e la religione:
Morto, il padre divenne più forte di quanto fosse stato da vivo [...] Ciò che prima egli
aveva impedito con la sua esistenza, i figli se lo proibirono ora spontaneamente nella
situazione psichica dell'«obbedienza retrospettiva», che conosciamo così bene
attraverso la psicoanalisi. Revocarono il loro atto dichiarando proibita l'uccisione del
sostituto paterno, il totem, e rinunciarono ai suoi frutti, interdicendosi le donne che
erano diventate disponibili. In questo modo, prendendo le mosse dalla coscienza di
colpa del figlio, crearono i due tabù fondamentali del totemismo, che proprio perciò
dovevano coincidere con i due desideri rimossi del complesso edipico (Ibid.: 195;
corsivo nell'originale).
Questa la storia raccontata da Freud. La «coscienza di colpa del figlio», come la definisce, è per
lui il fondamento psicologico di tutte le religioni successive; così come la figura del padre, per il
tramite del totem, è la base di ogni concezione di Dio.
Non ci interessa tanto, in questo mito, la spiegazione di istituti culturali quali il totemismo e
l’esogamia, quanto il fatto che Freud faccia derivare dalla violenza bruta del parricidio primordiale
le principali funzioni sociali: la struttura sociale, il cui nucleo risiede nelle regole esogamiche; la
religione, di cui il totemismo rappresenta appunto il nucleo; e l’etica, l’interiorizzazione dei divieti,
che in definitiva è la condizione di quello che Elias chiama il processo di civilizzazione.
Di più : per Freud, la storia del parricidio primordiale, che egli presenta come punto nodale
dell’evoluzione culturale, si ripresenta in qualche modo sul piano ontogenetico, nell’evoluzione
psicologica di ciascun individuo (perlomeno degli individui maschi, perché com’è noto la psicologia
freudiana è modellata su una soggettività di genere maschile, anche se molte delle sue pazienti
erano donne). Il tema del parricidio primordiale è cioè il nucleo del complesso edipico, anche se si
tratta naturalmente di un parricidio immaginato e rappresentato. Cosicché, in definitiva, il
desiderio e la violenza originaria stanno alla base della costituzione psicologica di ciascuno di noi sono la «verità» che si nasconde dietro gli istituti civili della religione, della famiglia, della morale.
Il francese René Girard è autore molto più recente di Frazer e Freud. Ha raggiunto una certa
celebrità negli anni ’70, con un libro dal titolo La violenza e il sacro. Per quanto ci riguarda, è
autore importante perché è di fatto l’unico antropologo (anche se sulla sua definizione come
antropologo si potrebbe discutere) che tematizza in modo diretto la violenza, ponendola al centro
di un affresco teorico affascinante seppur altamente speculativo. Girard rilegge Frazer e Freud, è
colpito dalle loro storie che pongono la morte violenta all’origine della società; tuttavia, rifiuta le
rispettive teorie che legano la violenza originaria alla magia, per Frazer, e all’ambivalenza della
situazione edipica per Freud. Dal suo punto di vista, è la pratica del sacrificio l’atto cruento su cui si
fonda la società civile. Il sacrificio, atto violento, è per lui tuttavia l’unico argine che la società riesce
a porre al dilagare incontrollato di una violenza disgregante e distruttrice.
Secondo Girard, il rischio radicale che ogni società umana si trova a dover fronteggiare, fin dalle
origini, è quello della disgregazione sotto la spinta dell’aggressività reciproca degli individui, che si
espanderebbe come un contagio sulla base di quel principio basilare che è la vendetta. La faida di
sangue, discussa prima, è il punto di partenza della stessa riflessione di Girard (anche se la sua
interpretazione di questo istituto non è probabilmente molto corretta sul piano etnologico): la faida
di sangue allude ad una catena di vendette (secondo il principio per cui un atto di violenza chiede
una risposta riequilibratrice) che giungerebbe a investire da ultimo l’intero corpo sociale. A questo
rischio Girard dà il nome di violenza essenziale :
una società primitiva, una società che non possiede alcun sistema giudiziario, è
esposta [...] alla escalation della vendetta, all’annullamento puro e semplice cui d’ora in
poi daremo il nome di violenza essenziale: si vede perciò costretta ad adottare nei
confronti di questa violenza certi atteggiamenti per noi incomprensibili. Se non
riusciamo a capire è perché noi non sappiamo assolutamente nulla della violenza
essenziale, nemmeno che esista, e perché gli stessi popoli primitivi conoscono tale
violenza solo in forma quasi del tutto disumanizzata, ossia sotto le parvenze
parzialmente ingannevoli del sacro (Girard 1972: 51).
La risposta della cultura alla propagazione indefinita della violenza consiste nel compiere un atto
di violenza che non crei squilibri nel corpo sociale e che non richieda dunque ulteriori passi di
vendetta e rappresaglia. E questo atto è il sacrificio, compiuto in sostanza dall’intera comunità, in
accordo, su un unico individuo che svolge la funzione di capro espiatorio. Il sacrificio è dunque un
atto di unanimità violenta, che placa per così dire le esigenze aggressive purificando la società (e
purificare significa eliminare la catena perversa della violenza).
Questa è una sintesi molto schematica. Girard dà corpo alla sua tesi attraverso un percorso
all’interno della mitologia e in particolare della tragedia greca, nella quale legge l’espressione del
timore della «crisi sacrificale», come la chiama. Egli sostiene che senza il presupposto della
violenza essenziale noi non riusciamo a capire nulla della cultura antica, che si aggrega tutta
attorno al superamento di questo rischio; non capiamo nulla del sacro e della religione, che sono
per così dire il precipitato ideologico dell’unanimità violenta (e che, come per Frazer e Freud, si
fondano dunque su un atto di violenza originaria); e non capiamo nulla della tragedia greca, che sta
poi all’origine della stessa letteratura moderna, così come non capiamo una parte importante
dell’etica delle società moderne.
D’altra parte, dice Girard, se non ci rendiamo conto di ciò è perché la cultura tende a dissimulare
queste sue operazioni, e a nascondere allo sguardo proprio quel nucleo di violenza essenziale che è
suo compito neutralizzare. Per comprendere questo nesso civiltà-violenza occorre calarsi in
qualche modo nella costituzione esistenziale dell’uomo arcaico, e seguire le tracce della crisi
sacrificale dentro i documenti classici, etnologici e folklorici. Il che apre un programma di studio e
di interpretazione praticamente illimitato.
Tutti questi autori considerano la violenza non semplicemente come un residuo che sarebbe
desiderabile eliminare, ma come una forza costitutiva che è incastonata nelle fondamenta stesse
della civiltà. La loro idea è che, quanto più dissimuliamo o tentiamo di ignorare questo
ingombrante fardello, tanto più difficilmente possiamo liberarcene. Un superamento reale della
violenza deve passare, a loro avviso, attraverso la consapevolezza di questo nesso originario.
Cosicché la società non avrebbe bisogno di buoni propositi, enunciazioni di principi morali, etc.,
che nascondono sempre più il nucleo terribile della violenza invece che risolverlo; avrebbe semmai
bisogno di una sorta di psicoterapia, che porti pienamente alla coscienza quel groviglio inestricabile
di violenza, desiderio, magia, e solo così lo risolva pienamente. Per tutti e tre, evidentemente, le
scienze umane possono svolgere una funzione importante in questa direzione.
5. Osservazioni conclusive
Sarebbe difficile a questo punto stringere il ragionamento ed arrivare ad una sintesi delle
posizioni teoriche esaminate. Come ho detto all’inizio, sono scettico sulla possibilità e
sull’opportunità di interrogare l’antropologia in cerca di una teoria generale della violenza, che
possa essere applicata alle singole manifestazioni storiche di essa - per quanto ritenga ineludibile,
vale la pena ripeterlo, il problema dell’intreccio tra dimensioni storiche e antropologiche, o se si
vuole tra logica dell’evento e logica dei modelli culturali, che la comprensione del nostro tempo così
spesso ci pone. Non si può pensare questo intreccio come una semplice questione di divisione del
lavoro: cosicchè l’approccio universalista dell’antropologo inizierebbe laddove si ferma l’approccio
individuante dello storico, e viceversa. Le due discipline (nonché le altre, come psicoanalisi,
sociologia, etologia) devono interagire a tutti i livelli, senza il timore né di sporcarsi le mani con la
fattualità empirica né di misurarsi con probemi filosofici, astrazioni teoretiche, suggestioni
interpretative.
Nel comune sforzo di comprensione, ogni disciplina porterà naturalmente il patrimonio di idee,
concetti, strumenti e metodi che le viene dalla propria tradizione intellettuale. Concludo, dunque,
cercando di enucleare alcune delle peculiarità (beninteso, non esclusive) dell’approccio
antropologico.
a) In primo luogo, l’interpretazione antropologica passa attraverso la soggettività degli attori
sociali. Per così dire, l’antropologia è una interpretazione di interpretazioni - si esercita cioè sulle
modalità in cui individui o gruppi umani costruiscono un proprio universo morale, danno senso al
mondo e alla storia. Per esser ancora più precisi, si esercita sulle pratiche sociali attraverso cui
questo “senso” viene negoziato, contrattato, sostenuto, modificato - con motivazioni che sono
sempre, in senso lato, politiche, che hanno cioè a che fare con il potere e la sua gestione. Mi sembra
degno di nota il fatto che gli storici contemporaneisti che più si sono interessati all’antropologia
sono proprio quelli che con maggior forza si sono posti il problema della soggettività degli attori
sociali. Per quanto riguarda il tema dei massacri o dei campi di concentramento e di sterminio,
oltre agli autori italiani già citati in precedenza, si possono ricordare gli studi di Christopher
Browning ( 1992) e Daniel Goldhagen (1996), che, pur da prospettive assai diverse, si sono posti
l’obiettivo di comprendere il punto di vista soggettivo dei massacratori, finendo entrambi su un
terreno di riflessione squisitamente antropologico.
b) Come conseguenza di quanto appena detto, nello studio di eventi storici l’antropologia ha a
che fare prevalentemente con discorsi, o meglio con racconti - vale a dire, con elaborazioni della
memoria nelle quali l’esperienza vissuta dei protagonisti viene forgiata in forma narrativa. La storia
di vita e la testimonianza narrativa, soprattutto orale, non è per l’antropologia una fonte come
tante altre, utile per ottenere dati che potrebbero esser ottenuti anche in altro modo. E’ invece
oggetto di interesse in sé, in quanto crogiuolo, per così dire, in cui si forgia il senso culturale della
storia.
c) L’antropologia è interessata al modo in cui specifiche pratiche contribuiscono alla
determinazione di un ordine culturale. Per quanto riguarda la violenza, importante è capire qual è
il suo significato culturale, quali valori la muovono, quali sono i suoi usi sociali - e non tanto
considerarla come un residuo, ciò che rimane una volta che si sono allentati i vincoli della civiltà e
della cultura e che è emersa la “belva che è in noi”. L’approccio antropologico può servire a
sviluppare sensibilità verso il linguaggio simbolico della violenza, abituando a leggere ciò che
sembra o si presenta come esplosione incontrollata di furore come, invece, una configurazione
ordinata di comportamenti che quasi sempre risponde a un codice culturalmente appreso;
abituando a chiedersi se atti violenti apparentemente analoghi abbiano lo stesso significato
all’interno di contesti culturali diversi; abituando a riflettere su come il confine stesso tra
comportamento violento e non violento venga costantemente ridisegnato nel corso della storia, in
relazione a strategie in senso lato politiche dei gruppi sociali.
d) La pratica del confronto con la diversità porta talvolta gli antropologi ad accostarsi a certe
epoche storiche come se fossero culture altre. Ciò può risultare fuorviante: ma può anche essere un
correttivo rispetto al presupposto di certa storiografia tradizionale, che pone come soggetto di ogni
evento una astratta individualità razionale piuttosto che soggettività plasmate da contesti di
differenze culturali. Il comportamento degli esecutori di massacri e genocidi può ad esempio
risultare incomprensibile se commisurato ai criteri di un generico agire razionale ( o ai criteri che
appartengono all’attuale cultura dello storico): in questo caso, l’intelligenza storiografica dovrà
usare un metodo antropologico, mirando a ricostruire il contesto socio-culturale “altro” in cui quel
comportamento possa esser ragionevolmente collocato. E’ l’operazione tentata da Goldhagen a
proposito della società tedesca che ha prodotto il nazismo e il progetto della soluzione finale. Lo
stesso evento della Shoah, egli afferma, “ci impone di mettere in discussione il presupposto
dell’affinità tra quella società e la nostra” e di “guardare alla Germania con gli occhi
dell’antropologo che studi un popolo di cui si sa poco” (Goldhagen 1996: 30). Scopriamo così che si
tratta di una società dominata da modelli cognitivi radicalmente diversi da quelli oggi diffusi nel
mondo occidentale, e in particolare da un antisemitismo talmente diffuso da risultare un vero e
proprio assioma indiscusso, una base della più elementare visione del mondo, un “luogo comune
che passava praticamente inosservato” (Ibid.: 34). Per inciso, l’analisi di Goldhagen è un po’ troppo
semplicistica, e fa un uso improprio e banalizzante di concetti antropologici come quello di
“modello cognitivo” (v. Hinton 1998). E’ dubbio che si possa considerare il nazismo come una
cultura radicalmente altra in senso antropologico; e, più in generale, la relativizzazione radicale dei
contesti culturali è operazione sempre rischiosa e da affrontare con estrema cautela. Tuttavia, è
anche un terreno su cui è talvolta necessario spingersi di fronte allo “scandalo” di eventi storici che
sembrano sfidare la stessa nostra idea di umanità.
e) Per restare a Goldhagen, il suo approccio per così dire distanziante al nazismo coglie con
lucidità almeno un aspetto importante del metodo antropologico. Egli si rende conto che per capire
il punto di vista dei “volenterosi carnefici di Hitler”, i tedeschi comuni che sono stati zelanti
esecutori materiali dei massacri, occorre studiare non solo il loro comportamento nel corso della
guerra e dei massacri stessi, ma anche e soprattutto la loro vita quotidiana, le loro routines, gli
aspetti più banali e ordinari della loro esistenza. Goldhagen enuncia con chiarezza questo principio
metodologico, anche se non riesce poi a svolgerlo completamente - cosicché, nell’architettura
complessiva del suo fortunato e discusso libro, lo studio della vita quotidiana degli esecutori resta
in secondo piano (Goldhagen 1996: 276sgg.). In effetti, è peculiarità dello sguardo antropologico il
concentrarsi sulle pratiche comuni più che su quelle estreme e straordinarie, sulle routines più che
sugli eventi eccezionali. Suo obiettivo è cogliere i livelli più profondi della costituzione culturale
degli individui e dei gruppi, che si manifestano per l’appunto nelle pratiche o nelle idee più banali e
più scontate: anzi, proprio le idee o le azioni così scontate da non esser neppure notate dai loro
attori stessi, sono quelle che più interessano gli antropologi. E’ anche vero, all’inverso, che in certe
circostanze gli eventi estremi possono esser rivelatori di aspetti della costituzione culturale
ordinaria che normalmente non si riesce a cogliere: è l’idea sviluppata ad esempio da alcuni
studiosi della vita nei lager, come il già citato Primo Levi o, più di recente, Tzvetan Todorov (1991),
il quale cerca di ricavare un’etica delle virtù e dei vizi quotidiani dalle esperienze-limite
dell’esistenza nei campi di concentramento nazisti e sovietici. I due approcci sono probabilmente
complementari: come ripeto, è però peculiare dell’antropologia la tendenza a discostarsi dal fatto
esemplare (su cui di solito si concentar invece lo storico), per immergersi nei dettagli
apparentemente opachi e insignificanti della quotidianità.
* (in AA.VV., Alle radici delle violenza. Per spiegare l’inumanità dell’uomo, a cura del CIDI della
Carnia e del Gemonese, Udine, Paolo Gaspari editore, 1999, pp. 31-55)
2. Perché si uccide in guerra?
Cosa può dire agli storici l’antropologia *
Fabio Dei
1. L‘ambigua razionalità della guerra
Gli storici sono giustamente scettici verso ogni approccio troppo generalizzante al problema della
comprensione - o della spiegazione, se preferiamo - della guerra. Di solito, essi ci mettono in
guardia contro i tentativi di ricondurre la guerra a più ampie ma vaghe categorie antropologiche,
come violenza o aggressività. Anzi, non amano affatto parlare di guerra in generale: preferiscono il
plurale, e tendono a mettere a fuoco casi particolari o almeno tipologie diverse di guerre, da
comprendere in relazione a specifici contesti storico-sociali. Ci chiamano a considerare la diversità,
piuttosto che presunte essenze universali o tratti invarianti. Non “perché la guerra”, occorre
domandarsi, come nel celebre carteggio Einstein-Freud degli anni Trenta, ma perché quella
particolare guerra, in quel luogo e in quell'epoca, condotta da quei particolari attori sociali che le
attribuiscono quei particolari significati, e così via. In questo senso, gli storici stanno
tendenzialmente dalla parte della celebre concezione del Vom Kriege di Clausewitz: assumendo la
fondamentale razionalità politica della guerra, ritengono che spiegarla significhi ricostruire le
condizioni in senso lato politiche che producono ogni singolo conflitto.
Tuttavia, lo stesso Clausewitz riconosceva la presenza, nella guerra, di un'altra e assai più oscura
dimensione, che definiva in termini di “attrito”. La guerra è una macchina programmata e guidata
dalle limpide ragioni degli Stati: ma è una macchina pesante che, una volta avviata, tende
costantemente a sfuggire al controllo, a muoversi autonomamente secondo una propria logica.
Forse, sarebbe meglio dire, tende all'assenza di una vera e propria logica, giacché il suo procedere
sembra dominato da elementi di imprevedibilità, irregolarità, disordine. Come ha notato Daniel
Pick nella sua importante rassegna sul pensiero della guerra tra Ottocento e Novecento (1993: 53),
per Clausewitz la guerra ha qualcosa in comune con l'ambigua creatura del dottor Frankenstein: in
essa si manifesta una forza distruttiva, capricciosa e in ultima istanza anarchica, che sovverte le
proprie stesse originarie finalità e rischia di volgersi contro la volontà razionale che l'ha originata.
Vi sarebbe dunque nella guerra una fondamentale ambivalenza: e l'arte militare consiste proprio,
per Clausewitz, nella capacità di controllare gli elementi di attrito, soggiogando il “mostro” alle
positive ragioni che lo hanno creato.
D'altra parte, questa caratterizzazione ambivalente non è tipica soltanto dell'opera di Clausewitz:
come ha mostrato Pick, essa è presente in modo costante e quasi ossessivo in gran parte degli
intellettuali che negli ultimi due secoli hanno teorizzato sulla guerra, sul versante sia bellicista che
pacifista. A fronte della razionalità strumentale che la muove, la guerra lascia emergere e scatena
elementi oscuri e irrazionali, attingendo a uno strato molto profondo e molto arcaico dell'animo
umano. Vi è in essa un “primato di forze ignote e inconoscibili, [...] nettamente al di là del regno
delle decisioni umane”, per usare le parole di Tolstoj (cit. in Pick 1993: 51). Mentre la razionalità
strumentale ha a che fare con i particolari contesti storici, questa seconda dimensione sembra
piuttosto rimandare alla natura umana, all'ordine del biologico o dell'istintuale, e in ogni caso
dell'universale. In breve, sembra sfuggire alla storia, presentandosi anzi come il limite stesso contro
il quale si scontra la razionalità storica (intesa sia come possibilità di comprensione da parte dello
storico, sia di plasmazione da parte dell'attore sociale, sia esso statista, condottiero o che altro).
Sarebbe però un errore considerare quest' “altra” dimensione della guerra come una mera
invenzione del pensiero speculativo, o di inclinazioni romantiche ed estetizzanti, cioè di
un'intelligenza radicalmente non-storica delle vicende umane. Ad imbattersi in essa, anzi, sono
spesso gli storici migliori, quelli che più profondamente si immergono nei contesti locali, nella
concretezza delle situazioni belliche, nelle pratiche umane di cui la guerra è fatta. Essi si trovano
spesso di fronte comportamenti individuali e collettivi non interamente riconducibili né alla
razionalità politica né a quella strettamente militare e strategica della guerra, per quanto terribile
essa possa rivelarsi.
Le manifestazioni della violenza fisica hanno tipicamente a che fare con tutto ciò. E' vero che la
violenza fa parte dell'essenza stessa della guerra, e viene consapevolmente mobilitata per le finalità
razionali che muovono i soggetti belligeranti. E tuttavia, essa sembra tenacemente resistere a una
integrale spiegazione di tipo contestuale, almeno per due motivi. Da un lato, nelle pratiche concrete
di guerra troviamo spesso un “di più” di violenza, in senso sia quantitativo sia qualitativo, non
richiesto e non giustificato da necessità politiche o strategiche di alcun tipo. Dall'altro lato, le
modalità di manifestazione della violenza in contesti storici anche radicalmente diversi presentano
analogie tanto sinistre quanto significative. Sembra quasi possibile costruire una fenomenologia
universale o meta-storica di certi atti di guerra, come il combattimento, la fuga e la caccia, il
massacro - l'operazione tentata ad esempio nel Saggio sulla violenza di W. Sofski (1996), con esiti
discutibili ma senza dubbio impressionanti.
2. “Un fondo limaccioso”
Nello studiare specifiche pratiche di violenza ci troviamo cioè di fronte a elementi che sfuggono a
una spiegazione contestuale e che propongono al contempo palesi rimandi intercontestuali. Alcuni
esempi assai significativi di messa a fuoco di questo problema ci vengono dalla più recente
storiografia italiana, che ha affrontato il tema della violenza negli anni della Seconda Guerra
Mondiale in modo nuovo e attraverso un approccio che potremmo chiamare etnografico. Vorrei
riferirmi brevemente a un paio di casi. A proposito degli eccidi di civili compiuti in Toscana dalla
Wermacht in ritirata, nell'estate del 1944, alcuni studiosi hanno cercato di rappresentare (fra
l'altro, attraverso l'uso cruciale delle fonti orali) la dimensione esperienziale e soggettiva del
massacro, dal punto di vista dei sopravvissuti come da quello degli esecutori. Ne sono risultati
resoconti di grande impatto anche emotivo, che ci pongono di fronte all'orrore del massacro nella
sua concretezza, attraverso i frammenti visivi, olfattivi e acustici della memoria dei superstiti. Da
tali resoconti la ferocia e la crudeltà degli uccisori non può non apparire spropositata, eccessiva, sia
pure a fronte di chiare motivazioni strategiche dell'esercito tedesco. Ma è anche una ferocia che in
qualche modo suona sinistramente familiare: è come se i soldati tedeschi seguissero un copione fin
troppo noto, non solo perché già sperimentato nei territori orientali, come nel caso della
famigerata divisione Hermann Goering, ma perché messo in scena più e più volte nei secoli. I
resoconti delle stragi naziste che emergono dai lavori di Paggi (1996, 1997), Pezzino (1997), Contini
(1997) e altri si discostano solo per dettagli dalla descrizione per così dire ideal-tipica del massacro
tentata da Sofsky (1996: 149sgg.), che pure si basa su fonti prevalentemente moderne. Per dirla con
quest'ultimo autore, “cambiano le vittime e i carnefici, cambiano le armi e il teatro degli eventi.
Nondimeno la natura del massacro rimane immutata” (Ibid.: 152). Il motivo, a suo parere, è che in
esso la violenza “gode di libertà assoluta”, agisce secondo una propria logica indipendentemente
dalle finalità e dalle ragioni che la innescano:
L'uniformità dei massacri non dipende dall'identità degli scopi, ma dalla dinamica
universale della violenza assoluta [...] E' la violenza stessa che detta il corso degli eventi.
L'eccesso dell'azione collettiva si svincola dalle intenzioni politiche o sociali (Ibid.: 153)
La “dinamica universale della violenza assoluta” è un concetto discutibile e difficile da accettare per
gli storici (e non solo per loro). Anch'essi, tuttavia, non possono fare a meno di confrontarsi con il
problema che pone Sofski, ammettendo l'insufficienza di spiegazioni meramente funzionaliste dei
massacri. Claudio Pavone, discutendo l'eccidio di Civitella val di Chiana (Arezzo), parla di
una linea di sotterranea tendenza alla violenza che sussiste anche nelle società che noi,
con eccessivo ottimismo, avevamo considerato ormai irreversibilmente civilizzate.
Questo limaccioso fondo, che può portare l'umanità a compiere eccessi ed orrori come
quelli operati dai tedeschi, era stato occultato dal monopolio della violenza legale che lo
Stato moderno si è attribuito (Pavone 1996: 18-9).
Questo monopolio si spezza in situazioni come quelle della guerra civile o guerra totale, che
sospendono le condizioni del processo di civilizzazione e lasciano “emergere quel fondo torbido e
violento” (Ibid.). L'uso ripetuto degli aggettivi “torbido” e “limaccioso” da parte di Pavone, che è
storico limpidamente razionalista, è significativo. Beninteso, il sostrato di cui egli parla non è una
“natura umana” che si sostituirebbe a una cultura momentaneamente sospesa. Pavone insiste anzi
sulle specifiche condizioni culturali che producono il “ritorno” del massacro, in particolare sulla
consapevole promozione dei valori della violenza da parte del nazismo. Anche nel suo celebre libro
«sulla Resistenza egli aveva posto il problema di quel “«di più» di violenza, quel di più del quale i
reduci di tutte le guerre preferiscono non parlare”, e che riguarda il campo fascista come quello
resistenziale (Pavone 1991: 427). Non si tratta di un semplice problema di crudeltà e sadismo, egli
afferma: sul piano della comprensione storiografica occorre invece cogliere “le strutture culturali
di fondo che sostengono le due parti in lotta, così da chiedersi perché le une siano più adatte delle
altre a selezionare i crudeli e i sadici e a far emergere con tutta evidenza al livello dei
comportamenti politicamente rilevanti le più oscure pulsioni dell'animo umano” (Ibid.). Resta
tuttavia il problema di come considerare un tale “sostrato torbido” che pesca tra le più “oscure
pulsioni dell'animo” e che sfugge al contesto storico collocandosi apparentemente in una
dimensione, se non naturale, almeno di lunghissima durata: si tratta semplicemente una nozionelimite, attorno alla quale l'analisi storiografica può solo girare, disegnandone per così dire i
contorni in negativo, oppure è qualcosa che può esser “chiarita” dalla storiografia o da altre
discipline?
Più netta in questo senso è la posizione di Leonardo Paggi, che si sofferma più volte sulla natura
per molti aspetti “rituale” e “sacrificale” del massacro nazista e parla, anch'egli, di “riemergenza di
sostrati profondi” (1996: 69). Paggi si trova nella eccezionale situazione di esercitare l'intelligenza
storica su un evento - l'eccidio di Civitella, appunto - di cui, bimbo di tre anni, è stato diretto
testimone. Ciò lo porta ad approfondire con forza particolare il problema dell'esperienza soggettiva
del massacro, e della sua rielaborazione nella memoria. Per quanto non tralasci alcun tentativo di
interpretazione storica e contestuale, egli è attratto dalle profonde strutture antropologiche e
psicologiche che il massacro va a toccare, sia dal punto di vista degli assassini che da quello delle
vittime, e tenta di darne conto in termini di nozioni come “rito sacrificale” e “pulsione di morte”. Il
massacro nazista, scrive, “si configura anche come risultato di una «eredità arcaica», come collasso
dei sistemi di autocoercizione, come emergenza di comportamenti e significati quasi in via di
principio sbrigativamente estromessi dal nostro presente”. In altre parole, nel bel mezzo di una
guerra tipicamente moderna, condotta sulla base di un impianto di razionalità strumentale e
tecnica senza precedenti, si apre un abisso che porta dritti allo stato arcaico - si sarebbe tentati di
dire selvaggio - dell'umanità. E' qui che per Paggi diviene possibile, anzi necessario, innestare la
comprensione antropologica o psicoanalitica sul tronco di quella storiografica:
Si apre qui il terreno di una antropologia del massacro, ancora tutta da fare, che
difficilmente potrà evitare di misurarsi - credo - con il grande tema dei riti sacrificali di
morte, che segnano profondamente, in senso sincronico e diacronico, tutta la storia
della cultura umana (Paggi 1996: 8).
Un altro autore che, sia pure con toni diversi, ha affrontato direttamente questo tipo di problema
è Gabriele Ranzato. Un suo recente volume studia un caso di linciaggio nella Roma appena liberata
del 1944: Donato Carretta, ex direttore delle carceri di Regina Coeli, collaborazionista minore
tardivamente passato dalla parte del movimento di liberazione, viene ucciso da una folla inferocita
radunata per assistere a un processo: il suo cadavere viene scempiato e infine appeso a testa in giù
davanti all’ingresso del carcere. Ranzato, dopo una acutissima analisi dell’evento, dei suoi
protagonisti de delle loro motivazioni, riconosce infine di trovarsi di fronte a un fenomeno non
comprensibile - almeno, non pienamente - in termini di agire razionale e di categorie meramente
politiche; uno di quei “fenomeni che scompaginano le carte della pretesa razionalità della politica”
(Ranzato 1997: 203). L’autore mette a fuoco in particolare due elementi. Da un lato, il linciaggio si
configura come un'eplosione di violenza di massa apparentemente irrazionale, sia per i modi
estremi della sua manifestazione che per l'oggetto cui si rivolge: per quanti pretesti si possano
trovare per questa violenza, essa non ha alcuna causa o motivazione razionale in senso stretto.
Dall'altro lato, Ranzato sottolinea la qualità particolare del linciaggio: non solo la spietata crudeltà
degli esecutori, ma soprattutto quella che potremmo chiamare la sintassi simbolica della violenza
messa in atto, il suo articolarsi secondo modalità formali che richiamano riti di rovesciamento del
potere tipici delle società di antico regime. Cosa spinge la folla ad agire? Chi o che cosa guida la
folla ad un comportamento ritualizzato che, come aveva scritto un commentatore dell'epoca, non si
vedeva a Roma dai tempi di Cola di Rienzo, e che con il linciaggio di Cola presenta sconcertanti
analogie? (Ibid.: 127-8).
Ancora una volta, si aprono problemi la cui soluzione sembra spingere risolutamente al di fuori
del particolare contesto storico. Ranzato offre una risposta complessa e articolata, che non è qui
possibile discutere nei dettagli. Ma anch'egli, come Pavone e Paggi, mette a fuoco il fenomeno del
riemergere di un sostrato culturale arcaico, che sembrava definitivamente soffocato dal processo di
civilizzazione; e anch'egli ritiene necessarie, per la soluzione di questo enigma, ampie aperture
interdisciplinari, in grado di individuare elementi che restano invisibili all'indagine empirica dello
storico. Se il linciaggio di Carretta ci mostra comportamenti sociali guidati da regole di cui gli attori
stessi sono (individualmente e collettivamente) inconsapevoli, per comprenderlo abbiamo bisogno
di far riferimento a qualcosa come l'inconscio o le strutture antropologiche:
E' evidente [...] che attraverso la falla lasciata aperta dall'ammissione di una presenza
dell'inconsapevole nella spiegazione politica dell'evento di cui ci siamo occupati,
passano altri saperi: la psicologia, l'antropologia e, in sede di indagine storiografica,
una storiografia più aperta al contributo di queste discipline anche per quel che
riguarda lo studio degli avvenimenti dell'età contemporanea (Ibid. 203).
3. Fra Hobbes e Rousseau
Antropologia, psicoanalisi, scienze umane sono dunque chiamate in causa da storici dell'età
contemporanea, per la comprensione di eventi di guerra e di violenza che presentano un
enigmatico “di più”, quantitativo e qualitativo, rispetto a quanto la razionalità contestuale
consentirebbe di aspettarsi. Questo appello a un approccio interdisciplinare è assai coraggioso e
innovativo. Per quanto riguarda l'antropologia culturale, viene così superata la tradizionale
tendenza a riservarle lo studio delle società senza Stato - il che equivale talvolta a dire “naturali” o
“senza storia” e dunque soggette a un determinismo generalizzante e nomotetico, laddove le società
statuali o moderne sarebbero di esclusiva competenza di un approccio individuante o idiografico,
dunque della storiografia. Questa divisione del lavoro, peraltro, è stata spesso ben accetta agli stessi
antropologi, perché coerente con la dominante impostazione epistemologica della loro disciplina. Il
che giustifica ampiamente le cautele espresse da Ranzato, secondo cui
le maggiori difficoltà all'integrazione, alla compenetrata collaborazione di psicanalisi,
politica, antropologia e storia, dipendono in gran parte dalla loro scarsa flessibilità, o
meglio dalla rigidità e pretesa onnicomprensività di molte teorie che si sviluppano nel
loro ambito. Integrazione presuppone infatti rinuncia alle ambizioni totalizzanti, a
quelle chiavi interpretative che appaiono tanto più esplicative di tutto, quanto più si
allontanano dai fatti (Ibid.: 204).
Ranzato si riferisce alla teoria del capro espiatorio di René Girard come esempio di approccio sì
suggestivo e stimolante, ma tanto astratto e speculativo da non riuscire plausibilmente a calarsi
nella concretezza di un preciso caso storiografico. La sua osservazione, tuttavia, si applica in effetti
a un ampio ventaglio di approcci socio-antropologici. Il che ci riporta a quanto osservato in
precedenza, circa la tendenza a spiegare la dimensione non immediatamente politico-razionale
della guerra in termini di ipotesi universalistiche, di appelli a caratteristiche generali della natura
umana. Una volta esaurite le spiegazioni razionali, non resta che riconoscere che “l'uomo è una
belva”, o, per usare la più solenne e famosa formulazione di Einstein, che “l'uomo alberga in sé il
bisogno di odiare e di distruggere” (Einstein-Freud 1933: 291). E non resta che rivolgersi agli
specialisti di una scienza dell'uomo che getti luce sulle più recondite profondità della sua vita
psichica e della sua costituzione antropologica, assunte come invarianti che fanno da sfondo alla
storia più che esserne prodotte. E' appunto quello che fa Einstein quando decide di interpellare
Freud sul problema “perché la guerra?”, ritenendo la domanda in ultima analisi “un enigma che
può essere risolto solo da chi è esperto nella conoscenza degli istinti umani” (Ibid.). Freud, da parte
sua, accetta il ruolo di esperto degli istinti nonché dell'evoluzione culturale, e offre in risposta una
piccola summa degli aspetti più speculativi della sua intera opera. Certo che l'uomo alberga in sé
una innata aggressività, e persino una pulsione di morte. Questa non si può abolire: si può soltanto
cercare di deviarla o scaricarla (la celebre teoria “idraulica”), o di interiorizzarla trasformandola
così in vincolo morale, affinché non sfoci nella guerra ma in comportamenti socialmente
accettabili.
Il carteggio Einstein-Freud è tipico del clima culturale della prima metà del secolo, e del rapporto
che in esso si instaura tra scienze umane e senso comune. Da un lato, vi è la diffusa convinzione che
antropologia e psicoanalisi possano dare risposte scientifiche e oggettivamente valide a eterni
quesiti morali o religiosi: ad esempio la natura del male, la fondamentale bontà o cattiveria degli
uomini, i legami esistenti tra sessualità e aggressività, e così via. Dall'altro lato le scienze umane,
quando escono dal loro specifico ambito di indagine e si avventurano su questi terreni, quasi
sempre non possono far altro che riproporre e accreditare le buone vecchie storie del senso
comune, e in particolare una qualche variante dei miti di Hobbes e Rousseau sull'originaria natura
morale degli esseri umani. La già citata rassegna di Pick (1993) mostra in modo assai convincente
la continuità, tra Ottocento e Novecento, delle teorie scientifiche su guerra e aggressività con le
relative elaborazioni della letteratura, dell'ideologia e del senso comune.
Dunque, possono le scienze umane rispondere adeguatamente alle richieste che gli storici
pongono loro? Possono davvero dirci qualcosa di interessante su quel “substrato” oscuro, arcaico e
irriducibile al contesto che la guerra sembra invariabilmente riportare alla luce? Non vorrei
soffermarmi qui in una discussione della psicoanalisi della guerra, se non per constatare la sua
palese e persistente difficoltà a passare da penetranti interpretazioni della condotta e della vita
psichica individuale e familiare a teorie sulla cultura e sulla società. Se le speculazioni metapsicologiche di Freud, da Totem e tabù a Perché la guerra, hanno svolto un importante ruolo
culturale e sono ancora oggi interessanti, è in virtù della loro natura mitopoietica e letteraria, non
del valore scientifico o del radicamento nell'indagine empirica. (Lo stesso Freud sembra
ammetterlo quando scrive ad Einstein: “Lei ha forse l'impressione che le nostre teorie siano una
specie di mitologia, neppure lieta in verità. Ma non approda forse ogni scienza naturale a una sorta
di mitologia?”; in Einstein-Freud 1933: 100). E lo stesso si può dire di molti suoi successori, nella
misura in cui continuano a misurarsi con teorie generali sulla guerra e con il problema della sua
origine o fondazione. Difficile ad esempio trovare un uso all'interno della comprensione
storiografica (o antropologica, se è per questo) per la tesi di Franco Fornari, autore negli anni '60 di
un fortunato libro sulla psicoanalisi della guerra, secondo il quale essa rappresenta “una istituzione
sociale volta a curare angosce paranoicali e depressive esistenti [...] in ogni uomo” (1966: 14).
Ma che dire dell'antropologia culturale? Sarebbe ragionevole pensare che il suo sviluppo
novecentesco come scienza empirica, radicata in rigorose metodologie di ricerca, l'abbia portata a
offrire risposte più solide e convincenti rispetto alle antiquate speculazioni. E' difficile dire se sia
davvero così. Si può cominciare con l'osservare come l'antropologia culturale moderna abbia
studiato relativamente poco il fenomeno della guerra, per almeno due motivi. Il primo è l'ovvia
difficoltà ad applicare alla guerra il metodo principe della ricerca etnografica - l'osservazione
partecipante. Il secondo consiste nel fatto che gli antropologi hanno avuto più facilmente accesso a
società “pacificate”, prive di guerra semplicemente perché la loro organizzazione militare e la loro
eventuale bellicosità sono state soffocate dal potere coloniale. Il che spiega la quasi totale assenza
della guerra in molte delle più classiche monografie etnografiche. Nonostante questo, il problema
della guerra (insieme a quello connesso, ma evidentemente non coincidente, della violenza) è stato
al centro di una letteratura specializzata, non particolarmente ampia ma dotata di una certa
compattezza (si veda una vasta bibliografia in Ferguson-Farragher 1988, e rassegne antologiche in
Riches 1986, Haas 1990 e Reyna-Downs 1997). Vediamone, in estrema sintesi, alcuni tratti.
4. L’antropologia della guerra
Si tratta in primo luogo di studi monografici su singole popolazioni: l'esempio più tipico è forse
rappresentato dai lavori di Napoleon Chagnon (1968) sugli amazzonici indios Yanomami,
presentati come emblema di un popolo guerriero e violento, costantemente impegnato in raid
assassini condotti tra villaggi nemici. Per altro verso, sul versante per così dire rousseauviano, assai
noti sono alcuni studi su popolazioni pacifiche (tipicamente piccole comunità egalitarie e non
competitive di cacciatori e raccoglitori o orticoltori), come quelli di Jean Briggs (1970) sugli
eschimesi o di Colin Turnbull (1961) sui pigmei Mbuti dello Zaire (monografie dai titoli assi tipici
come Never in Anger, The Harmless People etc.; se ne veda una rassegna in Knauft 1987). Un
secondo filone di studi riguarda prevalentemente l'antropologia fisica, e consiste in analisi di
reperti paletnologici volte a determinare la presenza di pratiche di violenza letale intraspecifica o di
vera e propria guerra in età preistorica (si veda Martin-Frayer 1997 per una recente rassegna e
valutazione di questo tipo di indagine).
In terzo luogo, l'antropologia della guerra consiste in studi di tipo comparativo e teorico, volti a
produrre generalizzazioni e a scoprire nessi causali in relazione al fenomeno della guerra tra quelli
che un tempo si dicevano i “primitivi”. Questo interesse è maturato soprattutto in ambito
statunitense, tra autori vicini al neo-evoluzionismo, all'ecologia culturale e, in molti casi, alla
sociobiologia. Le domande cui essi sono interessati riguardano l'origine e le cause della guerra, e
soprattutto la correlazione fra l'intensità e la frequenza delle guerre e determinate condizioni
ecologiche, economiche (popoli cacciatori e agricoltori, nomadi o sedentari) e sociali (sistemi di
discendenza patri- e matrilineari, sistemi di potere, stratificazione sociale e così via; v. Ferguson
1990, 1994, 1997). Tipico di questo approccio è ad esempio il lavoro dei coniugi Ember che,
all'interno del programma Human Relations Area Files, hanno tentato una immane comparazione
tra centinaia di culture etnograficamente registrate, estraendone dati passibili di analisi
quantitativa e di generalizzazioni statisticamente significative (Ember-Ember 1982, 1997). Occorre
infine citare gli studi sulla violenza intraspecifica e sui raid guerreschi tra i primati, che il neoevoluzionismo e la sociobiologia considerano assai rilevanti anche in prospettiva etnologica (v. fra
gli altri Manson-Wrangham 1991, Wrangham-Peterson 1996).
Ora, in che misura questi studi rispondono alle domande sopra sollevate? Riescono veramente a
sostituire un sapere oggettivo ed empiricamente fondato alle generiche speculazioni sulla belva
umana o sul buon selvaggio? Mi pare vi sia da dubitarne. Proprio l'impostazione naturalistica
dell'antropologia della guerra, la sua ossessione per la quantificazione e per la scoperta di leggi
generali, la allontanano dalla concretezza e complessità dei contesti empirici. I “dati” sono
costantemente semplificati al fine di renderli misurabili e utilizzabili statisticamente: la realtà
etnografica cui siamo posti di fronte è fatta, come nel caso degli Ember, di frequenze temporali
delle guerre, di incidenza statistica delle morti violente, e così via. Tali quantificazioni assumono
prima di tutto una impossibile oggettività dei fatti etnografici, depurati del tutto della dimensione
del significato e di quella della storia. A meno di non pensare all'etnografia come a una sorta di
entomologia, è chiara la dipendenza dai quadri interpretativi dei dati anche più semplici: perfino
contare il numero di morti violente, o la percentuale di maschi che hanno partecipato all'uccisione
di qualcuno, o delle persone che hanno perso un consanguineo per atti violenti – alcuni degli
indicatori che Chagnon usa per gli Yanomami - non sono operazioni banali e scontate. Quando ci
caliamo solo un po' più a fondo nel contesto etnografico, possiamo accorgerci quanto questi dati
siano interpretati, e scoprire che un diverso quadro interpretativo potrebbe produrre “dati”
assolutamente divergenti. E’ il caso appunto di Chagnon, le cui simpatie sociobiologiche sono
sfociate in una rappresentazione etnografica non solo non oggettiva, ma fortemente ideologizzata e
per molti assolutamente fuorviante (v. Albert 1989).
In secondo luogo, anche prendendo per buone le procedure di quantificazione, le “scoperte”
raggiunte su questa base sono empiricamente controverse e piuttosto deludenti sul piano teorico.
Se ne possono sintetizzare i risultati con le parole che Brian Ferguson usa in chiusura di un recente
volume su guerra e violenza nella preistoria:
Se c'è chi crede che violenza e guerra non esistessero prima dell'avvento del
colonialismo occidentale, o dello Stato, o dell'agricoltura, questo volume dimostra che
si sbaglia. Ugualmente, se c'è chi crede che tutte le società umane siano state afflitte da
violenza e guerra, e che queste ultime siano state sempre presenti nella storia evolutiva
dell'umanità, questo volume dimostra che si sbaglia (Ferguson 1997: 321)
Si dimostra cioè, se ce ne fosse stato bisogno, che i miti del buon selvaggio e dell’ homo homini
lupus sono, per l'appunto, dei miti, e che la realtà della guerra è troppo varia e multiforme per
essere ingabbiata in semplici categorie. Andar oltre è pericoloso e controverso, sia in termini di
generalizzazioni empiriche che di ipotesi esplicative. Basta scorrere la letteratura per accorgersi
come non vi sia accordo sui punti più fondamentali e, apparentemente, più fattuali. Ad esempio, in
che misura è diffusa la guerra tra le società non gerarchizzate e prive di potere centrale, considerate
le più evolutivamente arretrate? I pareri sono assai discordi. E’ piuttosto noto il punto di vista di
Pierre Clastres, secondo il quale la guerra è una condizione permanente e necessaria dell’esistenza
delle società senza Stato, e solo le condizioni di forzata pacificazione imposte dal colonialismo
impedirebbero agli antropologi di rendersene conto (“Se l’etnologia non parla della guerra è perché
non è possibile parlarne dal momento che le società primitive, quando divengono oggetto di studio,
sono ormai avviate lungo la strada della trasformazione, della distruzione e della morte: come
potrebbero mai dar mostra della propria libera vitalità guerriera?”; Clastres 1997: 30). Questa tesi,
che Clastres assume come autoevidente, è sostanzialmente suffragata dai dati degli Ember, secondo
i quali, “in assenza di poteri esterni che impongano la pacificazione, la guerra è quasi onnipresente
nelle registrazioni etnografiche” (Ember-Ember 1997: 5). Ma tali dati sono decisamente contestati
da altri ricercatori, che sottolineano l’esistenza di numerose società semplici sostanzialmente
pacifiche e prive di un’ideologia guerriera - un pacifismo primario, per così dire, che non v’è
motivo, contra Clastres, di considerare come un simulacro prodotto dall’oppressione imperialista
(v. fra gli altri Ferguson 1997: 330-2, e Knaupf 1987, 1991; quest’ultimo autore sottolinea tuttavia la
correlazione tra assenza di guerre esterne e alta percentuale di violenza letale interna al gruppo).
Ciò che colpisce in queste discussioni, informate da una retorica scientista e da costanti richiami
all’oggettività e alla neutralità dei fatti, è la totale impossibilità di risolverle sul piano empirico. Non
solo nessun dato particolare potrebbe mai smentire tesi così generali o schemi comparativi di tale
ampiezza; ciò che più importa, ogni dato etnografico impiegato è di per sé controverso, e non è
possibile il controllo diretto delle fonti. La gran massa di fatti integrati nelle tabelle della Human
Relations Area Files, ad esempio, semplicemente non può esser verificata in modo indipendente:
accettare o osteggiare le generalizzazioni che ne sono tratte dipenderà da motivi largamente
culturali e non scientifici in senso stretto. Il che è uno stato di cose normale per l’etnografia: solo
che ne andrebbero riconosciute le conseguenze epistemologiche.
Lo stesso vale per le teorie esplicative elaborate dall’antropologia della guerra. Seguendo un utile
schema di Clastres, possiamo sintetizzarle suddividendole in tre tipi: teorie naturaliste, teorie
economiciste e teorie dello scambio. Le prime sono le teorie che radicano la guerra in una generica
propensione umana all’aggressività e alla violenza, considerate come dati naturali o proprietà
zoologiche che hanno avuto - e che hanno ancora, eventualmente - un ruolo fondamentale
nell’adattamento della specie. E’ la prospettiva sostenuta con forza dall’etologia e, con accenti
diversi, dal neo-evoluzionismo e dalla sociobiologia. Clastres (1997: 33) ne vede la formulazione più
tipica in uno dei capolavori dell’etnologia novecentesca, Il gesto e la parola di Leroi-Gourhan:
un’opera che legge i principali problemi della contemporaneità in termini di divario tra evoluzione
biologica ed evoluzione sociale dell’umanità. “Il comportamento aggressivo – scrive Leroi-Gourhan
– fa parte della realtà umana almeno a partire dagli Australantropi e l’accelerata evoluzione del
sistema sociale non ha cambiato in nulla il lento sviluppo della maturazione filetica” (1964-5: 199200). La guerra moderna sarebbe allora lo sbocco inevitabile di istinti e tendenze che si impongono
in quanto adattive, ma per le quali non vi sono più spazi (se non fortemente surrogati: p.es. gli
sport) nella normale vita economica e sociale.
Le teorie economiciste fanno risalire la necessità della guerra per i primitivi alla scarsità di
risorse, e dunque alla concorrenza fra gruppi per accaparrarsi beni necessari alla sopravvivenza.
Anche in questo senso, la guerra avrebbe una funzione adattiva: le teorie ecologiche, o quelle del
materialismo culturale alla Marvin Harris, che stabiliscono strette correlazioni fra la presenzaassenza di guerra e la quantità di proteine disponibili nell’ambiente, confinano strettamente con
quelle naturaliste. Clastres classifica anche l’approccio marxista nella categoria delle teorie
economiche, dandone una valutazione ferocemente critica e, a me pare, semplicistica. Coglie
tuttavia bene un punto che accomuna il marxismo e molte teorie naturalistiche: la necessità di
assumere, come postulato di filosofia della storia, la miseria dell’economia primitiva, senza la quale
essa non potrebbe servire da punto di partenza di un processo di costante sviluppo delle forze
produttive. Assunto, questo, che Clastres critica con forza, richiamandosi alle analisi di Sahlins
sulle società primitive come società dell’abbondanza e del loisir, nelle quali un tempo ridottissimo
della vita individuale viene dedicato alla produzione.
Infine, le teorie che Clastres definisce dello scambio sono quelle di tipo sociologico: in particolare,
egli si riferisce a Lévi-Strauss e ad un singolo passo della sua opera in cui si afferma che “gli scambi
commerciali rappresentano guerre potenziali pacificamente risolte, e le guerre sono il risultati di
transazioni sfortunate” (Clastres 1997: 40). La guerra non avrebbe dunque carattere primario, ma
sarebbe il sottoprodotto o l’indesiderata conseguenza di più generali strutture sociologiche.
All’elenco andrebbe forse aggiunta la teoria che lo stesso Clastres (con un po’ troppa enfasi)
contrappone alle precedenti, basata sull’idea di guerra come meccanismo di protezione
dell’autonomia e dell’interno livellamento delle società senza Stato:
La guerra primitiva è manifestazione di una logica centrifuga, una logica della
separazione che si esprime periodicamente attraverso il conflitto armato. La guerra
serve a mantenere ogni comunità nel proprio stato di indipendenza politica; finché c’è
guerra, c’è autonomia […] La guerra è la più significativa forma di esistenza della
società primitiva nella misura in cui quest’ultima si distribuisce sul territorio in unità
sociopolitiche eguali, libere e indipendenti: se i nemici non esistessero, bisognerebbe
inventarli (Ibid.: 63).
5. Storiografia e antropologia
Se c’è qualcosa che accomuna questi approcci teorici, è la loro tendenza a restare ancorati a
questioni troppo generali o generiche sul perché della guerra o sulla sua origine. Non intendo
negare valore specifico agli studi che ho troppo rapidamente passato in rassegna; colpisce tuttavia
la sproporzione tra le loro esigenze di radicamento empirico e l’enormità – direi quasi metafisica –
delle domande che si pongono. Nell’approccio sociologico di Clastres e nel raffinato evoluzionismo
di Leroi-Gourhan, non meno che nel materialismo culturale o nella sociobiologia, si avverte la
presenza di una Grande Teoria dalle aspirazioni totalizzanti; si avverte ancora qualcosa della
pretesa ottocentesca di rispondere con il linguaggio della scienza alle domande ultime della
religione e dell’etica sul bene, sul male, sul destino dell’umanità. Non possiamo allora stupirci se ci
troviamo di fronte argomenti come il seguente, in difesa di una spiegazione sociobiologica della
violenza:
Gli attributi delle persone e di altri animali sono stati plasmati da una storia di
selezione che ha promosso l’adattamento […] Le uniche alternative alle spiegazioni
darwiniane delle proprietà adattive degli organismi sono miti religiosi
consapevolmente inventati. Gli sforzi di “confutare” la sociobiologia sono dunque futili:
sarebbe come cercare di confutare l’antropologia stessa (Daly-Wilson 1987: 483).
Sociobiologia a parte, tutto ciò ci riporta alle cautele espresse da Gabriele Ranzato verso le
ambizioni totalizzanti delle scienze sociali, verso la loro inguaribile tendenza a ricercare “chiavi
interpretative che appaiono tanto più esplicative di tutto, quanto più si allontanano dai fatti”.
Dunque, dobbiamo concludere che l’antropologia culturale non è attrezzata per rispondere alle
richieste e alle aperture di credito da parte degli storici? Che non è pronta a integrarsi con la
storiografia in un progetto di comprensione della guerra e della violenza della nostra epoca?
Naturalmente, il punto è un altro. Gli studi specialistici di antropologia della guerra si sono
mantenuti all’interno dei più stretti e tradizionali confini della disciplina, individuando come
proprio oggetto la guerra in società semplici o primitive e trattando queste ultime come entità
quasi-naturali, immerse nel tempo eminentemente non-storico dell’evoluzione. Hanno dunque
consapevolmente evitato ogni rapporto sia con la contemporaneità sia con la dimensione storica –
oltre che, per scelta di metodo, con la soggettività degli attori sociali e con quella che potremmo
chiamare la dimensione “significativa” della guerra. In quasi tutti gli studi citati i nativi - guerrieri o
pacifisti che siano - non parlano, proprio come le farfalle e gli scimpanzé: sembrano troppo
occupati con i propri attributi adattivi e con le strategie di promozione dei propri geni.
Questo non è un buon punto di partenza: ma l’antropologia culturale è naturalmente anche altro.
C’è semmai da chiedersi perché gli indirizzi di taglio comprendente e interpretativo, in linea di
principio più promettenti della sociobiologia, si siano occupati così poco dei temi della guerra e
della violenza (con rare eccezioni: v. ad esempio Robarchek 1990). In ogni caso, c’è un lavoro tutto
da fare in questa direzione, valutando le possibilità interpretative di un’antropologia che abbia
rinunciato una volta per tutte a inseguire origini, essenze, leggi generali e grandiosi schemi
esplicativi. Occorre anche fare attenzione a un trabocchetto nascosto nella chiamata in causa da
parte degli storici: il rischio di contrapporre troppo nettamente la dimensione “antropologica”,
come essi la chiamano, alla contingenza storica e contestuale, relegando così l’antropologia al ruolo
di disciplina residuale e subalterna, di ultimo rifugio per quelle spiegazioni che non si riescono a
trovare nell’analisi strettamente storiografica. Gli storici, abbiamo visto, hanno talvolta a che fare
con fenomeni di dilatazione dei contorni spazio-temporali degli eventi; sanno quanto insidioso sia
uscire dal contesto, e chiedono l’aiuto di quella guida autorizzata – per quanto malfidata – che è
l’antropologia. Usano il termine “antropologia” come se alludesse a qualcosa che sta al di là della
storia – invitando per così dire gli antropologi a un peccato per loro fin troppo familiare. A questa
provocazione, essi possono rispondere senza perdersi solo a patto di restare saldamente ancorati al
contesto storico, accettandone per intero la specificità e la complessità.
Per tornare al problema iniziale: lo scandalo storiografico di una violenza eccessiva e arcaica, che
contrasta con le stesse finalità razionali della guerra, sembra aprire lo spazio all’intelligenza
antropologica. Ma quest’ultima non può assumere la forma di una risposta generale alla domanda
“perché si uccide in guerra?”. L’antropologia non è specializzata negli oscuri recessi dell’animo
umano, o nella “dinamica universale della violenza assoluta” – non più di quanto lo siano la storia,
la biologia o, se è per questo, il senso comune. Ha semmai qualcosa da dire sul piano delle piccole
domande, dell’analisi dei microcontesti, delle strategie culturali locali. Se può aggiungere qualcosa
al sapere storico, è mettendo in gioco peculiari metodi di indagine e categorie interpretative
maturate all’interno di una tradizione intellettuale che di “scandali” etici ed epistemici, come si
esprimeva Ernesto de Martino, si è nutrita da sempre. Il caso, sopra citato, degli studi sugli eccidi
nazisti di civili è uno dei pochi che abbia finora visto incursioni antropologiche di questo tipo, con il
tentativo di chiarire le modalità eminentemente culturali di costruzione della memoria da parte dei
sopravvissuti (si veda in particolare Pasquinelli 1996, nonché gli atti in parte ancora inediti del
convegno In memory. Per una memoria europea dei crimini nazisti, Arezzo, 22-24 giugno
1994).
Vorrei concludere richiamando un altro esempio di scandalo storiografico – anzi, lo scandalo per
eccellenza della storiografia contemporanea. Gli studi sulla Shoah sono centrati attorno al
problema che qui ci interessa: come trattare una dimensione orrifica della guerra, che sembra
mantenere un margine irriducibile di inesplicabilità a fronte di ogni possibile, per quanto ampio,
criterio di razionalità politica. In particolare il recente dibattito sulla soggettività degli esecutori
della Shoah, aperto nell’ultimo decennio dagli storici americani Cristopher Browning e Daniel J.
Goldhagen, coinvolge massicciamente le categorie dell’interpretazione antropologica. Che tipo di
esseri umani erano i massacratori dei campi di sterminio o delle fosse comuni? Come hanno potuto
compiere in modo tanto zelante azioni contrarie a principi etici apparentemente elementari e
universali? Com’è noto, Browning (1992) ritiene che i massacratori siano “uomini comuni”, spinti
verso un comportamento mostruoso dalle circostanze storiche (l’ideologia nazista, il regime
totalitario, le pressioni della situazione bellica) unitamente ai meccanismi universali della
conformità di gruppo e dell’obbedienza all’autorità. Goldhagen (1996) preferisce invece parlare di
“tedeschi comuni”, e ritiene che causa necessaria e sufficiente dello sterminio sia la peculiare
ideologia antisemita del nazismo.
Mi interessa qui solo rilevare come Goldhagen faccia diretto ed esplicito richiamo all’approccio
antropologico nella impostazione stessa del suo argomento. La Shoah ci appare oggi inesplicabile,
egli afferma, perché noi diamo troppo facilmente per scontato il presupposto di una comune
umanità dei tedeschi nel periodo nazista: li supponiamo simili a noi, o almeno al modo in cui noi
amiamo rappresentarci - “figli sobri e razionali dell’Illuminismo, non guidati dal pensiero magico
ma radicati nella realtà oggettiva” (Goldhagen 1996: 29). Dovremmo, al contrario, guardare ai
tedeschi partendo dal presupposto di una loro radicale alterità : guardarli cioè
con l’occhio critico dell’antropologo che sbarca in una terra sconosciuta, aperto
all’incontro con una civiltà radicalmente diversa dalla propria e consapevole di dover
elaborare interpretazioni che non si adattano al suo senso comune, o persino lo
contraddicono, per poter capire la struttura di quella civiltà (Ibid.: 16).
Qui Goldhagen sembra enunciare un programma di ricerca relativista. Intende partire dal “rifiuto
dell’universalità del nostro «senso comune»” (Ibid.), mettere in discussione il presupposto
dell’affinità fra quella società e la nostra. Ciò che rende la cultura tedesca degli anni ’30
radicalmente “altra” è appunto l’antisemitismo, nella sua peculiare variante eliminazionista, che
gode in essa dello status di modello culturale o cognitivo – concetto che Goldhagen mutua
dall’antropologia cognitiva e da autori come D’Andrade, Lakoff e Harré. Un modello cognitivo è un
insieme di assunti che forniscono la struttura della “conversazione” di ogni società (Ibid.: 36). Tali
assunti non sono semplicemente opinioni condivise: sono la base comune a partire dalla quale le
opinioni stesse possono venir espresse. Non sono oggetto di dubbio o di certezza: sono il perno sul
quale i giudizi di dubbio o certezza si incardinano. Rappresentano dunque un prisma attraverso cui
guardare il mondo, nel quale ogni membro di una cultura è per così dire imprigionato, di cui non
può neppure rendersi conto se non uscendo dalla propria cultura. Così Goldhagen può affermare
(Ibid.: 41) che gli ebrei non sono soltanto valutati secondo i principi e le norme morali di quella
cultura, ma divengono costitutivi dell’ordine morale stesso e degli elementi cognitivi fondamentali
che delineano il campo del sociale e dell’etico. L’antisemitismo non sarebbe dunque solo un aspetto
di una visione del mondo, ma il cardine stesso attorno al quale quella visione ruota.
Goldhagen ha subìto un gran numero di critiche, fattuali e concettuali, da parte degli storici. Ma
raramente ci si è soffermati a valutare l’impianto antropologico della sua argomentazione. I
problemi antropologici che Goldhagen solleva sono reali e importanti: d’altra parte, è palese è il
fatto che egli se ne serve in modo superficiale e strumentale. Ad esempio, il concetto di modello
culturale che egli usa è decisamente semplicistico e superato dal punto di vista dell’antropologia
cognitiva. Goldhagen assume un eccessivo grado di coerenza interna del modello, e sottovaluta
sistematicamente la sua elasticità e le possibilità di divergenza individuale (Hinton 1998: 12).
Inadeguata e ingenua, ancora, è la sua discussione del relativismo e della incommensurabilità tra
sistemi etico-culturali; altrettanto ingenua la sua concezione delle credenze (antisemite) come
unica causa dell’azione genocida, concezione che ignora la complessità dei rapporti tra ragioni,
motivi e cause del comportamento.
Può darsi che la riflessione maturata dall’antropologia culturale su questi temi possa risultare di
qualche aiuto alla comprensione. Ciò che stupisce è il quasi totale silenzio mantenuto dagli
antropologi, di fronte a un dibattito che pure ha varcato i confini specialistici e ha avuto una certa
risonanza nell’opinione pubblica (l’unica eccezione di cui sono a conoscenza è Hinton 1998);
silenzio che contrasta, per tornare a un punto precedente, con la quasi maniacale attenzione alle
variazioni percentuali negli episodi di morte violenta in società formate da poche centinaia di
individui. Certo, ogni disciplina ha i suoi percorsi privilegiati, e l'antropologia procede attraverso
un “giro lungo” che la porta lontano dal centro, verso i più sperduti “angoli di mondo”. E’ anche
vero, però, che la Shoah ci pone di fronte ai limiti estremi della variabilità culturale e morale degli
esseri umani, di fronte a quella che Primo Levi chiamava “una gigantesca esperienza biologica e
sociale”. C’è da chiedersi se la scienza dell’uomo e della diversità culturale possa ignorare tutto
questo.
* in Parolechiave, 20-21 (“Guerra”), 1999, pp. 281-303
3. Per un’antropologia della Shoah:
cultura, modelli cognitivi e ordinari carnefici.
(Fabio Dei)
1. Un breve articolo apparso nel 1992 su American Anthropologist faceva rilevare il pressoché
totale silenzio dell’antropologia sul tema della Shoah – o dell’Olocausto, come gli americani
continuano impropriamente ad esprimersi. L’autrice, Carroll McC. Lewin, attribuisce tale silenzio a
una certa “riluttanza”, condivisa con altre discipline, ad affrontare gli aspetti più perturbanti della
Shoah: in particolare, quegli “aspetti nascosti” della società moderna e del progresso scientifico e
culturale che essa mette in luce (Lewin 1992: 161). A me pare piuttosto che la latitanza degli
antropologi su questo tema non sia che un aspetto dei loro difficili rapporti con la storia
contemporanea: vi è, da un lato, il timore di invadere ingenuamente campi fortemente specialistici,
dall’altra la tacita accettazione di una divisione del lavoro che riserva all’antropologia lo studio delle
società senza Stato. Così, mentre esistono ad esempio ricche tradizioni di studio su guerra e
violenza tra piccole comunità di cacciatori e raccoglitori o orticoltori, sembra illegittimo un
approccio antropologico alle grandi guerre che hanno mutato i destini dell’umanità nel ventesimo
secolo. Queste ultime sarebbero eventi unici, integralmente riconducibili alla razionalità politicoeconomica degli Stati che ne sono protagonisti; laddove le spiegazioni antropologiche
generalizzanti e strutturali, sarebbero pertinenti in contesti senza Stato – il che equivale a dire,
spesso, senza storia.
Questi pregiudizi epistemologici sembrano oggi superati, con ampie celebrazioni del “ritorno a
casa” dell’antropologia. Ma il silenzio sulla storia contemporanea, e sulla Shoah in particolare,
rimane. L’appello di Lewin all’apertura di un programma di studi in tal senso è rimasto senza
risposta, con rare eccezioni (si vedano negli anni Novanta Lewin 1993, Stein 1993, Conte-Essner
1995, Hauschild 1997, Linke 1997, Hinton 1998). Eppure la pertinenza antropologica del tema è
diretta e palese. Basti pensare all’importanza di un’antropologia storica del nazismo, che
ricostruisca non tanto le premesse strettamente ideologiche, quanto il più ampio contesto culturale
nel quale l’antisemitismo eliminazionista ha preso forma e concretezza; oppure, al tema del lager
come radicale esperimento antropologico, secondo un’idea suggerita fra gli altri da Primo Levi e
ripresa da Francesco Remotti in un suggestivo passo di Noi, primitivi (Remotti 1991: p. 39). E si
pensi ancora al problema della costruzione sociale della violenza e dell’obbedienza all’autorità,
fondamentale per ogni tentativo di comprendere il comportamento degli esecutori della Shoah; e,
su un diverso piano, al dibattito fra concezioni universaliste e relativiste dei diritti umani aperto
dalle reazioni intellettuali al genocidio (Cohen 1989). Infine, di stretta pertinenza antropologica
appare il tema della rappresentazione della Shoah: sia nel senso dell’analisi della strutturazione
retorica e narrativa delle testimonianze dei superstiti, che rappresentano la principale fonte
conoscitiva (v. fra l’altro Lang 1988, Langer 1991, Young 1988, 1993), sia nel senso più generale
della possibilità di testualizzare e rappresentare “oggettivamente” un evento che raggiunge i limiti
estremi dell’esperienza umana. Un punto, quest’ultimo, sottolineato dalla stessa Lewin. Questa
studiosa fa notare acutamente come la Shoah ponga in modo particolarmente drammatico quel
problema del rapporto tra testo e realtà che sta alla base delle correnti cosiddette postmoderne
dell’antropologia; assai superficiali appaiono però le sue conclusioni, che vedono nel rifiuto del
realismo etnografico e nella relativa frammentazione descrittiva un cedimento etico, potenziale
battistrada di interpretazioni revisionistiche (Lewin 1992: 163). Ben più complesso è il quadro del
dibattito fra “oggettivisti” e “postmodernisti” che si è aperto in storiografia (v. fra gli altri
Friedlander 1992, Braun 1994; Kellner 1994, Lang 1997, White 1999).
2. Lasciando sullo sfondo questi grandi temi, vorrei qui limitarmi a discutere un caso storiografico
che ha avuto una certa importanza negli anni ’90: il dibattito tra Cristopher Browning e Daniel J.
Goldhagen sulla soggettività degli esecutori della Shoah. In questo dibattito le categorie
dell’interpretazione antropologica si sono trovate massicciamente coinvolte, ad opera degli stessi
storici, senza che tuttavia gli antropologi abbiano voluto o potuto intervenire (la sola e preziosa
eccezione di cui sono a conoscenza è Hinton 1998). Sono consapevole di quanto, negli anni
trascorsi dalla pubblicazione del controverso libro di Goldhagen, I volenterosi carnefici di Hitler,
sia stato scritto e detto dagli storici su questo tema (v. fra l’altro i saggi raccolti in Finkelstein-Burn
1998 e in Shandley 1998). Nelle osservazioni che seguono non pretendo di dire nulla di nuovo, ma
semplicemente di rilevare elementi di pertinenza dell’antropologia messi in gioco in una
discussione densissima e di grande interesse; elementi che, per quanto maldestramente maneggiati
da Goldhagen, possono rappresentare un punto di partenza per quella integrazione
interdisciplinare che tanto spesso è auspicata.
Il tema della comprensione della soggettività degli esecutori del genocidio è stato a lungo
trascurato dalla storiografia, che si è adeguata al postulato di senso comune di una generica
“mostruosità” delle SS e dei più fanatici nazisti (o, al contrario, al cliché giustificazionista che li
rappresenta come semplici soldati che obbediscono agli ordini). Ma che tipo di persone erano gli
assassini degli ebrei? Con quali atteggiamenti, stati d’animo, presupposti culturali si ponevano di
fronte al loro “lavoro sporco”? Il loro comportamento può esser compreso nei termini di una teoria
dell’agire razionale? E ancora, è un tale comportamento compatibile con criteri minimi di
“umanità”? Questi problemi emergono in primo piano negli anni Novanta soprattutto a partire da
due libri: Uomini comuni di C. (1992) e il già ricordato I volenterosi carnefici di Hitler di D. J.
Goldhagen (1996). Si tratta di opere molto note, ed è appena il caso di ricordarne i punti salienti.
Il primo libro è la ricostruzione del punto di vista di un battaglione della polizia riservista tedesca
che, fra il ’41 e il ’42, fu lungamente impegnato in Polonia nelle operazioni prima di diretto
sterminio degli ebrei, attraverso rastrellamenti e fucilazioni di massa, e successivamente nella
deportazione verso i campi di sterminio, finendo per causare, direttamente o indirettamente, la
morte di centinaia di migliaia di esseri umani, fra cui donne, anziani, bambini e neonati. Basandosi
sugli atti di un processo svolto negli anni ’60, Browning ricostruisce la personalità, le motivazioni e
gli stati d’animo dei componenti il Battaglione 101: tutti uomini ordinari, appunto, padri di
famiglia, non sadici mostri, non militari di professione, non particolarmente fanatici del nazismo e
dell’antisemitismo. Attraverso una brillante lettura delle fonti, l’autore segue le iniziali difficoltà dei
soldati nell’adattarsi al rapporto quotidiano con la fisicità della morte, con l’orrore dei corpi
seviziati e macellati; e poi le loro modalità di assuefazione a questo lavoro sporco, incluse le
giustificazioni e le razionalizzazioni prodotte ex-post.
Browning si chiede che cosa abbia spinto questi uomini normali ad eseguire ordini tanto terribili,
ad abituarsi al ruolo di assassini genocidi, perfino a trovare soddisfazione nel loro lavoro. La sua
risposta è complessa, e fa appello a una serie di elementi, alcuni di ordine storico e altri di tipo
socio-psicologico. Fra i primi, le convenzioni antisemite, la forza della disciplina militare e
l’influenza dello stato di guerra, con la paura e la rabbia per le sorti di una Germania accerchiata; e
ancora, la natura totalitaria della società nazista, che assolutizza i valori della subordinazione
all’autorità costituita. Fra gli elementi psicologici, Browning cita la tendenza alla conformità di
gruppo e soprattutto i meccanismi - in apparenza universalmente umani - dell’obbedienza
all’autorità, con ampi riferimenti ai celebri studi di Stanley Milgram (1975) e di altri psicologi
sociali; fra gli elementi sociologici, riprende e discute le note tesi di Hannah Arendt sulla
deresponsabilizzazione morale degli individui che sarebbe prodotta dalla società moderna. Tutti
elementi che attenuano, annullano o forse semplicemente cambiano quella “coscienza morale” che
ci si aspetterebbe di trovare negli esecutori del massacro in quanto esseri umani.
L’approccio soggettivo di Browining viene ripreso, ma con un totale rovesciamento delle sue tesi,
nel libro di Goldhagen. Questo autore, reinterpretando fra le altre le stesse fonti di Browning,
sostiene che non di uomini comuni si è trattato, bensì di tedeschi comuni - intendendo con ciò che
la Shoah può trovare una spiegazione storica solo nelle peculiari condizioni della cultura tedesca
degli anni ’30 e ’40, e in particolare da quello che egli chiama il modello culturale o cognitivo
dell’antisemitismo eliminazionista. Pressioni sociali, conformità di gruppo e così via sono elementi
tipici di ogni cultura e società e, da soli, non spiegano un evento unico e terribile come la Shoah:
solo il peculiare antisemitismo eliminazionista può esser considerato causa necessaria e sufficiente
dello sterminio.
3. Uomini comuni o comuni tedeschi, dunque ? L’alternativa, apparentemente banale, nasconde
in realtà modalità profondamente diverse di intendere la comprensione storica - e, a me pare, ha
importanti implicazioni antropologiche, che provo a enucleare per poi discuterle singolarmente:
problema della incommensurabilità tra sistemi etico-culturali;
problema della pervasività e compattezza dei modelli cognitivi:
problema dell’individualismo metodologico e del rapporto tra credenza e azione
problema dell’interpretazione letterale o simbolica degli asserti degli informatori;
problema delle strategie retoriche della rappresentazione culturale.
In primo luogo, come accennato, Goldhagen fa un diretto ed esplicito richiamo all’approccio
antropologico nella impostazione stessa del suo argomento. La Shoah ci appare oggi inesplicabile,
egli afferma, perché noi diamo troppo facilmente per scontato il presupposto di una comune
umanità dei tedeschi nel periodo nazista: li supponiamo simili a noi, o almeno al modo in cui noi
amiamo rappresentarci - “figli sobri e razionali dell’Illuminismo, non guidati dal pensiero magico
ma radicati nella realtà oggettiva” (Goldhagen 1996: 29). Dovremmo, al contrario, guardare ai
tedeschi partendo dal presupposto di una loro radicale alterità : guardarli cioè
con l’occhio critico dell’antropologo che sbarca in una terra sconosciuta, aperto
all’incontro con una civiltà radicalmente diversa dalla propria e consapevole di dover
elaborare interpretazioni che non si adattano al suo senso comune, o persino lo
contraddicono, per poter capire la struttura di quella civiltà (Ibid.: 16).
Qui Goldhagen sembra enunciare un programma di ricerca relativista. Intende partire dal “rifiuto
dell’universalità del nostro «senso comune»” (Ibid.), mettere in discussione il presupposto
dell’affinità fra quella società e la nostra. Se la Shoah è un evento unico nella storia, non dovremmo
esitare a presupporre l’unicità e l’alterità radicale della cultura che lo ha prodotto, egli afferma.
In particolare, Goldhagen ritiene che questa alterità consista nell’insieme di convinzioni razziste,
e nella peculiare variante eliminazionista dell’antisemitismo, diffuse capillarmente nella cultura
tedesca di quell’epoca, nella quale godrebbero dello status di presupposti fondamentali, di certezze
assiomatiche che si collocano al di sopra o al di sotto del dubbio. Noi sottovalutiamo questo punto,
afferma Goldhagen, perché quelle credenze ci appaiono oggi troppo assurde e fantastiche;
ponendosi nella posizione dell’antropologo, egli ci ricorda come quasi tutte le culture storicamente
conosciute abbiamo sostenuto insiemi di credenze oggi, e qui, considerate assurde, ma da loro
considerate “così tautologicamente vere da entrare a far parte del «mondo naturale» della gente,
dell’ordine naturale delle cose” ; credenze e norme tanto indiscusse da risultare intrecciate “nel
tessuto stesso dell’ordine morale della società, non più suscettibili di dubbio di quanto lo sia per
noi una delle nostre idee fondanti, che cioè la «libertà» sia un bene” (Ibid.: 31).
Qui Goldhagen è molto netto: non si possono presupporre universali etici cui ogni cultura
dovrebbe almeno in parte uniformarsi. Questo richiamo al relativismo (che peraltro, vedremo, è
contraddetto da altre sue assunzioni intellettuali), è sostenuto nel libro per mezzo della teoria
antropologica dei modelli cognitivi, ripresa da autori come D’Andrade, Lakoff e Harré.
L’antisemitismo eliminazionista possiede per Goldhagen, per l’appunto, lo status di modello
cognitivo: un insieme di assunti che forniscono la struttura della “conversazione” di ogni società dove per conversazione, con Harré, si intende l’insieme degli scambi verbali e comunicativi della
realtà sociale (Ibid.: 36). Tali assunti non sono semplicemente opinioni condivise: sono la base
comune a partire dalla quale le opinioni stesse possono venir espresse. Non sono oggetto di dubbio
o di certezza: sono il perno sul quale i giudizi di dubbio o certezza si incardinano. Rappresentano
dunque un prisma attraverso cui guardare il mondo, nel quale ogni membro di una cultura è per
così dire imprigionato, di cui non può neppure rendersi conto se non uscendo dalla propria cultura.
Così Goldhagen può affermare (Ibid.: 41) che gli ebrei non sono soltanto valutati secondo i principi
e le norme morali di quella cultura, ma divengono costitutivi dell’ordine morale stesso e degli
elementi cognitivi fondamentali che delineano il campo del sociale e dell’etico. L’antisemitismo non
sarebbe dunque solo un aspetto di una visione del mondo, ma il cardine stesso attorno al quale
quella visione ruota.
Come commentare questo punto di vista? E’ evidente come tutto ciò abbia a che fare col difficile
problema antropologico della incommensurabilità delle culture altre. Possiamo notare, in prima
istanza, come Goldhagen faccia uso di una nozione piuttosto semplicistica e grossolana di modello
culturale, che non tiene conto delle più sofisticate teorie antropologiche sul rapporto tra modelli
sociali e comportamenti e motivazioni individuali (Hinton 1998: 12). Intanto, i modelli non sono
concepibili come dottrine o insiemi di asserti, forse neppure come visioni del mondo in senso
classico: sono piuttosto strutture di senso ampie ed elastiche, che vengono apprese, assimilate e
fatte proprie dagli individui in modi molti diversi, e con una possibilità molto ampia di variazioni.
Goldhagen considera l’antisemitismo eliminazionista come modello monoliticamente e
acriticamente accettato da tutti i tedeschi, e solo da loro. In questo modo egli assume un grado
eccessivo di coerenza interna del modello, secondo quello che Claudia Strauss ha chiamato il
“modello fax” della socializzazione (in D’Andrade-Strauss 1992; cit. in Hinton 1998: 12); inoltre,
sottovaluta da un lato le possibilità di divergenza individuale, dall’altro le continuità e i contatti fra
la cultura tedesca e le altre. In definitiva, i tedeschi non erano certo gli unici feroci antisemiti del
loro tempo, come molti storici hanno obiettato, né sono stati gli unici esecutori materiali della
Shoah - un punto che indebolisce la tesi di Goldhagen, il quale dà in proposito spiegazioni
sostanzialmente circolari (1996: 424 sgg.).
Inoltre, Goldhagen non sembra rendersi conto che questa relativizzazione della cultura tedesca
degli anni ’30 e ’40, l’insistenza sulla sua radicale alterità, fornisce paradossalmente una
giustificazione morale potentissima agli esecutori - e non a caso, ha rappresentato spesso il
principale argomento difensivo dei criminali nazisti. Se non era per loro possibile uscire dalla
propria cultura, distanziarsi dagli assunti fondamentali dell’antisemitismo eliminazionista, è allora
possibile almeno sollevarli dalla responsabilità morale individuale. Quest’ultima si dà infatti solo
quando vi sia reale possibilità di scelta fra il bene e il male. Goldhagen intende il suo libro come un
atto d’accusa definitivo contro i tedeschi : ma in realtà, quando sostiene che essi erano tanto
radicalmente alieni da non percepire come male l’uccisione di esseri umani inermi e innocenti, li
solleva dalla colpa.
4. Vi è una ulteriore e ancor più importante considerazione critica: le motivazioni all’azione non
seguono affatto meccanicamente rispetto all’acquisizione di descrizioni culturalmente modellate
della realtà. Qui si manifesta un limite serio della prospettiva di Goldhagen, che potremmo definire
in termini di individualismo metodologico o, per certi versi, di “intellettualismo”. Egli suppone che
le credenze rappresentino il presupposto necessario e sufficiente dell’azione, che dunque la
spieghino. “Sono le conoscenze e i valori, e soltanto questi, che in ultima istanza inducono un uomo
a levare volontariamente la mano verso un altro” (Ibid.: 22). Rispetto a Browning, che tenta di
ricondurre il comportamento degli esecutori dello sterminio a un insieme di fattori strutturali,
determinanti culturali, pressioni sociali e psicologiche, Goldhagen afferma con forza, lungo tutto il
suo ponderoso studio, la priorità esplicativa delle credenze. Ogni altro fattore, sostiene, non è
sufficiente a spiegare le peculiarità della Shoah. In questo modo egli aderisce, seppur
implicitamente, a una teoria intellettualista del soggetto agente, e propone una spiegazione
razionale del genocidio come opera di attori razionali che agiscono semplicemente secondo
sequenze di comportamenti diretti ad uno scopo. Come nelle vecchie teorie intellettualiste sulla
religione o sulla magia, date credenze di un certo tipo, è normale che si produca un certo tipo di
comportamenti.
Gli oppositori di Goldhagen, come Browning stesso, sono mossi dalla considerazione che quelle
credenze sono troppo assurde, “errate” o irrazionali per esser prese alla lettera, e per poterle
considerare come perno di corsi d'azione così drammatici. La loro argomentazione ricorda quella di
Wittgenstein (1975: 28), che ironizzava sui libri per le scuole elementari in cui sta scritto che Attila
intraprese le sue guerre di conquista perché credeva di possedere la spada del dio del tuono. Le
credenze non sono mai una base sufficiente dell'azione - può semmai esser vero il contrario.
Inoltre, alcuni studiosi sembrano convinti di non poter interpretare alla lettera credenze sulla
natura subumana degli ebrei, che contrasterebbero con un principio minimo universale di
razionalità epistemologica, o di “umanità” nel senso morale del termine. L’ideologia nazista non
può non innestarsi su un più profondo e universale sostrato culturale, su preesistenti e mai del
tutto cancellabili “certezze”, sia pure pre-discorsive, che fanno riconoscere un essere umano come
essere umano, e che non lasciano dubbi sul significato degli atti di violenza e di privazione della
altrui vita. Dunque, le credenze naziste andrebbero reinterpretate per renderle compatibili con il
fondamentale riconoscimento dell’umanità degli ebrei.
E’ un argomento familiare all’antropologia religiosa, che tende ad assegnare un significato
simbolico e non letterale a quelle credenze magico-religiose che contrastano palesemente con il
sapere empirico o con i criteri logici che una cultura possiede o che almeno, in quanto cultura
umana, non può non possedere (v. in proposito Simonicca-Dei 1998). E in effetti, numerosi sono i
punti in cui la disputa Browning-Goldhagen prende la forma di contrasto tra interpretazione
letterale e simbolica delle asserzioni dei realizzatori dello sterminio. Il problema è complicato dal
fatto che si tratta di asserzioni pronunciate durante un processo, quindi modulate secondo possibili
vantaggi giudiziari, e che per di più si riferiscono alla memoria di eventi di venti anni prima, letti
quasi necessariamente in modo selettivo.
Un esempio. Durante il massacro di Lomazy gli uomini (Goldhagen preferisce usare il termine
“tedeschi” piuttosto che “uomini”, ritenendo evidentemente che la seconda nozione non contenga
necessariamente la prima) del Battaglione 101 provano meno disagio rispetto al loro primo eccidio.
Evidentemente si sono assuefatti al “lavoro sporco”. Ma Browning interpreta il minor disagio come
conseguenza del fatto che gli uomini non erano stati posti di fronte alla scelta se partecipare o no al
massacro, diversamente dal primo episodio di Jozefow, in cui il comandante del battaglione aveva
offerto a chi non se la sentiva di tirarsi indietro. Dunque, i soldati dovevano solo obbedire agli
ordini e non sentivano su di sé il peso di una scelta morale. Goldhagen rifiuta questa
interpretazione: semplicemente, egli sostiene, i soldati si erano assuefatti agli aspetti spiacevoli e
fisicamente ripugnanti del loro compito, e “facevano tutto il loro dovere, non perché non avessero
scelta (formalmente, quanto meno), ma perché non avevano buoni motivi per fare altrimenti”
(Goldhagen 1996: 557 nota). In altre parole, Browning ritiene impossibile o improbabile che i
soldati non provassero avversione per il loro compito (una assunzione di elementarmente umano),
e procede a interpretare le loro azioni e asserzioni “simbolicamente”, riferendosi a profonde
dinamiche psichiche e così via. Goldhagen sostiene invece un'interpretazione “letterale” (fare una
cosa è indice di motivazioni a farla, o almeno di assenza di motivazioni a non farla), che prescinde
da significati nascosti e da dinamiche inconsce).
Gli esempi pertinenti si potrebbero moltiplicare, e ne aggiungo solo un altro. I soldati del
Battaglione 101 raccontano spesso di momenti di socialità festiva che seguivano talvolta i massacri,
nel corso dei quali alcuni di loro si vantavano delle uccisioni compiute o le prendevano a oggetto di
macabri scherzi. Browning ritiene impossibile che si tratti di veri festeggiamenti, e li interpreta,
all’interno del proprio schema, come segno dell'ottundimento della sensibilità, dell'abbrutimento
di chi era contrario al massacro o almeno ne era turbato (peraltro, il riso come reazione all’orrore è
fenomeno ben noto all’antropologia, che ha tentato di darne conto tramite nozioni quali
“dissonanza psicosociale” o “compartimentalizzazione psicologica”; v., Knauft 1987: 475,
Pasquinelli 1996: 121, Hinton 1998: 13). Goldhagen, al contrario, afferma che l'allegria è allegria, e
che essa si spiega solo col fatto che i tedeschi non consideravano delittuosi quegli eccidi. “Quella
non era gente abbrutita e insensibile: scherzavano su azioni che ovviamente approvavano, e alle
quali avevano preso parte con evidente piacere” (1996: 562 nota). Come i cacciatori al ritorno dalla
battuta, insomma: i tedeschi usavano la metafora della caccia all'ebreo, che forse non era solo
metafora (Ibid.: 251).
5. Questo scontro sulla interpretazione di fatti peraltro accettati da entrambi è molto interessante.
Browning e Goldhagen si accusano a vicenda di fare uso troppo selettivo delle fonti (v. anche
Browning 1998, 1999): ma il punto è che, una volta fatta la scelta interpretativa iniziale, ogni
dettaglio si posiziona facilmente attorno ad essa, senza che sia mai possibile invocare puri “fatti”
che spezzino la circolarità argomentativa. Di fronte a ciò, il lettore non può prender posizione sulla
base di considerazioni empiriche, e finirà per schierarsi dalla parte in cui avvertirà maggiore
sensibilità, autorevolezza o raffinatezza argomentativa e stilistica. Il che ci conduce a un ultimo
punto. I due autori trattano le fonti in modo molto diverso, e costruiscono due generi diversi di
libro. Goldhagen pretende di fornire una spiegazione, per di più monocausale, della Shoah. Egli
costruisce il libro come un trattato: un accumulo di fatti e prove empiriche a supporto di una
intelaiatura di asserzioni teoriche connesse da legami logico-argomentativi. Si richiama
esplicitamente a una metodologia scientifica di tipo popperiano (il che ha forse a che fare con il
tono presuntuoso e a tratti arrogante del suo discorso, tipico di quasi tutti gli antropologi di scuola
popperiana, da Ian Jarvie a Derek Freeman): non mira a produrre rappresentazioni
impressionistiche, ma a formulare ipotesi limpidamente soggette a giudizi di verità-falsità (ma
sulla falsificabilità delle sue ipotesi, incastonate all’interno di un quadro interpretativo totalizzante,
ci sarebbe molto da dire).
Browning, da parte sua, sembra puntare piuttosto ad una stretegia comprendente. Egli compone
il testo in forma narrativa, concentrandosi su singoli personaggi, su ambientazioni, su dettagli, nel
tentativo di ricostruire la realtà fenomenologica degli esecutori. Ciò rende il suo libro senza dubbio
più gradevole, e la sua figura autoriale più equilibrata di quella di Goldhagen. Peraltro, anche
quest’ultimo asserisce di mirare a rendere la realtà fenomenologica della violenza, in una serie di
passi descrittivi che contrastano singolarmente col tono complessivo del suo libro. Si ha
l’impressione che anche in Goldhagen, forse involontariamente e malgrado le proprie esplicite
asserzioni teoriche, finisca per operare una strategia comprendente, che mira all’identificazione
immaginativa del lettore nelle vittime o negli esecutori della violenza nazista. Non si
spiegherebbero diversamente le dimensioni e il carattere estremamente ripetitivo dell’opera, dove
gli “esempi” sono assolutamente ridondanti rispetto alle esigenze argomentative.
Questo è forse uno dei motivi del successo popolare del libro: a un’argomentazione quasi
sillogistica e di facile presa, che si è giustamente attirata le critiche della gran parte degli storici, si
sovrappongono frammenti di rappresentazione narrativa che parlano prevalentemente
all’immaginario del lettore. Un collage di frammenti, peraltro, che forse dice qualcosa di diverso
dalle esplicite opinioni dell’autore, alludendo in definitiva - a me pare - a quella che malgrado tutto
è la comune umanità dei nazisti, al fatto che ciascuno di noi avrebbe potuto partecipare a quella
tragedia non solo dalla parte delle vittime, ma anche da quella dei carnefici.
4. Il secolo delle tenebre. Verità storica e memoria sociale *
Fabio Dei
Il Novecento sarà ricordato dagli storici futuri come il secolo delle tenebre? Con questa
domanda Tzvetan Todorov apriva nel marzo 2000 un convegno senese dedicato a Storia, verità,
giustizia. I crimini del XX secolo. Si trattava di un incontro internazionale di grande respiro
teorico, volto a fare il punto sull’aspetto più oscuro e inquietante della storia del Novecento,
quello dei totalitarismi, delle violazioni dei diritti umani, delle stragi di popolazioni civili, dei
genocidi. Del convegno sono di recente usciti gli atti, con lo stesso titolo e a cura di Marcello
Flores (ed. Bruno Mondadori, 2001). Trovo che si tratti di un libro molto importante, e non solo
sul piano strettamente storiografico. I temi che affronta sono infatti centrali per quel processo di
plasmazione della memoria e di ricostituzione di categorie etiche e politiche da cui molti di noi si
sentono impegnati in questo esordio di XXI secolo. Vorrei qui discutere alcuni degli spunti che il
libro propone, legandoli ad altri recenti contributi al dibattito sulla memoria storica e con
un’attenzione particolare ai nessi con la mia disciplina di studio – che non è la storia ma
l’antropologia culturale.
1. Totalitarismi, democrazie e guerra totale.
E’ ormai acquisito che i crimini del XX secolo non possono essere compresi come occasionali
cadute o incidenti di percorso, buchi neri in una storia che resterebbe comunque di civiltà e di
progresso. Al contrario, essi esprimono un aspetto essenziale, per quanto parziale, del Novecento, e
a quel progresso sono profondamente e paradossalmente legati. Naturalmente, è difficile una
comparazione con altri secoli in termini di maggiore o minore barbarie e atrocità. La storia gronda
sangue ed è costellata di eccidi e violenze . Quel che caratterizza il Novecento è da un lato la
potenza delle tecnologie di morte impiegate, queste sì senza precedenti; e, dall’altro, la novità del
contesto politico in cui la violenza è stata impiegata. Come sottolinea Flores, alla base di tutti i
piccoli e grandi massacri del secolo vi sono stati “piani d’ingegneria etnica o sociale, razziale o
politica”, guidati da una “volontà di modificare la storia – di accelerarla, deviarla, indirizzarla –
che diventa desiderio e ossessione di poterla dominare” (p. 381).
Questa volontà di dominare la storia è tipicamente moderna, e sembra direttamente connessa
alla peculiare esperienza novecentesca dei totalitarismi. Questa è appunto la tesi di Todorov: i
crimini del XX secolo scaturiscono per lui in modo diretto dal “manifestarsi di un male nuovo, di
un regime politico inedito, il totalitarismo, che al suo apogeo ha dominato su buona parte del
mondo; un regime che è attualmente scomparso dall’Europa ma indubbiamente non dagli altri
continenti, e i cui postumi continuano ad agire tra noi” (p. 1). Il totalitarismo viene definito da
Todorov come un “utopismo scientista”: in esso si saldano la fede acritica e dogmatica nel sapere
positivo (lo scientismo è qui inteso non come scienza ma come religione, una dottrina che
contraddice la stessa natura critica della scienza) con “lo spirito rivoluzionario, il progetto, cioè, di
creare attraverso mezzi violenti una società nuova, abitata da uomini nuovi” (p. 7). Sarebbe dunque
questa miscela esplosiva di ingredienti moderni a fondare la violenza del ventesimo secolo, a
rappresentarne la metà oscura - in opposizione all’altra metà costituita dal grande nemico del
totalitarismo, la democrazia.
Todorov è naturalmente consapevole del carattere controverso della nozione di totalitarismo, che
include esperienze storiche diverse e per alcuni non accomunabili: ritiene tuttavia che la
contrapposizione democrazia-totalitarismo resti lo strumento fondamentale per pensare la storia
recente e il nostro stesso tempo. Altri contributi del volume tendono invece a sfumare questa
dicotomia, e a mostrare come la violenza politica si distribuisca in modi trasversali rispetto ad essa.
Lo stesso Flores, ad esempio, vede un tratto caratterizzante del Novecento nella “crescita di
istituzioni di controllo e repressione che hanno spesso acquistato un’autonomia di comportamento
quando anche non di stato giuridico”, che hanno fatto uso sistematico della violenza e della
violazione dei diritti umani e che non sono state affatto un’esclusività dei totalitarismi: si collocano
anzi “in un continuum, dove la contrapposizione tra democrazia e dittatura non è di per sé
sufficiente a garantire quella tra legalità e illegalità, tolleranza e violenza” (p. 382).
Non mancano certo esempi di crimini commessi in nome e per conto della democrazia, anche fra
le pagine di questo libro. In particolare, il comportamento dei paesi occidentali nel contesto del
dominio coloniale non mostra una netta demarcazione fra democrazie e totalitarismi; e lo stesso
vale per la conduzione di guerre di carattere “totale”, nelle quali la popolazione civile – come scrive
Gabriele Ranzato, “è equiparata a un obiettivo militare o addirittura diventa un bersaglio
privilegiato per il conseguimento della vittoria” (p. 70). Hiroshima ci appare oggi come uno dei
grandi crimini di guerra della storia recente, l’unico forse – è la tesi di Michael Löwy (p. 15) paragonabile alla Shoah per le dimensioni e per il diretto rapporto tra un disegno politico
(concludere rapidamente la guerra e stabilire una posizione di preminenza degli Stati Uniti nello
scenario del dopoguerra) e il massacro di centinaia di migliaia di persone innocenti. Ciò non
significa naturalmente sottovalutare l’importanza dei differenti progetti politici che sottendono
questi eccidi. Ma questa differenza è ciò che rende oggi Hiroshima ancor più inquietante,
unitamente al suo carattere, per così dire, di accentuata modernità. Siamo di fronte, scrive Löwy, a
una morte pulita e asettica recapitata dal cielo, attraverso un atto tecnico distante e impersonale,
privo di quei residui arcaici che caratterizzano ancora la Shoah – il sadismo e la furia omicida delle
SS, quella “violenza inutile” su cui ragiona Primo Levi in I sommersi e i salvati.
Analoghe considerazioni possono esser svolte su quella “guerra ai civili” che ha caretterizzato così
profondamente l’evolversi delle moderne strategie belliche. Il secondo conflitto mondiale ha
rappresentato un drammatico spartiacque sotto questo profilo: da una guerra combattuta tra
militari, si è passati a guerre che mietono fra i civili la stragrande maggioranza delle loro vittime.
Gli esempi più recenti, incluso quello che stiamo oggi vivendo, lo dimostrano. Qui l’ideologia o la
forma politica che supporta l’azione bellica sembra non far differenza sotto questo profilo. E’ la tesi
sostenuta con forza da Ranzato, che nel suo contributo ricostruisce una evoluzione in qualche
modo interna delle tecniche e degli apparati militari, largamente autonoma rispetto alle finalità per
le quali la guerra viene condotta: evoluzione che ha il suo punto di forza appunto nel
bombardamento di obiettivi civili. A quale logica rispondono i bombardamenti massicci delle città
tedesche e italiane, che hanno fatto la gran parte delle loro vittime quando le sorti della guerra
erano ormai decise? Il fatto che questa domanda sia stata posta in passato da revisionisti, più o
meno ansiosi di rovesciare il quadro delle responsabilità storiche di nazismo e fascismo, non la
rende meno inquietante.
Che la guerra tenda a operare secondo una sua logica interna, a svincolarsi e a divenire autonoma
rispetto alle finalità politiche che la muovono, l’aveva del resto osservato già Clausewitz. Nello
scenario del dopo-undici-settembre, non possiamo non chiederci se ciò valga anche per i peculiari
conflitti armati che hanno caratterizzato l’ultimo decennio, dalla guerra del Golfo al Kossovo
all’Afghanistan, sotto forma di interventi largamente appaggiati dalla comunità internazionale
contro aggressivi fondamentalismi regionali. La domanda è difficile, e la risposta nient’affatto
scontata. Da un lato, quel che oggi sappiamo sul comportamento dei militari nella Guerra del
Golfo, ad esempio, o sull’uso di uranio impoverito nei Balcani, è assai preoccupante. Dall’altro lato,
tuttavia, non possiamo ignorare di trovarci di fronte a contesti assai diversi dalle guerre totali del
Novecento, con la logica di massacro di civili che le ha caratterizzate. Sono semmai
l’ultranazionalismo e il terrorismo fondamentalista che mirano a creare scenari in cui le masse di
civili sono integralmente coinvolte in strategie di potere locale. In questo mutato contesto, vorrei
osservare per inciso, è anche difficile capire dove si situino le ragioni della pace – almeno, molto
più difficile di quanto a molti – su entrambi gli schieramenti – oggi appaia.
2. Le radici del male: illuminismo vs. storicismo
Ci sono dunque mostruosità della nostra storia, come dice Ranzato, che sono state commesse da
uomini non offuscati da ideologie, ma semplicemente disposti a usare qualsiasi mezzo per vincere il
nemico o punirlo. E’ tuttavia indubbio che alcuni crimini specifici, a partire dalla Shoah, non si
comprendano se non in riferimento a un peculiare contesto ideologico o almeno, in senso più
ampio, culturale. Tali crimini non si configurano semplicemente come mezzi per il raggiungimento
di finalità. Lo sterminio degli ebrei d’Europa si differenzia da Hiroshima perché rappresenta un
fine in sé: e si tratta di un fine che rimanda non a una generica razionalità politica, o a desideri, per
così dire, elementarmente umani, ma a un contesto socio-culturale assai specifico. Quali sono la
natura e le radici di questo contesto?
Il dibattito contemporaneo mi sembra muoversi tra due tesi contrapposte – ugualmente estreme,
e che è tuttavia interessante mettere a fuoco proprio nella loro radicalità. Entrambe le tesi vedono
la cultura criminale che ha sotteso la Shoah come profondamente connaturata all’età moderna e
alle sue origini. Ma mentre la prima individua nell’illuminismo e nella Rivoluzione francese le fonti
di un’ideologia totalitaria e disumanizzante, la seconda pone invece l’accento sugli esiti deleteri
della reazione ottocentesca al razionalismo illuminista e all’esperienza rivoluzionaria.
La prima tesi trova le sue basi filosofiche nella Dialettica dell’illuminismo di Adorno e
Horkheimer, e nelle riflessioni che Hannah Harendt e altri pensatori hanno svolto proprio a partire
dall’esperienza della Shoah. La sua formulazione più recente e più radicale si deve probabilmente a
Zygmunt Bauman, autore di un volume importante come Modernità e Olocausto. In un precedente
convegno senese dedicato a Nazismo, fascismo, comunismo. Totalitarismi a confronto (atti editi a
cura di M. Flores, Milano, B. Mondadori, 1998), Bauman aveva sostenuto con grande nettezza che
“gli orrori del XX secolo derivano dai tentativi pratici di creare la felicità, l’ordine di cui la felicità
aveva bisogno, e il potere totale necessario a instaurare quell’ordine” (p. 18). Questi tentativi, tra i
quali gli esperimenti nazista e comunista spiccano per la grandiosità degli obiettivi oltre che per
l’impatto storico, ereditano per Bauman l’ideale illuminista di un mondo integralmente governato
dalla Ragione, di una società perfetta e depurata dai residui di debolezza umana (pp. 24-5).
I campi di concentramento, il prodotto forse più mostruoso dei totalitarismi, sarebbero l’esito
estremo e più conseguente di questa Ragione-in-Atto, di una modernità che punta a una totale
adesione della realtà al modello ideale. Bauman pensa ai campi come a una sorta di permanente
possibilità antropologica della modernità, un luogo dove si inverano fino in fondo – e
paradossalmente – l’utopismo razionalistico e quello spirito rivoluzionario che è convinto di poter
programmare fino al dettaglio la vita umana. E laddove Todorov stabilisce un netto confine tra
totalitarismo e democrazia, Bauman sembra invece interessato alle aree di intersezione, alla
costante possibilità che la logica di un ordine totale progettato e amministrato dallo Stato, volto a
eliminare tutto ciò che è di disturbo o anche soltanto superfluo, si insinui nel mondo democratico,
magari sotto forme inaspettate. Hannah Arendt scriveva che “le soluzioni totalitarie possono
sopravvivere alla caduta dei regimi totalitari nella forma di forti tentazioni che si presenteranno
ogni volta che sembri impossibile alleviare la miseria politica, sociale o economica in un modo
degno dell’uomo” (Ibid., p. 32). Bauman sembra pensare che l’ordine dell’odierno capitalismo dei
consumi sia fortemente soggetto a simili tentazioni, pur nel quadro di una programmazione
fortemente dispersa, privatizzata e deregolata, e con la seduzione pubblicitaria che ha preso il posto
della coercizione, della sorveglianza e dell’addestramento.
La tesi contrapposta, per tornare al volume Storia, verità e giustizia, trova potente espressione
nell’intervento dello studioso israeliano Zeev Sternhell. Storico delle ideologie fasciste, Sternhell le
vede come “il nucleo e la variante più radicale di un fenomeno assai più diffuso e assai più vecchio:
una revisione complessiva dei valori essenziali insiti nell’eredità umanistica, razionalistica e
ottimistica proveniente dall’Illuminismo” (p. 47). Il fascismo, il nazismo e i loro esiti sono sì
prodotti del Novecento, legati alla crisi che seguì la Grande Guerra e all’emergere della società di
massa; il loro nucleo culturale è tuttavia antecedente, e consiste nella “lotta contro la modernità a
livello ideologico, vale a dire contro la tradizione francese e kantiana dell’illuminismo” (pp. 47-8).
Sternhell include sotto la nozione di “storicismo” questa reazione anti-illuminista, che fa
discendere dal movimento protoromantico tedesco e in particolare dal pensiero di Herder. Il
“relativismo storico” di Herder, il suo rifiuto di “qualsiasi interpretazione razionale dello sviluppo
sociale”, la sua insistenza sul Volksgeist o spirito di una nazione, in contrapposizione all’idea di una
ragione umana universale e di una altrettanto universale legge di natura – tutto ciò costituirebbe la
base di una ideologia reazionaria, volta verso il passato, esasperatamente nazionalista e
tendenzialmente razzista, che nell’Ottocento mette salde radici in Germania e in buona parte
d’Europa. Questo torbido miscuglio di idee irrazionaliste, di mistica nazionalista, di sfiducia nel
progresso e di nostalgie antidemocratiche passa poi nel Novecento, mediato dal grande attacco alla
modernità di Nietszche e da quello che Sternhell chiama (in modo piuttosto sorprendente) il
relativismo storico e morale di Croce. Fascismo e nazismo ne sono la traduzione politica – ciò che
succede quando la reazione anti-illuminista scende nelle strade.
Le posizioni di Bauman e di Sternhell non potrebbero contrapporsi in modo più netto. Come
detto, entrambe sono (volutamente, credo) parziali. Accentuano eccessivamente il peso di
movimenti culturali nel determinare gli eventi politici e i corsi d’azione della storia; e, soprattutto,
propongono interpretazioni a senso unico e quasi caricaturali di tradizioni di pensiero assai
complesse e articolate. Bauman trascura il semplicissimo fatto che sono stati l’illuminismo e la
rivoluzione francese a produrre una intera cultura dei diritti umani e un modello politico che lascia
ampi spazi di autonomia all’individuo all’interno della società - agli antipodi rispetto al
totalitarismo e a quelle sue particolari manifestazioni che sono il lager e il gulag. Sternhell, da parte
sua, dimentica il contributo essenziale che il razionalismo positivista ha dato all’affermazione della
teoria e della pratica razzista ed eugenetica tra Ottocento e Novecento, e la misura in cui le parole
d’ordine del progresso e della modernità scientifica sono state costitutive delle ideologie totalitarie.
Per contro e inversamente, dimentica tutti quegli aspetti della tradizione “storicista” che, proprio in
virtù dell’antiuniversalismo e dell’opposizione a una visione naturalista delle vicende umane,
hanno promosso il rispetto della diversità, la tolleranza, il dialogo - tutti quei valori ai quali i
totalitarismi e la “logica dei campi” si oppongono.
Questi due contrapposti tentativi di rintracciare le radici del “male” del ventesimo secolo,
tuttavia, non pongono soltanto un problema di storia delle idee. Si connettono invece direttamente
alle questioni che oggi ci affaticano, al dibattito del dopo-undici-settembre sullo scontro fra civiltà,
sulla “superiorità” occidentale, sui limiti e i pericoli del cosiddetto relativismo culturale e così via.
La tensione difficilmente risolvibile fra universalità dei diritti e particolarità delle culture, tra
fedeltà a certi nostri valori e tolleranza per i valori degli altri, che avvertivamo finora su un piano
prevalentemente teorico, ci si è manifestata nella sua drammatica concretezza etico-politica. Da
dove vengono oggi i rischi maggiori, dalla boria di un’autoproclamata superiorità o dalla sterilità di
un relativismo equivoco? E di cosa abbiamo più bisogno, di un approccio orientato verso la
ragione, il progresso, l’universalità, o di uno più attento alle culture, alla tradizione, alla
particolarità storica? E ancora, a quale modello di agente umano dovremmo far riferimento: la
astratta e dappertutto identica soggettività razionale distillata dal secolo dei Lumi, o una romantica
pluralità di soggetti storici, irriducibilmente legati a culture e tradizioni particolari?
Naturalmente, si può dare una risposta generica e di buon senso dicendo che abbiamo bisogno
del meglio di entrambe le tradizioni, quella illuminista e quella “storicista”, le quali devono
temperarsi a vicenda. Ci serve un illuminismo critico e consapevole dei limiti della ragione e dei
paradossi del progresso, ma anche una sensibilità per le differenze e le particolarità che non scivoli
sui versanti dell’irrazionalismo e del misticismo e non abdichi, come si esprimeva Ernesto de
Martino, alle fedeltà della nostra tradizione storica. Eppure, qualche volta, un cauto ed equilibrato
buon senso non serve a far progredire il dibattito. Io voglio dire che fra le due tesi sopra esposte
trovo particolarmente inaccettabile e pericolosa quella di Sternhell, con la sua svalutazione totale
della tradizione storicista, e con il suo implicito suggerimento che la cura per i mali della modernità
possa consistere nel ritorno “al razionalismo, all’universalismo e all’idea di progresso derivati
dall’Illuminismo francese”.
Anche se non posso qui sviluppare questo argomento, a me pare che riproporre una ragione e
un modello di agente razionale di tipo settecentesco non serva molto a capire la situazione che oggi
stiamo vivendo – né il processo di globalizzazione, né quello parallelo (e solo in apparenza
divergente) di una nuova esplosione di differenze e particolarismi. Si può davvero pensare ai
particolarismi culturali, religiosi o “etnici” (come si dice con termine equivoco) semplicemente
come a residui arcaici e superstiziosi, irrazionali incrostazioni sulla superficie di una soggettività
umana universale e tendenzialmente a-culturale? E si può davvero pensarli come destinati a esser
spazzati via sull’unica vera strada del progresso, nella graduale distillazione di un sistema sociale
volto a massimizzare l’utilità razionale? Se il nostro problema oggi è capire gli altri senza
pretendere che siano uguali a noi, comprendere i grumi di differenze al cui interno gli esseri umani
si costituiscono come tali, è piuttosto nella tradizione storicista che possiamo cercare appigli.
Incluso il vituperato Herder, che è sbagliato e ingiusto considerare come capostipite del pensiero
reazionario, antimoderno e razzista dell’età contemporanea, e di cui oggi dovremmo ricordare il
monito, rivolto all’Europa, a non comportarsi da “tiranna che costringe alla felicità tutte le
nazioni”.
3. Sull’indebolimento della verità
Il contrasto tra la tradizione illuminista e quella storicista ha a che fare con un altro problema
centrale nel dibattito contemporaneo, quello della verità storiografica e del suo rapporto con la
giustizia. A quale oggettività può aspirare la conoscenza storica? In che relazione sta la verità
storiografica con la verità dei testimoni della storia? E, infine, in che modo la verità storica può
fondare o almeno sostenere pratiche di giustizia?
E’ abbastanza diffusa l’idea che il (presunto) relativismo della tradizione storicista mini alla base
l’idea stessa di verità storica, legittimando potenzialmente ogni tipo di strategia revisionista e
negazionista. I recenti approcci “postmoderni”, che rifiutano una concezione realista del sapere
storico insistendo invece sugli inevitabili processi di plasmazione retorica e letteraria che lo
costituiscono, sono spesso i bersagli di simili critiche. La rinuncia a pretese di oggettività sembra
trapassare in un inaccettabile disimpegno etico nei confronti dei crimini e delle vittime della storia,
o, ancora peggio, in una sorta di complicità con i criminali stessi. L’indebolimento della verità è
infatti esplicitamente perseguito dai criminali. Le strategie negazioniste sono parte integrante degli
eccidi del ventesimo secolo, appartengono fin dall’inizio al loro progetto; e per contrastarle, sembra
che non possiamo fare a meno di una certa dose di oggettività o di realismo epistemologico –
dobbiamo poter distinguere con certezza verità e finzione, dire che lo cose sono andate così e così, e
basta.
Tra gli storici che hanno recentemente sostenuto questo punto di vista spicca il nome di Carlo
Ginzburg. Partendo da assunti epistemologici tutt’altro che ingenuamente realisti, riassunti nella
celebre formula del “paradigma indiziario”, Ginzburg ha difeso nelle sue ultime opere una nozione
critica ma forte di verità storica, in polemica con il decostruzionismo e con la “svolta retorica”
rappresentata ad esempio da Hayden White. E’ significativo che tale polemica si faccia
particolarmente dura a partire dal suo libro sul caso Sofri, e dalle considerazioni che lo
accompagnano a proposito del rapporto tra giudice e storico (Il giudice e lo storico, Torino,
Einaudi, 1991): nonché dal saggio, anch’esso dei primi anni ’90, “Just One Witness”, dedicato al
problema del negazionismo e della “vera” rappresentazione della Shoah (in S. Friedlander [ed.],
Probing the Limits of Representation. Nazism and the “Final Solution”, Cambridge, Mass. Harvard
University Press, 1992; versione italiana in Quaderni storici, 80, 1992). In questi scritti Ginzburg si
pone il problema dell’apporto della storia alla giustizia: e sostiene che questo apporto non può
tollerare i sofismi relativistici, e deve invece mirare a un ragionevole livello di oggettività, o almeno
a “prove” che possano decidere della verità/falsità di due versioni alternative (le dichiarazioni di
Sofri e quelle del pentito Marino, poniamo, o le narrazioni storiche di Primo Levi e quelle del
negazionista Faurisson).
In “Just One Witness” l’obiettivo polemico di Ginzburg è principalmente l’approccio retorico di
H. White, di cui egli mostra le radici nell’idealismo italiano, e in particolare nell’assunto gentiliano
per cui la storia è sempre una creazione della storiografia (p. 90). In un più recente libro, Rapporti
di forza (Milano, Feltrinelli, 2000), la critica si appunta sul decostruzionismo di Derrida e De Man,
la cui origine filosofica è con grande nettezza identificata in Nietzsche (a sua volta, per così dire,
campione della tradizione storicista) e nel suo celebre passo sulla verità e la menzogna:
Che cos’è dunque la verità? Un mobile esercito di metafore, metonimie,
antropomorfismi, in breve una somma di relazioni umane che sono state potenziate
poeticamente e retoricamente, che sono state trasferite e abbellite, e che dopo un lungo
uso sembrano a un popolo solide, canoniche e vincolanti... (cit. in Ibid., p. 25)
Questo passo, citatissimo nella letteratura decostruzionista, è per Ginzburg non solo paradossale,
in quanto implica la rinuncia ad ogni pretesa di conoscere il mondo attraverso il linguaggio (p. 35),
ma anche profondamente immorale. Tra la liquidazione della verità e la liquidazione della giustizia
il passo è breve: e Ginzburg cerca di dimostrarlo discutendo il caso di Paul De Man, che in nome
dell’ironia scettica postmoderna avrebbe nascosto per tutta la vita un passato collaborazionista e
antisemita. Il dominio della retorica si traduce così in una strategia di “autoassoluzione individuale
e collettiva” (p. 40), e dunque nella rinuncia al concetto stesso di giustizia storica.
Le osservazioni di Ginzburg sono importanti, e del tutto giustificato il suo richiamo alla nozione
di prova. C’è però da chiedersi se si possa accettare – chiamiamolo così – il ricatto etico contro gli
argomenti epistemologici del “relativismo” e del decostruzionismo. Soprattutto, mi pare
improponibile il nesso tra relativismo (qualunque cosa si intenda con questo termine) e
revisionismo o negazionismo. Problematizzare gli aspetti riflessivi e retorici nella costruzione del
sapere storico non significa affatto porre sullo stesso piano la verità delle vittime e quella dei
carnefici, o considerarle come due “finzioni” ugualmente costruite e ugualmente parziali. Al
contrario, proprio per la capacità di penetrare nelle modalità di costruzione del racconto storico, gli
approcci retorici possiedono una forte potenzialità critica verso la menzogna e la falsificazione. Chi
si è accostato qualche volta ai testi negazionisti, noterà come siano invece essi a prediligere il
linguaggio dell’oggettività e la retorica di una verità incondizionata: in essi, il confronto con il senso
complessivo di un racconto storico è sostituito da minuziose procedure “fisicaliste”, da sequele di
presunti dati di fatto, di piccole perizie da tribunale, di tentativi di screditare i testimoni e così via.
Ma non basta appellarsi ritualmente alla Verità, o fare ad essa professione di fede, per seguirne la
strada.
4. Il testimone e il racconto storico.
L’indebolimento postmoderno della verità è parso a molti inaccettabile soprattutto in relazione
all’etica della testimonianza. Come si può ridurre allo statuto di fiction quell’atto fondamentale del
portare testimonianza da parte di chi i crimini della storia li ha vissuti sulla propria persona, sul
proprio corpo, sui propri più cari affetti? Non è offensiva l’idea stessa di “decostruire” queste
testimonianze? Non prolunga l’atteggiamento di quegli aguzzini che dicevano alle vittime, come ci
rammenta Primo Levi, “anche se vi salverete e racconterete, non sarete credute”? Sembra cioè che
la verità testimoniale goda di uno statuto più solido rispetto alla narrazione storiografica, sia in
qualche modo meno attaccabile dallo scetticismo relativista.
Il rapporto tra testimonianza e storiografia è però molto più complesso di così. Su alcuni suoi
aspetti ha indirizzato l’attenzione un recente libro di Annette Wieviorka, che si intitola appunto
L’era del testimone (Milano, Cortina, 1999; ed. orig. L’Ère du témoin, 1998). Questa studiosa
analizza il progressivo emergere nel dopoguerra della figura del testimone individuale come nucleo
della memoria collettiva della Shoah. Non è così banale e scontata, come potrebbe oggi apparire, la
centralità del ricordo soggettivo, connotato da esperienze specifiche e da forti componenti
emozionali, per la nostra rappresentazione del passato; né è scontata l’idea che del racconto della
propria vita si possa e si debba fare atto di testimonianza pubblica. Non è così per i primi decenni
del dopoguerra, almeno fino al processo Eichmann (1961), che fa emergere per la prima volta il
testimone come figura pubblica. Successivamente, questa figura si colloca in un clima culturale in
cui la soggettività privata diviene sempre più oggetto di un discorso e di un immaginario diffuso.
Contribuisce a ciò la sessantottesca “presa di parola” della gente comune, con l’idea che “il
personale è politico”; vi contribuisce la tendenza di radio e televisione a esporre vicende personali,
intimi stati d’animo e difficoltà psicologiche, facendo spettacolo della parola e dei sentimenti di
quello che un tempo si chiamava “l’uomo della strada”. Nel clima culturale dell’occidente
mediatico, l’individuo è posto “al centro della società e retrospettivamente della storia. Diviene
pubblicamente, da solo, la Storia” (p. 110).
Questo nuovo clima culturale è di solito valutato positivamente. Combinato con gli sviluppi delle
tecnologie di registrazione audio e video, esso produce la grande stagione delle fonti orali, con un
progresso storiografico che non mi pare possa esser posto in dubbio. Tuttavia, non mancano
ambiguità in questo movimento verso la soggettività e verso una puntiforme storia dal basso –
ambiguità che Vieviorka attribuisce non tanto agli storici quanto al discorso mediale e pubblico
sulla storia. Tra i suoi principali bersagli c’è la Survivors of the Shoah Visual History Foundation,
la Fondazione creata nel 1994 dal regista Steven Spielberg con l’obiettivo di una raccolta a tappeto
delle testimonianze dei sopravvissuti ai lager nazisti. Questa grandiosa impresa di storia orale
raccoglie oggi più di 50.000 interviste in video, raccolte in 57 paesi e in 32 lingue diverse. Si
avvicina così a quella specie di sogno storiografico che consiste in un immane racconto del passato
narrato da tutti coloro che l’hanno vissuto. Sogno, o forse incubo: nel 1998 il direttore della
Fondazione calcolava che per visionare l’intero materiale raccolto (allora meno di 40.000
interviste) sarebbero occorsi nove anni e mezzo di lavoro 24 ore su 24. Abituati alla scarsità di
fonti, gli storici non avrebbero forse mai pensato di entrare in crisi per un loro eccesso (che non è,
occorre notare, semplice ridondanza, giacché ogni vita narrata è diversa dalle altre e ugualmente
degna di essere “raccolta” e “tramandata”).
Nell’impresa voluta da Spielberg c’è qualcosa di sacrale, legato a una concezione profondamente
ebraica del tramandare la memoria. La Fondazione lancia inoltre una sfida ineludibile alla
storiografia, portando alle sue estreme conseguenze le possibilità documentarie offerte dalle
tecnologie più avanzate. A Vieviorka non sfugge la ricchezza delle memorie così raccolte, e la
qualità della comprensione storiografica che esse possono offrire: ne vede tuttavia anche gli aspetti
più pericolosi, legati al tentativo di “sostituire le testimonianze…alla Storia” (p. 128), di confondere
il ruolo del testimone con quello dello storico o, come talvolta accade, con quello dell’insegnante. Il
discorso del testimone, in sé perfettamente legittimo e indispensabile, è oggi spesso incastonato
all’interno di stereotipi socio-politici e mass-mediali che ne mutano il senso. Attraverso di esso, le
categorie politiche si volgono in categorie psicologiche, il linguaggio del cuore tiene il posto del
linguaggio della ragione.
Il testimone stipula un “patto di compassione” con colui che l’ascolta […] Il protocollo
di compassione dispone una messa in scena fondata sull’esibizione dell’individuo, della
sua specifica sofferenza, e pone l’accento sulla manifestazione delle emozioni e sulla
espressione corporea. Per quanto riguarda la ricezione, l’identificazione con le infelicità
e l’empatia con le sofferenze costituiscono la molla dello slancio di compassione (p.
153)
E’ un meccanismo comunicativo che con le dovute differenze può essere accostato a quello della
cosiddetta “televisione dell’intimità” – i programmi in cui persone comuni danno pubblica
espressione alle loro relazioni e ai loro affetti o dolori più privati, guidati da abili (e cinici)
conduttori, spiati da registi pronti a cogliere il primo tremito delle mani o la prima lacrima non
trattenuta, trasformate immediatamente in percentuali di ascolto. E’ in questa dimensione, osserva
Vieviorka, che il nazismo e la Shoah sono prevalentemente presenti nello spazio pubblico (Ibid.). E
questa prevalenza delle memorie individuali può risultare d’ostacolo alla formulazione di un
autentico racconto storico: in che modo, ella si chiede, possiamo “fare appello alla riflessione, al
pensiero, al rigore quando i sentimenti e le emozioni invadono la scena pubblica”?
La critica di Vieviorka è forse eccessiva e provocatoria, ma coglie punti importanti. Intanto,
mostra come la testimonianza non possa considerarsi in alcun modo una inattaccabile base della
oggettività storiografica, e vada semmai intesa come fonte da trattare criticamente e da collocare
all’interno di un racconto storico che è comunque costruito, fabbricato. In secondo luogo, pone il
problema del rapporto tra il sapere storico e il discorso o l’immaginario pubblico e, in particolare,
mediale. L’ “era del testimone”, come la chiama Vieviorka, è caratterizzata da un netto declino del
ruolo sociale dei saperi specialistici, incluso quello storiografico. La democratizzazione
comunicativa, mentre da un lato diffonde informazioni e conoscenze in modo diffuso e senza
precedenti, dall’altro ha l’effetto di indebolire l’autorità dei “saperi esperti”, in particolare quelli
scientifici. Alla logica argomentativa del sapere esperto si sostituisce nell’universo mediale la logica
dell’opinione e della spettacolarizzazione. Dalla medicina alla politica, sia pure in gradi diversi, il
discorso pubblico si presenta come un proliferare di voci che, per così dire, partono tutte
ugualmente da zero, senza rendite pregresse di posizione. Si può sostenere qualsiasi punto di vista:
il fatto stesso di parlare di fronte a un microfono o a una telecamera dà legittimità a ciò che viene
detto: ed è la drammaticità, il taglio retorico, la spettacolarità della presenza mediale a decidere da
che parte sta la ragione.
Si potrebbe sostenere che l’altra faccia dell’indebolimento autoriale di storiografica e scienze
umane è il negazionismo. Come mostra piuttosto bene l’analisi del discorso negazionista svolta da
Valentina Pisanty (nell’intervento in Storia, verità, giustizia e, più ampiamente, nel volume
L’irritante questione delle camere a gas, Milano, Bompiani, 1998), esso è interamente incentrato
sul tentativo di presentarsi come una plausibile opzione in un dibattito d’opinione. Le sue strategie
retoriche mirano, come scrive Pisanty, a
dare l’impressione, del tutto illusoria, che sia in corso un serio dibattito storiografico
tra la “storiografia ufficiale” (o “sterminazionista”) da un lato e la “storiografia
revisionista dall’altro” (p. 370).
I negazionisti tentano di portare il problema della verità storica sul piano della querelle polemica,
dello scontro personale, come in quei dibattiti politici in televisione (così diversi da quelli di soli
vent’anni fa) in cui i contendenti si urlano in faccia slogan accompagnati dagli applausi e dai fischi
di rumorosi sostenitori. Rivendicano una par condicio per le loro posizioni, un potenziale
cinquanta per cento di consensi da cui partire. La già notata insistenza sui dettagli fattuali e su una
retorica della verità-falsità è solo l’altra faccia di questo atteggiamento da polemisti mediali. Due
modi complementari di sfuggire alle norme del discorso storiografico e della comunità scientifica
che lo sostiene. Fa parte di questa strategia la tendenza ad autorappresentarsi come una minoranza
illuminata ma esclusa, perseguitata dal bieco e pavido consenso di una maggioranza di intellettuali
asserviti al Grande Complotto. E’ su questo piano (oltre che per gli elementi di anti-sionismo) che il
negazionismo ha attratto l’attenzione di certi settori della sinistra radicale: valga il discusso caso di
Noam Chomski, che ha scritto la prefazione a un libro di Faurisson in nome della libertà
d’espressione.
Si potrebbe anche osservare come, ben al di là del revisionismo storico, questo paradigma
comunicativo basato sull’indebolimento dei saperi esperti, su un peculiare populismo
antiintellettualista e sulla teoria del complotto assuma sempre più spesso preminenza sociale e
politica. Un caso clamoroso come quello del dottor di Bella, ad esempio, può esser compreso solo
sullo sfondo di un simile scenario. Lo stesso può forse dirsi di molte delle strategie politiche
dell’attuale destra italiana, e del suo leader in modo particolare. In perfetta buona fede, egli
riterebbe certamente giusto riscrivere la storia sulla base di un sondaggio d’opinione.
5. Verità e giustizia.
Vorrei infine accennare al problema del rapporto tra sapere storico e giustizia, centrale nel
volume curato da Flores. Anche qui, possiamo schematicamente contrapporre due punti di vista.
Da un lato, molti interventi nel volume citano il Marc Bloch di Apologia della storia, con la sua
netta divaricazione etica ed epistemologica tra il lavoro dello storico e quello del giudice. La
comprensione cui lo storico aspira è per Bloch incompatibile con l’esigenza di assolvere o
condannare. “Non si può condannare o assolvere senza prendere partito per una tavola di valori
che non deriva da nessuna scienza positiva”, scriveva nel 1943 (mentre, come cittadino, formulava
invece giudizi precisi e si impegnava nella Resistenza). E aggiungeva che “per intendere una
coscienza estranea, separata da noi dall’intervallo delle generazioni, occorre quasi spogliarsi del
nostro io; per dirle il fatto suo, basta restare se stessi. Lo sforzo è certamente meno gravoso” (cit.
nel saggio di Mariuccia Salvati, p. 143). In altre parole, la compensione storica implica una sorta di
atteggiamento antropologico, un apprezzamento dall’interno e quasi empatico della diversità dei
contesti socio-culturali, che contrasta con l’atteggiamento esteriore del giudice, il quale per
definizione non volge mai in dubbio le norme di riferimento e il contesto che dà loro significato.
Questo punto di vista è sostenuto con forza particolare da Karol Modzelewski, storico medioevista
polacco che è anche stato uno dei protagonisti del movimento di Solidarność. Egli mette in guardia
dal confondere il ruolo di storico con quello di attore della storia. Non si può confondere il pesce
con l’ittiologo, afferma, e non si può essere storici di eventi vissuti in prima persona: la
partecipazione personale, la memoria diretta degli eventi (sempre parziale e soggettiva) non solo
non aiutano la ricerca, ma la ostacolano. Al contrario, come per Bloch, Modzelewski ritiene che la
comprensione richieda un processo di identificazione antropologica col punto di vista degli altri:
occorre attraversare la diversità che da essi ci separa, e ciò richiede un certo grado di empatia e
perfino di simpatia (p. 135) E’ questo, si potrebbe osservare, che rende così difficile studiare la
violenza: o partiamo da una sua condanna dall’esterno, il che ci rende difficile comprenderla, o
cerchiamo di calarci antropologicamente nei panni degli assassini e del loro contesto culturale,
etico e psicologico, e allora la comprensione rischia troppo facilmente di trasformarsi in
giustificazione. Il dibattito degli anni ’90 aperto da Uomini comuni di Browning si è incentrato in
buona parte attorno a questo dilemma.
Per tornare a Modzelewski, il suo monito a non confondere comprensione storica e condanna
morale o giuridica non è un semplice richiamo a una distaccata oggettività dello storico, il quale
constaterebbe i fatti lasciando agli altri il giudizio. Ciò che egli teme è la strumentalizzazione del
lavoro storico all’interno di processi politici che rispondono a logiche diverse da quella di una
giustizia in qualche modo “pura” In particolare nelle epoche di “transizione”, come quella
attraversata in questi anni dall’Europa dell’Est, il giudizio sul passato è costantemente soggetto a
“trappole”, a “rischi di manipolazione”, legati in particolare alla “sindrome del capro espiatorio”:
si sente il bisogno di esteriorizzare e condannare il male perché non rimanga dentro,
perché appaia come un fattore esterno; e condannandolo, magari nella persona di
qualche responsabile individuale, di alcune pecore nere, riusciamo a liberarci del peso
della corresponsabilità (p. 135).
Modzelewski applica queste considerazioni al contesto politico della Polonia di oggi, dove vede un
chiaro tentativo di convolgere la conoscenza storica e il giudizio sul regime comunista in questioni
politiche interne e attuali: in particolare, nella delegittimazione e nella messa al bando di un
partito, l’Alleanza della Sinistra Democratica, che del comunismo viene considerato l’erede. Ma
molti altri esempi, anche italiani, si potrebbero trovare per questi rischi di uso strumentale e
decontestualizzato della conoscenza storica.
Abbiamo dunque un richiamo al distacco conoscitivo della storiografia e alla sua netta
separazione dal giudizio e dalla pratica etico-politica. A questa cautela si contrappone, d’altra parte,
la diffusa convinzione che la storia possa e debba servire la causa della giustizia, in particolare nel
caso dei grandi crimini di massa. L’imperativo del “never again”, “affinché non accada mai più”,
che domina oggi il discorso pubblico sulla Shoah, trova nella storia uno strumento indispensabile.
Occorre conoscere il cattivo passato, come si dice, perché non si ripeta.Anzi, è solo attraverso la
storia che si può arginare la tendenza a negare i crimini che, come abbiamo visto, è profondamente
connaturata ai crimini stessi. In questa prospettiva, proprio in virtù del suo sapere tecnico e della
“oggettività” del suo approccio, lo storico si trova collocato in una dimensione di chiaro impegno
etico e politico.
Si sostiene anche spesso che l’inevitabile coinvolgimento emotivo nello spettacolo dei crimini di
massa rende impossibile, per lo studioso, il freddo distacco della teoresi, implicando invece un
coinvolgimento emotivo che può ostacolare ma anche vivificare lo sforzo conoscitivo. Come si sono
espressi nel convegno senese gli studiosi uruguayani Marcelo Viñar e Maren Ulriksen Viñar, in un
intervento molto bello sulla violenza politica e sul terrore di Stato in Sudamerica,
in tale argomento, la distanza politica e quella epistemica hnno confini incerti. Per
quanto concerne tale materia di studio non c’è alcuno spazio per l’oggettività e la
neutralità, bensì solo per atteggiamenti di coinvolgimento emotivo [...] Abbandoniamo
dunque l'erronea convinzione per cui uno sguardo oggettivo è la sola verità possibile,
mentre è, a dire il vero, al servizio dello status quo (p. 204)
Il caso dei desaparecidos di cui parlano i Viñar presenta in effetti una particolare saldatura tra
l’istanza di giustizia e quella di conoscenza storiografica – entrambe impegnate principalmente ad
affermare la realtà di crimini che ufficialmente non esistono Stabilire la verità e fare giustizia nei
confronti delle vittime del terrore rappresentano un unico obiettivo. Le vittime della tortura o i
familiari dei desaparecidos, di cui sono state distrutte le soggettività e i legami sociali primari,
hanno bisogno per reinserirsi nella società non solo di veder riconosciuto quanto è accaduto, ma di
poterlo “re-inscrivere simbolicamente” (p. 215), collocarlo in narrazioni dotate di senso. E questo è
lavoro per gli storici – oltre che per gli psicoanalisti, quali i Viñar sono.
Essi sono d’altra parte consapevoli che nelle situazioni di transizione, come quella che
caratterizza attualmente molti Stati sudamericani, emerge una potente esigenza sociale di amnesia.
La comunità nazionale esce dal terrore spaccata in due: coloro che sono stato colpiti e danneggiati,
e coloro che hanno colpito o che almeno sono usciti incolumi. Evitare questa frattura, ricostituire
un tessuto sociale compatto, implica una “ingiunzione all’oblio”, un divieto di rievocare il dolore se
non in forme innocue e controllate (lo stesso meccanismo che ha attenuato la portata delle
epurazioni e della giustizia nell’Italia del dopoguerra, come mostra l’intervento di Mariuccia
Salvati). Si apre così un irrisolvibile dilemma tra sicurezza e giustizia: e di fronte a questo, scrivono
i Viñar, “le deboli democrazie hanno scelto di dare alla sicurezza la priorità sulla giustizia” (p.
218). Ma i traumi non sanati, non “elaborati” e “simbolizzati”, sono destinati a ripresentarsi. Vi è
dunque per questi studiosi una fondamentale responsabilità etica, cui lo storico non può sfuggire,
che consiste nel “costruire una narrazione dell’orrore”, nel contribuire a una memoria sociale che
includa l'esperienza delle vittime e non le isoli.
6. Verità, memoria sociale, uso pubblico della storia.
Abbiamo dunque da un lato il richiamo al distacco teoretico, dall’altro quello a un rapporto
partecipato tra storico e vittime dei crimini, un rapporto che nella versione dei Viñar ha qualcosa
del transfert psicoanalitico. Sono compatibili queste due prospettive? Il limite della prospettiva di
Medzelevski sta nel fatto che, per condannare palesi strumentalizzazioni, egli rischia di
delegittimare ogni uso pubblico della storia. Occorre invece ribadire che la storia può e deve essere
usata pubblicamente, e che gli storici non possono fare a meno di impegnarsi consapevolmente e
criticamente nel dibattito pubblico. E’ d’altra parte indubbio che storico e giudice sono guidati da
obiettivi diversi e da diverse regole epistemologiche. Come sottolinea Flores nelle conclusioni del
volume, è illusorio pensare di equiparare verità giudiziaria e verità storica, o pensare di porre
quest’ultima sul piano di una perizia tecnica a oggettivo supporto della prima. “La storia,
diversamente dalla giustizia, non ha vestali riconosciute che mettano un punto fermo (la verità
giurudica) alle vicende in discussione; la storia è necessariamente oggetto di una revisione
continua e il suo canone è certamente più ambiguo di quello della giustizia penale” (p. 380).
Lo stesso può forse dirsi del rapporto tra la storiografia e quella che potremmo chiamare memoria
sociale, vale a dire i processi di rievocazione, monumentalizzazione e attribuzione di significati
etico-politici a eventi del passato. La ricerca e il racconto storico sono necessariamente di supporto
ai discorsi pubblici che si sviluppano in tal senso (inclusi, ad esempio, i discorsi commemorativi
della Shoah, o quelli relativi alle guerre o alla Resistenza), ma non coincidono con essi. Nel
dibattito sui limiti etici alle possibilità di rappresentazione della Shoah, cui già ho fatto cenno,
questo punto è stato individuato con grande chiarezza da Hans Kellner (“«Never again» is now”,
History and Theory, 33 [2], 1994; poi in The Postmodern History Reader, a cura di K. Jenkins,
London, Routledge, 1997, pp. 397-412). Kellner vede una fondamentale tensione tra l’obiettivo del
discorso pubblico e celebrativo sulla storia, che ha natura essenzialmente conservativa, e il discorso
della storiografia professionale che è invece essenzialmente innovatore – revisionista, potremmo
dire se questo termine non fosse così negativamente caratterizzato nella discussione odierna.
Il discorso pubblico tende ad attribuire agli eventi del passato significati stabili, quasi sacrali, e a
tramandarli attraverso versioni che potremmo ben chiamare “mitiche” e attraverso pratiche rituali.
La fedeltà a certe interpretazioni del passato è qui il valore positivo, e i mutamenti interpretativi
sono visti come potenziali attacchi. La posta in gioco è la difesa di certi valori etico-politici, che
appaiono legittimati e rafforzati dal radicamento storico. La professione storiografica, al contrario,
per le sue caratteristiche sociologiche prima ancora che per il suo statuto epistemico, tende a
valorizzare l’innovazione conoscitiva, la critica ai resoconti e alle interpretazioni esistenti, la
moltiplicazione dei punti di vista. Il successo di un’opera o la carriera di uno studioso possono
dipendere dalla misura in cui quest’opera e questo studioso presentano nuove acquisizioni e si
distanziano dal panorama precedente degli studi. Mentre il discorso pubblico o la memoria sociale
tendono a costruire monumenti, il discorso storiografico tende a demolirli. Il primo è contripeto, il
secondo centrifugo. E’ per questo, afferma Kellner (op. cit., p. 411), che la moderna professione
storica non risponde bene a funzioni cerimoniali e monumentali, né a quelle di sostegno di stabili
interpretazioni del passato. Lasciata alla sua intima logica, la storiografia accademica e
professionale tende a “usurpare la storia”, nel senso che a questa espressione si attribuisce nel
discorso pubblico.
Questa tensione fra memoria sociale, professione storiografica, etica (e pratica) della giustizia mi
sembra un nodo fondamentale nel dibattito sull’uso pubblico della storia. Per quanto in tutti e tre
gli ambiti ci si appelli alla verità storica, questa nozione ha in ciascuno di essi un significato molto
diverso; ed è difficile dire che una di queste verità è più “vera”, più importante o gerarchicamente
superiore alle altre. La saldatura non è impossibile, a patto però che si mantenga una distanza
critica. Soprattutto, è illusorio pensare che la verità storica rappresenti un fondamento oggettivo, o
un presupposto (logico e cronologico) per il discorso pubblico sulla memoria dei crimini di massa.
Si potrebbe forse sostenere il contrario: e cioè che il sapere storico può svilupparsi solo dove e
quando si siano create le condizioni politiche per la condanna dei crimini e per l’articolazione di un
corrispondente discorso pubblico. Come scrive Ruti Teitel nel suo intervento al convegno senese,
E’ la verità a permettere cambiamenti politici liberali, o sono i cambiamenti politici a
permettere il ripristino di un governo democratico e il racconto della verità?E ancora,
come può esattamente la verità impedire una catastrofe futura? La preseunzione
teorica per cui è la verità in sé a essere liberatrice – e di conseguenza che la verità sia in
grado di condurre alla democrazia – è sembrata errata quasi ovunque sotto il profilo
della realtà pratica (p. 270).
L’intervento di Teitel, “Giustizia di transizione come narrativa liberale”, mostra meglio di ogni
altro saggio del volume l’intreccio strettissimo tra i processi penali, la narrazione storiografica e la
costruzione della memoria sociale. Questi livelli si influenzano a vicenda, e contribuiscono alla
costruzione di una rappresentazione condivisa del passato strutturata su precisi modelli retorici.
Analizzando i racconti (sia letterari sia “veritieri”) dei periodi di trasformazione politica che
seguono a un potere repressivo, ad esempio nell’America Latina e nell’Europa dell’Est, Teitel vi
scorge all’opera una medesima matanarrazione, incentrata sulla rivelazione di conoscenze segrete,
di informazioni precedentemente occultate, di appropriazione di una nuova verità. Questa
profonda struttura metanarrativa suggerisce che la transizione sia appunto guidata dalla verità, che
il cambiamento, come si è espresso Václav Havel, sia un passaggio dal “vivere nella menzogna al
vivere nella verità” (cit. a p. 271). Si sostiene, esplicitamente o implicitamente, che “se ci fosse stata
prima la conoscenza, le cose sarebbero andate ben diversamente. E, al contrario, ora che la verità è
stata pubblicamente resa nota, la realtà avrà un corso assai diverso” (Ibid.).
Teitel valuta questo modello narrativo in una prospettiva non descrittiva (come detto, il rapporto
tra verità e mutamento che esso pone è per molti versi illusorio) ma normativa. Ritenere che la
verità guidi la transizione è a suo parere il valore-guida del liberalismo politico: dunque i racconti
di transizione svolgono una fondamentale funzione pedagogica nel modellamento di una identità
liberale (p. 274). Si dovrebbe estendere questa analisi retorica all’attuale discorso pubblico sulla
Shoah e sui crimini del Novecento. L’argomento del “conoscere il cattivo passato perché non si
ripeta”, con i relativi viaggi guidati ad Auschwitz, interventi di testimoni nelle scuole, documentari
televisivi, o conferenze organizzate per la Giornata della Memoria, dovrebbe esser considerato in
questo quadro: cioè come una propedeutica o un’autocelebrazione dei valori di una società e di
un’epoca che si ritiene al di là dei crimini. C’è in tutto questo un fondamentale elemento di fiction.
Il discorso del “mai più” si presenta più o meno così: dobbiamo conoscere la verità storica e, sulla
base di questo oggettivo fondamento, condannare certi valori e sceglierne altri. Ma l’analisi storica
ci mostra un processo piuttosto diverso: vi sono mutamenti di scenari politici e di quadri di valori
al cui interno matura la possibilità (e forse l’inevitabilità) di certe narrazioni del passato, di un
certo senso della verità storica.
Qui il problema si fa piuttosto intricato. Si può dire delle narrazioni liberali di transizione, così
come di un certo discorso pubblico sulla memoria, che si fondano su una inaccurata descrizione dei
rapporti tra verità, trasformazioni politiche e giustizia. D’altra parte, queste forme di discorso (e le
pratiche sociali ad esse legate) hanno grande importanza civile ed educativa: promuovono valori e
ideali normativi centrali per una democrazia liberale. E’ per questo che, come abbiamo visto, gli
attacchi (“relativisti”, “decostruzionisti”) a nozioni troppo forti della verità storica sono visti come
attacchi agli stessi valori liberal-democratici. Ma è davvero necessario accettare questa equazione?
Non è possibile fondare una memoria civicamente impegnata su narrazioni più scettiche o
autoriflessive? In altre parole – è il dubbio con il quale chiudo – non potrebbe l’ironia
postmoderna rivelarsi uno scenario di giustizia storica migliore di quella aperto da una Verità che
dopotutto, sul piano pratico, non ha poi dato così grande prova di sé?
* Testimonianze, XLV (3), 2002, pp. 28-43
5. Antropologia della violenza nel XX secolo
Fabio Dei - Università di Roma “La Sapienza”
1. La “belva umana”
In questo intervento vorrei discutere il contributo dell'antropologia e delle scienze sociali alla
comprensione della violenza di massa nel ventesimo secolo: in particolare di quelle pratiche di
genocidio che lo hanno caratterizzato con tanta forza da farlo oggi apparire a molti come il “secolo
delle tenebre”[1]. Come lavora la comprensione antropologica in relazione a eventi storici? Credo si
tratti di mettere in evidenza i collegamenti tra manifestazioni della violenza di massa e schemi
culturali, caratteristiche di lunga durata delle società e delle soggettività che ne sono state
protagoniste. Occorre capire se e come la violenza possa essere intesa non come pura esplosione di
brutalità selvaggia, né semplicemente come mezzo volto a raggiungere un fine (la conquista del
potere o della ricchezza): capire se possano individuarsi al di sotto di essa delle logiche culturali
profonde, dei significati socialmente condivisi da parte sia dei carnefici che delle vittime.
Naturalmente, parlare di significati o di valori della violenza non deve essere equivocato: non si
tratta di giustificarli (comprendere non è perdonare), ma di intenderli come comportamenti umani,
contro la diffusa concezione di senso comune che riconduce la crudeltà o la violenza genocida a
inumanità, comportamento bestiale o patologico, follia, qualcosa che sta al di là della cultura e
della civiltà[2]. Come se la cultura e la civiltà, o l'educazione, o il progresso, fossero il contrario
della violenza, e bastassero da soli a contrastarla; come se i crimini del Novecento, dal genocidio
degli armeni, alla Shoah, alla ex-Jugoslavia, fossero nient'altro che momentanee ricadute nella
barbarie, legate a perversioni della modernità, o al riemergere di condizioni premoderne, come gli
odii tribali o etnici, i sentimenti primordiali di appartenenza e di contrapposizione - categorie,
come vorrei mostrare, assai equivoche e fuorvianti. Al contrario, le caratteristiche della violenza di
massa del Novecento sono legate strettamente a caratteristiche costitutive della modernità; forse,
addirittura, non sono pensabili al di fuori della modernità.
Neppure una contrapposta tesi “utilitarista”, che vede la guerra semplicemente come
“prolungamento della politica con altri mezzi”, secondo la celebre definizione di von Clausewitz, è
soddisfacente: è difficile comprendere la violenza di massa come pura conseguenza della
razionalità economica di un soggetto astratto e universale. Ma contro il senso comune dominante, è
forse più urgente sgombrare il campo dalla tesi della “belva umana”, dall'idea che le violenze di
massa si producono solo quando vengono meno i freni della civiltà, lasciando riemergere la brutale
natura selvaggia degli uomini. Una tesi hobbesiana, diciamo, secondo la quale lo stato di natura
degli esseri umani è violento, e la convivenza pacifica si produrrebbe solo con il contratto sociale,
con il quale gli uomini rinunciano alla violenza conferendone il monopolio allo Stato. Questa
prospettiva coglie, certo, un aspetto importante di quello che chiamiamo il processo di
civilizzazione; e tuttavia, la contrapposizione natura-cultura non è molto promettente come chiave
di lettura della violenza. I tentativi di spiegare la violenza storica, o anche certe sue manifestazioni
sociologiche (come la violenza giovanile), sulla base della naturale aggressività degli esseri umani
sono non tanto errati, quanto banali e poco significativi. La stessa ricerca neurobiologica ha
smentito questa idea di senso comune, criticando p.es. le applicazioni alla realtà umana delle teorie
etologiche alla Konrad Lorenz[3], secondo le quali la società e la cultura si preoccuperebbero di
fornire delle valvole di sfogo innocue per il deflusso di una naturale aggressività da predatore che
non trova sbocchi diretti. Queste teorie interpretano la violenza come un vuoto di cultura (i ragazzi
“con la testa vuota”), laddove occorre capirla come un prodotto della cultura, come “piena” di
significati[4]. Anzi, come vedremo, non riusciamo a capirla se non collegandola ai meccanismi di
produzione del potere.
2. Riti della violenza
Vorrei procedere nell’analisi del problema discutendo alcuni esempi storiografici. Il primo
riguarda un caso apparentemente minore e assai locale di violenza politica, che presenta tuttavia
grande interesse metodologico. Si tratta di un episodio di linciaggio avvento a Roma nel settembre
del 1944, pochi mesi dopo la liberazione, studiato in una recente e accuratissima monografia da
Gabriele Ranzato[5]. Donato Carretta, direttore delle carceri di Regina Coeli nel periodo
dell'occupazione tedesca, viene catturato e linciato da una folla inferocita nel corso del processo che
si sta celebrando contro Pietro Caruso, questore di Roma, zelante collaborazionista e tra i principali
responsabili dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Il linciaggio non è organizzato e preparato. Alcune
donne inveiscono contro Carretta, che riconoscono come responsabile dell'arresto e uccisione dei
propri figli; la folla comincia a inseguirlo, e si apre una specie di caccia del gatto con il topo.
Carretta viene picchiato, poi momentaneamente messo in salvo dalle forze dell'ordine, poi ancora
preso dalla folla, picchiato e gettato in Tevere per affogarlo. Incredibilmente ancora vivo, comincia
a nuotare verso la riva. A questo punto intervengono i bagnanti di uno stabilimento balneare sulle
rive del fiume, che lo inseguono in barca e lo colpiscono con i remi (da notare che questi sono
soggetti completamente estranei alla vicenda che stava maturando attorno al tribunale). Una volta
ucciso, la folla fa scempio del cadavere e lo trascina fino alle carceri di Regina Coeli, dove viene
appeso a testa in giù alle cancellate, secondo un classico rituale di degradazione.
Ora, nell’evento del linciaggio di Carretta sono almeno due gli aspetti la cui comprensione
sembra non potersi esaurire nello specifico contesto delle vicende romane del ’44. In primo luogo,
le modalità dell’esplosione della violenza, che sembrano sfidare ogni possibile teoria dell’agire
razionale - cioè, nessuna motivazione (possibile o reale) di ordine in senso lato politico è sufficiente
a giustificarla. In particolare, è sconcertante il modo in cui gruppi successivi di persone si
aggregano al linciaggio, senza neppure conoscerne la vittima - soprattutto i bagnanti. Come detto,
dopo che Carretta è gettato nel fiume e tenta di salvarsi a nuoto, viene colpito e fatto affogare con
incredibile crudeltà da persone in calzoncini da bagno che erano fino a un attimo prima
completamente estranee al contesto del processo Caruso, nel cui ambito il linciaggio prende avvio.
Il secondo aspetto del linciaggio che non appare intelligibile alla sola luce del contesto locale è la
sua “sintassi simbolica”. Un’azione iniziata in modo quasi casuale, sicuramente non preparata in
anticipo, condotta in modo confuso, interrotta più volte dall’intervento delle forze dell’ordine dunque, lontanissima da un piano preordinato - quest’azione finisce tuttavia per seguire precise
configurazioni simboliche, facilmente individuabili a un’analisi comparativa come quella compiuta
da Ranzato. Il tentativo di far schiacciare Carretta da un tram, il lancio nel fiume, lo scempio del
cadavere trascinato per le strade di Roma e appeso a testa in giù alle carceri di Regina Coeli «detronizzato» nel suo stesso regno, come scrive l’autore: tutti questi elementi non sono casuali, e
rispondono invece a una logica simbolica precisa, che troviamo espressa con impressionanti
analogie in documenti storici riguardanti i supplizi corporali nelle società di antico regime e le
pratiche regicide nelle rivolte popolari dell’Europa moderna. Tanto che Ranzato può parlare di una
qualità rituale dell’evento:
è difficile allora non interpretare le modalità del massacro di Carretta […]
fondamentalmente come un rito – che in quanto tale ha una notevole fissità nel tempo
– di rovesciamento del potere, di – letteralmente – capovolgimento e dissacrazione.
Rito politico che si sarebbe ripetuto, a una scala ben più ampia, a pochi mesi
dall’episodio del linciaggio di Carretta, con il cadavere di Mussolini a Piazzale
Loreto[6].
Il che è paradossale : poiché un rito è un evento assolutamente strutturato, organizzato secondo un
ordine rigoroso, l’esatto contrario dalla caotica baraonda che si verifica quel giorno del ’44 al
Palazzo di Giustizia di Roma. Eppure c’è l’inquietante emergere, quasi spontaneo, della sintassi
simbolica della detronizzazione, e vediamo i comportamenti incontrollati della “folla impazzita”
configurarsi secondo un ordine antico, come per un disegno superiore. Fatto tanto più sconcertante
in quanto, come osserva Ranzato, gli attori della vicenda difficilmente potevano possedere, per così
dire, quella specifica competenza simbolico-rituale : né in modo diretto (perché, come dice un
commentatore, è dai tempi di Cola di Rienzo che a Roma non succedeva nulla di simile) né
indirettamente (attraverso libri etc.).
Dunque, come spiegare l’emergere della violenza da un lato, e dall’altro il suo configurarsi
secondo un ordine simbolico e rituale, quasi indipendentemente dalla consapevolezza e dalla
volontà degli stessi attori ? Si deve dire intanto che Ranzato libera subito e opportunamente il
campo dalle teorie alla Gustave Le Bon sull’irrazionalità del comportamento delle folle, considerate
come un soggetto collettivo nel quale si cancellano le singole persone che ne fanno parte. Teorie
che, curiosamente, sono fatte proprie dalla stessa Commissione d’inchiesta sul linciaggio di
Carretta e dalla Corte giudicante nel corso del processo[7]. Le pagine del libro su questo tema sono
molto lucide : Ranzato non nega una peculiarità all’azione sociale della «folla esaltata» (mob), ma
si richiama a una tradizione storiografica che rifiuta l’irrazionalità come spiegazione di eventi
sociali, e soprattutto insiste nel non considerare la folla come un’unità indistinta e indifferenziata.
La sua analisi delle motivazioni dell’eccidio mette infatti a fuoco alcuni singoli individui - gli
imputati - considerati come rappresentativi di categorie o tipologie di partecipanti al linciaggio. Il
giovane idealista, il piccolo delinquente di quartiere, la madre di paese in cerca di vendetta, e così
via. Credo che si potrebbe andar oltre nel supporre il carattere altamente differenziato e quasi
“organizzato” della folla. L’antropologia, ed esempio, quando ha potuto studiare direttamente
eventi collettivi, nei quali la folla è protagonista, ha quasi sempre riscontrato non solo la presenza
nella folla di singole e molto diverse personalità, ognuna mossa da particolari motivazioni: ma
anche l’immediata attivazione di relazioni interpersonali che tendono a stabilire ruoli di leadership,
a imporre corsi d’azione, a contrattare ed accreditare valori e significati[8]. Ma naturalmente quasi
sempre ci mancano i dati per compiere simili analisi, cioè ci manca l’accesso alle immediate
pratiche discorsive degli attori sociali ; in storia, per definizione, ci manca l’osservazione
partecipante. Potrà sembrare una forzatura razionalistica, ma è assai probabile che la folla
“indistinta” e “impazzita” sia stata articolata in ruoli precisi e sia stata percorsa, nei brevi momenti
che hanno preceduto il linciaggio, da pratiche comunicative (non solo verbali) che hanno spinto a
un certo tipo di comportamento. E questo mi pare coerente con l’osservazione di Ranzato[9]
sull’origine colta e politicizzata della configurazione simbolica assunta dal linciaggio, e sulla
presenza di “mediatori” intellettuali in grado di trasmettere alla folla significati e modelli
comportamentali acquisiti dalla letteratura, dai media, dalla stessa conoscenza storiografica.
La critica alle spiegazioni basate sull’irrazionalità della folla, tuttavia, non risolve di per sé il
problema. Ranzato analizza minuziosamente le diverse motivazioni che muovono o possono
muovere gli individui coinvolti nella vicenda : da quelle politiche, a quelle di vendetta personale.
Ma conclude che esse, nel loro insieme, non sono sufficienti a spiegare il linciaggio di Carretta, nel
quale resta una dimensione oscura, di pura e gratuita violenza, di “malvagità popolare”[10], che
non è comprensibile in termini di moventi o motivazioni, che non sembra potersi adattare ad
alcuna teoria dell’agire razionale. Anche l’ipotesi che Carretta sia oggetto di meccanismi di
“spostamento”, “proiezione” o “condensazione”, per usare termini della psicoanalisi, cioè che si
indirizzi su di lui la violenza e il rancore che in realtà è rivolto verso il questore Caruso, verso i
massacratori tedeschi, o verso tutte le ingiustizie del mondo, non risolve il problema. Resta un
residuo di violenza apparentemente immotivata, fine a se stessa, praticata per il puro piacere della
violenza.
Come comprendere questo aspetto? Ranzato inquadra la vicenda Carretta nel contesto di un forte
aumento degli episodi di violenza nel corso della guerra. La guerra è naturalmente il “lievito” della
violenza, e la violenza degli episodi bellici trapassa naturalmente all’interno della stessa società
civile, fra l’altro per l’enorme disponibilità di armi e per l’indebolimento e la perdita di autorità
degli apparati repressivi, ma anche perché la guerra diffonde valori che svalutano l’importanza e la
dignità della vita umana[11], produce assuefazione alla sopraffazione fisica e così via. La situazione
di guerra può dunque esser letta come un contesto che cancella o sospende le condizioni attuali del
processo di civilizzazione. Il libro di Ranzato contiene ampi riferimenti alle tesi del sociologo
Norbert Elias, che ha studiato il modo in cui le istituzioni sociali hanno storicamente messo sotto
controllo i naturali impulsi aggressivi dell’uomo, il piacere della violenza e dell’aggressione fisica,
che divengono monopolio del potere centrale. Il processo che Elias chiama di civilizzazione consiste
appunto nella eliminazione dei comportamenti violenti dalle pratiche quotidiane ; ma questa
inibizione non cancella gli impulsi, che si esprimono o in forme per così dire sublimate (lo sport è
per Elias una di queste), o riemergono nella loro natura originaria in periodi di crisi, di turbamento
sociale, di rivoluzioni e guerre.
L’opera di Elias ricostruisce la storia dell’Occidente nei termini di un continuo processo di
spostamento della linea che demarca i comportamenti accettati da quelli non accettati, quelli
normali da quelli abnormi, e che in sostanza accentua progressivamente gli elementi di controllo
sui sentimenti, le emozioni, le scariche pulsionali e i contatti fisici diretti tra gli esseri umani.
Attraverso le diverse epoche storiche si sono formate barriere sia istituzionali che psicologiche
contro la manifestazione immediata dei sentimenti, contro i contatti fisici che non rientrino in sfere
ben determinate come quella della sessualità, dello sport o di microrituali sociali estremamente
controllati (il bacio, la stretta di mano, etc.) ; ed è cambiato molto l’atteggiamento nei confronti
della violenza. Elias confronta ad esempio le manifestazioni dell’aggressività nelle moderne società
occidentali con quelle che caratterizzavano il Medioevo, mostrando come nelle prime l’aggressività
risulti fortemente controllata e attenuata, persino in contesti come la guerra :
essa è stata condizionata, pur nel mezzo dell’azione bellica, dalla più avanzata
divisione delle funzioni, dal più accentuato legame tra i singoli individui, dalla
maggiore dipendenza degli uni dagli altri e di tutti dall’apparato tecnico; è stata limitata
e smussata da un’infinità di regole e divieti che sono diventati autocostrizioni (dunque
sono stati interiorizzati). Si è pertanto trasformata, raffinata e civilizzata come tutte le
altre forme di piacere; e soltanto nel sogno o in singole esplosioni, che registriamo
come fenomeni patologici, si riaffaccia in parte con la sua forza immediata e
scatenata[12].
Elias documenta ad esempio per il Medioevo il piacere di uccidere e torturare come
manifestazione di potere, e la presenza dei valori della violenza nel codice cavalleresco, che noi
associamo di solito a valori di altro tipo. Traccia quindi un profilo psicologico dell’uomo
medioevale come dominato da sentimenti contrastanti ma fortissimi, da esplosioni improvvise di
gioia e allegria, dalla facilità di infiammarsi in reazioni di odio e aggressività:
Gli impulsi, le emozioni si manifestavano in modo più libero, più scoperto e più
diretto di quanto sarebbe avvenuto in seguito. Siamo soltanto noi, divenuti più
moderati, più misurati e più calcolatori, noi che nella nostra economia pulsionale
abbiamo interiorizzato in misura assai maggiore come autocostrizioni i tabù sociali, a
considerare contraddittoria - ad esempio - la grande devozione religiosa e le
manifestazioni di aggressività e di assoluta crudeltà. Nella società medioevale, chi non
sapeva amare o odiare con tutte le sue forze era destinato all’emarginazione sociale :
così come, in società successive (p.es nella vita di corte delle grandi monarchie), vi sarà
destinato chi non sarà in grado di dominare le sue passioni e celare i suoi affetti,
dimostrandosi così “civile”[13].
Questi mutamenti sono legati per Elias all’affermarsi di un potere centrale (virtualmente assente
nel Medioevo) che assume il monopolio della violenza e della sopraffazione fisica, non consentendo
più ai singoli individui di esercitarla - salvo a poche persone delegate a tal scopo, come il boia, il
poliziotto, il soldato, o salvo situazioni controllate come i rituali e lo sport; ma anche nei rituali e
nello sport si assiste a un processo di progressiva civilizzazione o “sublimazione”, in cui la violenza
è simbolizzata più che realmente agita.
Tornando a Carretta; alla fine della seconda guerra mondiale ci troveremmo dunque in un contesto
disgregato, in cui i legami e i valori sociali sono indeboliti, e che lascia in parte riemergere una
violenza per così dire originaria, una sorta di naturale gioia di distruggere e di uccidere. Tesi
convincente, salvo per un aspetto: l’idea cioè che la tendenza alla violenza sia un aspetto naturale,
universale e astorico degli esseri umani. Come già detto, questo è un assunto naturalistico, poco
utile per comprendere i fenomeni storici. La “sospensione momentanea del processo di
civilizzazione” non dev’esser intesa come un vuoto che si sostituisce a un pieno, un negativo a un
positivo, la natura che prende il sopravvento sulla cultura: bensì come l’affermazione di un diverso
codice culturale (forse più arretrato, se ci piace considerarlo in una prospettiva “progressista” come
quella di Elias), tanto poco naturale quanto quello che inibisce la violenza. Da dove viene questo
codice ? Dalla guerra, indubbiamente. Ma c’è anche un altro aspetto: il regime fascista ha
fortemente promosso i valori della violenza, nonché una chiara sintassi o strutturazione simbolica
della violenza, che deve aver fatto presa con forza su una generazione.
Il fascismo ha legato alla pratica della sopraffazione fisica la sua immagine, oltre che la pratica
concreta del suo potere. In esso, la violenza è incoraggiata come valore e usata come strumento del
potere. Essa non si limita a riemergere dagli oscuri recessi dell’inconscio, ma è positivamente e
“culturalmente” sostenuta. Ogni violenza è in questo senso politica; e la cultura della violenza
permea paradossalmente la stessa pratica degli oppositori al fascismo[14]. E’ peraltro noto il
fenomeno per cui le vittime della violenza si appropriano facilmente del suo linguaggio, della sua
simbologia. Il che ci porta al secondo esempio che vorrei discutere.
3. Un continuum genocida
L’aspetto del lager che forse più di ogni altro sconvolge Primo Levi è il fatto che le vittime, gli
ebrei internati nei lager, si appropriano facilmente della cultura e dei comportamenti dei loro
aguzzini, giungendo a riprodurli nella vita del campo. I libri di Levi, più di ogni altro racconto o
riflessione sui lager nazisti o sui gulag sovietici, sembrano andar oltre la peculiarità spaziale e
temporale - quei determinati campi, in quel periodo storico etc. - e avviare invece una riflessione
generale sulla cultura moderna e sull'etica delle relazioni umane. Una delle sue idee è che il campo
rappresenti una sorta di gigantesco e terribile esperimento antropologico:
Si rinchiudano fra i fili spinati migliaia di individui diversi per età, condizione, origine,
lingua, cultura e costumi, e siano quivi sottoposti a un regime di vita costante,
controllabile, identico per tutti e inferiore a tutti i bisogni: è quanto di più rigoroso uno
sperimentatore avrebbe potuto istituire per stabilire che cosa sia essenziale e che cosa
acquisito nel comportamento dell'animale uomo di fronte alla lotta per la vita[15].
Levi aggiunge che da ciò non si possono trarre facili deduzioni sull'egoismo, la brutalità o la
stupidità degli esseri umani, laddove sia tolta loro ogni infrastruttura civile. Sottolinea invece
l'emergere di due categorie, che chiama i sommersi e i salvati – binomio che, com’è noto, dà il
titolo a una sua più recente riflessione saggistica sull’esperienza del lager. I salvati sono quelli
che in qualche modo sanno adattarsi alla legge del lager, che è una legge “apertamente iniqua”.
I primi sono i "mussulmani", gli "uomini in dissolvimento" - una specie di simulacro di essere
umano, in cui qualche filosofo ha voluto vedere una figura della soggettività contemporanea, il
prodotto estremo di una tendenza che caratterizza l'intera modernità[16]. Ma Levi è fortemente
colpito da chi si adatta, da tutti coloro che nel lager non si collocano né dalla parte degli
assassini né da quella delle vittime, occupando una zona intermedia, di chiaroscuro, che Levi
definisce appunto la zona grigia (con termine che sarà poi ampiamente ripreso dagli storici e
usato anche per contesti esterni al lager). Gli ebrei che hanno fatto parte della zona grigia, che
hanno accettato la legge del lager, partecipando ad esempio alla persecuzione dei propri stessi
compagni per ottenere piccoli vantaggi personali, pongono i problemi etici forse più grandi spalancano abissi di oscurità morale forse ancora più incomprensibile di quella delle stesse SS.
E' ingenuo, assurdo e storicamente falso ritenere che un sistema infero, qual era il
nazionalsocialismo, santifichi le sue vittime; al contrario, esso le degrada, le assimila a
sé, e ciò quanto più esse sono disponibili, bianche, prive di un’ossatura politica o
morale. Da molti segni, sembra che sia venuto il momento di esplorare lo spazio che
separa (non solo nei Lager nazisti!) le vittime dai persecutori […] Solo una retorica
schematica può sostenere che quello spazio sia vuoto: non lo è mai, è costellato di figure
turpi o patetiche (a volte posseggono le due qualità a un tempo), che è indispensabile
conoscere se vogliamo conoscere la specie umana, e se vogliamo saper difendere le
nostre anime quando una simile prova si dovesse nuovamente prospettare…[17]
Levi ritiene che questa struttura delle relazioni umane nei lager rispecchi la natura dei regimi
totalitari, “in cui tutto il potere viene investito dall'alto e un controllo dal basso è quasi
impossibile”[18]. Troviamo qui il nucleo di una teoria che collega direttamente i crimini del XX
secolo con l'esperienza politica dei totalitarismi. E' il rapporto tra potere e soggettività umana
proprio del totalitarismo, in contrapposizione al liberalismo, che crea le condizioni per il
genocidio e la violenza di massa.
Un secondo grande elemento di riflessione nell’opera di Levi riguarda i meccanismi di
disumanizzazione messi in atto all'interno del lager: cancellazione dell'identità personale
(capelli rasati, divise, numero al posto del nome, eliminazione di ogni rete di relazioni
personali), la serie di inutili violenze e sofferenze inflitte, le offese al pudore (la nudità, l'essere
obbligati a evacuare in pubblico), il lavoro usato come tortura, e una serie di piccole privazioni
quotidiane, assolutamente inutili e inflitte quasi per un gusto sadico (come il dover mangiare la
minestra senza un cucchiaio). Levi si interroga sui meccanismi di degradazione e sui loro effetti
sulle vittime, ma anche sulla soggettività degli esecutori della violenza. Come possono normali
esseri umani comportarsi in modo non solo violento, ma tanto crudele e spietato, con un
surplus di violenza inutile che non può esser spiegato dalle sia pur terribili finalità politiche
razziste e genocide del regime hitleriano? Le sue risposte sono due. La prima fa riferimento
all'educazione alla violenza tipica dei regimi totalitari e del nazismo in particolare. Le SS erano
state educate alla violenza, dice Levi:
La violenza scorreva nelle loro vene, era normale, ovvia. Trapelava dai loro visi, dai loro
gesti, dal loro linguaggio. Umiliare, far soffrire il “nemico”, era il loro ufficio di ogni
giorno: non ci ragionavano sopra, non avevano secondi fini: il fine era quello. Non
intendo dire che fossero fatti di una sostanza umana perversa, diversa dalla nostra (i
sadici, gli psicopatici c’erano anche fra loro, ma erano pochi): semplicemente erano
stati sottoposti per qualche anno ad una scuola in cui la morale corrente era stata
capovolta. In un regime totalitario, l’educazione, la propaganda e l’informazione non
incontrano ostacoli: hanno un potere illimitato, di cui chi è nato e vissuto in un regime
pluralistico difficilmente può costruirsi un’idea[19].
La seconda risposta, parzialmente in contrasto con la prima, fa riferimento a un’affermazione
del criminale nazista Franz Stangl, comandante di Treblinka, intervistato nel 1971 dalla
giornalista Gitta Sereny:
“Visto che li avreste uccisi tutti…che senso avevano le umiliazioni, le crudeltà?”, chiede
la scrittrice a Stangl, detenuto a vita nel carcere di Dusseldorf; e questi risponde: “Per
condizionare quelli che dovevano eseguire materialmente le operazioni. Per rendergli
possibile fare ciò che facevano”. In altre parole: prima di morire, la vittima dev’essere
degradata, affinché l’uccisore senta meno il peso della sua colpa[20]
Questa seconda risposta contrasta forse con la precedente, come detto, perché suppone che le
SS non avessero perduto completamente il senso della morale comune, e avvertissero anzi il
contrasto fra una coscienza umanitaria e le imposizioni dell'ideologia nazista. La violenza
eccessiva potrebbe esser letta allora come una risposta alla dissonanza cognitiva causata da
questo contrasto: cioè dalla necessità per i nazisti di agire al punto d'intersezione fra due
insiemi di valori contrastanti, quello imposto con forza dall'indottrinamento ideologico e quelli
di una morale elementarmente umana assai più profondamente radicata che non era stato
possibile estirpare del tutto nel breve periodo della rivoluzione antropologica propugnata dal
nazismo, dai suoi tentativi di creare un uomo nuovo[21].
Ma nelle riflessioni di Levi sulla distruzione sistematica dell'identità personale e dei requisiti
di umanità vi è un elemento ancora più inquietante: queste pratiche di esercizio del potere non
sono affatto esclusive del lager. Le ritroviamo invece largamente disseminate in istituzioni
caratterizzanti la modernità: p.es. nelle prigioni, nell'organizzazione del lavoro industriale,
nell'esercito, in tutte quelle che Goffman ha chiamato le istituzioni totali, e che Foucault ha
analizzato in libri come Storia della follia o Sorvegliare e punire. Si tratta di strategie
attraverso le quali il potere si esercita sui corpi, che nel lager trovano una forma estrema,
eccessiva e quasi terribilmente caricaturale, ma pur sempre strategie note[22]. Si pone allora il
problema della continuità o discontinuità della pratica della violenza nel lager rispetto alle
forme “normali” di esercizio del potere nella modernità. Proviamo ad elencare alcune delle cose
che più ci colpiscono del lager:
la classificazione del genere umano in specie cui viene riservato un trattamento
radicalmente diverso, titolari di diritti completamente diversi; e anche il fatto che queste
specie siano contrassegnate sul piano fisico, cioè da marcatori che appartengono all'ordine
del biologico;
il fatto che il potere si eserciti direttamente sui corpi attraverso la reclusione, una
disciplina rigorosissima e “razionale” del tempo e dello spazio, forme di privazione e
pratiche miranti a infliggere dolore e sofferenza, torture fisiche e morali;
il fatto che questo diverso trattamento possa portare alla eliminazione di un gran numero
di individui delle categorie più basse, anche attraverso forme seriali di uccisione, e che
questa eliminazione sia vista con una sostanziale indifferenza morale da molte persone
appartenenti alle categorie privilegiate.
Tutto ciò lo ritroviamo in altri aspetti della modernità, anche se in forme meno palesi.
Sicuramente lo ritroviamo nei rapporti che l'Occidente ha stabilito con i paesi coloniali.
L'imperialismo è stato una vera e propria palestra di formazione di quei valori e di quelle
pratiche che si sono poi manifestate nella Shoah - in termini di classificazione del genere
umano, di pratiche di espropriazione, violenza e sterminio, nonché di indifferenza morale.
Soprattutto la crudeltà e la “violenza inutile”, che tanto colpiscono nella Shoah, si esercitano
sistematicamente nella situazione coloniale. La conquista dell’America ne costituisce una
situazione paradigmatica. Prendiamo come esempio un racconto di Las Casas su un massacro
compiuto a Caonao (Cuba) dagli spagnoli:
Bisogna sapere che gli spagnoli, il giorno del loro arrivo, si fermarono al mattino per
far colazione nel letto prosciugato di un torrente, disseminato ancora, qua e là, da
alcune piccole pozze d'acqua e pieno di pietre da molare: ciò suggerì loro l'idea di
affilare le spade.
Giunti al villaggio indigeno, agli spagnoli viene in mente di verificare la nuova affilatura delle
spade:
All'improvviso uno spagnolo (nel quale si può pensare fosse entrato il demonio), trae
la spada dal fodero, e subito gli altri cento fanno altrettanto: e cominciano a sventrare,
a trafiggere e a massacrare pecore e agnelli, uomini e donne, vecchi e bambini che se ne
stavano seduti tranquillamente lì vicino, guardando pieni di meraviglia i cavalli e gli
spagnoli. In pochi istanti, non rimase vivo nessuno. Entrati allora nella grande casa
vicina...gli spagnoli si misero ad uccidere, colpendoli di taglio e di punta, tutti coloro
che vi si trovavano: il sangue colava dappertutto, come se fosse stata scannata una
mandria di vacche[23]
Il racconto, nella sua essenzialità, è agghiacciante. Ciò che colpisce di più in esso è la gratuità
dell'atto degli spagnoli. Non vi sono ragioni apparenti che muovono il loro comportamento, se non
che “il diavolo è entrato dentro di loro”, come si esprime Las Casas (e il diavolo, nel linguaggio di
Las Casas e dell'Europa cattolica del '500, ha lo stesso valore semantico che ha per noi il
riferimento a un substrato arcaico di piacere per la violenza, a un affioramento di oscure pulsioni
da sotto lo strato sottile della civilizzazione). La comunità dei massacratori e quella dei massacrati
sono estranee l'una all'altra: non si conoscono, ma neppure si odiano, non sono nemiche in senso
proprio. Ciò rende l'eccidio ancora più incomprensibile, opaco ad ogni possibile ragione umana.
Inoltre, terribile è la sproporzione tra l'enormità del delitto e la leggerezza con cui viene compiuto.
Commentando il racconto di Las Casas, Todorov introduce l’importante distinzione tra una logica
del sacrificio e una logica del massacro, e tra società in cui queste due logiche sono rispettivamente
prevalenti. A Caonao, dice Todorov, “tutto avviene come se gli spagnoli provassero un piacere
particolare nella crudeltà, nell'esercizio del potere sugli altri, nella dimostrazione di poter dare la
morte”[24]. Questa è una crudeltà molto diversa, ad esempio, da quella dei sacrifici umani degli
Aztechi (pure citati spesso come paradigma di crudeltà). Aztechi e spagnoli del XVI secolo sono per
Todorov rappresentativi di due contrapposti usi della crudeltà, che rimandano appunto alle
categorie di sacrificio e di massacro.
Le differenze sono così sintetizzabili: il sacrificio è un delitto religioso; l’identità del sacrificato è
rilevante, e contano le sue qualità personali; è un atto rivendicato, pubblico e
aperto;
si richiama alla tradizione; testimonia della forza dei
legami sociali; si compie sul posto, “a casa”. Il massacro è un delitto ateo; l'identità del sacrificato è
irrilevante, non si ha neppure la curiosità di sapere chi si sta uccidendo; è un atto che si tende a
tenere segreto, a occultare, a negare; non si richiama esplicitamente a valori tradizionali; rivela la
debolezza del tessuto sociale, il venir meno dei principi che ne garantiscono la coesione; si compie
in luoghi lontani. Dalla riflessione su queste caratteristiche, Todorov conclude che il massacro è
una forma di violenza tipicamente moderna e legata alla situazione coloniale. I conquistadores
spagnoli sembrano dunque aver inaugurato un tipo di violenza, che ritroveremo poi nei massacri
nazisti:
Lontani dal potere centrale, lontani dalla legislazione regia, tutti i divieti cadono: il
legame sociale, già indebolito, si sfalda e rivela non una natura primitiva (la belva
assopita in ciascuno di noi), ma un essere moderno, a cui appartiene l'avvenire, che non
ha alcuna morale e che uccide perché e quando gli piace. La “barbarie” degli spagnoli
non ha niente d'atavico o d'animale: è interamente umana e preannuncia l'avvento dei
tempi moderni[25].
Una simile logica del massacro, in forme e con accenti diversi, pervade la storia e
l’immaginazione coloniale – trovando forse nella figura conradiana di Kurtz la sua espressione
letteraria più forte[26].
Ma anche al di fuori del contesto coloniale troviamo nella modernità occidentale pratiche di
disciplina dei corpi e di esercizio del potere attraverso l'imposizione della sofferenza e della
morte - tanto più simili alle logiche del genocidio quanto più legate a contesti di povertà,
scarsità di risorse e forti differenze sociali. Questa idea è stata recentemente espressa in forma
in qualche modo estrema dall’antropologa statunitense Nancy Scheper-Hughes, che stabilisce
una sorta di continuum genocida tra violenze di massa e crimini di guerra, da un lato, e
dall'altro quelli che Basaglia chiamava crimini di pace, le piccole o grandi violenze nella
gestione quotidiana del potere:
…un continuum genocida fatto di una moltitudine di “piccole guerre e genocidi
invisibili” condotto negli spazi sociali normativi delle scuole pubbliche, sale d’ospedale
e di pronto soccorso, case di cura, aule di tribunale, prigioni, riformatori, obitori
pubblici. Tale continuum si riferisce alla capacità umana di ridurre gli altri a nonpersone, a mostri, o a cose che conferiscono una struttura, un significato e un senso alle
pratiche quotidiane di violenza. E’ esenziale che riconosciamo nella nostra specie (e in
noi stessi) una capacità genocida, e che esercitiamo una ipervigilanza difensiva, una
ipersensibilità verso tutti quegli atti di violenza quotidiana che sono meno drammatici e
persino consentiti, ma che rendono possibile (in certe circostanze) la partecipazione ad
atti genocidi, più facilmente di quanto ci piace pensare. Includo in ciò tutte le
espressioni di esclusione sociale, deumanizzazione, depersonalizzazione, pseudospeciazione e reificazione che normalizzano le atrocità e la violenza verso gli altri[27].
Questa idea di continuità mi pare discutibile per molti aspetti: potremmo sostenere che il punto
determinante consiste nel comprendere quel “in certe circostanze” cui Scheper-Hughes si
riferisce. Ma il problema sollevato è essenziale. Proviamo ad affrontarlo da una ulteriore
prospettiva.
4. La soggettività dei carnefici.
La controversia tra due storici americani, Cristopher R. Browning e Daniel J. Goldhagen, è stata
al centro degli studi sulla Shoah negli anni Novanta. I termini del dibattito sono abbastanza noti e
li riassumo qui in estrema sintesi. Nel 1992 Browning pubblica Ordinary Men, un libro che
ricostruisce accuratamente il punto di vista di un battaglione della polizia riservista tedesca che, fra
il ’41 e il ’42, fu lungamente impegnato in Polonia nelle operazioni prima di diretto sterminio degli
ebrei, attraverso rastrellamenti e fucilazioni di massa, e successivamente nella deportazione verso i
campi di sterminio, finendo per causare, direttamente o indirettamente, la morte di centinaia di
migliaia di esseri umani, fra cui donne, anziani, bambini e neonati[28]. Basandosi sugli atti di un
processo svolto negli anni ’60, Browning ricostruisce la personalità, le motivazioni e gli stati
d’animo dei componenti il Battaglione 101: tutti uomini ordinari, appunto, padri di famiglia, non
sadici mostri, non militari di professione, non particolarmente fanatici del nazismo e
dell’antisemitismo. Attraverso una brillante lettura delle fonti, l’autore segue le iniziali difficoltà dei
soldati nell’adattarsi al rapporto quotidiano con la fisicità della morte, con l’orrore dei corpi
seviziati e macellati; e poi le loro modalità di assuefazione a questo lavoro sporco, incluse le
giustificazioni e le razionalizzazioni prodotte ex-post.
Browning si chiede che cosa abbia spinto questi uomini normali ad eseguire ordini tanto terribili,
ad abituarsi al ruolo di assassini genocidi, perfino a trovare soddisfazione nel loro lavoro. La sua
risposta è complessa, e fa appello a una serie di elementi, alcuni di ordine storico e altri di tipo
socio-psicologico. Fra i primi, le convenzioni antisemite, la forza della disciplina militare e
l’influenza dello stato di guerra, con la paura e la rabbia per le sorti di una Germania accerchiata; e
ancora, la natura totalitaria della società nazista, che assolutizza i valori della subordinazione
all’autorità costituita. Fra gli elementi psicologici, Browning cita la tendenza alla conformità di
gruppo e soprattutto i meccanismi - in apparenza universalmente umani - dell’obbedienza
all’autorità, con ampi riferimenti ai celebri studi di Stanley Milgram e di altri psicologi sociali; fra
gli elementi sociologici, riprende e discute le note tesi di Hannah Arendt sulla
deresponsabilizzazione morale degli individui che sarebbe prodotta dalla società moderna. Tutti
elementi che attenuano, annullano o forse semplicemente cambiano quella “coscienza morale” che
ci si aspetterebbe di trovare negli esecutori del massacro in quanto esseri umani.
Soffermiamoci sui modelli esplicativi proposti da Browing, che rappresentano uno schema utile
per parlare dei rapporti tra storiografia e scienze sociali.
a) Abbrutimento e tendenza all'atrocità prodotta dalla situazione di guerra - in particolare di
una guerra razziale. La guerra razziale tende a polarizzare il mondi in noi e loro, e la parte
avversa tende facilmente a essere disumanizzata, a essere esclusa dalla comunità umana e
dalle sue leggi morali. Si dà inoltre il fenomeno dell'esaltazione da campo di battaglia, ben
nota ad esempio nel caso della guerra in Vietnam. Browning distingue però le brutalità e le
atrocità che emergono spontaneamente ma non sono una procedura operativa corrente, da
quelle che invece lo sono, che rappresentano cioè la piena espressione della volontà dei
vertici militari e del governo. Coloro che eseguono gli ordini non sono normalmente spinti
dall'esaltazione, dall'esasperazione e dalla frustrazione. Quale situazione di personalità o
mentalità li caratterizza, allora?
b) Aspetti burocratici e amministrativi dello sterminio. Le caratteristiche della modernità divisione del lavoro, ampio apparato burocratico etc., creano distanza fisica tra chi agisce e
chi subisce le conseguenze dell'azione. Il caso di Eichmann, nell’interpretazione che ne ha
suggerito Hannah Arendt[29], è paradigmatico. Nella modernità, il male può consistere
nello svolgere il proprio lavoro di sterminatore con la stessa modalità di routine e lo stesso
zelo con cui gli impiegati svolgono le proprie mansioni d'ufficio. Non importa se si tratta di
comprare e rivendere stoffe, di gestire scuole o di sterminare ebrei. Una implicazione forte
di questo concetto è stata sviluppata da Zygmunt Bauman in Modernità e olocausto[30]:
secondo questo studioso la Shoah e i genocidi del XX secolo non contraddicono la
modernità, non sono buchi neri in un processo di civilizzazione che va in direzione opposta:
ne sono anzi la conseguenza, il prodotto, in molti sensi. In un ovvio senso tecnologico (armi,
tecnologie di distruzione); in un senso amministrativo-burocratico (solo una forte
burocrazia è in grado di organizzare lo sterminio di massa, basandosi su tecniche di
anagrafe e censimento, sugli stessi strumenti, cioè, tramite i quali il moderno stato-nazione
assicura il proprio controllo sui cittadini); in senso politico, poiché le ideologie che
producono i genocidi, quelle totalitarie, germinano storicamente dal cuore stesso della
modernità - dall'Illuminismo, per Bauman, dalle aspirazioni utopiche a una società ideale,
totalmente controllata dalla ragione. “Gli orrori del XX secolo derivano dai tentativi pratici
di creare la felicità, l'ordine di cui la felicità aveva bisogno, e il potere totale necessario a
instaurare quell'ordine”[31].
c) La personalità autoritaria. Fra le SS e nel partito nazista confluiscono, per una sorta di
spontanea selezione, individui particolarmente inclini alla violenza? Le ricerche della scuola
di Francoforte sulla personalità autoritaria mettono in luce una serie di caratteristiche
psicologico-sociali che produrrebbero “individui potenzialmente fascisti”, favorendo cioè
l’adesione a modelli totalitari e comportamenti intolleranti e violenti. Ecco come Browning
li riassume:
sottomissione alle figure che incarnano l’autorità: aggressività nei confronti dei
gruppi esterni; ostilità verso l’introspezione, la riflessione e la creatività; inclinazione
alla superstizione e ai giudizi stereotipati; ossessione per il potere e la “durezza”;
distruttività e cinismo; proiettività (“disposizione a credere che eventi selvaggi e
pericolosi accadano nel mondo” e “proiezione all’esterno di impulsi emotivi e
inconsci”); preoccupazione esagerata per i contatti sessuali[32].
In sostanza, per i teorici della personalità autoritaria, i movimenti fascisti e le ideologie
totalitarie consentirebbero a simili individui di proiettare legittimamente i propri impulsi e la
propria aggressività all’esterno, contro gruppi sociali stigmatizzati e perseguitati con il
consenso della stessa autorità. Questa tesi non va interpretata nel senso di un determinismo
psicologico della violenza di massa. I suoi sostenitori mirano piuttosto a chiarire il grande
problema etico posto dalla violenza: com’è possibile mantenere un comportamento che ci
sembra contrastare con i più elementari criteri di moralità umana. Il punto debole della tesi è
una certa circolarità metodologica nello stabilire le caratteristiche della personalità autoritaria
(si noti che sono l’esatto opposto di ciò che un buon progressista, politicamente corretto,
democratico e sano di mente penserebbe di sé), nonché la sua tendenza ad assolvere e
immunizzare gli “uomini comuni” dalla possibilità di diventare assassini genocidi. I soldati di
Browning non erano certamente tutti delle personalità autoritarie: il problema che egli pone
resta dunque ancora aperto.
d) Tesi dell'obbedienza all’autorità: gli individui scivolano nei ruoli sociali che sono loro
assegnati. Browning sfata fra le altre cose il mito della coercizione o del terrore, che avrebbe
imposto ai soldati tedeschi i comportamenti più efferati per il timore di subire a propria
volta terribili punizioni. I soldati del battaglione da lui studiato non solo non sono
minacciati in caso di non obbedienza (o di esecuzione meno zelante) agli ordini più crudeli,
ma hanno persino la possibilità di tirarsi indietro e non lo fanno, con poche eccezioni (che
non subiscono, appunto, alcuna rappresaglia). Esperimenti di psicologia sociale, come
quelli di Zimbardo (Stanford) e di Milgram (Yale), mostrano in modo piuttosto
sconcertante in che misura il comportamento violento dipenda dall’obbedienza agli ordini
ricevuti e dal rispetto del ruolo sociale in cui siamo calati. E’ soprattutto Stanley
Milgram[33] a mostrare come l'obbedienza all'autorità possa facilmente indurre, senza
alcuna minaccia di punizione o coercizione diretta, a eseguire azioni che sarebbero
normalmente considerate ripugnanti, contrarie a elementari e usualmente condivise norme
morali. Chi sarebbe disposto a infliggere una pesante tortura fisica, sotto forma ad esempio
di elettroshock, ad altre persone verso le quali non si nutre alcun particolare odio o
risentimento, e senza che da questo comportamento vengano particolari premi o vantaggi?
Milgram mostra come ciò possa avvenire normalmente in una situazione sperimentale che
pone gli individui in condizioni di eteronomia, vale a dire di dipendenza da un’autorità
indiscussa che impone un comportamento sulla base di vaghi valori ideali (in questo caso, si
tratta di uno scienziato che chiede di infliggere scosse elettriche a un terzo soggetto, il quale
ne simula le conseguenze dolorose, presentando la situazione come finalizzata a un
esperimento di psicologia cognitiva).
Le conclusioni di Browning mostrano che, se la Shoah è radicata in un particolare contesto
storico e in una specifica temperie socio-culturale come quella della Germania degli anni ’30 e
’40, le condizioni della sua esecuzione rimandano a qualcosa, per così dire, di più ampiamente
umano - a caratteristiche più generali del rapporto tra potere e individui. I tedeschi dell’epoca
nazista rappresentano solo un caso particolarmente forte di interiorizzazione del principio di
autorità. .
L’approccio soggettivo di Browning viene ripreso, ma con un totale rovesciamento delle sue tesi,
nel libro di Goldhagen[34]. Questo autore, reinterpretando fra le altre le stesse fonti di Browning,
sostiene che non di uomini comuni si è trattato, bensì di tedeschi comuni - intendendo con ciò che
la Shoah può trovare una spiegazione storica solo nelle peculiari condizioni della cultura tedesca
degli anni ’30 e ’40, e in particolare in quello che egli chiama il modello culturale o cognitivo
dell’antisemitismo eliminazionista. Pressioni sociali, conformità di gruppo e così via sono elementi
tipici di ogni cultura e società e, da soli, non spiegano un evento unico e terribile come la Shoah:
solo il peculiare antisemitismo eliminazionista può esser considerato causa necessaria e sufficiente
dello sterminio.
La tesi di Goldhagen ha implicazioni antropologiche importanti. Egli sostiene che la cultura
tedesca degli anni '30 e '40 va affrontata nello stesso modo in cui un antropologo si accosta a una
cultura completamente altra - cioè, sulla base di assunti o modelli cognitivi radicalmente diversi dai
nostri, fondati, addirittura incardinati, sul presupposto della sub-umanità e della natura patologica
degli ebrei (una concezione che il nazismo non si è certo inventato ma che ha salde radici nella
storia tedesca). Dall'altro lato, pone il problema di quanto le credenze, i modelli cognitivi e i
priincipi etici possano essere culturalmente variabili, e in che misura bastano a spiegare il
comportamento. Comunque la si metta, la tesi “intellettualista” di Goldhagen, l'idea che le credenze
antisemite bastino a spiegare la Shoah, non regge, e l'analisi di Browning è molto più profonda ed
efficace - anche se purtroppo porta a conclusioni assai più pessimiste circa la ripetibilità di simili
eventi[35].
E’ tuttavia importante, per comprendere la genesi delle pratiche del genocidio e della violenza di
massa, l'accento che Goldhagen pone sulla costruzione di una visione del mondo che divide
l'umanità in identità incommensurabili e nemiche. In qualche modo, la riflessione sui genocidi
contemporanei, come il Ruanda e la ex-Jugoslavia, confermano la presenza di un simile aspetto
cognitivo, di modelli culturali profondi che portano a classificare gli altri come sporchi, impuri,
pericolosi, dannosi, come anomalie in un sistema di ordine e di sicurezza che vanno eliminate per il
bene di “tutti noi”, dei nostri figli etc. Quando i leader politici assumono questo punto di vista,
soffiano sul fuoco potenziando il senso di insicurezza e istigando all'odio verso gli altri, assunti
come capri espiatori per ogni nostro problema, allora nascono le condizioni del genocidio.
Per tornare all'antropologia culturale, questa disciplina si è messa profondamente in discussione
negli ultimi anni proprio su questo punto. Essa ha contribuito per tutto il Novecento alla
costituzione di un discorso sulle identità culturali, viste come un elemento di rivendicazione locale
contro le pretese del potere imperialista. Ma oggi il discorso delle culture e delle identità è
diventato pericoloso, rischia di funzionare da supporto alla ideologia xenofoba e alla pratica
violenta e genocida. L’antropologia cerca allora di combattere le concezioni essenzialiste e reificate
dell’identità, insieme al mito della violenza etnica come causa scatenante dei conflitti nel mondo
contemporaneo. E’ solo quando sono piegate consapevolmente a ideologie, al servizio di interessi o
privilegi particolari, che le identità culturali divengono strumenti della violenza[36]. Opporsi a un
simile uso strumentale, e al contempo mantenere l’attenzione al problema della differenza culturale
in un mondo globalizzato, sembra la principale sfida per l’antropologia del nuovo secolo.
6. Etnografie della violenza *
Fabio Dei
Il secolo che si è da poco concluso ha prodotto un corpus amplissimo di resoconti etnografici.
Certo, niente di simile a quella collezione ordinata di culture che l’antropologia positivista si
sarebbe aspettata: piuttosto, racconti eterogenei, talvolta forse bizzarri, di persone che hanno scelto
di andare professionalmente incontro alla diversità. E’ sorprendente la relativa assenza, in questa
grande raccolta di sapere sull’uomo, di riferimenti alla guerra e alla violenza: cioè a quella specifica,
se non esclusiva, tendenza degli esseri umani a farsi male a vicenda, a procurare agli altri grandi
sofferenze per un piccolo proprio vantaggio, talvolta persino a provar piacere del dolore inflitto.
Non intendo dire che il tema della violenza sia assente dal discorso antropologico classico; anzi, per
certi aspetti esso vi si innesta, dibattuto com’è tra immagini dell’Altro dionisiache e apollinee,
hobbesiane e rousseoviane, e ossessionato, da Frazer a Freud a Girard, dall’idea di una violenza
originaria profondamente inscritta nel cuore stesso della civiltà. La violenza è tuttavia raramente
presente nelle narrazioni etnografiche, nei resoconti della ricerca sul campo, nella
rappresentazione delle culture: o almeno, non è presente nella stessa misura di parentela, religione,
sistemi di scambio e altri soggetti classici della disciplina. Né, salvo rari casi, appare tematizzata sul
piano soggettivo e dialogico, come elemento rilevante dell’incontro etnografico.
I motivi di ciò possono essere molteplici. L’antropologo classico lavora all’interno di realtà
coloniali, “forzatamente” pacificate dal potere occidentale; per di più, tende (giustamente) a
ritagliarsi “bolle ambientali” sicure, micro-realtà locali prive di elementi rilevanti di conflittualità e
rischio. Ma, ciò che più conta, l’antropologo classico mira a descrivere culture ordinate e “normali”,
strutture sociali, sistemi condivisi di valori e di significati: e per questo non è interessato
all’esperienza della violenza, di per sé destrutturante, che produce disordine, distrugge la normalità
delle relazioni sociali ed etiche. Le etnografie si soffermano magari sui sistemi di regolazione e
controllo del conflitto, dalla faida di sangue dei Nuer alla divinazione degli Azande: ma non su
quell’esperienza – che pure si intuisce assai comune - della violenza assoluta e irrelata, che incrina
irrimediabilmente l’orizzonte di senso della quotidianità.
Questo scenario degli studi è radicalmente mutato negli ultimi anni. Intanto, l’esplosione di
guerre e conflitti locali ha posto gli antropologi, molto più di prima, all’interno di contesti “non
controllati” di violenza. Inoltre, la cosiddetta svolta riflessiva della disciplina li ha un po’ allontanati
dalla ricerca maniacale dell’ordine e li ha predisposti, invece, a una più piena restituzione
dell’esperienza soggettiva di coinvolgimento sul campo. Partiti per il mondo con progetti di ricerca
più o meno tradizionali, si sono trovati coinvolti in situazioni di guerra civile, di terrorismo, di
macroscopiche violazioni dei diritti umani, o più semplicemente di violenza diffusa e quotidiana; e
non hanno potuto fare a meno di confrontarsi con tali situazioni nella loro scrittura, di costruire
resoconti etnografici che le inglobassero. Talvolta sono stati “antropologi nativi” a scrivere dei
violenti contesti di provenienza (p.es. ex-Jugoslavia, India, America Latina), fondendo in testi
complessi e ricchi uno sguardo “interno” con una prospettiva disciplinare “esterna”.
Negli ultimi dieci anni, soprattutto in ambito anglosassone, la letteratura di questo tipo è stata
assai ampia. Non ho qui lo spazio per una sia pur minima rassegna bibliografica. Vorrei citare,
come riferimenti base per il lettore, alcuni volumi antologici dai titoli eloquenti come Fieldwork
Under Fire (Nordstrom, Robben 1995), Social Suffering (Kleinman, Das, Lock 1997), Violence
and Subjectivity (Das et al. 2000), Cultures Under Siege. Collective Violence and Trauma
(Robben, Suárez-Orozco 2000), Meanings of Violence (Aijmer, Abbink 2000), Remaking a World:
Violence, Social Suffering, and Recovery (Das, Ramphele, Reynolds 2001), Anthropology of
Violence and Conflict (Schmidt-Schröder 2001); e alcune monografie importanti, a partire dagli
ormai classici studi di M. Taussig (1987) sulla violenza coloniale in Colombia e di A. Feldman
(1991) sul terrorismo nord-irlandese, fino agli studi di J.S. Tambiah (1991) e di E.V. Daniel (1996)
sullo Sri-Lanka, di N. Scheper-Hughes (1992) sul Brasile, di S. Kakar (1996) sui conflitti tra indù e
musulmani in India.
Questa letteratura etnografica pone una serie di problemi rilevantissimi, che vanno al di là del
tema specifico della guerra e della violenza per investire, più complessivamente, le basi stesse della
disciplina: in particolare, essa mostra come l’irruzione della violenza modifichi in profondità non
solo il metodo e le tecniche, ma anche l’etica e l’epistemologia della ricerca sul campo.
Schematizzerò alcuni di questi problemi in cinque punti.
1. Come accennato, l’antropologia classica parte dal presupposto di dover “scoprire” e descrivere
un ordine culturale, l’ethos di un certo gruppo sociale, il senso che esso dà alla vita. Ora,
quest’ordine viene usualmente disintegrato nelle situazioni di violenza radicale e cronica. La
violenza produce caos, disgregazione dei legami sociali fondamentali e dei mondi culturali.
Questo punto è posto in rilievo dalla gran parte dei contributi citati. Quando “la paura diventa
un modo di vita”, come scrive L. Green per il Guatemala, o “la guerra disfà i mondi, sia reali che
concettuali”, come si esprime Carolyn Nordstrom per il Mozambico (in Nordstrom-Robben
1995, pp.105, 131), l’antropologo sembra perdere il suo oggetto di studio. La cultura, l’identità,
la tradizione si sbriciolano, per così dire, fra le mani del ricercatore. Se la violenza è vissuta
dalle sue vittime come caotica, irrelata, priva di significato, non diviene tale anche l’esperienza
etnografica? La stessa nozione di una “ragione” etnografica ne risulta messa in discussione.
Non è forse ambiguo cercare di scoprire i “significati” della violenza? Non equivale in qualche
modo a giustificarla? Come nota ancora Nordstrom, “cercare le ragioni della guerra si avvicina
pericolosamente al cercare di rendere la guerra ragionevole”; l’accento sulle ragioni, per questa
autrice, oscura “la realtà della guerra” (Ibid., p. 138). Ma anche ammettendo questo, come
possiamo rendere nella forma e nel linguaggio etnografico l’esperienza irriducibilmente
irrazionale della violenza? Non è forse la scrittura etnografica un medium di per sé ordinatore,
intollerante del caos e dell’assenza di significato? Dobbiamo allora pensare che l’antropologia è
condannata a fornire della violenza resoconti “ragionevoli”, che ne tradiscono la più profonda
natura esperienziale?
2. A questo problema se ne connette strettamente un secondo. Da Malinowski in poi, si è abituati
a pensare alla ricerca sul campo nei termini di una tensione fra partecipazione e distacco. Da un
lato vi è l’esigenza di far proprie le forme di vita locali, di cogliere il mondo “dal punto di vista
dei nativi”; dall’altro, l’esigenza di oggettivare queste forme, di guadagnare rispetto ad esse
quell’autonomia di percezione e di giudizio che sola può fondare un atteggiamento scientifico.
Ora, il delicato equilibrio fra questi due momenti sembra rompersi nell’incontro con la
violenza, il terrore, la sofferenza cronica. L’esperienza di partecipazione personale del
ricercatore è troppo intensa e non lascia margini, sul piano emotivo come su quello etico.
Nessuna finzione di “osservazione partecipante” è possibile. Basta ascoltare una qualsiasi delle
storie di crudeltà, sopraffazione e terrore che raccontano informatori da ogni angolo del
mondo. Ci troviamo immersi in scenari che ricordano al lettore occidentale i resoconti della
Shoah o della Cambogia di Pol Pot. Per inciso, è curioso osservare come noi tendiamo a
proiettare queste forme di comportamento “barbaro e disumano” nel passato, magari
commemorandole con forte partecipazione civile, ma trascurando l’evidente manifestarsi nel
nostro presente della stessa fenomenologia della violenza. Solo le vicende della ex-Jugoslavia,
con i lager e gli stupri etnici, hanno per un momento scosso la nostra coscienza. Ma questi
eventi sono largamente rappresentativi del mondo attuale. Le guerre regionali e civili in molte
parti del mondo povero gareggiano in barbarie con i più oscuri eventi del ventesimo secolo.
Tornando all’antropologo, la partecipazione emotiva e l’impegno etico non confliggono forse
con il necessario detachment scientifico? E, viceversa, la semplice applicazione delle tecniche
standard di ricerca non può risultare inappropriata, inopportuna, quasi offensiva quando
l’”oggetto” di studio è il terrore e la sofferenza di individui e popolazioni? Molti etnografi
manifestano il loro disagio nel condurre interviste, nello sviluppare domande, nel praticare
quella “critica delle fonti” che il metodo scientifico richiederebbe. Di fronte a storie
drammatiche, o alla manifestazione del dolore e della sofferenza, sembra di poter solo ascoltare
e tacere. Antonius Robben, lavorando con i parenti dei desaparecidos argentini, scrive ad
esempio di essersi sentito incapace di mantenere un atteggiamento critico e analitico nei
confronti dei suoi testimoni, di superare l’impatto emozionale dei loro discorsi. A proposito del
racconto di un padre sui vani tentativi di avere informazioni sulla figlia scomparsa, commenta:
avrei voluto porre molte domande, “ma la mia mente era vuota: potevo solo condividere in
silenzio il dolore di quest’uomo” (Ibid., p. 93).
3. Robben lavora sulla memoria della violenza, ma i problemi che pone non sono molto diversi da
quelli di chi opera in contesti di guerra attuale. Egli definisce questa difficoltà nel rapporto con
le fonti in termini di “seduzione”. Seduzione è l’atteggiamento del testimone, che vuol condurre
il ricercatore ad aderire al proprio discorso. Per quanto questa adesione sia talvolta moralmente
inevitabile, Robben ritiene che sul piano scientifico e critico occorra resisterle. Anche perché la
seduzione è operata, simmetricamente, sia dalle vittime che dagli esecutori della violenza. I
colonnelli e generali argentini che Robben intervista, accusati di crimini politici, non mancano
di argomenti e strategie per mostrare la ragionevolezza della propria posizione. Robben si
rende conto che la seduzione poggia su elementi molto sottili – dall’affabilità
dell’atteggiamento, alla condivisione di riferimenti culturali, a stratagemmi retorici di vario
tipo. Ma tutto ciò fa parte sia del discorso delle vittime che di quello dei carnefici, nessuno dei
quali è dunque di per sé più “vero” o “autentico” (senza parlare del fatto che non sempre è così
facile separare i due ruoli). Possiamo allora chiederci: l’etnografo deve cercare comunque
l’imparzialità, facendo coincidere il suo (eventuale) impegno etico con il mantenimento della
capacità critica di distanziamento? O è invece inevitabile schierarsi, privilegiando
un’assunzione etica rispetto al determinarsi di condizioni conoscitive?
Il problema dei “carnefici” ha anche una ulteriore dimensione. Se l’etnografo vuole
comprendere la violenza, non dovrebbe essere in grado di cogliere, dall’interno, il loro stesso
punto di vista? E’ lo stesso metodo antropologico che sembra richiederlo. Ma come si può
entrare in relazione empatica con gli assassini? E’ un problema analogo a quello sollevato dalla
recente letteratura sulla Shoah, ad esempio da un libro come Uomini comuni di C. Browning
(1992), che si interroga sulla soggettività e sull’universo culturale degli esecutori del genocidio.
Le SS di Auschwitz non sono forse la più chiara manifestazione del radicalmente altro, verso il
quale l’intelligenza antropologica di solito intende mettersi alla prova? E d’altra parte, torna qui
inesorabile il dubbio che comprendere equivalga in parte a perdonare, il disagio di aprire un
virtuale dialogo con chi sta dalla parte del male assoluto. Questo dilemma si mostra forse con la
massima drammaticità in un testo dell’antropologa americana K. Winkler (in Fieldwork under
Fire), che analizza con sconvolgente distacco e dettaglio l’esperienza di uno stupro da lei stessa
subito – non in un contesto esotico e “selvaggio”, ma nella propria stessa città. L’autrice vuole
cogliere il punto di vista dello stupratore; ricostruisce puntigliosamente i dialoghi e cerca di
capirne l’universo simbolico. C’è un processo penale in corso, e tutto ciò non è finalizzato alla
pura conoscenza, ma all’individuazione e punizione del colpevole. Il lettore non può non
sentirsi a disagio di fronte a questa apparente freddezza autoriflessiva, che lascia intravedere
abissi di sofferenza. Il tentativo, eroico e paradossale, di K. Winkler è mettere le proprie
competenze etnografiche al servizio di una giustizia che, come sempre in questi casi, è assai
difficile da ottenere e richiede la reiterazione dell’umiliazione e del dolore.
4. Le difficoltà di rappresentare etnograficamente la violenza rimandano al problema della
scrittura. Quale linguaggio, quale forma compositiva, quali scelte stilistiche e retoriche
consentono di veicolare il terrore, il nonsenso, il caos culturale? Sembra chiara
l’insoddisfazione degli etnografi della violenza per le forme classiche della monografia realista.
Nei testi citati si assiste alla ricerca di risorse compositive nuove. Si fa ampio ricorso ad estratti
da note e diari di campo – come se, curiosamente, la scrittura immediatamente prodotta sul
campo fosse più vera e autentica delle rielaborazioni successive (un ricorso all’autorevolezza del
being there, per dirla con Geertz). L’uso di fonti orali è invece abbastanza limitato: la parola è
lasciata raramente in modo diretto ai testimoni. Alcuni autori si servono ampiamente di
riferimenti letterari. Ad esempio T. Swedenburg, scrivendo del fieldwork condotto in Palestina
negli anni ’80, sceglie di assumere come filo conduttore della sua esposizione il riferimento al
libro di Jean Genet, Un captif amoreux, resoconto dell’esperienza di soggiorno dello scrittore
francese tra i fedain all’inizio degli anni ’70. La sua esperienza è sistematicamente filtrata
attraverso il testo di Genet, che detta l’agenda etnografica e diviene, per così dire, più reale del
“terreno” stesso.
Nonostante ciò, gli etnografi della violenza non sembrano inclinare verso la totale
dissoluzione del realismo etnografico propugnata dagli indirizzi postmoderni. Al contrario,
molti di loro vedono in questi ultimi una intollerabile minaccia etica. Indebolendo la nozione di
verità, sostenendo che le rappresentazioni storiche o etnografiche sono solo finzioni testuali, si
rischia di negare la realtà della violenza e di giustificarne gli esecutori. Come è stato scritto di
recente, “se pensiamo ai campi di sterminio, di stupro e di tortura, l’idea di trattare gli eventi –
e le loro rappresentazioni – come finzioni diviene immediatamente ripugnante” (SuárezOrozco, Robben 2000, p. 12 n.). Tra il rifiuto del realismo etnografico e la negazione
dell’olocausto e di altri genocidi, non vi sarebbe che un passo. La prospettiva postmoderna
(qualunque cosa ciò voglia dire) trasformerebbe i genocidi in semplici “storie” o “finzioni”: il
che è inaccettabile intellettualmente e moralmente, rappresentando una nuova offesa e violenza
alle vittime che hanno sopportato una ben reale sofferenza (Ibid.). Questo problema è
importante, e sembra dominare il nascente dibattito antropologico sul tema dei genocidi (v.
Hinton 2002a, 2002b). Tuttavia, un simile modo di porlo è a mio parere semplicistico e
profondamente sbagliato, poiché confonde i “fatti” con le loro “rappresentazioni”. Accusare il
postmodernismo di “manipolare la memoria” o di fornire strumenti al negazionismo è del tutto
arbitrario: al contrario, è l’assolutismo, che non ammette margine tra fatti e rappresentazioni,
a costituire la base di molte ideologie totalitarie che hanno prodotto i più terribili crimini del
secolo.
5. Di fronte a contesti di violenza radicale, tre aspetti del lavoro antropologico sembrano dunque
intrecciarsi inestricabilmente, e a tratti forse confliggere: il sapere, il rappresentare, il dovere
morale. Per molti, quest’ultimo è predominante e deve in qualche modo guidare gli altri due.
Fare ricerca e scrivere sulla violenza serve a denunciarla, a dar voce alle sue vittime.
“L’antropologo come uno scriba – afferma Linda Green – che documenta fedelmente le storie
narrate dalla gente, ciò che essi hanno visto, sentito, annusato, toccato, interpretato e pensato
[…] Monografie come «luoghi di resistenza», «atti di solidarietà», un modo di «scrivere contro
il terrore»” (in Nordstrom, Robben 1995, p. 108). Risuona in queste frasi il de Martino delle
Note Lucane: l’intellettuale come mediatore, capace di prestar voce di fronte alla storia a coloro
che non possono parlare. Ma le cose non sono così semplici. L’antropologo sbaglia, e si
sopravvaluta, quando si autoelegge al ruolo di intellettuale organico, di voce ufficiale dei vinti.
Dobbiamo chiederci quali rapporti vi siano tra l’approccio dell’antropologo e quello di altri
intellettuali, dei giornalisti, degli attivisti di associazioni in difesa dei diritti e così via. C’è una
peculiarità del lavoro antropologico e, ancor più specificamente, etnografico? A me pare che , se
tale specificità esiste, dobbiamo cercarla proprio nella capacità di tenere sempre legati e in
continua reciproca tensione questi tre aspetti della ricerca, della scrittura e dell’impegno etico.
* Primapersona, 8, 2002, pp. 20-24
7. Antropologia e genocidio
Fabio Dei
(intervento al convegno internazionale “Discipline, violenza, Stato-nazione” - Napoli, 22-23 maggio
2003; in corso di stampa su Parolechiave, numero monografico su “Occidentalismo”, 2004)
0. Premessa.
La parola-chiave di questo numero spinge a cercare di mettere a fuoco alcuni mutati scenari
del dibattito epistemologico nell’antropologia contemporanea. Chi si è formato in questa
disciplina fra gli anni Settanta e Ottanta, come me, è abituato a pensare ai problemi
epistemologici nei termini della contrapposizione tra una posizione ermeneutica o interpretativa
e una naturalista o oggettivista. Quest’ultima, prevalente nella stagione classica della disciplina,
si è nutrita dell’ideale di una conoscenza oggettiva, verificabile e cumulativa, emulando la
statuto delle scienze naturali nello sforzo di inseguirne il prestigio. A molti essa appare oggi
ancorata a un concetto ingenuo e irriflessivo di rappresentazione etnografica, a una forma di
realismo etnografico basato sulla raccolta di fatti indipendenti sia dalla teoria che dalla
soggettività dell’osservatore. Interpretazione di culture di Clifford Geertz[37], per quanto letto
in Italia con un certo ritardo, è stata la nostra Bibbia – con i suoi fascinosi richiami alla densità
dell’incontro etnografico e della rappresentazione culturale, inevitabilmente coinvolta nelle
opache profondità della scrittura. Molti di noi hanno anche dato per scontato che l’approccio
ermeneutico fosse, per così dire, “di sinistra” o “progressista”, sul piano filosofico come su quello
etico-politico, portatore cioè delle istanze più radicali di superamento dell’etnocentrismo e di
riconoscimento dell’altro: laddove il naturalismo tenderebbe ad assolutizzare acriticamente le
categorie dell’Occidente, e, almeno implicitamente, ad appoggiarne e giustificarne le pratiche di
dominio.
Nel dibattito recente, nell’ambito dell’antropologia come dei cultural e postcolonial studies,
queste posizioni tendono a rovesciarsi. Assistiamo infatti a un deciso attacco all’approccio
ermeneutico, non più condotto in nome di un oggettivismo naturalistico di vecchio stampo, ma
portato “da sinistra”, in nome di una riformulazione in apparenza ancora più radicale delle
implicazioni politiche dell’incontro etnografico. L’antropologia interpretativa sarebbe, in questo
quadro, nient’altro che l’ultimo e più raffinato strumento che il sapere-potere occidentale
impiega per controllare e neutralizzare il potenziale politico della diversità - in ultima analisi,
per dominare l’Altro. Questa linea di ripensamento critico dell’ermeneutica si intreccia in modi
interessanti con un altro importante filone degli studi contemporanei: lo sviluppo, assai
consistente negli ultimi anni, di ricerche antropologiche sul tema della violenza di massa. In
questo intervento, vorrei seguire l’intreccio tra questi due ambiti del dibattito, riconoscendone le
importanti acquisizioni e, tuttavia, sollevando dubbi su alcuni degli esiti cui esso sembra
condurre.
1. Interpretazione e ideologia.
Possiamo così sintetizzare i principi fondamentali di un approccio ermeneutico
all’antropologia:
a) la comprensione antropologica consiste nell’incontro tra sistemi di significato;
b) essa non produce un sapere sotto forma di generalizzazioni, leggi, spiegazioni causali
(anche se ciò non implica che alcune porzioni del sapere antropologico non possano
utilmente articolarsi in forma naturalistica, generalizzante, causale);
c) questo incontro mette in gioco le categorie “nostre” come le “loro”, che risultano entrambe
mutate dal processo di comprensione: dunque, si tratta di un processo di carattere
riflessivo;
d) tale processo coinvolge inevitabilmente la soggettività del ricercatore, rendendo impossibile
la finzione della distaccata oggettività;
e) la comprensione (l’incontro tra sistemi di significato) non è mai garantita da regole
metodologiche (da una epistemologia) e passa invece attraverso strategie pratiche;
f) in particolare, visto che la scrittura è il principale mezzo di costruzione e trasmissione del
sapere etnografico e antropologico, queste strategie pratiche hanno carattere retorico e
letterario.
Se nel dibattito internazionale è stato Geertz, con la formula della interpretive anthropology,
l’indiscusso profeta di questo approccio, per noi in Italia è stato naturale vederne le connessioni
con l’antinaturalismo della tradizione storicistica; in particolare, con l’eredità dell’opera di
Ernesto de Martino e con la sua teorizzazione dell’etnocentrismo critico. A partire dagli anni
Novanta, tuttavia, la punta di diamante di una antropologia antinaturalistica è stata la corrente
di studi sulla scrittura etnografica, che ha il suo manifesto nel volume collettaneo del 1986
Writing Culture.[38] Basato sull’idea delle rappresentazioni etnografiche come finzioni
retoricamente costruite, il libro sviluppa coerentemente la linea di riflessione aperta da Geertz
(nonostante la profonda antipatia che sia apre fra quest’ultimo e gli autori cosiddetti – assai
impropriamente - “postmoderni”), spingendo alle sue estreme conseguenze la riflessione sulla
natura pratica della comprensione antropologica.
Ma proprio da Writing Culture si sviluppa una divaricazione, a partire dal binomio contenuto
nel sottotitolo: “poetica e politica dell’etnografia”. Il volume tenta, sia pure con difficoltà, di
tenere insieme i due termini. Poetica e politica sono le due dimensioni tenute nascoste, non
problematizzate, dalla tradizione del realismo etnografico: le relazioni di potere al cui interno
l’incontro etnografico avviene, e le strategie retoriche tramite le quali il sapere antropologico
viene costruito. E’ attraverso lo stesso movimento critico che entrambi questi aspetti sono
disvelati nel tessuto della rappresentazione etnografica, smascherando la strategia realista che li
celava sotto una impossibile pretesa di oggettività.
Eppure, il dibattito successivo sembra considerare inconciliabili e anzi in contraddizione un
approccio che si concentri sulla costruzione letteraria dell’alterità, da un lato, e dall’altro uno
che tenti invece di mettere a fuoco i reali rapporti di potere. Questi ultimi, così sembra a molti,
richiedono di essere descritti con un linguaggio reale e oggettivo, che si sottragga
all’affermazione postmoderna della natura finzionale e letteraria di ogni rappresentazione. Anzi,
proprio questa insistenza sul fatto che ogni immagine etnografica è in ampia misura una nostra
costruzione, che non può essere semplicemente confermata o smentita da fatti indipendenti, è
vista come una copertura del ruolo reale del potere, e dunque una sua giustificazione.
Insistere sul rapporto tra sottili “ragnatele di significato” più che su quello tra le ben più dure
e consistenti realtà degli interessi economici e politici, sulla retorica più che sul potere, può
apparire l’ultima e più subdola forma di mistificazione: l’estremo avamposto di una
epistemologia che legittima e giustifica o perlomeno nasconde i rapporti di potere asimmetrici
sui quali l’incontro tra noi e altri si verifica (il dominio dell’Occidente, in definitiva). Da qui il
potente ritorno di un concetto come quello di ideologia, riletto in chiave di un raffinato postmarxismo ma pur sempre volto a condannare sistemi di pensiero come coperture, come spettri,
dei reali rapporti di potere[39]. Concetto, quello di ideologia, che resta invece indigesto per
l’ermeneutica, restia a descrivere la realtà nei termini di una netta dicotomia essenzeapparenze.
Ciò finisce per mettere in discussione un concetto centrale per l’antropologia, quello di
differenza culturale. Se per l’approccio ermeneutico la differenza culturale è una priorità
irriducibile, qualcosa che esiste prima e indipendentemente dal processo interpretativo, per i
suoi critici essa è invece sempre costruita, fabbricata in relazione a interessi specifici del potere.
Il tema della finzionalità della cultura – il grande tema di Writing Culture o di Interpretation
of Cultures – assume allora un senso assai diverso. In Geertz e ancora in Writing Culture le
finzioni sono i costrutti rappresentativi dell’etnografo, le sue mezze verità, e sono comunque
finzioni produttive, che senza poter attingere a una impossibile oggettività cercano comunque di
gettare ponti verso l’altro, di aprire un percorso di comprensione che non dispone di altri
sbocchi. Nell’antropologia postmoderna-ma-anti-ermeneutica, che possiamo per comodità
definire “antropologia critica”, la finzione culturale è una manifestazione fantasmatica del
potere, suo sostegno e copertura: e compito dell’antropologia è costruire una rappresentazione
oggettiva dei rapporti di potere che smascheri quelle finzioni.
2. Etnografie della violenza.
Vorrei adesso affrontare il problema partendo da una seconda angolatura, apparentemente
piuttosto distante: il recente sviluppo di un’ampia letteratura antropologica sul tema della
violenza di massa connotata in senso etnico e politico. Violenza, conflitto e guerra non sono stati
temi centrali per l’antropologia classica – così come, peraltro, per molte scienze sociali. Il che è
piuttosto sorprendente, se si pensa alla centralità che le pratiche di sterminio e genocidio hanno
avuto nella storia del Novecento, sia in Europa che nelle più lontane aree tradizionalmente
oggetto degli studi etnografici. In queste pratiche, per di più, l’antropologia è stata - sia pure in
modo forse indiretto e involontario – coinvolta. Mentre assumeva l’Altro come suo oggetto di
studio, questo era al contempo oggetto di politiche di dominio caratterizzate da un contenuto
estremo di violenza: ma l’antropologia solo raramente ha saputo o voluto tematizzare questo
inquietante aspetto del proprio statuto disciplinare[40]. Così come raramente ha indirizzato la
propria riflessione sulle esplosioni genocide nel cuore stesso dell’Occidente, malgrado il loro
stretto legame con ideologie che mestavano ambiguamente sul terreno - elettivamente
antropologico - della diversità razziale e culturale. L’antropologia classica sembra aver
considerato questi fenomeni, dallo sterminio dei popoli indigeni sotto il dominio imperialista
alla Shoah, come spiacevoli incidenti, o al massimo come inevitabili effetti collaterali del
processo di civilizzazione, ma in ogni caso non essenziali rispetto a una definizione “normale”
delle culture, della civilizzazione stessa e della comprensione interculturale. Secondo tale
approccio, descrivere e comprendere le culture significa mettere a fuoco una loro presunta
normalità, esente e non turbata da violenze esogene. Queste ultime non farebbero parte degli
interessi dell’etnografo il quale, quando non può fare a meno di imbattervisi, tende a escluderle
dalla propria rappresentazione in quanto fattori contaminanti.
Su entrambi questi aspetti si é invece sviluppata negli ultimi 10-15 anni una notevole
letteratura, di carattere sia etnografico sia teoretico. Intanto, molti antropologi hanno scelto di
porre la dimensione della violenza, o della memoria della violenza, al centro dei resoconti della
loro ricerca sul campo: ci hanno dunque presentato esplicitamente il loro lavoro come una
Fieldwork under fire, per citare il titolo di un volume collettaneo particolarmente
rappresentativo[41]. L’effetto di questa scelta è profondo: la violenza non appare
semplicemente come un particolare oggetto di studio, da porre accanto ad altri temi come la
parentela, la religione e così via. Anzi, la violenza è per certi versi l’antitesi di quelle forme
ordinate della cultura (parentela, religione, etc.) che tradizionalmente stanno al centro degli
interessi antropologici. L’effetto della violenza sulle società e sugli individui che colpisce è
proprio la rottura dell’ordine culturale, la dissoluzione delle sue forme – dei legami sociali
primari, delle basi minime di sicurezza e dignità, di quella fiducia basilare nella domesticità del
mondo che sola è in grado di fondare un universo culturale. Come rappresentare attraverso la
scrittura etnografica il caos, il terrore, il disfacimento dei mondi culturali che si attua quando “la
paura diventa un modo di vita”[42]? Come operare quella descrizione densa che ci raccomanda
l’antropologia interpretativa, quando ciò che va inscritto nel testo etnografico è il puro terrore?
Sembra che lo stesso tentativo di rendere la realtà della violenza attraverso una descrizione
ordinata e “razionale” contraddica la natura profonda dell’esperienza della violenza. Come è
stato scritto a proposito delle rappresentazioni della Shoah, “una volta ‘risolto’ nella narrazione,
l’evento violento sembra perdere la sua particolarità […] Una volta scritti, gli eventi assumono
quel manto di coerenza che la narrazione impone necessariamente su di loro, e il trauma della
loro inassimilabilità è alleviato”[43].
Inoltre, fare “fieldwork under fire” porta a posizionare in modo necessariamente diverso il
ricercatore rispetto alla realtà studiata e ai suoi attori sociali. Da un lato, sembra impossibile
mantenere quella finzione di distacco teoretico che caratterizza il classico approccio
dell’osservazione partecipante: come si può essere distaccati di fronte alla sofferenza, al dolore,
al sopruso, allo spettacolo della negazione dei più elementari diritti umani? Dall’altro, appare
altrettanto problematico stabilire un rapporto empatico, per motivi diversi, sia con le vittime che
con gli esecutori della violenza. Michael Taussig ha affrontato con grande efficacia questo
problema nel suo lavoro sulla Colombia, mostrando come le conseguenze della violenza (la
tortura subita dagli oppositori al regime, in questo caso), si prolunghi all’interno della relazione
etnografica, producendo una irriducibile ambiguità[44]; e Antonius Robben, nel quadro di una
ricerca sulla memoria dei desaparecidos argentini, ha parlato di una “seduzione etnografica” che
caratterizza i rapporti con gli informatori, siano essi i generali argentini, gli ex-guerriglieri o i
parenti delle vittime[45]. Nel complesso, porre la violenza al centro di un progetto di
rappresentazione etnografica e di comprensione interculturale è sembrata a molti studiosi una
scelta radicale, dirompente rispetto alle convenzioni metodologiche e retoriche finora
dominanti nella disciplina[46].
3. Genocidio e modernità.
Parallelamente, si è aperta nell’ultimo decennio una riflessione teorica sul ruolo della violenza
di massa nella storia contemporanea. Come detto, è sorprendente constatare nell’antropologia
classica l’assenza pressoché totale di contributi sulla Shoah, sui lager e i gulag, e su tutti gli altri
fenomeni che hanno caratterizzato il Novecento come “secolo delle tenebre”, occupando tanto
spazio nella cultura e nella coscienza contemporanea[47]. Come giustificare questa assenza? E’
difficile appellarsi semplicemente a una incompetenza disciplinare. La Shoah pone infatti in
gioco problemi antropologici fondamentali, quali l’universalità delle norme morali e dei diritti
umani, la natura del processo di civilizzazione e della modernità in senso weberiano, il rapporto
tra coscienza individuale e istituzioni sociali. C’è da chiedersi come sia stato possibile per la
nostra disciplina sfuggire così a lungo alla sfida di comprensione posta dai resoconti della vita
nei lager, che come sosteneva Primo Levi hanno rappresentato un gigantesco e drammatico
esperimento antropologico. Levi diceva “biologico e sociale”, ma intendeva palesemente
antropologico, cioè qualcosa che ha a che fare con la natura morale degli esseri umani e delle
loro istituzioni culturali:
Vorremo far considerare come il lager sia stato, anche e notevolmente, una gigantesca
esperienza biologica e sociale. Si rinchiudano tra i fili spinati migliaia di individui
diversi per età, condizione, origine, lingua, cultura e costumi, e siano quivi sottoposti a
un regime di vita costante, controllabile, identico per tutti e inferiore a tutti i bisogni: è
quanto di più rigoroso uno sperimentatore avrebbe potuto istituire per stabilire che
cosa sia essenziale e che cosa acquisito nel comportamento dell’animale uomo di fronte
alla lotta per la vita[48].
Ma soprattutto, per una disciplina che si occupa dell’Altro, è difficile non confrontarsi con le
due grandi figure dell’alterità contemporanea che il lager presenta; da un lato quella del nazista,
che sembra sfuggire ai criteri minimi di moralità attribuiti dal nostro senso comune al concetto
stesso di “essere umano”, e dall’altro quella del “musulmano”, del sommerso, della vittima che
si presenta ormai soltanto come un simulacro di umanità.
Anche a questo proposito, come detto, il dibattito è in forte movimento, forse anche come
conseguenza dell’impatto culturale di genocidi come quelli del Ruanda e della ex-Jugoslavia e
della esplosione dei conflitti etnici e religiosi alla fine del XX secolo. Due recenti volumi dedicati
specificamente all’antropologia del genocidio ne sono una testimonianza, insieme a numerosi
studi di forte apertura interdisciplinare, mirati al tema della memoria traumatica e della
elaborazione individuale e collettiva dei lutti prodotti dalla violenza di massa[49]. Se dovessi
indicare un punto comune a questa ormai ampia letteratura, direi che esso consiste nell’indicare
il genocidio e la violenza di massa, anche nelle loro manifestazioni che siamo soliti considerare
più crudeli e “barbare”, come un fenomeno eminentemente moderno. Molti antropologi si
collocano, esplicitamente o implicitamente, in una tradizione interpretativa che fa capo
soprattutto ad Hannah Arendt e che trova la sua espressione forse più radicale in Modernità e
Olocausto di Zygmunt Bauman[50].
Perché il genocidio non è pensabile se non come fenomeno moderno? Le risposte di Bauman e
altri sono che esso, per la sua realizzazione, ha bisogno di tecnologie avanzate in senso sia
strumentale che amministrativo: armi, sostanze chimiche, ferrovie, ma anche una burocrazia,
una organizzazione amministrativa e una divisione del lavoro di tipo moderno, cioè un alto
grado di razionalizzazione della società in senso weberiano. Inoltre, il genocidio moderno si
fonda sull’ideale illuministico della creazione di una società perfetta e di un uomo nuovo – un
fine rispetto al quale la valutazione morale dei mezzi passa in secondo piano. E ancora, i
comportamenti “disumani” di cui il genocidio ha bisogno presuppongono una strutturazione
della coscienza morale in compartimenti stagni, tale da consentire la deresponsabilizzazione
dell’individuo rispetto alle conseguenze del suo agire in conformità alle norme dettate dal
potere[51].
Gli antropologi insistono spesso su un punto ulteriore. Condizione del genocidio è la
costruzione politica e culturale dell’Altro, della differenza essenziale che separa gli altri da noi.
Se c’è un elemento comune nei genocidi del XX secolo, da quelli degli Herero e degli Armeni,
fino alla pulizia etnica nei Balcani, si tratta proprio del processo di assolutizzazione delle
differenze che ci separano dall’altro; queste differenze sono reificate, stigmatizzate e poste a
fondamento di un programma politico che promette una qualche forma di purificazione.
4. Violenza disciplinare
Questo punto ci porta al cuore dell’argomentazione che vorrei sviluppare. La costruzione delle
differenze non può esser vista semplicemente come manifestazione di un generico e universale
sentimento etnocentrico: rappresenta, piuttosto, una conseguenza (anche se una conseguenza
estrema e non necessaria: questo è un punto importante su cui tornare) delle politiche del
moderno Stato-Nazione e delle ideologie che lo accompagnano, come il razzismo (anch’esso, è
appena il caso di ricordarlo, non retaggio di un pensiero arcaico ma fenomeno del tutto
moderno, nato dall’incrocio tra nazionalismo e positivismo). Lo Stato tende a massimizzare e
assolutizzare l’omogeneità interna – quella di cittadini che condividono un territorio dai confini
ben precisi e una cultura, una lingua, una religione più o meno altrettanto precise – e tende a
reificare le differenze esterne. Ciò avviene, nell’epoca classica del nazionalismo, per mezzo di un
insieme di discipline che ruotano attorno all’identità e alla differenza, nel duplice senso del
termine “discipline”; saperi o ideologie sui fondamenti naturali di quelle differenze che si
comincia appunto a chiamare razziali, da un lato, e dall’altro pratiche sociali (amministrative,
classificatorie, pedagogiche) attraverso le quali il potere – foucaultianamente – si inscrive e si
interiorizza nei corpi. Queste discipline raggiungono la loro maggior visibilità e crudezza nel
contesto coloniale, ma fanno parte fin dall’inizio del progetto dello Stato moderno.
Arjun Appadurai ha mostrato in un famoso articolo di qualche anno fa[52] come si debba
partire da qui per comprendere lo scatenarsi apparentemente selvaggio o “bestiale” della
violenza e della crudeltà nei genocidi contemporanei. La violenza senza limiti esercitata sui
corpi, con le mutilazioni, le degradazioni simboliche, gli stupri etnici ha a che fare con le
discipline statali dell’identità e della differenza, e con il senso di purezza-impurità, di ordine e
disordine classificatorio che esse implicano. La violenza estrema sui corpi è l’altra faccia della
costruzione moderna della identità nazionale: è il tentativo radicale di inscrivere nell’ordine dei
corpi una differenza classificatoria che non si palesa immediatamente nell’ordine naturale e
biologico. Pensando soprattutto agli eccidi del Ruanda, dove la violenza genocida si scatena fra
gruppi etnici che sono in larga parte creati dall’immaginazione coloniale, e sempre meno
distinguibili in modo “naturale” nella realtà, Appadurai scrive:
La mutilazione e lo smembramento dei corpi etnici è uno sforzo disperato di restituire
validità ai demarcatori somatici dell’ “alterità”, a fronte delle incertezze create dalle
definizioni dei censimenti, dai cambiamenti demografici e da quelli linguistici, tutti
fenomeni che rendono le appartenenze etniche meno somatiche e corporee, più sociali
ed elettive… [E’ questo che] rende il corpo luogo di risoluzione dell’incertezza, per
mezzo di forme brutali di violazione, ricerca, decostruzione ed eliminazione[53].
L’analogia tra il massacro e il censimento anagrafico, o altre pratiche amministrative
apparentemente innocenti che incasellano gli esseri umani in un astratto ordine categoriale, è
forte e impressionante. Si tratterebbe di due facce diverse ma complementari delle stesse
pratiche di controllo dello Stato, che si esercitano entrambe fin all’interno del corpo e che sono
ugualmente ossessionate dalla distinzione tra “cittadini” e “non cittadini”. Per comprendere tale
analogia, come Appadurai scrive, dobbiamo partire dalla “intuizione che i sentimenti coinvolti
nella violenza etnica acquistano senso solo entro vasti conglomerati di ideologia,
immaginazione e disciplina”[54].
Temi come questi sono piuttosto diffusi nella riflessione antropologica contemporanea sulla
violenza. Il nesso tra essenzialismo culturale (o primordialismo) e violenza genocida, inoltre,
viene spesso esteso fino a una imputazione complessiva di complicità nei confronti dell’intera
disciplina antropologica e di suoi concetti basilari quali cultura, identità, differenza. Tra le
espressioni più estreme di questo punto di vista c’è un testo dei primi anni ’90 di Lila AbuLughod, significativamente intitolato “Writing against culture”. La cultura, afferma AbuLughod, è lo strumento essenziale per la costruzione degli altri. E’ un costrutto teorico che si
porta dietro tutta la violenza del dominio occidentale. Il discorso antropologico, che la assume
come proprio fondamento, è per questo un discorso che costruisce e sostiene la differenza e la
discriminazione fra gruppi umani che essa implica. In questo senso, non vi sarebbe differenza
sostanziale tra il concetto di cultura e quello di razza: si tratterebbe di idiomi diversi volti
entrambi a preservare e rafforzare l’ineguaglianza[55].
5. Un continuum genocida.
Eccoci dunque al punto di giunzione tra la critica alla tradizione ermeneutica delle scienze
umane, sopra rapidamente tratteggiata, e la riflessione sulla violenza disciplinare di cui
l’antropologia sarebbe portatrice - non mero riflesso ma parte costitutiva della violenza del
dominio, la quale sarebbe plasmata dalle medesime istanze classificatrici e identitarie. Non solo
il discorso antropologico sulle culture, dunque, è epistemologicamente equivoco: esso è anche
inaccettabile sul piano etico-politico, proprio in quanto attraverso le finzioni culturaliste
nasconde la cruda realtà del potere, facendosi concretamente complice della violenza
essenzialista. Quest’ultima, come si legge in una recente raccolta europea di saggi
sull’antropologia del conflitto e della violenza , nasce potenzialmente laddove si stabiliscono
confini e barriere; non dove li si infrange (come vorrebbe una più classica teoria “liberal” della
violenza), ma dove si delimitano spazi e attività - appunto, l’attività prediletta dello Statonazione:
la violenza è una forza che si manifesta non soltanto nella distruzione di confini, ma
anche nella loro creazione; la “violenza intransitiva” (che può operare concettualmente
prima di manifestarsi nell’azione) ha l’effetto di creare identità integrali, che divengono
a loro volta bersaglio di quel tipo di violenza che va in cerca di vittime. La violenza non
è una performance nel corso della quale una entità integrale (una persona, una
comunità, uno stato) viola l’integrità di un’altra; piuttosto, essa consiste nel processo
stesso che genera tali identità integrali per mezzo della inscrizione di confini…[56]
Questa affermazione sembra trascurare l’importanza decisiva del passaggio dalla violenza
intransitiva a quella transitiva o reale – che è un po’ la stessa differenza tra immaginare un
delitto e compierlo. Ma il problema posto è decisivo: c’è continuità o discontinuità fra le
pratiche normali e quotidiane tramite cui lo Stato-nazione controlla le menti e i corpi dei suoi
cittadini, e le pratiche straordinarie del genocidio e della violenza di massa? E’ un problema che
già Primo Levi poneva, notando come le modalità di esercizio del potere all’interno del lager, in
particolare le strategie di distruzione sistematica dell’identità dei detenuti e dei loro “requisiti di
umanità”, non sono affatto esclusive del lager. Le ritroviamo invece largamente disseminate in
istituzioni caratterizzanti la modernità occidentale: nelle prigioni, nell'organizzazione del lavoro
industriale, nell'esercito, negli ospedali, e soprattutto nell’amministrazione coloniale. In tutte
queste situazioni, abbiamo a che fare con una classificazione del genere umano in specie titolari
di diritti diversi e oggetto di diversi trattamenti; con una inscrizione diretta del potere sui corpi
attraverso la reclusione, una disciplina rigorosissima e “razionale” del tempo e dello spazio,
forme di privazione, torture fisiche e morali; e, ancora, con la possibilità che questo diverso
“trattamento” possa portare alla eliminazione di un gran numero di individui delle categorie più
basse, anche attraverso forme seriali di uccisione, e che questa eliminazione sia vista con una
sostanziale indifferenza morale da molte persone appartenenti alle categorie privilegiate.
La Shoah, lontano dal rappresentare una inspiegabile falla nella modernità occidentale,
scaturisce da alcuni suoi tratti costitutivi: come ha scritto Enzo Traverso, occorre vederne
“l’ancoraggio profondo nella storia dell’Occidente, dell’Europa del capitalismo industriale, del
colonialismo, dell’imperialismo, della rivoluzione scientifica e tecnica, l’Europa del darwinismo
sociale e dell’eugenismo, l’Europa del ‘lungo’ XIX secolo concluso nei campi di battaglia della
prima guerra mondiale”[57].
L’antropologa statunitense Nancy Scheper-Hughes, in un recente e assai incisivo contributo,
richiama la nozione basagliana di “crimini di pace”, sostenendo che solo una differenza di grado
separa questi ultimi dai “crimini di guerra”[58]. Essi sarebbero accomunati in una sorta di
“continuum genocida”, nel quale coesistono il lager e le istituzioni “normali” di controllo e
disciplina dei corpi e delle menti, le grandi e le piccole violenze, lo sterminio e le pratiche di
stigmatizzazione, esclusione, essenzializzazione dell’altro che caratterizzano la nostra vita
quotidiana:
…un continuum genocida fatto di una moltitudine di “piccole guerre e genocidi
invisibili” condotto negli spazi sociali normativi delle scuole pubbliche, sale d’ospedale
e di pronto soccorso, case di cura, aule di tribunale, prigioni, riformatori, obitori
pubblici. Tale continuum si riferisce alla capacità umana di ridurre gli altri a nonpersone, a mostri, o a cose che conferiscono una struttura, un significato e un senso alle
pratiche quotidiane di violenza. E’ essenziale che riconosciamo nella nostra specie (e in
noi stessi) una capacità genocida, e che esercitiamo una ipervigilanza difensiva, una
ipersensibilità verso tutti quegli atti di violenza quotidiana che sono meno drammatici e
persino consentiti, ma che rendono possibile (in certe circostanze) la partecipazione ad
atti genocidi, più facilmente di quanto ci piace pensare. Includo in ciò tutte le
espressioni di esclusione sociale, deumanizzazione, depersonalizzazione, pseudospeciazione e reificazione che normalizzano le atrocità e la violenza verso gli altri[59].
Questo passo esprime con grande efficacia il punto di vista della critical anthropology, anche
nella scelta di considerare un problema quasi secondario quello delle “certe circostanze” che
consentono di trascorrere dall’uno all’altro capo del continuum, di trasformare la potenzialità
genocida in atto concreto. Per una teoria liberale o hobbesiana della politica, il problema
consisterebbe proprio nel tenere sotto controllo queste circostanze. Per l’approccio critico, la
violenza non è invece che l’inveramento più trasparente del dominio all’interno della società
liberale e capitalistica. Compito dell’antropologia è smascherare le apparenze e svelare il vero
volto di tale dominio, mettendo al contempo in discussione il proprio stesso coinvolgimento con
esso, la violenza epistemologica sulle cui basi la disciplina è nata. Essa scopre così il carattere
costruito e interessato – dunque determinato sul piano economico-politico - di quelle differenze
che l’ermeneutica pretende di assumere come punto di partenza per il suo libero gioco di
interpretazioni. In questa prospettiva, la svolta riflessiva che insiste sul carattere finzionale e
retorico del sapere antropologico non può che apparire il primo gradino di una ben più radicale
consapevolezza politica; un gradino che, se resta isolato, non soltanto è insufficiente ma finisce
per rappresentare la più raffinata e subdola copertura ideologica alla violenza del potere.
6. Per una critica all’antropologia critica.
L’antropologia critica rappresenta un contributo importante, forse decisivo, alla comprensione
della violenza politica ed etnica nel mondo contemporaneo, e dei suoi rapporti con le istituzioni
e i saperi della modernità occidentale. Tuttavia, alcune delle sue conseguenze in termini di
epistemologia e teoria delle scienze umane mi sembrano ambigue e dense di difficoltà. Cercherò,
in conclusione di questo articolo, di farne risaltare alcune, partendo dalla convinzione che
l’analisi politica possa e debba esser ricompresa all’interno di un orizzonte ermeneutico di
comprensione degli altri, e non soppiantarlo in nome di una sia pur implicita epistemologia
realista.
a) In primo luogo, assai equivoca appare la liquidazione del concetto di differenza culturale e
dello stesso concetto antropologico di cultura, in quanto mere coperture ideologiche del dominio
dello Stato-nazione. Il riconoscimento della differenza culturale come costitutiva della agency
umana, assunto basilare dell’ermeneutica, non implica i processi di essenzializzazione e
naturalizzazione della differenza che, come abbiamo visto, possono esser correlati al razzismo e
al genocidio. Il rifiuto del concetto stesso di differenza nasconde anzi una nozione
universalistica di agente umano – un’idea illuminista e fortemente anti-antropologica di una
ragione assoluta, di un modello di agente come cittadino del mondo, dal quale l’analisi filosofica
dovrebbe semplicemente raschiar via le incrostazioni del pregiudizio religioso, culturale,
differenzialista, create da biechi dominatori per l’esercizio del loro potere. Considerare il
concetto di cultura come un sottoprodotto dell’ideologia nazionalista, un mascheramento dei
reali rapporti di potere dell’epoca borghese – secondo lo schema classico dell’Ideologia tedesca
– ci riporta a una prospettiva non post- ma pre-antropologica. A questo approccio dovremmo
contrapporre l’invito di Clifford Geertz a ricostruire e riformare oggi il linguaggio della politica e
dell’economia alla luce di una sensibilità per le differenze culturali – differenze che non sono
mai essenziali o naturali quanto non sono integralmente riducibili a residui arcaici o coperture
ideologiche[60].
b) L’approccio dell’antropologia critica sembra talvolta sviato da una concezione superficiale del
potere-sapere e del suo rapporto con la violenza – a sua volta, frutto forse di fraintendimenti
nella lettura di Foucault, soprattutto di Sorvegliare e punire. Si parla talvolta del potere come
di qualcosa di esterno e separabile dalle relazioni umane – qualcosa di cui si potrebbe fare a
meno in una società più giusta e non violenta. Ma, proprio in termini foucaultiani, la scoperta
che un sapere non è “innocent of power”[61] è una pura tautologia. Niente nella nostra vita è
innocente o avulso da contesti di potere: il problema è distinguere fra un potere migliore e uno
peggiore, ad esempio tra uno che è genocida e uno che non lo è. Abbiamo già visto come
Scheper-Hughes sottovaluti il problema delle “circostanze” che trasformano la “potenzialità
genocida” che sta dentro ciascuno di noi, e dentro la nostra società, in genocidio effettivamente
agito. Allo stesso modo, Appadurai afferma che i movimenti culturalisti e primordialisti non
portano sempre alla violenza: semmai vi sono “inclini”, e solo in certe condizioni la violenza si
manifesta[62]. Ma il problema cruciale diviene allora: quali sono queste condizioni? Cosa
risveglia le potenzialità sopite? La più classica risposta a questa domanda fa appello alla
distinzione fra democrazie (social)-liberali e totalitarismi[63]. L’antropologia critica ha buone
ragioni per rifiutare una dicotomia troppo netta di questo tipo, soprattutto alla luce della storia
del colonialismo: tuttavia,
minimizzando le differenze in funzione anti-liberale, rischia di privarsi di strumenti di
discriminazione etica e politica e di cadere in una indistinta e quasi caricaturale denuncia del
“moderno stato occidentale” – quello che potremmo a buona ragione chiamare uno stereotipo
occidentalista. Non sarà allora inutile ricordare le critiche che già alla fine degli anni ’60
Hannah Arendt rivolgeva alle tesi secondo cui “la violenza non è altro che la più flagrante
manifestazione del potere”, anzi, la sua più profonda essenza; tesi strettamente connesse all’idea
che “l’insieme della politica e delle sue leggi e istituzioni siano pure e semplici sovrastrutture
coercitive, manifestazioni secondarie di altre forze sottostanti[64]. Per Arendt, non solo potere e
violenza non sono la stessa cosa, ma si trovano in una relazione per certi versi oppositiva: La
violenza passa in primo piano come strumento di dominio quando il potere si indebolisce o è
assente (una situazione che si manifesta pienamente, ad esempio, nel caso di invasione o
occupazione straniera): “Il potere e la violenza sono opposti: dove l’una governa in modo
assoluto, l’altro è assente. La violenza compare dove il potere è scosso, ma lasciata a se stessa
finisce per far scomparire il potere”[65].
c) Si imputa all’approccio ermeneutico una colpa di dissoluzione della realtà e della verità,
incompatibile con le istanze di testimonianza e di denuncia che il tema della violenza e del
genocidio implicano. Sostenere la natura finzionale di ogni rappresentazione o racconto storico
sembra legittimare le strategie revisioniste e negazioniste, facendo il gioco dei criminali stessi, i
quali mirano sempre all’indebolimento della verità. E’ stato mostrato in modo assai convincente
come il negazionismo sia parte integrante dei genocidi del Novecento: e per contrastarlo,
sembra che non possiamo fare a meno di una certa dose di oggettività o realismo
epistemologico. E’ in particolare il cosiddetto postmodernismo ad essere accusato di complicità
revisionista. Esso è giudicato “eticamente inammissibile” in relazione alla conoscenza e alla
memoria storica della Shoah, in quanto sostenitore di un “relativismo in cui tutte le voci e le
interpretazioni divengono ugualmente valide”, con lo spostamento dal testimone al lettore del
“fardello della creazione del significato”[66]. Di più, come scrivono i curatori di una raccolta di
testi sul rapporto tra violenza e cultura,
se pensiamo ai campi di sterminio, di stupro e di tortura, l’idea di trattare gli eventi – e
le loro rappresentazioni – come finzioni diviene immediatamente ripugnante […] Chi
sostiene un’idea dell’etnografia come puro racconto pone l’autorità degli studiosi (sia
pure involontariamente) al servizio dei sinistri tentativi di negare l’Olocausto, la
“guerra sporca” latino-americana, e altri recenti episodi di distruzione organizzata.
Attraverso la lente postmoderna, essi divengono semplicemente “racconti” o “finzioni”,
il che è repellente in termini sia intellettuali che morali. In termini intellettuali, si fa
così violenza a un periodo storico che ha coltivato l’odio organizzato in dimensioni
nuove e senza precedenti. In termini morali, si fa violenza (sebbene in un diverso
idioma) alle indicibili sofferenze di milioni e milioni di persone[67].
Ma possiamo accettare questa sorta di ricatto etico a favore di una cattiva epistemologia? Il
nesso tra ermeneutica (o relativismo, o postmodernismo, benché questi concetti non siano
affatto sinonimi) e negazionismo mi sembra assolutamente improponibile. Sostenere il carattere
costruito di ogni racconto storico o rappresentazione etnografica non significa affatto porre sullo
stesso piano la verità delle vittime e quella dei carnefici, o considerarle come due finzioni
ugualmente parziali e infondate; è da notare che un radicale oggettivismo fattuale è proprio la
strategia usata dalle argomentazioni negazioniste, che sostituiscono il racconto storico con
minuziose procedure fisicaliste, sequenze di perizie tecniche da tribunale, prove portate a
discredito dei testimoni, e così via. Un’adesione così stretta ai “fatti” che ci fa perdere il senso del
nostro rapporto con la storia. Inoltre, l’argomento della incompatibilità etica fraintende
completamente la natura di un approccio interpretativo alla conoscenza storica o etnografica,
appiattendolo sul modello di un relativismo in cui “tutto va bene”. Al contrario, lo scetticismo
nei confronti di verità oggettive assolute spinge nella direzione di una maggiore apertura e di
una più rigorosa attenzione critica verso i dati empirici. Non è dunque così facile attribuire
attestati di rispetto per la verità storica e per la sofferenza delle vittime.
d) Quale ruolo politico gioca l’antropologia culturale? Il fatto che essa nasca – almeno in una
delle sue componenti – come una delle discipline della differenza del moderno Stato-Nazione, e
che la sua epistemologia continui a portarsi dietro questo imprinting, non vuol dire affatto che
storicamente essa abbia sempre mantenuto il ruolo di mosca cocchiera del nazionalismo e
dell’imperialismo. L’accusa rivolta oggi all’antropologia da parte di molti post-colonial studies
è che, in virtù delle sue origini e della sua complicità nello sviluppo del discorso della differenza,
essa non può che rappresentare un discorso del potere, un’arma volta alla incorporazione
3
dell’Altro a fini di dominio: ancora una volta, un’arma tanto più subdola quanto più raffinata
alla scuola dell’ermeneutica. Curioso ritorno alle tesi evoluzioniste, per cui il significato di un
fenomeno risiede nella sua origine. Ma storicamente, l’antropologia culturale non ha
rappresentato solo complicità e incorporazione: ha significato anche resistenza e
riconoscimento. E’ stata l’antropologia a fare della lotta all’etnocentrismo un programma
insieme etico e scientifico; in contesti storici che tendevano ad elevare muri, è stata
l’antropologia che si è sforzata di gettare ponti; in contesti che perseguivano il dominio puro,
l’antropologia si è posta l’obiettivo della comprensione. E rileggere oggi, a posteriori, le sue
aperture come sottili e subdole strategie di incorporazione dell’Altro appare ingeneroso oltre che
non corretto in una prospettiva di storia delle idee. Del resto, su questo piano si applica
l’argomento del tu quoque. Se ogni disciplina è così strettamente determinata dalla struttura di
potere nel cui quadro nasce, cosa dire allora dell’antropologia critica o dei postcolonial studies di
oggi[68]?
In conclusione, sottolineare gli elementi che accomunano l’epistemologia delle scienze sociali e
la violenza tipicamente moderna del genocidio è un’operazione assai utile, e anzi necessaria, sul
piano della consapevolezza riflessiva della disciplina, ma non porta necessariamente a
imputazioni di complicità e connivenza. Quale ideologia è più vicina alle logiche dello sterminio:
quella che insiste sulle differenze e sulle culture, herderiana, se vogliamo, o quella – hegeliana –
che insiste sulla unicità della ragione, sulla convinzione di poter parlare il linguaggio stesso della
realtà? Si riapre il tema tante volte posto sull’origine della Shoah e del fascismo: sono prodotti di
una eredità illuministica o romantica? La domanda è forse oziosa. Il punto essenziale è capire
come si verificano le condizioni del passaggio dal primordialismo culturalista, per dirla con
Appadurai, allo sterminio; perché il continuum genocida di cui parla Scheper-Hughes trascorra
dai suoi gradi più bassi a quelli più alti; perché il potenziale genocida, il dormiente nascosto nel
nostro self moderno e nelle nostre moderne istituzioni, si realizzi, da potenza si faccia atto. E per
rispondere a queste domande c’è bisogno di una filosofia politica un po’ più complessa rispetto
al generico discorso sul “potere” e al modello caricaturale di Stato-nazione su cui si fonda certa
critical anthropology.
[1] La definizione è di T. Todorov, “Il secolo delle tenebre”, in M. Flores (a cura di), Storia, verità, giustizia. I crimini del
XX secolo, Milano, Bruno Mondadori, 2001, pp. 1-8.
[2] J. Abbink, “Preface: Violation and violence as cultural phemomena”, in G. Ajimer, J. Abbink (eds.), Meanings of
Violence. A Cross-Cultural Perspective, Oxford, Berg, 2000, p. xiii.
[3] V. su questo P. Karli, L’uomo aggressivo, trad. it Milano, Jaca Books, 1990 (ed. orig. 1987)
[4] Per gli aspetti epistemologici e metodologici del problema, qui appena accennati, rimando a F. Dei, “Interpretazioni
antropologiche della violenza, tra natura e cultura”, in AA.VV., Alle radici della violenza, Udine, Paolo Gaspari editore,
1999, pp. 31-55; F. Dei, “Perché si uccide in guerra”, Parolechiave, 20-21, 1999 [2000], pp. 281-301.
[5] G. Ranzato, Il linciaggio di Carretta, Roma 1944. Violenza politica e ordinaria violenza, Milano, Il Saggiatore, 1997.
[6] Ibid., p. 128. Per una approfondita analisi dell’episodio di Piazzale Loreto v. Sergio Luzzatto, Il corpo del duce, Torino,
Einaudi, cap. 2.
[7] G. Ranzato, op. cit, p. 141
[8] Un esempio particolarmente interessante, in tutt’altro campo di ricerca, è rappresentato dalle analisi di Paolo Apolito
sulle apparizioni mariane ad Oliveto Citra, nella Campania degli anni ’80: dove si mostra quanti negoziati, quanti scontri
e quante “manovre sociali” stiano dietro a un evento tradizionalmente collocato nella categoria dell’ “eccitazione
collettiva”; P. Apolito, Dice che hanno visto la Madonna, Bologna, Il Mulino, 1990.
[9] G. Ranzato, op. cit., p. 140
[10] Ibid., p. 161
[11] Ibid., p. 180
[12] N. Elias, La civiltà delle buone maniere, trad. it. Bologna, Il Mulino, 1988, p. 346
[13] Ibid., p. 358
[14] Su questo punto è fondamentale il contributo di C. Pavone, Una guerra civile, Torino, Bollati Boringhieri, 1991, in
particolare cap. 7.
[15] P. Levi, Se questo è un uomo, Torino, Einaudi, 1958 (ed. orig. 1947), p. 105
[16] Si veda fra i contributi più recenti G. Agamben, Quel che resta di Auschwitz, Torino, Bollati Boringhieri, 1999
[17] P. Levi, I sommersi e i salvati, Torino, Einaudi, 1986, pp. 27-8
[18] Ibid., p. 33
[19] Ibid., p. 97
[20] Ibid., p. 101. L’affermazione di Stangl si trova in G. Sereny, In quelle tenebre, trad. it. Milano, Adelphi, 1975, p. 135.
[21] Per l’applicazione del concetto di dissonanza cognitiva al contesto della Shoah v. A.L. Hinton, “Why did the Nazis
kill? Anthropology, genocide and the Goldhagen controversy”, Anthropology Today, 14 (5), 1998, pp. 9-15.
[22] Per una recente riflessione su questi temi v. E. Traverso, La violenza nazista. Una genealogia, Bologna, Il Mulino,
2002
[23] Las Casas, Historia de Las Indias, cit. in T.Todorov, La conquista dell’America, trad. it. Torino, Einaudi,
1982, pp.170-72.
[24] Ibid., p. 174
[25] Ibid., p. 176
[26] Tra i contributi antropologici sul nesso colonialismo-crudeltà-terrore vorrei segnalare quello di Michael Taussig,
Shamanism, Colonialism, and the Wild Man, Chicago, University of Chicago Press, 1987.
[27] N. Scheper-Hughes, “Coming to our senses: Anthropology and Genocide”, in A.L. Hinton (ed.), Annihilating
Difference. The Anthropology of Genocide, Berkeley, California University Press, 2002, p. 369.
[28] C. R. Browning, Uomini comuni: Polizia tedesca e “soluzione finale” in Polonia, trad. it. Torino, Einaudi, 1995 (una
seconda edizione, 1999, contiene un’ampia postfazione in risposta, appunto, alle critiche di Goldhagen).
[29] H. Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme), trad. it. Milano, Feltrinelli, 1999 (ed. orig. 1963).
[30] Z. Bauman, Modernità e olocausto, trad. it. Bologna, Il Mulino, 1992 (ed. orig. 1989).
[31] Z. Bauman, “I campi: Oriente, Occidente, Modernità”, in M. Flores (a cura di), Nazismo, fascismo, comunismo.
Totalitarismi a confronto, Milano, Bruno Mondadori, 1998, p .18.
[32] C.R. Browining, op. cit., p. 172
[33] S. Milgram, Obbedienza all’autorità, trad. it. Milano, Bompiani, 1975 (ed. orig. 1974).
[34] D.J. Goldhagen, I volenterosi carnefici di Hitler, trad. it. Milano, Mondatori, 1997 (ed. orig. 1996).
[35] Per una critica di taglio antropologico all’uso che Goldhagen fa della nozione di “modelli culturali” v. A.L. Hinton,
“Why did the Nazis kill?”; cit. Per una più generale valutazione critica delle tesi di Goldhagen si vedano fra gli altri i
contributi raccolti in R.R. Shandley, Unwilling Germans? The Goldhagen Debate, Minneapolis-London, University of
Minnesota Press, 1998.
[36] Si veda per una sintesi di questa prospettiva J. R. Bowen, "The myth of global ethnic conflict", Journal of
Democracy, 7 (4), 1996, pp. 3-14
[37] Trad. it. Bologna, Il Mulino, 1987 (ed. originale 1973)
[38] Trad. it. Scrivere le culture, Roma, Meltemi, 2001
[39] Rappresentativo di questa tendenza è ad esempio il volume curato da Slavoj Žižek, Mapping Ideology, London-New
York, Verso, 1994. L’introduzione di Žižek è disponibile in traduzione italiana in C. Bianchi, C. Demaria, S. Nergaard,
Spettri del potere, Roma, Meltemi, 2002, pp. 41-86; volume, quest’ultimo, che fornisce un quadro assai utile delle
posizioni dei cultural e postcolonial studies intorno ai concetti di ideologia, identità e traduzione.
[40] Vedi John Bodley, Victims of Progress, Mountain View, CA, Mayfield, 1999; David Maybury-Lewis, “Genocide
against indigenous peoples”, in A.L. Hinton (ed.), Annihilating Difference: The Anthropology of Genocide, Berkeley,
California University Press, 2002, pp. 43-53.
[41] Carolyn Nordstrom, Antonius C.G.M. Robben (eds.), Fieldwork Under Fire. Contemporary Studies of Violence and
Survival, Berkeley, California University Press, 1995.
[42] Linda Green, “Fear as a way of life, in Fieldwork under fire, cit., p. 105.
[43] James E. Young, Writing and Re-writing the Holocaust. Narrative and the Consequences of Interpretation,
Bloomington, Indiana University Press, 1988, pp. 15-16
[44] Michael Taussig, “Terror as usual: Walter Benjamin’s theory of history as state of siege”, in M. Taussig, The Nervous
System, London-New York, Routledge, 1992, pp. 11-36.
[45] Antonius C.G.M. Robben, “The politics of truth and emotion among victims and perpertrators of violence”, in
Fieldwork Under Fire, cit., pp. 81-103.
[46] Rimando per alcune ulteriori osservazioni in proposito a F. Dei, “Etnografie della violenza”, Primapersona, 5,
Giugno 2002, pp. 20-24
[47] Per una rassegna delle rilevanze antropologiche della Shoah, e un invito all’apertura di un dibattito in proposito, si
vedano Carroll McC. Lewin, “The Holocaust: Anthropological possibilities and the dilemma of representation”,
American Anthropologist, 1992, 94 (1), pp. 161-66; Ibid., “Negotiating selves in the Holocaust”, Ethos, 1993, 21, pp. 295318.
[48] Il passo di Levi si trova in apertura del cap. 9 (“I sommersi e i salvati”) di Se questo è un uomo, Torino, Einaudi,
1992, p. 105. Per un ampio sviluppo di questa riflessione si veda Tzvetan Todorov, Di fronte all’estremo, trad. it. Milano,
Garzanti, 1992 (ed. orig. 1991); per un commento specificamente antropologico cfr. Francesco Remotti, Noi, primitivi. Lo
specchio dell’antropologia, Torino, Bollati Boringhieri, 1990, pp. 38-9.
[49] Alexander L. Hinton (ed.), Genocide. An Anthropological Reader, Oxford, Blackwell, 2002; Ibid., Annihilating
Difference. The Anthropology of Genocide, Berkeley, California University Press, 2002. Tra l’ampia letteratura sulla
memoria traumatica, di particolare interesse antropologico sono altre due raccolte di saggi: Paul Antze, Michael Lambek
(eds.), Tense Past. Cultural Essays in Trauma and Memory, London-New York, Routledge, 1996; Antonius C.G.M.
Robben, Marcelo M. Suárez-Orozco (eds.), Cultures under Siege. Collective Violence and Trauma,Cambridge, Cambridge
University Press, 2000
[50] trad. it. Bologna, Il Mulino, 1992 (ed. orig. 1989). Per una formulazione particolarmente incisiva di questa tesi si
veda anche Z. Bauman, “I campi: Oriente, Occidente, Modernità”, in M. Flores (a cura di), Nazismo, fascismo,
comunismo. Totalitarismi a confronto, Milano, Bruno Mondadori, 1998, pp. 15-35.
[51] Quest’ultimo è il tema sollevato nel commento di Hannah Arendt al processo Eichmann, che ha reso celebre la
formula “banalità del male” (H. Arendt, La banalità del male, trad. it. Milano, Feltrinelli, 1999, ed. orig. 1963). Il
problema del comportamento violento e crudele di “uomini comuni” è stato successivamente al centro della riflessione
della psicologia sociale, ad esempio con il notissimo esperimento di Yale sull’obbedienza all’autorità (S. Milgram,
Obbedienza all’autorità, trad. it. Milano, Bompiani, 1975, ed. orig. 1974; v. anche Ervin Staub, The Roots of Evil. The
Origins of Genocide and Other Group Violence, Cambridge, Cambridge University Press, 1989), nonché di quella
storiografica, soprattutto con il saggio di Christopher R. Browning, Uomini comuni: Polizia tedesca e “soluzione finale”
in Polonia, trad. it. Torino, Einaudi, 1995 (ed. orig. 1992).
[52] A. Appadurai, “Dead Certainty: Ethnic violence in the era of globalization”, Public Culture, 10 (2), 1998, pp. 225-47;
poi in A.L. Hinton (ed.), Genocide: An Anthropological Reader, cit., pp. 286-303.
[53] Ibid., p. 297.
[54] A. Appadurai, Modernità in polvere, trad. it. Roma, Meltemi, 2001 (ed. orig. 1996), p. 192. Nel quadro di ampio
respiro offerto da Appadurai, l’esplodere della violenza etnica e particolarista nell’ultima parte del XX secolo non appare
come un attacco alla coesione degli Stati ma, al contrario, come una reazione difensiva dalla forma-Stato a fronte della
sua progressiva implosione nello scenario della globalizzazione.
[55] L. Abu-Lughod, “Writing against culture”, in R. Fox (ed.), Recapturing Anthropology. Working in the Present,
Santa Fe, School of American Research Press, 1991, pp. 137-62. Per più approfonditi commenti in proposito rimando a F.
Dei, Beethoven e le mondine. Ripensare la cultura popolare, Roma, Meltemi, 2002, p. 40 sgg.
[56] Glenn Bowman, “The violence in identity”, in Bettina E. Schmidt, Ingo W. Schröeder (eds.), Anthropology of
Violence and Conflict, London, Routledge, 2002, pp. 27-8
[57] E. Traverso, La violenza nazista. Una genealogia, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 22
[58] N. Scheper-Hughes, “Coming to our senses”, in A.L. Hinton (ed.), Annihilating Difference, cit., p. 370
[59] Ibid., p. 369.
[60] C. Geertz, Mondo globale mondi locali. Cultura e politica alla fine del ventesimo secolo, Bologna, Il Mulino, 1999
[61] L. Abu-Lughod, “Writing against culture”, cit., p. 142. Nella sua imputazione di complicità nei confronti del concetto
di cultura, Abu-Lughod insiste sul fatto che proprio la professionalizzazione del discorso antropologico lo configura
come sapere esperto al servizio del potere. Sembra tuttavia non rendersi conto che lo statuto delle scienze umane implica
la costituzione di una comunità scientifica regolata da principi diversi da quelli del potere economico e politico nelle sue
manifestazioni più dirette. Non coglie cioè la costituzione di una sfera relativamente autonoma del sapere nella
modernità, che lo difende dalle intrusioni più dirette e strumentali del potere (è forse questa l’essenza, sociologica più
che epistemologica, della scienza moderna). Un argomento simile si può applicare alla critica, largamente diffusa nei
postcolonial studies, all’auspicio kantiano sul predominio della ragione: se questa nozione può apparire manifestazione
neppure tanto celata della hybris del dominio, non si può non ricordare che essa era volta a sostituire le regole della
discussione razionale al dominio arbitrario della violenza pura, caratteristico dell’antico regime.
[62] A. Appadurai, Modernità in polvere, cit., p. 202.
[63] Si vedano ad esempio le posizioni sostenute nei più recenti lavori di Todorov: Tzvetan Todorov, Memoria del male,
tentazione del bene. Inchiesta su un secolo tragico, trad. it. Milano, Garzanti, 2001 (ed. orig. 2000).
[64] H. Arendt, Sulla violenza, trad. it. Parma, Guanda, 2001 (ed. orig. 1969), pp. 37-8.
[65] Ibid., pp. 58-9, 61.
[66] Carroll McCLewin, “The Holocaust: Anthropological possibilities and the dilemma of representation”, cit., p. 163
[67] Marcelo M. Suárez-Orozco, Antonius C. G. M. Robben, “Interdisciplinary perspectives on violence and trauma”, in
A. Robben , M. Suárez-Orozco, (eds.), Cultures Under Siege, cit. p. 12 nota .
[68] v. su questo punto Steven Sangren, “Rhetoric and the authority of ethnography”, Current Anthropology, 29 (3),
1988, pp. 405-35