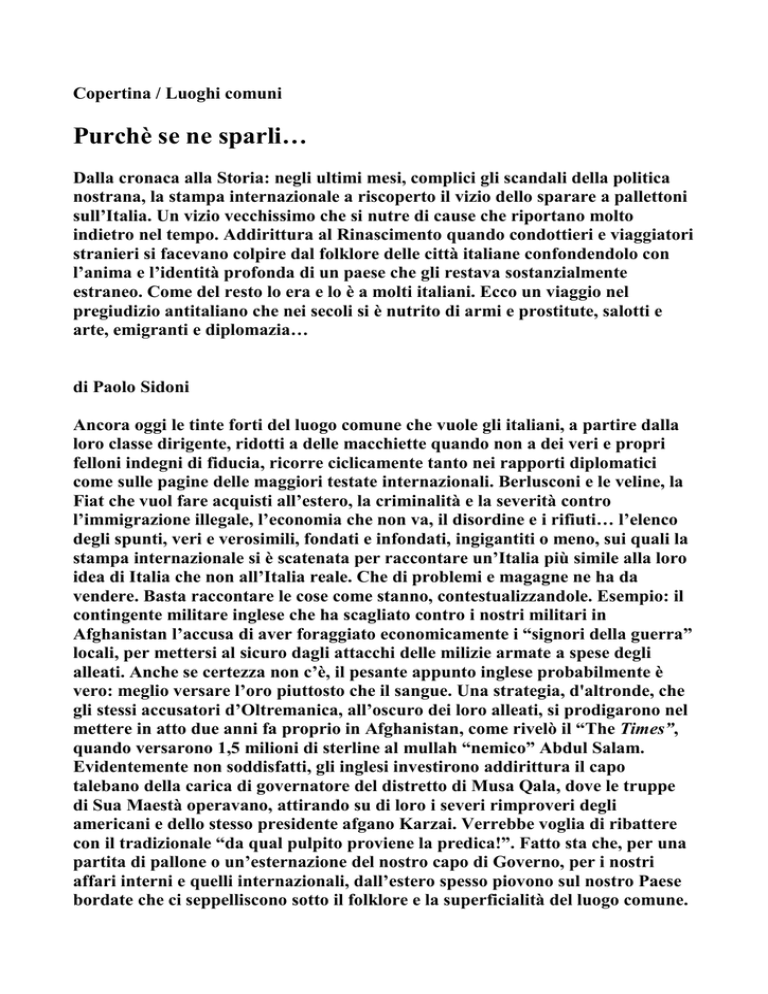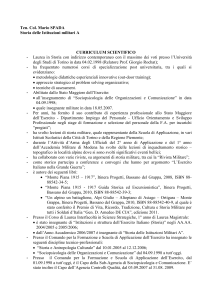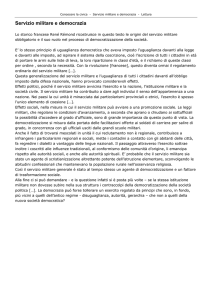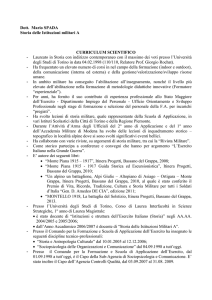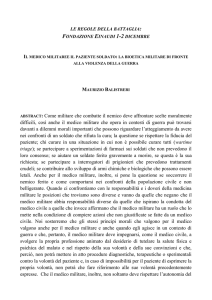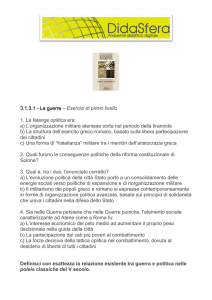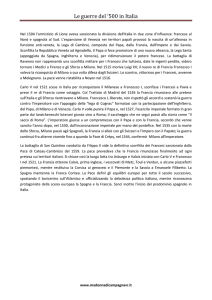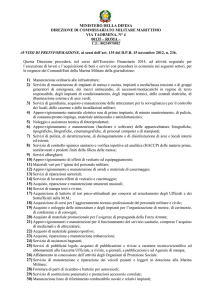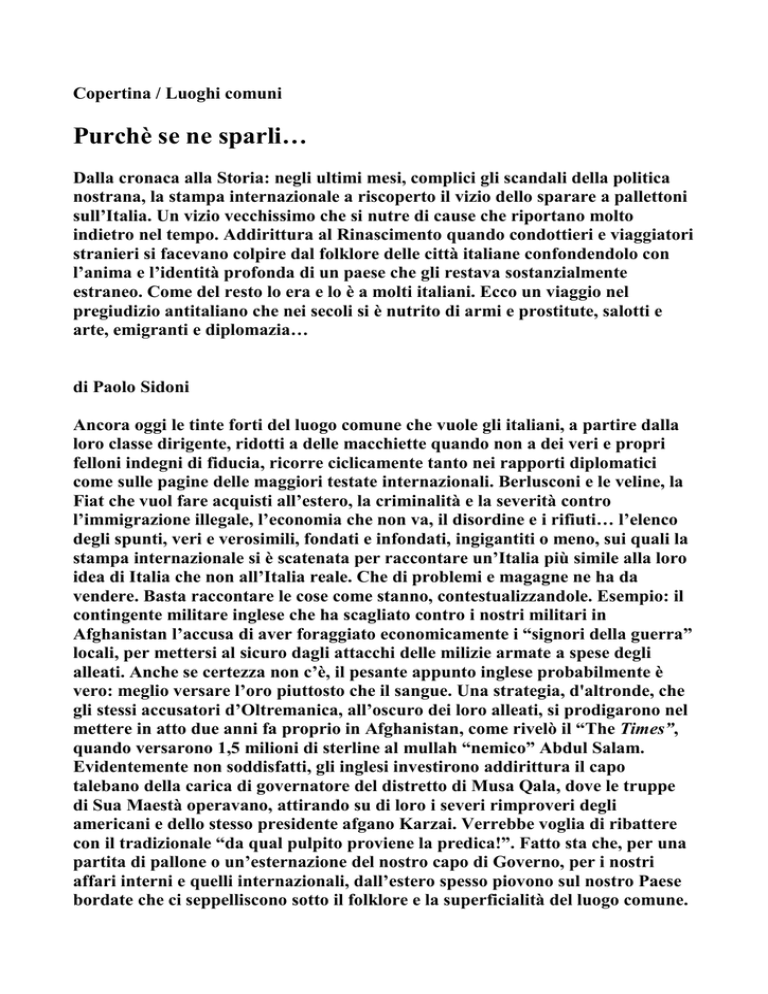
Copertina / Luoghi comuni
Purchè se ne sparli…
Dalla cronaca alla Storia: negli ultimi mesi, complici gli scandali della politica
nostrana, la stampa internazionale a riscoperto il vizio dello sparare a pallettoni
sull’Italia. Un vizio vecchissimo che si nutre di cause che riportano molto
indietro nel tempo. Addirittura al Rinascimento quando condottieri e viaggiatori
stranieri si facevano colpire dal folklore delle città italiane confondendolo con
l’anima e l’identità profonda di un paese che gli restava sostanzialmente
estraneo. Come del resto lo era e lo è a molti italiani. Ecco un viaggio nel
pregiudizio antitaliano che nei secoli si è nutrito di armi e prostitute, salotti e
arte, emigranti e diplomazia…
di Paolo Sidoni
Ancora oggi le tinte forti del luogo comune che vuole gli italiani, a partire dalla
loro classe dirigente, ridotti a delle macchiette quando non a dei veri e propri
felloni indegni di fiducia, ricorre ciclicamente tanto nei rapporti diplomatici
come sulle pagine delle maggiori testate internazionali. Berlusconi e le veline, la
Fiat che vuol fare acquisti all’estero, la criminalità e la severità contro
l’immigrazione illegale, l’economia che non va, il disordine e i rifiuti… l’elenco
degli spunti, veri e verosimili, fondati e infondati, ingigantiti o meno, sui quali la
stampa internazionale si è scatenata per raccontare un’Italia più simile alla loro
idea di Italia che non all’Italia reale. Che di problemi e magagne ne ha da
vendere. Basta raccontare le cose come stanno, contestualizzandole. Esempio: il
contingente militare inglese che ha scagliato contro i nostri militari in
Afghanistan l’accusa di aver foraggiato economicamente i “signori della guerra”
locali, per mettersi al sicuro dagli attacchi delle milizie armate a spese degli
alleati. Anche se certezza non c’è, il pesante appunto inglese probabilmente è
vero: meglio versare l’oro piuttosto che il sangue. Una strategia, d'altronde, che
gli stessi accusatori d’Oltremanica, all’oscuro dei loro alleati, si prodigarono nel
mettere in atto due anni fa proprio in Afghanistan, come rivelò il “The Times”,
quando versarono 1,5 milioni di sterline al mullah “nemico” Abdul Salam.
Evidentemente non soddisfatti, gli inglesi investirono addirittura il capo
talebano della carica di governatore del distretto di Musa Qala, dove le truppe
di Sua Maestà operavano, attirando su di loro i severi rimproveri degli
americani e dello stesso presidente afgano Karzai. Verrebbe voglia di ribattere
con il tradizionale “da qual pulpito proviene la predica!”. Fatto sta che, per una
partita di pallone o un’esternazione del nostro capo di Governo, per i nostri
affari interni e quelli internazionali, dall’estero spesso piovono sul nostro Paese
bordate che ci seppelliscono sotto il folklore e la superficialità del luogo comune.
Questo tòpos ha d’altronde radici antiche, che risalgono al Rinascimento
quando, in un’Italia politicamente frammentata e in preda ai conflitti interni, le
armate angioine di Carlo VIII, quelle d’Orléans-Visconti di Luigi XII e
l’esercito spagnolo sotto la guida di Consalvo di Cordova, si contendevano il
dominio della penisola. Lo spazio italiano era terreno di scontro tra le maggiori
potenze europee dell’epoca e ai comuni in continuo antagonismo tra loro non
restava che porsi sotto la loro tutela, uniche autorità in grado di assicurarsi i
dispendiosi servizi dei condottieri mercenari. Gli italiani, insomma, non
combattevano se non sotto i vessilli stranieri. Fu probabilmente questo il motivo
che indusse a dar vita alla credenza che gli italiani, in fatti d’arme, erano meno
di nulla. Eppure, fa notare Virgilio Ilari, docente di storia militare presso
l’Università Cattolica di Milano, in quel periodo, prima che l’epicentro bellico si
trasferisse nelle Fiandre per le lunghe guerre tra spagnoli cattolici e protestanti,
«fu proprio il nostro Paese a fornire le fondamenta sulle quali venne
successivamente edificata la moderna arte bellica occidentale». Uno smacco alle
dicerie nei confronti della combattività italiana giunse con la Disfida di Barletta,
nel 1503 [rievocata anche su “Storia In rete” n. 28 del febbraio 2008]. La
tradizione vuole che Charles De La Motte, un cavaliere francese prigioniero,
irritato dai continui elogi che durante un banchetto i soldati spagnoli
rivolgevano ai loro commilitoni italiani, sbottò offendendo con veemenza questi
ultimi con l’accusa di viltà, codardia e tradimento. Uno schiaffo in piena regola,
una questione d’onore che, per essere risolta, richiedeva il prezzo del sangue.
Nella zona tra Corato e Andria venne così organizzato un torneo tra tredici
cavalieri italiani di stanza a Barletta e altrettanti francesi. Com’è noto i militi
italiani sconfissero duramente la compagine d’Oltralpe; fu lo stesso campione
della formazione italiana, il capitano Ettore Fieramosca, a vibrare il colpo
mortale contro De La Motte. La disfida di Barletta non riuscì tuttavia a
compensare la nostra cattiva reputazione militare, che andava pian piano
prendendo piede. Solo qualche anno dopo, una raccolta di luoghi comuni e adagi
popolari avrebbe infatti negato, nero su bianco, qualsivoglia vis pugnandi agli
abitanti dello Stivale.
Ma, sempre nel Cinquecento, altri motivi covavano sotto la cenere pronti ad
ingrandire le pecche che ogni popolo ha per farle diventare dei pregiudizi duri a
morire. Un motivo era, detto in senso ampio, “religioso”. Il 3 gennaio 1521 con la
bolla Decet Romanum Pontificem, Leone X de Medici scomunicava Martin
Lutero. Era il punto di rottura di una lunga polemica dottrinaria e morale che
apriva un nuovo capitolo di contrasti. Gli attacchi dei protestanti alla Curia
romana e alla religione cattolica non hanno tardato, nel corso dei secoli, ad
identificarsi con la nazione dove il Vaticano aveva messo le proprie radici.
Tranne l’olandese Adriano VI, per un solo anno sul trono di Pietro, per tutto il
Rinascimento e poi su su fino a Karol Woytila tutti i papi sono stati italiani. Lo
stesso Rodrigo Borgia, spagnolo di nascita, era giunto così presto in Italia al
seguito dello zio, papa Callisto III (1378-1478), da essere un italiano a tutti gli
effetti. E alla polemica anti-cattolica si assommava – con qualche ragione fino
alla Controriforma – la “questione morale” che in qualche modo colpiva tutti i
viaggiatori che arrivavano a Roma, una città dove la percentuale delle prostitute
sfiorava il 10% della popolazione. Percentuali simili si registravano anche a
Venezia, con Firenze, Milano e Napoli, una delle principali realtà italiane ed
europee. Facile quindi che i viaggiatori stranieri rimanessero colpiti dalla realtà
delle strade, una sensazione destinata a ripetersi fino a tutto il Settecento
quando, con l’abitudine del “Gran Tour” le giovani e future classi dirigenti
europee, soprattutto inglesi, si confrontavano con l’immenso patrimonio
culturale e storico italiano in un viaggio di formazione che non disdegnava anche
i piaceri della carne. Bellezze artistiche, sontuose vestigia del passato e
compiacenti “navi scuola” andavano a formare un tutt’uno dove la realtà del
paese veniva trascurata a vantaggio delle suggestioni che colpivano i sensi. Se poi
tra le letture dei ricchi e snob viaggiatori c’erano anche i libri di Erasmo da
Rotterdam allora il cerchio si chiudeva…
Tra i pochi storici che hanno approfondito questo tema, Ilari (“Liberal Risk”, n.
6, 23 marzo 2005) cita un’ampia raccolta di proverbi di Erasmo da Rotterdam,
gli Adagiorum Chiliades. Il maggiore esponente dell’Umanesimo cattolico riportò
in questo testo la definizione di “Myconius calvus”, chiarendo che si trattava di
un ossimoro. All’epoca era infatti risaputo come i Miconi fossero una
popolazione che vantava folte capigliature; come dire – continuava l’autore de
“L’elogio della follia” – “uno sciita colto, un italiano pugnace, un commerciante
onesto, un soldato pio o un cartaginese affidabile” (veluti si quis Scytham dicat
eruditum, Italum bellacem, negotiatorem integrum, militem pium aut Poenum
fidum). Piccato da questa critica, “il curiale Pietro Corsi da Carpi pubblicò a
Roma, nel 1535, una “Defensio pro Italia” [...] incentrata su un rosario di esempi
di valore e sagacia militare degli italiani”. Erasmo, incurante del fatto che se le
eccezioni sono molte perdono la loro caratteristica di “eccezioni”, replicò al
Corsi che le “eccezioni non confutano, ma semmai confermano la regola”. Il
dotto umanista continuava con toni razzisti, ribattendo che l’ossimoro “Italum
bellacem” veniva inoltre sostenuto da “alcuni eruditi” romani, convinti che i
pochi italiani eroici non fossero altri che i discendenti delle antiche gentes
barbare; al contrario, gli eredi dell’antica romanità altri non erano se non
“quelli piccoletti e malnati”. Già in questo dibattito, svoltosi poco meno di mezzo
millennio fa, si coglie un tipico elemento antropologico italiano, che nei secoli a
seguire si ripeterà con costanza: l’insultarsi, il dir male di se stessi. Come non
mettere in correlazione gli “eruditi romani” menzionati da Erasmo da
Rotterdam con quel che accadrà, secoli più tardi, per la disfatta di Adua? Certo,
analogie non mancano neanche con le nostre cronache d’attualità. Ancora oggi il
fosco spirito di fazione illude taluni di poter trarre profitto, un vero e proprio
tornaconto politico, da un presunto decadimento civile e morale del Paese e da
ogni sua sconfitta – militare, economica o politica – il tutto imputabile,
ovviamente, alla controparte. È una vecchia storia, molto vecchia.
Un altro punto che la vicenda di Erasmo pone involontariamente in evidenza è il
meccanismo che governa il luogo comune. L’esperienza umana, tanto
individuale quanto collettiva, induce per sua stessa natura a ricordare in
maniera più immediata, solida e profonda fatti che concordano con le proprie
opinioni. Quelli che invece le smentiscono, vengono semplicemente rimossi e
lasciati cadere nell’oblio. Questo è il meccanismo di base attraverso il quale,
grazie a una memoria di tipo selettivo, nascono e si consolidano pregiudizi e
luoghi comuni. Non esistono esempi contrari, per quanto numerosi e oggettivi
essi possano essere, in grado di aver ragione del tòpos. L’incoerenza tra il dato
palese e il luogo comune viene solitamente risolta – la querelle tra Erasmo da
Rotterdam e Pietro Corsi da Carpi è, in questo senso, illuminante – ricorrendo
alla casualità, espressa nella locuzione “l’eccezione che conferma la regola”.
Sembrerebbe, insomma, che persuadersi della veridicità di un luogo comune
richieda una sorta di atto di fede, contro il quale nessuna soverchiante evidenza
di segno opposto può rendere giustizia o, quantomeno, riportare il ragionamento
sui binari della razionalità. Va sottolineato che anche l’espressione “eccezione
che conferma la regola”, così come viene solitamente usata, è un luogo comune.
Diversamente sarebbe se fosse riportata nella sua forma completa: “è l’eccezione
che conferma la regola nei casi eccezionali”, il che sta semplicemente a
significare che “tutto è possibile”. Anche in questo caso il luogo comune deriva
da un uso parziale di un dato oggettivo che, comunque, non risulta mai
completamente del tutto arbitrario. Fatta questa necessaria premessa, diventano
comprensibili nascita e sviluppo dei pregiudizi, e non solo di quelli nei nostri
confronti. Inglesi e francesi risentono ancora, nella considerazione che uno ha
dell’altro, della Guerra dei Cent’anni; e i sudditi di Sua Maestà non fanno venir
meno ai loro dirimpettai il ricordo del governo filo-nazista di Vichy, mentre i
francesi ancora rinfacciano oltremanica le azioni di Mers-el-Kebir e i
bombardamenti “pro liberazione” durante la Seconda guerra mondiale [vedi
“Storia in Rete” n° 45-46, luglio-agosto 2009 NdR].
Insieme agli italiani, a causa della guerra dei Trent’anni, nel Seicento anche la
popolazione tedesca venne per lungo tempo tacciata di incapacità bellica.
Pressoché contemporanea a quella italiana, durante il XIX secolo l’unità
nazionale della Germania – a partire dalle vittorie di Scharnhorst e Gneisenau
contro Napoleone – generò una serie di imprese militari che rimasero marchiate
nella memoria di tutta l’Europa. «La guerra dei Sette Anni e le riforme militari
di Federico II di Prussia – scrive Ilari - hanno durevolmente associato l'idea di
militarismo non solo alla Prussia, ma all'intera Germania». La battaglia di
Sedan (1870) in cui i prussiani sbaragliarono l’esercito francese di Napoleone
III, mutilandone i territori e facendo sfumare il sogno di grandeur così caro a
Parigi; le capacità belliche che dimostrarono, seppur sconfitti, durante la Prima
e la Seconda guerra mondiale, fecero sì che il tòpos sull’affidabilità tedesca
cambiasse completamente di significato semantico. “Lo stesso stereotipo
riguardava gli ebrei – continua Ilari - benché durante la Prima guerra mondiale
gli ebrei tedeschi fossero il gruppo sociale con la maggiore percentuale di
decorati al valor militare”. Il ribaltamento in positivo delle loro virtù guerresche
si celebrò «già prima della fondazione dello stato di Israele, di fronte alle
capacità militari e al valore dimostrati dalla lega di difesa ebraica in Palestina,
della Jewish Brigade in Africa Settentrionale, e all'eroica insurrezione del ghetto
di Varsavia». Come in ogni gruppo sociale, etnia o nazione, nella
stereotipizzazione del carattere morale dell’italiano ha inevitabilmente avuto
peso preponderante lo specifico e particolare sviluppo storico. Con ricadute
anche sul fronte politico-diplomatico.
Sergio Bertelli, professore emerito di Storia moderna all’università di Firenze,
fa il punto sulla nostre peculiari e altalenanti vicende, ricordando che nella
prima parte del Cinquecento «la situazione geopolitica della Penisola portò più
volte alla necessità di un ribaltamento di alleanze: Giulio II (papa dal 1503 al
1513) tra Francia e Impero, così dicasi per Clemente VII (sul trono dal 1523 al
1534)». L’esempio più evidente della specificità italiana, così propensa alla
fulminea alternanza di fronte, conosce il suo momento tipico nel ducato di
Savoia, confinante con una potenza ingombrante come quella del «re di Francia,
dal quale cercò sempre di emanciparsi con politiche matrimoniali che, in un
movimento basculatorio, lo portarono verso la Spagna, per poi rientrare
nell'orbita francese». Alla medesima dinamica sottostò il ducato di Mantova,
«che aveva nel Monferrato una vera e propria "palla al piede", che lo spingeva
ad una sorta di dipendenza feudale verso gli Asburgo, per difendersi dai Savoia
appoggiati dai francesi». Non i numerosi e indiscutibili casi di gloria italiana, ma
i rapporti ancillari con le potenze di turno e la conseguente frammentazione
politica, protrattisi per lungo tempo, sono i ricordi sedimentati nella memoria e
nella coscienza generale.
I mercenari, i contractors italiani d’allora, dal Cinquecento all’Ottocento, hanno
comunque fornito numerose prove di indiscutibile valore, tanto che la Regia
Marina dedicò ai Capitani di Ventura un’intera serie di incrociatori negli anni
Trenta e Quaranta. Prendendo ad esempio un’area di conflitto oggi sotto gli
occhi di tutto il mondo, l’Afghanistan cui l’Italia ha tributato il suo triste pegno
di vittime, l’unico personaggio che riuscì a domare la riottosa e fiera popolazione
locale fu un reduce dall’esercito napoleonico: Paolo Avitabile, nome storpiato
dalle tribù del posto in Abu Tabela (come ricorda Stefano Malatesta in «Il
napoletano che domò gli afgani», Neri Pozza, 2002). Avitabile divenne
governatore di Peshawar e generale dell’impero britannico; la sua figura
incuteva un tale timore, giustificato dai metodi draconiani che usò per stabilire
l’ordine, che «gli afgani guardavano a lui con la stessa paura e ammirazione con
cui un branco di iene guarda alla tigre». Ma di lui, nella memoria storica
italiana e britannica, non c’è traccia. Né è rimasta traccia della battaglia di
Castelfidardo del 18 settembre 1860, che contrappose l’esercito sabaudo a quello
pontificio guidato dal francese De La Moriciere, nominato per l’occasione
comandante in capo. De La Moriciere, vincitore del leggendario Abd-el Kader
(1808–1883) durante la guerra d’Algeria, affermò che “les italiens ne se battent
pas”, vale a dire che non c’era d’aver timore di quelle bande che andavano
premendo sui confini dello Stato Pontificio, perché gli italiani sono una
popolazione che al dunque fugge dalla battaglia. La spocchiosa esternazione
ricorda un po’ quella di De La Motte, smentita da Fieramosca. Ancora una
volta, i soldati italiani dovettero far ricredere i francesi. A Castelfidardo le
truppe di De La Moriciere vennero messe in rotta e il generale francese riuscì a
porsi in salvo camuffandosi da pastore. Con la sconfitta dei papalini, i territori
italiani a nord e a sud vennero così uniti sotto un’unica bandiera, quella
tricolore.
Il continuo ricorso ai vessilli stranieri da parte dei potentati locali italiani, le
alleanze di questi ultimi che sovente venivano rotte all’ultimo momento per
passare alla “parte opposta”, giudicate nella contingenza molto più proficue per
i propri interessi, hanno tuttavia continuamente sollecitato la suggestione che
dava nutrimento al luogo comune dell’italiano inaffidabile tout court. Tanto che
lo scrittore francese Gustave Flaubert, nel suo “Dizionario dei luoghi comuni”,
riportò alla voce “Italiani: tutti musicisti, tutti traditori”. Senz’altro l’albagia
con cui le potenze straniere guardano il nostro Paese origina nel 1400, con la
calata di Carlo VIII in Italia e le prime disastrose disfatte. Ma
antropologicamente affonda le radici nelle diverse essenze nazionali: la Francia
angioina è una nazione il cui unico orgoglio è dato dalla nobiltà di spada: le
glorie sono quelle delle conquiste carolingie, poi dalla primazia nelle crociate
(dove pure i principi italiani furono numerosissimi). Ma la spada pesava più
dell’oro della cultura e dell’arte, che abbondava nell’Italia dell’Umanesimo e del
Rinascimento (e non a caso la nobiltà di spada in Francia, così come gli hidalgos
spagnoli, vanteranno sempre una loro altera superiorità sulla nobiltà di toga e
sulla borghesia anche nella più miserabile decadenza). Così la citata Disfida di
Barletta si inserisce proprio nel solco del tentativo francese di far valere – anche
nella sconfitta – l’unica pretesa di superiorità, quella cavalleresca.
Culturalmente, artisticamente, economicamente e perfino politicamente è
ancora l’Italia a primeggiare (e altrimenti francesi e spagnoli non starebbero
dalle parti nostre a scannarsi per il possesso di questo Paese che ha regioni di
straordinaria ricchezza). Ma all’epoca, la morale che contava era quella
dell’hidalgo, del nobile di spada, e l’intera corte di Lorenzo il Magnifico non
valeva quanto un cavaliere blasonato o magari un maestro di falconeria di corte.
D’altronde, non dimentichiamo che nell’Evo Moderno l’artista ancora mangiava
in cucina, considerato poco più che un servo, e anche poeti, filosofi e musicisti
ancorché ammessi nelle corti, sedevano nei posti meno prestigiosi, salvo che
qualche mecenate non li avesse in particolare grazia.
Un’immagine della Penisola come paese teatrale per eccellenza è quella poi che
emerge dai resoconti dei “viaggi in Italia” compiuti nell’epoca del Grand Tour, a
partire dal Barocco fino all’Ottocento. Scrivono i fratelli Goncourt – i cui diari
di viaggio sono stati pubblicati in Italia alla fine dello scorso decennio – che “Nel
secolo XIX l’Italia è il Paese dove sembrano essersi rifugiati il romanzo e
l’inverosimiglianza della vita europea. Qui sono stati accolti e conservati i
drammi, le commedie, gli imbrogli, le catastrofi, i dolori e le situazioni ridicole
che per uno spirito poetico possono rappresentare un vero palcoscenico tra cielo
e terra...”. Ciò che impressiona più di tutto i visitatori è lo spettacolo degli
accattoni (la Roma papale ne era ricolma, ed è vero). Ma è il pregiudizio quello
che spinge il commento: lo scrittore inglese Charles Dickens visitò l’Italia fra
1844 e 1845. Nella descrizione che fece di una sentenza capitale a Roma –
eseguita dal celebre Mastro Titta a via de’ Cerchi – esprime disgusto assoluto:
«Fu uno spettacolo orrendo, immondo, volgare e rivoltante...». Ma Dickens non
poteva non sapere come venissero eseguite le condanne a morte in altri Paesi – a
cominciare dal suo - al cui confronto quelle del boia romano Bugatti non erano
certamente più crudeli. Un paragone che di lì a pochi anni sarebbe stato
evidenziato nelle memorie del celebre carnefice, paragonando una sua asettica
decapitazione all’atroce sorte di un condannato alla sedia elettrica negli USA
[vedi “Storia in Rete” n° 21-22 NdR].
Il pregiudizio dei viaggiatori si rivelava anche e soprattutto verso gli usi e
costumi italiani, considerati troppo “gaudenti” per le bacchettone morali del
nord Europa, egemonizzato dal puritanesimo protestante. Il cicisbeo, il cavalier
servente, è una di quelle istituzioni sociali tipiche dell’Italia barocca e rococò che
oltralpe proprio non veniva capita. E – fraintesa – è un sistema per sparlare
dello Stivale: con Sismonde de Sismondi si crede di individuare il punto più
basso del rammollimento di una nazione intera. Nel volume XVI della sua
monumentale “Histoire des Républiques italiennes” Sismondi (1773-1842),
indicò proprio nel cicisbeismo il punto di approdo di quel grande arco di civiltà
italiana iniziatosi con i Comuni. Montesquieu nel 1728 addirittura scriveva:
«Non vi ho parlato dei cicisbei. È la cosa più ridicola che un popolo stupido
abbia potuto inventare: sono degli innamorati senza speranza, delle vittime che
sacrificano la loro libertà alla dama che hanno scelto». Un giudizio che in un
colpo ha dato dello “stupido” a personaggi del calibro di Pietro Verri e Vittorio
Alfieri, che cicisbei lo erano stati a loro volta. [sulla vera natura del fenomeno dei
cicisbei si veda l’articolo pubblicato da «Storia In Rete» n. 29-30 del novembredicembre 2007]
In alcuni momenti particolari, anche per noi però si registrarono dei
ribaltamenti di giudizio. Napoleone – che per i sostenitori era l’Empereur ma per
i detrattori diventava l’Italien – ebbe sotto le sue insegne 30 mila italiani in
Spagna e altri 27 mila in Russia, dei quali ebbe sempre la più alta opinione,
dichiarando a più riprese di aver fatto rinascere le virtù belliche del nostro
Paese. Il tema della “rinascita” militare italiana fu presente anche nel periodo
risorgimentale e nel ventennio fascista, allorché il regime di Mussolini lanciò la
formula politica della “nazione militare”. “Ma non li possiamo però considerare
veri mutamenti di giudizio – precisa Ilari nel suo studio – perché incisero (e per
poco) sulla percezione domestica e non su quella universale”. Una percezione
che subiva – nel frattempo – da lunghi anni la propaganda negativa data
dall’immagine che i nostri immigrati davano del Paese, non certo per loro
volontà, ma per le condizioni oggettive di miseria da cui fuggivano. Umili
lavoratori, si adattarono ad ogni disagio, in un’epoca in cui la morale era ancora
quella altoborghese e sussiegosa di “Orgoglio e Pregiudizio”. Per cui si formò
ben presto nei Paesi che accoglievano i milioni di diseredati che partivano dalla
Penisola l’idea che il popolo italiano fosse formato solo la pizzaioli, barbieri e
gelatai, perlopiù analfabeti. Nonché da anarchici bombaroli e assassini (molte
teste coronate lo sperimentarono direttamente nella seconda parte
dell’Ottocento) e – ahinoi – da mafiosi e delinquenti varu, la cui fuoriuscita dal
Regno – non ufficialmente ma nei fatti - era incentivata affinché andassero a far
danno altrove. Senza rendersi conto che il danno era a doppio taglio, con scorno
per l’immagine dell’Italia. Una scelta miope che pesa ancora oggi nonostante
milioni di italiani si siano fatti onore onestamente ai quattro angoli del Pianeta,
da qualche decennio anche come “cervelli” e non più come manovali e minatori.
Da poco formata come nazione e stato unitario, appena uscita da un lungo
Risorgimento, l’Italia resa ancora fragile dai numerosi problemi interni e con
una classe politica in via di formazione, si gettò nell’impresa coloniale. Altri
Paesi intrapresero la medesima via solo però dopo secoli di unità, che li
mettevano in grado di sopportare meglio gli inevitabili rovesci e battute
d’arresto che queste operazioni oltremare prevedevano: dai massacri in Algeria
per i francesi alla sollevazione dei cypois in India, dalle campagne contro gli zulu
alla repressione dei boeri in Sud Africa per gli inglesi. L’Italia volle affrontare
questo insicuro e impegnativo cammino a pochi decenni dalla sua Unità, e
l’esperienza risultò fatale. Le operazioni militari del nostro paese durante la
campagna d’Africa Orientale terminarono disastrosamente ad Adua il 1° marzo
1896. Le truppe italiane, al comando del tenente generale Oreste Barattieri,
subirono una cocente sconfitta contro gli uomini del negus Menelik II. Barattieri
venne destituito e, più tardi, messo sotto processo, reo di aver predisposto un
piano d’attacco “ingiustificabile” e aver abbandonato le sue truppe sul campo di
battaglia. Venne assolto, ma la corte marziale lo giudicò “del tutto inadatto” al
comando. Il governo Crispi fu costretto alle dimissioni, la nuova
amministrazione Di Rudinì ne prese il posto adottando una politica di prudenza
e astensione da ulteriori avventure coloniali. L’esito della sconfitta di Adua
portò alla firma del trattato di Addis Abeba, che riconosceva all’Etiopia la sua
indipendenza. La disfatta fu percepita in Italia come una vergogna nazionale,
incidendo in maniera determinante nella memoria storica, condizionando le elite
politiche e culturali del paese. L’umiliazione che gravò sull’Italia si protrasse
per i successivi 40 anni, fino al ’35, quando Mussolini avviò nuovamente, questa
volta con esito rapido e positivo, la conquista dell’Abissinia. La sconfitta
etiopica, che rappresentò il più grosso smacco che mai esercito coloniale avesse
dovuto subire, suscitò un’ondata di proteste che assunsero da subito toni antiitaliani.
A Milano e in altre città del nord, saputa la notizia, la gente scese per le strade
occupando le stazioni al fine di impedire la partenza dei rinforzi che, di lì a
pochi giorni, dovevano imbarcarsi per l’Africa. Il vero bersaglio di quelle
manifestazioni era Crispi, colpevole di aver trascinato il paese in un conflitto irto
di incognite e gravido di sangue. Molti spinsero la propria gioia per la sconfitta
al punto da urlare per le strade “viva Menelik!”: un’assurda manifestazione di
anti-italianità e una riprova dei sentimenti eversivi che serpeggiavano all’interno
del paese. Ma era anche un inequivocabile segnale della fragilità del sentimento
nazionale e l’apparizione di una sinistra internazionalista, fondamentalmente
diversa da quella mazziniana e democratica che aveva contribuito
all’unificazione del paese. Le reazioni dei partiti, della stampa e della classe
politica italiana furono scomposte e concitate. La “batosta risolutiva” in terra
d’Africa auspicata da Turati fece esultare i socialisti; una mano ignota scrisse
sui muri della caserma milanese di Sant’Ambrogio “Soldati, non andate al
macello! Viva la bandiera rossa, viva Menelik!”. Dalle pagine de “l’Osservatore
Romano” e di “Civiltà Cattolica” esultò anche il mondo cattolico. Nelle piazze le
folle urlavano “L’esercito è vigliacco!”, mentre il radicale Imbriani e Felice
Cavallotti facevano pressioni sul governo affinché Baratieri, invece che al
giudizio di un Tribunale Militare, venisse sottoposto al vaglio di una apposita
Alta Corte di Giustizia presieduta da nove membri del Parlamento. Fu lo stesso
Imbriani che propose alla Camera il ritiro definitivo del contingente coloniale
italiano e, facendogli sponda, Andrea Costa gridava in Parlamento “Neanche
più un soldo per l’Eritrea! Neanche più un soldo per l’Africa!”. Ad un anno di
distanza, il 16 ottobre 1897, nella “Nuova Antologia” Alfredo Panzini ricorse al
sarcasmo, parafrasando l’esclamazione di Francesco I dopo la battaglia di
Pavia: “Tutto è salvo fuorché l’onore”. Qualche affinità con certe reazioni che
seguirono alla strage di carabinieri a Nassirya? Sembrerebbe proprio di sì.
Adua fu ad ogni modo una terribile sconfitta, un cumulo di errori strategici, un
esempio di leggerezza militare come mai dovrebbero esserci. Ma non fu tuttavia,
come i detrattori interni affermarono, un disonore per chi la combatté.
Anche all’estero la disfatta ebbe un’eco importante. Nell’opinione del “The
Times” si trattò di “un disastro militarmente inferiore all’apparenza, [ma]
politicamente gravissimo”. L’Italia cercò di sbarazzarsi dell’infausto ricordo con
delle iniziative poco comprensibili e prive di ponderazione: il 18 maggio dello
stesso anno nel forte di Adigrat, senza che alcun pericolo venisse ravvisato, il
generale Baldissera fece ammainare il tricolore; Cassala, che venne conquistata
dopo un’aspra lotta contro i dervisci, venne ceduta a sua volta agli inglesi. Di
Rudinì, il Re e l’esercito furono talmente scossi da queste reazioni che Umberto I
decise di inviare a Menelik 20 milioni di lire in oro, a titolo di rimborso per le
spese di guerra sostenute. Un’improvvida offerta che, ovviamente, il Negus
abissino e le diplomazie internazionali interpretarono come un atto di
sudditanza. Diciassette anni più tardi, nel 1913, il sindacalista rivoluzionario
George Sorel denunciò che gran parte della pressante campagna anticolonialista
successiva ad Adua venne orchestrata da agenti francesi, per indebolire il fronte
interno italiano e, di conseguenza, la Triplice Alleanza. Vero o meno, certo è che
una parte ragguardevole della popolazione italiana si scagliò a testa bassa contro
la propria patria e i suoi soldati. E proprio dalla Triplice Alleanza, patto
militare difensivo stipulato nel 1882 e via via rinnovato, con il quale l’Italia si
era legata alla Germania e all’Austria-Ungheria in contrapposizione allo
schieramento anglo-russo-francese della Triplice Intesa, venne l’ennesima
accusa di tradimento nei nostri confronti.
La questione delle terre irredente che ambivamo a porre sotto la nostra tutela,
indusse nel 1915 il governo Salandra a firmare in tutta segretezza il Patto di
Londra, e cambiare alleanze a favore dell’Intesa: ma non possiamo dimenticare
che l’Austria-Ungheria fece del bello e del buono per inimicarsi l’Italia e che a
più riprese i suoi generali – Conrad in testa – proposero d’attaccare il nostro
Paese alle spalle (anche durante la crisi del terremoto di Messina del 1908).
Anche durante la Prima guerra mondiale feroci critiche si riversarono contro i
nostri soldati, complice – una volta ancora – gli atteggiamenti spregiudicati di
alcuni connazionali. Dopo circa due anni e mezzo dall’inizio del conflitto, che ci
si illuse essere una guerra di breve durata, gli italiani furono sconfitti a
Caporetto [vedi “Storia in Rete”, n. 37-38, novembre-dicembre 2008, l’articolo
di Aldo A. Mola “I veleni di Caporetto arrivarono fino a Vittorio Veneto”]. Il
bilancio fu pesantissimo: 30 mila morti, 300 mila prigionieri e altrettanti
dispersi. Le armate austro-ungariche dilagarono costringendo le truppe italiane
ad arretrare e trincerarsi sulla destra del Piave. Questa debacle militare
“divenne un grano nel lungo rosario delle sconfitte”, ha scritto Mola, che si
aggiunse a Custoza e Novara (1848-49), ancora Custoza e Lissa (1866) e alla
citata disfatta di Adua. La reazione del comandante Cadorna fu avventata, con
il suo dispaccio che faceva ricadere tutta la responsabilità sulla viltà delle
truppe, dimenticando gli errori e le mancanze sue e soprattutto dei comandi
della Seconda Armata. Ancora una volta, come fu per Adua, l’Italia politica e
militare diede una pessima prova di se stessa. E nuovamente, nonostante i
numerosi atti di valore da parte dei soldati tricolori, narrati anche dallo scrittore
americano Ernest Hemingway [vedi ancora il n. 37-38, novembre-dicembre
2008, l’articolo di Pierluigi Romeo di Colloredo, “La leggenda del Col
Moschin”], la suggestione che passò nelle coscienze collettive fu quella della
nostra inadeguatezza e impreparazione bellica, che le successive, eccezionali
vittorie del Piave e di Vittorio Veneto non riuscirono a cancellare, e nemmeno il
fondamentale contributo alla resa della Germania grazie allo sfondamento del
dispositivo austrotedesco sulla direttrice Brennero-Innsbruck, vero e proprio
“ventre molle” degli Imperi Centrali.
Che comunque l’avvilimento del Paese e la percezione che gli stranieri avevano
di esso fosse negativa è chiaro anche dalla reazione che si registrò con l’avvento
del Fascismo. La propaganda del quale era chiaramente in buona parte volta ad
evidenziare l’orgoglio italiano, i risultati ottenuti e la politica dei “record”, segno
che il problema bifronte di immagine all’estero e del complesso d’inferiorità non
erano mai venuti meno. E puntuali si ripresentarono con la Seconda guerra
mondiale, quando la nazione subì come una doccia fredda le sconfitte in Africa e
Grecia (dimenticando che l’Italia era in guerra già dal 1935, e che le sue risorse
di materiali erano al lumicino, e che i francesi – con il loro “esercito più potente
d’Europa” – erano durati all’ombra dell’inutile Maginot solo 40 giorni, mentre
l’Italia teneva botta contro gli inglesi da 40 mesi). Così nell’immaginario
collettivo si perpetua la considerazione che se il nemico è riuscito a mettere a
segno un colpo – prendiamo il caso della notte di Taranto, quando gli
aerosiluranti britannici affondarono una corazzata danneggiandone due in
porto – è dovuto all’inadeguatezza italiana, mentre episodi analoghi da parte
italiana – per esempio le imprese degli incursori della Decima MAS – sono
dovuti alle eccezionali doti dei singoli eroi, non dovendosi gli inglesi
rimproverare alcunché. Uno strabismo che troviamo anche da parte dei
commentatori (professionisti o amatori della Storia) italiani, che ricorda molto
da vicino il trattamento riservato ai CT della Nazionale di calcio perdenti
rispetto a quelli che portano a casa coppe e trofei: i primi sono dei geni; i
secondi, eravamo tutti capaci a far meglio di loro.
Insomma, lo sparlare dell’Italia è un fenomeno che mescola due complessi di
inferiorità, quello italiano e quello del popolo straniero di turno. I primi, sempre
pronti all’esterofilia, tengono bordone ai secondi, che consapevoli delle infinite
virtù del “popolo di santi, di eroi, di poeti, di navigatori e di trasmigratori” (e di
masochisti) ha trovato un’arma formidabile per prevaricarlo nella denigrazione
per equilibrare il confronto. Lo vediamo perfino fra popoli il cui confronto con
quello italiano è a dir poco impietoso – i croati per esempio – che da un lato
disprezzano il Bel Paese e gli attribuiscono orrori immani commessi durante la
Seconda guerra mondiale (ricordiamo le uscite del presidente croato Mesic nel
2007) e dall’altra fanno carte false per attribuire natali slavi ai dalmati italiani
delle repubbliche di Venezia e Ragusa, alla disperata caccia di qualche gloria
nazionale da esibire su monete e francobolli: così perfino Marco Polo diviene un
“esploratore croato” e i fratelli Laurana – immortali architetti umanistici del
castello di Urbino – “artisti croati”. Una campagna di croatizzazione che i lettori
di “Storia in Rete” conoscono bene per le sue velenose derive sulla Wikipedia
inglese, il sito internet culturalmente più influente del mondo, dove gli italiani e
il loro retaggio storico culturale sono continuamente sotto attacco.
Per l’Italia vale l’icastica definizione che ne diede Marinetti durante la Grande
Guerra, in una celebre “tavola parolibera”, «Sintesi Futurista della Guerra”:
«Tutte le forze e tutte le debolezze del GENIO». Ma all’estero e in alcuni settori
nostrani sembra che prevalgano sempre e comunque solo le debolezze. Un vizio
antico. Anzi antichissimo. Vecchio di cinque secoli.
Paolo Sidoni