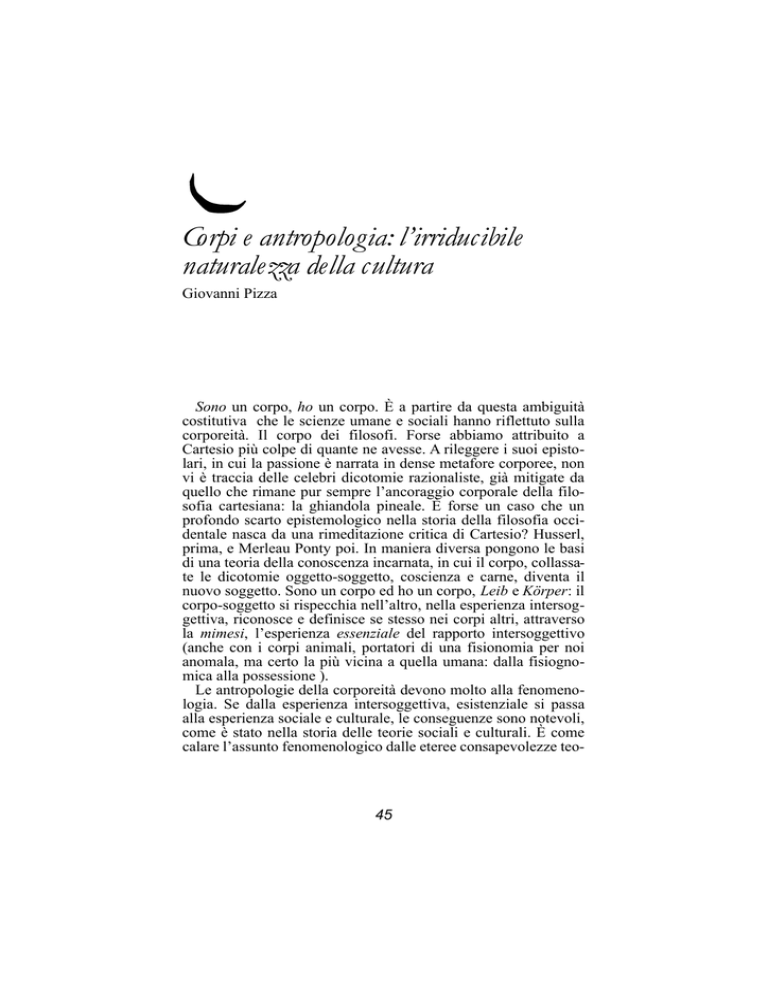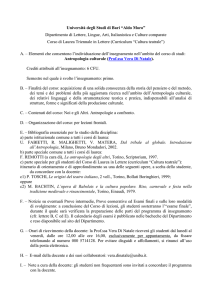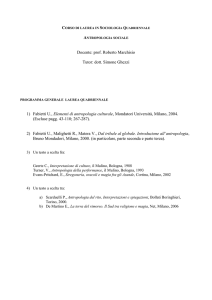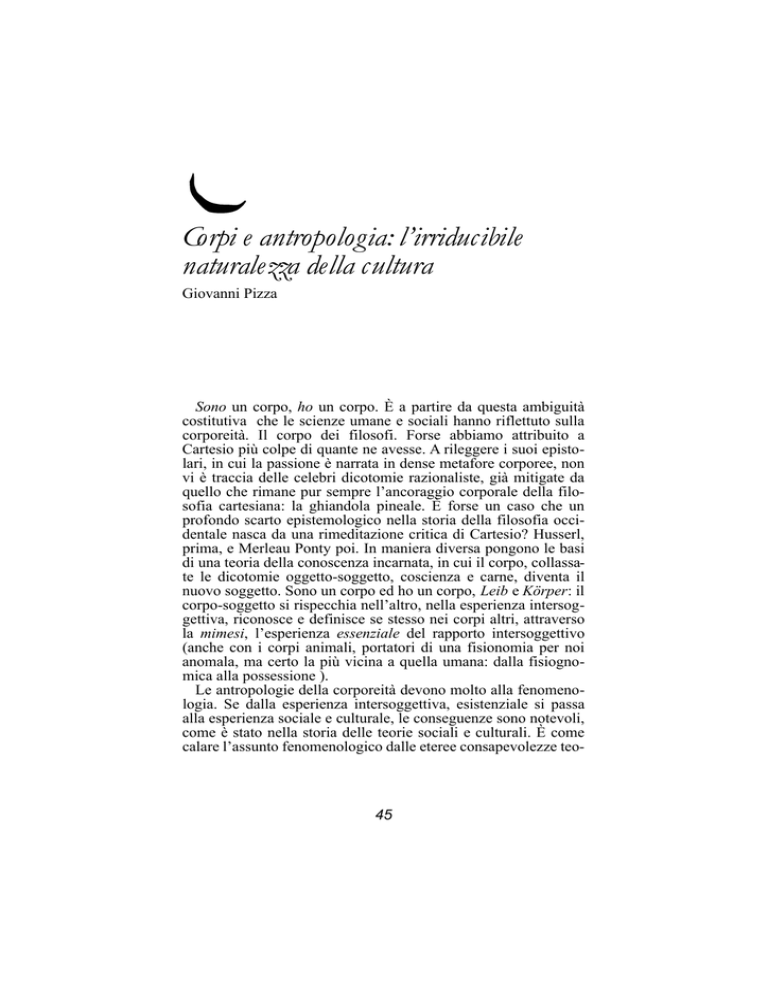
Corpi e antropologia: l’irriducibile
naturalezza della cultura
Giovanni Pizza
Sono un corpo, ho un corpo. È a partire da questa ambiguità
costitutiva che le scienze umane e sociali hanno riflettuto sulla
corporeità. Il corpo dei filosofi. Forse abbiamo attribuito a
Cartesio più colpe di quante ne avesse. A rileggere i suoi epistolari, in cui la passione è narrata in dense metafore corporee, non
vi è traccia delle celebri dicotomie razionaliste, già mitigate da
quello che rimane pur sempre l’ancoraggio corporale della filosofia cartesiana: la ghiandola pineale. È forse un caso che un
profondo scarto epistemologico nella storia della filosofia occidentale nasca da una rimeditazione critica di Cartesio? Husserl,
prima, e Merleau Ponty poi. In maniera diversa pongono le basi
di una teoria della conoscenza incarnata, in cui il corpo, collassate le dicotomie oggetto-soggetto, coscienza e carne, diventa il
nuovo soggetto. Sono un corpo ed ho un corpo, Leib e Körper: il
corpo-soggetto si rispecchia nell’altro, nella esperienza intersoggettiva, riconosce e definisce se stesso nei corpi altri, attraverso
la mimesi, l’esperienza essenziale del rapporto intersoggettivo
(anche con i corpi animali, portatori di una fisionomia per noi
anomala, ma certo la più vicina a quella umana: dalla fisiognomica alla possessione ).
Le antropologie della corporeità devono molto alla fenomenologia. Se dalla esperienza intersoggettiva, esistenziale si passa
alla esperienza sociale e culturale, le conseguenze sono notevoli,
come è stato nella storia delle teorie sociali e culturali. È come
calare l’assunto fenomenologico dalle eteree consapevolezze teo-
45
retiche alla conturbante umanità del processo storico e culturale,
incastrarlo nella storia delle tecniche dell’esistenza sociale.
Occorre, insomma, sporcarsi le mani. Non possiamo prescindere
dalla storia che è incorporata nei nostri organi. Se ne accorgeva
pionieristicamente nei primi anni trenta Marcel Mauss. Il suo
saggio su Le tecniche del corpo rimane un punto di partenza che
illumina l’enigma ambiguo e irriducibile della corporeità: l’intreccio, inestricabile, della dimensione naturale e culturale.
Eppure, se solo questa opposizione fosse stata intesa in maniera
meno radicale, se solo non si fossero messi di mezzo i volgarizzatori dello strutturalismo, una moltitudine di fedeli più fedeli
dello stesso maître, se solo ci si fosse fermati a Lévi-Strauss - saltando a piè pari il levistraussismo -, allora avremmo potuto fin
dall’inizio risparmiarci tanti dibattiti sul corpo “fra natura e cultura”. Ma la storia (del corpo) non si fa con i se. Ci era riuscito in
parte Josè Gil, autore della voce Corpo per l’Enciclopedia
Einaudi: il corpo come trasduttore di segni problematizzava
quella nozione di significante fluttuante che Lévi-Strauss aveva
elaborato proprio in margine all’opera del suo maestro Mauss.
Ma Gil non fu molto ascoltato. Erano più numerosi - e più forti coloro che criticavano il paradigma teorico di una separazione
corpo mente in nome di nuove fratture: no alla separazione corpo
mente, si a nuove scissioni quali natura e cultura, materiale e spirituale, tecnico e simbolico, e così via. Così dal corpo schizofrenicamente spezzato in naturale e culturale si è proceduto alla produzione dei corpi “multipli” della antropologia. Un solo elemento comune nelle antropologie della corporeità - che pure si contendono spazi discorsivi nel dibattito contemporaneo - è la
apprezzabile tendenza a considerare il corpo un prodotto storico,
facendo propria la lezione di Foucault. Ma poi ci si divide sulle
strade da seguire nella lettura della corporeità: approcci cognitivi, semiotici, simbolici, fenomenologici, politici, si fronteggiano
invece di integrarsi, con il risultato di produrre una sorta di “multicorpo” antropologico: da I due corpi di Mary Douglas, a I cin que corpi di ‘O Neill, passando per I tre corpi di Margareth
Locke e Nancy Scheper Hughes, ciascuno moltiplica il numero in
base agli aspetti che intende privilegiare nel proprio programma
teorico e di ricerca. E c’è anche chi, come Thomas Csordas, rifiuta il progetto di una antropologia del corpo per proporre, in nome
di un approccio definito di fenomenologia culturale, una antropologia dal corpo: antropologia definitivamente naturalizzata,
che rischia di negare ogni problema di conferimento di senso e di
46
significato riproponendo, stavolta a vantaggio della natura, la
dicotomia madre: Natura-Cultura.
Ma, mi chiedo, il corpo non indica forse quella dimensione
che, con un inevitabile ossimoro, possiamo definire la “naturalezza della cultura”? Sono napoletano. Gesticolare è per me
spontaneo, ma il mio gesto è naturale o culturale? De Jorio avrebbe detto che in un mio movimento della mano, in una espressione del viso, persino nella mia voce (cos’è la voce se non un gesto
fonetico che dal corpo risuona?), si scorgono le tracce di una
mimica antica. Mai come nel caso del classico di De Jorio sulla
mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano, la
metafora evoluzionista, biologica e storico-culturale, mostra un
inaspettato valore: non è il gesto la mia azione più storicamente
conformista, tradizionale e tradizionalista proprio quanto più pretende di essere spontaneamente naturale, trasgressiva rispetto al
codice delle buone maniere? Non è forse la naturalezza del gesto
la più autorevole spia di un sapere incorporato, appreso per esposizione e non per trasmissione, poiché sottratto al linguaggio,
assorbito direttamente dalla carne, rubato con gli occhi?
(L’anticonformismo del corpo è un ossimoro che le filosofie della
trasgressione e della liberazione corporea, dalla letteratura erotica ai “nuovi filosofi” fino alla vulgata [vetero-neo-post] femminista, si sono solo illuse di sciogliere). Nessuna metafora meccanica, nessuna idea di un automatismo del corpo macchina può dar
conto della magia dell’apprendimento corporeo. Né lo hanno
potuto in passato la fisiologia e la medicina (e ancor meno la loro
figlia ribelle: la psicoanalisi). Dall’altra parte il gesto non può
essere ridotto alla cultura, poiché esso è fisiologico, naturale.
Eppure il movimento che lo genera non è riducibile a spiegazioni scientifiche, anatomiche, fisiologiche, neurologiche. Il movimento del corpo è pura magia. Le teorie del cervello non possono ridurlo alla spiegazione, e se lo spiegano non possono che
operarne una riduzione. Il mistero della sindrome dell’arto fantasma, ancora vivo nell’immaginario percettivo del mutilato, è uno
degli studi di Merleau Ponty che più di altri avrebbe potuto suggerire la fallacia della opposizione natura cultura. Forse quelle
opposizioni che tanto hanno segnato anche il pensiero antropologico trovavano una inconscia motivazione nella cristiana frazione anima/corpo (non dimentico che l’antropologia è figlia
dell’Occidente cristiano, e non a caso essa è spesso stata una
antropologia religiosa). È vero, anche noi antropologi non possiamo non dirci cristiani, ma quale cristianesimo ha potuto fare a
47
meno del corpo? Non certo quello delle agiografie, e neanche le
teologie che, malgrado se stesse, hanno prodotto complesse teorie dell’anima, nozioni della persona riflesse, in ultima istanza, in
pratiche corporee: ha ragione Wittgenstein quando afferma che è
il corpo umano la migliore immagine dell’animo umano. Su questo punto egli era senz’altro più avanti di Mauss, il quale nel
momento in cui sosteneva l’importanza di una classificazione
culturale delle tecniche corporee, produceva una nuova separazione fra i concetti di corpo e persona, trattandoli in sezioni nettamente distinte della sua opera. Né il cristianesimo inteso come
sistema di pensiero e di pratica religiosa ha messo realmente in
opera tali separazioni così sbandierate sul piano ideologico istituzionale: il corpo è a fondamento della esperienza religiosa,
agìta nel rituale e narrata nel mito (o narrata nel rituale e agìta nel
mito, se si preferisce una lettura performativa di queste strutture
elementari della vita religiosa), e conferisce a tale esperienza la
materia di cui essa si compone e insieme la possibilità di essere
espressa, comunicata e, direi, vissuta, poiché è la corporeità il terreno esistenziale e passionale della cultura. Se prendiamo ad
esempio il processo di fabbricazione delle figure di santità ci
accorgiamo che esso è tutto interno al linguaggio corporeo,
performativamente drammatizzato nella magia dei prodigi corporali, una fisica e una fisiologia che si sperimentano nella macerazione ascetica o nel miracolo, nel superamento dei confini visibili, varcando le soglie fra il corpo, il mondo, l’invisibile, attraverso l’elaborazione di nuovi idiomi: la possessione, l’estasi, il
dialogo mistico.
Ma tutto questo non avviene alla lettera. Non ha senso a mio
avviso misurare con gli strumenti scientifici della biomedicina lo
stato alterato della coscienza della posseduta. E non perché non
lo si possa riscontrare. Ma perché anche quando se ne conoscesse la misura questa non potrebbe deterministicamente spiegarlo,
riducendolo a malattia o ad evento meccanico. È la passione della
metafora viva che lo rende pensabile, vivibile, rappresentabile,
comunicabile. È la demartiniana “autonomia simbolica” che lo
sottrae al determinismo naturalistico. Non possiamo negare la
metafora. Anche gli approcci fenomenologici, che tendono a
cogliere il corpo vissuto messo in ombra dal codice semiotico,
non possono coglierlo che attraverso la narrazione, il racconto,
intessuto di metafore. Né la metafora si genera unicamente nella
carne del corpo proprio, ma promana dalla profondità della storia
che le offre i termini da accostare in trasposizione. Se il corpo è
48
“tutto impresso di storia” (Foucault) occorre allora esplorare quei
complessi sistemi di senso che lo qualificano come prodotto storico e ne consentono la costruzione culturale e sociale.
L’antropologia del corpo si confronti dunque con la storiografia
della corporeità: non certo la storia dei mores corporei, ma quella delle figure e delle pratiche del corpo, ovvero dei modi di
costruzione della corporeità, intesa come processo in cui si
intrecciano in maniera inseparabile il pensiero e la vita, il senso
e l’azione. Se l’antropologia riscopre le basi corporee del concetto di cultura, la storiografia - almeno quella più sensibile alla
lezione di Foucault - illumina quel processo dialettico, insieme
sorvegliato e creativo, che definisce il gioco delle politiche e
delle poetiche del corpo e della sua costruzione culturale. È nel
rapporto fra storia e antropologia che si ripropone oggi il tema
gramsciano della egemonia e della sua critica, il tema attuale del
potere: il corpo “docile” o “resistente” ai processi egemonici è il
luogo in cui anche una antropologia dei dislivelli, delle circolarità, dei conflitti e delle connivenze culturali può ripensare se
stessa su nuove basi. Come accadeva all’ultimo de Martino, nelle
sue riletture critiche di Mauss e Merleau Ponty, o come accade in
alcuni dibattiti antropologici contemporanei, quando si riscopre
nella cultura popolare europea il bachtiniano “corpo grottesco”,
inteso come spazio creativo in cui si incarnano le commedie tragiche della marginalità e della miseria, o quando si preferisce,
allo studio delle rappresentazioni del corpo, l’ascolto dei suoi
racconti: le retoriche del corpo sofferente segnalano il crollo del
linguaggio, ma proprio nel momento in cui quel corpo s-figurato
dal dolore grida il fallimento della comunicazione non si sta protendendo forse verso nuove intenzionalità comunicative? Dalla
parola segno alla parola grido, il corpo si fa parola, o la parola
corpo. Storie umane, individuali o collettive, condivise o incondivisibili, che si offrono comunque a chi sappia ascoltare o sentire. Solo una pulsione autodistruttiva, una insana passione del
nulla, una macabra tensione verso la morte può spingerci a negare il valore della comunicazione, della condivisione, del senso.
Le poetiche del corpo vivente non contemplano il letteralismo.
Non è possibile oggettivare il corpo vivente, come difficile è
farlo con il cadavere (finché ci sarà qualcuno che lotti contro il
traffico d’organi o l’uso di salme nei crash tests) e con i corpi
cosiddetti inorganici (e se l’antropologia simbolica rivalutasse la
magia naturale? La “vita” degli oggetti, dell’”inorganico” non è
anche nell’assunto fenomenologico che li considera “predicati”
49
del soggetto? E anche questa consapevolezza fenomenologica,
non dovrebbe informare di sé la tradizione antropologica delle
varie etnoscienze, lo studio cioè dei saperi locali sul mondo naturale: dall’etnozoologia all’etnomineralogia?). Ci aveva provato il
pensiero greco classico a oggettivare il corpo, considerandolo la
“tomba” dello spirito, ma fu pura illusione; il pensiero classico
non riuscì certo a isolare il pensiero selvaggio, anzi, la costruzione del sapere medico e naturalistico greco mostrava le stesse levistraussiane “logiche del concreto” (basti pensare ai lavori di
Lloyd o agli studi degli antichisti francesi da Detienne a Vernant).
Né ci è riuscita la medicina occidentale, ereditando quella antica
pretesa: le antropologie del sapere medico hanno mostrato come
la storia della medicina si intrecci con quelle delle medicine
popolari così vicine al pensiero religioso come lo erano e lo sono
gli stessi saperi naturalistici tradizionali, inopportunamente divisi in colti e popolari. La stessa esperienza individuale del “corpo
proprio”, ha un ruolo fondante nel processo di formazione del
medico, che in tal modo è più vicino al guaritore e allo sciamano
di quanto non si creda, come hanno mostrato recenti lavori etnografici e antropologici sul “paradosso del medico malato”
(Emmanuelle Godeau). Nonostante i suoi sforzi secolari la medicina occidentale non è riuscita ad oggettivare il corpo: la carne si
ribella a ogni tentativo di reificazione, fornendo immagini eloquenti e incontestabili di questo rifiuto: l’arco della “isterica”,
l’urlo angoscioso del “folle”, figure di una critica incorporata
della egemonia medica sostanzialmente analoghe alle immagini
della posseduta o della strega, anch’esse figure di corpi che resistono alle egemonie religiose e morali. È un omaggio alla memoria di Ernesto de Martino che dovremmo fare un po’ tutti noi,
quando snoccioliamo alcune di queste apparenti consapevolezze.
La “tarantata” pugliese non è forse l’emblema di un corpo che
incarna la propria storia culturale ed esistenziale e la mette in
scena in una esecuzione letterale della metafora del morso del
ragno? Esecuzione di azioni che si offrono a uno sguardo che
possa comprenderle, realizzando nella condivisione un conferimento di senso a una drammatica esperienza di dolore.
Ogni tentativo di sfuggire alla rete dei simboli, di negare la
vitalità delle metafore, di rinunciare alla ricerca del senso, mi
pare contempli il rischio di una regressione al corpo cosa, di un
ritorno alla dicotomia oggetto-soggetto, di un passaggio al corpo
clinico. Il collasso delle dicotomie, dovrebbe condurre semmai
verso un riconoscimento della vita che permea la materia e non
50
della materia alla quale la vita debba ridursi.
Così come già la medicina, certo teatro contemporaneo si illude di trasformare il corpo in lettera, in retorica disincarnata, ottenendo come unico risultato un processo di neoreificazione che
ripropone il corpo clinico, peraltro ignorando Foucault. È il caso
del corpo anoressico, notomizzato, laparoscopizzato, del Giulio
Cesare messo in scena dai Raffaello Sanzio. Pensando di esplorare la lettera corporea si regredisce alla figura clinica mettendo
in scena corpi realmente anoressici, scegliendo volutamente attori laringectomizzati, proponendo lo spettacolo di una laringoscopia in diretta (perché non altre performances clinico-chirurgiche?). Non è certo nella pratica splatter dei performers postmoderni che si svenano in pubblico quella crudeltà del cui teatro
Artaud è stato il pensatore (il teatro di quella parola grido che
prima evocavo, parola corpo che rinuncia alla sua funzione
semiologica ma per assumere un valore di nuova intenzionalità
comunicativa proprio nel momento in cui svela e autodenuncia il
suo facile gioco). Così come il neofemminismo cyborg di Donna
Haraway non sembra aver fatto propria la straordinaria lezione di
Blade Runner, splendido film che inverte la prospettiva di questi
autori postmoderni: qui gli automi, i cosiddetti “lavori in pelle”,
svelano una inaspettata nostalgia dell’umano.
In fondo il corpo in sé non esiste, è nel gioco delle relazioni che
esso diviene pensabile, e queste operazioni culturali, pensando di
liberarsene, al contrario lo trasformano in cosa.
Ma il corpo che si fa parola e la parola che si fa corpo può servirsi solo della ironia, della magia, dell’arte, per mostrarsi sparendo e sparire mostrandosi. Come è nei controtempi ossimorici
della marionetta Totò (“Fermo con le mani!”). O nel teatro di due
grandi maestri cui siamo grati di essere loro contemporanei:
Carmelo Bene ovvero la Voce “che smerda se stessa” (come ha
scritto Pasolini), e Dario Fo, primo grandissimo e felice esempio
storico di un Nobel per la letteratura conferito alla parola-Corpo:
siamo forse a una nuova consapevolezza, una svolta nella cultura occidentale?
Post scriptum
Del corpo ho scritto. E mi chiedo: è da più di dieci anni che le
scienze umane e sociali si interrogano sulla scrittura come
maschera testuale, forma di mediazione riduttiva dell’esperienza
di cui essa tratta. E l’unica risposta sembra essere stata una
incoraggiata e consolatoria deriva letteraria. E se riflettessimo
51
invece sulla scrittura come tecnica del corpo? E se cercassimo,
insieme, nuove modalità, forme “sperimentali” di rappresenta zione? Potremmo mai escludere il nostro corpo dal gioco?
Potremmo cioè leggere il foglio e ignorare la mano che lo scri ve? E infine, ora che scrivo al computer, e magari invio questo
pezzo in”e-mail”, debbo rassegnarmi anch’io all’idea postmo derna di un corpo cyborg, un corpo nomade, che si estende o si
frammenta, secondo i punti di vista, nelle tecnologie delle reti
globali? Piuttosto sorrido, scorgendo il riflesso del mio volto
sullo schermo, le dita che battono sulla tastiera.
52