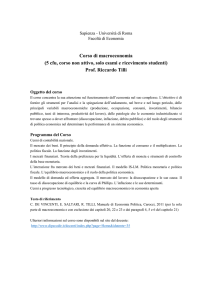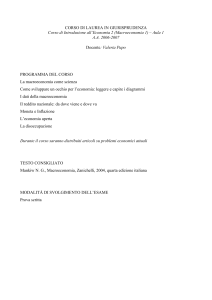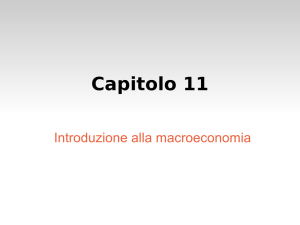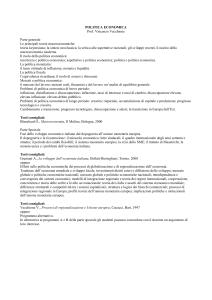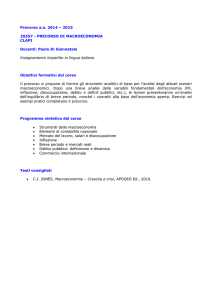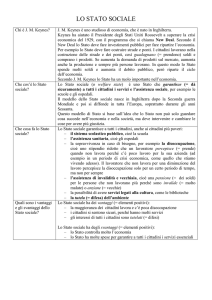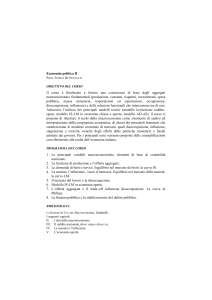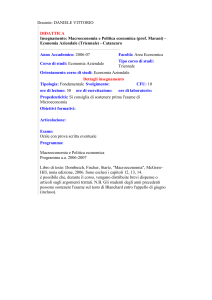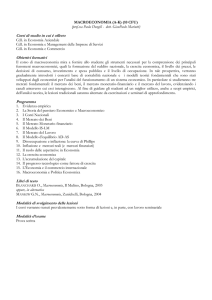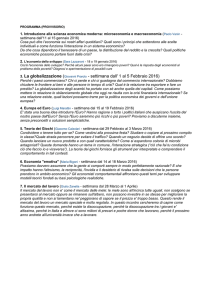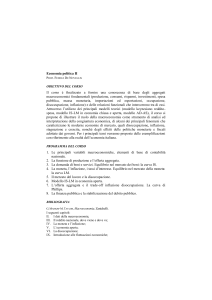L’ERRORE NELLE SCELTE DI MACROECONOMIA
Le idee generali e astratte sono la fonte dei più grandi errori dell’umanità
Rousseau, Émile (1762)
Sommario: 1. Introduzione – 2. La distinzione tra economia e politica – 3. Alcuni errori nelle teorie
macroeconomiche – 3.1 La politica economica e il laissez faire dei classici e dei neoclassici – 3.2 La
rivoluzione keynesiana – 3.3 Alcune posizioni recenti – 4. Errori non evitati nelle scelte di
macroeconomia – 4.1 In Italia – 4.2 In Europa – 4.3 Negli Stati Uniti – 4.4 In Asia – 4.5 In America
Latina – 4.6 In Africa – 5. Errori da evitare in Italia – 6. Opere citate
1. INTRODUZIONE
L’errore è l’esito di una falsa conoscenza della realtà. Diversamente, l’errore, secondo Spinoza1,
è una mancanza di cognizione. Tuttavia, se non è possibile condividere una percezione della realtà e
non si può attingere la verità, tutta la nostra conoscenza della realtà fenomenica2 è viziata dall’errore 3. E’
con questa consapevolezza che si affronta il compito arduo accettato in questo saggio.
Le cause di errore sono generalmente indicate nei limiti delle nostre percezioni sensoriali e della
capacità di gestirle oppure in fattori psicologici (la precipitazione, il pregiudizio, la tendenza al
conformismo e all’accettazione delle idee tradizionali, l’ambiguità del linguaggio, ecc.) che falsano i
nostri atti conoscitivi. Entrambe queste inadeguatezze ci inducono a considerare oggettivo il
fondamento soggettivo dei nostri giudizi, generando una difformità del pensiero dal suo oggetto.
Per Francesco Bacone l’intelletto umano ha la tendenza ad ammettere nella natura un ordine e
un’armonia senza provarli, anticipa con l’immaginazione quelle che dovrebbero essere le risultanze di
una paziente opera di ricerca, pretende di imporre alla realtà gli schemi del suo pensiero (idola mentis) e
di sopperire alle insufficienze dei suoi sensi con la fantasia (idola tribus), con i condizionamenti
dell’educazione (idola specus), del linguaggio (idola fori), dei pregiudizi (idola theatri)4.
Posta l’ineliminabilità dell’errore, l’idealismo e lo storicismo hanno impostato per la prima volta
il problema dell’errore non in termini psicologici, ma logici; ci si domanda quale sia il posto della
negatività, del limite nella vita del pensiero e dell’azione dell’uomo. L’errore è visto come un prodotto
dello spirito, un momento della verità senza il quale non ci sarebbe quello della positività. La realtà è
svolgimento nel quale il termine negativo, intrinseco al positivo, è come la molla del progresso. In
questo senso, la teoria smithiana della “mano invisibile” è, secondo Dobb, affine a quella di Hegel nella
Spinoza B., “De Mente”, Ethica more geometrico demonstrata, parte II, scolio della XXXV proposizione, trad. it. Torino, 1959.
Diversa è la situazione se ci si riferisce a una realtà formale.
3 Il concetto di errore assume significati diversi nelle diverse discipline. Nelle scienze sperimentali, l’errore è dato dalla
differenza tra il valore misurato di una determinata grandezza e il valore “vero” teorico calcolabile o non calcolabile. Vi sono
due tipi di errori, gli errori sistematici (che agiscono sempre nella stessa direzione) e gli errori casuali. Nella teoria dei
campioni troviamo l’errore campionario che prende il nome di errore casuale, di stima o di campionamento (la differenza
tra il valore vero di un parametro della popolazione e una sua stima costruita come funzione dei dati campionari e che si
riduce aumentando la numerosità del campione), e l’errore extracampionario o di rilevazione; nella teoria dei test troviamo
l’errore del I tipo (rifiuto dell’ipotesi nulla quando è vera) e l’errore del II tipo (accettazione dell’ipotesi nulla quando è falsa).
Nei modelli econometrici l’errore, misurato dalla differenza tra valore previsto e valore effettivo futuro, può dipendere da
errori di rilevazione dei dati, di specificazione, stocastici. Due studiosi di serie storiche, C.W.J. Granger e P. Newbold, hanno
osservato che i criteri classici di valutazione delle previsioni (per es. l’indice di ineguaglianza U di Theil) possono dare
risultati paradossali quando utilizzati per valutare errori di previsione generali di modelli dinamici. Gli stessi studiosi hanno
suggerito che, di fronte alla disponibilità di previsioni alternative di una stessa variabile, invece di ordinarle secondo un
qualche criterio, si può cercare di combinarle insieme ottenendo un’unica previsione come media ponderata di quelle
originali, calcolando i pesi in modo tale da rendere minima la varianza dell’errore di previsione).
4 Bacone F., Novum Organum, trad. it. a cura di Banfi A., Milano, 1951. In questa opera Bacone sostiene che il compito di
fondare la scienza consiste di due momenti: negativo l’uno, positivo e costruttivo l’altro.
1
2
1
proposizione secondo cui dalle azioni degli uomini deriva qualcosa di radicalmente diverso da ciò che
essi si propongono scientemente di ottenere5.
Di fatto ogni problema è condizionato da una particolare situazione e postula certe finalità
limitate. La consapevolezza dei limiti di un problema non può essere conquistata a priori, ma solo dopo
che quei limiti siano stati sperimentati attraverso la constatazione delle conseguenze e dei presupposti
falsi che avevamo accettati. Il riconoscimento della dialetticità del conoscere non implica nessuno
scetticismo o agnosticismo, nessuna sfiducia nella ragione, ma solo la consapevolezza del fatto che le
conquiste umane sono sempre fornite di un significato e di un valore finiti, condizionate (non
determinate) da situazioni storiche concrete particolari. Il significato e il valore dei pensieri e delle azioni
dell’uomo sono compresi nel loro limite solo in virtù dell’atto in cui quel limite viene riconosciuto e
superato da chi sia riuscito a porsi su un piano superiore a quello considerato. Tuttavia, la radice
ineliminabile dell’errore è l’essenzialità del limite al pensare e al fare dell’uomo. In questo senso, la
macroeconomia, che studia la struttura e l’andamento delle economie nazionali nel loro complesso6
attraverso le variabili economiche aggregate (come la produzione dell’economia nel suo insieme, o il
prezzo medio di tutti i beni), è il risultato di un incessante processo di costruzione e dell’interazione tra
idee ed eventi che ha dominato la riflessione degli economisti per alcuni secoli. Ciò che gli economisti
credono oggi è il risultato di un processo evolutivo nel corso del quale hanno eliminato alcune idee che
si sono rivelate sbagliate e hanno mantenuto quelle che sembravano spiegare meglio la realtà. Ma le
lezioni della storia e l’interazione tra idee ed eventi non sono tali da indurre un consenso ampio nella
professione. Ciò è dovuto a due motivi principali. Il primo riguarda l’importanza relativa degli obiettivi.
Il secondo riguarda la difficoltà di raggiungere una visione condivisa del funzionamento dell’economia7.
Occasionalmente, le revisioni del sistema teorico sono state indotte da eventi storici. E’ quanto
accadde, ad esempio, durante la Grande Depressione quando la teoria macroeconomia tradizionale si
rivelò incapace di spiegare la profondità e la durata della recessione e lasciò il campo alla rivoluzione
keynesiana. Per questa ragione, la storia della macroeconomia moderna inizia nel 1936, con la
pubblicazione della “Teoria Generale” di Keynes8. A parte questi momenti di svolta, alcuni eventi
inducono gli studiosi di macroeconomia a pensare di aver tralasciato alcune variabili cruciali o di aver
interpretato erroneamente il comportamento di altre. Questo accadde all’inizio degli anni settanta
quando molti paesi attraversarono quasi un decennio di stagnazione produttiva inaspettatamente
accompagnato da inflazione e per questo denominato stagflazione. La macroeconomia keynesiana non
trovò facilmente una risposta e i suoi modelli si sono confrontati prima con quelli monetaristi e poi con
quelli della nuova macroeconomia classica che hanno dato una spiegazione plausibile agli effetti degli
shocks di offerta, di domanda, e delle variazioni degli strumenti di politica economica.
E’ sempre difficile datare la nascita di un indirizzo ideale o di una tendenza del pensiero. La vera
novità reale può consistere tanto nel porre una nuova domanda o vecchie domande in forma nuova
quanto nel rinvenire una risposta convincente9. Per alcuni decenni, tra la fine del XIX e l’inizio del XX
secolo, lo spostamento d’accento sull’analisi di equilibrio particolare aveva indotto a concentrare
Vedi Dobb M., Storia del pensiero economico, Editori Riuniti, Roma, 1974, p.41
La macroeconomia studia anche le politiche che i governi utilizzano per tentare di migliorare i risultati ottenuti dalle loro
economie, i loro effetti e la validità relativa delle teorie a cui hanno riferito le loro scelte. Importanti temi macroeconomici
dello schema analitico tradizionale includono lo studio delle determinanti, nel breve, come nel lungo periodo, del consumo,
del risparmio, dell’investimento, della crescita economica di lungo periodo, dei cicli economici, della disoccupazione,
dell’inflazione, del commercio e dei prestiti internazionali. Un allargamento di questo schema contempera le differenze
istituzionali esistenti tra i diversi paesi e la trasmissione internazionale degli effetti delle politiche nazionali. Vedi Sachs J.D.,
Larrain F., Macroeconomia e politica economica, Il Mulino, Bologna, 1995, pp. 42-44
7 Vedi Blanchard O., Macroeconomia, Il Mulino, Bologna, 2000, p.27. Per sua natura la macroeconomia si concentra su grandi
problemi: gli effetti delle politiche economiche,
8 La macroeconomia utilizza una grande mole di dati. Non a caso la moderna economia potè svilupparsi in Europa negli
anni trenta quando gli statistici, sulla scia del suggerimento teorico keynesiano applicato alla Grande Depressione, iniziarono
una raccolta sistematica di questi dati. Tra queste statistiche, le più importanti per la macroeconomia sono state quelle della
contabilità nazionale. A partire dagli anni venti, negli Stati Uniti, contemporaneamente alla identificazione del ciclo
economico come fenomeno ricorrente, era iniziata la raccolta e la ricerca sistematica dei dati macroeconomici effettuata dalla
National Bureau of Economic Research con la direzione di Simon Kuznets. Vedi Sachs J.D., Larrain F., op. cit., 1995, pp.212 e 34-35.
9 Vedi Dobb, op.cit., p. 237.
5
6
2
l’attenzione sulla “microeconomia” escludendo, o ponendo in secondo piano, la più ampia
concatenazione delle interdipendenze e degli effetti che è basilare per la formazione delle
macrorelazioni10. Si osserva peraltro che le teorie macroeconomiche maggioritarie che attualmente si
confrontano - la nuova macroeconomia classica e la macroeconomia post-keynesiana - sono entrambe
il risultato di una rifondazione microeconomica. Tuttavia, l’impoverimento dell’ economia politica che
aveva allontanato gli economisti dall’analisi degli aggregati e dei loro rapporti, per concentrarsi sui
prodotti singoli e sui loro prezzi individuali, è stato messo in causa negli anni trenta del novecento
dall’opera di Keynes e dallo spostarsi dell’attenzione, dopo la seconda guerra mondiale, dalla statica di
Jevons alla teoria dello sviluppo11. Ma anche la ripresa d’interesse per gli economisti classici dell’età
ricardiana, che prese l’avvio con l’edizione delle opere di Ricardo da parte di Piero Sraffa 12, fu
strettamente connessa con lo spostamento dell’attenzione sui problemi “macroscopici”.
Lo scopo principale di questo saggio è quello di individuare alcuni errori delle teorie
macroeconomiche che, insieme agli errori di previsione, hanno influito negativamente nelle scelte di
macroeconomia dando luogo a perdite di benessere, come nel caso di crisi economiche, o hanno
impedito di contrastarle in modo adeguato. L’auspicio è che la riflessione sugli errori compiuti possa
contribuire ad evitarne qualcuno in futuro. Tuttavia, esiste, anche per gli errori nelle scelte di
macroeconomia, sia la possibilità di non rilevarli, sia, piuttosto, di farlo anche se non ci sono. In molti
casi ci si trova dinanzi a scelte che diventano erronee in presenza di alcuni presupposti o di alcune
condizioni e cessano di esserlo se questi cambiano. Vi sono errori che vengono accettati come mali
minori o in relazione a finalità superiori, che si compiono a causa di una struttura di incentivi a deviare
da scelte appropriate, che non è facile evitare se si vuole governare con una soglia minima di consenso
interno o che si devono accettare o subire in forza di un accordo o di una imposizione internazionale.
Anche se i grandi gruppi economici e finanziari hanno acquisito, soprattutto per la mancata
liberalizzazione dei mercati, un potere crescente di scelta politica che viene gradualmente sottratta ai
politici i quali sovente abdicano, in quanto mediatori degli interessi di gruppi, a scelte indipendenti di
macroeconomia nell’interesse generale.
2. LA DISTINZIONE TRA ECONOMIA E POLITICA
Un aspetto importante da considerare riguarda le implicazioni associate alla distinzione tra le
scienze superorganiche, qui esemplificata con riferimento all’economia e alla politica, per quanto
riguarda la scelta decisionale. Accade, infatti, che l’analisi economica sia confusa con le enunciazioni di
principi di politica e ciò rende pertinente considerare l’esame del loro carattere e della loro validità quale
parte integrante della scienza economica. Non si disputa sul fatto che la scienza economica dispieghi il
suo ambito sia su relazioni tecnologiche, che si stabiliscono tra uomo e mondo naturale, sia su relazioni
individuali e sociali, tra uomo e uomo. Né si ritiene che tali relazioni interagiscano in modo irrilevante o
che abbia senso studiarle separatamente secondo una specializzazione disciplinare. Tuttavia appare
opportuno evitare la confusione degli ambiti disciplinari qui descritti di economia e politica, e anzi se ne
discute l’opportunità metodologica. Non confondere significa distinguere, non separare. In questo
senso, si argomenta la possibilità di distinguere, pur non separandole, l’azione dall’intenzione e,
parallelamente, gli ambiti disciplinari di economia e politica.
La confusione dell’analisi economica con l’enunciazione di principi di politica può essere
valutata in base a due aspetti13. Il primo riguarda l’importanza relativa attribuita alle caratteristiche del
metodo scientifico positivo14, il secondo riguarda la titolarità dei compiti e quindi delle responsabilità sul
Di queste si erano invece occupati i classici la cui caratteristica peculiare era stata l’attenzione per la politica economica.
Vedi Dobb M., op. cit., p.168.
12 Vedi Sraffa P., Works and correspondence of David Ricardo, Cambridge, 1951.
13 Interessante, per quel che ci interessa, l’affermazione di Francesco Bacone: citius emergit veritas ex errore quam ex confusione.
Idem, op.cit.
14 Queste richiedono sia l’osservazione del fenomeno da cui si inducono le ipotesi di base e con cui si confrontano i risultati
da una parte, sia la coerenza formale del processo analitico attraverso il quale si deducono le tesi, dall’altra. Il fattore
discriminante di questa proposta metodologica consiste nel considerare la falsificabilità empirica e la falsificazione requisiti
solo formali, non sostanziali, per la scientificità delle teorie empirico -probabilistiche appartenenti a una disciplina.
10
11
3
“terreno proprio dei teoremi e dei consigli”15. La confusione suddetta, in quanto consente la
commistione di fenomeni empirici formalmente osservabili e non osservabili, viola in modo grave il
primo dei requisiti sostanziali e qualificanti del metodo positivo16. In secondo luogo tale commistione
non consente di distinguere con quali domande e con quali modalità il politico possa interrogare
l’economista.
Gli stessi strumenti analitici, anche se le proposizioni da essi derivate sono vincolate solo alla
coerenza formale, divengono positivi e sintetici se applicati a un contenuto empirico. In quanto positivi,
essi divengono anche ipotetici e soggettivi17 e tuttavia condizionano la scelta.
Per quanto riguarda la pertinenza della valutazione delle enunciazioni di politica alla scienza
economica, non si disputa qui sull’opportunità di enucleare, o di rendere espliciti, i criteri dai quali esse
sono state desunte nel tempo. Tuttavia, dopo aver espresso dubbi sull’opportunità che siano gli
economisti a desumere tali enunciazioni, si valuta anche l’opportunità che siano gli economisti ad
enucleare i criteri da cui esse sono desunte. Si conclude, infine, che il compito della valutazione delle
enunciazioni suddette non è pertinente alla scienza economica. I criteri cui si fa riferimento possono
essere intesi in due modi diversi, anche se non separabili, quello positivo e quello normativo. I primi, in
quanto determinano le regole secondo cui i dati empirici possono convalidare o meno una
proposizione, dovrebbero essere derivati dagli economisti. I secondi, in quanto individuano la norma su
cui si fondano i giudizi, le diverse linee di azione o di condotta in considerazione della valenza
metafisica che in parte li connota, dovrebbero essere derivati dai soggetti che hanno mandato per
farlo18.
Le argomentazioni esposte sulla inopportunità che l’economista enuclei criteri normativi e
desuma enunciazioni di politica, se convincenti, implicano che questo studioso si astenga anche dalla
valutazione di queste ultime. Infatti, anche se le motivazioni da cui dipendono le decisioni oggetto di
studio della politica, una volta attuate, danno luogo a dati osservabili, utili alla derivazioni di
proposizioni scientifiche, si ritiene che questo momento valutativo abbia un luogo elettivo nella scelta
decisionale.
Si delinea, a questo punto, una ulteriore distinzione che riguarda i due momenti interrelati della
valutazione dei modelli economici e della valutazione di misure alternative di politica economica. Il
primo dei due momenti riguarda la elaborazione e l’applicazione di criteri che valutino l’adeguatezza
della struttura proposta dall’economista, quale rappresentazione analogica della realtà economica da
utilizzare per un determinato scopo. Anche in questo caso è opportuno distinguere, nell’elaborazione
dei criteri positivi e dei criteri normativi, la divisione dei compiti dell’economista e del politico. Con
riferimento a questa distinzione si può individuare un insieme di interrogativi che il politico non può
porre all’economista. Essi sono determinati dall’osservazione che l’inferenza statistica non consente
all’economista, per coerenza e correttezza metodologica, di assumere, come nella consuetudine invece
avviene, diverse posizioni: 1. respingere, se non probabilisticamente, una proposizione; 2. scegliere tra
una proposizione “teoricamente” migliore e una “statisticamente” peggiore; 3. distinguere “buoni”
Si tratta di una ben nota distinzione di Luigi Einaudi.
Vedi Romagnoli G.C., “Falsificabilità e falsificazione nella scienza economica. Alcune riflessioni metodologiche”, Studi
Urbinati, n.B4, 1984-85, pp. 103-35.
17 Per questa ragione non si condivide la posizione contraria assunta e mantenuta da Schumpeter, secondo il quale l’analisi è
un antidoto dell’ideologia. Vedi Schumpeter J.A.,” Science and Ideology”, American Economic Review, marzo 1949, pp.345-59.
p.263 e Idem, Storia dell’analisi economica, edizione ridotta a cura di Napoleoni C., Boringhieri, Torino, 1968 (1° ed. 1954),
pp.37-8.
18 La complessità di valutazione dell’errore si evidenzia con l’osservazione di John Stuart Mill che prospetta l’impossibilità di
risolvere alcuna questione pratica soltanto in base a premesse economiche. Qui il riferimento è alla originale distinzione di
Mill: “…. tra le leggi della produzione della ricchezza, che sono leggi della natura, dipendenti dalle proprietà degli oggetti, e
le forme della distribuzione che, soggette ad alcune condizioni, dipendono dalla volontà umana”. Mill J.S., Essays on some
unsettled questions of political economy, London, 1844. In questo senso, si comprende il favore di Mill, che nasce liberista e muore
fabiano, “per un atteggiamento riformista dello Stato che deve erogare istruzione elementare gratuita, proteggere il lavoro
infantile, favorire la riduzione delle ore lavorative, controllare gli eccessi nell’esercizio della proprietà privata della terra,
fornire assistenza ai lavoratori temporaneamente senza occupazione a causa delle innovazioni tecnologiche, moderare lo
stesso ritmo del progresso tecnico, deliberare programmi di lavori pubblici nelle fasi di recessione ciclica”. Vedi Dobb M.,
op.cit., p.133.
15
16
4
economisti da “cattivi” economisti. Emergono, a questo punto, alcune questioni fondamentali per
l’applicazione dell’analisi economica. Esse riguardano il ruolo dell’economista e l’impotenza della
scienza economica davanti all’esigenza di compiere una selezione, visto che l’analisi economica, come
ogni altra scienza empirica superorganica, non è in grado di condannare una teoria, bensì soltanto la
eventuale violazione dei requisiti metodologici della sua derivazione. Da quanto affermato si evince che
l’economista non può isolare una teoria specifica, intesa come un insieme di proposizioni logicamente
determinato19, e offrirla al politico, come riferimento transitorio - anche se specificato dinamicamente -,
del suo comportamento decisionale. L’economista dovrebbe invece proporre al politico che lo
interroghi un ventaglio di modelli alternativi diversificati in corrispondenza all’uso. E’ invece compito e
responsabilità del politico scegliere, di volta in volta, a quale modello vincolare la massimizzazione della
sua funzione di preferenza.
Il secondo momento valutativo emerge in relazione alla necessità di tener conto delle variazioni
strutturali nel sistema delle preferenze e dei processi decisionali in presenza di nuove misure di politica
economica. Tale necessità richiede di adottare modelli strutturali alternativi che consentano di ottenere
previsioni condizionate20, oppure di valutare i risultati delle simulazioni tenendo conto degli intervalli di
confidenza degli stimatori. Non si ritengono, infatti, convincenti i tentativi di procedere sul sentiero
tradizionale del confronto dei risultati di un solo modello con la realtà osservata, utilizzando la
giustificazione – peraltro illusoria – che il suo orizzonte temporale operativo sia più breve del tempo
richiesto perché le variazioni strutturali abbiano luogo21.
Si ritiene peraltro fruttuosa, al fine di attenuare il problema delle deviazioni tra strutture “vere”
in tempi diversi, l’introduzione delle aspettative degli operatori a riguardo di variazioni annunciate nelle
prescrizioni di politica economica. Si sottolinea tuttavia l’opportunità, già espressa, che l’ipotesi di
razionalità sia derivata con le altre, da uniformità comportamentali osservate in condizioni simili,
piuttosto che dalla assolutizzazione di posizioni estreme. Tale orientamento, coerente con le
caratteristiche del metodo positivo descritto, non è compatibile pertanto con l’astratto processo di
selezione dinamico-competitiva di Friedman delle cui motivazioni ha fatto giustizia Joan Robinson22. Si
condivide, al contrario, che il comportamento egoistico è soltanto un caso particolare di razionalità pura
e tutt’altro che frutto di una conoscenza perfetta o di situazioni non osservate di equilibrio. La perdita
dell’homo oeconomicus rende orfana la razionalità economica e soprattutto la sottrae a un’etica
consequenziale. Crescono, nella letteratura economica, il consenso per l’abbandono dell’impostazione
riduzionista riferita all’homo oeconomicus e il riconoscimento dell’importanza, accanto al reddito, delle
capacità individuali e della loro realizzazione per il benessere individuale23.
3. ALCUNI ERRORI NELLE TEORIE MACROECONOMICHE
3.1 LA POLITICA ECONOMICA E IL LAISSEZ FAIRE DEI CLASSICI E DEI NEOCLASSICI
Gli sviluppi precedenti del pensiero filosofico e i mutamenti sociali pongono agli economisti
classici la questione di spiegare come il sistema sociale possa operare attraverso meccanismi appropriati
che possano funzionare indipendentemente dall’intervento statale. Il liberismo classico reagisce
all’ingerenza e all’interferenza statale che inibivano o soffocavano l’iniziativa individuale, impedendo
così la crescita economica. La concorrenza porta automaticamente all’equilibrio che rappresenta la
situazione più conveniente per la società. Il mercato appare autonomo rispetto allo Stato e alla società, e
La capacità previsiva di un insieme di proposizioni sintetiche positive è vincolata a un momento determinato del tempo.
Essa costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire la veridicità di una teoria. Vedi Boland L.A., The
Foundations of Economic Method, Allen and Unwin, London, 1982, pp. 102-4.
20 Vedi l’analisi di Lucas R.E., “Econometric Policy Evaluation: A Critique”, in Brunner K., Meltzer A.H. (eds.), The Phillips
Curve and Labor Markets, North Holland, Amsterdam, 1976, p.124.
21 Pertanto non è condivisibile questa posizione sostenuta da Hahn F. e Hollis M., “Introduction”, al volume da essi curato,
Philosophy and Economic Theory , Oxford University Press, Oxford, 1979, pp.1-17, in part. pp.8-9.
22 Vedi Robinson J., Economic Philosophy, Pelican Books, New York, 1978 (1° ed. 1962), pp.24-5.
23 Vedi Sen A.K., Commodities and capabilities, Oxford: Oxford U.P., 1985.
19
5
pertanto non ha bisogno di legittimazione da parte della società: esso si autolegittima. Questo nuovo
sistema è basato su due postulati (primo, ogni individuo è il miglior giudice dei propri bisogni; secondo,
la società è composta da un gruppo di individui e pertanto l’utilità sociale equivale alla somma delle
utilità individuali) e su un teorema (è la concorrenza che consente di trasformare il tornaconto
individuale nel massimo vantaggio sociale). Questo teorema non indica uno stato di natura, ma
piuttosto un sistema con una struttura ideale derivata dai postulati dell’economia classica24. Questo
teorema vale solo se lo Stato persegue una politica rivolta contro le posizioni di privilegio e fa in modo
che esse non si riproducano. Ma la concorrenza presente nel sistema capitalistico è diversa da quella
atomistica e Marx ha indicato che la concorrenza reale tende a distruggere la concorrenza.
Smith crede sia nel meccanismo di mercato sia nella capacità del governo di discernere e di
perseguire l’interesse generale. Mill conserva invece dei dubbi sul primo postulato ovvero sulla capacità
dei singoli di essere i migliori giudici del proprio benessere (qui un esempio rilevante è dato
dall’istruzione). In altre parole ci sono cose il cui valore non è ben misurato dalla domanda del mercato.
Il secondo postulato viene utilizzato per valutare gli effetti di interventi alternativi di politica sul
benessere economico, affinché il nuovo sistema veda il conseguimento di un’armonizzazione di
interessi (che non preesiste al sistema ma è prodotto da esso grazie all’azione di meccanismi
particolari).
L’attività economica che produce beni scambiati sul mercato va comunque lasciata alla libera
iniziativa individuale che produce il miglior risultato per la società. Mill sostiene che, in molti campi,
l’iniziativa pubblica anziché sostitutiva di quella privata, deve essere complementare. Ma a differenza di
Smith e Ricardo, Mill non teme lo stato stazionario che è comunque ritardabile attraverso l’esportazione
di capitali verso i paesi sottosviluppati finalizzata ad ottenere materie prime a basso costo. Al frenetico
interesse per il miglioramento della ricchezza aggregata egli preferisce una ricerca dei miglioramenti
possibili della qualità della vita.
Vi sono peraltro attività mirate alla fornitura di beni pubblici e rispetto a queste nascono due
problemi: quali siano le strutture economiche appropriate per produrli e come raccogliere le risorse
finanziarie necessarie, ricordando - con Ricardo e Malthus - i rischi di depressione economica o di
rinuncia ad aumenti di ricchezza e di accumulazione di capitale legati ad una tassazione eccessiva. Il
principio del bilancio in pareggio per lo Stato, che era stato all’origine del regime parlamentare, finirà
per essere abbandonato. Le funzioni dello Stato divengono quindi più ampie. Il problema della
distribuzione del reddito verrà associato al suo tasso di crescita e alla sua stabilità. Tuttavia Malthus, a
differenza di Smith e Ricardo, non considera il consumo improduttivo un fattore negativo per il
processo di crescita, e introduce una linea di pensiero destinata a guadagnare terreno un secolo dopo
con Keynes, che dà alla spesa pubblica una funzione autonoma aggiuntiva rispetto a quella di originare
la fornitura di beni pubblici.
Sul presupposto smithiano della lotta alla moltiplicazione delle rendite, Ricardo indicava
correttamente, al contrario di Malthus, un errore nelle leggi inglesi sul grano che prevedevano
l’applicazione di un dazio che proteggeva i proprietari terrieri a scapito dei consumatori e dell’industria,
e in definitiva dell’accumulazione. Anche se la dimostrazione che il libero commercio avrebbe
comportato benefici per tutti i paesi in nome della teoria dei vantaggi comparati assumeva
un’occupazione di pieno impiego e l’assenza di crisi di sovrapproduzione malthusiane. Su questa
diversità di ipotesi teoriche si fondavano inoltre posizioni ed errori opposti in relazione al problema del
finanziamento della spesa pubblica attraverso il debito pubblico, che era benvisto da Malthus e, al
contrario, malvisto da Ricardo sul fondamento erroneo della legge di Say, non valido in un’economia
monetaria, e sul teorema dell’equivalenza ricardiana25. Entrambi consideravano invece errori sia le leggi
Vedi a questo proposito l’ampia analisi contenuta in Lombardini S., “Lo Stato nel pensiero degli economisti classici” in
Finzi R. ( a cura di), Il ruolo dello Stato nel pensiero degli economisti, 1977, pp. 17-58, in part. p. 30 e sgg.
25 Vedi Blanchard O., op.cit., p.130-1. Questo teorema, ribattezzato negli anni settanta come teorema di Barro-Ricardo,
afferma che né il disavanzo né il debito hanno effetti sull’attività economica (spesa per consumi, risparmio nazionale, spesa
per investimenti, saldo delle partite correnti) se si tiene conto del vincolo di bilancio del governo. In effetti l’evidenza
empirica recente per gli Stati Uniti ha suggerito che l’aumento del disavanzo pubblico non è stato accompagnato da un
corrispondente aumento del risparmio privato. Vedi Blanchard O., op.cit., pp. 516-19. Ma questo fenomeno può essere
spiegato sia dalla presenza di vincoli cogenti all’indebitamento che dalla differenza tra l’orizzonte temporale del settore
24
6
sui poveri che la costituzione dei sindacati, perché interferivano con la determinazione spontanea del
livello dei salari provocando distorsioni sull’impiego delle risorse e stimolando l’incremento della
popolazione.
Oggetto di contrasto fu anche la scelta annosa, e attualissima, tra regole fisse e discrezionalità
politica che divise Ricardo, che aderiva alla teoria quantitativa, e Thornton che operava una corretta
distinzione tra cause interne ed esterne di variazione delle riserve della banca centrale e riconosceva gli
effetti sulle grandezze reali dei cambiamenti nella quantità di moneta, ovviamente senza distinguere tra
breve e lungo periodo. Allora prevalse l’ortodossia di Ricardo sull’eresia di Thornton26.
Il dibattito tra economisti classici e neoclassici si svolge soprattutto con riguardo alle questioni
del valore, dei salari, del capitale, della distribuzione, dei prezzi, del protezionismo e delle crisi
economiche. E’ stato osservato che oggi la ricerca di una misura concettuale o di un modello invariabile
del valore può apparire priva di senso e tuttavia il peso assunto nel dibattito economico sulle questioni
della misurazione del capitale e dell’influsso della distribuzione sui prezzi dovrebbe riportare
l’attenzione sulla ricerca ricardiana27. Questa convinzione è tuttavia discutibile se invece si accetta l’idea
neoclassica che il valore è soggettivo28 e che il valore d’uso di un bene ne determina il valore di
scambio29. In questo caso, la differenza tra valore e prezzo è determinata dalla disponibilità a pagare
rappresentata dal surplus del consumatore e non, come viene affermato da Ricardo e dai suoi epigoni,
da differenti strutture di capitale.
Smith misura il valore attraverso la “teoria addizionale delle componenti”, sicché Marx dice che
Smith calcola il valore naturale “mediante l’addizione dei prezzi naturali del salario, del profitto, e della
rendita fondiaria”30, mentre Ricardo rimprovera giustamente a Smith la confusione tra salario e quantità
di lavoro, ossia tra “lavoro comandato” e “lavoro contenuto”, come misura del valore. Per Smith,
profitto e rendita vengono indicati implicitamente come detrazioni da quello che è naturalmente
considerato il prodotto del lavoro. Riguardo al profitto, Smith afferma che anch’esso è condizionato
dalla situazione d’incremento o di decadenza della ricchezza della società ma in modo opposto. Perciò
l’aumento del capitale che eleva il salario tende ad abbassare il profitto, come pure la concorrenza tra
commercianti31. Sotto l’influenza della filosofia giusnaturalistica, di tipo lockiano, per la quale il lavoro
dà diritto alla proprietà del proprio prodotto, Smith ha aperto la via a una teoria residuale dei salari nota
come teoria del fondo salari. I lavoratori producono l’intero prodotto ma debbono subire alcune
deduzioni per il profitto e la rendita. Pertanto la teoria della detrazione si può interpretare all’interno di
una teoria giusnaturalistica o al contrario come teoria embrionale dello sfruttamento e del plusvalore di
cui fa parte, oltre a profitto e rendita, anche l’interesse32. In questo senso, Borkiewicz ha parlato di una
teoria della deduzione preferendo tale designazione a quella di sfruttamento33.
Per Ricardo, invece, i profitti tendono a scendere nella misura in cui aumentano il capitale e la
popolazione, per effetto della produttività decrescente del lavoro, dovuta all’estensione della
coltivazione. Con la caduta dei profitti Ricardo vede approssimarsi anche lo stato stazionario e la fine
del progresso34. Ricardo sostiene, al contrario di Smith, che un aumento dei salari non innalza i prezzi
bensì contrae i profitti ma, in questo caso, non si preoccupa dell’avvento dello stato stazionario. Ha
pubblico, che dovrebbe essere maggiore rispetto a quello degli operatori. Nel primo caso, il teorema dell’equivalenza
ricardiana non è valido e il deficit di bilancio causato da una diminuzione delle entrate fiscali ha effetti reali.Vedi Abel A.B.,
Bernanke B.S., Macroeconomia, Il Mulino, Bologna, 1994, p.331. Nel secondo caso, le generazioni non gravate dai futuri
aumenti delle imposte modificheranno le loro decisioni intertemporali di consumo, di risparmio e di investimento. Vedi
Sachs J.D., Larrain F., op. cit., p.331.
26 Vedi Dobb M., op.cit. p.139
27 Ibidem, p.82
28 Ibidem, p.163
29 Ibidem, p.176
30 Ibidem, p. 49n.
31 Ibidem, p.54.
32 Ibidem, p.143. La previsione mancata delle indicazioni pessimiste ricardiane per il futuro è stata giudicata un esempio
negativo salutare per evitare lunghe serie di ragionamenti deduttivi. Ibidem, p.87.
33 Ibidem, p. 49n.
34 Ibidem, p.71 e 82.
7
così origine, in contrasto alla teoria del fondo salari, l’idea del salario variabile indipendente e del
profitto inteso come variabile residuale35.
La dottrina milliana del fondo salari, inteso come entità indipendente e predeterminata, si
presenta con la semplicità e la forza di un truismo aritmetico36. Tuttavia, nella ritrattazione successiva
della sua tesi, Mill riconosce che non esiste una legge di natura che impedisca ai salari di crescere oltre i
fondi che l’imprenditore ha inteso destinare alla prosecuzione della sua attività, fino al punto di
assorbire tutto ciò che egli riserva per le sue spese private al di là della semplice sussistenza. Il limite
reale all’aumento dei salari è la considerazione, da parte dell’imprenditore, che quest’aumento può
condurlo alla rovina o costringerlo ad abbandonare la sua attività. Tuttavia, per Mill, l’auspicato
miglioramento della distribuzione del reddito è legato a una situazione in cui “la popolazione
rappresenti un rapporto progressivamente decrescente rispetto al capitale e all’occupazione”37.
Marx mostra l’analogia tra il capitalismo e le forme precedenti di società circa l’appropriazione
di un surplus da parte di persone che non partecipano all’attività produttiva. Egli mostra l’analogia che
esiste tra situazioni in cui l’appropriazione di plusvalore38 o di plusprodotto è sancita politicamente, con
la forza militare o per via legale, o in cui è riconosciuta di fatto, come accade nella forma specificamente
capitalistica di sfruttamento. Il problema propriamente economico è nel conciliarla con la legge del
valore, nello spiegare cioè come essa si verifichi nel regno della concorrenza dove ogni cosa è scambiata
secondo il suo “valore naturale”39. Dato il saggio di plusvalore, o il grado di sfruttamento, il saggio di
profitto è tanto più alto quanto più breve è il tempo di rotazione del capitale variabile e tanto più basso
quanto più alto è il rapporto tra capitale fisso e capitale variabile, ovvero quanto più alta è la
composizione organica del capitale. Marx fornisce la sua risposta al problema classico della cosiddetta
tendenza alla caduta del saggio di profitto e alla determinazione delle crisi economiche periodiche. Se le
differenze nella composizione organica del capitale provocano una “redistribuzione” del plusvalore tra
le industrie in proporzione al capitale, è ragionevole supporre che i mutamenti di tale composizione
possano risolversi nel lungo termine in mutamenti del saggio di profitto. Per spiegare lo stato
stazionario, al ricorso di Ricardo ai rendimenti decrescenti, Marx sostituisce l’effetto che il progresso
tecnico esplica sull’andamento del capitale fisso in rapporto al lavoro salariato, che comprime il saggio
di profitto realizzabile con un determinato saggio di plusvalore40. La teoria dell’utilità marginale di
Jevons, secondo John Maurice Clark, fu una risposta diretta all’opera di Marx. Le teorie marginaliste
“…colpiscono alla radice la dottrina marxiana del plusvalore, in quanto fondano il valore sull’utilità,
invece che sul costo del lavoro, e forniscono un’alternativa a qualsiasi dottrina dello sfruttamento,
marxiana o di altro tipo, con la tesi che tutti i fattori della produzione…ricevono un compenso
proporzionale al contributo da essi fornito alla produzione”41. A proposito del lavoro, Jevons affermò,
in modo convincente, che “il suo valore deve essere determinato dal prodotto e non il valore del
prodotto da quello del lavoro”, mentre, sempre secondo questo studioso, il concetto di capitale come
“anticipo” implica una dimensione temporale: il periodo di tempo per cui l’anticipo viene fatto, o
“periodo di produzione”. Ma la tesi di Clark è manifestamente erronea in una realtà dei mercati che non
Ibidem, p.78. Il profitto invece dipende dal grado di monopolio sul mercato dei prodotti e sul mercato del lavoro in linea
con l’osservazione di Kalecki. Vedi Dobb M., op.cit., p.214.
36 W=C/L (dove W è il salario, C, il fondo di beni di sussistenza per gli operai, L, il numero degli operai). In questo senso, la
teoria milliana è stata considerata una drastica risposta alle pretese dei sindacati di agire sul livello generale dei salari. Vedi
Dobb M. op. cit., pp.129-30.
37 Ibidem, p.133.
38 Il plusvalore coincide con “il lavoro non pagato” p, ovvero con le ore lavorate in eccesso alla reintegrazione di tutti i beni
corrisposti al lavoratore, ovvero il capitale variabile che gli è stato anticipato v. Per questo i lavoratori vengono sfruttati al
saggio p/v che ovviamente non è il tasso d’interesse che invece è pari a p/(c+v), dove c indica il capitale costante. Il
plusvalore è guadagno gratuito del capitalista che espanderà la produzione fino a che il plusvalore cade a zero. Il saggio
decrescente del profitto era spiegato da Marx con due proposizioni: a) la produzione che si meccanizza fa aumentare il
capitale costante rispetto a quello variabile; b) solo il capitale variabile (capitale-salari produce plusvalore). Vedi Schumpeter
J.A., Storia…cit., pp.131-35.
39 Ibidem, p.139.
40 Ibidem, p.153. Qui vi è da ricordare la correzione dell’errore compiuto da Ricardo, effettuata prima da Mill e poi da Marx,
per aver ignorato il “capitale costante” come fattore per la determinazione del saggio di profitto, e di aver identificato così il
profitto col plusvalore. Ibidem, pp.124-6.
41 Ibidem, p.161.
35
8
operano in regime di concorrenza perfetta. Pertanto le teorie marginaliste non inficiano la teoria del
plusvalore di Marx. Esse prefigurano la visione walrasiana dell’economia concepita come un cosmo che
consiste di quantità interdipendenti con l’idea di un equilibrio economico generale insediata al centro
della teoria causale42 che però rimane una concezione astratta di interdipendenza di tutti i prezzi in un
mercato concorrenziale. Pareto assocerà a questa posizione il corollario dell’ottimizzazione e il teorema
della corrispondenza tra equilibri competitivi e posizioni di ottimo paretiano sarà in seguito dimostrato
rigorosamente da Arrow e Debreu.
Come nota Dobb, i guai cominciano non appena l’ottimo paretiano viene identificato con
l’equilibrio raggiunto in condizioni di concorrenza perfetta. Di colpo intervengono errori e confusioni.
La conclusione che quando sono soddisfatte le condizioni per l’ottimo paretiano le quantità prodotte
sono tali da massimizzare il benessere sociale, è in genere sbagliata perché quelle eguaglianze che si
realizzano per ogni produttore e per ogni consumatore non possono essere aggregate. Ogni
aggregazione di questo tipo (per esempio in una curva di indifferenza sociale) dipende dalla
distribuzione del reddito monetario43, nel senso che l’utilità marginale della spesa (o l’utilità marginale
del reddito) differisce tra individui con reddito diverso, e quindi ogni processo di aggregazione
comporta una valutazione delle varie situazioni individuali sulla base di tali differenze. Oppure, ove la
logica della negazione delle comparazioni interpersonali non consenta di parlare di tali differenze, non si
deve dir niente su tale aggregazione. Ecco l’errore in cui sono caduti i “nuovi economisti del benessere”
nel tentativo di dimostrare la natura ottimale dei risultati della concorrenza perfetta in un sistema di
libero mercato44. Si tratta dell’errore della sovranità del consumatore. La domanda, l’offerta e l’equilibrio
sono concetti utili per esprimere relazioni quantitative nell’ambito dell’insieme di beni e servizi. Ma se
insistiamo a voler applicare i termini domanda e offerta agli aggregati sociali, dobbiamo ricordare che
questa domanda e questa offerta sono interdipendenti l’una dall’altra.
Sul grande quesito che riguarda la direzione di causalità tra distribuzione e prezzi, si osserva che
se l’influenza dei prezzi sulla distribuzione è innegabile (come esito di salari residuali, del profitto
variabile indipendente e di una teoria del valore soggettivo), lo è anche la dipendenza dell’utilizzazione
del reddito dalla sua distribuzione. Nella seconda edizione del suo libro45 Jevons formula quella
singolare sintesi della sua teoria su cui dovevano appuntarsi le critiche di Marshall: “il costo di
produzione determina l’offerta; l’offerta determina il grado finale di utilità; il grado finale di utilità
determina il valore”. Marshall non rilevò la presenza di un problema di aggregazione annidato nella
seconda parte della proposizione di Jevons e commentò che essa equivaleva ad affermare che il costo di
produzione determina il valore. Molto probabilmente ciò che Jevons intendeva dire era che in
concorrenza perfetta il costo di produzione determina il valore di scambio e quindi il prezzo di un bene.
Dopo aver esposto la sua concezione della “determinazione reciproca” tra “prezzo di offerta, prezzo di
domanda e quantità prodotta” (che Marshall giustamente considera come l’obiezione più importante
alla definizione jevonsiana), lo stesso Marshall propone un’inversione dell’ordine fissato da Jevons:
“L’utilità determina la quantità che deve essere offerta; la quantità che deve essere offerta determina il
costo di produzione; il costo di produzione determina il valore, in quanto determina il prezzo di offerta
necessario perché i produttori possano continuare a produrre”46. Malgrado la buona intenzione, anche
la proposizione di Marshall non è convincente perché è astratta, oltre ad essere viziata da un problema
di aggregazione nella prima parte. Una implicazione della proposizione di Jevons è che il prezzo dei
beni capitali non cambia con la distribuzione; quindi il capitale può essere concepito come il valore dei
beni capitali e come fattore che ha come prezzo del suo servizio il saggio di interesse.
E’ stato osservato che, quando i salari aumentano e i profitti diminuiscono, una tecnica può
essere sostituita con un’altra a più alta intensità di capitale, senonché a un livello salariale ancora più alto
Vedi Schumpeter J. A., Storia…..cit., pp.195-6 e 422.
E’ interessante ricordare che è con riferimento a diverse alternative di distribuzione del reddito che si affrontano i
problemi della costruzione delle curve di indifferenza collettive e della derivazione di una funzione del benessere sociale
dalle preferenze individuali.
44 Vedi Dobb M., op.cit., p.233.
45 Vedi Jevons W., Theory of political economy, Second Edition, London, 1879.
46 Vedi Dobb M., op. cit., p.177-8.
42
43
9
(e quindi con un saggio di profitto ancora più basso)47. Ma è difficile che la tecnica abbandonata possa
tornare ad essere meno costosa, se si tiene conto dei costi irrecuperabili del capitale inutilizzato a causa
di questo ritorno. Le relazioni di prezzo sono esse stesse correlate in larga misura alla distribuzione del
reddito e cambiano pertanto col variare del rapporto profitto-salario48. In questo senso, salari diversi e
tassi d’interesse diversi possono modificare i prezzi delle merci e dei beni capitale. I prezzi relativi
risultano indipendenti dalla struttura del consumo e della domanda49 perché dipendono dai costi di
produzione e dal potere relativo di mercato dei singoli settori. Il ricorso sraffiano alla “riduzione al
lavoro datato” del costo o del prezzo finale di una merce è utile per capire come si forma il valore–
lavoro, che spiega il valore di scambio nella teoria di Ricardo, a sua volta funzionale alla teoria del
plusvalore di Marx50; tuttavia, la teoria di Sraffa non invalida, in assenza di un “ritorno delle tecniche”,
il metodo del “periodo di produzione” come misura della quantità di capitale che può essere usata. Ciò
rende possibile combinare i periodi delle varie prestazioni di lavoro in un’unica grandezza che si può
assumere come rappresentativa della quantità di capitale51.
Un altro tema importante nel dibattito dell’economia classica ha riguardato la teoria del
commercio internazionale sulla quale i contributi fondamentali vanno dalla teoria dei vantaggi assoluti
di Smith, che incoraggia i governi all’apertura dei mercati, a quella dei costi comparati di Ricardo, che
generalizza i benefici del commercio internazionale, alla giustificazione milliana del protezionismo
sull’argomento delle industrie nascenti, che indica ai governi l’unico modo di entrare in mercati nuovi.
Ognuna di esse è nata, come è noto, dalla rilevazione di limiti ed errori nelle teorie precedenti, anche se
innovative, ma la tesi di Mill è profetica e di grande momento sia perché, ai suoi tempi, i costi di
trasporto costituivano ancora una barriera naturale al commercio internazionale52 sia per la sua grande
attualità nella spiegazione di molti errori futuri non evitati nelle scelte di macroeconomia. In assenza
della protezione delle industrie nascenti, l’apertura al commercio internazionale si coniugava, allora, alla
teoria della produttività decrescente e all’atteggiamento sfavorevole all’incremento demografico.
L’atteggiamento opposto a questo, in quanto originato da motivi economici, implica la convinzione che
l’aumento della popolazione accrescerà (entro certi limiti) la ricchezza individuale; implica, cioè, la
convinzione che agisca la “produttività crescente” riferita all’economia nazionale nel suo complesso53.
Questa stessa convinzione è esplicita nell’atteggiamento favorevole al protezionismo. Infatti il
protezionismo contrae gli scambi internazionali a favore della produzione interna. Con rendimenti di
scala crescenti54, il commercio reciprocamente vantaggioso può aver luogo anche quando i due paesi
sono identici sotto ogni aspetto, ma la convenienza dello scambio non è condizionata da questa
identità. La presenza di economie di scala determina condizioni di monopolio o di oligopolio nell’intero
mercato. Sraffa dimostrerà che, in condizioni di concorrenza perfetta, un’impresa non può essere in
equilibrio perfetto finché l’incremento nella sua produzione sia accompagnato da economie interne. Ma
l’equilibrio si raggiunge quando l’intera domanda è stata soddisfatta.
Ibidem, pp.241-2.
Ibidem, pp.242-3.
49 Ibidem, p.246.
50 Ibidem, p. 154.
51 Ibidem., p.243. Questa considerazione consente di criticare la posizione di Joan Robinson che aveva messo in questione il
concetto di capitale come grandezza indipendente dal reddito sui concreti beni capitali. Per questa ragione la Robinson
aveva abbandonato il concetto di “funzione di produzione” continua (in favore della nozione di uno “spectrum di tecniche”)
e insieme il concetto di capitale come grandezza. Se i saggi del profitto o le tecniche di produzione o entrambi gli elementi
sono differenti, la valutazione di uno stock di beni capitali è impossibile in linea di principio (vedi Robinson J., Accumulation
of Capital, London, 1956), ma possibile attraverso il prezzo dei beni capitali.
52 Il grado di commerciabilità di un bene dipende essenzialmente da due fattori: i costi di trasporto e il grado di
protezionismo.
53 Vedi Dobb M., op.cit ., p.144. Questa posizione è in contrasto con quella espressa da molti economisti classici e,
successivamente, da Kalecki secondo cui l’aumento della popolazione non costituisce uno stimolo allo sviluppo se non sono
disponibili grandi riserve di lavoro. Ibidem, p.222n. Questa posizione non è condivisibile per due ragioni: 1. non tiene conto
dell’aumento delle unità di lavoro effettivo disponibili nell’economia; 2. non tiene conto dei rendimenti crescenti.
54 E’ la situazione della produzione in cui la quantità prodotta cresce più che proporzionalmente rispetto alla crescita dei
fattori di produzione a causa di una maggiore divisione del lavoro e di una più elevata specializzazione interni all’impresa e
favoriti dalla dimensione della produzione che diminuiscono i costi medi.
47
48
10
Tuttavia se lo sviluppo delle forze produttive giustifica l’interesse per un regime di libertà
economica, gli imprenditori tentano di raggiungere posizioni di monopolio e gruppi d’interesse forti
tendono ad interferire con le attività dello Stato. Per risolvere questa contraddizione si dà allo Stato un
potere sovrano affinché lo usi per mantenere un sistema concorrenziale. Per gli economisti classici ci
sono comunque delle funzioni (ad esempio quelle monetarie e fiscali) che non possono essere lasciate al
mercato e vanno esercitate dallo Stato indipendentemente da i singoli individui.
Ciò che di fatto consente, secondo i classici, di armonizzare interessi privati e pubblici è
comunque l’operare della libera concorrenza. Si spiega così il giudizio negativo di Smith nei confronti
dei sistemi di politica economica di derivazione mercantilista e fisiocratica55. Solo il conflitto con le tre
finalità istituzionali dello Stato - difesa (inclusa quella della proprietà), giustizia (inclusa la garanzia degli
adempimenti contrattuali), opere pubbliche - consente una deroga ai principi del liberismo economico.
Pertanto nel programma di politica economica smithiano si consente l’applicazione dei dazi come
misura di rappresaglia contro terzi, la protezione delle industrie nascenti, l’indicazione di un tetto
massimo all’interesse per impedire l’usura, la fissazione del prezzo del pane se nella sua produzione
prevalgono condizioni di monopolio. Tuttavia Smith indica un errore nella moltiplicazione delle rendite
che riducono i profitti favorendo lo stato stazionario, in cui si interrompe l’accumulazione del capitale.
Anche se sottostima, in questo modo, l’effetto recessivo corrispondente a una stasi degli investimenti.
Gli economisti classici avevano ben presente che le attività svolte dallo Stato sono diverse da paese a
paese e di conseguenza anche la raccolta di risorse finanziarie. La funzione fondamentale dello Stato
rimaneva comunque quella di creare le condizioni affinché la concorrenza si diffondesse insieme ai
benefici ad essa associati. Tuttavia se gli economisti classici inglesi propongono politiche di laissez faire,56
seppure con qualche eccezione, gli economisti tedeschi rifiutano il libero scambio tra le nazioni e fra
essi Federico List, in particolare, sottolinea un limite della teoria economica classica nella sua
disattenzione alle condizioni iniziali dello sviluppo dei diversi paesi. Pertanto la Germania vede
coniugare una politica liberistica all’interno con una politica protezionistica all’estero.
In altri paesi lo Stato dovrà intervenire ancor più direttamente per promuovere lo sviluppo
industriale e scongiurare le crisi economiche, creando i presupposti per il più recente dibattito tra
fallimenti del mercato e fallimenti del non mercato. Le crisi economiche costituiscono un fenomeno
costante dello sviluppo del sistema economico e ne caratterizzano l’evoluzione storica. Le crisi sono
generalmente caratterizzate da una flessione del livello produttivo, aumento della disoccupazione,
moltiplicazione dei fallimenti e da una generale diminuzione dei prezzi. Sovente si autoalimentano
attraverso una esportazione del ciclo e possono prolungarsi per un periodo più o meno lungo finché
non interviene uno shock che spezza la spirale recessiva. Le spiegazioni di questo fenomeno, avanzate da
vari studiosi, sono diverse a seconda della loro appartenenza a grandi correnti del pensiero economico57.
Per i Classici le crisi economiche sono dovute a fattori umani che alterano il libero gioco dei
meccanismi naturali di autoregolamentazione del sistema economico. Per fattori umani si intendono sia
l’azione di individui viziata da errori di previsione, che l’azione di pubblici poteri, viziata da ritardi,
nelle politiche anticicliche tradizionali. Tuttavia, l’analisi classica appare più come una difesa della
Contrariamente alla logica mercantilista del beggar thy neighbour policy e a quella fisiocratica classista che vede nel consumo
dei proprietari terrieri l’unico stimolo a incrementare la produzione e la ricchezza, Smith loda la parsimonia e la frugalità
perché il risparmio è la fonte dell’accumulazione ed è questa, a sua volta, all’origine della ricchezza delle nazioni. Vedi
Bianchi C., “Politica economica” in Lunghini G. e D’Antonio M. (a cura di), Dizionario di Economia Politica, Bollati
Boringhieri, Torino, 1988, pp. 107-256, in part. p.126.
56 Laissez faire, manchesterismo o smithianismo indicano un atteggiamento liberista in questioni di politica economica che
faceva riferimento per le loro costruzioni teoriche alle assunzioni sul comportamento di singole imprese o famiglie. Le “leggi
naturali” di un ordine economico autoregolato furono il tema dominante dell’economia politica classica. Pertanto la politica
di gran lunga migliore consiste nel lasciare le cose al loro corso naturale, dominate dai valori naturali, che Smith indicava nel
prezzo di equilibrio che la concorrenza produce attraverso l’azione della domanda e dell’offerta. Vedi Dobb M., op.cit.,
pp.45-7. Ma le nuove teorie dell’utilità marginale non avevano nulla che servisse l’apologetica del capitalismo (vedi ad
esempio le implicazioni egualitarie della “legge” dell’utilità marginale).
55
Qui il riferimento è ai classici, a Marx, ai neoclassici, a Keynes e ai neokeynesiani. Vedi De Luca G., Minieri S., Verrilli A.
(a cura di), Nuovo Dizionario di Economia, Edizioni Simone, Napoli, 1998, pp. 176-8.
57
11
validità del sistema capitalistico che come un reale contributo obiettivo alla spiegazione delle cause delle
crisi economiche.
Per l’analisi marxista, la concentrazione capitalistica e la formazione di un proletariato sempre
più povero e numeroso porta ad una crescita della capacità produttiva maggiore delle effettive capacità
di acquisto della classe operaia e di conseguenza a crisi periodiche di sovrapproduzione dovute alla
saturazione dei mercati che si sarebbero progressivamente aggravate fino alla catastrofe finale. Questa
avrebbe portato al crollo della società capitalista e all’instaurazione di un regime basato sulla dittatura
del proletariato.
Per l’analisi neoclassica, la generale accettazione della legge degli sbocchi non permetteva di
elaborare una teoria compiuta che fornisse una spiegazione della variazione del livello di attività
economica. I fenomeni di deflazione e inflazione sono associati agli scostamenti in più o in meno tra
tasso effettivo di mercato e tasso naturale d’interesse (che mette in equilibrio investimenti e risparmi).
Sebbene la disoccupazione come possibile effetto cronico di una “carenza di domanda effettiva” sia
stata proclamata a lungo nel “sottomondo degli eretici”58, è un fatto degno di nota, e indubbiamente
significativo, che solo dopo l’impatto della crisi economica mondiale del 1929-31 quest’idea, fino ad
allora negletta, sia stata presa in considerazione dagli accademici. Prima di quella crisi la legge di Say
dominava incontrastata l’opinione pubblica corrente59. Dalla legge di Say segue che normalmente la
produzione non soltanto aumenta l’offerta di beni sul mercato, ma ne aumenta anche la domanda. In
questo senso è la stessa produzione che crea il fondo da cui scaturisce la domanda dei suoi prodotti. In
ultima analisi i prodotti sono pagati dai prodotti tanto nel commercio estero che nel commercio
interno60. Ma se la legge di Say è ovvia, e non banale, in un’economia di baratto, non vale in
un’economia monetaria61. Pertanto le proposizioni di Say hanno fatto parlare a buon diritto di
apologetica del capitalismo.
Per l’analisi keynesiana, già Keynes aveva messo in evidenza come il fenomeno delle crisi fosse
essenzialmente legato al livello d’investimenti generato dal sistema economico. Se, infatti, per
qualsivoglia motivo gli imprenditori riducono il livello dei loro investimenti, la domanda globale
risulterà inferiore all’offerta potenziale di piena occupazione in mercato chiuso, causando una crisi di
sovrapproduzione; in una situazione di crisi poi le aspettative degli imprenditori saranno influenzate
ancor più negativamente per cui il livello degli investimenti subirà un’ulteriore riduzione che verrà
aggravata da un minore consumo da parte delle famiglie (in una situazione di crisi le imprese tendono a
licenziare operai in esubero per cui il reddito disponibile delle famiglie sarà inferiore).
Due tipi di fluttuazioni economiche rivestono, ancora oggi, particolare interesse per i
macroeconomisti: 1. i sensibili e prolungati scostamenti del tasso di disoccupazione dai suoi livelli medi
di lungo periodo; 2. l’insieme di variazioni sincronizzate delle principali variabili macroeconomiche
intorno a un trend, che va sotto il nome di ciclo economico62. Esso si misura attraverso il gap di
produzione che è pari alla differenza tra la produzione potenziale di Okun, ovvero quel livello che il
sistema economico può conseguire quando tutti i fattori di produzione, e in particolare le forze lavoro,
sono pienamente utilizzati63.
Con questo nome Keynes aveva indicato un nutrito gruppo di economisti socialisti ricardiani: scrittori come Hodgskin,
Thompson, Jones, Bray, Gray e Ravenstone in Inghilterra, Rodbertus e Dühring in Germania e Saint Simon, Fourier,
Proudhon e i suoi seguaci in Francia che anticiparono la teoria marxiana del plusvalore. Essi ebbero il merito di scoprire un
fatto di grande importanza, di fronte al quale gli ortodossi, come dice Dobb, erano rimasti ciechi. Vedi Dobb M., op.cit.,
p.135-8. Essi non seppero darne un’interpretazione esauriente e non riuscirono, in particolare, a mostrare come lo scambio
di non equivalenti, o il plusvalore, potessero conciliarsi con la concorrenza libera.
59 Ibidem, p. 25
60 Vedi Schumpeter J.A., Storia …cit., p. 285.
61 Marx stesso respinge decisamente la cosiddetta legge di Say, in considerazione della possibile tesaurizzazione del denaro.
Vedi Dobb M., op.cit. p.159. Un’opinione opposta è argomentata, tra gli altri, proprio da Schumpeter, Storia…. cit., pp. 286-8.
Tuttavia Marx afferma che l’aumento dell’investimento, in un’ottica di ”riproduzione allargata”, può realizzarsi nella misura
in cui i beni di consumo eccedenti vengono esportati in cambio del nuovo oro fornito dai produttori di questo metallo. Vedi
Dobb M., op.cit., p. 159
62 Vedi Sachs J.D., Larrain F., op. cit., p.121.
63 Pertanto il tasso di disoccupazione è pari al suo valore naturale.
58
12
La Grande Depressione negli Stati Uniti rappresentò una catastrofe mondiale e una sfida per la
teoria economica dominante secondo la quale il meccanismo di mercato avrebbe dovuto avrebbe
dovuto autoregolarsi e impedire il fenomeno di disoccupazione di massa prolungato. Il tasso di
disoccupazione salì dal 3,2 % nel 1929 al 24.9% nel 1933. All’origine di questo aumento della
disoccupazione ci fu un forte calo della domanda, causato dal crollo del mercato azionario del 1929 e
dal conseguente aumento dell’incertezza. La conseguenza dell’elevata disoccupazione fu una forte
deflazione dal 1929 al 1933. L’effetto favorevole della deflazione sui saldi monetari reali fu compensato
da una riduzione proporzionale della moneta nominale. Questa riduzione fu il riflesso degli assalti agli
sportelli bancari favoriti dalla combinazione di depositi a vista e sistema bancario a riserva frazionaria,
dei costi economici associati al panico bancario e di una serie di fallimenti bancari che, aumentando la
rischiosità dei depositi64, ridussero il moltiplicatore della moneta. Un altro effetto negativo della
deflazione fu l’aumento dei tassi di interesse reali, che provocò un’ulteriore riduzione della domanda e
della produzione. La ripresa iniziò nel 1933. La crescita media fu alta, del 7,7 % annuo, dal 1933 al 1941.
Ma a causa dell’alto livello raggiunto nel 1933, nel 1941 la disoccupazione era ancora del 9,9%.
Contrariamente alle previsioni della curva di Phillips trasformata, dal 1934 in poi la deflazione lasciò
posto all’inflazione, nonostante il tasso di disoccupazione fosse ancora alto. Ma ciò ricorda soltanto che
l’inflazione non è monocausale e non dipende solo dalla dinamica del costo del lavoro per unità di
prodotto. E’ evidente che la spesa pubblica accompagnata dall’elevata crescita della moneta nominale, e
quindi della moneta reale, fu un fatto cruciale65. Sulle cause della Grande Depressione, oltre a Keynes, si
sono cimentati molti economisti tra i quali Friedman e Schwartz, Kindleberger, Temin. Trattandosi di
una crisi profonda e generalizzata, tutte le spiegazioni sottolineano cause prevalenti piuttosto che
univoche. Tuttavia, si osserva che lo schema macroeconomico di Keynes, che attribuisce lo scatenarsi
della depressione alla instabile fiducia degli investitori, è molto convincente, insieme a quella di Temin66,
che nella spiegazione della origine e della diffusione della crisi mutua due tesi fondamentali di Keynes,
quella delle conseguenze economiche della pace e quella delle conseguenze economiche di Mr.
Churchill67. Meno convincente è invece la tesi Friedman e Schwartz68, non tanto per aver trascurato i
fattori di natura internazionale, come gli è stato addebitato da Kindleberger69, bensì perché la loro
attribuzione della responsabilità della depressione alle politiche monetarie restrittive seguite dalla Federal
Riserve negli anni della crisi dà per scontata la legge degli sbocchi che, come si è ricordato, non è valida
in un’economia monetaria.
3.2 LA RIVOLUZIONE KEYNESIANA
La rivoluzione keynesiana ha avuto implicazioni politiche di grande peso circa la gestione di una
moderna economia mista, essa è stata il riflesso di eventi e problemi del suo tempo, come la deflazione,
la caduta salariale del Ministero Cripps e la disoccupazione degli anni venti (riconducibile alla “fallacia di
composizione” della domanda nella teoria classica dei salari secondo la quale una loro diminuzione
avrebbe aumentato la domanda di lavoro), la crisi economica mondiale e l’accentuazione della
disoccupazione del periodo 1929-32. Oltre a essere una dottrina della depressione, inserita nel contesto
della ricerca condotta da Malthus e da tutti i teorici del sottoconsumo, la concezione di Keynes prevede
anche la possibilità di una stagnazione cronica, o secolare, come motivo del declino dell’investimento
privato. Questo aspetto erroneo, che Keynes condivise con gli economisti classici, fu dovuto a una
sottovalutazione dell’innovazione, che invece non sfuggì, più tardi, a Kalecki70. Si può dire che si tratta
Gran parte delle regolamentazioni a cui sono sottoposti i sistemi finanziari odierni sono nate dalla necessità di evitare il
ripetersi di questi avvenimenti drammatici.
65 Blanchard, op. cit., pp. 591-7. I manuali di macroeconomia tendono ormai a sottacere la tesi di Keynes a favore della sola
lettura in termini della scarsa quantità di moneta.
66 Vedi Temin P., Lessons from the Great Depression, MIT Press, Cambridge, Mass., 1989.
67 A questo riguardo vedi il successivo paragrafo 4.2
68 Vedi Friedman M. e Schwartz A., “The Great Depression, 1929-33”, in Idem, A Monetary History of the United States 18671960, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1963.
69 Vedi Kindleberger C., The World in Depression 1929-1939, University of California Press, Berkeley, 1973.
70 Vedi Kalecki M., Observations in the “Theory of Growth” in The Economic Journal, marzo 1962, pp.134 e 150..
64
13
di un errore che deriva dalla ossessione classica per lo stato stazionario. A questo aspetto si riferisce
Schumpeter quando parla di un’affinità con la spiegazione marxiana delle crisi. Marx aveva sostenuto
che nei periodi di boom l’accumulazione di capitale sopravanza l’offerta di forza-lavoro assottigliando
l’esercito industriale di riserva e l’investimento tende ad arrestarsi fin quando la pressione dei salari sui
profitti non si alleggerisce.
Come economista, Keynes non guardò mai ai problemi in modo isolato, o avulso dal contesto,
bensì come elementi appartenenti a un sistema unitario e in esso interagenti. Keynes sottolinea che
l’economia non è un sapere isolato, bensì inseparabilmente legato ad altri saperi come la filosofia, la
psicologia, la storia e la politica. L’organicismo di Keynes (proprio soprattutto della General Theory in cui
la negazione atomistica consente a relazioni macro di essere in contrasto con la somma delle relazioni
micro: il paradosso del risparmio e la fallacia di composizione nella teoria classica dei salari) contrasta
con il presupposto neoclassico che gli interi siano solo aggregati. Usare il dato aggregato come somma
delle parti induce, ad esempio l’errore dell’agente rappresentativo. Gli agenti economici possono agire in
modo razionale e tuttavia non c’è garanzia che il sistema economico genererà risultati razionali per
l’intera società. In economia, i fondamenti atomistici dell’ortodossia però fornivano una teoria solida
dell’impresa e della distribuzione del reddito71. L’assunzione di razionalità consente un rigoroso
ragionamento deduttivo che, pur nei diversi approcci, conduce ad una sorprendente unità di analisi. Ma
la tesi di Keynes era che razionale e vero non necessariamente coincidono72.
Keynes apprezza la distinzione tra criteri analitici e criteri sintetici73, vede l’economia come una
branca della logica, non della matematica, un modo di pensare e non una pseudo scienza naturale, la cui
complessità è dovuta sia alla presenza delle aspettative74, degli errori - come l’illusione monetaria75-, delle
motivazioni, dell’incertezza76, sia al fatto di dover affrontare fenomeni complessi come le crisi di
ristagno di fine ‘800 e degli anni ’30. Keynes fece un uso molto limitato, come Marshall prima di lui, di
un’economia matematica meccanicistica che poteva configurarsi soltanto in un mondo prevedibile e
senza incertezza.
Per Keynes, come per altri economisti critici dell’individualismo metodologico77, alcune
proprietà di sistemi complessi non possono essere spiegate, in linea di principio, sulla base della
conoscenza degli attributi delle parti. E’ per la presenza di queste proprietà inspiegabili, denominate
“proprietà emergenti” che alcuni comportamenti di gruppo non possono essere analizzati mediante una
teoria dei comportamenti dei singoli individui. Keynes rovesciò la teoria del risparmio78 e
l’argomentazione economica a favore della disuguaglianza basata sulla necessità di forti risparmi. Il Il
laissez faire, ad eccezione di Smith, aveva fatto di un vizio privato (il consumo) una pubblica virtù; la
Teoria Generale fece di una virtù privata (il risparmio) un vizio pubblico.
Vedi O’ Donnell R. M., Keynes: Philosophy, Economics and Politics. The Philosophical Foundations of Keynes’s Thought and their
Influence on his Economics and Politics, MacMillan, London, 1992, pp. 177-78.
72 Ibidem, p.104.
73 Romagnoli G.C., “Falsificabilità e…”, cit., in part. pp.124-7.
74 Vedi Blanchard O., op. cit., pp.231-2.
75 Illusione monetaria è l’errore compiuto dall’agente economico che guarda al valore nominale della moneta, tenendo conto
in modo inadeguato della variazione del suo valore espresso dal potere di acquisto reale. L’illusione monetaria spiega anche,
in parte, il comportamento dei risparmiatori che, in condizioni inflazionistiche, accettano, di impiegare la loro ricchezza, in
presenza di alternative migliori, a tassi di rendimento che ex post risultano negativi. Non soffrono di illusione monetaria gli
operatori economici che sono interessati essenzialmente al potere di acquisto reale della moneta che posseggono e non al
suo valore nominale.
76 Siamo entrati nell’età dell’incertezza quando, tra gli anni ’20 e gli anni’30, le ipotesi sulla stabilità sociale, sull’equilibrio del
sistema monetario, sugli stati del mondo presenti e futuri si sono rivelate precarie e quindi non associabili a probabilità
oggettive conoscibili a priori.
77 Il riferimento è agli economisti marxiani, istituzionalisti, neoricardiani, oltre che keynesiani. Vedi a questo riguardo
Romagnoli G.C., “La psicologia economica dello Universal Bogey” in Marconi G. e Termini C. (a cura di), I volti di Giobbe.
Percorsi interdisciplinari, EDB, Bologna, 2002.
78 A questo proposito va osservato che l’imposizione di controlli sui movimenti dei capitali può rivelarsi utile al fine di
tradurre un aumento del risparmio nazionale in un aumento della spesa interna per investimenti. Vedi Sachs J.D., Larrain F.,
op. cit., p.269. Ma in presenza di questi controlli la legge dell’arbitraggio sui tassi d’interesse nonè più rispettata e nulla
garantisce quindi la parità dei tassi d’interesse. In questo caso, un’espansione monetaria provocherebbe una perdita
equivalente di riserve ufficiali in cambi fissi e invece un deprezzamento del cambio in cambi flessibili.. Ibidem, p.482.
71
14
In questo senso la Teoria Generale era insieme una necrologia e una prospettiva per un mondo
nuovo, un mondo caratterizzato da incertezza, instabilità, entrambe sottolineate dalla prossimità
temporale della Grande Depressione, e conoscenza imperfetta che richiedevano una valutazione
continua del perseguimento non di un equilibrio nozionale o naturale ma del miglior equilibrio
possibile. Una visione che rimaneva peraltro inserita all’interno del quadro politico e sociale esistente.
Attribuire la disoccupazione nell’economia del laissez faire al livello di risparmio e ai tassi d’interesse
equivaleva a togliere responsabilità ad altri attori o entità economiche. Keynes consentiva che gli
imprenditori perseguissero il loro interesse senza farsi carico del problema sociale della disoccupazione,
anche se allora il riferimento era a una borghesia risparmiatrice e accumulatrice di capitale generatore di
occupazione, una borghesia diversa dunque da quella degli anni successivi alla Seconda Guerra
Mondiale che è diventata preda del consumismo e di status symbols. Ma Keynes esonerò anche i sindacati
dalla responsabilità della disoccupazione dovuta a salari monetari troppo alti in un mondo in cui i
capitali erano scarsamente mobili e la conquista di quote di mercato internazionale non si coniugava
necessariamente a politiche del tipo beggar thy neighbour79. In campo internazionale, in particolare, valgono
le sue lezioni e i suoi suggerimenti sull’esigenza di aggiustamenti simmetrici tra paesi in deficit e paesi in
surplus80, la regolamentazione dei mercati di produzione delle materie prime, istituzioni internazionali
che stabilizzino il ciclo internazionale, lo scoraggiamento dei movimenti speculativi dei capitali.
Keynes considerò la Teoria Generale “moderatamente conservatrice nelle sue implicazioni” ma
portò a compimento, nonostante le sue riserve su Marx, il compito affidato da Marx ai filosofi: “I
filosofi hanno solo interpretato il mondo in modi diversi. Il punto peraltro è quello di cambiarlo”. E
Keynes lo rivoluzionò!
L’acquisizione di una coscienza sociale del problema della disoccupazione e la sua inclusione tra
i mali prioritari contro cui indirizzare l’azione della politica economica sono generalmente riconosciute
all’opera di Keynes, ma va ricordato che le possibilità dell’intervento pubblico contro la disoccupazione
attraverso programmi di lavori pubblici nel settore delle costruzioni e attraverso l’occupazione nel
settore dei servizi pubblici erano state esperite durante i periodi di depressione e di crisi tra le due
guerre mondiali soprattutto dai governi totalitari italiano e tedesco, così come dal New Deal
roosveltiano81.
Il perseguimento della piena occupazione ha esteso inevitabilmente il ruolo attivo dello Stato. Il
rifiuto dell’ipotesi atomistica nelle scienze superorganiche era la premessa naturale al rifiuto
dell’approccio individualistico che era prevalso alla fine dell’800 e su cui si era modellato il
comportamento di individui in uno stato liberale perfetto. Ma la politica concerne le scelte, le priorità, i
fini così come i mezzi. L’economia diventa nuovamente economia politica, come al tempo di Smith, e le
scelte poste in ombra dai neoclassici tornano allo scoperto, visto che non c’è spazio per una
conciliazione di interessi conflittuali in un tutto armonioso. Anche se, una volta raggiunta la piena
occupazione, ci accorgiamo che ogni cosa si ottiene a spese di qualcos’altro. Negli anni ’30 tutti
potevano migliorare la loro situazione, attualizzando l’uso di risorse potenziali. Quando ciò è stato
realizzato, la riduzione della povertà chiede essenzialmente un’attività redistributiva che può arricchire il
povero a spese del povero. Siamo passati da un gioco a somma positiva ad uno a somma zero o
negativa.
E’ piuttosto facile, oggi, prendere posizione sulla questione se la piena occupazione e le
politiche keynesiane atte a perseguirla siano una condizione sufficiente dell’inflazione. Keynes e i classici
In questo senso il “Rapporto della Commissione Macmillan” e i lavori della “Economic Advisory Committee” mostrano
che nel corso del 1930-31 la visione di Keynes sulla politica commerciale cambia rispetto ai tempi della prima guerra
mondiale che lo avevano visto acceso sostenitore del libero commercio proprio della posizione classica. L’Addendum al
Rapporto Macmillan, redatto per affrontare l’emergenza della crisi della sterlina sui mercati finanziari internazionali,
affermava che l’aumento dell’occupazione poteva derivare da maggiori esportazioni, da una produzione sostitutiva delle
importazioni, da maggiori investimenti. Esso rifiutava i rimedi della riduzione dei salari monetari e della svalutazione ma
guardava con favore ad una svalutazione indiretta attraverso uno schema di dazi, restrizioni delle importazioni e di sviluppo
del capitale.
80 Questi suggerimenti sono stati trascurati negli anni successivi e hanno portato al fallimento di importanti accordi monetari
come “il serpente” negli anni settanta.
81 Vedi Hancock K. J., “The reduction of unenmployment as a problem of public policy 1920-1929”, in S. Pollard, The Gold
Standard and Employment Policies between the wars, Methuen, London, 1970, pp.107-9.
79
15
proponevano modelli che prefiguravano due mondi, descritti dalle ipotesi sottostanti, entrambi possibili
anche se con diversi gradi di realtà. Dagli anni ’70, con la stagflazione persistente, abbiamo visto
emergere, nei Paesi dell’Ocse, comportamenti economici in linea con alcune delle ipotesi sottostanti il
modello classico ortodosso (la razionalità illimitata82, i comportamenti massimizzanti, l’attenzione agli
aspetti istituzionali del mercato del lavoro) e, al contrario, venir meno lentamente alcune delle ipotesi
sottostanti il modello keynesiano (l’illusione monetaria, le rigidità nominali verso il basso, l’incertezza, la
non neutralità della moneta), tratteggiate da Keynes nel ”Trattato sulla moneta” e poi ipostatizzate nella
“Teoria Generale”. Ma la conseguenza politica più importante dell’opera di Keynes è rappresentata
dalla rinascita dell’economia politica, ovvero dalla reintegrazione della vita politica, economica e sociale.
Le nuove idee di Keynes erano in realtà rivoluzionarie. Della dottrina tradizionale, egli
contestava l’assunzione di un equilibrio statico, necessariamente condizionato dal pieno impiego di tutte
le risorse produttive. Questa prevedeva che attriti potevano ostacolare il raggiungimento dell’equilibrio,
ma di qui emergeva l’implicito corollario che la politica dovesse liquidare gli attriti invece di fare altri
interventi. In qualsiasi altra situazione si sarebbe avuto un movimento dei prezzi relativi e, di qui, il
corollario della teoria di Pigou che il manifestarsi di una disoccupazione permanente fosse il sintomo
dell’eccessivo livello dei salari. In polemica con la teoria tradizionale, la nuova teoria affermò che
l’equilibrio poteva essere raggiunto a qualsiasi livello dell’output e dell’impiego, perché non c’era un
adeguamento appropriato dell’output e dell’impiego. Ciò riportava indietro alla controversia tra
Ricardo e Malthus sulla sovrapproduzione e all’interpretazione tradizionale della legge di Say83, secondo
cui uno stato di sovrapproduzione generale è impossibile perché “l’offerta crea sempre la sua domanda”
tesi che poggia sul presupposto che tutto il reddito sia consumato o investito e quindi speso, in un
modo o nell’altro come domanda di prodotti. Ossia l’investimento coincide sempre con il risparmio.
Ma, come è stato già detto, ciò che vale in un’economia di baratto non altrettanto vale in un’economia
monetaria. E invece i sostenitori della legge di Say affermano che il saggio di interesse tende a cadere
fino a che non s’incoraggiano nuovi prestiti e quindi nuovi investimenti (reali, non finanziari)84. Ora
proprio questo pilastro della legge di Say diventa il punto centrale dell’attacco di Keynes a quella che
egli chiama la dottrina “classica” ossia ”un corpus teorico universalmente accettato durante gli anni
venti”. La negazione del ruolo decisivo del saggio d’interesse, come equilibratore del risparmio e
dell’investimento, conduce direttamente alla teoria keynesiana delle determinanti dell’impiego. Se il
saggio di interesse perde il suo ruolo di equilibratore tra flussi di risparmio e di investimento, dove può
collocarsi e come può essere determinato? L’interesse è virtualmente convertito a un saggio monetario
su cui influiscono, da una parte la politica monetaria e, dall’altra, la preferenza per la liquidità85.
Nella visione ottimistica del mercato, propria dei neoclassici, i cicli finiscono per essere
considerati parte dell’ordine naturale tanto che essi gli attribuiscono virtù terapeutiche perché i cicli
eliminano gli eccessi speculativi e riducono investimenti non giustificati. In tale contesto, provvedimenti
contro le fluttuazioni non appaiono necessari, né desiderabili. Un eventuale eccesso della produzione di
beni sulla domanda, ovvero del risparmio volontario sull’investimento, provocherebbe una riduzione
dell’interesse in grado di eliminarlo.
La razionalità è la caratteristica assunta alla base del comportamento economico degli operatori nello svolgimento
dell’attività economica. In particolare l’analisi marginalista definisce la razionalità nell’azione dell’homo oeconomicus mirante
al raggiungimento dell’obiettivo di massimizzazione del profitto per l’imprenditore o dell’utilità per il consumatore, tenendo
conto dei vincoli imposti dalla disponibilità delle risorse e dalla tecnologia. Tale comportamento mira, quindi, ad ottimizzare
il rapporto mezzi - fini in presenza di vincoli, in un orizzonte temporale definito dalla durata della vita dei percettori dell’
utilità o del profitto. In questo modo chi persegue un fine diverso dall’interesse personale, definito in modo indipendente da
quello di altri, è, per ciò stesso, irrazionale.
83 Il dibattito Ricardo-Malthus sulle cause delle strozzature e sulle possibilità di una sovrapproduzione generale verteva sul
richiamo ricardiano alla legge di Say e all’anticipazione malthusiana della dottrina novecentesca, che respingendo la legge di
Say, porrà l’accento sulla domanda effettiva.
84 Vedi Dobb M., op.cit ., pp.207-9. E’ interessante ricordare, a questo riguardo, la posizione di Pantaleoni: ”…che l’interesse
non sia originato dalla differenza di valutazione dei beni attuali e di beni prospettivi…non potendo l’interesse variare, ceteris
paribus, e brevemente detto, che in ragione della fecondità degli investimenti di capitale, e precisamente degli ultimi, o
novissimi”. Vedi Pantaleoni M., op. cit., pp. 260 e 263.
85 Vedi Dobb M., op. cit., p.210.
82
16
Ancora nei primi anni del secolo ventesimo la disoccupazione non era annoverata, come si è
detto, tra gli obiettivi della politica economica. Il principio della finanza ortodossa voleva il bilancio
pubblico mediamente in pareggio e l’analisi neoclassica degli effetti degli investimenti pubblici rimaneva
quella corrispondente alla Treasury View86. Lo stesso Keynes, fino al “Tract on Monetary Reform” del
192387, si muove all’interno dell’ortodossia neoclassica. Tuttavia, la sua preoccupazione per il breve
periodo lo induce a un atteggiamento più interventista nei confronti delle fluttuazioni cicliche, che vede
come patologiche, piuttosto che fisiologiche, del sistema e quindi da prevenire e curare perché sono
fonte di redistribuzioni dei redditi ingiuste nella fase inflazionistica e di sottoutilizzazione delle risorse
nella fase deflazionistica88. Keynes indica, in questo modo, un errore fondamentale ripetuto nelle scelte
di macroeconomia. Nella “Teoria Generale” trova completamento un processo di radicale revisione
delle idee di Keynes che segna una rottura definitiva e rivoluzionaria con la teoria tradizionale89. La
novità teorica fondamentale del volume è che le variazioni periodiche dell’occupazione non sono più il
sottoprodotto dell’evoluzione temporale dei prezzi, bensì la conseguenza diretta e immediata delle
analoghe variazioni periodiche della domanda globale di beni, e in particolare degli investimenti. E,
ancora, i cicli non avvengono intorno a una normale situazione di pieno impiego delle risorse, bensì in
prossimità di una situazione di sostanziale sottoutilizzazione della forza di lavoro esistente. Si tratta di
due ulteriori errori comuni alla base delle scelte di macroeconomia. Il compito fondamentale dell’analisi
economica diviene proprio quello di spiegare le cause ultime di tale situazione. Nell’assolvere questo
compito Keynes usa un approccio vicino a quello degli economisti classici con i quali presenta notevoli
affinità: lo stesso interesse per la ricchezza della nazione, la divisione della società in classi cui attribuisce
comportamenti diversi, l’enfasi primaria dell’analisi sulle grandezze aggregate o macroeconomiche.
Rovesciando completamente la logica alla base della legge di Say, Keynes afferma che la produzione del
sistema è determinata e limitata dalla domanda complessiva di beni esistente sul mercato. Tale
produzione è inoltre di equilibrio perché non ci sono meccanismi automatici in grado di far coincidere
la produzione effettiva con quella potenziale. Contrariamente alle indicazioni della teoria neoclassica,
nello schema di Keynes la causa della disoccupazione involontaria non può risiedere in un livello dei
salari monetari troppo elevato, dato che la funzione di questi ultimi è solo quella di determinare il livello
generale dei prezzi. Al contrario, la causa della disoccupazione è costituita da un insufficiente volume
della domanda effettiva. In questo contesto, il rimedio della situazione deve essere trovato in misure in
grado di stimolare direttamente la domanda. Keynes ritiene che lo Stato debba assumersi la
responsabilità di effettuare direttamente investimenti pubblici compensativi, ovvero procedere a una
vasta “socializzazione dell’investimento” finalizzata al pieno impiego90. Contrariamente alla Treasury
View, in un sistema in cui le risorse sono inutilizzate, una maggiore spesa pubblica, lungi dal provocare
uno spiazzamento dell’investimento privato, può invece più verosimilmente stimolarlo attraverso un
miglioramento delle prospettive imprenditoriali. Si tratta della indicazione di un ulteriore errore
consueto nelle scelte di macroeconomia. Per Keynes, il livello dei prezzi è determinato più dai costi di
produzione, e in primo luogo dai salari, che dal livello della domanda. In questa prospettiva, Keynes si
dimostra già conscio e preoccupato dall’eventualità che con il crescere dell’occupazione i lavoratori
possano sfruttare la loro posizione di maggiore forza contrattuale per chiedere remunerazioni più
elevate, provocando un inevitabile aumento dei prezzi. Tuttavia, anche per affrontare una simile
situazione, Keynes indica un ulteriore errore sovente implicito nelle scelte di macroeconomia
Un livello crescente di spesa pubblica, in presenza di un volume di risparmio dato, non poteva far altro che diminuire
proporzionalmente l’investimento privato. Si provocava cioè lo spiazzamento, o crowding out, attraverso un aumento del tasso
di interesse naturale che equilibra risparmio e investimento. Vedi Bianchi C., op. cit. p.147.
87 Vedi Keynes J.M., Tract on Monetary Reform, Harcourt Brace and Company, NewYork,1924, trad.it.La riforma monetaria,
Feltrinelli, 1975.
88 A volte il termine fluttuazioni economiche non coglie a fondo cosa succede nell’economia. L’inflazione può raggiungere
tassi estremamente elevati, oppure la disoccupazione non accenna a diminuire per molto tempo. Questo è ciò che accadde
durante la Grande Depressione. A volte il debito pubblico, ovvero il valore totale dei titoli emessi dalle amministrazioni
pubbliche, raggiunge livelli molto elevati.
89 I due postulati dell’analisi neoclassica marginalista sotto accusa nell’incipit della “Teoria Generale” sono: 1. l’eguaglianza del
salario alla produttività marginale del lavoro; 2. la capacità dei lavoratori di contrattare i propri salari reali. Vedi Keynes J.M.,
The General Theory of Employment Interest and Money, Macmillan, London, 1967, pp. 5-11.
90 Al contrario, Kalecki ammette che parte della spesa pubblica possa essere destinata a sostenere i consumi.
86
17
mostrandosi contrario all’uso della deflazione91 e suggerendo implicitamente l’opportunità di una
qualche forma di politica dei redditi. Con l’opera di Keynes la politica economica assume i connotati
propri della sua concezione moderna.
3.3 ALCUNE POSIZIONI RECENTI
Negli anni settanta, la macroeconomia keynesiana attraversò una crisi. Tre ne erano le ragioni.
La prima era data dal fenomeno della stagflazione, che sorprese molti economisti. La seconda era
rappresentata dalla rigidità salariale ingiustificata. La terza era costituita dalla sfida teorica condotta da
Robert Lucas e la sua scuola, i quali mostrarono che con l’introduzione dell’ipotesi di aspettative
razionali nei modelli macroeconomici si poteva giungere ad alcune conclusioni originali: a) i modelli
keynesiani non potevano più essere utilizzati per orientare la politica economica; b) i modelli keynesiani
non erano più in grado di spiegare deviazioni durature della produzione dal suo livello naturale; c) la
teoria della politica economica doveva essere studiata usando i concetti della teoria dei giochi92. Al di là
dell’enfasi eccessiva di queste conclusioni teoriche, la prima delle quali non è fondata, come è stato
argomentato da Tobin93, la lentezza delle risposte keynesiane allo sconcerto posto dalle nuove sfide fu
tale che gran parte degli anni settanta e ottanta furono spesi per inserire le aspettative razionali nella
teoria macroeconomica, al fine di determinare, alla loro luce, gli effetti di shocks esogeni e delle misure
di politica economica.
Le aspettative sono le previsioni degli operatori economici, sulla base delle proprie esperienze e
delle proprie intuizioni, circa l’andamento delle variabili economiche nel futuro. Uno dei primi a
sottolineare il ruolo delle aspettative nel comportamento degli operatori economici fu proprio Keynes
(animal spirits). Si osserva, invece, che il modello hicksiano IS-LM di base trascura le aspettative. In realtà
le aspettative hanno un ruolo essenziale in macroeconomia. Quasi tutte le decisioni economiche
intertemporali prese da individui e imprese dipendono dai tassi di interesse futuri, da profitti futuri e
così via. Le prime trattazioni formali delle aspettative avvengono ad opera dei monetaristi con tre
diverse teorie sulla loro formazione:
-aspettative statiche: i valori futuri sono eguali a quelli correnti;
-aspettative estrapolative: i valori futuri sono funzione di quelli del passato prossimo;
-aspettative adattive: i valori sono funzione dello scostamento fra valori attesi e valori realizzati
precedentemente.
Tutte queste teorie presentano però l’inconveniente di ipotizzare che gli operatori basino le
aspettative solo sui valori passati: ciò rende probabili errori sistematici e costituisce un atteggiamento
irrazionale perché porta ad escludere le altre informazioni disponibili. Questa critica, in particolare, ha
portato a formulare l’ipotesi di aspettative razionali. Nei primi anni settanta, un gruppo di economisti,
guidati da Robert Lucas e Thomas Sargent, sosteneva che gli economisti avrebbero dovuto ipotizzare
aspettative razionali, cioè che le persone guardano al futuro e fanno del loro meglio per prevederlo
usando tutte le informazioni a loro disposizione. Lucas e Sargent hanno mostrato che l’introduzione
delle aspettative razionali, e con essa la impossibilità che le persone compiano errori sistematici, poteva
alterare radicalmente i risultati dei modelli macroeconomici. Di qui la necessità di una revisione
completa dei modelli esistenti. Si dubita, tuttavia, che questa possa essere considerata una soluzione
corretta. Ci si chiede invece se, così facendo, non si compia un errore ulteriore in considerazione
dell’opportunità, già espressa, che l’ipotesi di razionalità sia derivata, con le altre, da uniformità
comportamentali osservate in condizioni simili, piuttosto che dalla assolutizzazione di posizioni estreme
come, in questo caso, quella della razionalità illimitata.
Due cause di malessere economico sono state al centro del dibattito macroeconomico di questi
ultimi trenta anni: l’inflazione elevata e la disoccupazione elevata. Gli economisti si preoccupano molto
dell’inflazione perché l’inflazione pura non esiste. Durante le fasi inflative, non tutti i prezzi e i salari
aumentano proporzionalmente. L’inflazione influenza pertanto la distribuzione del reddito, oltre a
Come invece come fece la Banca d’Italia con la stretta monetaria del 1964.
Vedi Blanchard O. op. cit., p.768.
93 Vedi Tobin J., “La teoria macroeconomia in discussione”, Bancaria, 1985.
91
92
18
creare drenaggio fiscale nei sistemi impositivi progressivi, incertezza e distorsioni attraverso il
mutamento dei prezzi relativi. Quando il tasso d’inflazione raggiunge un livello così alto che i prezzi
aumentano quotidianamente, l’economia funziona male. I tassi d’inflazione possono variare
drammaticamente, come è accaduto diverse volte, durante il secolo XX, in Europa e soprattutto in
America Latina a causa del finanziamento di cospicui deficit attraverso la creazione di base monetaria.
Di conseguenza ciò che serve per porre fine a un’inflazione elevata è un programma di stabilizzazione.
Questo può essere di due tipi: ortodosso (se si basa soltanto su misure fiscali finalizzate alla riduzione
del disavanzo di bilancio e monetarie finalizzate a un impegno credibile di rinuncia automatica alla
monetizzazione del debito) o eterodosso (se oltre alle misure monetarie e fiscali include politiche dei
prezzi e dei redditi)94.
L’elevata disoccupazione non è una tradizione europea, ma negli ultimi trenta anni ne ha
assunto l’aspetto, con prospettive di una ripresa lenta95. Fino ai primi anni settanta, il tasso di
disoccupazione era nettamente inferiore a quello statunitense. Aumentarono entrambi prima
gradualmente negli anni settanta e poi bruscamente nei primi anni ottanta. Sulle sue cause a tutt’oggi
non c’è consenso. Alcuni additano problemi dal lato della domanda, errori di politica economica
restrittiva indotti dall’appartenenza del Sistema monetario europeo (Sme), e l’isteresi96. Altri la
attribuiscono invece a problemi dal lato dell’offerta e alla sclerosi del sistema economico. Ma da venti
anni il tasso statunitense è diminuito, mentre quello europeo è rimasto elevato fino alla fine degli anni
novanta, quando ha iniziato a scendere. Mentre l’aumento della disoccupazione negli anni ottanta è
stato associato a un forte calo dell’inflazione, da quando l’inflazione si è ridotta e stabilizzata si
propende a pensare che l’attuale tasso di disoccupazione sia vicino a quello naturale.
La prima linea interpretativa della disoccupazione elevata in Europa attribuisce la causa alle
rigidità del mercato del lavoro: dall’eccessiva protezione del posto di lavoro, a sussidi di disoccupazione
troppo generosi, a elevati minimi salariali che emarginano i lavoratori poco qualificati dal mercato del
lavoro. Questa interpretazione non spiega però perché la disoccupazione è aumentata in un periodo in
cui queste rigidità sono di fatto diminuite. Una spiegazione possibile è che la forte e prolungata
contestazione sociale, che aveva preceduto e accompagnato la formazione delle rigidità, avesse
indebolito gli animal spirits degli imprenditori in modo non marginale.
Una seconda linea interpretativa, basata sul concetto di isteresi, sostiene che l’elevata
disoccupazione è stata causata inizialmente da politiche disinflazionistiche, ma che l’alto tasso effettivo
di disoccupazione ha provocato nel corso del tempo un incremento del tasso naturale di
disoccupazione. Il suo valore dipende da numerosi fattori: demografici, minimi salariali, sussidi di
disoccupazione, potere sindacale, grado di centralizzazione della contrattazione salariale97, imposte
contributive sui redditi da lavoro (cuneo fiscale), effetti di isteresi98. In particolare una disoccupazione
elevata è all’origine dell’alta proporzione di disoccupati di lunga durata, e i disoccupati di lunga durata
hanno scarsi effetti sulla determinazione dei salari. In conclusione, non è affatto certo che ci sia
Le iperinflazioni europee del novecento sono state tutte arrestate con programmi di stabilizzazione ortodossi. Molte
stabilizzazioni in America Latina, invece, sono state arrestate con programmi eterodossi. I programmi eterodossi partono dal
presupposto che l’inflazione contenga una forte componente inerziale, dovuta alla presenza di contratti di lavoro
multiperiodali, clausole di indicizzazione salariale del tipo backward-looking, ed altri meccanismi analoghi. In questa situazione
le misure ortodosse possono condurre a recessioni inutilmente profonde. Vedi Sachs J.D., Larrain F., op. cit., pp.1118-20.
Una osservazione che può aiutare a capire la ragione di questa differenza è che le iperinflazioni europee hanno avuto luogo
nella prima metà del secolo, in cui la capacità dei sistemi economici di sopportare recessioni profonde era maggiore, mentre
quelle latino-americane hanno avuto luogo nella seconda metà del secolo in un contesto caratterizzato da un forte controllo
sociale.
95 L’industrializzazione e l’urbanizzazione hanno spinto, nel secondo dopoguerra, verso il basso l’offerta di lavoro femminile
che è uscita dal mercato del lavoro contribuendo così ad abbassare il tasso di disoccupazione. Questo fenomeno si è
invertito a metà degli anni settanta.
96 Mutuando un concetto dalla fisica, gli economisti hanno indicato così la tendenza del tasso naturale di disoccupazione ad
aumentare quando viene superato da quello effettivo e viceversa.
97 Il sistema di contrattazione salariale maggiormente centralizzato, in cui i gruppi rappresentati concedono alle
organizzazioni nazionali di vertice un’ampia delega di negoziare a loro nome, prende il nome di corporativismo. Sistemi
fortemente centralizzati e fortemente decentralizzati sembrano dare luogo a tassi di disoccupazione mediamente inferiori dei
sistemi mediamente centralizzati.
98 Vedi Sachs J.D., Larrain F., op.cit., pp. 765-6.
94
19
un’unica causa di elevata disoccupazione. Infatti, come l’inflazione, nemmeno la disoccupazione è
monocausale.
La politica economica può affrontare queste cause di malessere economico attraverso la teoria
normativa e la teoria positiva. La teoria normativa della politica economica analizza il modo in cui le
autorità di politica economica dovrebbero agire. Gli approcci proposti da Tinbergen e Theil erano
basati sull’ipotesi dell’esistenza di una relazione quantitativamente stabile tra strumenti e obiettivi. Ciò
sfortunatamente non vale sempre per il trade-off tra inflazione e disoccupazione, associato ai successi
ondivaghi della “curva di Phillips trasformata”. Infatti, questo trade-off dipende dai meccanismi impiegati
dagli operatori per formare le proprie aspettative. Le attese adattive danno luogo al principio
accelerazionista. In altre parole se il policy maker tenta di mantenere la disoccupazione al di sotto del
livello naturale in modo permanente, il tasso di inflazione registra un’accelerazione continua. Nel caso
di aspettative razionali, la mancanza di errori da parte degli agenti economici fa sì che l’offerta aggregata
assuma la forma di una relazione tra disoccupazione e variazione dell’inflazione99. In questo caso, il
trade-off tra inflazione e disoccupazione può scomparire anche nel breve periodo. Un’inflazione nulla e
una disoccupazione pari al tasso naturale non sono un cattivo risultato. Sembrerebbe però che la banca
centrale potrebbe fare meglio perseguendo un trade-off incerto tra inflazione e disoccupazione
(accettando un po’ di inflazione, può ridurre notevolmente la disoccupazione), una volta che i salari
sono stati fissati incorporando un’inflazione attesa pari a zero. In teoria dei giochi, questo incentivo a
deviare dalla politica annunciata una volta che gli altri giocatori hanno fatto già le loro mosse, è noto
come “incoerenza temporale” o “incoerenza dinamica” della politica ottimale. Sfortunatamente la storia
non finisce qui e il risultato finale, in presenza di pieno impiego, sarà un’inflazione più elevata. In
questo caso, la politica migliore per la banca centrale è quella di impegnarsi in modo credibile a non
tentare di ridurre la disoccupazione al di sotto del livello naturale100. Ma il problema dell’incoerenza
temporale consiste nella difficoltà che le autorità di politica economica incontrano per essere credibili
anche perché il confronto tra regole e regime discrezionale pone un trade-off tra credibilità e flessibilità
che ha esito diverso a seconda della probabilità di shocks dell’offerta. Apparentemente, la maggior parte
dei paesi non è disposta a seguire regole fisse prive di qualsiasi elasticità. Esistono, peraltro, anche
argomentazioni a favore di un certo grado di discrezionalità. In particolare questa è opportuna quando
il modello economico a disposizione di chi compie le scelte di macroeconomia non è sufficientemente
attendibile, ma anche nel caso in cui si verifichi un evento inatteso. Molti economisti dubitano che tutte
le fluttuazioni del prezzo delle azioni siano dovute a informazioni sui dividendi o sui tassi di interesse.
Essi non dimenticano periodi come l’ottobre nero del 1929, quando il mercato azionario statunitense
scese del 23% in due giorni, o il 13 ottobre del 1987, quando l’indice Dow Jones perse il 22.6% in un
giorno solo 101. La libertà di azione con cui il Governatore della Federal Riserve decise, con un intervento
discrezionale, di finanziare le società colpite dal crollo del mercato azionario del 13 ottobre 1987 è un
buon esempio di come l’applicazione di regole fisse possa portare ad errori gravidi di conseguenze. In
quel modo fu evitato un errore di portata mondiale nelle scelte di macroeconomia. L’adesione a un
piano di politica economica prestabilito può risultare utile nel caso in cui le politiche economiche
ottimali siano dinamicamente coerenti, ovvero che non si attengano a quanto annunciato in precedenza.
In altri termini una politica economica dinamicamente coerente, nella quale le scelte vengono effettuate
periodo per periodo può risultare sub-ottimale. Un tipico esempio di incoerenza dinamica è
rappresentato dalla lotta all’inflazione.
Si tratta del caso polarmente opposto al caso keynesiano estremo secondo cui sia il livello della produzione che quello
dell’occupazione sono determinati in modo univoco dalla domanda aggregata. Infatti, se la produttività del lavoro a è
costante, la funzione di produzione è Q = aL e poiché w è fisso e di conseguenza P è fisso, se w/P è minore di a le imprese
domandano una quantità di lavoro infinita. Vedi Sachs J.D., Larrain F., op. cit., pp.104.
100 I monetaristi, capeggiati da Milton Friedman, sostengono che in pratica, a causa dei problemi informativi e dei ritardi che
intercorrono tra la decisione delle misure di politica economica ed il manifestarsi dei loro effetti, l’opportunità di usare la
politica monetaria per stabilizzare un sistema economico è ridotta. Inoltre, poiché ritengono che la banca centrale non sia in
grado di utilizzare gli strumenti di politica monetaria in modo appropriato e nel pubblico interesse, sono favorevoli
all’adozione di regole di politica monetaria per impedire che le fluttuazioni monetarie destabilizzino l’economia. Vedi Abel
A.B., Bernanke B.S., op. cit., p.861.
101 Vedi Sachs J.D., Larrain F., op.cit., pp.917
99
20
Esiste infine una teoria positiva della politica economica che studia il modo in cui i policy-makers
operano nella realtà e che mostra una tendenza generale verso politiche inflazionistiche. Oltre alle
politiche monetarie ”temporalmente coerenti”, esistono altre spiegazioni di questa tendenza, basate sia
su considerazioni di natura economica che di natura politica. Esempi noti sono: la teoria del ciclo
politico-economico, la difficoltà di consenso su misure impopolari da parte di coalizioni multipartitiche
o da “governi deboli”, l’orizzonte temporale dei politici ridotto al periodo in cui sono al potere, che
genera un conflitto tra diversi gruppi sociali sulla ripartizione dei costi della politica di stabilizzazione102.
Di conseguenza, tutte le teorie che sottolineano la razionalità delle scelte di macroeconomia
dimenticano purtroppo come queste ultime rappresentino spesso il risultato finale di un processo di
contrattazione politica assai complesso.
Il dibattito contemporaneo sul ruolo e l’efficacia delle politiche economiche continua a essere
dominato dalla contrapposizione tra le tesi della nuova macroeconomia classica, da un lato, e quelle
della scuola neokeynesiana, dall’altro. In relazione a queste tesi, sembrano esistere le premesse per la
realizzazione di un nuovo modello consensuale basato sull’approccio: tasso naturale di disoccupazione aggiustamento graduale dei prezzi, che lascerebbe peraltro aperta la discussione sulla maniera più
corretta e più appropriata di attuare in concreto politiche di stabilizzazione e di fare maggiore o minore
ricorso a regole piuttosto che a comportamenti discrezionali.
L’approccio macroeconomico classico poggia le sue fondamenta sulle ipotesi smithiane,
secondo cui gli agenti economici perseguono il proprio interesse e i prezzi si aggiustano abbastanza
velocemente in modo da equilibrare quantità domandate ed offerte. Si tratta di modelli di concorrenza
perfetta, con prezzi e salari perfettamente flessibili, nei quali gli shocks danno origine a fluttuazioni
cicliche nei livelli di produzione e di occupazione103. La neutralità della moneta è una conclusione molto
forte del modello della macroeconomia classica perché l’analisi del ciclo economico mostra che la
moneta appare essere un indicatore anticipatore prociclico. Tuttavia i teorici del ciclo reale sostengono
che il legame causale tra crescita della moneta ed espansioni economiche sia di tipo inverso104. In questo
caso, tuttavia, essi riconoscono alla banca centrale una capacità di azione anticipatrice che le hanno
sempre negato a motivo di ritardi e disinformazione. L’implicazione che discende da questo approccio è
che soltanto le variazioni non previste degli strumenti di politica economica, come una variazione
dell’offerta di moneta, possano influire sul livello delle variabili reali. L’evidenza empirica sembra
tuttavia negare la validità di tale posizione teorica. L’adozione dell’approccio della nuova
macroeconomia classica comporta alcune implicazioni politiche molto forti. Queste si sostanziano nella
proposizione normativa che il governo dovrebbe sempre limitare al massimo il proprio intervento in
economia e nella proposizione positiva che le politiche del governo saranno inefficaci e
controproducenti nel raggiungere gli obiettivi prefissati, come la stabilizzazione delle fluttuazioni
economiche105.
La scuola neokeynesiana condivide l’idea che la sintesi emersa in risposta alla critica delle
aspettative razionali sia fondamentalmente corretta. Insiste però sull’idea che vi sia ancora molto da
imparare sulla natura delle imperfezioni dei diversi mercati e sugli effetti di tali imperfezioni
sull’andamento delle variabili macroeconomiche. Questa ricerca ha anche dato alcune risposte
importanti alle questioni addebitate al modello keynesiano negli anni settanta.
L’obiettivo della politica monetaria, come quello della politica economica in generale,
nell’approccio tradizionale, è la promozione del benessere economico dei cittadini. Gli economisti
classici e keynesiani concordano sul fatto che, nel lungo periodo, la politica monetaria influenza solo il
tasso di inflazione, senza produrre effetti reali. Quindi, secondo entrambe le scuole, la politica
monetaria dovrebbe essere impiegata per mantenere basso e stabile il tasso d’inflazione di lungo
periodo106. Sia secondo il modello classico sia secondo quello keynesiano, il tasso di disoccupazione
effettivo può deviare dal tasso naturale nel breve, ma non nel lungo periodo. Si tratta di un’accettazione
Ibidem, pp.919-20.
Ibidem, pp.815-6.
104 Vedi Abel A.B., Bernanke B.S., op. cit., p.583.
105 Ibidem, p.51.
106 Ibidem, p.839.
102
103
21
definitiva, da parte dei neokeynesiani, della “sintesi neoclassica”, con la quale Hicks e Samuelson
avevano ridotto il modello di Keynes ad un caso particolare, all’interno del modello neoclassico,
caratterizzato dalla presenza di rigidità nominali.
Tra le posizioni minoritarie, ma influenti, è emersa negli Stati Uniti tra la fine degli anni settanta
e i primi anni ottanta la “economia dell’offerta”, la cui tesi fondamentale è che la macroeconomia
keynesiana è stata sviluppata su fondamenti erronei e ha condotto a conseguenze deprecabili per aver
trascurato gli effetti sull’offerta delle misure di controllo della domanda. In particolare, l’economia
dell’offerta afferma che l’eccessivo carico delle imposte, conseguente alla dilatazione della spesa
pubblica di ispirazione keynesiana, ha anche effetti disincentivanti sull’offerta di lavoro, sul risparmio e
sull’investimento, con il risultato di contribuire a produrre una riduzione della crescita economica di
fatto sperimentata107. Questa tesi è tuttavia inattendibile con riguardo sia alla ”erroneità dei fondamenti
della macroeconomia keynesiana”, come è stato già ricordato, sia alle sue “conseguenze deprecabili” che
in effetti si sono verificate, ma sono riconducibili a uno stravolgimento della macroeconomia
keynesiana, anche se perpetrato nel nome di Keynes. Per questo si può avanzare l’ipotesi che il
fallimento delle politiche posteriori agli anni ’60 non derivò dal fallimento dell’economia keynesiana,
bensì dall’incapacità, o forse dal rifiuto, della nostra generazione di analizzare con chiarezza le
condizioni necessarie e sufficienti per coniugare alti livelli di occupazione e bassi tassi d’inflazione, di
identificare i mutamenti istituzionali necessari per conseguire questi obiettivi, curando, naturalmente, di
favorire il consenso connesso a tali mutamenti, invece di perseguire obiettivi tutt’altro diversi da quelli
dichiarati. In questo modo gli epigoni di Keynes hanno consentito, se non favorito, l’estremizzazione
del modello di Keynes108 e la sua delegittimazione teorica prima di intraprendere un percorso virtuoso,
come quello di Keynes, che si era spinto fino a rovesciare le sue impostazioni originarie109.
Per quanto riguarda il tema dell’assegnazione appropriata di strumenti agli obiettivi di politica
economica, le tesi di Kaldor sull’endogenità della domanda di moneta e sulla scarsa mobilità dei capitali
hanno previsto una combinazione diversa da quella suggerita da Mundell, che corrisponde al
programma di politica economica della Vecchia Scuola di Cambridge, e associa la politica fiscale
all’obiettivo interno e la politica monetaria all’obiettivo esterno. In una teoria in cui i prezzi risultano
determinati dai costi sulla base del principio del mark-up, il controllo dell’inflazione viene esercitato dalla
regola fondamentale della politica dei salari. Queste tesi sono state sottoposte a una radicale revisione a
metà degli anni settanta, attraverso una ipotesi forte, detta anche “legge di Godley”, da parte dei
rappresentanti della Nuova Scuola di Cambridge. Con questa ipotesi si è affermata la sostanziale
compensazione, nel settore privato, tra la variazione delle attività finanziarie delle famiglie e quella delle
passività nette delle imprese. Il saldo finanziario nullo del settore privato, che implica una propensione
alla spesa pari all’unità, insieme all’ipotesi di esogenità del saldo del settore pubblico, produce il risultato
di invertire l’assegnazione appropriata degli strumenti agli obiettivi di politica economica. La Nuova
Scuola ha sostenuto, infatti, che la politica fiscale doveva essere utilizzata per il conseguimento
dell’obiettivo esterno, mentre la politica valutaria andava finalizzata all’obiettivo interno. Ma queste
conclusioni riposavano in maniera cruciale su ipotesi inattendibili. Le conclusioni della Nuova Scuola
sembrano pertanto destituite di fondamento e risulta pertanto impossibile assegnare uno strumento
piuttosto che un altro a uno specifico obbiettivo.
In conclusione, nonostante le differenze nelle posizioni teoriche recenti, vi è un nucleo di teoria
macroeconomica sul quale vi è un ampio consenso. Esso si articola in due proposizioni fondamentali:
nel breve periodo le variazioni della domanda aggregata influenzano la produzione; nel lungo periodo la
produzione torna al suo livello naturale110.
4. ERRORI NON EVITATI NELLE SCELTE DI MACROECONOMIA
107Vedi
Bianchi C. op. cit., pp. 237-8.
Qui il riferimento è allo stravolgimento dello schema di Keynes estraneo alla forzatura dei limiti della politica economica.
109 Vedi a questo riguardo. Romagnoli G.C, “Keynes e Wittgenstein tra le due guerre”, in Basciani A. e Clementi M. (a cura
di), Intellettuali, storici ed economisti davanti ai totalitarismi dell’Europa centro-orientale, Quaderni di Roma Tre, Roma,
2005.
110 Vedi Bianchi C., op.cit., pp.243-6
108
22
La lunga riflessione su alcuni dei temi del dibattito teorico sulle scelte di macroeconomia
introduce ora alla rilevazione degli errori commessi nelle scelte concrete di macroeconomia. Questo
tema, già molto ampio se riferito a un singolo paese, assume dimensioni sconfinate se si guarda al
mondo intero. La preferenza per una visione aperta sugli argomenti di malessere economico del mondo
ha privilegiato la dimensione orizzontale della questione, rispetto a quella verticale, e ha condotto ad
indicare alcuni errori nelle scelte di macroeconomia nelle realtà italiana, europea, statunitense, asiatica,
latino-americana e africana.
Nel secolo XIX la Gran Bretagna intraprese una liberalizzazione unilaterale degli scambi
internazionali. Alla fine del XX secolo, gli Stati Uniti hanno intrapreso il cammino verso la
globalizzazione dei mercati spostando l’attenzione dai redditi medi nazionali e dalla questione se i
redditi pro capite dei diversi paesi siano convergenti o divergenti alla questione su come rispondono i
governi democratici dei paesi più ricchi man mano che si realizzeranno sempre di più le previsioni del
teorema del pareggiamento dei prezzi dei fattori di produzione. Nel frattempo è aumentato il costo
politico del rifiuto di consentire il libero scambio (il paradosso è dato dal fatto che dovendo essere la
convenienza, e non la prescrizione, alla base della crescita del trade, da anni i paesi più poveri si vedono
costretti dal ricatto finanziario estero ad aprire unilateralmente i loro mercati). Non è più possibile
invocare l’abbandono dell’economia globale come mezzo di soluzione dei problemi economici
interni111. Dove il protezionismo persiste, ad eccezione dell’agricoltura, viene attuato il più furtivamente
possibile, utilizzando terminologie oscure e palesi artifici, come quello che tende ad accreditare come
distorsivi i dazi europei e come non distorsivi quelli statunitensi.
La globalizzazione porta a compimento il capitalismo in quanto rimuove la pressione dei salari
sui profitti a livello planetario, ma non affronta la preoccupazione keynesiana della redistribuzione
mondiale del reddito e della ricchezza.
4.1 IN ITALIA
Gli errori nelle scelte di macroeconomia, in Italia, si sono concentrati negli anni settanta e
ottanta. In estrema sintesi, durante gli anni settanta, i governi hanno lasciato crescere una spesa
pubblica finalizzata a un disegno perverso dello stato sociale112, dando luogo, nonostante il consistente
aumento del gettito tributario, a deficit primari sempre maggiori e crescenti finanziati attraverso il
debito pubblico. Ciò ha dato luogo all’aumento dell’inflazione e all’indicizzazione dei salari nominali che
sono state accompagnate da svalutazioni periodiche del tasso di cambio compensative dell’inflazione.
Nel decennio successivo, i governi non hanno attuato politiche di rientro del debito, lasciando che i
tassi d’interesse nominale elevati continuassero ad espandere il deficit e il debito dando luogo a
inflazione elevata e frequenti svalutazioni della moneta.
I sindacati dei lavoratori e degli imprenditori attuarono, a metà degli anni settanta,
l’indicizzazione dei salari nominali, per cui questi ultimi venivano aggiustati secondo l’andamento
dell’indice dei prezzi al consumo. In Italia venne così introdotta la cosiddetta “scala mobile” che, con
un diverso grado di copertura discendente all’aumento dei salari113, ne difese il potere d’acquisto
dall’inflazione fino alla prima metà degli anni ottanta. Questo tipo di indicizzazione salariale si rivelò
particolarmente problematico in due circostanze: la presenza di shocks negativi dal lato dell’offerta
rappresentati dagli aumenti dei prezzi del petrolio e l’adozione di politiche antinflazionistiche. In
entrambi i casi, la presenza di clausole di indicizzazione di tipo backward looking rallentò il processo di
aggiustamento del salario reale al suo nuovo livello di equilibrio fissato dall’esito del confronto tra i
Vedi Hillman A.L.,”La Politica del commercio internazionale per gli anni 2000”, in Corsetti G., Rey G.M., Romagnoli
G.C. ( acura di), Il futuro delle relazioni economiche internazionali, volume curato in collaborazione con Franco Angeli,
Milano, 2001.
112 Vedi Romagnoli G.C., “Anagrafe dei bisogni e lotta alle povertà”, Nuovi studi politici, n. 1-2, 1997, passim.
113 I salari minori erano coperti quasi al 100%.
111
23
poteri contrattuali delle forze sociali114 e accrebbe i costi della disinflazione in termini di contrazione
della produzione e dell’occupazione.
Nei venti anni precedenti l’istituzione dell’Unione monetaria europea, l’Italia ha svalutato molte
volte la propria moneta pur avendo aderito ad un meccanismo di cambio in un regime di cambi fissi.
L’argomentazione principale a favore della svalutazione fu sempre che essa aiutava l’economia ad
aggiustarsi più velocemente e a un costo minore in termini di disoccupazione. In questo modo però
venne vanificato lo scopo di stabilizzazione intrinseco all’adozione di un regime di tassi di cambio fissi.
Le svalutazioni resero la banca centrale più ricca e il settore privato più povero115. Da questa esperienza
l’Italia ha tratto la conclusione che il governo può di fatto essere svantaggiato dalla possibilità di
svalutare. L’anticipazione di una svalutazione, infatti, può indurre i mercati finanziari a chiedere tassi di
interesse molto elevati, aggiungendo al problema della sopravvalutazione anche quello di tassi di
interesse proibitivi, e costringendo in tal modo il governo a svalutare, al fine di evitare una crisi
valutaria, anche se esso non aveva intenzione di farlo.
Lo stato sociale, che avrebbe dovuto essere disegnato in modo da ottenere, ove possibile, dagli
individui, dalle loro famiglie e dalle loro associazioni i loro sforzi migliori, è divenuto invece la risposta
pubblica all’egoismo individuale in nome del consenso politico. In molti casi è diventato un sostituto
della responsabilità, della libertà, dell’autocontrollo e della legge favorendo il pericolo dell’indolenza e il
nuovo leggero dispotismo profetizzato da Tocqueville, in cui i gruppi di interesse lottano per
conquistarsi i favori dello Stato. Ciò ha condotto anche l’Italia, negli anni novanta, e con almeno un
decennio di ritardo rispetto agli altri paesi europei, a decentralizzare, a privatizzare, e a sostituire le
burocrazie statali con altre istituzioni della società civile. Invece non si è ancora abbandonato lo stato
sociale universalistico che è amorale, inefficiente e iniquo116 creato a fronte di un debito pubblico che è
rimasto tra i più elevati in Europa.
Si sostiene infine che uno dei maggiori tra gli errori nelle scelte di macroeconomia commessi in
Italia sia stato quello di privatizzare prima di liberalizzare. Ciò ha condotto dalle inefficienze dei
monopoli pubblici a quelle dei monopoli, o quasi, dei privati117. Tuttavia, i vizi della politica, la
prevaricazione degli interessi costituiti, gli errori dei regolatori nelle modalità di accesso alle reti e nella
Nessuno di questi shocks richiede, per sua natura, una diminuzione del salario reale come invece viene affermato in
alcuni manuali di macroeconomia. Vedi Sachs J.D., Larrain F., op.cit., pp. 722. Tuttavia, nel 1977 fu necessario un congresso
sindacale per riaffermare che il salario non poteva essere considerato una variabile indipendente.
115 Infatti l’aumento repentino del livello dei prezzi, determinato dalla svalutazione, riduce le scorte monetarie reali degli
operatori, che essi compensano attraverso la liquidazione dei titoli esteri. Allo stesso tempo, la ricchezza che defluisce dal
settore privato viene interamente incamerata dalla banca centrale. Vedi Sachs J.D., Larrain F., op.cit., pp.470-1.
116 Jim Buchanan prevede la generalizzazione degli obiettivi della scelta politica e il rifiuto di una specificità nella
applicazione della normativa che regola il trattamento economico di persone e gruppi. Il punto interessante qui è che non
sarebbero i politici ad abbandonare il perseguimento dell’interesse pubblico perché motivati diversamente, ma è la struttura
della politica in cui agiscono che li obbliga ad agire contro l’interesse pubblico se vogliono sopravvivere come politici. La
struttura degli incentivi della politica assicura la sopravvivenza a quei politici che si allontanano dall’interesse pubblico.
Pertanto i politici devono seguire il proprio interesse, piuttosto che quello collettivo, per la stessa ragione per cui gli
imprenditori nel settore privato sono costretti a massimizzare i profitti. In sintesi, la sopravvivenza costringe il politico a
sostituire la specificità nella normativa con la generalità; ma la ricerca della generalità, come quella delle rules versus
discretion, conduce la politica a un ruolo di mediazione iniquo e inefficiente. Il paradosso è che i politici non sono
nemmeno responsabili di questo! Certo questa visione spiega molto bene gli approcci universalistici dei sistemi di sicurezza
sociale e delle politiche sanitarie, tuttora conservati e difesi nelle attuali proposte di legge, dove il trattamento differenziale
che discrimina a favore dei bisognosi si verifica raramente. Cfr. Romagnoli G. C., “Anagrafe…”, cit., pp. 113-30.
117 “Il prodotto totale che il monopolista può ottenere vendendo quantità crescenti di una merce, non cresce con l’aumento
della quantità smerciata, ma cresce soltanto fino a un limite massimale, dopo del quale decresce fino a zero, e ciò perché i
prezzi unitari ribassano in una qualche ragione con gli aumenti della quantità smerciata…Quindi, ogni qualvolta la quantità
disponibile della sua merce supera quella per la quale egli realizza il prodotto lordo massimo, egli avrà un interesse a
distruggerne una parte, o di ritirarla in qualunque altro modo dalla offerta effettiva, e sovratutto quella di non
produrla;…Quando poi il monopolista preferisce determinare il prezzo, egli si fermerà da principio su quelli
maggiori,…All’incontro, in caso di concorrenza tra venditori, non vi sarà mai un interesse per alcuno dei competitori di
trattenere dall’offerta una parte …perché il rialzo del prezzo che ne deriverebbe, andrebbe a benefizio certo dei competitori,
mentre sarebbe incerto l’aumento del proprio prodotto lordo per chi ciò facesse in conseguenza della quantità minore delle
unità della merce che resterebbe da vendere a prezzi rialzati …finalmente, in quanto alla determinazione del prezzo di ogni
unità di merce, ogni competitore dovrà dal bel principio a preferenza fissarsi sul minimo che è compatibile con un
profitto…”. Vedi Pantaleoni M., Principii di economia pura, Cedam, Padova, 1970, pp. 168-70.
114
24
dinamica delle tariffe, che si aggiungono alla cattura dei regolatori da parte dei regolati, mostrano che i
processi di liberalizzazione nel settore dei servizi pubblici mantengono aperto il fronte dei conflitti tra
gli interessi costituiti e le ragioni della concorrenza.
4.2 IN EUROPA
Esiste, in Europa, un caso storico di gestione della domanda aggregata che riveste un notevole
interesse tra gli errori nelle scelte di macroeconomia. Nel 1925 la Gran Bretagna, per iniziativa di
Winston Churchill e contro l’avviso di Keynes118, decise di ritornare al Gold Standard. A questo fine, il
governo britannico fu costretto a perseguire una politica monetaria restrittiva e a rivalutare la sterlina
del 10%, con la conseguenza di contrarre fortemente la domanda aggregata. Keynes aveva percepito
che la manovra avrebbe portato, oltre che ad una contrazione della domanda, anche a una riduzione di
prezzi, ma non ad una proporzionale riduzione dei salari nominali. Di conseguenza le imprese
sarebbero state costrette a ridurre la domanda di lavoro, con l’effetto di esacerbare la recessione. I fatti
diedero ragione a Keynes. Se le ipotesi classiche di flessibilità dei prezzi e dei salari fossero state valide,
la politica di Churchill non avrebbe avuto conseguenze sulla produzione e sull’occupazione. Ma le cose
andarono diversamente119.
Qualche decennio dopo, si può considerare un errore grave quello commesso dal governo
tedesco in occasione della riunificazione territoriale delle due Germanie. Questa portò con sé una forte
divergenza di obiettivi tra la Bundesbank e le altre banche centrali dei paesi membri dello Sme, anche se
questa politica, dando origine al deficit commerciale tedesco, incrementò la loro domanda di
esportazione. Gli effetti di ordine macroeconomico dell’unificazione erano stati i seguenti: la necessità
di ingenti trasferimenti alla Germania orientale e la forte espansione degli investimenti. Questi avevano
portato ad un significativo aumento della domanda globale del Paese. Il timore di un aumento eccessivo
dell’attività economica indusse la Germania ad una politica monetaria restrittiva, accompagnata da un
brusco aumento dei tassi nominali d’interesse. Questo poteva anche essere il giusto mix per la
Germania, ma non altrettanto per gli altri paesi ad essa legati nello Sme, che, secondo gli accordi,
dovettero allineare i loro tassi d’interesse nominali a quelli tedeschi, pur senza aver registrato gli stessi
aumenti della domanda. Ciò dette luogo a un brusco calo della domanda e della produzione e, di
conseguenza, a scarsa crescita e a disoccupazione crescente. Inoltre, a causa di un’inflazione attesa
inferiore in questi paesi, ne risultò per loro un aumento dei tassi reali120 molto maggiore di quelli
tedeschi. Nel 1992, la disoccupazione media nell’UE, che nel 1990 era dell’8,7%, aumentò al 10.3%121.
Nei primi anni novanta i paesi dell’Europa dell’Est hanno abbandonato il sistema economico di
pianificazione centralizzata per una transizione verso l’economia di mercato. Sono stati raggiunti
risultati considerevoli, ma l’aspetto sociale è stato particolarmente doloroso. In seguito alle misure di
liberalizzazione dei prezzi e della privatizzazione delle imprese pubbliche, le economie in transizione
hanno subito un profondo cambiamento strutturale, ma il cambiamento drammatico ha riguardato la
contrazione della produzione. In Europa Centrale il declino della produzione è stato minore che nei
paesi dell’ex Unione Sovietica (nel 1995, in Russia la produzione registrata era pari al 47% di quella del
1989, in Ucraina era pari al 43% di quella del 1989). Questi dati rappresentano un vero e proprio crollo
se si pensa che nel 1933, il Pil reale statunitense era pari al 66% del suo livello del 1929122. Tra i molti
fattori che hanno contribuito alla caduta delle economie pianificate, il principale è stato il loro
fallimento come sistema economico. Da qui l’origine economica della transizione. Il crollo della
produzione è stato in gran parte il risultato di un processo di cambiamento strutturale. Il settore statale,
che era sovradimensionato e produceva molti beni non più richiesti dal mercato, ha sofferto una forte
Vedi Keynes J. M., “The Economic Consequences of Mr. Churchill”, in Idem, Essays in Persuasion, Macmillan, London,
1931.
119 Vedi Sachs J.D., Larrain F., op.cit., pp. 113-6.
120 I tassi di interesse reali sono calcolati sottraendo ai tassi nominali il tasso d’inflazione attesa. La proposizione generale è
che i paesi con inflazione più elevata tendono ad avere tassi di interesse più alti, per cui le differenze nei tassi di interesse
reali sono generalmente inferiori alle differenze nei tassi nominali.
121 Vedi Blanchard O., op. cit., pp.312-3.
122 Ibidem, pp.569-72.
118
25
riduzione di produzione. La domanda di nuovi beni, e quindi del prodotto del nuovo settore privato, è
stata alta, ma la crescita del settore privato era ostacolata da molti fattori, soprattutto dalla mancanza di
capitale, dal funzionamento insufficiente del sistema bancario e dalla mancanza di esperienza e di
personale qualificato. L’aumento di produzione dl nuovo sistema privato è stato insufficiente a
compensare la riduzione della produzione statale. Ciò ha generato una riduzione netta del prodotto
aggregato e dell’occupazione con gravi ripercussioni sul tenore di vita e addirittura sulle capacità di
sussistenza anche a causa di periodi di inflazione elevata originati da enormi disavanzi di bilancio123 che i
paesi membri della UE avrebbero potuto finanziare in maniera maggiore. Questo è un punto di
contatto con quanto è avvenuto in altri casi di iperinflazione. Esistono, tuttavia, aspetti peculiari di
queste economie che è necessario considerare per correggere le scelte di macroeconomia: 1. le imprese
statali non sono sottoposte a vincoli di bilancio stringenti; 2. nelle medesime imprese non esiste alcuna
disciplina salariale; 3. lo Stato effettua ingenti trasferimenti sotto forma di sussidi a favore delle famiglie
e delle imprese; 4. esiste una eccessiva disponibilità di risorse monetarie. Questa situazione ha posto i
governi di alcuni di questi paesi davanti alla difficile alternativa tra una rapida ristrutturazione delle
imprese statali (che genera ulteriore disoccupazione, con la prospettiva di un aumento della produttività,
della produzione e dell’occupazione nel lungo periodo) e il mantenimento dei livelli occupazionali (che
tuttavia costringe i governi a sussidiare le imprese statali e le famiglie con il risultato di rallentare la
transizione, e inoltre di generare ampi disavanzi di bilancio, forte crescita della quantità di moneta e alta
inflazione). Si tratta di errori che sarà possibile eliminare solo gradualmente in un sistema democratico.
Negli anni recenti vi è stato un ampio dibattito sulle diverse strategie che l’autorità monetaria
europea (Bce) può perseguire per realizzare l’obiettivo della stabilità dei prezzi. Al riguardo sono stati
studiati in particolare due approcci denominati rispettivamente monetary targeting (basato sull’annuncio
utile di un tasso di crescita della quantità di moneta) e inflation targeting (basato sull’annuncio astratto,
perché indipendente dalla situazione economica, e quindi dalla disoccupazione, di un sentiero
desiderato per l’inflazione futura). La strategia della Bce, che è stato ufficialmente denominato “strategia
di politica monetaria orientata alla stabilità”, non si identifica con nessuna delle due alternative. Esso è
di fatto un approccio intermedio basato su due pilastri: la quantità di moneta e la valutazione delle
previsioni sugli andamenti dei prezzi, nell’area dell’euro, e dei rischi per la loro stabilità. Ma, al contrario
di quanto previsto dallo statuto della Federal Riserve, la disoccupazione involontaria rimane fuori da
questa valutazione.
4.3 N EGLI STATI U NITI
La dichiarazione di Nixon circa l’inconvertibilità “temporanea” del dollaro dette un colpo
definitivo al sistema di pagamento internazionale noto come Gold-Exchange Standard o sistema
monetario a cambio aureo, che parificando il dollaro all’oro, aveva consentito agli Stati Uniti, per anni,
di indebitarsi con gli altri paesi senza mai pagare. Nella misura in cui i saldi in dollari detenuti fuori degli
Stati Uniti non sono più convertibili in oro, il substrato comune di tutte le monete convertibili non è
più l’oro, ma bensì il dollaro. Anche in precedenza, a causa delle pressioni morali esercitate dal governo
americano sui governi amici e su quelli che ne ricercavano l’amicizia, il cambio dei dollari in oro non
poteva essere ottenuto. Sicché il dollaro era diventata una moneta convertibile finché non se ne fosse
richiesta la convertibilità. Gli espedienti della Federal Reserve finalizzati a non intaccare il dollaro, e che al
massimo hanno migliorato la bilancia dei pagamenti americana facendo diminuire l’avanzo degli altri
paesi, nulla hanno fatto per eliminare il male alla radice, cioè l’insolvibilità del dollaro124. Questo
problema di vulnerabilità è nato dal fatto che il sistema a cambio aureo aveva comportato l’aumento dei
saldi in dollari in relazione al deficit della bilancia dei pagamenti degli Stati Uniti. Questi avrebbero
potuto, in teoria, risolvere il problema e correggere l’errore, riassorbendo i surplus di disponibilità
dovuti al rientro nei loro paesi di origine dei versamenti compiuti all’estero. Ma l’esperienza ha costretto
a constatare che una simile eventualità è puramente teorica. In un regime non totalitario è inconcepibile
che le autorità monetarie di un paese a moneta di riserva possano creare, mediante il riassorbimento di
123
124
Qui il riferimento principale è ai processi di iperinflazione polacca e jugoslava che si sono verificati a partire dal 1989.
Vedi Rueff J., L’errore monetario dell’Occidente, Etas-Kompass, Milano, 1971. pp.159-60.
26
potere di acquisto, una contrazione monetaria equivalente a quella che in un regime aureo, considerato
barbaro e superato, uno stesso deficit di bilancia dei pagamenti avrebbe causato. Vi è una differenza
enorme fra l’effetto lento e progressivo esercitato giorno per giorno, dunque insensibilmente, dalle
variazioni di potere d’acquisto che risultano dai regolamenti internazionali e le conseguenze subitanee,
enormi e generalmente drammatiche di contrazioni decise dalle autorità monetarie. L’opinione pubblica
non accetterebbe più la cieca tutela della moneta125. L’analisi compiuta da Jacques Rueff a questo
riguardo è senza dubbio molto convincente. Nondimeno, il suo errore maggiore consiste proprio nella
sua proposta di correzione, sebbene una delle regole storicamente adottate sia consistita proprio nel
chiedere alla banca centrale di mantenere il prezzo dell’oro a un livello prefissato. Infatti, questa era la
regola di base del Gold Standard, e gli esiti attesi da una sua riedizione erano stati già sperimentati dal
ritorno della Gran Bretagna a questo sistema di pa gamento nel 1925. Il compito di ristabilire l’equilibrio
della bilancia dei pagamenti statunitense senza ricorrere a metodi della regolazione monetaria,
considerati barbari e superati, lascia l’alternativa di applicare controlli amministrativi con un rigore
proporzionale alle pressioni politiche del resto del mondo che si pone questo obiettivo.
Venendo ai nostri giorni, si può osservare che il maggior problema economico degli Stati Uniti
negli ultimi venti anni si è complicato con la crescita dei deficit gemelli, il deficit di bilancio e il deficit
della bilancia commerciale. Nel 1980, Ronald Reagan fu eletto sulla base della promessa di una
riduzione dell’imposizione fiscale e dell’intervento pubblico nell’economia. Di fatto l’Amministrazione
volle tagliare le imposte senza ridurre proporzionalmente la spesa pubblica. La responsabilità di questa
scelta venne associata a un gruppo marginale, ma influente, di economisti fautori dell’economia
dell’offerta, secondo i quali una riduzione delle aliquote fiscali avrebbe indotto le persone e le imprese a
lavorare di più e in modo più produttivo, e questo aumento di attività avrebbe aumentato, e non
ridotto, il gettito fiscale. Invece il gettito diminuì e il disavanzo di bilancio aumentò, anche perché la
riduzione della spesa che avrebbe dovuto accompagnare la riduzione del gettito non fu sufficiente. Gli
effetti di questa espansione fiscale, accompagnata da una stretta monetaria, furono coerenti con quelli
del modello Mundell-Fleming. Ciò diede luogo alla danza del dollaro negli anni ottanta, un brusco
apprezzamento nel primo quinquennio, seguito da una caduta nel secondo, guidata dalle variazioni dello
stesso segno dei tassi di interesse reali. L’aumento dei tassi fu la conseguenza dell’espansione fiscale
accompagnata dalla stretta monetaria. I paesi europei furono costretti ad allineare verso l’alto i loro tassi
nominali a quelli statunitensi, importando così un ciclo negativo per le loro economie. La “benevola
negligenza” statunitense anticipò di dieci anni quella tedesca che è stata già ricordata. Dai suoi costi
derivò la scelta europea di accelerare l’unione monetariacompleta. La successiva caduta dei tassi
statunitensi fu dovuta a una politica monetaria meno restrittiva. La maggiore crescita della produzione
che ne seguì, insieme all’apprezzamento del dollaro, generarono un consistente disavanzo commerciale
finanziato dal surplus del conto finanziario. L’apprezzamento della valuta nazionale, causato
dall’afflusso di capitali dal resto del mondo, equivalse a un deprezzamento delle valute europee126.
4.4 IN ASIA
Non sempre le fluttuazioni del tasso di cambio reale sono causate da corrispondenti variazioni
dei tassi di interesse reali. A volte le fluttuazioni del tasso di cambio reale sono dovute ad accordi
internazionali, come fu il caso, nel 1990, della rivalutazione dello yen al Plaza Hotel di New York127.
Nella prima metà degli anni novanta lo yen si è rivalutato del 40% circa rispetto al dollaro. Nonostante
Stime dei ricercatori della Fed hanno suggerito che forse più della metà dello stock di moneta statunitense è detenuta
all’estero. Vedi Blanchard O., op.cit., p.259.
126 Politiche di segno contrario danno luogo beggar thy neighbour policies, poiché l’aumento della produzione di un paese
avviene a spese di una sua diminuzione nel resto del mondo. Altrettanto non avviene, invece, nel caso di una politica fiscale
espansiva. Vedi Sachs J.D. e Larrain F., op. cit., pp.638-9. In un’economia aperta, i vari tipi di shock possono avere origini
interne o esterne al paese. L’evidenza empirica suggerisce che all’interno dei paesi industrializzati i cicli economici
presentano un grado marcato di conformità e sincronia. Ibidem, p.817.
127 Questo riconoscimento esime gli economisti dalla proposizione di tesi prive di significato. A questa categoria appartiene,
in questo caso, quella di Blanchard: “A volte le fluttuazioni del tasso di cambio reale sono dovute all’andamento del tasso di
cambio reale di lungo periodo”. Idem, op. cit., p.426-7.
125
27
l’apprezzamento dello yen, l’avanzo commerciale giapponese rimase piuttosto consistente per tre
possibili motivi (effetti dinamici della curva J, effetti del ciclo economico sulla bilancia commerciale,
aspettative dei mercati finanziari). Tuttavia, l’inversione delle aspettative derivata dalla rivalutazione
subita, congiunta alle debolezze del sistema finanziario giapponese, diedero luogo ad una stagnazione
ultradecennale dell’economia.
Negli ultimi 40 anni, alcuni paesi dell’estremo oriente - Corea del Sud, Indonesia, Singapore,
Taiwan - cui si sono aggiunti da tempo alcuni paesi poveri - Filippine, Indonesia, Malaysia e Thailandia
e, più recentemente - Cina e India -, sono cresciuti ai ritmi più sostenuti del resto del mondo. Tuttavia
dal 1997 al 1999, alcuni di questi paesi - Thailandia, Corea, Indonesia e Malaysia - sperimentarono una
grave crisi finanziaria ed economica provocata dal ritiro immediato dei capitali da parte degli investitori
esteri che ha innescato un crollo sui mercati azionari e valutari nazionali. Ciò fece scoppiare la bolla
speculativa irrazionale creata in precedenza da un consistente afflusso di dollari che aveva allontanato le
quotazioni di borsa dai valori fondamentali. Le banche e le imprese di quei paesi che si erano indebitate
in dollari dichiararono la bancarotta. Questo è un esempio evidente dei rischi per l’autonomia dei
governi nazionali associati alla instabilità finanziaria e alla volatilità dei cambi che i movimenti
speculativi incontrollati dei capitali possono creare, come è stato evidenziato da Tobin e Minsky.
Ridurre questi rischi, ad esempio evitando che bolle speculative razionali si trasformino in bolle
irrazionali128, contribuirebbe ad allontanare crisi finanziarie, economiche e politiche che la
liberalizzazione dei capitali può indurre, indipendentemente dai fondamentali di un’economia, dando
luogo anche a riduzione dei crediti, declino della produzione e dell’occupazione.
4.5 IN AMERICA LATINA
Uno dei problemi principali problemi in molti paesi dell’America Latina, nel secondo
dopoguerra, è stata l’inflazione elevata. Il caso più eclatante è stato quello della Bolivia che tra il gennaio
1984 e il settembre 1985 sperimentò un aumento dei prezzi di circa 1000 volte in 21 mesi129. Se si
pongono a confronto il tasso medio di inflazione dei paesi industrializzati con quello dei paesi
dell’America Latina negli anni ottanta, si vede che mentre il primo non superò mai il 10%, il secondo si
mantenne al di sopra del 100% per 6 anni su 10 e nell’ultimo anno superò il 1000% l’anno. La ragione
comune di questi episodi di iperinflazione è data dall’alta crescita della moneta a causa di ampi disavanzi
di bilancio non finanziabili altrimenti a causa di forti shocks. Il pesante fardello del debito estero
gravante sui governi della maggior parte dei paesi dell’America Latina ha giocato un ruolo fondamentale
all’interno di tale processo. In primo luogo ha accresciuto le dimensioni del deficit di bilancio; in
secondo luogo, limitando la possibilità di ricorrere ai mercati internazionali dei capitali130, come nel caso
boliviano, ha favorito il finanziamento dei disavanzi tramite la creazione di base monetaria131. Nel corso
di un’iperinflazione le persone riducono i loro saldi monetari reali in svariati modi: attraverso il baratto,
la maggiore frequenza dei pagamenti salariali, l’acquisto immediato dei beni di cui hanno bisogno, il
passaggio ad altre valute come riserva di valore. Poiché in virtù del processo di dollarizzazione, la legge
della parità del potere d’acquisto tende ad essere rispettata in maniera pressoché perfetta, la
stabilizzazione del tasso di cambio rappresenta la chiave per arrestare l’inflazione, dal momento che
Le bolle speculative sono razionali se gli agenti hanno aspettative razionali sul valore fondamentale dei titoli, sono
irrazionali nel caso contrario. Una condizione necessaria perché la bolla sia razionale è che la sua dimensione aumenti più
lentamente dell’economia di riferimento.
129 Si è trattato di un episodio di iperinflazione (40% di media mensile) paragonabile, anche se di molto inferiore a quelli
molto noti della Germania di Weimar (322% di aumento mensile) dopo la prima guerra mondiale e dell’Ungheria (19800%
di aumento mensile dei prezzi che ha condotto a moltiplicare per 3800 miliardi di miliardi di volte la spesa di un “pengo” in
12 mesi) e della Grecia (365% di aumento mensile) dopo la seconda guerra mondiale. Vedi Blanchard O., op. cit., pp.619-20.
130 Il rischio di insolvenza dei paesi debitori porta inoltre i creditori a non rinnovare i prestiti oltre il limite che il creditore
ritiene possa essere restituito con certezza.
131 Vedi Sachs J.D., Larrain F., op.cit., pp.491-2. Durante il periodo 1982-85, i paesi dell’America Latina effettuarono
trasferimenti netti annui di risorse verso il resto del mondo per un ammontare corrispondente al 4,2% del loro Pil,
trasferimenti quasi doppi di quelli effettuati dalla Germania (pari a circa il 2,5% del Pil) a favore delle nazioni alleate vincitrici
della Prima Guerra Mondiale. Ibidem, pp.1050-1.
128
28
esso costituisce il legame fondamentale fra i prezzi in dollari e i prezzi in valuta interna132. La
stabilizzazione del tasso di cambio è tuttavia impossibile, a meno che non venga riportato sotto
controllo il disavanzo di bilancio dal cui finanziamento in moneta è nata appunto l’iperinflazione.
La politica di bilancio e l’indebitamento estero hanno dato luogo ad errori ripetuti in molti paesi
di questo continente. A questi si aggiunsero misure di politica economica adottate dai paesi debitori che
svolsero un ruolo determinante nello sviluppo delle crisi ricorrenti. Espansione eccessiva della spesa
pubblica, forte chiusura al commercio internazionale, apprezzamenti eccessivi delle valute nazionali che
favorirono massicce fughe di capitali rappresentarono ulteriori errori commessi dai policy makers dei
paesi indebitati nelle scelte di macroeconomia. L’esperienza storica ha dimostrato che il metodo più
sicuro per uscire da una crisi debitoria, quale quella dei paesi in via di sviluppo (pvs) a partire dagli anni
ottanta, consiste nel combinare misure di austerità interna a una riduzione negoziata dell’onere del
debito133.
Questo argomento suggerisce un ultimo caveat con riguardo all’aggregazione nei casi in cui ciò
faccia da velo alle componenti che si nascondono dietro un dato aggregato134. Se si considera, ad
esempio, l’andamento del saldo di parte corrente di un paese, si può correre il rischio di trascurare che
un medesimo deficit delle partite correnti può risultare tanto da un livello eccessivamente elevato della
spesa per investimenti, quanto da un livello eccessivamente basso del risparmio prodotto dall’economia.
In modo del tutto analogo, la determinante ultima del deficit può essere costituita sia da un deficit della
bilancia commerciale, sia dalla necessità di pagare interessi su uno stock di debito estero particolarmente
gravoso. I paesi maggiormente indebitati mostrano saldi di partite correnti che sono cattivi indicatori
delle loro bilance commerciali e sono quindi fonte di errore. La ragione della discrepanza tra il saldo di
parte corrente e quello della bilancia commerciale è da ricercarsi negli enormi pagamenti per interessi
sul debito estero.
4.6 IN AFRICA
Nella seconda metà del secolo XX, l’Africa ha avuto nel complesso, con l’eccezione di pochi
paesi, un netto e continuo declino economico relativo (ciò ovviamente è tragico se si tiene conto delle
sue condizioni iniziali). Tale declino è stato particolarmente severo per i paesi poveri dell’Africa SubSahariana, in genere gravati negli anni ottanta e novanta da un enorme debito estero che ha posto un
vincolo stringente sulle possibilità di sviluppo. Ma un altro ostacolo è stato costituito dalle spese militari
(3,6% del Pil) e dai gravi conflitti prevalenti in molti paesi, così come dalla vasta diffusione dell’Aids.
Gran parte dei paesi africani nel 1960 erano molto poveri e da allora molti hanno attraversato fasi di
crescita negativa del prodotto pro capite e quindi un declino assoluto del loro tenore di vita. E non è
dipeso soltanto dalle guerre: il Ciad e il Madagascar, anche in assenza di conflitti, hanno avuto
esperienze simili ad altri paesi poveri.
La crescita non è una necessità storica. Storicamente, la crescita sostenuta della produzione è un
fenomeno recente e la convergenza dei livelli di prodotto non è un fenomeno esteso su scala mondiale.
Le teorie che spiegano la crescita dei Paesi Ocse e dei paesi emergenti spiegano la sua assenza nel
passato e nell’Africa dei nostri giorni135. Per quanto riguarda l’Africa, i maggiori paesi e soprattutto
quelli sub sahariani hanno sperimentato un trend negativo di crescita sia durante gli ottanta che durante
gli anni novanta136. Gran parte dei paesi africani hanno sia bassi livelli di prodotto pro capite, sia bassi
tassi di crescita. La crescita assai modesta del Pil, dovuta anche all’enorme peso del debito estero
Durante le inflazioni latino-americane degli anni ottanta, le persone hanno fatto ricorso ai dollari per le loro transazioni
quotidiane dando luogo al fenomeno della dollarizzazione, che sposta sulla valuta estera le tre funzioni canoniche della
moneta nazionale. Ciò ovviamente è possibile solo fino alla vigilia del crollo del cambio: a quel punto infatti la banca
centrale, avendo ormai esaurito le proprie riserve in valuta estera, si rifiuterebbe, o non sarebbe in grado di effettuare tale
conversione.
133 Vedi Sachs J.D., Larrain F., op. cit., pp.1073-4.
134 Ibidem, pp.249-51.
135 Vedi Blanchard O., op. cit., pp.682-3.
136 Tra il 1980 e il 1995 il valore delle esportazioni mondiali è aumentato in media del 6.7% l’anno e l’Africa subsahariana ha
avuto un tasso di crescita dell’1% annuo mentre negli ultimi 25 anni il tasso medio è stato di circa il 2%.
132
29
accumulato in precedenza, spesso non è riuscita a superare l’elevata crescita della popolazione, per cui
in molti paesi il Pil pro capite è sceso o ha ristagnato.
Un aspetto importante della crescita economica in un’economia aperta è rappresentato dalla
relazione che lega la crescita e le politiche commerciali adottate dai governi nazionali. Il dibattito sulle
possibili strategie di crescita dei paesi poveri (Africa e America Latina) e di quelli a medio reddito
(Estremo Oriente) si è incentrato su due strategie commerciali tra loro contrastanti: l’orientamento
verso l’esterno, ossia verso l’apertura unilaterale del mercato e la produzione dei beni esportati, e
l’orientamento verso l’interno, ossia verso la restrizione del commercio internazionale e la produzione
sostitutiva dei beni importati. L’evidenza empirica prevalente ha mostrato che i primi hanno conseguito
risultati migliori in termini di crescita137. Tuttavia, la crescita non è sufficiente a migliorare
necessariamente il benessere dei paesi poveri, anche nel caso di rendimenti crescenti di scala, magari
indotti da governi capaci di favorire economie esterne dinamiche. Ciò può accadere a causa del
paradosso di Bhagwati, noto come “la crescita che impoverisce”138. Questo fenomeno è determinato dal
possibile saldo negativo tra l’effetto ricchezza, dato dalla variazione del prodotto pro capite derivato dalla
crescita, e l’effetto ragioni di scambio, dato dalla variazione negativa di benessere associata a un
deterioramento delle ragioni di scambio. Il deterioramento delle seconde può essere tanto grave da
condurre a una diminuzione netta del benessere del paese nonostante la crescita del volume del suo
prodotto. Il deterioramento delle ragioni di scambio è favorito dalla diversa capacità di appropriazione
dei guadagni di produttività da parte dei diversi paesi. In quelli sviluppati essi vengono distribuiti ai
salariati, e quindi internalizzati, al contrario, nei pvs, essi danno luogo in gran parte alla diminuzione dei
prezzi dei prodotti esportati, e quindi vengono esternalizzati. Nel caso in cui le economie di scala
riguardino una serie abbastanza ampia di prodotti, l’apertura del mercato al commercio internazionale
porterà a una specializzazione completa nella produzione di questi beni in uno dei paesi. Questo
fenomeno impoverisce la varietà del paniere merceologico prodotto dai paesi e ne aumenta la
dipendenza economica dall’estero139.
Le cause della crescita economica costituiscono ancora oggi l’oggetto di un ampio dibattito.
L’accumulazione di capitale di per sé non può sostenere la crescita. In ultima analisi, una crescita
sostenuta del prodotto pro capite è dovuta al progresso tecnico. Le sue determinanti principali
nell’ambito della teoria della crescita sono due e riguardano entrambe l’attività di ricerca: 1. la fertilità
dell’attività di ricerca; 2. la appropriabilità dei risultati dell’attività di ricerca. In questo senso, i nuovi
teorici della crescita analizzano il ruolo di ricerca e sviluppo e dei rendimenti crescenti. In assenza di
questi strumenti, è velleitario, per molti pvs, indebitarsi all’estero per finanziare consumi e investimenti,
sapendo che i capitali ricevuti in prestito non potranno essere restituiti. Questo è stato l’errore
prospettico della classe politica africana. La crisi debitoria, che ha minacciato la sopravvivenza di
consistenti segmenti della popolazione dei paesi debitori, rimane ancora oggi l’ostacolo principale alla
crescita economica dei pvs. La conseguenza più tragica di questa crisi è stata tuttavia rappresentata dalle
sofferenze registrate nei paesi africani a basso reddito dove il collasso dello sviluppo ha provocato un
forte aumento della mortalità infantile, un sensibile deterioramento delle condizioni di denutrizione per
le fasce più giovani della popolazione, nonché altre gravi calamità140.
5. ERRORI DA EVITARE IN ITALIA
Vedi Sachs J.D., Larrain F., op.cit., pp.859-62.
Vedi Bhagwati J. N., “Immiserizing Growth”, Review of Economic Studies, June 1958, pp.327-40.
139 Durante l’ultimo decennio vi è stato un pronunciato incremento del commercio internazionale di parti e componenti dei
vari prodotti, nonché nell’installazione di impianti produttivi all’estero per la convenienza associata al prezzo dei fattori
produttivi. Questi fenomeni hanno dato luogo a nuove e rilevanti economie di scala internazionali. Anche i paesi più inclini
al libero scambio mantengono barriere tariffarie e non tariffarie su alcuni prodotti. Tuttavia, nella maggior parte dei paesi, i
dazi medi sono piuttosto bassi e tendono a scendere. Vedi Salvatore D., Economia Internazionale, Etas, Milano, 2002, pp.
200-2.
140 Vedi Sachs J.D., Larrain F., op.cit., pp. 1033-4.
137
138
30
Le riflessioni teoriche e le conseguenze ricordate degli errori nelle scelte di macroeconomia
possono essere rilevanti nelle scelte future per evitare di ripetere gli errori già fatti e ripetuti a lungo di
un Paese ancora caratterizzato da forti dualismi territoriali. Tali scelte sono poste dall’estensione
dell’integrazione reale e dall’approfondimento di quella monetaria in Europa, e dalla globalizzazione dei
mercati. Quanto si è detto sulla natura dell’errore ha implicazioni rilevanti in una realtà dinamica.
Tuttavia il cambiamento vede permanere a lungo, soprattutto nelle aree povere del pianeta, stati di
malessere che si candidano all’attenzione delle scelte di macroeconomia, anche se le sue finalità sono
spesso eterodirette da interessi specifici, particolari e sezionali piuttosto che generali.
Uno degli errori da evitare è dato dal rinvio della politica di rientro del debito pubblico. Il
rischio di un debito pubblico molto elevato pone i governi davanti all’alternativa tra molti decenni di
austerità fiscale, con il rischio di formazione di potenziali circoli viziosi legati al ritorno di alti tassi di
interesse in presenza di mercati finanziari globalizzati, o comunque alla richiesta da parte degli
investitori di rendimenti più elevati per detenere attività finanziarie emesse dallo Stato, e una manovra
di finanza straordinaria di consolidamento del debito. Ma, se questa deve essere considerata l’ultima
risorsa, e in qualche modo un ulteriore errore da evitare, è necessario perseguire con rigore le politiche
di risanamento finalizzate a scongiurare crisi finanziarie, e che passano, soprattutto in periodi di
stagnazione della crescita, attraverso la formazione di avanzi primari. Un livello elevato del debito
espone il paese ai rischi associati all’innalzamento dei tassi d’interesse, sperimentati dai pvs dell’America
Latina e dell’Africa negli anni ottanta. Infatti i mercati finanziari, sospinti dalle oscillazioni di credibilità
espresse dalle agenzie di rating, possono richiedere differenziali positivi sui tassi di interesse applicati,
come accadde per molti paesi dello Sme nei primi anni novanta141. La parità dei tassi d’interesse implica
infatti che variazioni della politica monetaria possono provocare ampie fluttuazioni del tasso di cambio.
E’ stato osservato che lo Stato deve usare il suo potere coercitivo per ridurre il potere
economico e proteggere le rendite dei consumatori. Ma come cambia questa prescrizione se vi è un
trade-off tra protezione del consumatore e sopravvivenza dell’impresa di fronte alla concentrazione di
potere economico degli oligopoli internazionali in un sistema economico che va verso la
globalizzazione? In altre parole, qualche forma di protezione che consenta di accrescere la possibilità di
favorire la nascita e il rafforzamento di settori produttivi caratterizzati da rendimenti crescenti può
anche essere necessaria per affrontare la concorrenza internazionale.
Tuttavia, il nostro Paese deve fare ancora parecchia strada su innovazione e conoscenza, nonché
su concorrenza e liberalizzazione dei servizi. Per il domani serve un’azione ad ampio spettro per far sì
che l’Italia esca dalla condizione di bassa crescita in cui versa da anni. Tale azione passa attraverso la
rimozione degli ostacoli strutturali all’espansione economica, con la promozione della liberalizzazione
dei mercati dei beni e dei servizi, della produttività e del monitoraggio dei conti pubblici, visto che le
leggi finanziarie basate sui tagli di spesa fatti finora non sono servite e che le leggi finanziarie elettorali
hanno guardato spesso al breve periodo, secondo la teoria del ciclo politico economico.
Concorrenza e liberalizzazione sono indissolubilmente legate: da esse ci si aspetta un impulso
alla crescita e alla competitività del sistema economico. Ciò vale in particolare per i guadagni di
efficienza associati ai passaggi dai monopoli alla concorrenza. Contro la liberalizzazione vi sono due
ostacoli: gli interessi specifici e il timore che la liberalizzazione possa indebolire il servizio pubblico. Ma
l’assetto liberalizzato ha il vantaggio di porre le istituzioni, altrimenti protette dalla concorrenza, nel
presupposto troppo facilmente accettato che l’interesse del paese coincida con quello delle imprese
monopoliste, nella posizione di garanti del consumatore. La regolazione ha il compito di garantire
questo risultato.
Le funzioni dello Stato cambiano con lo sviluppo della struttura capitalistica mostrando
l’evoluzione storica della contrapposizione società civile- Stato. E’ curioso che il capitalismo, il cui
sviluppo ha imposto il superamento del sistema economico feudale, si sia recentemente confrontato
con l’ipotesi di “rifeudalizzazione della società” di Habermas, nel senso di una rinnovata
compenetrazione della sfera pubblica in quella privata nello stadio più avanzato del capitalismo. Questo
fenomeno non è dovuto ad un aumento dell’intervento pubblico, anzi al contrario. Per molti anni la
Nel 1992, ciò riguardò l’Italia e la Gran Bretagna, le cui valute rischiavano di svalutarsi rispetto all’Ecu e, nel 1993, la
Francia che non voleva perdere la parità tra il marco tedesco e la sua valuta.
141
31
crescente socializzazione dello Stato si è accompagnata ad un statalizzazione crescente. Lo Stato ha
perso il senso dei suoi limiti, andando molto al di là delle sue tradizionali attività di protezione, di ordine
e così via, esercitando funzioni di coordinamento, controllo, regolamentazione, programmazione del
processo produttivo e perfino di produzione e distribuzione di beni e servizi privati al fine di
stabilizzare il ciclo economico. L’esperienza ha mostrato come i costi economici dell’intervento
pubblico possano superare quelli prodotti dalle situazioni che li motivano. Ciò ha posto l’esigenza di
esaminare a fondo anche gli inconvenienti e i limiti della politica economica e, in meno di venti anni, si
è assistito a una riduzione spettacolare dell’intervento pubblico in economia. Tuttavia lo Stato politico
non ha cessato di svolgere, anzi ha moltiplicato, le sue funzioni di mediazione con una pluralità di
interessi privati. Ma l’attività redistributiva si è spesso svolta al di fuori di criteri di equità e i gruppi
d’interesse hanno tentato di trarre vantaggi privati sempre maggiori dalla normativa. La teoria della
regolamentazione ha segnalato il caso di fallimento di quella azione normativa che Stigler ha definito
“cattura del regolatore da parte del regolato” sicché le agenzie preposte a questa attività tendono a
essere catturate dalle imprese, piuttosto che proteggere i consumatori, e hanno fatto nascere cartelli
protetti dallo Stato, ad esempio attraverso l’imposizione di barriere all’entrata (licenze, permessi di
lavoro, iscrizioni ad albi non necessari) che riducono la concorrenza in un dato mercato e la
competitività di un sistema produttivo. Questo è coerente con l’apparente paradosso denunciato
dall’Antitrust in Italia che si trova spesso a confrontarsi con monopoli privati che hanno una veste
pubblica. Contro di essi questa Autorità può spendere solo parole che chiedono allo Stato italiano di
ritirarsi, di fare il suo lavoro, di cessare di proteggere interessi privati nelle imprese di pubblica utilità,
nella distribuzione commerciale e nei settori dove l’innovazione é vitale. Il fatto che alcune sfere private
abbiano assunto un carattere quasi pubblico ha reso evidente che lo Stato e le istituzioni sociali si sono
fusi in un complesso di organizzazioni che non sono più prone alla consueta distinzione tra pubblico e
privato142.
6. OPERE CITATE
Abel A.B., Bernanke B.S., Macroeconomia, Il Mulino, Bologna, 1994.
Bacone F., Novum Organum, trad. it. a cura di Banfi A., Milano, 1951.
Bhagwati J. N., ” Immiserizing Growth”, Review of Economic Studies, June 1958, pp.327-40.
Bianchi C., “Politica economica”, in Lunghini G. e D’Antonio M. (a cura di), Dizionario di
Economia Politica, Bollati Boringhieri, Torino, 1988.
Blanchard O., Macroeconomia, Il Mulino, Bologna, 2000.
Boland L.A., The Foundations of Economic Method, Allen and Unwin, London, 1982.
De Luca G., Minieri S., Verrilli A. (a cura di), Nuovo Dizionario di Economia, Edizioni Simone,
Napoli, 1998.
Dobb M., Storia del pensiero economico, Editori Riuniti, Roma, 1974.
Friedman M. e Schwartz A., “The Great Depression, 1929-33”, in Idem, A Monetary History of
the United States 1867-1960, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1963.
Hahn F. e Hollis M., “Introduction”, al volume da essi curato, Philosophy and Economic Theory,
Oxford University Press, Oxford, 1979.
Vedi Romagnoli G.C., “ Le funzioni economiche dello Stato in Italia“, in Acocella N., Rey G.M., Tiberi M. (a cura di),
Saggi di politica economica in onore di Federico Caffé, volume III, Angeli, Milano 1999.
142
32
Hancock K. J., “The reduction of unenmployment as a problem of public policy 1920-1929”, in
Pollard S., The Gold Standard and Employment Policies between the wars, Methuen, London, 1970.
Hillman A.L.,”La Politica del commercio internazionale per gli anni 2000”, in Corsetti G., Rey
G.M., Romagnoli G.C. (a cura di), Il futuro delle relazioni economiche internazionali, volume curato in
collaborazione con Franco Angeli, Milano, 2001.
Jevons W., Theory of political economy, Second Edition, London, 1879.
Kalecki M., Observations in the “Theory of Growth” in The Economic Journal, marzo 1962.
Keynes J.M., “Tract on Monetary Reform, Harcourt Brace and Company, NewYork, 1924,
trad.it., La riforma monetaria, Feltrinelli, 1975.
Id., “The Economic Consequences of Mr. Churchill”, in Id., Essays in Persuasion, Macmillan,
London, 1931.
1967.
1973.
Keynes J.M., The General Theory of Employment Interest and Money, Macmillan, London,
Kindleberger C., The World in Depression 1929-1939, University of California Press, Berkeley,
Lombardini S., “Lo Stato nel pensiero degli economisti classici” in Finzi R. ( a cura di), Il ruolo
dello Stato nel pensiero degli economisti, 1977, pp. 17-58.
Lucas R.E., “Econometric Policy Evaluation: A Critique”, in Brunner K., Meltzer A.H. (eds.),
The Phillips Curve and Labor Markets, North Holland, Amsterdam, 1976.
Mill J.S., Essays on some unsettled questions of political economy, London, 1844.
O’ Donnell R. M., Keynes: Philosophy, Economics and Politics. The Philosophical Foundations of Keynes’s
Thought and their Influence on his Economics and Politics, MacMillan, London, 1992.
Pantaleoni M., Principii di economia pura, Cedam, Padova, 1970.
Robinson J., Accumulation of Capital, London, 1956.
Ead., Economic Philosophy, Pelican Books, New York, 1978 (1° ed. 1962).
Romagnoli G.C., “Falsificabilità e falsificazione nella scienza economica. Alcune riflessioni
metodologiche”, Studi Urbinati, n.B4, 1984-85.
Id., “Anagrafe dei bisogni e lotta alle povertà”, Nuovi studi politici, n. 1-2, 1997.
Id., “ Le funzioni economiche dello Stato in Italia“, in Acocella N., Rey G.M., Tiberi M. (a cura
di), Saggi di politica economica in onore di Federico Caffé, volume III, Angeli, Milano 1999.
Id., “La psicologia economica dello Universal Bogey” in Marconi G. e Termini C. (a cura di), I
volti di Giobbe. Percorsi interdisciplinari, EDB, Bologna, 2002.
33
Id., “Keynes e Wittgenstein tra le due guerre”, in Basciani A. e Clementi M. (a cura di),
Intellettuali, storici ed economisti davanti ai totalitarismi dell’Europa centro-orientale, Roma, 2005.
Rueff J., L’errore monetario dell’Occidente, Etas-Kompass, Milano, 1971.
Sachs J.D., Larrain F., Macroeconomia e politica economica, Il Mulino, Bologna, 1995.
Salvatore D., Economia Internazionale, Etas, Milano, 2002.
Schumpeter J.A.,” Science and Ideology”, American Economic Review, marzo 1949.
Id., Storia dell’analisi economica, edizione ridotta a cura di Napoleoni C., Boringhieri, Torino, 1968
(1° ed. 1954).
Sen, A.K., Commodities and capabilities, Oxford: Oxford U.P., 1985.
Spinoza B.,” De Mente”, Ethica more geometrico demonstrata, parte II, trad. it. Torino, 1959.
Sraffa P., Works and correspondence of David Ricardo, Cambridge, 1951.
Temin P., Lessons from the Great Depression, MIT Press, Cambridge, Mass., 1989.
Tobin J., “La teoria macroeconomia in discussione”, Bancaria, 1985.
Gian Cesare Romagnoli
Prof. ordinario di Politica Economica
Facoltà di Scienze Politiche
Università di Roma Tre
34