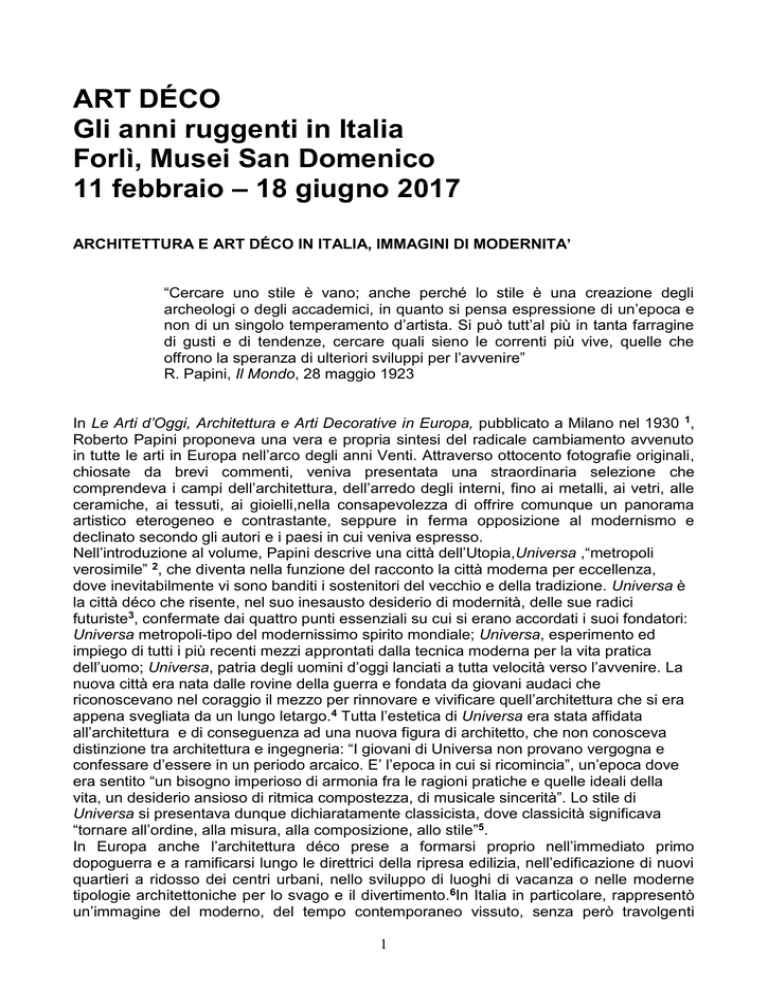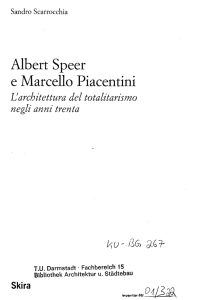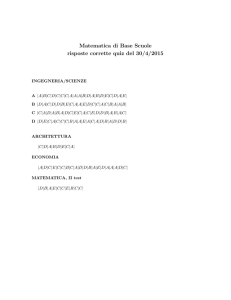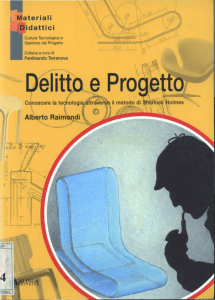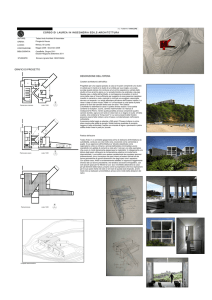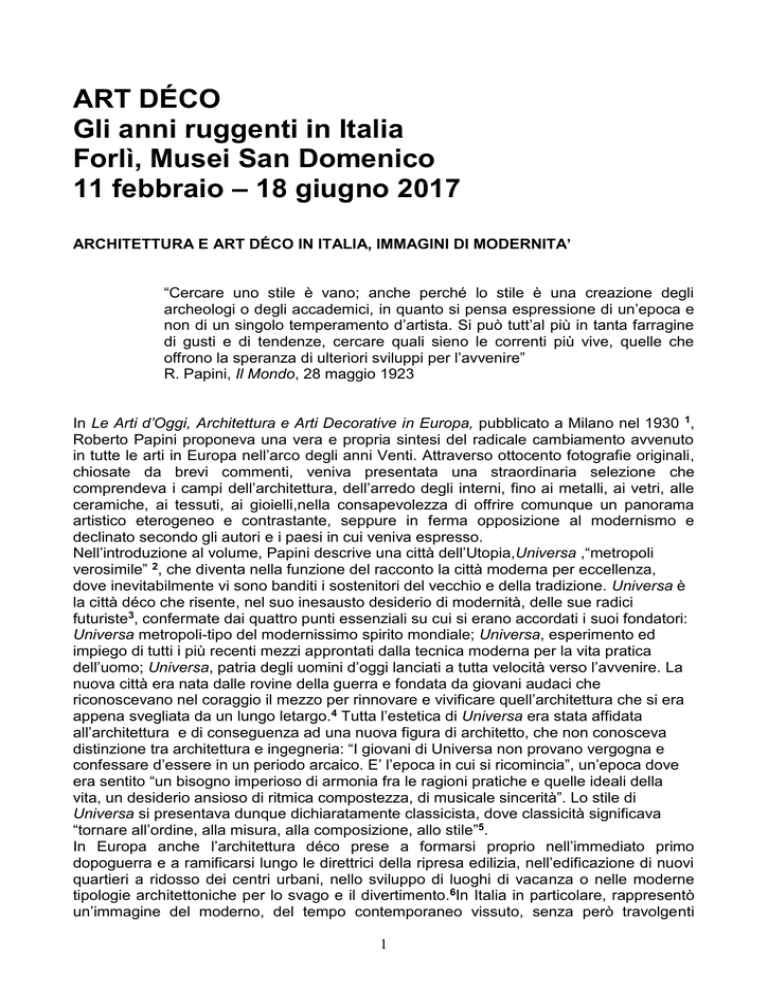
ART DÉCO
Gli anni ruggenti in Italia
Forlì, Musei San Domenico
11 febbraio – 18 giugno 2017
ARCHITETTURA E ART DÉCO IN ITALIA, IMMAGINI DI MODERNITA’
“Cercare uno stile è vano; anche perché lo stile è una creazione degli
archeologi o degli accademici, in quanto si pensa espressione di un’epoca e
non di un singolo temperamento d’artista. Si può tutt’al più in tanta farragine
di gusti e di tendenze, cercare quali sieno le correnti più vive, quelle che
offrono la speranza di ulteriori sviluppi per l’avvenire”
R. Papini, Il Mondo, 28 maggio 1923
In Le Arti d’Oggi, Architettura e Arti Decorative in Europa, pubblicato a Milano nel 1930 1,
Roberto Papini proponeva una vera e propria sintesi del radicale cambiamento avvenuto
in tutte le arti in Europa nell’arco degli anni Venti. Attraverso ottocento fotografie originali,
chiosate da brevi commenti, veniva presentata una straordinaria selezione che
comprendeva i campi dell’architettura, dell’arredo degli interni, fino ai metalli, ai vetri, alle
ceramiche, ai tessuti, ai gioielli,nella consapevolezza di offrire comunque un panorama
artistico eterogeneo e contrastante, seppure in ferma opposizione al modernismo e
declinato secondo gli autori e i paesi in cui veniva espresso.
Nell’introduzione al volume, Papini descrive una città dell’Utopia,Universa ,“metropoli
verosimile” 2, che diventa nella funzione del racconto la città moderna per eccellenza,
dove inevitabilmente vi sono banditi i sostenitori del vecchio e della tradizione. Universa è
la città déco che risente, nel suo inesausto desiderio di modernità, delle sue radici
futuriste3, confermate dai quattro punti essenziali su cui si erano accordati i suoi fondatori:
Universa metropoli-tipo del modernissimo spirito mondiale; Universa, esperimento ed
impiego di tutti i più recenti mezzi approntati dalla tecnica moderna per la vita pratica
dell’uomo; Universa, patria degli uomini d’oggi lanciati a tutta velocità verso l’avvenire. La
nuova città era nata dalle rovine della guerra e fondata da giovani audaci che
riconoscevano nel coraggio il mezzo per rinnovare e vivificare quell’architettura che si era
appena svegliata da un lungo letargo.4 Tutta l’estetica di Universa era stata affidata
all’architettura e di conseguenza ad una nuova figura di architetto, che non conosceva
distinzione tra architettura e ingegneria: “I giovani di Universa non provano vergogna e
confessare d’essere in un periodo arcaico. E’ l’epoca in cui si ricomincia”, un’epoca dove
era sentito “un bisogno imperioso di armonia fra le ragioni pratiche e quelle ideali della
vita, un desiderio ansioso di ritmica compostezza, di musicale sincerità”. Lo stile di
Universa si presentava dunque dichiaratamente classicista, dove classicità significava
“tornare all’ordine, alla misura, alla composizione, allo stile”5.
In Europa anche l’architettura déco prese a formarsi proprio nell’immediato primo
dopoguerra e a ramificarsi lungo le direttrici della ripresa edilizia, nell’edificazione di nuovi
quartieri a ridosso dei centri urbani, nello sviluppo di luoghi di vacanza o nelle moderne
tipologie architettoniche per lo svago e il divertimento.6In Italia in particolare, rappresentò
un’immagine del moderno, del tempo contemporaneo vissuto, senza però travolgenti
1
mutamenti, o meglio fu l’immagine di un cambiamento avvenuto senza fratture e accettato
dalla società e immediatamente integrato nella produzione e nel consumo. Un consistente
radicamento del gusto déco si ebbe a Milano, dove il contesto artistico sviluppò un
ambiente decisamente classicista, caratterizzato per alcuni architetti da un severo
neoclassicismo, come per Giovanni Muzio, che recuperava attraverso un linguaggio
moderno stilemi classici ricomposti come elementi semplificati, o da una disinvolta ironica
leggerezza come nel caso di Giò Ponti, che progettava con il suo gusto colto e raffinato,
recuperando oltre ai repertori di forme e decorazioni dell’antichità classica, anche la
prospettiva rinascimentale e il trattatismo modulare di Palladio7 .
Il gruppo del “Labirinto”, formato da Ponti nel 1927 con gli architetti Tomaso Buzzi, Emilio
Lancia, Michele Marelli e con i vetrai Chiesa e Venini, espresse la forma artistica più
straordinaria del Déco neoclassico.
A Roma fu Marcello Piacentini, in sintonia con Milano, a rappresentare l’elaborazione
moderna degli stili classici, ma con una diversa intonazione. Mentre nel capoluogo
lombardo i contenuti classicisti venivano ricomposti decorativamente in maniera quasi
calligrafica (rilievi, lesene, timpani), nella capitale venivano risolti in modo plastico (pilastri,
colonne, trabeazioni) con forti risalti e contrasti coloristici. Alla fine degli anni Venti la
romana Casa del Mutilato, espressione di un Déco ormai monumentale, segnerà per
Piacentini il passaggio di un cambiamento di gusto verso un neoclassicismo novecentista
che caratterizzerà tutte le opere del successivo decennio.
Altri architetti operanti in quegli anni a Roma si riferivano oltre che al neoclassicismo
storico, all’architettura romana antica e a quella cinquecentesca. Enrico Del Debbio,
Alessandro Limongelli, Innocenzo Sabbatini, tra gli altri, hanno avuto il merito di aver
impiegato formulari déco, oltre che nelle palazzine o nelle piccole case di abitazione,
nell’edilizia economica e popolare, dove puntualmente veniva applicata quella serie di
invarianti formali prese dal repertorio manieristico-rococo, riconoscibili nelle finestre iscritte
in sagome timpanate, con il loro piccolo vano o urna a ornamento dello spazio triangolare
liscio, nelle facciate monocuspidate, nelle cimase coronate da mossi fastigi.8 Nella
seconda metà degli anni Venti gli influssi del Déco romano raggiunsero la Romagna, nella
nuova erigenda borgata di Predappio, luogo simbolo del mito dell’uomo Mussolini.
Florestano Di Fausto diede vita ad“un rustico eclettismo”, dove il repertorio iconografico
romano veniva ibridato con suggestioni decorative locali. Il compendio termale di
Castrocaro, creazione dovuta alla genialità decorativa di Tito Chini, fu un prezioso frutto
proiettato nel tempo degli anni Trenta, quando ormai il gusto déco confondeva i suoi tratti,
come spesso accadeva in quegli anni in Italia, con quelli del “Novecento”.
“Quella famiglia esigua ma valorosa di Architetti lombardi”
Nell’ottobre del 1925,dalle pagine della rivista Emporium,Roberto Papini annunciava che
all’Esposizione di Parigi, la giuria internazionale aveva attribuito l’ambito “Grand Prix” alle
porcellane della Richard-Ginori, a parità di punti con la Fabbrica Reale di porcellane di
Copenaghen. Il trionfo di Giò Ponti, architetto e “uomo di gran gusto e raffinata sensibilità”
faceva rammentare a Papini che “il brio moderno, con spirito caricaturale” proprio
dell’artista lo faceva appartenere a “quella famiglia esigua ma valorosa di Architetti
lombardi” 9, che nel corso degli anni Venti aveva prodotto a Milano un’architettura déco
con caratteri propri e riconoscibili, dove prevaleva un’eleganza portata ai limiti dell’ironia, e
dove pur con situazioni differenziate, le punte più evidenti erano rappresentate dallo
stesso Ponti, da Piero Portaluppi, da Giovanni Greppi, da Tomaso Buzzi, da Mino Fiocchi
e ancorchè da Giovanni Muzio, nonostante che lo stesso abbia sempre rifiutato nella sua
opera la presenza di un gusto déco. In realtà la Ca’Brüta, progettata da Muzio nel 1920,
2
traduce nella sua semplificata poggiatura classicheggiante, costituita da motivi di
repertorio tracciati come fosse una tavola didattica, uno degli aspetti peculiari del Déco10.
Milano, in quel torno di anni, rappresentava il fulcro del dibattito sulla funzione delle arti
decorative, del rapporto tra produzione industriale e invenzione artistica, tra artigianato e
serialità, il tutto espresso e sublimato nelle Esposizioni biennali di Arti Decorative, tenute
nella villa reale di Monza e guidate da Guido Marangoni. Giò Ponti ,per il suo stretto
collegamento fra la progettazione architettonica (anche se in quegli anni esigua) e la
progettazione di oggetti di arredi, è certamente quello con caratteristiche più squisitamente
déco: progetta con l’aria di divertirsi, costruisce come se continuasse ad inventare fondali
per le composizioni architettoniche prospettiche che “distribuisce negli albi panciuti delle
sue ceramiche” in maniera così evidente, che Ferdinando Reggiori su Architettura e Arti
Decorative11 citava il decorativismo della facciata della casa di via Randaccio a Milano,
progettata da Ponti insieme a Emilio Lancia, come “la traduzione tangibile di un colorato
disegno ornamentale”. In realtà la leggerezza ornativa dei prospetti maschera la
complessità dell’impianto planimetrico a forbice della villetta: la forma concava del
prospetto principale e quella convessa della facciata retrostante restituiscono grazia al
volume dell’edificio, compensando le inevitabili deformazioni ottiche12; l’uso ironico del
repertorio classico si rivela nel fastigio, dove il motivo ascendente del timpano, interrotto ai
due lati degli obelischi, inquadra un altro piccolo elemento monocuspidato che simula un
piccolo frontoncino di tempio13. A contrasto, nella successiva villa de “L’Ange Volant”,
progettata nel 1926 con Lancia e Buzzi, per il presidente della Casa Christofle Tony
Bouilhet, a Garches nei pressi di Parigi, spariscono quasi del tutto gli elementi decorativi,
per lasciare posto ad una felicissima interpretazione della casa di campagna palladianosettecentesca, a cui seguiranno “il classicismo senza umori” della casa Borletti, in via S.
Vittore (1928) e la casa per appartamenti in via Domenichino (1928-30), entrambe
progettate a Milano con Lancia.14
Alla soave leggerezza di Giò Ponti, Piero Portaluppi, altro grande protagonista del
professionismo milanese, contrapponeva una personalità complessa, creativa ed
intrigante, in cui possono essere riconosciuti prontezza nella ricezione delle novità
europee e ampio respiro immaginativo. Nell’arco dei primi decenni del ‘900, Portaluppi
definì tipologie e ritmi compositivi orientati verso il gusto déco e modulati con originalità nel
rapporto architettura e arti decorative. La sua dichiarata avversione verso le forme
stilistiche del Liberty lo portarono inevitabilmente ad ispirarsi e a riformulare gli stili del
passato, in specie la ritmicità musicale del rococò e a certi suggestioni orientaleggianti e
secessioniste, che venivano regolarmente proiettate in una modernità scenografica.15Nelle
grandi centrali elettriche progettate dal 1910, (Verampio, Crego, Crevolo, Piacenza) gli
edifici ripropongono in chiave rievocativa rivisitazioni neomedievali, dove espressioni
architettoniche di matrice gotica si trasformano in strutture adeguate alle novità
tecnologiche. Miscuglio di repertori storicistici con proposte di avanguardia, con immissioni
di moduli e cadenze déco: castelli, basiliche, monasteri esprimono attraverso il loro
linguaggio eclettico l’importanza dell’industria elettrica, delle società e delle banche
coinvolte, di quella “committenza dorata”, propria del mondo in cui l’architetto si
muoveva.16
Nel decennio 1920-30 Portaluppi produsse un gruppo di progetti relativi a strutture non
realizzate, attraverso accattivanti disegni, che rendevano indistinta la linea di confine tra
gioco e serietà, pur rimanendo nel campo di una sensibilità elegante e singolare. A
spiegare l’atmosfera
provocatoria di questi progetti si presentò significativa la
presentazione in forma di lettera aperta, stilata da tre colleghi dell’architetto, Aldo Lucchini,
Umberto Sabbioni e Sandro Tibaldi per la pubblicazione Aedilitia I: “Ecco: progetti?
Schizzi? Fotografie? Li chiami altri come vuole. Tutte cose eseguite o qualcuna soltanto
sognata? La risposta altri la trovi […] Raccoglile e lanciale, così come getteresti un tuo
3
buon motto; ma sotto il sorriso si senta bene vibrare, con lieta franchezza, l’orgoglio del
cammino compiuto e la speranza di una meta più lontana“ 17. Il nuovo piano urbano del
quartiere di Monte Amarillo per una città immaginaria dell’America del Sud, Allabanuel
(1920) si traduce in una città orizzontale impostata su una griglia regolare con isolati
ripetuti e ripetibili all’infinito, costituiti da un unico edificio cubico a nove piani dove le
facciate sono simmetricamente scalate, con un evidente riferimento ai piani urbanistici con
edifici a gradoni di Henri Sauvage, all’architettura sociale olandese e ad alcune proposte
del secessionismo viennese 18.Nel titolo letto a rovescio sta la morale della proposta (L’è
una balla), che ci rammenta che la standardizzazione non è la migliore soluzione per
costruire una città-giardino. Nel disegno per un grattacielo destinato a New York,
Portaluppi esorcizza l’eccessivo verticalismo delle città americane, trasferendo ancora una
volta nel titolo le sue intenzioni umoristiche, dove il significato del nome del grattacielo
S.K.N.E. è “scappane”. I disegni successivi per Hellytown (1926) sono una derivazione
delle utopie precedenti, prodotta dalla funzione dell’iperbole orizzontale e le unità
residenziali di Allabanuel con l’iperbole verticale e gli spazi adibiti ad uffici dell’edificio
newyorkese. Sempre nel 1926, tra intenzioni serie e ludiche, si pongono i disegni
progettuali per un edificio da adibire ad uffici per una società immaginaria S.T.T.S, da
collocare in corso Sempione a Milano. Tre diverse soluzioni dove i disegni formano un
trittico coerente, come tre pannelli appartenenti alla medesima striscia. Alla prima versione
di sapore ancora convenzionale, segue la seconda di aspetto più dichiaratamente
modernista, dove sulla superficie prospettica si sviluppano geometrie lineari labirintiche.La
terza facciata rappresenta invece un ibrido, con finestre convenzionali, incorniciata da
riquadri verticali. 19Negli anni Trenta Portaluppi, abbandonata la spinta creativa del Déco,
approdò a scenari diversi, ad una monumentalità filtrata da istanze
razionaliste. La
“Casa degli Sposi”, presentata alla Triennale milanese del 1933, è prova evidente della
trasformazione linguistica ed espressiva dell’architetto esplicitata anche nel gusto
dell’arredo, che troverà il suo apice all’interno della villa Campiglio, nell’elegantissima via
Mozart a Milano (1930-32).
Marcello Piacentini
Nel 1915 Marcello Piacentini vinceva l’unico Grand Prix (su 110 padiglioni americani e
stranieri partecipanti) per il padiglione Italiano o meglio la cittadella italiana progettata per
la Panama-Pacific International Exposition di San Francisco, e per la quale ebbe la
nomina di Gran Ufficiale della Corona d’Italia. Il grande successo di pubblico e di critica fu
dovuto alla proposta innovativa di un padiglione diffuso, composto da più corpi
“armoniosamente riuniti, e tali da offrire l’aspetto di un angolo, di un cantuccio d’Italia […]
l’intimità di un’atmosfera raccolta, come potrebbe essere una piazza, ai lati della quale
fossero erette varie costruzioni, ispirate agli stili più belli che l’Italia abbia espresso”. 20
Piacentini già avveduto uomo di potere, aveva scelto un’unica via stilistica, quella
rassicurante dell’Eclettismo: il gotico senese e il rinascimento fiorentino reinterpretati
negavano con evidenza quell’arte nuova che l’Esposizione per il Cinquantenario dell’Unità
d’Italia, svoltosi a Roma nel 1911, aveva rivelato come una stagione ormai chiusa, dopo
che le esigenze di una diffusione di massa avevano trasformato quell’arte in una ottusa e
meccanica ripetizione di sole cifre formali. La cittadella espositiva italiana rappresentava
ciò che per Piacentini significava la sua ricerca di modernità di “uno stile rispondente
all’epoca” e anche un anticipato richiamo all’ordine”, da consumare in quel lento
trasformarsi della tradizione in nuove forme più consone ai tempi 21, che sfociava in una
rinnovata forma di eclettismo.I viaggi in Francia e Belgio e poi quelli successivi in
Germania e Austria del 1913 resero al giovane architetto romano la consapevolezza che i
4
tempi erano ormai mutati e che richiedevano un’arte che rappresentasse la
contemporaneità.
Dopo aver visitato a Lipsia l’Internazionale Baufach Ausstellung aveva dichiarato: “L’arido
e tormentoso periodo dello stile moderno, la banalità plebea dell’Arte Nuova è cessata: le
cartellette piatte e i nastrini convessi, i testoni muliebri e i rami fioriti, le parallele a chitarra
e i punti e i cerchi hanno fatto ormai il loro tempo”, condannando un generale sistema
iconografico che aveva trasformato l’architettura in decorazione .22
Conobbe ed apprezzò l’architettura dello Jugendstil, nel momento del suo superamento e
cioè nella fase cruciale del protodecò, inteso come un ritorno al classico attraverso una
libertà compositiva che proprio le precedenti poetiche moderniste avevano consentito23.
Ne Il momento architettonico all’estero,consistente “proemio” del primo numero della
rivista Architettura e Arti Decorative (1921) codiretta con Gustavo Giovannoni, Piacentini
riservava il suo plauso alle architetture viste in Germania, Francia e Austria,e dove faceva
notare con evidenza e su tutti che nel Palazzo Stoclet a Bruxelles, Josef Hoffmann aveva
generato un geniale ribaltamento compositivo, poichè gli elementi che altrove erano solo
complementari e accessori, diventavano a tutti gli effetti gli “elementi principali”
dell’architettura.24
La battaglia per la novazione di un gusto moderno per Piacentini ebbe nuovo terreno con
la progettazione del cinema Corso, all’interno del cortile di palazzo Ruspoli, nella
centralissima piazza di San Lorenzo in Lucina a Roma, realizzato tra il 1915 e il 1918
dove ebbe la possibilità di confrontarsi con una nuova tipologia, quello della sala
cinematrografica, nata dalla necessità di differenziarsi per motivi funzionali dall’impianto
dominante fino a quel momento, dalla sala teatrale. Ed è da questo cambiamento
sostanziale che l’architettura delle sale cinematrografiche si lega all’Art Dèco25,esprimendo
una conseguente idea di modernità. Il cinema Corso divenne un caso nazionale e dal
quotidiano Il Giornale d’Italia Piacentini fu accusato di “disfattismo”, per aver utilizzato in
tempo di guerra uno stile che si riferiva a quello dei paesi austro-tedeschi, inoltre di poca
sensibilità per l’ambiente in cui la sala veniva collocata ed ancora per aver ignorato la
cultura architettonica della tradizione romana. Dalle pagine di Emporium, Luigi Angelini lo
apprezzò invece proprio per il rapporto con l’ambiente circostante, che si esprimeva senza
mimetismi, e che donava un carattere nuovo ad un edificio che a sua volta conteneva una
forma d’arte nuova: il cinema.26Il cinema teatro Corso, nella cui progettazione ebbe un
ruolo determinante l’architetto trentino Giorgio Wenter Marini, può essere considerato il
più importante edificio inaugurale la corrente artistica del Déco italiano, dove vennero
messi in gioco con un senso di desacralizzazione del passato, prendendo dalla lezione
secessionista, i motivi stilistici ispirati al Neoclassicismo, al Rinascimento, al Barocco e
dove fu introdotta, come segno di modernità, una ricca decorazione d’ispirazione austrotedesca, dovuta all’apporto di artisti che avevano aderito alla Secessione romana, come
Alfredo Biagini, autore dei bassorilievi in stucco e del fregio della facciata, Arturo Dazzi,
autore di quattro medaglioni aventi come soggetto la Danza, la Commedia, la Tragedia, la
Musica ed infine Matilde Festa, moglie di Piacentini dal 1914, per un arazzo composto di
stoffe tagliate e ricucite da ricami che ornava una delle sale d’attesa, esempio importante
di arte tessile déco.27I successivi interventi dell’architetto romano per nuove sale
cinematografiche si limitarono agli interni, come nel 1922 per il cinema-teatro Savoia (oggi
Odeon) a Firenze. Piacentini coadiuvato dall’architetto Ghino Venturi fu chiamato nel 1921
nel capoluogo toscano ad intervenire su di una struttura già fondata, secondo un
precedente progetto redatto nel 1916 da Adolfo Coppedè. L’obbligo di conservare le
facciate del palazzo quattrocentesco, noto come “Lo Strozzino” aveva precluso qualsiasi
modernizzazione esterna,che fu limitata alle sole vetrine e all’insegna. All’interno la
struttura di cemento armato costituita da un sistema puntiforme di colonne gemelle e da
archi ribassati, si pose come base ad una generale decorazione che proponeva molti dei
5
motivi iconografici propri del Déco, e che rappresenterà per la sua ricchezza decorativa un
caso limite, presto sostituito a metà degli anni Venti da nuovi orientamenti decorativi più
austeri. Roberto Papini notava “nella acquisita bicromia di latteo e di grigio” cioè di calce e
di pietra serena dell’interno, un riferimento alla vena cromatica dell’architettura
quattrocentesca fiorentina, qui ravvivata dalle “note calde dell’oro e del rosso”28. La grande
cupola di vetro colorato, realizzata dalla ditta fiorentina Quentin, apribile per assicurare il
ricambio d’aria, conferisce alla sala la liquidità e le trasparenze di un acquario,
caratteristica degli interni Dèco, mutuata peraltro dalle atmosfere del Liberty. I corpi
illuminati a bilanciere, in legno scolpito posti al termine delle colonne gemelle a formare un
sopra capitello sono opera della società Barsi di Firenze. Le tre statue poste sul timpano
del boccascena e dovute allo scultore Antonio Maraini, policromate d’oro, di verde e di
rosso, rappresentano tre momenti diversi vissuti da un’attrice “nei tre tempi del prepararsi
alla scena, del presentarsi al suo pubblico e del riposarsi nella coscienza dell’effetto
raggiunto”.
Lo scultore Giuseppe Gronchi modellò le formelle dorate nei parapetti dei palchi, Matilde
Festa Piacentini due arazzi a guisa di un mosaico di stoffe, sulla linea di quelli cuciti per il
cinema Corso; Laura Agresti per il Setificio fiorentino aveva invece tessuto il sipario in seta
e Umberto Bartoli il bestiario scolpito in legno dorato per la cassa del cinema. All’esterno
una lanterna ornata di putti, realizzata dallo scultore Bernardo Morescalchi segnalava il
Bar Tabarin annesso al cinema e sistemato nel sottosuolo, dove i soffitti furono affrescati
dal pittore Giulio Rosso.
Un caso decorativo limite dunque il cinema fiorentino, se lo stesso Papini su un lungo
articolo Botteghe e vetrine di Roma29, descrivendo alcuni interni realizzati da Piacentini, ne
lodava il raggiunto uso di mezzi parsimoniosi, con cui aveva ottenuto, con l’aiuto anche di
un proprio gusto raffinato, “squisiti effetti decorativi” nelle armonie del colore e nella ricerca
di particolari preziosi. Le sale da pranzo dei grandi magazzini romani della Rinascente
(1923) erano dunque contrassegnate “da signorilità, equilibrio e misura” in un raffinato
apparato di delicati stucchi. Per la Casa di Mode Montorsi, in via Condotti (1923),
Piacentini disegnò invece “in maniera sobria e ispirata”, oltre ai saloni interni, la mostra
delle vetrine sulla notissima strada, modulata da un ricorrere di cornici che occupavano
due piani, e impreziosita da quattro lanterne a cestello che pendevano da mensole adorne
di putti, elaborati in un gioco di preziosa oreficeria. Nella sale interne,l’architetto
raggiunse livelli di altissima raffinatezza.
Con il ristorante e caffè concerto “La Quirinetta”, sistemati nei sotterranei del teatro Quirino
(1925-27) Piacentini riuscì a rappresentare l’elegante testimonianza di una Roma
mondana, in sintonia con l’Europa, ancora lontana dai riti volgari della vita del regime
fascista e dove la collaudata collaborazione con Giulio Rosso e Alfredo Biagini aveva
trovato uno dei momenti più alti del Déco italiano. Nella complessità di questo elegante
gusto, l’uso ironico degli stili30 trovava la sua sublimazione proprio in questo esclusivo
ritrovo: un’irrispettosa ed ironica irriverenza attivata da nuove sottili elaborazioni di
memorie archeologiche e di motivi di antichi repertori, con alcuni riferimenti all’arte etrusca
e pompeiana, a quella bizantina ravennate, non dissimili dalle esperienze stilistiche messe
in atto da Giò Ponti in quegli stessi anni a Milano31.
E’ ancora possibile riconoscere un gusto déco nella gran macchina dell’albergo
Ambasciatori in via Veneto, nel momento stesso in cui il Déco approdava al
neoclassicismo novecentista. Progettato nel 1925 e realizzato fra il 1926 e il 1932 con
Giuseppe Vaccaro, l’edificio consacrava ancora una volta Piacentini come l’architettoarbitro della mondanità romana32. Di fronte ad un progetto già avviato dall’architetto
svizzero Emilio Vogt su commissione di Gino Clerici, intraprendente industriale milanese,
l’architetto romano si trovò ad intervenire su un organismo complesso, posizionato in
curva, lungo la strada in pendenza, con una facciata bucata da più filari di finestre uguali e
6
con due accessi di ingresso laterali. Per ovviare alla monotonia della facciata, che in un
primo tempo aveva trovato la dinamicità di un movimento scalare nei piani ascendenti e
poi abbandonato , Piacentini optò per una conclusione monumentale, rendendo una
superficie giocata sull’alternanza dei motivi decorativi,delle vibrazioni del colore, del
contrasto fra il liscio e lo scolpito. Nell’alto basamento, entro tre nicchie sono collocate tre
statue bronzee di donne che recano una lampada, opera dello scultore Nino Clora, allievo
di Arturo Dazzi. All’interno le architetture dei colonnati, dei prospetti, dei giardini, delle
sale, sono opera dell’architetto Brenno del Giudice. Per la grande sala, trasformabile
all’occorrenza da sala da pranzo in sala da ballo, fu deciso di decorare le pareti con pittura
a fresco, in alternativa al “solito abusato tritume decorativo” allora di moda. La sala fu
spartita in grandi campiture di muro, incorniciate da pilastri e da zoccoli di lacca ideati da
Melchiorre Bega, autore anche dell’arredo. Gli affreschi furono affidati al pittore Guido
Cadorin e condotti con la tecnica veneziana della pittura murale, rappresentanti un mondo
festoso, lussuoso, elegante, concepito in composizioni serrate in cui l’armonia delle masse
e dei colori erano ricercate nelle distribuzioni simmetriche e bilanciate, nelle luci riflessate.
Venne ricreato così un ambiente fantastico rappresentante un ricevimento mondano negli
abiti dei tardi anni Venti, contrassegnato dal lusso dei costumi, dalla molteplicità delle luci,
da una variazione madreperlacea dei toni, dal richiamarsi alterno fra le cadenze delle
architetture e i ritmici atteggiamenti dei personaggi, dove si riconoscono tra gli altri
Margherita Sarfatti e la figlia Fiammetta, i critici Francesco Sapori e Roberto Papini, gli
architetti Giò Ponti e lo stesso Piacentini, il pittore Felice Carena e ritratti di bellissime
donne senza storia, ma con abiti di sartoria e magnifiche pellicce33.
Il cinema teatro Barberini (1927-30) infine, fu salutato dai critici come uno dei migliori
risultati raggiunti dall’architetto romano, che aveva scelto di “fondere il suo gusto attento di
architetto italiano con le disposizioni plastiche e le innovazioni tecniche dello stile europeo”
34. Sull’Illustrazione Italiana Papini sosteneva che il nuovo teatro Barberini,costruito con la
collaborazione dell’ing. Giuseppe Cecconi, era da considerarsi la maggiore prova in Italia
“del come si risolve nell’epoca attuale il problema della copertura dei grandi spazi senza
mascherare le strutture con le reminescenze scolastiche degli stili, anzi lasciandole nude e
crude e ottenendone, quel che più conta, una compiuta armonia” 35.Costruito nell’intervallo
di tempo che intercorre tra la prima (1928) e la seconda Esposizione Italiana di
Architettura Razionale (1931) il cinema Barberini fu secondo Ezio Godoli36 la risposta
piacentiniana a quanto di innovativo avevano proposto i giovani architetti del MIAR
(Movimento Italiano di Architettura Razionale). La decorazione, di assoluto gusto déco fu
affidata da Piacentini ancora una volta ad Alfredo Biagini, “il suo gioielliere”e realizzata con
uno stucco trattato alla maniera degli antichi , giocato su piccoli rilievi, con fughe di
prospettive illusorie in minimi spessori ed infine arricchita con eleganti figurette argentate
di donne e di animali. “A fondere ancor meglio tutto l’insieme in un diffuso e ben distribuito
chiarore, interviene l’illuminazione artificiale della sala […]. Alleggerisce e sottolinea, fonde
ed accentra, scaturisce inaspettata da un vano, luccica nelle modanature di una cornice,
traspare dall’opalescenza dei vetri, brilla su un risalto, si insinua nell’ombra. Ne risulta una
specie di immaterialità delle forme che è tutta nuova, che è tutta d’oggi, capace di
capovolgere il chiaroscuro e di creare le più inattese illusioni “ 37.Con il cinema Barberini si
chiudeva la parabola déco di Piacentini, iniziata un decennio prima con il cinema Corso.
Due aspetti del Déco in Romagna:Florestano Di Fausto e Tito Chini
Florestano Di Fausto a Predappio
7
Dopo il diploma ottenuto presso la sezione Architettura dell’Accademia di Belle Arti di
Roma, Florestano Di Fausto fu nominato nel 1920 consulente della Commissione C.A.S.E.
(Commissione Arredo Sedi Estere) del Ministero degli Affari Esteri con la funzione di
curatore e allestitore di interni per le varie sedi diplomatiche italiane nel mondo ed ebbe
come primo incarico l’arredo dell’Ambasciata di Tokyo. Il fortunato incontro avvenuto in
Giappone con la famiglia dell’ambasciatore forlivese Raniero Paulucci di Calboli, con cui
condivideva per diversi motivi una difficile “vita da esuli”, e la solida amicizia con Giacomo
Barone Russo, segretario e genero del suddetto diplomatico e poi suo erede nel nome
nobiliare e nelle sostanze, gli procurò una straordinaria continuità di incarichi che si
conclusero nel 1932, quando gli fu affidato a Tripoli il ruolo di capo dell’Ufficio Tecnico e
Urbanistico; nello stesso anno il marchese Paulucci di Calboli terminava la sua attività di
influente uomo politico con la cessazione del suo mandato di segretario della Società delle
Nazioni a Ginevra38.“Visione mediterranea della mia architettura”, articolo apparso nel
1937 sulla rivista Libia, risulta l’unico lascito teorico di Di Fausto, dove l’architetto
ripercorre la sua esperienza di progettista per il Governo Italiano in area mediterranea.
Con l’affermazione dichiarata su quelle pagine :”Non una pietra è stata da me posta senza
che io prima mi sia riempito dello spirito del luogo sì da farlo mio “, Di Fausto introduceva
nella sua progettazione, svolta tra le estreme propaggini dell’eclettismo e dei nuovi
linguaggi, il tema dell’ambientamento dove le scelte formali, pur collegate alla leggenda, al
mito e alla storia del luogo, erano il prodotto di un bilanciamento tra la libera
interpretazione della tradizione e la nuova visione di quell’architettura ritenuta “moderna”;
in realtà la disinvoltura con cui utilizzò i suoi sofisticati strumenti progettuali gli permisero di
affrontare le più svariate situazioni producendo “ibridazioni di stili più o meno clandestini”.
Nel 1923, dopo la nomina a capo di Gabinetto del Ministero degli Affari Esteri, retto ad
interim da Benito Mussolini, Paulucci di Calboli raccomandò Di Fausto all’amico Mario
Lago, governatore di Rodi e dell’intero Dodecaneso, che chiedeva insistentemente una
figura professionale capace di trasformare l’antica città dei Cavalieri in una moderna
capitale europea. Fu a Rodi, nell’area portuale di Mandracchio,che l’architetto romano
creò le sue più scenografiche architetture manipolando vari stilemi, frutto di fantasia e di
un vagheggiato gusto “déco”, direzionati ad una ricerca linguistica di “ambientamento”
sviluppata su impaginati prospettici di tradizione classica e ricchi di plastica muraria. “Di
tutte le opere architettoniche progettate da Di Fausto a Rodi la più vistosa e fantasiosa è il
Palazzo del Governo […] si vuol dire cioè che Di Fausto era spinto da una fantasia vivace
e poetica attraverso la quale plasmava motivi eterogenei; qualche volta come in questo
caso la memoria del Palazzo Ducale di Venezia, spinta da un lato verso goticismi espliciti,
dall’altro verso preziosi arabeschi o puliti geometrismi, […] a Rodi la teatralità del palazzo
del Governo, questa specie di fondale per opera lirica, asseconda un’idea di sogno che
sembra pertinente con il luogo, sposando il gusto dell’orientalismo al gusto della
rievocazione medievale “ 39.
L’aggravarsi di contrasti con il governatore Lago portarono Di Fausto alla decisione di
lasciare Rodi, per svolgere altri compiti, che l’amico Paulucci di Calboli gli aveva nel
frattempo procurato, come il ridisegno degli edifici della nuova Predappio (1926-1929),
luogo celebrativo del mito delle origini del fascismo40.
Benito Mussolini, distante ma attento, controllava i lavori della piccola erigenda borgata
attraverso l’assidua presenza della moglie Rachele e di altri congiunti, ma in particolare
dai sopralluoghi effettuati dal suo Capogabinetto,che dalla residenza della vicina Forlì si
recava settimanalmente sui cantieri della nuova Predappio. La visita effettuata dal
marchese insieme a Di Fausto il 1 maggio del 1926, segnò la svolta dell’immagine
urbanistica e linguistica del nuovo abitato. Non piacquero ai qualificati esaminatori la
configurazione degli edifici che stavano crescendo poichè “…tutti i progetti, singolarmente
esaminati, rivelano pretenziose forme banali dell’ultimo periodo di scimiuttatura del
8
barbaro stile liberty, periodo oggi facilmente superato”. Le conclusioni della relazione di
sopralluogo supportate sempre dalle considerazioni dell’architetto romano, misero in
evidenza l’effettiva mancanza di visione organica iniziale dell’intera pianificazione del
nuovo abitato, sostenendo che “sarebbe stata necessaria una concezione sintetica
dell’opera stessa la quale […] avesse anche tenuto nel necessario conto gli elementi
estetici e sentimentali che scaturiscono dalla vera tradizione e che sono suggeriti
dall’ambiente vario e pittoresco”. Le principali indicazioni scaturite dalla relazione furono
quelle di sottoporre tutte le nuove costruzioni, anche quelle già iniziate, alla revisione
competente di Di Fausto nel tempo breve di cinque o sei giorni “…sia per risparmio di
tempo e di spese, sia per la sicura conoscenza di questioni del genere […] sia ancora per
aver avuto egli (Di Fausto) la possibilità di prendere visione dei lavori in corso e del luogo”
41.La missiva di Mussolini al ministro Giuriati del 5 maggio 1926, confermava l’affidamento
dell’incarico all’architetto romano, preoccupato in quel momento non tanto dei nuovi
progetti, quanto dell’eventuale esito del concorso per la nuova parrocchiale, bandito nel
marzo precedente, poiché vedeva sfuggire l’unica occasione per la progettazione a
Predappio di un nuovo importante edificio. La vittoria scontata dei “pericolosi, soliti
Piacentini e Bazzani” e la presenza di Brenno Del Giudice “un tale di Venezia”, spinsero Di
Fausto a scrivere a Mussolini promettendogli un nuovo progetto dove avrebbe egli stesso
dimostrato in pieno le proprie capacità. Il 15 maggio 1926 il concorso fu giudicato e
segnalato come miglior progetto quello di Cesare Bazzani, lodato per la sua immagine
generale ispirata ai migliori esempi del Rinascimento. Il progetto Piacentini non piacque,
nonostante tre diverse soluzioni planimetriche presentate, peraltro non corrispondenti agli
alzati e che troppo si allontanavano dalla concezione della croce latina e non piacquero i
partiti architettonici archeologizzanti del prospetto ispirati all’architettura romana imperiale.
il progetto di Del Giudice fu criticato per il suo esotismo déco, caratterizzato da “linee care
a scuole esotiche”, poco adatte ad essere applicate a strutture di tradizione latina. Gli esiti
del concorso furono messi presto a tacere e rimandati a tempi migliori, ma segnarono la
scomparsa di Piacentini dall’area del forlivese, incalzata dalla potente presenza di
Bazzani42. L’impressione prospettica, stilata da Di Fausto il 26 maggio 1926 e approvata
dal Capo del Governo riportava la centralità dei poteri su di un’unica piazza, già con
l’indicazione scenografica della scalea monumentale e dove Palazzo Varano riproponeva
l’immagine piacentiniana del palazzetto “rinascimentale” della cittadella italiana
all’Esposizione di San Francisco, non senza gli evidenti riferimenti agli antichi palazzi
comunali dei piccoli centri vicini, dove la torre dell’orologio assurge generalmente al ruolo
di asse geometrico e visivo. La torre sino dalla base contiene inoltre i momenti decorativi
più importanti di tutto l’insieme, sublimata dal grande fastigio che incornicia lo stemma
comunale, realizzato dallo scultore Ulderigo Conti in stucco romano. Secondo una
concezione di parità fra le arti che il déco aveva ereditato dal Liberty, l’architetto romano
coordinava anche tutte le dotazioni artistiche e decorative degli interni, che si presentava
ricco di stucchi, marmi, parati, busti, corpi illuminanti in ferro battuto. Di Fausto utilizzava
dunque a Predappio un linguaggio pseudovernacolare estremamente colto, fatto di
passaggi e di cadenze, di “genius loci” e di suggestioni storicistiche, quali quelle bizantinoravennati e quelle romaniche, manieriste e barocche, ma con un gusto per i partiti e le arti
decorative di sostanza squisitamente déco 42.Nel caso degli edifici residenziali e nell’ufficio
postelegrafonico modulava registri più “moderni” come quelli vicini al “barocchetto” in gran
voga a Roma, dove l’impiego di formulari dèco semplificati erano diffusi nell’edilizia
economica e popolare da Innocenzo Sabbatini (quartiere Trionfale) o da Alessandro
Limongelli (quartiere Flaminio). Ecco dunque in un forte risalto coloristico e messi in
evidenza da materiali scuri sull’intonaco bianco o giallo, aperture di porte e finestre
contornate da bugnato liscio o alternato, chiavi di piattabande architravate in forte rilievo,
epigrafi apotropaiche o di datazione impresse con carattere lapidario, campiture d’intonaco
9
riquadrate contenenti decorazioni a rilievo (volo di rondini, canestri), tondi con medaglioni
e volti celebrativi,lanterne forgiate in ferro battuto, obelischi e mascheroni. Il gusto
decorativo dei nuovi edifici fu raccontato, non senza una vena di ironia da Antonio Baldini,
dopo un sopralluogo effettuato insieme all’amico Antonio Beltramelli, nel luglio del 1927: “
l’occhio tornando sulla strada, è subito chiamato da due file di case nuove di zecca, che
cominciano qualche decina di metri più in là, in un aspetto più moderno, confortevole e
cittadino, ancora fresche di calce e di colore, con delle grandi iscrizioni latine e mascheroni
decorativi stile Supercinema(…)Poco più avanti in posizione dominante, con bella vista sul
fiume, con in opera gradinate e fontane decorative, sorge il vecchio e quadrato palazzotto
Varano di Costa, interamente rammodernato con esito non privo di gusto…” 44. Nell’Asilo e
nell’adiacente oratorio di Santa Rosa, Di Fausto articolava i fronti, in un afflato puramente
déco,con i caratteri del barocchetto e quelli dell’ormai collaudata “aulica rusticità”: mattone
faccia vista montato secondo accurate tessiture decorative, quindi finestre centinate e
articolati cartigli barocchi. La facciata rosso cupo dell’oratorio è caratterizzata dalla
sovrapposizione del ritaglio di una seconda facciata intonacata a stucco romano su cui
campeggia la statua del Redentore, iscritta a sua volta in una vetrata circolare policroma.
All’interno un ricco apparato decorativo contempla la decorazione absidale in oro e
azzurro a finto mosaico, riferita ai modelli ravennati, illuminata da artistiche vetrate.Un
registro linguistico semplificato, contrassegnato da ricorrenti e sobri apparati decorativi del
mattone, venne applicato infine agli edifici meno rappresentativi, come il foro boario, il
mercato viveri, o i piccoli padiglioni del complesso della Casa dei Sanitari, ornati da
raffinati inserti ceramici, 45 a dimostrare ancora una volta che l’architettura di Di Fausto era
qualificata anche dal portato dell’ornamentazione.
Tito Chini a Castrocaro
“…Questo è bello, questo è del Chini, e non Galileo, ma Tito”, è quanto con tono gioioso,
Tito Chini comunicava epistolarmente alla moglie Valentina, il successo ottenuto dalle
ceramiche della “Premiata Manifattura Fornaci di San Lorenzo, Chini e C.” alla terza
Esposizione di Arti Decorative, tenutasi nella villa reale di Monza nel 192746.
Un’affermazione importante per Tito, giovane direttore artistico, succeduto nel 1925 al
biscugino e notissimo Galileo, ormai pittore ufficiale della Biennale di Venezia e al culmine
della fama. Galileo
era il più celebrato dei Chini, anche se era Chino, padre di Tito, a rendere possibile con
grande competenza le sue richieste artistiche, a ricercare e a perfezionare quelle tecniche
del “lustri a granfuoco” che rendevano alle ceramiche borghigiane le raffinate opalescenze
dei “clair de lune” di Gallè o le iridescenze preziose di “favrile glass” di Tiffany.
L’apprendistato di Tito presso Galileo fu determinante per la sua formazione: a Venezia
nel 1921, mentre attendeva all’affresco della cupola dell’atrio della Biennale, ebbe modo di
conoscere e di apprezzare le opere di Maurice Denis e dei Nabis e la loro semplicità
figurativa, dipinta attraverso superfici piatte, dominate dalle campiture del colore e dai
contorni netti; nel 1922 collaborava invece alla decorazione delle terme Berzieri di
Salsomaggiore, espressione della volontà di una sperimentazione, incentrata su una
figurazione decorativa ad alto quoziente cromatico applicata ad una architettura 47.
Fondamentale fu per Tito anche il soggiorno a Parigi nel 1925, in occasione dell’Exposition
des Arts Decoratifs et Industriels, dove riuscì a maturare un suo inconfondibile stile,
affrancandosi dai tardi fascinosi influssi dal Liberty, e dove ottenne la medaglia d’oro per la
decorazione del Padiglione Italiano;a Parigi conobbe nuovi artisti, nuove tecniche e mise a
punto un aspetto che sarà da quel momento, e soprattutto a Castrocaro, essenziale: il
connubio perfetto fra la struttura architettonica e l’apparato decorativo. La rinnovata
tendenza del gusto fu accolta da Tito nella sua predilezione per la geometrizzazione e
10
astrazione delle forme e nella volontà di assegnare un valore fondante al colore, con la
conseguente riformulazione di un rinnovato repertorio costituito da forme leggere,
sintetiche, caratterizzate da un’ironia che rimandava al repertorio figurativo di Giò Ponti,
dal 1923 direttore artistico delle manifatture ceramiche Richard-Ginori. Nel 1936, molti
anni dopo la giovanile esperienza condotta a Salsomaggiore, Tito Chini tornava ad
operare presso gli stabilimenti delle acque con un lessico affinato, fatto di suggestivi
rimandi e di nuovi originali apporti 48.
Fu Pietro Zavagli, funzionario a Roma del Demanio Pubblico e Immobiliare dello Stato e
responsabile a Forlì dell’Ufficio Tecnico Erariale a portare a Tito Chini, a metà degli anni
Trenta, incarichi di consulenza per il riammodernamento di alcuni edifici in importanti siti
termali demaniali, come a Roncegno-Vetriolo in Val Sugana, Levico e Recoaro intorno a
Vicenza, e Santa Cesarea nei pressi di Otranto. Fu ancora Zavagli a metterlo in contatto
con Diego Corsani per le nuove terme demaniali di Castrocaro, dove il primo edificio ad
essere costruito fu il Padiglione delle Feste (1936), progettato dallo stesso Corsani e
reinventato dalla grazia e dalla forza espressiva degli interventi di Tito, chiamato a ragione
nel cantiere “l’architetto Chini”.L’assidua presenza dell’artista e la sua straordinaria
competenza, contribuirono al controllo sia dell’immagine architettonica che di quella
decorativa: suggeriva, modificava, trasformava, creava nuove spazialità, maturava infine
nell’unità decorazione-architettura la sua concezione culturale del rapporto tradizionemodernità. I semplici e stereometrici volumi del Padiglione venivano valorizzati dall’uso
sapiente dei materiali: il cotto, il marmo nero delle Alpi, il travertino di Rapolano e la
ceramica iridescente, ispirata al motivo dell’onda stilizzata. Ai lati del corpo aggettante
semicircolare d’ingresso, entro due nicchie appena accennate, sono collocate due grandi
fontane “a torsolo” realizzate in marmo verde di Prato, ispirate ai progetti di fontane di G.
Giandante X (Dante Pescò) per l’esposizione di Monza del 1925, da cui scendono getti di
acqua filiforme. I colori dei marmi e e i lustri a gran fuoco della ceramica si intonano
perfettamente e sulla tessitura muraria si sovrappongono i ricorrenti motivi del delfino e
della cornucopia.Nei luminosi interni tornano le ceramiche iridescenti, i lampadari a
cappello di cardinale e appliques a forma di conchiglia con opalescenze madreperlacee,
sovrapposte a vitree onde turchine, realizzati dalla ditta Venini di Murano49. Per gli arredi
interni, nella sala di lettura, ancora rimandi al 1925 come nel tavolo centrale che ricorda
l’ideazione di Maurice Dufrène per la sala da pranzo del padiglione La Maitrise (Atelier de
les Galeries Lafayette). Per la sala da fumo, Tito Chini inventò invece temi decorativi
ironizzando con allusioni al piacere e all’amore, mentre per la sala da gioco propose il
tema dei Tarocchi. Nella galleria posta al primo piano dove si aprono dieci palchi,
altrettanti pannelli occupano ciascuno un’intera parete laterale di ogni palco e portano il
tema dei mestieri della terra proiettati nel ciclo delle stagioni. Il Padiglione era stato
concepito come uno spazio continuo da vivere in un’esplosione di luce e di colore,
caratterizzato da continue trasparenze che permettevano anche al verde circostante di
essere soggetto attivo al suo interno. Il salone delle Feste al suo interno conteneva nella
parte absidale due vasche di marmo verde cipollino, sulle quali scendeva l’acqua
curatrice, vera fortuna del complesso termale, che riportava la bouvette all’interno
dell’edificio come grande elemento decorativo. In realtà le cure idropiniche continuarono a
essere dispensate nel Tempietto Pompeiano o Littorio,restaurato dallo stesso Chini nel
1941,ma ideato nel 1924 dalla ditta ceramica Focaccia & Melandri di Faenza, per
accogliere una nuova scaturigine di acqua sulfurea salsoiodica che aprì la via alle
applicazioni idropiniche e quindi ad un nuovo ramo di risorse terapeutiche. L’apparato
decorativo del tempietto è fastoso, costituito da capitelli di maiolica di ordine composito
che sormontano le due colonne e le due paraste angolari, da una copertura a padiglione
composta da un manto di scandole policrome in ceramica, ed infine da un magnifico
dossale, da cui escono le fontanelle dell’acqua curativa, in ceramica invetriata dove si
11
mescolano con raffinata eleganza i toni del blu, del verde e dell’oro50. Il Compendio
termale comprensivo del Padiglione delle Feste, dello Stabilimento per le cure e
dell’incompiuto Grand Hotel, rappresenta l’opera più significativa dell’attività artistica di
Tito Chini, esemplare per la sua capacità di trasformare semplici schemi o spesso solo
idee in elaborati progetti e ancor più per ottenere,oltre al sapiente e concatenato rapporto
di volumi,la perfetta fusione fra architettura e decorazione.
12