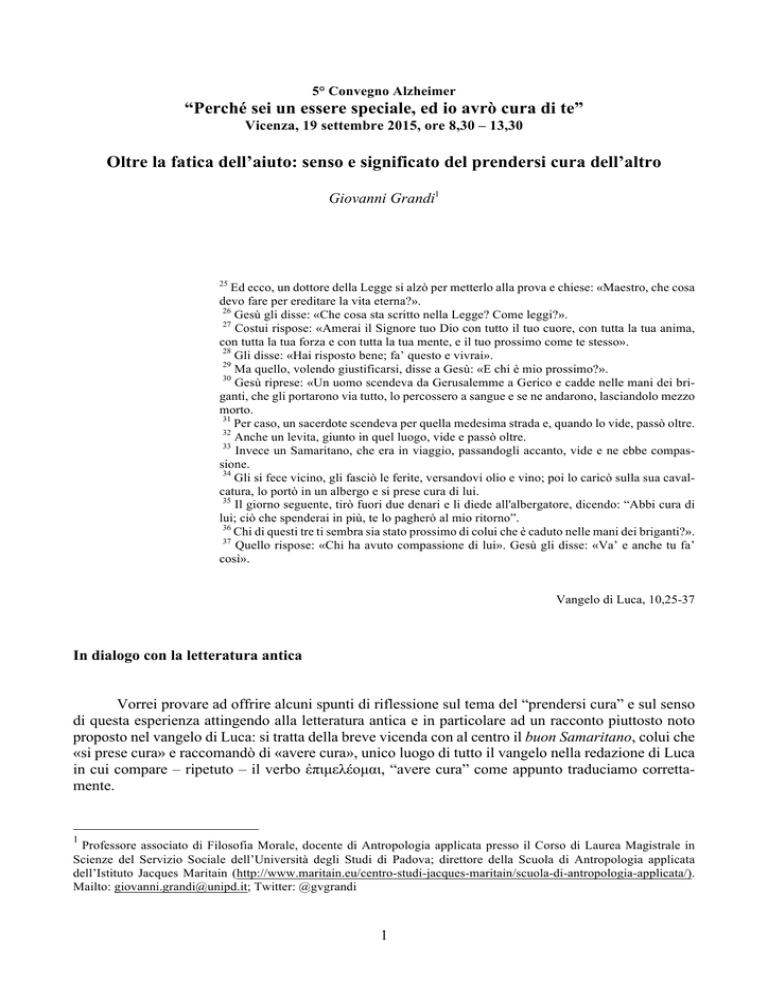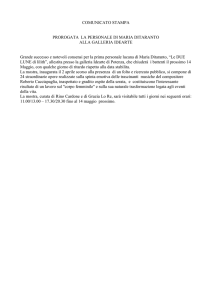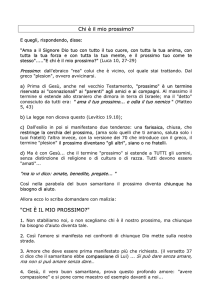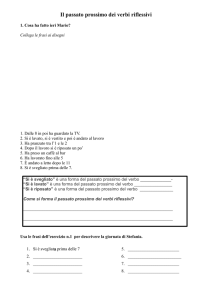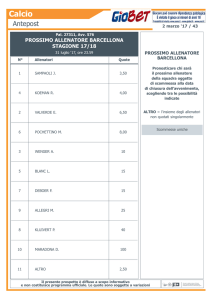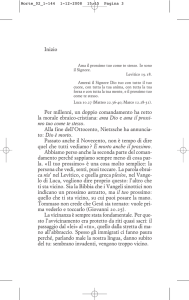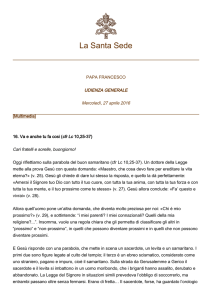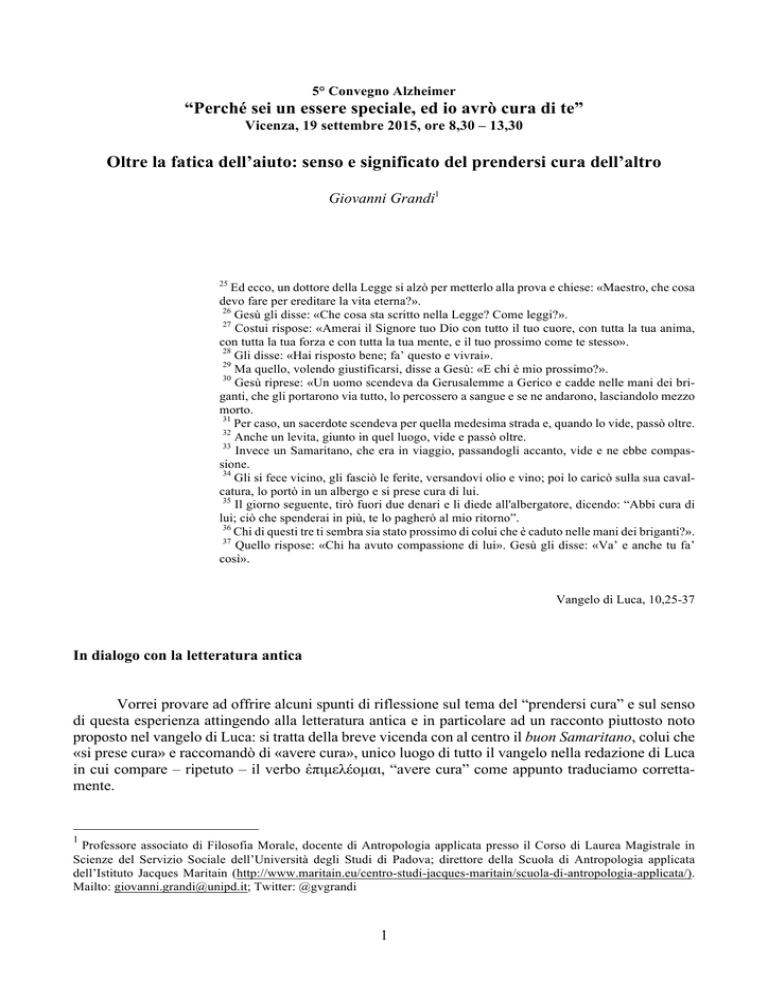
5° Convegno Alzheimer
“Perché sei un essere speciale, ed io avrò cura di te”
Vicenza, 19 settembre 2015, ore 8,30 – 13,30
Oltre la fatica dell’aiuto: senso e significato del prendersi cura dell’altro
Giovanni Grandi1
25
Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che cosa
devo fare per ereditare la vita eterna?».
26
Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?».
27
Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima,
con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso».
28
Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai».
29
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?».
30
Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo
morto.
31
Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre.
32
Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre.
33
Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione.
34
Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui.
35
Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all'albergatore, dicendo: “Abbi cura di
lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”.
36
Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?».
37
Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’
così».
Vangelo di Luca, 10,25-37
In dialogo con la letteratura antica
Vorrei provare ad offrire alcuni spunti di riflessione sul tema del “prendersi cura” e sul senso
di questa esperienza attingendo alla letteratura antica e in particolare ad un racconto piuttosto noto
proposto nel vangelo di Luca: si tratta della breve vicenda con al centro il buon Samaritano, colui che
«si prese cura» e raccomandò di «avere cura», unico luogo di tutto il vangelo nella redazione di Luca
in cui compare – ripetuto – il verbo ἐπιµελέοµαι, “avere cura” come appunto traduciamo correttamente.
1
Professore associato di Filosofia Morale, docente di Antropologia applicata presso il Corso di Laurea Magistrale in
Scienze del Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Padova; direttore della Scuola di Antropologia applicata
dell’Istituto Jacques Maritain (http://www.maritain.eu/centro-studi-jacques-maritain/scuola-di-antropologia-applicata/).
Mailto: [email protected]; Twitter: @gvgrandi
1
Sappiamo che le esigenze comunicative degli antichi erano diverse dalle nostre: la trasmissione degli insegnamenti era fondamentalmente orale e, nel trovare anche forma scritta, vi era l’esigenza di condensare in pochi tratti molti contenuti, che l’ascoltatore più attento poteva desumere
anche dalla architettura dei racconti, dalle ripetizioni, dalle assonanze, dalle contraddizioni alle volte.
Incontriamo così molto spesso dei testi molto brevi, in cui però troviamo condensati molti spunti.
Potremmo, un un certo senso, paragonarli a dei post-it con parole chiave e brevi schemi logici: dei
promemoria molto agili ma da cui poter estrarre ad ogni rilettura elementi diversificati.
La letteratura in parabole è molto interessante proprio in prospettiva antropologica, perché
indubbiamente porta con sé un messaggio religioso, confessionale, ma lo innesta in una lettura delle
dinamiche ordinarie della vita. Consultarla, per noi, significa incontrare problematiche di sempre che
coinvolgono tutti, non solo intellettuale o specialisti. In questo senso nei racconti brevi dell’antichità
incontriamo qualcosa che difficilmente non ci riguarda, e che senz’altro possiamo riconsiderare e
attualizzare per la nostra meditazione.
La domanda sulla vita, l’aver cura, il riconoscimento del «prossimo»
La brevissima parabola è interessante perché sollecita una riflessione proprio sul senso del
«fare», come segnalano le espressioni che la incorniciano: «che cosa devo fare?» è la domanda da
cui scaturisce il dialogo che introduce il racconto, «anche tu fa’ così» è l’esortazione che chiude il
brano. Questo fare poi è orientato alla vita: «che cosa devo fare per ereditare la vita eterna (ζωὴν
αἰώνιον, vita che dura)» chiede specificamente il dottore della legge e, nelle prime battute, troviamo
già una anticipazione nella risposta di Gesù: «fa’ questo e vivrai (ζήσῃ)».
C’è dunque un fare che mette in contatto con la vita, che accompagna nel dare risposta a questo
desiderio insopprimibile che ciascuno avverte in se stesso, e questo fare è l’aver cura.
La tradizione ha intitolato questo brano come la vicenda del “buon Samaritano”, attribuendo
al protagonista una qualifica di “bontà” che non troviamo nel testo, e che potrebbe indurre a considerazioni di ordine deontologico, quasi a trarne molto rapidamente il messaggio che per ottenere la vita
occorre essere buoni e avere cura degli altri. Questa conclusione non è naturalmente lontana dalle
corde dell’esortazione evangelica, ma rischia di perdere proprio quelle sottolineature che qui possono
interessarci maggiormente e – forse – aiutarci ad illuminare il senso dell’aver cura segnato dalla
fatica, anche da quella fatica che consiste nel non ottenere cenni di riuscita.
Se osserviamo il racconto attraverso la sua cornice ci accorgiamo subito che si tratta di un
commento al comandamento dell’amore per il prossimo. «Chi è il mio prossimo?» chiede il dottore
della Legge: chi si tratta dunque di amare come se stessi? La memoria che non di rado portiamo in
noi come eco di una lettura pietista ci farebbe dire che il prossimo da amare è, come si concludeva
sopra, il malcapitato. Però il testo non dice questo, non almeno in modo così diretto: Gesù chiede
espressamente di individuare la figura del «prossimo» tra quelle dei tre che sono passati accanto allo
sventurato: «Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?».
Lo spunto sorprendente risiede in una curiosa inversione, perché è come se Gesù stesse dicendo: se vuoi dare una risposta alla tua attesa di vita e a quel che c’è da fare, esamina una relazione
di aiuto, osserva quel che il «prendersi cura» rivela, ma nel farlo riconosciti anzitutto nella figura del
malcapitato, non in quella del soccorritore.
Chi è allora il mio prossimo? Uno dei tre. Dunque tu sei l’uomo «mezzo morto».
2
Riconoscersi «mezzi morti»
La suggestione merita di essere esplorata: per fare quel che intuisco essere bene – il dottore
della legge riconosce facilmente l’esemplarità del Samaritano –, devo anzitutto prendere coscienza di
qualcosa che mi riguarda, devo cioè scoprire che proprio io sono quello «mezzo morto».
Non posso entrare nel senso dell’aver cura se non mi riconosco anzitutto nell’uomo bisognoso
di cura. Non posso fare come il Samaritano – per quanto possa approvarne deontologicamente l’operato – e sostenere un fare simile al suo se non elaboro in profondità la mia sete di vita, se non riconosco
i miei luoghi di aridità, di fatica, di oppressione, se non riconosco il mio limite e il mio bisogno di
essere soccorso. Occorre maturare questa coscienza esistenziale per aprirsi al senso del fare e per
poterne sostenere le esigenze – alle volte molto onerose – liberati, ad esempio, dall’ansia da prestazione, dalla pretesa di dover risolvere, dall’illusione di essere in grado di provvedere un lieto fine.
Riconoscersi come dei «mezzi morti» bisognosi di soccorso – e solo poi, a partire da qui, come
dei potenziali soccorritori – ridimensiona quell’aura di divinità, di superiorità che talvolta le professioni di aiuto si portano (loro malgrado) cucite addosso. Non dimenticare il proprio essere «mezzi
morti», in attesa di vita, riduce la distanza che alle volte si crea tra il sano e il malato, tra il soccorritore
e il soccorso. Soprattutto però aiuta a stare di fronte alle insufficienze del proprio aver cura, evitando
di distorcere il senso del dolore – che accompagna l’evolversi di molte storie irrisolvibili – in un senso
di colpa paralizzante. Nessun «mezzo morto» ha in mano le chiavi della vita: ne sperimenta il desiderio, fa di tutto per sostenerla, ma non ne è la sorgente. Chiunque sia stato «mezzo morto» è consapevole della propria debolezza, conosce i limiti del proprio potere di autoguarigione e a maggior
ragione del potere di guarigione dell’altro. In breve: non si immagina di essere Dio.
Amare il prossimo come se stessi significa così (anche) riconoscere che nessuno è Dio per
l’altro uomo, ma che tutti ci rispecchiamo gli uni negli altri come «mezzi morti», bisognosi di soccorso. Potremmo trarne che diventiamo tanto più capaci di soccorrere, di riportare agli altri quel tanto
di vita che possiamo, quanto più demitizziamo il nostro potere sulla vita, sul corso di una storia, sul
decorso di una malattia. E, insieme, diventiamo tanto più capaci di farci aiutare quanto più accettiamo
i limiti di chi si prede cura di noi, quando accogliamo il fatto che a sua volta abbia solo il potere
piccolo dei «mezzi morti» e non un potere divino di guarigione.
Il prossimo, dunque, proprio come noi stessi: né noi né lui signori della vita e della morte. Il
prossimo, ancora, da amare come noi stessi: da accogliere come è, riconoscendone la limitatezza, il
potere precario, la stessa fragilità che segna la nostra esperienza. Il prossimo da non caricare di aspettative, il prossimo a cui voler bene perché – quale che sia la sua posizione (pensiamo alle asimmetrie
dei diversi contesti di “cura”: medico-paziente, docente-studente…) – è un «mezzo morto» proprio
come noi e, ciononostante, capace di essere di aiuto. Dunque per soccorrere non occorre neppure
essere perfetti.
Riconoscersi in viaggio
Un secondo spunto viene dal considerare uno dei tratti distintivi di questo «prossimo» che
esistenzialmente ci somiglia molto, che non è onnipotente, ma nella cui vita il prendersi cura si inserisce in modo quasi connaturale, armonico si potrebbe persino dire.
L’evangelista annota che il Samaritano «era in viaggio» e, in effetti, si direbbe quasi lavorare
con finezza con i verbi di moto e con la loro disposizione. In particolare qui è interessante la sequenza
tra i verbi «vedere» e «passare».
Il sacerdote e il levita prima «videro» e quindi «passarono oltre» (ἀντιπαρέρχοµαι), come traduce la versione italiana più recente; «passò oltre dall’altra parte» provava ad esplicitare la traduzione precedente, per non perdere il senso di uno spostamento su un altro versante proposto dal verbo
3
greco, un movimento che richiama proprio l’aggirare un ostacolo. Quasi a dire che i due si preoccupano di mettere la massima distanza possibile tra sé e il «mezzo morto», e modificano il loro percorso
a questo scopo. In un certo senso si sopravvalutano, è come se dicessero che non hanno nulla a che
vedere con i «mezzi morti», loro sono diversi, sono «vivi», potenti. Eppure questa è un’illusione:
gelosi del loro status finiscono per non mettere in campo alcuna forma, neppure precaria, di guarigione dell’altro. Il che rivela che non sono affatto vivi come vorrebbero dire a se stessi, prendendo le
distanze dal «mezzo morto»: sono più morti di lui e lo si capisce perché da loro non parte alcuna
iniziativa di soccorso, di rianimazione.
Nel caso del Samaritano la sequenza dei due verbi è invertita e il «passare» diventa il contesto
in cui si dispiega anche il «vedere»: «passandogli accanto (ἔρχοµαι) vide». Al contrario degli altri
due non modifica la sua traiettoria, non sceglie chi incontrare e chi evitare, ma accoglie semplicemente quello che si presenta sulla strada. E il suo cammino lo porta anche a passare accanto allo
sventurato. A partire da questa apertura a ciò che viene incontro, il «vedere» genera uno sviluppo ben
diverso: «vide e ne ebbe compassione». Il prendersi cura sgorga da queste tre coordinate: passare
accanto, vedere, cum-patire, cioè sentire su di sé la situazione dell’altro, riconoscersi nel «mezzo
morto». Da questa posizione umile, esistenzialmente alla pari, si liberano le attenzioni concrete ricordate nel denso versetto 34: «Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò
sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui». È interessante qui il fatto che il
Samaritano, in fondo, attivi tutti i gesti della cura a partire dalla fedeltà al proprio viaggio, dalla
risolutezza nel non deviare, cosa che non accade per gli altri due, che invece sono risoluti nello scartare quel che la strada riserva loro.
Diventa capace di dispiegare tutto il ventaglio dei gesti di cura chi si riconosce a propria volta
bisognoso, ma al tempo stesso affronta la vita con una prospettiva di lungo respiro (potremmo specificare: spirituale?), chi ha una destinazione, chi non è impegnato anzitutto ad evitare gli incomodi,
chi soprattutto non scappa da quello che la vita propone, ma è disponibile ad ospitare, a fare spazio
all’inconveniente. L’aver cura si realizza in quel che l’esistenza ordinaria già propone, non in chissà
quali impegnativi e remoti contesti.
Insieme però noteremo che il Samaritano è anche determinato nel proseguire per la propria
strada che – lo intuiamo dal cenno del ritorno – potrebbe essere un pellegrinaggio.
I gesti risananti della cura diventano possibili e sostenibili allora anche ad un’altra condizione:
quella di non farsi assorbire dalla cura e di mantenere vive le esigenze del viaggio. È il viaggio che
dà senso al prendersi cura, non viceversa. È nel contesto del viaggio che l’aver cura diventa un punto
di fioritura della vita, tanto di chi soccorre, quanto di chi è soccorso. Senza la prospettiva del viaggio
– noi potremmo tradurre: senza una percezione del senso della propria esistenza nel suo complesso,
nelle sue diverse stagioni, nelle sue relazioni, nella sua destinazione – anche le soste riservate al farsi
carico dell’altro rischiano di diventare terribilmente faticose, macerate in un senso di privazione e
alla fine sterili. Il Samaritano, in fondo, passa la mano all’albergatore: prosegue nella fedeltà al suo
itinerario; allo stesso tempo rimane fedele allo sventurato con quella promessa di ritorno. Non pretende di esserci sempre, non ritiene di dover fare tutto lui ma, non per questo, smette di farsi carico.
In questa coordinata di un viaggio personale che va rispettato, tenuto presente e talvolta –
specie nella vita adulta – riscoperto, mi pare si possa vedere proprio il richiamo ai rischi che ciascuno
corre nelle situazioni di assistenza prolungate e difficoltose. Non è raro che in queste situazioni le
persone impegnate nella cura, specialmente dei propri famigliari, pian piano ridefiniscano la propria
esistenza quotidiana in base alle esigenze dell’assistenza. Particolarmente nel tempo di questa sorta
di “sosta alla locanda” è fondamentale mantenere vivo il senso del proprio essere in cammino, sapendo che perdere questa dimensione significa anche, pian piano, smarrire il senso delle soste e – con
questo – le energie per prolungarle.
4
Il senso del prendersi cura, spunti per interrogarsi
Che cosa fare, dunque, per ottenere la vita durevole, salda? Fare come il Samaritano, cioè
mettersi in viaggio: la compassione, di cui questi si mostra capace, diventa possibile e sostenibile
perché sta compiendo un itinerario personale, spirituale potremmo senz’altro aggiungere. Il motivo
per cui questo straniero ci viene additato non è, non almeno immediatamente, il suo aver cura, il suo
buon fare. I gesti ricompresi in quella acuta sequenza ci colpiscono esemplarmente, e tuttavia non
sono il terminale per la nostra attenzione: a loro volta vengono proposti per invitare a risalire al perché
diventino possibili, al che cosa ne garantisca la sostenibilità, al perché in alcuni si facciano storia
ordinaria, laddove in altri rimangono allo stato di buone intenzioni, mentre l’esistenza concreta si
risolve in strategie più o meno efficaci di evitamento di quel che si incontra per via.
Il senso dell’esperienza stessa del prendersi cura, del fallire, del riuscire, dello sfiancarsi o del
ritrovare vita sta anche nel farci giungere all’appuntamento con questi interrogativi: il prendersi cura,
specialmente lì dove la fatica si fa sentire, è un fare di cui è importante percepire la provocazione
profonda e il richiamo a risalire alle sorgenti della vita. E a non perdere, tra le mille cose da fare, il
senso esistenziale del pellegrinaggio.
5