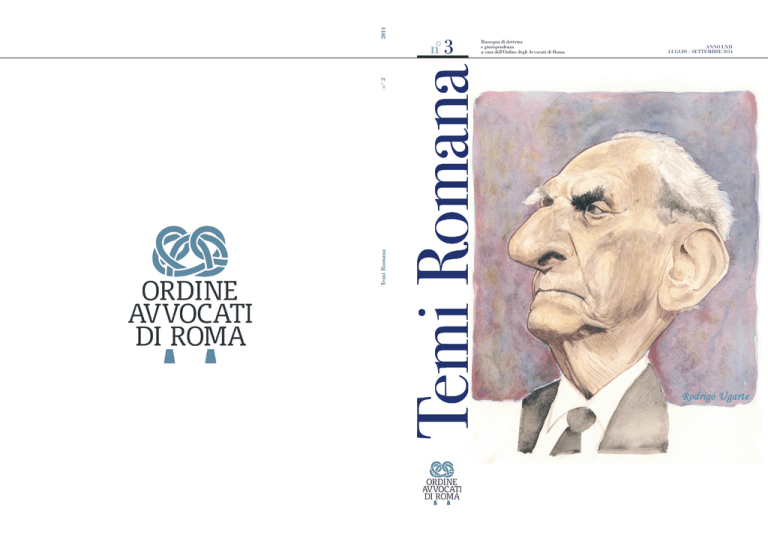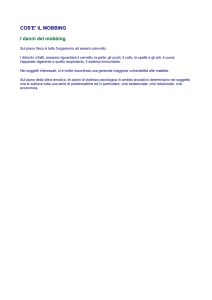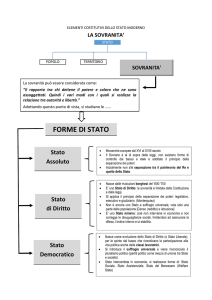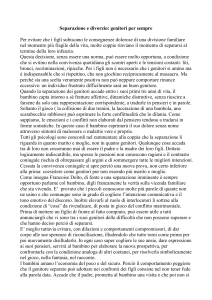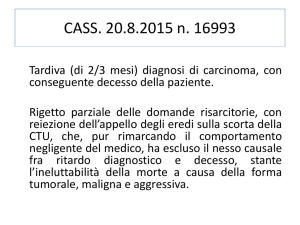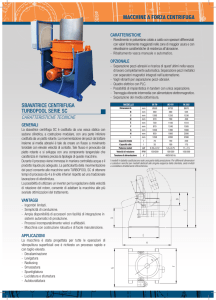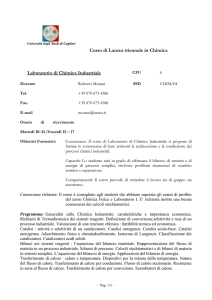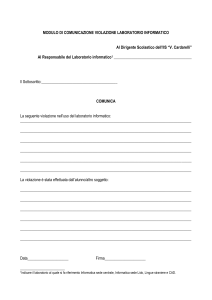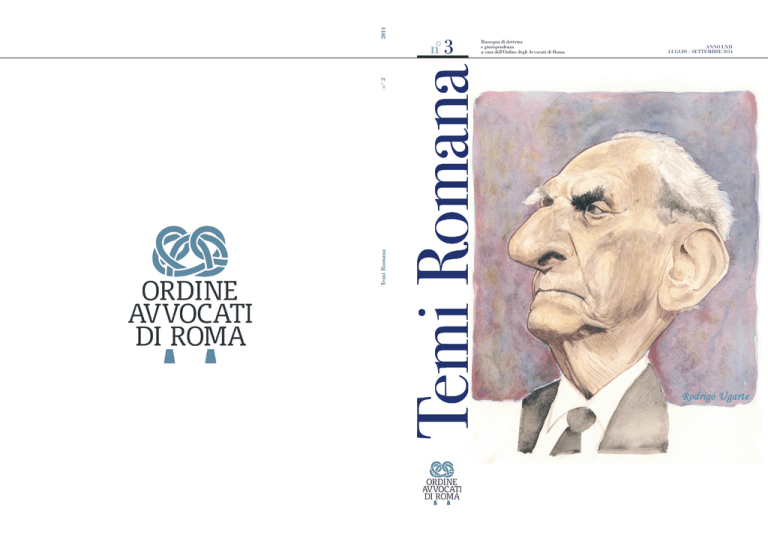
2014
n° 3
Temi Romana
n° 3
Rassegna di dottrina
e giurisprudenza
a cura dell’Ordine degli Avvocati di Roma
ANNO LXII
LUGLIO – SETTEMBRE 2014
Passeggiata in libreria
n° 3
Rassegna di dottrina
e giurisprudenza
a cura dell’Ordine degli Avvocati di Roma
“TRASPARENZA E PRIVACY NELLA GESTIONE DEL BILANCIO
DELL’UNIONE EUROPEA”
Giuseppina Crisponi NUOVA EDITRICE UNIVERSITARIA, ROMA
pp. 160, euro 15,00
Da metafora esistenziale a paradigma istituzionale – dall’oracolo di Delfi alle Istituzioni
comunitarie – il motto «nulla di troppo» indica la strada del bilanciamento come metodo
per affrontare e risolvere i conflitti. Nell’ambito della formazione ed esecuzione del
bilancio generale dell’Unione europea e della presentazione e revisione dei conti, in questo
libro è offerta un’immagine rappresentativa della complessità intrinseca alla necessità di
stabilire un equilibrio ottimale tra diritti ugualmente meritevoli di salvaguardia: l’interesse
dell’Unione europea a garantire la trasparenza e una sana gestione delle finanze pubbliche,
da un lato, e i diritti fondamentali dei beneficiari dei fondi dell’UE al rispetto della vita
privata e alla protezione dei dati personali, dall’altro, con il fondamentale contributo del
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sulla questione.
Direttore Responsabile: Mauro VAGLIO
Direttore Scientifico: Alessandro CASSIANI
Capo Redattore: Samantha LUPONIO
Comitato Scientifico:
Paola BALDUCCI, Antonio BRIGUGLIO, Luigi CANCRINI,
Pierpaolo DELL’ANNO, Antonio FIORELLA, Giovanni Maria FLICK
Giorgio LOMBARDI, Carlo MARTUCCELLI, Ugo PETRONIO
Eugenio PICOZZA, Giulio PROSPERETTI, Giorgio SPANGHER
Alfonso STILE, Federico TEDESCHINI, Roberta TISCINI,
Giancarlo UMANI RONCHI, Romano VACCARELLA
Comitato di Redazione:
Mauro VAGLIO, Pietro DI TOSTO, Antonino GALLETTI
Riccardo BOLOGNESI, Fabrizio BRUNI
Alessandro CASSIANI, Domenico CONDELLO, Antonio CONTE
Mauro MAZZONI, Aldo MINGHELLI, Roberto NICODEMI, Livia ROSSI
Matteo SANTINI, Mario SCIALLA, Isabella Maria STOPPANI
Coordinatori:
Antonio ANDREOZZI, Andrea BARONE, Camilla BENEDUCE
Domenico BENINCASA, Marina BINDA, Ersi BOZEKHU
Francesco CASALE, Francesco CIANI, Benedetto CIMINO, Irma CONTI
Antonio CORDASCO, Alessandro CRASTA, Carmelita DE FINIS
Annalisa DI GIOVANNI, Ruggero FRASCAROLI, Maria Vittoria FERRONI
Fabrizio GALLUZZO, Alessandro GENTILONI SILVERI, Mario LANA
Paola LICCI, Andrea LONGO, Giuseppe MARAZZITA, Franco MARCONI
Alessandra MARI, Gabriella MAZZEI, Arturo MEGLIO, Chiara PACIFICI
Ginevra PAOLETTI, Chiara PETRILLO, Tommaso PIETROCARLO
Aurelio RICHICHI, Sabrina RONDINELLI, Serafino RUSCICA
Marco Valerio SANTONOCITO, Massimiliano SILVETTI, Luciano TAMBURRO
Federico TELA, Antonio TESTA, Federica UMANI RONCHI, Clara VENETO
Segretario di redazione: Natale ESPOSITO
Progetto grafico: Alessandra GUGLIELMETTI
Disegno di copertina: Rodrigo UGARTE
____________
Temi Romana - Autorizzazione Tribunale di Roma n. 320 del 17 luglio 2001 - Direzione, Redazione: P.zza Cavour - Palazzo di Giustizia - 00193 Roma
Impaginazione e stampa: Infocarcere scrl - Via C. T. Masala, 42 - 00148 Roma
“CODICE DEL PUBBLICO IMPIEGO”
Francesco Caringella, Ciro Silvestro, Francesco Vallacqua (Coordinatori)
Testi di: Ciro Silvestro, Francesco Vallacqua, Renata Mazzaro, Fabrizio Sileri,
Bruno Strati, Caterina Panzarino, Antonio Campanella, Anna Consiglio,
Tina Cecilia Menelao, Alessandro Nicodemi, Luigi Pianesi, Valentina Fiorillo,
Veronica Valenti, Barbara Malaisi, Simone Calzolaio
DIKE GIURIDICA EDITRICE, ROMA
pp. 1900, euro 150,00
Il codice si prefigge l’obiettivo di dotare operatori, amministratori e studiosi di una guida
completa ed organica che illumini il variopinto mondo del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni, tracciando un esaustivo panorama delle norme fondamentali
relative al pubblico impiego, privatizzato e non, ed all’universo previdenziale.
L’opera, inedita per ricchezza del materiale normativo e profondità dell’indagine, offre
agli operatori un quadro a 360 gradi del patrimonio di contributi ed esperienze svolti negli
ultimi anni sull’accidentato campo della riforma del lavoro alle dipendenze delle p.a..
“LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
E LE PROCEDURE CONCORSUALI”
Antonio Caiafa DISCENDO AGITUR, ROMA
pp. 292, euro 30,00
L’attuale ordinamento non offre una risposta adeguata alle esigenze delle imprese e dei
lavoratori nel caso di processi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione in caso di
crisi del mercato, in quanto le soluzioni previste (concordato preventivo, accordi di
ristrutturazione, piani attestati di risanamento e la stessa transazione fiscale), solo in
apparenza rappresentanti un rimedio volto alla preservazione dei valori aziendali, ma,
invero, non sono in grado di assicurare l’obiettivo voluto, soprattutto in ragione della
dimostrata incapacità del legislatore di regolare, in modo appropriato, il procedimento di
conformazione che le direttive comunitarie, troppo spesso ignorate, hanno inteso imporre,
nonostante le numerose pronunce intervenute attestino una preoccupante difformità della
disciplina nazionale da quella europea.
“L’AVVOCATO E LE SUE QUATTRO RESPONSABILITÀ”
Vito Tenore (a cura di) EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE, NAPOLI
pp. 576, euro 60,00
Mancava nel pur vasto panorama editoriale dedicato alla professione forense una
monografia a tutto tondo sulle quattro responsabilità dell’avvocato e delle società tra
avvocati. Difatti, gli studi editi si sono di solito soffermati sulla responsabilità civile per
errori professionali o su quella disciplinare per violazione di regole deontologiche. Molto
poco era stato scritto sulla responsabilità penale del difensore e mai nulla era stato
pubblicato su quella mministrativo-contabile per talune attività dell’avvocato. Il volume
colma, dunque, questa lacuna scientifica con uno studio organico, approfondito, aggiornato
alla riforma forense della Legge n. 247 del 2012, ancorato al basilare referente normativo e,
soprattutto, ricco di giurisprudenza (anche del CNF) e di dottrina, che hanno scandagliato
diversi profili della patologia comportamentale del peculiare professionista legale.
Sommario
n° 3
Rassegna di dottrina
e giurisprudenza
a cura dell’Ordine degli Avvocati di Roma
2
NORBERTO BOBBIO: LA STORIA
4
SAGGI
A cura di Eleonora Senese
Diritto penale europeo
Pietro Mazzei
12
Il mobbing nella prospettiva criminologica integrata
Giovanni Neri e Flavia Forgione
19
Profili generali relativi alla tutela del consumatore ed azione di classe - Parte I
Alessandro Nicodemi
32
Criteri d’individuazione del titolare della qualifica soggettiva nell’ambito delle organizzazioni
complesse e operatività della delega di funzioni, con particolare riferimento, alla responsabilità
di Amministratori e Sindaci di società - Parte II - Posizione di garanzia e Responsabilità
Francesca Zignani
39
Colpevole!... al 50%. Ovvero quando le perizie danno i numeri
Marco Zonaro
42 OSSERVATORIO LEGISLATIVO
Ancora sulla colpa medica: il danno da nascita indesiderata
Marina Binda
46
I modelli di organizzazione e controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001 nella prospettiva
di un magistrato della pubblica accusa
Pierluigi Cipolla
51 NOTE A SENTENZA
Concordato con riserva e licenziamento
Antonio Caiafa
57
Decadenze in materia di licenziamento
Carlotta Maria Manni
59 CRONACHE E ATTUALITÀ
L’addebito della separazione
Matteo Santini
Con i contributi di: Barbara Capicotto
Anna Lanza
Marco Meliti
Patrizia Paris
Temi Romana
1
Norberto Bobbio: la storia
È il senso del limite
che ci fa prendere contatto con la realtà
A cura di Eleonora Senese
N
orberto Bobbio nasce a Torino il 18 ottobre del
1909 da una famiglia abbastanza agiata che gli
consente di studiare. Dopo il conseguimento
del diploma al Liceo classico “Massimo D’Azeglio”,
nel 1928 si iscrive al Partito Nazionale Fascista, pur
non essendo vicino a quell’ideologia. Si iscrive
all’Università ove diviene allievo di due importanti
professori, Gioele Solari e Luigi Einaudi e, dove consegue la laura con lode in Giurisprudenza nel luglio del
1931, esponendo una tesi sulla “Filosofia e dogmatica
del Diritto”. Successivamente si trova a studiare in
Germania dove si avvicina alla filosofia di Jaspers e
all’esistenzialismo, laureandosi poco dopo anche in
Filosofia con una tesi riguardante la fenomenologia di
Husserl. Circa un anno dopo ottiene la cattedra
all’Università di Siena e a Padova, iniziando così la sua
carriera universitaria.
La sua avversione per il Fascismo gli procura un arresto a Torino e poco dopo un’intimidazione per la quale
scrive un esposto direttamente a Benito Mussolini. Nel
testo si discolpa delle accuse rivoltegli, riuscendo ad
ottenere addirittura la cattedra di Filosofia del diritto
all’Università di Camerino proprio grazie all’intervento dello stesso Mussolini.
Negli anni giura ancora fedeltà al Regime, per poter
riaccedere alle cattedre dell’Università di Siena e di
Padova e, per questo motivo, fu oggetto di aspre
critiche.
Negli anni ’40 del Novecento aderisce al movimento
liberal-socialista e per l’attività clandestina viene incarcerato per tre mesi. Riottenuta la libertà intraprende
una critica all’esistenzialismo, tornando alla contemplazione delle teorie illuministe. In quegli anni si sposa
con Valeria Cova dalla quale ha tre figli: Marco,
Andrea e Luigi.
I suoi studi politico-sociali si incentrano, poi, sulla tesi
di un federalismo inteso come unione di stati diversi
che, però, è da considerarsi ormai superata dopo l’unificazione nazionale. È la “Teorica della libertà”.
Dopo aver lasciato l’incarico a Padova, occupa la
Cattedra di Filosofia del diritto a Torino, riscontrando
un notevole successo in merito ai suoi corsi fino al
1961. Dall’anno successivo fino al 1971, insegna presso la facoltà di Scienze Politiche della quale fu fondatore a Torino e che gli consente di ottenere la cattedra
di Filosofia politica.
Proprio nel 1971 è tra i firmatari della lettera sul caso
Pirelli pubblicata da L’Espresso Il figlio Luigi milita
nel frattempo in Lotta Continua. Durante quegli anni
diviene Presidente della Facoltà e la politica diventa
punto cardine del suo percorso intellettuale, tant’è che
di notevole rilievo è un testo del 1972 indirizzato a
Guido Fassò, nel quale si scaglia contro l’ingiustizia e
la corruzione che si nasconde sotto l’insegna della
Democrazia. Dice nel libro: “La democrazia non è soltanto metodo, ma è anche un ideale: è l’ideale egualitario…”.
Per i suoi numerosi lavori diventa socio dell’Accademia dei Lincei e della British Academy, collaborando,
inoltre, con l’amico Aldo Capitini all’opera I problemi
della guerra e le vie della pace del 1979, anno in cui è
nominato Professore emerito all’Università di Torino.
Cinque anni dopo, ottiene la carica di Senatore a vita
dal Presidente della Repubblica, Sandro Pertini e, dal
1996, si iscrive al gruppo parlamentare del Partito
Democratico della Sinistra.
Grazie al suo contributo non solo accademico, Bobbio
riceve lauree honoria, vincendo il Premio Balzan nel
1994 e il Premio Agnelli nel 1995.
Pubblica la sua autobiografia alla fine degli anni ’90,
ma poco più tardi, dopo la scomparsa della moglie
Valeria, inizia a ritirarsi a vita privata, pur continuando
sporadicamente ad esporre le sue osservazioni critiche
sulla politica del tempo.
Nell’anno 2003 è onorato del “Sigillo Civico” per i
suoi contributi alla città di Torino, in cui muore il 9
gennaio del 2004.
Norberto Bobbio ha sempre ricercato i principi fonda2
Temi Romana
Norberto Bobbio: la storia
mentali che consentono lo sviluppo di una democrazia
giusta ed equa. Pur ritenendo fallimentare l’esperienza
marxista-leninista Bobbio ha tuttavia creduto in una
contrattazione delle parti che si allarghi a tutto il
mondo, che comprenda la fratellanza tra gli uomini e
che non concepisca la violenza come mezzo per raggiungere tale obiettivo.
Nell’ambito della teoria generale del diritto ha sostenuto e abbracciato la critica al giusnaturalismo e ha creduto nella costruzione di una scienza giuridica come
sistema coerente.
Considerato come “più occupato a seminare dubbi che
a raccogliere consensi”, ha fondato la propria filosofia
nel cercare appunto di trovare falle in quei sistemi che
tanto si reputano sani ed incrollabili, incarnando in sé,
l’ideale della concezione critica e militante del pensiero. È il padre della filosofia analitica italiana e reputa
Temi Romana
che per far evolvere questa democrazia sia necessario
far progredire innanzitutto la civiltà nella quale essa
deve avere luogo.
Famose sono le sue parole: “Mi ritengo un uomo del
dubbio e del dialogo. Del dubbio perché ogni mio ragionamento su una delle grandi domande termina, quasi
sempre, o esponendo la gamma delle possibili risposte,
o ponendo ancora un’altra grande domanda. Del dialogo, perché non presumo di sapere quello che non so, e
quello che so lo metto alla prova continuamente con
coloro che presumo che ne sappiano più di me”.
Tra i numerosi scritti che ci ha lasciato, occorre ricordare: L’indirizzo fenomenologico nella filosofia sociale
e giuridica (Torino, 1934); La consuetudine come fatto
normativo (Padova, 1942); Stati Uniti d’Italia (1945);
Saggi sulla scienza politica in Italia (Torino, 1969);
Liberalismo e Democrazia (Milano, 1985).
3
Saggi
Diritto penale europeo
Pietro Mazzei
Avvocato del Foro di Roma
I
carsi alla già esistente dimensione d’integrazione economica ed istituzionale, costituita dalle originarie tre
(oggi due) Comunità Europee:
- Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio,
Ceca, istituita con il Trattato di Parigi del
18/4/1951, in vigore dal 27/7/1952, ed estintasi una
volta decorso il prefissato termine di 50 anni;
- Comunità Europea, CE, e Comunità Europea per
l’Energia Atomica, CEEA o EURATOM, entrambe
istituite con i Trattati di Roma del 25/3/1957, in
vigore dal 1/1/1958 (che oggi ricomprendono anche
la materia del carbone e dell’acciaio.
Le predette tre comunità avevano creato un sistema
giuridico di cooperazione interstatuale su materie prettamente economiche, con una struttura permanente,
complessa e articolata, dotata dei mezzi e degli strumenti idonei al raggiungimento degli scopi previsti e,
specificamente, la creazione di un mercato comune.
Il trattato di Maastricht ha introdotto, per un diverso
ambito (quello politico), un sistema giuridico di cooperazione simile, ferme restando alcune fondamentali differenze, che ha in parte mutuato le strutture e le istituzioni comunitarie già esistenti (c.d. quadro istituzionale unico).
Del resto, l’idea di un’integrazione politica europea era
già stata avanzata nel 1953 con il progetto di trattato
per la Comunità politica europea, accantonato dopo il
rifiuto dell’Assemblea nazionale francese di ratificare
il diverso, ma complementare, Trattato istitutivo di una
comunità europea per la difesa (Ced).
L’ostracismo francese, pertanto, bloccò sul nascere le
aspirazioni europee di integrazione politica che ritroveranno slancio esclusivamente negli anni ’80 e raggiungeranno un primo tangibile risultato con l’adozione nel
febbraio del 1986 dell’Atto Unico Europeo (entrato in
vigore il 1/7/1987) nel quale, oltre ad alcune modifiche
apportate ai trattati istitutivi delle tre comunità, si ritrovano le prime disposizioni sulla cooperazione europea
in materia politica estera e di cooperazione politica2.
Il trattato di Maastricht si compone di un Preambolo, di
l diritto internazionale, nella sua accezione più
semplice, è costituito dal complesso delle norme
che regolano i rapporti tra soggetti della comunità
internazionale, tra i quali gli Stati che, pur essendo
indubbiamente i maggiori protagonisti, non sono i soli.
Appare opportuno rilevare che si riconduce al diritto
internazionale anche quel particolare diritto, anch’esso
di natura internazionale, che si sviluppa all’interno
delle Organizzazioni Internazionali.
Le predette organizzazioni generano, a loro volta, uno
specifico ordinamento giuridico con propri soggetti,
propri organi, fonti normative e procedure.
I meccanismi di funzionamento delle organizzazioni
internazionali possono certamente differire dagli schemi tradizionali del diritto internazionale per la semplice ragione che, avendo all’origine un esplicito accordo
internazionale, nulla impedisce agli Stati la più ampia
libertà di scelta delle forme e dei meccanismi di funzionamento dell’organizzazione nonché della tipologia,
delle finalità e dei mezzi.
In tale ipotesi, si suole parlare di un “diritto delle organizzazioni internazionali”, in senso generale, ovvero del
diritto della singola organizzazione quale, ad esempio, il
“diritto delle Nazioni Unite” o il “diritto dell’Unione
Europea”1, indicandosi con tale precisazione tutti gli atti
appartenenti all’ordinamento dell’organizzazione considerata che abbiano carattere giuridico.
Sul punto, appare opportuno rilevare che il Trattato
sull’Unione Europea (firmato a Maastricht il 7/2/1992
ed entrato in vigore il 1/11/1993, successivamente
modificato dal Trattato di Amsterdam del 2/10/1997 e
dal Trattato di Nizza del 26/2/2001) istituisce
un’Unione Europea tra gli Stati membri allo scopo di
segnare “una nuova tappa nel processo di creazione di
un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in
cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente
possibile e più vicino possibile ai cittadini” (art. 1).
Ebbene, l’Unione Europea rappresenta la dimensione
politica dell’integrazione europea che viene ad affian4
Temi Romana
Saggi
sette Titoli, di un Atto finale, di 17 protocolli e di 33
Dichiarazioni allegate (ratificato in Italia con L. n.
454/1992).
Sin dal Preambolo appare chiaro come la nuova dimensione politica di integrazione non intenda sostituirsi,
bensì affiancarsi alla già esistente dimensione economico-istituzionale di integrazione.
Rispetto al sistema giuridico comunitario, quindi, quello europeo rappresenta un completamento, una “nuova
tappa nel processo di integrazione europea intrapreso
con l’istituzione delle Comunità europee” che ritrova
ora tra i suoi fine anche quello di “rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle
istituzioni in modo da consentire loro di adempiere in
modo più efficace, in un contesto istituzionale unico, i
compiti loro affidati”, quello di “attuare una politica
estera e di sicurezza comune al fine di promuovere la
pace, la sicurezza ed il progresso in Europa e nel
mondo” e quello di “agevolare la libera circolazione
delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza
dei loro popoli, con l’istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”.
Tra le Disposizioni Comuni del Titolo I (artt. 1-7) spiccano l’art. 2 che fissa, riprendendo in parte le indicazioni del Preambolo, gli obiettivi dell’Unione, tra i quali:
la promozione di un progresso economico e sociale ed
un elevato livello di occupazione; il raggiungimento di
uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare
mediante la creazione di uno spazio senza frontiere
interne, il rafforzamento della coesione economia e
sociale e l’instaurazione di un’unione economica e
monetaria; l’affermazione di un’identità europea sulla
scena internazionale, in particolare mediante l’attuazione di una politica estera e di sicurezza comune; la conservazione e lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Ancora, l’articolo 3 che dota l’Unione di un quadro
istituzionale unico capace di assicurare coerenza e continuità al complesso delle azioni; l’articolo 5 che riconosce alle Istituzioni Comunitarie (Parlamento Europeo, Consiglio, Commissione, Corte di Giustizia e Corte dei Conti) una certa competenza (in aggiunta alla
competenza piena già attribuita loro dai trattati istitutivi) anche sulle materie previste dal trattato di
Maastricht; l’art. 6 che elenca i principi che fondano
l’Unione e che devono essere rispettati dagli Stati
Temi Romana
membri e da quelli candidati all’ammissione, come
libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto3.
La nuova riconfigurazione operata dal Trattato di
Maastricht ha, così, introdotto un secondo sistema giuridico che presenta numerosi punti di contatto, sovrapposizione ed integrazione con il preesistente sistema
comunitario: in tal senso, si suole parlare di “una struttura a pilastri”.
Secondo questa ricostruzione, il primo pilastro, detto
comunitario, corrisponde ai Trattati di Roma, mentre
gli altri due (il secondo ed il terzo) corrispondono a
quelle disposizioni introdotte dal Trattato sull’Unione
aventi rispettivamente ad oggetto la politica estera e di
sicurezza comune (artt. 11-28) e la cooperazione di
polizia e giudiziaria in materia penale (artt. 29-42).
Il principale tratto distintivo tra i due sistemi (tra il
primo pilastro e gli altri due; tra diritto comunitario e
diritto dell’Unione Europea) consiste, oltre che nella
diversità di oggetto, nella diversa competenza e diversa tipizzazione degli atti normativi, nel quorum richiesto per l’adozione di decisioni: salvo eccezioni, la maggioranza qualificata nel pilastro comunitaria (metodo
comunitario) e l’unanimità nel secondo e nel terzo pilastro (metodo intergovernativo).
La scelta in favore dell’unanimità si spiega, politicamente, in ragione della particolare delicatezza degli
interessi statuali coinvolti dalla cooperazione intergovernativa introdotta dal Trattato4.
Per quel che maggiormente ivi ci riguarda, il terzo pilastro del Trattato di Maastricht, prevede le disposizione
(artt. 29-42) per la cooperazione interstatuale di polizia
e giudiziaria in materia penale.
Secondo l’art. 29, infatti, “fatte salve le competenze
della Comunità europea, l’obiettivo che l’Unione si
prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”.
Il predetto obiettivo è perseguito “prevenendo e reprimendo la criminalità organizzata o di altro tipo
mediante un’ampia ed articolata cooperazione che
coinvolge, tra le atre, le forze di polizia, le autorità
doganali e le autorità giudiziarie degli Stati membri”.
In particolare, l’art. 34 elenca i provvedimenti tipici
(posizioni comuni, decisioni-quadro, decisioni e convenzioni) attraverso l’adozione o lo stabilimento dei
5
Saggi
quali il Consiglio, deliberando all’unanimità, persegue
gli obiettivi del terzo pilastro.
Anche in questo ambito, un ruolo minore viene riservato alle istituzioni comunitarie (Parlamento Europeo,
Commissione, Corte di Giustizia). Di particolare
apprezzamento è il ruolo riconosciuto dall’art. 35 alla
Corte di Giustizia in termini di competenza a pronunciarsi pregiudizialmente sulla validità o l’interpretazione delle decisioni-quadro e delle decisioni, sull’interpretazione delle convenzioni stabilite ex art. 34 e sulla
validità ed interpretazione delle misure di applicazione
di queste ultime5.
Nell’attuale momento storico, il nostro sistema penale,
come quello di tutti gli altri Paesi dell’Unione Europea,
è sempre più influenzato da norme che promanano da
Organi dell’Unione Europea.
Pertanto, fonte del diritto penale non è più solo la legge
statale, ma anche la norma europea.
Specificamente, premesso che (almeno fino ad oggi)
non si ritiene ammissibile che una norma comunitaria
(direttiva, regolamento) possa direttamente creare fattispecie incriminatrici né, tanto meno, aggravare la
responsabilità penale del cittadino di uno Stato membro
– attesa la riscontrata assenza di legittimazione democratica delle fonti di produzione delle norme
dell’Unione Europea (Consiglio dei Ministri,
Commissione) – l’influenza del diritto comunitario sul
diritto penale può essere schematicamente sintetizzata
come segue.
Il principio fondamentale è rappresentato dalla prevalenza della normativa comunitaria sulla normativa
interna con essa incompatibile, la quale deve dunque
essere disapplicata.
Ciò premesso, il diritto comunitario può incidere:
A. sulla produzione normativa di uno Stato membro;
B. sull’ampiezza della fattispecie incriminatrice di
uno Stato membro.
Per quanto attiene l’influenza sulla produzione legislativa di uno Stato membro, la stessa può realizzarsi
attraverso direttive (che per le loro caratteristiche non
possono trovare immediata applicazione), le quali
impegnano uno Stato membro a legiferare in determinati settori (ad es., nel settore dello smaltimento dei
rifiuti) in conformità a criteri predeterminati; oppure
attraverso decisioni quadro che vincolano lo Stato
membro a costruire le fattispecie incriminatrici “dome-
stiche” (ad es., in materia di pedopornografia) utilizzando come elementi costitutivi quelli contemplati
nella fonte europea.
Sia attraverso le direttive che le decisioni quadro si persegue l’obiettivo di un’armonizzazione delle legislazioni penali degli Stati membri.
Per quanto attiene, invece, l’influenza sull’ampiezza
delle fattispecie incriminatrici, la stessa può consumarsi attraverso la strada della vera e propria integrazione
del precetto penale ovvero attraverso la strada dell’adozione di una interpretazione conforme alla norma
comunitaria.
La prima strada – il cui lastricato è costituito dai trattati, dalle direttive c.d. self executing (ossia specifiche
e non bisognose di leggi attuative) e dalle sentenze
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – può
trovare sbocco all’interno delle norme di parte generale necessariamente integrative della fattispecie incriminatrice, quali quelle in materia di colpa ex art. 43
c.p. (si pensi, ad es., alle norme comunitarie impositive di obblighi di prudenza come non guidare un
camion per più di un certo numero di ore consecutive),
oppure di garanzia del non verificarsi dio eventi dannosi ex art. 40, comma 2, c.p. (si pensi, ad es., alla
imposizione di standard di sicurezza europei concernenti ceri prodotti, come i giocattoli), ovvero all’interno della stessa fattispecie incriminatrice, comportandone la restrizione (non v’è dubbio, ad es., che le
norme penali sul contrabbando non possano trovare
applicazione relativamente a merci di provenienza
comunitaria) o l’ampliamento (si pensi, ad es., all’art.
194 del Trattato Euratom che vincola gli Stati membri
a proteggere il segreto atomico europeo con le stesse
norme penali poste a presidio del segreto nazionale).
La strada dell’interpretazione conforme al diritto
comunitario è illuminata dai tre fari delle direttive,
delle decisioni quadro e del ricorso per interpretazione
alla Corte di Giustizia.
Pertanto, il Giudice nazionale ha il dovere di applicare
le norme penali interne in senso conforme a quelle
comunitarie.
Se sussiste un dubbio sul preciso significato da attribuire alla norma comunitaria della quale deve tenere conto
per la risoluzione del caso di specie, il Giudice nazionale è tenuto a promuovere l’intervento della Corte di
Giustizia affinché essa ne determini la corretta interpre-
6
Temi Romana
Saggi
tazione che sarà vincolante6.
Quanto alla gerarchia delle fonti nel quadro dell’Unione
Europea, il c.d. terzo pilastro (cooperazione di polizia e
giudiziaria in materia penale) è quello che maggiormente si avvicina al sistema comunitario, in quanto lo stesso, oltre ad altre figure di atti comuni al secondo pilastro
e a deliberazioni del consiglio genericamente denominate “misure” (art. 34, 2, Tue), prevede l’emanazione di
atti vincolanti che sono denominati decisioni-quadro o
decisioni (art. 34, 1, lett. b, e c, Tue).
Le decisioni-quadro creano norme giuridiche che, per
produrre effetti a carico dei soggetti di diritto statale,
hanno bisogno di un atto di trasformazione da parte
degli Stati destinatari, non diversamente di quanto stabilito per le direttive; le decisioni hanno un valore ed
una portata analoghi a quelli propri delle decisioni
comunitarie.
Anche nel quadro del terzo pilastro è prevista la possibilità che siano stipulate dall’UE convenzioni internazionali (art. 34, par. 1, lett. d, Tue), il cui contenuto sarà
poi oggetto di una raccomandazione inviata agli Stati
membri, affinché gli stessi procedano, secondo le
forme previste dai rispettivi ordinamenti, all’adozione
delle misure necessarie per dare esecuzione alle obbligazioni assunte dall’UE7.
La sintesi dell’articolata euro risposta alle problematiche della giustizia va individuata in quel passaggio storico-cronologico segnato dal consiglio Europeo di
Tampere del 1999 che, nel rilanciare in ambito comunitario le esigenze di tutela della collettività, ha indicato quale via prioritaria, rispetto alla linea dell’armonizzazione, il reciproco riconoscimento degli atti posti in
essere nei singoli Paesi dell’UE.
La decisione-quadro sul mandato di arresto, quella sul
blocco dei beni, la previsione di un ordine UE per la
ricerca delle prove, la figura di Eurojust e l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, costituiscono le soluzioni evolutive
del predetto obiettivo.
Nel percorso per la stabilizzazione dello “Spazio di
libertà, sicurezza e giustizia” è, altresì, essenziale il
superamento della struttura in pilastri operato dal
Trattato costituzionale europeo del 18 giugno del 2004,
firmato a Roma il 29 ottobre 2004 dai Capi di Stato e
di Governo dei Paesi dell’UE.
Alla base vi è l’idea di rimodellare gli strumenti opera-
Temi Romana
tivi settoriali previsti oggi a seconda del tipo di politica
d’intervento (si ribadisce, direttive e regolamenti, per
le materie propriamente comunitarie – primo pilastro
Tr. CE; decisioni e decisioni-quadro per l’ambito della
giustizia – terzo pilastro Tr. CE).
In sostanza, gli attuali regolamenti, direttive, decisioni
e decisioni-quadro verrebbero sostituiti da leggi europee e leggi-quadro europee, con le quali si potranno
stabilire norme minime riguardanti l’ammissibilità
reciproca delle prove tra gli Stati membri, i diritti della
persona nei procedimenti penali, i diritti delle vittime
della criminalità ed altri elementi specifici della procedura penale individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione europea.
Il rinnovato metodo legislativo dovrà, tuttavia, superare remore trasversali.
Allo stato degli atti è difficile confidare nella ratifica
senza alcun inciampo nella Carta.
Peraltro, il processo di integrazione UE risulta arricchito da prospettive che potremmo definire di “policentrismo normativo-giurisdizionale”.
Un esempio di questa ipotesi ricostruttiva è offerto
dalla sentenza della Corte di Giustizia 16 giugno 2005
che si distingue per la capacità di innovare la declinazione dei rapporti tra diritto interno (processuale penale) ed europeo.
Nella sentenza c.d. “Pupino”, la Corte, stabilendo l’obbligo per l’autorità giudiziaria di interpretare il diritto
interno in senso conforme alla disciplina delle decisioni-quadro, opera un parallelismo con le direttive CE
definendo in termini innovativi il principio di legalità
in materia penale e la questione circa la natura del diritto dell’Unione.
La pronuncia reca, pertanto, in sé il germe di una tendenza espansiva degli atti UE, la cui potenzialità sembrerebbe commisurata all’esigenza pratica di garantire
il progressivo adeguamento a standards di tutela omogenei in Europa.
Lo Stato, dunque, resta il soggetto di riferimento nella
produzione delle norme, ma esso non è più il solo attore del diritto ed il suo territorio non rappresenta più il
solo spazio normativo.
Siamo oggi di fronte a molteplici livelli di influenza
che tendono ad una configurazione modulare del diritto, quello che è stato definito in dottrina il “pluralismo
ordinato”, ovvero un’altra via al di là del relativismo
7
Saggi
assoluto (che determinerebbe la totale incomunicabilità tra gli ordinamenti, provocando il disordine mondiale), e quell’ordine imposto in nome di un universalismo
sovrastante di tipo egemonico8. Il Libro XI del c.p.p.
disciplina i rapporti con le autorità straniere costituiti
da estradizione, rogatorie, riconoscimento della sentenza penale straniera ed esecuzione all’estero della sentenza penale italiana.
Gli istituti de quibus non esauriscono, tuttavia, il settore della cooperazione in materia penale, ma rappresentano quelli che di regola sono maggiormente utilizzati.
Va, peraltro, precisato che l’evoluzione impressa al settore in argomento dall’UE ha determinato la nascita di
ulteriori forme di cooperazione che rappresentano, da
un lato, lo snellimento di quelle già esistenti, dall’altro
lato, la loro naturale evoluzione (Maria Riccarda
Marchetti, Rapporti giurisdizionali con autorità straniere in Il Diritto. Enciclopedia Giuridica, Vol. 12,
capitolo I, pag. 610).
Ebbene, l’evoluzione dell’istituto dell’estradizione
all’interno dell’Unione Europea è costituita dal mandato di arresto europeo (Mae) che rappresenta una
più snella modalità di consegna dei soggetti ricercati
per l’esecuzione di un provvedimento privativo della
libertà personale ovvero di una sentenza di condanna a
pena detentiva.
Trattasi di un procedimento di carattere esclusivamente
giurisdizionale volto a ridurre i tempi di consegna e, in
quanto fondato sul principio del mutuo riconoscimento
delle decisioni, a semplificare l’iter per l’esecuzione.
Il procedimento ha, quindi, inizio secondo due modalità:
1. la prima costituita dalla trasmissione della richiesta
di esecuzione per il tramite del Ministro – che non
ha comunque alcun potere di rigetto – ovvero direttamente all’autorità giudiziaria;
2. la seconda derivante dall’arresto effettuato dalla
polizia giudiziaria a seguito di segnalazione nel
Sistema informativo Schengen (Sis).
Nel primo caso, il Presidente della Corte di Appello,
cui il Mae è trasmesso dal Ministro, compiuti gli accertamenti preliminari, riunisce la Corte per la eventuale
applicazione di una misura coercitiva che non può
venire disposta ove si abbia ragione di ritenere che sussistano cause ostative alla consegna.
Entro cinque giorni dall’esecuzione della misura, il
Presidente provvede a sentire la persona sottoposta a
misura coercitiva alla presenza del difensore di fiducia,
ovvero d’ufficio, informandola del contenuto del Mae
e della possibilità di consentire alla consegna e di
rinunciare al principio di specialità.
Nella seconda ipotesi, la polizia giudiziaria pone l’arrestato, mediante trasmissione del relativo verbale, a
disposizione del Presidente della Corte nel cui distretto è
avvenuto l’arresto non oltre ventiquattro ore dallo stesso.
Entro le successive quarantotto ore, questi provvede a
sentirlo in presenza del difensore (di fiducia o d’ufficio)
e, se risulta che l’arresto è stato eseguito per errore di
persona, ovvero fuori dai casi di cui all’art. 11 della
legge de qua, ne dispone la immediata liberazione.
Al di fuori di tali casi, si procede alla convalida applicando, ove necessario, una misura coercitiva.
In tale sede il Presidente raccoglie, inoltre, l’eventuale
consenso alla consegna manifestato dall’interessato,
preliminarmente informato di tale possibilità dall’Ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all’arresto.
L’ordinanza che dispone l’applicazione di una misura è
ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art.
9, comma 7, L. n. 69/20059.
Premesso che, come si vedrà, nel caso di consenso alla
consegna da parte dell’interessato si delinea una procedura ulteriormente semplificata, soffermiamoci ora sul
rito, per così dire, ordinario.
In entrambi i casi sopra considerati, il Presidente della
Corte fissa l’udienza per la decisione entro venti giorni
dall’esecuzione della misura coercitiva se disposta,
Premesso che la normativa di recepimento interno (L. n.
69/2005) non è sempre in linea con la decisione-quadro
(584/2002/GAI), in quanto non pone limiti ed adempimenti ulteriori a quelli previsti dalla decisione de qua,
analizziamone sinteticamente gli aspetti essenziali.
In primo luogo, si stabilisce per l’esecuzione del Mae
la competenza della Corte di Appello nel cui distretto
l’interessato ha la residenza, la dimora o il domicilio al
momento di ricezione della domanda da parte dell’autorità giudiziaria.
In mancanza, la competenza è della Corte di Appello di
Roma.
Diversamente, nell’ipotesi in cui vi sia stato l’arresto
da parte della polizia giudiziaria, la competenza spetta
alla Corte del luogo ove è stato effettuato l’arresto.
8
Temi Romana
Saggi
sto con il presupposto su cui si fonda la decisione-quadro, sostenendo che l’autorità giudiziaria deve solo
controllare che il mandato sia “fondato su un compendio indiziario che l’autorità giudiziaria emittente ha
ritenuto seriamente dimostrativo di un fatto reato”11.
Infine, appare opportuno rammentare che per un elenco di reati si prevede la consegna obbligatoria indipendentemente dalla verifica in ordine alla sussistenza
della doppia incriminabilità, verifica che viene, per
contro, ribadita con riguardo a tutti gli altri reati esulanti dalla lista di cui all’art. 8.
Ancor più snello il procedimento nel caso di consenso
che può essere manifestato sia in sede di audizione a
seguito di applicazione dio una misura coercitiva o di
convalida dell’arresto sia, successivamente, nel corso
dell’udienza dinnanzi alla Corte e fino alla conclusione
della discussione.
In questo caso, la decisione – adottata con ordinanza
sentiti il PG, il difensore e, se comparso, l’interessato –
deve avvenire al massimo nei successivi dieci giorni.
ovvero (è da ritenere) dalla pronuncia negativa in ordine all’applicazione della stessa.
Contestualmente dispone il deposito del Mae e della
documentazione che in base all’art. 6 della legge de
qua ha un contenuto più ampio della corrispondente
norma della decisione-quadro.
Il relativo decreto è comunicato al Procuratore
Generale e notificato all’interessato, al suo difensore e,
si suppone, al rappresentante dello Stato richiedente, la
cui partecipazione è prevista anche in tale procedimento stante la dichiarata applicabilità dell’art. 702 c.p.p..
L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del PG e del difensore, mentre
l’interessato ed il rappresentante dello Stato richiedente hanno la facoltà di partecipare.
La Corte decide con sentenza sull’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta entro sessanta giorni dall’esecuzione della misura cautelare ovvero
dalla pronuncia negativa, salvo l’impossibilità di
rispettare il predetto termine, nel qual caso si prevede
una proroga di ulteriori trenta giorni.
Le cause ostative alla consegna sono dettagliatamente
elencate dall’art. 18 che contempla le ipotesi individuate dagli artt. 3 e 4 decisione-quadro, nonché quelle deducibili dai consideranda.
Alle predette se ne aggiungono di ulteriori che non trovano alcun riscontro nella disciplina sovranazionale di
cui la legge in argomento dovrebbe costituire attuazione: ad esempio, il caso previsto alla lettera e “se la legislazione dello Stato di emissione non prevede i limiti
massimi della xcarecerazione preventiva”10.
Entrambi i provvedimenti sono ricorribili per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla legale
conoscenza degli stessi.
Il termine assegnato per la decisione è di quindici giorni dalla ricezione degli atti e, nell’ipotesi di annullamento con rinvio, il Giudice del rinvio decide entro
venti giorni.
Il ricorso ha effetto sospensivo, ma solo quando venga
impugnata la sentenza.
Tale previsione innesca intuibili problemi allorché la
decisione della Suprema Corte intervenga successivamente all’avvenuta consegna e sia di rigetto della
richiesta di esecuzione.
Secondo la dottrina, dovrebbe subordinarsi la consegna
alla condizione che l’interessato venga rinviato nel territorio dello Stato ovvero venga rimesso in libertà assegnandogli un intervallo temporale entro il quale allontanarsi.
Spetta alla Corte vincolare la consegna ad alcune condizioni e stabilire l’ordine di priorità nel caso di più
domande.
Giova, infine, rammentare come anche per il Mae valgano alcune regole previste per l’estradizione (rinvio
della consegna o consegna temporanea, transito, divieto di consegna o estradizione successiva) la più importante delle quali è costituita dal principio di specialità
Nel complesso sono elencati venti casi che, tuttavia,
non esauriscono il novero di quelli nei quali deve rifiutarsi la consegna.
Infatti, quando venga richiesto il completamento della
documentazione di cui all’art. 6 ovvero delle informazioni integrative ex art. 16, l’inottemperanza da parte
dello Stato di emissione del mandato determina il rigetto della domanda.
Inoltre, la consegna è comunque subordinata alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del
ricercato.
Qui, per vero, la giurisprudenza ha ridimensionato la
portata della disposizione, che si pone in palese contra-
Temi Romana
9
Saggi
efficace azione di contrasto alla criminalità e, in particolare, di quella organizzata.
L’organismo da ultimo deputato anche al perseguimento delle predette finalità è denominato Eurojust che
svolge un’attività di coordinamento ed impulso investigativo non troppo dissimile da quello della Direzione
Nazionale Antimafia.
Quanto alle competenze, l’articolo 4 decisione-quadro
187/2002/GAI (da noi attuata con legge n. 41/2005)
riguarda gravi forme di criminalità di carattere prevalentemente transazionale quali, ad esempio, il terrorismo,
riciclaggio, criminalità informatica ed ambientale, traffico di stupefacenti, partecipazione ad una organizzazione
criminale negli Stati membri dell’UE, nonché i reati contro gli interessi finanziari della Comunità Europea.
L’attività del predetto organismo si realizza per il tramite dei membri nazionali, ovvero attraverso il collegio.
Il tipo di intervento è similare in entrambi i casi, ma
quando agisce attraverso il collegio le autorità nazionali sono obbligate ad ottemperare alla richiesta formulata ai sensi dell’art. 7, lett. a, della decisione-quadro
ovvero a motivare il rifiuto.
Per quel che attiene più specificamente alle sue funzioni, può sollecitare – o imporre – l’inizio di indagini (o
l’esercizio di azioni penali) per fatti precisi, invitare a
porre in essere un coordinamento tra autorità giudiziarie e ad istituire una squadra investigativa comune,
comunicando le informazioni necessarie (art. 6, lett. a
ed art. 7, lett. a).
Tra gli ulteriori compiti e senza alcuna pretesa di un’indicazione completa, va segnalata la possibilità di assistere, se richiesto, le autorità giudiziarie per garantire il
coordinamento delle indagini e delle azioni penali; di
assicurare l’informazione reciproca; sotto il profilo dell’assistenza giudiziaria, può anche intervenire, a certe
condizioni, per migliorare la cooperazione.
Inoltre, collabora con la rete giudiziaria europea contribuendo, fra l’altro, ad arricchirne la base di dati documentali.
In sostanza, si ribadisce, ha la funzione di dare impulso e coordinare le indagini e di agevolare la cooperazione tra gli Stati15.
che, sebbene disciplinato con maggiore attenzione, non
si discosta dalla formulazione tradizionale pattizia,
atteso che costituisce una condizione di procedibilità12.
L’emissione del Mae spetta al Giudice che ha applicato la
misura coercitiva ovvero al PM che ha emesso l’ordine di
esecuzione, i quali trasmettono al Ministro per l’inoltro
all’autorità straniera e per la comunicazione al Sis.
Il mandato contiene le informazioni previste dalla decisione-quadro e relative all’individuazione del soggetto,
all’indicazione sia dell’esistenza del provvedimento
per la cui esecuzione il Mae è emesso, sia del reato e
delle sue conseguenze.
Vale pure in questo caso il principio di specialità e si
computa la custodia cautelare subita all’estero in esecuzione del mandato.
Analogamente a quanto previsto per l’estradizione dall’art. 722 c.p.p. e nonostante quanto affermato dalla
Corte Costituzionale 253/2004, la computabilità non
riguarda i termini di fase13.
Sono, poi, disciplinate dal Capo III della legge in argomento le misure reali e lo stesso riguarda sia le misure
richieste dal nostro Stato sia quelle domandate dallo
Stato estero.
Per le prime si stabilisce che il PG con il Mae chieda la
consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o confisca.
Quando la richiesta provenga, invece, dall’autorità
straniera che deve precisare se la consegna è necessaria
a fini probatori o di confisca, si prevede la competenza
della Corte di Appello che decide con decreto motivato, sentito il PG.
La disciplina applicabile è quella sul sequestro probatorio, con la espressa esclusione dell’art. 257 c.p.p.
(riesame del decreto di sequestro).
Atteso il rinvio all’art. 719 c.p.p., l’impugnabilità è,
dunque, limitata al ricorso per cassazione per violazione di legge14.
L’esigenza di imprimere alla cooperazione internazionale un maggiore impulso ha portato all’interno
dell’UE all’adozione di strumenti volti ad agevolare
siffatta cooperazione e a consentire una più rapida ed
_________________
1 Cfr. C. ZAGHÌ, Diritto internazionale, in Il
Diritto, in Enciclopedia Giuridica, Vol. V,
pp. 398-400.
2 Cfr. A. SINAGRA, Diritto dell’Unione
Europea, in Il Diritto. Enciclopedia Giuridica,
Vol. 5, par. I, pp. 379-380.
10
3 Cfr. SINAGRA, Diritto dell’Unione Europea, Vol. 5, par. II, p. 380.
4 Cfr. SINAGRA, Diritto dell’Unione Europea,
Temi Romana
Saggi
Vol. 5, par. III, pp. 380-381.
5 Cfr. SINAGRA, Diritto dell’Unione
Europea, cit., Vol. 5, par. V, p. 382; T.
BALLARINO, Lineamenti di diritto comunitario, Padova, CEDAM, 2004; R.A.
CANGELOSI – V. GRASSI, Dalle Comunità
all’Unione. Il Trattato di Maastricht,
Milano, Franco Angeli, 1996; P. V. DASTOLI
– G. VILELLA, La nuova Europa: dalla
Comunità all’Unione, Bologna, il Mulino,
1992; U. DRAETTA, Elementi di diritto
dell’Unione Europea, Milano, Giuffrè,
2004; V. GUIZZI, Manuale di diritto e politica dell’Unione Europea, Napoli, Editoriale
Scientifico, 2003; R. MONACO, Diritto delle
Comunità Europee e diritto interno,
Milano, Giuffrè, 1967; ID., Scritti di diritto
europeo, Milano, Giuffrè, 1972; C. ZANGHÌ,
Istituzioni di diritto dell’Unione europea,
Torino, Giappichelli, 2005.
6 Cfr. G. FLORA, Diritto Penale, L’attuale
dimensione comunitaria e internazionale
del diritto penale, in Il Diritto.
Enciclopedia Giuridica, Vol. 5, par. VII, pp.
418-419; M. LUCIANI, Fonti del Diritto, in
Il Diritto. Enciclopedia Giuridica, Vol. 6,
cap. IV, par. 4, pp. 483-484; S. STAIANO,
Legge di delega e decreto legislativo delegato, in Il Diritto. Enciclopedia Giuridica,
Vol. 8, cap. I, par. 4, pp. 783-786.
Temi Romana
7 Cfr. L. SICO, Fonti del diritto internazionale e comunitario, in Il Diritto.
Enciclopedia Giuridica, Vol. 6, cap. IV, pp.
502-503; C. ZANGHÌ, Adattamento del diritto italiano al diritto internazionale, in Il
Diritto. Enciclopedia Giuridica, Vol. 1, pp.
110-118; A. D’ATENA, L’anomalo assetto
delle fonti comunitarie, in A. D'ATENA-P.
GROSSI (a cura di), Diritto, diritti e autonomie tra Unione europea e riforme costituzionali, in ricordo di Andrea Paoletti,
Milano, Giuffrè, 2003; L. DANIELE, Diritto
dell’Unione Europea. Sistema istituzionale,
ordinamento, tutela giurisdizionale, competenze, Milano, Giuffrè, 2006; GUIZZI,
Manuale di diritto e politica dell’Unione
Europea, cit.; F. POCAR, Diritto dell’Unione
e delle Comunità Europee, Milano, Giuffrè,
2003; G. STROZZI, Diritto istituzionale
dell’Unione Europea, Torino, Giappichelli,
2005; G. TESAURO, Diritto comunitario,
Padova, 2005; A. TIZZANO, La gerarchia
delle norme comunitarie, in Dir. Un. Eur.,
1997, p. 97; C. ZANGHÌ, Istituzioni di diritto dell’Unione europea, cit.
8 Cfr. B. PIATTOLI, Processo Penale
Europeo, in Il Diritto. Enciclopedia
Giuridica, Vol. 12, pp. 170-171; B.
PIATTOLI, Cooperazione giudiziaria e pubblico ministero europeo, Milano, Giuffrè,
2002; F. SPIEZIA, Crimine transazionale e
11
procedure di cooperazione giudiziaria, in I
libri di Guida al diritto, Milano, il Sole 24
ore, 2006.
9 Cfr. M. R. MARCHETTI, Rapporti giurisdizionale con autorità straniere, in Il Diritto.
Enciclopedia Giuridica, Vol. 12, cap. III,
par. 1, pp. 615-616.
10 Cass., Sez. IV, 8 maggio 2006, Cusini, in
Dir. Giust., 2006, n. 23, p. 77; Cass., Sez.
Un., 30 gennaio 2007, Ramoci, per la diversa interpretazione che ritiene di dover rispettare la lettera e lo spirito dell’art. 18 e,
pertanto, un sistema di controlli periodici
sulla necessità della custodia cautelare
anche in mancanza di un termine massimo
di durata della stessa.
11 Cass., Sez. VI, 23 settembre 2005, P.
ILIE, in Cass. Pen., 2005, p. 3772.
12 Cfr. M. R. MARCHETTI, Rapporti giurisdizionale con autorità straniere, in Il Diritto
Enciclopedia Giuridica, Vol. 12, cap. III, par.
2, pp. 616-618.
13 Cfr. MARCHETTI, Rapporti giurisdizionale con autorità straniere, cit., par. 3, p. 618.
14 Cfr. MARCHETTI, Rapporti giurisdizionale con autorità straniere, cit., par. 4, p. 618.
15 Cfr. MARCHETTI, Rapporti giurisdizionali con autorità straniere, cit., cap. VII,
pp. 623-624.
Saggi
Il mobbing nella prospettiva criminologica integrata
Giovanni Neri* e Flavia Forgione**
* Avvocato del Foro di Roma – Docente di Criminologia UNI I.P.U.S. Chiasso – Direttore scientifico della Collana Jus & Comparative Law
** Dottore di Ricerca in Diritto Penale, Università degli Studi Roma Tre
1.
Il mobbing. Nozione e caratteristiche
Il termine mobbing deriva dal verbo to mob
(“assalire in massa”) e consiste in un complesso abituale di condotte vessatorie, discriminatorie e di
tipo aggressivo, praticate sul luogo di lavoro allo scopo
di perseguitare un collega o un subalterno e talora agevolate dai cd. sighted mobbers1, ossia i compagni del
mobbizzato che, con atteggiamenti di accettazione neutrale, incrementano lo stato di emarginazione e disagio
della vittima2.
I comportamenti ostili possono anche essere leciti o
giuridicamente irrilevanti: quel che rileva è la reiterazione costante degli stessi e il correlato stato di impotenza che si alimenta nel mobbizzato3.
Si tratta infatti di una “situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente in un costante progresso
in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni
al alto contenuto persecutorio da parte di uno o più
aggressori in una posizione superiore, inferiore o di
parità, con lo scopo di provocare alla vittima danni di
vario tipo e gravità. Il mobbizzato si trova nell’impossibilità di reagire adeguatamente a tali attacchi ed a lungo
andare accusa disturbi psicosomatici, relazionali e dell’umore, che possono portare anche invalidità psicofisiche permanenti di vario genere e percentualizzazione”4.
Similmente, lo studioso svedese Leymann definisce il
fenomeno come “una comunicazione contraria ed ostile
ai principi etici, perpetrata in modo sistematico da una o
più persone, principalmente contro un singolo individuo
che viene per questo spinto in una posizione di impotenza e impossibilità di difesa e qui costretto a restare con
continue attività ostili. Queste azioni sono effettuate con
un’alta frequenza …e per un lungo periodo di tempo ….
A causa dell’alta frequenza e della lunga durata, il comportamento ostile da luogo a seri disagi psicologici, psicosomatici e sociali”5.
Dalle esposte definizioni si ricavano, dunque, gli elementi costitutivi del mobbing che possono riassumersi
nel contestuale ricorso di più condizioni ed in partico-
lare: la natura vessatoria e persecutoria della condotta,
la collocazione della stessa nell’ambiente di lavoro, la
ripetizione e persistenza temporale delle azioni mobbizzanti6, l’intento persecutorio del mobber, la subordinazione psicologica e lavorativa della vittima e l’andamento fasico7 degli effetti delle praticate ostilità sul
mobbizzato.
E la rosa di condotte devianti è ampia. Può spaziare da
atteggiamenti di ostacolo alla regolare conduzione del
lavoro (demansionamenti, trasferimenti, controlli esagerati, arresti di carriera, sanzioni disciplinari reiterate,
svilimento dell’immagine, atteggiamenti di critica), a
vere e proprie molestie, anche di tipo sessuale. Deve
comunque trattarsi di atteggiamenti che, per diverse
vie, finiscono per minare la serenità del lavoratore. Ad
esempio, anche la richiesta continua di visite fiscali per
malattia, come la diffamazione o l’omessa concessione
dolosa del riposo settimanale possono costituire condotte mobbizzanti, se tali da provocare nella vittima
turbative psicologiche impeditive del regolare e tranquillo svolgimento delle mansioni affidate. A costituire
il comune denominatore delle azioni descritte è quindi
la relativa natura sistemica, l’andamento progressivo e
lo scopo e/o l’effetto persecutorio che vi associa8.
Solitamente, si distinguono più tipologie di mobbing:
quello gerarchico, o verticale, è perpetrato dal datore
di lavoro verso i subalterni, mentre quello orizzontale è
attuato tra colleghi di pari grado. Ancora, si ha mobbing
combinato, quando le condotte del superiore gerarchico sono avallate dagli altri lavoratori e mobbing ascendente se, inusualmente, sono i dipendenti a boicottare
l’operato del proprio capo. Se poi alle vessazioni sui
luoghi di lavoro segue una conseguente perdita di
sostegno all’interno del nucleo familiare si integra il
fenomeno del cd. doppio mobbing9.
Infine, una particolare condizione mobbizzante è integrata dalla molestia di tipo sessuale. Si tratta di una
forma di mobbing del tutto peculiare, sia per la genesi,
che per le modalità operative del molestatore. In primo
12
Temi Romana
Saggi
luogo infatti l’intento del mobber non coincide con la
volontà di allontanare la vittima dai luoghi di lavoro.
Anzi, al contrario, se ne incita l’avvicinamento coattivo a fronte di reazioni opposte del molestato, che tende
a chiedere trasferimenti o giorni di malattia per sfuggire alle attenzioni sgradite. E le tecniche di sopruso
risentono dei sentimenti di vendetta del respinto, che,
specie se in posizione gerarchicamente favorevole, utilizza il ricatto come arma contro la vittima, stretta nell’alternativa tra l’accondiscendenza alla molestia o
l’accettazione di uno stato mobbizzante. Ciò non toglie
che talvolta il mobbing sessuale possa consistere anche
una buona strategia di allontanamento della vittima dal
proprio posto di lavoro. E questo si verifica quando i
lavoratori, per danneggiare un collega, iniziano a diffondere voci non veritiere sulle abitudini sessuali del
mobbizzato.
Ad ogni modo, indipendentemente dalle forme che
assume, il mobbing costituisce una fattispecie dai contorni assai incerti, di creazione giurisprudenziale10, che
desta non poche perplessità, anche per la recente ed
esponenziale diffusione delle condotte mobbizzanti in
Europa e nel mondo11.
In Italia il fenomeno è in crescita, anche se con minore
intensità rispetto alle medie europee, e colpisce in particolare donne e impiegati nella pubblica amministrazione. Le prime per la loro maggiore fragilità emotiva
e per la più evidente esposizione a molestie di tipo sessuale12. I secondi per il minor rigore dei controlli pubblici sul dilagare degli atteggiamenti mobbizzanti tra
lavoratori. L’imprenditore privato, infatti, temendo gli
effetti negativi del mobbing sul successo delle politiche
aziendali, è più incline rispetto alla p.a. alla predisposizione di adeguati strumenti di freno e contenimento
delle pratiche vessatorie.
Restano ora da analizzare, in una prospettiva criminologica integrata, le cause del mobbing e le relative conseguenze sull’equilibrio psico-fisico della vittima.
Infatti, la diffusione del mobbing viene in genere riconnessa a una serie di cause criminologiche legate al contesto ambientale di lavoro. In quest’ottica vengono in
rilievo: l’importanza della tipologia e remuneratività
dell’occupazione espletata secondo i canoni della
società d’appartenenza; il livello di competitività sui
posti di lavoro; il grado di aggressività ritenuto tollerabile; l’eventuale presenza di adeguati ammortizzatori
sociali; e da ultimo, la maggiore o minore elasticità culturale del paese di riferimento, dal momento che il
ricorso a tecniche mobbizzanti è inversamente proporzionale all’accettazione delle diversità biologiche
(sesso, età, etnia) tra i lavoratori13.
Ma non solo. Molto dipende anche dalla struttura organizzativa aziendale e dalle richieste di sempre maggior
efficienza e produttività, imposte dal nuovo mercato
globalizzato.
Gli standard attuali infatti esigono rendimenti eccellenti a basso costo, il che talvolta impone rivisitazioni di
spesa e conseguenti riallocazioni o riduzioni del personale. E questo, unito a sempre più frequente ricorso a
contratti di lavoro interinale o a termine, sottopone i
dipendenti ad un forte stress psicologico, alimentato
dal timore di perdere la propria occupazione e dalla
necessità di adeguarsi agli elevati livelli di produttività
raggiunti nel mondo imprenditoriale. Invero, il forte
grado di tensione, l’insicurezza dell’impiego, le inadeguatezze nella gestione manageriale e la pressione
competitiva generano tra i lavoratori un evidente stato
di conflittualità, particolarmente accentuato nelle fasi
di eventuale ridimensionamento dell’organico, quando
la volontà di boicottare colleghi antagonisti spinge ad
attuare a loro svantaggio tecniche subdole di isolamento e discredito.
Talora poi è lo stesso datore di lavoro a ricorrere ad
atteggiamenti ostili proprio per eliminare dal gruppo i
dipendenti meno efficienti o più anziani, inducendoli
all’interruzione volontaria e prematura del rapporto
lavorativo14.
A ciò ovviamente si aggiungono le caratteristiche soggettive degli attori della vicenda mobbizzante.
Invero, pur non esistendo un profilo psicocomportamentale di tipo unitario della vittima di mobbing, in
prima approssimazione si tratta di una persona efficiente, scrupolosa e come tale temuta dai colleghi, che talvolta approfittano di uno suo temporaneo stato di stress
2. Le cause del fenomeno
Il ricorso a tecniche mobbizzanti sul luogo di lavoro
può dipendere dall’intersecarsi di più fattori compositi,
da analizzare caso per caso.
Dal punto di vista squisitamente oggettivo, il proliferare del fenomeno dipende da ragioni culturali e dal contesto economico in cui le imprese si trovano a operare.
Temi Romana
13
Saggi
per favorirne l’espulsione dal gruppo di lavoro15. D’altra
parte quanto più è evidente la debolezza psicologica del
lavoratore, tanto maggiore è il livello di aggressività cui
si spinge il mobber, per invidia o frustrazione16.
Ad ogni modo, indipendentemente da ogni generalizzazione, gli episodi di mobbing sono difficilmente stereotipabili, sia per modalità operative che li caratterizzano,
che per le peculiari condizioni ambientali e personologiche in cui si sviluppano.
Spesso infatti l’area manageriale alla quale il mobbizzato si rivolge per denunciare il sopruso tende a minimizzare la patologia, attribuendola a stress lavorativi
ordinari, oppure addirittura a sfruttarla in vista di eventuali ridimensionamenti d’organico.
Non a caso infatti la quasi classica conseguenza dell’avvio di pratiche di mobbing è la perdita del lavoro,
alla quale inevitabilmente segue un senso di fallimento
e la privazione della propria identità sociale. Talvolta,
si percepisce anche un’ostilità all’interno della propria
famiglia che, stanca di assecondare un componente
emotivamente instabile, ritira il proprio sostegno emotivo, peggiorando in modo allarmante la situazione già
compromessa della vittima. Motivo per il quale in casi
limite il mobbizzato può addirittura meditare o mettere
in atto tentativi di suicidio.
Questi gli effetti sulla vittima. Ma il mobbing è foriero
di conseguenze negative anche per l’impresa all’interno della quale si sviluppa.
Infatti, ne deriva un calo generale del rendimento e
delle produttività del gruppo di lavoro, una compromissione dell’immagine aziendale, un incremento di atteggiamenti di assenteismo, e una generale perdita di fiducia e collaborazione tra i colleghi. A ciò deve inoltre
aggiungersi il costo, pur in termini di Know-how, per la
sostituzione, anche temporanea del mobbizzato, la perdita di personale specializzato, e l’obbligo economico
di risarcimento dei danni.
Si tratta quindi di un fenomeno, non ancora compiutamente regolamentato ma da non sottovalutare, alla luce
anche dell’incremento negli ultimi anni di pratiche
mobbizzanti, direttamente proporzionale alla crescita
del mercato globalizzato, all’elevato tasso di disoccupazione e alla precarietà dei rapporti lavorativi.
3. Le conseguenze del mobbing
La costante sottoposizione a pratiche mobbizzanti conduce la vittima ad uno stato di disagio psicologico, che
può sfociare in malattie psicosomatiche a vari livelli,
clinicamente riconducibili al “disturbo dell’adattamento”17, al “disturbo acuto da stress”18 e al più grave
“disturbo post traumatico da stress”19.
Più in generale comunque, la sintomatologia della “sindrome da mobbing” è stata inquadrata dalla letteratura
criminologica in base agli effetti psico fisici che determina nel mobbizzato.
Alla variabilità dello stato socio emotivo, con conseguente alternanza di reazioni aggressive e remissivodepressive, si associa una modificazione dell’equilibrio
psico fisico, dovuta alla somatizzazione del disagio vissuto, e una variazione del comportamento manifesto20.
Si passa da crisi di pianto, ad attacchi di panico, a stati
di alterazione psicosomatica anche gravi, che possono
sfociare in disturbi alimentari o del sonno, ovvero in
atteggiamenti di autolesionismo, come l’abuso di alcool o di farmaci anti depressivi.
Sintomi tutti amplificati dal senso di impotenza derivante dalla reazione sociale, imprenditoriale e familiare alla manifestazione di devianze comportamentali.
_________________
1 Si tratta di colleghi che partecipano
all’azione mobbizzante (cd. spettatori non
conformisti), o che per timore o opportunità non prendono posizione a favore del
mobbizzato (cd. spettatori conformisti). Sul
punto vd. H. EGE, Mobbing Conoscerlo per
vincerlo, Milano, Franco Angeli, 2001, che
distingue tra side – mobber e co – mobber.
2 Il termine, che mutua anche dalla locuzio-
ne latina mobile vulgus utilizzata con accezione negativa nei confronti del popolo
meritevole di disprezzo, è stato ripreso
anche dall’etologo Lorenz nella descrizione
del comportamento aggressivo tenuto dagli
animali in branco per allontanare i propri
simili e, se trasposto sul piano umano,
evoca tutta una serie di comportamenti praticati in massa per isolare un membro della
comunità ritenuto scomodo o pericoloso.
14
Non si sviluppa quindi soltanto nei luoghi
di lavoro ma anche altrove, ad esempio nell’ambiente militare (ove prende il nome di
“nonnismo”; cfr. F. BATTISTELLI, Anatomia
del nonnismo: cause e misure di contrasto
del Mobbing militare, Milano, Angeli,
2000), condominiale o scolastico (il bullismo infatti null’altro è che una particolare
specie di condotta mobbizzante applicata
tra minori).
Temi Romana
Saggi
3 L’elemento dell’abitualità distingue il
mobbing dal cd. straining, consistente in
condotte vessatorie di tipo isolato, ma
comunque tali da procurare disagi e danni
psicologici alla vittima. Cfr. E. DI SABATINO,
Dal Mobbing allo stalking allo straining, in
Resp. civ., II, 2007, p. 171 ss.; H. EGE, Oltre
il mobbing. Straining, stalking e altre forme
di conflittualità sul posto di lavoro, Milano,
Giuffrè, 2005; N. SAPONE, I danni nel rapporto di lavoro, Milano, Giuffrè, 2009, p.
178 ss., che scrive: “L’utilità della figura del
mobbing è quella di consentire uno sguardo
sinottico, teleologico di condotte disparate,
stringendole in unità, e facendone così
emergere la complessiva illiceità, anche
quando tale illiceità non sarebbe stata praticabile all’esito di una valutazione separata,
atomistica dei singoli comportamenti”; e B.
TRONATI, Mobbing e straining nel rapporto
di lavoro. Cosa sono, come riconoscerli,
come reagire, come tutelarsi, Bologna,
Ediesse, 2008. In giurisprudenza vd. tra le
altre Corte Cost. 19 dicembre 2003, n. 359:
“I comportamenti in cui può esternarsi il
mobbing hanno la duplice peculiarità di
poter essere esaminati singolarmente, anche
leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di
vista giuridico, e tuttavia di acquisire
comunque rilievo quali elementi della complessiva condotta caratterizzata nel suo
insieme dall’effetto e, talvolta secondo alcuni, dallo scopo di persecuzione e di emarginazione”; Cass. pen., Sez. V, 29 agosto
2007, n. 33624: “La condotta di mobbing
suppone non tanto un singolo atto lesivo, ma
una mirata reiterazione di una pluralità di
atteggiamenti, anche se non singolarmente
connotati da rilevanza penale, convergenti
sia nell’esprimere l’ostilità del soggetto attivo verso la vittima sia nell’efficace capacità
di mortificare ed isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro”.
4 Così H. EGE, Il Mobbing in Italia.
Introduzione al mobbing culturale,
Bologna, Pitagora, 1996. Dello stesso autore vd. anche Mobbing Conoscerlo per vincerlo, cit.; I numeri del mobbing. La prima
ricerca italiana, Bologna, Pitagora, 1999; Il
mobbing in Italia, Bologna, Pitagora, 1997;
Che cos’è il terrore psicologico sul luogo di
lavoro, Bologna, Pitagora, 1996.
La letteratura criminologica sull’argomento
è vastissima. Tra gli altri C. BALDASSARRI –
M. DEPOLO, La vittimizzazione psicosociale
sul lavoro, in Psicologia Contemporanea,
Temi Romana
1999, 152, p. 18 ss.; C. BALDUCCI, I processi psichici del mobbing, Bologna, Edizioni
Prima, 2000; M. BUCCI, Affrontare il mobbing dal punto di vista dell’azienda, un’esperienza concreta in un’amministrazione
pubblica, in Psicologia e lavoro, 2007, p.
21 ss.; G. BUSSOTTI – S. MORIONDO
Valutazione del mobbing. Manuale per la
gestione del rischio dei lavoratori e delle
lavoratrici, Bologna, Ediesse, 2010; L.
CANALI. – R. DE CAMELIS – F. LAMANNA –
B. PRIMICERIO, Il mobbing, Roma,
Armando, 2004; S. CARRETTIN – N.
RECUPERO, Il mobbing in Italia. Terrorismo
psicologico nei rapporti di lavoro, Bari,
Dedalo, 2002; A. CASILLI, Stop mobbing.
Resistere alla violenza psicologica sul
luogo di lavoro, Roma, Derive Approdi,
2000; G. COCCO – C. ANGELONE – V.
PIERFELICE, Il mobbing. Aspetti psicosociologici e giuridici, Pozzuoli, Sistemi Editoriali, 2007; S. DE RISIO, Psichiatria della
salute aziendale e mobbing, Milano, Franco
Angeli, 2001; M. DEPOLO, Mobbing: quando la prevenzione è intervento. Aspetti
giuridici e psicosociali del fenomeno,
Milano, 2003; H. EGE – M. LANCIONI,
Stress e Mobbing, Bologna, Pitagora, 1998;
G. FAVRETTO (a cura di), Le forme del mobbing. Cause e conseguenze di dinamiche
organizzative disfunzionali, Milano, Cortina, 2005; G. GULOTTA, Il vero e il falso
mobbing, Milano, Giuffrè, 2007; C. LAZZARI, Mobbing: conoscerlo, affrontarlo,
prevenirlo, Pescara, ESI, 2001; ID., Vincere
le ingiustizie sul lavoro, Bologna, Pitagora,
1997; ID., Adesso mi arrabbio. Conoscere
ed affrontare il litigio sul lavoro, Bologna,
Pitagora, 1996; E. MAIER, Il Mobbing e lo
stress organizzativo, Cesena, Il Ponte
Vecchio, 2002; G. POZZI (a cura di), Salute
mentale e ambiente di lavoro. Conoscere e
tutelare dal disadattamento al mobbing,
Milano, Franco Angeli, 2008; B.
RUPPRECHT-STROELL, Difendersi dal mobbing. Strategie contro aggressioni, boicottaggi, provocazioni, diffamazioni e umiliazioni sul posto di lavoro, Milano, Mondadori, 2007; ID., Mobbing: no grazie!
Strategie di difesa contro aggressioni,
boicottaggi, provocazioni, diffamazioni e
umiliazioni sul posto di lavoro, Milano,
TEA, 2001; G. SPRINI (a cura di), Mobbing:
fenomenologia, conseguenze ed ipotesi di
prevenzione, Milano, Franco Angeli, 2007;
P. TOSI (a cura di), Il mobbing, Torino,
Giappichelli, 2004; R. VACCANI, Stress,
15
mobbing e dintorni. Le insidie intangibili
degli ambienti lavorativi, Milano, ETAS,
2007; C. VENTIMIGLIA, Disparità e disuguaglianza. Molestie sessuali, mobbing e
dintorni, Milano, Franco Angeli, 2003.
5 In questi termini H. LEYMANN, The content and development of mobbing at work,
in European journal and Organization psychology, 5, 2, 1996; ID., Mobbing and psychological terror at workplaces, in Violence
and Victims, 5, 2, 1990.
Le definizioni fornite dagli studiosi vengono riprese anche dal legislatore regionale e
dalla giurisprudenza italiana, che tenta in
particolare di ancorare la tutela del mobbizzato ad appigli normativi, civili e penali. A
titolo esemplificativo, la Legge Regionale
16/2002, della Regione Lazio, poi dichiarata incostituzionale per violazione dell’art.
117 Cost., definiva il mobbing come un
insieme di “atti o comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti
in essere nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte del datore
di lavoro o da soggetti posti in posizione
sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che
si caratterizzano come una vera e propria
forma di persecuzione psicologica o di violenza morale”. Prevedeva inoltre un elenco
non tassativo di atti e comportamenti mobbizzanti tra cui rientravano: pressioni e
molestie psicologiche; calunnie sistematiche, maltrattamenti verbali ed offese personali; minacce e atteggiamenti intimidatori o
avvilenti, palesi o indiretti; delegittimazione dell’immagine; esclusione o marginalizzazione immotivata dall’attività lavorativa;
svuotamento delle mansioni; attribuzione di
compiti esorbitanti, eccessivi o dequalificanti; inibizione all’accesso a informazioni
sull’ordinaria attività lavorativa; marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto a iniziative formative, di riqualificazione
o aggiornamento professionale; controllo
eccessivo del dipendente; e discriminazioni
sessuali, di razza, lingua o religione.
Per la giurisprudenza cfr. ad es. Cass. civ.,
Sez. lav., 8 agosto 2011, n. 17089: “Come
indicato dalla Corte costituzionale (a partire dalla sentenza n. 359 del 2003), la sociologia ha mutuato il termine mobbing da una
branca dell’etologia per designare un complesso fenomeno consistente in una serie di
atti o comportamenti vessatori, protratti nel
tempo, posti in essere nei confronti di un
lavoratore da parte dei componenti del
Saggi
gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo
capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato
all’obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo”; Cass. civ., Sez. lav. 17 febbraio 2009, n. 3785: “Per ‘mobbing’ (nozione elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza giuslavoristica) si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o
del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del
lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si
risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere
forme di prevaricazione o di persecuzione
psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del
dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della
sua personalità. Ai fini della configurabilità
della condotta lesiva del datore di lavoro
sono pertanto rilevanti i seguenti elementi:
a) la molteplicità dei comportamenti a
carattere persecutorio, illeciti o anche leciti
se considerati singolarmente, che siano stati
posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente
con intento vessatorio; b) l’evento lesivo
della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta
del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psicofisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio”; Cass. civ., 6 marzo 2006, n. 4774:
“Si qualifica come mobbing una condotta
sistematica e protratta nel tempo, che concreta, per le sue caratteristiche vessatorie,
una lesione dell’integrità fisica della personalità morale del prestatore di lavoro,
garantita dall’art. 2087 c.c.; tale illecito,
che rappresenta una violazione dell’obbligo
di sicurezza posto da questa norma generale a carico del datore di lavoro, si può realizzare con comportamenti materiali o
provvedimenti del datore di lavoro, indipendentemente dall’inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla
disciplina del rapporto di lavoro subordinato… La sussistenza della lesione del bene
protetto e delle sue conseguenze dannose
deve essere verificata considerando l’idoneità offensiva della condotta del datore di
lavoro, che può essere dimostrata, per la
sistematicità e la durata dell’azione nel
tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di
persecuzione e discriminazione, risultanti
specialmente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza di una
violazione di specifiche norme di tutela del
lavoratore subordinato”.
6 Secondo Cass. civ., Sez. lav., 9 settembre
2008, n. 22858, la durata della vessazione
non può comunque essere inferiore a undici mesi.
7 Cfr. LEYMANN, The content and development of mobbing at work, cit., distingue
quattro fasi: fase del conflitto latente, connotata da usuali contrasti a cadenza grosso
modo quotidiana; fase del conflitto mirato,
ove si inizia a bersagliare una vittima specifica; fase del conflitto pubblico, ossia della
pubblicizzazione dell’intento mobbizzante;
e fase di espulsione, che culmina in genere
con le dimissioni forzate del mobbizzato.
EGE, Mobbing in Italia, cit., al primo
momento di conflittualizzazione generale,
fa seguire sei step: individuazione della vittima; autocolpevolizzazione del mobbizzato, che inizia a sentirsi responsabile per le
accuse di incompetenza e inefficienza che
gli vengono rivolte; presenza dei primi sintomi di malattie psicosomatiche; applicazione di sanzioni disciplinari per le conseguenti assenze; aggravamento dello stato di
salute della vittima; e da ultimo espulsione
dal mondo del lavoro per licenziamento o
dimissioni forzate.
8 All’idoneità lesiva della condotta deve
quindi affiancarsi, almeno secondo la giurisprudenza maggioritaria, l’animus nocendi,
ossia la volontà di arrecare un danno alla
vittima. Sul punto, l’Osservatorio nazionale
mobbing è chiaro: “Il Mobbing …si pone
sempre come fine l’emarginazione del
dipendente, in termini di frantumazione
delle sue sicurezze lavorative, psicologiche
ed esistenziali, con l’intento di escluderlo
dal suo ruolo di lavoro e di destabilizzarlo
nelle sue difese esistenziali e psicosociali,
onde metterlo in conflitto con se stesso e
con la microsocietà in cui si muove e dentro la quale espleta le sue scelte ed i suoi
interessi sociali e culturali”.
9 L’esistenza del cd. doppio mobbing è teorizzata da EGE, Mobbing. Conoscerlo per
vincerlo, cit.
10 A quest’ultimo proposito, pur se non è
questa la sede per occuparsi del fenomeno
sul piano legislativo e processuale, molto
brevemente e senza pretese di completezza,
si evidenzia l’assenza di specifiche previ-
16
sioni normative sul tema e il conseguente
tentativo della giurisprudenza italiana di
sussumere il fenomeno in fattispecie gia
contemplate dall’ordinamento. In particolare, i giudici civili riportano la figura all’art.
2087 c.c., oltre che agli artt. 1175 e 1375
c.c., in tema di buona fede, mentre la giurisprudenza penale invoca l’applicazione
degli artt. 572 e 610 c.p. Ad esempio, nella
prima pronuncia di legittimità sul tema
(Cass. pen., 12 marzo 2001, n. 10090) si
legge: “Anche se l’ipotesi di reato di più
frequente verificazione è quella che dà il
nome alla rubrica dell’art. 572 c.p., la
norma incriminatrice prevede altresì le ipotesi di chi commette maltrattamenti in
danno di persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione,
istruzione, cura, vigilanza o custodia, per
l’esercizio di una professione o di un’arte…
Non vì è dubbio che il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e
lavoratore subordinato, essendo caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che
la legge attribuisce al datore nei confronti
del lavoratore dipendente, pone quest’ultimo nella condizione, specificatamente prevista dalla norma penale richiamata, di persona sottoposta alla sua autorità, il che, sussistendo gli altri elementi previsti dalla legge, permette di configurare a carico del datore di lavoro il reato di maltrattamenti in
danno del lavoratore dipendente. L’aspetto
saliente della presente vicenda sta nel fatto
che, diffusamente illustrato dai giudici di
merito, l’imputato con ripetute e sistematiche vessazioni fisiche e morali, consistite in
schiaffi, calci, pugni, morsi, insulti, molestie sessuali e la ricorrente minaccia di troncare il rapporto di lavoro senza pagare le
retribuzioni pattuite, aveva ridotto i suoi
dipendenti, tra i quali una minorenne, in
uno stato di penosa sottomissione e umiliazione, al fine di costringerli a sopportare
ritmi di lavoro forsennati, essendo il profitto dell’impresa direttamente proporzionale
al volume delle vendite effettuate. Ne risulta, dunque, una serie di atti volontari, idonei
a produrre quello stato di abituale sofferenza fisica e morale, lesivo della dignità della
persona, che la legge penale designa col termine maltrattamenti”. Tra le altre, di recente Cass. pen., Sez. VI, 27 aprile 2012, n.
16094: “Le pratiche persecutorie realizzate
ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (cosiddetto
“mobbing”) possono integrare il delitto di
Temi Romana
Saggi
maltrattamenti in famiglia qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente
assuma natura para-familiare, in quanto
caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti,
dalla soggezione di una parte nei confronti
dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto
più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia”; Cass. pen.,
Sez. VI, 3 aprile 2012, n. 12517: “Il delitto
di maltrattamenti previsto dall’art. 572 cod.
pen. può trovare applicazione nei rapporti
di tipo lavorativo a condizione che sussista
il presupposto della parafamiliarità, intesa
come sottoposizione di una persona all’autorità di altra in un contesto di prossimità
permanente, di abitudini di vita proprie e
comuni alle comunità familiari, nonché di
affidamento e fiducia del sottoposto rispetto all’azione di chi ha ed esercita l’autorità
con modalità, tipiche del rapporto familiare, caratterizzate da ampia discrezionalità
ed informalità”.
Per approfondimenti sulla tutela giuridica,
civile e penale, della vittima di mobbing
cfr. tra gli altri F. Amato – M.V. Casciano –
L. Lazzeroni – A. LOFFREDO, Il Mobbing.
Aspetti lavoristici: nozioni, responsabilità,
tutele, Milano, Giuffrè, 2002; M. BELLINA,
Mobbing: profili penali, in Dir. & Pratica
del Lavoro, XXX, 2007, p. 1913 ss.; M.
BONA – G. MONATERI – U. OLIVA, La
responsabilità civile del mobbing, Milano,
IPSOA, 2002; F. COSTA, Il mobbing,
Napoli, ESI, 2010; G. DE FALCO – A.
MESSINEO – F. MESSINEO, Mobbing: diagnosi, prevenzione e tutela legale, Roma,
EPC Libri, 2003; E. DE LUISE, Il Mobbing.
La tutela esistente, le prospettive legislative e il ruolo degli organi di controllo,
Napoli, Esselibri, 2003; F. DE STEFANI,
Danno da mobbing, Milano, Giuffrè, 2012;
G. DI PARDO – S. DI PARDO – V. IACOVINO
– C. IZZI, Mobbing. Tutela civile, penale ed
assicurativa. Casi giurisprudenziali e consigli pratici, Milano, Giuffrè, 2007; M. V.
FERACO, Sulla rilevanza penale del mobbing (nota a Cass. pen., sez. VI, 21 settembre 2006, n. 31413), in Cass. pen., VI,
2007, p. 2493 ss.; S. FIGURATI,
Osservazioni in materia di mobbing, in
Guida al lavoro, XXXII-XXXIII, 2000, p.
35 ss.; M. GALLO, L’abuso del diritto come
strumento provvisorio di contrasto al mobbing, in Il Lavoro nella giurisprudenza, III,
2008, p. 237 ss.; D. GAROFALO, Mobbing e
Temi Romana
tutela del lavoratore tra fondamento normativo e tecnica risarcitoria, in Il Lavoro
nella giurisprudenza, VI, 2004, p. 521 ss.;
N. GHIRARDI, Il mobbing nella giurisprudenza, in Dir. & Pratica del Lavoro, X,
2008, p. 3 ss.; A. GUGLIELMO,
Responsabilità civile e mobbing, in Dir. &
Pratica del Lavoro, XVII, 2008, p. 1033
ss.; G. MANNACCIO, Il mobbing ancora una
volta in Cassazione, in Il lavoro nella giurisprudenza, XII, 2008, p. 1235 ss; S.
MARETTI, Mobbing: fattispecie e strumenti
di tutela, in Dir. & Pratica del Lavoro,
2007, n. 32; S. MAZZAMUTO, Il mobbing,
Milano, Giuffrè, 2004; M. MEUCCI, Danni
da mobbing e loro risarcibilità. Danno
professionale, biologico e psichico, morale, esistenziale, Roma, Ediesse, 2003; L.
NOCCO, Il mobbing, in Danno e resp., IV,
2008, p. 398 ss.; F. PETRONI, Il danno derivante dal mobbing: autonomia dell’onere
della prova, in Il merito, IX, 2008, p. 18
ss.; A. QUAGLIARELLA, Elementi caratterizzanti del mobbing, in Il Lavoro nella giurisprudenza, IX, 2008, p. 927 ss.; A. RAFFI,
Il ruolo della Cassazione nella tutela del
“mobbing” (nota a Cass. pen., sez.VI, 7
novembre 2007, n. 40891), in Riv. giur. lav.
e prev. soc., II, 2008, p. 349 ss.; M.
SANSONE, Prospettive per una penalizzazione del «mobbing», in Riv. pen., IX,
2006, 9, p. 885 ss.; M. VERRUCCHI,
Rilevanza penale del mobbing, in Dir. pen.
proc., VII, 2008, p. 892 ss.; C. ZOLI, Il
mobbing: brevi osservazioni in tema di fattispecie ed effetti, in Il lavoro nella giurisprudenza, IV, 2003, p. 337 ss.
Quanto alla tutela in ambito europeo, si segnala la Risoluzione del 20 settembre 2001
A5-0283/2001 e, in chiave comparatistica,
si evidenzia un interesse generale alla tematica. Invero, si sono dotate di normative anti
mobbing la Svezia, la Norvegia e la Francia, ma il fenomeno interessa anche l’Inghilterra, la Spagna, la Germania e gli USA
che, per diverse vie, comunque individuano
meccanismi nazionali di tutela delle vittime
di mobbing. In Francia si parla di harcelement au travail e in Spagna di acoso moral,
distinguendo poi il bossing, ossia la condotta di molestia gerarchica, dal mobbing praticato invece dai colleghi. Nei paesi anglosassoni si preferisce invece parlare di bulling at work, work harrassment o work
abuse, ripartendo poi le condotte d’abuso a
seconda delle caratteristiche peculiari che
17
le connotano (è corporate bulling, la vessazione esercitata dal datore di lavoro, client
bulling, quella attuata dai destinatari della
prestazione lavorativa, serial bulling, quella diretta a tutti indistintamente i colleghi di
lavoro, e gang bulling quella praticata in
gruppo).
11 I casi di mobbing sono numerosi in
Inghilterra e, a seguire, in Svezia, Francia,
Irlanda, Germania, Spagna e Belgio.
12 Il mobbing sessuale colpisce infatti per
lo più le donne, ma nulla vieta che siano
queste ultime a sfruttare la propria posizione gerarchica verso il sesso maschile.
Ovviamente, la scarsa tendenza degli uomini alla denuncia impedisce una giusta analisi della cd. “cifra nera” del fenomeno.
13 Cfr. EGE, Il Mobbing in Italia, cit.
14 Si parla a questo proposito di mobbing
strategico, attuato cioè proprio per l’eliminazione del personale in esubero.
15 Secondo EGE, Mobbing Conoscerlo
per vincerlo, cit. “nella letteratura in tema
di mobbing vengono riscontrate nell’indole scrupolosa, sensibile ai riconoscimenti e
alle critiche e con elevato senso del dovere le caratteristiche caratteriali che agevolano il ruolo di vittima o mobbizzato”.
L’autore elenca poi 18 possibili categorie a
rischio: il distratto, il prigioniero, il paranoico, il severo, il presuntuoso, il passivo
e dipendente, il buontempone, l’ipocondriaco, il vero collega, l’ambizioso, il sicuro di sé, il camerata, il servile, il sofferente, il capro espiatorio, il pauroso, il permaloso e l’introverso.
16 Quanto alla personalità del mobber, lo
studioso Ege ha elaborato 14 diverse figure
di riferimento: l’“istigatore”, ossia colui
che è sempre alla ricerca di nuove cattiverie
e maldicenze per colpire gli altri; il “casuale”, che diventa mobber per conflitti occasionalmente nati in azienda; il “conformista”, che non prende direttamente parte al
conflitto attaccando la vittima, ma si limita
ad osservare come spettatore inerte; il “collerico”, che non riesce a contenere la propria rabbia e la sfoga con terzi; il “megalomane”, che ha una visione distorta di se
stesso da cui deriva il complesso di superiorità sui colleghi; il “frustrato”, che insoddisfatto della propria vita, scarica il suo
malessere sugli altri, analogamente al collerico; il “sadico”, che prova piacere nel di-
Saggi
struggere i colleghi; il “criticone”, che crea
un clima di insoddisfazione e di tensione
nel gruppo; il “leccapiedi”, ossia il carrierista, tirannico con i subalterni ed ossequioso
con i superiori; il “pusillanime”, che, pur
non esponendosi direttamente, agevola il
mobber e ne condivide gli intenti; il “tiranno” che sfrutta la propria posizione contro
gli altri; il “terrorizzato”, che, temendo la
concorrenza, si oppone con atteggiamenti
mobbizzanti di difesa; l’“invidioso”, che
reagisce ai successi altrui con cattiveria; e il
“carrierista”, che cerca di farsi una posizione con tutti i mezzi possibili, anche se illeciti e dannosi. T. Field, invece, elenca quattro tipologie di tratti di personalità psicopatologicamente disturbate del possibile mobber: disturbo di personalità antisociale (ca-
ratterizzato da mancata accettazione delle
norme sociali, disonestà, impulsività, mancanza di empatia per gli altri, irresponsabilità e assenza di rimorso); personalità paranoica (connotata da sospetti infondati sull’onestà delle intenzioni altrui, riluttanza a
confidarsi, diffidenza verso le persone vicine, travisamento della realtà e mancanza di
perdono per dubbie offese ricevute); disturbo narcisistico di personalità (che si estrinseca in sentimenti di superiorità rispetto
agli altri, desiderio costante di ammirazione, scarsa empatia, fantasie sconfinate di
successo e esagerazione delle proprie qualità) e disturbo borderline (che si manifesta
con relazioni instabili, sensazione di vuoto,
senso di abbandono, incapacità di controllare la collera, comportamenti autolesionisti e
18
mutamenti d’umore costanti).
17 Si caratterizza per la presenza di sintomi
depressivi al primo stadio, come disturbi
dell’ansia, difetti di rendimento o alterazione degli ordinari rapporti sociali.
18 Caratterizzato da disturbi dissociativi di
varia natura, come distacco, senso soggettivo di torpore, assenza di reattività emozionale, depersonalizzazione, derealizzazione,
riduzione della consapevolezza dell’ambiente e amnesia dissociativa.
19 Disturbo cronico particolarmente grave,
in genere connesso a eventi traumatici
abnormi, che necessità di una obbligatoria
terapia psicologica, unita alla somministrazione di aiuti farmacologici.
20 Cfr. EGE, I numeri del mobbing, cit.
Temi Romana
Saggi
Profili generali relativi alla tutela del consumatore
ed azione di classe
Parte I
Alessandro Nicodemi
Avvocato, Dottorando di Ricerca “Consumatori e Mercato-area giuridica” Università degli Studi Roma Tre (XXVII ciclo)
Il contributo reso affronta – in questa prima parte – taluni profili generali relativi alla materia consumeristica,
soffermandosi dapprima sulle istanze socio-economiche poste alla base della relativa legislazione per poi analizzare alcuni elementi pregnanti della disciplina di riferimento quali, in particolare, le clausole vessatorie, la tutela amministrativa ad esse correlata e l’azione di classe. Nella seconda parte, di successiva pubblicazione, si continuerà ad analizzare l’azione di classe: istituto che – mutuato da altri ordinamenti ed apparentemente idoneo al
contrasto delle condotte illecite poste in essere dagli operatori del mercato – allo stato sembra ancora caratterizzato da una ridotta effettualità.
Sommario Prima Parte: 1. – La tutela del consumatore in ambito comunitario e domestico: nozione ed evoluzione storica; 2. – Uno sguardo generale al Codice del Consumo: clausole vessatorie ed altri elementi di rilievo;
3. – La tutela amministrativa del consumatore introdotta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27; 4. – La disciplina italiana della class action: la genesi ed i confronti con i
rimedi preesistenti; 5. – I diritti tutelabili mediante l’azione di classe: struttura dell’illecito e danno risarcibile; 6.
– Cenni di diritto comparato in materia di azione di classe; 7. – Le peculiarità processuali dell’azione di classe.
Sommario Seconda Parte: 1. – Poteri processuali dell’organo giurisdizionale e pronunce adottabili dal Giudice;
2. – La legittimazione all’azione di classe; 3. – Il giudizio di ammissibilità nella class action; 4. – Le pronunce
sull’ammissibilità del giudizio; 5. – Adesione ed intervento nell’art. 140 bis del Codice del Consumo; 6. – Le ipotesi emerse nella prassi giudiziaria: peculiarità delle singole fattispecie ed analisi correlata.
1.
La tutela del consumatore in ambito comunitario e domestico: nozione ed evoluzione
storica
La necessità di apprestare forme di tutela nei confronti
del consumatore attiene alla più ampia problematica
relativa alla giustizia contrattuale ed alle correlate
istanze di tutela del soggetto debole all’interno di
forme di contrattazione connotate da diseguaglianze ed
asimmetrie1.
Tale esigenza si manifestò, in origine, nell’esperienza
statunitense dove, prima che in ogni altro paese al
mondo, si crearono le condizioni per la nascita ed il
veloce sviluppo di un capitalismo monopolistico ed oligopolistico2.
In correlazione, dunque, all’affermarsi delle suddette
forme economiche e di mercato, emersero altresì le
prime istanze di difesa degli interessi consumeristici.
Temi Romana
Soltanto in un secondo momento, le medesime istanze
furono avvertite in ambito europeo, dapprima sul piano
sociale ed economico e, successivamente, sul versante
dell’elaborazione giuridica (fase, quest’ultima, collocabile, temporalmente, all’inizio degli anni settanta del
secolo scorso).
Sul piano strettamente nazionale, il legislatore italiano
mostrò una scarsa attenzione al problema, benché nella
Relazione al Re sul codice civile taluni passaggi relativi agli artt. 1341 e 1342 avessero posto in evidenza la
necessità di predisporre una tutela per l’aderente ai c.d.
contratti di massa, connotandosi, questo, per essere il
soggetto debole dell’operazione economica di riferimento.
Dati normativi di rilievo sul piano nazionale, dunque,
sono rinvenibili nell’art. 2597 c.c., pure teso ad offrire
una forma di tutela esclusivamente in presenza di un
19
Saggi
soggetto monopolista, nonché nei menzionati artt. 1341
e 1342 c.c., idonei ad apprestare una forma di difesa
puramente formale e scevra da interventi di carattere
sostanziale.
Tornando, quindi, al crinale comunitario, ove, per
primo si registrò la prima elaborazione giuridica della
materia, un primigenio dato di rilievo è costituito dalla
Risoluzione sui diritti dei consumatori che, approvata
nel 1975, fornì impulso alle politiche in materia consumeristica e dall’Atto Unico europeo del 23 dicembre
1986 che conferì un fondamento giuridico alla politica
dei consumatori, modificando l’art. 100 del Trattato di
Roma e prevedendo che, nella materia relativa alla protezione dei consumatori, dovesse esservi un livello di
protezione elevato.
Dati di assoluta pregnanza nell’affermazione del diritto
dei consumi furono successivamente rappresentati dal
Trattato di Maastricht (datato 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993) che elevò la tutela dei
consumatori a strumento atto a perseguire gli obiettivi
dell’Unione Europea e consentì l’adozione di azioni che
fossero direttamente tese alla tutela del consumatore
[cfr. art. 3, lett. t) ed art. 129 del Trattato] nonché dall’art. 153, comma 2 del Trattato Istitutivo della
Comunità Europea, come novellato dal Trattato di
Amsterdam (entrato in vigore in data 1 maggio 1999),
secondo cui l’affermazione e l’attuazione delle politiche
comunitarie avrebbero dovuto prendere in considerazione le esigenze relative alla protezione dei consumatori.
Altri dati normativi di rilievo, inoltre, sono costituiti
dall’art. 38 della Carta dei diritti Fondamentali
dell’Unione Europea (Nizza, 2000), secondo cui nella
politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di
protezione dei consumatori, nonché, da ultimo, nell’art.
169 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea (TFUE, in vigore dal 1 dicembre 2009),
secondo cui la UE contribuisce a tutelare la salute, la
sicurezza e gli interessi economici dei consumatori
nonché a promuovere il loro diritto all’informazione,
all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia
dei loro interessi, sia con misure adottate nel quadro
della realizzazione del mercato interno, sia con misure
di sostegno, integrazione e controllo della politica svolta dagli Stati membri.
L’art. 12 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea ha, poi, recepito l’articolo 153 del Trattato
Istitutivo della Comunità Europea, al quale già si è
fatto riferimento.
2. Uno sguardo generale al Codice del Consumo:
clausole vessatorie ed altri elementi di rilievo
Il Codice del Consumo è stato varato con il D.Lgs. 6
settembre 2005, n. 206, in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 7, L. 29 luglio 2003, n. 229.
Esso accorpa in un unico testo le disposizioni normative relative alla figura del consumatore, come cittadino
consapevole dei propri diritti e doveri, altresì provvedendo al coordinamento ed alla semplificazione delle
disposizioni stesse.
Il Codice è teso a consentire l’informazione del consumatore nonché ad assicurare la correttezza dei processi
negoziali su cui sono fondate le determinazioni correlate.
Esso provvede anche a definire diritti ed interessi dei
consumatori e degli utenti, nella loro forma sia individuale che collettiva, promuovendone la tutela in sede
nazionale e locale.
Il testo normativo in parola è costituito da 146 articoli
ed è teso al riordino e alla semplificazione della normativa preesistente, posta a tutela del consumatore.
Esso appresta regole di tutela in ordine al contratto ed
alla fase precontrattuale (si pensi agli articoli posti a
disciplina delle pratiche commerciali aggressive ed
ingannevoli), altresì guardando alla fase della produzione e della distribuzione dei prodotti e dei servizi; disciplina, poi, la corretta informazione ed il diritto di recesso dal contratto, anche nella materia delle televendite.
Tra le altre cose, richiama la disciplina relativa ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e a distanza, quella relativa all’acquisto di pacchetti turistici, alla
multiproprietà, alla sicurezza e qualità dei prodotti, alle
garanzie legali e commerciali riferite ai beni di consumo (non è più presente, invece, nel codice, la disciplina relativa al credito al consumo, trasferita all’interno
del Testo Unico Bancario a seguito delle modifiche
normative indotte dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141).
L’intento perseguito dal legislatore, risulta evidente, è
stato, quindi, quello di apprestare un unico corpus normativo, a carattere totalizzante ed idoneo a contenere la
generalità delle previsioni relative alla materia consumeristica.
Nella disamina, poi, dei rapporti tra il Codice del consumo ed il codice civile, è stato altresì evidenziato che
20
Temi Romana
Saggi
le discipline offerta dall’uno e dall’altro, non avendo
ambiti coincidenti, tendono a cumularsi, piuttosto che a
porsi in un rapporto da genus a species, sul piano dell’individuazione delle norme concretamente rilevanti3.
In via generale, comunque, secondo la medesima dottrina, mentre il codice civile porrebbe maggiore attenzione alla fattispecie astratta ed al dato formale, il codice del consumo guarderebbe al dato dinamico e funzionale, concentrandosi sull’elemento della disuguaglianza strutturale e mirando ad interventi di riequilibrio4.
Tanto rilevato in via generale, occorre osservare che il
Codice del consumo, teso a riequilibrare rapporti in
radice sperequati, si avvale, a tale scopo, di diversi
strumenti, imponendo obblighi informativi ed oneri
formali in capo al professionista, sancendo l’illiceità di
atti e comportamenti, sanzionando condotte aggressive
e comportamenti ingannevoli, conferendo diritti di
ripensamento in ordine a pattuizioni contrattuali già
concluse, affermando la nullità di forniture di servizi
non richieste, attribuendo poteri di vigilanza e regolazione ad organi amministrativi.
Sul versante propriamente contrattuale, tuttavia l’elemento di tutela offerto al consumatore di maggiore pregnanza è forse costituito dall’accertamento giudiziale
relativo alle clausole vessatorie.
La disciplina di rilievo, estrapolata dal codice civile
(originari artt. 1469 e ss., introdotti dalla L. 6 febbraio
1996, n. 52) ed introdotta nel corpo del Codice del consumo agli artt. 33 e ss., attuativa di una pregressa normazione comunitaria, ha inteso realizzare una forma di
tutela sostanziale – in antitesi alla tutela formale originariamente apprestata dall’art. 1341 c.c. – in favore del
consumatore, a fronte di assetti negoziali già predisposti dal professionista, così come preconfezionati in una
veste immutabile ed espressivi della sola potestà di
scelta del prendere o del lasciare.
In altri termini, all’incapacità del consumatore di fronteggiare il professionista nel proprio campo – non
disponendo di un idoneo apparato informativo e difettando delle conoscenze del settore invece proprie del
soggetto professionale – ed all’impossibilità di modificare assetti negoziali già predisposti dal professionista,
il legislatore, comunitario prima e nazionale poi, ha
inteso porre rimedio sul piano delle tutele, così da riequilibrare, per via giudiziaria, una sperequazione ineliminabile sul piano dei rapporti socio-economici.
Temi Romana
Sul punto, poi, non pare inutile ribadire che l’incapacità del consumatore di incidere sull’assetto contrattuale
– a fronte del diniego ordinariamente frapposto dal professionista a che il consumatore stesso modifichi le
clausole negoziali predisposte – è tanto più rilevante
ove si consideri che nella prassi i soggetti professionali non soltanto tendono a predisporre contratti che siano
conformi ai propri interessi, ma talora fanno ciò andando a vulnerare, più o meno smaccatamente, gli interessi della controparte (per giunta, sovente sprovvisti della
preparazione giuridica necessaria alla comprensione
del documento sottoscritto).
Guardando al dato sociale appena riportato, non appare arduo comprendere i motivi per i quali il legislatore
ha introdotto una disciplina relativa alle clausole vessatorie, altresì apprestando ulteriori forme di garanzia (si
pensi al c.d. foro del consumatore di cui all’art. 63 del
Codice del consumo).
In dottrina5, una volta premesso che la nuova tutela del
consumatore ha carattere sostanziale – in quanto permette al giudice, diversamente dal passato, di valutare
e sindacare il contenuto del contratto – sono state sinteticamente richiamate le peculiarità della disciplina
normativa in parola.
In particolare, è stato evidenziato che l’art. 33, cod. cons.,
collega l’abusività delle clausole non più al dato formale
della mancata specifica sottoscrizione delle medesime da
parte dell’aderente, bensì al “significativo squilibrio dei
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
Nel caso dell’anzidetto significativo squilibrio a carico
del consumatore, l’art. 36, Codice del consumo, prevede la nullità delle clausole considerate vessatorie, mentre, per il resto, il contratto rimane valido.
Anche attraverso quest’ultima disposizione normativa,
quindi, la protezione del consumatore viene rafforzata,
posto che l’inefficacia delle clausole abusive (prevista
dall’art. 1341 c.c. e dall’abrogato art. 1469 quinquies
c.c.) viene sostituita dalla nullità delle stesse.
Si tratta di una nullità di protezione (come risulta,
peraltro, dalla stessa rubrica della richiamata norma),
operando esclusivamente a vantaggio del consumatore.
Tale forma di nullità è relativa, essendo rilevabile soltanto dal consumatore, e si contrappone, dunque, alla
nullità assoluta, che può essere fatta valere da chiunque
vi abbia interesse.
La nuova normativa amplia anche l’ambito oggettivo
21
Saggi
scelta era tra un controllo giudiziale, un controllo
amministrativo, ed un controllo integrato o combinato.
Il legislatore italiano, nel dare attuazione alla dir.
1993/13/CEE, optava, dopo molte indecisioni, per un
sistema di controllo giudiziale, e dettava l’art. 1469
sexies c.c., che sarebbe poi diventato l’art. 37 cod.
cons., rubricato “azione inibitoria”.
La scarsa incisività di siffatto strumento induce ora il
legislatore a rivedere la scelta a suo tempo effettuata, e
ad affiancare alla tutela giudiziale, di cui all’art. 37 cod.
cons., la tutela amministrativa, di cui all’art. 37 bis
dello stesso Codice: si passa così da un sistema di controllo giudiziale ad un sistema di controllo integrato o
combinato.
“Meglio tardi che mai”, è stato il commento espresso
sul punto7.
Tale norma, appunto, ha introdotto una forma di tutela
del consumatore priva del carattere giurisdizionale ed
attivabile in via puramente amministrativa: in termini
pratici, a fronte di clausole vessatorie, il consumatore
potrà sporgere apposita denuncia presso l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato e questa, ravvisata l’effettiva sussistenza dell’illecito, provvederà a
dare la prescritta pubblicità al fatto, altresì irrogando,
ove si renda necessario, apposite sanzioni amministrative (cfr. art. 37 bis, commi 1 e 2, Codice del consumo).
Una vicenda siffatta, certamente inidonea a determinare
un esito risarcitorio in capo al consumatore, assume, tuttavia, un certo rilievo, fungendo da deterrente nei confronti delle imprese che, meno timorose dell’instaurazione di cause giudiziali (venendo spesso in rilievo le c.d.
small claims), saranno, invece, assai più sensibili a forme
di tutele attivabili dal consumatore con una semplice
denuncia amministrativa e foriere, ove la denunzia sia
fondata, di rilevanti conseguenze sul piano economico.
La questione relativa all’opportunità di introdurre o
meno una tutela di carattere amministrativo è stata
ampiamente discussa in dottrina ancora prima che
fosse emanata la direttiva comunitaria 93/13/CEE che,
per prima, disciplinò le clausole vessatorie8.
A fronte, tuttavia, di una tutela che pare assai incisiva e
penetrante – anche solo per l’effetto deterrente che essa
è in grado di realizzare sulle imprese – viene da pensare che l’elemento ostativo al suo inserimento stesse non
tanto nel dubbio che la stessa potesse o meno avere una
reale efficacia, quanto piuttosto in considerazioni di
della tutela del consumatore.
Al riguardo, si osserva che, mentre l’art. 1341 c.c. si
riferisce all’ipotesi particolare delle condizioni generali di contratto, l’art. 33, Codice del consumo, non contiene alcuna limitazione e, pertanto, l’abusività delle
clausole può essere rilevata dal consumatore anche nel
caso di un contratto individuale stipulato con il professionista.
In ordine al quesito, poi, se la tutela così apprestata
dagli artt. 33 e ss. del Codice del consumo assuma un
carattere alternativo rispetto a quella tradizionalmente
posta dall’art. 1341 c.c., pare preferibile la tesi del
cumulo delle discipline, secondo cui la normazione
posta dal codice del consumo, foriera di ulteriori tutele, andrebbe ad aggiungersi alle forma di tutela tralaticie e non già a sostituirsi alle stesse.
Giova, inoltre, precisare che le clausole in parola vanno
soggette alla disciplina menzionata, “malgrado la
buona fede”, come testualmente stabilito dall’art. 33
del Codice del consumo.
Tale ultimo dato testuale, sin dall’emanazione della L.
6 febbraio 1996, n. 52, ha posto il quesito se la buona
fede in parola debba essere interpretata in chiave oggettiva – vale a dire come correttezza o lealtà – oppure in
chiave soggettiva, così riferendosi ad un dato psicologico di buona fede in capo al professionista, ignaro
della vessatorietà della clausola.
Benché la dizione testuale della direttiva comunitaria
93/13/CEE, cui le norme in parola hanno inteso dare
attuazione, induca a propendere per l’iterpretazione in
chiave oggettiva, il dibattito dottrinale sul punto pare
tutt’altro che sopito6.
3. La tutela amministrativa del consumatore introdotta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27
L’art. 5 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
strutture e la competitività (c.d. Cresci Italia) ha inserito, all’interno del Codice del consumo, l’art. 37 bis,
intitolato “Tutela amministrativa contro le clausole
vessatorie”.
Al riguardo, è opportuno premettere che l’art. 7 della
dir. 1993/13/CEE del Consiglio devolveva ai legislatori nazionali il compito di stabilire l’autorità competente e i rimedi di tipo generale, preventivo e collettivo: la
22
Temi Romana
Saggi
natura politica in certa misura ostili a nuove forme di
controllo amministrativo nei confronti dei soggetti
imprenditoriali.
In ordine alla tutela de qua, comunque, è dato avanzare una serie di considerazioni.
In primo luogo, essa ha carattere preventivo, secondo
due distinte accezioni: ha un carattere preventivo
rispetto all’instaurazione di una lite giudiziaria; ancora,
essa ha un carattere preventivo in relazione alla possibilità, per le imprese, di interpellare preventivamente
l’Autorità in ordine alla vessatorietà delle clausole che
esse intendono adottare nei rapporti coi consumatori
(art. 37 bis, comma 3, Codice del consumo).
In secondo luogo, la tutela in parola è assai più facilmente attivabile da parte del consumatore il quale, a tal
fine, non andrà incontro ai costi che, invece, sono correlati ad una causa giudiziale e, di più, per il caso in cui
l’Autorità effettivamente riscontri la paventata vessatorietà, egli potrà utilizzare le relative determinazioni per
far valere, con maggiore vigore, il proprio diritto al
risarcimento del danno dinanzi all’Autorità giudiziaria
(che, pure, com’è ovvio, davvero non rimane vincolata
alle decisioni assunte in sede amministrativa).
In terzo luogo, la tutela amministrativa, sul versante
della concreta efficacia, appare maggiormente idonea a
sortire effetti pratici rispetto all’azione inibitoria di cui
all’art. 37 del Codice del consumo, essendo attivabile
con maggiore facilità e, come detto, non abbisognando
dell’instaurazione di un procedimento giudiziario.
Da ultimo, guardando specificamente allo strumento
dell’interpello previsto dal predetto art. 37 bis, comma 3,
esso costituisce un istituto mutuato dal diritto tributario
(cfr. art. 11, L. 27 luglio 2000, n. 212) e del quale, si ritiene, le imprese faranno un uso tutt’altro che rarefatto.
Guardando a tale istituto, la tutela amministrativa, letta
in un’ottica di sussidiarietà, si pone, in maniera assai più
palese rispetto ad altre ipotesi, come strumento di vigilanza sul corretto uso dell’autonomia, la quale non può
spingersi a predisporre un modello di composizione
degli interessi che non risponde a ragionevolezza, imponendo ad una delle parti sacrifici i quali, secondo i criteri di accertamento indicati, risultano sproporzionati.
Il legislatore amplia i margini di autonomia dei privati,
limita il ricorso alle norme inderogabili, sfuma la rigidità dei tipi, tuttavia, al fine di evitare che la libertà
possa essere “abusata”, non circoscrive la tutela al
Temi Romana
rimedio giurisdizionale, ma introduce sistemi di vigilanza che si spingono fino alla verifica della corretta
incidenza sul mercato di offerte che ancora non sono
state emesse.
La procedura di interpello non attribuisce di certo
all’Autorità una funzione per così dire dirigistica, ma
tende ad incentivare il passaggio dalla predisposizione
all’autoregolamentazione9.
4. La disciplina italiana della class action: la genesi
ed i confronti con i rimedi preesistenti
L’azione di classe italiana, ispirata alla class action statunitense, è prevista dall’art. 140 bis del Codice del
consumo, come introdotto dall’art. 2, commi 446-449,
L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il
2008) e successivamente modificato.
L’art. 2 della suddetta Legge finanziaria, richiamando
in larga misura precedenti disegni di legge non approvati10, ha introdotto nell’ordinamento un’azione collettiva risarcitoria riferita ad illeciti contrattuali o extracontrattuali produttivi di danni nei confronti di una pluralità di utenti o consumatori.
La ratio giustificatrice della norma in commento può
essere spiegata alla luce della difficoltà delle istanze
consumeristiche ad approdare alle aule giudiziarie, trattandosi, assai frequentemente, di domande risarcitorie
a connotazione esigua (c.d. small claims).
Proprio alla luce di tale rilievi, sin dagli anni ’70 si è
cercato di creare un mezzo di tutela più effettivo, economico e semplice, per la soluzione delle controversie
seriali: un’azione estranea ai meccanismi ordinari del
processo litisconsortile che altrimenti genererebbe giudizi con centinaia o migliaia di parti.
In questa prospettiva, è opinione comune che un’azione risarcitoria seriale dovrebbe contemperare e garantire il soddisfacimento di tre interessi fondamentali:
quello dei danneggiati ad ottenere una tutela efficace,
quello del danneggiante alla predeterminazione dei
danni, quello del sistema giudiziario a realizzare una
deflazione del contenzioso seriale.
In particolare, per quanto concerne l’ultimo degli obiettivi menzionati, esso può essere perseguito con qualche
probabilità di successo solo mediante uno strumento
processuale che svolga anche una funzione di deterrenza e stimoli comportamenti virtuosi degli operatori.
Diversamente, le imprese, non avvertendo il rischio di
23
Saggi
potenziali iniziative giudiziarie, avrebbero deboli motivazioni a rispettare le disposizioni normative e regole
di condotta improntate a lealtà e correttezza nelle relazioni economiche11.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il legislatore ha introdotto l’azione di classe, così superando
le titubanze che, al riguardo, erano state manifestate in
precedenza.
L’art. 2, 446° comma, Legge finanziaria, infatti, inserisce nel Codice del consumo l’art. 140 bis il quale al 1°
co. statuisce preliminarmente che la legittimazione
all’azione spetta alle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale (ex art.
137, 1° co., Codice del consumo) e iscritte nell’apposito elenco tenuto presso il Ministero delle attività produttive nonché alle associazioni e ai comitati che siano
adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi
fatti valere (art. 140 bis, 2° co., Codice del consumo).
L’elemento qualificante della class action, idoneo a
distinguerlo dalle azioni di matrice collettiva già previste dal codice del consumo agli artt. 37, 139, 140, per
la verità, risulta già dall’intitolazione dell’art. 140 bis
del codice (“Azione collettiva risarcitoria”).
Come risulta chiaramente a seguito di un’analisi comparativa tra l’art. 140 bis e le norme citate, infatti, il
predetto art. 140 bis ha aggiunto agli strumenti di tutela posti a disposizione delle associazioni considerate
rappresentative a livello nazionale – domande inibitorie, domande tese ad ottenere l’adozione di misure di
correzione od eliminazione di effetti dannosi, domande
tese ad ottenere la pubblicazione dei provvedimenti
giudiziari così adottati – altresì la possibilità di chiedere, per via giudiziale, il risarcimento dei danni cagionati ai consumatori nell’ambito di rapporti contrattuali
stipulati per adesione od in relazione ad illeciti extracontrattuali, pratiche commerciali scorrette, illeciti
concorrenziali; tutto ciò in riferimento alla lesione dei
diritti di una pluralità di consumatori od utenti.
La medesima finalità risarcitoria non può essere ricondotta all’art. 140, comma 1, lett. b) del Codice del consumo che, nel menzionare, con linguaggio scarno e
poco specificativo, misure idonee ad eliminare gli
effetti dannosi delle violazioni accertate, intende riferirsi a misure giudiziali che abbiano l’effetto di eliminare tali effetti, ripristinando lo status quo ante, ma non
già dal punto di vista del ristoro patrimoniale o della
compensazione del depauperamento subito.
L’opinione largamente dominante, in consonanza a quanto appena sostenuto, infatti, esclude che l’azione di cui
all’art. 140 cod. cons. possa consentire di domandare il
risarcimento dei danni subiti dai singoli consumatori12.
Sul punto, ben vero, è stato sostenuto che l’azione ex
art. 140 del Codice del consumo, avendo natura preventiva-inibitoria, può rivelarsi insufficiente o non
adatta a tutelare alcune tipologie di illeciti seriali (c.d.
danni di massa o mass torts) che non sempre rappresentano il risultato di comportamenti valutabili preventivamente e che, inoltre, presenta lo svantaggio di costringere il singolo, danneggiato dalle violazioni accertate
per mezzo dello strumento inibitorio, ad avviare
un’azione individuale per ottenere il risarcimento del
danno13.
La medesima opinione è stata poi avanzata in seno alla
dottrina laddove è stato osservato che, prima dell’introduzione dell’art. 140 bis del codice del consumo, il
meccanismo dell’art. 140 del Codice consentiva alle
associazioni dei consumatori e degli utenti solamente
di convenire in giudizio l’impresa e di ottenere dal giudice un provvedimento che inibisse l’uso della clausola di cui fosse stata accertata l’abusività. Il massimo
risultato ottenibile, secondo tale ermeneutica, era dunque l’emissione di provvedimenti di accertamento e di
natura preventiva. Proprio per ovviare a questo limite,
il legislatore era perciò intervenuto integrando la normativa del Codice del Consumo, nella parte concernente la legittimazione ad agire in giudizio a tutela di interessi collettivi disciplinata dagli articoli 139 e 14014.
Il punto è che le azioni giudiziali di cui agli artt. 139 e
140 del Codice del consumo assumono una valenza
propriamente collettiva, come tale incapace di guardare ai profili risarcitori di pertinenza dei singoli consumatori danneggiati15; aspetto questo che rimane “stemperato” od eliso dalla stessa dizione testuale dell’art.
140 bis del Codice che, pur indirizzando l’azione delle
associazioni a finalità di tutela di interessi collettivi, fa
espresso riferimento all’accertamento della responsabilità ed alla condanna al risarcimento del danno in favore dei singoli consumatori.
Il dato sostanziale della vicenda in relazione al quale,
assunta l’insufficienza degli strumenti processuali
preesistenti, si è addivenuti all’introduzione della class
action nel nostro ordinamento, per la verità, è stato
24
Temi Romana
Saggi
ampiamente affrontato dalla dottrina.
In favore dell’introduzione di una tutela risarcitoria di
classe, in particolare, sono state addotte nel tempo, una
serie di motivazioni16.
In primo luogo, ragioni di economia processuale connesse alla contrazione del contenzioso civile, insieme
ad esigenze di equità, tradotte nella necessità di eliminare il rischio di provvedimenti giudiziali difformi tra
singoli consumatori.
Nel medesimo senso, poi, stava la considerazione per
cui tali forme di tutela collettiva consentono all’imprenditore di predeterminare il rischio economico al
quale va incontro.
Inoltre la prospettiva di strumenti efficaci di deterrenza
corrispondeva al più ampio obiettivo di ristabilire fiducia nel mercato e di rassicurare i consumatori e gli
utenti, oltre a consentire l’accesso alla giustizia alle
situazioni generalizzate a ridotto importo economico
individuale (si allude alle small claims,cui già si è fatto
riferimento).
L’azione di classe consentiva, poi, il riequilibrio dell’asimmetria, sul piano processuale, tra le parti occasionali (i consumatori, portatori degli interessi attinenti alla
loro singola pretesa) e la parte abituale (il professionista, portatore di interessi economici assai più elevati).
Un’asimmetria delle poste economiche, questa, che si
traduce a sua volta in una diversa propensione ad investire nel giudizio e che influenza l’accesso alla giustizia e la tutela di situazioni sostanziali pure enunciate
come fondamentali: trattandosi di contenzioso ripetitivo, l’impresa non solo ha vantaggi strategici, ma tendenzialmente destina al singolo processo risorse economiche commisurate non alle singole domande, ma
all’entità globale delle pretese complessive.
La differenza di potere economico e di accesso alla
tutela giudiziale menzionata è suscettibile di superamento proprio coordinando le parti occasionali così da
contribuire insieme alle spese necessarie per la lite.
La situazione così descritta faceva propendere per l’opportunità di una tutela di classe.
In tal senso stava anche la considerazione per cui l’efficacia e l’attuazione delle regole poste a protezione della
libera concorrenza nel mercato, per essere realmente
operative, devono essere affidate non soltanto alla vigilanza dei pubblici poteri (c.d. public enforcement), ma
anche all’operatività di rimedi civilistici (c.d. private
Temi Romana
enforcement), come sostenuto a livello comunitario in
materia di attuazione del diritto antitrust (in tal senso, il
Libro Verde delle azioni risarcitorie in materia antitrust,
presentato dalla Commissione il 19 dicembre 2005, ed
il Libro Bianco del 2 aprile 2008).
Queste, dunque, sono le ragioni note e sostanzialmente
condivise che hanno indotto all’adozione dell’azione di
classe17.
Ragioni, evidentemente, ben presenti al legislatore al
momento in cui, da ultimo, ha ritenuto di richiamare
l’applicabilità dell’azione di classe anche in riferimento
alle controversie relative ai diritti dei consumatori nei
contratti, con specifico riferimento alle disposizioni
contenute nelle Sezioni da I a IV del Capo I, Titolo III,
Parte III del Codice del consumo (in tal senso dispone
l’art. 66, cod. cons., come riformato dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 intitolato: “Attuazione della direttiva
2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE”).
5. I diritti tutelabili mediante l’azione di classe:
struttura dell’illecito e danno risarcibile
L’ambito oggettivo di applicazione della norma è compiutamente delineato ai primi due commi dello stesso
art. 140 bis, cod. cons., come riformulato dalle modifiche normative intervenute.
Per ragioni di opportunità espositiva, dunque, viene
riportato, a seguire, tale dato normativo.
“1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli
utenti di cui al comma 2 nonché gli interessi collettivi
sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe,
secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire
per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. (170)
2. L’azione di classe ha per oggetto l’accertamento
della responsabilità e la condanna al risarcimento del
danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L’azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori
e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a
contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del
codice civile;
25
Saggi
dotta precontrattuale scorretta e realizzata in termini di
generalità (si ipotizzi il caso delle informazioni false o
fallaci rese alla generalità dei consumatori) od ancora
dal generale inserimento, nei contratti d’impresa, di
clausole vessatorie verso il consumatore.
È interessante, poi, rilevare come la tutela sia stata estesa ai consumatori anche a prescindere da un rapporto
contrattuale diretto [lett. b), comma 2, art. 140 bis],
potendosi, dunque, attivare anche nei confronti di un
fornitore di servizi o produttore di beni, anche laddove
il consumatore non abbia instaurato cogli stessi una
vicenda contrattuale.
Una siffatta formulazione della norma è meno ampia
rispetto a quella presente nella versione originaria, che
assumeva l’azionabilità della class action in relazione
ad atti illeciti extracontrattuali, ma, verosimilmente,
più specialistica, ovvero maggiormente aderente alle
situazioni di danni che possono concretamente verificarsi in capo a classi di consumatori.
Rimane, ancora, la previsione relativa all’attivabilità
dell’azione in commento anche in relazione a pregiudizi derivanti da pratiche commerciali scorrette o da
comportamenti anticoncorrenziali, da sempre presente
nell’ambito della norma de qua.
A fronte di una disciplina siffatta, resta, tuttavia, un’incertezza sul piano soggettivo: la norma non utilizza il
termine professionista che nel codice del consumo designa sia l’imprenditore che il libero professionista, sicché permane il dubbio se l’azione di classe possa essere
esperita soltanto nei confronti dell’imprenditore o anche
nei confronti degli esercenti le professioni intellettuali o
dei loro ordini e associazioni professionali18.
In ogni caso, minimo comune denominatore delle
vicende da cui può scaturire la class action è sicuramente rappresentato da un fatto costitutivo a rilevanza
comune che vale a fondare la pluralità di diritti risarcitori o restitutori e che deve potersi riferire in modo
indifferenziato alla pluralità di consumatori od utenti19.
Tanto delineato in termini generali, sul fronte della
struttura dell’illecito, pare che la stessa, di massima, si
caratterizzi nei termini consueti, assurgendo a rilievo la
condotta del danneggiante nonché il nesso di causalità
della stessa col danno riportato dal danneggiato.
Minor rilievo pare, invece, che debba assumere l’elemento psicologico della condotta dannosa, in considerazione del fatto che in ambito contrattuale, a fronte di
b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di
un determinato prodotto o servizio nei confronti del
relativo produttore, anche a prescindere da un diretto
rapporto contrattuale;
c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante
agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali”.
Il comma 1 della norma in commento estende il proprio
ambito di tutela, oltre ai diritti individuali omogenei di
consumatori ed utenti, anche agli interessi collettivi.
Una siffatta estensione testuale non pare, tuttavia,
caratterizzarsi in termini di effettività: la norma de qua,
come in precedenza esposto, assolve alla specifica finalità di fornire uno strumento risarcitorio alla pletora di
consumatori che abbiano subito l’illecito laddove alla
tutela degli interessi collettivi dei consumatori sono
preposte altre norme (artt. 140 e 37, cod. cons.).
Anche ove si ignorassero, poi, le ragioni poste a fondamento dell’introduzione di un’azione di classe nel
nostro ordinamento e le istanze sociali che ne hanno
costituito la base, la stessa struttura della norma depone nel senso di una tutela specificamente finalizzata
alle restituzioni ed ai risarcimenti in favore dei consumatori che siano stati danneggiati (si guardi, in tal
senso, al comma 12 dell’art. 140 bis, relativo ai poteri
decisori del giudice nel caso di accoglimento della
domanda), piuttosto che al perseguimento di interessi a
rilievo collettivistico (salvo che l’interesse collettivo in
parola sia considerato proprio quello attinente all’azione di classe).
Acclarato, dunque, come il proprium della tutela in
commento attenga ai diritti risarcitori di spettanza dei
singoli consumatori, pure inseriti nel contesto collettivo di un’azione di classe, giova rilevare come l’ambito
di applicazione della fattispecie si presenti in termini
decisamente più ampi rispetto alla primigenia formulazione della norma, riferendosi non più soltanto all’ambito di rapporti giuridici stipulati ai sensi dell’art. 1342
c.c., ma alla più vasta categoria dei diritti contrattuali di
una pluralità di consumatori e utenti che versano nei
confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi
degli articoli 1341 e 1342 del codice civile (lett. a),
comma 2, art. 140 bis, attuale formulazione.
Diritti contrattuali che, quindi, potrebbero essere stati
vulnerati da un inadempimento, ma anche da una con-
26
Temi Romana
Saggi
prestazioni rese da un soggetto professionale, l’interpretazione giurisprudenziale, ormai da tempo, individua forma di responsabilità per danni che assumono
una valenza oggettiva o semioggettiva.
L’assunto per cui il soggetto professionale, alla luce
della propria esperienza, è in grado di prevedere i danni
verificabili e, per questo, è tenuto a predisporre opportune misure idonee a prevenirli od evitarli, quindi – per
quanto consta – induce la prassi giudiziaria a prescindere in certa misura dall’elemento della colpevolezza
in capo al professionista, nei limiti, naturalmente, del
sacrificio esigibile in capo al debitore professionale e,
soprattutto, del caso fortuito.
Circa la portata delle disposizioni in parola, naturalmente, non sono mancati commenti dottrinali.
In particolare, sul punto è stato osservato20 che l’omogeneità dei diritti contrattuali di cui al menzionato
comma 2, lett. a), allude ad una contrattazione seriale
iniqua od illecita riferita ad una pluralità di consumatori/utenti laddove l’omogeneità delle situazioni soggettive sarebbe data dalla comune condizione di parti contraenti (deboli) pregiudicate dalla medesima clausola o
condizione iniqua apposta al regolamento negoziale.
In altri termini, secondo la menzionata dottrina, i diritti risarcitori a connotazione aggregata sono quelli ad
una contrattazione equa, vulnerati da un’identica condizione o clausola illegittima, anche non predisposta
dall’impresa.
Circa le situazioni soggettive di cui al comma 2, lett.
b), poi, la superfluità del rapporto contrattuale tra consumatore finale e produttore viene interpretata nei termini per cui possono promuovere l’azione di classe non
soltanto i soggetti che abbiano la qualifica di emptores,
ma anche chiunque venga a trovarsi, anche in via occasionale, a contatto col prodotto stesso21.
Relativamente, poi, all’idoneità dell’azione di classe a
riferirsi anche a condotte anticoncorrenziali, ciò muove
dalla necessità di tutelare l’assetto concorrenziale del
mercato non soltanto per via pubblicistica, ma anche
tramite strumenti a carattere privatistico.
Aspetto, questo, che appare maggiormente comprensibile ove si consideri che l’effetto distorsivo della concorrenza è idonea a ledere, oltre agli interessi delle
imprese, anche quelle dei consumatori che, “a valle”,
subiscono gli effetti degli illeciti verificatisi “a monte”
(cioè ab origine, con la condotta anticoncorrenziale) e
Temi Romana
che, dunque, hanno diritto alla restituzione del sovrapprezzo pagato22.
Sul piano generale e conclusivo, comunque, è stato
ritenuto che il rimedio sia stato concepito in riferimento a risarcimenti tutt’affatto omogenei e standardizzabili quanto alla loro monetarizzazione, come è agevole
desumere dal rinvio all’art. 1226 c.c., operato dal
comma 12 dell’art. 140 bis cod. cons.: la tutela risarcitoria collettiva gravita soprattutto in ambito contrattuale e comunque, anche quando lambisce la responsabilità aquiliana, nelle ipotesi tipizzate ivi previste, essa si
ricollega pur sempre alla stipula di un negozio, che rileverà come fatto storico nella prospettazione attorea,
ancorché non sia necessario che un rapporto negoziale
corra direttamente tra i consumatori e l’impresa convenuta; specie a fronte di illeciti anticoncorrenziali, infatti, la condotta dell’impresa convenuta influirà direttamente sulla validità del contratto concluso a valle dal
consumatore o sulla causazione del danno derivante
dalla sua esecuzione.
In sostanza, secondo l’ermeneutica ivi riportata, il contesto che il legislatore sembra avere immaginato come
spazio operativo del rimedio è quello di fasci di microcrediti risarcitori/restitutori spettanti ai singoli quali
vittime di illeciti seriali occasionati da identici rapporti
di consumo di cui essi sono parte e, quindi, di entità
tendenzialmente commisurate al valore del bene o del
servizio richiesto23.
Sul versante ultimo dell’utilità del rimedio giudiziale in
parola, tuttavia, in ambito dottrinale24 è stato individuato quale elemento di dissuasione presente nell’attuale
disciplina legislativa il fatto che l’azione, nella sostanza, possa essere esperita soltanto da soggetti economicamente forti.
Soltanto soggetti che presentino tali requisiti, infatti,
possono farsi carico di oneri economici adeguati a
remunerare professionisti legali e consulenziali di certo
livello, capaci di superare il vaglio di ammissibilità
processualmente imposto dalla norma (comma 6, art.
140 bis, cod. cons.).
Parimenti una certa capacità economica in capo al soggetto proponente dell’azione è de facto imposta dalla
norma al momento in cui si richiede che lo stesso dia
dimostrazione di poter curare adeguatamente gli interessi della classe: requisito, questo, inclusivo della possibilità, in capo all’attore, di dar luogo alla pubblicità
27
Saggi
disposta dal Tribunale per consentire l’adesione degli
appartenenti alla classe nonché della possibilità di raccogliere e gestire le adesioni operate dai soggetti danneggiati.
L’art. 140 bis in parola, al comma 8, poi, stabilisce che
un’eventuale ordinanza di inammissibilità emessa dal
Tribunale, oltre a disporre sulle spese, ponga altresì a
carico del soccombente l’onere di dare adeguata pubblicità al provvedimento stesso.
Una siffatta situazione pare sortire effetti dissuasivi
assai efficaci nei confronti dei consumatori, posto che
questi si guarderanno bene dal proporre un’azione di
classe ove questa non sia assistita da un’efficacia certa
e da una notevole probabilità di successo.
Una prospettiva de iure condendo, dunque, potrebbe
incidere sugli aspetti da ultimo segnalati, prevedendo
un riparto delle spese non afflittivo in capo al consumatore che veda respinte le proprie istanze quando
esse abbiano un certo grado di fondamento ed altresì
disponendo sistemi di pubblicità che – avallati da una
previsione legale in tal senso e dotati di efficiacia
impositiva nei confronti di taluni organi mediatici
oppure basati sull’utilizzo della televisione pubblica –
abbiano una portata lieve o non vessatoria nei confronti del consumatore, sul versante propriamente
economico.
Modifiche siffatte, favorendo l’accesso alla giustizia,
senza meno aumenterebbero il numero delle azioni di
classe effettivamente proposto così mutando l’attuale
trend, caratterizzato da un’esperienza giudiziaria assai
ridotta o limitata25.
adattamenti dovuta a talune peculiarità proprie di quel
sistema che non sempre sono riproducibili nell’ambito
degli altri Paesi (si pensi, esemplificativamente, ai c.d.
punitive damages, tipici degli ordinamenti di common
law e, in particolare, degli Stati Uniti).
Il dato sostanziale dell’azione di classe statunitense, in
particolare, è stato rinvenuto26 nell’unione di una pluralità di consumatori avverso un soggetto professionale,
sovente con l’impulso di grandi studi legali disposti a
sostenere le spese correlate, con la prospettiva di guadagnare una congrua percentuale sul risultato ottenuto
(c.d. patto di quota lite, ormai ammesso anche nel
nostro ordinamento).
L’analisi della class action statunitense, tuttavia, evidenzia un contrasto stridente, si potrebbe dire, rispetto
a taluni principi propri dell’ordinamento italiano: il c.d.
sistema dell’opt-out – in base al quale un membro del
gruppo interessato dalla controversia di classe decide
di rimanere estraneo al relativo contenzioso, consapevole del fatto che l’assenza di una scelta in tal senso lo
renderebbe automaticamente partecipe del relativo
esito giudiziario – collide nettamente coll’assunto per
cui la sentenza produce effetti soltanto nei confronti
delle parti processuali (cfr. art. 2909 c.c.).
Il decisum giudiziale, cioè, nel nostro ordinamento
produce i propri effetti nei confronti delle parti, degli
eredi o degli aventi causa, ma non anche nei confronti
di altri soggetti che, pur partecipi della medesima
situazione sostanziale, siano rimasti estranei al relativo contenzioso.
Tanto ciò è vero che l’azione di classe di cui all’art. 140
bis cod. cons. prevede l’opposto sistema dell’opt-in
ovvero della scelta di prendere parte al processo quale
necessaria condizione affinché la relativa sentenza
estenda i propri effetti ad altri soggetti, diversi da colui
che ha proposto l’azione e dal convenuto.
Altro elemento di differenziazione tra la class action
originale e l’omologo sistema rimediale recentemente
introdotto nel nostro ordinamento attiene alle possibili
pronunce giudiziali cui è possibile pervenire: in particolare, nell’ordinamento statunitense possono essere
emesse sentenze di condanna a danni c.d. punitivi (si
tratta dei già menzionati punitive damages), ossia a
vocazione propriamente sanzionatoria nei confronti del
convenuto.
Pronunce giudiziali di questo tipo, a notevole effetto
6. Cenni di diritto comparato in materia di azione
di classe
Sul crinale comparativo, l’esperienza di maggiore rilievo in materia di azioni di classe si è verificata negli
Stati Uniti, verosimilmente in relazione alla precoce
maturazione industriale ed economica di tale Paese e
del correlato manifestarsi, prima che altrove, di esigenze di tutela consumeristica sorte dalla prassi dei rapporti economici.
La previa realizzazione di una siffatta casistica giudiziaria negli Stati Uniti ha comportato che l’azione di
classe delineatasi nell’ambito di tale ordinamento
assurgesse propriamente a modello od a stereotipo per
gli altri ordinamenti giuridici, pur con la necessità di
28
Temi Romana
Saggi
deterrente o di prevenzione generale nei confronti dei
soggetti professionali – comprensibilmente timorosi di
subire rilevanti disfatte economiche correlate a siffatte
decisioni – non sono riproponibili nel nostro ordinamento ove il risarcimento viene associato non già ad
intenti punitivi, quanto piuttosto ad esigenze di reintegrazione o riparazione della lesione perpetrata (Cass. n.
1183 del 19 gennaio 2007).
Le differenze sopra esposte, per altro, sono state altresì
evidenziate dalla dottrina27.
L’analisi ermeneutica28 ha anche posto in rilievo un’altra differenza rispetto al modello di class action nostrano: il fatto, cioè, che nel sistema di origine i singoli
componenti della classe saranno vincolati in linea di
principio anche dalla transazione, che eventualmente
porrà termine a quel processo.
Una delle problematiche più rilevanti poste nei tempi
recenti dall’operatività della class action negli USA è
proprio connessa alle prospettive di una possibile transazione e all’endemico conflitto di interessi che tende
ad innestarsi, tra avvocati e membri della classe.
Spesso infatti si concretizza l’ipotesi del pool di avvocati che, a un certo punto, avendo già messo sotto pressione l’impresa convenendola in giudizio, pur di realizzare in tempi rapidi il profitto atteso, è disponibile ad
accettare un risarcimento che, per gli stessi finanziatori della class actions, può essere sicuramente appagante, ma che invece è quasi irrisorio rispetto all’ammontare complessivo del pregiudizio sofferto dai vari componenti della classe.
All’atto pratico, poi, innanzi a fattispecie quali quella
descritta, accade frequentemente che, non appena i rappresentati si avvedono che in realtà il pregiudizio da
compensare era molto più elevato, spesso ripartono con
un’altra class action contro il primo pool dei legali che
li ha, in questo modo, non adeguatamente rappresentati.
I casi di azioni seriali, di class actions originatesi in
ragione di una inadeguata difesa nella prima azione di
classe, sono infatti molto frequenti a verificarsi nella
pratica americana.
Una tale eventualità di possibile conflitto di interessi
tra rappresentanti e rappresentati, tuttavia, è scarsamente probabile a verificarsi nella class action all’italiana, in cui la transazione non vincola coloro che non
abbiano dichiarato espressamente di volerne beneficiare (art. 140 bis, 15° comma, cod. cons.).
Temi Romana
7. Le peculiarità processuali dell’azione di classe
Guardando all’articolo 140 bis, cod. cons., emerge ictu
oculi la sussistenza di un dato processuale anomalo o di
certa peculiarità.
La fattispecie, cioè, viene disciplinata sul versante processuale secondo modalità difformi da quelle ordinarie ed
alla stregua di una regolamentazione specificamente prevista per le azioni di classe esercitate dai consumatori.
La peculiarità delle azioni in parola, dunque, è stata tale
da indurre il Legislatore alla formulazione di un apposito processo che adattasse il crinale giurisdizionale
alla dimensione collettiva delle situazioni sostanziali
da tutelare.
In prima approssimazione, è possibile rilevare dati processuali difformi rispetto alla disciplina ordinaria nella
possibilità di adesione dei soggetti interessati senza
ministero di difensore (aspetto, questo, che è però compatibile con la natura di small claims delle situazioni da
tutelare), nella possibilità d’intervento da parte del pubblico ministero, correlata alla dimensione collettiva e
quindi pubblica delle vicende de quibus, nella previsione di una fase preliminare costituita da un vaglio di
ammissibilità, nelle modalità idonee a pubblicizzare il
processo pendente, nell’esclusione della possibilità
d’intervento del terzo ex art. 105 c.p.c. (correlata alle
particolari caratteristiche del processo in parola), nel
potere del giudice di determinare il corso della procedura, nelle peculiari modalità di determinazione del
danno nonché in altre previsioni particolari, proprie
della norma in commento.
Il punto è che l’azione di classe offre una tutela ai consumatori, consentendogli di agire giudizialmente per
situazioni che altrimenti rimarrebbero spesso prive di
un’effettiva tutela; cumula una sommatoria di istanze
individuali, così evitando il pericolo dell’intasamento
degli uffici di giustizia; rende possibili ipotesi di accordo tra le parti nella fase finale della decisione, così consentendo alle imprese di assentire a risarcimenti accettabili piuttosto che esporsi all’aleatorietà di una decisione calata dall’alto ed alla connessa (potenzialmente
letale) imprevedibilità.
Tutto quanto precede, rilevando sul piano sostanziale,
non poteva rimanere privo di effetti sul versante processuale: piuttosto che affidare le situazioni in parola
agli ordinari meccanismi del rito processuale, dunque,
il legislatore ha inteso delineare un modello giudiziale
29
Saggi
menti sopra indicati); trattandosi, cioè, di una fase a
valenza non ordinaria od eccezionale, in quanto normalmente insussistente, pare che essa debba attenersi rigorosamente ai limiti di legge, senza consentire agli organi giudiziari di inoltrarsi in (straordinarie) valutazioni di
ammissibilità non facoltizzate dalla norma.
Ancora appare pertinente alle problematiche in parola
l’esigenza di dare idonea pubblicità all’azione giudiziale ammessa – che la norma ha inteso assicurare adeguatamente – così da consentire l’adesione degli appartenenti alla classe.
In consonanza, poi, con la disciplina peculiare del dato
processuale de quo, non trova applicazione l’istituto
dell’intervento del terzo di cui all’art. 105 c.p.c. (esigenze di intervento sono già soddisfatte dai meccanismi di pubblicità suindicati).
Di certo rilievo, inoltre, appare il potere del Tribunale
di determinare il corso della procedura assicurando, nel
rispetto del contraddittorio, l’equa, efficace e sollecita
gestione del processo: facoltà, questa riconosciuta agli
organi giudicanti che, doppiando previsioni tipiche di
processi a connotazione sommaria od accelerata (si
allude al rito ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. od al rito del
lavoro), pare idonea ad assicurare una tutela idonea –
ed in certa misura rafforzata rispetto a quella ordinaria,
quanto meno sul piano della rapidità dei tempi processuali – alle istanze provenienti dalla classe.
Anche la fase attinente al dato decisionale, infine,
appare caratterizzata da certe peculiarità, come saranno
debitamente evidenziate nelle pagine a seguire.
ad hoc, meglio idoneo alla definizione delle problematiche consumeristiche a dimensione collettiva.
Per tali motivi, esigenze di giustizia hanno reso possibile aderire all’azione di classe anche senza ministero
di difensore, analogamente alle possibilità di ricorso
sussistenti per le piccole controversie civili o tributarie
o per l’opposizione a talune sanzioni amministrative di
ridotto rilievo economico.
Per gli stessi motivi, poi, in conformità alla rilevanza
collettiva – e, dunque, pubblica – delle istanze di classe
la norma ha imposto che l’atto introduttivo del giudizio
fosse notificato anche al pubblico ministero, così facoltizzato ad intervenire nella fase preliminare del giudizio.
Istanze ancora correlate alla peculiarità della situazione
sostanziale di riferimento hanno indotto il Legislatore
all’introduzione di un vaglio preliminare di ammissibilità a valenza plurima, cioè teso alla valutazione di
situazione diverse, quali la patente infondatezza della
domanda, la mancata omogeneità delle situazioni giuridiche di riferimento (coessenziale all’azione di classe),
la sussistenza di conflitti d’interessi o l’idoneità del
promotore a curare l’interesse della classe.
Circa il vaglio di ammissibilità in parola, esso, nell’ambito della prassi giudiziaria, può costituire uno “scoglio” non facilmente superabile, essendo rimesso alla
stringente analisi degli organi giudiziari.
Per altro, la stessa fase preliminare di ammissibilità pare
comunque debba basarsi – pressoché esclusivamente –
sugli elementi di valutazione previsti dalla norma (la
manifesta infondatezza della domanda e gli altri ele-
_________________
1 Sul punto, cfr. F. CARINGELLA - L.
BUFFONI, Manuale di diritto civile, Roma,
Dike, 2010, p. 845 e ss.
2 Cfr. G. ALPA, Il Diritto dei consumatori,
Bari, Laterza, 1995, p. 12.
3 Cfr. L. ROSSI CARLEO, Diritto dei consu-
mi – Soggetti, contratti e rimedi, Torino,
Giappichelli, 2012, p. 18.
4 Cfr. L. ROSSI CARLEO, Diritto dei consumi, cit., p. 19.
5 Cfr. P. BARBIERI, La tutela del consumatore in materia di clausole contrattuali abusi-
30
ve, rinvenibile sul sito www. Nel diritto.it
6 Cfr. F. CARINGELLA - L. BUFFONI,
Manuale di diritto civile, cit., p. 851.
7 Cfr. E. MINERVINI, La tutela amministrativa contro le clausole vessatorie nei contratti del consumatore, in Nuove Leggi Civ.
Temi Romana
Saggi
Comm., 2012, 3, p. 563.
12 Cfr. DINACCI, Diritto dei consumi, cit., p. 233.
cessuali, cit., p. 74.
8 Cfr. L. ROSSI CARLEO, La tutela amministrativa contro le clausole vessatorie, in
Obbl. e Contr., 2012, 7, p. 492.
13 Cfr. S. MICONI, La “class action” nell’ordinamento italiano: sintesi di una trasformazione, in Resp. civ., 2008, 8-9, p. 678.
22 Cass. Sez. Un. 4 febbraio 2005, n. 2207.
9 Così L. ROSSI CARLEO, La tutela aministrativa contro le clausole vessatorie, cit., p. 7 e ss.
14 Cfr. M. ATELLI, Class action/1: profili di
legittimazione ad agire, in Obbl. e Contr.,
2008, 3, p. 79.
10 In particolare, è stato richiamato il testo
del disegno di legge 3058/S/XIV, presentato al Senato il 22.7.2004, poi divenuto
C1495 (2006), di origine interministeriale.
Nella materia de qua, comunque, erano state avanzate diverse proposte di legge tra cui
ricordiamo le seguenti: la n. 1834 di iniziativa del deputato Pedica; la n. 1443 di iniziativa dei deputati Poretti e Capezzone; la
n. 1330 di iniziativa del senatore Fabris; la
proposta di legge di iniziativa dei ministri
Bersani e Mastella; la n. 1662 di iniziativa
del deputato Buemi e altri, la n. 679 di iniziativa del senatore Benvenuto nonché la n.
1289 di iniziativa dei deputati Maran e altri.
11 Cfr. F. TEDIOLI, La class action all’italiana: alcuni spunti critici in attesa del preannunciato intervento di restyling, in Obbl.
e Contr., 2008, 10, p. 831.
Temi Romana
15 Cfr. A. C. DI LANDRO, Interessi dei consumatori e azione di classe, Napoli, E.S.I.,
2012, p. 72.
16 Cfr. DI LANDRO, Interessi dei consumatori e azione di classe, cit., p. 18 e ss.
17 Cfr. DI LANDRO, Interessi dei consumatori e azione di classe, cit., p. 21 e ss.
18 Cfr. DINACCI, Diritto dei consumi, cit., p. 236.
19 Cfr. DI LANDRO, Interessi dei consumatori e azione di classe, cit., p. 88.
20 Cfr. C. CONSOLO - B. ZUFFI, L’azione di
classe ex art. 140 bis codice consumo –
Lineamenti processuali, Padova, CEDAM,
2012, p. 73.
21 Cfr. CONSOLO - ZUFFI, L’azione di classe
ex art. 140 bis cod. cons. – Lineamenti pro-
31
23 Cfr. CONSOLO - ZUFFI, L’azione di classe
ex art. 140 bis cod. cons. – Lineamenti processuali, cit., p. 85.
24 Cfr. DINACCI, Diritto dei consumi, cit., p. 239.
25 Sul punto, cfr. DINACCI, Diritto dei consumi, cit., p. 238, secondo cui “Sebbene l’interesse della dottrina per la nuova disciplina sia vivissimo, e l’attenzione mediatica
sempre alta, le azioni di classe effettivamente proposte avanti ai Tribunali si contano, a
due anni dall’entrata in vigore del novellato art. 140 bis, sulle dita di una mano”.
26 Cfr. CODACONS, Dissanguati? – la guida
pratica per la tutela del consumatore –
Novara, De Agostini, 2013, p. 176.
27 Cfr. I. LUCATI, “Class action” all’italiana nuove forme di tutela per consumatori e
utenti, in Resp. Civ., 2008, 2, p. 188.
28 Cfr. M. SACCHI, Nuova class action: tra
tutela dei diritti soggettivi omogenei ed interessi a valenza collettiva, in www.altalex.it.
Saggi
Criteri d’individuazione del titolare della qualifica
soggettiva nell’ambito delle organizzazioni complesse e
operatività della delega di funzioni, con particolare
riferimento, alla responsabilità di Amministratori e
Sindaci di società
Parte II – Posizione di garanzia e Responsabilità
Francesca Zignani
Avvocato
L
e osservazioni formulate nella Parte I della presente dissertazione consentono di affrontare,
con maggiore consapevolezza, le problematiche
inerenti la posizione di garanzia e la responsabilità
degli amministratori e sindaci di società.
Lo schema posizione di garanzia/responsabilità implica, in ossequio ai principi costituzionali di legalità,
colpevolezza, personalità della responsabilità penale:
i) l’individuazione di una posizione di garanzia in capo
all’organo di controllo e, dunque, la demarcazione di
un obbligo giuridico d’impedimento e dei relativi
poteri impeditivi; ii) la prova del nesso causale tra la
mancata attivazione dei poteri impeditivi e il fatto di
reato; iii) nell’ipotesi di compartecipazione in un reato
doloso, la prova del dolo e, quindi, della rappresentazione e volizione del fatto storico congruente con la
fattispecie di reato.
Si può evidenziare, pertanto, alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale in materia di art. 40 cpv. c.p., che
al fine di perseguire le condotte di amministratori non
operativi e di sindaci è necessaria la precisa rappresentazione dell’evento nella sua portata illecita, e la omissione consapevole nell’impedirlo. Tali soggetti, debbono certamente attivare il loro potere informativo per
attingere notizie utili all’esercizio del loro mandato.
Essi hanno il dovere di richiedere informazioni, quando percepiscano segnali di pericolo o sintomi di patologia nelle operazioni da compiere.
In sintesi, per poter affermare la responsabilità penale
dei soggetti in esame è necessario che vi sia la prova
che gli stessi siano stati debitamente informati, oppure
che vi sia stata la presenza di segnali peculiari in relazione all’evento illecito, nonché l’accertamento del
grado di anormalità di questi sintomi1.
In effetti, la riforma della disciplina delle società, portata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, ha certamente modificato il quadro normativo dei doveri di chi è preposto alla
gestione della società ed ha compiutamente regolamentato la responsabilità dell’amministratore destinatario di delega. La nuova disciplina ha delineato, inoltre, il criterio direttivo “dell’agire informato”, che
sostiene il mandato gestorio (art. 2381 c.c., comma 5)
e, correlativamente, l’obbligo di ragguaglio informativo sia a carico del presidente del consiglio di amministrazione (art. 2381 c.c., comma 1: “provvede affinché
adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine
del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri”), sia in
capo agli amministratori delegati, i quali, con prestabilita periodicità, devono fornire adeguata notizia “sul
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate” (art. 2381
c.c., comma 5).
In tal modo, la riforma ha alleggerito gli oneri e le
responsabilità degli amministratori privi di deleghe,
poiché l’art. 2392 c.c., comma 1 prevede che sono
responsabili verso la società nei limiti delle attribuzioni proprie. È stato rimosso il generale “obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione” (già con32
Temi Romana
Saggi
templato dall’art. 2392 c.c., comma 2), sostituendolo
con l’onere di “agire informato”, atteso il potere2 di
richiedere informazioni (senza che ciò assegni anche
un’autonoma potestà di indagine). La modifica dell’art. 2392 c.c. è stata introdotta nell’ordinamento con
immediata vigenza, attesa la disposizione di cui all’art.
209 disp. trans. codice civile.
Per ciò che interessa il settore penale, la suesposta premessa riconfigura la “posizione di garanzia” del consigliere non operativo, postoché l’obbligo di impedire
l’evento, disciplinato quale tramite giuridico causale,
dall’art. 40 c.p., comma 2, si parametra su una fonte
normativa che costituisce il dovere di intervento.
Dunque, anche il ruolo penale dell’amministratore
privo di delega risulta modificato.
A chiarimento di quanto sinora esposto, occorre evidenziare il limite operativo dell’art. 40 c.p., comma 2,
quando correlato ad incriminazioni connotate da
volontarietà, onde evitare di sovrapporlo o, peggio,
sostituirlo con responsabilità di natura colposa, incompatibile con la lettera delle fattispecie incriminatici,
che configurando comportamenti modulati su consapevolezza dolosa, non consentono di addebitare all’autore di volontaria omissione, con argomentazione propria della colpa (e cioè con rimprovero di imperizia, o
di negligenza, o di imprudenza), l’evento che egli ha
l’obbligo giuridico di impedire.
La Riforma ha operato in questa direzione, poiché la
relazione accompagnatrice del testo legislativo accenna alla necessità di evitare ingiustificate letture estensive della responsabilità degli amministratori.
In sede di legittimità è stato posto il quesito se ed in
quali termini possa invocarsi la disciplina dettata dall’art. 2 c.p., in seno al combinato disposto delle norme
penal-societarie e dell’art. 40 c.p., comma 2, tenuto
conto della obiettiva restrizione della responsabilità
apportata nel contesto del codice civile e della più
favorevole condizione prevista per gli amministratori
privi di delega.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 4 maggio
2007, n. 23838, precisa che l’analisi del profilo della
responsabilità, discendente dall’art. 40 c.p., comma 2
per condotte connotate da volontarietà, e la configurazione della “posizione di garanzia”, che qualifica il
ruolo dell’amministratore, evidenzia due momenti, tra
loro complementari, ma idealmente distinti ed entram-
Temi Romana
bi essenziali. Il primo postula la rappresentazione dell’evento, nella sua portata illecita, il secondo – discendente da obbligo giuridico – l’omissione consapevole
nell’impedirlo.
Entrambi questi due presupposti debbono ricorrere nel
meccanismo tratteggiato dal nesso di causalità giuridico. Non è responsabile, quindi, chi non abbia avuto
rappresentazione del fatto pregiudizievole (sì che
l’omissione dell’azione impeditiva non risulti connotata da consapevolezza).
Ovviamente l’evento può essere oggetto di rappresentazione anche eventuale. Pertanto, chi consapevolmente si sia sottratto nell’esercitare i poteri-doveri di controllo, attribuiti dalla legge, accettando il rischio, presente nella sua rappresentazione, di eventi illeciti
discendenti dalla sua inerzia può risponderne ai sensi
dell’art. 40 c.p., comma 2.
E, tuttavia, per il Giudice di legittimità non può esservi equiparazione – pur in questa dilatazione consentita
dalla forma eventuale del dolo – tra “conoscenza” e
“conoscibilità” dell’evento che si deve impedire, attenendo la prima, all’area della fattispecie volontaria, e
la seconda, quale violazione ai doveri di diligenza,
all’area della colpa.
Riportando l’assunto nel contesto della responsabilità
dell’amministratore non operativo, può evidenziarsi
che l’effettiva rilevanza derivante dalla disciplina di
cui all’art. 2 c.p. risulta molto contenuta.
L’amministratore (ed è indifferente che egli sia o meno
dotato di delega) è penalmente responsabile (ex art. 40
c.p., comma 2) per la commissione dell’evento che
ebbe a conoscere (anche se al di fuori dei prestabiliti
mezzi informativi) e che, pur potendo, non scongiurò.
Altro discorso attiene alla conoscibilità dell’evento e,
quindi, per restare nell’area del fatto volontario, situazione desunta dalla percezione dei segnali di pericolo
o di sintomi di patologia insiti nell’operazione coinvolgente la società, evincibili dagli atti sottoposti alla
sua attenzione.
Situazioni che possono – pertanto – mantenere rilievo
penale nella prospettiva del dolo (oltre che, evidentemente, per la colpa). Ma, pur accogliendo in via astratta tale prospettazione, il Collegio osserva che in capo
all’organo di accusa grava la dimostrazione della presenza di segnali perspicui e peculiari, in relazione
all’evento illecito, nonché l’accertamento del grado di
33
Saggi
anormalità di questi sintomi. E l’onere, nel caso di specie, non è stato ritenuto assolto dal PM ricorrente.
Ritiene la Corte, inoltre, che l’addurre a sostegno della
tesi d’accusa la “consapevole approvazione di ogni
iniziativa della dirigenza” è del tutto logicamente
inconcludente: se consapevole fu il voto favorevole,
tanto non dimostra che esso fu correttamente ed esaurientemente “informato” sull’effettiva sostanza della
decisione, sì che discenda seria attestazione di una
adesione volontaria all’opzione illecita o dannosa per
la società.
Né il fatto che, poco tempo dopo la approvazione dei
bilanci incriminati, vi siano state sostanziose rettifiche
illumina sul reale stato conoscitivo dei prevenuti
all’atto della lettura delle relazioni loro rimesse. Né,
ancora, la riduzione del consiglio di amministratore a
“ratificatore” di decisioni “adottate altrove” risulta
peculiare e congruente rispetto alla esigenza di puntualità dimostrativa di cui si è detto.
Tutto ciò, ritiene il Supremo consesso, per tacere della
difficile compatibilità del dolo eventuale con fattispecie non soltanto marcatamente fraudolente (art. 2638
c.c., comma 1), ma anche contrassegnate da specificità del dolo, da espressa connotazione di consapevolezza (art. 2638 c.c., comma 2, tipica delle condotte di
omessa informazione) e, financo, da intenzionalità di
inganno (artt. 2621 e 2622 c.c.).
Non diversamente si deve concludere per la posizione
dei sindaci: per essi la riforma non ha disposto mutamento quanto all’obbligo di vigilanza, essendo rimasto
inalterato il paradigma della responsabilità dettato dall’art. 2407 c.c., comma 2. Tuttavia, l’espresso e diretto
obbligo di vigilanza sulla gestione degli amministratori estende molto il grado di responsabilità.
La giurisprudenza di legittimità ha ravvisato il discrimine, tra condotte esenti e quelle pregne di responsabilità, nel grado di conoscenza dell’atto antidoveroso
degli amministratori, con ciò applicando alla figura del
sindaco, il medesimo vaglio giuridico sin qui svolto ed
addebitandogli – ai sensi dell’art. 40 c.c., comma 2 –
la colpevole inerzia, censurabile in quanto pienamente
conscia dell’evento da evitare.
Sulla scorta di tali principi, il Supremo Collegio ha
affermato che la riforma della disciplina delle società
ha alleggerito gli oneri degli amministratori privi di
deleghe e comportato un’obiettiva restrizione della
loro responsabilità. L’amministratore non esecutivo
risponde di omesso impedimento di un reato doloso
posto in essere agli amministratori delegati, purché si
sia rappresentato l’evento, nella sua portata illecita, e
abbia consapevolmente omesso di impedirlo.
Non vi può essere equiparazione tra “conoscenza” e
“conoscibilità” dell’evento che si deve impedire, attenendo la prima, alla sfera della fattispecie volontaria e
la seconda, quale violazione ai doveri di diligenza, a
quella della colpa. La responsabilità penale dell’amministratore non esecutivo postula la dimostrazione di un
effettivo ed efficace ragguaglio, circa l’evento oggetto
del doveroso impedimento.
In relazione all’arresto sopra citato la dottrina non ha
mancato di evidenziare l’omesso approfondimento, da
parte della Corte di legittimità, in ordine ai poteri dell’amministratore delegato. L’indagine assume, in effetti, rilievo decisivo al fine di determinare se l’inerzia
del delegante sia stata condizione necessaria del reato
posto in essere dal delegato: un giudizio contro-fattuale compiuto, dunque, immaginando presente – nel caso
di specie – l’azione doverosa e, quindi, l’esercizio da
parte del delegante degli eventuali poteri impeditivi a
lui attribuiti dalla legge, e realmente esercitabili nella
vicenda concreta.
In estrema sintesi, è opportuno ricordare che la riforma
civilistica non ha certo enucleato autonomi poteri
impeditivi, pur avendo espressamente introdotto, con
l’art. 2388 c.c., l’impugnativa, da parte del consigliere
assente o dissenziente, della delibera consiliare che sia
contraria alla legge o allo statuto.
Tale rimedio civilistico si aggiunge alle altre azioni
speciali, già espressamente riconosciute dalla legge ed,
in particolare, all’impugnativa ex art. 2391 c.c. per i
casi di delibere consiliari che violino la disciplina sul
conflitto d’interessi e a quelle ulteriori azioni, già individuate (da una parte della dottrina) per via interpretativa, come l’azione di accertamento relativa ai vizi del
bilancio consolidato, approvato con una delibera consiliare (argomentando ex art. 157 t.u.f.).
Gli amministratori, quando legittimati, possono e
devono impugnare le delibere consiliari invalide, al
fine di impedire il compimento di fattispecie di reato.
La riforma del diritto societario ha drasticamente limitato, tuttavia, il ricorso al procedimento di cui all’art.
2409 c.c., determinando così una contrazione dei pote-
34
Temi Romana
Saggi
ne necessaria del reato, posto in essere dal delegato.
Il legislatore ha reso, quindi, penalmente lecite alcune
particolari condotte omissive sino a quel momento
ritenute illecite, con tutte le relative conseguenze in
relazione alla questione della successione di leggi, non
compiutamente affrontato dalla Suprema Corte.
Il mutamento delle norme extrapenali, che concorrono
a descrivere la posizione di garanzia dei deleganti
segue, dunque, la disciplina dell’art. 2 c.p.. In particolare, nel campo delle posizioni di garanzia dei consiglieri deleganti, la riforma del diritto societario ha dato
vita ad una “restrizione dell’area applicativa di una
incriminazione preesistente” e, quindi, ad una “abolitio criminis parziale”, che risulta palese da una analisi
dei rapporti logico-strutturali tra le diverse fattispecie
(ante e post riforma), emergenti dalla combinazione
dell’art. 40 cpv. con gli artt. 2381 e 2392 c.c..
Resta punibile, nei processi in corso, la realizzazione
di fatti di reato, che il garante avrebbe dovuto prevenire, in quanto avrebbe potuto attivare rimedi astrattamente impeditivi, di cui disponeva allora come ancora
oggi. Mentre fuoriesce dall’aerea dell’illiceità penale,
il mancato attivarsi con poteri che il garante, a seguito
della riforma del diritto societario, non può più utilmente esercitare.
Come più volte sottolineato dalla Corte costituzionale,
il principio di retroattività della norma più favorevole,
trova il suo fondamento costituzionale nel principio di
eguaglianza, che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti,
a prescindere dalla circostanza che essi siano stati
commessi prima o dopo l’entrata in vigore della
norma, che ha disposto l’abolitio criminis o la modifica mitigatrice.
Se la valutazione del legislatore in ordine al disvalore
del fatto muta – nel senso di ritenere che quel presidio
non sia più necessario od opportuno o che sia sufficiente un presidio meno energico – tale mutamento
deve riverberarsi, quindi, a vantaggio anche di coloro
che abbiano posto in essere il fatto in un momento
anteriore.
Sennonché, il fondamentale problema – sul quale non
vi è una comune posizione in dottrina – resta la nozione di potere impeditivo.
Nell’ambito dei controlli societari, il potere impeditivo – ai fini dell’individuazione della posizione di
ri e doveri degli amministratori non esecutivi: da un
lato, escludendo il pubblico ministero dalla cerchia dei
soggetti legittimati ad attivare il procedimento, quando
si tratti di società che non fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio; dall’altro, circoscrivendo il controllo giudiziario ai soli casi di gravi irregolarità “che possono arrecare un danno alla società o a una o più
società controllate”.
Com’è stato evidenziato in dottrina trattasi di “un’arma decisamente spuntata”: il singolo amministratore
potrà attivare il pubblico ministero, solo nel caso di
società con azioni quotate o con azioni diffuse in misura rilevante, e solo nel caso di irregolarità di gestione
capaci di produrre un danno alla società.
Tali modifiche incidono non poco sulla definizione
della sfera dei poteri e, quindi, dei doveri dei consiglieri deleganti: si pensi a tutti quei casi in cui la segnalazione al pubblico ministero costituisce “la sola strada
percorribile” – cioè astrattamente dotata di una attitudine preventiva – nel caso in cui manchi “una delibera suscettibile di impugnazione” oppure occorre “bloccare l’operato di organi delegati”.
Sicché il limite del potere segna i confini invalicabili
della garanzia esigibile: il delegante è obbligato a fare
ciò che può fare.
Oltre alle iniziative appena cennate, il consigliere
senza delega può (e quindi deve) spendersi in consiglio
per impedire l’adozione di una delibera che possa integrare una fattispecie di reato, far annotare il proprio
dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni
del consiglio e darne immediata notizia al presidente
del collegio sindacale, chiedere al presidente del consiglio d’amministrazione la convocazione dello stesso.
Ma come appare ben evidente l’amministratore, in
generale, non può direttamente impedire il compimento di fatti criminosi poiché non ha il potere di adottare, individualmente, provvedimenti direttamente impeditivi. Il consigliere non esecutivo, può innescare il
meccanismo in astratto idoneo, insieme al verificarsi
di altre condizioni, ad impedire la realizzazione di un
fatto criminoso; ma l’effettivo impedimento dell’evento, presuppone sempre l’opera almeno di un soggetto
terzo: il pubblico ministero, il presidente del consiglio,
il presidente del collegio sindacale, il giudice, etc.
Da qui le straordinarie difficoltà di provare che la condotta omissiva del delegante rappresenti una condizio-
Temi Romana
35
Saggi
carotta semplice di cui alla L. Fall. art. 217, comma 2,
è un reato di pericolo, punibile anche a titolo di colpa
e, pertanto, è irrilevante che l’agente si sia mantenuto
estraneo all’amministrazione dell’azienda, in quanto è
obbligato, in ogni caso, ad esercitare un controllo sulla
regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.
Così inquadrata la fattispecie, ben si comprende come
nessuna efficace incidenza hanno esplicato le deduzioni difensive incentrate sulla acclarata (e riconosciuta
dagli stessi giudici del merito) completa estraneità del
ricorrente alla gestione dell’azienda, riconducibile,
invece, esclusivamente all’amministratore di fatto,
nonché sulla copiosa documentazione dimostrativa di
tale estraneità, e sulle risultanze emerse dalle altre
decisioni giudiziarie, attestanti che, uno dei due imputati fu vittima di condotte illecite altrui. Come pure
inconferente è stato il riferimento alla giurisprudenza
di legittimità formatasi in tema di amministratore
meramente formale.
Per la Corte, infatti, la lettura della L. Fall. art. 216,
comma 1, n. 2, rende chiaro che il dolo specifico è
relativo all’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, mentre la seconda ipotesi, della quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile, è caratterizzata dalla
tenuta delle scritture contabili, tali da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento
degli affari, ed e questo lo scopo cui deve tendere
l’agente e, quindi, l’elemento soggettivo del reato.
Occorre, in definitiva, l’intenzione di impedire la
conoscenza relativa al patrimonio o al movimento
degli affari, ma non occorre, invece, l’intenzione di
recare pregiudizio ai creditori e neppure la rappresentazione di questo pregiudizio.
Discende che essendosi accertato dai giudici del merito che lo scopo dell’omessa tenuta della contabilità
interna è stato proprio quello di impedire la conoscenza relativa al patrimonio o al movimento degli affari,
non vi è possibilità alcuna per il Giudicante, diversamente dal dedotto della difesa, di configurare tale fatto
omissivo come integrante gli estremi della bancarotta
semplice documentale, di cui alla L. Fall., art. 217,
comma 2, e non quelli della bancarotta fraudolenta
documentale.
Il che ha consentito alla Corte di affermare che integra
il reato di bancarotta semplice (art. 217 L. Fall.) l’amministratore che, ancorché estraneo alla gestione del-
garanzia volta all’impedimento di un illecito di terzi –
è quel potere giuridico che può astrattamente (secondo un modello di causalità generale) impedire3 il verificarsi dell’illecito da parte del soggetto sottoposto al
controllo.
Il primo dato da considerare è che, anche nella riforma
delle società, il carattere collegiale del consiglio d’amministrazione impedisce l’adozione d’iniziative individuali. Il giudice penale deve considerare, invece, nella
ricostruzione della posizione di garanzia, i soli poteri
individuali astrattamente impeditivi.
Tra questi vi è, innanzitutto, l’impugnazione della delibera consiliare (art. 2388 c.c.). Ma tale impugnativa
non assume, neanche astrattamente, natura impeditiva
quando il reato si è già perfezionato, con l’assunzione
della delibera.
In altri termini, la sua potenziale efficacia è limitata ai
casi in cui la delibera non sia self executing, cioè,
costituisca solo un passaggio essenziale, di un più
complesso iter criminoso, diretto a realizzarsi compiutamente in un momento successivo: in questo caso,
infatti, l’impugnazione della delibera può operare ex
ante e la declaratoria di invalidità, o addirittura un
provvedimento cautelare, possono intervenire prima
del compimento dell’atto.
Ecco spiegata la ragione per cui, nella prassi, il problema cruciale è quello della verifica causale.
L’esistenza di un obbligo giuridico d’impedimento e
dei relativi poteri impeditivi è, infatti, un presupposto
indispensabile, ma non sufficiente, per la definitiva
affermazione di responsabilità del garante: nel processo rimane da affrontare4, infatti, il problema della
prova e, quindi, della verifica, ex post, che l’esercizio
di quel potere astrattamente impeditivo avrebbe effettivamente neutralizzato, in quel particolare caso, il
programma criminoso.
In assenza di questo ineludibile passaggio, si configura il rischio di un addebito di responsabilità per fatto
altrui. E, al fine di rendere inequivocabile il proprio
pensiero, la Suprema Corte cita espressamente le Sez.
Unite nella c.d. sentenza Franzese del 2002.
In tema di responsabilità omissiva degli amministratori, nell’alveo di reati fallimentari, deve darsi menzione,
infine, di un’altra importante decisione del Giudice di
legittimità5.
Nella sentenza, il Collegio osserva che il reato di ban-
36
Temi Romana
Saggi
l’azienda – esclusivamente riconducibile all’amministratore di fatto – abbia omesso, anche per colpa, di
esercitare il controllo sulla regolare tenuta dei libri e
delle scritture contabili, poiché l’accettazione della
carica di amministratore, anche quando si tratti di
mero prestanome, comporta l’assunzione dei doveri di
vigilanza e di controllo di cui all’art. 2932 c.c..
Il principio affermato in sede di legittimità ha offerto
ad una parte della dottrina, l’occasione di svolgere
alcune considerazioni e censure critiche. In effetti, la
pronuncia in esame rappresenta certamente un novum
di particolare interesse, meritando peculiare attenzione
per una variegata serie di motivi.
Il primo attiene al fondamento giuridico della responsabilità penale, posto che, nell’individuare i doveri
gravanti sull’organo gestorio, la Corte – per così dire –
relega qualsiasi rinvio alle sopra citate norme extrapenali, che concorrono a descrivere la posizione di
garanzia degli amministratori, e sposa la teoria secondo la quale il fulcro dell’incriminazione risiede semplicemente nella mera assunzione della carica.
In altre parole, nel percorso logico seguito dalla
Cassazione, gli (asseriti meri) obblighi di vigilanza e
di controllo (convertiti in veri e propri obblighi impeditivi) acquisterebbero completa operatività già al
momento dell’accettazione dell’incarico, sicché – pur
in assenza di un corrispondente approfondimento probatorio/argomentativo in merito all’effettiva titolarità
di poteri d’intervento e, sebbene, difetti ogni indagine
sulle concrete mansioni svolte dal soggetto nella realtà aziendale – l’amministratore assumerebbe il ruolo di
“garante” della salvaguardia degli interessi protetti e,
di conseguenza, risponderebbe anche dei risultati connessi al suo mancato attivarsi.
Sono evidenti i profili di complessità di un simile
ragionamento. Anzitutto un’eccessiva dilatazione della
responsabilità per non impedimento, fondata sul solo
criterio formale, senza che a ciò si accompagni una
benché minima verifica del limite decisivo della
garanzia esigibile da parte del soggetto coinvolto. In
secondo luogo, un obbligo impeditivo avulso dalla
“posizione fattuale di garanzia” del bene giuridico
tutelato, ed ancorato ad un momento, quello di assunzione della carica, precedente rispetto alla reale configurazione, in capo all’amministratore, dei poteri idonei a scongiurare l’evento.
Temi Romana
Ciò non solo comporta un’aprioristica ed ingiustificata responsabilità “anomala” o di pura “posizione” a
carico dell’organo di gestione, ma ancor di più equivale a legittimare un’estensione esagerata del sistema
delle incriminazioni per omesso impedimento, violando – tra l’altro – il fondamentale criterio della corrispondenza, ai fini della costruzione della posizione di
garanzia penalmente rilevante, tra poteri e doveri
impeditivi.
Le conseguenze di questa impostazione, emergono in
tutta la loro stridente gravità ove solo si consideri che,
nel caso sottoposto all’attenzione del supremo
Collegio, il soggetto interessato è un semplice “prestanome” ovverosia un individuo generalmente estraneo
alla gestione dell’azienda ed, in tal misura, tendenzialmente sprovvisto di quei requisiti necessari per essere
considerato, anche solo astrattamente, titolare di un
potere giuridico a contenuto impeditivo del comportamento criminoso da altri tenuto.
Da qui le considerevoli difficoltà per ricondurre l’intera interpretazione offerta dalla Corte nell’alveo della
responsabilità penale personale.
In altri termini, continua a non comprendersi come il
mero richiamo a dati normativi extrapenali possa, di
per sé, ritenersi sufficiente per il sorgere di autonomi e
distinti obblighi d’impedimento dell’evento lesivo, e
ciò specialmente a seguito delle modifiche di cui alla
riforma del diritto societario del 2003, che ha enormemente attenuato i poteri-doveri degli amministratori
senza delega.
Sembra superfluo rammentare, anzitutto, che anche ai
fini della configurabilità del delitto colposo, il disposto
normativo obbliga l’interprete ad accertare, oltre il
ragionevole dubbio, se la condotta del soggetto agente
presenti tutti gli elementi strutturali previsti dalla
legge, secondo cui il delitto è colposo per violazione
non voluta, e sia pure prevista, di regole a contenuto
precauzionale scritte o non scritte/sociali.
Va da sé che non possa parlarsi di colpa se non può
essere mosso all’agente il rimprovero di avere trascurato le precauzioni cui era tenuto, o qualora, seppur in
presenza di regole cautelari, l’evento non era prevedibile o evitabile dall’agente.
Approfondendo l’indagine si evince che la Cassazione
ha omesso la verifica sia dell’effettiva prevedibilità/evitabilità dell’evento, sia della sussistenza di obiet-
37
Saggi
tive regole cautelari di condotta cui l’agente è tenuto
all’automatica osservanza, finendo in tal modo per
individuare il nucleo centrale dell’imputazione colposa a carico del prestanome, non nella violazione di predeterminati doveri imposti dalla normativa vigente,
quanto, piuttosto, nella mera acquiescenza alla carica.
Ragionando in tali termini, non pare azzardato sostenere che l’agente risponde dell’evento non voluto,
indipendentemente da ogni indagine circa il suo atteggiamento psichico, nei confronti dell’evento medesimo, e ciò, sulla base della sola accettazione del ruolo
di amministratore e dei doveri che la qualifica astrattamente comporta. Il che implica un giudizio d’inaccettabile astrattizzazione dei criteri d’imputazione per
colpa, che prescindono da ogni profilo di concretizzazione del rimprovero rispetto all’evento hic et nunc
verificatosi.
Alla luce delle osservazioni svolte dalla dottrina,
l’orientamento giurisprudenziale in esame sembrerebbe prestare il fianco ad un duplice ordine di censure.
Anzitutto una così eccessiva dilatazione della funzione
di garanzia conferita ai membri dell’organo di amministrazione – i quali, sembrano dover, sempre e
comunque, rispondere penalmente del reato da altri
commesso, a prescindere dalla loro effettiva partecipazione causale e soggettiva al fatto lesivo – pare il frutto di una contingente giustizia penale che opta per un
sicuro e rapido verdetto di condanna, piuttosto che,
assicurare la fedele applicazione dei principi propri di
un sistema penale autenticamente garantito.
D’altra parte, anche la motivazione offerta dai giudici nella sentenza in esame sottolinea l’esigenza di salvaguardare un maggior rigore in termini di configurabilità della posizione di garanzia dei soggetti obbligati, non potendo non stupire la scelta di considerare
sic et simpliciter ascrivibile il reato di bancarotta
semplice documentale al prestanome, sul mero rilievo della sua (presunta) consapevole acquisizione del
ruolo gestorio.
Proprio l’assunto dell’estraneità alla gestione dell’azienda dovrebbe di fatto comportare una più cogente verifica, idonea ad accertare la reale possibilità di
intervento da parte del prestanome, il quale ben
potrebbe risultare, nella singola vicenda concreta, del
tutto sprovvisto di un concreto ed effettivo ‘margine di
manovra’ ai fini dell’impedibilità dell’evento.
_________________
1 Cass. Pen., Sez. V, 4 maggio 2007, n.
23838 del 2007.
2 Ma che si qualifica come doveroso nell’ottica dell’indicazione normativa sulla
modalità di gestione informata.
3 Agendo su una o più fasi del processo di
4 Oltre, ovviamente, alla questione della
dimostrazione del dolo.
realizzazione del reato.
5 Cass. Pen., Sez. V, 23 settembre 2009, n.
31885.
38
Temi Romana
Saggi
Colpevole!... al 50%.
Ovvero quando le perizie danno i numeri
Marco Zonaro
Esperto in informatica forense e sistemi d'intercettazione, iscritto nell’Albo dei Periti del Tribunale Penale di Roma
V
cere, non lo farà ma sarà molto più facile che egli
scommetta se gli dite che con la medesima probabilità
ne può perdere 100 ma ne può vincere 250. La percentuale è ingannevole e viene utilizzata sovente per illudere, soprattutto all’interno di spot pubblicitari. Se vi
dicessero di scegliere tra uno yogurt magro al 90% e
uno grasso al 10% probabilmente scegliereste quello
magro.
Vorrei rifarmi alla nota barzelletta del tizio che pretendeva di portare con sé in aereo una bomba perché era
nulla la probabilità che su un aereo potessero esserci
due bombe per prendere in esame quanto asserito in un
bollettino di una nota Carta di Credito che, in merito
alla sicurezza delle transazioni in internet, asseriva che
il 99% delle stesse andava a buon fine. Una percentuale di 99 su 100 dovrebbe rassicurarci assai sull’utilizzo
di tale sistema di pagamento attraverso la rete Internet,
ma se pensiamo che utilizzando la carta una volta alla
settimana per un anno la probabilità che almeno una
transazione abbia esito negativo è di circa il 41%, non
c’è da stare allegri.
Prendi un matematico statistico, mettilo con la testa in
un forno e con i piedi in un congelatore e poi chiedigli:
“come ti senti?” e ti risponderà: “mediamente bene!”. È
una battuta che circola al pari di quelle su Architetti e
Ingegneri, che si prendono in giro vicendevolmente,
eppure rende l’idea di come coi numeri, ma soprattutto
con le percentuali statistiche, non si debba scherzare, in
particolar modo nelle aule di Giustizia.
È sufficiente quindi la presenza di un nesso di causalità per poter esprimere un giudizio su un determinato
evento? La sentenza Daubert (Corte Suprema degli
Stati Uniti, 1993) nega questo assunto. L’ipotesi accusatoria sosteneva che un farmaco antidolorifico prodotto dalla casa farmaceutica Merrel provocasse malformazioni nel feto di donne che lo assumessero in stato di
gravidanza. La perizia farmacologica individuò nessi di
causalità tra alcuni principi attivi del farmaco e le malformazioni fetali e la Merrel venne condannata a risarcire la Parte Offesa. Successivamente la Difesa dimostrò che su 10.000 donne che avevano assunto il farma-
olendo fare una valutazione nemmeno troppo
spicciola, si può affermare che ben pochi sono i
procedimenti penali di una certa rilevanza per i
quali, in sede d’indagini, la Polizia Giudiziaria non
abbia utilizzato tecnologie elettroniche o informatiche
a scopo investigativo o non si sia affidata a qualche
metodologia scientifica forense per la ricerca di prove
o per l’analisi di evidenze probatorie. Le scienze forensi hanno subìto negli ultimi 15 anni una spinta accelerativa di notevole intensità, promossa innanzitutto dal
progresso tecnologico e dagli investimenti sulla ricerca
in campo informatico.
Lo sviluppo di microprocessori sempre più veloci, di
memorie sempre più capienti e più piccole, di metodologie d’analisi sempre più precise, ha consentito l’implementazione di potenti strumenti d’indagine a disposizione degli investigatori.
Senza entrare nel merito delle singole branche della criminalistica e discutere in chiave critica queste metodologie che possono offrire ottimi risultati solo se correttamente impiegate, vorrei disaminare gli esiti che esse
producono, o meglio, come tali risultati vengano proposti ed utilizzati in sede dibattimentale.
Vi sono casi, infatti, in cui le conclusioni di una perizia
non sono trancianti e producono più perplessità che
benefici; il più delle volte ciò accade perché esse sono
mal esposte o meglio mal interpretate. Non è difficile
che nel corso dell’escussione di un Perito egli si senta
rivolgere la classica domanda: “con che probabilità?”,
ed è altrettanto facile che la risposta faccia più danni di
uno tsunami se il Perito non ha ben chiaro il concetto
statistico di “probabilità”.
Questo termine è utilizzato con troppa facilità nelle
aule di Giustizia, nella convinzione, errata, che l’indicazione di un valore percentuale possa sgombrare
dubbi e risolvere quesiti. Purtroppo dietro al concetto
di probabilità si nascondono un’infinità d’insidie e chi
non conosce almeno i fondamenti della statistica non è
in grado di coglierle e valutarle.
È quasi sicuro che, se proponete a qualcuno di scommettere 100 Euro dandogli il 50% di probabilità di vin-
Temi Romana
39
Saggi
anonima appartenga all’imputato, il Perito se vorrà
rispondere in tale termine dovrà farlo applicando le
leggi della matematica e non inventando un numero
sulla base di un proprio mero convincimento.
Nel corso del convegno tenutosi a Roma e intitolato
“Maresciallo mi sente?”, il Ten. Col. Davide Zavattaro
del R.I.S. illustrò un’interessante disamina raccogliendo in tre grandi categorie i Periti che di volta in volta si
avvicendano nelle aule di Giustizia.
• Il Duro: secondo il quale esiste la certezza e la
difende a tutti i costi nella consapevolezza di rivestire un ruolo di longa mano del Giudice e nell’inconsapevolezza (forse) di essere un pochino ignorante.
• Il Diplomatico: tutto è possibile e negoziabile,
l’unica certezza che ha è che quando piacerà a Dio
egli ritornerà ad essere polvere, per il resto la certezza non è di questo mondo.
• Lo Scientifico: quantifica la delimitazione del
campo d’indeterminazione; se ti dico che il reperto
A è compatibile con l’elemento B in comparazione,
ti quantifico di quanto sono compatibili, ti dico qual
è il margine d’errore che la metodologia introduce e
ti dico anche qual è la possibilità che esistano altri
elementi in comparazione che soddisfino quei
requisiti di compatibilità.
E questo è l’approccio più corretto.
Chi mi conosce sa che sono un’amante degli esempi e
quindi eccone uno: supponiamo che da un’analisi fonica per il riconoscimento della voce emerga che la voce
anonima e quella dell’imputato presentino molteplici
caratteri timbrici, prosodici, sociolinguistici e fonetici
simili. Queste somiglianze sono accertate mediante
un’analisi uditivo-percettiva e quindi senza ausilio di
strumenti di misura. L’esperto mette a disposizione
della Giustizia il proprio orecchio, affetto o meno da
problemi o patologie che ne limitino le prestazioni.
Come può, quindi, egli esprimere un giudizio in termini di percentuale di somiglianza se l’analisi compiuta
fornisce solo “sensazioni” e non dati oggettivi?
Poniamo ora che oltre all’esame uditivo-percettivo egli
possa anche eseguire un analisi parametrica misurando
il valore delle frequenze formanti dei foni vocalici. Una
volta ottenuti questi “numeri” come farà il Perito a tradurli in un valore percentuale che soddisfi la richiesta
del Giudice ovvero “con che probabilità le due voci
appartengono allo stesso parlatore?”.
Eh si, perché il Giudice con questa domanda vorrebbe
sapere con quale probabilità l’imputato è colpevole, ma
questa è una risposta che il Perito non può fornire. E
allora come si fa? Concettualmente è piuttosto sempli-
co in gravidanza l’incidenza delle malformazioni era
inferiore alla media nazionale; in pratica il farmaco
incriminato anziché provocare malformazioni, secondo
la casistica utilizzata, sembrava avere un effetto protettivo. Nacque da ciò un dibattito accesissimo sulla
valenza scientifica delle perizie tecniche che si risolse
modificando i criteri per l’ammissione della prova
scientifica in aula, ovvero essa doveva soddisfare alcuni precisi requisiti:
• la verifica della metodologia utilizzata da parte di
esperti riconosciuti;
• la falsificabilità dell’esito della prova: se da A si
deduce B, e se B è falso, allora è falso anche A. Se
una teoria non possiede questa proprietà, è impossibile controllare la validità del suo contenuto informativo relativamente alla realtà che essa presume di
descrivere;
• la produzione di un error-rate: ovvero dev’essere
stimato l’errore che il sistema può commettere nell’affermare quanto in esito dell’indagine;
• la metodologia dev’essere accettata dalla comunità
scientifica.
Questo è quanto dovrebbe avvenire anche in ambito
giudiziario italiano: il Giudice dovrebbe pretendere dal
suo Perito il soddisfacimento di questi requisiti per
poter produrre una relazione di perizia. Eppure sono
ancora in molti i Periti che rispondono alla domanda:
“con che probabilità?” fornendo numeri quasi a casaccio o in relazione ad una stima del tutto soggettiva ossia
non suffragata da alcun elemento matematico.
Fino alla metà del secolo scorso era radicata l’idea che
la matematica fosse il paradigma della precisione e
soprattutto dell’univocità dei risultati, nel senso che se
veniva stabilita la verità di una proposizione essa non
sarebbe mai stata messa in discussione. Da ciò nasceva
il detto popolare “la matematica non è un’opinione”,
per testimoniare appunto il fatto che in matematica non
esistevano “punti di vista”, non potevano dunque esprimersi pareri tranne che su congetture o su risultati non
provati.
Ebbene, tralasciando le geometrie non euclidee e i
paradossi sulle teorie degli insiemi, che in parte hanno
scardinato questo assunto (per i nostri scopi è più che
sufficiente l’utilizzo della matematica tradizionale), la
matematica continua a non essere dipendente da convinzioni personali e quindi è necessario rispettarla nelle
sue regole e nei suoi fondamenti. Se un Giudice chiede
a un Perito che ha appena attribuito una voce anonima
a quella dell’imputato, quale sia la percentuale di somiglianza o meglio quale sia la probabilità che la voce
40
Temi Romana
Saggi
ni? Come posso essere certo che non ne esista almeno
uno la cui voce ha una percentuale di somiglianza con
la voce anonima di un valore superiore all’80%, ad
esempio l’82%? In quel caso il mio 80% diverrebbe
una percentuale si alta, ma che mi scagiona. È necessario quindi avere a disposizione una popolazione di riferimento, ossia una casistica tale che mi permetta di
definire la probabilità di “falsa identificazione”:
l’espressione della possibilità che il test stia sbagliando
nell’attribuzione di un termine anonimo ad uno noto.
Attenzione quindi alle percentuali di probabilità che i
Periti dichiarano nei loro elaborati o nel corso della
loro escussione, ci si accerti che provengano da calcoli
reali, con l’applicazione di teoremi accettati alla comunità scientifica e dimostrabili, al fine di evitare che una
valutazione priva di pregnanza scientifica possa trasformarsi in una probabilità di colpevolezza, anche perché è più raro che si trasformi in una probabilità d’innocenza.
ce; nel valutare due termini a confronto ne analizzo le
peculiarità che li contraddistinguono. Se su 100 caratteri peculiari 80 sono simili, potrò sostenere che i due termini si assomigliano all’80%. È sufficiente ciò per poter
dire che i due termini hanno la medesima origine?
Ovvero che sono lo stesso elemento? Se fosse dimostrabile che esiste un solo elemento con quelle peculiarità
allora quell’80% sarebbe individualizzante.
La voce dell’anonimo assomiglia alla mia all’80%. Se
io sono l’unico uomo su un pianeta abitato da sole
donne allora io sono per forza identificabile nell’anonimo parlatore. Le cose si complicano un pochino se
sullo stesso pianeta vivono 10 uomini. Quell’80% di
somiglianza è ancora così individualizzante? Per poter
rispondere dovrei esaminare la voce degli altri 9 uomini esistenti. Se dall’analisi emergesse che le loro voci
assomigliano a quella dell’anonimo con percentuali
inferiori all’80% allora ecco che mi ritroverei ad essere di nuovo colpevole. Ma se gli uomini sono 20 milio-
Temi Romana
41
Osservatorio legislativo
Ancora sulla colpa medica: il danno da nascita indesiderata
Marina Binda
Avvocato iscritto nell’Elenco Speciale Avvocati di un Ente pubblico, Foro di Roma
“Bambini? Preferisco cominciarne cento che finirne uno…” (Paolina Bonaparte)
I
l danno da nascita indesiderata viene normalmente
definito come il pregiudizio patito dal genitore, leso
nel proprio diritto di scegliere se e quando avere
figli.
La figura affonda le radici nel diritto alla libera autodeterminazione delle scelte relative al bene-salute, con
specifico riferimento al rapporto medico-paziente.
Il diritto alla libera autodeterminazione, come è noto, è
strettamente connesso all’obbligo di informazione gravante sul sanitario, il quale è tenuto a rendere notizie in
maniera adeguata ed efficace al fine di ottenere dal
paziente un consenso pieno, consapevole e certo. In
tale prospettiva il diritto del paziente di essere informato è evidentemente correlato all’obbligo del medico di
informare.
Il dovere di informazione trova fondamento in diverse
fonti di vario rango.
Viene anzitutto in considerazione la Convenzione sui
diritti umani e la biomedica, adottata dal Consiglio
d’Europa il 19 novembre 1996, ancora non ratificata
dall’Italia, secondo cui ogni intervento sulla persona
può essere effettuato solo dopo aver ottenuto un consenso libero e informato.
Viene poi in considerazione la legge 23 dicembre 1978,
n. 833, recante l’istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale, che, all’art. 33, dispone che gli accertamenti sanitari sono accompagnati da iniziative volte ad
assicurare il consenso e la partecipazione di chi vi è
obbligato.
Viene altresì in considerazione la legge 22 maggio 1978
n. 194, che, all’art. 14, statuisce che in presenza di anomalie del nascituro il medico deve fornire alla donna i
ragguagli necessari per la prevenzione.
Viene infine in rilievo il codice deontologico, approvato dall’Ordine nazionale dei medici chirurghi, che
impone la necessità di acquisire il consenso informato
del paziente.
Da tutte le disposizioni citate deriva, a tutta evidenza,
che il medico è assolutamente obbligato a porre il
paziente in condizione di valutare ogni rischio e ogni
alternativa terapeutica.
In concreto, in caso di omessa o inadeguata informazione del medico nei confronti del paziente il diritto
alla salute e il diritto alla autodeterminazione possono
venire in rilievo in due ipotesi.
a) Il paziente non ha rilasciato il consenso e l’intervento, ritenuto imprescindibile dal medico, viene effettuato nel pieno rispetto delle regole d’arte. L’esito, peraltro, risulta infausto o infelice.
Qui la colpa del medico è rinvenibile non nella tecnica
utilizzata durante l’intervento (c.d. colpa da imperizia1), bensì nella mancata doverosa acquisizione del
consenso del paziente2. Ditalché, nell’ipotesi considerata, risultano lesi sia il diritto alla salute sia il diritto
all’autodeterminazione, ma la violazione di quest’ultimo diritto rende senz’altro risarcibile anche il primo.
b) Il paziente non ha prestato il consenso, il medico ha
operato secondo le migliori regole dell’arte e il risultato è fausto.
Qui la colpa del medico non consiste nell’aver causato
un danno alla salute, bensì nell’aver leso il diritto
all’autodeterminazione del paziente, derivante dalla
mancata prestazione del consenso.
La giurisprudenza3, in ipotesi siffatte, ha ritenuto risarcibili le sofferenze derivanti dal fisiologico decorso
dell’operazione che il paziente non si aspettava, in
quanto non informato. Si tratta, per tale orientamento,
di sofferente superiori – poiché inattese – a quelle che
il paziente avrebbe provato ove fosse stato consapevole degli effetti dell’intervento.
Il dovere di informazione in capo al sanitario nei confronti dei propri assistiti viene poi in rilievo nel caso in
cui l’informazione costituisce proprio l’oggetto principale della prestazione medica: ci si riferisce alla controversa ipotesi di danno da nascita indesiderata.
Tralasciando il caso di nascita indesiderata derivante da
42
Temi Romana
Osservatorio legislativo
quantomeno a livello psichico.
Secondo un orientamento consolidato7, è irrilevante la
circostanza che la madre, dopo la nascita del bambino
non si sia ammalata, in quanto il giudizio sulla patologia e sulla pericolosità della salute deve essere valutato
ex ante, con prognosi postuma, trascurando ciò che è
effettivamente accaduto e immaginando cosa sarebbe
piuttosto avvenuto se l’informazione fosse stata fornita.
Nel solco di questo indirizzo giurisprudenziale è intervenuta una nota sentenza della Corte di Cassazione8
(Cass. Civ. 2 ottobre 2012, n. 16754), secondo cui
l’omessa informazione delle malformazioni di cui è
affetto il nascituro comporta la responsabilità per danni
patrimoniali, consistenti nelle maggiori spese sopportate per le anomalie del bambino, nonché la responsabilità per danni non patrimoniali, consistenti nelle significative sofferenze e nello sconvolgimento della vita
familiare.
La sentenza si distingue per l’allargamento della platea
dei soggetti legittimati ad ottenere il risarcimento del
danno; oltre alla madre e al padre viene riconosciuta la
titolarità del diritto ai fratelli del bambino e allo stesso
soggetto nato con patologie non notiziate.
La tesi suscita perplessità sia con riferimento alla risarcibilità del danno in favore dei fratelli che con riferimento
alla risarcibilità in favore del bambino malformato.
Per quanto riguarda la legittimazione dei fratelli, è
innegabile che la nascita di un bimbo malato possa in
concreto causare grave dolore, ma non si ritiene condivisibile che dalla sofferenza possa discendere, sic et
simpliciter, un automatico diritto al risarcimento.
Al riguardo non ci si può esimere dal rilevare che la
nascita di un bimbo malformato non provoca ai fratelli
sofferenze necessariamente maggiori di quelle provate
da altri soggetti particolarmente legati alla famiglia: si
pensi, ad es., ad una “tata” affezionata, alla migliore
amica della madre, ai nonni, ad un parente convivente,
ad un compagno di uno dei familiari, e così via. Tutte
le persone esemplificamente elencate possono in concreto soffrire dolori indicibili per la nascita di un bimbo
malformato sino ad ammalarsi, in ipotesi, a seguito di
tale evento. Sicché l’allargamento dei destinatari del
risarcimento va operato con prudente cautela, tenendo
conto di criteri diversi rispetto a quello della semplice
sofferenza.
Al riguardo, va chiarito che il dovere di informazione
errata esecuzione degli esami prenatali, ove si verifica
una tipica colpa da imperizia, è opportuno soffermarsi
sul caso di impropria o mancata informazione del corretto significato degli esami stessi, ove ricorre, invece,
un’ipotesi di colpa da negligenza.
Sussiste nell’ordinamento giuridico un diritto generalizzato ad abortire? È noto che la legge n. 194/1978 sottopone l’interruzione volontaria di gravidanza a determinate condizioni.
Prima del terzo mese, a partire dall’inizio del concepimento, l’interruzione della gravidanza è possibile purché la donna deduca che la prosecuzione della gestazione comporterebbe un serio pericolo per la propria salute, fisica o psichica.
In questo caso l’interruzione della gravidanza viene
considerato quasi un atto dovuto, volto a scongiurare
un danno temuto per la gestante, inteso dalla giurisprudenza anche in senso molto lato4 come afferente al
benessere anche solo mentale della donna. I giudici di
legittimità e di merito5, invero, hanno sempre mostrato
un atteggiamento volto ad indebolire significativamente l’onere probatorio in capo alla donna, richiedendo la
mera allegazione della anomalia del feto e ritenendo
che sia normale, naturale, che dalla nascita di un bimbo
malformato derivi un serio danno alla salute della
madre.
Dopo il novantesimo giorno dal concepimento, la legge
n. 194/1978 preclude l’aborto salvo che sussista: a) un
grave pericolo per la madre; b) una malattia in atto del
concepito che esponga la salute della madre ad un pericolo anch’esso grave.
Il caso sub. a) non reca particolari problemi, in quanto
la legge predilige sempre la preservazione della vita
della madre rispetto a quella del nascituro.
Nel secondo caso, invece, la norma richiede non solo la
malformazione in atto del feto, ma anche che la gestante corra un grave pericolo per la salute. Ciò significa
che, al fine di accertare la responsabilità del medico,
occorrerebbe non solo dimostrare la patologia del feto,
ma anche dimostrare che la madre, ove informata,
avrebbe corso un grave pericolo di ammalarsi.
Tale rigoroso onere probatorio, tuttavia, viene nella
pratica alleggerito facendo ricorso alla prova presuntiva: la giurisprudenza6 ritiene scontato che, laddove la
madre fosse stata informata della malformazione, ella
avrebbe corso il rischio di ammalarsi gravemente,
Temi Romana
43
Osservatorio legislativo
nesso causale. Al riguardo è necessario chiedersi: qual
è il collegamento finalistico tra la condotta del medico
ed i relativi effetti nei confronti del soggetto nato malformato?
A ben vedere, il dovere di informazione che incombe in
capo al medico rileva unicamente nei confronti della
gestante (e, in determinate condizioni, nei confronti del
padre) giammai nei confronti del nascituro, in quanto,
proprio perché privo di soggettività giuridica, non può
essere considerato destinatario di notizia alcuna circa
lo stato della propria salute.
Per le ragioni esposte si ritiene che l’allargamento della
titolarità del diritto al risarcimento del danno in caso di
danno da nascita indesiderata – e, in generale, in tutti i
casi di responsabilità – sia operazione ermeneutica non
scevra da possibili criticità.
Al riguardo, va dato conto di un recente orientamento
della Corte di Cassazione13 che segna un deciso revirement rispetto all’anteriore orientamento giurisprudenziale, in tema di danno da nascita indesiderata.
Qui i giudici di legittimità pongono in dubbio la pregressa affermazione giurisprudenziale secondo cui la
gestante, se informata delle anomalie del feto, si sarebbe senz’altro avvalsa della facoltà di abortire concessale dalla legge, fondando tale ragionamento presuntivo
anche sul solo elemento della malformazione del bambino. Secondo la Cassazione, in particolare, l’accertamento del nesso causale tra omessa informazione e
nascita indesiderata – e perciò dannosa – va affrontato
facendo ricorso alle regole generali.
Ne deriva che: l’onere di provare che, in caso di corretta informazione, sussistevano le condizioni per procedere all’aborto grava sulla gestante e non sul medico;
non può essere sufficiente, al fine del raggiungimento
della prova, la mera circostanza che la donna avesse
richiesto di venir sottoposta a esami diagnostici prenatali. Viene richiesto, all’opposto, un indice univoco
della volontà di abortire, da valutarsi tenendo conto di
tutte le circostanze del caso concreto, venendo in rilievo ad es. la condotta della madre, le credenze religiose,
le convinzioni etiche, il livello culturale, eccetera.
E con ciò la Cassazione mostra di aver tenuto in debito
conto la constatazione di Calamandrei secondo cui il
giudice spesso propende inconsciamente ad accorrere
in soccorso del soggetto ritenuto più debole, pur se
questi ha torto14.
da parte del medico sulle condizioni di salute del nascituro è indirizzato anzitutto verso la madre, con la quale
esiste un vero e proprio rapporto contrattuale avente ad
oggetto l’assistenza medica in corso di gravidanza.
Analogo dovere di informazione, peraltro, normalmente ricorre nei confronti del padre9, il quale, pur essendo
estraneo al rapporto medico-gestante, è titolare del
diritto all’informazione nascente dal contratto tra quelli concluso, in quanto è indiscutibilmente legato ad una
delle parti contrattuali da una relazione socialmente
significativa10.
I fratelli del nascituro, all’opposto, non sono destinatari delle informazioni su eventuali anomalie del feto, pur
se, in concreto, è possibile che tali anomalie rechino
sofferenze, anche notevoli, nella loro vita. Inoltre, ai
fratelli la legge non riconosce alcun potere di pianificazione della famiglia: solo ai coniugi il codice civile
attribuisce il potere di indirizzo della vita familiare. Di
conseguenza, non si ritiene che ai fratelli del nascituro
possa essere attribuito, in via ermeneutica, alcun diritto
all’interruzione della gravidanza della loro madre, non
trovando tale diritto fondamento nella legge.
Quanto alla titolarità del diritto al risarcimento in capo
al bimbo nato malformato, si rappresenta quanto segue.
La citata sentenza della Corte di Cassazione, partendo
dal rilievo secondo cui la capacità giuridica si acquista
con la nascita in quanto prima di tal momento il concepito è privo di soggettività, fa inverare l’effetto che il
bimbo subisce un pregiudizio dal fatto stesso di nascere, una sorta di danno in sé, scaturente dalla semplice
venuta in vita della persona malformata.
Il danno derivante dalla venuta al mondo del bambino
malformato non sarebbe occorso, secondo la sentenza
in commento, se la madre fosse stata informata ed
avesse esercitato correttamente il proprio diritto di
abortire.
A prescindere da ogni considerazione di tipo ideologico, qui assolutamente ultronea11, va rilevato che l’ordinamento giuridico non attribuisce all’individuo un
diritto alla felicità, una pretesa ad una vita serena e
senza affanni, la cui lesione risulti passibile di risarcimento12. È del tutto opinabile, peraltro, che per il soggetto malformato la nascita costituisca un danno, e che
per lui sarebbe stata più vantaggiosa la “non nascita”.
A ciò si aggiunga che il ragionamento del giudicante
porta ad un utilizzo improprio dello strumento del
44
Temi Romana
Osservatorio legislativo
1 Per imperizia medica si intende normalmente l’assenza di zelo e precisione nell’applicazione delle regole d’arte e operative e nell’utilizzo delle tecniche condivise
dalla comunità scientifica.
2 La giurisprudenza discute se in questo caso
l’elemento soggettivo qualificante l’illecito è
identificabile come colpa o come dolo; la
tesi prevalente rinviene un caso di colpa (Ex
multis: Cass. Civ., 10 maggio 2002, n. 6735).
3 Ex multis: Cass. Civ., 9 febbraio 2010, n. 2847.
4 Viene invero utilizzata l’espressione “aborto terapeutico” anche con riferimento a possibili malattie psichiche della donna. Ex multis: Cass. Civ., 29 luglio 2004, n. 14488.
5 Ex multis: Cass. Civ., 2 febbraio 2010, n. 2354
6 Ex multis: Cass. Civ., 4 gennaio 2010, n. 13.
7 Cass. Civ., 10 maggio 2002, n. 6735;
Cass. Civ., 29 luglio 2008, n. 14488.
8 Cass. Civ., 2 ottobre 2012, n. 16754. In
Temi Romana
dottrina a commento cfr. M. ROSSETTI, La
responsabilità del medico, in Libro dell’anno del diritto 2012, Roma, Treccani, 2013.
9 La giurisprudenza, in casi siffatti, fa riferimento alla figura del “contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo” ove il
terzo ha diritto alla protezione del contratto
stipulato da altri, distinguendo tale istituto
da quello del “contratto a favore di terzo”
ove il terzo ha diritto non alla semplice protezione bensì alla prestazione oggetto del
contratto stipulato da altri.
10 Tale dovere, peraltro, si atteggia diversamente a seconda delle circostanze concrete:
è evidente che l’adempimento dell’obbligo
di informazione comporta che il medico sia
tenuto a fornire ogni notizia riguardante la
salute del nascituro ad un padre assiduamente presente ai controlli, ma tale adempimento non può di certo comportare che il
medico ricerchi affannosamente un padre
mai partecipe alle visite (anche per impedi-
45
menti oggettivi), al fine di renderlo edotto
sullo stato di salute del feto.
11 Al riguardo, la Corte di Cassazione
(Cass. Civ. 2013 n. 7269 cit.) ha rilevato
che la questione deve essere affrontata e
risolta “all’infuori degli schematismi di
soluzioni fortemente condizionate da implicazioni emotive e da opzioni ideologiche”,
che siano opzioni che patrocinano il diritto
di abortire in modo libero e consapevole, o
che siano opzioni che aderiscono all’idea
secondo cui “ogni bambino che nasce porta
la notizia che Dio non è ancora stanco
degli uomini” (Tagore).
12 In tale senso si vedano le esemplari statuizioni della nota sentenza di San Martino delle
Sezioni Unite: 11 novembre 2008, n. 26972.
13 Cass. Civ., 22 marzo 2013, n. 7269.
14 Le opinioni e i giudizi contenuti nel presente lavoro sono espressi a titolo personale e non sono in alcun modo riferibili
all’Ente di appartenenza.
Osservatorio legislativo
I modelli di organizzazione e controllo ex D.Lgs. n. 231
del 2001 nella prospettiva di un magistrato della pubblica
accusa
Pierluigi Cipolla
Magistrato
1.
La centralità dei modelli di organizzazione e
controllo nel “sistema 231”
È indubbio che i modelli di organizzazione e
controllo costituiscano il “fulcro” della riforma epocale introdotta dal D.Lgs. n. 231 del 2001 .
Non solo perché essi sono richiamati da molteplici
norme del testo normativo in esame, e perché dalla loro
adozione ed efficace attuazione dipende l’affrancamento dalla responsabilità amministrativa degli enti collettivi ivi prevista (si verte in una sorta di scusante positivizzata, secondo alcuni1, ovvero, secondo altri, in una
causa di non punibilità2), ma soprattutto perché la loro
mancata o inefficace attuazione costituisce l’essenza di
quella “colpa di organizzazione” che si pone alla base
dell’illecito parapenale di cui si discute.
Se infatti la ratio della innovativa disciplina del 2001
consiste nella volontà di perseguire gli enti che non
hanno impedito ai cd vertici (art. 6 D.Lgs. n. 231 del
2001) e ai sottoposti (art. 7 D.Lgs. n. 231 del 2001) la
perpetrazione di reati nell’interesse o a vantaggio degli
enti stessi, l’addebito di fondo nei confronti della persona giuridica consiste nel non aver adottato efficaci
misure di contenimento del cd rischio di reato, nell’aver
omesso di adeguare la struttura dell’impresa in modo da
neutralizzare le condotte illegali, nell’aver conservato e
perpetuato un deficit organizzativo, il che si traduce in
una vera e propria “colpa” di organizzazione.
Di converso, i “modelli comportamentali” calibrati sul
rischio di reato di cui parla la legge a più riprese costituiscono quella “virtuosa” organizzazione la cui messa
in atto è idonea a impedire o attenuare l’impatto delle
(talvolta temibili) sanzioni amministrative sulla vita
dell’ente, esattamente come nel diritto penale degli
umani il rispetto delle cautele prevenzionistiche esclude in radice la colpa delle persone fisiche.
Si giunge a questa conclusione sulla base della relazione ministeriale (pag. 9) e alla luce della rilevanza attribuita ai programmi de quibus dal testo normativo citato, laddove non solo l’attuazione dei modelli in fase
antecedente alla commissione del reato-presupposto (in
una con l’avverarsi di altre condizioni, se il reato base è
riferibile ad un “vertice”: art. 6 D.Lgs. n. 231 del 2001)
comporta l’esenzione della responsabilità dell’ente, ma
anche la messa in atto ex post implica molti benefici: la
sospensione e la revoca di misure cautelari (art. 49
D.Lgs. n. 231 del 2001), la reductio della sanzione
pecuniaria (art. 12 D.Lgs. n. 231 del 2001), l’inapplicabilità delle formidabili sanzioni interdittive (art. 17
D.Lgs. n. 231 del 2001), la conversione di sanzioni
interdittive in sanzioni pecuniarie in executivis (art. 78
D.Lgs. n. 231 del 2001). Proprio il rilievo processuale e
sostanziale dato alla collaborazione dell’ente (anche
postdelictum) mediante l’adozione di compliance programs evidenzia la finalità di fondo della riforma: provocare un rinnovamento ab interno dell’ente in prospettiva legalistica, la trasformazione dell’humus che ha
consentito la commissione del reato, il recepimento di
una nuova etica di impresa, dato che gli strumenti di
contrasto ai white e blue collars crimes finora applicati
(il controllo amministrativo ab externo e la repressione
penale dei singoli) non hanno funzionato.
2. Modelli reali e modelli cartolari
Proprio l’esigenza di effettiva prevenzione [oltre che la
lettera della legge, che agli artt. 6 comma 1 lettera a), e
7 comma 2 D.Lgs. n. 231 del 2001 parla di “efficace
attuazione”] e non tanto la volontà persecutoria dei
pubblici ministeri impone di valutare se gli adempimenti siano effettivi oppure “cartolari” id est apparenti
o fittizi. Su questo vi è una concordia generalizzata in
46
Temi Romana
Osservatorio legislativo
reato-base5 a prescindere dalla conformità rispetto alle
“linee guida”, il che potrà rilevare, al limite, come presunzione semplice pro reo.
Tale incertezza di fondo, fin dal 2001 ha legittimato
chiunque a formulare opinioni sulla forma, la struttura,
il contenuto e i requisiti di efficienza dei programmi di
organizzazione e controllo di cui si discute e il sottoscritto si inserisce alla schiera.
Quanto alla forma, si opina che il modello debba essere deliberato dall’assemblea e iscritto nello statuto
societario, ed in effetti questa conclusione è corroborata da un argomento di diritto positivo6.
Quanto alla struttura, vi sono coloro che propongono
una tipologia “leggera”, con specificazioni nei singoli
settori7, tuttavia non si vede come tale struttura leggera
possa essere compatibile con imprese di grandi dimensioni. Il problema maggiore riguarda tuttavia i contenuti, dato che chi si è cimentato ha fatto ricorso alla fantasia oppure ha mutuato indicazioni utili dalle vicende
giudiziarie.
Chi scrive ritiene che occorra comunque partire dalla
legge (soprattutto dalla sua ratio) e solo in un secondo
momento desumere qualcosa dalle sentenze, se non
altro al fine di non prestare il destro a chi censura l’ennesimo caso di diritto giurisprudenziale. Orbene, la
legge è chiara nel distinguere la disciplina a seconda
che il reato presupposto sia posto in essere dai vertici
(art. 6 D.Lgs. n. 231 del 2001) ovvero dai sottoposti
(art. 7 D.Lgs. n. 231 del 2001).
Nel primo caso non è sufficiente che l’ente abbia adottato ed efficacemente attuato un compliance program,
ma occorre che il reato sia stato possibile da una elusione fraudolenta dei modelli e dei controlli. Se si aderisce
alla tesi che individua nell’elusione fraudolenta dei
modelli un aggiramento del sistema mediante eccezionale abilità e astuzia – come sostiene dottrina autorevole8, e come si legge anche nelle linee guida per la
costruzione di Modelli di organizzazione, gestione e
controllo della Associazione bancaria italiana, del
20049 – ne deriva che il sistema prevenzionistico, per
poter produrre i suoi effetti giuridici, dovrà essere
alquanto complesso e sofisticato, a prova di resistere
alla calliditas dei suoi stessi artefici: un livello ordinario di cautela sarebbe soggetto a facile e non fraudolenta elusione! Invero costituirebbe “colpa” dell’Ente
anche il mancato impedimento (possibile) della con-
dottrina e giurisprudenza. D’altra parte è la legge stessa a subordinare l’esonero da responsabilità non solo
all’adozione di un Modello di organizzazione idoneo a
contenerne il rischio reato, ma anche alla presenza di
misure/controlli/interventi idonei a prevenire e impedire condotte di violazione e aggiramento delle regole da
parte di coloro che hanno maggiore interesse a commettere reati nell’interesse e a vantaggio dell’Ente.
Di converso, se lo scopo dell’ordinamento giuridico è
quello contenere il rischio di reato mediante il concorso dell’ente, un niveau di diligenza eccessivamente alto
indurrebbe l’ente stesso ad accettare il rischio di una
condanna, piuttosto che innescare un meccanismo di
riorganizzazione di sicura onerosità (in termini pecuniari) e incerta efficacia salvifica. Il principio di realtà
e non il bieco cinismo insegna che lo scopo naturale
dell’impresa commerciale è il profitto3; all’uopo la possibilità di subire sanzioni per comportamenti economicamente produttivi ma giuridicamente illeciti rientra tra
i rischi di impresa: se il beneficio “possibilità di affrancamento da responsabilità parapenale” implica oneri
esorbitanti preferirà non fare nulla, ossia assumersi il
rischio di reato, e ciò tanto più in quanto quel beneficio
appaia remoto o soltanto ipotetico.
La necessità di trovare un giusto mezzo tra una concezione “lassista” e una visione “puritana” dei modelli di
organizzazione e controllo si complica poiché sia il
legislatore delegante sia il governo si sono astenuti dal
fornire indicazioni realmente concrete oltre che cogenti in materia: sul punto esiste un indubbio deficit di
determinatezza.
Nonostante lo spazio attribuito dalla legge alla macchinosa procedura ministeriale di “pubblicazione” di codici di comportamento elaborati dalle associazioni di
categoria4, la mancata formulazione di rilievi da parte
del ministro della Giustizia non potrà avere significato
di lasciapassare dirimente: 1) nessuna disposizione di
legge attribuisce al silenzio il valore di assenso; 2) la
procedura riguarda, a rigori, i codici di comportamento generali, le c.d. linee guida, che devono essere calate nelle singole situazioni aziendali; 3) la legge stessa
dispone in più punti che solo l’aver efficacemente
attuato i modelli produce efficacia salvifica. Dunque
all’autorità giudiziaria in fase di accertamento dell’illecito è rimesso il vaglio sulla concreta idoneità dei programmi adottati prima o dopo la perpetrazione del
Temi Romana
47
Osservatorio legislativo
dotta illecita di coloro che al massimo grado esprimono la voluntas societatis ossia esprimono e rappresentano la politica dell’Ente medesimo e che quindi, possono, meglio di altri, aggirarne le regole.
Tale livello di complessità evidentemente non è richiesto né per i modelli adottati al fine di impedire i reati di
dipendenti, né per i modelli postdelictum, per i quali,
tuttavia, sono ravvisabili ulteriori requisiti.
È possibile quindi immaginare tre tipologie diverse di
modelli di organizzazione e gestione, con tre differenti
standard di diligenza.
risorse extracontabili. Nel caso in cui il commercio di
merce con marchi contraffatti sia stato favorito dalla
mancanza di controlli sulla scelta dei fornitori, sarà
d’uopo introdurre sistemi di verifica preventiva e successiva dei partner economici e della provenienza della
merce da questi commercializzati.
Dato che il reato generalmente viene consumato con il
favore delle tenebre del segreto, della arbitrarietà e
monocraticità delle decisioni, potranno essere immessi
opportuni antidoti quali la trasparenza delle operazioni,
il principio della collegialità delle decisioni, la rotazione delle funzioni, l’immodificabilità periodica dei dati
contabili, la separazione tra le funzioni di chi decide,
chi esegue e chi controlla.
Inutile aggiungere che molta importanza dovrà essere
attribuita inoltre alla formazione periodica dei dipendenti e alla introduzione di un sistema disciplinare.
3. I Modelli postdelictum
Se lo scopo del “sistema 231” consiste nel provocare
un mutamento della cultura di impresa, nel senso dell’avvicinamento a livelli accettabili di legalità, occorre
che il programma di organizzazione e controllo sia non
un abito calato a forza e dall’alto sull’impresa commerciale, bensì un quotidiano, ordinario e dinamico atteggiarsi della vita aziendale in modo conforme alla legalità preventiva. Ciò impone, per quanto attiene ai
modelli elaborati postdelictum, che si tenga conto nel
concreto della situazione che ha favorito la commissione dell’illecito, e che si eliminino le specifiche carenze
organizzative grazie alle quali il reato ha potuto essere
ideato e realizzato. Il che presuppone: 1) una compiuta
indagine “sul campo” delle aree di rischio connesse
all’evento già verificatosi; 2) la rappresentazione di
tutti i reati potenzialmente ancora perpetrabili nel contesto operativo e nei momenti di vita dell’ente viziati
dai fattori di pericolo. Cessata siffatta fase istruttoria
(la c.d. mappatura del rischio di reato) seguirà la procedimentalizzazione delle attività a rischio, ossia la previsione di regole idonee a impedire il ripetersi del
reato, forgiate in una direttrice diretta e contraria rispetto alla spinta criminale. Ad es., nel caso in cui il reato
di corruzione sia stato favorito dalla procedura di
appalto a trattativa privata, occorrerà inibire tale procedimento ovvero individuare meccanismi controllabili
di presentazione delle offerte. Nel caso in cui il reato di
corruzione sia stato agevolato dalla facilità nel creare
fondi occulti, sarà necessario adeguare la gestione della
contabilità, ad es. introducendo controlli incrociati
sulle fatturazioni, sulle movimentazioni pecuniarie,
sulle consulenze a terzi, ossia su tutte quelle condotte
che secondo la prassi consentono l’accantonamento di
4. Modelli antedelictum
La mancanza di “precedenti” rende ben più ardua l’elaborazione di un modello di organizzazione e controllo
antecedente alla commissione del reato realmente idoneo a esonerare da responsabilità (c.d. modello ex
ante): l’assenza di un precedente specifico rischia di
rendere la mappatura dei rischi generica e incompleta.
Tuttavia a più di dieci anni dalla entrata in vigore è
legittimo far tesoro delle vicende processuali e procedere per così dire per analogia; in tal caso l’esperienza
delle aule giudiziarie è insostituibile.
Pertanto, traendo spunto dalle più rilevanti pronunce di
merito in materia, anche per la elaborazione di modelli
ex ante occorrerà identificare le aree in cui si possono
verificare fatti criminosi, mediante una indagine sur-lechamp; sarà poi necessario individuare i comportamenti anomali indicativi di intenti illeciti (o della volontà di
occultamento di condotte illecite) ed adottare le necessarie contromisure, di natura persuasiva (in primis
sistemi premiali conseguenti al raggiungimento di
obiettivi economici nel rispetto della legalità; incentivi
connessi alla segnalazione di condotte anomale) e di
natura dissuasiva (sistema di informazione e comunicazione mediante “visti”; codici di comportamento sia
all’interno sia nei rapporti di affari; individuazione di
un codice etico che autorizzi tutti a riferire comportamenti anomali altrui; separazione tra chi decide, chi
attua e chi controlla: c.d. segregazione delle funzioni).
48
Temi Romana
Osservatorio legislativo
base familiare e da una industria multinazionale.
Più di tante parole, tuttavia sarà utile una metafora per
comprendere il discrimen tra il modello “di facciata” e
il compliance program realmente indicativo di un
mutamento della cultura di impresa in senso legalistico: potrà definirsi idoneo perché specifico e dinamico
il programma di organizzazione che mutui dalle api lo
stesso sistema di controllo reciproco e “dal basso” che
connota l’alveare, dove il rispetto delle regole da parte
di tutti non ostacola anzi favorisce il successo dell’impresa proprio perché il controllo reciproco isola i disonesti, galvanizza il lavoro degli onesti e quindi ne provoca il successo.
È evidente, comunque, che il problema di fondo del
“sistema 231” consiste nella sua non convinta accettazione da parte dei destinatari, che continuano a vedere
nei modelli di organizzazione e controllo – al più – un
ulteriore fardello imposto dalla legge e non, come il
legislatore del volgere del millennio auspicava, un
segno concreto della rigenerazione della cultura di
impresa. Eppure, per provocare un mutamento di passo,
basterebbe far leva sul quid pluris simbolico – connesso al contenuto etico – che i compliance programs portano con sé valorizzandone il potenziale economico.
Scrive Garapon a proposito di un argomento viciniore,
il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese commerciali nell’era della globalizzazione: “i diritti umani
… saranno trattati come rischi e forse anche come un
vantaggio competitivo …. Una grande impresa vorrà
presentarsi come la più rispettosa dei diritti umani per
farne argomento di pubblicità per le vendite. Non si
moralizzerà il capitalismo, dunque, facendo appello a
un improbabile senso etico dell’impresa, bensì facendo
integrare nel mercato i dati sociali e ambientali”12.
Il tutto andrà corroborato da un efficiente sistema interno di supervisione, che dovrà assommarsi al controllo
riferibile all’organo di vigilanza, la cui essenzialità è
talmente palese da non richiedere neanche una parola:
si tratta del “custode” del modello, nello stesso senso in
cui la Corte costituzionale è il custode della Carta fondamentale.
Anche per i modelli preventivi rileverà quanto detto a
proposito della adeguata formazione del personale e
dell’effettivo modello disciplinare10.
5. Rilievi conclusivi
Da quanto sommariamente esposto si evincono le tre
qualità fondamentali del modello organizzativo “efficace”: specificità, dinamicità, procedimentalizzazione,
laddove la prima viene meno in programmi passivamente recettizi delle disposizioni penali e delle c.d.
Linee guida, privi di indicazioni di illeciti e sanzioni,
carenti di protocolli di lavoro tesi a neutralizzare i
rischi; la seconda si eclissa quando non siano previsti
revisioni periodiche, un sistema di informazione e formazione del personale e una struttura di monitoraggio
interno; la terza svanisce quando non siano contemplate procedure di ricerca e identificazione di rischi di
reato al cospetto di situazioni particolari, codici di
autoregolamentazione con riguardo a attività a rischio,
obblighi informativi periodici degli amministratori e
dei dirigenti in merito a violazioni del modelli, sistemi
di controllo di routine o periodico a sorpresa11.
Parlando in generale, non è possibile dire oltre. Ogni
rischio di reato, infatti, ha la sua particolarità e quindi reclama specifiche contromisure. Del pari, molto dovrà variare
a seconda della dimensione dell’impresa: non si potrà pretendere lo stesso dispendio di energie da una impresa a
_________________
1 Cfr. C.E. PALIERO, La responsabilità
penale della persona giuridica nell’ordinamento italiano: profili sistematici, in
Societas puniri potest, in AA.VV., La
responsabilità da reato degli enti collettivi,
a cura di F. PALAZZO, Padova, CEDAM,
2003 p. 29; DESIMONE, I profili sostanziali
della responsabilità c.d. amministrativa
degli enti. La parte generale e la parte spe-
Temi Romana
ciale del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in
AA.VV., Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, a
cura di G. GARUTI, Padova, CEDAM, 2002,
p. 107; C. PIERGALLINI, La responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, in
AA.VV., I nuovi reati societari: diritto e
processo, a cura di A. GIARDA - S.
SEMINARA, Padova, CEDAM, 2002, p. 76.
49
2 Cfr. D. PULITANÒ, La responsabilità da
reato degli enti: i criteri di imputazione, in
Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, p. 429 ss.; G.
COCCO, L’illecito degli enti dipendente da
reato e il ruolo dei Modelli di prevenzione,
in Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, p. 97 ss.
3 Cfr. A. GARAPON, Lo Stato minimo, il neoliberalismo e la giustizia, Milano, Raffaello
Osservatorio legislativo
Cortina Editore, 2012, p. 146: “L’impresa –
come ricordava crudamente Milton Friedman – è sottoposta ad un’unica responsabilità, quella di arricchirsi. Essa non è né a favore né contro i diritti dell’uomo: essa è
indifferente verso gli stessi. Se è necessario
rispettare i diritti dell’uomo per arricchirsi,
lo farà; se non è necessario, se ne asterrà”.
4 Art. 6 comma 3 D.Lgs. n. 231 del 2001
5 In questo senso, M. BARBUTO, Responsabilità amministrativa della società
per reati commessi a suo vantaggio, in
Impresa c.i., 2001, n. 6, p. 935; G. BUSSON,
Il commento ai codici di comportamento
delle associazioni rappresentative degli
enti, in AA.VV., Societas puniri potest, la
responsabilità da reato degli enti collettivi,
Atti del convegno di Firenze, marzo 2002,
Padova, CEDAM, 2003, p. 408; G. LANCELLOTTI, I modelli organizzativi e gestio-
nali dell’ente, contenuto e rilevanza, in
AA.VV., La responsabilità dell’impresa
per i fatti di reato, a cura di A. FIORELLA G. LANCELLOTTI, Torino, Giappichelli,
2004, p. 118; R. RORDORF, La normativa sui
modelli di organizzazione dell’ ente, in
AA.VV., Responsabilità degli enti per reati
commessi nel loro interesse, Atti del convegno di Roma, nov.-dic. 2001, in Cass pen.,
2003, suppl. al n. 6, p. 89; G. PAOLOZZI,
Vademecum per gli enti sotto processo,
Torino, Giappichelli, 2006, p. 69; contra
DE VERO, La responsabilità dell’ ente collettivo dipendente da reato, criteri di imputazione e qualificazione giuridica, in
AA.VV., Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi da reato, Padova,
CEDAM, 2002, p. 27.
vità economiche, Bologna, il Mulino, 2010,
p. 225.
8 Cfr. G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Milano, Giuffrè, 2008, p. 185; E. AMODIO, Prevenzione
del rischio penale di impresa e Modelli
integrati di responsabilità degli enti, in
Cass. pen., 2005, p. 320.
9 “L’elusione fraudolenta […] presuppone
la messa in opera di un artificio, di una forzatura precipuamente e artatamente volta
alla elusione del precetto”.
10 Sul punto, ex plurimis, Trib. Milano, 20
settembre 2004, in PAOLOZZI, Vademecum,
cit., cd allegato, p. 862 ss.
6 Art. 5 D.M. 26 giugno 2003 n. 201.
11 Su alcune di queste indicazioni: Trib.
Roma 4 aprile 2003, in PAOLOZZI,
Vademecum, cit., cd allegato, p. 805.
7 Cfr. A. ALESSANDRI, Diritto penale e atti-
12 Cfr. GARAPON, Lo Stato, cit., p. 147.
50
Temi Romana
Note a sentenza
Concordato con riserva e licenziamento
Tribunale di Roma 1 Agosto 2014 Pres. Russo, Est. Di Salvo
Antonio Caiafa
Avvocato del Foro di Roma - Professore di Diritto Fallimentare Università L.U.M. “Jean Monnet” di Bari
OMISSIS
- vista l’istanza con la quale la Merimar s.a.s. di
Cesare Menasci e C. ha chiesto di essere autorizzata a
risolvere i rapporti in essere con i propri dipendenti ed
avviare la procedura di licenziamento collettivo di tutti
i dipendenti al fine di ridurre i costi aziendali connessi
al personale dipendente e di essere autorizzata a nominare un professionista per essere assistita durante la
procedura di licenziamento nella gestione delle relazioni con le rappresentanze sindacali e in ogni adempimento conseguente per un compendo predeterminato;
- rilevato che detta società con ricorso depositato il
24.4.2014 ha chiesto l’ammissione al concordato preventivo cosiddetto “prenotativo” ai sensi dell’art. 161
co. 6 l.f. e che il Tribunale con decreto in data
23.5.2014 ha concesso termine fino al 16.9.2014 per il
deposito della proposta e del piano ammessa alla procedura nominando il commissario giudiziale;
- che l’istanza di autorizzazione allo scioglimento dei
contratti di lavoro è intervenuta in una fase in cui
comunque la società proponente ha definito nelle sue
linee essenziali i contenuti della proposta e del piano di
concordato prospettando un concordato liquidatorio
con la cessione dei beni ai creditori;
- considerato che effettivamente l’art. 169 bis l.f. attribuisce al Tribunale la facoltà di autorizzare il debitore
ricorrente a sciogliersi dai contratti in corso alla data
di presentazione del ricorso ovvero a sospendere gli
effetti di tali contratti nella fase che precede la ammissione al concordato preventivo;
- considerato, tuttavia, che l’ultimo comma di tale
disposizione stabilisce espressamente che “le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di
lavoro subordinato”;
- ritenuto, dunque, che tale disposizione non possa
essere invocata in un caso come quello in esame poiché
dall’ambito applicativo della disciplina dettata dai
primi tre commi sono espressamente esclusi proprio i
Temi Romana
contratti oggetto dell’istanza, e ciò esime da ogni valutazione sia in ordine alla funzionalità della richiesta
rispetto all’interesse del ceto creditorio e sia in ordine
alle ragioni di urgenza;
- ritenuto, dunque, che i contratti di lavoro e i relativi
rapporti proseguono nel corso della procedura per concordato preventivo sicché la società proponente non
può essere autorizzata a determinarne lo scioglimento;
visto il parere negativo espresso dal commissario giudiziario reso in data 1.8.2014;
- ritenuto, pertanto, che alla luce di tali considerazioni
l’istanza non può trovare accoglimento;
P.Q.M.
rigetta integralmente l’istanza depositata il 28.7.2014.
***
Seppur il debitore proponente ha definito i contenuti
della proposta prospettando un concordato liquidatorio, con la cessione dei beni ai creditori, tuttavia non
può essere autorizzato, ai sensi dell’art. 169 bis l.f., dal
Tribunale la risoluzione dei rapporti di lavoro, atteso
che l’ultimo comma di tale disposizione ne esclude la
applicazione ad essi, sì da rendere superflua ogni valutazione in ordine alla funzionalità della richiesta
rispetto all’interesse del ceto creditorio.
I contratti di lavoro ed i relativi rapporti proseguono
nel corso della procedura concordatizia e, pertanto, la
società proponente non può essere autorizzata a determinarne lo scioglimento.
[artt. 161 e 169 bis l.f.; art. 2119 cod. civ.]
***
I
l provvedimento offre spunti di riflessione in relazione al tema affrontato ed alla soluzione offerta,
ritenuta l’unica possibile attraverso una interpretazione, decisamente singolare, dell’art. 169 bis l.f.
51
Note a sentenza
intende realizzare, e ciò sicuramente avviene qualora
questi intenda, attraverso il piano, poi, prevedere la
prosecuzione dell’attività di impresa, ovvero la cessione dell’azienda in esercizio o, ancora, il conferimento
di questa in una o più società, anche di nuova costituzione, potendo essere richiesta, in tal caso, anche l’autorizzazione alla liquidazione dei beni che si ritengono
non funzionali per il fine proposto e l’obiettivo che si
intende realizzare.
L’art. 186 bis l.f., al secondo comma, opera una descrizione del contenuto del piano e della relazione attestativa e, ancora, l’art. 182 quinquies l.f. consente al debitore, che abbia presentato la domanda ai sensi dell’art.
161, sesto comma, l.f., di ottenere l’autorizzazione, da
parte del tribunale, per la contrazione dei finanziamenti, alla condizione che la richiesta sia accompagnata da
una attestazione e sempre che questi risultino essere
funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.
Ed ancora, nell’ottica della realizzazione della continuità aziendale, la stessa norma consente il pagamento
di crediti anteriori, per prestazioni di beni e servizi in
presenza di una relazione attestativa che affermi essere
questi essenziali per la prosecuzione dell’attività di
impresa e, al tempo stesso, funzionali ad assicurare la
migliore soddisfazione dei creditori.
Dunque, è in tal senso, e nei limiti descritti, che il
debitore, nel presentare il ricorso per l’ammissione
alla procedura di concordato preventivo prenotativo
ha, evidentemente, interesse a chiarire – pur senza
necessità di operarne una specifica illustrazione –
quale sarà l’offerta che ipotizza di formulare ai propri
creditori, non potendo, diversamente, avvalersi, poi,
della possibilità di richiedere quelle autorizzazioni che
il tribunale potrà concedere solo se le ritenga funzionali all’obiettivo e tali da garantire il miglior soddisfacimento dei creditori.
In questa fase, difatti, non vi è un programma, né un
piano, essendo ancora assente l’offerta che si intende,
poi, sottoporre alla specifica approvazione dei creditori, ma gli interessi di questi devono essere già tutelati
affinché la par condicio – cui la procedura è ispirata –
non venga ad essere alterata attraverso iniziative che,
ove assunte ed in contrasto con la previsione normativa, potranno consentire al tribunale di intervenire
immediatamente, quante volte l’attività compiuta risulti essere inidonea, con riferimento alla proposta ed al
Stupisce la decisione adottata, soprattutto in ragione
del fatto che il ricorso depositato per l’ammissione al
concordato preventivo prenotativo, cui la società istante era stata ammessa, conteneva la definizione (come si
legge nel provvedimento) del contenuto della proposta
e del piano concordatario volto alla cessione dei beni ai
creditori – pertanto liquidatorio – sicché la conclusione
avrebbe (ma così non è, per quanto si dirà) potuto trovare una sua giustificazione quante volte la richiesta
autorizzazione avesse dato luogo ad una modificazione
strutturale degli elementi essenziali del complesso dei
beni organizzati, per l’esercizio dell’attività di impresa,
sì da poter incidere, in modo irreversibile, sulla possibilità concreta di attuare il risanamento attraverso la
continuità aziendale, per avere il proponente anticipato
di voler presentare una proposta concordatizia ai sensi
dell’art. 186 bis l.f. (c.d. concordato in continuità).
È noto che, nell’ambito del concordato prenotativo,
non sussiste un onere del proponente di anticipare il
contenuto della soluzione che intende poi prospettare,
nel termine assegnatogli dal Tribunale, ai propri creditori, se non nella misura in cui è necessario per poter,
poi, ottenere quelle autorizzazioni di cui non sarebbe
possibile lo scrutinio in assenza di una offerta indicazione delle linee essenziali della successiva proposta.
Le pronunce che sono intervenute sulla corretta interpretazione dell’art. 161, sesto comma, l.f. hanno avuto
modo di sottolineare che la domanda deve contenere,
integralmente, al suo interno, l’esposizione dei requisiti formali e processuali e, dunque, l’enunciazione della
sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per
l’accesso alla procedura, e l’ammissione non può essere condizionata dalla produzione di documenti diversi,
da quelli espressamente previsti dalla legge (bilanci
degli ultimi tre esercizi), per acquisire, nel prosieguo,
attraverso gli obblighi informativi, notizie in ordine
alla gestione finanziaria dell’impresa ed all’attività
svolta, con la periodicità prevista nel provvedimento di
ammissione, sotto la vigilanza del Commissario giudiziale, se ed in quanto nominato, sino alla scadenza del
termine fissato1.
Ecco, che il mantenimento dei livelli occupazionali e la
tutela delle specifiche professionalità, da un lato, e del
patrimonio tecnologico, delle strutture e degli impianti
dall’altro, possono rappresentare, anche nel caso del
concordato prenotativo, la finalità che l’imprenditore
52
Temi Romana
Note a sentenza
piano, che, per le ragioni esposte, devono essere stati
anticipati, pur se non completamente delineati.
Non è, tuttavia, escluso che al risanamento possa pervenirsi anche attraverso una efficace ristrutturazione
dell’azienda, ovvero un ridimensionamento di parte
delle unità occupate, in quanto ritenute non indispensabili nell’ambito di un assetto aziendale maggiormente
funzionale e, comunque, competitivo.
Possono, dunque, verificarsi in concreto, già al
momento della presentazione della domanda di
Concordato con riserva, le condizioni legittimanti la
riduzione del personale, così come, al contrario, qualora l’attività risulti essere già cessata, ovvero prossima alla conclusione subito dopo la presentazione, non
potrà essere inibito, in ragione della natura liquidatoria della proposta futura, all’imprenditore, di attuare
la risoluzione dei rapporti di lavoro attraverso il particolare iter procedimentale per questi previsto, ove
occupi più di quindici dipendenti (art. 24 della legge
n. 223 del 1991).
In tal caso, il licenziamento collettivo verrà a trovare la
sua giustificazione, secondo l’orientamento della giurisprudenza, nella situazione di fatto che viene a discendere dalla scelta unilaterale operata dall’imprenditore,
relativamente alla quale il personale viene globalmente
considerato in quella che è la sua composizione quantitativa e qualitativa, con riferimento ai posti di lavoro, e
non già ai lavoratori che ne sono titolari.
Il licenziamento collettivo è, difatti, caratterizzato
dalla circostanza di essere esso riferito ad una pluralità di persone, nell’ambito di imprese che occupano
più di quindici dipendenti, e può riguardare anche
parte del personale, alla condizione che interessi più
di cinque dipendenti, nell’arco dei centoventi giorni,
laddove il recesso sarà individuale ove riguardi direttamente il lavoratore o quei lavoratori il cui rapporto
l’imprenditore è intenzionato a risolvere in presenza
di circostanze che sono riconducibili ad un grave inadempimento dell’interessato, oppure a motivi relativi
all’attività produttiva ed alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esso (artt. 1 e 9
legge n. 604 del 1966).
Ed allora, va diversamente interpretata la previsione di
cui all’ultimo comma, dell’art. 169 bis l.f., che esclude
dalla applicazione delle disposizioni precedenti, per
quel che attiene il possibile scioglimento e la sospen-
Temi Romana
sione del rapporto, quello di lavoro subordinato, per il
fatto di trovare esso una sua regolamentazione nell’ambito di una normativa specifica, come risulta evidente
dalla circostanza che non sono a questo applicabili i
principi dettati, in via generale, per ogni tipo di contratto, dagli artt. 1256 e 1463 cod. civ., tant’è che la
sopravvenuta impossibilità di una delle prestazioni corrispettive produce la sua risoluzione non solo se abbia
carattere definitivo ma, anche, se temporanea, purché si
profili di non breve durata, indeterminata ed indeterminabile, e sia, comunque, tale da fare venir meno l’interesse dell’una o dell’altra parte al mantenimento in
virtù del rapporto.
In particolare, con riferimento al contratto di lavoro la
sopravvenuta impossibilità, laddove riguardi il lavoratore e non sia rapportabile ai casi di sospensione legale, previsti dagli artt. 2110 e 2111 cod. civ., determina
l’estinzione del rapporto, sempre che si presenti di
durata indeterminata e tale da non consentire di prevedere il tempo per il quale, nell’ambito della struttura
sinallagmatica, può venir meno l’effettiva e concreta
prestazione dell’attività lavorativa, così escludendo
quella funzione di scambio tra lavoro e retribuzione che
rappresenta la causa stessa del contratto.
L’impossibilità della esecuzione della prestazione lavorativa, dovuta a cause non imputabili al datore di lavoro, comporta, ai sensi dell’art. 1463 cod. civ., il venir
meno del diritto del lavoratore alla retribuzione, senza
che, in tal caso, possa porsi un discorso di mora accipiendi – che si profila allorché sia stata offerta una prestazione parziale o alterata nella sua essenza – ciò in
quanto l’oggettiva impossibilità della prestazione lavorativa rende non configurabile una offerta da parte dei
dipendenti.
Specularmente, le ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa non possono che essere
fatte valere, mediante il licenziamento e le sue regole,
anche causali, per garantire i coinvolti interessi alla
certezza e stabilità dell’occupazione.
Al di là, pertanto, della manifestata volontà di risolvere il rapporto, non par dubbio che il datore di lavoro,
ove non esegua esattamente la prestazione dovuta, è
tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non imputabile,
estinguendosi, nel qual caso, l’obbligazione ai sensi,
53
Note a sentenza
via, ad essa equiparate, alla condizione, peraltro, che
intervenga e permanga il relativo provvedimento autorizzativo, che ha natura di accertamento costitutivo e
segna il sorgere del rapporto previdenziale diretto tra il
lavoratore posto in cigs e l’Inps, rispetto al quale l’imprenditore stesso, ormai liberato dall’obbligo retributivo, assume la figura di adectius solutionis causa6.
Al di fuori delle ipotesi ora considerate, tuttavia, la giurisprudenza ha riconosciuto validità all’accordo attraverso il quale l’imprenditore e le OO.SS. pattuiscano,
ai fini del ricorso alla cigs, una sospensione del rapporto di lavoro, con esonero del datore dall’obbligazione
retributiva, indipendentemente dall’esito della richiesta
di concessione dell’integrazione salariale, alla condizione, però, che i lavoratori interessati abbiano conferito, specificamente, ai rappresentanti sindacali, l’incarico di stipularlo, ovvero abbiano provveduto a ratificarne l’operato, trattandosi di un accordo che incide,
immediatamente, sulla disciplina dei contratti individuali di lavoro e sui diritti di cui i singoli sono titolari7.
La cessazione dell’attività imprenditoriale, dovuta ad
una situazione di crisi aziendale irreversibile, ove abbia
determinato l’imprenditore a richiedere l’accesso alla
procedura di concordato preventivo prenotativo, al fine
di poter, poi, presentare, nel termine assegnato dal tribunale, la documentazione prevista dall’art. 161, l.f., la
proposta ed il piano, certamente non integra una ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione e,
dunque, non lo abilita a sospendere l’obbligazione
retributiva, discendente dal rapporto di lavoro, ma
costituisce, tuttavia, il presupposto perché questi possa
provvedere al licenziamento per giustificato motivo
oggettivo – previsto dall’art. 3 della legge n. 604 del
1966 – quante volte occupi meno di quindici dipendenti o, in alternativa, al licenziamento collettivo regolato
dall’art. 24 della legge n. 223 del 1991, nell’ipotesi di
organico superiore8.
Le svolte considerazioni sono pertinenti, oltre che
necessarie ed utili, per meglio comprendere e valutare
la portata della decisione e la erroneità della conclusione cui è pervenuto il tribunale nel richiamare l’art.
169 bis l.f., al fine di giustificare il proprio convincimento, affermando che, proseguendo senza soluzione
di continuità, i contratti di lavoro, durante la procedura
concordatizia, la proponente non poteva essere autorizzata a determinarne lo scioglimento.
per l’appunto, degli artt. 1218 e 1256 codice civile.
Ricorre, difatti, la tradizionale esimente del caso fortuito e della forza maggiore, scaturenti da eventi naturali o accadimenti non ascrivibili all’uomo, solo quando inevitabili, nonostante l’uso della ordinaria diligenza, da valutarsi con riguardo alla natura dell’attività
esercitata2.
Ne consegue, quindi, che la sospensione unilaterale del
rapporto da parte del datore di lavoro esonera il medesimo dalla obbligazione retributiva solo quando non sia
imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed
evitabile, e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendali, ovvero a contingenti difficoltà di mercato3.
La sospensione unilaterale del rapporto è, pertanto,
giustificata solo quando ricorre una situazione obiettiva di forza maggiore, non imputabile, e tale da determinare l’impossibilità della prestazione, ovvero altra
situazione che sia stata valutata dalle parti del rapporto contrattuale e sia stata da queste espressamente
accettata, dovendosi escludere che la sospensione
possa essere conseguenza della mera volontà del datore di lavoro, risolvendosi, in tal caso, in una condizione meramente potestativa4.
Altre situazioni, ancorché incolpevoli, dovute a crisi
economiche congiunturali e strutturali ed a reali difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, al
calo delle commesse, in quanto rientranti nel c.d.
rischio di impresa, inibiscono l’unilaterale determinazione datoriale di sospendere la prestazione ed originano una situazione di mora credendi dalla quale discende l’obbligo al risarcimento del danno in misura corrispondente alle ordinarie retribuzioni dovute5.
La soluzione, nella ricorrenza delle ultime ipotesi formulate di crisi strutturale ed economica, è data dalla
possibilità di ottenere la sospensione delle obbligazioni attraverso la richiesta di accesso alla cassa integrazione ordinaria, ovvero straordinaria, che consente, sul
piano del diritto comune, di sospendere il rapporto di
lavoro, la cui applicazione è previsto intervenga in
situazioni dovute ad eventi transitori non imputabili
all’imprenditore, ovvero ai dipendenti di questi.
Le cause che giustificano la domanda di integrazione
salariale, pur non sostanziandosi in ipotesi di impossibilità sopravvenuta – che unica libera l’imprenditore dall’obbligo del pagamento delle retribuzioni – sono, tutta-
54
Temi Romana
Note a sentenza
Anche tale affermazione, contenuta nel provvedimento, disorienta il lettore, perché il rapporto di lavoro
vede assicurata la continuità giuridica anche nel fallimento, ma l’avere ritenuto il legislatore di collocarlo
nell’ambito dell’art. 72 l.f. – ovvero tra i rapporti giuridici pendenti che rimangono sospesi sino a quando il
curatore non intende avvalersi della facoltà di risolverli – non esclude, ma, al contrario, ne legittima la
risoluzione attraverso il necessario rispetto dell’iter
procedimentale di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223
del 1991 quante volte l’organico sia superiore a quindici dipendenti, ovvero il curatore intenda risolvere più di
cinque rapporti, nell’arco dei centoventi giorni, qualora sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio o disposta la continuazione temporanea dell’attività, su sua
richiesta, ed abbia, tuttavia, ritenuto superflue alcune
figure professionali e, pertanto, necessaria una riduzione del personale in esubero.
La linea seguita dal collegio capitolino non è, pertanto,
convincente e la conclusione sarebbe stata giustificata
esclusivamente nell’ipotesi in cui il debitore, con la
domanda di concordato prenotativo, avesse rappresentato l’esigenza di una continuazione temporanea dell’attività e, poi, motivato l’istanza, volta ad ottenere la
relativa autorizzazione, in ragione della necessità di
organizzare diversamente l’impresa in modo rispondente al mutare della situazione.
In tal caso, il tribunale avrebbe dovuto svolgere l’indagine sulla dedotta ristrutturazione aziendale e sul rapporto di causalità intercorrente tra questa ed i licenziamenti che si intendevano attuare, per poi stabilire se,
rientrando la richiesta di autorizzazione al compimento
dell’atto nell’ambito della straordinaria amministrazione, il relativo compimento poteva ritenersi subordinato
allo scrutinio positivo del collegio.
La volontà che il legislatore ha inteso esprimere attraverso la formulazione della norma e la esclusione da
essa dei rapporti di lavoro non incide sulla facoltà dell’imprenditore di operare le scelte, con riferimento al
successivo piano che è tenuto a depositare con la proposta, e l’attività da questi svolta non può essere considerata ordinaria, ovvero straordinaria, a seconda della
rilevanza patrimoniale delle conseguenze che da essa
possono discendere, atteso che lo stesso recesso di uno
o più dipendenti può essere inteso come atto di conservazione del patrimonio, ed in quanto tale, certamente,
Temi Romana
non è straordinario9.
Il richiamo effettuato all’art. 169 bis l.f. non è, né può
essere, esaustivo in conseguenza della riconosciuta
possibilità per l’imprenditore di formalizzare, nel prosieguo, la proposta, ed avrebbe dovuto indurre, al contrario, il tribunale ad affermare che, nel caso di specie,
essendo l’istanza intervenuta in una fase in cui la società proponente aveva definito “…nelle sue linee essenziali i contenuti della proposta e del piano di concordato prospettando un concordato liquidatorio con la cessione dei beni ai creditori”, mancando, quindi, l’intento di risanare l’impresa l’autorizzazione, avrebbe dovuto essere concessa e, ancor prima, non richiesta.
Non può, d’altronde, sfuggire che l’art. 161, sesto
comma, l.f. abilita l’imprenditore al deposito di un
ricorso che contiene la domanda di concordato, con la
documentazione prevista dalla norma, senza, tuttavia,
che questi debba presentare la proposta, il piano e la
documentazione di cui al secondo e terzo comma dello
stesso articolo, adempimento cui è tenuto, nel termine
fissato dal tribunale, diversamente previsto a seconda
che sia stata già presentata una istanza per la dichiarazione di fallimento.
La anticipazione del contenuto della proposta e del
piano può essere utile al solo fine di ottenere l’autorizzazione al compimento di quegli atti che non potrebbero trovare ingresso durante tale fase, con la conseguenza che potrebbe – l’uso del condizionale è d’obbligo –
prevenire alla conclusione che, qualora sia stata manifestata ed anticipata l’intenzione di elaborare un adeguato programma di ristrutturazione per il superamento della crisi, in grado da consentire la rimozione del
dissesto ed il riavvio dell’attività produttiva, nell’interesse dei creditori, oltre che quello generale dell’economia, il tribunale, investitone, sarebbe tenuto a stabilire
se la richiesta di risolvere alcuni rapporti di lavoro confligga con la anticipata soluzione negoziale conservativa ed a negare l’autorizzazione stessa qualora fosse
diretta alla risoluzione di tutti i rapporti, perché in contrasto, in tal caso, con la manifestata ed anticipata
intenzione di realizzare il risanamento dell’impresa.
Il concordato preventivo, d’altronde, una volta abrogata la procedura disciplinata dagli artt. 187 l.f. e
segg., può avere una funzione liquidatoria, ovvero
anche di risanamento, e, in tal caso, di salvaguardia
del patrimonio aziendale, con la conseguenza, sicché,
55
Note a sentenza
ove tale obiettivo sia stato in qualche modo anticipato, in ragione della riconosciuta possibilità di formulare le richieste consentite dagli artt. 169 bis e 182
quinquies l.f., potrebbe giustificarsi la domandata
autorizzazione per la riduzione del personale occupato, che non è necessaria quante volte la soluzione concordatizia prospettata sia liquidatoria, per essere l’attività già cessata.
_________________
1 Tribunale Modena, 15 novembre 2012,
che ha ritenuto non integrare la fattispecie
degli atti di straordinaria amministrazione,
la cessione di immobili, qualora inerente
l’attività caratteristica dell’impresa ammessa alla procedura.
2 Cass., 22 ottobre 1999, n. 11916, in Not.
giur. lav., 2000, p. 68.
3 Cass., 4 settembre 2013, n. 20319 in Not.
giur. lav., 2014, p. 362; Cass., 6 ottobre 1999,
n. 11147, ivi, 1999, p. 10; Cass., 1 settembre
1997, n. 8273, ivi, 1997, p. 708; Cass., 2
dicembre 1985, n. 6032, ivi, 1986, p. 398;
Cass., 19 gennaio 1983, n. 498, in Giust. civ.,
1983, I, p. 3230; Cass., 13 maggio 1982, n.
2994, in Not. giur. lav., 1983, p. 39.
4 Cass., 26 maggio 2000, n. 6928, in Not.
giur. lav., 2000, p. 696 che ha ritenuto nulla
la clausola di un contratto collettivo che autorizzava il datore di lavoro a sospendere
unilateralmente il rapporto e la relativa
retribuzione.
5 Cass., 13 marzo 1997, n. 2232, in Not.
giur. lav., 1997, p. 365; Cass., 10 maggio
1995, n. 5090, ivi, 1995, p. 535; Cass., 3
ottobre 1991, n. 10298, in Dir. prat. lav.,
1991, p. 3038.
6 Cass., Sez. Un., 28 aprile 1989, n. 2034, in
Arch. civ., 1989, p. 821; Cass., Sez. Un., 20
giugno 1987, n. 5454, in Mass. giur. lav.,
1987, p. 403; Cass., 9 luglio 1983, n. 4658,
in Riv. It. lav., 1984, II, p. 218 che hanno
ritenuto esonerato il datore di lavoro dall’obbligo retributivo in coincidenza con l’intervento del provvedimento autorizzativo.
7 Cass., 19 settembre 2006, n. 19500;
Cass., 22 ottobre 1999, n. 11916, in Not.
giur. lav., 2000, p. 68.
8 Cass., 5 ottobre 19991, n. 10819; Cass.,
56
15 novembre 1991, n. 12249, in Dir. prat.
lav., 1992, p. 121; Cass., 24 ottobre 1991, n.
11300; Cass., 28 settembre 1989, n. 3941,
in Mass. giur. lav., 1989, p. 644 ove risulta
ribadito il principio per il quale, ove
sopravvenga la cessazione dell’attività
aziendale, il giudice che accerti la illegittimità del licenziamento non può disporre
la reintegrazione nel posto di lavoro, ma
deve limitarsi ad accogliere la sola domanda di risarcimento del danno, dal momento
che la prestazione è divenuta impossibile
per cessazione dell’attività.
9 Cass., 3 luglio 1979, n. 3731, in Il fallimento, 1980, p. 290, ed ulteriori richiami di
dottrina e giurisprudenza; Cass., 17 maggio
1974, n. 1433, in Giur. comm., 1975, II, p.
175, sui criteri distintivi tra atti di ordinaria
e straordinaria amministrazione con riferimento all’art. 167 l.f..
Temi Romana
Note a sentenza
Decadenze in materia di licenziamento
Carlotta Maria Manni
Praticante Abilitato
L’
proprio datore di lavoro mediante cui mette a disposizione del medesimo le proprie energie lavorative tenuto
conto dell’allontanamento dal posto di lavoro.
In merito al termine ad quem si è assistito ad un dibattito giurisprudenziale conclusosi, solo di recente, con
l’intervento delle Sezioni Unite. Nel dettaglio negli anni
’80 la Suprema Corte aveva stabilito che l’impugnativa
del licenziamento dovesse pervenire all’indirizzo del
datore di lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione;
diversamente il lavoratore sarebbe decaduto da ogni
diritto4. Ciò in quanto il termine previsto ex lege opera
nell’interesse del datore di lavoro, il quale deve conoscere per tempo le intenzioni del lavoratore licenziato
senza incorrere nel rischio di future quanto impreviste
pretese economiche e/o reintegratorie che potrebbero
incidere negativamente sulla posizione dell’impresa.
Circa venti anni dopo la Consulta è chiamata a decidere in
merito ad una questione simile: la decorrenza ad quem
della notifica degli atti giudiziari. Si tratta di un tema di
carettere processual-civilistico che presenta un certo rilievo in riferimento al tema qui esaminato. Nella specie i giudici della Corte erano chiamati a verificare la costituzionalità del combinato disposto degli artt. 139 e 148 c.p.c.
rispetto agli artt. 3 e 24 Costituzione. In tale occasione
l’organo giudicante, conformandosi a precedenti pronunzie, ha affermato il principio della “doppia notifica”.
Sulla base di detto principio la notifica si perfeziona nei
confronti del notificante nel momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o all’agente postale; mentre
per il destinatario i termini decorrono dal momento in cui
ha ricevuto l’atto5. La ratio di tale principio consiste nel
tutelare il notificante che diversamente potrebbe incorrere incolpevolmente nella decadenza per attività imputabili a soggetti terzi e non a lui direttamente6.
La sentenza richiamata ha influenzato, ampiamente,
l’orientamento della S.C. la quale, mutando il precedente indirizzo, ha precisato che i 60 giorni rappresentano il
termine entro cui il lavoratore deve proporre l’impugnativa, non rilevando il fatto che il datore di lavoro riceva
solo successivamente la comunicazione di contestazione
articolo 32 del Collegato lavoro (Legge n.
183/2010) e successive integrazioni interviene, come è noto, a modificare l’articolo 6 L.
604/1966 in materia di decadenze per l’impugnativa
del licenziamento. Precisamente l’articolo indica due
termini decadenziali: l’uno di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale, l’altro di 180 giorni per l’impugnazione giudiziale.
La norma, benché apparentemente chiara, presenta
complessità interpretative.
In riferimento al primo termine è pacifica la sua decorrenza dalla comunicazione del licenziamento in forma
scritta o, comunque, dalla comunicazione dei soli motivi, se successiva.
Alla base di una simile disposizione vi è certamente un
riferimento alla disciplina civilistica (art. 1335 c.c.) laddove il licenziamento si configura come atto unilaterale
recettizio. Ciò comporta che il medesimo produce i propri effetti solo nel momento in cui venga portato a conoscenza del lavoratore che può discrezionalmente valutare se impugnarlo o meno nel termine di 60 giorni.
Pertanto l’effettiva conoscenza del licenziamento sarà presunta nel momento in cui la lettera di licenziamento giunga presso la residenza del lavoratore. Si tratta, invero, di
una presunzione relativa; il destinatario potrà dimostrare
l’impossibilità di averne avuto notizia senza sua colpa1.
Esula da questa fattispecie il licenziamento verbale, che
viene definito dal legislatore inefficace2. Sebbene nel
corso dei lavori preparatori il Collegato lavoro prevedesse che i termini decadenziali riguardassero sia i licenziamenti invalidi sia quelli inefficaci, al momento della promulgazione l’ambito applicativo risultava ristretto alle
sole ipotesi di invalidità. Sulla base di ciò il lavoratore
licenziato oralmente non è tenuto ad impugnare in via
stragiudiziale nel termine di 60 giorni, in quanto l’assenza della forma scritta comporta l’inidoneità ad avviare la
procedura di licenziamento nei termini di legge3. Ne consegue che il lavoratore può ricorrere all’autorità giudiziaria nel più ampio termine prescrizionale di 5 anni, oppure più semplicemente possa inviare una raccomandata al
Temi Romana
57
Note a sentenza
del licenziamento7. Si tratta, invero, della logica prevalenza dell’interesse del lavoratore a impugnare un provvedimento datoriale irregolare rispetto al più generico
interesse alla certezza dei rapporti giuridici. Si comprende bene come il principio, sancito dalla Consulta, non
operi solo in ambito processuale; è ragionevole applicarlo in via estensiva anche al diritto sostanziale, tanto più
in una materia delicata come il diritto del lavoro, laddove il soggetto licenziato venga privato di una fonte reddituale stabile tale da coinvolgere il diritto ad una esistenza libera e dignitosa propria e della sua famiglia8.
Pertanto si ritiene che il momento della spedizione dell’impugnativa sia idoneo a interrompere il decorso del
termine decadenziale, mentre la ricezione dell’impugnativa da parte del datore di lavoro è il momento in
cui si perfeziona la fattispecie impugnatoria. Ne consegue che sarà tempestiva la lettera inviata dal lavoratore
quando verrà spedita nei termini di legge presso il
domicilio del datore di lavoro o la sede legale dell’impresa, facendo fede il timbro postale.
L’impugnativa stragiudiziale diviene inefficace se non
è seguita, nei successivi 180 giorni, dal deposito del
ricorso avverso il datore di lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. In merito riteniamo di poter condividere l’orientamento maggioritario9 secondo cui tale
termine decorre dal giorno in cui il lavoratore ha impu-
gnato stragiudizialmente il licenziamento e non piuttosto dal giorno successivo al 60mo; ciò al solo scopo di
garantire una più sollecita definizione della controversia a vantaggio di entrambe le parti.
Se il lavoratore lascia decorrere inutilmente detto termine, decade dal diritto di impugnare il licenziamento e con
esso viene meno l’efficacia della prima impugnativa.
Per quanto concerne il termine ad quem di 180 giorni la
Cassazione aveva dapprima condiviso l’orientamento
secondo cui il lavoratore per impedire la decadenza
dovesse notificare il ricorso con pedissequo decreto entro
il termine previsto ex lege, non risultando sufficiente il
mero deposito in cancelleria10. Per attenuare la rigidità di
un simile orientamento, la S.C. in altro contesto ha precisato che il lavoratore, seppure decaduto dall’impugnativa, può comunque presentare domanda di risarcimento in
via ordinaria per illiceità del recesso. In tale occasione si
avrà un richiamo ai principi generali di responsabilità
contrattuale (art. 1218) ed extracontrattuale (art. 2043)
contenuti nel Codice civile11. Oggi vi è un orientamento
condiviso secondo cui il termine finale è quello del deposito del ricorso o comunque della comunicazione della
richiesta di tentativo di conciliazione e arbitrato. Infatti è
irrilevante la data del decreto di fissazione di udienza (nel
primo caso) o la data di convocazione per la procedura
conciliativa (nel secondo caso), poiché si tratta di elementi estranei alla sfera di controllo del lavoratore12.
_________________
1 La S.C. precisa che sussiste una impossibilità oggettiva ogniqualvolta il lavoratore
non ne abbia avuto conoscenza a causa di
un evento eccezionale estraneo alla sua
volontà (v. Cass. Sez. lav. n. 18272/2002 e
n. 6845/2014).
2 In particolare cfr. il dettato di cui all’art. 2
che stabilisce quanto segue: “Il datore di
lavoro, imprenditore o non imprenditore,
deve comunicare per iscritto il licenziamento
al prestatore di lavoro. (…) Il licenziamento
intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”.
3 Così il Tribunale di Napoli 8.9.1994; Trib.
di Palermo 9.1.2013 secondo cui nessun
onere di impugnativa nei termini dell’art. 6
L. 604/1966 può essere posto a carico del
lavoratore licenziato verbalmente.
4 Cfr. Cass., Sez. Un., n. 5395/1982 (conf.
Cass. Sez. lav. n. 5468/1981; contra Cass.
Sez. lav. n. 4560/1978).
5 Corte Cost. n. 28/2004.
6 Si pensi, a titolo di esempio, al caso di
eventuali scioperi da parte del personale
degli Uffici notifiche (Unep) o ipotesi non
del tutto rara di possibili comportamenti
dilatori posti in essere dal ricevente che
rifiuti la notifica. È irragionevole, quanto
lesivo per il notificante, considerare il termine ad quem in riferimento alla materiale
consegna dell’impugnativa.
7 Cass., Sez. Un., n. 8830/2010.
8 Di tale avviso la Cass. Sez. lav. n.
22287/2008, secondo cui nello specifico:
“In tema di disciplina, dettata dall’art. 6
della legge n. 604 del 1966, concernente la
decadenza dal potere di impugnare il licenziamento, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata – che consente
l’estensione del principio generale dell’or-
58
dinamento in materia di decadenza processuale da impedire tramite la notificazione
di un atto al diritto sostanziale e, segnatamente, anche tramite l’art. 36, primo
comma, Cost., alla tutela apprestata contro
il licenziamento illegittimo – l’impugnazione anzidetta è tempestiva, e detta decadenza è quindi impedita, qualora la lettera raccomandata con la quale essa viene effettuata sia, entro il termine di sessanta giorni
previsto dal citato art. 6, consegnata all’ufficio postale ed ancorché essa venga recapitata dopo la scadenza di quel termine”.
9 Peraltro condiviso dal Tribunale di
Milano con recenti pronunzie (Cfr. in particolare la sentenza del 20.12.2013 n. 4709).
10 Cass. Sez. lav. n. 5552/2007.
11 Cass. Sez. lav. n. 245/2007.
12 Così la S.C. Sez. lav. n. 2837/2014.
Temi Romana
Cronache e attualità
L’addebito della separazione
Attualità dell’istituto e profili applicativi tra la giurisprudenza di legittimità e quella di merito
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
Progetti consiliari di settore
SETTORE FAMIGLIA, MINORI, IMMIGRAZIONE
Cons. Avv. Matteo Santini
SOMMARIO: CAPITOLO PRIMO – 1. Dal sistema sanzionatorio all’intollerabilità della convivenza – 2. Aspetti processuali del giudizio di addebito – 3. Addebito della separazione: quale futuro?; CAPITOLO SECONDO – 4.
L’addebito nella giurisprudenza di legittimità e di merito – 5. Presupposti per la pronuncia di addebito – 6.
Giurisprudenza di legittimità e di merito; CAPITOLO TERZO – 7. Il risarcimento del danno nella separazione con o
senza addebito – 8. Giurisprudenza di merito – 9. La giurisprudenza della Corte di Cassazione
CAPITOLO PRIMO
Una siffatta argomentazione, però, si era ben presto
scontrata con i timori di chi riteneva che l’assenza di
una sanzione nei confronti del coniuge che si era reso
protagonista, con il proprio comportamento contrario ai
doveri coniugali, del fallimento dell’unione, sarebbe
equivalso ad elidere la giuridicità di tali doveri1, in
quanto avrebbe irrimediabilmente indebolito gli stessi
impegni formali assunti al momento della celebrazione
del matrimonio.
A fronte di detta contrapposizione aveva finito per prevalere una situazione di compromesso, ben ravvisabile
nell’attuale formulazione dell’art. 151 codice civile.
Se, infatti, la regola generale contenuta nel riformato
primo comma dell’art. 151 c.c. sancisce il passaggio
dalla separazione a carattere sanzionatorio a quella
avente funzione di rimedio ad una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, è altrettanto vero che il secondo comma lascia la possibilità al
Giudice, se investito da specifica domanda di parte, di
sanzionare il coniuge che si sia reso autore di comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio,
addebitando allo stesso la separazione.
Con l’intervenuta riforma del diritto di famiglia, pertanto, il legislatore nel sostituire il termine “colpa” con
la locuzione addebitabilità della separazione ha inteso
marcare la distanza con la precedente normativa che, in
mancanza di accordo, aveva nella colpa dei coniugi il
presupposto imprescindibile e sufficiente per la pronuncia di separazione.
Nella previgente ipotesi, infatti, il Giudice era tenuto a
pronunciare la separazione solamente in presenza di
di Marco Meliti
Avvocato del Foro di Roma
1. Dal sistema sanzionatorio all’intollerabilità
della convivenza
Il tema dell’addebito della separazione, seppure sia
stato eroso nel tempo dalle trasformazioni sociali che
hanno inciso sensibilmente sul mutamento dei costumi,
mantiene tutt’ora una posizione preminente nei giudizi
di separazione, in quanto intimamente legato a sentimenti come la rabbia ed il dolore che generalmente
accompagnano le crisi familiari.
Si tratta di pulsioni spesso difficilmente arginabili e che
trovano molte difficoltà ad essere governate in sede
processuale, stante anche l’inadeguatezza dei rigidi
schemi del diritto ad adattarsi alla complessità delle
situazioni dibattute.
Non a caso la riforma del diritto di famiglia del 1975
aveva inciso in maniera sostanziale sull’istituto, sganciando la separazione dal concetto di colpa cui era
stata, fino ad allora, indissolubilmente legata.
Nel corso dei lavori preparatori si era fatta strada la
volontà di abbandonare ogni possibile riferimento alle
responsabilità individuali dei coniugi in relazione alla
crisi coniugale.
La ratio ispiratrice di tale tesi vedeva nella separazione
esclusivamente un rimedio ai problemi sorti nel matrimonio, senza che dovessero in alcun modo assumere
rilevanza le eventuali colpe dei coniugi che avevano
determinato la frattura del rapporto.
Temi Romana
59
Cronache e attualità
nunce giurisprudenziali che si sono succedute hanno
progressivamente affermato lo spirito della riforma del
1975, concentrandosi sul necessario rapporto che vi
doveva essere tra quei comportamenti (non più tipizzati) in violazione dei doveri matrimoniali posti in essere
da uno dei coniugi e la frattura del rapporto coniugale.
In tal modo, si è andato consolidando il principio
secondo il quale affinché si possa giungere ad una pronuncia di separazione con addebito è imprescindibile
che venga prima accertata, in maniera rigorosa, la sussistenza di un nesso causale tra la condotta contraria ai
doveri nascenti dal matrimonio e l’intollerabilità della
prosecuzione della convivenza, ovvero del grave pregiudizio all’educazione della prole12.
una delle cause tassativamente indicate dalla legge
come violazione dei doveri coniugali2.
Attraverso l’odierna formulazione dell’art. 155 c.c.,
invece, il legislatore ha operato un’inversione prospettica, ponendo l’accertamento dell’addebito solo come
eventuale ed eccezionale3 rispetto, invece, alla preminente verifica della sussistenza di fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da
recare grave pregiudizio all’educazione della prole4.
A decorrere dalla riforma del 1975, pertanto, il presupposto della separazione è dato dall’intollerabilità della
convivenza, che può determinarsi indipendentemente
da colpe dell’uno o dell’altro coniuge5 ed il cui accertamento andrà effettuato in chiave soggettiva, ovvero
per come viene percepita dal coniuge che domanda la
separazione.
Per la pronuncia di separazione, pertanto, non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la
frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di
distacco spirituale di una sola delle parti.
In tal modo, il diritto di ciascun coniuge di separarsi rappresenta l’attuazione di un diritto individuale di libertà,
riconducibile al combinato disposto degli artt. 2 e 29
della Carta costituzionale, che implicano per ciascun
coniuge il diritto di ottenere la separazione ed interrompere la convivenza ove, per fatti obiettivi, ancorché non
dipendenti da “colpa” dell’altro coniuge o propria, tale
convivenza sia per lui divenuta “intollerabile”, così da
essere divenuto impossibile svolgere adeguatamente la
propria personalità in quella “società naturale”, costituita con il matrimonio, che è la famiglia6.
In ragione di questa visione evolutiva del rapporto
coniugale, la declaratoria di addebito ha assunto carattere eventuale ed accessorio, richiedendo un’autonoma
domanda7 di parte ed i cui effetti si riverberano esclusivamente sul piano patrimoniale8, determinando la perdita del diritto all’assegno di mantenimento9 (ma non a
quello degli alimenti) e dei diritti successori10.
Come spesso accade, la giurisprudenza ha inizialmente
faticato a recepire il significato della riforma, sovrapponendo spesso il concetto di separazione per colpa a
quello di separazione addebitabile.
Nel tempo, anche grazie alla spinta propulsiva della
dottrina che sin da subito aveva dimostrato di aver
meglio colto la portata delle novità introdotte11, le pro-
2. Aspetti processuali del giudizio sull’addebito
Al Giudice è stato così demandato l’arduo compito di
stabilire se, effettivamente, il comportamento in violazione abbia causato la frattura del rapporto coniugale o
se, invece, abbia solamente aggravato o reso definitiva
la crisi matrimoniale.
Come è facile comprendere si tratta di un accertamento assai difficile, in quanto necessita di una valutazione
complessiva della condotta tenuta da entrambi i coniugi durante tutto il matrimonio, poiché il fallimento dell’unione è sovente frutto di un complesso di concause
maturate nel corso degli anni che, pertanto, non potrà
essere realmente compreso limitandosi al mero esame
di singoli episodi di frattura.
La necessità di comparazione delle rispettive condotte
dei coniugi all’interno del matrimonio, secondo parte
della dottrina13, ha confinato ad ipotesi del tutto residuali la possibilità – pur prevista dalla norma – di arrivare ad una pronuncia di “doppio addebito” a carico di
entrambi i coniugi, poiché in caso di reciproche violazione dei doveri nascenti dal matrimonio appare certamente ancora più arduo per il giudice districarsi tra
azioni e reazioni più o meno giustificate, nell’impervio
tentativo di isolare le singole responsabilità che giustifichino una pronuncia di addebito.
Ovviamente, la necessità di raffrontare i comportamenti tenuti da entrambi i coniugi è stata correttamente
esclusa in ipotesi di violenza intrafamiliare, in quanto la
gravità di tali atti non potrebbe certamente trovare valida giustificazione nella condotta dell’altro coniuge14.
In ogni caso, poiché è indubbio che la pronuncia di
60
Temi Romana
Cronache e attualità
costituisce mera deduzione difensiva e, pertanto, dovrà
essere inserita dal ricorrente nell’atto introduttivo del
giudizio, mentre – se proposta dal resistente – richiederà il rispetto dei termini e dei modi previsti per la
domanda riconvenzionale19.
Né, peraltro, può ritenersi che la domanda di addebito
possa essere introdotta a seguito di quella proposta in
via riconvenzionale dall’altro coniuge, in quanto le
istanze di addebito non presentano tra loro alcuna interdipendenza, poiché l’eventuale declaratoria di addebito
a carico di uno dei coniugi non esclude l’addebitabilità
della separazione anche all’altro.
È stata, invece, riconosciuta la possibilità di proporre
per la prima volta in appello la richiesta di un assegno
alimentare qualora la stessa sia conseguenza di un’intervenuta pronuncia di addebito della separazione, in
quanto tale domanda non può essere qualificata come
nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c., considerata anche la
natura degli interessi sottostanti. Per il giudice di legittimità, infatti, tale richiesta costituisce un minus ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un
assegno di mantenimento per il coniuge.
Sotto il profilo della prova, non vi è dubbio che il giudizio in materia di addebito presenti notevoli difficoltà,
risultando spesso assai difficoltoso dare contezza dell’abitualità e del progressivo ripetersi di comportamenti idonei a minare il rapporto coniugale.
Ragione per cui, qualora non si riesca a raggiungere la
piena prova che la condotta contraria ai doveri del
matrimonio posta in essere da uno dei coniugi, o da
entrambi, sia stata causa diretta del fallimento della
convivenza, il giudice dovrà necessariamente astenersi
da pronunciare la separazione con addebito20.
Inoltre, proprio a ribadire l’importanza di un’attenta
valutazione dell’effettiva sussistenza di un nesso causale tra violazione e crisi del rapporto, la Suprema Corte
ha avuto modo di affermare la tendenziale irrilevanza,
ai fini dell’addebito, di quei comportamenti in violazione avvenuti dopo che la crisi familiare si è già irreversibilmente consacrata21.
Anzi, con le più recenti pronunce la Corte romana è
andata anche oltre, negando la possibilità di ottenere il
mutamento del titolo della separazione sia in relazione
a comportamenti posti in essere successivamente alla
sentenza di separazione (od all’omologa dell’accordo)
che con riferimento a fatti preesistenti, ma di cui una
addebito si debba basare su un rigoroso accertamento
delle cause che hanno determinato la crisi dell’unione
coniugale, si è giustamente rilevato come sia da escludere che tale valutazione possa essere compiuta in sede
di udienza presidenziale, trattandosi di una fase processuale a cognizione sommaria.
Non a caso le Sezioni Unite hanno posto in risalto
come la richiesta di addebito, sia pur intimamente legata a quella di separazione, costituisca una domanda
autonoma15, determinando un ampliamento del thema
decidendum, i cui effetti si manifestano sul piano dei
rapporti patrimoniali tra i coniugi e che, pertanto,
necessita di un giudizio a cognizione piena.
La configurazione dell’istanza di addebito quale
domanda in senso tecnico, dotata di un proprio petitum
e di una propria causa petendi, seppur logicamente
subordinata alla pronuncia di separazione, introduce
quindi un’indagine su fatti indipendenti da quelli che
giustificano la separazione.
Non a caso il giudice non potrà indagare e statuire d’ufficio sul quesito dell’addebito, in quanto lo stesso
necessita dell’iniziativa di parte, così come inequivocabilmente previsto dall’art. 151, 2° comma, c.c..
Di conseguenza, è stata affermata la scindibilità della
domanda di separazione rispetto a quella relativa
all’addebito16; per cui, in ipotesi di impugnazione della
sola statuizione relativa all’addebito, la parte della sentenza dichiarativa della separazione acquisterà valore
di res iudicata17.
Da ciò ne discende la possibilità di proporre la successiva domanda di divorzio pur nella prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di addebito, dal momento
che il giudicato sulla pronuncia autonoma sulla separazione consente l’immediata dichiarabilità dello scioglimento del vincolo con sentenza non definitiva.
Per molti autori, proprio il fatto di aver ammesso il passaggio in giudicato del capo della sentenza sulla separazione ove quest’ultima sia stata impugnata solo sull’addebito, ha determinato un effetto deflattivo sulle liti
in corso, impedendo che tale impugnazione possa essere utilizzata al solo fine di dilatare i tempi della controversia, così da costituire un mero strumento di pressione sull’altro coniuge nei casi in cui quest’ultimo abbia
interesse ad una sollecita definizione della causa18.
Tra l’altro, sotto l’aspetto procedurale, la domanda di
addebito, proprio in ragione della sua autonomia, non
Temi Romana
61
Cronache e attualità
Del pari, dalla violazione degli obblighi inerenti allo
status di coniuge e di genitore potranno derivare anche
specifiche sanzioni penali. Ci si riferisce in particolare
all’art. 570 c.p. relativo alla “violazione degli obblighi
di assistenza familiare”; disposizione che, inserita tra i
delitti contro la famiglia, trova il suo fondamento nell’esigenza di tutelare i diritti della prole e del coniuge26.
parte sia venuta a conoscenza solo successivamente
alla pronuncia di separazione.
Di contro, è stato chiarito22 come il patto siglato tra i
coniugi al termine di un periodo di crisi matrimoniale
per regolare i loro rapporti economici non possa essere
considerato vincolante in sede di separazione nel caso
in cui si sia in presenza di una declaratoria di addebito.
Le conseguenze patrimoniali che derivano ex lege dalla
dichiarazione di addebito (art. 156, comma 1 e 3 c.c.)
inducono, infatti, ad escluderne radicalmente la vincolatività.
Quanto ai rapporti tra la declaratoria di addebito della
separazione ed i provvedimenti in materia di affidamento dei figli, va subito chiarito come non vi possa
essere tra loro alcun legame diretto, nel senso che tale
pronuncia non potrà essere considerata di per sé ostativa all’affidamento condiviso dei figli minori.
Sul punto la Suprema Corte ha espresso il principio di
diritto in base al quale “in tema di separazione personale i provvedimenti di affidamento della prole minore
prescindono dalle responsabilità dell’uno e dell’altro
coniuge23 nel rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza coniugale, dovendo essere adottati con
esclusivo riferimento al superiore interesse morale e
materiale della prole stessa”24.
Ovviamente, nelle ipotesi residuali in cui la separazione sia stata pronunciata in relazione a gravi condotte
poste in essere da uno dei coniugi ed idonee a determinare un grave pregiudizio alla educazione della prole, il
giudice potrà certamente utilizzare gli accertamenti
relativi all’addebito anche al fine di decidere sul regime di affidamento dei figli della coppia.
Da ultimo – rimandando all’apposito capitolo per un
approfondimento del tema – preme solo ricordare
come, poiché i doveri che derivano ai coniugi dal
matrimonio hanno natura giuridica, la loro violazione
non trovi sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quali l’addebito della separazione.
Ove tale violazione, infatti, cagioni la lesione di diritti
costituzionalmente protetti, la stessa potrà integrare gli
estremi dell’illecito civile, dando così luogo anche ad
un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni
non patrimoniali, senza che la mancanza di pronuncia e
di addebito in sede di separazione sia preclusiva
all’azione di risarcimento relativa a tali danni25.
3. Addebito della separazione: quale futuro?
A distanza di quasi quarant’anni dall’intervenuta riforma del diritto di famiglia, è lecito interrogarsi se oggi
abbia ancora senso parlare di addebito della separazione, anche in considerazione dei mutati costumi e dell’intervenute trasformazioni sociali.
Secondo una parte della dottrina, la funzione dell’addebito sarebbe quella di evitare al coniuge “che ha patito
una convivenza non solo fallita, ma travagliata da una
condotta dell’altro contraria agli impegni assunti con il
matrimonio, di restare legato a quest’ultimo da obblighi di assistenza e vincoli di carattere ereditario” anche
successivamente all’intervenuta separazione27.
Inoltre, vi sarebbe anche un interesse del coniuge non
colpevole a vedere riconosciuta la propria correttezza
nel rispetto dei doveri coniugali, sia nei confronti della
prole e dei parenti, sia in vista di un possibile nuovo
matrimonio28.
Ora, se non vi è dubbio che la domanda di addebito
conservi un’indiscussa valenza nelle ipotesi in cui uno
dei coniugi si renda autore di condotte gravemente lesive della dignità della persona e della sua integrità
psico-fisica, è altrettanto vero come nel tempo si stia
affievolendo la sensibilità degli effetti della pronuncia
dell’addebito sotto il profilo dell’interesse pubblico
alla tutela dei diritti nascenti dal matrimonio.
D’altro canto non si può ignorare come il giudizio sull’addebito della separazione, oltre a risvolti di natura
patrimoniale, coinvolga anche delicati aspetti psicologici, alimentando tra i coniugi quella conflittualità che
inevitabilmente si ripercuote sui figli minori.
Peraltro, la necessità per il Giudice di estendere l’accertamento all’intera vicenda matrimoniale, per stabilire se effettivamente la violazione posta in essere da uno
dei coniugi sia effettivamente la causa diretta della
crisi, introduce nel giudizio elementi di soggettività
difficilmente decifrabili.
Quando, infatti, la crisi familiare cessa di essere un
62
Temi Romana
Cronache e attualità
A questo ha certamente contribuito anche un’altra
ragione che risiede nella bulimia che investe i nostri
Tribunali31, ormai sommersi da una mole spropositata
di ricorsi per separazione e divorzio in cui il litigio
sembra essere l’unico modo per i coniugi per non rompere definitivamente il filo che li lega, quasi a voler
impedire che il partner possa ritrovare una propria
libertà ed autonomia.
Così i Tribunali hanno finito sempre più per ignorare le
istanze di addebito della separazione proposte, anche
reciprocamente, dai coniugi, impendendo spesso l’ingresso nel processo di parenti ed amici pronti a sconfessarsi tra loro pur di sostenere le ragioni di uno o l’altro coniuge.
I fautori di tale orientamento32 – che di fatto pone un
notevole sbarramento all’accoglimento delle domande
di addebito – osservano come lo stesso abbia il pregio
di evitare di appesantire ulteriormente la procedura di
separazione, magari favorendo persino il raggiungimento di accordi consensuali, offrendo al contempo un
contributo determinante nel cercare di contrastare un
retaggio culturale che vede nella fine del matrimonio
un momento in cui si debba necessariamente distribuire giudizi o riparare a presunti torti.
I sostenitori dell’eliminazione dell’istituto dell’addebito hanno, poi, posto l’accento anche sul fatto che molto
spesso le conseguenze dirette che derivano dalla declaratoria sono lievi e prive di effettiva praticabilità, come
nel caso la separazione venga addebitata ad un coniuge
che goda di redditi autonomi e sufficienti, tali da non
legittimare alcuna richiesta di mantenimento.
Del pari, sempre secondo la dottrina sopra richiamata,
anche nel campo successorio gli effetti sarebbero piuttosto limitati, in quanto riferibili solamente al periodo
intercorrente tra separazione e divorzio.
Ciò premesso, non vi è dubbio che anche in ragione
dell’accostamento della responsabilità civile al diritto
di famiglia determinatosi in questi ultimi anni, sia più
che doveroso interrogarsi sull’attualità e sull’utilità
dell’istituto dell’addebito.
Nell’ambito di tale condivisibile riflessione, però, non
bisognerà cadere nella tentazione di imboccare pericolose scorciatoie che, nel rifiuto aprioristico di un rigoroso esame delle ragioni poste alla base della domanda di addebito, finiscano per privare l’istituto del
matrimonio di quelle tutele che fino ad oggi hanno
evento privato per essere calata, attraverso il giudizio
di separazione, in una dimensione pubblica-giuridica è
inevitabile che le diverse visioni che le parti hanno
della vicenda coniugale e delle cause che ne hanno
determinato la fine entrano a far parte del processo.
In tal modo i fatti narrati dal cliente secondo il proprio
punto di vista vengono modellati dai rispettivi avvocati in ragione della strategia processuale che si ritiene
più idonea al raggiungimento degli obiettivi prefissati29.
Torti e ragioni finiscono così per mescolarsi, impedendo di comprendere se realmente la violazione dei doveri matrimoniali posta in essere da uno dei coniugi possa
essere realmente considerata come il peccato originale
che ha determinato la fine dell’unione coniugale.
Peraltro, è evidente come il giudizio sull’addebito
necessiti di apprezzamenti di fatto in relazione ad un
quadro di “valori”, cosicché la medesima violazione, a
seconda del rapporto e del contesto sociale nel quale lo
stesso si è estrinsecato, può determinare o meno un’effettiva situazione di intollerabilità della convivenza.
Il giudice, quindi, si trova spesso davanti a due versioni discordanti, se non incompatibili, che oltre a rendere
difficile la decisione, rischiano di prestarsi a valutazioni soggettive da parte dello stesso giudice il quale,
avventurandosi in ambiti della vita personale e familiare talvolta imperscrutabili anche agli stessi protagonisti
della vicenda, diventa inevitabilmente anch’egli portatore dei propri pregiudizi mentali e culturali.
In tale quadro non è difficile comprendere come il giudizio legato alla domanda di addebito mostri tutti i propri limiti, poiché è riduttivo immaginare di poter racchiudere in un istruttoria od in una sentenza un fenomeno così complesso e spesso di lunga durata (anni di vita
quotidiana) com’è il rapporto a due30.
Per cui troppe volte i coniugi tendono a riporre nel giudizio aspettative illusorie ed irrealistiche, in quanto il
processo legale non è certamente luogo per il raggiungimento di verità assolute.
Il confine tra comportamento lecito, espressione del
diritto a separarsi, e la violazione dei doveri matrimoniali determinante l’insorgenza della intollerabilità della
convivenza, è così divenuto nel tempo molto labile.
A fronte di tali oggettive difficoltà, anche legate al
mutamento dei costumi, con il passare degli anni le
domande di addebito hanno sempre più faticato a trovare accoglimento in sede processuale.
Temi Romana
63
Cronache e attualità
contribuito – sia pure con i loro innegabili limiti – a
difendere la solennità e la giuridicità degli impegni
assunti dai coniugi.
mento ormai costante, ha precisato che: «ai fini dell’addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve
accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata
provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista
un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il
verificarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza,
o se piuttosto la violazione dei doveri che l’art. 143 c.c.
pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già
maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o
per effetto di essa» (Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n.
8873; Cass. Sez. I, 2008, n. 14042, conf. Cass. Sez. I,
2010, n. 21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999,
n. 7566, Cass. Sez. I, 1998, n. 10742).
Ciò che la Suprema Corte di Cassazione richiede dunque, per poter addebitare la separazione al “coniuge
trasgressore”, è che la crisi dell’unione coniugale sia
riconducibile secondo un nesso di causa-effetto alla
violazione di uno degli obblighi di cui all’art.143 c.c.
(ad esempio dell’obbligo di fedeltà coniugale). Mentre
è irrilevante ai fini dell’addebito il comportamento
tenuto dal coniuge che ha “trasgredito” (per es. infedele) successivamente al verificarsi di una situazione di
intollerabilità della convivenza.
Per tale ragione, la parte richiedente l’addebito deve
fornire in giudizio la prova che la violazione degli
obblighi nascenti dal matrimonio sia stata la causa
(unica o prevalente e determinante) dell’intollerabilità
dell’ulteriore convivenza fino a determinare la separazione33-36.
Qualora invece emerga nel corso del giudizio che alla
suddetta violazione preesisteva una diversa causa di
intollerabilità della convivenza (per cui la crisi coniugale era già in atto), il Giudice dovrà pronunciare la
separazione ma senza addebito (Cass. 2001, n. 12130).
CAPITOLO SECONDO
di Barbara Capicotto e Anna Lanza
Avvocati del Foro di Roma
4. L’addebito nella separazione
In forza del novellato art. 151 c.c. attualmente la separazione può essere chiesta quando per qualsiasi motivo
sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra
i coniugi (c.d. affectio maritalis) e la convivenza sia
ormai divenuta intollerabile o possa arrecare un pregiudizio ai figli (Cass. 1994, n. 10512). La Dottrina e la
Giurisprudenza definiscono nella prassi queste fattispecie come “separazione senza colpa o per incompatibilità di carattere”.
La separazione con addebito non configura un tipo di
separazione a sé, ma necessita comunque di una specifica domanda dell’attore o, in via riconvenzionale, del
convenuto, la quale può essere abbandonata in qualsiasi grado del giudizio.
Nel caso in cui venga ritenuto insussistente l’addebito,
può essere pronunciata separazione senza addebito.
Spetta pertanto al Giudice, solo se vi è una espressa e
specifica domanda, pronunciare la separazione con
addebito a seguito di una discrezionale valutazione con
riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da
parte di uno o di entrambi i coniugi. Tale valutazione
deve comprendere e basarsi sul comportamento complessivo tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio
nello svolgimento del rapporto coniugale.
5. Presupposti per la pronuncia di addebito
1) Un comportamento cosciente e volontario contrario
ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all’art. 143
c.c.: per esempio infedeltà coniugale qualora uno dei
due coniugi abbia una relazione extraconiugale, abbandono della casa coniugale; infedeltà apparente che
costituisca grave offesa all’altro coniuge, mentre non è
necessario che vi sia l’intenzione di ledere l’altro
coniuge o recargli nocumento.
*
2) Tale violazione deve essere la causa determinante
della crisi coniugale. La Giurisprudenza, con orienta-
6. Giurisprudenza di legittimità e di merito
A tal proposito sebbene la Cassazione con orientamento
costante ribadisce quanto sopra richiamato. Degne di particolare menzione appaiono alcune Sentenze dei Tribunali
di Merito ed in particolare la Giurisprudenza del Tribunale
di Roma che con riferimento agli aspetti più problematici
della richiesta di addebito precisa quanto segue:
1) Abbandono della casa coniugale e violazione dell’obbligo di coabitazione. La Corte di Cassazione ha
precisato che non costituisce causa di violazione del-
64
Temi Romana
Cronache e attualità
l’obbligo matrimoniale, e non è quindi causa di addebito, se l’abbandono della casa coniugale è determinato
dalla “mancanza di una appagante e serena intesa sessuale” (Cass., Sez. I, 31.5.2012 n. 8773). Nella fattispecie presa in esame dalla Corte la moglie aveva abbandonato la casa coniugale a causa di problematiche di
natura sessuale (mancanza di intesa sessuale). Il marito, in sede di ricorso in Cassazione, evidenziava che le
problematiche lamentate erano da imputare alla donna
che “si presentava indisponibile e priva di recettività”.
La Suprema Corte confermando l’orientamento dominante, rigettava le richieste del marito ribadendo che la
mancanza di intesa sessuale rappresenta una «giusta
causa» per abbandonare il tetto coniugale per cui chi
lascia il coniuge, non vivendo con lui un rapporto
«sereno e appagante» non rischia di vedersi addebitata
la colpa della separazione.
Altra causa ritenuta dalla Suprema Corte giustificativa
dell’abbandono della casa coniugale è costituita dai
frequenti litigi domestici della moglie con la suocera
convivente37.
2) Allontanamento dalla casa coniugale. La
Cassazione, riformando la sentenza dei giudici di
primo e secondo grado, ha stabilito che “è sufficiente
una lettera di addio del coniuge all’altro per provare la giusta causa dell’allontanamento definitivo
dalla casa coniugale” (Cass. Pen., Sez. VI, 11.9.2012
n. 34562).
Nella fattispecie il marito (che in primo e secondo
grado era stato condannato ai sensi dell’art. 570 c.p.)
aveva lasciato una lettera di addio alla moglie in cui
giustificava la sua scelta con riferimento ad una situazione di intenso disagio nei rapporti con il proprio
coniuge.
La Cassazione preso atto di tale circostanza ha precisato che in presenza di questo elemento che pare aver
determinato una situazione di intollerabilità della vita
coniugale, i Giudici di merito avrebbero dovuto accertare la presenza di una giusta causa di allontanamento
fermo restando che l’imputato si era allontanato ma
senza far venire meno i mezzi di sussistenza ai figli.
Ribadisce la Suprema Corte che: “il giudice non può
esaurire il proprio compito nell’accertamento del fatto
storico dell’abbandono, ma deve ricostruire la situazione in cui esso si è verificato onde valutare la presenza di cause di giustificazione, per impossibilità, intolle-
Temi Romana
rabilità o estrema penosità della convivenza”. L’art.
570 c.p. rende punibile non l’allontanamento (rectius
abbandono del domicilio domestico) in sé ma quello
privo di una giusta causa.
Al contrario, viene ritenuto motivo di addebito della
separazione, l’allontanamento del marito dalla casa
familiare dettato non da esigenze lavorative, ma dall’intento di abbandonare la famiglia38, mentre non costituisce causa di addebito39 quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità
della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.
3) Violazione dell’obbligo di fedeltà. Presuppone una
comunione spirituale tra i coniugi ed implica un “impegno globale di devozione” al fine di garantire e consolidare una ampia armonia interna tra gli stessi. In tal
senso dunque la fedeltà sessuale è solo un aspetto (un
minus) anche se rilevante di tale obbligo coniugale.
Precisa la Cassazione che l’addebito per violazione di
tale obbligo sussiste pertanto qualora vi siano state violazioni degli obblighi matrimoniali, gravi e ripetute,
che abbiano causato l’intollerabilità della prosecuzione
della convivenza (Cass. 8862/2012). Ciò vale in generale per tutti gli obblighi nascenti dal matrimonio e non
solo per quello di fedeltà.
Interessante appare anche la sentenza della Cassazione
n. 21245 del 2010, nella quale viene riconosciuto l’addebito al coniuge che tradisce l’altro e rende nota la sua
relazione extraconiugale agli amici di famiglia.
Tuttavia anche in questo caso la Giurisprudenza per
escludere l’addebito richiede che si fornisca la PROVA
che il ménage preesistente restava in piedi solo sul
piano formale (Cass. Sez. I, 2010 n. 21245).
Recentemente la Cassazione ha anche precisato che
sempre nell’ottica in cui la violazione dell’obbligo
coniugale deve essere la causa della frattura dell’unione coniugale nell’ambio del più ampio menage familiare preesistente, ha negato l’addebito della separazione
al marito fedifrago se la moglie era contraria ad avere
figli. In tale caso la Corte ha ritenuto che la reazione
extraconiugale del marito era proporzionata all’omissione dei doveri coniugali da parte della moglie (Cass.
21.9.012).
4) Prova dell’addebito Cass. 2012 n. 2059. Grava
sulla parte che richiede, per l’inosservanza dell’obbligo
di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniu-
65
Cronache e attualità
ge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione
della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce
l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su
cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della
crisi matrimoniale all’accertata infedeltà. (Rigetta,
App. Bari, 2.2.2010)40, anche se in una recente sentenza, la Cassazione ha affermato che “Deve escludersi
che il richiedente la separazione con addebito debba
altresì fornire la prova che la crisi coniugale sia stata
provocata in via diretta ed esclusiva dall’accertata
relazione extraconiugale intrattenuta dall’altro coniuge. Nella specie, peraltro, non contestata”41.
Non può non evidenziarsi che la prova per l’accertamento della violazione dei doveri matrimoniali, ai fini
della dichiarazione di addebito, risulta spesso indiziaria e indiretta perché i fatti oggetto di causa, sono
avvenuti tra le mura domestiche o nella dimensione privata dei soggetti coinvolti. Quando si tratta di provare
l’infedeltà coniugale entrano in gioco una serie di elementi probatori che singolarmente non avrebbero alcun
valore, ma unitariamente considerati possono condurre
il giudice a considerare il fatto come provato
(Cassazione 6 novembre 2012, n. 19114). Si tratta di
prove indiziarie (le così dette testimonianze de relato
o indirette da parte di soggetti terzi estranei alla vicenda), poiché il fatto non è sottoposto alla diretta percezione fisica del teste. Tali dichiarazioni testimoniali
secondo la Suprema Corte possono divenire valido
elemento di prova se sono suffragate da altre circostanze oggettive e soggettive o da altre risultanze
probatorie acquisite al processo che concorrano a rafforzarne la credibilità (Cass. Civ. 19 maggio 2006, n.
11844 e Cass. Civ. 8 febbraio 2006, n. 28159). Pertanto
il Giudice nel pronunciare l’addebito potrà basare la
propria decisione anche su presunzioni purché siano
gravi, precise e concordanti.
Ciò significa che nel giudizio di separazione e divorzio
potranno essere sentiti come testi i familiari e in generale i parenti delle parti la cui attendibilità dovrà essere
successivamente valutata dal Giudice sia con riguardo
alla deposizione, sia con riguardo agli episodi riferiti.
Inoltre, il giudice di merito non è obbligato ad accettare integralmente la deposizione di un teste ma potrà
scinderla e accettarla soltanto per quella parte che
meglio si armonizza con le altre risultanze di causa e
che quindi riterrà discrezionalmente più attendibile.
*
Sempre in tema di infedeltà coniugale, la Cassazione
nega l’addebito in caso di tradimenti reciproci dei
coniugi, non attribuendo valore alcuno al soggetto che
ha tradito per primo42.
Del pari, la Corte Suprema nega l’addebito della separazione a carico del marito che abbia convissuto con
un’altra donna in costanza di matrimonio, ove si sia
determinata medio tempore una separazione di fatto
dalla consorte43.
In una sentenza di approccio particolarmente “aperto”,
la Cassazione ha negato efficacia ai fini dell’addebito
anche alla relazione extraconiugale della moglie, stante il successivo periodo di riappacificazione tra i coniugi44. Al contrario, è stata addebitata la separazione alla
moglie che dopo la conciliazione seguita alla separazione, ha intrattenuto una convivenza con un terzo
uomo45.
In ogni caso il Tribunale di Roma è tranciante nel suo
giudizio, ove afferma che “In materia di separazione
giudiziale dei coniugi non può essere accolta la
domanda di addebito di uno dei coniugi qualora non ne
venga data idonea prova in giudizio”46.
*
Sul nesso di causalità: alcune pronunce del giudice
di merito
- Corte Appello Roma 8.2.2012 sempre in tema di
prova e infedeltà coniugale
In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente
l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza,
deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge
responsabile, sempre che non si constati la mancanza di
nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante
accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva
del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne
risulti la preesistenza di una crisi irrimediabilmente il
fatto in un contesto caratterizzato da una convivenza
meramente formale.
- Appello Roma 21.9.2011 addebito e accertamento
del Giudice
66
Temi Romana
Cronache e attualità
In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi esclusivamente
sull’accertamento della violazione dei doveri posta
dall’art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo,
invece, necessario accertare se tale violazione, lungi
dall’essere intervenuta quando era già maturata ed in
conseguenza di una situazione di intollerabilità della
convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale
nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.
L’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di
entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità
della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica.
- In senso conforme a Cassazione Civile, Sez. I,
24.2.2011 n. 4540
La giusta causa legittimante l’allontanamento di uno
dei coniugi dalla casa coniugale, prima della separazione, deve intendersi identificabile non solo nel comportamento illegittimo dell’altro coniuge, anch’esso concretatosi nella violazione dei doveri coniugali, ma
anche nella obiettiva determinatasi situazione di intollerabilità della convivenza coniugale. In tal senso, pertanto, l’abbandono del tetto coniugale non costituisce
violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, e conseguente causa di addebito della separazione, qualora
legittimato da una giusta causa nei termini di cui innanzi, con ciò dovendosi intendere anche i frequenti litigi
della moglie, poi allontanatasi, con la suocera, qualora
determinanti un progressivo deterioramento del rapporto di coniugio.
- Appello Roma, 16.2.2011
In tema di separazione personale dei coniugi, l’abbandono della casa familiare, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, con la conseguenza che
il volontario allontanamento dal domicilio coniugale è
causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza,
salvo che si provi – e l’onere incombe a chi ha posto in
essere l’abbandono – che esso é stato determinato dal
comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il
suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui
l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si
sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.
- Tribunale Roma, Sez. I, 1.2.2011
II volontario abbandono del domicilio coniugale costi-
Temi Romana
tuisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è pertanto di per sé sufficiente a configurare, in quanto porta
all’impossibilità della convivenza, causa di addebito
della separazione, salvo che si provi – e l’onere incombe su chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è
stato determinato dall’altro coniuge ovvero che sia
intervenuto quando l’intollerabilità della prosecuzione
della convivenza si era già verificata.
- Appello Roma, 13.10.2010
La dichiarazione di addebito della separazione necessita della prova che l’irreversibile crisi coniugale sia
riconducibile in via esclusiva alla condotta volontariamente e consapevolmente contraria ai doveri nascenti
dal matrimonio assunta da uno o da entrambi i coniugi,
ovverosia che sussista un nesso eziologico tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza. In caso di mancato
raggiungimento della suddetta prova, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
- Conf. anche con Appello Roma 8.9.2010; Cass.
Civ., Sez. I, 19.7.2010 n. 16873; Appello Roma
30.6.2010; Appello Roma 9.6.2010
In materia di separazione dei coniugi, con riguardo
all’addebito, può ritenersi sussistente la responsabilità
quantomeno prevalente nel fallimento del matrimonio
di quel coniuge che ha posto in essere nei confronti dell’altro coniuge e del figlio (nel caso di specie gravemente disabile) condotte violative dei doveri scaturenti
dal matrimonio, eziologicamente collegabili al fallimento del rapporto – Tribunale Roma, Sez. I,
10.3.2011, n. 5212.
*
Altre cause di addebitabilità della separazione
Oltre alla infedeltà ed all’abbandono della casa familiare, la giurisprudenza individua anche altre possibili
cause di addebito della separazione.
Al riguardo, la Cassazione precisa i confini dei comportamenti atipici a cui è possibile ricondurre l’addebito della separazione: “In tema di addebitabilità della
separazione personale, ove i fatti accertati a carico di
un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili – traducendosi nell’aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l’incolumità e l’integrità fisica, morale e
sociale dell’altro coniuge, ed oltrepassando quella
soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque
67
Cronache e attualità
Altro caso in cui la Cassazione ha addebitato al marito
la separazione riguarda la scelta del marito di fissare la
residenza familiare nel luogo più consono alla propria
attività lavorativa non curandosi delle esigenze della
moglie, prossima al parto54.
necessaria e doverosa per la personalità del partner –
essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest’ultimo, e si
sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per
escludere l’addebitabilità nei confronti del coniuge che
quei fatti ha posto in essere”47.
Sicuramente una delle cause di addebito della separazione è costituita dalla violenza endofamiliare, in relazione alla quale, il Tribunale di Roma ha concesso l’addebito a carico del marito il quale: “non soltanto non ha
ottemperato ai propri doveri familiari ma ha altresì
avuto nel corso della convivenza coniugale condotte
ripetutamente violente nei confronti delle figlie e della
moglie esternatesi in aggressioni fisiche, espressioni
scurrili ed offensive, scatti di rabbia incontrollata a
fronte di motivi futili se non inesistenti, intolleranza nei
confronti dei familiari, oltre ad essersi più volte allontanato dall’abitazione familiare per periodi prolungati
senza più dare notizie di sé”48.
La Cassazione ha confermato la pronuncia di addebito
al marito che si è reso protagonista anche di un solo
episodio di percosse, soprattutto ove causato da un
motivo banale e futile come l’aver gettato nella spazzatura un tozzo di pane raffermo49.
Il marito è stato ritenuto responsabile della separazione
che gli è stata addebitata, per aver fatto mancare il suo
sostegno morale e materiale alla moglie malata di
depressione50.
Al contrario, la Cassazione non ritiene sussistere una
valida causa di addebito della separazione ove un coniuge si rechi all’estero ad assistere un genitore malato51.
Ai coniugi viene richiesto, altresì, pena l’addebito della
separazione, di comunicare all’altro coniuge un’eventuale incapacità ad avere figli: in caso contrario, il comportamento tenuto dall’altro coniuge viene considerato
una mera conseguenza dell’omessa verità sulla propria
impotenza a generare e non da luogo all’addebito della
separazione52.
Altra fattispecie particolare di addebito della separazione è costituita dalla la condotta del marito che ha imposto alla moglie pratiche di scambio di coppia e di amori
di gruppo, le quali, seppur dalla stessa a lungo accettate, hanno determinato un atteggiamento violento ed
umiliante del marito allorquando la stessa ha dichiarato di volerle interrompere53.
CAPITOLO TERZO
di Patrizia Paris
Avvocato del Foro di Roma
7. Il risarcimento del danno nella separazione con
o senza addebito
Il tema della responsabilità civile nell’ambito delle
relazioni coniugali si colloca nel contesto della progressiva valorizzazione delle posizioni individuali.
Venuto meno il profilo istituzionale, che voleva gli
interessi dei familiari subordinati a quelli “superiori”
del consorzio, è mutata l’intera prospettiva in cui si collocano le situazioni attinenti la responsabilità civile;
infatti nuovi spazi ha conquistato nell’area dei rapporti
tra coniugi e tra genitori e figli l’illecito civile, a testimoniare ancora una volta l’attenzione dell’ordinamento alle prerogative individuali, un tempo sacrificate
dalle incombenti potestà familiari.
Le norme che regolano il diritto di famiglia hanno
costituito fino ad oggi un sistema autonomo, completo
e autosufficiente, assolutamente refrattario al concetto
della responsabilità civile ex art. 2043 c.c., ma la rielaborazione giurisprudenziale ha apportato profonde
modifiche a tale impianto; così la responsabilità aquiliana, con il suo risarcimento del danno ingiusto ha
fatto l’ingresso anche all’interno delle problematiche
della famiglia.
Si tratta, dunque, di una nuova forma di tutela che trova
il presupposto in una ridefinizione – avviata con la
riforma del 1975 – del concetto di “famiglia”, da formazione sociale a sé stante, capace da sola di tutelare i
propri membri da eventuali illeciti endofamiliari, a formazione sociale che valorizza i diritti fondamentali
costituzionalmente protetti dei suoi singoli appartenenti come persone, alle quali viene riconosciuta una ulteriore tutela.
Attualmente dottrina e giurisprudenza unanimemente
riconoscono la risarcibilità del danno endofamiliare,
sempre che la condotta del coniuge contraria ai doveri
nascenti dal matrimonio abbia altresì cagionato un
68
Temi Romana
Cronache e attualità
danno ingiusto suscettibile di essere risarcito ai sensi
degli artt. 2043 ss..
Lo status di coniuge non può certo comportare una
riduzione ed una limitazione delle prerogative riconosciute a tutte la persone, ma semmai può prevedere un
aggravamento delle conseguenze a carico del familiare
responsabile.
Il problema consiste nel verificare le circostanze nelle
quali la condotta di un coniuge cagiona all’altro un
danno ingiusto, nonché i rapporti che intercorrono tra
la violazione dei doveri matrimoniali, l’addebito della
separazione ed il danno ingiusto.
Appare difficile sostenere che la semplice violazione
dei doveri matrimoniali possa legittimare una condanna al risarcimento del danno; pertanto è necessario
escludere ogni automatismo di giudizio tra la violazione dei doveri coniugali, il giudizio di addebito della
separazione e il danno.
Il comportamento di un coniuge in violazione dei doveri matrimoniali, può provocare l’addebito della separazione, soltanto se ha determinato l’intollerabilità della
prosecuzione della convivenza, oppure il grave pregiudizio all’educazione della prole.
Può portare ad una responsabilità aquiliana se concretizza un danno ingiusto, che non necessariamente coincide con la violazione dei doveri matrimoniali o con la
declaratoria di addebito.
Il risarcimento del danno può essere accordato quando
la condotta, particolarmente grave, del coniuge ha violato non solo uno dei diritti nascenti dal matrimonio,
ma ha anche provocato la lesione di un interesse ulteriore, tutelato dall’ordinamento; in tal caso se non si
riconoscesse il risarcimento del danno, tale interesse
rimarrebbe privo di tutela, perché non potrebbe essere
compensato con i rimedi specifici previsti nell’ambito
del diritto di famiglia.
La violazione dei doveri derivanti dal matrimonio rappresenta il presupposto per accertare la concreta lesione di un interesse tutelato, al riguardo la Suprema Corte
ha affermato a chiare lettere che «il rispetto della dignità e della personalità di ogni componente del nucleo
familiare assume i connotati di diritto inviolabile, la
cui lesione da parte dell’altro componente del nucleo
della famiglia, così come da parte del terzo, costituisce
il presupposto logico della responsabilità civile, non
potendo ritenersi che diritti definiti come inviolabili
Temi Romana
ricevano tutela diversa a seconda che i loro titolari si
pongano o meno all’interno di un contesto familiare»
(Cassazione, 10 maggio 2005, n. 9081).
Il rapporto tra violazione dei doveri coniugali e responsabilità aquiliana deve essere inquadrato nel più ampio
contesto del risarcimento del danno per lesione di un
interesse costituzionalmente rilevante ex art. 2059 c.c.,
“... Appare significativa l’evoluzione della giurisprudenza di questa S.C., sollecitata dalla sempre più avvertita esigenza di garantire l’integrale riparazione del
danno ingiustamente subito, non solo nel patrimonio
inteso in senso strettamente economico, ma anche nei
valori propri della persona (art. 2 Cost.). In proposito
va anzitutto richiamata la rilevante innovazione costituita dall’ammissione a risarcimento (a partire dalla
sentenza n. 3675-81) di quella peculiare figura di danno
non patrimoniale (diverso dal danno morale soggettivo)
che è il danno biologico, formula con la quale si designa l’ipotesi della lesione dell’interesse costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.) alla integrità psichica e
fisica della persona. Non ignora il Collegio che la tutela risarcitoria del c.d. danno biologico viene somministrata in virtù del collegamento tra l’art. 2043 c.c. e
l’art. 32 Cost., e non già in ragione della collocazione
del danno biologico nell’ambito dell’art. 2059, quale
danno non patrimoniale, e che tale costruzione trova le
sue radici (v. Corte cost., sent. n. 184-1986) nella esigenza di sottrarre il risarcimento del danno biologico
(danno non patrimoniale) dal limite posto dall’art.
2059 norma nel cui ambito ben avrebbe potuto trovare
collocazione, … si deve ormai ritenere acquisito dal
diritto positivo la nozione di danno non patrimoniale
inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona, e non più solo come “danno morale soggettivo”
(Cassazione, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828).
Il danno non patrimoniale così configurato costituisce
la forma più appropriata per un adeguato ristoro alla
lesione subita dal familiare, in quanto consente di offrire una tutela indipendentemente dalla circostanza che
la condotta lesiva integri fattispecie delittuosa, o fattispecie per la dichiarazione dall’addebito della separazione (Cassazione, n. 18853/11).
Al riguardo merita una lettura attenta la recente sentenza della I Sezione Civile della Corte di Cassazione, del
15 settembre 2011, n. 18853, che si è espressa con
molta chiarezza al riguardo: “se la violazione del dove-
69
Cronache e attualità
re di fedeltà arriva a ledere diritti fondamentali ed
inviolabili, il coniuge tradito, a prescindere dalla
separazione o addebito, ha diritto al risarcimento”.
La ricorrente dopo aver scoperto la relazione adulterina del marito con una donna sposata, aveva prima proposto ricorso per separazione giudiziale, con richiesta
di addebito, ma poi, preferendo accelerare il più possibile la procedura, ha sottoscritto un verbale di separazione consensuale, ritualmente omologato, e solo successivamente ha attivato un nuovo giudizio, questa
volta ordinario, perché la relazione extraconiugale di
cui era stata vittima, suo malgrado, aveva leso profondamente la sua dignità, l’immagine, etc., diritti fondamentali riconosciuti dall’ordinamento. Il marito, infatti, non aveva mai cercato di nascondere quella relazione, ma anzi l’aveva “consumata” pubblicamente, senza
mai mostrare il minimo riguardo per la moglie, per la
sua dignità, la sua immagine, i suoi rapporti sociali,
la sua riservatezza e la sua stessa salute.
E proprio per l’umiliazione inferta da questo “tradimento plateale” che la moglie si è determinata a
chiedere il risarcimento per tutte le sofferenze che il
coniuge le aveva provocato.
La domanda veniva respinta sia in primo che in secondo grado.
Le pronunce negative non hanno scoraggiato la ricorrente che si è rivolta alla Suprema Corte chiedendo la
“cassazione” della decisione con cui i giudici di appello avevano negato il diritto al risarcimento dei danni
provocati dalla “violazione dell’obbligo di fedeltà,
avvenuto con modalità particolarmente frustranti,
stante la notorietà della relazione intrattenuta con
donna sposata”.
Con il proprio ricorso l’istante ha rilevato come la decisione d’appello fosse viziata da un errore di fondo, perché dopo aver confermato l’applicabilità, anche in caso
di violazione dei doveri matrimoniali, delle norme in
tema di responsabilità, le aveva poi ingiustamente
negato il risarcimento per uno “specifico presupposto”:
“l’abbandono della domanda di addebito presupporrebbe la volontà da parte dei coniugi di non accertare
la causa della crisi coniugale”.
La ricorrente contestando proprio questa erronea trasposizione, in un giudizio risarcitorio, di regole ed i
limiti che sono previsti dall’art. 151 c.c. e che sono,
dunque, applicabili esclusivamente in tema di separa-
zione con addebito (con conseguenze del tutto peculiari e limitate) nell’adire la Corte di Cassazione chiedeva
preliminarmente che si disponesse che: “la mancanza
di addebito in sede di separazione per mutuo consenso non è preclusiva di separata azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri
nascenti dal matrimonio e riguardanti diritti costituzionalmente protetti”.
La Cassazione chiarendo la propri posizione dichiarava
che: “Ove nel giudizio di separazione non sia stato
domandato l’addebito o si sia rinunciato alla pronuncia di addebito, il giudicato si forma coprendo il
dedotto e il deducibile unicamente in relazione al
‘petitum’ azionato e non sussiste pertanto alcuna preclusione all’esperimento dell’azione di risarcimento
per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio,
così come nessuna preclusione si forma in caso di
separazione consensuale”.
La Corte ha poi analizzato le richieste risarcitorie della
ricorrente evidenziando che la mera violazione dei
doveri matrimoniali e finanche la pronuncia di addebito non possono di per sé ed automaticamente integrare
una responsabilità risarcitoria; in particolare il dovere
di fedeltà del nostro diritto di famiglia deve conciliarsi
anche con il diritto di libertà garantito dall’art. 2 della
Costituzione, che prevede per ciascun coniuge il diritto
di separarsi e divorziare, a prescindere dalla volontà o
dalle colpe dell’altro coniuge: “ciascun coniuge può
legittimamente far cessare il proprio obbligo di fedeltà proponendo domanda di separazione”.
Dunque la “semplice” violazione in costanza di convivenza matrimoniale del dovere di fedeltà, potrà
senz’altro costituire valido motivo di separazione,
qualora sia stata la causa determinante della separazione; potrà (se richiesto ed accertato) essere
“sanzionata” con la misura tipica dell’addebito, ma
tale violazione, di per sé, non è idonea, né sufficiente ad integrare una responsabilità risarcitoria del
coniuge che l’abbia compiuta.
Di contro, si deve sottolineare come i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non sono esclusivamente
morali ma hanno anche natura giuridica, come confermano le nozioni di diritti e doveri reciproci dei coniugi
racchiuse nell’art. 143 e seguenti del codice civile oltre
che la previsione della loro inderogabilità prevista dal
successivo art. 160 c.c.; risulta dunque evidente che l’in-
70
Temi Romana
Cronache e attualità
teresse di ciascun coniuge all’osservanza di tali doveri
da parte dell’altro ha valenza di diritto soggettivo.
Pertanto, l’infedeltà coniugale, qualora abbia provocato in danno dell’altro coniuge la grave compromissione
di diritti fondamentali, potrà comportare un diritto al
risarcimento, ma come viene specificato in sentenza il
motivo della richiesta non potrà “consistere nella sola
sofferenza psichica causata dall’infedeltà e nella percezione dell’offesa che ne deriva – insita nell’obbligo
di fedeltà, ma nella lesione di un interesse costituzionalmente protetto”.
Il risarcimento da infedeltà è dunque riconducibile a
casi e contesti del tutto particolari in cui sarà possibile
dimostrare che l’infedeltà sia la causa unica e determinante di una lesione alla salute del coniuge o che i comportamenti infedeli abbiano travalicato i limiti dell’offesa (di per sé insita nella violazione) e si siano concretizzati con atti specificamente lesivi della dignità della
persona.
Solo in presenza di tali circostanze sarà dunque possibile invocare il risarcimento ex art. 2059.
La Suprema Corte ha dunque accolto il ricorso per il
“tradimento plateale” disponendo la cassazione della
sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di
Genova che dovrà applicare il seguente principio: “I
doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno
natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche
previste dal diritto di famiglia quale l’addebito della
separazione, discendendo dalla natura giuridica degli
obblighi suddetti; che la relativa violazione ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa
integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al
risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. senza che la mancanza di pronuncia di
addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento relativa a detti danni”.
Il danno non patrimoniale sarà risarcibile ove ricorrano
contestualmente le seguenti condizioni:
a) che l’interesse leso (non il pregiudizio sofferto)
abbia rilevanza costituzionale;
b) che la lesione dell’interesse sia grave nel senso che
l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità
come impone il dovere di solidarietà di cui all’articolo 2 della costituzione;
c) che il danno non sia futile ma consistente e possa
Temi Romana
considerarsi giuridicamente rilevante.
Ad eliminare ogni dubbio sull’orientamento della
Cassazione vi è la recentissima sentenza della Prima
Sezione Civile, 1 giugno 2012 n. 8862, che dispone:
“La violazione di obblighi nascenti dal matrimonio
che, da un lato è causa di intollerabilità della convivenza, giustificando la pronuncia di addebito, con
gravi conseguenze, com’è noto, anche di natura patrimoniale, dall’altro, dà luogo ad un comportamento
(doloso o colposo) che, incidendo su beni essenziali
della vita, produce un danno ingiusto, con conseguente risarcimento, secondo lo schema generale
della responsabilità civile. Possono dunque sicuramente coesistere pronuncia di addebito e risarcimento del danno, considerati i presupposti, i caratteri, le
finalità radicalmente differenti”.
La Cassazione chiarisce che assumeranno particolare
rilievo, rispetto ai coniugi, le modalità con cui la violazione viene realizzata dal convenuto; non sarà sufficiente la semplice infedeltà, ma dovrà risultare che la
condotta fedifraga è stata storicamente così intensa o
crudele nella sua manifestazione da ledere la dignità
stessa del coniuge tradito.
La dichiarazione di addebito non riesce a riparare le
conseguenze negative, provocate dalla condotta illecita
di un coniuge nella sfera di interessi dell’altro, non
potendosi attribuire all’assegno di mantenimento o
all’assegno divorzile funzione risarcitoria – avendo per
loro natura solo finalità assistenziali.
Altrettanto insufficienti sono le sanzioni penali inadeguate a tutelare il coniuge, vuoi per i caratteri restrittivi delle fattispecie delittuose, che limitano una applicazione ampia e adattabile alle diverse situazioni bisognevoli di tutela, vuoi perché è improbabile che nell’ambito delle relazioni familiari la tutela penale possa
condurre a risultati apprezzabili.
Così, quando con istanza di parte si dimostri che vi è stata
la violazione dei doveri coniugali, e che tale comportamento ha costituito la causa unica e diretta della determinazione della crisi coniugale, si può ottenere la pronuncia
di addebito, che spiega i suoi effetti patrimoniali:
- la perdita del diritto all’assegno di mantenimento
(sempre che vi fossero i presupposti per ottenerlo) e dei
diritti successori; ad essa può affiancarsi la richiesta di
risarcimento del danno per responsabilità aquiliana,
quando la violazione dei doveri coniugali si è realizza-
71
Cronache e attualità
ta con modalità tali da arrecare un pregiudizio che lede
non solo i diritti del coniuge, ma anche quelli della persona, precisando che tale azione potrà essere esperita
anche in assenza della dichiarazione di addebito nella
separazione.
Un risultato innovativo e “rivoluzionario” che forma
l’humus per l’affermarsi all’interno della famiglia dei
danni di carattere non patrimoniale, “il danno biologico”, e offre al coniuge due tipi di tutela che si distinguono fra di loro per compiti e per natura:
- l’uno, l’addebito, ha funzione prevalentemente sanzionatoria;
- l’altro, la responsabilità aquiliana, ha funzione riparatoria.
Quindi se la semplice violazione dei doveri coniugali
de sé non da luogo alla responsabilità aquiliana, la correlata lesione dei diritti costituzionalmente riconosciuti e tutelati, permetterà al Giudicante di applicare i
principi previsti dall’art. 2043 c.c. e riconoscere il
danno non patrimoniale, così come individuati dalle
Sezioni Unite con sentenza 26972/0855.
Con tale sentenza le Sezioni Unite hanno sancito la
risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale
quando il fatto illecito abbia violato in modo grave
“diritti inviolabili della persona”, la valorizzazione
della persona, non solo nel suo essere, ma anche nel
suo volere e nel suo agire, in nome di quei diritti inviolabili che sono garantiti dalla Costituzione.
Tale sentenza ha chiarito il significato di danno non
patrimoniale, definito come danno biologico, diverso e
omnicomprensivo del danno morale, esistenziale, di
relazione, etc., unica categoria alla quale si riconduce
la lesione dell’integrità psichica e fisica della persona.
Tale danno potrà essere accolto sulla base anche di presunzioni semplici, fermo restando però l’onere per il danneggiato di rappresentare gli elementi di fatto dai quali
desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio, il Giudice
per calcolare il ristoro del danno nella sua interezza, oltre
a far riferimento alle relative tabelle, dovrà procedere ad
una adeguata personalizzazione della liquidazione del
danno biologico, valutando l’effettiva consistenza delle
sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso.
Riassumendo secondo l’attuale orientamento della
Cassazione:
1. la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio
che costituisce la causa diretta della intollerabilità della
convivenza, giustifica la pronuncia di addebito, con le
note conseguenze di natura patrimoniale.
2. La violazione dei doveri coniugali, con comportamento (doloso o colposo) che incide sui beni essenziali della vita, può determinare una sanzione di natura
risarcitoria unitamente alla richiesta di addebito in
sede di separazione dei coniugi.
3. La mancanza di addebito, anche nel caso di separazione consensuale, non è preclusiva di separata azione
civile per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri discendenti dall’art. 143 del Codice
Civile e riguardanti diritti costituzionalmente garantiti.
4. Qualora ne sussistano i presupposti, l’azione per far
valere l’illecito civile deve ritenersi del tutto autonoma
rispetto agli strumenti previsti dal diritto di famiglia.
Possono così coesistere la pronuncia di addebito e il
risarcimento del danno, essendo differenti i presupposti, i caratteri, le finalità, anche se il comportamento del
coniuge non ha assunto carattere ingiurioso o manifestazioni di eccezionale disdoro per l’altro.
Tale responsabilità aquiliana si estende a tutte le relazioni familiari, anche a quelle del genitore nei confronti del figlio, laddove con la violazione dei doveri derivanti dal rapporto genitoriale si realizza una lesione ai
diritti inviolabili e primari del destinatario costituzionalmente garantiti (artt. 2 e 30 Cost.), come la salute, la
privacy, ai rapporti relazionali.
Il disinteresse palese e prolungato dimostrato dal genitore verso il figlio, realizza la violazione degli obblighi
di mantenimento, istruzione ed educazione, e determina un “vulnus” dalle conseguenze rimarchevoli ed ineliminabili a quei diritti inviolabili che scaturiscono dal
rapporto di filiazione, tutelati dalla Carta costituzionale e dalle norme di natura internazionale recepite nel
nostro ordinamento.
È superfluo ribadire che l’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del proprio figlio sorge con la
nascita del medesimo (Appello Milano, 12 aprile
200656, Cass. civ. n. 5652 /2012, e Cass. n. 610 /2012).
8. Giurisprudenza di merito
- Trib. Firenze, 13.6.2000
ll Tribunale a fronte di una fattispecie in cui il marito
aveva fatto mancare per lungo tempo ogni assistenza
alla moglie, affetta da infermità mentale, determinando
così una compromissione della sua integrità psicofisica
72
Temi Romana
Cronache e attualità
rilevata a mezzo di apposita c.t.u., le ha riconosciuto il
diritto al risarcimento del danno biologico corrispondente alla durata della sofferenza debitamente accertata.
- Trib. Milano, 4.6.2002
Il Tribunale acquisita prova adeguata e sufficiente della
condotta, soprattutto omissiva, assunta dal marito in
aperto contrasto con i doveri di assistenza morale e
materiale e di collaborazione con il coniuge, tale da
giustificare pienamente a suo carico la declaratoria di
addebito della separazione ex art. 151, 2° co., c.c., ha
ritenuto che siffatta condotta non può che integrare violazione dell’art. 2043 c.c..
- Trib. Milano, 22.11.2002
Il Tribunale, in relazione ad un caso di separazione personale per infedeltà coniugale, ha negato che possa
essere riconosciuta una responsabilità risarcitoria a
carico del coniuge inadempiente, richiedendo, per la
configurabilità dell’illecito civile un «“quid pluris”
costituito dalla condotta trasgressiva posta in essere in
aperta e grave violazione di uno o più doveri coniugali», che, nel caso in questione, non appariva ravvisabile, trattandosi di «una vicenda di ordinaria infedeltà,
clandestina e negata», la quale, seppure ritenuta idonea
a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, non si connotava «per specifica gravità e per peculiare lesività della personalità del coniuge tradito». Per
il prevalente indirizzo giurisprudenziale, la possibilità
di azionare la tutela aquiliana non si pone in rotta di
collisione con la pronuncia di addebito della separazione; tuttavia, è dato constatare una comprensibile prudenza nell’individuare, nei casi prospettati, profili di
responsabilità civile: fatti che danno luogo alla dichiarazione di addebito possono ingenerare responsabilità
aquiliana solo se siano con sicurezza riscontrabili, nella
fattispecie, tutti gli estremi prescritti dall’art. 2043 c.c..
- Tribunale di Venezia, Sez. III Civile, 30 giugno 2004
Il danno esistenziale è presente se vi è trascuratezza e
privazione affettiva da parte del genitore.
Il figlio che è immotivatamente trascurato o rifiutato dal
genitore subisce, malgrado l’assenza di esiti apprezzabili sul piano psicopatologico che potrebbero configurare
un danno biologico, l’immotivata e dolorosa privazione
di un apporto che la Costituzione garantisce.
Viene quindi leso un diritto fondamentale del figlio
all’apporto anche morale ed assistenziale che trascende
l’ambito strettamente patrimoniale, lesione risarcibile e
Temi Romana
riconducibile nell’alveo del c.d. danno esistenziale.
- Corte d’Appello di Bologna, 10 febbraio 2004
La nuova dimensione dei doveri genitoriali è stata integralmente recepita dalla giurisprudenza con specifico
riguardo alla applicazione dei principi della responsabilità civile nell’ambito dei rapporti di filiazione,
segnatamente per l’ipotesi in cui il genitore li abbia trascurati, arrecando al figlio un danno ingiusto.
- Tribunale di Modena, 12 settembre 2006
Il Tribunale ha deciso che la condotta del padre che non
abbia riconosciuto il figlio naturale e si sia rifiutato di
adempiere gli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione, è contraria agli artt. 147, 148 e 261 c.c., e causa
un danno esistenziale al figlio naturale e alla madre
che, nel caso di specie, si manifesta, per la donna, sul
piano delle relazioni sociali, per il figlio, nelle ripercussioni sociali derivanti dalla consapevolezza di non
essere mai stato desiderato e trattato come figlio. Il
diritto al risarcimento del danno da essi subito, nonché
il diritto della madre al rimborso pro quota delle spese
effettuate per il mantenimento del figlio naturale, può
essere tutelato attraverso il sequestro conservativo
autorizzato sui beni del padre e sulle somme e cose al
medesimo dovute.
- Tribunale di Brescia, Sez. II 12 ottobre 2006
Con orientamento sicuramente innovativo, i giudici di
Brescia in merito alla domanda di risarcimento del
danno non patrimoniale avanzata dalla sig.ra C. nei confronti del coniuge, avente ad oggetto il risarcimento del
c.d. danno esistenziale conseguente alla compromissione della complessiva sfera di esplicazione personale
della sig.ra C., con contestuale richiesta di liquidazione
del danno in via equitativa, hanno, in primis, esaminato
il tradizionale orientamento giurisprudenziale che, in
ragione del principio “lex specialis derogat legi generali” di cui all’art. 14 disp. prel., esclude ogni forma di
risarcimento del danno in caso di addebito della separazione personale, poi hanno così argomentato: «se all’ingiustizia del danno è affidato il ruolo della selezione
degli interessi meritevoli di tutela ed il danno ingiusto
coincide con la violazione di qualunque bene meritevole di tutela alla luce dell’ordinamento giuridico, allora
non si comprende per quale ragione tale meritevolezza
deve essere esclusa nelle relazioni tra sposi».
Nel contesto familiare, il “bene meritevole di tutela alla
luce dell’ordinamento giuridico” è stato individuato
73
Cronache e attualità
nella dignità e nei valori della persona propri di ciascun
componente del nucleo familiare, la cui lesione da
parte di altro componente della famiglia non può non
costituire, a giudizio del Tribunale di Brescia, il presupposto logico della responsabilità civile. In tale prospettiva, il comportamento del marito della sig.ra C., consistente nell’avere intrattenuto rapporti omosessuali in
costanza di matrimonio, ha comportato l’ingiusta lesione della dignità e della personalità della sig.ra C.
Pertanto, oltre a fondare la pronuncia di addebito
della separazione, giustifica la condanna del sig. B
al risarcimento del danno non patrimoniale subito
dalla sig.ra C., «anche alla luce dell’id quod plerumque accidit e di presunzioni derivanti dalla comune
esperienza quotidiana».
- Tribunale di Trani, 27 settembre 2007
Il Tribunale ha ritenuto ammissibile una domanda di
risarcimento del danno esistenziale conseguente al
mancato riconoscimento del figlio naturale, ma la ha
rigettata per mancanza di prova.
- Tribunale Reggio Emilia Dec., 31 marzo 2008
Il Tribunale ha rigettato per infondatezza il ricorso proposto dalla madre che aveva chiesto la revisione delle
condizioni di divorzio e la condanna del padre al risarcimento del danno anche in favore della figlia con le
seguenti motivazioni: “mentre le questioni connesse al
c.d. illecito endofamiliare (fra cui, ad esempio, quella
relativa alla responsabilità del genitore che si è volontariamente disinteressato della prole violando l’obbligo
di assistenza materiale, morale ed educativa) vanno
trattate in un ordinario giudizio di cognizione, l’art. 709
ter c.p.c. ha lo scopo di garantire la soluzione delle
controversie familiari in corso insorte vuoi nell’ambito
di una lite già pendente fra i genitori vuoi nell’ambito
di una situazione già definita, ma suscettibile di modifica – e di stimolare l’adempimento dei doveri genitoriali anche mediante l’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal secondo comma di tale norma:
pertanto, nel caso di specie, l’indagine del Tribunale
deve essere limitata all’accertamento di eventuali gravi
inadempienze agli obblighi posti a carico del padre
nella sentenza di divorzio”.
- Tribunale di Macerata del marzo 2009
“... pronunciava la separazione giudiziale tra i coniugi
F.L. e B.C., con addebito al marito, assegnando la casa
coniugale alla moglie e disponendo l’affidamento con-
giunto delle figlie minori E. e F., con collocamento
presso la madre; poneva a carico del F. assegni a favore delle due figlie, di importo differente; escludeva
l’assegno di mantenimento, nonché risarcimento dei
danni non patrimoniali per la moglie; condannava
peraltro il F. a corrispondere alla moglie stessa somma
da essa anticipata a favore del marito per l’acquisto di
un appartamento...”.
La sentenza sosteneva che la condotta del F., con il suo
tradimento, non sarebbe stata antigiuridica perché legata al legittimo desiderio di “libertà e felicità” riconosciuto all’individuo dal nostro diritto; inoltre evidenziava che “l’adulterio non costituisce più illecito sanzionabile”, pertanto la domanda di risarcimento del
danno contrasterebbe con il diritto del coniuge di perseguire le proprie scelte personali, che seppure hanno
portato alla disgregazione della famiglia, possono solo
essere valutate esclusivamente come motivo di addebito della separazione, senza potersi spingere fino a configurare una fonte di un risarcimento di danni.
Il Giudicante ha omesso di valutare l’introduzione
della logica e dei metodi della responsabilità civile
nel rapporto tra coniugi e tra genitori e figli, che del
resto, si inserisce nel più generale ampliamento dell’area della responsabilità aquiliana.
- Tribunale di Roma, I sezione, 14 ottobre 2011
È risarcibile il danno esistenziale patito dal figlio naturale a causa del mancato riconoscimento.
Due sorelle quarantenni citano in giudizio davanti al
Tribunale di Roma il loro presunto padre naturale, chiedendo l’accertamento giudiziale della paternità e formulando specifiche domande di natura patrimoniale. In
particolare chiedono la condanna del genitore naturale
al pagamento di somme a titolo di mantenimento arretrato mai corrisposto e di un assegno di natura alimentare per il futuro. Insieme formulano anche domanda di
risarcimento del danno morale patito in relazione al
mancato riconoscimento da parte del genitore.
Il Tribunale, accertata la paternità biologica, dichiara il
convenuto padre naturale delle due sorelle, ma respinge sia la domanda di mantenimento pregresso che la
domanda di assegno alimentare per il futuro sul presupposto, quanto alla prima, che le donne non avevano
titolo essendo state mantenute dalla madre e dalla
nonna e poi da una comunità che le aveva ospitate per
molti anni e, quanto alla seconda, che non fosse stata da
74
Temi Romana
Cronache e attualità
loro provata l’impossibilità di trovare una occupazione
confacente.
Il Tribunale accoglie la domanda di risarcimento del
danno morale “originato dalla sofferenza patita per la
privazione della figura genitoriale”.
- Corte d’Appello di Napoli, 19 ottobre 2011
L’adulterio della moglie, concretizzato dalla nascita di
un bambino concepito con altro uomo, costituisce condotta illecita e fonte di danno non patrimoniale di cui il
marito può esigere il risarcimento.
Costituzione, va così “necessariamente esteso fino a
ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in
senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici
della persona umana”.
Per cui, quindi – essendo le norme costituzionali di
garanzia dei diritti fondamentali della persona pienamente e direttamente, operanti “anche nei rapporti tra
privati” (c.d. drittwirkung) – “non è ipotizzabile limite
alla risarcibilità”, della correlativa lesione, “per sé considerata” (184/1986 cit.), ai sensi dell’articolo 2043
c.c.: che, per tal profilo la Corte veneziana ha per ciò
correttamente applicato, riconoscendo all’attore il
ristoro del danno (non già “morale” da illecito penale,
ma) da lesione in sé di suoi diritti fondamentali, in conseguenza della riferita condotta del suo genitore.
- Cass. Sez. I, 26 maggio 1995, n. 5866
La Suprema Corte ha disposto che “... la risarcibilità
dei danni è configurabile solo se i fatti che hanno dato
luogo alla dichiarazione di addebito integrino gli estremi dell’illecito ipotizzato dalla clausola generale di
responsabilità”.
- Cass., Sez. I, 10 maggio 2005, n. 9801
La Suprema Corte ha precisato come fatti generatori di
responsabilità aquiliana possano ritenersi «unicamente
quelle condotte che per la loro intrinseca gravità si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali
della persona».
- Cass. civile, Sez. I, 15 settembre 2011 n. 18853
“I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio
hanno natura giuridica e la loro violazione non trova
necessariamente sanzione unicamente nelle misure
tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione,
ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente
protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile
e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione
sia preclusiva dell’azione di risarcimento relativa a
detti danni”.
- Cass. Civile, Sezione I, 1 giugno 2012, n. 8862
Separazione dei coniugi - Responsabilità aquiliana:
La violazione di diritti fondamentali della persona
costituzionalmente garantiti, anche ai sensi dell’art. 2
9. La giurisprudenza della corte di cassazione
- Cass. 7 giugno 2000, n. 7713
“...il comportamento sanzionato dall’articolo 570 del
codice penale – sia pur costituito nella sua materialità
dalla mancata corresponsione di mezzi di sussistenza –
rileva, sul piano civile, in termini di violazione non di
un mero diritto di contenuto patrimoniale, ma di sottesi e più pregnanti diritti fondamentali della persona, in
quanto figlio e in quanto minore”.
Ed è poi del pari innegabile che la lesione di diritti siffatti, collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti, vada incontro alla sanzione
risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza). Il che è stato del resto già ben posto in luce
dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza
184/1986, relativa al danno-evento da lesione del
diritto alla salute (c.d. danno biologico) ma riferibile (per la latitudine dei suoi enunciati) ad ogni analoga lesione di diritti comunque fondamentali della
persona, risolventesi in un danno esistenziale ed alla
vita di relazione. La vigente Costituzione, garantendo
principalmente e primariamente valori personali impone, infatti, una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 2043 c.c. (che non si sottrarrebbe altrimenti
ad esiti di incostituzionalità) “in correlazione agli articoli della Carta che tutelano i predetti valori”, nel senso
appunto che quella norma sia “idonea a compensare il
sacrificio che gli stessi valori subiscono a causa dell’illecito”, attraverso “il risarcimento del danno [che] è
sanzione esecutiva del precetto primario ed è la minima
delle sanzioni che l’ordinamento appresta per la tutela
di un interesse”.
Il citato articolo 2043 c.c., correlato agli articoli 2 e ss.
Temi Romana
75
Cronache e attualità
Cost., invero, incidendo sui beni essenziali della vita,
dà luogo a risarcimento dei danni non patrimoniali. La
responsabilità aquiliana del coniuge per violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale è compatibile con la pronuncia di addebito della separazione a carico del medesimo. Va precisato che la responsabilità tra coniuge o
del genitore nei confronti del figlio, non si fonda sulla
mera violazione dei doveri, matrimoniali o di quelli
derivanti dal rapporto di genitorialità, ma sulla lesione,
a seguito dell’avvenuta violazione di tali a doveri, di
beni inerenti la persona umana, come la salute, la privacy, i rapporti relazionali, eccetera.
_________________
1 Cfr. C. GRASSETTI, in Commentario CianOppo-Trabucchi, p. 686.
2 Adulterio, volontario abbandono, eccessi,
sevizie, minacce od ingiurie gravi, condanna penale e non fissata residenza.
3 Cfr. G. VETTORI, L’unità della famiglia e
la nuova disciplina della separazione giudiziale fra i coniugi, in Riv. tri. dir. e proc.
civ., 1978, p. 740.
4 Cfr. B. DE FILIPPIS – G. CASABURI,
Separazione e divorzio nella giurisprudenza, Padova, CEDAM, 1988, p. 389.
5 Cfr. DE FILIPPIS, Trattato breve del diritto
di famiglia, 2002, p. 496.
6 Cass. n. 210999/ 2007.
7 Cfr. L. BARBIERA, Stato patologico di un
coniuge come fondamento della domanda
di separazione personale proposta dall’altro coniuge e addebitabilità della separazione, in Giur. it., 1996, I, p. 885.
8 Cfr. M. DOGLIOTTI, La separazione giudiziale, in Il diritto di famiglia, Trattato diretto da G. BONILINI - G. CATTANEO, Torino,
UTET, 1997, I. .
9 Cass. n. 7165/1994: “la perdita del diritto
al mantenimento a carico del coniuge al
quale la separazione sia stata addebitata
costituisce una sanzione che prescinde dalla
condizioni economica del colpevole e si
fonda su una valutazione discrezionale del
Legislatore che non è censurabile per violazione degli articoli 3 e 29 della Costituzione”.
10 In tema di eredità, infatti, il coniuge cui
è stata addebitata la separazione ha diritto
solo a un assegno vitalizio se quando viene
aperto il testamento godeva degli alimenti a
carico del coniuge deceduto.
11 Cfr. DOGLIOTTI, in La Separazione, cit.,
p. 484; Rossi Carleo, in Trattato Bessone,
p. 187.
12 Cass. n. 2183/2013 Con la sentenza n.
3356 del 2007 questa Corte ha ampliato
l’originaria interpretazione, di stampo strettamente oggettivistico, di tale norma –
interpretazione secondo la quale il diritto
alla separazione si fonda su fatti che nella
coscienza sociale e nella comune percezione rendano intollerabile il proseguimento
della vita coniugale – per dare della medesima norma una lettura aperta anche alla
valorizzazione di “elementi di carattere
soggettivo, costituendo la intollerabilità un
fatto psicologico squisitamente individuale,
riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno alla vita dei
coniugi”. Ribadita, quindi, l’originaria
impostazione oggettivistica quanto al (solo)
profilo del controllo giurisdizionale sulla
intollerabilità della prosecuzione della convivenza nel senso che le situazioni di intollerabilità della convivenza devono essere
oggettivamente apprezzabili e giudizialmente controllabili – e puntualizzato che la
frattura può dipendere, come già affermato
da questa stessa Corte (Cass. 7148/1992)
dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale anche di uno solo dei coniugi,
ha concluso che in una doverosa “visione
evolutiva del rapporto coniugale – ritenuto,
nello stadio attuale della società, incoercibile e collegato al perdurante consenso di ciascun coniuge – (...) ciò significa che il giudice, per pronunciare la separazione, deve
verificare, in base ai fatti obiettivi emersi,
ivi compreso il comportamento processuale
delle parti, con particolare riferimento alle
risultanze del tentativo di conciliazione ed a
prescindere da qualsivoglia elemento di
76
addebitabilità, l’esistenza, anche in un solo
coniuge, di una condizione di disaffezione
al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi
di addebitabilità da parte dell’altro, la convivenza. Ove tale situazione d’intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo
coniuge, deve ritenersi che questi abbia
diritto di chiedere la separazione: con la
conseguenza che la relativa domanda, costituendo esercizio di un suo diritto, non può
costituire ragione di addebito”.
13 Cfr. M. DOGLIOTTI, Separazione e divorzio, Torino, UTET, 1995, p. 40.
14 Cass. n. 817/ 2011, in CED, Cassazione,
2011: “in tema di separazione personale dei
coniugi, la pronuncia di addebito richiesta
da un coniuge per le violenze perpetrate
dall’altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a
sconvolgere definitivamente l’equilibrio
relazionale della coppia, poiché lesivo della
pari dignità di ogni persona”.
15 Cfr. C. PADALINO, in Guida al Diritto
15.12.2001, n. 48, p. 45. La declaratoria
d’addebito è sollecitabile ed adottabile soltanto nell’ambito del giudizio di separazione, ed inoltre integra un quid pluris che si
affianca alla pronuncia di separazione,
senza alterarne la natura e la consistenza, e
senza delineare una diversa figura di separazione, contrapposta a quella priva di
addebito; la separazione giudiziale, addebitabile o meno, è istituto unitario.
16 In giurisprudenza: Cass. 11688/2013. In
dottrina: E. CIPRIANI, Impugnazione per il
solo addebito, in Foro it., 1998, I, 2143, p.
2146; A. FINOCCHIARO, Ammettere l’auto-
Temi Romana
Cronache e attualità
nomia delle due azioni, in Giur. it., 1998, p.
38; L. BARBIERA, Una non convincente conferma dell’unità del giudicato su intollerabilità della prosecuzione della convivenza e
addebito, in Giur. it., 1998, I, p. 2250.
17 Cass. n. 14639/ 2008, massimata e pubblicata in Questioni di diritto di famiglia,
Rimini, Maggioli Editore, 2008, 6, p. 86.
18 Sul punto, cfr. Guida al Diritto,
9.5.1998, n. 18, p. 37.
19 Con la conseguenza che la domanda
avanzata nella fase dinanzi al presidente del
tribunale ovvero in un momento ancora
successivo a essa, soggiace alla sanzione
dell’inammissibilità: “perché introduce,
nell’originario contenzioso, un nuovo tema
d’indagine, non rappresentando mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico
della contesa instaurata con la domanda di
separazione”, Cass. n. 17349/ 2010.
20 Cass. n. 5061/ 2006.
21 Sul punto occorre tenere a mente anche
quanto affermato dalla Suprema Corte con
alcune significative pronunce (Cass. 10719
del 2013), secondo cui anche il comportamento tenuto dal coniuge successivamente
al venir meno della convivenza, ma in tempi
immediatamente prossimi a detta cessazione
può rilevare ai fini della dichiarazione di
addebito della separazione allorché costituisca una conferma del passato e concorra ad
illuminare sulla condotta pregressa.
22 Cass. n. 10718/2013, in Il Sole 24 Ore,
Famiglia e Minori, 2013.
23 Anche in passato la Corte romana (sent.
n. 3776/1983) aveva sostenuto come l’affidamento dei figli non potesse essere inteso
come una sorta di punizione o premio per
l’uno o l’altro dei genitori, a secondo dei
torti o delle ragioni di ciascuno di essi, dovendo invece tener conto esclusivamente di
ciò che appare più idoneo a preservare l’interesse morale e materiale dei figli stessi.
24 Cass. n. 23786/2004, in Famiglia e diritto, 2005, 118, con nota di GELLI.
25 Cass. n. 18853/2011 in Danno e
Responsabilità, Ipsoa, 2012, 4, p. 382.
26 Cfr. A. R. GALLUZZO, Famiglia e minori, Milano, Il Sole 24 Ore, 2011.
27 Cfr. P. ZATTI, in Trattato Rescigno,
Milano, Giuffrè, 1996, p. 175 ss.
28 Cfr. F. SCARDULLA, La separazione per-
Temi Romana
sonale dei coniugi ed il divorzio, Milano,
Giuffrè, 2008, p. 131.
29 Cfr. O. MANCA UCCHEDDU - A.
BUSONERA, Storie di separazione fra coniugi, Milano, Giuffrè, 2004, p. 293.
30 Cfr. P. PERLINGIERI intervento in Diritto
di famiglia: casi e questioni, Napoli, 1982,
p. 126, dove afferma che se determinati fatti
sono dovuti al comportamento di un soggetto, “come si fa a ricercare se quel comportamento è l’effetto o la causa? Com’è possibile in quella comunità familiare isolare quel
fatto da un contesto di vita comune?”.
31 Anche a seguito dell’entrata in vigore il
1º gennaio 2013 della legge 219 del 10
dicembre 2012 (pubblicata sulla «Gazzetta
Ufficiale» del 17 dicembre), che elimina la
distinzione tra figli legittimi e naturali e trasferisce la competenza dal Tribunale per i
minorenni al giudice ordinario su una serie
di giudizi che riguardano la tutela dei diritti dei figli, nati nel matrimonio o no.
32 Per un esame della problematica, con riferimento alla dottrina che ha auspicato l’abrogazione dell’istituto dell’addebito e dei progetti di legge che si sono uniformati a tale indirizzo, ci permettiamo di rinviare a A. MORACE
PINELLI, La crisi coniugale tra separazione e
divorzio, Milano, Giuffrè, 2001, p. 190 e ss.
33 Grava sulla parte che richieda, per
l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge
l’onere di provare la relativa condotta e la
sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre
è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei
fatti posti a fondamento della domanda, e
quindi dell’infedeltà nella determinazione
dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda,
vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà. Cassazione
Civile, Sez. I, 14.2.2012, n. 2059 –
Pellegrini c. Tagliaferri – Red. Giust. civ.
Mass., 2012, 2.
34 La pronuncia di addebito della separazione può essere accolta dove il coniuge
provi che la causa del venir meno della
comunione coniugale sia imputabile al
partner, il quale ha commesso una o più
violazioni dei doveri che discendono dal
matrimonio, salvo il caso in cui ricorra una
palese e grave violazione di diritti fondamentali. Tribunale Varese, 4.1.2012,
77
Redazione Giuffrè 2012.
35 I doveri che derivano ai coniugi dal
matrimonio hanno natura giuridica e la loro
violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo dalla
natura giuridica degli obblighi su detti che
la relativa violazione, ove cagioni la lesione
di diritti costituzionalmente protetti, possa
integrare gli estremi dell’illecito civile e
dare luogo al risarcimento dei danni non
patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c.
senza che la mancanza di pronuncia di
addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento relativa a
detti danni (in applicazione del suesposto
principio, la Corte ha riconosciuto un risarcimento in favore della moglie che aveva
dovuto subire le sofferenze per la relazione
extraconiugale del marito, ampiamente
pubblica e quindi particolarmente frustrante). Cassazione Civile, Sez. I, 15.9.2011, n.
18853 Giust. civ. Mass. 2011, 9, 1296 –
Diritto & Giustizia 2011 – Guida al diritto
2011, 42, 12 (nt. FIORINI).
36 L’addebito di colpa presuppone la violazione dei doveri coniugali derivanti dal
matrimonio e il nesso di causalità tra tale
violazione e l’intollerabilità della convivenza, che deve essere provato dal richiedente.
Pertanto, fallita la riconciliazione, non rileva il comportamento pregresso della
moglie, e la mancanza di prove sulla prosecuzione della relazione extra coniugale,
nonché sulla causalità di tale circostanza
con la nuova crisi e l’intollerabilità della
convivenza, preclude l’accoglimento dell’istanza di addebito di colpa. Cassazione
Civile, Sez. I, 12.9.2011, n. 18618 – Diritto
& Giustizia 2011 (nota PALEARI)
37 Cass. Civ. I, sent. del 24.2.2011, n. 4540.
L’allontanamento dalla casa familiare,
senza il consenso dell’altro coniuge e confermato dal rifiuto di tornarvi, costituisce
violazione di un obbligo matrimoniale;
conseguentemente è causa di addebitamento della separazione poiché porta all’impossibilità della coabitazione. Tuttavia, non
sussiste tale violazione qualora risulti legittimato da una “giusta causa”, da ravvisare
anche nei casi di frequenti litigi domestici
della moglie con la suocera convivente e
nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi, e ciò
anche in assenza di tradimento o di violen-
Cronache e attualità
ze da parte del marito.
38 Tribunale Bari, 7.10.2008, n. 1039 –
L’allontanamento di un coniuge dalla casa
coniugale, se dettato non da specifiche esigenze lavorative, ma dall’intento del medesimo di abbandonare la famiglia, in violazione degli obblighi di assistenza, collaborazione e coabitazione enunciati dall’art.
143 c.c., comporta l’accoglimento della
domanda di addebito della separazione proposta nei suoi confronti dall’altro coniuge.
39 Tribunale Bari, Sez. I, 12.6.2008, n.
1495 – Ai fini dell’addebito della separazione, il fatto oggettivo dell’abbandono
della casa coniugale non può essere ritenuto sufficiente, poiché se è vero che lo stesso
costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, può costituire causa di addebito della separazione, in
quanto porta all’impossibilità della convivenza, è però altrettanto vero che detto
comportamento non concreta tale violazione allorquando sia determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando
il suddetto abbandono sia intervenuto nel
momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto, sicché
anche in caso di abbandono della casa familiare occorre la prova che tale fatto sia stato
la causa dell’impossibilità della convivenza, e non la conseguenza di una preesistente intollerabilità della prosecuzione della
convivenza stessa.
40 Cassazione Civile, Sez. I, 12.9.2011, n.
18618 – L’addebito di colpa presuppone la
violazione dei doveri coniugali derivanti
dal matrimonio e il nesso di causalità tra
tale violazione e l’intollerabilità della convivenza, che deve essere provato dal richiedente. Pertanto, fallita la riconciliazione,
non rileva il comportamento pregresso
della moglie, e la mancanza di prove sulla
prosecuzione della relazione extra coniugale, nonché sulla causalità di tale circostanza
con la nuova crisi e l’intollerabilità della
convivenza, preclude l’accoglimento dell’istanza di addebito di colpa. – Diritto &
Giustizia 2011 (nota PALEARI).
41 Cass. Civ., Sez. I, 26.9.2011, n. 19606.
42 Cass. Civ., Sez. I, 20.4.2011, n. 9074 – In
tema di separazione tra coniugi, la reiterata
inosservanza da parte di entrambi dell’obbligo di reciproca fedeltà non costituisce circostanza sufficiente a giustificare l’addebito
della separazione in capo all’uno o all’altro
o ad entrambi, quando sia sopravvenuta in
un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire,
in una situazione stabilizzata di reciproca
sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis.
Cass. Civ., Sez. I, 20.4.2011, n. 9074 – La
reiterata inosservanza da parte di entrambi
dell’obbligo di reciproca fedeltà, pur se
ricorrente, non costituisce circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione in capo all’uno o all’altro o ad
entrambi allorché sopravvenga in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
43 Cass. Civ., Sez. I, 8.4.2011, n. 8052 –
Qualora la sentenza di merito affermi che la
separazione è addebitabile al marito per avere
introdotto nella casa coniugale, anteriormente alla instaurazione del giudizio di separazione, un’altra donna con la quale ha iniziato
una convivenza more uxorio, deve essere
rigettato il motivo di ricorso per cassazione
che denunzi che ciò si è verificato molti anni
dopo che la moglie si era allontanata dalla
casa coniugale trasferendosi a vivere nella
mansarda dello stesso immobile (così realizzandosi una separazione di fatto). (Conferma
App. Milano luglio 2006, n. 1947).
44 Cass. Civ., Sez. I, 17.12.2010, n. 25560 –
La relazione extraconiugale della moglie non
costituisce necessariamente e automaticamente causa esclusiva di addebito della separazione coniugale. Occorre accertare, infatti,
se la relazione extraconiugale, che di regola
si presume causa efficiente di situazione d’intollerabilità della convivenza rappresentando
violazione particolarmente grave, non risulti
comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un ménage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia
ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico. T.G. c. C.A. –
Redazione Giuffrè 2011.
45 Cass. Civ., Sez. I, 19.7.2010, n. 16873 –
La ripresa della convivenza, dopo la precedente separazione, comportando il venire
meno – in capo ai coniugi – dello status di
separati, pur se avvenuta nell’esclusivo
interesse della prole, postula il rispetto
degli obblighi di cui all’art. 143 c.c., liberamente assunti dai coniugi con la concordata decisione. Correttamente, pertanto, il
giudice del merito, accertato che successi-
78
vamente alla conciliazione la moglie ha
abbandonato la casa familiare per andare a
convivere con un terzo nel pronunciare
nuovamente la separazione dichiara la stessa addebitabile a questa prescindendo dalle
circostanze che avevano giustificato l’originaria separazione. – Guida al diritto 2010,
39, 88.
46 Tribunale Roma, Sez. II, 30.11.2010, n.
23717.
47 Cass. Civ., Sez. I, 14.4.2011, n. 8548.
48 Tribunale Roma, Sez. I, 11.2.2011, n.
2899 – In tema di giudizio di separazione
giudiziale dei coniugi è fondata la domanda
di addebito formulata dal coniuge ricorrente qualora il medesimo provi nel corso del
giudizio “de quo” che il coniuge resistente
non soltanto non ha ottemperato ai propri
doveri familiari ma ha altresì avuto nel
corso della convivenza coniugale condotte
ripetutamente violente nei confronti delle
figlie e della moglie esternatesi in aggressioni fisiche, espressioni scurrili ed offensive, scatti di rabbia incontrollata a fronte di
motivi futili se non inesistenti, intolleranza
nei confronti dei familiari, oltre ad essersi
più volte allontanato dall’abitazione familiare per periodi prolungati senza più dare
notizie di sé.
49 Cass. Civ., Sez. I, 14.1.2011, n. 817 – In
tema di separazione personale dei coniugi,
la pronuncia di addebito richiesta da un
coniuge per le violenze perpetrate dall’altro
non è esclusa qualora risulti provato un
unico episodio di percosse, trattandosi di
comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della
pari dignità di ogni persona. Anche un solo
episodio di non lieve violenza, con percosse, consumato dal marito ai danni della
moglie, per di più per un banale, futilissimo
motivo (avere gettato nella spazzatura un
tozzo di pane raffermo), legittima la moglie
a chiedere la separazione personale dal
coniuge con addebito a quest’ultimo, rendendo verosimile l’affermazione della
moglie che il marito fosse solito “alzare le
mani”, pur non potendo essere data la prova
di ciò, trattandosi di condotte verificatesi
all’interno delle mura domestiche ed in
assenza di persone estranee. – Giust. civ.
Mass. 2011, 1, 63.
50 Cass. Civ., Sez. I, 10.7.2008, n. 19065 –
La separazione può essere addebitata al
Temi Romana
Cronache e attualità
coniuge che sia rimasto indifferente alla
depressione dell’altro, non sostenendolo
economicamente e moralmente, violando
così l’obbligo di assistenza coniugale, esistente a tutti gli effetti anche per le malattie
mentali. Nella fattispecie, la violazione di
tale obbligo, concretizzatasi nella condotta
non partecipativa e distaccata dell’uomo
rispetto alla malattia della moglie, è stata la
causa della fine della convivenza e della
conseguente separazione. Diritto &
Giustizia, 2008.
51 Cass. Civ., Sez. I, 12.8.2009, n. 18235 –
Non integra causa di addebito della separazione l’allontanamento dalla casa coniugale
del coniugi che, andato all’estero per assistere il genitore malato, si allontani dalla
casa coniugale, qualora non si dimostri che
l’intollerabilità della convivenza fosse antecedente rispetto all’allontanamento e dipendente dalla violazione del dovere di fedeltà
da parte dell’altro coniuge. – Redazione
Giuffrè 2009.
52 Cass. Civ., Sez. I, 19.3.2009, n. 6697 – Il
giudice del merito non può fondare la pronuncia di addebito della separazione sulla
mera inosservanza, da parte di uno dei
coniugi, dei doveri di cui all’art. 143 c.c.,
ma deve verificare la effettiva incidenza
delle relative violazioni, nel determinarsi
della situazione di intollerabilità della convivenza. Deriva da quanto precede – pertanto – che deve essere cassata la pronuncia
che ha addebitato la separazione alla moglie sulla base della sola condotta tenuta da
costei – in violazione del dovere di fedeltà
– totalmente trascurando che il marito ha
portato a conoscenza della moglie solo un
anno e mezzo dopo la celebrazione del
matrimonio la propria “impotentia generandi”, e omettendo quindi qualsiasi indagine
sulla lesione del diritto fondamentale della
moglie stessa di realizzarsi nella famiglia e
nella società come donna, come moglie ed
eventualmente come madre. – Guida al
diritto 2009, 17, 26 (nota FINOCCHIARO).
53 Tribunale Prato, 2.12.2008 – Costituisce
motivo di addebito della e, nell’arco di una
lunga convivenza matrimoniale, sottopone
la moglie ad umiliazioni quotidiane, rivolgendosi alla stessa, in presenza di terzi, in
modo irriguardoso e non assistendola anche
quando aveva problemi di salute, ed infine
manifestando nei suoi confronti ulteriore
ostilità allorché la donna aveva manifestato
l’intenzione di cessare le pratiche di scam-
Temi Romana
bio di coppia e di amori di gruppo che il
marito le aveva imposto in precedenza, e
dalla stessa a lungo accettate. – Foro it.,
2009, 3, p. 753.
54 Cass. Civ., Sez. I, 3.10.2008, n. 24574 –
Nel giudizio di separazione personale, ove
venga dedotto come causa di addebitabilità
della separazione il mancato accordo sulla
fissazione della residenza familiare, il giudice di merito, al fine di valutare i motivi
del disaccordo, deve tenere presente che
l’art. 144 c.c. rimette la scelta relativa alla
volontà concordata di entrambi i coniugi,
con la conseguenza che questa non deve
soddisfare solo le esigenze economiche e
professionali del marito, ma deve soprattutto salvaguardare le esigenze di entrambi i
coniugi e quelle preminenti della serenità
della famiglia. (In applicazione del predetto
principio, la S.C. ha cassato la sentenza del
giudice di merito, che aveva tenuto conto
unicamente delle esigenze economiche e
lavorative prospettate dal marito, omettendo di valutare quelle, offerte dalla moglie,
inerenti al suo stato di gravidanza ed all'imminente maternità).
55 Danno non patrimoniale Cassazione a
Sezione Unite con sentenza dell’ 11 novembre 2008, n. 26972 (di contenuto identico
ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente). La sentenza ha innanzitutto
ribadito che il danno non patrimoniale è
risarcibile nei soli casi previsti dalla legge,
i quali si dividono in due gruppi:
- le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in
modo espresso (ad es., nel caso in cui il
fatto illecito integri gli estremi di un reato);
-e quella in cui la risarcibilità del danno in
esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve
ammettersi sulla base di una interpretazione
costituzionalmente orientata dell’art. 2059
c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in
modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.
Questa sentenza ha non solo composto i
precedenti contrasti sulla risarcibilità del
c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più
in generale riesaminato approfonditamente
i presupposti ed il contenuto della nozione
di “danno non patrimoniale” di cui all’art.
2059 c.c.. ll danno non patrimoniale di cui
parla, nella rubrica e nel testo, l’art. 2059
c.c., si identifica con il danno determinato
dalla lesione di interessi inerenti la persona
non connotati da rilevanza economica. Il
79
suo risarcimento postula la verifica della
sussistenza degli elementi nei quali si articola l’illecito civile extracontrattuale e definito dall’art. 2043 c.c..
L’art. 2059 c.c. non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non
patrimoniale, ma consente la riparazione
anche dei danni non patrimoniali, nei casi
determinati dalla legge, nel presupposto
della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell’illecito civile, che si
ricavano dall’art. 2043 c.c. (e da altre
norme, quali quelle che prevedono ipotesi di
responsabilità oggettiva elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra
condotta ed evento di danno, connotato quest’ultimo dall’ingiustizia, determinata dalla
lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue
(danno-conseguenza, secondo opinione
ormai consolidata: Corte Cost. n. 372/1994;
S.U. n. 576, 581, 582, 584/2008)”.
La decisione è quindi passata ad esaminare
il contenuto della nozione di danno non
patrimoniale, stabilendo che quest’ultimo
costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all’interno della quale non è
possibile ritagliare ulteriori sottocategorie,
se non con valenza meramente descrittiva.
È, pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il
c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale
sofferenza psichica transeunte, dagli altri
danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui
il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell’unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.
Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d’un danno definito
“esistenziale”, inteso quale la perdita del
fare areddituale della persona. Una simile
perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno
che un ordinario danno non patrimoniale, di
per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non
può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.
Quando, per contro, un pregiudizio del tipo
definito in dottrina “esistenziale” sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la
limitazione di cui all’art. 2059 c.c..
Da ciò le Sez. Un. hanno tratto spunto per
Cronache e attualità
negare la risarcibilità dei danni non patrimoniali cc.dd. “bagatellari”, ossia quelli
futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, ed
hanno al riguardo avvertito che la liquidazione, specie nei giudizi decisi dal giudice
di pace secondo equità, di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non
serie, è censurabile in sede di gravame per
violazione di un principio informatore
della materia.
La sentenza è completata da tre importanti
precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, liquidazione e prova del danno.
Per quanto attiene la responsabilità contrattuale, le Sez. Un. hanno precisato che anche
dall’inadempimento di una obbligazione
contrattuale può derivare un danno non
patrimoniale, che sarà risarcibile nei limiti
ed alle condizioni già viste (e quindi o nei
casi espressamente previsti dalla legge,
ovvero quando l’inadempimento abbia leso
in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione).
Per quanto attiene la liquidazione del
danno, le Sez. Un. hanno ricordato che il
danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve,
pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di
liquidare in caso di lesioni della persona sia
il danno morale sia quello biologico; come
pure quella di liquidare nel caso di morte di
un familiare sia il danno morale, sia quello
da perdita del rapporto parentale: gli uni e
gli altri, per quanto detto, costituiscono
infatti pregiudizi del medesimo tipo.
Infine, per quanto attiene la prova del
danno, le Sez. Un. hanno ammesso che essa
possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l’onere del dan-
80
neggiato gli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio.
56 Corte d’Appello di Milano, 12 aprile
2006, in Fam. e dir., 2006, p. 509, che
ammette il risarcimento del danno esistenziale, quale conseguenza della dichiarazione di nullità del matrimonio viziato da errore essenziale sulle qualità del coniuge, consistente nello stato di gravidanza causato da
persona diversa dal marito, sotto il duplice
profilo del danno da privazione affettiva per
la perdita della qualità di padre (e nel caso
di specie anche di nonni) a seguito dell’accertata non paternità biologica del ricorrente del figlio e del danno cagionato dal comportamento della convenuta, che ha inciso
sulla libertà matrimoniale del futuro marito.
Trib. Milano, 4 giugno 2002.
Temi Romana
Passeggiata in libreria
n° 3
Rassegna di dottrina
e giurisprudenza
a cura dell’Ordine degli Avvocati di Roma
“TRASPARENZA E PRIVACY NELLA GESTIONE DEL BILANCIO
DELL’UNIONE EUROPEA”
Giuseppina Crisponi NUOVA EDITRICE UNIVERSITARIA, ROMA
pp. 160, euro 15,00
Da metafora esistenziale a paradigma istituzionale – dall’oracolo di Delfi alle Istituzioni
comunitarie – il motto «nulla di troppo» indica la strada del bilanciamento come metodo
per affrontare e risolvere i conflitti. Nell’ambito della formazione ed esecuzione del
bilancio generale dell’Unione europea e della presentazione e revisione dei conti, in questo
libro è offerta un’immagine rappresentativa della complessità intrinseca alla necessità di
stabilire un equilibrio ottimale tra diritti ugualmente meritevoli di salvaguardia: l’interesse
dell’Unione europea a garantire la trasparenza e una sana gestione delle finanze pubbliche,
da un lato, e i diritti fondamentali dei beneficiari dei fondi dell’UE al rispetto della vita
privata e alla protezione dei dati personali, dall’altro, con il fondamentale contributo del
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sulla questione.
Direttore Responsabile: Mauro VAGLIO
Direttore Scientifico: Alessandro CASSIANI
Capo Redattore: Samantha LUPONIO
Comitato Scientifico:
Paola BALDUCCI, Antonio BRIGUGLIO, Luigi CANCRINI,
Pierpaolo DELL’ANNO, Antonio FIORELLA, Giovanni Maria FLICK
Giorgio LOMBARDI, Carlo MARTUCCELLI, Ugo PETRONIO
Eugenio PICOZZA, Giulio PROSPERETTI, Giorgio SPANGHER
Alfonso STILE, Federico TEDESCHINI, Roberta TISCINI,
Giancarlo UMANI RONCHI, Romano VACCARELLA
Comitato di Redazione:
Mauro VAGLIO, Pietro DI TOSTO, Antonino GALLETTI
Riccardo BOLOGNESI, Fabrizio BRUNI
Alessandro CASSIANI, Domenico CONDELLO, Antonio CONTE
Mauro MAZZONI, Aldo MINGHELLI, Roberto NICODEMI, Livia ROSSI
Matteo SANTINI, Mario SCIALLA, Isabella Maria STOPPANI
Coordinatori:
Antonio ANDREOZZI, Andrea BARONE, Camilla BENEDUCE
Domenico BENINCASA, Marina BINDA, Ersi BOZEKHU
Francesco CASALE, Francesco CIANI, Benedetto CIMINO, Irma CONTI
Antonio CORDASCO, Alessandro CRASTA, Carmelita DE FINIS
Annalisa DI GIOVANNI, Ruggero FRASCAROLI, Maria Vittoria FERRONI
Fabrizio GALLUZZO, Alessandro GENTILONI SILVERI, Mario LANA
Paola LICCI, Andrea LONGO, Giuseppe MARAZZITA, Franco MARCONI
Alessandra MARI, Gabriella MAZZEI, Arturo MEGLIO, Chiara PACIFICI
Ginevra PAOLETTI, Chiara PETRILLO, Tommaso PIETROCARLO
Aurelio RICHICHI, Sabrina RONDINELLI, Serafino RUSCICA
Marco Valerio SANTONOCITO, Massimiliano SILVETTI, Luciano TAMBURRO
Federico TELA, Antonio TESTA, Federica UMANI RONCHI, Clara VENETO
Segretario di redazione: Natale ESPOSITO
Progetto grafico: Alessandra GUGLIELMETTI
Disegno di copertina: Rodrigo UGARTE
____________
Temi Romana - Autorizzazione Tribunale di Roma n. 320 del 17 luglio 2001 - Direzione, Redazione: P.zza Cavour - Palazzo di Giustizia - 00193 Roma
Impaginazione e stampa: Infocarcere scrl - Via C. T. Masala, 42 - 00148 Roma
“CODICE DEL PUBBLICO IMPIEGO”
Francesco Caringella, Ciro Silvestro, Francesco Vallacqua (Coordinatori)
Testi di: Ciro Silvestro, Francesco Vallacqua, Renata Mazzaro, Fabrizio Sileri,
Bruno Strati, Caterina Panzarino, Antonio Campanella, Anna Consiglio,
Tina Cecilia Menelao, Alessandro Nicodemi, Luigi Pianesi, Valentina Fiorillo,
Veronica Valenti, Barbara Malaisi, Simone Calzolaio
DIKE GIURIDICA EDITRICE, ROMA
pp. 1900, euro 150,00
Il codice si prefigge l’obiettivo di dotare operatori, amministratori e studiosi di una guida
completa ed organica che illumini il variopinto mondo del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni, tracciando un esaustivo panorama delle norme fondamentali
relative al pubblico impiego, privatizzato e non, ed all’universo previdenziale.
L’opera, inedita per ricchezza del materiale normativo e profondità dell’indagine, offre
agli operatori un quadro a 360 gradi del patrimonio di contributi ed esperienze svolti negli
ultimi anni sull’accidentato campo della riforma del lavoro alle dipendenze delle p.a..
“LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
E LE PROCEDURE CONCORSUALI”
Antonio Caiafa DISCENDO AGITUR, ROMA
pp. 292, euro 30,00
L’attuale ordinamento non offre una risposta adeguata alle esigenze delle imprese e dei
lavoratori nel caso di processi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione in caso di
crisi del mercato, in quanto le soluzioni previste (concordato preventivo, accordi di
ristrutturazione, piani attestati di risanamento e la stessa transazione fiscale), solo in
apparenza rappresentanti un rimedio volto alla preservazione dei valori aziendali, ma,
invero, non sono in grado di assicurare l’obiettivo voluto, soprattutto in ragione della
dimostrata incapacità del legislatore di regolare, in modo appropriato, il procedimento di
conformazione che le direttive comunitarie, troppo spesso ignorate, hanno inteso imporre,
nonostante le numerose pronunce intervenute attestino una preoccupante difformità della
disciplina nazionale da quella europea.
“L’AVVOCATO E LE SUE QUATTRO RESPONSABILITÀ”
Vito Tenore (a cura di) EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE, NAPOLI
pp. 576, euro 60,00
Mancava nel pur vasto panorama editoriale dedicato alla professione forense una
monografia a tutto tondo sulle quattro responsabilità dell’avvocato e delle società tra
avvocati. Difatti, gli studi editi si sono di solito soffermati sulla responsabilità civile per
errori professionali o su quella disciplinare per violazione di regole deontologiche. Molto
poco era stato scritto sulla responsabilità penale del difensore e mai nulla era stato
pubblicato su quella mministrativo-contabile per talune attività dell’avvocato. Il volume
colma, dunque, questa lacuna scientifica con uno studio organico, approfondito, aggiornato
alla riforma forense della Legge n. 247 del 2012, ancorato al basilare referente normativo e,
soprattutto, ricco di giurisprudenza (anche del CNF) e di dottrina, che hanno scandagliato
diversi profili della patologia comportamentale del peculiare professionista legale.
2014
n° 3
Temi Romana
n° 3
Rassegna di dottrina
e giurisprudenza
a cura dell’Ordine degli Avvocati di Roma
ANNO LXII
LUGLIO – SETTEMBRE 2014