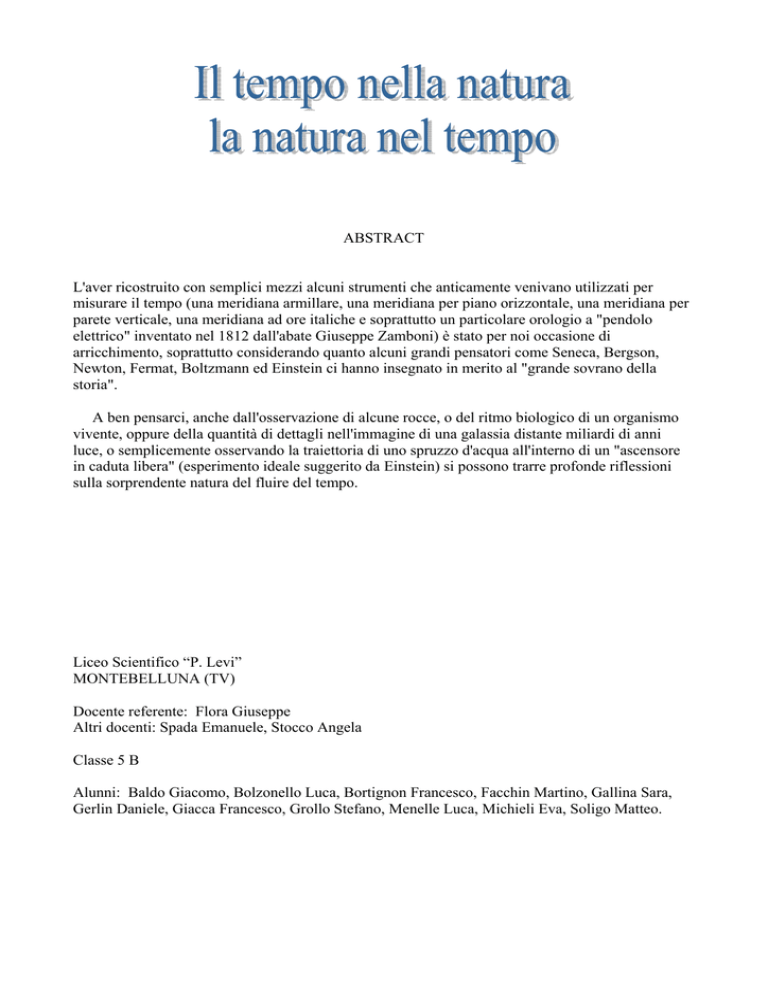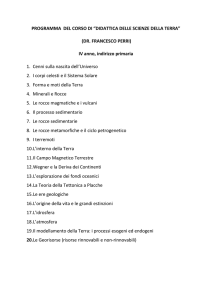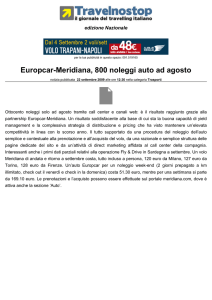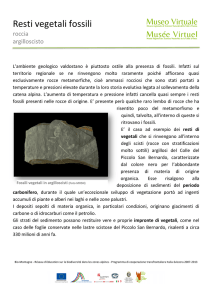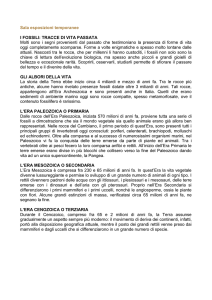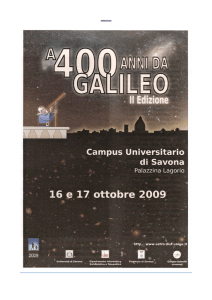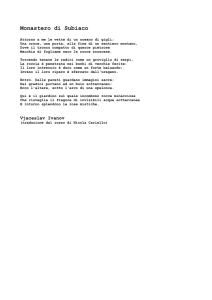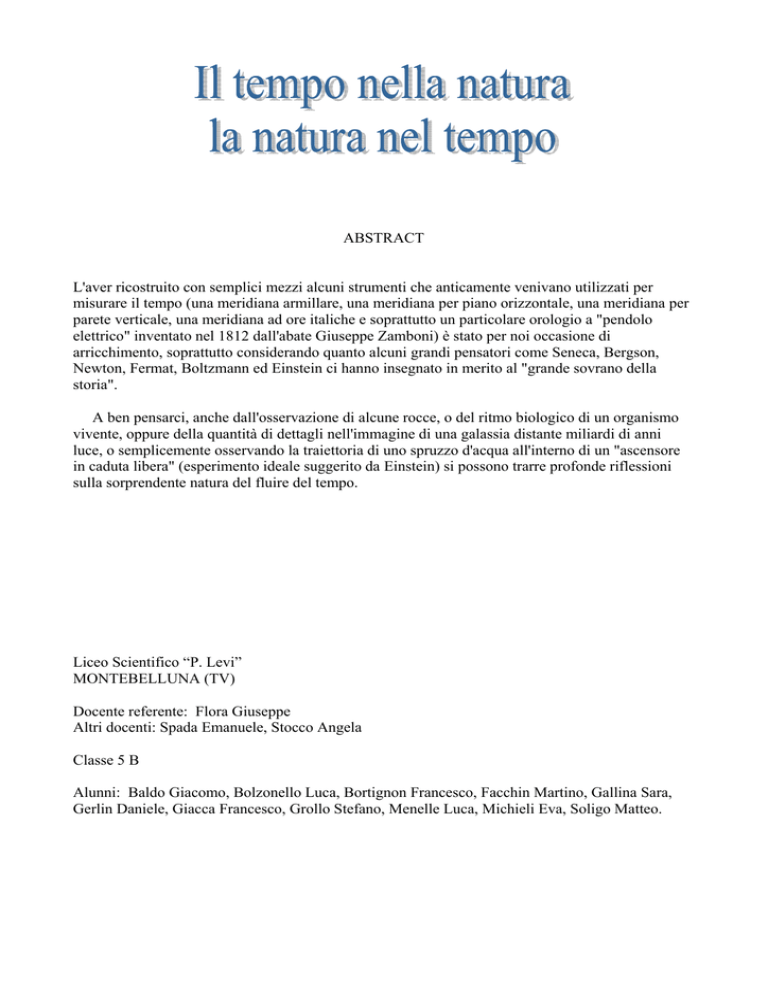
ABSTRACT
L'aver ricostruito con semplici mezzi alcuni strumenti che anticamente venivano utilizzati per
misurare il tempo (una meridiana armillare, una meridiana per piano orizzontale, una meridiana per
parete verticale, una meridiana ad ore italiche e soprattutto un particolare orologio a "pendolo
elettrico" inventato nel 1812 dall'abate Giuseppe Zamboni) è stato per noi occasione di
arricchimento, soprattutto considerando quanto alcuni grandi pensatori come Seneca, Bergson,
Newton, Fermat, Boltzmann ed Einstein ci hanno insegnato in merito al "grande sovrano della
storia".
A ben pensarci, anche dall'osservazione di alcune rocce, o del ritmo biologico di un organismo
vivente, oppure della quantità di dettagli nell'immagine di una galassia distante miliardi di anni
luce, o semplicemente osservando la traiettoria di uno spruzzo d'acqua all'interno di un "ascensore
in caduta libera" (esperimento ideale suggerito da Einstein) si possono trarre profonde riflessioni
sulla sorprendente natura del fluire del tempo.
Liceo Scientifico “P. Levi”
MONTEBELLUNA (TV)
Docente referente: Flora Giuseppe
Altri docenti: Spada Emanuele, Stocco Angela
Classe 5 B
Alunni: Baldo Giacomo, Bolzonello Luca, Bortignon Francesco, Facchin Martino, Gallina Sara,
Gerlin Daniele, Giacca Francesco, Grollo Stefano, Menelle Luca, Michieli Eva, Soligo Matteo.
Introduzione
Due motivi ci hanno portato alla scelta dell’esperimento (la ricostruzione di un orologio “a
pendolo elettrico”) : innanzitutto la notizia, da parte del nostro insegnante di fisica, che questo
primo orologio storico a “pile elettriche” è stato inventato nel 1812 dal veronese abate Giuseppe
Zamboni e in secondo luogo il fatto che il tema del “tempo” è stato ampiamente trattato durante il
nostro quinto anno di liceo da diversi insegnanti e ci ha particolarmente appassionato per le sue
sorprendenti caratteristiche.
La visita alla mostra “Einstein, il genio all’opera”, realizzata nella Biblioteca Comunale della
nostra città (Montebelluna) nel mese di gennaio 2006, è stata un’ulteriore occasione per
approfondire le novità apportate dal grande fisico tedesco al concetto stesso del tempo, unificandolo
con quello dello spazio.
L’esperimento del pendolo elettrico non è stato dunque soltanto un’esercitazione di fisica ma è
stato un punto di partenza per una ricerca molto più ampia sul tema del “tempo” e in particolare
della sua “misura”. Per questo abbiamo voluto ricostruire anche altri antichi orologi: alcuni modelli
di meridiana di diversa tipologia, un “orologio floreale” sul modello di Linneo e un “orologio a
rocce” (alcuni campioni di rocce che riproducono la stratigrafia - e quindi una cronologia - di una
regione dolomitica).
Probabilmente pochi ne sono a conoscenza ma il primo
orologio elettrico è stato inventato e costruito a Verona
dall’abate Giuseppe Zamboni. Nato ad Arbizzano Veronese nel
1776, Zamboni divenne erudito non solo in filosofia e teologia
ma anche in fisica. Egli era particolarmente interessato alle pile
elettriche, al punto che alcuni tipi di pile a secco da lui ideate
portavano il nome di “pile di Zamboni” (erano composte da
centinaia di dischetti di carta ricoperti da un lato di foglia
metallica e dall'altro di biossido di manganese). Il suo massimo
contributo scientifico fu l’invenzione di un orolgio elettrico
denominato “perpetuo”. Con l’aiuto di abili mastri orologiai
veronesi egli riuscì infatti a progettare e realizzare nel 1812 un
orologio il cui pendolo veniva spinto da forze elettriche. Il
nome “perpetuo” era dovuto al fatto che il consumo di corrente era talmente piccolo da consentire il
funzionamento dell’orologio per decine di anni senza bisogno di sostituire le pile.
L’orologio di Zamboni assomiglia ad un tradizionale orologio a pendolo, ma il principio fisico con
cui il pendolo viene mantenuto in oscillazione è ben diverso dagli orologi con carica “a molla”
oppure “a peso”. Il pendolo termina con una sfera metallica che oscilla tra le due armature di un
condensatore alimentato da pile a secco. Ad ogni urto con una delle due armature, la sfera si carica
per contatto con una certa quantità di carica avente lo stesso segno dell’armatura urtata. Ne
consegue che la sfera venga respinta dall’armatura e venga invece attratta dall’armatura opposta,
carica di segno contrario, compiendo così mezza oscillazione. Appena la sfera tocca quest’ultima
armatura il processo di caricamento sopra descritto si ripresenta tale e quale ma col segno invertito.
In tal modo la sfera continuerà ad oscillare tra le due armature. Il consumo di energia elettrica è
estremamente basso in quanto la carica che passa nel circuito è solamente quella che la sfera è in
grado di acquisire nell’urto con un’armatura. Il conteggio del tempo avveniva con il metodo
tradizionale degli orologi meccanici.
Il principio di funzionamento di questo orologio è dunque assai semplice, ma non mancano
problemi tecnici di entità tale che il suo sviluppo commerciale fu assai limitato, al punto che gli
esemplari ancora esistenti sono soltanto una decina. Innanzitutto le pile in serie dovevano
raggiungere una differenza di potenziale di circa 900 V (per garantire una spinta sulla sfera
sufficiente a vincere gli attriti) e questo rendeva pericolosa la manutenzione dell’orologio. In
secondo luogo il periodo del pendolo poteva venire alterato da accidentali vibrazioni dell’edificio o
persino da variazioni dell’umidità dell’aria, cosicché la situazione di isocronismo delle oscillazioni
risulta assai critica. L’abate Zamboni aveva comunque cercato di limitare questi rischi per l’utente e
disturbi sul periodo di oscillazione rinchiudendo l’orologio all’interno di un mobiletto a vetrina.
Nel modello da noi realizzato sono state apportate alcune modifiche rispetto al progetto originale di
Zamboni, senza tuttavia alterarne il principio fisico. Per ottenere l’alimentazione a 900 V abbiamo
preferito utilizzare un trasformatore di tensione alimentato dalla rete di corrente alternata a 220 V.
Abbiamo utilizzato un normale trasformatore per campanelli ma con uno scambio dei circuiti
primario e secondario, in modo da ottenere in uscita una differenza di potenziale maggiore di quella
in ingresso. Naturalmente il trasformatore per campanelli non è progettato per essere alimentato con
queste modalità e ci sarebbe stato il rischio di un surriscaldamento del circuito collegato alla rete
urbana. Il problema è stato superato aggiungendo in ingresso, in serie al trasformatore, una
lampadina da100W : la resistenza della lampadina limita infatti l’intensità di corrente nel
trasformatore. All’uscita dal trasformatore abbiamo ottenuto una differenza di potenziale di 900 V
in tensione alternata. Per renderla “continua” abbiamo utilizzato un raddrizzatore di tipo
commerciale ma, anche in questo caso, abbiamo limitato la corrente in ingresso nel raddrizzatore
collegandovi in serie un resistore di resistenza 10kΩ (vedi schema del circuito elettrico). All’uscita
dal raddrizzatore abbiamo così ottenuto corrente continua con differenza di potenziale 900V. Il
collegamento alle armature del condensatore è stato infine realizzato mediante un resistore di
resistenza 10MΩ in modo da evitare qualsiasi rischio di shock elettrico per gli utenti: l’intensità
massima di corrente attraverso il corpo di chi toccasse entrambe le armature sarebbe infatti di soli
0,09 mA, largamente inferiore all’intensità di 30mA che la normativa europea considera
“pericolosa”.
Anche il metodo di conteggio delle oscillazioni è stato da noi semplificato rispetto ai sofisticati
metodi meccanici dei mastri orologiai veronesi: il filo del nostro pendolo è stato reso conduttore
(rame) nella metà superiore, lontana dalle armature, in modo che ad ogni oscillazione del pendolo
avvenga la chiusura di un interruttore elettrico. L’interruttore è stato poi collegato ad un contatore
elettronico per il conteggio delle oscillazioni e quindi del tempo.
Abbiamo regolato il periodo di un’oscillazione completa pari ad “un secondo” in modo da
semplificare il conteggio del tempo. Abbiamo notato che il periodo dipende non solo dalla
lunghezza del pendolo ma soprattutto dalla distanza “d” tra le armature del condensatore.
SCHEMA ELETTRICO
ANALISI FISICA DELLE ENERGIE DISSIPATE E PRODOTTE
NELL’OROLOGIO DI ZAMBONI.
Abbiamo voluto tentare di affrontare un’analisi fisica della quantità di energia elettrica fornita
dall’alimentatore in un sua semi-oscillazione del pendolo per confrontarla poi con l’energia
meccanica dissipata in una semi-oscillazione a causa degli attriti, presenti soprattutto durante l’urto
tra la sfera e una delle due armature del condensatore. Presentiamo questo nostro tentativo, consci
che esso possa essere soggetto a osservazioni critiche, e ringraziamo chi volesse lasciarci qualche
suggerimento correttivo in merito.
ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN UNA SEMI-OSCILLAZIONE:
Nell’urto con un’armatura è plausibile che la sfera acquisti “tutta” la carica elettrica Q presente in
quell’armatura perché la sua superficie della sfera diametralmente opposta al punto di contatto è
assai curva rispetto alla superficie delle armature (vedi potere disperdente delle punte). Il valore di
ε A
questa carica è facilmente ottenibile dalla legge del condensatore: Q = C ⋅ ΔV = 0 ⋅ ΔV
d
In base ai nostri dati sperimentali, secondo i quali risulta ΔV =900V, d=2,2 cm, A=78,5 cm2 ,
risulta Q=2,84.10-9 C.
Il consumo di energia elettrica in una semi-oscillazione è dunque L=Q.ΔV=2,55.10-6 J.
ENERGIA MECCANICA ACQUISTATA IN UNA SEMI-OSCILLAZIONE.
La forza elettrica a cui la sfera è soggetta dopo l’urto con l’armatura è F=Q.E dove E è il campo
elettrico generato dall’altra armatura. Il valore di quest’ultimo sarebbe la metà del campo del
condensatore se l’alimentatore fosse rimasto scollegato. In realtà è plausibile pensare che
ΔV
l’alimentatore abbia rapidamente ricaricato il condensatore e che quindi risulti E =
.
d
Infine l’energia acquistata dal pendolo nel suo moto verso l’altra armatura è
L = F ⋅ ΔS = F ⋅ (d − Φ ) dove Φ è il diametro della sfera.
In conclusione, in base ai nostri dati sperimentali, secondo i quali risulta ΔV =900V, d=2,2 cm,
ε A
Φ =1,6 cm, A=78,5 cm2 , risulta L = 0 2 ⋅ ΔV 2 ⋅ (d − Φ ) = 7,0.10-7 J.
d
ENERGIA DISSIPATA IN ATTRITI VARI IN UNA SEMI-OSCILLAZIONE
Durante una semi-oscillazione del pendolo l’energia meccanica viene dissipata sia a causa
dell’attrito viscoso con l’aria sia a causa del fatto che l’urto tra la sfera e l’armatura del
condensatore non è affatto elastico. Poiché la velocità della sfera è, mediamente,
ΔS d − Φ
=
= 0,012m / s , cioè estremamente bassa, la perdita di energia meccanica è
vmedia =
Δt
T /2
dovuto sostanzialmente all’urto con l’armatura e non all’attrito con l’aria. Dette v1 la velocità di
impatto tra la sfera e l’armatura e v2 la velocità di rimbalzo, l’energia meccanica perduta nell’urto
1
2
2
con l’armatura sarà Ldiss = m ⋅ (v1 − v 2 ) .
2
La stima sperimentale di v1 è assai difficile, tuttavia è plausibile che il suo “ordine di grandezza” sia
pari a quello della velocità media sopra calcolata, ovvero v1=0,010m/s. Partendo da questo valore
“approssimato” di v1, possiamo invece calcolare in modo abbastanza preciso il corrispondente
valore di v2: esso è legato a v1 dalla relazione v2 =kv1, dove k è il coefficiente di restituzione. Per
una misura sperimentale di quest’ultimo abbiamo disposto una delle due armature del condensatore
nel punto di equilibrio del pendolo. Abbiamo quindi allontanato la sfera del pendolo di un certo
tratto Δx1 dall’armatura, l’abbiamo lasciata rimbalzare sull’armatura e abbiamo misurato la distanza
Δx 2 di allontanamento dall’armatura dopo l’urto. Da un analisi delle energie potenziali e cinetiche
si ottiene con semplici passaggi v1 = 2 gΔh = 2 gl (1 − cos
Δx1
) e
l
Δx 2
) dove l è la lunghezza del pendolo e g l’accelerazione di gravità.
l
v
Dai nostri dati sperimentali risulta k = 2 = 0,30 .
v1
Ritornando ora al problema del calcolo di v2 durante il normale funzionamento dell’orologio, è ora
possibile ottenerne il valore di v2 a partire dal valore di v1=0,010 m/s: v2=k.v1= 0,003m/s.
Otteniamo così infine Ldiss=7.10-7 J.
v 2 = 2 gΔh = 2 gl (1 − cos
BILANCIO ENERGIA OTTENUTA - ENERGIA DISSIPATA
Considerato il fatto che la nostra analisi energetica è soltanto “approssimata”, il bilancio energetico
tra l’energia meccanica ottenuta dall’alimentatore elettrico e l’energia meccanica dissipata dal
pendolo è da considerarsi soddisfacente.
ANALISI DEL CONSUMO ELETTRICO E DELL’AUTONOMIA DELL’OROLOGIO DI
ZAMBONI
In base all’analisi sopra esposta possiamo valutare l’autonomia di un orologio elettrico di questo
tipo. Dalle descrizioni riscontrabili in bibliografia sulle “pile di Zamboni”, si può ritenere che la
“quantità di carica erogabile” da una singola pila di quel tipo non fosse molto diversa da quella
ottenibile da un’odierna pila a bottone da orologio da polso, ovvero dell’ordine di grandezza di
100 C.
Benché il numero di pile da collegare in serie per ottenere 900 V di tensione sia molto elevato, nel
momento in cui il pendolo dell’orologio urta un’armatura, ogni singola pila dovrà fornire una carica
pari a quella “rubata” dalla sfera del pendolo all’armatura del condensatore, ovvero Q=2,84.10-9 C.
A questo punto è sufficiente calcolare il rapporto tra la carica erogabile da una singola pila e quella
utilizzata in un urto del pendolo per ottenere il numero di semi-oscillazioni possibili: 3,5.1010.
In conclusione, essendo pari a mezzo secondo la durata di una semi-oscillazione, l’autonomia di tale
orologio dovrebbe essere di circa 1,7.1010 s, pari a circa 500 anni!
Naturalmente l’autonomia reale dell’orologio è invece limitata dalle possibilità di conservazione in
stato di efficienza delle pile. Dalle notizie storiche risulta che gli orologi costruiti da Zamboni
abbiano funzionato per decine e decine di anni e c’è persino chi, come il veronese Paolo Francesco
Forlati, afferma che il suo “orologio di Zamboni” sia ancora oggi perfettamente funzionante!
Abbiamo citato il Forlati anche per il fatto che il suo libro Segnatempo veronensis, stampato presso
le Grafiche Fiorini di Verona nel 1987, è stato il testo da cui è iniziata la nostra “scoperta”
dell’esistenza dell’orologio elettrico “perpetuo” dell’abate Giuseppe Zamboni.
Uno degli esemplari dell’orologio perpetuo di Zamboni
Le meridiane, dal latino meridies ( mezzogiorno): l’orologio più “naturale” inventato dall’uomo, un
piccolo trattato di astronomia con le sue linee orarie e di declinazione del sole, per qualcuno un
invito alla preghiera suggerita dai motti religioso-filosofici quali “horas non numero nisi serenas –
io conto solo le ore belle” oppure “nulla dies sine linea – non passa nessun giorno che non sia
caratterizzato da un segno” oppure “fugit hora, ora et labora – l’ora fugge, tu prega e lavora”.
Opere d’arte? Forse no, o almeno in tal senso non sono ancora inserite tra i beni culturali protetti
dalla Soprintendenza. Ma quale prezioso scrigno di sapienza!
Testimonianza di un passato, meditazione sulle stagioni, sui tempi della natura, sul tempo della vita,
sul Tempo. Questo sovrano che ci trascende, che resta e resterà un mistero anche dopo la nostra era
dell’orologio atomico.
Alcuni di questi orologi antichi segnano le ore secondo il Tempo Vero Locale, secondo cui la
giornata è ripartita in 24 ore e le 12 sono a mezzo-giorno cioè al passaggio del sole sul meridiano
del luogo in cui si trova l’orologio. Quest’ora non coincide con quella del nostro orologio da polso
(Tempo Medio), sia perché quando il sole passa sul meridiano di Trieste non passa anche sul
meridiano di Torino, sia perché il moto della terra attorno al sole non è circolare e uniforme ma
ellittico e con velocità variabile. Tuttavia la differenza tra i due sistemi di regolazione non supera
normalmente la mezz’ora. La maggior parte di questi quadranti risale al XIX secolo e sono anche
chiamate “ore francesi” perché prima dell’invasione napoleonica in Italia si usavano le Ore Italiche.
Già, chi le ricorda le ore italiche? Forse qualche commentatore de “I promessi sposi” di A. Manzoni
intento a capire perché mai il romanziere inscena Renzo che torna a casa alle 23 e si mette a cenare?
Le ore italiche infatti suddividono la giornata ancora in 24 parti ma l’ora 24 è posta al tramonto del
sole, non alla mezzanotte. Solo le meridiane potevano seguire con semplicità questo modo di
scandire la giornata mentre gli orologi meccanici importati dalla Francia si sarebbero dovuti
regolare quasi quotidianamente a causa del variare del momento del tramonto con le stagioni. Le
ore italiche erano così comode per il lavoro agricolo! Se la meridiana segnava le 22 sapevi che ti
restavano ancora 2 ore di luce (qualche lettore di una certa età potrebbe ricordare che nel suo paese,
verso sera, il campanaro suonava la cosiddetta “campana delle 22 ore”) . L’ora 24 è una linea
orizzontale e l’ora 23 è lievemente inclinata verso il basso a destra, da cui il detto giunto fino ai
nostri giorni “portare il berretto sulle 23”.
Meridiane ad ore italiche, risalenti alla seconda metà del ‘600, nel trevigiano.
Ma come nacque nell’uomo l’esigenza di misurare il tempo? Come nacque quest’arte di costruire
meridiane, detta “gnomonica”? Essa si perde nella preistoria! L’archeologia ci evidenzia che molti
monumenti risalenti al Neolitico: i megaliti di Stonehenge in Inghilterra, le grandi pietre dell’isola
di Pasqua e, più vicino a noi, i megaliti del Piccolo San Bernardo presso La Thuile (AO), i
“casteller” nei pressi di Montebelluna (TV), sicuramente fungevano da osservatori astronomici e
misuratori del tempo (soprattutto per la determinazione della durata dell’anno) e probabilmente
anche da centri di culto religioso. L’allineamento di queste pietre non è infatti casuale ma segue le
direzioni in cui sorge il sole in particolari periodi dell’anno (ad esempio nel solstizio estivo e in
quello invernale). Il sole era: luce, calore, vita, altezza divina, scansione del tempo (giorni, stagioni,
anni): dedicare monumenti al suo studio coincideva con un vero e proprio culto. Comprendere i suoi
movimenti apparenti nella volta celeste significava capire di più anche il senso della vita dell’uomo
singolo e della sua tribù. Il ripetersi con precisione sovrumana degli eventi astronomici (i solstizi,
ad esempio) non era distinto dal destino umano, talvolta ciclico nel passaggio da una generazione
all’altra (da qui probabilmente anche il senso della reincarnazione secondo alcune religioni
orientali…). Certamente questi monumenti non erano ancora “orologi solari” nel senso “orario” del
termine ma lo erano nel senso “annuale”. Nei millenni successivi l’orientamento astronomico degli
edifici umani resterà di importanza fondamentale: dalle piramidi d’Egitto fino alle nostre chiese,
orientate tipicamente verso Est (sole nascente = risurrezione) oppure, nei casi di chiese dedicate ad
un particolare santo, verso la direzione in cui sorge il sole nella data corrispondente alla morte del
santo (talvolta addirittura la chiesa presentava un’apertura da cui la luce solare poteva entrare e
illuminare un’icona dedicata al santo soltanto nel giorno ricorrente la sua morte).
Con gli antichi Egizi inizia inoltre anche l’uso dell’orologio solare in senso “orario”: al museo del
Louvre di Parigi è esposta una meridiana egizia datata 1500 a.c. La giornata veniva suddivisa in 12
ore, come ai giorni nostri, anche se il conteggio partiva dall’alba e la durata di un’ora non
corrispondeva tutto l’anno con i nostri 60 minuti perché d’inverno le giornate sono più corte e
d’estate più lunghe.
Il motivo del numero “12” in questa suddivisione del giorno è quasi sicuramente di origine
astronomica, infatti in un anno si osservano circa 12 pleniluni (da cui la suddivisione dell’anno in
12 mesi, operata presso tutti i popoli antichi e giunta fino a noi). L’orologio egizio era spesso
realizzato mediante un gigantesco obelisco che fungeva da “gnomone” (dal greco γνωμωυ , che
significa “indicatore”), ovvero tale da dare sul terreno un’ombra di lunghezza variabile nei giorni
dell’anno e di direzione variabile durante la giornata. Questa meridiana funzionava quindi sia da
calendario che da orologio. Sull’uso “gnomonico” degli obelischi egizi è interessante il fatto che
uno di questi, alto oltre 20 m, sia stato trasportato fino a Roma dall’imperatore Augusto per
realizzare una gigantesca meridiana (80m x 180m!) nel Campo Marzio (la zona attualmente
compresa tra l’Ara Pacis e via di Campo Marzio (le tracce di questa meridiana sono state rinvenute
pochi decenni fa dall’archeologo tedesco E. Buchner e l’obelisco egizio esiste ancora: è quello che
oggi si trova in piazza Montecitorio, ivi fatto trasferire da papa Benedetto XIV nel 1748,
probabilmente ignorando che quella stupenda pietra, miracolosamente salvatasi tra le macerie
dell’antica città, avesse avuto un’importante funzione gnomonica.
Meridiana di Augusto in Campo Marzio a Roma riscoperta tra il 1970 e 1980 dall’archeologo
Edmund Buckner.
Le meridiane antiche non segnavano di certo il minuto ma spesso segnavano le mezze ore e talvolta
i quarti d’ora. Soltanto nel rinascimento nacque l’esigenza di poter “regolare” gli orologi meccanici
(dei campanili ma anche dei centri di studio astronomico come quelli delle università) con
precisione via via crescente. Così si realizzarono meridiane di precisione pari a 1 o 2 secondi! Lo
gnomone non avrebbe mai consentito questa precisione perché qualsiasi asta fornisce un’ombra dai
bordi incerti a causa del fenomeno della penombra (il disco solare non è puntiforme ma ha
un’ampiezza angolare di circa mezzo grado). Si ottenne invece quella precisione suddetta mediante
“meridiane a camera oscura”: sul soffitto o sulla parete di una stanza poco illuminata veniva
praticato un foro assai piccolo (pochi centimetri di diametro) e l’ingresso dei raggi solari attraverso
il foro dava luogo sul pavimento ad una “immagine” del disco solare priva di penombra. Stanze
ideali a tale scopo potevano essere anche le chiese. Ecco allora le “linee del mezzodì” sul
pavimento di alcune famose chiese: il duomo di Milano, il duomo di Firenze (qui il soffitto, alto più
di 90 metri, consente una precisione estrema), la chiesa di San Petronio a Bologna, la chiesa di
Santa Maria degli Angeli a Roma (di fronte alla stazione Termini). Spesso la linea meridiana era
arricchita dall’indicazione della posizione del “disco solare proiettato” in numerose date dell’anno.
In tal modo la meridiana a camera oscura assumeva non solo la funzione di “indicatore del
mezzodì” ma anche quella di “calendario estremamente preciso”, con cui riconoscere ad esempio il
giorno dell’equinozio di primavera (importante per determinare la data della Pasqua cristiana).
Ecco alcuni modelli di meridiana da noi ricostruiti:
UNA MERIDIANA ARMILLARE
L’armillare è il più elementare e immediato modello di meridiana che si possa realizzare.
Essa deve essere orientata in modo che l’asse del semicilindro sia parallelo all’asse terrestre. Per far
ciò è comodo usare di notte il riferimento della stella polare; oppure basta orientare suddetto asse
verso nord e fare in modo che esso risulti inclinato, rispetto al piano dell’orizzonte, di un angolo
pari alla latitudine del luogo (45°e25’ per Ponte di Brenta).
Sull’asta situata sull’asse del cilinindro è stata fissata una sferetta (punto gnomonica della
meridiana) la cui ombra sulla superficie cilindrica segna l’ora e le stagioni. Le 13 linee orarie
risultano, in questa meridiana, tutte parallele e separate di un angolo di 15° rispetto all’asse del
cilindro. Questo perché, mentre la terra gira su se stessa, questa meridiana sta semplicemente
ruotando attorno al proprio asse con velocità angolare tale da compiere, rispetto al sole, un giro di
360° in 24 ore, ovvero 15° ogni ora.
Il semicilindro può essere fissato, agendo sul morsetto, in varie posizioni a cui corrispondono
diversi sistemi di misurazione del tempo.
1. Se si sceglie di fissarlo in modo che alla data odierna la meridiana segni l’ora coincidente
con quella dei nostri orologi da polso, si dice che essa è stata regolata secondo il TEMPO
MEDIO NAZIONALE.
2. Se si sceglie di posizionare la linea oraria delle ore 12 nella posizione più bassa possibile,
ovvero di allinearla col meridiano locale, allora la meridiana segna il TEMPO VERO
LOCALE.
3. Se da questa posizione si sposta la linea oraria delle ore 12 verso sinistra (osservando la
meridiana col volto orientato verso nord) di un angolo di 3°e05’ (pari alla differenza tra la
longitudine 15° del meridiano dell’Europa Centrale, su cui sono regolati i nostri orologi, e la
longitudine 11°e55’ di Ponte di Brenta) la meridiana segna il TEMPO VERO DEL FUSO
NAZIONALE.
Quanto all’indicazione delle stagioni, essa è fornita dalle tre semicirconferenze ortogonali alle linee
orarie: quella centrale, detta “equinoziale” ed indicata dai segni zodiacali dell’ariete e della bilancia,
viene percorsa dall’ombra del punto gnomonico il 21 marzo (equinozio di primavera) e il 23
settembre (equinozio d’autunno). Quella superiore, indicata dal segno del capricorno, viene
percorsa dall’ombra il 21 dicembre (solstizio invernale). Infine quella inferiore, indicata dal segno
del cancro, viene percorsa dall’ombra il 21 giugno (solstizio estivo). La linea equinoziale segue la
proiezione ortogonale del punto gnomonica sulla superficie cilindrica, questo perché i raggi solari
risultano, in quei due giorni dell’anno, ortogonali all’asse terrestre e quindi anche ortogonali
all’asse della meridiana. Le due linee solstiziali distano da quella equinoziale d= r tg(23°26’) dove r
è il raggio della superficie cilindrica, infatti durante i due solstizi i raggi solari risultano spostati,
rispetto alla precedente situazione, di un angolo pari all’angolo di cui è inclinato l’asse terrestre
rispetto al piano dell’eclittica.
Ancora un’informazione può venire da questo semplicissimo modello di meridiana: immaginando
le intersezioni tra le tre semicirconferenze appena descritte e un piano orizzontale passante per la
sferetta (su cui giacciono i raggi solari al tramonto), si possono comprendere le diverse durate del
“dì” nei vari periodi dell’anno: nei due giorni equinoziali queste intersezioni avvengono alle ore 6 e
alle ore 18 e ciò significa che il dì dura 12 ore; nel solstizio invernale le due intersezioni avvengono
circa alle ore 8 e alle ore 16 e ciò significa che il dì è di sole otto ore; infine nel solstizio estivo le
due intersezioni avvengono circa alle ore 4 e alle ore 20 (si immagini di prolungare il semicilindro)
e ciò significa che il dì dura bel 16 ore.
UNA MERIDIANA PER PIANO ORIZZONTALE
La meridiana armillare descritta nel precedente paragrafo si può considerare “la madre delle
meridiane”, nel senso che dalla comprensione del suo semplice principio di funzionamento, riesce
più facile comprendere anche il grafico di meridiane più complesse come quella per “piano
orizzontale”. Si immagini di appoggiare sopra il piano una meridiana armillare di piccole
dimensioni (ad esempio di raggio 5 cm del semicilindro), il cui grafico sia stato tracciato, anziché su
un semicilindro opaco, su un semicilindro in vetro o in pellicola trasparente. Si immagini poi che
sul cui punto gnomonico venga posta, invece della sferetta, una lampadina.
I raggi di luce emessi dalla lampadina e intersecanti il grafico della meridiana simulano le direzioni
dei raggi solari nelle varie stagioni e nelle varie ore del giorno, per cui il grafico che la lampadina
proietta sul piano orizzontale riproduce esattamente il grafico della meridiana su piano orizzontale:
le linee orarie assumono la forma di segmenti convergenti, la linea equinoziale è una retta e le due
linee solstiziali sono due rami di iperbole.
Naturalmente, se si desidera ottenere un grafico con discreta precisione, questo “esperimento
ideale” non si presta altrettanto facilmente ad una realizzazione pratica, pur essendo utilissimo per
comprenderne il principio di calcolo geometrico. Nel realizzare il nostro modello abbiamo fatto
invece riferimento ad uno dei programmi software reperibili su internet alla voce “gnomonica”.
Il modello da noi realizzato è stato calcolato per le coordinate geografiche di Ponte di Brenta e per
un’altezza gnomonica (distanza tra il punto gnomonico e il piano orizzontale) di 6 cm. Lo gnomone
è inclinato (gnomone polare) in modo da “puntare la stella polare”, esattamente come nella
meridiana armillare; in questo modo l’ombra dell’intero gnomone si sovrappone alle linee orarie e
la lettura dell’ora ne risulta facilitata. Abbiamo scelto di calcolare le linee orarie secondo il TEMPO
VERO DEL FUSO. Sul mezzodì abbiamo aggiunto anche una linea a forma di lemniscata: essa
indica il TEMPO MEDIO. A mezzogiorno, dunque, si può verificare la perfetta coincidenza tra
l’ora indicata dalla meridiana e l’ora indicata dai nostri orologi da polso (nel periodo primaverile ed
estivo si deve ovviamente aggiungere un’ora per ottenere l’ora legale); per le rimanenti ore della
giornata, invece, si possono riscontrare differenze variabili durante l’anno, con un valore masso di
16 minuti in novembre. La differenza tra i due sistemi orari si chiama “equazione del tempo” ed è
tabulata in vari testi di astronomia (vedi testi di gnomonica indicati in bibliografia).
UNA MERIDIANA PER PIANO VERTICALE
Con lo stesso “esperimento ideale” descritto per la meridiana per piano orizzontale, si può ottenere
il grafico di una meridiana per piano verticale pensando di avvicinare la meridiana armillare in
vetro e con lampadina alla parete verticale su cui si vuole tracciare il grafico.
Il modello da noi realizzato è stato calcolato per una parete orientata esattamente verso sud, per le
coordinate geografiche di Ponte di Brenta e per un’altezza gnomonica di 6 cm. Lo gnomone è
ancora di tipo “polare”.
UNA MERIDIANA AD ORE ITALICHE
Come già detto, le ore italiche sono un sistema orario che poneva le ore 24 al tramonto del sole
anziché alla mezzanotte. Esso era ampiamente diffuso in Italia nel periodo rinascimentale e rimase
il sistema orario di uso civile fino all’invasione napoleonica. Gli invasori francesi non ammettevano
un sistema orario diverso dal loro anche per un fatto commerciale: gli orologi meccanici non si
adattavano a questo sistema orario (l’ora del tramonto cambia continuamente durante l’anno) e non
potevano dunque essere facilmente venduti in Italia.
Lo gnomone di una meridiana ad ore italiche era normalmente costituito da un’asta ortogonale alla
superficie e solo la sua estremità (punto gnomonico) serviva ad indicare l’ora (uno gnomone di tipo
“polare” non avrebbe avuto senso in questo tipo di meridiana perché le linee orarie non sono
convergenti verso un unico punto come nei due modelli precedenti di meridiana e l’ombra dello
gnomone non si sarebbe sovrapposta interamente alle linee orarie).
Per ottenere il grafico di questo tipo di meridiana si può pensare di partire dal grafico di una
meridiana per parete verticale (vedi precedente paragrafo). Detta H la proiezione ortogonale del
punto gnomonico (estremità dello gnomone), si traccia una retta orizzontale passante per H e si
considera la sua parte AB dove A è sua intersezione con la linea solstiziale invernale e B un altro
punto situato a destra di A ai bordi del quadrante. Il segmento AB costituisce la linea oraria delle
ore 24 della meridiana ad ore italiche. Infatti nel momento del tramonto i raggi solari giacciono su
un piano orizzontale e l’ombra del punto gnomonico cade necessariamente sulla linea orizzontale
passante per H. Se la parete è rivolta verso ovest (molte meridiane ad ore italiche si trovavano
effettivamente su pareti di campanili o ville “declinanti” ad ovest), il segmento AB interseca anche
la linea equinoziale in un certo punto E.
I due punti A ed E cadono, nel grafico della meridiana per parete verticale, in corrispondenza di due
precisi momenti della giornata: rispettivamente all’ora del tramonto il 21 dicembre e l’ora del
tramonto il 21 marzo. Se ci spostiamo indietro di un’ora sia lungo la linea solstiziale che lungo la
linea equinoziale, otterremo due punti A’ ed E’ che, congiunti, ci danno la linea oraria delle ore 23
per la meridiana ad ore italiche. Si ripete poi il processo in modo analogo per ottenere la linea delle
ore 22, 21, 20, etc.
Il modello da noi realizzato è stato calcolato per una parete orientata a 45° verso sud-ovest
(declinante di 45° verso ovest), per le coordinate geografiche di Ponte di Brenta e per un’altezza
gnomonica di 6 cm. Lo gnomone è, questa volta, di tipo “ortogonale”.
COME ORIENTARE CORRETTAMENTE I MODELLI
Per orientare i modelli si può pensare di usare una semplice bussola, tuttavia va ricordato che oltre
al problema di dover conoscere la declinazione magnetica del luogo (differenza tra la direzione del
meridiano locale e del campo magnetico) vi è anche l’elevata probabilità che eventuali tubi in ferro
presenti all’interno dei muri di un’abitazione, alterino la direzione del campo magnetico nel luogo
in cui viene posta la bussola (queste alterazioni possono essere addirittura di decine di gradi!).
Un metodo molto più preciso, che gli antichi “gnomonisti” usavano per tracciare sopra un piano
orizzontale una linea perfettamente orientata in direzione nord-sud è il seguente:
1. Si dispone un filo a piombo in modo che la sua estremità inferiore sfiori la superficie piana e
si traccia sul piano il punto H indicato dall’estremità del piombo.
2. Si fissa sul filo del piombo, ad un’altezza di circa 80 cm dal piano, una sferetta (in legno o
in plastica, su cui sia stato praticato un forellino per il passaggio del filo “diametrale”) di
diametro circa 1 cm.
3. Si traccia sul piano il percorso dell’ombra della sferetta durante un’intera giornata di sole
(preferibilmente nel periodo autunno-inverno, per una maggiore precisione del risultato). La
linea tracciata avrà la forma di un ramo d’iperbole.
4. Si traccia sul piano una circonferenza di centro H e di raggio sufficientemente ampio
affinché l’arco di circonferenza intersechi in due punti A e B distanti circa 80 cm l’iperbole
ottenuta sopra.
5. Si traccia il punto medio M del segmento AB
6. Si traccia la retta HM: essa rappresenta la direzione nord-sud.
Il tema del tempo è sicuramente uno dei più fruttuosi e interessanti topoi della filosofia europea
d’ogni tempo. Riflessioni su questo argomento sono state prodotte, fra gli altri, da Eraclito, da
Orazio, da Seneca, da – in tempi più recenti – l’economista A.J. Marshall ed i pensatori Martin
Heidegger e Henry Bergson.
Molte anzi delle frasi a corredo di meridiane sono più o meno consapevolmente desunte da opere
letterarie o filosofiche sull’argomento – si pensi, ad esempio, al celebre Carpe diem di ispirazione
epicureo-oraziana.
Quali dunque le implicazioni di un qualche interesse?
Già i movimenti stoici ed epicurei avevano individuato quel carattere di indefinibilità della
dimensione temporale che la stessa fisica moderna ha dovuto accettare. Il tempo dell’uomo è
innegabilmente il presente: nulla anzi di ciò che appartiene al passato può sopravvivere se non a
livello di ricordo individuale. Di qui la rilevanza dell’oraziano Carpe diem e del senecano Nihil
differamus. Concedere il proprio tempo – a qualcuno o a qualcosa – equivale all’erogazione di un
credito a fondo perduto: e dunque fruiamone in una maniera che permetta, giunti al termine dei
nostri giorni, di distaccarci dalla vita imperturbabilmente, giacché alcunché in misura maggiore
rispetto alla nostra condizione interiore che ci seguirà in un eventuale aldilà, ci ha mai dato una
gioia superiore.
Cambiamenti condivisi della concezione di tempo soggiacciono alle più grandi rivoluzioni culturali
e sociali della storia specificatamente europea. Si pensi, a titolo d’esempio, allo sviluppo
manifatturiero dei secoli XIII e XIV come analizzato in rapporto al tempo dal medievalista
LeGoffe. In una società ancora profondamente e nichilisticamente cattolica, entro la cui ottica lo
spessore dell’esistenza individuale naturale è ridotto in proiezione dell’eternità della vita spirituale,
il tempo del mercante rivaluta prepotentemente la dimensione del qui e dell’ora. La concezione
ciclica di una storia provvidenzialisticamente determinata, nel cui contesto l’agire dell’uomo
comune risulta indifferente rispetto al fine ultimo, viene ad essere sostituita da un idea di linearità e
concausalità degli eventi, contestato nei tempi antichi come nei moderni.
In effetti, il concepire la dimensione temporale, sul piano della successione dei fatti (ciclicità o
linearità) come su quello della consequenzialità (successione causale oppure flusso alogico) risente
di un’alternanza mai sopita. Già Eraclito, cinque secoli prima della nascita di Cristo, trattava del
passare del tempo in termini di eterno fluire; unico a sottrarsi al divenire perenne, il motore
immobile, quell’identificarsi di pensiero, parola e azione, espressione di una volontà immanente al
mondo e capace di determinarne l’evolversi. Ripresa dal filone idealistico di matrice hegeliana,
dove è unificata allo sviluppo dello spirito dell’uomo, l’idea di un principio ordinatore è contestata
in tempi già moderni da Friedrich Nietzsche. La concezione, medievalmente nichilistica, della
ciclicità della storia si fonde armoniosamente con la coscienza dell’insensatezza e nondimeno il
rifiuto coraggioso al lasciarsi vivere. È questo il fondamento della morale superomistica, l’ostacolo
in vista del quale deve essere elaborata una nuova figura di essere umano.
Solo con Martin Heidegger il sistema categorico innanzitutto aristotelico e kantiano, secondo il
quale il divenire è fra le garanzie dell’essere, la concezione della dimensione temporale si
riappropria del valore di selettore di senso. È in funzione del tempo che l’ente che è
“temporalmente” ( i processi naturali e gli eventi storici) si separa da quello che è “nontemporalmente” (le relazioni spaziali e numeriche) e si contrappone a ciò che è “non
temporalmente” (Dio).
Questa funzione della dimensione temporale come criterio ontologico, è già presente nella
concezione greca dell’essere dell’ente come ousia (essenza, sostanza): Heidegger rinnova l’idea
avvalorandone l’elemento della presenza, ovvero postulando che l’analisi innanzitutto dell’essenza
umana non può prescindere da un’ermeneutica della fatticità – l’uomo e deterministicamente
influenzato dal contesto in cui vive.
Di qui, anche sulla scorta dell’indagine psicanalitica freudiana, il rivolgimento bergsoniano all’idea
del tempo della coscienza quale eterno fluire. L’attività della mente non può essere ridotta ad una
serie numerabile e consequenziale di atti. L’impossibilità di estendere alla coscienza la temporalità
spazializzante della fisica, ovvero l’impossibilità di ridurre la descrizione del tempo vissuto a
estensione cronometrica e rapporto spaziale, è elemento fondante anche di molta produzione libraria
novecentesca: l’Ulysses di J. Joyce e la Coscienza di un fumatore di Ettore Schmitz (Italo Svevo)
sono illuminanti esempi del genere.
… OSSERVANDO UNO SPRUZZO D’ACQUA
Uno spruzzo d’acqua lanciato verso l’alto ricade a terra descrivendo, come è noto, la traiettoria
parabolica di qualunque altro corpo lanciato in volo. La curvatura della parabola nel suo vertice è
più evidente se lo spruzzo è relativamente lento mentre diventa meno accentuata se lo spruzzo è più
veloce.
Ma quale forma assumerebbe questo spruzzo se venisse prodotto all’interno di un ascensore libero
di precipitare?
La risposta a questa domanda apparentemente innocua la diede per primo Albert Einstein:
seguirebbe una traiettoria rettilinea! L’idea dell’ascensore in caduta libera fu definita da Einstein
“la più felice della mia vita”: mentre l’ascensore precipita, chi si trovasse al suo interno giurerebbe
di trovarsi in assenza di gravità, vedrebbe gli oggetti fermi a mezz’aria oppure in moto rettilineo ed
uniforme…Einstein concluse che anche un raggio di luce, prodotto all’interno dell’ascensore,
viaggerebbe di moto rettilineo. Fin qui tutto chiaro. Ma le deduzioni che si traggono da queste
premesse rappresentarono una svolta storica sulla teoria fisica riguardante la luce. Infatti,
applicando le trasformazioni di coordinate (che, come è noto, sono di forma quadratica) dal sistema
di riferimento “ascensore” al sistema di riferimento “edificio in cui l’ascensore è posizionato”, si
ottiene che tutte le traiettorie che nel primo erano rettilinee, nel secondo diventano curvilinee: una
parabola per lo spruzzo d’acqua, come appunto ci si aspettava…e per la luce? Ancora una curva,
intuì Einstein!
Da questa intuizione così semplice eppure così rivoluzionaria rispetto a quanto si credeva a fine
ottocento, Einstein passò ad elaborare una teoria (la teoria della Relatività Generale) che gli
permettesse di calcolare l’angolo di cui avrebbe dovuto deviare un raggio di luce che, provenendo
da una stella, fosse giunto a noi dopo aver sfiorato il nostro sole. Nel 1916 riuscì nel suo intento:
l’angolo di deviazione sarebbe dovuto essere pari a 1,75” di grado: molto piccolo ma misurabile con
i telescopi di allora, che avevano sensibilità 0,1” di grado. Nel 1919 ci fu un’eclisse totale di sole e,
dalle foto delle stelle visibili in quel momento in prossimità del sole nella volta celeste, risultò che
veramente esse apparivano in posizione falsata ed esattamente di quanto Einstein aveva previsto.
La curvatura della luce all’interno di un campo gravitazionale, come quello del sole, apparve un
fatto paradossale e sembrava violare il principio settecentesco di Fermat: nel suo passaggio da un
punto A ad un punto B dello spazio la luce segue, tra tutte le traiettorie possibili, quella più breve in
termini di tempo, anche se non dovesse essere la più breve in termini di spazio (come accade nel
caso in cui la luce passi dall’aria all’acqua subendo la rifrazione). Einstein, però, scoprì che in ogni
caso il principio di Fermat resta valido: infatti all’interno di un campo gravitazionale succede che il
tempo (e anche lo spazio) viene “deformato” ( dilatazione gravitazionale del tempo), cosicché una
traiettoria rettilinea della luce non risulterebbe affatto più breve in senso temporale!
Per osservare la curvatura della luce in un campo gravitazionale, oggi sono disponibili immagini
stupende come quella qui riportata (oggetto astronomico MG1131+049 ): il dischetto luminoso al
centro è l’immagine di un quasar la cui luce è giunta a noi dopo aver attraversato una galassia
perfettamente interposta tra noi ed il quasar. L’anello di luce (anello di Einstein) che si vede attorno
al dischetto è ancora luce proveniente dallo stesso quasar: raggi di luce che hanno sfiorato il bordo
di quella galassia e che sono stati deviati dal suo campo gravitazionale, esattamente come se si
trattasse di una immensa lente convergente.
Immagine di un quasar e del suo anello di Einstein.
… OSSERVANDO L’IMMAGINE DI UNA GALASSIA
Due galassie in collisione
Siamo talmente abituati, al giorno d’oggi, a vedere immagini con risoluzione sempre più alta degli
oggetti astronomici, che raramente ci domandiamo quanto tempo sia trascorso tra il momento in cui
la luce è partita da quegli oggetti e il momento in cui è giunta ai nostri telescopi. Nel caso in cui gli
oggetti siano galassie, questo tempo può essere addirittura dell’ordine di grandezza dei miliardi di
anni. Nasce allora una seconda domanda: “Come è possibile che le informazioni che la luce ci offre
su questi oggetti (dettagli sulla forma, temperatura, composizione chimica, movimenti rotatori, etc.)
siano così particolareggiate e precise anziché essere confuse dall’invecchiamento subito durante il
viaggio?”. Se pensiamo ai reperti archeologici, ci rendiamo conto che anche i dettagli incisi su
pietra dura vengono deteriorati dall’invecchiamento in sole poche migliaia di anni (vedi nella foto la
famosa “Stele di Rosetta”).
L’invecchiamento è inevitabile su tutto ciò che è materiale e segue il principio fisico dell’aumento
di entropia nel tempo. Come è possibile dunque che la luce non risulti “invecchiata” neppure dopo
un viaggio di miliardi di anni? La risposta ci viene ancora dalla teoria della Relatività di Albert
Einstein: la durata del viaggio è diversa a seconda del sistema di riferimento inerziale da cui esso
viene osservato. Se la durata del viaggio della luce per noi osservatori terrestri è Δt = 1 miliardo di
v2
anni, nel sistema di riferimento solidale alla luce essa è Δt ' = Δt ⋅ 1 − 2 , dove v è la velocità
c
relativa tra i due sistemi di riferimento e c è la velocità della luce. Nel nostro caso la velocità
relativa tra i due sistemi è ancora c, per cui risulta Δt’= 0.
In conclusione, la luce non è invecchiata perché, nel suo sistema di riferimento, la durata del
viaggio è stata nulla!
… OSSERVANDO L’APERTURA E LA CHIUSURA DEI FIORI
L'orologio floreale di Linneo
Carlo Linneo (1707-1778), naturalista famoso per la scoperta e classificazione di molte specie
(autore della classificazione binomiale), ideò nel suo giardino di Upsala un orologio floreale basato
sulla periodicità di apertura di diverse specie vegetali: dall’alba al tramonto si assiste al susseguirsi
di aperture e chiusure di fiori in risposta al percorso diurno del Sole.
Riportiamo un disegno dell’epoca (Pearson) e la tabella originale costruita da Linneo.
Qui sotto si legge lo schema originale di Linneo per l'orologio
floreale in una edizione del 1763
Nel pannello esposto nella mostra abbiamo realizzato un orologio floreale utilizzando alcune piante
indicate da Linneo:
1) Lassana (Lapsana communis)
2) Rosa del Giappone (Chaenomeles sp.)
3) Patata (Solanum tuberosum)
4) Giglio d’acqua (Nymphaea sp.)
5) Fiorancio (Calendula officinalis)
6) Escolzia ( Eschscholtzia sp.)
7) Ieracio ( Hieracium sp.)
8) Erba cristallina (Astenia cordifolia)
9) Cardo (Cynara cardunculus)
10) Bella di notte (Mirabilis jalapa)
11) Pigliamosche (Dionea sp.)
12) Regina della notte (Selinecereus)
Per il mattino abbiamo considerato l’apertura cadenzata dei fiori, per il pomeriggio la graduale
chiusura delle corolle e per la sera l’apertura dei fiori serali e notturni.
… OSSERVANDO LE MIGRAZIONI DEGLI UCCELLI
Il nostro ambiente organico interno (composto di fluidi e tessuti) mantiene nel tempo l'uniformità di
una miriade di componenti, con un'alterna ed intricata rete di stimolazioni e inibizioni, azioni e
retroazioni: una minima variazione comporta un'immediata risposta. Sembrerebbe dunque
inconciliabile l'idea che i fenomeni biologici abbiano un andamento non uniforme. Eppure,
omeostasi e bioperiodicità non solo sono compatibili, ma cooperanti. Potremmo dire che i processi
che regolano l'omeostasi operano seguendo la ritmicità degli eventi biologici.
I ritmi biologici, scoperti da Franz Halberg, seguono - in prima approssimazione - una curva simile
a quella sinusoidale: cresce fino ad un massimo (acrofase) e poi scende fino a un minimo, variando
intorno ad un valore mediano che si chiama mesor. Il tutto si completa in un periodo di tempo ben
definito e caratteristico che può essere: un giorno
(ritmi circadiani), una settimana (ritmi circasettani),
un mese (ritmi circatrigintani), un anno (ritmi
circannuali), e così via. In particolare, il ritmo
circadiano, (dalle parole latine "circa" e "dies" =
"ciclo di quasi un giorno") è il componente
fondamentale di quello che potremmo chiamare
"orologio biologico".
Gli esempi più evidenti di questo "orologio" sono il
battito cardiaco, il ciclo mestruale femminile, la
variazione della temperatura corporea durante il
giorno, l'apertura e la chiusura di certi fiori
rispettivamente all'alba e al tramonto, le migrazioni
periodiche di alcune specie animali, ecc. Poiché
alcuni di questi fenomeni hanno periodi approssimativamente coincidenti con quelli di altri
fenomeni ciclici ambientali, quali l'alternarsi giorno-notte, i cicli stagionali, le fasi lunari, ecc., è
abbastanza naturale cercare fra queste variabili una possibile relazione di causa effetto.
Dunque, gli esseri viventi hanno anche una struttura temporale. Ed i fenomeni bioperiodici esistono
a tutti i livelli di organizzazione, dagli eucarioti unicellulari ai pluricellulari tra cui l'uomo.
Le attività della maggior parte degli esseri viventi sul nostro pianeta si caratterizzano per l’influsso
costante di due cicli geofisici: quello del giorno e quello della notte. Una delle numerose reazioni a
questa periodicità sono le migrazioni.
Molti di questi spostamenti periodici sono sorti in risposta alle stagioni che si avvicendano sulla
Terra e coinvolgono molti pesci, quali le anguille, i salmoni e i tonni, anfibi, insetti, ma soprattutto
gli uccelli.
Questi vertebrati hanno occupato quasi tutte le regioni della Terra, e il tracciato dei loro viaggi
avvolge come una rete l’intera superficie del pianeta, compreso l’emisfero meridionale. Gli
spostamenti australi conducono perlopiù dalle regioni della nidificazione verso zone di
stazionamento più prossime all’equatore. In casi eccezionali gli uccelli migratori effettuano percorsi
che corrispondono all’intera circonferenza del globo, attraversando oceani, deserti, catene montuose
e superfici ghiacciate, a eccezione forse dei poli, e non c’è mese dell’anno nel quale in qualche
parte del mondo non sia in atto una qualche migrazione di uccelli.
Per quanto riguarda le causa delle migrazioni lo studioso Rappole ne ha individuate otto categorie:
1)cambiamenti antichi nelle condizioni ambientali come le glaciazioni;
2)cambiamenti climatici più recenti;
3)cambiamenti ambientali di vasta portata;
4)presenza di risorse vitali in luoghi distanti dai quali si trovano gli uccelli;
5)fruizione di frutti o nettare in regioni contigue per il ciclo stagionale;
6)competizione tra le specie;
7)influssi di dominanza;
8)ipotesi dell’esistenza di un limite geneticamente determinato di sopportazione di condizioni
ambientali avverse, il superamento del quale determinerebbe un inarrestabile impulso alla partenza.
A proposito dell’ultima teoria si pensa che i migratori fossero in origine uccelli stanziali, e che
“qualcosa” abbia messo in moto l’attività migratoria: infatti negli uccelli la scelta di intraprendere o
no il viaggio migratorio corrisponde al superamento o al mancato superamento di una soglia
geneticamente determinata da un’eredità poligenica (caratteri quantitativi).
Prima delle migrazioni avvengono delle disposizioni migratorie che sono condizioni fisiologiche e
comportamentali complesse che dimostrano in vari modi che un uccello è sul punto di partire.
Mettendo a confronto uccelli stanziali ed uccelli migratori si notano differenti fasi di sviluppo nelle
caratteristiche dei migratori, che per esempio devono portare a termine il ricambio del piumaggio in
un tempo minore. In questo modo lo sviluppo giovanile dei migratori si adatta ai requisiti di
comportamento migratorio della popolazione di appartenenza per accelerare gli stadi di sviluppo
intermedi, e permettere loro di raggiungere la disposizione migratoria per partire.
In generale prima dell’inizio della stagione migratoria gli uccelli cominciano ad assumere maggiori
quantità di cibo, così attraverso l’iperfagia vengono accumulate le riserve di energia per
l’immigrazione autunnale.
E’ dimostrato che i migratori alternano un periodo d’ingrassamento con uno di dimagrimento, un
fenomeno per molti aspetti governato da ritmi endogeni (orologi biologici). In questo periodo è
stato notato che per aumentare le riserve di grasso gli uccelli che normalmente si cibano
prevalentemente di insetti e altri animali hanno un più largo consumo di frutta e bacche, ma per
riuscire a sopportare sforzi fisici elevati hanno bisogno di integrare la loro alimentazione con una
quantità di cibo di origine animale.
Durante il periodo migratorio alcune specie cambiano la loro struttura corporea mediante ipertrofia
e atrofia muscolare, e i fisiologi delle migrazioni dopo aver estratto i depositi di grasso dai migratori
hanno potuto studiarne la composizione sia a livello qualitativo che quantitativo.
Il dimostrabile accumulo di grasso anche al rientro dalla migrazione, ossia durante il periodo degli
accoppiamenti, è stato ricondotto a quattro possibili cause: 1)fornire il nutrimento per la formazione
di cellule riproduttive; 2)evitare che i migratori si ritrovino in affanno per i tempi stretti e i ritmi
serrati nei quartieri riproduttivi; 3)favorire la capacità di resistenza di fronte a condizioni avverse;
4)permettere agli uccelli di ritorno di dedicarsi ad una ricerca mirata delle sostanze necessarie al
metabolismo riproduttivo.
Grazie alle sorprendenti capacità energetiche fornite dal grasso come carburante per le migrazioni i
migratori raggiungono autonomie di volo paragonabili a quelle di grandi aeroplani, e perciò è facile
comprendere come riescano a superare barriere gigantesche come gli oceani.
Mentre si trova in volo l’uccello presenta un metabolismo quintuplo rispetto a quello da fermo, e di
dieci-trenta volte maggiore del metabolismo basale. I migratori, quindi, specialmente quelli che
percorrono lunghi tragitti in temperature ambientali alte, vanno incontro al pericolo teorico di
ipertermia e, se accanto al calore ceduto per irradiazione o per convezione, impiegano troppa acqua
per la traspirazione, sono minacciati di disidratazione.
E’ interessante inoltre osservare come negli uccelli in generale siano numerosi gli adattamenti alla
permanenza a grandi altezze e ai cambi repentini di altitudine. I principali adattamenti sono i
seguenti: il polmone parabronchiale lavora col sistema della corrente incrociata nel quale l’aria
inspirata e quella espirata passa attraverso due parabronchi disposti in parallelo, senza mescolarsi.
… OSSERVANDO LA SRATIFICAZIONE DELLE ROCCE
Camminando in montagna ci è difficile pensare al trascorrere del tempo: eppure intorno a noi si
apre un libro naturale le cui pagine (sapendo sfogliarle e leggere) ci raccontano di eventi
straordinari, a volte veloci e catastrofici, più spesso lenti e inesorabili, che i sono svolti nel corso di
milioni di anni.
Nel pannello in mostra abbiamo provato a ricostruire una sequenza temporale attraverso le rocce
che si trovano frequentemente nelle Dolomiti: non si tratta di una formazione precisa riferita ad un
luogo particolare ma vuole essere un “riassunto“ dei principali strati rocciosi che si possono trovare,
dai più antichi ai più recenti, in questa catena montuosa.
Abbiamo perciò raccolto e ordinato cronologicamente le seguenti rocce:
− Scisto metamorfico (Paleozoico)
− Porfido (Paleozoico)
− Arenaria da sedimentazione di ceneri vulcaniche (Paleozoico)
− Dolomia principale (Mesozoico)
− Calcare grigio (Mesozoico)
− Rosso ammonitico (Mesozoico)
− Biancone (Mesozoico)
− Scaglia rossa (Mesozoico)
− Arenaria glauconitica (Cenozoico)
− Marna (Cenozoico)
“Con i valloni deserti,
con le gole tenebrose,
con i crolli improvvisi di sassi,
con le mille antichissime
storie e tutte le altre cose che
nessuno potrà dire mai…”
Dino Buzzati
(da “Barnabo delle montagne”)
La datazione delle rocce
Esistono due metodi per datare le rocce, i fossili e gli eventi del passato geologico.
Essi vengono chiamati rispettivamente datazione relativa e datazione radiometrica o assoluta.
Il primo metodo è quello più antico e, come dice la parola stessa, non fornisce una datazione
quantitativa, ma soltanto relativa: una roccia o un fossile vengono riferiti a un certo periodo della
storia della terra collocato in una scala temporale di cui, fino agli inizi del secolo scorso, non si
conosceva la misura quantitativa.
Il metodo radiometrico, basato sul processo fisico del decadimento degli elementi radioattivi, è
invece in grado di quantificare con buona e sufficiente approssimazione l’età di un minerale, di una
roccia o di un fossile.
E’ stato così possibile, dopo la scoperta della radioattività e nel giro di pochi decenni, avere un
quadro realistico del tempo geologico e della collocazione cronologica dei vari fenomeni
succedutisi dalla formazione del nostro pianeta ad oggi.
Ci si è così resi conto che si trattava non di migliaia (come riportato nelle Sacre Scritture), ma di
milioni e di miliardi di anni.
Datazione relativa
Il metodo della cronologia relativa è fondato su due concetti base: quello della sovrapposizione
degli strati e quello dell’evoluzione biologica.
Il principio della sovrapposizione è stato usato fin dai primordi della geologia, a metà del Seicento.
Già nel 1759, il veronese Giovanni Arduino stabiliva una suddivisione cronologica relativa delle
formazioni geologiche del Veneto in quattro categorie, da lui dette “ordini”, e chiamate, dalla più
recente alla più antica, quaternaria, terziaria, secondaria e primaria.
La vita è presente sulla Terra da circa tre miliardi e duecento milioni di anni.
La paleontologia è la scienza che cerca di capire i vari aspetti della vita di piante e animali
succedutisi in questo lunghissimo lasso di tempo e perciò basata sullo studio dei fossili, ossia resti
di organismo o tracce della sua attività che si sia conservata.
Circa il problema dell’età della Terra, fino agli inizi del Settecento, in tutto il mondo cristiano
veniva accettato ciò che era scritto nella Bibbia.
Nel 1654, l’arcivescovo irlandese James Ussher, analizzando le Sacre Scritture, concludeva che la
Terra era stata creata nel 4004 a.C..
L’idea di una Terra vecchia di seimila anni fu accettata almeno fino agli inizi del Settecento, ma i
grandi geologi dell’Ottocento, quali lo scozzese James Hutton e l’inglese Charles Lyell,
resero il mondo scientifico consapevole che il tempo geologico doveva avere un’estensione enorme.
Già nel 1830 i geologi ragionavano in termini di milioni di anni. Si aprì così la strada alla teoria
dell’evoluzione che verrà proposta da Darwin una ventina di anni dopo.
L’attuale stato biologico del nostro pianeta è il risultato di un lungo processo di variazioni e sviluppi
graduali e completi che nel loro insieme prendono il nome di evoluzione, perciò i fossili di uno
stesso gruppo di organismi variano gradualmente nelle rocce via via più recenti.
Impronte di dinosauro su di una superficie di
strato di Dolomia Principale nel Monte
Pelmetto (figura A); il blocco di Dolomia
Principale con la superficie improntata
esposta (figura B); veduta ravvicinata delle
impronte (figura C)
Datazione radiometrica
La datazione assoluta è certamente un’aspirazione molto antica dell’uomo. Già Erodoto (484-424
a.C.) aveva pensato che il delta del Nilo fosse stato costruito dalle piene del fiume e che, siccome
ogni alluvione aggiungeva solo pochi centimetri all’anno di limo e sabbia, dovevano essere state
necessarie diverse migliaia d’anni per costruirlo.
Fu però la scoperta della radioattività nel 1896 che offrì la possibilità di misurare il tempo geologico
con una precisione che prima era impensabile.
Appena nove anni dopo la scoperta della radioattività, Lord Rutherford annunciò nel 1905 la
possibilità di usare il decadimento radioattivo per misurare l’età delle rocce e tre anni dopo fu in
grado di attribuire un’età di 500 milioni di anni a un cristallo di fergusonite ( un ossido ittrio e
niobio), in base al suo contenuto di uranio e elio.
L’età così determinata viene definita età radiometrica.
La radioattività naturale consiste nell’emissione di particelle alfa, beta e altre quali positoni, neutrini
e antineutrini, e di radiazioni gamma.
Mediante questo processo un elemento genitore (isotopo o nuclide radioattivo) si trasforma in un
altro elemento figlio (isotopo radiogenico).
La velocità di decadimento è data dal numero di atomi che decadono nell’unità di tempo. Questa
velocità non solo è diversa per ogni isotopo radioattivo, ma varia anche per lo stesso isotopo.
Infatti, la velocità di trasformazione nel prodotto finale decresce nel tempo.
Ogni isotopo decade in un altro impiegando sempre lo stesso tempo per dimezzare la propria
quantità. Tale grandezza costante viene chiamata tempo di dimezzamento ed è indicata col simbolo
t 1/2. Con il ricorso a tale tempo è possibile calcolare facilmente il tempo intercorso dalla formazione
del minerale ad oggi.
Il rapporto tra la quantità di isotopo radioattivo e quella dell’isotopo prodotto dal suo decadimento
permette di stabilire da quanto tempo l’isotopo iniziale emette radiazioni.
Ciò equivale a dire che il rapporto tra i due isotopi ci consente di stabilire l’età del minerale o della
roccia in cui essi sono contenuti. Quindi occorre conoscere tale rapporto. I metodi di datazione
radiometrica attualmente più usati utilizzano le coppie potassio-argon (K/Ar), rubidio-stronzio
(Rb/Sr), samario-neodimio (Sm/Nd), uranio-piombo (U/Pb), torio-piombo (Th/Pb) e carbonio-14
(14C). Mentre i primi cinque, a causa del lunghissimo tempo di dimezzamento, sono utilizzati per
datare minerali e rocce molto antichi, il carbonio-14, che ha un tempo di dimezzamento di soli 5730
anni, può solo essere usato per datare materiali organici, quali ossa, legni, carboni negli ultimi
80000 anni. Tale metodo, quindi, è utilizzato per datare gli avvenimenti più recenti del Quaternario,
per la preistoria e per l’archeologia.
L’errore nella datazione di una roccia di alcune centinaia di anni è compreso in qualche milione di
anni. Ecco, quindi, che, accanto a una cronologia relativa si ha una cronologia assoluta espressa in
milioni di anni e con un insignificante margine di errore. Tali valori comunque vengono
continuamente aggiornati, corretti e raffinati, datando con i vari metodi radiometrici migliaia di
rocce di tutto il mondo, la cui età relativa è nota con sufficiente precisione.
Se si riduce la storia della Terra (4 miliardi e 700 milioni i
anni) a 12 ore, cioè a n giro di quadrante dell’orologio, le
prime cellule viventi sono apparse verso le 3:30, mentre la
fotosintesi, responsabile dell’immissione di ossigeno
nell’atmosfera, è iniziata verso le 5:00. I protozoi, che si
possono considerare i primi animali, compaiono verso le
9:00. Da questo momento i processi evolutivi accelerano i
tempi: gli invertebrati compaiono prima delle 11:00, i pesci
poco dopo, i mammiferi seguono verso le 11:30. L’uomo è
l’ultimo ad arrivato, compare meno di mezzo minuto prima
delle 12:00.
La storia geologica delle Dolomiti
Le Dolomiti, universalmente famose per la suggestività dell’ambiente e per l’interesse scientifico,
hanno una lunga e complessa storia geologica e geomorfologia che ne ha determinato il tipico
aspetto. In esse si trovano l’una associata all’altra due tipi di rocce, quella dolomica e quella
vulcanica, che normalmente non lo sono perché derivano da processi e ambienti totalmente diversi.
La roccia dolomica è molto più resistente agli agenti della degradazione meteorica rispetto alle
rocce vulcaniche, le quali si alterano e infrolliscono facilmente.
Risulta che i pallidi e torreggianti picchi dolomitici si trovano vicino o emergono dalle verdi valli e
dai pendii, dove invece stanno le scure rocce di origine vulcanica.
La dolomia e quasi tutte le rocce che affiorano nella zona dolomitica si sono formate in fondo al
mare durante quello che viene chiamato “processo litogenetico” (o della formazione delle rocce).
Ben diverso è il “processo orogenetico” in cui si ha la formazione delle montagne e che, nel caso
delle Dolomiti, è separato da quello litogenetico da ben 100-150 milioni di anni.
Le principali tappe nella storia geologica della Regione Dolomitica. I numeri sulla sinistra
indicano i milioni di anni
Processo litogenetico
Le vicende che hanno consentito l’evoluzione del paesaggio dolomitico, decifrate attraverso lo
studio delle rocce e delle forme del rilievo, si possono far risalire ad almeno 270 milioni di anni fa,
durante il Permiano. In questo periodo, fra l’Europa e l’Africa, comincia ad aprirsi un grande
oceano, conosciuto col nome di Tetide, dove per decine di milioni d’anni avviene la deposizione di
ingenti quantità di sedimenti.
La nostra regione appare come un’ampia pianura
alluvionale dal clima arido e caldo, dove i fiumi
accumulano detriti di vario genere, trasformatisi in
seguito in solida roccia, nota con il nome di Arenaria
di Val Gardena.
Dall’inizio del periodo Triassico per 20-30 milioni di
anni la profondità del mare oscilla più volte
provocando a tratti l’emersione di alcune zone e la
conseguente erosione delle rocce che si sono
precedentemente formate sui fondali marini. Il clima
Le Arenarie di Val Gardena; gli strati
tropicale di quel periodo favorisce l’insediamento di
bianchi sono gessi
colonie di alghe calcaree in grado di costruire le prime
piattaforme carbonatiche.
Circa 255-260 milioni di anni fa il mare invade la nostra regione determinando inizialmente il
formarsi di depositi salini bianchi e farinosi e poi di sedimenti scuri detti formazione di
Bellerophon.
A partire dal Ladinico (235 milioni di anni fa) i
fondali cominciano a sprofondare, addirittura
1000 metri in pochi milioni di anni. Alcune
zone si sollevano ed emergono dal mare
formando isole. Alla fine di questo periodo,
però, tutta la zona subisce un lento processo di
sprofondamento (la “subsidenza”), che fa
sprofondare le isole sopra citate, sulle quali
hanno attecchito comunità organogene: si tratta
di primitive scogliere coralline che cercano di
tenere il passo della subsidenza per rimanere
costantemente a pochi metri di profondità e che
oggi costituiscono alcune delle più famose
montagne dolomitiche quali lo Sciliar, il
Latemar, la Marmolada, il Catinaccio, le Pale di
San Martino, il Putia e la parte inferiore della
Civetta. La roccia di cui sono
Il Trias e le sue suddivisioni. La datazione tuttavia
formate è detta calcare della Marmolada o
viene continuamente aggiornata e quindi sono
dolomia dello Sciliar a seconda della
possibili piccole discrepanze
composizione chimico-mineralogica.
Alla fine del Ladinico, 230 milioni di anni fa, si formano due grossi vulcani che emergono
dall’acqua ( uno vicino Predazzo e uno nei pressi della Val di San Nicolò) e dai quali fuoriesce un’
enorme quantità di lava e tufi che si riversa lungo i pendii delle scogliere riempiendo così i bacini
marini. Interi gruppi sono formati da queste rocce vulcaniche: catena del Padòn, il Monte Pore e il
Piz del Corvo, il Col di Lana, la Cima di Pape, il sottogruppo Colac-Buffaure.
Tale attività vulcanica è accompagnata da terremoti,
maremoti, variazioni del livello del mare e frane
sottomarine, importanti per la modificazione dell’aspetto
della regione.
Grande blocco di “scogliera” inglobato
nella Formazione di S.Cassiano del
Passo Sella
All’inizio del Carnico (227 milioni di anni fa) le successive fasi di stabilità documentate in questo
periodo consentono il ristabilirsi di condizioni ambientali atte all’insediamento di nuovi organismi
costruttori.
La quasi totale assenza di fenomeni di subsidenza consente l’accrescersi di imponenti scogliere, che
si possono espandere lateralmente anche al di sopra dei sedimenti terrigeni.
In seguito si verifica un brusco abbassamento del livello del mare che determina l’emersione delle
scogliere, di banchi carbonatici e degli edifici vulcanici.
Le nuove condizioni subaeree portano alla fine del delicato ecosistema “di scogliera” e i vari edifici
vulcanici vengono spianati dall’erosione e i detriti finiscono di riempire i bacini.
In zone più lontane dai vulcani, comunque, persistono ampie aree bacinali.
Adesso sono fenomeni tettonici a sconvolgere la regione: si formano faglie che portano alla
deformazione, al piegamento e all’accavallamento delle rocce precedentemente deposte.
Una volta terminata questa turbolenta fase, la zona dolomitica torna ad essere un tranquillo mare
tropicale, nel quale prosperano coralli, alghe e spugne.
Il risultato è che inizia a formarsi una nuova generazione di scogliere e piattaforme carbonatiche, la
così detta Dolomia Cassiana, molto meno sviluppata in altezza e più in larghezza (in fondo, infatti,
è più regolare e c’è meno subsidenza).
Sullo Sciliar sono ancora preservati i depositi del
Ladinico e del Carnico: le lave (V), le Dolomie
stratificate carniche (DC) e in cima i rossi
sedimenti della Formazione di Raibl
Formazione di Raibl
Rocce sedimentarie marine depositatesi tra 220 e
150 milioni di anni fa
Nei bacini adiacenti, invece, si vanno accumulando i fini prodotti delle
erosioni delle rocce vulcaniche mescolati a particelle calcaree di varia
natura: è questa la Formazione di San Cassiano, nota per la
straordinaria quantità di fossili in essa contenuti.
Alla fine del Carnico (224 milioni di anni fa), un nuovo forte
abbassamento del mare determina la fine dello sviluppo delle scogliere
e un ulteriore riempimento dei bacini: la regione torna ad essere
un’area piatta, in parte marina, in parte costiera. Su questa superficie si
deposita la Formazione di Raibl, di spessore modesto e dal colore
rosso-verde. E’ costituita di questi sedimenti la cengia che taglia tutto
il Sella a metà altezza, come pure la base della Tofana di Rozes e delle
Cinque Torri.
Con il Norico (223 milioni di anni fa), in un mare sottile e caldo, in
continua subsidenza, si deposita metro dopo metro una
potente successione di dolomie stratificate, la Dolomia
Principale (il suo spessore è di ben 1000 metri) che oggi
costituisce alcune delle cime più famose delle Dolomiti
cadorine e bellunesi: le Tre Cime di Lavaredo, il Cristallo, la
Civetta, la Croda da Lago e molte altre ancora.
Alla fine del Trias e all’inizio del Giurassico (210 milioni di
anni fa), tutta l’Italia è coperta dal mare ed il clima diviene
Dal basso: Dolomia Cassiana, Formazione di
umido e di tipo marino. Non ci sono più dolomie o depositi
Raibl e Dolomia Principale
salini, ma calcari grigi, ben stratificati.
Tra 170 e 135 milioni di anni fa, la regione sprofonda ulteriormente e si hanno i depositi di
Ammonitico Rosso (un calcare caratterizzato dalla presenza delle ammoniti), mentre con il
Cretaceo, l’ultimo periodo dell’era Mesozoica, si depositano le rocce più giovani della nostra
regione (le Marne del Puez, materiali teneri e di colore grigio-verde).
Successione di rocce stratificate nel Passo Rolle
accumulatasi nel Trias inferiore
Formazione di Calcari grigi e parete di
ammonitici rossi
Sezione semplificate della Regione Dolomitica: B - basamento e porfidi; P – terreni permiani; W – Formazione di
Werfen; Li – Formazione di Contrin e successioni bacinali ladino-carniche; v – rocce vulcaniche; DS – piattaforme
carbonatiche ladiniche e carniche; R – Formazione di Raibl; DP – Dolomia Principale
La successione stratigrafica che compare nelle
varie zone della Regione Dolomitica
Processo orogenetico
All’inizio del Cretaceo (120-130 milioni di anni fa) tutta la pila di rocce descritta precedentemente
si trovava sepolta in fondo al mare Tetide.
Verso la fine del Cretaceo (70-80 milioni di anni fa), il continente africano comincia ad avvicinarsi
a quello europeo, determinando uno schiacciamento dei materiali interposti e il loro conseguente
innalzamento (orogenesi = nascita di una catena montuosa).
Le Dolomiti iniziano ad essere interessate da queste dinamiche circa 40 milioni di anni fa, ma è
soprattutto negli ultimi 25 che si hanno gli effetti più forti, con un sollevamento tale da far emergere
il tutto dal mare.
Il maggiore definitivo sollevamento si è ha negli ultimi 4-5 milioni di anni. I corsi d’acqua scavano
ed incidono sempre più, finchè compaiono i terreni triassici e permiani: le dure e resistenti Dolomie
rimangono sempre più isolate, mentre le tenere rocce vulcaniche, con i loro derivati sedimentari,
vengono spianate con facilità, dando luogo a valli, passi, altopiani.
Circa 2 molini di anni fa, infine, le Dolomiti vengono ricoperte dai
ghiacci, i quali danno il loro fondamentale contributo alla
geomorfologia della zona. Infatti, assieme ai processi gravitativi, alle
acque correnti, al disgelo, provocano processi di frane, per crollo dalle
pareti dolomitiche oppure per scivolamento o colata sui pendii
terrigeni.
Nelle aree poste alle quote più elevate, oltre i 2200 metri, si possono
osservare una serie di forme, la cui genesi è legata alla presenza della
Modellamento dei
neve e agli effetti ciclici del gelo e disgelo. Tra i più frequenti si
fianchi della valle da
possono ricordare le nivomorene (cordoni dalla forma allungata o a
parte di un ghiacciaio
festone), prevalentemente paralleli al versante, legati allo scivolamento
vallivo
di materiale detritico su superfici nevose o i grandi accumuli di detriti
che si rinvengono alla base delle ripide pareti verticali dolomiche e che conferiscono al paesaggio
un aspetto lunare.
Rocce erose che per la loro
particolare forma sono
denominate “i frati”
Tipica valle glaciale delle
Dolomiti: la Vallunga
Approfondimento: Dolomia, una roccia particolare
E’ a un’intuizione di Dèodat Tancrède Gratet de Dolomieu (1750-1801) un francese di nobile
famiglia, membro dell’Institut de France e studioso di mineralogia, che risale la scoperta di quella
particolare composizione chimica (doppio carbonato di calcio e magnesio) che rende così diverse le
rocce dolomitiche.
Nel 1789 Dolomieu inviò al geologo Nicholas de Saussure dei campioni di alcune “strane” rocce,
da lui stesso raccolte durante un viaggio in Sud Tirolo.
Era incuriosito dalla loro anomala reazione all’acido cloridrico: al confronto delle altre formazioni
calcaree, sviluppavano una ridotta effervescenza.
L’intuizione che si trattasse di un minerale sconosciuto fu confermata e, nonostante Dolomieu
avesse proposto il nome di “Saussurite”, il nuovo minerale fu catalogato, in onore del suo
scopritore, con il nome di “Dolomite”, mentre fu chiamata “Dolomia” la roccia che lo conteneva.
Successivamente, nel 1864, anche all’intera zona montuosa in cui prevaleva questa roccia fu dato il
nome, appunto, di Dolomiti.
… OSSERVANDO LA BIODIVERSITA’
I fossili sono stati fondamentali per la comprensione dell’esistenza dell’evoluzione biologica: le
specie non sono immutabili ma cambiano nel tempo con ritmi diversi a seconda delle condizioni
ambientali e della pressione selettiva. Oggi è possibile “misurare” il passare del tempo anche
studiando gli organismi viventi attualmente e fra loro contemporanei grazie alle tecniche di biologia
molecolare: il confronto tra proteine comuni a più specie e la comparazione della sequenza di geni
presenti negli organismi sono diventati gli strumenti per ricostruire gli alberi genealogici e i rapporti
filogenetici tra gli organismi. I risultati sono sempre più precisi e si riescono a dare interpretazioni
temporali non solo qualitative ma anche quantitative e in accordo con i dati ottenuti da altre
discipline quali la paleontologia e la geologia.
LA NATURA NEL TEMPO: L’EVOLUZIONE BIOLOGICA
L’evoluzione biologica rappresenta i cambiamenti del patrimonio genetico dei membri di una
popolazione.
Più in particolare, i cambiamenti relativi a un numero limitato di generazioni vengono indicati
complessivamente come microevoluzione, mentre quelli che richiedono secoli, millenni o
addirittura tempi più lunghi per verificarsi sono definiti cambiamenti macroevolutivi o
macroevoluzione.
I cambiamenti a breve termine che avvengono nelle popolazioni , cioè i cambiamenti che
richiedono periodi di tempo di anni o decenni, appartengono complessivamente a cambiamenti
microevolutivi. Studi sulla microevoluzione rappresentano un ramo importante della biologia
evolutiva, perché i cambiamenti a breve termine possono essere osservati direttamente e manipolati
sperimentalmente. Essi da soli tuttavia non possono fornire una spiegazione completa dei processi
macroevolutivi. Attraverso una serie di studi, ad esempio, siamo in grado di misurare le varie forme
delle zampe dei cavalli e correlare tali forme alla loro velocità di corsa e alla capacità di sfuggire ai
predatori (microevoluzione). Studi di questo tipo non rivelano però per quale motivo
Hyracotherium, piccolo progenitore a quattro dita del cavallo, vissuto nei boschi dell’Eocene, dette
origine a discendenti di elevate dimensioni che pascolano nelle pianure e che sono caratterizzati da
un singolo dito (macroevoluzione).
I quadri dei cambiamenti macroevolutivi possono essere fortemente influenzati da eventi che
accadono molto raramente (impatti di meteoriti, ad esempio) o con tale lentezza (cambiamenti
climatici sul lungo periodo, movimenti delle masse continentali…) da non poter essere osservati nel
corso degli studi sulla microevoluzione. Prove di altro tipo, soprattutto derivanti dallo studio dei
fossili e delle rocce, devono essere raccolte per poter comprendere il corso dell’evoluzione
avvenuta in un arco di tempo di miliardi di anni.
I METODI DI DATAZIONE DEGLI EVENTI SULLA TERRA
I geologi dividono la storia della Terra in quattro eoni: Adeano, Archeano, Proterozoico e
Fanerozoico. Quest’ultimo viene a sua volta diviso in ere, ulteriormente suddivise in periodi. Il
passaggio da una divisione temporale all’altra si basa sullo studio delle fondamentali differenze del
materiale fossile rinvenuto in strati rocciosi successivi. Sono quindi gli organismi fossili, e non le
rocce stesse, a fornire ai geologi le informazioni utilizzate per elaborare una scala temporale degli
eventi, dato che la vita in evoluzione lascia tracce che possono essere ordinate cronologicamente.
Non è sempre così invece per le rocce, in quanto una data roccia può formarsi in un periodo
qualunque, se sottoposta alle medesime condizioni ambientali. Esiste tuttavia un metodo “assoluto”
che consente di datare anche rocce prive di resti fossili, ed è il metodo della radiodatazione, che si
basa sul fatto che per i materiali radioattivi in uguali intervalli di tempo decade la medesima
frazione di materiale radioattivo.
Non tutte le rocce contengono però materiali radioattivi in quantità misurabili; per questo è spesso
più facile per stabilire l’età di un campione fare riferimento ai fossili che contiene.
I FOSSILI
Un fossile è quanto rimane di un organismo animale o vegetale vissuto nei tempi passati e
conservato nei resti rocciosi. I fossili sono le uniche testimonianze rimaste degli organismi che
popolarono la Terra nelle ere trascorse; permettono non solo di conoscere le caratteristiche
morfologiche di questi organismi, ma forniscono dati essenziali per la ricostruzione dei processi
evolutivi che hanno portato agli organismi attuali, delle condizioni ambientali del passato e delle
variazioni di queste nelle ere geologiche. La fossilizzazione, il processo fisico-chimico che permette
ad un organismo di conservarsi nel tempo è un processo lungo e piuttosto raro: essenziale è che
l’organismo venga a trovarsi, dopo la morte, in ambiente privo di ossigeno. Infatti, quando non c’è
contatto con l’aria le sostanze organiche di cui è composto il corpo dell’animale o del vegetale
vengono lentamente sostituite da sostanze minerali (carbonati, silice…). Solo le parti molli si
deteriorano, ma spesso il loro posto viene preso da sedimenti minerali, cosa che permette la
conservazione dell’impronta (stampo) nello strato in cui giace il resto.
Fino ad oggi sono state descritte circa 300 000 specie di organismi fossili, e il loro numero è in
continuo aumento. Tuttavia, le specie fossili finora descritte non rappresentano che una piccola
frazione delle specie realmente esistite. Tanto per fare un confronto, nel complesso dei biota attuali,
vale a dire tra i componenti di tutti i regni (batteri, archea, protisti, piante, funghi e animali) sono
state descritte 1,5 milioni di specie. In realtà il numero di specie viventi ammonta probabilmente ad
almeno 10 milioni (non sono state ancora descritte la maggior parte delle specie di insetti).Di
conseguenza, il numero delle specie fossili note costituisce meno del 2% del probabile numero delle
specie viventi.
Tra tutti questi organismi, particolare interesse destano i cosiddetti “fossili guida”, i più utili per
l’indagine biostratigrafica, quella cioè che, basandosi sull’ovvio principio che i fossili rinvenuti in
strati più bassi sono più antichi di quelli soprastanti e valutando i rapporti di posizione dei fossili nei
singoli strati rocciosi, riesce a stabilire i tempi relativi di comparsa, di vita e di scomparsa delle
singole specie, dei generi e delle categorie sistematiche di ordine superiore. I fossili guida sono resti
di specie a rapida evoluzione e quindi di breve durata nel tempo, che presentano una estesa
diffusione geografica e sono poco soggetti a fattori ambientali. Essi permettono di datare i
sedimenti che li contengono e di stabilire la loro posizione nella scala cronologica. Permettono
anche il confronto cronologico tra strati di località diverse, anche molto distanti, ma che contengono
la stessa specie di “fossili guida”. Vengono quindi usati per la datazione dei diversi periodi della
storia della Terra. Esempio classico di “fossili guida” sono le trilobiti, per il periodo del Cambriano
(500-400 milioni di anni fa), o le ammoniti del Mesozoico (200-65 milioni di anni fa).
I fossili sono la testimonianza più evidente dell’evoluzione biologica delle specie nel tempo.
Nonostante l’incompletezza, rivelano chiaramente che passando, nella scala temporale geologica,
da periodi storici remoti a quelli più recenti, i fossili somigliano sempre di più alle specie attuali.
L’EVOLUZIONE MOLECOLARE
Un altro fenomeno che ci permette di valutare gli effetti dello scorrere del tempo sugli organismi
viventi è l’evoluzione molecolare.
Esiste la possibilità di estrarre il DNA da alcuni fossili, più o meno recenti (è stato estratto DNA da
campioni racchiusi in ambra di 135 milioni di anni). Tuttavia, anche nel caso in cui non sia
possibile studiare direttamente le molecole presenti in organismi estinti, possiamo dedurre i modelli
evolutivi confrontando la struttura delle molecole presenti negli organismi attualmente viventi. Un
valido esempio dell’uso dell’approccio comparato per determinare i modelli di evoluzione
molecolare è fornito dagli studi sulla proteina citocromo c. Il citocromo c è uno dei costituenti della
catena respiratoria mitocondriale presente nelle cellule di tutti gli eucarioti. Oggi è nota la sequenza
aminoacidica del citocromo c in almeno 100 specie di organismi, dai lieviti all’uomo. Esaminando
tali sequenze aminoacidiche si può notare che esistono regioni che accumulano sostituzioni
abbastanza rapidamente; per esempio le posizioni 44, 89 e 100 contengono residui diversi in molti
degli organismi presi in esame. Al contrario, esistono anche delle posizioni invarianti, per esempio
le posizioni 14, 17, 18 e 80. E’ noto che questi invarianti interagiscono con il gruppo eme,
contenente ferro e essenziale per il funzionamento della proteina. Si pensa quindi che, avendo effetti
negativi sul funzionamento della proteina, qualunque cambiamento di aminoacidi in tali zone sia
stato eliminato per selezione naturale ogni volta che è comparso in un organismo. Al contrario le
regioni che ammettono un ampio numero di sostituzioni sono probabilmente meno significative dal
punto di vista funzionale; di conseguenza le sostituzioni aminoacidiche in tali regioni sono
funzionalmente neutre e non risentono della selezione naturale. Una volta stimato il tasso di
sostituzione aminoacidica, che per queste sequenze sarà simile al tasso di mutazione (per esempio
100 sostituzioni ogni 500 milioni di anni), è facile capire che due specie che differiscono per 10
aminoacidi sono imparentate tra loro in maniera più stretta di due che differiscono per 20
aminoacidi. Quanto maggiore è il numero delle differenze nella sequenza aminoacidica tra due
molecole di citocromo c di due organismi differenti, tanto più lontano nel tempo può essere datato
l’antenato comune. Ecco quindi che se la struttura di una molecola cambia con velocità costante,
possiamo utilizzare la molecola stessa come un orologio molecolare per determinare le date a cui si
sono verificati eventi evolutivi. E’ bene precisare che questo metodo non sostituisce la datazione
per mezzo dei fossili, ma gli si affianca e può essere di aiuto nel caso esistano pochi reperti fossili di
specie attualmente viventi.
SULL’OROLOGIO ELETTRICO DELL’ABATE ZAMBONI:
- Paolo Francesco Forlati: Segnatempo veronensis, Verona, Grafiche Fiorini, 1987
- G. Zamboni, Descrizione ed uso dell' elettromotore perpetuo, Verona, Tipografia
Mainardi, 1814
- G. Zamboni, Sull'elettromotore perpetuo. Istruzione teorico-pratica, Verona, Tipografia di
Giuseppe Antonelli, 1843
- sito internet: http://www.galileonet.it/Dossier/doss26/dossier26_4.html articolo di M.
Tinazzi dal titolo: Il padre dell'elettromotore Perpetuo
SULLE MERIDIANE
-Cintio Alberto Le meridiane delle Marche, A. Livi Editore – Fermo, 1999
-Gian Carlo Rigassio Le ore e le ombre, Ed. Mursia, 1988
-Giuliano Romano et all. Il sole e il tempo, Ed. Sit, Treviso, 1990
-Gabriele Vanin Le meridiane bellunesi, Ed. Libreria Pilotto – Feltre BL, 1991
-D’Agnolo Mauro et all. Conto solo ore serene, pubblicato dalla Comunità Montana delle
Prealpi Trevigiane ( una raccolta fotografica delle meridiane della Pedemontana, arricchita
da commenti tecnici dello gnomonista Giovanni Flora e introdotta da piacevoli riflessioni
del poeta A. Zanzotto e di altri personaggi di cultura e di scienza astronomica del territorio
veneto, tra cui l’astronomo prof. G. Romano.
-Sito internet: www.gnomonica.it
SULLA DILATAZIONE RELATIVISTICA DEL TEMPO
-E.F. Taylor e J.A. Wheeler Fisica dello spazio-tempo, Ed. Zanichelli
SULL’ OROLOGIO FLOREALE
-Sito internet: www.gnomonica.it
SULLE MIGRAZIONI DEGLI UCCELLI
-P. Berthold La migrazione degli uccelli, Bollati Boringhieri, 2003
-Sito internet: www.nemesi.net di Marcello Guidotti, 2002
SULLE ROCCE DOLOMITICHE
- Alfonso Borsellini La storia geologica delle Dolomiti, Edizioni Dolomitiche, 1989
SULL’EVOLUZIONE
-W. Purves, G. Orians, D. Sadava, H. Heller I processi evolutivi, Ed. Zanichelli, 2001