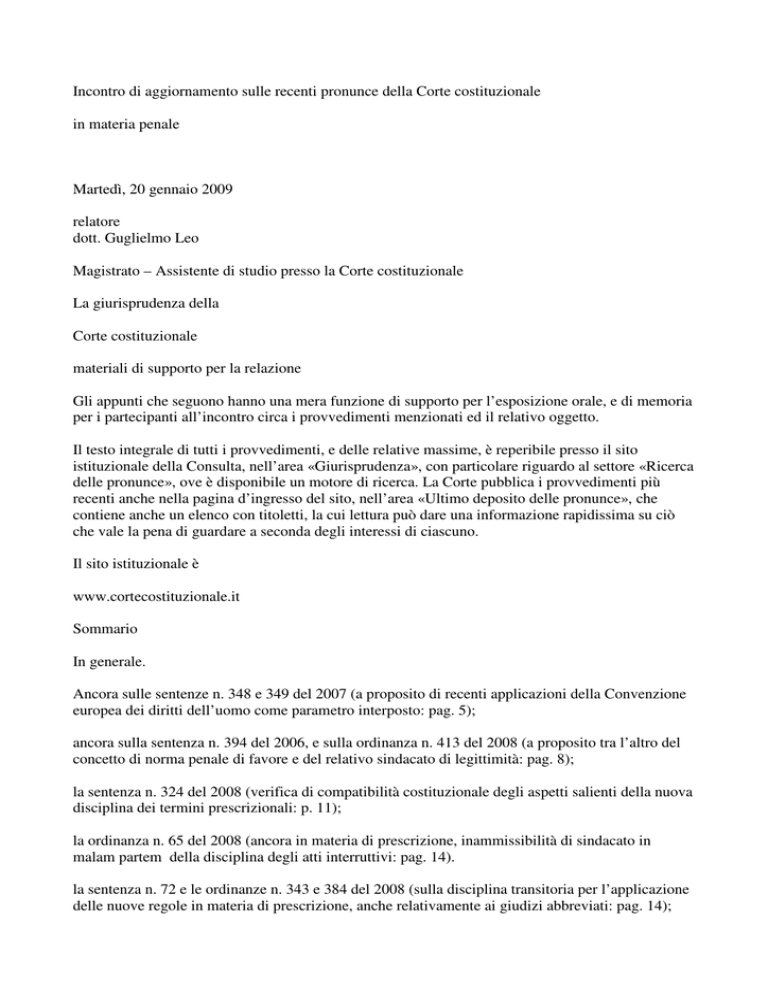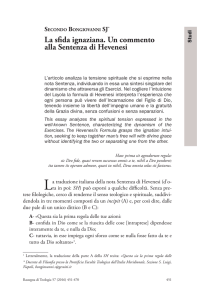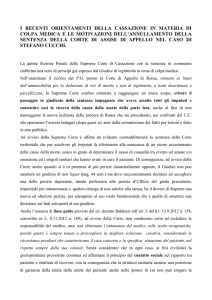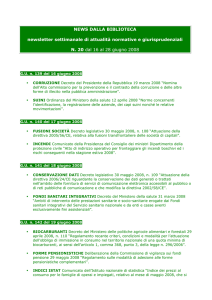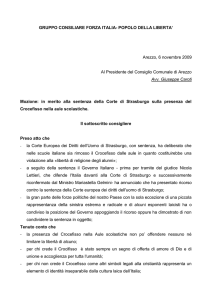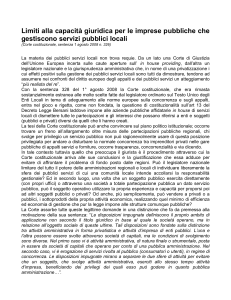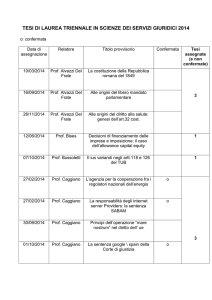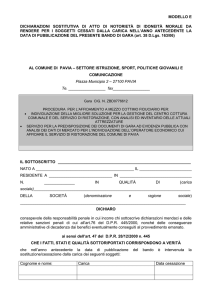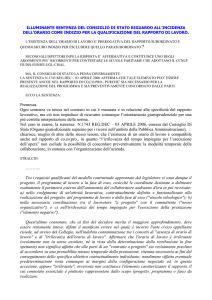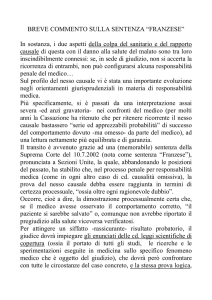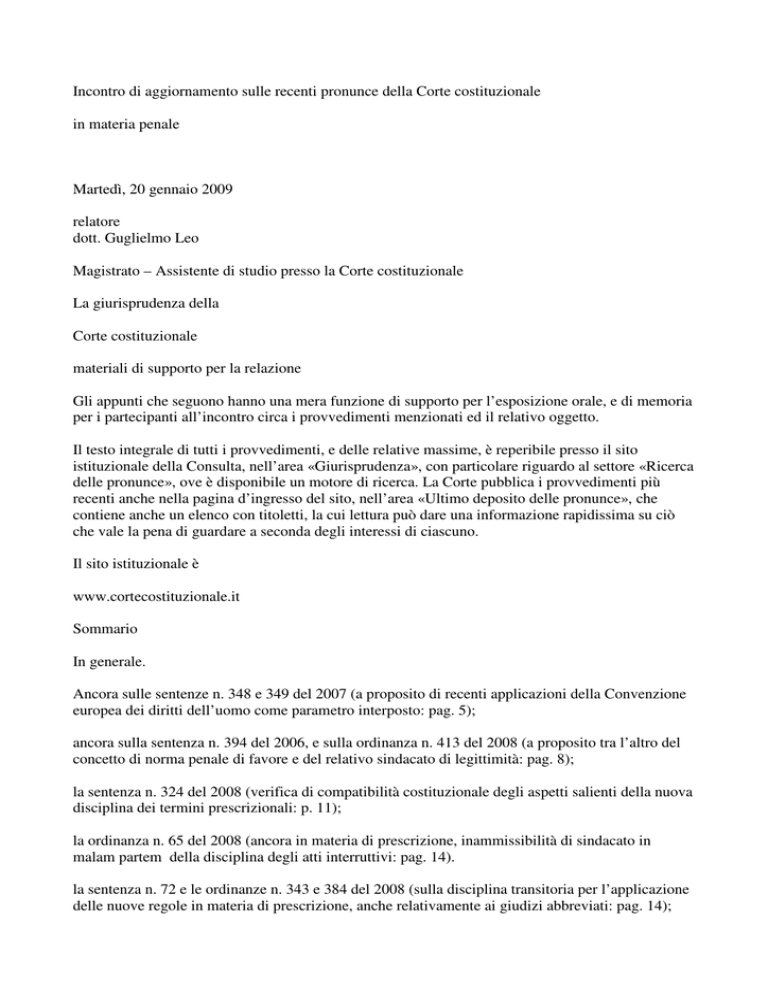
Incontro di aggiornamento sulle recenti pronunce della Corte costituzionale
in materia penale
Martedì, 20 gennaio 2009
relatore
dott. Guglielmo Leo
Magistrato – Assistente di studio presso la Corte costituzionale
La giurisprudenza della
Corte costituzionale
materiali di supporto per la relazione
Gli appunti che seguono hanno una mera funzione di supporto per l’esposizione orale, e di memoria
per i partecipanti all’incontro circa i provvedimenti menzionati ed il relativo oggetto.
Il testo integrale di tutti i provvedimenti, e delle relative massime, è reperibile presso il sito
istituzionale della Consulta, nell’area «Giurisprudenza», con particolare riguardo al settore «Ricerca
delle pronunce», ove è disponibile un motore di ricerca. La Corte pubblica i provvedimenti più
recenti anche nella pagina d’ingresso del sito, nell’area «Ultimo deposito delle pronunce», che
contiene anche un elenco con titoletti, la cui lettura può dare una informazione rapidissima su ciò
che vale la pena di guardare a seconda degli interessi di ciascuno.
Il sito istituzionale è
www.cortecostituzionale.it
Sommario
In generale.
Ancora sulle sentenze n. 348 e 349 del 2007 (a proposito di recenti applicazioni della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo come parametro interposto: pag. 5);
ancora sulla sentenza n. 394 del 2006, e sulla ordinanza n. 413 del 2008 (a proposito tra l’altro del
concetto di norma penale di favore e del relativo sindacato di legittimità: pag. 8);
la sentenza n. 324 del 2008 (verifica di compatibilità costituzionale degli aspetti salienti della nuova
disciplina dei termini prescrizionali: p. 11);
la ordinanza n. 65 del 2008 (ancora in materia di prescrizione, inammissibilità di sindacato in
malam partem della disciplina degli atti interruttivi: pag. 14).
la sentenza n. 72 e le ordinanze n. 343 e 384 del 2008 (sulla disciplina transitoria per l’applicazione
delle nuove regole in materia di prescrizione, anche relativamente ai giudizi abbreviati: pag. 14);
la sentenza n. 215 del 2008, e le ordinanze n. 414 e 415 del 2008 (a proposito d’un caso di
irretroattività della legge di depenalizzazione giudicato illegittimo dalla Corte: pag. 17);
Diritto sostanziale.
La sentenza n. 2 del 2008 e le ordinanze n. 223 e n. 381 (ancora sulla prescrizione, relativamente ai
reati di competenza del giudice di pace: i termini si calcolano, per tutti tali reati, a norma dell’art.
157, comma 1, cod. pen: pag. 18);
le ordinanze n. 33, 91 e 257 del 2008 (ancora sulla nuova disciplina della recidiva, anche riguardo al
bilanciamento con altre circostanze: pag. 19);
la sentenza n. 327 del 2008 (la figura del disastro innominato ed il punto sull’attuale giurisprudenza
circa il principio di tassatività: pag. 23);
la sentenza n. 225 del 2008 (ancora in punto di tassatività e di necessaria offensività delle condotte
penalmente sanzionate: pag. 24);
le sentenze nn. 97, 134, 135, 279 e 330 del 2008 (tutte a proposito della immunità di parlamentari
e consiglieri regionali per le opinioni espresse e per i voti dati: pag. 25);
la sentenza n. 70 del 2008 (a proposito dell’ultimo condono edilizio e delle condizioni per
l’estinzione del reato: pag. 27).
la sentenza n. 286 del 2008 (dichiarativa della illegittimità costituzionale parziale delle norme in
materia di peculato militare: pag. 28).
Diritto processuale.
Le sentenze nn. 26 e 320 del 2007 (a proposito, rispettivamente, della illegittimità costituzionale
della preclusione dell’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento di rito
ordinario ed abbreviato: pag. 29);
la sentenza n. 298 del 2008 (a proposito della preclusione dell’appello del pubblico ministero
avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace: pag. 32);
le ordinanze nn. 4, 156 e 403 del 2008 (a proposito dell’appellabilità della sentenza di non luogo a
procedere: pag. 33);
le ordinanze nn. 3, 85, 155, 226 e 302 del 2008 (a proposito della facoltà di appello della parte
civile avverso le sentenze del giudice ordinario e del giudice di pace: pag. 34);
la sentenza n. 85 del 2008 (a proposito dell’appello dell’imputato avverso le sentenze di
proscioglimento: pag. 37);
la sentenza n. 426 del 2008 (a proposito dell’appello dell’imputato avverso le sentenze di condanna
del giudice di pace: pag.39);
la sentenza n. 401 del 2008 (a proposito di un nuovo ed ennesimo intervento additivo sull’art. 34
c.p.p. in materia di incompatibilità del giudice: pag. 40);
la sentenza n. 432 del 2008 (a proposito della competenza territoriale per procedimenti concernenti i
prossimi congiunti di magistrati: pag. 40);
la sentenza n. 136 del 2008 (a proposito dell’art. 157, comma 8-bis, c.p.p. e della effettuazione
presso il difensore delle notifiche per l’imputato successive alla prima: pag. 41);
la ordinanza n. 89 del 2008 (a proposito della compatibilità costituzionale del processo
contumaciale: pag. 41):
la sentenza n. 129 del 2008 (a proposito degli effetti nell’ordinamento nazionale dell’accertata “non
equità” – ad opera della Corte europea dei diritti dell’uomo – del processo culminato con la
sentenza di condanna, e dell’irrilevanza in proposito dell’attuale disciplina in materia di revisione
del processo: pag. 43);
l’ordinanza n. 339 del 2008 (a proposito dell’avviso per la persona offesa nel procedimento di
riesame del sequestro cd. probatorio, e, in generale, della posizione della vittima nel procedimento
penale: pag. 49);
le ordinanze n. 101 e 444 del 2008 (sul diritto alla controprova della parte civile nel giudizio
abbreviato condizionato: pag. 50);
l’ordinanza 67 del 2008 (relativamente ai rapporti tra contestazioni suppletive e diritto di accesso al
rito abbreviato: pag. 52);
la sentenza n. 305 del 2008 (a proposito della illegittimità parziale dell’art. 195 c.p.p., riguardo alla
testimonianza de relato degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria: pag. 55);
le ordinanze nn. 67 del 2007 e 318 del 2008 (mutamento della persona fisica del giudice e
utilizzazione della prova dichiarativa: pag. 57);
la questione concernente il nuovo testo dell’art. 240 c.p.p. (ed in particolare la distruzione
immediata delle cd. intercettazioni illegali: pag. 59);
la sentenza n. 149 del 2008 (ancora a proposito delle riprese audiovisive in luoghi di privata dimora:
pag. 60);
la sentenza n. 336 del 2008 (dichiarativa della illegittimità costituzionale parziale dell’art. 268 c.p.p.
nella parte in cui non prevede a favore del difensore il diritto alla copia della traccia fonica di
conversazioni intercettate, e contestate in ambito cautelare, a prescindere dall’intervenuto deposito:
pag. 61);
la questione concernente la legittimità costituzionale dell’art. 238-bis c.p.p. (acquisizione a fini di
prova di sentenze irrevocabili: pag. 63)
le ordinanze n. 267 e n. 359 del 2008 (relativamente all’interrogatorio di garanzia in caso di
aggravamento di misura già applicata ed in fase successiva all’apertura del dibattimento di primo
grado: pag. 63);
l’ordinanza n. 236 del 2008 (a proposito della obbligatorietà dell’arresto per il reato di indebito
trattenimento dello straniero che abbia ricevuto l’ordine di lasciare il territorio nazionale: pag. 64);
un nuovo provvedimento, l’ordinanza n. 417 del 2008, a proposito del rilascio «obbligatorio» del
nulla osta all’espulsione da parte del giudice penale: pag. 65);
la sentenza n. 143 del 2008 (a proposito delle modalità di computo della durata massima della
custodia cautelare in caso di soggetto arrestato all’estero in esecuzione della normativa sul mandato
di arresto europeo: pag. 67);
la sentenza n. 219 del 2008 (dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 314 c.p.p.,
in materia di riparazione per ingiusta detenzione: pag. 69);
la sentenza n. 310 del 2008 (sulla competenza a provvedere circa la richiesta di estradizione passiva
nel caso di soggetti minorenni: pag.71);
le ordinanze nn. 114 e 321 del 2008 (sul procedimento di ricorso immediato della persona offesa nel
giudizio relativo ai reati di competenza del giudice di pace: pag. 72);
l’ordinanza n. 397 del 2008 (sui presupposti per la conversione della libertà controllata in pena
detentiva: pag. 73);
l’ordinanza n. 446 del 2008 (sulla mancata previsione della possibilità che il magistrato di
sorveglianza applichi provvisoriamente la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale: pag.
73).
In generale
Nel corso di precedenti incontri di aggiornamento abbiamo ampiamente commentato le
fondamentali sentenze 348 e 349 del 2007 (estensori, rispettivamente, Silvestri e Tesauro).
Come tutti sanno, la Corte ha chiarito che le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
non sono «autoapplicative» perché non sono norme comunitarie, né sono riferibili all’art. 11 della
Costituzione, dato che non introducono alcuna limitazione di sovranità.
Sono norme internazionali pattizie (dunque non consuetudinarie, con conseguente inapplicabilità
del primo comma dell’art. 10 Cost.), che vincolano lo Stato, ma non producono effetti diretti
nell'ordinamento interno, tali da affermare la competenza dei giudici nazionali a darvi applicazione
nelle controversie ad essi sottoposte, non applicando nello stesso tempo le norme interne in
eventuale contrasto.
Per altro, il testo riformato dell’art. 117, primo comma, Cost. condiziona l'esercizio della potestà
legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali
indubbiamente rientrano quelli derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo. Va
respinta – secondo la Corte – la tesi che la norma sia da considerarsi operante soltanto nell'ambito
dei rapporti tra lo Stato e le Regioni. Allo stesso tempo, non può ritenersi che ogni norma contenuta
in un trattato internazionale assuma, per il tramite dell’art. 117 comma 1, il rango di norma
costituzionale.
In realtà la disposizione presenta struttura simile a quella di altre norme costituzionali, che
sviluppano la loro concreta operatività solo se poste in stretto collegamento con altre norme, di
rango sub-costituzionale, destinate a dare contenuti ad un parametro che si limita ad enunciare in
via generale una qualità che le leggi in esso richiamate devono possedere. Le norme necessarie a
tale scopo sono di rango subordinato alla Costituzione, ma intermedio tra questa e la legge
ordinaria. Nel linguaggio corrente si tratta di “fonti interposte".
Quindi le norme della Convenzione, quali interpretate dalla Corte di Strasburgo, non acquistano la
forza delle norme costituzionali e sono perciò non immuni dal controllo di legittimità della Corte
costituzionale italiana. Proprio perché si tratta di norme che integrano il parametro costituzionale,
ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, è necessario che esse siano conformi a
Costituzione.
L'esigenza che le norme che integrano il parametro di costituzionalità siano esse stesse conformi
alla Costituzione è assoluta e inderogabile, per evitare il paradosso che una norma legislativa venga
dichiarata incostituzionale in base ad un'altra norma sub-costituzionale, a sua volta in contrasto con
la Costituzione. E’ illegittima solo una norma che contrasti con un parametro interposto del quale
sia positivamente scrutinata la conformità alla Costituzione.
Insomma, quando sorga il dubbio di un contrasto tra una norma nazionale ed una della
Convenzione, occorre verificare: a) se effettivamente vi sia contrasto, non risolvibile in via
interpretativa, tra la norma interna e le norme della CEDU, come interpretate dalla Corte europea ed
assunte come fonti integratrici del parametro di costituzionalità di cui all'art. 117, primo comma,
Cost.; b) se le norme della CEDU invocate come integrazione del parametro, nell'interpretazione ad
esse data dalla medesima Corte, siano compatibili con l'ordinamento costituzionale italiano.
I riflessi delle decisioni citate fin qui erano prevedibili e si stanno manifestando in tutta la loro
importanza. Farò solo due esempi di stretta attualità, uno nel settore del diritto civile, l’altro in
quello della procedura penale, per evidenziare la vera e propria dimensione sovranazionale assunta
dal complesso delle norme e dei parametri che vincolano la discrezionalità del nostro legislatore sul
piano della legittimità costituzionale.
In campo civile, è stata posta recentemente la questione della possibilità di conferire al neonato il
cognome materno, nel procedimento instaurato da una coppia di coniugi che si vede rifiutare
dall’autorità di stato civile la richiesta concorde di assegnare ai figli, appunto, il cognome della
madre (Cass., 1^ sez. civ., ordinanza n. 23934 del 2008).
Occorre sapere che non esiste una norma specifica che riservi ai figli, esclusivamente, il cognome
del padre, e tuttavia questa norma viene desunta da un complesso di disposizioni concernenti lo
stato civile.
La Corte costituzionale, ancora con la sentenza 61 del 2006, aveva definito la trasmissione ai figli
del solo cognome paterno quale «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia (…) non più
coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’eguaglianza tra uomo e
donna». Tuttavia era stata rimarcata la necessità di scelte tecniche riservate alla discrezionalità del
legislatore, che dal canto proprio studia disegni di riforma da oltre trenta anni, senza pervenire ad un
adeguamento del sistema.
In realtà l’attuale legislazione italiana sembra contrastare con numerose norme internazionali. Tra le
altre, la Convenzione di New York del 18 dicembre 1979 contro le discriminazioni in danno delle
donne, anche con specifico riguardo alla trasmissione del cognome ai figli. Inoltre l’art. 5 del
settimo Protocollo addizionale della C.E.D.U. stabilisce che i coniugi debbano avere identica
posizione nelle relazioni giuridiche con i figli. La Corte europea ha ripetutamente identificato
violazioni della Carta in relazione a legislazioni nazionali che, sotto singoli aspetti, attribuivano
maggior rilevanza al cognome del marito-padre.
Tutto ciò premesso, e per quanto ci interessa in questa sede, la 1^ sezione civile della Cassazione ha
ritenuto che, nel senso in cui è attualmente ricostruita, la normativa italiana sia illegittima, per il
contrasto con il primo comma dell’art. 117 Cost.. È interessante notare che, sviluppando un
concetto che la Consulta aveva riferito espressamente alla CEDU, la Cassazione alluda anche alla
sopra citata convenzione di New York quale parametro interposto. Ciò premesso, la causa è stata
rimessa alle sezioni unite, perché sciolgano la seguente alternativa: individuare lo spiraglio per una
interpretazione costituzionalmente orientata che ravvisi già nell’attuale ordinamento una disciplina
di apertura al cognome materno (così come hanno fatto alcuni giudici di merito e, per certi versi, il
Consiglio di Stato), o, in alternativa, sollevare questione di legittimità costituzionale nei termini
che, ormai, dovrebbero essere chiari.
In campo penale si può segnalare una recente ordinanza della 1^ sezione penale della Cassazione
(35555 del 2 luglio 2008 - depositata il 17 settembre 2008).
Va fatta una breve premessa, anche per evidenziare le differenti sensibilità evidentemente sottese a
questi temi. Si poneva da tempo la questione, relativa all’art. 175, comma 2 c.p.p., se il meccanismo
della rimessione in termini per l’impugnazione dell’imputato processato in contumacia possa essere
azionato quando il gravame sia già stato interposto dal difensore dell’imputato (il quale, dopo la
relativa modifica normativa, può appunto impugnare la sentenza anche senza specifico mandato), ed
in particolare dal difensore di ufficio.
I problemi sul tappeto sono chiari: il difensore può sentire l’obbligo deontologico di impedire il
passaggio in giudicato d’una sentenza di condanna, ma la celebrazione del gravame nell’assenza e
nella inconsapevolezza dell’imputato può implicare che questi si ritrovi condannato in via definitiva
senza neppure disporre del rimedio introdotto con la modifica dell’art. 175 c.p.p. Per questa ragione
taluni hanno sostenuto che l’impugnazione tardiva sarebbe comunque ammissibile, il che, per altro,
pone il problema della duplicazione dei giudizi e dell’eventuale contrasto tra giudicati.
Come si ricorderà, le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza Huzuneanu (n. 6026 del 2008),
avevano stabilito che l’imputato contumace non ha diritto alla restituzione in termini per
l’impugnazione quando il gravame sia già stato proposto dal difensore (anche d’ufficio) e già
definito. La soluzione, in problematico rapporto con la giurisprudenza CEDU sul diritto di
personale partecipazione al processo, è stata giudicata costituzionalmente compatibile perché –
naturalmente semplifico – mai specificamente “imposta” dalla Corte europea ed espressiva di un
necessario bilanciamento con altri principi costituzionali, che si risolvono nel parametro della
ragionevole durata.
Con l’ordinanza citata, la prima sezione penale della Cassazione ha sostanzialmente contraddetto
questo giudizio, sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 175, comma 2, c.p.p., tra
l’altro, nella parte in cui preclude la restituzione nel termine in caso di impugnazione del difensore
d’ufficio, anche per il contrasto con l’art. 117 comma 1 Cost. e dunque per il contrasto con i
principi enunciati dalla Corte europea in rapporto all’art. 6 della CEDU.
1111111111
C’è un altro aspetto di fondo dei limiti di sindacabilità delle scelte legislative, concernente
specificamente le disposizioni penali, che conviene evocare in via preliminare.
In un’epoca segnata da frequentissime riforme del sistema penale, anche sul piano sostanziale, ed
in particolare da riforme che «addolciscono» il trattamento di determinate fattispecie, matura con
molta frequenza l’esigenza di un controllo di legittimità sulle scelte legislative. Si pongono
problemi di successione nel tempo delle leggi penali, alla luce del principio di retroattività della
legge più favorevole. Ma il sindacato sulla legittimità della lex mitior, naturalmente, deve fare i
conti con il divieto di interventi in malam partem, nella materia penale, da parte della Corte
costituzionale.
Conviene ancora partire, sebbene si tratti di un provvedimento ormai piuttosto risalente, alla
sentenza n. 394 del 2006, Flick: sentenza dichiarativa, come tutti ricorderete, della parziale
illegittimità della normativa di favore introdotta, nel 2004, con riguardo ai falsi elettorali.
Per brevità, e per opportuna documentazione, trascrivo i passaggi essenziali della motivazione,
cominciando dal primo tema: nozione di norma penale di favore
(…) secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, all'adozione di pronunce in malam
partem in materia penale osta non già una ragione meramente processuale – di irrilevanza, nel senso
che l'eventuale decisione di accoglimento non potrebbe trovare comunque applicazione nel giudizio
a quo – ma una ragione sostanziale, intimamente connessa al principio della riserva di legge sancito
dall'art. 25, secondo comma, Cost., in base al quale «nessuno può essere punito se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso» (…) Rimettendo al legislatore – e
segnatamente al «soggetto-Parlamento», in quanto rappresentativo dell'intera collettività nazionale
(sentenza n. 487 del 1989) – la riserva sulla scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro
applicabili, detto principio impedisce alla Corte sia di creare nuove fattispecie criminose o di
estendere quelle esistenti a casi non previsti; sia di incidere in peius sulla risposta punitiva o su
aspetti comunque inerenti alla punibilità (…).
Questa Corte ha peraltro chiarito che il principio di legalità non preclude lo scrutinio di
costituzionalità, anche in malam partem, delle c.d. norme penali di favore: ossia delle norme che
stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello
che risulterebbe dall'applicazione di norme generali o comuni. Di tale orientamento – che trova la
sua prima compiuta enunciazione nella sentenza n. 148 del 1983 – questa Corte ha fatto ripetute
applicazioni (…). Esso si connette all'ineludibile esigenza di evitare la creazione di «zone franche»
dell'ordinamento (così la sentenza n. 148 del 1983), sottratte al controllo di costituzionalità, entro le
quali il legislatore potrebbe di fatto operare svincolato da ogni regola, stante l'assenza d'uno
strumento che permetta alla Corte di riaffermare il primato della Costituzione sulla legislazione
ordinaria. Qualora alla preclusione dello scrutinio di costituzionalità in malam partem fosse
attribuito carattere assoluto, si determinerebbe, in effetti, una situazione palesemente incongrua:
venendosi a riconoscere, in sostanza, che il legislatore è tenuto a rispettare i precetti costituzionali
se effettua scelte di aggravamento del trattamento penale, mentre può violarli senza conseguenze,
quando dalle sue opzioni derivi un trattamento più favorevole.
In accordo con l'esigenza ora evidenziata, va osservato che il principio di legalità impedisce
certamente alla Corte di configurare nuove norme penali; ma non le preclude decisioni ablative di
norme che sottraggano determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una
norma comune o comunque più generale, accordando loro un trattamento più benevolo (sentenza n.
148 del 1983): e ciò a prescindere dall'istituto o dal mezzo tecnico tramite il quale tale trattamento
si realizza (previsione di una scriminante, di una causa di non punibilità, di una causa di estinzione
del reato o della pena, di una circostanza attenuante o di una figura autonoma di reato punita in
modo più mite). In simili frangenti, difatti, la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione
resta salva: l'effetto in malam partem non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla
manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione
giudicata lesiva dei parametri costituzionali; esso rappresenta, invece, una conseguenza
dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso
già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria. Tale riespansione costituisce una reazione
naturale dell'ordinamento – conseguente alla sua unitarietà – alla scomparsa della norma
incostituzionale: reazione che si verificherebbe in ugual modo anche qualora la fattispecie
derogatoria rimossa fosse più grave; nel qual caso a riespandersi sarebbe la norma penale generale
meno grave, senza che in siffatto fenomeno possa ravvisarsi alcun intervento creativo o additivo
della Corte in materia punitiva.
(…) la nozione di norma penale di favore è la risultante di un giudizio di relazione fra due o più
norme compresenti nell'ordinamento in un dato momento: rimanendo escluso che detta
qualificazione possa esser fatta discendere dal raffronto tra una norma vigente ed una norma
anteriore, sostituita dalla prima con effetti di restringimento dell'area di rilevanza penale o di
mitigazione della risposta punitiva. In tal caso, difatti, la richiesta di sindacato in malam partem
mirerebbe non già a far riespandere la portata di una norma tuttora presente nell'ordinamento,
quanto piuttosto a ripristinare la norma abrogata, espressiva di scelte di criminalizzazione non più
attuali: operazione, questa, senz'altro preclusa alla Corte, in quanto chiaramente invasiva del
monopolio del legislatore su dette scelte (…).
Il requisito della compresenza della norma di favore e di quella che dovrebbe «riespandere» la
propria portata, che la dottrina ha fissato parlando di «specialità sincronica» è stato compiutamente
focalizzato proprio attraverso la sentenza in esame, sebbene la Corte ne avesse fatto applicazione in
precedenza, ad esempio coi provvedimenti del 2004 sulla riforma del falso in bilancio. Una nuova
applicazione è stata compiuta, al fine di dichiarare la inammissibilità della questione sollevata, con
la ordinanza n. 413 del 2008, Flick, Tesauro: la Cassazione tendeva a sindacare la depenalizzazione,
in sostanza, del trasporto di rifiuti prodotti in proprio dalle aziende e non pericolosi, a prescindere
dall’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese dedite alla gestione di rifiuti; la Corte ha replicato:
invero, nelle più recenti pronunce si è precisato che la nozione di norma penale di favore
costituisce la risultante di un giudizio di relazione fra due o più norme compresenti
nell'ordinamento in un dato momento (sentenze n. 324 del 2008 e n. 394 del 2006); (…) dunque, la
detta qualificazione va esclusa quando, come nella specie, la norma sottoposta a scrutinio sia messa
a raffronto con una norma anteriore, dalla prima sostituita con conseguente contrazione dell'area di
rilevanza penale; in tal caso, infatti, la richiesta di sindacato mira, non già a far riespandere la
portata di una norma contemporaneamente vigente nell'ordinamento, quanto piuttosto ad ottenere la
reintroduzione di una norma incriminatrice abrogata, in contrasto con il principio, più volte ribadito
da questa Corte, secondo cui l'individuazione delle condotte ai fini della repressione penale è
espressione di una scelta discrezionale riservata al legislatore (sentenze n. 324 del 2008, n. 394 del
2006, n. 330 del 1996; ordinanza n. 175 del 2001), fermo ovviamente il rispetto del principio di
irretroattività già sopra richiamato.
Ma veniamo al secondo dei profili essenziali trattati dalla decisione, cioè la questione della
rilevanza costituzionale del principio di retroattività della norma più favorevole.
La questione è venuta in gioco in quanto i comportamenti contestati nel giudizio principale erano
antecedenti all’introduzione della norma penale di favore, e dunque tenuti in costanza della
disciplina in ipotesi ripristinata attraverso la soppressione della norma medesima: situazione che,
per inciso, evidenzia l’enorme importanza istituzionale del tema, il quale attiene alla possibilità di
una determinata maggioranza politica di beneficiare irrevocabilmente, sebbene con una
deliberazione in ipotesi contraria a Costituzione, i responsabili di determinati fatti.
La Corte veniva per altro da una decisione ben più tormentata sull’argomento (tormentata anche a
seguito della posizione assunta dalla Corte di giustizia delle comunità europee sulla riforma del
falso in bilancio), assunta con la sentenza n. 393 del 2006 relativamente alla disciplina transitoria
della novella concernente la prescrizione del reato: dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (…), limitatamente alle parole «dei processi già
pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché».
La Corte, pur ponendo in rilievo il «rango» del principio di retroattività (a parte l’asserzione della
sua pertinenza alle tradizioni costituzionali comuni dei Paesi dell’Unione, sono stati ricordati il
Patto di New York e la Carta di Nizza), tale da richiedere una particolare attenzione del legislatore
nelle scelte eventualmente derogatorie, aveva comunque ribadito:
(…) deve essere preliminarmente ribadita la giurisprudenza di questa Corte, costante nell'affermare
che il regime giuridico riservato alla lex mitior, e segnatamente la sua retroattività, non riceve
nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in
quanto la garanzia costituzionale, prevista dalla citata disposizione, concerne soltanto il divieto di
applicazione retroattiva della norma incriminatrice, nonché di quella altrimenti più sfavorevole per
il reo.
Da ciò discende che eventuali deroghe al principio di retroattività della lex mitior, ai sensi dell'art. 3
Cost., possono essere disposte dalla legge ordinaria quando ricorra una sufficiente ragione
giustificativa.
Ricordato un siffatto ed importante antecedente, torniamo alla sentenza 394 sui falsi elettorali:
(…) il principio di retroattività della lex mitior ha una valenza ben diversa, rispetto al principio di
irretroattività della norma penale sfavorevole. Quest'ultimo si pone come essenziale strumento di
garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo dell'esigenza della “calcolabilità”
delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera
autodeterminazione individuale (… ). In questa prospettiva, è dunque incontroverso che il principio
de quo trovi diretto riconoscimento nell'art. 25, secondo comma, Cost. in tutte le sue espressioni: e,
cioè, non soltanto con riferimento all'ipotesi della nuova incriminazione, sulla quale pure la formula
costituzionale risulta all'apparenza calibrata; ma anche con riferimento a quella della modifica
peggiorativa del trattamento sanzionatorio di un fatto già in precedenza penalmente represso. In
questi termini, il principio in parola si connota, altresì, come valore assoluto, non suscettibile di
bilanciamento con altri valori costituzionali. La circostanza che una determinata norma, di rilievo
penalistico, sia contraria a Costituzione, non può comunque comportare – come conseguenza della
sua rimozione da parte della Corte – l'assoggettamento a pena, o a pena più severa, di un fatto che
all'epoca della sua commissione risultava, in base alla norma rimossa, penalmente lecito o soggetto
a pena più mite: derivandone, per tale aspetto, un limite al principio della privazione di efficacia
della norma dichiarata costituzionalmente illegittima, enunciato dall'art. 136, primo comma, Cost. e
dall'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale) (sentenza n. 148 del 1983).
Invece, il principio di retroattività della norma più favorevole non ha alcun collegamento con la
libertà di autodeterminazione individuale, per l'ovvia ragione che, nel caso considerato, la lex mitior
sopravviene alla commissione del fatto, al quale l'autore si era liberamente autodeterminato sulla
base del pregresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo. In quest'ottica, la Corte ha
quindi costantemente escluso che il principio di retroattività in mitius trovi copertura nell'art. 25,
secondo comma, Cost. (…). Ciò non significa, tuttavia, che esso sia privo di un fondamento
costituzionale: tale fondamento va individuato, invece, nel principio di eguaglianza, che impone, in
linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla
circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha
disposto l'abolitio criminis o la modifica mitigatrice (…)
Il collegamento del principio della retroattività in mitius al principio di eguaglianza ne segna,
peraltro, anche il limite: nel senso che, a differenza del principio della irretroattività della norma
penale sfavorevole - assolutamente inderogabile – detto principio deve ritenersi suscettibile di
deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente
ragionevoli (…).
Ma soprattutto, per quanto interessa nella specie, è giocoforza ritenere che il principio di
retroattività della norma penale più favorevole in tanto è destinato a trovare applicazione, in quanto
la norma sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima. Il nuovo apprezzamento del
disvalore del fatto, successivamente operato dal legislatore, può giustificare - in chiave di tutela del
principio di eguaglianza – l'estensione a ritroso del trattamento più favorevole, a chi ha commesso il
fatto violando scientemente la norma penale più severa, solo a condizione che quella nuova
valutazione non contrasti essa stessa con i precetti della Costituzione. La lex mitior deve risultare,
in altre parole, validamente emanata: non soltanto sul piano formale della regolarità del
procedimento dell'atto legislativo che l'ha introdotta e, in generale, della disciplina delle fonti (…);
ma anche sul piano sostanziale del rispetto dei valori espressi dalle norme costituzionali. Altrimenti,
non v'è ragione per derogare alla regola sancita dai citati art. 136, primo comma, Cost. e 30, terzo
comma, della legge n. 87 del 1953, non potendosi ammettere che una norma costituzionalmente
illegittima – rimasta in vigore, in ipotesi, anche per un solo giorno – determini, paradossalmente,
l'impunità o l'abbattimento della risposta punitiva, non soltanto per i fatti commessi quel giorno, ma
con riferimento a tutti i fatti pregressi, posti in essere nel vigore dell'incriminazione o
dell'incriminazione più severa.
11111111111
Abbiamo ampiamente richiamato la summa più recente del pensiero della Consulta sui limiti di
sindacabilità in malam partem di riforme «migliorative» del trattamento sanzionatorio, così da poter
più facilmente illustrare, e valutare, la decisione recentemente assunta dalla Corte sulla nuova
disciplina della prescrizione, introdotta dalla cd. legge ex-Cirielli.
Si tratta della sentenza n. 324 del 2008 (pres. Bile, rel. Silvestri, red. Napolitano), che ha definito i
giudizi promossi mediante tre particolari ordinanze, le quali evocavano i dubbi più ricorrenti nella
dottrina e nella stessa giurisprudenza, dichiarando inammissibili o infondate tutte le questioni
sollevate.
Si tratta di un quadro complesso, che proviamo a semplificare come segue.
Secondo i rimettenti – riducendo i quesiti alla sostanza - sarebbero state illegittime:
a) La previsione di irrilevanza, nel computo del termine, delle circostanze attenuanti e delle
aggravanti comuni.
b) La maggior durata del termine prorogato in base a circostanze inerenti la persona del colpevole.
c) La irrilevanza degli atti interruttivi relativamente ai reati connessi.
d) La irrilevanza della continuazione in punto di decorrenza del termine di prescrizione per i singoli
reati compresi nella fattispecie.
e) La ragionevolezza, più in generale, del quadro dei termini scaturente dalle modifiche introdotte.
f) La legittimità della disciplina transitoria.
Vediamo allora, con molta sintesi, come ha risposto la Corte.
L’attenzione principale è stata riservata alla riforma forse più «dannosa» per i procedimenti in
corso, a parte naturalmente il dato della riduzione secca della durata dei termini, e cioè quella sopra
indicata sub d): prescrizione e continuazione.
Le varie questioni proposte sono state giudicate inammissibili, proprio perché la pronuncia
sollecitata avrebbe violato il principio di insindacabilità in malam partem delle norme concernenti il
trattamento sanzionatorio penale. La Corte ha ribadito – smentendo con facilità la tesi di uno dei
rimettenti – che il divieto non riguarda solo la previsione edittale di pena, od i limiti della previsione
incriminatrice, ma ogni aspetto del «trattamento» di una fattispecie a fini di punizione, compreso
quello concernente la prescrizione (principio già molte volte affermato).
La Corte, ancora, ha negato fondamento alle tesi ingegnose delle parti private di uno dei giudizi a
quibus, che, in estrema sintesi, miravano a prospettare la nuova disciplina come norma penale di
favore. Nessun rapporto di specialità con una disciplina generale e coesistente: non quella
precedente, appunto perché abrogata, e non quella dell’art. 81 c.p., che non si occupa della
decorrenza del termine prescrizionale.
La Corte non ha ritenuto di confrontarsi, d’altra parte, con le tesi, di prevalente matrice dottrinale
(ad esempio Marinucci e Dolcini), secondo le quali il sindacato in malam partem sarebbe comunque
ammesso in caso di norme assolutamente «irrazionali». È un problema risalente, studiato ad
esempio da coloro che sondarono l’eventuale esistenza di obblighi costituzionali di penalizzazione,
che ha assunto consistenza del tutto speciale nell’attuale contingenza politico-istituzionale. Come
risponderemmo alla domanda circa la legittimità di una ipotetica norma che escludesse ogni
sanzione, per tutti, relativamente all’omicidio doloso? Le riflessioni dottrinali non sono prive di
punti di riferimento nella stessa giurisprudenza costituzionale (si veda soprattutto la ordinanza n.
337 del 1999, Granata, Neppi Modona, ove l’intervento additivo in senso peggiorativo viene
escluso «sempre che la disciplina non sia frutto di una scelta palesemente irrazionale e
ingiustificata»).
Va aggiunto che, nonostante qualche cenno a questa prospettiva, nessuno nel giudizio si era
impegnato seriamente a verificare la razionalità «intrinseca» della scelta legislativa. Questione
molto seria: la scelta, ad esempio, sembra coerente con la ratio del reato continuato, che è istituto di
favore per il condannato (tanto da restare inapplicato quando produrrebbe effetti negativi), ma è
incoerente sul piano della relazione tra profili sanzionatori e disciplina della prescrizione, che nel
caso del reato continuato è oggi interrotta.
Naturalmente anche la questione c): diffusione degli effetti interruttivi ai reati connessi, è stata
risolta nel senso della inammissibilità, trattandosi di sollecitazione per un intervento peggiorativo
del trattamento sanzionatorio.
La questione sub b): recidiva e maggior durata del termine, è stata sostanzialmente giudicata
irrilevante nei giudizi a quibus (e comunque un allargamento a tutti dei termini previsti per i recidivi
sarebbe stato precluso dal solito principio della insindacabilità in malam partem).
La questione sub a): irrilevanza delle attenuanti e delle aggravanti comuni, è stata giudicata
infondata, perché pertinente al ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa. È parso
congruo aver riguardo al fatto nella prospettiva della pena più severa, considerando a questo fine le
circostanze che comportano una variazione qualitativa del trattamento sanzionatorio: le aggravanti a
effetto speciale.
Uno dei rimettenti aveva posto la questione più finemente, lamentando che non si considerino
almeno le attenuanti ad effetto speciale, per le quali vale la ratio appena evocata. La Corte ha
risposto individuando un’altra esigenza ragionevolmente perseguita dal legislatore: consentire che i
termini siano valutabili in astratto, anche prima del giudizio (ove normalmente vengono
riconosciute le attenuanti) e comunque a prescindere dal giudizio di comparazione.
Le questioni che ho genericamente ricondotto alla lettera e): irragionevolezza dei nuovi termini, si
sono diluite in varie cause di inammissibilità.
Quanto alla disciplina evocata sub f), cioè la disciplina transitoria per il nuovo regime della
prescrizione, c’è da dire che i rimettenti, cercando di escludere la rilevanza della riforma nei
processi in corso, hanno perseguito un obiettivo «antistorico»: la Corte ha nuovamente precisato di
non considerare addirittura costituzionalizzato il contrario principio di retroattività della lex mitior,
ma ha ribadito quanto già stabilito nella citata sentenza n. 393 del 2006, ove addirittura era stata
giudicata illegittima l’inapplicabilità della riforma nei giudizi di primo grado: «per le leggi in esame
l'applicazione retroattiva è la regola e tale regola è derogabile solo in presenza di esigenze tali da
prevalere su un principio il cui rilievo, si è già osservato, non si fonda soltanto su una norma, sia
pure generale e di principio, del codice penale» ma che assume carattere di «principio generale
dell'ordinamento comunitario, desunto dal complesso degli ordinamenti giuridici nazionali e dei
trattati internazionali dei quali gli Stati membri sono parti contraenti» (sentenza n. 393 del 2006 che
espressamente cita la sentenza della Corte di Giustizia, 3 maggio 2005, C-387/02, C-391/02 e C403/02)».
Sempre a proposito della inammissibilità di interventi “peggiorativi” della Consulta sul piano del
trattamento penalistico delle condotte dei consociati, e sempre a proposito della disciplina della
prescrizione – in particolare quella concernente l’identificazione degli atti interruttivi (curiosamente
non intaccata dal legislatore della riforma, nonostante l’evidente obsolescenza) – va ricordata
l’ordinanza n. 65 del 2008 (Bile, Flick), che concerne il problema della ipotetica valenza interruttiva
dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.).
È noto che dopo un certo dibattito, segnato anche da sentenze di segno contrastante, la questione è
stata risolta in senso negativo dalle Sezioni unite della Cassazione (sentenza 22 febbraio 2007, n.
21833, ric. Iordache). L’ordinanza della Consulta si segnala per due ragioni: convalida apertamente
ed incondizionatamente l’opzione ermeneutica della Cassazione, e cioè che l’avviso di conclusione
delle indagini non interrompe il corso della prescrizione; esclude l’ammissibilità di questioni di
legittimità che – facendo valere l’irragionevolezza, per certi aspetti plateale, dell’esclusione di
quest’atto dal catalogo degli eventi interruttivi – mirino a provocare una sentenza additiva che
integri l’elenco contenuto nell’art. 160, secondo comma, cod. pen.. La ragione è quella che stiamo
da tempo analizzando: inammissibilità di una sentenza peggiorativa del trattamento sanzionatorio
riservato dalla legge penale a determinate fattispecie. È poiché, come già abbiamo ricordato, la
disciplina della prescrizione è compresa in quest’ambito, si conferma l’inutilità di doglianze
espresse nei confronti di interventi “lassisti” del legislatore.
Molto sinteticamente si può aggiungere che il concetto è stato dalla Corte ribadito, per l’ennesima
volta, con la ordinanza 5 del 2009, Flick, Napolitano, relativa ad tentativo di ottenere una
manipolazione in peius della disciplina concernente la decorrenza della prescrizione per i reati
punibili a querela e per il reato continuato.
Per concludere con la riforma della prescrizione, sotto il particolare aspetto dei suoi effetti
retroattivi, conviene ricordare la sentenza n. 72 del 2008 (Bile, Finocchiaro), ove la Corte, in
ritenuta congruenza coi principi fin qui evocati, aveva invece ritenuto legittima la previsione di
irretroattività delle nuove disposizioni sulla prescrizione relativamente ai giudizi di appello in corso
all’epoca di entrata in vigore della legge ex Cirielli. La lettura dei passaggi decisivi del
provvedimento è utile per il fare il punto più attuale sulla giurisprudenza in materia di retroattività
della lex mitior
deroghe a tale regola sono possibili solo se superano un vaglio positivo di ragionevolezza in quanto
mirino a tutelare interessi di analogo rilievo rispetto a quelli soddisfatti dalla prescrizione
(efficienza del processo, salvaguardia dei diritti dei soggetti destinatari della funzione
giurisdizionale) o relativi a esigenze dell'intera collettività connesse a valori costituzionali. In
particolare, la deroga al regime della retroattività delle disposizioni più favorevoli al reo è
ammissibile nei confronti di norme che riducano i termini di prescrizione del reato, purché essa sia
coerente con la funzione assegnata dall'ordinamento all'istituto della prescrizione e tuteli interessi
del tipo indicato (…) la circostanza che nel processo sia stata pronunciata una sentenza (di primo
grado) è significativamente correlata all'istituto della prescrizione, come si desume dall'art. 160 cod.
pen. che considera rilevante ai fini della prescrizione la sentenza (oltre il decreto di condanna ed
altri atti processuali). Deve, in particolare, evidenziarsi che il riferimento generico al decreto di
citazione a giudizio, contenuto nell'art. 160 cod. pen., consente di ricomprendere tra gli atti
interruttivi del corso della prescrizione anche il decreto di citazione per il giudizio di appello di cui
all'art. 601 cod. proc. pen.
Inoltre, nei giudizi penali di appello (e ancor più in quelli di cassazione), l'esigenza di evitare che
l'acquisizione del materiale probatorio (e quindi l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato) sia
resa più difficile dallo scorrere del tempo è già soddisfatta dalla disciplina positiva di tali giudizi.
Infatti, in via di principio, quel materiale probatorio è acquisito nel corso del dibattimento di primo
grado (in appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è ammessa solo nei casi di cui all'art.
603 cod. proc. pen.).
Sotto tale profilo, la scelta legislativa di escludere l'applicazione a tali giudizi dei nuovi termini di
prescrizione è ragionevole, non potendosi per essi invocare la ricordata esigenza cui il fondamento
della prescrizione è correlato.
La ragionevolezza di tale scelta è poi ulteriormente comprovata dal rilievo che essa - poiché nei
giudizi in esame il materiale probatorio, in linea di massima, è ormai stato acquisito - mira ad
evitare la dispersione delle attività processuali già compiute all'entrata in vigore della legge n. 251
del 2005, secondo cadenze calcolate in base ai tempi di prescrizione più lunghi vigenti all'atto del
loro compimento, e così tutela interessi di rilievo costituzionale sottesi al processo (come la sua
efficienza e la salvaguardia dei diritti dei destinatari della funzione giurisdizionale).
Nello stesso senso, più recentemente, è intervenuta la ordinanza n. 343 del 2008 (Bile, Finocchiaro).
Si può menzionare, per chiudere il quadro, la decisione che ha tratto le ovvie implicazioni della
sentenza 393 del 2006 riguardo alla retroattività della nuova disciplina della prescrizione nel caso di
fatti perseguiti, all’epoca di entrata in vigore della legge cd. ex Cirielli, mediante giudizio
abbreviato.
Come si ricorderà, una delle critiche mosse all’art. 10 della legge 251 del 2005, ed alla scelta di
individuare nelle formalità di apertura del dibattimento la soglia utile ad arginare la propagazione
retroattiva della lex mitior, consisteva nell’incertezza creata a proposito dei giudizi strutturalmente
privi di «dibattimento», quale è appunto il rito abbreviato. Per risolvere il problema erano state
proposte varie tesi, le quali però hanno perso ormai rilevanza.
È chiaro infatti come la Corte, spostando di fatto alla sentenza di primo grado la soglia
discriminante tra vecchia e nuova disciplina, avesse risolto il problema, «introducendo» un
adempimento proprio anche del rito abbreviato.
Con la ordinanza n. 384 del 2008 (Flick, Quaranta) si è preso formalmente atto della situazione,
restituendo gli atti al rimettente che aveva censurato il comma 3 dell’art. 10 «nella parte in cui non
esclude l'applicazione dei termini di prescrizione più brevi ai processi pendenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, ove sia stato disposto o ammesso il giudizio abbreviato»: è chiaro,
infatti, che il giudice a quo dovrà rivalutare la questione (ovviamente fondata su un preciso
presupposto interpretativo) alla luce della disciplina che ormai parifica i giudizi ordinari e quelli
abbreviati in corso all’epoca di introduzione del nuovo regime della prescrizione.
11111111111
È opportuno segnalare qui brevemente, perché si è risolta in una dichiarazione di illegittimità
costituzionale, e soprattutto perché rappresenta l’ennesimo intervento della Corte sul tema della
successione di leggi penali nel tempo, anche una decisione in materia di apparecchi automatici per il
gioco d’azzardo. Si tratta della sentenza n. 215 del 2008, Bile, Tesauro.
Era stato censurato l’art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005, il quale prevedeva che per le
violazioni di cui all’art. 110, comma 9, T.u.l.p.s., commesse in data antecedente alla data di entrata
in vigore della citata legge, si applicassero le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.
In sostanza, a fronte della depenalizzazione delle fattispecie di reato già previste dall’art. 110,
comma 9, T.u.l.p.s., la norma censurata introduceva una deroga al principio di non ultrattività della
legge penale, sancito dall’art. 2 del codice penale. Secondo i rimettenti, tale deroga non era assistita
da una sufficiente ragione giustificativa, e violava dunque l’art. 3 della Costituzione.
La norma penale individuava diverse figure di reato contravvenzionale (installazione ed uso di
apparecchi da gioco d’azzardo; installazione ed uso di apparecchi da intrattenimento non
rispondenti alle caratteristiche previste dai commi 6 e 7; violazione del divieto di utilizzo ai minori
di 18 anni) ed una fattispecie di illecito amministrativo (distribuzione, installazione ed uso in
mancanza di nulla osta). La depenalizzazione è stata attuata con l’art. 1, commi 525 e da 541 a 546,
della legge n. 266 del 2005.
Secondo la giurisprudenza della Corte, deroghe ai principi di cui all’art. 2 cod. pen. possono essere
disposte per via di legislazione ordinaria, ma devono essere assistite da una sufficiente ragione
giustificativa (v. sentenze n. 72 del 2008 e n. 393 del 2006, nonché, proprio in relazione al principio
di non ultrattività della legge penale, sentenze n. 164 del 1974 e n. 6 del 1978). Si è ritenuta
legittima una norma che escludeva l’applicabilità della depenalizzazione di cui alla legge n. 561 del
1993 alle violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore, quando il procedimento
penale era già stato definito con sentenza passata in giudicato, siccome giustificata dall’«esigenza di
salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti cui è finalizzata l’intangibilità del giudicato»
(sentenza n. 330 del 1995; nello stesso v. sentenza n. 74 del 1980).
Soprattutto, con riferimento al non più vigente art. 20 della legge n. 4 del 1929, il quale sanciva in
via generale la ultrattività della norma penale tributaria [«Le disposizioni penali delle leggi
finanziarie (...) si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in vigore»], la Corte ha
assunto a sufficiente ragione giustificativa l’interesse primario alla riscossione dei tributi ex art. 53
Cost., ritenendo che la norma (non si trattava, come nella specie, di una disposizione transitoria)
fosse «diretta a garantire che la spinta psicologica all’osservanza della legge fiscale non sia sminuita
nemmeno dalla speranza di mutamenti di legislazione» (sentenze n. 6 del 1978 e n. 164 del 1974).
Si legge, in particolare, nella sentenza n. 6 del 1978 che «La disposizione concerne la generalità dei
soggetti che abbiano violato la legge penale finanziaria (...). Il trattamento meno favorevole che
viene riservato agli autori di reati finanziari, relativi a tributi dello Stato, rispetto agli autori di reati
comuni, non appare irragionevole in quanto correlato all’esigenza di mantenere costante nel tempo
l’efficacia di prevenzione generale delle disposizioni penali poste a tutela dell’interesse dello Stato
alla riscossione dei tributi».
Come accennavo, la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale della previsione di ultrattività.
Ci interessa, particolarmente, com’è ovvio, la nuova presa di posizione sulla proiezione
costituzionale dell’art. 2 c.p..
Dopo aver ricordato che il principio di uguaglianza tendenzialmente impone la retroattività della lex
mitior (salvo appunto ricorrano significative eterogeneità connesse al tempus commissi delicti), la
Corte prosegue:
Il principio della retroattività della legge penale favorevole, dunque, è suscettibile di limitazioni e
deroghe, ma - in ragione della peculiare rilevanza dell'interesse da esso tutelato, dimostrata dal
grado di protezione accordatogli dal diritto interno, come pure dalla sua appartenenza alle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri dell'Unione europea (Corte di giustizia, sentenza 3 maggio
2005, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02) e al diritto internazionale (art. 15, primo
comma, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16
dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881) - tali limitazioni e
deroghe devono giustificarsi in relazione alla necessità di preservare interessi contrapposti di
analogo rilievo (sentenze n. 72 del 2008, n. 394 e n. 393 del 2006).
Ciò premesso in generale, la Corte ha rilevato che nessuna ragione attendibile (men che meno
quella indicata nella relazione parlamentare: fare chiarezza sul regime sanzionatorio del fenomeno
regolato) giustificava la scelta legislativa di ultrattività: non in particolare quella di assicurare la
continuità delle entrate finanziarie, trattandosi nella specie non di violazioni finanziarie, appunto,
ma di reati contro l’ordine pubblico.
Una breve notazione di carattere processuale. In epoca successiva alla sentenza di cui si è detto, la
Corte ha esaminato una questione analoga, sollevata ovviamente prima della sentenza medesima,
deliberando le ordinanze n. 414 e n. 415 del 2008 (Flick, Tesauro). Negli ultimi tempi, in tutti i casi
del genere, gli atti erano stati restituiti al rimettente per una nuova valutazione di rilevanza della
questione sollevata: valutazione destinata a chiudersi in senso negativo, essendo stata espunta
dall’ordinamento la norma censurata. Riprendendo una giurisprudenza più risalente, invece, la
Corte ha stavolta dichiarato inammissibile la nuova questione: valendo ex tunc la dichiarazione di
illegittimità della norma censurata, è come se il rimettente avesse sollevato una questione priva di
oggetto, cioè relativa ad una disposizione inesistente.
diritto sostanziale
Siamo già abbondantemente «scivolati», trattando dei limiti intrinseci al controllo di
costituzionalità, su argomenti di stretta pertinenza del diritto sostanziale, che ora conviene esaurire,
a cominciare, ancora una volta, dall’istituto della prescrizione.
Un ulteriore aspetto giunto all’attenzione della Consulta, riguardo alla legge cd. ex Cirielli, è quello
della prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace, tema notoriamente riferibile anche al
giudice non onorario, quando questi sia chiamato a giudicare di quei reati per ragione di
connessione. Il «problema» qui derivava dal 5° comma dell’art. 157 del codice penale, nel testo
novellato dalla legge n. 251 del 2005: il termine prescrizionale è di appena tre anni quando si tratta
di reati puniti con «pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria»; i soli reati puniti con
pene diverse sono appunto alcuni di quelli riferibili al giudice di pace (e puniti con le sanzioni paradetentive), cioè i più gravi; il paradosso, secondo alcuni, era che per i reati di pace meno gravi,
puniti con pena pecuniaria, la prescrizione interverrebbe in quattro o sei anni, mentre per gli altri
(puniti con pena “più che pecuniaria”, anche se non “detentiva”) la prescrizione sarebbe maturata,
appunto in tre anni.
La Corte ha ritenuto, con la sentenza n. 2 del 2008, Bile, Silvestri, che i termini prescrizionali per
tutti i reati di competenza del giudice di pace siano individuati a norma del primo comma dell’art.
157 del codice penale, avuto riguardo, per i fatti sanzionabili con le pene cosiddette
«paradetentive», al criterio di ragguaglio fissato nel primo comma dell’art. 58 del d.lgs. n. 274 del
2000 (considerazione quali pene detentive della specie corrispondente a quella della pena
originariamente prevista per il reato preso in considerazione).
Si tratta di una tipica pronuncia interpretativa di rigetto. Per quanto non emerga espressamente dal
testo della motivazione, la soluzione interpretativa presupposta al ragionamento dei rimettenti
comportava una effettiva violazione dell’art. 3 Cost. La soluzione opposta, adottata alla stregua di
interpretazione costituzionalmente obbligata, “elimina” dal panorama la norma censurata,
implicando la non fondatezza delle questioni sollevate.
C’è da dire che, dopo qualche incertezza iniziale, anche la Cassazione ha ripetutamente affermato
che, per i reati di competenza del giudice di pace, i termini prescrizionali sono sempre quelli
indicati nel primo comma dell’art. 157 c.p.. Si tratta di pronunce sia antecedenti che successive alla
pubblicazione della sentenza n. 2 del 2008, la quale è stata ovviamente citata, nelle decisioni più
recenti, quale elemento di conferma dell’orientamento ormai dominante.
Ecco la massima di una delle più recenti decisioni pubblicate sul punto:
Cass., Sez. IV, Sentenza n. 13966 del 24/02/2008 Ud. (dep. 03/04/2008), Antichi.
Il termine di prescrizione da applicare ai reati di competenza del giudice di pace è quello di cui
all'art. 157, comma primo, cod. pen. (come novellato dall'art. 6 L. n. 251 del 2005), poiché le pene
previste per detti reati hanno sempre natura pecuniaria, e solo in alcune ipotesi ed a determinate
condizioni possono essere sostituite da pene paradetentive; al contrario, il termine previsto dall'art.
157, comma quinto, cod. pen. è applicabile ad ipotesi di sanzioni non rinvenibili nell'attuale sistema
delle pene. (Conf. C. cost. 14-18 gennaio 2008, n. 2).
La stessa Consulta è tornata sull’argomento, più volte, in tempi recenti, definendo decine di
questioni sollevate da giudici di pace e tribunali, e ribadendo un principio di diritto che ormai può
dirsi del tutto stabilizzato (ordinanze n. 223 e 381 del 2008, rel. Silvestri).
11111111111
L’altro aspetto fondamentale dell’intervento attuato con la legge n. 251 del 2005 riguarda, com’è
noto, l’istituto della recidiva.
Con alcuni recenti provvedimenti – l’ordinanza n. 33 del 2008 e l’ordinanza n. 257 del 2008 (Bile,
Flick), la Corte ha ribadito il proprio punto di vista su uno degli aspetti più rilevanti della novella,
cioè il «divieto di prevalenza» delle attenuanti sulla recidiva reiterata, previsto dal novellato comma
4 dell’art. 69 c.p., nel quadro della regolamentazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze
eterogenee.
La questione era stata affrontata e risolta, per la prima volta, con la sentenza n. 192 del 2007, Bile,
Flick.
La norma censurata, che fa seguito ad un regime di quasi assoluta “liberalizzazione” del giudizio di
valenza (almeno pro reo), dice testualmente:
«le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del
colpevole, esclusi i casi previsti dall’art. 99, quarto comma, nonché dagli artt. 111 e 112, primo
comma, n. 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute
circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di
specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato».
La «neutralizzazione» (se non addirittura la soccombenza) delle attenuanti contrapposte alla
recidiva – compresa ad esempio la fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 309 del 1990,
con la conseguenza che anche fatti di lieve entità in materia di stupefacenti parevano sanzionati al
minimo con dieci anni di reclusione – aveva suscitato dubbi di legittimità presso innumerevoli
giudici.
I rimettenti evocavano gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., e in qualche caso anche gli artt. 25 comma 2
e 27 comma 1 Cost.. In qualche caso ulteriore erano evocati anche gli artt. 101 comma 2 e 111
comma 1, Cost.
Nel ragionamento della Corte ha assunto significato decisivo la ritenuta mera apparenza
dell’automatismo prospettato dai rimettenti, e dunque la perdurante possibilità per il giudice di
procedere all’adeguamento della pena alle caratteristiche del caso concreto.
Se, infatti, la contestata recidiva, una volta ritenuta, non può soccombere nel giudizio di
comparazione con le attenuanti, è pur vero che la stessa recidiva può tuttora essere esclusa dal
giudice, con la conseguente sua esclusione dal bilanciamento tra circostanze.
Il testo originario della legge Cirielli prevedeva inequivocamente la trasformazione della recidiva da
facoltativa in obbligatoria con riguardo a tutte le sue forme, sostituendo, a tal fine, nei primi quattro
commi dell’art. 99 c.p., la precedente voce verbale «può» (riferita all’aumento di pena) con l’altra
«è». La soluzione era stata fortemente osteggiata. Nel parere della Commissione Affari
costituzionali della Camera si evidenziava, in effetti, l’esigenza di valutare «se l’inasprimento in via
generale della normativa in tema di recidiva e in particolare la disposizione che prevede
l’automatica applicazione dell’aumento di pena senza quindi lasciare la giudice la possibilità di
valutare anche altri elementi … non si ponga in contrasto con i principi costituzionali ed in
particolare con quello dettato dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione che prevede che le pene
debbano tendere alla rieducazione del condannato».
A fronte di tali resistenze, il testo della proposta di legge era stato emendato in duplice direzione:
per le previsioni dei c. 1 e 2 (recidiva semplice e aggravata) ― ma non anche a quelle di cui ai c. 3
e 4 (recidiva pluriaggravata e reiterata) ― veniva ripristinata la voce verbale «può», in luogo di
«è»; veniva per altro introdotto un nuovo comma 5, in forza del quale, come già ricordato, «se si
tratta di uno dei delitti indicati dall’art. 407 comma 2 lett. a c.p.p., l’aumento della pena per la
recidiva è obbligatorio e, nei casi di cui al c. 2, non può essere inferiore ad un terzo della pena da
infliggere per il nuovo delitto».
Può considerarsi pacifico:
* che la recidiva semplice (c. 1) e la recidiva aggravata (c. 2) siano rimaste facoltative, salvo
nell’ipotesi che segue;
* che la recidiva, in tutte le sue forme, sia divenuta obbligatoria quando si tratti di taluno dei delitti
di cui all’art. 407 comma 2 lett. a c.p.p.;
Restava dubbio, invece, se la recidiva pluriaggravata (c. 3) e ― soprattutto ― la recidiva reiterata
(c. 4), fuori delle ipotesi previste dall’art. 407 comma 2 lett. a c.p.p., fossero facoltative od
obbligatorie: quesito al quale la dottrina aveva offerto risposte contrastanti.
A sostegno della tesi della obbligatorietà, in ogni caso, di dette forme di recidiva sembrava militare
l’argomento letterale. Con l’impiego della voce verbale «è», anziché «può» (riferita all’aumento di
pena), la formulazione dei c. 3 e 4 dell’art. 99 c.p. è stata riportata a quella anteriore alla novella del
’74, allorquando ― pacificamente ― la recidiva era sempre obbligatoria. Ciò a maggior ragione
considerando l’espressione «può» rimasta nei primi due commi della norma.
L’opinione maggioritaria (ed espressa da voci autorevoli, come Insolera, Dolcini, Marinucci,
Pavarini, Scalfati, ecc.) si era tuttavia schierata nell’opposto senso della facoltatività, ritenendo
l’accennato argomento di ordine testuale soverchiato da un complesso di argomenti di segno
contrario.
Si osservava al riguardo, sullo stesso piano testuale, che il c. 4 dell’art. 99 c.p. richiama, quali
«casi» in cui la recidiva reiterata può trovare applicazione, quelli dei c. 1 e 2, che contemplano
ipotesi di recidiva facoltativa; soprattutto, che la recidiva pluriaggravata e reiterata sono mere
“sottospecie” della figura generale delineata dal c. 1: il che indurrebbe a ritenere che la struttura
della recidiva sia quella ivi contemplata, limitandosi i commi successivi (e, in particolare, i c. 3 e 4)
a derogare alla relativa disciplina solo in relazione all’entità degli aumenti di pena. In quest’ottica,
dunque, il verbo essere all’indicativo («è») dovrebbe intendersi riferito, nella sua imperatività,
esclusivamente alla misura dell’aumento di pena ― che, a differenza che per l’ipotesi della recidiva
aggravata di cui al c. 2, si è voluto fisso, e non variabile tra un minimo e un massimo ― rimanendo
peraltro inalterato il potere discrezionale del giudice di ritenere o meno la recidiva.
Infine l’unica previsione espressa di obbligatorietà della recidiva, presente nell’art. 99 c.p., è quella
del c. 5 (relativa ai delitti dell’art. 407 comma 2 lett. a c.p.p.): sicché ― in applicazione del canone
ermeneutico ubi lex voluit dixit ― era giocoforza concludere che, fuori delle ipotesi espressamente
contemplate, il legislatore abbia inteso mantenere il carattere della facoltatività. Nello stesso senso
alcuni spunti provenienti dai lavori parlamentari.
Naturalmente, le ripetute determinazioni adottate proprio dalla Consulta nello stesso senso rendono
oggi sostanzialmente indiscussa la questione.
In conclusione, il comma 4 dell’art. 69 comprende casi di recidiva (quella reiterata) ove l’esito del
giudizio di comparazione è predeterminato, ma la stessa recidiva può essere sic et simpliciter
esclusa dal giudice (cioè i casi in cui non ricorrono reati del catalogo di cui all’art. 407 c.p.p.).
Accreditando questa soluzione, la Corte ha “rimproverato” ai giudici rimettenti di non averla
sperimentata nei giudizi a quibus, così recuperando quella possibilità di adeguamento della pena al
fatto che consideravano preclusa dal denunciato automatismo.
Nella citata ordinanza 257 del 2008 si affronta un ulteriore aspetto del problema. Alcuni dei
rimettenti, infatti, avevano ammesso la possibilità di non applicare la recidiva reiterata, ma avevano
sostenuto – con riferimento alla formula «circostanze aggravanti ritenute» che figura nell'art. 69,
quarto comma, cod. pen. – che l’intervenuta contestazione, ove naturalmente fondata, inibirebbe
comunque l’applicazione di attenuanti generiche concorrenti.
La Corte ha replicato:
Qualora si ammettesse che la recidiva reiterata, da un lato, mantenga il carattere di facoltatività, ma
dall'altro abbia efficacia comunque inibente in ordine all'applicazione di circostanze attenuanti
concorrenti, ne deriverebbe la conseguenza - primo visu paradossale - di una circostanza "neutra"
agli effetti della determinazione della pena (ove non indicativa di maggiore colpevolezza o
pericolosità del reo), nell'ipotesi di reato non (ulteriormente) circostanziato; ma in concreto
"aggravante" - eventualmente, anche in rilevante misura - nell'ipotesi di reato circostanziato "in
mitius" (in sostanza, la recidiva reiterata non opererebbe rispetto alla pena del delitto in quanto tale
e determinerebbe, invece, un sostanziale incremento di pena rispetto al delitto attenuato).
È appena il caso di porre in rilievo che, con le decisioni richiamate, la Corte non ha preso posizione
relativamente ai casi, più o meno ampi ma certamente esistenti, in cui la recidiva non può essere
esclusa.
C’è per altro un problema ulteriore, di corretta esegesi del c. 5 dell’art. 99 c.p. («se si tratta di uno
dei delitti di cui all’art. 407 comma 2 lett. a c.p.p. …»), e segnatamente di individuazione di quale
fra i delitti che determinano l’insorgenza dello status di recidivo debba appartenere al catalogo
racchiuso nella norma processuale richiamata, affinché scatti il regime di obbligatorietà.
In dottrina vi sono ben quattro tesi:
* che il delitto di cui all’art. 407 comma 2 lett. a c.p.p. debba essere quello pregresso: soluzione a
favore della quale si allega l’argomento logico per cui meriterebbe un surplus di pena solo il
condannato per un grave reato che ne commetta un altro, anche se meno «preoccupante»
* che il delitto di cui all’art. 407 comma 2 lett. a c.p.p. debba essere, invece, quello commesso dal
già recidivo: e ciò in quanto la logica sottesa alla previsione normativa de qua sarebbe quella di
colpire il fenomeno dell’escalation criminale
* che il delitto di cui all’art. 407 comma 2 lett. a c.p.p. possa essere, indifferentemente, quello
pregresso o quello attuale
* che tanto il delitto pregresso che quello attuale debbano appartenere al catalogo dell’art.
407comma 2 lett. a c.p.p.
L’ultima soluzione interpretativa comporta un ulteriore energico restringimento dell’area di
obbligatorietà della recidiva, il quale potrebbe essere ritenuto contrastante con la voluntas legis, ma
viene giustificato quale interpretazione “costituzionalmente orientata”.
E’ stato operato il sindacato di legittimità costituzionale anche su un’ulteriore aspetto della nuova
disciplina della recidiva, fissato nell'art. 99, primo, terzo e quarto comma, del codice penale, come
sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251: la previsione che – nei casi di recidiva
semplice, di recidiva pluriaggravata e di recidiva reiterata - il giudice operi un aumento in misura
fissa della pena irrogata per il reato in contestazione.
Numerosi giudici hanno giudicato che tale «automatismo» contrasti con l’art. 3 della Costituzione,
impedendo di modulare le pene in base alle differenze tra i vari casi concreti. La Corte, in sostanza,
ha richiamato la propria tradizionale giurisprudenza sulla discrezionalità legislativa in materia di
trattamento sanzionatorio. Ma ha sviluppato, nel contempo, alcuni rilievi specifici (ordinanza n. 91
del 2008, Bile, Flick)
In primo luogo, come abbiamo visto più volte anche in questa sede, la Corte ha riconosciuto che
l’applicazione di pena nei casi di recidiva è in genere facoltativa, anche nel caso di recidiva
reiterata: se il giudice ritiene che l’aumento «fisso» derivante dalla applicazione della circostanza
implichi un difetto di proporzionalità tra la sanzione ed il concreto fatto sottoposto a giudizio,
ebbene lo stesso giudice può non applicare la recidiva.
La Corte ha richiamato, in secondo luogo, la propria tradizionale giurisprudenza sulla compatibilità
costituzionale delle pene fisse. La disarmonia di queste fattispecie con il principio di uguaglianza, e
con il principio di finalizzazione rieducativa della pena, non viene negata. Tuttavia si è detto che la
possibilità per il giudice di adeguare la sanzione alle caratteristiche del fatto deve essere valutata nel
suo complesso, alla luce di tutte le norme applicabili ai casi considerati, e non solo in relazione alla
previsione edittale di una determinata fattispecie (per esempio, è stata respinta una questione
proposta riguardo ad una pena pecuniaria fissa prevista congiuntamente ad una pena detentiva
variabile tra minimo e massimo).
Infine un terzo rilievo. Nel caso della recidiva la pena in aumento non è realmente fissa, essendo il
frutto di una misurazione percentuale sulla pena base, e dunque assume una dimensione quantitativa
variabile in relazione alla variabilità della pena base. Il giudice quindi – secondo la Corte – può
ridurre l’effetto di aggravamento eccessivo eventualmente ricorrente nella specie attraverso
l’opportuna modulazione della pena a monte dell’applicazione della recidiva.
A questo punto, per altro, devono consentirsi due osservazioni, necessariamente telegrafiche. La
prima, valevole per tutta la giurisprudenza che la Consulta ha costruito sulla «facoltatività della
recidiva», è che la soluzione prescelta per “salvare” la riforma ex-Cirielli – oltre che non valere per
le pur limitate ipotesi di effettiva obbligatorietà dell’applicazione (supra) – presenta il difetto d’una
eccessiva compressione degli spazi di discrezionalità del giudice: impone l’alternativa tra
l’applicazione di una aggravante che divora le circostanze di segno opposto, con effetti di
inasprimento della pena talvolta ipertrofici, e la completa indifferenza alla condizione di recidivo
(nel che si sostanzia la disapplicazione della recidiva); tutto ciò, probabilmente, con conseguenze su
larga scala opposte a quelle che il legislatore ha perseguito con la riforma. Vero che il giudice può
comunque aumentare o diminuire la pena ex art. 133 c.p., per bilanciare gli effetti di un
meccanismo tanto sgangherato, ma la coerenza del sistema esce distrutta da tale situazione: perché
giustificare l’applicazione della pena minima per un rilevante fatto di narcotraffico, proprio nei
confronti di un recidivo, solo perché altrimenti la sanzione “finale” risulterebbe insopportabilmente
alta?
Analogamente: perché il giudice dovrebbe calcolare al minimo una pena base solo per evitare che
l’aumento frazionario di misura fissa comporti un aumento eccessivo in termini di quantità della
sanzione aggiuntiva?.
Non è un caso che, nella sentenza in esame, la Corte abbia voluto inserire un piccolo ma pur
significativo inciso: «pur costituendo, quello scrutinato, un assetto che si discosta per più versi dalle
linee generali del sistema».
11111111111
Alcune sentenze ulteriori dell’ultimo anno si segnalano per la pertinenza ad un tema di grandissima
importanza per il diritto penale sostanziale, specie in tempi di scarso livello tecnico nell’attività di
legislazione. Si tratta del principio di tassatività, sanzionato dall’art. 25 della Costituzione, ed
evocato da diverse nuove fattispecie, tra le quali può ricordarsi quella dell’indebito trattenimento
dello straniero, sul territorio nazionale, «senza giustificato motivo»: questione risolta dalla Corte,
favorevolmente alla compatibilità costituzionale della norma (art. 14, comma 5-ter del T.U. imm.),
con la nota sentenza n. 5 del 2004.
Le decisioni più recenti, per altro, riguardano fattispecie ormai risalenti, cioè figure originarie del
codice penale. Entrambe sono state «salvate» dalla Corte, con provvedimenti importanti anche
perché costituiscono il “punto” sul complesso tema del livello minimo di determinatezza della
previsione incriminatrice.
Conviene iniziare dal provvedimento che ha riguardato la figura di «disastro innominato» regolata
dall’art. 434 del codice penale. Può essere utile ricordare come la norma punisca «chiunque, fuori
dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una
costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro…». Una fattispecie che la rubrica della
norma definisce con l’espressione «altri disastri» era chiaramente destinata ad una verifica di
compatibilità con il principio di determinatezza, e sorprende solo, semmai, il numero dei decenni
trascorsi prima dell’evento. Non è probabilmente estranea alla circostanza la relativa frequenza con
la quale, da qualche tempo, gli uffici del pubblico ministero contestano il reato de quo di fronte a
gravi fatti di inquinamento ambientale.
Comunque sia, con la sentenza n. 327 del 2008 (Bile, Flick), la Consulta ha respinto i dubbi di
legittimità espressi dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, e l’ha fatto riassumendo ed aggiornando
la propria posizione in punto di tassatività:
Per costante giurisprudenza di questa Corte, la verifica del rispetto del principio di determinatezza
della norma penale va condotta non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo
dell'illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in
cui questa si inserisce. In particolare, «l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito di
espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero […] di clausole generali o concetti “elastici”,
non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva
del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite
dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il
significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario
compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di
corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento
ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una
percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo» (…).
In tal modo, risultano soddisfatti i due obiettivi fondamentali sottesi al principio di
determinatezza: obiettivi consistenti – come lo stesso rimettente ricorda – per un verso, nell'evitare
che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in
materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini
tra il lecito e l'illecito; e, per un altro verso, nel garantire la libera autodeterminazione individuale,
permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridicopenali della propria condotta (…).
Su queste premesse è stata condotta l’analisi della fattispecie sottoposta a verifica. Vero – dice la
Corte - che il concetto di «disastro» si presenta, di per sé, scarsamente definito. Tuttavia concorrono
alla sua delimitazione la finalità dell'incriminazione e la sua collocazione nel sistema dei delitti
contro la pubblica incolumità.
L'art. 434 cod. pen. è norma di “chiusura” del predetto sistema. Dunque fa parte di un genus che
comprende le precedenti figure incriminatrici, delle quali condivide i tratti unificanti. L’evento
incriminato è un accadimento diverso, ma comunque omogeneo, sul piano delle caratteristiche
strutturali, rispetto ai «disastri» contemplati negli altri articoli compresi nel capo relativo ai «delitti
di comune pericolo mediante violenza».
L’elemento strutturale unificante è desumibile dall’analisi d'insieme dei delitti in questione. Da un
lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni
straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi
ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare – in accordo
con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la «pubblica incolumità») – un
pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro
sia richiesta anche l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti.
La Consulta invoca, a sostegno del proprio ragionamento, il fatto che nella pratica giurisprudenziale
questi elementi sono stati evidenziati senza particolari sbandamenti o contrasti. Non che
l’uniformità dell’interpretazione possa colmare in sé un deficit di tassatività. Tuttavia l'esistenza di
un indirizzo giurisprudenziale costante diviene elemento di conferma della possibilità di
identificare, sulla scorta d'un ordinario percorso ermeneutico, la più puntuale valenza di
un'espressione normativa in sé ambigua, generica o polisenso.
La Corte aggiunge, in relazione allo specifico andamento della motivazione sviluppata dal
rimettente, che la «pubblica incolumità» esposta a rischio dalla condotta va intesa «nel suo preciso
significato filologico, ossia come un bene, che riguarda la vita e l'integrità fisica delle persone» (da
ritenere naturalmente comprensiva anche della salute)».
Un problema di tassatività è stato recentemente affrontato – qui non per la prima volta – con la
sentenza n. 225 del 2008, Bile, Flick, relativa alla fattispecie di possesso ingiustificato di chiavi
alterate o grimaldelli (art. 707 codice penale).
Il rimettente, in un provvedimento prevalentemente incentrato sulla tassatività come elemento di
garanzia della necessaria offensività del fatto incriminato, aveva lamentato tra l’altro che la
condotta sarebbe scarsamente definita, incentrandosi piuttosto la fattispecie su una condizione
personale dell’interessato (già condannato per determinati reati). La Corte ha fatto nella specie
applicazione pratica dei principi più volte enunciati, anche a proposito della interpretazione
teleologica: il possesso è di per sé una condotta, e nella specie non è punito semplicemente come
relazione tra l’agente ed una cosa determinata; la norma infatti sanziona chi viene «colto» in
possesso, evocando anche con tale espressione una situazione dinamica, di elevata probabilità della
destinazione del materiale alla commissione di un reato, che dal canto proprio assicura l’offensività
della condotta.
Proprio a quest’ultimo proposito può essere citato un brano della motivazione del provvedimento,
utile a sua volta per un “punto” sulla giurisprudenza in materia
L'ampia discrezionalità che – per costante giurisprudenza di questa Corte – va riconosciuta al
legislatore nella configurazione delle fattispecie criminose, si estende anche alla scelta delle
modalità di protezione penale dei singoli beni o interessi. Rientra, segnatamente, in detta sfera di
discrezionalità l'opzione per forme di tutela avanzata, che colpiscano l'aggressione ai valori protetti
nello stadio della semplice esposizione a pericolo; nonché, correlativamente, l'individuazione della
soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva.
Tali soluzioni debbono misurarsi, nondimeno, con l'esigenza di rispetto del principio di
necessaria offensività del reato: principio desumibile, in specie, dall'art. 25, secondo comma, Cost.,
in una lettura sistematica cui fa da sfondo «l'insieme dei valori connessi alla dignità umana»
(sentenza n. 263 del 2000).
La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito in qual modo si atteggi, a tale riguardo, la
ripartizione di competenze tra giudice costituzionale e giudice ordinario (sentenze n. 265 del 2005,
n. 263 e n. 519 del 2000, n. 360 del 1995). Spetta, in specie, alla Corte – tramite lo strumento del
sindacato di costituzionalità – procedere alla verifica dell'offensività «in astratto», acclarando se la
fattispecie delineata dal legislatore esprima un reale contenuto offensivo; esigenza che, nell'ipotesi
del ricorso al modello del reato di pericolo, presuppone che la valutazione legislativa di pericolosità
del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all'id quod plerumque accidit
(tra le altre, sentenza n. 333 del 1991).
Ove tale condizione risulti soddisfatta, il compito di uniformare la figura criminosa al principio di
offensività nella concretezza applicativa resta affidato al giudice ordinario, nell'esercizio del proprio
potere ermeneutico (offensività «in concreto»). Esso – rimanendo impegnato ad una lettura
“teleologicamente orientata” degli elementi di fattispecie, tanto più attenta quanto più le formule
verbali impiegate dal legislatore appaiano, in sé, anodine o polisense – dovrà segnatamente evitare
che l'area di operatività dell'incriminazione si espanda a condotte prive di un'apprezzabile
potenzialità lesiva.
11111111111
Continua il lavoro della Corte a fini di delimitazione della immunità dei parlamentari per le opinioni
espresse, come sancita dall’art. 68 Cost. Nessuna novità sconvolgente, negli ultimi tempi, ma la
decisa riproposizione di paletti che il Parlamento, dal canto proprio, generalmente non riconosce.
Uno dei principi più essenziali, ed ormai chiari, è che il nesso funzionale tra dichiarazioni extra
moenia ed atti tipici della funzione parlamentare può essere fondato solo su una sostanziale
coincidenza di contenuti, tale che l’esternazione sia credibilmente risolta in propalazione nella
società di quanto il parlamentare ritiene di dire nell’Assemblea di appartenenza. Ciò vuol dire che
una mera comunanza di tema tra gli atti tipici della funzione e l’esternazione in ipotesi diffamatoria
non è sufficiente a fondare l’immunità.
Ecco un passaggio della sentenza n. 135 del 2008, Presidente e redattore Bile, relatore Napolitano,
con la quale è stato accolto il ricorso del Giudice contro una delibera di insindacabilità:
… la Giunta, nel formulare la propria proposta, ritenne “di dover porre l'accento sul fatto,
incontestabile e ampiamente noto, che l'impegno politico e parlamentare del senatore XY sui temi
della criminalità mafiosa e del contrasto alla stessa ha rappresentato - e rappresenta - in certo qual
modo la naturale proiezione del suo impegno giornalistico e che tale impegno ha avuto ad oggetto
in modo sostanzialmente esclusivo le predette problematiche”. Ciò premesso, la Giunta aveva
ritenuto non potersi disconoscere l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, Cost.,
delle dichiarazioni contenute nell'articolo a firma del senatore XY in quanto «relativo ad una
vicenda - quella del pentito Giuffrè - che rientra senz'altro fra quei temi che [...] da sempre sono
stati al centro dell'attività giornalistica e dell' impegno politico dello stesso senatore». Tuttavia secondo la giurisprudenza di questa Corte - il mero riferimento all'attività parlamentare o comunque
all'inerenza a temi di rilievo generale (pur anche dibattuti in Parlamento), entro cui le dichiarazioni
si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, ove esse, non
costituendo la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare
nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun
deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri
voti (come tale coperto dall'insindacabilità, a garanzia delle prerogative delle Camere e non di un
“privilegio personale [...] conseguente alla mera "qualità" di parlamentare”: sentenza n. 120 del
2004), ma un'ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla
pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21
Cost.».
Identici concetti sono stati espressi in uno dei provvedimenti più recenti della Corte – sentenza n.
330 del 2008, Bile, Saulle, casualmente relativo allo stesso Parlamentare, e di nuovo consistito
nell’annullamento di una delibera di insindacabilità.
Va ricordato per altro verso – e di fronte ad un argomento di “difesa” sovente proposto dai legali
della Camera o del Senato – come la Consulta abbia escluso che sia possibile configurare una
“insindacabilità di gruppo”, cioè la pretesa immunità del parlamentare che compia affermazioni in
ipotesi diffamatorie con riferimento a circostanze poste ad oggetto di un atto tipico della funzione
posto in essere da altro parlamentare dello stesso gruppo (chissà poi perché dovrebbe restare
irrilevante l’eventuale nesso con le affermazioni intra moenia di un parlamentare dell’opposta parte
politica). Tra i provvedimenti più recenti può citarsi la sentenza n. 97 del 2008, Bile, Tesauro, che si
può brevemente trascrivere:
Sono indicati atti funzionali a firma di altri parlamentari (interrogazione n. …. che, per consolidato
orientamento di questa Corte, sono «irrilevanti» ai fini della sussistenza della prerogativa
costituzionale prevista dall'art. 68 della Costituzione (sentenze numeri 151 e 97 del 2007). Questa
Corte ha già ripetutamente affermato che la verifica del nesso funzionale deve essere effettuata con
riferimento alla stessa persona, non potendosi configurare «una sorta di insindacabilità di gruppo»
(sentenza n. 28 del 2008). Né per lo stesso motivo può condividersi la tesi della difesa della Camera
dei deputati secondo cui «la natura specificatamente politica del rapporto rappresentativo dei
parlamentari» imporrebbe «la spersonalizzazione di tutti gli elementi del conflitto».
Sullo stesso tema segnalo anche la sentenza n. 134 del 2008, Bile, De Siervo.
L’occasione della sentenza n. 279 del 2008, Bile, Cassese, è utile per ricordare che la Consulta ha
lavorato anche, negli ultimi anni, sulla insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai
consiglieri regionali, secondo il disposto del quarto comma dell’art. 122 della Costituzione. Com’è
noto alcune Regioni hanno disciplinato procedure destinate a culminare con una delibera di
insindacabilità dell’Assemblea regionale, sul modello di quanto avviene, in relazione all’art. 68
Cost., per i parlamentari nazionali. L’ambizione è quella di provocare effetti sui procedimenti penali
instaurati nei confronti del consigliere interessato, secondo la procedura che la legge 140 del 2003
ha formalizzato, appunto, per i deputati ed i senatori.
Con una importante decisione, la sentenza n. 195 del 2007, la Corte, considerata la diversa
posizione dei Consigli regionali e delle Assemblee parlamentari nel sistema costituzionale, aveva
escluso che le delibere di insindacabilità regionali abbiano un'efficacia inibitoria nei confronti degli
atti dell'autorità giudiziaria, e negato l'estensibilità della disciplina prevista dalla legge n. 140 in
favore dei consiglieri.
Il concetto è stato ribadito con la recente sentenza n. 279 del 2008.
Naturalmente la immunità direttamente garantita dal dettato costituzionale può sussistere, e la
Regione interessata è ammessa a promuovere conflitto con lo Stato, nella specie rappresentato
dall’Autorità giudiziaria, in base all’assunto che venga violata la prerogativa in questione. In
proposito, la Corte ha detto e ribadito che l’immunità riguarda i consiglieri regionali nell’esercizio
delle loro funzioni, e non dunque i componenti della Giunta od il presidente di questa.
È plausibile una estensione alla fattispecie dai concetti elaborati dalla giurisprudenza costituzionale
circa i presupposti per la insindacabilità dei comportamenti tenuti extra moenia dai Parlamentari
nazionali.
1111111111
Va segnalata, non foss’altro perché risolta in una dichiarazione di illegittimità costituzionale, la
sentenza n. 70 del 2008, Bile, De Siervo, a proposito della incidenza del condono edilizio sulla
estinzione del reato. L’art. 32, comma 36 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, prevede che gli effetti di cui all’art. 38,
comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 – cioè l’estinzione dei reati ivi previsti – si producono
con il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il pagamento dell’oblazione.
Questa dilazione, non nuova nei meccanismi di “clemenza edilizia” ma inedita per quanto concerne
l’effetto estintivo del reato, si connette ad un dato essenziale: l’Amministrazione competente gode
di un termine triennale, a partire dal versamento della somma “auto liquidata” dal richiedente, per
valutarne ed eventualmente contestarne la congruenza, fissando l’importo eventualmente dovuto a
conguaglio; scaduto quel termine senza interventi in tal senso, l’oblazione si intende correttamente
effettuata.
Non è irragionevole, dice la Corte, che l’effetto estintivo del reato si verifichi solo quando si è
stabilizzata la valutazione amministrativa sulla congruenza dell’oblazione versata e che dunque, in
caso di silenzio dell’amministrazione, occorra attendere tre anni dal versamento. È del tutto
irragionevole, però, che questa attesa venga imposta – dato l’inequivoco tenore letterale della norma
– anche quando l’amministrazione, invece che rimanere silente, abbia entro il termine accertato ed
attestato la congruenza del versamento. In questo caso l’ulteriore attesa (con conseguente “blocco”
del procedimento penale per il reato edilizio) resta inutiliter data.
Per brevità trascrivo letteralmente il dispositivo della sentenza:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 36, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui
non prevede che gli effetti di cui all'art. 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), si producono anche allorché, anteriormente al decorso dei 36 mesi dal pagamento
dell'oblazione, sia intervenuta l'attestazione di congruità da parte dell'autorità comunale
dell'oblazione corrisposta.
11111111111
Sempre in considerazione dell’opportunità di segnalare comunque le pronunce con effetto ablatorio,
va evocata una recente decisione in materia di peculato militare. In sintesi, dopo la riforma dell’art.
314 c.p., si era determinata una disparità di trattamento tra i militari e gli altri appartenenti alla
pubblica amministrazione, perché solo per questi ultimi il comma 2 della norma citata prevedeva
una sanzione fortemente attenuata per il cd. peculato d’uso: se cioè l’agente si appropria della cosa
al solo scopo di farne un uso momentaneo, per poi immediatamente restituirla. Infatti l’art. 215 del
codice penale militare di pace, e art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (che riguarda
specificamente il peculato degli appartenenti alla Guardia di Finanza), punivano la condotta in
questione quale forma ordinaria di peculato militare.
La Corte, con la sentenza n. 286 del 2008, Bile, Mazzella, ha ritenuto irragionevole la
discriminazione indicata.
(…) non sussistono, cioè, peculiarità relative alle specifiche esigenze dell'amministrazione militare,
in grado di giustificare un maggior rigore nel trattamento sanzionatorio del peculato d'uso
commesso in ambito militare rispetto all'analoga condotta commessa in altri rami della pubblica
amministrazione.
Pertanto, le norme censurate, nel comminare un'unica sanzione penale per tutte le forme di
peculato, senza attribuire un autonomo rilievo alla fattispecie del peculato d'uso, che anche in
ambito militare presenta, rispetto al peculato vero e proprio, un grado di offensività sensibilmente
minore, devono considerarsi entrambe lesive del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della
Costituzione.
Con la dichiarazione di illegittimità la Corte, come espressamente ha indicato in motivazione, ha
realizzato l’effetto di ritagliare dalle fattispecie incriminatrici militari una “fetta” della condotta,
quella appunto del peculato d’uso commesso da militare, la quale condotta dunque ricadrà nella
figura comune di peculato d’uso, e sarà conseguentemente punita con le sanzioni attenuate previste
dal codice penale. Sembra restar ferma l’operatività delle norme speciali riguardo a forme di
peculato non riconducibili a quella indicata. Ecco comunque, per precisione ed opportuna
documentazione, il dispositivo della sentenza:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, nella parte in
cui si riferisce al militare della Guardia di finanza che abbia agito al solo scopo di fare uso
momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace nella parte in
cui si riferisce anche al militare che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e,
dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita.
Diritto processuale
Ancora primeggia, per quanto concerne la giurisprudenza costituzionale recente sul processo
penale, il tema della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
Non molto ormai c’è da dire quanto alla dichiarata illegittimità costituzionale della norma che
precludeva l’appello del pubblico ministero contro la sentenza dibattimentale di proscioglimento
(art. 1 della legge n. 46 del 2006, di modifica dell’art. 593 c.p.p., e art. 10 della stessa legge n. 46, di
transitoria disciplina per gli appelli pendenti al momento di entrata in vigore della novella).
Si tratta della sentenza n. 26 del 2007, Bile, Flick.
Come semplice traccia per la memoria, trascrivo due delle massime ufficiali concernenti il
provvedimento:
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui,
sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le
sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc.
pen., se la nuova prova è decisiva. Il principio di parità tra accusa e difesa ex art. 111, secondo
comma, Cost., non comporta necessariamente l'identità dei poteri processuali del pubblico ministero
e del difensore dell'imputato, stanti le differenze fisiologiche fra le due parti: tali dissimmetrie sono,
così, ammissibili anche con riferimento alla disciplina delle impugnazioni, ma debbono trovare
adeguata giustificazione ed essere contenute nei limiti della ragionevolezza. A tali requisiti non
risponde la norma contestata, che introduce una dissimmetria radicale, privando in toto il pubblico
ministero del potere di proporre doglianze di merito avverso la sentenza che lo veda soccombente,
con la conseguenza che una sola delle parti, e non l'altra, è ammessa a chiedere la revisione nel
merito della pronuncia a sé completamente sfavorevole. Tale sperequazione non è attenuata dal
fatto che l'appello è ammesso nel caso di sopravvenienza o scoperta di nuove prove decisive,
trattandosi di ipotesi assolutamente eccezionali, né dall'ampliamento dei motivi di ricorso in
Cassazione, perché tale rimedio non attinge alla pienezza del riesame del merito. La rimozione del
potere di appello del pubblico ministero - generalizzata, perché estesa indistintamente a tutti i
processi, e unilaterale, ossia senza contropartita in particolari modalità di svolgimento del processo
- non trova giustificazione neppure alla luce delle rationes che, secondo i lavori parlamentari, sono
alla base della riforma, ed altera il rapporto paritario tra le parti con modalità tali da determinare
anche un'intrinseca incoerenza del sistema, poiché il potere di appello viene sottratto al pubblico
ministero totalmente soccombente in primo grado ma mantenuto nel caso di soccombenza solo
parziale. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 nella parte
in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento
prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile. Il principio di
parità tra accusa e difesa ex art. 111, secondo comma, Cost., non comporta necessariamente
l'identità dei poteri processuali del pubblico ministero e del difensore dell'imputato, stanti le
differenze fisiologiche fra le due parti: dissimmetrie sono, così, ammissibili anche con riferimento
alla disciplina delle impugnazioni, ma debbono trovare adeguata giustificazione ed essere contenute
nei limiti della ragionevolezza. L'art. 1 della legge n. 46 del 2006 non risponde a tali requisiti,
poiché, privando in toto il pubblico ministero del potere di proporre doglianze di merito avverso la
sentenza che lo veda soccombente, introduce una dissimmetria radicale, in quanto una sola delle
parti, e non l'altra, è ammessa a chiedere la revisione nel merito della pronuncia a sé completamente
sfavorevole. La rimozione del potere di appello del pubblico ministero - generalizzata e unilaterale altera il rapporto paritario tra le parti con modalità tali da determinare un'intrinseca incoerenza del
sistema, ed è, pertanto, in contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost.. Sulla base di tali
osservazioni, deve correlativamente considerarsi costituzionalmente illegittimo in parte qua anche
l'art. 10, comma 2, della medesima legge, con assorbimento degli ulteriori profili di censura.
È evidente, specie grazie alla lettura del testo della motivazione, l’attenzione con la quale la Corte
ha inteso non “pregiudicare” un prossimo ed auspicabile intervento di riforma sul sistema delle
impugnazioni, ribadendo diversi principi di «libertà» per il legislatore: il doppio grado di
giurisdizione nel merito non è costituzionalmente necessario, le impugnazioni non costituiscono per
il pubblico ministero modalità di attuazione dell’esercizio obbligatorio dell’azione penale, la parità
tra le parti non implica analogia di poteri neppure sul piano delle impugnazioni. Su questo piano,
anzi, le distinzioni sono ben possibili, purché corrispondano ad una diversità di situazione che le
giustifichi razionalmente.
Ciò che mancava, nella legge Pecorella, era proprio questa ragionevole giustificazione del baratro
introdotto tra l’imputato, legittimato a sindacare senza limiti la sentenza per sé sfavorevole, e la
parte pubblica, impedita sempre (tranne che nell’ipotesi marginale e un po’ ridicola della
sopravvenienza di nuovi elementi in pendenza dei termini per l’impugnazione) a sindacare la
sentenza per sé sfavorevole (ma paradossalmente legittimata a impugnare le sentenze parzialmente
favorevoli, come quelle di condanna).
Dopo la decisione appena commentata, l’esito dello scrutinio di costituzionalità della preclusione
dell’appello contro le sentenze di proscioglimento nel rito abbreviato non era affatto scontato. Come
si è visto, la Corte aveva addirittura evocato la propria precedente giurisprudenza di legittimazione
della preclusione riguardante le sentenze di condanna come esempio nel quale una discriminazione
«ragionevole» era stata introdotta tra le parti con riferimento alle facoltà di impugnazione.
Tuttavia, con la sentenza n. 320 del 2007, Bile, Flick, la Consulta ha dichiarato la «illegittimità
costituzionale dell’art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (…), nella parte in cui, modificando
l’art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa
appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato». Come
avvenuto già in occasione della pronuncia concernente la sentenza deliberata in esito al giudizio
dibattimentale, inoltre, la Consulta ha demolito anche la disciplina transitoria introdotta al fine di
rendere «retroattivo» il principio di inappellabilità, dichiarando la «illegittimità costituzionale
dell’art. 10, comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che
l’appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, contro
una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato
inammissibile».
Dunque, di nuovo appellabili anche i proscioglimenti intervenuti in esito al rito abbreviato.
La questione è stata ritenuta fondata in rapporto al secondo comma dell’art. 111 della Costituzione.
La Corte, ancora attenta a circoscrivere nella massima misura possibile le implicazioni della sua
scelta sulla materia generale delle impugnazioni, ha ribadito che il principio di parità tra le parti non
implica la necessaria corrispondenza delle occasioni di gravame. Le eventuali asimmetrie, però,
devono trovare «un’adeguata ratio giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero,
ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in vista del
completo sviluppo di finalità esse pure costituzionalmente rilevanti»; al tempo stesso, e in assoluto,
devono comunque essere contenute, «anche in un’ottica di complessivo riequilibrio delle posizioni
delle parti», entro i limiti della ragionevolezza.
Proseguendo l’esame del vaglio di legittimità sulla cd. legge Pecorella, da un punto di vista logico
più che cronologico, si deve ora trattare il tema dell’appello contro le sentenze di proscioglimento
del giudice penale di pace.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 41215 del 2007 (depositata l’8 novembre 2007), aveva
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 36 del d.lgs. n. 274 del 2000, come
modificato dal secondo comma dell’art. 9 della legge n. 46, nella parte in cui non consente al
pubblico ministero, appunto, di appellare le sentenze di proscioglimento del giudice di pace. A
parere della Corte, sussistevano le identiche ragioni di illegittimità poste a fondamento della
sentenza n. 26 del 2007, considerando l’ingiustificata dissimetria introdotta tra le posizioni delle
parti e considerando anche l’irrazionalità del sistema, che ancora consente, a determinate
condizioni, l’appello contro le sentenze di condanna.
Tuttavia la Consulta – con la sentenza n. 298 del 2008 (Bile, Flick) – è andata stavolta in senso
contrario, dichiarando la questione infondata, e dunque consolidando il regime di inappellabilità
delle sentenza di proscioglimento del giudice di pace.
La Corte ha enunciato gli argomenti che, a suo avviso, differenziano la fattispecie in questione dalle
altre già esaminate (cioè, in sostanza, tutti i proscioglimenti del giudice ordinario). Non tutti
sembrano avere la stessa forza persuasiva.
In primo luogo mancherebbe il carattere “generalizzato” della preclusione imposta alla pubblica
accusa, perché detta preclusione concerne, al contrario, «i soli reati di competenza del giudice di
pace, ossia un circoscritto gruppo di figure criminose di minore gravità e di ridotto allarme sociale:
figure espressive, in buona parte, di conflitti a carattere interpersonale e per le quali è comunque
esclusa l'applicabilità di pene detentive».
In secondo luogo «la limitazione censurata viene ad innestarsi su un modulo processuale (il
procedimento davanti al giudice di pace), che … presenta caratteristiche assolutamente peculiari.
Esso risulta improntato a finalità di snellezza, semplificazione e rapidità, che lo rendono non
comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e comunque tali da giustificare sensibili
deviazioni rispetto al modello ordinario».
In terzo luogo, la riforma avrebbe emendato una precedente sperequazione in danno dell’imputato,
posto che «il pubblico ministero fruiva del potere di appello, a certe condizioni, in rapporto ad
entrambi gli epiloghi decisori del processo di primo grado (condanna e proscioglimento); mentre
l'imputato fruiva dell'omologo potere, a certe condizioni, in rapporto ad uno soltanto di detti
epiloghi (la condanna). Non solo: l'imputato non poteva (né può) proporre appello contro le
sentenze di condanna per reati puniti con pena alternativa, allorché sia stata concretamente applicata
la sola pena pecuniaria (salvo che impugni l'eventuale capo di condanna al risarcimento dei danni);
invece, il pubblico ministero poteva appellare in ogni caso le sentenze di proscioglimento relative
alla medesima categoria di reati».
A livello di sintesi sembra dominante, nel pensiero della Corte, la bassa offensività dei reati di cui si
discute, con la connessa congruenza di un modulo procedimentale di particolare snellezza, anche
nel passaggio dall’un grado di giudizio all’altro. La Corte svaluta l’argomento del rimettente (in
caso di sentenza errata, il processo si allunga, perché occorre per il rimedio transitare dalla
Cassazione), affermando che si tratta di una mera eventualità. Si potrebbe aggiungere, forse più
efficacemente, che non ogni doglianza può essere mossa alla sentenza di proscioglimento con un
ricorso ammissibile.
Resta l’incongruenza di un pubblico ministero che ha conservato il potere di appello avverso le
sentenze di condanna a pena diversa da quella pecuniaria, ma ne resta privo riguardo alle sentenze
che disattendono in toto la pretesa punitiva (si vedano, al riguardo, le sentenze n. 26 e n. 320 del
2007). Ma la Corte osserva che l’incongruenza «non necessariamente dovrebbe essere rimossa nel
senso auspicato dalla Corte rimettente: e, cioè, tramite l'ablazione della norma modificativa e il
ripristino del regime pregresso. Sarebbe ipotizzabile, infatti, anche un intervento che incida sulla
perdurante (e, peraltro, di fatto assai circoscritta) appellabilità, da parte del pubblico ministero, delle
sentenze di condanna: intervento che non può essere peraltro preso in considerazione nella presente
sede, sia perché di segno opposto al petitum; sia perché comunque irrilevante nel giudizio a quo».
Resta una ulteriore questione da risolvere nel merito, sempre relativamente all’intervento di riforma
attuato con la cd. legge Pecorella, e sempre con riguardo ai poteri di impugnazione del pubblico
ministero: concerne la inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere.
Com’è noto l’art. 4 della legge n. 46 del 2006 ha modificato in questo senso l’art. 428 c.p.p.. La
Consulta è ripetutamente stata chiamata a valutare se debbano prevalere ragioni di analogia con le
due disposizioni già dichiarate illegittime (relativamente alle sentenze di proscioglimento deliberate
nella sede dibattimentale ed in quella del rito abbreviato) od eventuali peculiarità dello specifico
provvedimento considerato.
Era per altro già noto come, secondo una parte della giurisprudenza di legittimità, il problema
riguardasse solo le sentenze successive all’entrata in vigore della cd. legge Pecorella, perché la
disciplina transitoria mirata all’immediata applicazione del novum (cioè l’art. 10 della legge, che
decretava l’inammissibilità delle impugnazioni già proposte) non avrebbe riguardato le decisioni di
non luogo a procedere.
Con la ordinanza n. 4 del 2008, Bile, Flick, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili –
in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione – le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 428 cod. proc. pen., come sostituito dalla legge n. 46 del 2006, nella parte in cui esclude
che il pubblico ministero possa proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere
emessa in esito all’udienza preliminare.
Tutti i rimettenti, nella specie, procedevano per appelli proposti prima dell’entrata in vigore della
citata legge n. 46 del 2006, ed avevano agito sul presupposto che il relativo art. 10, prevedendo la
definizione dei giudizi già pendenti mediante dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto
contro la «sentenza di proscioglimento», si riferisse anche alle impugnazioni concernenti sentenze
di non luogo a procedere.
La Corte, dopo aver evocato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la norma transitoria in
questione (di carattere eccezionale rispetto al principio tempus regit actum) deve applicarsi alle sole
sentenze concernenti il merito dell’imputazione (cioè di «proscioglimento»), ha rilevato come i
rimettenti abbiano omesso di prendere in adeguata considerazione, anche solo per confutarla, una
tale soluzione interpretativa, che avrebbe escluso nei giudizi a quibus la sopravvenuta
inammissibilità dell’impugnazione.
Dunque, manifesta inammissibilità delle questioni per carenza di argomentazione in punto di
rilevanza delle questioni medesime.
In un successivo provvedimento sul medesimo oggetto e con il medesimo dispositivo – la ordinanza
n. 156 del 2008, Bile, Flick – la Corte ha evocato una ratio della diversa disciplina che il legislatore
avrebbe introdotto per la transizione al nuovo regime, facendo salve le impugnazioni pendenti:
«potrebbe giustificarsi (…) alla luce della non riferibilità alle sentenze di non luogo a procedere
delle rationes che, alla stregua dei lavori preparatori della novella, sono alla base della scelta di
rendere inappellabili le sentenze di proscioglimento (rationes consistenti nel garantire all'imputato
un doppio grado di merito sulla pronuncia di condanna; nell'impossibilità di escludere ogni
ragionevole dubbio sulla colpevolezza, dopo una sentenza di proscioglimento; nell'opportunità di
evitare che la decisione di proscioglimento emessa da un giudice che ha assistito alla formazione
della prova in contraddittorio, quale quello di primo grado, possa essere ribaltata da altro giudice −
quello di appello − che ha una cognizione prevalentemente «cartolare» del materiale probatorio)».
La perdurante ammissibilità degli appelli proposti contro le sentenze di non luogo a procedere in
epoca antecedente alla legge n. 46 del 2006 è stata indirettamente ribadita, da ultimo, con la
ordinanza n. 403 del 2008, Flick, Napolitano.
È appena il caso di osservare che il nodo verrà al pettine non appena la questione dovesse essere
sollevata riguardo ad una impugnazione proposta dopo l’entrata in vigore della legge Pecorella. Per
ora, la Corte continua a definire nel senso della manifesta inammissibilità le questioni proposte in
regime di transizione.
Possiamo passare ora ad un altro aspetto della disciplina introdotta con la legge Pecorella: l’appello
della parte civile, a fini di tutela della sua pretesa risarcitoria, contro le sentenze di proscioglimento.
L’art. 6 della legge ha modificato il comma 1 dell’art. 576 c.p.p., eliminando, nel primo periodo, il
riferimento al «mezzo previsto per il pubblico ministero» e prevedendo, nel secondo periodo, che la
parte civile può «altresì» proporre l’impugnazione contro la sentenza pronunciata all’esito del
giudizio abbreviato quando ha acconsentito alla abbreviazione del rito.
Il testo attuale dell’art. 576, comma 1, è, dunque, il seguente: «La parte civile può proporre
impugnazione, [con il mezzo previsto per il pubblico ministero], contro i capi della sentenza di
condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la
sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. La parte civile può altresì proporre
impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 443, quando ha consentito alla
abbreviazione del rito».
In sintesi, si era aperta immediatamente una discussione: se la riforma avesse soppresso anche
l’appello della parte civile o se questo, invece, continuasse ad essere ammesso nonostante la
preclusione posta al pubblico ministero (e poi rimossa dalla Corte).
Diverse Corti di appello avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 576 cod.
proc. pen., nel testo modificato dalla legge n. 46 del 2006, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione.
Presupposto interpretativo sotteso alle ordinanze di rimessione era che la facoltà di appello fosse
stata soppressa anche per la parte civile (del che, appunto, i rimettenti si dolevano).
La discussione era nata perché la norma, passata in ‘rilettura’ nella sede parlamentare ex art. 74
Cost. dopo il rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica con rilievi critici pertinenti
anche alla posizione della vittima del reato, ha subito in extremis la soppressione del riferimento al
mezzo di impugnazione esperibile dal pubblico ministero, perdendo così ogni specificazione circa il
mezzo a disposizione della parte civile. Di qui, considerando che i mezzi di impugnazione sono
tassativi e "legali" (v. art. 568 comma 1, c.p.p.), alcuni avevano inferito che la parte civile potesse
solo proporre il ricorso per cassazione. Posto in questi termini il problema riguardava, in effetti,
tutte le impugnazioni della parte civile, quindi anche quelle contro la sentenza di condanna.
Un indice a favore dell'appellabilità era rappresentato dall'art. 600 comma 1 c.p.p. – che continua a
prevedere che la parte civile possa chiedere al giudice di appello la clausola di provvisoria
esecuzione della sentenza di primo grado, se il giudice di prime cure abbia omesso di pronunciarsi
sulla relativa istanza – nonché dal silenzio della norma transitoria (art. 10 comma 2) sugli appelli
della p.c. medesima.
C’è da dire, inoltre, che la rimozione del collegamento tra mezzi esperibili dal p.m. e mezzi
utilizzabili dal danneggiato aveva piuttosto il senso di escludere quest’ultimo dalla concomitante
previsione di inammissibilità dell’appello da parte del primo, anche dato che si stava dando seguito
ai rilievi critici del Presidente della Repubblica circa la tutela delle vittime del reato.
La Cassazione, in effetti, aveva espressamente e ripetutamente affermato la conservazione, in capo
alla parte civile, del potere di impugnativa.
La Consulta aveva affrontato il tema con l’ordinanza n. 32 del 2007, pres. Bile, rel. Flick, fecendo,
in sostanza, il ragionamento che segue. Non è vero che la legge debba essere interpretata nel senso
della preclusione dell’appello. La stessa Corte di cassazione, in realtà, è presto pervenuta a
conclusioni ermeneutiche opposte, facendo leva sulla voluntas legis emergente dai lavori
parlamentari. Dunque non sussiste alcun “diritto vivente” conforme alla premessa interpretativa
dell’ordinanza, ed il rimettente non ha fornito adeguata motivazione delle ragioni per le quali
l’opposto orientamento − vale a dire la tesi della conservazione del potere di appello in capo alla
parte civile − non sia condivisibile: con la conseguente “sanzione” della declaratoria di
inammissibilità del quesito di costituzionalità per la carenza di una verifica di altre opzioni
ermeneutiche.
L’effetto pur indiretto di “accredito” della tesi della perdurante appellabilità in favore della parte
civile si è poi manifestato in una nuova e specifica decisione delle Sezioni unite penali (sentenza 29
marzo 2007, n. 27614 (rv 236539), PG in Proc. Lista): «anche dopo le modificazioni introdotte
dall’art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 all’art. 576, la parte civile ha facoltà di proporre
appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel
giudizio di primo grado»
Poteva dirsi dunque, ed ormai, che il diritto vivente si fosse orientato in senso esattamente opposto
alla opzione interpretativa sulla quale si erano fondate le molte questioni di legittimità pervenute
alla Corte.
Ecco infatti il gioco dell’interazione tra le due Corti, attuato con la ordinanza n. 3 del 2008, Bile,
Flick, nuovamente dichiarativa di inammissibilità delle questioni esaminate nella fattispecie.
(…) tale tesi − nel frattempo divenuta maggioritaria presso la giurisprudenza di legittimità − ha
trovato ulteriore conferma nella pronuncia delle Sezioni unite della Corte di cassazione (…)
nell'affermare tale opzione ermeneutica, il giudice della legittimità ha, in particolare, fatto leva
sull'interpretazione logico-sistematica dell'art. 576 cod. proc. pen. − attribuendo «a mero difetto di
tecnica legislativa la formulazione letterale» della norma in questione − e, soprattutto, sulla volontà
legislativa, quale desumibile dai lavori parlamentari (…) la Corte di cassazione ha evidenziato come
le modifiche apportate al testo normativo originariamente approvato dal Parlamento, dopo il rinvio
alle Camere da parte del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 74 Cost. − ed in particolare la
soppressione, nell'art. 576 cod. proc. pen., dell'inciso «con il mezzo previsto dal pubblico
ministero» − risultassero in realtà finalizzate a «rimodulare, accrescendoli, i poteri di impugnazione
della parte civile, sganciandone la posizione da quella del pubblico ministero» ed a ripristinare,
dunque, il potere di appello della parte privata: con il chiaro intento di recepire il rilievo formulato
nel messaggio presidenziale, circa l'eccessiva compressione della tutela delle vittime del reato quale
si delineava nelle soluzioni legislative inizialmente adottate (…) pertanto, avendo omesso i giudici
rimettenti di sperimentare adeguate soluzioni ermeneutiche - diverse da quelle praticate - idonee a
rendere la disposizione impugnata esente dai prospettati dubbi di legittimità, le questioni proposte
devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, alla luce della costante giurisprudenza di
questa Corte .
Nello stesso senso, a definire ulteriori porzioni della massa imponente delle questioni sollevate dalle
Corti italiane, anche la ordinanza n. 155 del 2008, Bile, Flick, e la ordinanza n. 226 del 2008, Bile,
Flick, a loro volta dichiarative della manifesta inammissibilità delle questioni trattate.
Da notare che la Corte ha specificamente confermato, anche con riguardo alle sentenze di
proscioglimento del giudice di pace, la facoltà di appello della parte civile, sostanzialmente
riprendendo gli argomenti, già sopra illustrati, in base ai quali la soluzione analoga è stata
prospettata per le sentenze di proscioglimento del giudice ordinario. Sul problema si è pronunciata,
in particolare, la ordinanza n. 302 del 2008, Bile, Flick.
Solo sinteticamente conviene infine segnalare, sempre con riguardo all’appello contro le sentenze
del giudice di pace, un provvedimento di manifesta infondatezza adottato dalla Corte riguardo ad
una questione di diritto transitorio (ordinanza n. 332 del 2008).
Veniamo allora all’ultimo aspetto della discussa riforma “Pecorella”, cioè quello concernente
l’appello dell’imputato contro le sentenze di proscioglimento. La Corte com’è noto ha dichiarato la
«illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (…), nella parte in cui,
sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che l'imputato possa appellare contro
le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola
ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del
medesimo codice, se la nuova prova è decisiva». Nel contempo, e com’era avvenuto nelle
precedenti occasioni, la Corte ha dichiarato anche l’illegittimità della disciplina transitoria che
stabiliva l’inammissibilità sopravvenuta degli appelli pendenti.
Si tratta della sentenza n. 85 del 2008, Bile, Flick, che è intervenuta in una situazione
obiettivamente complessa, già incisa dai precedenti interventi di demolizione della riforma.
I limiti all’appello dell’imputato che viene prosciolto – anche oltre quello “fisiologico” della
mancanza di interesse al gravame contro una sentenza completamente favorevole (il fatto non
sussiste o l’imputato non l’ha commesso) – sono in qualche misura tradizionali.
Il codice abrogato in pratica, a parte il caso dell’insufficienza di prove, lo consentiva solo per quei
proscioglimenti che presupponessero la riferibilità del fatto all’imputato (ad esempio per difetto di
imputabilità).
Tuttavia la Corte costituzionale estese progressivamente il regime di impugnabilità, proprio a
partire dalle sentenze di proscioglimento su presupposto “colpevolista”.
La “capofila” è la sent. 70/1975 (relativa alle sentenze del pretore, “bissata” poi dalla sent.
73/1978 con riguardo alle sentenze del tribunale), con cui fu dichiarata incostituzionale l’esclusione
dell’appello dell’imputato avverso il proscioglimento per amnistia susseguente al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti. Omologhe decisioni investirono quindi il
proscioglimento per amnistia o per prescrizione conseguente ad una serie di interventi giudiziali
sulle circostanze o sull’imputazione (sent. 72/1979; sent. 299/1985; sent. 53/1981; sent. 224/1983;
sent. 922/1988), investendo anche la sentenza conseguente alla remissione della querela (sent.
249/1989). Inoltre l’appello fu imposto per tutte le sentenze dalle quali avrebbe potuto derivare
l’applicazione di una misura di sicurezza (sent. 200/1986, sent. 140/1989).
In tutti i casi, la Corte ravvisò la violazione degli artt. 3 e 24, comma 2, Cost. La Corte in sostanza
― ferma restando la negazione della rilevanza costituzionale del principio del doppio grado di
giurisdizione ― operò un significativo raccordo tra violazione del diritto di difesa e mancanza di un
secondo giudizio di merito, sia pure in connessione ad un principio di parità rispetto al pubblico
ministero, che appellava tutte le sentenze di proscioglimento.
Nella sent. 200/1986 si legge che le norme «che negano all’imputato il diritto di proporre appello
contro provvedimenti suscettibili di essere appellati dal p.m. violano congiuntamente gli artt. 3,
comma 1, e 24, comma due, Cost., quando si tratti di provvedimenti dei quali pure l’imputato possa
avere ragione di lamentarsi»; «in tutte le ipotesi di proscioglimento ― escluse le pronunce emesse
perché il fatto non sussiste o non è stato commesso dal prevenuto, le uniche per cui manca ogni
interesse ad impugnare ― il legislatore attribuisce all’imputato un fatto, o non esclude
l’attribuzione di un fatto, che può non costituire reato ma tuttavia essere giudicato sfavorevolmente
dall’opinione pubblica o comunque dalla coscienza sociale»: sicché, in pratica, «soltanto nei casi di
proscioglimento con formula ampiamente liberatoria si potrebbe essere sicuri della mancanza di
ogni pregiudizio (attuale o potenziale) per il prosciolto».
Raccogliendo le indicazioni della Corte, la legge delega per il nuovo c.p.p. prevedeva, alla direttiva
n. 86, il «riconoscimento del diritto di impugnazione dell’imputato prosciolto che vi abbia
interesse». In attuazione, il testo originario dell’art. 593 escludeva l’appello dell’imputato nei soli
casi di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
Nel contempo, e per altro, erano inappellabili ― da ambedue le parti ― le sentenze di condanna
alla sola pena dell’ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con
la sola ammenda o con pena alternativa. Il che, dopo alterne vicende, vale ancor oggi, o meglio
valeva fino alla legge n. 46 del 2006.
Il quadro scaturito da tale ultima legge era davvero singolare.
Da un lato, infatti, il p.m. poteva appellare la sentenza a sé parzialmente sfavorevole (quella di
condanna a pena non congrua), ma non la sentenza totalmente sfavorevole (il proscioglimento),
salvo il caso eccezionale della nuova prova decisiva.
L’imputato, dal canto proprio, poteva appellare la sentenza a sé totalmente sfavorevole (la
condanna), ma non la sentenza parzialmente sfavorevole (il proscioglimento con formula non
ampiamente liberatoria), salvo sempre il novum probatorio.
In altre parole, nell’ipotesi della “soccombenza totale” appariva “svantaggiato” il p.m.; in quella
di “soccombenza parziale”, l’imputato.
La gran parte della dottrina aveva sollevato immediati dubbi sulla legittimità costituzionale della
radicale limitazione al potere di impugnazione dell’imputato contro le sentenze di proscioglimento,
dubbi già affiorati, peraltro, nel corso dei lavori parlamentari. Ovvio il richiamo alla giurisprudenza
costituzionale sopra segnalata, specialmente con riguardo alle sentenze prodromiche
all’applicazione di una misura di sicurezza.
Naturalmente, sul quadro in questione, sono poi intervenute le sentenze sull’appello del pubblico
ministero. La dottrina ha subito osservato che dette sentenze avevano introdotto una sperequazione
in danno dell’imputato (giudicata dai più illegittima). L’imputato infatti continuava a poter proporre
appello solo nei confronti delle sentenze di condanna (salva, quanto alle sentenze di
proscioglimento, la marginale eccezione delle nuove prove decisive), mentre il p.m. poteva ormai
impugnare incondizionatamente, nel merito, entrambe le decisioni. Si era determinata, cioè, una
situazione paradossale, per cui una disposizione nata con l’intento di eliminare, pro parte, l’appello
del p.m., valeva ormai ad eliminare solo l’appello dell’imputato.
La Corte, nel deliberare la propria pronuncia di illegittimità costituzionale, ha ribadito come le
sentenze di proscioglimento siano un genus variegato, nel cui ambito si rinvengono provvedimenti
fortemente lesivi dell’onorabilità dell’interessato e dei suoi stessi diritti patrimoniali o di libertà
(massime per il caso di applicabilità delle misure di sicurezza).
La « norma censurata - accomunando nel medesimo regime situazioni tra loro fortemente
eterogenee - nega all'imputato, salvo il novum probatorio, un secondo grado di giurisdizione di
merito nei confronti delle sentenze di proscioglimento, anche quando le stesse comportino una
sostanziale affermazione di responsabilità o attribuiscano, comunque, il fatto al prosciolto, così da
rendere configurabile un suo interesse all'impugnazione; e ciò pur a fronte del riconoscimento al
pubblico ministero della facoltà di dolersi nel merito della sentenza di condanna, la quale abbia solo
parzialmente recepito le richieste dell'accusa. A ciò viene ad aggiungersi che, per effetto
dell'intervento di riequilibrio operato dalla sentenza n. 26 del 2007 con riguardo all'ipotesi delle
sentenze totalmente sfavorevoli, il pubblico ministero si trova, allo stato, a poter appellare
incondizionatamente la sentenza di primo grado - diversamente dall'imputato - in rapporto ad
entrambi gli esiti (proscioglimento e condanna)». Non solo, perché la stessa parte civile aveva
conservato potere di appello.
Una tale asimmetria, secondo la Corte, risultava lesiva del principio di parità delle parti (art. 111,
secondo comma, Cost.), in quanto non sorretta - per quanto attiene ai rapporti tra imputato e parte
pubblica - da alcuna razionale giustificazione, correlata al ruolo istituzionale del pubblico ministero
o ad esigenze di corretta e funzionale esplicazione della giustizia; lesiva inoltre dei principi di
eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), stante l'evidenziata equiparazione di esiti decisori tra
loro ampiamente diversificati - quali quelli ricompresi nel genus delle sentenze di proscioglimento nel medesimo regime di inappellabilità da parte dell'imputato. Il medesimo assetto si poneva
correlativamente in contrasto con il diritto di difesa (art. 24 Cost.), al quale la facoltà di appello
dell'imputato risulta collegata come strumento di esercizio.
La Corte ha avuto cura, da ultimo, di escludere dall’area della ripristinata appellabilità le sentenze
di proscioglimento relative a contravvenzioni per le quali potrebbe essere inflitta la sola pena
dell'ammenda. Ciò, in sintesi, per la semplice ragione che l’appello contro queste sentenze è
precluso per l’imputato in caso di condanna, e sarebbe stato davvero un paradosso la sua
introduzione per il caso di assoluzione.
Un cenno molto sintetico richiede anche, per concludere la nostra analisi nella materia delle
impugnazioni, una recentissima decisione circa l’appello dell’imputato contro le sentenze di
condanna del giudice di pace, appello che è consentito dall’art. 37 del d.lgs. n. 274 del 2000 anche
quando sia stata irrogata la sola pena pecuniaria, purché sia stata contestualmente deliberata una
condanna al risarcimento del danno. Con la sentenza n. 426 del 2008, Flick, Tesauro, la Corte ha
dichiarato infondata una questione tendente ad eliminare la possibilità dell’impugnazione.
Il dubbio di legittimità era stato prospettato sotto il profilo dell’eccesso di delega, oltre che in
termini di violazione del principio di eguaglianza, posto che le condanne alla pena pecuniaria
inflitte dal giudice professionale sono comunque inappellabili, quando riguardano l’ammenda. Per il
primo profilo conviene rinviare gli interessati al testo del provvedimento. Quanto al secondo, la
Corte ha ribadito i limiti della comparazione tra giudizio penale innanzi al giudice di pace e giudizio
ordinario, data la peculiarità dell’oggetto e della struttura del primo rispetto al secondo.
11111111111
Un ennesimo e per qualche verso inaspettato, dopo una pausa durata vari anni, intervento
manipolativo della Corte in materia di incompatibilità del giudice. Con la sentenza 401 del 2008,
Flick, Tesauro, l’art. 34 c.p.p. è stato dichiarato illegittimo, nella parte in cui non prevede
l’incompatibilità quale giudice dell’udienza preliminare del magistrato che abbia, all'esito di un
precedente dibattimento riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato,
ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma 2, cod. proc.
pen.
La situazione prospettata dal rimettente non è gestibile, in effetti, senza ritenere l’incompatibilità,
posto che da anni la Corte costituzionale ha stabilito il valore pregiudicante dell’ordinanza di
restituzione degli atti per riscontrata difformità tra il fatto e l’enunciazione contenutane nel capo di
accusa (sentenza 455 del 1994). Più volte, d’altra parte, la Corte aveva mutato il proprio
orientamento iniziale e qualificato l’udienza preliminare quale funzione pregiudicabile (a partire
dalla sentenza 224 del 2001).
La Corte aveva per altro abbandonato il «criterio casistico», che ha portato ad un numero
esorbitante di dichiarazioni di illegittimità parziale di una stessa norma di legge, anche attraverso la
(discutibile) considerazione dell’udienza preliminare quale «giudizio» nella specifica prospettiva
dell’art. 34 c.p.p.. Dunque, negli ultimi anni, si erano registrate pronunce di rigetto o di
inammissibilità su base interpretativa.
Il criterio ha peraltro fatto ritorno nell’occasione presente, sebbene, ed oltretutto, il precedente del
1994 già comprendesse una situazione genericamente definita come «funzione di giudizio».
11111111111
A proposito dei fattori che possono turbare la serenità di giudizio del magistrato si segnala una
decisione concernente il tema «contiguo» delle deroghe alla disciplina ordinaria della competenza
per territorio stabilite dall’art. 11 c.p.p. per i procedimenti riguardanti magistrati.
In un caso obiettivamente delicato, il rimettente ha lamentato che la disciplina contenuta nella
norma non sia applicabile quando il giudice debba procedere nei confronti di un prossimo congiunto
del suo collega di distretto. In tale situazione, sarebbero violati gli artt. 3, 24, 25 primo comma e
111 secondo comma della Costituzione.
La questione è originale, anche se non è la prima volta che viene tentata, senza successo, una
«estensione» dei casi di deroga alle regole ordinarie della competenza. In precedenza però le
questioni avevano riguardato figure giudiziarie diverse dal giudice (cancellieri, avvocati, ecc.). Qui
si guarda piuttosto ad un’altra dimensione del fenomeno, cioè la relazione parentale tra l’interessato
ed il giudice. La censura principale (quella in punto di ragionevolezza ed uguaglianza) si fonda sul
rilevo che in altre prospettive è dato a quella relazione, cominciando dagli istituti
dell’incompatibilità e dell’astensione.
La Corte (con la sentenza 432 del 2008, Flick, Cassese) ha replicato obiettando l’incongruenza della
comparazione, posto che nella specie il fattore di perturbazione sarebbe dato dalla colleganza tra il
giudice ed il protagonista della relazione parentale, e non dalla relazione medesima. Ed il rilievo del
rapporto di colleganza, come la Corte ha stabilito anche in altre occasioni, non è razionalmente
delimitabile su base territoriale e non può radicarsi sul piano astratto, originando deroghe alla
competenza, le quali potrebbero estendersi fino alla dimensione nazionale, rendendo impossibile la
celebrazione del processo.
È ovvio, potrebbe aggiungersi, che situazioni di fatto delicate trovano la loro soluzione nella
disciplina dell’astensione e della ricusazione, che per sua caratteristica risolve nei casi concreti
situazioni non generalizzabili nella prospettiva della incompatibilità oppure in quella, mutatis
mutandis, della incompetenza per territorio.
11111111111
Per la centralità ed attualità del tema – il ruolo della difesa tecnica nella garanzia del diritto
personale dell’imputato al contraddittorio – conviene segnalare subito la decisione con la quale la
Corte ha «convalidato» la scelta legislativa di «instradare» le notificazioni concernenti l’accusato,
dopo che questi abbia avuto sicura percezione del processo (tanto da nominare un difensore di
fiducia), proprio verso lo studio del difensore (a meno che questi non rifiuti espressamente tale
specifica funzione), con un evidentissimo effetto di semplificazione del procedimento.
La regola è stata introdotta nel 2003 con l’inserimento nell’art. 157 c.p.p. del comma 8-bis: «Le
notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo
96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che
procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le
disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis ».
È noto che la disposizione ha dato adito a polemiche e ad incertezze interpretative, parte delle quali
risolte dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 19602 del 2008, ric. Micciullo.
È nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il
difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni.
Trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti
provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di
difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla
sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle
regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod.
proc. pen.. (In applicazione di detto principio le S.U. hanno ritenuto che il vizio di notificazione,
difforme dal modello legale, non abbia provocato lesioni del diritto di conoscenza e di intervento,
del resto nemmeno dedotti, dell'imputato, il quale, tra l'altro, aveva proposto personalmente le
impugnazioni di appello e di legittimità; d'altro canto, le S.U. hanno ritenuto tardiva la relativa
eccezione di nullità, che ben poteva e doveva essere proposta nel giudizio di appello).
Insomma, l’imputato può paralizzare la nuova disposizione semplicemente dichiarando od
eleggendo il proprio domicilio. Ed anche tale constatazione ha pesato, nel giudizio della Consulta,
allorquando ha deliberato la sentenza cui si faceva cenno – sentenza n. 136 del 2008, Bile, Silvestri
- dichiarando infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate riguardo alla norma di
recente introduzione.
La sentenza contiene rilievi di ordine generale sul ruolo che al difensore tecnico può essere
assegnato quale responsabile della partecipazione al processo del suo assistito: una forte
valorizzazione della professionalità e della deontologia dell’avvocato. E’ stato ribadito, inoltre, che
la legge processuale penale può operare presunzioni di conoscenza con riguardo alle parti in
contraddittorio, purché naturalmente siano ragionevoli ed esistano, per altro verso, rimedi nel caso
di fallacia della presunzione nella concreta fattispecie.
La norma censurata si ispira all'esigenza di bilanciare il diritto di difesa degli imputati e la
speditezza del processo, semplificando le modalità delle notifiche e contrastando eventuali
comportamenti dilatori e ostruzionistici. La scelta del legislatore è caduta sulla valorizzazione del
rapporto fiduciario tra l'imputato ed il suo difensore, fermo restando che il primo atto del
procedimento deve essere notificato comunque nelle forme ordinarie. Tale scelta non è lesiva dei
diritti dell'imputato, in quanto la nomina del difensore di fiducia implica l'insorgere di un rapporto
di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente, che
riguarda ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, allo
scopo di approntare una piena ed efficace difesa. Il difensore può peraltro sottrarsi all'onere (…)
Anche l'imputato può rendere inapplicabile la norma censurata, mediante dichiarazione del
domicilio o sua elezione presso un qualunque soggetto (…) Infine, si deve osservare che l'art. 175,
comma 2, cod. proc. pen., nel testo attualmente vigente, consente all'imputato, in caso di
dichiarazione di contumacia, la rimessione in termini per proporre impugnazione, ove non abbia
avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento che lo riguarda.
Questa Corte ha già chiarito che non vi è una assoluta incompatibilità delle presunzioni legali di
conoscenza con le garanzie di difesa e che non può negarsi che il legislatore possa presupporre un
onere di diligenza a carico del destinatario delle notificazioni, che gli impone una certa forma di
cooperazione (sentenza n. 211 del 1991). A maggior ragione un minimo di cooperazione è richiesto
al difensore di fiducia, nel caso in cui, pur avendo la possibilità di rifiutare le notificazioni ai sensi
dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., accetti di riceverle e si accolli pertanto l'onere di
mantenere costantemente e compiutamente informato il proprio cliente.
Deve anzi ritenersi che, proprio per effetto della norma censurata, il difensore nominato di fiducia
sia gravato anche dal compito di rendere edotto il proprio assistito delle conseguenze che, in
assenza di elezione o dichiarazione di domicilio, la stessa nomina comporta circa le modalità di
notificazione degli atti del procedimento. L'adempimento di tale dovere professionale costituisce
garanzia del buon funzionamento del rapporto fiduciario a fini specifici di efficacia delle future
notifiche.
Ove poi l'imputato si rendesse irreperibile anche per il proprio difensore, ciò sarebbe, di norma,
l'indice del suo disinteresse alla partecipazione attiva al processo.
Particolarmente interessante, tra gli altri, il riferimento alla procurata irreperibilità dell’imputato, nei
confronti del suo stesso difensore, quale indice di volontaria assenza dalla sede processuale.
11111111111
Come si vede, il tema del diritto dell’imputato al contraddittorio, che involge quelli connessi della
ammissibilità di forme «legali» di conoscenza, e della compatibilità del processo contumaciale con
la C.E.D.U. e la stessa Costituzione, continua a tenere banco.
Su piani diversi, due importanti provvedimenti della Consulta hanno ulteriormente affinato una
riflessione che, comunque, sembra ancora lontana dal concludersi con esiti che assicurino un
ragionevole equilibrio tra garanzie difensive ed effettività della giurisdizione.
Ad alcuni continua a sembrare che il processo contumaciale sia incompatibile con le Convenzioni
internazionali e con la nostra Carta, o che comunque il problema della condanna dell’imputato
inconsapevole possa essere risolto precludendo, radicalmente, che il processo si celebri nell’assenza
dell’interessato, almeno nei casi di minore attendibilità della presunzione di conoscenza legata a
forme di notificazione diverse da quella personale.
Tra gli altri, il Tribunale di Pinerolo ha ripetutamente sollevato – in riferimento agli artt. 3, 10,
primo comma, 97, primo comma, e 111, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione –
questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, 160, 420-quater, comma 1, e 484 del codice di
procedura penale «nella parte in cui non prevedono la sospensione obbligatoria del processo penale
nei confronti degli imputati ai quali il decreto di citazione a giudizio è stato notificato previa
emissione di decreto di irreperibilità».
La Corte ha risposto con una prima deliberazione di infondatezza mediante la sentenza n. 117 del
2007, ed ha ribadito il concetto con la ordinanza n. 89 del 2008, Bile, Amirante, di manifesta
infondatezza, cui possiamo affidare il compito di sintetizzare le ragioni della Consulta:
in quell'occasione la Corte ha evidenziato la centralità del diritto di difesa, al quale, secondo lo
stesso giudice a quo, la CEDU non accorda, in tema di processo svoltosi in absentia, garanzie
maggiori di quelle previste dall'art. 111 Cost., sottolineando come la stessa Corte di Strasburgo, con
la seconda sentenza emessa nel caso Sejdovic (sentenza della Grande Camera 1° marzo 2006), non
abbia negato, in linea di principio, il rilievo che possono assumere idonee misure ripristinatorie.
11111111111
C’è un altro fronte sul quale incidono profondamente i rapporti tra legislazione nazionale e norme
sovranazionali, ancora una volta riguardante la Convenzione e la Corte europea dei diritti
dell’uomo. Si tratta ormai di una vexata quaestio, tale divenuta per la perdurante inerzia del
legislatore. Occorre stabilire, in particolare se e quali conseguenze processuali derivino da una
decisione di condanna deliberata dalla Corte europea sul presupposto di una violazione del diritto
all’equo processo.
È appena il caso di evidenziare, a titolo di premessa, quale sia la differenza essenziale tra questo
problema e quello trattato in apertura della presente relazione. In quella sede si discute del contrasto
tra normative e dei poteri-doveri che ne derivano per il giudice nazionale. Qui parliamo di una
singola fattispecie concreta, in cui la Corte sovranazionale afferma la violazione di una regola che
l’Italia avrebbe dovuto rispettare: ma ciò può dipendere sia da un’erronea applicazione del diritto
interno, sia – ed è questo il problema – da una perfetta applicazione di quel diritto, il quale però, a
parere della Corte, non è stato in grado di assicurare la tutela apprestata dalla Convenzione.
Ora, l’art. 41 della Convenzione europea statuisce che, «se la Corte europea dei diritti dell’uomo
dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno
dell’Alta parte contraente non permette che in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale
violazione, la Corte stessa accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa ». Inoltre,
l’art. 46 della medesima Convenzione, sotto l’epigrafe “Forza vincolante ed esecuzione delle
sentenze” statuisce che «Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alla sentenza
definitiva della Corte per le controversie di cui sono parti (comma 1). La sentenza definitiva della
Corte viene trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione».
Dunque, una sentenza di condanna della Corte di Strasburgo fa nascere in capo allo Stato anzitutto
l’obbligo di rimuovere le cause della violazione, ripristinando la situazione anteriore alla stessa.
Solo in via sussidiaria la constatata violazione darà diritto al risarcimento, eventualmente
riconosciuto dal giudice europeo, a titolo di satisfaction équitable. Pertanto, per ottemperare
all’obbligazione di risultato che discende dall’accertamento della Corte europea, le autorità
nazionali devono prevedere, all’interno del loro sistema processuale, misure idonee a ripristinare la
situazione giuridica preesistente alla suddetta violazione. Ma, ovviamente, la presenza di un
giudicato interno (inevitabile, posto che è proprio l’esaurimento dei rimedi interni la condizione
imprescindibile per la legittimazione a ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo) necessita
di uno strumento idoneo alla sua “rimozione”.
Inizialmente, nell’ambito del Consiglio d’Europa si coltivò l’idea di introdurre direttamente, con
uno strumento internazionale, l’obbligo per gli Stati di prevedere meccanismi di revisione delle
sentenze penali irrevocabili a seguito delle pronunce della Corte di Strasburgo, idea che poi non si
realizzò. Le Raccomandazioni successive accreditano la tesi che l’unica vera forma di restitutio in
integrum sia la “revisione” (in senso più o meno tecnico, inteso cioè come riapertura) del giudicato
penale e la celebrazione di un nuovo processo in conformità alle norme pattizie.
Al momento, salvo errore, sono otto gli Stati che ammettono in via giurisprudenziale la possibilità
di riaprire un processo a seguito di una sentenza della Corte europea, indipendentemente
dall’esistenza di una disciplina legislativa ad hoc (Austria − che di recente si è dotata di legislazione
specifica − Belgio, Danimarca, Finlandia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Russia); sono quattordici i
Paesi che si sono dotati di una legislazione speciale per regolare il ricorso alla revisione quale
misura riparatoria da adottarsi in esecuzione di una sentenza della Corte europea (Austria, come
detto; Bulgaria; Croazia; Francia; Germania; Grecia; Lituania; Lussemburgo; Norvegia; Polonia;
Slovenia; Svizzera; Regno Unito); sono ancora otto i Paesi nei quali, mancando una specifica
disciplina, si ritiene impossibile la revisione del giudicato in ambito penale (Cipro, Irlanda, Italia,
Lettonia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Portogallo e Romania) ed, infine, quattro i Paesi ritenuti
“prossimi” a varare provvedimenti legislativi in materia (Belgio, Romania, Turchia e, secondo gli
osservatori internazionali, anche l’Italia…).
A proposito della situazione italiana va segnalato che, dopo la serie dei disegni di legge di iniziativa
parlamentare, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 3 agosto 2007, aveva approvato un disegno
di legge in materia di “Revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo”.
Sul presupposto che la decisione C.E.D.U. non consenta attualmente la revisione della condanna, e
nel perdurante silenzio del legislatore, alcuni interpreti hanno configurato comunque una efficacia
diretta delle sentenze che affermano la non equità del processo.
Limitandoci alla giurisprudenza della Cassazione, possiamo segnalare la notissima sentenza
Somogyi [Sez. 1, Sentenza n. 32678 del 2006], concernente la riapertura dei termini ex art. 175
c.p.p., la quale presuppone, al fine di legittimare l’impugnazione della sentenza contumaciale
passata in giudicato, che l’interessato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento. La
Corte, con una sentenza da alcuni ritenuta ridondante rispetto allo scopo (oltre che discutibile),
aveva stabilito che nel relativo accertamento il giudice é tenuto a conformarsi alla decisione della
Corte europea dei diritti dell'uomo che, in accoglimento del ricorso proposto dal condannato, abbia
riconosciuto il carattere non equo del processo celebrato in absentia, di talché il diritto al nuovo
processo non può essere negato invocando l'autorità del pregresso giudicato formatosi in ordine alla
ritualità del giudizio contumaciale svoltosi nel rispetto della normativa processuale interna.
Una seconda pronuncia di rilievo è rappresentata dalla sentenza Cat Berro [Sez. 5, Sentenza n. 4395
del 2006]. La decisione non nega l’efficacia “vincolante” delle pronunce di Strasburgo, ma afferma
che, in caso di condanna pronunciata all'esito di un giudizio contumaciale giudicato non equo dalla
Corte EDU, il condannato, onde ottenere la rinnovazione del giudizio, può avvalersi unicamente
dell'istituto della rimessione in termini per la proposizione dell'impugnazione, rimanendo per
converso escluso che egli possa ottenere la declaratoria di non eseguibilità della condanna,
semplicemente proponendo incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., senza nel
contempo avanzare, come tra l'altro previsto dal comma terzo dello stesso art. 670, anche richiesta
di restituzione in termini.
In questo senso – o almeno in senso contrario alla «sospensione» del titolo esecutivo - si era
pronunciata anche parte della giurisprudenza di merito (ad esempio la Corte di assise di appello di
Milano nel caso Cat Berro).
La terza sentenza è rappresentata dalla notissima sentenza Dorigo [Sez. 1, Sentenza n. 2800 del
2007]. Con questa pronuncia la Cassazione ha riconosciuto il massimo valore alle statuizioni della
Corte di Strasburgo, fino al punto di affermare che il giudice italiano deve dichiarare l'ineseguibilità
del giudicato quando la Corte europea abbia accertato che la condanna è stata pronunciata in
violazione delle regole sul processo equo e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla
rinnovazione del giudizio.
La sentenza per altro induce la situazione di un giudicato ineseguibile e però non superabile in alcun
modo, quasi che il carattere ingiusto della procedura precluda per sempre la possibilità di valutare il
fatto (soluzione estrema che la Convenzione non accredita in alcun modo).
Non a caso la giurisprudenza successiva si è fatta più prudente. Ad una decisione che sembra
confermarne in linea astratta l’enunciato, negandone però l’efficacia per il caso concreto[1], si
affianca una sentenza che, invece, riprende la posizione assunta dalla Corte nel procedimento Cat
Berro, il cui deliberato conviene trascrivere mediante citazione della massima ufficiale [Sez. 1,
Sentenza n. 8784 del 12/02/2008 (dep. 27/02/2008 ) Rv. 239141, Ay]:
In caso di condanna pronunciata all'esito di un giudizio contumaciale giudicato non equo dalla
Corte europea per i diritti dell'uomo, il condannato non può ottenere la declaratoria di non
eseguibilità della condanna limitandosi a proporre incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod.
proc. pen., ma, per ottenere la rinnovazione del giudizio, deve avvalersi unicamente dell'istituto
della rimessione in termini per la proposizione dell'impugnazione, come disciplinato dall'art. 175,
commi secondo e secondo-bis stesso codice, restando riservato al giudice italiano il potere di
valutare la ricorrenza dei presupposti di diritto interno per l'accoglimento dell'istanza. (V. Corte
cost., 20 ottobre 2007 n. 348).
È il caso Dorigo, comunque, che ha assunto rilievo anche nella giurisprudenza costituzionale, ed ha
indotto recentemente la Consulta ad un provvedimento che, in sostanza, ha confermato
l’inutilizzabilità dell’istituto della revisione, nella sua attuale disciplina, al fine di risolvere il
problema di cui stiamo discutendo. Si tratta della sentenza n. 129 del 2008, Bile, Flick.
Paolo Dorigo era un componente della colonna veneta delle Brigate Rosse. Con sentenza del 3
ottobre 1994, divenuta irrevocabile il 27 marzo 1996, fu condannato ad una pena piuttosto severa
(circa 13 anni e mezzo) per banda armata ed altri reati.
Successivamente, il condannato aveva adito la Corte Edu (o meglio, l’organismo ad essa
antecedente), la quale, con decisione del 9 settembre 1998, aveva stabilito che il processo a carico
del Dorigo era stato non equo per violazione dell'art. 6 § 3 lett. d) della Convenzione europea. Ciò
in quanto la condanna era stata pronunciata sulla base delle dichiarazioni rese nel corso delle
indagini preliminari da tre coimputati non esaminati in dibattimento, perché si erano avvalsi della
facoltà di non rispondere, con la conseguenza che l'accusato non aveva potuto esercitare il diritto di
interrogare o di fare interrogare i testimoni a carico.
Più volte, in seguito, il Comitato dei Ministri ha constatato l'inadempienza dell'Italia all'obbligo di
dare esecuzione alla decisione della Corte e di riaprire il processo nei confronti del Dorigo,
invitando le autorità italiane ad adottare, nel più breve tempo, le misure che permettessero di
eliminare le conseguenze della violazione e deplorando il fatto che, ad oltre sei anni dalla sentenza,
non fosse stata ancora adottata alcuna misura.
Nell’ottobre 2005 il Comitato ha affermato che il fatto che l’Italia, contrariamente alla maggioranza
degli Stati membri del Consiglio d’Europa, non preveda ancora nessuna possibilità di riapertura del
processo definito ingiusto da una sentenza della Corte, costituisce un ostacolo importante alla piena
conformità della sua normativa alla Convenzione. Di qui il reiterato invito ad adottare una legge che
consenta alle giurisdizioni nazionali di riaprire il processo in conformità alla Convenzione. Le
inottemperanze, in questo senso, sono state poi censurate anche dall’Assemblea Parlamentare.
Com’è noto, «pendono» in Parlamento diversi disegni di legge, della cui effettiva approvazione non
v’è però alcun concreto sentore. V’è stata per altro a luglio l’approvazione di un nuovo ddl
governativo.
Tornando a Dorigo, questi, che si trovava detenuto in esecuzione della pena, dopo aver ottenuto la
sentenza della CEDU, si è mosso su un duplice fronte interno.
a) Si è rivolto al giudice dell’esecuzione – la Corte di assise di Udine – in accordo con il
Procuratore generale, per far constatare la ritenuta inefficacia sopravvenuta del titolo esecutivo. La
Corte udinese, per altro, ha rigettato la richiesta, ritenendo limitato il proprio compito all’esclusivo
controllo dell'esistenza di un valido titolo esecutivo, ed in sostanza escludendo che la sentenza
CEDU avesse in qualche modo invalidato il titolo stesso, formato a seguito del giudicato interno.
Manca nell’ordinamento, secondo la Corte, un rimedio per la rinnovazione del processo valutato
non equo dalla Corte europea, sicché la liberazione del Dorigo avrebbe determinato «la possibilità
di una pronuncia di condanna sospesa sine die nella sua esecuzione, senza che nessuna autorità
abbia poi modo di deciderne la sorte, con evidenti problemi, per così dire, di chiusura del sistema».
La Corte accennava, in maniera abbastanza esplicita, alla possibilità di promuovere un giudizio di
revisione in favore del condannato, con la possibilità di sospensione dell'esecuzione della pena
prevista dall'art. 635 c.p.p.
Il P.M. di Udine, comunque, ha impugnato il provvedimento con ricorso per cassazione, sostenendo
l'inefficacia (o l'ineseguibilità) sopravvenuta del giudicato contrastante con la decisione della Corte
europea, anche perché la prospettata attivazione del procedimento di revisione non escludeva il
controllo della perdurante efficacia del titolo esecutivo.
La Corte di Cassazione − sez. I, 25 gennaio 2007 (cc 1 dicembre 2006), n. 2800 (Pres. Fazzioli, Rel.
Silvestri) − ha accolto il ricorso del P.M., statuendo che «il giudice dell'esecuzione deve dichiarare,
a norma dell'art. 670 c.p.p., l'inesigibilità del giudicato quando la Corte europea dei diritti
dell'Uomo abbia accertato che la condanna sia stata pronunciata in violazione delle regole sul
processo equo sancite dall'art. 6 della Convenzione (…) e abbia riconosciuto il diritto del
condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia omesso di introdurre
nell'ordinamento il mezzo idoneo a instaurare il nuovo processo». Con la medesima pronuncia, la
Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, dichiarato la
inefficacia dell'ordine di carcerazione emesso in esecuzione della sentenza di condanna, con
conseguente scarcerazione del Dorigo (in realtà già libero per provvedimento della Corte di appello
di Bologna: infra).
b) Il condannato, nel frattempo, aveva aperto il secondo fronte (suggerito dalla stessa Assise di
Udine), sollecitando la revisione della sentenza di condanna. Della domanda si è occupata (ex art.
11 c.p.p.) la Corte d’appello di Bologna, che è il giudice rimettente. Avvalendosi degli ampi poteri
discrezionali accordati dall’art. 635 c.p.p., la Corte ha sospeso l’esecuzione della sentenza raggiunta
dalla istanza di revisione, di fatto scarcerando Dorigo.
In pari data, è stata deliberata una ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
Secondo la Corte, l’art. 630 c.p.p. avrebbe dovuto essere manipolato nel senso di ammettere la
revisione non solo nel caso di nuove prove, ma anche quando la CEDU abbia stabilito la
“ingiustizia” del processo culminato con la sentenza di condanna.
La questione ha investito l'art. 630, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte
in cui esclude dai casi di revisione l'impossibilità di conciliare i fatti stabiliti a fondamento della
sentenza (o del decreto penale di condanna) con la decisione della Corte europea dei diritti
dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
La Consulta ha giudicato infondata la questione, seguendo un ragionamento che possiamo
riassumere come segue.
Presupposto logico dell’eccezione, nella prospettiva dell’art. 3 Cost., era una sostanziale analogia
tra la situazione considerata (sopravvenuto “accertamento” di “iniquità” del processo) e le
fattispecie regolate nel testo attuale dell’art. 630 c.p.p.: di qui, appunto, la pretesa rilevanza del
difforme trattamento. Tuttavia, osserva la Corte, la revisione – nella parte in cui concerne il
contrasto tra decisioni giudiziarie – accede a situazioni in cui si scontrano due ricostruzioni
inconciliabili di un determinato fatto storico.
Anche quando è pertinente ad un fatto processuale, il problema concerne la ricostruzione di un
determinato avvenimento della vita, come ad esempio l’esistenza di una situazione impeditiva della
partecipazione al giudizio dell’imputato.
L’oggetto della sentenza pronunciata dalla Corte di Strasburgo, invece, è la violazione di una delle
regole di assicurazione del giusto processo. Non c’è contrasto su un avvenimento, ma su una
relazione giuridica tra norme nazionali e sovranazionali, oppure sulla rilevanza di un determinato
fatto (non controverso) nell’una e nell’altra prospettiva.
Il giudice bolognese aveva poi prospettato una violazione dell’art. 10, primo comma, Cost.:
l’ordinamento si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
È il fenomeno, com’è noto, del cosiddetto adattamento automatico, che però presuppone la natura
non pattizia della norma sovranazionale, cioè la sua natura consuetudinaria. Secondo il rimettente,
la presunzione di non colpevolezza sarebbe norma consuetudinaria, sostanzialmente violata da una
disposizione che resta indifferente ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo la quale
«abbia accertato un “vizio fondamentale nella procedura precedente”».
Ragionamento disatteso per una molteplicità di ragioni. La prima è che la presunzione di innocenza
– per la sua natura prima ancora che per il lemma con il quale viene evocata – è qualcosa che
precede la sentenza irrevocabile di condanna. La revisione di quest’ultima non dipende da essa, ma
dall’accertamento – in termini storici - di un errore commesso dal giudice. In ogni caso la norma
convenzionale evocata non presenta, appunto, natura consuetudinaria. Senza dire – può aggiungersi
– che se invece lo fosse si darebbe luogo ad un adattamento automatico dell’ordinamento interno.
Quanto alla finalizzazione rieducativa della pena – che sarebbe vanificata ove questa fosse inflitta
mediante una sentenza “ingiusta” – la Consulta osserva tra l’altro che la norma costituzionale,
intesa come vorrebbe il rimettente, imporrebbe una costante e completa possibilità di revisione delle
sentenze di condanna, anche e per esempio per le questioni non dedotte. Il giudicato, di contro,
presenta una propria ed irrinunciabile rilevanza anche nella dimensione costituzionale.
D’altra parte « “Giusto processo” e “giusta pena” sono … termini di un binomio non confondibili
fra loro; se non a prezzo … di una inaccettabile trasfigurazione dello “strumento” (il processo) nel
“fine” cui esso tende (la sentenza irrevocabile e la pena che da essa può conseguire)».
La sentenza si chiude sul rilievo che il gravissimo problema posto dalla Corte bolognese può (e
deve) essere risolto secondo varie concepibili opzioni, che ovviamente spettano al legislatore. Un
solo e semplicissimo rilievo: non tutte le violazioni accertabili dalla C.E.D.U. riguardano
l’attendibilità del giudicato di condanna, ed impongono quindi una ripetizione del processo. Si pensi
solo all’accertata violazione del principio di ragionevole durata. O si pensi all’accertata “iniquità” di
specifici adempimenti processuali, della quale occorrerebbe comunque stabilire la rilevanza, e, se
del caso, ed in esito alla quale dovrebbe attivarsi una disciplina, allo stato inesistente, per la
ripetizione (più o meno parziale) del procedimento.
La Consulta, insomma, esprime forti e fondati dubbi che la soluzione possa consistere nella mera
introduzione di un nuovo caso di revisione. E comunque rileva l’ormai chiara insostenibilità
dell’inerzia legislativa sull’argomento, tanto che rivolge « al legislatore un pressante invito ad
adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire all'ordinamento di adeguarsi alle
sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali,
violazioni ai principi sanciti dall'art. 6 della CEDU ».
11111111111
Un problema di parità tra le parti, e di garanzia del diritto al contraddittorio, si pone – a mio avviso
con sempre maggiore evidenza – anche con riguardo a quella che genericamente possiamo definire
la vittima del reato.
Con poche ed inadeguate battute si può notare come la posizione della parte offesa, da sempre
regolata in senso deteriore rispetto a quella degli altri agenti del processo, sembri oggi ulteriormente
discriminata. Scrivendo il quinto comma dell’art. 111 Cost., il nuovo «Costituente» ha trascurato
che il contraddittorio non è solo una garanzia per l’imputato, e che la progressiva incentivazione dei
poteri d’indagine conferiti alle parti private comporta contraddizioni insopportabili, poiché solo una
tra esse può «disporre» delle deroghe al contraddittorio quale mezzo di formazione della prova.
La produzione della Consulta sull’argomento, per altro, è ancora improntata ad insegnamenti
tradizionali.
Per esempio una decisione molto recente, relativa al diritto (anzi alla mancata previsione del diritto)
di avviso per l’udienza di riesame del sequestro probatorio in favore della parte lesa che abbia già
nominato un difensore, ha giudicato legittima una situazione di minor garanzia per la persona offesa
dal reato (ordinanza 339 del 2008, Bile, Finocchiaro).
La Corte ha inteso ribadire «che l'eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al
processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, ancor prima, sul suo
diritto di agire in giudizio, perché resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del
danno nella sede civile, traendone la conclusione che ogni "separazione dell'azione civile
dall'ambito del processo penale non può essere considerato come una menomazione o una
esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale", essendo affidata al legislatore la scelta della
configurazione della tutela medesima, in vista delle esigenze proprie del processo penale». Inoltre,
si è voluto ricordare che «l'assetto generale del nuovo processo è ispirato all'idea della separazione
dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di
sollecita definizione del processo penale rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la
propria azione nel processo medesimo».
Insomma, secondo la Corte, «la persona offesa, anche nel nuovo codice, conserva la veste di
soggetto eventuale del procedimento o del processo, ma non di parte: ne discende che colui il quale
venga offeso dal reato non è titolare del diritto alla prova che l'art. 190 cod. proc. pen. limita
esclusivamente alle parti ("le prove sono ammesse a richiesta di parte")». Non avrebbe quindi senso
la pronuncia additiva richiesta dal rimettente del caso di specie, di fatto finalizzata a consentire una
interlocuzione sulla prova della vittima del reato.
Ecco il passaggio chiave della decisione: «in relazione all'evidente eterogeneità delle situazioni di
imputato e pubblico ministero da un lato e persona offesa dall'altro, nonché alla discrezionalità del
legislatore nel modulare la configurazione della tutela di quest'ultima in vista delle necessità proprie
del processo penale e delle esigenze di speditezza di quest'ultimo, la disciplina censurata non viola
né il diritto alla tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 della Costituzione, né l'art. 3 della
Costituzione, avendo semplicemente il legislatore trattato in maniera adeguatamente diseguale
situazioni diseguali».
Questione insomma manifestamente infondata.
Come ben si vede, la Corte ha potuto semplificare il proprio ragionamento anche in considerazione
del fatto che il rimettente non aveva evocato il secondo comma dell’art. 111 Cost., in relazione al
quale non risulta sia stata prospettata l’esclusione della vittima sul piano della parità tra le parti.
Naturalmente – ed a prescindere dal tema complesso e delicatissimo degli eventuali contenuti
aggiuntivi del nuovo art. 111 rispetto ai principi enucleati in precedenza muovendo dagli artt. 3 e 24
Cost. – resta vero che il principio di parità non impone completa assimilazione di poteri e facoltà
(si ricordino ad esempio gli enunciati in materia di impugnazioni). Ma certamente la Corte ha
potuto escludere un problema di diritto alla prova solo in relazione al fatto che la persona offesa non
è, notoriamente, una parte del procedimento, ruolo che assume soltanto dopo la costituzione di parte
civile.
La presa di posizione non dovrebbe quindi esercitare una influenza decisiva sulla soluzione di una
diversa e delicata questione, già due volte portata all’attenzione della Corte. La questione riguarda il
diritto alla controprova della parte civile nel giudizio abbreviato condizionato.
È appena il caso di ricordare che, a norma del comma 5 dell’art. 438 c.p.p., l’imputato può chiedere
il giudizio abbreviato, subordinando la domanda all’assunzione di prove integrative, che devono
essere necessarie e compatibili con le caratteristiche di economia del rito. Nel caso che il giudice
accolga la richiesta, il pubblico ministero ha diritto alla controprova. Secondo l’opinione
assolutamente dominante in dottrina, analogo diritto non spetta alla parte civile, che può essere già
costituita e, secondo l’opinione preferibile, può costituirsi anche immediatamente dopo l’ordinanza
introduttiva del rito (arg. ex art. 441, comma 2, c.p.p.).
La sperequazione dovrebbe giustificarsi alla luce dei correnti rilievi sulla natura eventuale della
partecipazione al processo del danneggiato, ai quali si aggiungono rilievi sulla necessità di
«semplificazione» del rito speciale, e sulla possibilità che la «controprova» sia di fatto introdotta
mediante l’intervento officioso del giudice in esito al giudizio. Si rileva, inoltre, che la parte civile
la quale non gradisca restare nel giudizio, in vista delle prove introdotte per iniziativa dell’imputato,
può abbandonare la sede penale e rivolgersi al giudice civile, senza neppure pagare il prezzo della
sospensione dell’instaurando giudizio civile, dato che in tal senso dispone il quarto comma dell’art.
441 c.p.p.
Nessuno di questi rilievi, a mio avviso, è realmente decisivo, ed anzi qualcuno tra essi esprime
opzioni sistematiche opinabili. Se davvero la possibilità di evitare una determinata fase o sede
processuale fosse argomento utile a giustificare sperequazioni o diminuzioni delle garanzie, si
potrebbe ad esempio ipotizzare un giudizio abbreviato senza contraddittorio, visto che l’imputato
potrebbe evitare la lesione del diritto di difesa semplicemente omettendo la richiesta di accesso al
rito. L’argomento della «copertura» offerta dall’esistenza di poteri officiosi in capo al giudice è, a
tacer d’altro, piuttosto spregiudicato, posto che evoca un ruolo tutorio tipico del modello
inquisitorio del processo.
Soprattutto, il diritto alla prova è garantito a tutte le parti, e può trovare assicurazioni sperequate
solo a fronte di peculiari caratteristiche della fase interessata. Nella specie non si discute della
pretesa di esercitare la ius probandi come nel rito ordinario, pretesa negata allo stesso pubblico
ministero (sentenza 115 del 2001) in nome, appunto, delle caratteristiche del rito. Si discute,
piuttosto, di una necessità conseguente ad una estensione del tema probatorio provocata dallo stesso
imputato. Tanto sarebbe assurda la pretesa di questi di introdurre nuovi temi di prova senza
contraddittorio che il legislatore ha introdotto il diritto alla controprova del pubblico ministero. C’è
da chiedersi, a questo punto, se abbia senso negare analogo diritto alla parte civile, anche
considerando che questa, a differenza del pubblico ministero, non ha avuto neppure una posizione
egemone o privilegiata nella fase delle indagini preliminari.
La questione non è stata sciolta dalla Corte in una prima occasione (ordinanza 101 del 2008, Bile,
Silvestri), per una necessaria dichiarazione di manifesta inammissibilità: il rimettente aveva
sollevato la questione, dopo la richiesta dell’imputato, senza provvedere sulla sua domanda; ed è
chiaro che un problema di diritto alla controprova delle altre parti si sarebbe posto solo in caso di
accoglimento della domanda medesima. In termini di processo costituzionale: una questione
«precoce» e quindi irrilevante, essendo ancora eventuale, per il giudice rimettente, la necessità di
fare applicazione della norma censurata.
Analogo esito di inammissibilità si è determinato in una seconda e recentissima occasione
(ordinanza n. 444 del 2008, Flick, Silvestri). Nella specie, a parte il carattere almeno formalmente
ancipite della questione (o illegittima la limitazione probatoria in danno della parte civile o
illegittima la sua presenza nel rito abbreviato condizionato), il rimettente non ha precisato (fornendo
anzi in proposito indicazioni contraddittorie) se la costituzione di parte civile fosse stata o meno
antecedente all’ordinanza introduttiva del giudizio. Inoltre la Corte non ha potuto verificare, date
anche in questo caso la carenza e la contraddittorietà delle prospettazioni compiute dal giudice a
quo, che si discutesse di diritto alla controprova e non piuttosto d’una pretesa della parte civile di
introdurre prove nuove nel giudizio abbreviato richiesto dall’imputato, con conseguente incertezza
circa la congruenza del quesito e la stessa pertinenza dei parametri evocati (è appena il caso di
ricordare che lo stesso pubblico ministero ha diritto alla mera controprova, e non certo alla
sollecitazione fondata su una propria ed autonoma prospettiva di integrazione probatoria).
11111111111
Restiamo per un momento sul terreno dei riti speciali, ed in particolare del giudizio abbreviato. Un
provvedimento all’apparenza assai scarno – l’ordinanza n. 67 del 2008, Bile, Flick – sembra
condizionare risolutivamente, se non addirittura chiudere, un dibattito che si protraeva da tempo a
proposito dell’accesso al rito abbreviato nel caso di contestazioni suppletive effettuate, nella sede
dibattimentale, sulla base di elementi già disponibili al tempo della formulazione dei capi di accusa.
Trascrivo di seguito, anzitutto, una ricostruzione dei termini della questione.
Il tema delle contestazioni suppletive nel dibattimento è oggetto di un contrasto radicato ormai da
molti anni. La discussione riguarda, in particolare, l’ammissibilità di modifiche dell’imputazione
che non traggano spunto da nuove emergenze istruttorie, ma si fondino piuttosto su elementi
raccolti nel corso delle indagini e dell’udienza preliminare, o comunque nella fase predibattimentale
del giudizio (per una ricognizione di dettaglio della controversia, nella fase più risalente, si veda G.
Leo, Contestazioni suppletive nel dibattimento: ammissibili solo se fondate su nuovi elementi di
prova?, in Dir pen proc., 2003, 704).
Neppure un intervento delle Sezioni unite della Corte di legittimità è valso a sedare la controversia,
sebbene la sentenza avesse espresso una opzione molto netta: « la modifica dell’imputazione di cui
all’art. 516 c.p.p. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui
all’art. 517 c.p.p. possono essere effettuate dopo l’avvenuta apertura del dibattimento e prima
dell’espletamento dell’istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già
acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari » (Cass., Sez. un., 11 marzo
1999, n. 4, Barbagallo, in Dir. pen proc., 1999, 633).
Esisteva in effetti, e continua a sussistere, un evidente problema di garanzia del diritto di difesa, il
quale diritto si estrinseca anche attraverso le eventuali scelte di accesso ai riti speciali. L’intervento
di modifiche dell’imputazione nella fase dibattimentale può vulnerare la posizione dell’imputato in
una duplice prospettiva: alterando il quadro in base al quale l’interessato aveva a suo tempo stabilito
di non formulare domande di patteggiamento o di rito abbreviato per i reati posti ad oggetto della
contestazione originaria; introducendo capi d’accusa per i quali, data la progressione del giudizio
oltre le soglie preclusive fissate dalla legge, non potrebbe comunque essere richiesto l’accesso ad un
rito speciale. Il sacrificio dell’interesse difensivo può sembrare ineluttabile, o almeno giustificabile,
quando concerne contestazioni che non avrebbero potuto essere effettuate in precedenza, perché
sorrette, appunto, da elementi di prova emersi solo nella fase dibattimentale del giudizio. Ma la
conclusione può essere opposta, nella stessa logica, riguardo a contestazioni che avrebbero ben
potuto essere modellate nel contesto della citazione o del provvedimento di rinvio a giudizio,
quando ancora l’imputato avrebbe potuto tenerne conto nel valutare l’opportunità di una richiesta di
accesso ai riti.
La questione non riguarda, ormai da molti anni, gli istituti dell’applicazione della pena su richiesta e
dell’oblazione. Gli artt. 516 e 517 del codice di rito sono stati infatti dichiarati illegittimi nella parte
in cui non consentivano la richiesta di patteggiamento ove la contestazione suppletiva intervenisse
sulla base di elementi già acquisiti al momento di esercizio dell’azione penale, oppure se a suo
tempo v’era stata richiesta dell’imputato rispetto alle contestazioni originarie (Corte cost., 22
giugno 1994, n. 265, in Giur. cost. 1994, 2153). Analogamente le norme sono state dichiarate
illegittime nella parte in cui non consentivano che l’imputato potesse sollecitare l’oblazione per
reati oggetto della contestazione suppletiva, sempre che ricorressero le condizioni delineate agli artt.
162 e 162-bis c.p. (Corte cost., 29 dicembre 1995, n. 530, in Cass. pen. 1996, 1084). Alla base delle
decisioni il rilievo che le valutazioni difensive circa la convenienza del rito speciale dipendono dalla
impostazione che il pubblico ministero conferisce all’accusa, cosicché, quando l’imputazione deve
essere modificata per un errore od una negligenza dello stesso pubblico ministero, la preclusione
dell’accesso al rito sarebbe ingiustificatamente lesiva del diritto di difesa.
Le sentenze in questione dimostrano, con evidenza, la serietà del problema che concerne la
perdurante preclusione del rito abbreviato nel caso di contestazioni « tardive ». Tuttavia la
giurisprudenza costituzionale, anche nelle sue espressioni più recenti, non è giunta alla
determinazione di « estendere » al giudizio sullo stato degli atti il meccanismo di rimessione in
termini introdotto per il patteggiamento. In una fase iniziale, anzi, la Consulta era parsa orientata nel
senso che spettasse al legislatore, in ragione del connotato discrezionale dei meccanismi di raccordo
tra giudizio ordinario e rito speciale, l’individuazione di una garanzia per l’imputato nei confronti
delle variazioni apportate all’accusa senza elementi di novità sul piano probatorio (Corte cost., 1
aprile 1993, n. 129, in Giur. it. 1995, 177; sull’argomento v. anche Corte cost., 28 dicembre 1990,
n. 593, in Cass. pen. 1991, 135; Corte cost., 4 maggio 1992, n. 213, in Giur. cost. 1992, 1743; Corte
cost., 22 giugno 1994, n. 265, Cass. pen. 1994, 2884).
Il concetto era stato ribadito finanche nell’ambito della decisione che, invece, aveva imposto la
rimessione in termini per la richiesta di patteggiamento: la Corte aveva dichiarato inammissibile
un’analoga questione concernente il giudizio abbreviato, prospettando ancora una volta la
pertinenza alla discrezionalità legislativa delle scelte utili ad assicurare la pur necessaria tutela delle
aspettative dell’imputato (Corte cost., 22 giugno 1994, n. 265, cit.).
Nonostante l’atteggiamento che si è descritto è stata più volte reiterata, negli ultimi anni, l’istanza di
una sentenza manipolativa che estenda la possibilità di recupero del rito in caso di modifiche «
tardive » dell’imputazione. Si è registrata, in proposito, una lunga serie di pronunce di
inammissibilità, che però non si sono fondate sull’asserito carattere discrezionale dell’addizione
richiesta dai giudici a quibus, quanto piuttosto su « vizi motivazionali » delle ordinanze di
rimessione (Corte cost., 16 aprile 2003, n. 129; Corte cost., 3 novembre 2005, n. 413; Corte cost.,
16 giugno 2005, n. 236, in Arch. n. proc. pen. 2005, 633, con nota di Cremonesi, Persa una
occasione per fare chiarezza sui rapporti tra le contestazioni dibattimentali e il giudizio abbreviato,
in Arch. n. proc. pen. 2005, 636).
Un esame di merito è mancato anche nell’intervento più recente della Consulta sul tema (Corte
cost., 8 novembre 2006, n. 384), intervento che per altro potrebbe aprire un varco per le opinioni
critiche circa la legittimità dell’attuale disciplina. Nella specie il rimettente lamentava che
l’imputato, quando rimane contumace nell’udienza preliminare, non deve essere necessariamente
avvertito della modifica dell’imputazione, cosicché, anche nel caso che detta modifica si fondi sugli
elementi già disponibili all’epoca della prima contestazione, l’interessato non viene posto in grado
di valutare nuovamente, nella mutata prospettiva, l’opportunità d’una richiesta di rito abbreviato. La
Corte, nel dichiarare infondata la questione, ha escluso che nella specie potesse assumere rilevanza
la « rimessione in termini » già introdotta per il patteggiamento. Quella decisione, infatti,
riguardava l’introduzione di una « nuova accusa » in una fase processuale ove l’imputato – presente
od assente che fosse – restava comunque escluso dalla possibilità di formulare in termini una
richiesta di accesso al rito speciale. Nel nuovo caso sottoposto alla sua attenzione, invece, la Corte
si è trovata a valutare un mutamento di contestazione maturato nell’ambito dell’udienza
preliminare, e dunque suscettibile d’una tempestiva reazione attraverso la domanda di definizione
mediante giudizio abbreviato: la preclusione di fatto riguardante l’imputato contumace, dunque,
dipenderebbe da una sua scelta volontaria (e consapevole del « rischio » di modifica dell’accusa),
non da una previsione di legge contrastante col pieno esercizio del diritto di difesa. Come si
accennava, potrebbe almeno ipotizzarsi una soluzione diversa ove la questione sia posta riguardo ad
un imputato – contumace o meno – che si veda modificare l’imputazione, in assenza di elementi
nuovi, in una sede processuale ove i termini per la richiesta di accesso al rito abbreviato siano già
scaduti.
In attesa d’una ipotetica manipolazione del quadro normativo, una parte della giurisprudenza di
legittimità continua a proporre una soluzione diversa e radicale del problema, considerando
inammissibile la contestazione suppletiva non fondata su nuovi elementi di prova.
L’assunto è stato proposto per la prima volta alcuni anni or sono, pur nel contesto d’una perdurante
tendenza maggioritaria in senso opposto, ed è stato tra l’altro motivato proprio in base all’esigenza
di non eludere i diritti dell’imputato sul terreno delle scelte concernenti i riti speciali (Cass., sez. VI,
29 maggio 2000, n. 6251, Apicella e altri, ivi, n. 216313). In seguito, anche al fine di giustificare il
distacco dalla soluzione a suo tempo accreditata dalle Sezioni unite, si è notato come il sistema
conosca ormai, per il caso di modifica all’imputazione, diverse ipotesi di regressione necessaria del
procedimento alla fase dell’udienza preliminare (comma 1-ter dell’art. 516 e comma 1-bis dell’art.
517): « il legislatore ha mostrato che le esigenze di concentrazione e di immediatezza possono
cedere alle garanzie difensive anche in presenza della condizione dell’acquisizione della novità nel
corso del dibattimento e ha così ribadito che solo da simile condizione oggettiva (e non da scelte o
omissioni dell’accusa) può comunque derivare la prevalenza dell’interesse alla concentrazione ed
all’immediatezza sulle medesime garanzie della difesa». Se ciò risulta chiaramente per le effettive
novità dell’istruttoria dibattimentale, non si vede perché l’udienza preliminare (con le connesse
possibilità di accesso al rito abbreviato) dovrebbe essere sacrificata quando addirittura si sarebbe
imposta sulla base delle prove già acquisite a monte del rinvio a giudizio (Cass., sez. VI, 15 gennaio
2002, n. 1431, Porricelli, in Cass. pen. 2003, 3870).
L’orientamento continua a manifestarsi in modo episodico (Cass., sez. II, 17 febbraio 2004, n. 6584,
F., in C.E.D. Cass, n. 228554; Cass., sez. VI, 15 marzo 2005, n. 10125, P.c. in proc. A., ivi, n.
231225). Va subito precisato, però, che continua ad essere ampiamente prevalente la soluzione
favorevole alla ammissibilità delle contestazioni suppletive fondate su elementi raccolti in fase
antecedente al dibattimento (Cass., sez. VI, 28 luglio 2003, n. 31705, Bienati, ivi, n. 228400; Cass.,
sez. VI, 5 maggio 2004, n. 21085, P.c. in proc. S., ivi, n. 229807; Cass., sez. IV, 22 aprile 2004, n.
18660, M., ivi, n. 228357; Cass., sez. II, 28 maggio 2004, n. 24537/04, M., ivi, n. 229028; Cass.,
sez. II, 17 settembre 2004, n. 36842, N., ivi, n. 229729; Cass., sez. VI, 22 dicembre 2004, n. 49017,
P.c. in proc. S., ivi, n. 231271; Cass., sez. II, 27 marzo 2006, n. 10524, D.P., ivi, n. 233802; Cass.,
sez. V, 3 ottobre 2006, n. 32797, B., ivi, n. 235071).
Anche la Consulta, con la recente decisione sopra citata, è parsa dare un avallo all’orientamento
dominante. La questione concernente l’imputato contumace è stata dichiarata infondata, tra l’altro,
sul presupposto che la modifica dell’imputazione sia un « evento prevedibile », e che ciò sarebbe
tanto più vero nei casi di mutamento operato in assenza di elementi di prova differenti da quelli
disponibili al momento della prima contestazione. L’assunto, che serve alla Corte per riferire ad una
scelta volontaria e consapevole del contumace l’omessa possibilità di reagire con una richiesta di
giudizio abbreviato al mutamento dell’accusa, sembra evidentemente presupporre la piena
ammissibilità della modifica, nei confronti del contumace come, a maggiore ragione, dell’imputato
presente (Corte cost., 8 novembre 2006, n. 384, cit.).
Ma veniamo sen’altro alla pronuncia più recente.
Come si accenna nel pezzo che precede, esiste nei casi in esame un problema molto serio, che non
sempre viene colto con nettezza. Quando la contestazione suppletiva concerne un reato aggiuntivo,
si verificano diversi tipi di lesione degli interessi difensivi: quello concernente il nuovo reato, per il
quale il rito non ha potuto mai essere chiesto e mai potrà esserlo; quello concernente il reato di
originaria contestazione: qui la facoltà di accesso è stata oggetto di rinuncia, ma in un contesto
successivamente modificato per effetto delle contestazione suppletiva, con la possibilità che
l’opzione iniziale risulti fortemente inopportuna (ad esempio per la gravità assai maggiore del
nuovo reato). Occorrerebbe allora chiarire – sempre sul presupposto di una “colpa originaria” del
pubblico ministero, e cioè che il quadro delle contestazioni avrebbe potuto essere costruito
correttamente fin dall’avvio del processo – se si discute di lesione del diritto di difesa solo per il
reato aggiuntivo o se si giunge ad ipotizzare una generalizzata rimessione in termini per tutte le
imputazioni. Ipotesi quest’ultima problematica, sia perché concernente una scelta di rinuncia
comunque effettuata dall’interessato, sia perché suscettibile di incidenza sulle dinamiche
fisiologiche del processo (il p.m. potrebbe omettere la contestazione suppletiva proprio per evitare
l’effetto in questione).
Non a caso, in linea generale, le domande di abbreviato per contestazione tardiva riguardano “solo”
il reato posto ad oggetto della contestazione medesima. Ma si introduce, per tal via, un nuovo
problema: quello della definizione del processo con due riti diversi.
Bene, con la citata ordinanza n. 67 del 2008 la Consulta tocca due profili essenziali dell’intricata
questione. Il primo è quello della ammissibilità di richieste parziali di accesso al rito abbreviato. Il
problema è più generale, ed è risolto dalla giurisprudenza in senso negativo (contro il parere forse
prevalente della dottrina). È chiaro però, per tornare al nostro tema, che l’imputato il quale chieda il
rito abbreviato solo per il “nuovo reato” sta effettuando una richiesta parziale. La Corte ne ha preso
atto per dichiarare inammissibile la questione sollevata dal giudice a quo, che non aveva valutato
questo aspetto del problema, e dunque non avrebbe compiutamente dimostrato la rilevanza del
dubbio prospettato. Al di là della questione di procedura riguardante il giudizio incidentale, è chiaro
che la Corte, valorizzando il profilo, ha finito con l’accreditare la tesi della inammissibilità di
richieste parziali di giudizio abbreviato.
Un secondo aspetto di rilievo, questo rimasto implicito, riguarda eventuali future questioni sullo
stesso oggetto: o si dimostrerà alla Corte la piena e credibile sostenibilità dell’assunto per il quale le
richieste parziali sono ammissibili, oppure il problema di legittimità dovrà essere posto a fonte di
una domanda “tardiva” che coinvolga tutte le imputazioni, comprese quelle originarie. E tuttavia,
come si è visto, in questo caso la questione si pone in termini affatto particolari.
Fin qui, per altro, abbiamo discusso della contestazione suppletiva che aggiunga all’imputazione un
nuovo caso di accusa. Quid per il caso che il pubblico ministero, sempre a fronte di elementi già
desumibili all’atto della citazione o del rinvio a giudizio, modifichi l’imputazione preesistente
attraverso la contestazione di nuove circostanze?
Con un provvedimento anche stavolta “nascosto” sotto le vesti dell’inammissibilità manifesta per
ragioni procedurali (inammissibilità per altro evidentissima, dato che l’eccezione è stata formulata
in vista della mera eventualità d’una richiesta di giudizio abbreviato), la Corte sembra aver
anticipato un giudizio molto netto sulla questione.
Per porre ciascuno in condizione di verificare un tale assunto, trascrivo il brano pertinente della
citata ordinanza n. 67 del 2008:
che, pertanto - a prescindere da ogni rilievo riguardo al merito delle censure, e segnatamente quanto
alla validità dell'assunto per cui, in rapporto ad una circostanza aggravante quale la recidiva (basata
sui meri precedenti penali dell'imputato), la mancata tempestiva richiesta del rito alternativo non
comporterebbe la libera assunzione del «rischio» della sua contestazione in dibattimento - la
questione va dichiarata manifestamente inammissibile (con riferimento ad analogo quesito, si veda
l'ordinanza n. 129 del 2003)
11111111111
Una parte cospicua della recente produzione giurisprudenziale della Consulta in materia di processo
penale si riferisce al tema delle prove.
Possiamo iniziare, non foss’altro perché si è risolta in una dichiarazione di parziale illegittimità
costituzionale dell’art. 195 c.p.p., dalla sentenza n. 305 del 2008, Bile, Amirante, molto recente.
Sullo sfondo della decisione c’è la vexata questio della ammissibilità di dichiarazioni testimoniali di
appartenenti alla polizia giudiziaria a proposito di notizie acquisite da persone informate sui fatti
senza le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen.
In verità la questione non era più seriamente discussa, dovendosi escludere, quanto alla deposizione
de relato, un regime più favorevole proprio nei casi in cui l’indagine è segnata da un vizio
originario, cioè l’omessa osservanza delle procedure che la polizia giudiziaria deve seguire quando
assume informazioni sui fatti. In tal senso si sono pronunciate le Sezioni unite della Corte di
Cassazione con la notissima sentenza Torcasio (n. 36747 del 2003), alla quale la giurisprudenza
successiva si è sostanzialmente uniformata, anche se si deve registrare, comprensibilmente, un
dibattito sulle condizioni di fatto che imporrebbero l’adozione delle procedure richiamate. È chiaro,
per fare una ipotesi estrema ma evocativa del concetto, che il divieto di testimonianza non varrebbe
per le circostanze apprese dagli agenti fuori da un contesto investigativo: è corrente l’esempio delle
ultime parole di un soggetto morente, nell’atto in cui viene soccorso dalle forze di polizia, circa
l’identità del proprio assassino.
Perché dunque proprio la Corte di cassazione ha sollevato una questione allo scopo di fare
dichiarare illegittima una “norma” che le stesse Sezioni unite avevano escluso potesse trarsi dal
disposto dell’art. 195 c.p.p.? Perché la Corte si trovava a gestire il ricorso contro una sentenza di
condanna basata sulla testimonianza de relato di agenti della polizia giudiziaria: sentenza che il
giudice di merito era stato “costretto” a pronunciare da una precedente decisione di annullamento
della stessa Cassazione, evidentemente ispirata, in quell’occasione, dall’orientamento poi risultato
soccombente. Come censurare la sentenza di un giudice di rinvio adeguatosi al principio di diritto
stabilito in sede di annullamento da parte del giudice di legittimità? Ma come accettare, per altro
verso, l’eventualità di una condanna irrevocabile fondata su una regola che le stesse Sezioni unite
avevano definito illegittima (tanto da imporre quella opposta in base all’interpretazione
costituzionalmente orientata)?
Non sorprenderà sapere che, a fronte di questa sorta di ingorgo, la Cassazione aveva attaccato anche
l’art. 627 c.p.p., cioè la regola inderogabile di adeguamento al principio di diritto enunciato dalla
Cassazione in sede di annullamento con rinvio. Giustamente la Consulta si è sottratta a questa
logica, ricordando come, per giurisprudenza ormai pacifica, il giudice di rinvio deve applicare la
“norma” enunciata nella sentenza di legittimità, ma proprio per questo può contestarne la legittimità
costituzionale (si vedano, ex plurimis, le sentenze n. 130 del 1993 e n. 78 del 2007, nonché, con
riguardo al giudizio di rinvio in sede civile, per quanto qui interessa avente struttura non dissimile
dal giudizio penale di rinvio, le sentenze n. 138 del 1977 e n. 349 del 2007).
D’altra parte, com’è avvenuto anche di recente, la Corte costituzionale ritiene che il meccanismo
dell’interpretazione adeguatrice (dal quale deriva l’inammissibilità di questione sollevate in base ad
interpretazioni alternative e contrarie a Costituzione) non operi quando, appunto, detta
interpretazione non è possibile, come tipicamente avviene nel giudizio di rinvio.
In questi casi viene sindacata la “norma” che il giudice è chiamato ad applicare, e tale norma, se del
caso, viene dichiarata illegittima. Il meccanismo è quello, non frequentemente applicato ma ben
noto, della sentenza interpretativa di accoglimento.
È proprio quanto avvenuto nella specie. La Corte ha ritenuto che sarebbe «irragionevole e, nel
contempo, indirettamente lesivo del diritto di difesa e dei principi del giusto processo ritenere che la
testimonianza de relato possa essere utilizzata qualora si riferisca a dichiarazioni rese con modalità
non rispettose delle disposizioni degli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen., pur
sussistendo le condizioni per la loro applicazione, mentre non lo sia qualora la dichiarazione sia
stata ritualmente assunta e verbalizzata. Si finirebbe per dare rilievo processuale - anche decisivo come accadrebbe nel caso in esame, ad atti processuali compiuti eludendo obblighi di legge, mentre
sarebbero in parte inutilizzabili quelli posti in essere rispettandoli».
Di qui la decisione che, per precisione ed opportuna documentazione, segnalo citandone
testualmente il dispositivo:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, ove
interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati
a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalità di
cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen., e non anche nel caso in cui, pur
ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate;
Nulla di realmente innovativo dunque, se non il dato, non trascurabile, che il principio di
inammissibilità delle dichiarazioni de relato della polizia giudiziaria non è solo autorevolmente
affermato dai precedenti di legittimità, ma «formalizzato» attraverso l’intervento della sentenza
manipolativa della Corte.
Sempre a proposito della prova dichiarativa, la Corte è ritornata più volte, in tempi recenti, su
un’altra vexata quaestio, quella della rinnovazione nel caso di mutamento della persona fisica del
giudice.
L’art. 525 comma 2 c.p.p., esprimendo una regola di continuità del giudice, espressione del
principio di immediatezza, stabilisce che la sentenza debba essere deliberata, a pena di nullità
assoluta, dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. La ratio consiste, all’evidenza,
nella tutela del criterio di oralità del dibattimento: si vuole che a decidere siano le stesse persone
che hanno assistito all’istruttoria, e per questo, in caso di mutamento della persona fisica del
giudice, si sacrificano (ma solo relativamente) prove che pure sono state assunte pubblicamente e
nel pieno contraddittorio tra le parti.
Naturalmente, la «nuova» istruttoria può comprendere, come la prima, le «letture consentite», che
tra l’altro comprendono gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento. In tale fascicolo, formato
a norma dell’art. 431 c.p.p., si trovano anche i verbali della precedente istruttoria dibattimentale, dei
quali dunque, in prima approssimazione, è possibile dare lettura (il che vuol dire, com’è noto, che
possono essere utilizzati direttamente come prove per la decisione: comma 1 dell’art. 511 c.p.p.).
Tuttavia, per le prove dichiarative, il principio va coordinato con la regola posta dal comma 2
dell’art. 511, il quale, a presidio appunto dell’oralità, dispone che la «lettura dei verbali di
dichiarazioni è disposta solo dopo l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non
abbia luogo». Ciò vuol dire che se l’esame è richiesto, e può avere luogo, la lettura resta «bloccata».
Ecco in particolare quanto stabilito dalle Sezioni unite penali con la sentenza n. 2 del 1999
(massima ufficiale, ric. Iannasso)
Nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice
monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo
giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del
dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti. (Nell'enunciare
il principio di cui in massima, la S.C. ha, peraltro, affermato che allorquando, nel corso del
dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, nessuna delle parti riproponga la
richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, il giudice può di ufficio disporre la
lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite
legittimamente negli atti dibattimentali). (V. Corte Cost. 3 febbraio 1994 n. 17 e Corte Cost., 3
aprile 1996 n. 99).
A determinare il regime concorrono, com’è ovvio, le norme sul diritto alla prova e quelle sul
«recupero» degli atti divenuti irripetibili (art. 512 c.p.p.).
Il fatto che la mera richiesta di una parte possa imporre la ripetizione necessaria dell’escussione è
apparso ad alcuni contrastare con minime esigenze di economia del processo e di conservazione
della prova. Ma la Corte ha ripetutamente stabilito che il sacrificio è giustificato dall’esigenza di
garantire oralità al dibattimento.
È forse opportuno segnalare due equivoci nei quali talvolta si incorre nella pratica. Il primo è che
non si deve per forza rinnovare ogni escussione, anche quella che sia risultata inutile nel «primo»
dibattimento, perché la rinnovazione riguarda anche la fase di ammissione delle prove, e quelle
superflue potranno essere scartate. Non è vero, soprattutto, che la prima prova dichiarativa vada
comunque «dispersa». La lettura non è vietata (come avviene, ex art. 514, per quasi tutte le
dichiarazioni raccolte in fase di indagini e di udienza preliminare), ma va semplicemente
posticipata, il che consentirà al giudice di tenere comunque conto della prima versione del
dichiarante.
La Corte è intervenuta (nuovamente) sul tema con la ordinanza n. 318 del 2008 (Bile, Napolitano)
e, qualche tempo prima, con la ordinanza n. 67 del 2007, Bile, Flick.
Per brevità mi limito a citare la massima ufficiale di tale ultimo provvedimento
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 511, 514 e 525,
comma 2, cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 Cost., nella
parte in cui, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione, non prevedono
che, nel caso di mutamento totale o parziale dell'organo giudicante, le dichiarazioni assunte innanzi
a giudice diverso siano utilizzabili per la decisione mediante lettura a prescindere dal consenso o dal
dissenso delle parti. La disciplina censurata non può, in primis, essere considerata manifestamente
irrazionale ed arbitraria, in quanto deve essere correlata al principio di immediatezza, che postula
l'identità fra il giudice che acquisisce le prove e quello che decide; inoltre, non determina una
lesione del principio di non dispersione dei mezzi di prova, in quanto in nessun caso la prova
dichiarativa precedentemente assunta va dispersa, essendo sempre possibile acquisirla tramite
lettura del relativo verbale, con l'unica differenza che, qualora l'esame del dichiarante sia possibile e
sia stato richiesto, la lettura dovrà seguire tale esame. Deve escludersi, altresì, la violazione sia del
principio di ragionevole durata del processo, che va contemperato, secondo il canone della
ragionevolezza, con il complesso delle altre garanzie costituzionali rilevanti nel processo penale, sia
del principio di eguaglianza, poiché le fattispecie richiamate dai rimettenti non possono essere
utilmente invocate quali tertia comparationis.
La rinnovata ed autorevole conferma che in caso di mutamento del giudice non si determina
inutilizzabilità della prova raccolta, ma mera necessità di lettura secondo le regole dibattimentali,
può semmai consentire qualche riflessione negativa sull’orientamento giurisprudenziale che
vorrebbe il cd. principio di continuità del giudice applicabile anche nel rito abbreviato.
11111111111
Sempre a proposito di prove, non si può trascurare il fondamentale capitolo delle intercettazioni
telefoniche e, in genere, dei rapporti tra indagine penale e riservatezza.
Possiamo partire da un aspetto, per altro, che solo per una certa confusione concettuale – cui forse
non restò estraneo neppure lo stesso legislatore – può essere sovrapposto al tema dei limiti per i
poteri di indagine dell’Autorità e della polizia giudiziaria.
Tutti ricorderanno la vicenda, tuttora attualissima, dei cd. dossier Telecom, cioè della presunta
raccolta illegale di informazioni curata anche da persone collegate alla citata azienda di
telecomunicazioni. Si ricorderà, in particolare, che dopo il sequestro dei presunti dossier il Governo
aveva modificato con decreto legge, poi convertito con rilevantissime varianti, l’art. 240 c.p.p.
L’essenza della nuova disciplina, che secondo l’opinione corrente non riguarda le intercettazioni
condotte per conto dell’Autorità giudiziaria, neppure quando illegittime ed inutilizzabili, consiste
nella previsione di un procedimento dai tempi assai ristretti, finalizzato alla distruzione del
materiale illecitamente raccolto. Si tratta di una scelta per molti versi innovativa, perché la
protezione della riservatezza di chi sia rimasto vittima dell’attività di dossieraggio assume
prevalenza assoluta, e viene assicurata mediante la distruzione immediata e definitiva del materiale
raccolto. Con la conseguenza, però, di distruggere irrevocabilmente la prova a carico dell’autore
della illecita attività di raccolta delle informazioni, e ciò oltretutto in un contesto poco garantito per
la struttura e la velocità del procedimento.
È noto che il gip di Milano (ma non solo), chiamato a fare applicazione della disciplina proprio nel
procedimento “Telecom”, ha sollevato una complessa questione di legittimità costituzionale, in
sostanza censurando l’art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, del codice di procedura penale, nel testo
attualmente vigente per effetto del citato d.l. n. 259 del 2006.
È sospettata di illegittimità, in particolare, la norma che dispone che i supporti recanti dati
illegalmente acquisiti a proposito di comunicazioni telefoniche o telematiche, o informazioni
illegalmente raccolte, vengano distrutti in esito ad una udienza camerale celebrata dal giudice per le
indagini preliminari, e che in proposito venga redatto un verbale ove si dia «atto dell’avvenuta
intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti (…) nonché della modalità e dei
mezzi usati oltre che dei soggetti interessati», e tuttavia venga omesso qualsiasi «riferimento al
contenuto degli stessi documenti, supporti ed atti». Una tale disciplina violerebbe gli art. 24,
secondo comma, e 111, commi primo, secondo e quarto, della Costituzione: la procedura assume
forma camerale, con la partecipazione solo eventuale delle parti, pur trattandosi in sostanza di
predisporre una (per altro inefficace) prova valevole per il dibattimento; inoltre, la distruzione dei
supporti indicati, e la concomitante assenza di riferimenti all’oggetto ed alla natura delle
informazioni illegalmente acquisite nel verbale destinato alla lettura dibattimentale,
pregiudicherebbero il diritto di difesa ed il diritto alla prova del soggetto accusato dell’illecita
raccolta, impedendo la verifica del carattere riservato delle informazioni e, comunque, della loro
acquisizione mediante modalità illecite. Sarebbe ancora violato anche il primo comma dell’art. 24
Cost., poiché la distruzione dei supporti, e la concomitante assenza di riferimenti all’oggetto ed alla
natura delle informazioni illegalmente acquisite nel verbale destinato alla lettura dibattimentale,
pregiudicherebbero il diritto della persona offesa ad agire in diritto per ottenere il risarcimento del
danno subito. Violazione, infine, dell’art. 112 Cost., in quanto la distruzione della prova del reato
connesso all’illecita acquisizione dei dati pregiudicherebbe l’efficace esercizio dell’azione penale in
relazione a tale reato.
La trattazione delle questioni è fissata per il 28 gennaio 2009.
Per quanto (non insolitamente) «dissimulato» sotto le spoglie della dichiarazione di inammissibilità,
un nuovo provvedimento della Corte in materia di riprese audiovisive merita particolare attenzione,
perché accredita e ribadisce, con particolare nettezza, due principi di diritto solo recentemente
stabilizzatisi nella giurisprudenza costituzionale ed ordinaria.
Si tratta della sentenza n. 149 del 2008 (Bile, Flick), pronunciata a fronte della sollecitazione di un
rimettente che chiedeva, in sostanza, una manipolazione additiva dell’art. 266 c.p.p., al fine di
estendere il relativo procedimento di garanzia ai casi di riprese audiovisive in luoghi di privata
dimora, anche quando non si tratti di documentare comunicazioni interpersonali (casi questi nei
quali, specie per effetto dell’ordinanza 135 del 2002, si ritiene invece applicabile la disciplina
fissata per le intercettazioni di comunicazioni).
Partendo dal caso di specie (riprese operate dalla polizia giudiziaria, attraverso una finestra,
mediante telecamere puntate su altra finestra) la Consulta ha chiarito che non ogni attività che si
svolga in un luogo di privata dimora può considerarsi “protetta” dall’art. 14 della Costituzione,
perché tale protezione si smarrisce quando l’attività viene tenuta senza alcuna cautela rispetto
all’osservazione di terzi posti all’esterno (esempio estremo: atti osceni sul balcone di casa). A
partire da questo principio, e poiché il rimettente non aveva precisato che cosa fosse stato ripreso e
dove, la questione è stata dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Il secondo ed ormai pacifico profilo affrontato dalla sentenza è quello dell’attuale disciplina delle
riprese visive nel domicilio privato, a partire dal fatto che il legislatore non ha inteso regolare tale
attività, ed in relazione ovviamente alla riserva di legge posta dall’art. 14 Cost. La tesi che, proprio
per l’assenza di una procedura simile a quella delineata per le intercettazioni, le riprese sarebbero
liberamente effettuabili dalla polizia giudiziaria, senza necessità di un provvedimento autorizzativo,
sembra definitivamente tramontata dopo il contrario assunto delle Sezioni unite penali della
Cassazione (sentenza n. 26795 del 2006, ric. Prisco). In realtà neppure un ipotetico (ed illegittimo)
provvedimento giudiziario potrebbe superare l’impasse dell’assenza di una procedura legale
appositamente dettata per bilanciare inviolabilità del domicilio ed esigenze dell’investigazione. La
Corte, con la sentenza de qua, ha ribadito autorevolmente il concetto.
Ultima, ma non certo per importanza, la sentenza n. 336 del 2008, Flick, Silvestri, che ha dichiarato
la illegittimità costituzionale dell’art. 268 c.p.p., «nella parte in cui non prevede che, dopo la
notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore
possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o
comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se
non depositate».
Il problema, in sintesi, era il seguente. Le richieste cautelari del pubblico ministero possono
fondarsi, notoriamente, anche sulla sola esibizione dei cd. «brogliacci», cioè delle trascrizioni –
letterali o sommarie – che la polizia giudiziaria predispone nel corso delle operazioni di
intercettazione telefonica. Questo assunto è sostanzialmente incontestato in giurisprudenza (anche
se gran parte della dottrina lo avversa). Ben diverso lo stato del dibattito sulla necessità che il
fascicolo cautelare venga predisposto includendo anche i decreti autorizzativi ed i provvedimenti
esecutivi del pubblico ministero, ma la questione non rileva in questa sede.
Normalmente, a maggior ragione quando è intenzionato a sollecitare provvedimenti cautelari, il
pubblico ministero chiede ed ottiene l’autorizzazione prevista dal comma 5 dell’art. 268 c.p.p., cioè
quella a ritardare il deposito degli atti concernenti le intercettazioni. Questa situazione, coniugata al
combinato disposto degli artt. 291 e 293 c.p.p., implica una fattispecie ricorrente: il giudice, e
comunque la difesa dell’indagato, si trovano a ragionare sulle sole trascrizioni di polizia, e la difesa,
in particolare, non può accedere alle registrazioni per verificare se i brogliacci contengano errori o
falsità.
Ora, il ritardato deposito ha un senso fino a quando la divulgazione dell’indagine compiuta, e delle
specifiche informazioni raccolte, può danneggiare lo sviluppo delle investigazioni e vanificare
eventuali iniziative cautelari. Ma queste esigenze vengono meno, se non altro riguardo alle singole
comunicazioni poste a base del provvedimento, quando all’indagato vengono contestate proprio le
risultanze delle intercettazioni, con l’ordinanza cautelare e/o nel corso dell’interrogatorio di
garanzia. Non a caso, nella stesura predisposta dalla Commissione per il nuovo codice, l’art. 268
c.p.p. prevedeva una sorta di revoca automatica dell’autorizzazione a ritardare il deposito in caso di
utilizzazione delle risultanze a fini di prova. Non a caso, molti ed attenti giudici per le indagini
preliminari non assecondano l’uso, purtroppo invalso, di autorizzare il ritardo fino alla fine delle
indagini, ma limitano detta autorizzazione fino al momento in cui lo stesso pubblico ministero non
divulghi il dato investigativo, adottando o richiedendo un provvedimento che ne comporti la
contestazione.
Spesso, per altro, così non accade, e comunque la situazione può essere complicata dal perdurare di
esigenze di segretezza riguardo a specifiche utenze o conversazioni. Inoltre, quand’anche il deposito
segua a stretto giro l’iniziativa cautelare, i tempi della cd. «udienza di stralcio» sono incompatibili
con la necessità di una rapida verifica, tipica della situazione cautelare in atto. Dunque si è posto, ed
è stato posto alla Corte, il problema dell’immediato accesso difensivo alle tracce foniche nel
subprocedimento cautelare, indipendentemente (e dunque prima) della procedura regolata dall’art.
268 c.p.p.
Il caso che ha occasionato la pronuncia è presto descritto: catturato a seguito della intercettazione di
alcune conversazioni, rappresentate al giudice mediante i soli brogliacci, l’indagato sosteneva che il
senso delle sue comunicazioni fosse stato travisato; il difensore si era rivolto al P.M. per accedere
alle registrazioni – solo quelle delle conversazioni contestate – ed ottenerne copia; il pubblico
ministero aveva replicato che la copia sarebbe suscettibile di rilascio solo in esito alla procedura
regolata dall’art. 268 c.p.p., nella specie non avviata.
Il rimettente è partito dal presupposto che, secondo la legislazione vigente, la difesa dell’indagato
non avesse diritto alla copia, sebbene le conversazioni contestate non fossero più segrete, in
applicazione della regola generale di cui all’art. 116 c.p.p. La Consulta ha in sostanza accreditato
tale presupposto (anche se sembra aver prevalso soprattutto l’esigenza di negare ogni discrezionalità
nel rilascio della copia e di assicurare l’ovvia esigenza difensiva a prescindere da una adesione a
singole opzioni interpretative sulla legislazione vigente).
Ciò premesso, è chiaro che l’interesse difensivo non poteva e non può ragionevolmente soccombere
di fronte ad una esigenza di riservatezza che non esiste più, e non esiste più perché proprio il p.m.
l’ha superata, e perché il giudice, tra l’altro, ha valutato la conversazione utilizzabile e rilevante al
punto da inserirla nel quadro indiziario descritto con la motivazione dell’ordinanza. La disciplina,
così come ricostruita, assicurava al p.m. l’assurdo privilegio di «nascondere» una prova della quale
lo stesso pubblico ministero, o meglio la polizia giudiziaria, predispone una rappresentazione
mediata, fuori da ogni contraddittorio.
Resta solo da porre in chiara evidenza che la Corte non ha introdotto una nuova fattispecie di
deposito, semplicemente stabilendo che, quando la difesa ne faccia richiesta, le tracce foniche delle
conversazioni utilizzate contro l’indagato siano messe a disposizione della difesa medesima,
mediante il rilascio di copia.
Fermo restando che la pronuncia e la situazione che ne scaturisce andranno studiate con cura,
sembra di poter dire che la fattispecie esula dalla dinamica regolata dagli artt. 293, 294 e 302 c.p.p.
In particolare parrebbe azzardato prospettare una successione necessaria tra rilascio della copia l'obbligo del quale scaturisce solo dalla espressa e puntuale richiesta del difensore - e
l'interrogatorio di garanzia. Sia le sezioni unite (sentenza Vitale del 2005) che la stessa Consulta
(sentenza n. 192 del 1997) hanno chiarito che l'esistenza del diritto alla copia non può implicare
dilazione dei termini di garanzia fissati dalla legge e che dunque il previo rilascio non può
condizionare la validità degli adempimenti imposti dalla legge. Certo, quei rilievi riguardavano atti
comunque depositati, ma sembra conservino la loro validità, almeno in un regime di ripetibilità ad
libitum dei controlli sulla legittimità della restrizione cautelare. L'effettività della garanzia non resta
poi rimessa, mi pare, alla sola buona volontà del PM: il rilascio costituisce dovere deontologico e
disciplinare.
11111111111
Sempre a proposito di prove, è stata trattata nella camera di consiglio del 19 novembre scorso una
importante questione circa la legittimità costituzionale dell’art. 238-bis c.p.p., cioè della norma che
consente la acquisizione di sentenze irrevocabili a fini di prova dei fatti in esse valutati.
L’importanza della norma, introdotta d’urgenza dopo le stragi siciliane del 1992 e non intaccata
dalla legge 63 del 2001, è fin troppo nota per essere commentata.
Il Tribunale di Pinerolo ha ritenuto di porne in discussione la legittimità con riferimento,
essenzialmente, al quarto comma dell’art. 111 Cost., e dunque in relazione al principio del
contraddittorio quale metodo di formazione della prova nel dibattimento.
Mi limito ad enunciare i termini della questione, non essendo stata ancora pubblicata la decisione
eventualmente assunta in proposito dalla Consulta.
11111111111
A proposito di misure cautelari può segnalarsi un provvedimento relativamente interessante in
merito al cd. interrogatorio di garanzia, come prescritto dall’art. 294 c.p.p., con la collegata
sanzione di inefficacia del successivo art. 302.
Il Tribunale del riesame di Napoli aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 294 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'interrogatorio di garanzia della persona
sottoposta ad aggravamento della misura cautelare, ai sensi del precedente art. 276, comma 1, nella
fase compresa tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l'inizio del giudizio di appello.
Il ragionamento del Tribunale presupponeva che l’interrogatorio di garanzia sia necessario quando
si sostituisce una misura, con un’altra più grave, per la violazione delle prescrizioni inerenti alla
misura originaria: questione controversa all’epoca dell’ordinanza di rimessione. Il ragionamento
presupponeva anche che l’interrogatorio di garanzia non sia dovuto, in linea generale, quando siano
state chiuse le formalità di apertura del dibattimento di primo grado.
La Corte – con la ordinanza n. 267 del 2008 (Bile, Silvestri) – non ha inteso impegnarsi sul primo
presupposto, e dunque non ha sostenuto né contestato che l’aggravamento della misura debba essere
seguito dall’interrogatorio. Ha invece confermato che, in tutti i casi in cui è prescritto,
l’interrogatorio è comunque dovuto solo prima delle formalità di apertura del dibattimento di primo
grado. Quindi, quando l’aggravamento è successivo, non è comunque dovuto.
Tale disciplina – come già la Corte aveva detto con l’ordinanza 230 del 2005 - non è illegittima,
perché l’interessato gode comunque dei rimedi impugnatori, e d’altra parte la norma si basa «sul
particolare significato della dichiarazione di apertura del dibattimento, quale momento di inizio
effettivo del giudizio di merito, a partire dal quale, «proprio in virtù di quella fisiologica coesistenza
e assorbimento delle funzioni cautelari in quelle di merito - nel che sta quel valore di "immanenza"
richiamato dalla sentenza n. 32 del 1999 -, si realizza appieno il costante controllo sulla
indispensabilità del permanere della misura, che l'interrogatorio [...] dovrebbe - per sé solo –
assicurare”»
Non può non aggiungersi che in tempi recentissimi le Sezioni unite penali della Corte di cassazione
hanno risolto la controversa questione che il rimettente aveva risolto postulando la necessità
dell’interrogatorio di garanzia in caso di aggravamento della misura cautelare.
Si tratta di una decisione non ancora depositata, assunta il 18 dicembre 2008 nel procedimento a
carico di Giannone Maria. Nel sito ufficiale della Corte (www.cortedicassazione.it) possono
leggersi il quesito e la soluzione adottata
Questione: Se, a seguito della sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere, per
la trasgressione dell’obbligo di non allontanarsi dal luogo di custodia, si debba provvedere
all’interrogatorio nei termini stabiliti dalla legge, a decorrere dall’inizio dell’esecuzione della nuova
misura.
Soluzione: Negativa. La Corte ha precisato che il giudice non ha l’obbligo di procedere
all’interrogatorio dell’imputato in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 276 c.p.p..
Per parziale comunanza di tema può essere segnalata in questa sede anche una importante decisione
in materia di obbligatorietà dell’arresto per quanto concerne lo straniero indebitamente trattenutosi
nel territorio dello stato (reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del T.U. in materia di immigrazione).
Si tratta della sentenza n. 236 del 2008 (Bile, Silvestri), che ha dichiarato infondata la questione di
legittimità della norma che prescrive obbligatoriamente, invece che quale mera facoltà della polizia
giudiziaria, l’arresto dello straniero responsabile dell’indebito trattenimento.
La Corte ha rilevato, richiamando i principi della legge delega, che l’obbligatorietà dell’arresto può
essere disposta in base a due criteri essenziali. Il primo ha natura quantitativa e si basa sulla gravità
del reato, quale risulta dalle pene edittali, minima e massima, previste. Il secondo ha natura
qualitativa e si basa su «speciali esigenze di tutela della collettività».
Al primo criterio si informa l'art. 380, comma 1, del codice di procedura penale, che prevede
l'arresto obbligatorio in flagranza per reati puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a
cinque anni e nel massimo a venti anni. Al secondo criterio si informa il comma 2 dello stesso
articolo, che contempla, accanto ai reati consumati, anche quelli tentati, per i quali, ai sensi dell'art.
56 del codice penale, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.
Nel secondo dei casi considerati, i valori di pena possono essere anche relativamente bassi, e non
sono quindi gli stessi a giustificare la misura, «ma le particolari esigenze di tutela della collettività,
che vengono apprezzate dal legislatore in rapporto ad una serie molteplice di elementi, storicamente
mutevoli e frutto di scelte di politica criminale non censurabili in sede di controllo di legittimità
costituzionale delle leggi, a meno che non si tratti di opzioni manifestamente irragionevoli».
La manifesta irragionevolezza può essere rilevata o a seguito di confronto con tertia comparationis
omogenei o in esito alla constatazione di una contraddizione intrinseca della norma censurata.
Nel caso che ci interessa manca una siffatta contraddizione (nel 2004 l’arresto fu dichiarato
illegittimo perché non era poi consentita l’applicazione di una misura cautelare, ma, com’è noto, i
valori edittali di pena per l’indebito trattenimento sono poi stati elevati proprio per consentire la
restrizione cautelare).
D’altra parte le pene previste per l’indebito trattenimento, come appena si è detto, sono del tutto
assimilabili ad alcune altre fattispecie regolate dall’art. 380 comma 2 c.p.p. (ad esempio furto con
strappo).
La Corte ha ribadito «l'insufficienza delle censure di legittimità costituzionale basate su “una
comparazione tra norme concernenti misure cautelari, condotta sul solo piano dell'offensività
piuttosto che su quello, più ampio, delle complessive esigenze che possono essere assicurate
attraverso le misure in questione» (sentenza n. 22 del 2007)”».
Piaccia o meno, dice in sostanza la Corte, ai reati connessi all’immigrazione viene collegato un
allarme rilevante, per una scelta politica che non può essere sindacata fuori del caso di manifesta
irrazionalità.
Sempre a proposito di norme processuali concernenti l’immigrazione, va segnalata l’ennesima
pronuncia di inammissibilità che la Corte ha deliberato riguardo ad un fenomeno che per brevità,
nelle relative discussioni, viene talvolta definito «automatismo espulsivo». Si tratta in particolare
della ordinanza n. 417 del 2008, Flick, Silvestri.
La questione, che è complessa e richiederebbe una trattazione dedicata, è stata proposta spesso,
sempre con esito di inammissibilità: sembra che i magistrati rimettenti fatichino ad individuarne le
condizioni di rilevanza, e comunque, forse anche per questo, stentino ad elaborare una esposizione
completa e convincente in punto di rilevanza.
Il problema è noto. L’art. 13 del T.u. imm. regola l’espulsione dello straniero che non abbia titolo a
restare nel territorio dello Stato, e cerca di realizzare un coordinamento tra le relative previsioni e le
esigenze connesse alla pendenza di un procedimento penale nei confronti dello straniero medesimo.
Per comodità e precisione, trascrivo le norme più spesso denunciate, cioè i commi 3 e 3-bis del
citato art. 13:
3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se
sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di
eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza
di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della
persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità
giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta,
provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In
attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del
trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della
convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391,
comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta
può essere negato ai sensi del comma 3.
Come si vede, l’unica esigenza che riceve effettiva garanzia è quella connessa all’utilità della
presenza dello straniero per la prova di reati concernenti terzi: una figura per così dire di
collaboratore degli inquirenti. Non ha invece rilevanza il diritto di partecipazione dell’interessato al
procedimento che lo riguarda – salvo il caso della sua custodia in carcere – e si pone quindi un
evidentissimo problema di concreta attuazione del diritto di difesa. Il giudice non può negare il
nulla osta per assicurare allo straniero la possibilità di partecipare al suo processo. E bisogna dire
che la scelta legislativa – sia o meno tollerabile dal punto di vista costituzionale – è inequivoca e
comprensibile: il diritto di difesa non è un accessorio eventuale del processo, e deve essere sempre
garantito; se la legge contemplasse la possibilità di negare il nulla osta per la sua attuazione, ebbene
il nulla osta dovrebbe essere sempre negato, non essendo concepibile una regolazione discrezionale
da parte del giudice circa il diritto di partecipazione al processo dell’imputato; tuttavia va detto con
chiarezza che la meccanica trasformazione della pendenza di un processo in «titolo» per il rinvio
dell’espulsione sarebbe una scelta strategica dell’ordinamento, pertinente per sua natura alla
valutazione legislativa.
La crisi del sistema è particolarmente evidente nei casi di giudizio direttissimo, che poi sono la
maggioranza, almeno quando si discute della violazione delle leggi penali concernenti
l’immigrazione.
Lo straniero è obbligatoriamente arrestato e presentato al giudice del direttissimo tanto per la
convalida che per la celebrazione del giudizio di merito. Proprio in occasione della convalida, come
si è visto, il giudice è tenuto al rilascio del nulla osta all’espulsione amministrativa. Ove venga
applicata una misura restrittiva, o nel caso che l’imputato consenta alla immediata celebrazione del
giudizio, non si pongono problemi particolari, almeno quanto al procedimento di primo grado, dato
che la posticipazione dell’espulsione è assicurata almeno in via di fatto. Ma il problema esiste
proprio nella maggior parte dei casi, e cioè quando il giudice dispone la liberazione dell’interessato
e questi chiede la concessione del termine a difesa: qui le probabilità che lo straniero venga espulso
prima della celebrazione del giudizio sono elevatissime. E d’altra parte – pur volendo tacere delle
relative difficoltà organizzative ed economiche – il meccanismo «inventato» dal legislatore con
l’art. 17 del T.u., e cioè lo speciale permesso di rientro per ragioni di giustizia, è palesemente
inadeguato proprio a fronte dei ritmi di definizione del giudizio direttissimo. È appena il caso di
aggiungere che lo strumento della sentenza di non luogo a procedere è inutilizzabile per il caso del
giudizio direttissimo (almeno secondo l’opinione ampiamente prevalente), e che la disciplina crea
ulteriori spazi di irrazionalità, connettendo all’espulsione un effetto «liberatorio» per reati anche
gravi, ed escludendo quello stesso effetto per reati che sembrerebbero ragionevolmente meno
significativi.
Questo essendo il problema, resta da dire della giurisprudenza della Corte. Non è possibile in questa
sede una ricostruzione del quadro dei precedenti, che pure rivestirebbe grande interesse. Può dirsi in
termini generali, ad esempio, come molti rimettenti dimentichino che il loro silenzio conduce alla
formazione di un provvedimento autorizzativo dell’espulsione (effetto che comunque sarebbe
precluso da una sospensione formale del relativo subprocedimento). Si riceve spesso, per altro
verso, una sensazione di astrattezza nell’approccio alla questione. Talvolta ci si dimentica finanche
di precisare che l’imputato non è ricomparso all’udienza di rinvio, si tace sulle prospettazioni
difensive, si presume una connessione tra rilascio del nulla osta ed assenza – una assenza futura ed
ipotetica, sulla cui dipendenza da un impedimento non si è forse riflettuto abbastanza – che
rappresenta uno dei nodi critici della questione (mai risulta – anche se la questione è sollevata dopo
il rilascio del nulla osta – se l’espulsione amministrativa abbia poi avuto luogo, ecc.).
Paradigmatico il caso di specie, ove il giudizio a quo si è svolto a tre anni dalla convalida
dell’arresto con contestuale liberazione dello straniero, dopo un rinvio a nuovo ruolo, ed ove il
rimettente ha trascurato di riferire non solo e non tanto se l’imputato fosse assente (il che forse
potrebbe darsi per implicito), ma finanche se e come fosse stato instaurato nuovamente il
contraddittorio, e quindi come fosse stato nuovamente citato l’imputato, che cosa avesse prospettato
la sua difesa di fiducia, ecc.. Insomma, la Corte non è stata messa in grado di comprendere se e
perché il rilascio del nulla osta avrebbe implicato il preteso vulnus al diritto di partecipazione
dell’interessato. Inoltre, e sia pure in un contesto particolare, la Corte ha rilevato anche la tardività
della questione, essendo maturati nella specie in termini per il silenzio-assenso alla espulsione.
11111111111
Ancora sul terreno delle misure cautelari, va segnalato un importante e per altro non sorprendente
intervento della Corte sul tema della durata massima della custodia cautelare. Il problema
riguardava, in particolare, il rilievo del periodo di detenzione patito all’estero nell’ambito della
procedura cd del mandato di arresto europeo. La Consulta è intervenuta sull’argomento, con
pronuncia di illegittimità costituzionale, mediante la sentenza n. 143 del 2008, Bile, Flick.
L’art. 33 della legge introduttiva dell’istituto (n. 69 del 2005) prevedeva che il periodo di custodia
cautelare sofferto all’estero, in esecuzione del mandato di arresto europeo, fosse computato (solo) ai
sensi e per gli effetti dell’art. 303, comma 4, vale a dire ai soli fini del computo della durata
complessiva della custodia cautelare, e non anche agli effetti della durata dei c.d. “termini di fase”
della custodia stessa. Ciò in quanto, come appena si è visto, la norma non richiama anche i commi
1, 2 e 3 del citato art. 303 cod. proc. pen.
Conviene dire subito che questa regola era la stessa che caratterizzava la disciplina dell’estradizione
attiva, in quanto l’art. 722 c.p.p. espressamente limitava il computo della custodia all’estero «ai soli
effetti della durata complessiva stabilita dall’art. 303, comma 4».
Sennonché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 253 del 2004, aveva dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 722 c.p.p., proprio nella parte in cui non prevedeva che la custodia cautelare
subita all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato venisse
computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall’art. 303, ai commi 1, 2 e 3.
Insomma, con la norma censurata, pur approvata (poco) dopo la sentenza, il legislatore aveva
emulato la norma concernente la procedura “parallela” dell’estradizione, senza tener conto che
quest’ultima contrastava con la Costituzione. Violando, per altro, la Costituzione sotto un nuovo e
diverso profilo, non essendo ragionevole il peggior trattamento riservato a chi venga «catturato» in
base alla nuova procedura rispetto a colui che viene perseguito attraverso la tradizionale procedura
estradizionale.
In effetti la Corte, con la sentenza citata, aveva già affermato il principio della equivalenza tra
detenzione cautelare all’estero in attesa di estradizione e custodia cautelare in Italia. Alla luce di
detta equivalenza − si disse allora − «evidenti motivi di razionalità e coerenza interna di sistema
impongono di applicare alla custodia cautelare all’estero la medesima disciplina prevista per la
durata dei termini di custodia cautelare in Italia»: dunque, di applicare, all’ipotesi di custodia
cautelare all’estero in attesa di estradizione, l’intero complesso normativo relativo ai termini di
custodia cautelare, ivi compresa la disciplina dei c.d. “termini di fase”, previsti dall’art. 303, commi
1, 2, e 3 c.p.p., costituente asse portante del relativo reticolo di garanzie.
È ovvio che gli stessi principi dovessero investire la disciplina del mae, ed anzi che la soluzione si
imponesse a maggior ragione, dato che la procedura, a differenza dell’estradizione, non mette in
gioco alcun rapporto intergovernativo, ma si fonda su rapporti diretti tra le varie autorità
giurisdizionali dei Paesi membri, con l'introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna
delle persone condannate o sospettate. Ciò rende ancor più intollerabile un aggravio o un
allungamento dei tempi di consegna e disarmonica la conseguente obliterazione delle garanzie in
tema di carcerazione preventiva.
Dunque la Corte ha dichiarato « l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 22 aprile 2005,
n. 69 (….) nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero, in esecuzione del
mandato d'arresto europeo, sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti
dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale».
Sempre a proposito della custodia cautelare, va ora evocato il tema della riparazione per ingiusta
detenzione¸ cui si riferisce una importante sentenza, dichiarativa della parziale illegittimità
costituzionale dell’art. 314 c.p.p..
Il tema sul tappeto era quello, in sostanza, della «risarcibilità» del danno derivante dalla
sperimentazione della custodia cautelare per un tempo eccedente la pena inflitta con la sentenza di
condanna. È noto come il rimedio della riparazione operi essenzialmente in caso di assoluzione
(commi 1 e 3 della norma citata). L’ingiusta detenzione, per il caso di condanna, rileva in sostanza
solo quando il provvedimento restrittivo sia stato assunto illegittimamente (comma 2). E non è
questo il caso, naturalmente, della custodia legittimamente instaurata, e poi protratta per un tempo
superiore a quello che, in fine del processo, e per effetto dei fattori più vari, segna la durata della
pena detentiva inflitta.
Va subito aggiunto che il caso considerato nel giudizio a quo, pendente addirittura innanzi alle
Sezioni unite della Cassazione, non corrisponde pienamente alla semplice situazione appena
delineata. Nella specie, un soggetto era stato condannato con sentenza non irrevocabile, e da lui solo
impugnata, ad una pena più breve della custodia patita. Nel giudizio di gravame, che non avrebbe
potuto concludersi con una condanna ad una pena più alta per il divieto di reformatio in peius, è
sopravvenuta l’estinzione del reato. Di conseguenza l’interessato è stato assolto, ma non con le
formule indicate al comma 1 dell’art. 314 c.p.p. Di qui l’interesse ad un ragionamento ipotetico: se
anche il ricorrente fosse stato condannato, ciò sarebbe avvenuto con riguardo ad una pena più bassa
della custodia, la quale dunque, nella parte in eccedenza, sarebbe stata comunque scontata
ingiustamente. In un certo senso, ed appunto, viene evocato il caso della condanna da cui derivi
l’eccedenza di una porzione della custodia patita. Da notare, per completezza di informazione, che
la fattispecie concreta è ancor più complicata, ma sembra di poter dire che la questione, ridotta
all’osso, fosse quella fin qui indicata.
Le Sezioni unite hanno ritenuto che, nella fattispecie concreta, il diritto alla riparazione non potesse
essere riconosciuto, e che ciò per altro contrastasse con gli artt. 2, 3, 13 (quest'ultimo evocato solo
nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione), 24, 76 e 77 della Costituzione.
La Consulta, dopo un giudizio non del tutto agevole di rilevanza della questione sollevata, e dopo
aver «fissato» la questione medesima nel senso della compatibilità costituzionale della regola di non
riparabilità delle detenzione in caso di sentenza diversa dall’assoluzione nel merito, ha parzialmente
accolto il ragionamento del rimettente. Si tratta della sentenza n. 219 del 2008, Bile, De Siervo,
provvedimento di notevole complessità, alla cui lettura necessariamente deve rinviarsi in questa
sede.
In estrema sintesi, può dirsi che la Corte, attraverso un elaborato complesso di richiami alle fonti (in
testa l’ultimo comma dell’art. 24 Cost.) ed ai propri precedenti, ha stabilito che il vulnus al bene
della libertà personale deve essere «socialmente» compensato anche quando non sia stato inferto
illegittimamente o per errore. Tuttavia, l'art. 314 cod. proc. pen. condiziona espressamente il
rimedio alla circostanza per cui, all'esito del giudizio, l'imputato sia stato prosciolto nel merito.
La scelta legislativa è apparsa manifestamente irragionevole, e pertanto lesiva dell'art. 3 della
Costituzione.
Non è infatti costituzionalmente ammissibile, sotto tale profilo, che l'incidenza che la custodia
cautelare ha esercitato sul bene inviolabile della libertà personale dell'individuo, nella fase anteriore
alla sentenza definitiva, possa venire apprezzata con esclusivo riferimento all'esito del processo
penale, e per il solo caso di assoluzione nel merito dalle imputazioni. Se, infatti, un sacrificio della
libertà personale vi è stato durante la fase della custodia cautelare, il meccanismo solidaristico della
riparazione non può che attivarsi anche per tale caso, quale che sia stato l'esito del giudizio, e
pertanto anche ove sia mancato il proscioglimento nel merito. È, per tale ragione, palesemente privo
di ragionevolezza che il legislatore pretenda di apprezzare la ricorrenza delle condizioni necessarie
ai fini della riparazione alla luce dell'esito della vicenda processuale concernente il merito
dell'imputazione, e non già della sola lesione verificatasi durante l'applicazione della misura
custodiale. Per apprezzare quest'ultima, non è poi certamente possibile limitarsi a constatare la
legalità del procedimento di applicazione della misura cautelare: invero, le guarentigie attorno alle
quali si deve costituire il nucleo irriducibile dell'inviolabilità del diritto apparirebbero ben misero
presidio, se esse fossero soddisfatte dalla mera osservanza della riserva di legge e della riserva di
giurisdizione contenute nell'art. 13 della Costituzione, senza accompagnarsi all'imposizione di un
fine costituzionalmente tracciato che le giustifichi sostanzialmente, per la parte in cui esse si
rendono strettamente e necessariamente strumentali al suo perseguimento.
Secondo la Corte, ove la durata della custodia abbia ecceduto la pena successivamente irrogata in
via definitiva, l'ordinamento, al fine di perseguire le finalità assicurate mediante il trattamento
cautelare, ha imposto al reo un sacrificio direttamente incidente sulla libertà che, per quanto
giustificato alla luce delle prime, ne travalica il grado di responsabilità personale.
Insomma, e per banalizzare: la previsione di forme cautelari di restrizione della libertà è una
necessità sociale che impone costi individuali quando non trova riscontro nell’accertata
meritevolezza di una pena detentiva corrispondente od eccedente, costi che dunque vanno assunti
dall’intera società, nella forma risarcitoria della riparazione.
Naturalmente la Corte si è resa conto dei potenziali effetti dilaganti del principio enunciato, essendo
di istintiva percezione il dato che non può essere oggetto di riparazione ogni differenza negativa –
per qualunque ragione indotta – tra la pena eseguibile e la durata della custodia. L’eventualità che
immediatamente si concepisce è quella, ad esempio, della prescrizione del reato o della stessa pena.
Ecco allora la brusca «frenata» in chiusura della sentenza, che alcuni hanno già stimato incongrua
rispetto alle premesse.
L'art. 314 cod. proc. pen. deve essere pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella
parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa
riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. Naturalmente, una volta sancito il
diritto alla riparazione, la quantificazione dell'indennizzo verrà compiuta dal giudice, nelle forme e
secondo i criteri allo stato vigenti (…).
Naturalmente, la presente decisione non osta a che il legislatore, nell'esercizio della propria
discrezionalità, possa in futuro revisionare l'istituto della riparazione nel rispetto delle fondamentali
esigenze di tutela del valore primario della libertà personale dell'individuo.
Questa sentenza, infatti, ha per oggetto – secondo quanto già osservato al punto 4 – la sola
ipotesi, rilevante ai fini del giudizio a quo, in cui la pena definitivamente inflitta all'imputato,
ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di
giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto.
Resta pertanto escluso il riconoscimento dell'indennizzo in fattispecie nelle quali la mancata
corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita o eseguibile – se diversa da quella inflitta –
consegua a vicende posteriori, connesse al reato o alla pena. In tali casi, infatti, si produce una
situazione affatto diversa rispetto a quella che induce questa Corte a dichiarare l'illegittimità
costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen.
Non sembra in caso che lo stesso dispositivo della sentenza risenta della volontà (e, forse, della
difficoltà) della Corte di delimitare la portata dell’intervento additivo: la illegittimità costituzionale
dell'art. 314 del codice di procedura penale, è stata infatti dichiarata nella parte in cui, nell'ipotesi di
detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al
proscioglimento nel merito dalle imputazioni, secondo quanto precisato in motivazione.
11111111111
Una breve citazione per la sentenza n. 310 del 2008, Bile, Saulle, dato che interessa
prevalentemente i giudici minorili.
La Cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 701 e 704 del codice
di procedura penale, nella parte in cui attribuiscono «alla Corte di Appello, e non alla "Sezione di
Corte di Appello per i minorenni" la competenza a decidere sulla estradizione di soggetti minorenni
all'epoca dei fatti per i quali l'estradizione è richiesta». In sostanza, si riteneva che le norme
censurate facessero una ingiustificabile deroga, in materia di estradizione passiva, alla regola
generalizzata di competenza del giudice minorile per i soggetti minori d’età.
La Corte ha dichiarato infondata la questione, in ragione della erroneità del presupposto
interpretativo.
L'art. 18 del d.P.R. n. 449 del 1988, modificando l'art. 58 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario), nel disciplinare le funzioni della Corte di appello prevede che,
nell'ambito della stessa, la sezione per i minorenni «giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti
del tribunale per i minorenni. Ad essa sono altresì demandate le altre funzioni della corte di appello
previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni».
In ragione di tale previsione, le disposizioni censurate, nel riferirsi esplicitamente alla Corte di
appello quale organo competente in materia di estradizione, devono essere interpretate nel senso
che, se il relativo procedimento riguarda un minore, la competenza di decidere è devoluta alla
relativa sezione per i minorenni
11111111111
Rapidamente su una questione che interessa, questa volta, i soli giudici di pace, e per altro viene
posta con notevole frequenza. Riguarda il procedimento su ricorso immediato della persona offesa,
nella particolare ipotesi in cui il pubblico ministero ritenga il ricorso inammissibile o l’accusa
infondata. Stando agli artt. 25 e seguenti del d. lgs. n. 274/00, il giudice che ritenga invece
ammissibile e fondata la richiesta della persona offesa procede senz’altro alla fissazione
dell’udienza. C’è però il problema dell’imputazione, visto che, stando sempre alla lettera della
legge, il pubblico ministero è tenuto a formularla solo quando ritenga ammissibile e fondato il
ricorso della vittima. Di qui i tentativi di vari giudici di pace affinché la Consulta, con una sentenza
manipolativa, colmasse questo evidente “buco” del sistema.
La soluzione più ricorrente è stata quella della sollecitazione di una sentenza additiva, relativamente
all’art. 25, nella parte in cui non impone la formulazione dell’imputazione, a cura del p.m., anche
quando trasmette il ricorso con parere di inammissibilità o comunque contrario alla citazione.
Ma la Corte ha rifiutato la sollecitazione. Con l’ordinanza n. 361 del 2005 ha dichiarato
manifestamente inammissibile una questione assimilabile a quella appena evocata: «il giudice non
tiene nel debito conto che (...) la disciplina generale dell’imputazione coatta potrebbe trovare
applicazione anche nel caso in cui il giudice, dopo aver trasmesso gli atti al pubblico ministero,
ritenga di non condividere una eventuale richiesta di archiviazione; pertanto, prima di affermare che
non sarebbe possibile altra soluzione conforme a Costituzione diversa da quella prospettata in via
additiva, il rimettente avrebbe dovuto utilizzare tutti i poteri interpretativi che la legge gli
riconosce».
In sostanza, il giudice che registra il parere contrario del p.m. sul ricorso immediato, invece di
provvedere come la legge sembra richiedergli (cioè spedire la citazione «trascrivendo
l’imputazione»), potrà restituire gli atti allo stesso p.m. La Procura, se orientata negativamente
anche sul fondamento della notitia criminis, provvederà a formulare la necessaria richiesta di
archiviazione. A questo punto il giudice potrà reagire, come sopra si accennava, con l’ordine di
formulare l’imputazione.
Con ordinanza n. 43 del 2007 la Corte ha ripetuto la declaratoria d’inammissibilità per omessa
sperimentazione dell’interpretazione costituzionalmente orientata, richiamandosi all’orientamento
ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, favorevole alla restituzione degli atti al
pubblico ministero che ha espresso il parere contrario.
Il concetto è stato ribadito, da ultimo, con l’ordinanza n. 114 del 2008, Bile, Tesauro, che segnalo
perché relativa ad un provvedimento relativamente argomentato del rimettente, che presupponeva la
lettura delle precedenti ordinanze della Corte. Nondimeno, la questione è stata ritenuta
manifestamente infondata, a definitiva chiusura – credo – di ogni prospettiva “costituzionale” di
superamento di quella che comunque, è una inutile complicazione scaturita dalla disattenzione del
legislatore. Sull’argomento si veda anche la ordinanza n. 321 del 2008, Bile, Tesauro, ove tra l’altro
si ricorda, come in altre occasioni, che il ricorso della persona offesa produce l’effetto della querela
anche nel caso, qui esaminato, di restituzione degli atti al pubblico ministero.
11111111111
Un’ultima segnalazione riguarda la fase esecutiva, ed in particolare i presupposti per la conversione
della libertà controllata in pena detentiva. Il Tribunale di sorveglianza aveva eccepito circa la
legittimità dell'art. 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), sul presupposto che la conversione non sarebbe consentita se non quando si accertino
ripetute violazioni delle prescrizioni impartite con il provvedimento di conversione.
Con la ordinanza 397 del 2008, Flick, Napolitano, la Corte ha smentito un tale presupposto
interpretativo (nato da un equivoco nella lettura delle giurisprudenza di legittimità che consente un
ridotto impegno motivazionale nella adozione di provvedimenti conseguenti a violazioni ripetute
delle prescrizioni). Basta dunque una sola violazione, fermo restando che la conversione deve
intervenire di fronte al conclamato fallimento dello «esperimento» fondato sulla libertà controllata:
«pertanto, allorché si è in presenza della violazione di almeno una delle prescrizioni tipiche
impartite con il provvedimento di applicazione della libertà controllata, il giudice potrà comunque
procedere alla conversione, valorizzando o la gravità oggettiva del comportamento violativo della
prescrizione ovvero altre circostanze sintomatiche di una mancata volontà di reinserimento del
condannato, come, ad esempio, l'assidua frequentazione di pregiudicati».
Questione dunque manifestamente infondata.
Sempre in tema di esecuzione, una ulteriore pronuncia di manifesta infondatezza: la ordinanza 446
del 2008, Flick, Silvestri. Il rimettente lamentava il fatto che il magistrato di sorveglianza, a fronte
della domanda di affidamento in prova al servizio sociale del detenuto in stato di esecuzione della
pena detentiva, non può applicare provvisoriamente la misura, come avviene per altri istituti (quali
la detenzione domiciliare o l’affidamento per finalità terapeutiche e di recupero), nell’attesa della
deliberazione del tribunale. È vero che il magistrato può ordinare la sospensione della esecuzione,
ma ciò sarebbe causa di ulteriore irrazionalità, consentendosi al singolo magistrato una decisione
ancor più impegnativa dell’applicazione provvisoria (cioè la completa liberazione dell’interessato),
e nel contempo imponendosi una interruzione del percorso rieducativo del condannato, che d’altra
parte, in caso di rigetto della sua istanza, dovrebbe rientrare il carcere scontando l’intera pena
residua.
La Corte ha ritenuto che la discrezionalità legislativa non sia stata esercitata in modo
manifestamente irragionevole. I casi evocati in termini comparativi dal rimettente sono segnati da
una peculiare urgenza dell’applicazione del regime connesso alla misura alternativa; la liberazione
dell’interessato è subordinata ad una prognosi favorevole sull’applicazione della misura e quindi ad
un giudizio di ridotta pericolosità; non sarebbe logico, d’altra parte, che un periodo trascorso in
completa libertà, nell’attesa di una deliberazione del tribunale poi risolta in senso negativo,
costituisse il presupposto di uno «scomputo» rispetto alla pena residua che deve essere eseguita.
Roma – Torino, 19 gennaio 2009
Guglielmo Leo
-------------------------------------------------------------------------------[1] Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20633 del 21/02/2008 (dep. 22/05/2008), Rojas, Rv. 239987: «Il
positivo accertamento, in una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, di una violazione
delle regole del giusto processo sancite dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
non comporta, di per sé, in assenza di un riconosciuto diritto del condannato alla rinnovazione del
giudizio, una pronuncia di inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso in seguito a condanna
irrevocabile. (Nella specie, peraltro, il provvedimento emesso in seguito a dichiarazione di
ricusazione e all'origine della sentenza della Corte europea non era stato oggetto di impugnazione
da parte del condannato)».