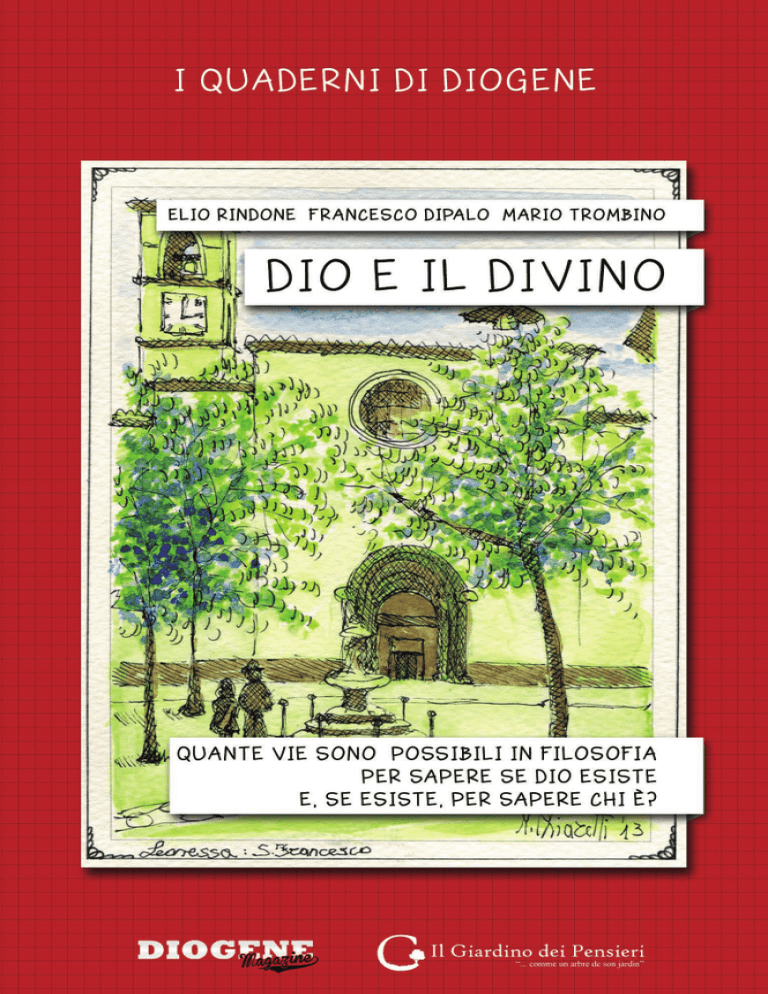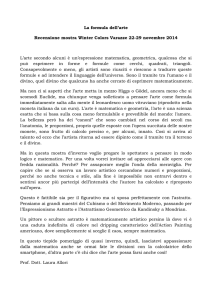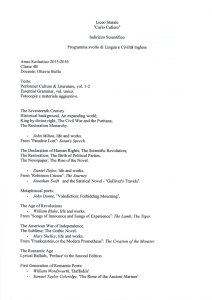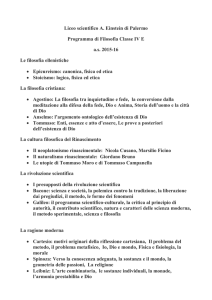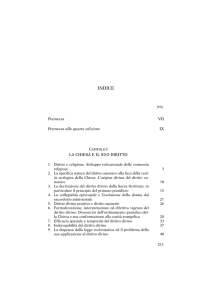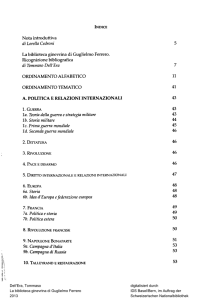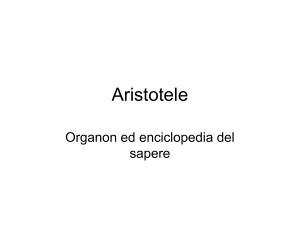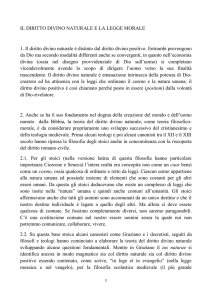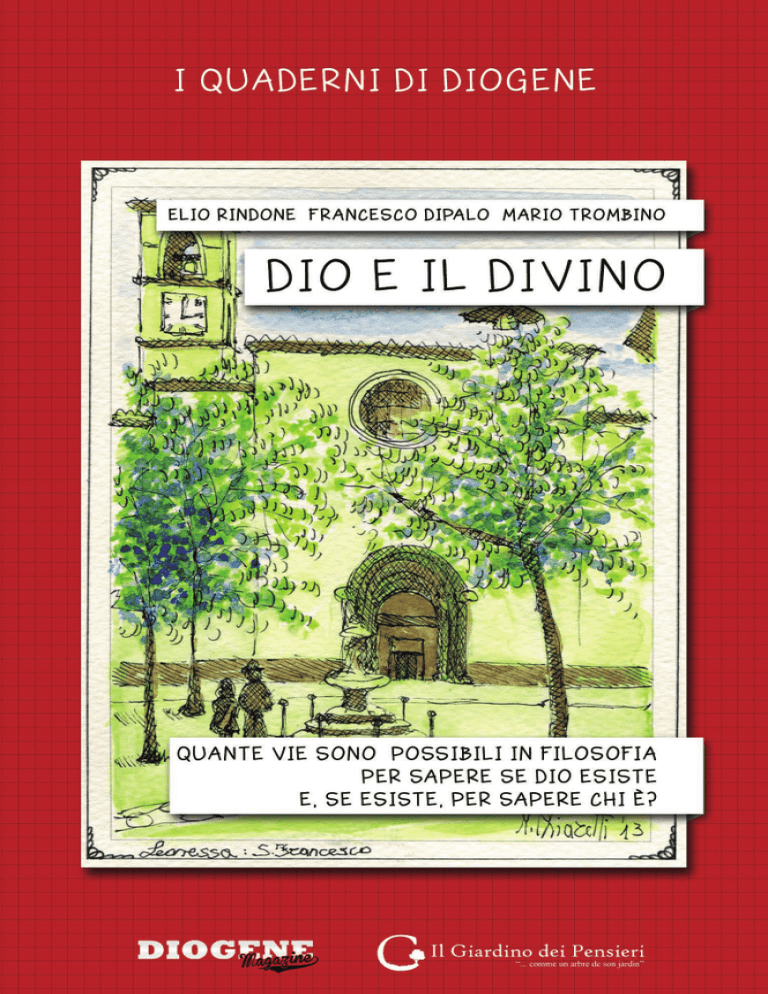
Collana “Quaderni di Diogene”
diretta da Stefano Scrima
Elio Rindone, Francesco Dipalo, Mario Trombino
DIO E IL DIV INO
Quante vie sono possibili in filosofia per sapere se Dio esiste e,
se esiste, per sapere chi è?
Il Giardino dei Pensieri
“... comme un arbre de son jardin”
Copertina e impaginazione: Jimmy Knows S.C.P., Barcelona (ES)
L’immagine della copertina riproduce
la chiesa e il convento di San Francesco a Leonessa.
È opera di Maria Teresa Chiaretti
www.deco.pittoriche.too.it
ISBN 978-88-98227-35-8
© Edizioni del Giardino dei Pensieri di Mario Trombino
Via Nadi 12, 40139 Bologna
I edizione, gennaio 2014
INDICE
6
6
9
9
INTRODUZIONE
AUGUSTO CAVADI
Il perché e il come di questo “Quaderno”
RELAZIONI
ELIO RINDONE
Dio, gli dèi e il divino alle radici della nostra cultura
Le tradizioni religiose e filosofiche dell’Antichità e del Medioevo
66
MARIO TROMBINO
Chi è Dio?
La ricerca filosofica su Dio, nel suo rapporto col mondo e con
l’uomo, nell’età della rivoluzione scientifica
103
FRANCESCO DIPALO
Il divino dopo la morte di Dio
Verso un nuovo concetto di spiritualità ecumenica nel mondo
contemporaneo
154
TAVOLA ROTONDA CONCLUSIVA
155
Riccardo Apolloni, Sintesi delle relazioni
165
Intervento di Salvatore Fricano
171
Intervento di Mario Mercanti
176
NOTE
INTRODUZIONE
IL P ERCHÉ E IL COME DI
QUESTO “QUADERNO”
È dal 1983 che quasi ogni anno ci rifugiamo, per una o due
settimane estive, in una bella località montana (dalla Verna al
Passo delle Mendola, dal Monte Rosa a Erice…) per regalarci
una pausa di silenzio, di riflessione filosofica, di confronto amichevole, di convivialità. La finalità è semplice: dare ad alcuni
filosofi di professione la possibilità di incontrarsi con un gruppetto di filosofi per passione che nella vita quotidiana sono
impegnati in altro (magistrati e operai, assistenti sociali o medici, imprenditori o maestre elementari…). Altrettanto semplici, essenziali, le modalità di svolgimento: un seminario dalle
9 alle 10,30 del mattino e un altro dalle 18,30 alle 20. Per il
resto, tempo assolutamente libero: per leggere o passeggiare,
meditare o fare turismo, chiacchierare al bar in compagnia o
girovagare da soli in bicicletta.
Ognuno di noi, insomma, vive con una propria intenzionalità
e con una propria tonalità le ormai trentennali “vacanze filosofiche per non…filosofi”, accomunato agli altri partecipanti dall’interesse per il tema dell’anno: l’amicizia o il dolore, il
6
tempo o il linguaggio, l’amore o l’impegno politico e così via.1
Nell’estate del 2013 (più precisamente dal 24 al 30 agosto) il
luogo prescelto è stato Leonessa, accogliente località turistica del rietino, e “il divino al vaglio della filosofia” la tematica
proposta. Più d’una persona che non ha potuto partecipare
all’esperienza ci ha chiesto di recuperare, per quanto possibile,
i contenuti veicolati. Da qui l’idea del volumetto che avete in
mano e che, per ovvie ragioni, restituisce solo i testi su cui si
sono basati i tre ‘facilitatori’ (o, secondo i casi, ‘complicatori’)
per impostare la conversazione collettiva a ogni incontro: la
ricchezza dei vari interventi estemporanei dei trenta partecipanti all’iniziativa è stata salvata, e restituita, solo in parte grazie ai brevi resoconti che chiudono il libretto.
Come si evince dalle tre relazioni che state per leggere, il filo
seguito è stato storico e teoretico a un tempo. Elio Rindone
(grazie alla sua doppia formazione filosofica e teologica) ha lumeggiato l’idea del divino presso i Greci, nella tradizione ebraico-cristiana e, infine, nel Medioevo, riportando con fedeltà le
“vie” tomistiche dal mondo a Dio senza tacere le sue riserve
sulla affidabilità razionale di tali “vie”.
Mario Trombino si è concentrato sulla pretesa della Modernità di trattare la questione di Dio con i metodi e gli strumenti
euristici della razionalità umana, a suo avviso inscindibilmente
scientifica e filosofica, come dimostrerebbero i testi di Newton, Cartesio, Spinoza e colleghi. Una pretesa irrinunciabile
perché, quando si abbandona la ragione come facoltà per pronunziarsi sul divino, dall’ambito proprio del pensiero filosofico
si scivola nel sociologismo o nello psicologismo. Non si parla
più se Dio ci sia o meno, ma solo se l’uomo – come collettività
o come individuo – ne avverta o meno il bisogno interiore.
Feuerbach, Nietzsche, Sartre, Wittgenstein sono alcuni degli
autori che – secondo Francesco Dipalo – hanno destrutturato
ogni pretesa, antica e moderna, di attingere il divino mediante
analisi concettuali e dimostrazioni argomentative: così facen7
do, hanno non solo seppellito per sempre una certa idea di
Dio come Essere supremo, ma anche – quasi mai intenzionalmente – spianato il terreno per nuove prospettive religiose in
cui alla dimensione dogmatica e istituzionale subentra, un po’
come nelle sapienze orientali quali il buddhismo, la centralità
dell’esperienza interiore e della prassi quotidiana ‘laica’.
Pleonastica l’osservazione conclusiva: questi sei giorni son serviti più a riaprire nell’intelligenza e nell’animo dei partecipanti
la questione del divino che a definirla, in positivo o in negativo.
Ciò è molto in sintonia con “lo spirito del tempo” che, spazzate
le certezze granitiche dell’Ottocento, sembra concedere solo la
possibilità o di una fede inquieta o di un’inquieta miscredenza.
Augusto Cavadi
www.augustocavadi.com
8
ELIO RINDONE
DIO, GLI DÈI E IL DIVINO
ALLE RADICI DELLA
NOST RA CULT URA:
LE TRADIZIONI RELIGIOSE E FILOSOFICHE DELL’ANTICHITÀ E DEL MEDIOEVO
Esiste Dio? E, se esiste, chi o che cosa è?
Ancor prima di tentare di rispondere a tali domande, sembra
però inevitabile chiedersi: ha senso porre la questione oggi, in
una società che da tempo si sente ormai adulta, rivendica la
propria autonomia da forze superiori e considera le tradizioni
religiose un fenomeno residuale?
Domanda senz’altro pertinente, quest’ultima, perché almeno
nel mondo occidentale sembra che si possa benissimo fare a
meno di Dio. Milioni di uomini e donne non credono più in
un Dio che interviene realmente nelle loro vite, “che assiste e
provvede a compensare delle innumerevoli ingiustizie e sofferenze che ciascuno sa o ritiene di aver subito. Un Dio che
amministra in modo misterioso le vicende della storia degli
uomini, riservandosi di ristabilire la giustizia continuamente
violata, di risarcire gli oppressi togliendo a chi ha avuto troppo
per dare a chi invece ha sofferto ogni privazione. Un Dio che rimunera chi è afflitto da troppo dolore senza perché. […] [Que9
sta fede diffusa] da secoli di tradizione cristiana, tanto nei suoi
aspetti nobili (di indignazione per la sofferenza di troppi, per
lo più in assenza di qualsiasi colpa, almeno di gravità proporzionata alle pene), quanto, viceversa, nei suoi aspetti troppo
umani (volontà di rivalsa nei confronti degli uomini, attitudine
rivendicativa nei confronti di Dio stesso, sottoposto a giudizio
per la mancata assistenza alle proprie creature, in particolare
alle più deboli)”2 è irrimediabilmente in crisi.
È vero: nonostante momenti di rinascita religiosa troppo spesso enfatizzati, l’idea stessa di Dio sembra aver perso diritto di
cittadinanza nel sentire comune e ancor più nel mondo della
cultura. E tuttavia credo che anche oggi sia possibile e addirittura necessario interrogarsi su Dio, perché si tratta di una questione ineludibile, quale che sia la risposta che si potrà dare. Se
si vuole vivere con consapevolezza la propria vita, infatti, come
non chiedersi se la realtà ha un senso, e quale questo possa
essere e per che cosa in ultima analisi valga la pena vivere?
È proprio per designare questo senso ultimo della realtà che
tradizionalmente è stato usato il termine ‘Dio’3, e la ricerca di
tale senso è un’esigenza attuale oggi come ieri. Censurare la
domanda di senso, rinunciando a interrogarsi su Dio, sarebbe
perciò una scelta razionalmente ingiustificata, segno d’incredibile superficialità: “che ne è di Dio è domanda che la filosofia non si può scrollare di dosso come un abito dismesso, solo
che abbia memoria di quanto intrinsecamente l’esperienza e
la ricerca di Dio abbiano segnato il suo riprendere di epoca in
epoca le proprie interrogazioni”4.
Se le cose stanno così, può essere di estremo interesse fare il
punto sullo stato della questione, cominciando dall’antica Grecia per passare poi alla cultura ebraica e a quella medievale. La
scelta degli argomenti mi sembra imposta dall’oggettiva rilevanza che hanno avuto per la civiltà occidentale sia la cultura
greca che la tradizione biblica e la teologia cristiana.
10
1. IL MONDO GRECO
Cosa s’intende con la parola ‘Dio’? Se vogliamo comprendere
qualcosa del mondo greco, dobbiamo anzitutto mettere tra parentesi l’idea che, credenti o meno, riceviamo dal nostro ambiente culturale: quella del Dio cristiano. È indispensabile, poi,
ricorrere all’indagine etimologica per risalire alle esperienze
originarie che mediante quella parola hanno trovato espressione. L’italiano ‘Dio’, come il latino ‘Deus’ (e ‘dies’ = giorno) e il
greco ‘Zeus’ (Djeus, al genitivo Diòs), deriva dalla radice ariana
‘DIV’, che significa ‘splendere’, ‘brillare’. L’esperienza primaria,
variamente elaborata poi dalle differenti tradizioni religiose, è
dunque quella della luce: lo splendore del cielo, il chiarore del
giorno che dà gioia e sicurezza, liberando dall’oscurità delle tenebre notturne 5.
Questa stupefacente esperienza, cui si aggiungono, da una
parte, l’ammirazione per l’ordine dell’universo e il timore provocato dalla sproporzione tra le forze della natura e la fragilità
umana, e, dall’altra, l’esigenza di dare una risposta alla domanda sul senso della realtà e della vita umana, è all’origine in Grecia non solo della fioritura di una sapienza poetico-religiosa
di eccezionale profondità ma anche della creazione di quella
rigorosa indagine razionale che va sotto il nome di filosofia.
1.1. La sapienza poetico-religiosa
Il mondo, di cui l’uomo fa parte, si presenta con una sua stabilità ma, nello stesso tempo, è caratterizzato da continue trasformazioni. Ovvia, quindi, la domanda: la realtà è stata sempre così? No, risponde la tradizione mitologica: il mondo non è
stato sempre come lo vediamo oggi, ma è il frutto di un lungo
travaglio. Così attesta il racconto più antico giunto sino a noi,
quello di Esiodo che agli inizi del VII secolo a. C. scrive sull’ar11
gomento un poema di mille versi: la Teogonia. Può sembrare
strano che in un poema che narra la cosmogonia, la formazione del mondo, si parli di teogonia, della nascita degli dèi. Il fatto è che per gli antichi Greci il mondo e gli dèi non sono realtà
distinte: il mondo stesso è un tutto divino.
All’origine è il Caos
Il punto di partenza di questa complessa vicenda è dunque,
per il poeta ispirato dalle Muse6, qualcosa d’informe, di oscuro
e disordinato: “prima nacque il Caos” (v. 116). Questa divinità,
una sorta di buco nero privo di caratteristiche personali, ‘nasce’ non si sa come e perché, così come non si spiega come
“poi [nascano] Gaia dall’immenso seno […] e il buio Tartaro,
sotterraneo grande di tetre gallerie, ed Eros, che è il più bello
fra gli dei immortali” (vv. 116-120). Non bisogna dimenticare,
è ovvio, che siamo nel mondo del mito e non avrebbe senso
pretendere dimostrazioni di ordine razionale.
La seconda divinità è dunque Gaia, la madre terra, stabile e
solida, su cui si muoveranno gli uomini e gli dèi, che ancora
non sono stati generati. La terza divinità è il Tartaro, un luogo d’impenetrabile oscurità, in cui saranno relegati, quando ci
saranno, gli dèi che si abbandonano alla cieca violenza e che
saranno sconfitti dopo una terribile lotta. La quarta è Eros, l’amore, la primordiale forza cosmica da cui si sprigiona la vita,
da non confondere col giovane Eros che susciterà la passione
amorosa tra gli dèi e gli uomini.
Da Urano a Crono
Forse sotto l’impulso di Eros, Gaia genera da sola nuove divinità: “prima di tutto Gaia diede vita al suo simile, Urano stellato,
perché tutta l’abbracciasse, e fosse per sempre dimora incrollabile per gli dèi beati; generò i bei Monti elevati, dove amano
restare le divine Ninfe, che abitano fra i monti scoscesi; generò
anche il mare mai stanco, che si agita e ribolle” (vv. 126-131).
12
Il mondo come lo conosciamo comincia così a prendere forma, ma la convivenza tra queste entità naturali, e a un tempo
divine, non è per nulla pacifica. Urano, il cielo stellato, non è
infatti distante dalla terra ma incombe su di essa: sembra non
avere altri interessi al di fuori del coito, e da questi incessanti
accoppiamenti nascono sempre nuovi figli. Temendo di essere
spodestato da uno di questi, Urano dunque resta sempre appiccicato a Gaia, che è costretta così a tenere i figli nel proprio
grembo.
Per liberarsi dell’opprimente presenza, Gaia allora fabbricò
una falce affilata e la diede all’ultimogenito Crono, il tempo,
che “in un istante dal caro padre staccò il genitale” (vv. 180181). Urlando per il dolore, Urano si allontanò allora dalla terra, cosicché questa può ora portare alla luce i suoi figli. Si crea
così sulla terra uno spazio abitabile e ha inizio una successione
temporale che scandisce la serie degli eventi.
Gli dèi dell’Olimpo
Crono non è ossessionato dal piacere sessuale ma dal desiderio di conservare il potere. Si unisce, infatti, a una delle sue
sorelle, Rea, ma, “avendo saputo da Gaia e da Urano stellato
quello che era fissato per lui, per quanto forte fosse, che uno
dei figli lo avrebbe sottomesso” (vv. 463-465), si affretta a divorarli subito dopo che sono stati generati. Rea, allora, ricorre
all’inganno: nasconde l’ultimo nato, Zeus, e al suo posto fa inghiottire a Crono una pietra avvolta nelle bende.
Divenuto un giovane di grande forza e bellezza, Zeus può ora
affrontare Crono, che intanto, con uno stratagemma, era stato
costretto a sputare “fuori i suoi nati” (v. 496). Con l’aiuto di
fratelli e sorelle egli sconfigge in un memorabile scontro, che
rischia di rigettare il mondo nel caos, Crono e gli esseri più o
meno mostruosi che lo sostengono, rinchiudendoli nel Tartaro.
Zeus è ormai il padre degli uomini (generati, secondo alcune
tradizioni, anch’essi dalla terra) e degli dèi, garante dell’ordi13
ne dell’universo. Pur continuando a identificarsi con le forze
della natura, gli dèi, che hanno ora la loro dimora sull’Olimpo, acquistano sempre più caratteristiche personali. Accanto a
Zeus, signore della folgore e del tuono, troviamo la sua sposa,
Era, protettrice della famiglia, Estia, dea del focolare, Demetra
la dea delle messi e delle stagioni, Ade, che regna sul Tartaro, Poseidone, il dio dei mari, Afrodite, la dea della bellezza e
dell’amore, Efesto, il dio degli artigiani, Ares, il dio della guerra
brutale, Atena, la dea della saggezza e della strategia militare,
Apollo, il dio dell’intelligenza e della bellezza, Artemide, la dea
della caccia, Ermes, il messaggero degli dèi e protettore degli
imbroglioni, e infine Dioniso.
Il ruolo di Zeus
Per comprendere meglio la visione esiodea del cosmo è necessario soffermarsi un po’ su Zeus e Dioniso. Prima di Era, Zeus
ha sposato Meti, dea dell’astuzia e della saggezza, ma, temendo di essere spodestato da uno dei figli che nascerà dal loro
amore, ingoia la moglie (intanto Meti aveva concepito Atena,
che nascerà quindi dalla testa del padre). Zeus, dunque, non
sarà detronizzato e il suo potere non avrà fine perché ispirato
a quella saggezza che egli ha incorporato ingoiando Meti.
Ma Zeus ha sposato anche Temi, l’irremovibile dea della giustizia, che lo aiuterà a creare e a mantenere un ordine cosmico
armonioso ed equilibrato. Dalla loro unione nasce Dike, che
ristabilisce con la giusta punizione l’ordine violato dal delitto.
L’insegnamento della mitologia è chiaro: “non è possibile essere il re degli dèi e il padrone del mondo soltanto con la forza
bruta”7. Un potere stabile, per garantire l’ordine, la bellezza e
la bontà del cosmo, deve fondarsi su saggezza e giustizia8.
Dioniso: una divinità impresentabile
Dioniso è figlio di Zeus e, unico tra gli dei dell’Olimpo, di una
donna mortale, Semele: del resto sono innumerevoli le avven14
ture extraconiugali di Zeus. Semele è stata incenerita perché
ha chiesto insistentemente a Zeus di mostrarsi in tutto il suo
splendore e un mortale non può resistere a tale vista; ma Zeus
strappa il feto dal corpo che sta bruciando e lo rinchiude nella propria coscia, che farà da utero. Dioniso, il dio del vino e
dell’orgia sfrenata che inducono a gesti di efferata crudeltà e
sadismo, è sentito come uno straniero nelle città della Grecia:
accompagnato da un festoso corteo di Satiri, Baccanti e Sileni,
regolarmente ubriachi, vi porta dolore, disordine e morte.
Com’è possibile che un tipo così poco raccomandabile sia annoverato tra gli dei dell’Olimpo? Probabilmente il mito vuole
ricordare che l’ordine del cosmo implica necessariamente una
parte di disordine: mortali e immortali, saggezza e follia, gioia e dolore, cittadini e stranieri sono inscindibilmente presenti
nel mondo. Il negativo ha una sua funzione e non può essere
eliminato del tutto, ma deve essere contenuto. L’ordine cosmico, in effetti, è fragile e richiede continua vigilanza perché non
prevalga il caos.
I mortali
La varietà e la completezza dell’universo implicano dunque, accanto agli dèi immortali, anche la presenza degli uomini, i mortali. Questi, narra sempre Esiodo in un altro suo poema, Opere
e giorni, all’inizio vivevano, banchettando assieme agli dèi, una
vita felice: senza lavorare, esenti da sofferenze e malanni, alla
fine si addormentavano dolcemente nel sonno della morte, divenendo demoni e continuando a vivere come benevoli custodi
degli uomini9. Va detto, però, che mentre ci sono dee immortali
non ci sono per ora donne mortali ma solo maschi.
Ma perché si passa, attraverso una serie di fasi alterne, dalla
condizione felice dell’età dell’oro all’attuale età del ferro, caratterizzata da fatica, sofferenza, ingiustizia, violenza, malattia
e morte? Perché – secondo Esiodo – gli uomini non accettano
il posto loro assegnato: si ribellano all’ordine cosmico, non ri15
spettano la giustizia, si abbandonano all’hybris, alla dismisura orgogliosa. Proprio quest’atteggiamento di tracotanza, che
porta gli uomini a misconoscere i propri limiti e a sfidare le
forze divine della natura, è per i Greci l’origine di tutti i mali,
perché esso rischia di riportare il cosmo al caos iniziale.
A causa dell’hybris umana, quindi, gli dèi si ritirano ormai stabilmente sull’Olimpo e Zeus decide di punire gli uomini servendosi di uno strumento che li trarrà in inganno affascinandoli
con le sue attrattive: la donna. Invia loro, quindi, Pandora, la
prima donna appunto, che, aprendo per la sua sciocca curiosità l’orcio in cui stavano rinchiusi, sarà causa d’infiniti mali10.
Ora, infatti, uomini e donne nasceranno dall’unione sessuale,
conosceranno sofferenza e malattia e saranno davvero mortali; i primi dovranno inoltre affrontare la fatica del lavoro per
soddisfare i desideri insaziabili delle loro mogli.
Non dal nulla all’essere ma dal Caos al Cosmo
Se ci fermiamo ora a riflettere sulla narrazione esiodea, possiamo mettere in luce alcune caratteristiche essenziali della
visione greca della realtà.
Il primo aspetto da evidenziare è il seguente: per gli antichi
Greci l’esistenza del mondo è un fatto. Non si chiedono perché la realtà esiste11 ma perché è così come la vediamo oggi.
Il mondo attuale è il frutto di una serie di trasformazioni ma,
per quanto indietro si possa risalire, non si trova un principio
primo. Per Esiodo, infatti, anche il Caos, come abbiamo visto,
‘nacque’. Cosa c’era prima di quest’oscura voragine, da cui deriva il mondo che conosciamo, non riusciamo a immaginarlo e
neanche le Muse ce lo dicono: il sapere umano non può varcare questo limite.
Va inoltre rilevato che il divenire dell’universo ha una direzione
ben precisa: si può dire che c’è una tensione finalistica per cui
si passa dal disordine all’ordine, dal Caos al Cosmo. Il trionfo
dell’ordine, però, è il prodotto non dell’azione di un essere in16
telligente che guida tutto il processo ma di una lotta feroce, in
cui domina una cieca necessità, tra potenze che si scontrano
fra loro. È un fatto, tuttavia, che l’ordine riesca a prevalere sul
disordine, tanto che, una volta realizzato l’equilibrio tra i vari
elementi, questo, per quanto fragile, è in grado di conservarsi
in maniera stabile e duratura, mentre la pura violenza è definitivamente sconfitta.
Che significa theos?
Gli elementi, poi, che costituiscono il mondo della natura
sono, per la tradizione mitologica, ‘dèi’. Ma cosa significa ciò?
Il termine theos, la cui etimologia è incerta, sembra che all’inizio indicasse un’esperienza particolarmente intensa, fuori
dall’ordinario: “Pronunciare il termine theós equivaleva a dire:
‘Ecco qui, proprio qui c’è Dio’. Originariamente theós, lungi
dal designare un’entità, indicava un accadimento. E allora Dio
‘chi’, ‘che cosa’? Appunto: la fonte che disseta, il fiume che lava
e trascina, Dio è il mare in cui si naviga, tempestoso, calmo,
navigabile, pescoso, ma anche distruttore di navi, soprattutto
inesplorato, infinito”12.
In quest’ottica, ovviamente, tutti i fenomeni naturali sono divini: gli alberi, i monti e soprattutto il cielo, contemplando il
quale l’uomo è profondamente compreso di timore, per la sua
incolmabile distanza, e di ammirazione, per il moto perfettamente regolare degli astri. Non è un caso, perciò, che proprio
il cielo luminoso sia identificato con la divinità suprema, Zeus,
parola che deriva, come abbiamo già ricordato, dalla radice
ariana ‘DIV’, che significa ‘splendere’, ‘brillare’. L’esperienza
della luce che scaccia le tenebre è appunto quella che, per antonomasia, viene percepita come divina.
Divinità antropomorfe
Ciò non toglie che anche le esperienze umane possano essere
singolarmente intense, uscire dalla banalità del quotidiano ed
17
essere, perciò, qualificate come divine. Come le sorgenti o i
venti, pure la guerra o l’amore – abbiamo visto – sono divinità:
Ares e Afrodite13. E non solo i sentimenti umani14 ma anche
manufatti, come templi o statue, che suscitano forti emozioni
per la loro bellezza perfetta sono non simboli del divino ma divini essi stessi15. E quanto più l’uomo fa esperienza di sé, tanto
più attribuisce agli dèi caratteristiche personali.
Insomma, divino “è il mondo nel suo contenuto essenziale, la
totalità delle forze in esso operanti”16, la vita nella varietà delle sue forme, che certo “non si cura delle leggi della morale
umana”17. Acqua e fuoco, mondo vegetale e animale, uomini e
dèi sono espressioni di questa inesauribile energia vitale18. L’espressione più perfetta è costituita ovviamente dagli dèi, che
“si manifestano realmente in forma umana: era questa, infatti,
l’unica forma esteriore, propria di un essere vivente dotato di
spirito, che si conoscesse, e ingenuamente la si trasferiva anche a quella divinità che, di norma, è sottratta ai nostri sensi”19.
Gli uomini, gli dèi e il fato
L’esistenza degli dèi, quindi, per gli antichi greci non va dimostrata e neanche creduta per fede, ma è oggetto d’immediata
e diretta esperienza20. È evidentemente impossibile, infatti,
mettere in dubbio lo spettacolo del mare in tempesta, con cui
si identifica Poseidone, o i turbamenti del delirio amoroso, con
cui si identifica Afrodite. Esseri eccelsi e immortali, gli dèi intervengono nelle vicende umane e sono incomparabilmente
kreittones, più forti degli uomini, i quali devono onorarli e rendere loro un culto adeguato per assicurarsi la loro benevolenza o per placare la loro ira. Ma, seppur degni di venerazione,
sono sempre congiunti agli uomini dalla comune origine: come
i mortali, anch’essi infatti nascono dalla Terra. Come non c’è un
abisso incolmabile tra gli alberi e gli uomini, così non c’è tra
questi e gli dèi.
Un’ultima notazione sulla religiosità olimpica: il cosmo è retto
18
da leggi immutabili, e stolto sarebbe il tentativo di cambiare il
corso degli eventi. Un ordine necessario regge l’universo, più
forte non solo degli uomini ma anche degli dèi: il fato, le Moire
nel linguaggio del mito, “è superiore perfino agli immortali”21.
Alle gioie si accompagnerà sempre un inevitabile carico di dolori, perché il negativo, come abbiamo visto, fa parte anch’esso
della realtà naturale. Liberi da vane illusioni, poeti e pensatori
hanno detto più volte che per gli uomini sarebbe meglio non
esser mai nati e, se nati, al più presto scendere nella tomba.
Eppure i Greci amano appassionatamente la vita22, tanto che
attribuiscono alle ombre che soggiornano nell’Ade un costante rimpianto di essa. Saggezza per l’uomo è, dunque, accettare il proprio posto nel mondo sapendo che una vita beata è
esclusivo privilegio degli dèi. Questo è il senso del motto inciso
sul frontone del tempio di Apollo a Delfi: Conosci te stesso. È
l’invito a trovare il proprio luogo “in seno al grande Tutto e
soprattutto a restarci, a non peccare mai di hybris, arroganza
e dismisura”23.
Le religioni misteriche
Bisogna però aggiungere, per completare la nostra analisi, che
la Grecia ha conosciuto anche un’altra religiosità, tanto diversa
da quella olimpica da essere sempre avvertita come straniera anche quando avrà una larga diffusione: la religiosità dei
misteri. Questa, in particolare la tradizione orfica su cui è qui
opportuno soffermarsi seppur brevemente, avrà sulla filosofia
un’influenza non minore di quella olimpica.
Conosciamo poco la dottrina di queste sette misteriche, perché
caratterizzate dalla segretezza. Gli iniziati, infatti, erano obbligati a non rivelarne i contenuti, e il termine ‘mistero’ deriva
proprio dal verbo myein che significa ‘tacere’. Possiamo però
affermare con certezza che la cosmogonia orfica si allontana
da quella esiodea, con cui pure ha alcuni punti di contatto, su
una questione decisiva: la natura dell’uomo.
19
Secondo il mito orfico, infatti, la generazione degli uomini fu
preceduta da quella dei Titani, astuti e crudeli figli di Urano e
di Gaia, che uccidono un fanciullo divino, Dioniso (che non è
per gli Orfici il dio della frenesia orgiastica dei misteri dionisiaci
ma un divino maestro di saggezza), e ne divorano le membra
dopo averle arrostite. Zeus, per punirli, li incenerisce col suo
fulmine e da quelle ceneri nasce il genere umano.
Gli uomini, dunque, sono un misto di bene e di male: da una
parte conservano le malvagie inclinazioni dei Titani e dall’altra custodiscono in sé una particella del divino Dioniso, di cui
quelli si erano nutriti. Essi sono, perciò, eredi di un crimine
precedente, che causa nuove colpe e che deve essere espiato
attraverso le sofferenze che accompagnano una lunga serie di
reincarnazioni. Solo sottoponendosi a una dura ascesi l’anima,
liberatasi dall’impurità corporea, potrà sottrarsi al “ciclo aspro
e terribilmente doloroso” di nascita e morte, di cui parla una
delle piccole lamine d’oro poste dagli orfici in mano ai loro
defunti, e raggiungere la piena beatitudine. L’orfismo elabora
quindi un’immagine dell’aldilà come luogo di premio e di punizione, in cui quelli che hanno raggiunto la piena purificazione
fruiscono della mistica identificazione con la divinità, mentre
chi ha disobbedito a tale imperativo etico-religioso soffre i più
crudeli tormenti.
L’antropologia orfica
Ci troviamo – è chiaro – di fronte a un’antropologia fortemente
dualistica, caratterizzata dalla contrapposizione tra un mondo
materiale, identificato col male, da cui l’anima deve liberarsi
per unirsi con una non meglio precisata divinità. E si tratta di
un’identificazione ‘mistica’, di cui appunto non si può dire nulla: il termine ‘mistico’ deriva infatti sempre da myein e quindi
designa qualcosa di indicibile, incomunicabile.
È evidente, a questo punto, la distanza che separa la visione
olimpica della realtà, e di conseguenza del senso della vita
20
umana, da quella orfica. Per la prima, il ciclo della natura comprende ugualmente nascita e morte, gioia e dolore, e nessun
giudizio negativo grava sulla materia animata e vivente. L’uomo è parte del grande Tutto, che ha i suoi ritmi immodificabili,
cui è impensabile sottrarsi. La vita, perciò, era in quest’ottica
“insanabile, da accettare qual era, nella sua malignità e nel
suo splendore. Si poteva solo desiderare di mantenersi ancora
per qualche momento sulla cresta del flutto, prima di ricadere
nell’ombra del ripido gorgo”24.
Nella concezione orfica, invece, l’uomo, o almeno l’elemento
divino che è in lui, l’anima, aspira a una vita più vera, del tutto
libera dal dolore e dal male che sulla terra sono ineliminabili.
La materia esiste, certo, ma è qualcosa di negativo e viene contrapposta all’anima, una sorta di demone che da essa tende a
liberarsi. Va detto subito che la filosofia non rifiuterà questa
prospettiva, intrecciandola in qualche modo con quella olimpica. Anzi, “sottrarsi all’esistenza come a un fardello e a una
colpa, questo dogma fondatore degli Orfici venne trasmesso
più dallo stile di Platone che dalle formule degli adepti”25.
1.2. La riflessione filosofica
Intorno al mondo e al divino i primi filosofi si pongono le stesse domande della tradizione mitologico-religiosa, e le loro risposte sono ovviamente influenzate da quella. Ciò non toglie,
però, che ci siano profonde differenze. Infatti, per comprendere la realtà, con le sue apparenti contraddizioni – il permanere di una totalità che non vien meno nonostante le continue
trasformazioni delle sue parti – i filosofi, grazie alla libertà di
cui godono 26, possono abbandonare il linguaggio delle immagini e il ricorso a divinità antropomorfiche, propri del mito, e
affidarsi solo all’esperienza sottoposta al vaglio rigoroso della
ragione27.
21
La natura e il divino
I primi filosofi, comunemente detti naturalisti o presocratici,
spiegano e riconducono all’unità la molteplicità e il divenire
dei fenomeni che si offrono alla nostra esperienza mediante il
concetto di physis, che i latini tradurranno con natura: un principio che fa nascere e crescere le varie realtà. Ciò che vediamo,
ad esempio il mondo vegetale, è in continua trasformazione:
le piante nascono da un piccolo seme, crescono sino all’attuazione delle loro possibilità e poi cedono il posto ad altre della
stessa specie28. Ciò è possibile perché evidentemente c’è una
forza generatrice, la natura appunto, che permane e che è
all’origine di questo incessante rinnovarsi della vita29.
Il concetto di natura, dunque, è per i Greci la chiave che da sola,
senza ricorso a forze a essa estranee, apre le porte della comprensione della realtà30. In questo concetto unitario di physis,
infatti, “la prima speculazione filosofica greca cerca non soltanto il centro di raccoglimento e sintesi della sparsa e caotica
molteplicità fenomenica ma ancor più il principio permanente,
di fronte alla mutazione e instabilità di tutte le cose”31.
Questo principio che permane al di là del divenire, questa
forza generatrice che mai viene meno è per i filosofi qualcosa di divino: “nei naturalisti presocratici il concetto di natura
(physis) non si scompagna da quello del divino (to thèion); ma
con esso anzi appare tuttora scambiarsi, come con concetto
equivalente”32. E questa identificazione del divino col principio
immanente che dà vita a tutte le cose resterà una caratteristica
essenziale della visione greca del mondo33.
Divina, dunque, è la natura stessa, principio di vita che pare
eterno e indistruttibile, perché si perpetua attraverso le successive generazioni delle cose che da essa derivano: la physis,
fonte inesauribile di vita, quindi “non vien concepita mai quale
natura naturata [insieme dei fenomeni naturali], ma sempre
quale natura naturans [forza generante], da tutti i filosofi che
riconoscano i fenomeni e si propongano di spiegarli”34.
22
Poiché, inoltre, il mondo appare retto da un ordine immutabile
– basta osservare l’immodificabile moto degli astri e il regolare
succedersi delle stagioni – è ragionevole attribuire alla natura
divina un moto necessario che escluda la casualità: “l’idea del
divino conduce all’idea di una legge di ordine necessario e giusto inerente a tutta la natura: la physis, appunto perché identica al to theion, non è soltanto potenza di vita, di generazione e
di nutrizione, che potrebbe per sé stessa essere anche pensata
priva di regola e di legge, ma è dotata invece di una intrinseca
necessità”35.
Talete e Anassimandro
Questa idea, che il mondo stesso sia un tutto divino, sembra
presente già nel primo dei filosofi di cui ci è stato tramandato
il nome: Talete di Mileto (637-547 a. C.). A lui, infatti, è attribuita l’espressione: “il tutto è animato e insieme pieno di dèi”
(Diels-Kranz 11 A 23). Ma è, questa, un’opinione comune a tutti i primi pensatori greci. Come in Esiodo cosmogonia e teogonia erano inseparabili, così ora sono inseparabili cosmologia
e teologia36. L’intuizione mitologica che identificava il divino
con le forze della natura resterà, infatti, alla base della speculazione filosofica, anche se, evidentemente, verificata alla luce
dell’esperienza e tradotta in coerenti termini concettuali.
Così, mentre Esiodo, senza preoccuparsi della coerenza logica,
faceva derivare il mondo che conosciamo dal Caos, che però
non era un vero principio perché esso stesso era stato generato, Anassimandro di Mileto (610-545 a. C.) invece pone come
origine di tutte le cose l’apeiron, un infinito “da cui gli esseri
hanno origine e in cui trovano la loro distruzione secondo necessità: essi, infatti, pagano l’uno all’altro la pena e l’espiazione
dell’ingiustizia secondo l’ordine del tempo” (DK 12 B 1).
Per Anassimandro la natura è il principio ingenerato ed eterno
che regge e governa con una legge ferrea il ciclo di ciò che nel
tempo nasce e poi muore per confondersi di nuovo col tutto:
23
“è ciò da cui tutto ha origine e in cui tutto ritorna. È dunque
l’inizio (arche) e la fine (teleute) di tutto ciò che esiste”37. Il
mondo è un cosmo, come diranno i pitagorici, cioè un tutto
armonico in virtù delle sue proprie leggi, senza che sia necessario ricorrere a una divinità, come lo Zeus del mito, che faccia
trionfare ordine e giustizia. Anzi l’antropomorfismo delle divinità mitologiche sarà contestato duramente, com’è noto, da
Senofane di Colofone (570-475 a. C.).
Parmenide
Ma le esigenze della ragione portano Parmenide di Elea (515450 a. C.) ancora oltre. Se il reale, e cioè questo mondo, è un
tutto eterno, ingenerato e indistruttibile, esso non può che essere sempre identico a se stesso. Se mutasse, infatti, che cosa
diverrebbe se non qualcosa d’irreale, un non essere? Ma il non
essere non può esistere, e quindi non si dà divenire. Divino,
dunque, è per Parmenide un mondo della natura immobilizzato e pietrificato, una physis che però non genera più nulla.
Il tutto, infatti, non solo è ingenerato, come già insegnava
Anassimandro, ma neanche può generare. Cosa potrebbe generare: o qualcosa che è o qualcosa che non è. Ma non può
generare essere, perché l’essere è già, né può generare non
essere, perché il non essere non è: quindi “giammai la forza
della convinzione verace concederà che dall’essere alcunché
altro da lui nasca. Perciò né nascere né perire gli ha permesso
la giustizia, disciogliendo i legami, ma lo tien fermo” (DK 28 B
8). E tanti filosofi faranno propria l’identificazione parmenidea
del divino con l’essere immutabile ed eterno.
Ma allora che cos’è quel mondo molteplice e diveniente,
quell’insieme di fenomeni che con la loro varietà e col loro fascino s’impongono alla nostra esperienza? Non è che apparenza, risponde Parmenide. Di fronte all’evidenza che s’impone
alla ragione – solo l’essere è, mentre il non essere necessariamente non è – non ci resta che dubitare dei sensi: “tu da
24
questa via di ricerca allontana il pensiero, né l’abitudine nata
dalle molteplici esperienze ti costringa lungo questa via a usar
l’occhio che non vede e l’udito che rimbomba di suoni illusori
e la lingua, ma giudica col raziocinio la pugnace disamina che
io ti espongo” (DK 28 B 8).
Platone
La contrapposizione tra conoscenza sensibile e razionale la ritroviamo in Platone (427-347 a. C.). Anch’egli separa il regno
dell’essere conoscibile mediante la ragione, che però – si badi
bene – non è più come in Parmenide il mondo della physis, da
quello del divenire, il mondo delle apparenze sensibili, delle
cose materiali che nascono e muoiono. Vero essere, dunque,
è quella trama razionale, quel mondo di essenze eterne, immutabili e perfette che solo l’intelligenza può cogliere: è l’anima, infatti, che “contempla la giustizia in sé, la temperanza, la
scienza: ma non quella legata al divenire, né quella che varia
secondo le diverse cose che noi chiamiamo esseri, ma quella
che ha come oggetto l’essere che realmente è”38.
Il mondo sensibile, dunque, viene irrimediabilmente depotenziato da Platone. Non è più la natura naturans, il tutto divino
di cui parlavano i filosofi naturalisti, e tuttavia non è neanche
il nulla: non è semplice illusione ma possiede una sua consistenza. Platone ammette infatti, accanto al vero essere, e cioè
quello immutabile, una realtà molteplice e diveniente: qui una
cosa non è un’altra (un tavolo non è una sedia) e può cambiare
(una sedia può diventare cenere). Tavolo, sedia, cenere sono
cose diverse, ma sempre esistenti: ci troviamo ancora nell’ambito dell’essere e restiamo così fedeli al principio parmenideo
per cui solo l’essere esiste mentre il non essere non può assolutamente essere.
Il demiurgo e la materia informe
Nel mondo sensibile, Platone vede una mescolanza di ordine e
25
di disordine, qualcosa di positivo e, a un tempo, di negativo. Per
tentare di spiegare questa condizione ibrida, secondo Platone
non possiamo che far ricorso al linguaggio mitologico, che non
dimostra in maniera apodittica ma si affida a ipotesi plausibili.
Il nostro mondo è verosimilmente opera di un demiourgos, un
intelligente artigiano divino che, ispirandosi al modello perfetto
delle idee, ha plasmato la khora, una materia informe preesistente, un ricettacolo universale, che è il luogo in cui si svolge
il divenire e che in sé comprende le determinazioni della materia e dello spazio: essendo buono e “volendo che tutte le cose
fossero buone e, per quant’era possibile, nessuna cattiva, prese
dunque quanto c’era di visibile che non stava quieto, ma si agitava sregolatamente e disordinatamente, e lo ridusse dal disordine all’ordine, giudicando questo del tutto migliore di quello”39.
Quindi, se siamo lontani dall’idea di una divinità che crea dal
nulla, perché la khora esiste di per sé, non ci troviamo neanche
più di fronte alla physis autosufficiente dei naturalisti: posto
l’ordine finalistico che si riscontra nel mondo, l’ipotesi di un’intelligenza ordinatrice sembra a Platone, come già ad Anassagora di Clazomene (496-428 a. C.), più ragionevole di quella
che attribuisce alla natura la capacità di organizzarsi da sola in
modo da produrre un cosmo armonicamente ordinato.
Il cosmo corporeo non è stato sempre così come lo vediamo,
ma, come già suggeriva la sapienza mitologica, è nato, ha avuto un inizio. Se ha ordine e movimento e bellezza, però, queste
caratteristiche gli vengono da fuori, contrariamente a quanto
ritenevano Esiodo e, in genere, i primi filosofi. È il demiurgo,
infatti, che fa un’opera per quanto possibile bella, e poiché il
vivente è superiore a ciò che è privo di vita, è lecito concludere che egli abbia dotato il mondo di un’anima, facendone un
immenso organismo vivente: “seguendo un argomento verosimile, occorre dunque dire che questo mondo nacque come
un vivente, davvero dotato di anima e intelligenza grazie alla
provvidenza divina”40.
26
L’idea del Bene e il divino
Platone pensa, così, di avere corretto, senza rinnegarla, la posizione di Parmenide che, concependo il divenire come passaggio dall’essere al non essere, lo rendeva contraddittorio e quindi inammissibile: il divenire non è affatto contraddittorio perché, come abbiamo visto, una cosa che cambia diventa un’altra
cosa e non il nulla. Ciò non toglie però – è bene ribadirlo – che
alla physis non si possono più attribuire, come se li possedesse
in proprio, quei caratteri di ordine, bellezza e intelligenza che
essa pur manifesta. Tali perfezioni il mondo sensibile le riceve
da una realtà superiore: da quella realtà perfetta e intellegibile che è l’essere immutabile, il vero essere al cui vertice c’è il
Bene che a ogni cosa garantisce in giusta proporzione essere
e intelligibilità, come nel mondo fisico il sole diffonde luce e
calore. Ancora una volta il divino viene collegato all’esperienza
della luce, non più però quella sensibile ma quella intellegibile.
Le conseguenze di questa concezione metafisica sul piano antropologico e morale sono evidenti, così come è esplicito il richiamo alle credenze orfiche: l’uomo, che pure deve operare
per portare quanto più è possibile nel mondo terreno l’ordine
razionale, è soprattutto la sua anima, quella realtà spirituale
che vive nel corpo come in una prigione e che tende a liberarsi da esso per trovare la propria piena realizzazione nella
contemplazione del mondo ideale, della cui natura partecipa.
In conclusione, Platone condivide la tradizionale identificazione del divino col principio eterno, immutabile e indistruttibile,
solo che esso non è più la realtà naturale ma quella ideale. E
divino può essere considerato tutto ciò che di quell’eternità in
qualche modo partecipa, come gli astri, l’anima del mondo e le
singole anime. Il divino, quindi, ammette gradazioni: c’è qualcosa di più o meno perfetto, qualcosa di più o meno divino, a
seconda che possieda maggiore o minore somiglianza con quel
principio.
27
Aristotele
Anche Aristotele (384-322 a. C.), come Platone, pensa che l’idea di physis come forza generatrice immanente non sia sufficiente per spiegare la realtà che è sotto i nostri occhi. Per
comprenderne il motivo, dobbiamo ricordare i punti nodali
della sua metafisica. Le cose sensibili, secondo Aristotele, sono
certo fatte di una componente materiale: un tavolo e una sedia sono, per esempio, di legno. Ma tavolo e sedia non sono
soltanto legno, perché altrimenti sarebbero la stessa cosa. Se
sono due cose distinte, è perché c’è un’altra componente, immateriale, che le caratterizza e fa che una sia un tavolo e l’altra
una sedia. Questo elemento è ciò che Aristotele chiama forma,
mentre chiama sostanza l’unione di una determinata materia
e di una determinata forma: questo cane o questo albero. Noi
non vediamo mai, quindi, realtà solo materiali: ferro e legno
sono materia attuata dalla forma. È dunque la forma che fa
esistere, che fa passare all’atto le potenzialità della materia.
Le sostanze, poi, sono soggette al divenire: in presenza di determinate condizioni, un seme diventa un albero, un pezzo di
legno cenere… Anche per Aristotele, quindi, il divenire non è
affatto contraddittorio, come credeva Parmenide, perché non
è il passaggio dall’essere al nulla ma dall’essere in un modo (il
seme), la potenza, all’essere in un altro modo (l’albero), l’atto.
Anzi non occorre dire, come faceva Platone, che il mondo sensibile e diveniente è una mescolanza di essere e non essere:
esso è certamente essere, ma ciò non significa che non siano
possibili altre modalità di essere, come, per ipotesi, esseri sottratti al divenire.
L’essere, chiarisce infatti Aristotele, si dice in molti modi, con
significati simili ma non identici: in breve, è un termine che ha
una valenza analogica. Come usiamo la parola sano per indicare un uomo in buona salute, il colorito che ne è un indizio,
l’aria che la favorisce…, così diciamo che esiste quest’uomo, la
sua altezza, la sua simpatia… Nel linguaggio aristotelico, altez28
za e simpatia non sono sostanze ma accidenti. Sono elementi
che caratterizzano la sostanza, che non esistono senza di essa:
ciò non toglie, però, che siano reali, che abbiano un proprio
modo di essere.
Il primato dell’atto
Se dunque è vero che ci sono molti modi di esistere, possiamo
allora interrogarci sull’ipotesi di cui sopra: esistono, oltre alle
sostanze sensibili e mutevoli di cui abbiamo esperienza, anche
sostanze immutabili, che i nostri sensi non sono in grado di
cogliere? La risposta di Aristotele è affermativa: c’è una realtà
immateriale e immutabile, e tale certezza non si fonda su argomentazioni plausibili ma su dimostrazioni rigorose. Ecco come
si sviluppa il ragionamento.
Il punto di partenza è costituito dall’esperienza: c’è qualcosa
che diviene, che passa dalla potenza all’atto. Perché questo
mutamento sia possibile, debbono però esserci particolari
condizioni: una statua, per esempio, non c’è senza un artista
che scolpisca il marmo. Ovviamente, lo scultore e la volontà di
scolpire la statua debbono già esistere, debbono essere già in
atto, perché altrimenti il blocco di marmo resterà sempre tale
e non diventerà mai statua41. Ciò significa che c’è un primato
dell’atto sulla potenza: solo se è già in atto, A può causare il
passaggio dalla potenza all’atto di B.
Ora, se la materia è solo potenza e non può esistere se la forma non la attua, non può certo muoversi da sola, ma deve essere mossa da altro. La materia prima – che per Aristotele è il
sostrato di cui sono fatte tutte le sostanze sensibili, e che è in
qualche modo simile alla khora di Platone – non può perciò
essere all’origine di tutto: essa è pura potenzialità, da sempre
bisognosa della forma per esistere in atto. Siamo – è evidente
– lontanissimi dalla physis intesa come forza generatrice che
da sola passa dal caos al cosmo.
29
Il motore immobile
All’origine di tutto ciò che diviene, quindi, non c’è il caos, la
realtà informe, ma la forma che attua la materia e determina
quei movimenti ordinati in vista di un fine che rendono il mondo un tutto armonico: l’albero, per esempio, produce fiori e
frutti, il fuoco si dirige verso l’alto, che è il suo luogo naturale…
Ora, prosegue Aristotele, se c’è qualcosa che diviene eternamente, la causa di questo divenire deve essere essa stessa
eterna. Ma la successione temporale, che scandisce il mutare
delle cose, è eterna, perché parlare di un ‘prima’ della nascita
del tempo significherebbe ammettere ancora la dimensione
temporale42. L’insieme delle sostanze sensibili, quindi, è un
eterno divenire, che sarebbe contraddittorio senza una causa
adeguata: una sostanza eternamente in atto.
E possiamo essere certi che questa sostanza deve essere priva
di potenza, e quindi di materia43, perché altrimenti, per muovere, avrebbe bisogno di passare essa stessa all’atto, e non sarebbe perciò la spiegazione adeguata dell’eterno divenire del
mondo: si tratta quindi di un atto puro, di un motore immobile,
che appunto muove senza essere mosso44, orientando come
fine ultimo la tensione verso l’atto di ciò che è in potenza.
È così dimostrata l’esistenza della sostanza soprasensibile e
immutabile, di cui ovviamente non possiamo fare esperienza
ma che la ragione deve necessariamente ammettere, perché
altrimenti sarebbe contraddittorio il divenire di cui abbiamo
esperienza.
Caratteri dell’Atto puro
Dell’atto puro possiamo, secondo Aristotele, intravedere anche alcune caratteristiche. È una realtà spirituale vivente, e
la sua attività è quella più elevata, la vita intellettuale: “egli è
vita, perché l’attività dell’intelligenza è vita, ed egli è appunto
quell’attività”45. E l’oggetto di quest’attività intellettuale non
possono essere le vicende mondane, perché in tal caso l’at30
to puro stesso sarebbe coinvolto nel divenire del mondo. Egli,
quindi, senza occuparsi di quel mondo che eternamente diviene e che non è stato da lui plasmato (è caduta ovviamente
l’ipotesi mitologica del demiurgo platonico), non può che contemplare eternamente se stesso e le proprie perfezioni: “se,
dunque, l’intelligenza divina è ciò che c’è di più eccellente, essa
pensa se stessa, e il suo pensiero è pensiero di pensiero”46.
Per Aristotele, dunque, ciò che egli chiama più volte Theòs ha
i seguenti caratteri: è atto puro, e cioè atto senza potenza, forma senza materia, e quindi sostanza incorporea, perfezione
assoluta e autosufficiente, pensiero di pensiero, vita intellettuale perennemente in atto ed eternamente beata, motore
immobile e fine ultimo da cui “dipendono il cielo e la natura”47.
Non bisogna attribuire, però, ad Aristotele una concezione
monoteistica: egli ritiene, infatti, che il moto delle sfere celesti
abbia bisogno di altre intelligenze motrici, e arriva a contarne
ora 47 ora 55, ma le pone in posizione subordinata rispetto al
primo motore immobile. Egli considera, inoltre, divini anche
gli astri e l’anima intellettiva perché, nell’ottica greca, divino è
tutto ciò che è eterno e incorruttibile.
In conclusione, Aristotele pensa di aver dimostrato razionalmente l’esistenza di una sostanza incorporea che spiega, come
causa finale, il divenire del mondo sensibile ma è separata da
questo e per sé sussistente. Per designare tale soggetto spirituale egli non parla – e ciò va sottolineato – di to theion ma
di Theos. Anche se divine sono per lui pure altre realtà, può
essere chiamato Dio solo il primo motore, la contemplazione
del quale costituisce per l’uomo la vera felicità48.
Plotino
Con Plotino di Licopoli (205-270 d. C.), l’ultimo grande rappresentante della metafisica greca, ci allontaniamo sempre più dai
primi filosofi, che identificavano il divino con la physis, e siamo
ben oltre Platone e Aristotele, i quali, pur ammettendo una
31
realtà che trascende la materia come modello e causa dell’ordine del mondo terreno, riconoscevano l’irriducibile ed eterna
consistenza della dimensione materiale: la khora plasmata dal
demiurgo o la materia strutturata dalla forma.
Per Plotino, invece, c’è una sola realtà, che però non è la physis
ma un principio da cui tutto deriva e di cui non possiamo propriamente dir nulla, perché è radicalmente diverso da tutto ciò
di cui abbiamo esperienza e che possiamo pensare49. Da tale
principio divino, eterno, immutabile e amante della propria
perfezione50, il mondo trae la propria consistenza non perché
sia creato liberamente dal nulla ma perché da esso emana, per
la ridondante pienezza del suo essere, con spontanea necessità come i raggi luminosi irradiati dal sole51.
Ancora una volta, quindi, il divino è identificato con la realtà
che abbaglia col suo splendore ed è assolutamente immutabile. Profondamente originale, invece, è la concezione del mondo sensibile e del suo rapporto col principio da cui deriva. Da
quest’unica fonte emana anzitutto un mondo intelligibile, che
ha una ricchezza ben maggiore di quello sensibile. L’anima, che
è il grado più povero del mondo spirituale, si estrinseca poi in
un mondo fenomenico e spaziale che non ha consistenza se
non nell’anima stessa che lo produce. Il mondo visibile, che per
i primi filosofi era vera realtà, non sussiste dunque in se stesso,
ma ha la consistenza delle immagini percepite dall’anima: un
mondo di sogni52.
La materia è mancanza di bene
Quindi la materia non è la divina natura naturans, da cui derivano le cose, ma ciò in cui appaiono le nostre sensazioni. Il
mondo, con i colori, i sapori e gli odori delle forme sensibili
che lo costituiscono, è, in ultima analisi, opera dell’anima, non
certo come cosa sostanziale ma come luogo ideale delle sue
possibili sensazioni: come il pensare s’identifica con l’oggetto
del pensiero, così il sentire s’identifica con l’oggetto sentito,
32
che non esiste al di fuori di esso. La materia, quindi, non ha alcuna positività, è qualcosa di negativo, pura mancanza di bene,
come l’oscurità non è che assenza di luce.
È evidente che in questa prospettiva il fine dell’uomo debba
essere non la semplice contemplazione ma l’estasi, l’unione
mistica col principio di tutte le cose di un’anima che sembra
separarsi totalmente dal corpo: “Ed ecco la vita degli dei e degli
uomini divini e beati: separazione dalle restanti cose di quaggiù, vita cui non aggrada più cosa terrena, fuga da solo a solo”53.
In conclusione, per Plotino c’è una sola realtà, quella divina, e
tutto ciò che esiste non è che sua manifestazione. Come definire questa prospettiva metafisica? L’idea di una realtà trascendente da cui tutto emana esclude sia il panteismo immanentistico, che identifica il divino con il mondo, come per esempio
quello dei primi naturalisti o degli stoici, sia il dualismo aristotelico, che pone due principi irriducibili come l’atto puro e
la materia prima, sia la creazione dal nulla di cui parleranno i
pensatori cristiani.
Panenteismo è forse l’espressione più appropriata per designare questa concezione metafisica, che in qualche modo riunisce
sia i caratteri del teismo sia quelli del panteismo. Il panenteismo, infatti, da un lato afferma la dimensione trascendente
del principio divino, e dall’altro non vede nel mondo altro che
l’estrinsecazione empirica e temporale di tale eterno principio.
Democrito
L’idea che il mondo sia un tutto armonico, ordinato finalisticamente, è predominante nella filosofia greca e ha avuto grande seguito nel pensiero successivo. Essa è comune non solo
a Platone e ad Aristotele, per i quali l’ordine dipende da un
mondo ideale o da un motore immobile propriamente divini,
ma anche agli stoici, secondo i quali l’ordine finalistico dipende
da una divina ragione immanente, un soffio caldo che anima
e dà forma a tutte le cose54. Ma occorre ricordare, seppur bre33
vemente, anche altre posizioni, nella cultura greca certamente
minoritarie, che quel presupposto non condividono.
Un sistema filosofico estremamente complesso è quello di Democrito di Abdera (460-360 a. C.), per il quale la realtà è fatta
di atomi, particelle materiali invisibili e indivisibili, ingenerate
e indistruttibili, che dall’eternità si aggregano e si disgregano
muovendosi nel vuoto e formando i corpi che noi conosciamo.
Il moto degli atomi è una proprietà della materia e non è regolato da alcuna divinità o forza esterna: è un moto spontaneo,
che segue leggi meccaniche necessarie ed estranee a ogni finalismo55.
Ci troviamo, dunque, di fronte a una concezione materialistica
e deterministica che spiega il mondo e il suo divenire senza ricorrere a un disegno razionale immanente o a interventi divini,
considerati frutto di ridicole superstizioni56, anche se Democrito ammette gli dèi della tradizione, la cui esistenza non può
essere però ricavata dall’osservazione della natura.
Epicuro
Pure per Epicuro di Samo (341-271 a. C.), la realtà è fatta di
atomi che si muovono eternamente nel vuoto, secondo proprie leggi, che non escludono la casualità, e senza alcun ordine
finalistico. Gli dèi esistono, dato che attraverso i sensi li conosciamo e sappiamo che vivono la loro vita immortale e beata
(come il Theos di Aristotele, che però non era conoscibile mediante i sensi ma mediante la ragione, in quanto fine ultimo
del divenire di tutte le cose) negli spazi che si trovano tra un
mondo e l’altro, ma non sono causa del moto regolare degli
astri57 ed è certo che non intervengono nel mondo, dato che
facciamo esperienza del male, incompatibile con la bontà e la
potenza che attribuiamo loro.
Come quello di Democrito, anche quello di Epicuro è un mondo desacralizzato, che rigetta la presenza incombente di esseri
divini che, con la minaccia di punizioni terrene e ultraterre34
ne, terrorizzano gli uomini: compito prioritario della filosofia
è proprio quello di liberare le menti da una falsa concezione
del divino58.
Protagora e Crizia
Se per Epicuro l’esistenza degli dèi, concepiti in maniera antropomorfica, era assolutamente evidente, questa certezza non
era stata affatto condivisa dai sofisti. Protagora di Abdera (486411 a. C.), per esempio, limitava la conoscenza umana a ciò di
cui possiamo avere esperienza e quindi, come riferisce Diogene Laerzio, riguardo agli dèi assumeva una posizione rigorosamente agnostica: “Intorno agli dèi non ho alcuna possibilità di
sapere né se esistono né se non esistono. Molti sono gli ostacoli che impediscono di sapere: sia l’oscurità dell’argomento
sia la brevità della vita umana”59.
Crizia di Atene (460-403 a. C.), invece, negava decisamente l’esistenza di esseri superiori, sostenendo che gli dèi erano stati
inventati dai governanti per evitare che gli uomini infrangessero le leggi, convincendoli dell’esistenza di potenze divine capaci di osservarli e di punirli anche quando agivano di nascosto60.
Socrate
Assolutamente originale, infine, è la posizione di Socrate di
Atene (469-399 a. C.). Egli, infatti, abbandona gli studi naturalistici61: sa, e lo dichiara apertamente, di non conoscere la
struttura della physis. Anzi, riteneva che “chi si dedicava a tali
questioni cadesse in vaneggiamenti”62, disinteressandosi di ciò
che è più importante: l’uomo e le sua scelte di vita. È proprio
l’indagine filosofica sui problemi morali che porta Socrate all’esperienza del divino: una divinità caratterizzata essa stessa da
razionalità e moralità.
Per quanto riguarda la religione tradizionale, Socrate ritiene
che ogni cittadino debba attenersi al costume della propria città. Ma la sua religiosità va evidentemente ben oltre quella po35
polare, che rende culto agli dèi per ottenerne il favore. Gli dèi
dell’Olimpo per lui sono soltanto espressioni dell’unico principio divino, al quale è lecito chiedere non già beni materiali, ma
il vero bene, e cioè la virtù.
Se l’intelligenza, la capacità di capire cosa è bene fare, è la caratteristica propria dell’uomo ed è quanto di più prezioso si
dà nella nostra esperienza, è ovvio infatti che proprio queste
caratteristiche dobbiamo attribuire al divino. E Socrate vive la
ricerca filosofica come una missione: dal dio – gli fa dire Platone – ho ricevuto “l’ordine di vivere facendo filosofia ed esaminando me stesso e gli altri”63. La ricerca coerente di verità
e giustizia: questo è il compito che gli dèi, buoni e amanti del
bene, gli hanno affidato64 a vantaggio dei suoi concittadini.
Fede religiosa, ricerca filosofica e vita morale sono perciò secondo Socrate, strettamente connesse.
Col mondo divino, infine, Socrate si sente in contatto attraverso un fenomeno sovrumano, demonico (to daimonion), che
non gli suggerisce cosa fare ma lo distoglie da scelte dannose:
“è come una voce che, sin da fanciullo, sento dentro. E tutte le
volte che io la sento, mi trattiene da quello che sto per fare, e
non mi esorta mai a fare”65. Si tratta, evidentemente, di un’esperienza di carattere intuitivo e non passibile di verifica razionale, ma non per questo per lui meno importante.
36
2. IL MONDO CRISTIANO
Se, abbandonata la civiltà greca, passiamo a quella cristiana, ci
troviamo di fronte a uno scenario ben diverso. La nozione cristiana di Dio, su cui pure hanno influito pensatori come Platone, Aristotele o Plotino, è stata infatti elaborata anzitutto sulla falsariga dell’esperienza religiosa ebraica condensata nella
Bibbia. Ma qual è l’immagine di Dio contenuta in quei libri che
i cristiani chiamano Antico e Nuovo Testamento?
Chi non si accontenta della predicazione corrente, sa che libri
composti nel corso di lunghi secoli, utilizzando generi letterari
differenti e non di rado conservando, sovrapponendo e modificando tradizioni, leggende e ricordi storici di epoche precedenti, non presentano, ovviamente, una visione unitaria di
Dio. Questi è certamente il protagonista di questa grande opera letteraria, ma i suoi tratti mutano, si arricchiscono, appaiono
contraddittori, talvolta all’interno di uno stesso libro.
La fisionomia di questo personaggio cercheremo ora di delineare soffermandoci, prima di passare al Nuovo Testamento,
su alcune delle pagine più significative dei libri dell’Antico Testamento, esaminati nell’ordine proprio del canone ebraico,
differente da quello proposto dai cristiani66.
2.1. La sapienza poetico-religiosa
Protagonista assoluto della prima pagina della Genesi è un Dio
che appare sulla scena da solo, senza moglie figli o compagni
divini67, e che, con l’efficacia della sua parola, dà origine al
mondo: “In principio Dio creò il cielo e la terra [cioè tutte le
cose]. Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque”68. Dio,
dunque, dà ordine all’universo separando la terra dalle acque,
37
ponendo nel firmamento il sole, la luna e le stelle, che non
sono quindi delle divinità, facendo germogliare gli alberi e facendo “l’uomo a sua immagine”69, a partire da qualcosa che
c’era già: una massa ‘informe e deserta’, un abisso avvolto nelle tenebre70. La nozione di creazione dal nulla, che tanto rilievo
avrà nella filosofia cristiana, pare quindi che non abbia alcun
fondamento biblico71.
Ora, però, l’uomo non risponde alle attese divine e disobbedisce a un ordine esplicito, indotto a ciò dalla donna, plasmata
da una sua costola e sedotta a sua volta da un serpente, “la
più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte da Jahvè, il dio”72.
La punizione divina non si fa attendere: il serpente viene maledetto “più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche”73, la donna partorirà con dolore e sarà soggetta al marito,
che la “dominerà”74, e l’uomo dovrà lavorare con fatica, perché la terra “spine e cardi produrrà”75, e conoscerà addirittura
la morte. Piuttosto collerico e vendicativo il Dio presentato in
queste pagine!
Il diluvio
Ma nei capitoli successivi si assiste a una vera esplosione dell’ira divina, perché la malvagità dilagava tra gli uomini, cosa che
pare prendere Dio alla sprovvista, e “ogni disegno concepito
dal loro cuore non era altro che male”76. Jahvè allora “si pentì
d’aver fatto l’uomo sulla terra […] [e] disse: Sterminerò dalla
terra l’uomo che ho creato; con l’uomo anche il bestiame e i
rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito d’averli fatti”77.
La promessa di sterminio viene mantenuta e si salva soltanto
Noè, un uomo giusto, con la sua famiglia e una coppia di ciascuna specie di animali, entrati in un’arca costruita su consiglio
di Jahvè.
Terminato il diluvio, Noè “offrì olocausti sull’altare. Jahvè ne
odorò la soave fragranza e pensò: Non maledirò più il suolo a
causa dell’uomo”78. E sembra così rabbonito dall’odore del sa38
crificio da rassicurare Noè e tutti i viventi: “Io stabilisco la mia
alleanza con voi: non sarà più distrutto nessun vivente dalle
acque del diluvio, né più il diluvio devasterà la terra”79. L’arcobaleno sarà il segno dell’avvenuta pacificazione.
L’alleanza con Abramo
Ma dopo questa alleanza con tutta l’umanità, Jahvè ne stabilisce un’altra con un uomo particolare, Abramo, a cui chiede di
lasciare il suo paese e a cui promette più volte una numerosa
discendenza. Quando Abramo ha ormai novantanove anni, il
Signore gli rinnova la promessa, ma ora la condiziona a esigenze di carattere morale: “Io sono il Signore della montagna
[comunemente tradotto con Dio onnipotente]: cammina davanti a me e sii integro. Porrò la mia alleanza tra me e te e ti
renderò numeroso molto, molto. […] Stabilirò la mia alleanza
con te e con la tua discendenza dopo di te di generazione in
generazione, come alleanza perenne […]. Darò a te e alla tua
discendenza dopo di te il paese dove sei straniero, tutto il paese di Canaan in possesso perenne”80. E segno di tale alleanza,
riservata a una sola casata, sarà la circoncisione.
Discendenza e possesso della terra Abramo li otterrà grazie
alla fiducia nelle promesse divine, fiducia che sarà messa, forse con un po’ di sadismo, a dura prova: infatti non solo Isacco
nascerà, dopo una lunghissima attesa, da genitori stravecchi
ma al padre sarà chiesto di sacrificarlo e la sua mano sarà fermata appena in tempo per evitare la morte del bambino.
Quello che è certo è che ormai il Signore dell’universo, alleato
di tutta l’umanità, acquista sempre più i caratteri del protettore di un individuo e del suo clan: il Dio di Abramo, di Isacco
e di Giacobbe. E questa predilezione per Abramo e la sua discendenza provoca un ulteriore cambiamento nell’immagine
di Dio.
39
Il liberatore dalla schiavitù
Da Abramo infatti, e passiamo così al libro dell’Esodo, è nato
ormai un popolo così numeroso da mettere in pericolo la sicurezza dell’Egitto, tanto che il faraone lo riduce in schiavitù e
ordina di uccidere tutti i neonati maschi. Allora il Signore, che
conosce le sofferenze del suo popolo, decide di intervenire e
da un roveto che arde senza consumarsi chiama Mosè e lo invia dal faraone per ottenerne la liberazione.
Conseguenze di enorme portata per la concezione cristiana di
Dio ha avuto la risposta data a Mosè che chiede a nome di chi
deve presentarsi come incaricato di una simile missione: “Dio
disse a Mosè: Io sono colui che sono. Poi disse: Dirai agli Israeliti: Io sono mi ha mandato a voi”81. Gli esegeti, però, oggi sono
concordi nell’attribuire all’espressione, cui non si può riconoscere una valenza ontologica82, il significato di ‘sono con voi’,
‘agirò per liberarvi’, ‘Io-agirò mi ha mandato a voi’.
Ora Mosè può presentarsi al faraone, che però non vuole lasciar partire gli israeliti nonostante le piaghe che si abbattono
sull’Egitto. E l’immagine di Dio che presenta il libro dell’Esodo
si arricchisce di un aspetto singolare: è Jahvè stesso che indurisce il cuore del faraone83, quasi a voler infierire sulla popolazione egiziana. Pare che il Signore voglia impedire che il
faraone ceda alle richieste di Mosè al fine di mostrare la sua
potenza punitiva: “Io ho reso irremovibile il suo cuore e il cuore dei suoi ministri, per operare questi miei prodigi in mezzo a
loro”84.
E questi ‘prodigi’ culminano nell’uccisione dei primogeniti egiziani, mentre le case degli israeliti saranno risparmiate perché
cosparse col sangue di un agnello immolato: “Io passerò per il
paese d’Egitto e colpirò ogni primogenito nel paese d’Egitto,
uomo o bestia […]. Il sangue sulle vostre case sarà il segno che
voi siete dentro: io vedrò il sangue e passerò oltre, non vi sarà
per voi flagello di sterminio”85. Questa è la pasqua: la salvezza
dalla catastrofe che si abbatte sugli egiziani. Per gli israeliti, ma
40
ovviamente non per gli egiziani, è un giorno festivo di cui fare
memoria: “di generazione in generazione, lo celebrerete come
un rito perenne”86.
Il legislatore
La sconfitta dell’Egitto, la maggiore potenza militare dell’epoca, non è certo merito degli Israeliti: è opera di Jahvè, che è
ormai diventato un dio guerriero invincibile, che usa la sua forza a vantaggio di Israele, assumendo alcune caratteristiche di
Baal, la principale divinità cananea87.
Ma le sorprese non sono finite! Jahvè, infatti, si mostra anche
saggio ed equilibrato legislatore. Comunica a Mosè, sulla vetta
di un monte e in mezzo a tuoni e lampi, dieci comandamenti
(o, meglio, parole), un decalogo che ha conservato la sua attualità nel corso dei secoli, esigendo, al contempo, un culto
esclusivo: “Non fate dèi d’argento e dèi d’oro accanto a me”88.
Purtroppo, invece il popolo costruisce un vitello d’oro da adorare, scatenando la collera di Mosè che ordina ai leviti di provare la propria fedeltà al Signore uccidendo le persone a loro
più care: “uccida ognuno il proprio fratello, ognuno il proprio
amico, ognuno il proprio parente”89. Ma i circa tremila morti
non sono sufficienti per Jahvè, che promette: “nel giorno della
mia visita li punirò per il loro peccato”90.
Il conquistatore della terra
Ad ogni modo, le caratteristiche di Jahvè che sono emerse sin
qui resteranno fissate una volta per tutte nel Deuteronomio.
Egli è il Signore dell’universo, ha scelto come suo popolo Israele, lo ha liberato con la forza di un guerriero invincibile e gli
ha dato una legge da mettere in pratica con assoluta fedeltà:
“Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo.
Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano
fissi nel cuore; li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai
41
seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai”91.
Dall’obbedienza alla legge – prosegue Mosè – dipenderà dunque la sorte di Israele: “Se tu obbedirai fedelmente alla voce
del Signore tuo Dio, preoccupandoti di mettere in pratica tutti
i suoi comandi che io ti prescrivo, il Signore tuo Dio ti metterà
sopra tutte le nazioni della terra”92 e ti arricchirà di benedizioni,
mentre “se non obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, […] verranno su di te e ti raggiungeranno tutte queste maledizioni”93.
E in effetti, la conquista della terra promessa e la successiva
storia del popolo ebraico dipenderanno dalla fedeltà a Jahvè. Quando saranno fedeli, gli israeliti passeranno di vittoria
in vittoria, sterminando quei popoli che avevano la sola colpa
di difendere il proprio territorio. Presa Gerico, per esempio,
“votarono poi allo sterminio, passando a fil di spada, ogni essere che era nella città, dall’uomo alla donna, dal giovane al
vecchio, e perfino il bue, l’ariete e l’asino”94, e ciò su espresso
ordine di Jahvè.
Quando si abbandoneranno al culto di altri dèi, invece, gli israeliti saranno sconfitti dai loro nemici. Il dilagare dell’idolatria
porterà addirittura al naufragio dell’alleanza. Allora il Signore si
servirà delle potenze del tempo per infliggere la punizione definitiva: la deportazione degli abitanti dei due regni in cui si era
divisa la nazione. Nel 722 a. C., infatti, il re d’Assiria Salmanassar, “occupò Samaria [capitale del regno di Israele e] deportò
gli Israeliti in Assiria”95, mentre nel 587 a. C. il re di Babilonia,
Nabucodonosor, “deportò tutta Gerusalemme [capitale del regno di Giuda], cioè tutti i capi, tutti i prodi, in numero di diecimila, tutti i falegnami e i fabbri; rimase solo la gente povera
del paese”96.
Padre, sposo, santo
La storia potrebbe dunque finire qui se inaspettatamente Jahvè non acquistasse, ad opera dei profeti, nuove, e per certi ver42
si sconvolgenti, caratteristiche. Per limitarci a Isaia, egli appare
ora come un padre, una madre, un marito, un amante, un re,
un redentore, il Santo d’Israele. Non solo è pronto a ripristinare l’alleanza col suo popolo97 ma vuol fare di esso la guida che
insegnerà agli altri popoli le vie della pace: “Verranno molti popoli e diranno: Venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo
camminare sui suoi sentieri. […] Forgeranno le loro spade in
vomeri, le loro lance in falci; un popolo non alzerà più la spada
contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell’arte della
guerra”98.
Il Santo d’Israele, che in alcune pagine mantiene ancora i tratti della violenza più crudele, non finisce di sorprenderci. Egli
è nemico di “coloro che assolvono per regali un colpevole e
privano del suo diritto l’innocente”99. Siede su un trono regale, circondato da serafini che cantano “Santo, santo, santo è il
Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria”100.
Non vuole più lo sterminio degli altri popoli che, come la natura stessa, entreranno a far parte di un mondo radicalmente
trasformato: “Il lupo dimorerà insieme con l’agnello, la pantera
si sdraierà accanto al capretto”101. Addirittura farà scomparire
la sofferenza e la morte: “Eliminerà la morte per sempre; il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto”102.
Amante fedele
I toni si fanno ancora più originali nella parte finale del libro,
che gli studiosi attribuiscono a un altro autore, che chiamano
Deuteroisaia. Il Signore per mezzo “del suo messia, di Ciro”103,
re di Persia, sconfiggerà Babilonia e ricondurrà gli esuli a Gerusalemme, e lì condurrà anche gli stranieri, sul “monte santo
[…] [che diventerà] casa di preghiera per tutti i popoli”104, che
prima dovevano essere semplicemente sterminati, mostrando
così una sollecitudine che si estende a tutta l’umanità. Non si
può negare che Jahvè riservi continue sorprese; è davvero un
43
Dio misterioso, che sfugge alla comprensione umana: “Veramente tu sei un Dio nascosto, Dio di Israele, salvatore”105.
Nei confronti di Gerusalemme, infatti, egli appare ora come
una madre piena di tenerezza106, come uno sposo che ama la
sua donna alla follia: “Viene forse ripudiata la donna sposata in
gioventù? […] Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti riprenderò con immenso amore”107. Le stesse infedeltà di Israele, anziché disgustare il Signore, pare che abbiano scatenato in
lui una vera passione amorosa e quelle sofferenze, che erano
giusta punizione delle colpe, acquistano ora un valore redentivo. Israele è diventato il servo di Jahvè, percosso e umiliato:
“al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori”; ma la sua obbedienza ha una valenza salvifica: “si compirà per mezzo suo la
volontà del Signore”; e questa salvezza sarà accessibile a tutti:
“il giusto mio servo giustificherà molti [cioè le moltitudini]”108.
Anche capriccioso e crudele?
Ripristinata l’alleanza, ritornati gli esuli da Babilonia e ricostruito a partire dal 520 a. C. il tempio di Gerusalemme, Israele gode
sotto il dominio persiano di un paio di secoli di pace, durante
i quali la religiosità ruota intorno alla legge e al culto liturgico.
La sua attenzione, tralasciando i rapporti con gli altri popoli,
sembra ora concentrarsi su una questione che pare davvero insolubile: se Jahvè ha promesso benedizioni a chi gli è fedele e
maledizioni a chi si allontana dai suoi precetti, perché i malvagi
prosperano mentre i giusti sono spesso oppressi dalla sventura109? In sostanza, la promessa, troppo spesso smentita dall’esperienza, di un giusto governo del mondo è credibile o no?
Non è affatto facile rispondere, ci dice il libro di Giobbe. Non si
può escludere che Dio non sia perfettamente buono e giusto,
che in lui stesso ci sia una qualche presenza del male, o almeno una debolezza di fronte alla tentazione. In questo libro,
infatti, il Signore si lascia tentare da un misterioso ‘avversario’,
il satana, che insinua che Giobbe sia “uomo integro e retto”110
44
soltanto perché è stato colmato di benedizioni. Se fosse abbandonato alla sventura, Giobbe manterrebbe la sua rettitudine? In sostanza, è un uomo giusto perché ama la giustizia o
perché la sua virtù è ampiamente ricompensata?
Il Signore accetta di mettere alla prova la fedeltà di Giobbe,
consentendo non solo che i suoi beni vengano distrutti ma anche che i suoi figli muoiano (ma non la moglie, che gli resta accanto: ulteriore prova da superare, secondo l’autore biblico?!)
e che lui stesso sia colpito dalle più terribili malattie. Ma, così
facendo, egli appare come un sovrano assoluto che si trastulla
capricciosamente con gli uomini, indifferente alle loro tribolazioni. Tanto dolore può essere permesso per decisioni così
arbitrarie?
Ridotto al silenzio?
Giobbe supera la prova: dimostrando l’autenticità di una virtù non dettata dalle convenienze, egli accetta senza ribellarsi
tutte le sue disgrazie, ma dichiara con fierezza che esse non
sono una punizione meritata dai suoi peccati. La questione,
che all’inizio concerneva l’effettiva giustizia di Giobbe, è diventata così un’altra: si può credere davvero nella giustizia di un
Dio che quasi per gioco permette la sofferenza di un uomo innocente111?
Il Signore stesso sembra in difficoltà, tanto che cerca di ridurre
al silenzio Giobbe, che protesta la propria innocenza, rivendicando non la propria giustizia ma la propria potenza. Come può
pretendere l’uomo di giudicare le decisioni di Dio: “Dov’eri tu
quand’io ponevo le fondamenta della terra? Dillo, se hai tanta
intelligenza!”112? Ma Giobbe non si lascia intimidire e addirittura si mostra piuttosto preoccupato per le sorti dell’umanità:
“Ora che i miei occhi ti hanno visto, tremo di pena per l’argilla
mortale”113.
Certo, alla fine il Signore riconosce l’innocenza di Giobbe e anzi
lo ricompensa benedicendolo più di prima: “egli possedette
45
quattordicimila pecore e seimila cammelli, mille paia di buoi
e mille asine. Ebbe anche sette figli e tre figlie”114. Ma ciò non
toglie che il libro consegni al lettore un’immagine di Dio piuttosto ambigua: “il mondo continua a sembrare più giusto che
ingiusto, e Dio a sembrare più buono che cattivo”115. Ma il dubbio resta: possiamo fidarci senza riserve della giustizia divina?
Un vecchio imperatore
In effetti, a giudicare dai libri successivi, letti secondo l’ordine
del canone ebraico, pare che per la soluzione dei suoi problemi
Israele ora conti più sulle proprie forze che su straordinari interventi divini, mentre la presenza del Signore sembra a poco
a poco rarefarsi116. Infatti, i discorsi di Jahvè riportati nei libri
delle Cronache sono citazioni, senza sostanziali modifiche, dei
libri di Samuele e dei Re. Nel Cantico dei cantici e nel libro di
Ester il Signore non solo non parla ma viene raramente citato.
La saggezza del Qoèlet sembra inclinare a un rassegnato scetticismo: “Osserva l’opera di Dio: chi può raddrizzare ciò che
egli ha fatto curvo? Nel giorno lieto sta’ allegro e nel giorno
triste rifletti: Dio ha fatto tanto l’uno quanto l’altro, perché
l’uomo non trovi nulla da incolparlo”117. È vero, spesso gli empi
prosperano, ma è inutile arrovellarsi su quella questione che
angosciava l’autore di Giobbe e che pare ormai irrisolvibile: la
storia umana è governata da un Dio giusto? L’idea deuteronomistica, che ha ispirato la storia d’Israele, secondo cui alla fedeltà corrisponde la benedizione e all’infedeltà la maledizione
non viene rinnegata formalmente ma sembra riscuotere sempre meno consensi.
Un’ultima volta appare il Signore nel libro, ricco di visioni apocalittiche, di Daniele, ma ormai ha l’aspetto di un Antico dei
giorni, un vegliardo assiso in trono, dalla veste “candida come
la neve”118. E la visione così prosegue: ecco “uno, simile ad un
figlio di uomo, giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui,
che gli diede potere, gloria e regno; tutti i popoli nazioni e lin46
gue lo servivano; il suo potere è un potere eterno, che non tramonta mai, e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto”119.
Gli imperi (assiro, babilonese, persiano, macedone) sorgono e
cadono, ma Israele continua a sognare la propria vittoria definitiva. Questa, però, sarà opera, più che del vecchio imperatore ormai stanco, dei suoi angeli, Gabriele e Michele, che “guideranno e difenderanno la nazione fino alla vittoria finale”120.
Ascoltate Gesù
Lo scenario, almeno in parte, cambia, ancora una volta, con le
Scritture cristiane. Infatti, mentre da secoli, ormai, la profezia
sembrava estinta, nei vangeli appare un ultimo profeta, Gesù
di Nazareth. E non è certo un caso se, per tratteggiarne la figura, gli evangelisti hanno utilizzato, tra i libri dell’Antico Testamento, soprattutto gli scritti profetici e se questi, nel canone
ecclesiastico, occupano ora l’ultimo posto, quasi a chiudere la
prima e ad annunciare la nuova alleanza. In particolare, tutta
la passione di Gesù è stata riletta alla luce del Servo di Jahvè
del Deuteroisaia.
Nei vangeli sentiamo di nuovo la voce di Jahvè. Ma Theòs, Dio
(tutto il Nuovo Testamento è scritto in greco), ha ora una sola
cosa da dire: quando Gesù venne battezzato, “si sentì una voce
dal cielo: Tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto”121. E ancora, al momento della trasfigurazione di Gesù,
“uscì una voce dalla nube: Questi è il figlio mio prediletto;
ascoltatelo!”122.
Ormai Dio non parla e non opera più direttamente: l’attenzione
dei vangeli si concentra sulle parole e sulle azioni di Gesù. Parole e azioni che sono portatrici di un lieto annuncio: “Il tempo
è compiuto e il regno di Dio è vicino”123. I vangeli quindi, come
del resto l’Antico Testamento, non contengono speculazioni
sulla natura di Dio124: sono, piuttosto, interessati al suo disegno salvifico. Dio è un padre125 che qui e ora ha a cuore il bene
dell’uomo. La regalità di Dio annunciata da Gesù, infatti, non
47
è da lui intesa come un dominio oppressivo, come l’inappellabile condanna dei malvagi, ma al contrario come “l’amore indiscriminato per buoni e cattivi, la ricerca insonne dei perduti,
il perdono accordato senza condizioni ai peccatori, l’amorosa
cura degli indifesi e dei minacciati”126.
Dio è agape
Il Dio di Gesù, come è ovvio, non è radicalmente diverso da
quello dell’Antico Testamento: anzi, conserva ancora aspetti
del carattere violento di Jahvè127, ma questi restano in secondo
piano. Ha una sua originalità, e credo che si possa essere d’accordo col grande biblista J. Dupont quando afferma che essa
“risulta essenzialmente dall’accentuazione di certi tratti che il
giudaismo non rifiuta, ma ai quali Gesù accorda un rilievo così
vigoroso e un’importanza così assoluta che altri tratti tradizionali ne sono come relegati nell’ombra, anche se non formalmente contestati”128.
Per gli evangelisti, in sostanza, Dio non si vede e non si sente,
ma chi vuole conoscerlo e affidarsi a lui non deve far altro che
guardare Gesù: “Chi ha visto me ha visto il Padre”129. Nel modo
di essere e di parlare di lui, che si è messo a servizio degli altri operando il bene sino a rischiare la propria vita130, Dio si
rende manifesto. Chi ha fatto dell’amore la legge della propria
vita può, quindi, dichiarare con verità: “Io e il Padre siamo una
cosa sola”131. La più profonda intuizione riguardante il significato che si può attribuire al termine ‘Dio’, infatti, è forse quella
contenuta nel Nuovo Testamento: “Dio è agape”132, amore che
si dona senza riserve.
Un Dio non della natura ma della storia
Se confrontiamo la visione ebraica con quella greca, possiamo
rilevare notevoli differenze. Poeti e filosofi greci, come abbiamo visto, sono interessati al mondo della natura, al suo essere e al suo divenire, di cui cercano una spiegazione. La physis
48
stessa e, in particolare il principio che la anima, sono qualcosa
di divino.
La tradizione ebraica, invece, ha scarso interesse per il mondo
della natura. Giunta al monoteismo, essa rielabora in poche
pagine i miti dell’area mediorientale considerando un unico
dio artefice dell’ordine del mondo, che viene quindi desacralizzato: sole e luna, per esempio, non sono dèi ma semplici luminari voluti da lui133. Tutto l’interesse, invece, si concentra sulla
storia, in particolare sulla propria storia, tanto che all’unico Dio
del cielo si attribuisce una predilezione per il popolo ebraico:
col suo capostipite, Abramo, ha stabilito un’alleanza che, nonostante ripetute infedeltà, non verrà meno, e sarà rinnovata
definitivamente, almeno per i cristiani, in Gesù.
Mentre per i Greci, quindi, la storia umana è soggetta, come
la natura, alla legge della necessità, il fato cui anche gli dèi
debbono sottostare, per gli ebrei essa è guidata da un essere
personale, che trascende l’universo e che nutre un interesse
esclusivo per l’uomo: lo plasma, si pente di averlo fatto, lo vuole distruggere col diluvio, sceglie un clan a cui assicura straordinaria fecondità, lo libera dalla schiavitù, stermina i suoi nemici
per assicurargli una terra su cui insediarsi, esige che cammini
con fedeltà sui sentieri che gli indica, lo punisce con severità,
si manifesta infine in Gesù come amore che si dona senza riserve.
Un Dio, quindi, che non ha nulla a che fare con l’Atto puro di
Aristotele, del tutto estraneo alle vicende umane. Ci troviamo
qui di fronte a un essere non solo personale ma anche passionale e imprevedibile: sicuro protagonista della storia narrata
dalla Bibbia, egli agisce all’inizio in prima persona, facendo
sentire la sua voce tra tuoni e fulmini e distruggendo i suoi nemici, e solo a poco a poco sembra placarsi, lasciando sempre
maggiore spazio all’azione degli uomini134: a loro spetta operare perché venga il suo regno.
49
2.2. La riflessione filosofica
Mentre i pensatori greci, interrogandosi sul divino, si sono
mossi in un ambiente culturale omogeneo, quello plasmato
dalla loro tradizione mitologica, i pensatori cristiani, al contrario, si sono trovati di fronte a due mondi culturali molto differenti: quello ebraico e quello greco. Già con i primi Padri della
Chiesa, formatisi in genere nelle scuole filosofiche ellenistiche,
ha quindi avuto inizio, rifiutati ovviamente gli dèi della mitologia classica, la rilettura dei testi biblici alla luce di categorie
filosofiche a essi del tutto estranee.
Il Dio biblico – personale, passionale, volubile, che ha un debole per l’umanità – ha così acquistato a poco a poco, spesso senza perdere le prime, caratteristiche nuove, sino a essere identificato con l’Atto puro, immutabile e impassibile, della filosofia.
E se ai pensatori della patristica e della scolastica si può concedere l’attenuante che non avevano adeguati strumenti critici
e filologici per cogliere le differenze tra le due culture a cui si
ispiravano, questa di sicuro non vale per i manuali di teologia
dogmatica che ancora oggi, estrapolando una frase o l’altra da
uno scritto biblico, pretendono che certe tesi filosofiche siano
contenute nella rivelazione.
Certo è che, per quanto riguarda l’esistenza di Dio, i pensatori
cristiani hanno dovuto affrontare un’impresa davvero improba. Infatti, mentre l’ordine e il divenire di questo mondo erano
già considerati divini, o tutt’al più inducevano, per esempio,
Aristotele ad affermare la necessità di un Motore immobile che
li giustificasse, i cristiani devono dimostrare che c’è qualche
motivazione razionale per ammettere l’esistenza di quell’essere personale e trascendente, signore del cielo e della terra e,
a un tempo, deciso ad allearsi una prima e una seconda volta
con gli uomini, di cui parla la loro fede. L’impresa è resa ancora
più ardua dal fatto che, a differenza dei Greci, che si rapportavano con totale libertà alla loro tradizione mitologica, i cristiani
50
muovono generalmente dal presupposto che tutti i contenuti
della Sacra Scrittura sono da accettare senza riserve, perché
rivelati da Dio e quindi assolutamente veri.
Dio biblico e filosofia greca
Allora, come procedere? Le categorie filosofiche disponibili sono quelle greche, e perciò quelle è gioco forza utilizzare.
Scartata la divinizzazione della physis proposta dai primi filosofi ma incompatibile con la prospettiva biblica, la via sembra,
quindi, obbligata: non pensavano già i grandi metafisici che
questo mondo non si spiega da solo, che ciò che diviene ed è
ordinato in vista di un fine rinvia a una Causa dell’ordine e del
movimento? Non affermava già Platone che questo mondo è
mescolanza di essere e non essere, mentre la realtà vera e divina è quella immateriale, immutabile ed eterna? E allora Jahvè
può essere identificato con la Causa Prima del mondo, tanto
più che anche la Bibbia lo presentava come signore dell’universo. Già molti Padri della Chiesa, tra cui per esempio Agostino d’Ippona, seguono questa via, rifacendosi esplicitamente a
Platone.
Ma quando, nel medioevo, si avrà un’adeguata conoscenza delle opere di Aristotele, i pensatori della Scolastica cominceranno ad attingere alla sua metafisica, che sembra tenere meglio
conto dei dati d’esperienza. Così farà, in particolare, Tommaso
d’Aquino, e poiché il suo tentativo di elaborare procedimenti
di ordine razionale che conducano ad ammettere l’esistenza di
Dio è comunemente considerato il più rigoroso, ci limiteremo,
in questa sede, a esaminare gli argomenti da lui addotti.
Tommaso e la nozione di ente
Va ricordato, anzitutto, che Tommaso riprende le nozioni aristoteliche di materia e forma, potenza e atto, sostanza e accidente. Ritiene, però, che non basti concepire la sostanza come
sinolo di materia e forma per descrivere adeguatamente la re51
altà che conosciamo mediante i sensi. L’uomo, per esempio,
è un animale (materia) razionale (forma): ma ciò non è sufficiente per definire quest’uomo che mi sta di fronte. Questa
persona, infatti, è un animale razionale che esiste qui e ora.
Perché la descrizione sia completa, occorre dunque dire che
è un animale razionale (materia + forma = essenza) che esercita un atto d’essere (esistenza). Ecco: la realtà per Tommaso
è un insieme di enti, cioè di essenze che esistono in atto. Tali
enti, poi, sono soggetti al divenire, si trasformano attuando le
loro potenzialità: quest’albero esercita un suo atto d’essere,
ma può diventare cenere e, se lo brucio, cessa di esistere come
albero e comincia a esistere come cenere in atto.
Ciò posto, ci chiediamo: gli enti di cui facciamo esperienza costituiscono tutta la realtà? Le cose sensibili che esistono, e che
divengono, hanno in se stesse la ragione sufficiente della loro
esistenza e del loro divenire? Se non l’hanno, e per Tommaso
non ce l’hanno, questa costatazione diventa il punto di partenza di un cammino che porta la ragione a scoprire una realtà di
cui non abbiamo esperienza ma che è necessario ammettere
perché non siano contraddittori, in quanto privi di adeguato
fondamento, l’esistenza e il divenire del mondo sensibile.
L’esistenza di Dio, oggetto di dimostrazione
Questo ragionamento Tommaso l’ha articolato in cinque modi,
scegliendo come premessa l’uno o l’altro dei segni di fragilità,
di contingenza della realtà di cui abbiamo esperienza. Dato che
qui si tratta del Dio cristiano che, come dicevamo all’inizio, è
quello a cui oggi pensiamo spontaneamente, mi sembra opportuno esaminare nei suoi passaggi decisivi, segnalandone
qualche aspetto discutibile, il testo classico sull’argomento,
l’articolo 3 della seconda questione della prima parte della
Somma teologica.
Ancor prima, però, va rilevato che per Tommaso l’esistenza di
Dio può e deve essere dimostrata in maniera rigorosa. All’o52
biezione per cui essa è oggetto di fede e non di scienza, egli
risponde infatti che l’esistenza di Dio, e altre verità che riguardo a Dio si possono conoscere con la ragione naturale, “non
sono articoli di fede, ma preliminari agli articoli di fede; difatti
la fede presuppone la conoscenza naturale, così come la grazia presuppone la natura e la perfezione il perfettibile. Tuttavia
nulla impedisce che una cosa, che è di per sé oggetto di dimostrazione e di scienza, sia accettata come oggetto di fede da
chi non arriva a comprenderne la dimostrazione”135. La tesi è
formulata con la massima chiarezza, e non va edulcorata: l’esistenza di Dio ‘è di per sé oggetto di dimostrazione e di scienza’.
Prima e seconda via
Chiarito ciò, la prima delle cinque vie136 prende spunto dall’innegabile esperienza del divenire. Poiché tutto ciò che si muove, e cioè passa dalla potenza all’atto, è mosso da qualche altra
cosa che è già in atto137, e poiché non si può procedere all’infinito perché altrimenti non ci sarebbe nessun movimento,
dato che “i motori intermedi non muovono se non in quanto
sono mossi dal primo motore, come il bastone non muove se
non in quanto è mosso dalla mano”, bisogna necessariamente
concludere, sulla falsariga di Aristotele, che c’è “un primo motore che non sia mosso da altri; e tutti riconoscono che esso è
Dio”138.
L’argomento è valido, ovviamente, solo se si accetta la negazione aristotelica della physis come forza generatrice autosufficiente. In quest’altra ipotesi, cara come abbiamo visto ai
presocratici, il primo motore sarebbe la natura stessa, da loro
considerata appunto divina.
La seconda via prende le mosse dalla costatazione che nel
mondo sensibile c’è una catena di cause efficienti. Poiché una
cosa non può essere causa di se stessa e poiché non si può
procedere all’infinito perché altrimenti nessuna cosa sarebbe
in grado di causarne un’altra, necessariamente “bisogna am53
mettere una prima causa efficiente, che tutti chiamano Dio”.
Questo argomento sembra una variante del precedente139, e
quindi ha la stessa forza probativa e gli stessi limiti di quello.
Quarta e quinta via
Tralasciando per ora la terza, passiamo alla quarta via, che
muove dalla costatazione che nella realtà il bene, il vero e altre
simili perfezioni si trovano in grado maggiore o minore. Ma
parlare di più o di meno non ha senso se non in riferimento a
un livello massimo. Quindi c’è un essere che non solo possiede queste perfezioni in sommo grado ma anche le comunica
alle altre cose: infatti, “ciò che è massimo in un dato genere, è
causa di tutto ciò che appartiene a quel genere, come il fuoco,
caldo al massimo, è causa di ogni calore […]. Dunque vi è qualcosa che per tutti gli enti è causa dell’essere, della bontà e di
qualsiasi perfezione. E questo chiamiamo Dio”.
Argomento, questo, convincente solo se sono valide le intuizioni metafisiche di Aristotele e ancor più di Platone: in particolare, una visione gerarchica della realtà e l’idea che ciò che
un ente ha di essere e di bene lo ha per partecipazione dell’Essere e del Bene.
La quinta via parte dalla costatazione che ci sono cose che operano regolarmente in vista di un fine: un albero di mele, per
esempio, pur privo d’intelligenza produce sempre mele, e ciò
non può essere un caso. Ma “ciò che è privo di conoscenza non
tende al fine se non perché è diretto da un essere dotato di
conoscenza e intelligenza […]. Vi è dunque un qualche essere
intelligente, dal quale tutte le cose naturali sono ordinate a un
fine, e quest’essere chiamiamo Dio”.
Quest’argomento sembra presupporre una visione del mondo
(specie fisse, finalismo) superata dalle acquisizioni della scienza. Se si accetta la teoria evoluzionistica e si riconosce il ruolo
che hanno il caso e la necessità nelle trasformazioni del mondo
della natura, la solidità dell’argomento resta gravemente com54
promessa. Infatti, la riflessione filosofica, che certo si muove
su un piano diverso da quello della scienza, si basa pur sempre
sull’esperienza, e oggi questa non è più quella immediata e ingenua di cui disponevano i pensatori dell’antichità ma quella
elaborata con rigore scientifico, di cui il filosofo non può non
tener conto.
Terza via
Sulla terza via140 credo che sia necessario fermarsi più a lungo, perché si basa sulla concezione dell’essere propria di
Tommaso. Il punto di partenza è dato dalla costatazione che
alcuni enti non ci sono stati sempre e non esisteranno sempre: questo gatto, per esempio, è nato un anno fa e tra alcuni anni morirà. L’essenza di questi enti, quindi, non implica di
per sé l’esistenza: all’essenza questa si aggiunge, per così dire,
dall’esterno, tanto che può essere perduta senza che l’essenza
resti modificata. Gli enti che cominciano a esistere e cessano
di esistere li chiamiamo ‘contingenti’: capita che esistano ma
potrebbero benissimo non esistere. Ma, allora, come mai esistono? Da dove ricavano l’esistenza? In sostanza, come mai c’è
qualcosa anziché il nulla?
In effetti, sostiene Tommaso, se ci fossero solo realtà contingenti, la loro esistenza sarebbe contraddittoria, perché esse
verrebbero tutte all’essere… dal non essere. Per evitare la contraddizione, non c’è che una possibilità, e cioè che non esistano solo realtà contingenti.
La ragione, infatti, ci dice che ciò che esiste ma non ha di per
sé l’essere non può che riceverlo da qualcuno o qualcosa che
possiede l’essere in proprio, un essere cioè la cui essenza è
appunto quella di esistere. Moltiplicare il numero degli esseri
contingenti non servirebbe, essendo l’intera serie pur sempre
contingente e quindi senza una ragione sufficiente del proprio
esistere: allungando all’infinito la serie degli asini, è evidente
che non si otterrà mai un elefante. Partendo dall’esperienza
55
ma oltrepassandola, possiamo perciò affermare con certezza
che esiste un essere necessario, cioè un essere che non può
non esistere, in cui appunto s’identificano essenza ed esistenza.
In sintesi: 1) sappiamo che qualcosa esiste: alberi, animali, uomini…; 2) questi enti o hanno l’essere in proprio, e quindi non
hanno bisogno di altro per esistere, o lo ricevono da altro; 3)
ma non l’hanno in proprio, dato che lo ricevono nascendo e
morendo lo perdono; 4) dunque, se esistono, esistono perché
ricevono l’essere da altro; 5) una serie infinita di enti non è
la soluzione, perché l’intera serie, per esistere, ha bisogno di
ricevere l’essere; 6) quindi, perché l’esistenza di un insieme di
enti che esistono ma potrebbero non esistere non sia contraddittoria, occorre ammettere un essere che esiste di per sé e
che dà l’essere a ciò che altrimenti non esisterebbe.
Perplessità
Le mie perplessità in merito alla terza via riguardano non il rigore del ragionamento ma la solidità del punto di partenza.
È vero, infatti, che noi costatiamo che ci sono enti che nascono e muoiono: ma ciò significa che qualcosa viene all’essere
(dal nulla) e lo perde (tornando nel nulla), o piuttosto che c’è
qualcosa che si trasforma, restando sempre essere? Un seme
diventa albero, e poi tavolo e poi cenere: siamo sempre nel
campo dell’essere141! Gli individui appaiono qualcosa di fragile
(ora esistono, ora non esistono), ma la realtà di cui abbiamo
esperienza si presenta, nel suo complesso, con una sua consistenza. In sostanza: l’esperienza attesta la contingenza dei singoli enti non quella del mondo della natura. Se questo, in base
alla nostra esperienza, non è mai sfiorato dal nulla, conserva
la sua legittimità la domanda: perché c’è l’essere e non il nulla,
con la conseguente necessità di giustificare quell’essere?
In altri termini: se, riguardo ai singoli enti, avessimo esperienza
del passaggio dal nulla all’essere, allora quella domanda sa56
rebbe ineludibile e la ragione imporrebbe il ricorso a un essere
sussistente che fa esistere tutta la serie degli enti contingenti,
perché moltiplicare il loro numero non basterebbe certo a risolvere il problema. Se invece abbiamo esperienza di un essere che resta tale nella molteplicità delle sue manifestazioni,
esso ha già una sua consistenza e quel ricorso non è più necessario. L’individuo, è vero, nasce e muore, ma la realtà nel
suo complesso si trasforma, passando dalla potenza all’atto. È
l’ipotesi aristotelica, di una materia prima che assume sempre
nuove forme: il mondo esiste di per sé, eternamente attratto
dal Motore immobile.
Perché Tommaso esclude questa ipotesi? E perché esclude
quella ancora più radicale, sostenuta dai presocratici, di una
natura naturans assolutamente autosufficiente, se evidente è
la contingenza dei singoli enti ma non quella del tutto, inteso
come forza generatrice di quelli (e in tal caso il tutto non sarebbe l’improbabile elefante ottenuto moltiplicando gli asini ma la
realtà di cui facciamo esperienza nel perenne fluire degli enti)?
La sua posizione mi pare che si fondi non sull’esperienza, dato
che non sperimentiamo mai passaggi dall’essere al non essere
e viceversa, ma sulla Bibbia. Infatti, fa precedere i suoi cinque
argomenti dalla citazione: “Nell’Esodo si dice, in persona di
Dio: Io sono Colui che è”.
Forse proprio su questa premessa, suggeritagli dalla Scrittura,
tradotta per giunta, come abbiamo visto, in maniera poco corretta, Tommaso ha elaborato la sua metafisica dell’essere. Dio
stesso ha rivelato il suo nome: egli è l’Essere per essenza. Ne
consegue che, se solo lui ha l’essere in proprio, tutto il resto, se
esiste, non può che ricevere l’essere da lui. Si ha così l’impressione che, grazie alla Bibbia, si abbia la certezza, ancor prima
di elaborare la dimostrazione razionale, che Dio è l’essere necessario e il mondo la realtà contingente.
57
La metafisica dell’Esodo
Ciò non deve stupire perché, come ricorda un tomista insigne
quale Gilson, Tommaso non fa il filosofo ma il teologo. Quando
parla dell’esistenza di Dio, egli cita, perciò, a buon diritto il versetto dell’Esodo ed elabora argomenti di ragione per confermare quella verità, sicché non si comprende nulla della Somma teologica “se si perdono di vista per un solo istante la rivelazione fatta da Dio della propria esistenza e il nome col quale
vi si è rivelato”142. E lo stesso Gilson nota, cosa del resto ovvia,
che sarebbe ridicolo pensare che filosofia e teologia non convivano e non collaborino nella mente di un uomo: Tommaso
“non mantiene con tale fermezza la distinzione formale delle
due luci e delle due sapienze che per meglio permettere loro di
collaborare, senza confusione possibile ma senza falsi scrupoli
e in intima familiarità”143. Credo, perciò, che il posto di rilievo
che la citazione biblica occupa nell’articolo non possa e non
debba essere sottovalutato.
Ma, prescindendo dal versetto dell’Esodo e dalla sua traduzione poco corretta144, la tesi tomista che, affermando la semplicità di Dio perché in Lui si identificano essenza ed essere,
considera invece gli enti composti di essenza ed essere, è razionalmente fondata? Con grande onestà intellettuale, Gilson
riconosce che “molte ragioni suggeriscono la composizione
negli enti di essenza ed essere, ma nessuna la dimostra in maniera rigorosa”145. Qualche riserva sulla validità della terza via
mi sembra, dunque, legittima.
La creazione dal nulla
Alla concezione tomista di Dio come Ipsum esse subsistens è
strettamente collegata, poi, la teoria della creazione del mondo dal nulla. Ma anche questa tesi è razionalmente fondata
solo a condizione che si sia certi che Dio è l’essere stesso. In
tal caso, infatti, fuori di Dio c’è il nulla: se esiste qualche ente,
è perché lui l’ha creato traendolo dal nulla e mantenendolo
58
costantemente nell’essere. Il mondo, quindi, di per sé sarebbe
nulla146; se esiste, deriva la sua reale consistenza dall’essere
divino non per emanazione, alla maniera di Plotino, ma per
partecipazione: e “partecipare non significa essere una parte
di ciò di cui si partecipa, ma avere il proprio essere e riceverlo
da un altro essere”147
Ma, se è dubbia la composizione negli enti di essenza ed essere, diventa per conseguenza dubbia anche la tesi della creazione dal nulla, suggerita dall’immagine biblica di un Dio creatore, che però, come abbiamo visto, forse è anch’essa frutto di
un’errata traduzione della Genesi. Quel che è certo è che, con i
pensatori cristiani, l’idea che i Greci avevano di Dio e del mondo viene trasformata ben più di quanto non appaia a prima
vista. Per quanto riguarda Dio, infatti, divino in qualche modo
era il mondo stesso, e non solo per i presocratici ma anche per
Platone e Aristotele148. Per i cristiani, invece, Dio è totalmente
svincolato dal mondo, lo trascende infinitamente149, anche se
è presente in esso in quanto causa della sua esistenza150.
Parimenti, per quanto riguarda il mondo, la teoria della creazione dal nulla per un libero atto di volontà è semplicemente
inconcepibile per i Greci151. I pensatori cristiani negano, infatti,
l’esistenza autonoma delle particelle che si aggregano dando
origine ai mondi immaginati dagli atomisti, della materia informe e disordinata di Platone e dell’universo eterno di Aristotele152. Il mondo perde perciò ogni sua consistenza: esso ha
ormai interamente fuori di sé la causa non solo del proprio ordine e della propria bellezza ma anche del proprio essere. Dato
l’abisso che lo separa dal creatore, esso appare desacralizzato:
diventa il mondo secolarizzato, che oggi conosciamo153.
Motore immobile e Dio biblico
Ma, ammesso che si possa dimostrare l’esistenza di un Motore
immobile, di una Causa prima, di un Essere necessario, di un
Essere perfetto, di un’Intelligenza ordinatrice, è stata così di59
mostrata anche l’esistenza di ‘Dio’? Tommaso pensa di sì, tanto
che, come abbiamo ricordato, conclude le sue prove affermando, per esempio, che c’è “un primo motore e tutti riconoscono
che esso è Dio”. Siamo però sicuri che l’idea di Motore che, in
quanto fine ultimo, rende intelligibile il divenire possa identificarsi col Dio dell’esperienza religiosa? Sembra difficile credere
che ai lettori cristiani di Tommaso venga spontaneo collegare
al primo motore il Dio biblico che interviene nella storia e che
in Gesù rinnova la sua alleanza!
La filosofia, infatti, ha difficoltà a immaginare Dio come un Tu,
perché lo concepisce come l’Assoluto, la Causa prima o il Fine
ultimo, ma non come una Persona che interpella e ama altre
persone. Quindi bisogna riconoscere, come fa Gilson, che ‘Dio’
è un termine proprio non del linguaggio filosofico ma di quello
religioso: “l’ontologia del filosofo, se si interdice di prendere in
considerazione tutto ciò che è diverso dal suo oggetto proprio,
si interdice con ciò stesso di raggiungere il Dio della religione”154.
Il Dio dei filosofi, il Fondamento dell’essere, ha poco a che fare,
in effetti, col linguaggio della religione. Le grandi narrazioni mitiche, che parlano di un Dio misericordioso, di una Presenza
benevola che ci avvolge e ci salva, di un essere personale da
ringraziare e da lodare, non hanno molto in comune con l’imperturbabile Atto puro della filosofia. È solo all’interno dell’esperienza religiosa – che valorizza momenti diversi dal procedimento razionale, come l’intuizione poetica o la dimensione
affettiva o la purezza del cuore – che il termine ‘Dio’ acquista la
sua pregnanza e la sua incidenza sulla vita umana.
‘Dio’ non è un termine del linguaggio filosofico…
Ma, prima di occuparci dell’esperienza religiosa, dobbiamo
ancora chiederci se, servendoci solo della ragione filosofica,
sappiamo di cosa stiamo parlando quando nominiamo Dio. A
rigor di termini, no, risponde Tommaso. La ragione, infatti, può
dire che Dio è, non che cosa è155, perché l’oggetto proporziona60
to alla nostra intelligenza è la realtà sensibile, e quindi i nostri
concetti, come ‘bellezza’ o ‘bontà’, e persino la nozione di ‘essere’, riferendosi in senso proprio alle creature, non possono
essere applicati a Dio. Perciò Tommaso afferma esplicitamente che, innalzandoci a Dio, dobbiamo negare non solo gli altri
concetti ma la stessa nozione di essere156.
È vero che per Tommaso è possibile, poi, affermare di Dio, e in
maniera eminente, quanto è stato in precedenza negato, ma
ciò non significa che si abbia, allora, una conoscenza di Dio. Affermare, infatti, che Dio è ‘essere’ in modo eminente non vuol
dire che noi sappiamo quale sia il suo essere. Neanche per via
analogica, dunque, come ribadisce il Gilson, conosciamo Dio:
“partendo dall’essere, non si può in effetti arrivare che a dell’essere, ed è ciò che si fa ponendo Dio come l’Essere, puramente
e semplicemente. È naturale che degli spiriti non metafisici credano di formarsi con ciò un concetto positivo di Dio, ma poiché
noi lo poniamo come supremo in una linea che parte dalla creatura, Essere è ancora per Dio un nome di creatura”157.
Bisogna, perciò, dare tutto il loro peso alle ripetute affermazioni di Tommaso sulla inconoscibilità di Dio: “l’ultimo passo
della nostra conoscenza di Dio è nel conoscere che non lo conosciamo”158; “giunti al termine della nostra conoscenza, noi
conosciamo Dio come inconosciuto”159. Anche chi pensa che,
perché l’esistenza della realtà contingente non appaia contraddittoria, si debba ammettere una realtà divina, un Ipsum esse
subsistens, sa che di essa non possiamo dir nulla, perché totalmente diversa da quella che conosciamo.
… ma del linguaggio religioso
La filosofia, dunque, non è in grado forse – e sottolineo il
forse – di dimostrare l’esistenza di Dio, la cui natura, in ogni
caso, resterebbe sconosciuta. Chiuso, allora, il discorso su Dio?
Nient’affatto, perché quella filosofica non è l’unica via percorribile: anzi ‘Dio’ è un termine proprio di una differente espe61
rienza, quella religiosa160. E, anche nell’ipotesi che l’esistenza
di Dio non sia dimostrabile in maniera rigorosa, non è detto
che l’esperienza religiosa sia qualcosa d’irrazionale, da accettare per cieco fideismo. Pur ammettendo, infatti, che le prove
dell’esistenza di Dio non siano cogenti, ciò non significa che
l’autosufficienza del mondo sia evidente e che tutti i problemi
siano perciò risolti. La filosofia, quindi, giustamente s’interroga
su Dio, e forse, pur con crescente consapevolezza dei propri
limiti, non cesserà mai di farlo. Ma, se non trova una soluzione
definitiva161, lascia almeno spazio a esperienze di altro genere.
Fatto salvo, dunque, il valore dell’interrogazione filosofica sul
senso ultimo delle cose, e ridimensionata la pretesa di trovare con la ragione risposte incontrovertibili, credo che l’atteggiamento più ragionevole sia quello del rispetto per le diverse possibili opzioni riguardanti l’esistenza di Dio162. Non tutto,
infatti, è dimostrabile o esprimibile col linguaggio della ragione163: come descrivere, per esempio, in termini concettuali l’esperienza dell’amore tra due persone? In effetti, è impossibile
tradurre in linguaggio razionale la certezza di amare e di essere
amati, ma ciò non significa che si tratti di esperienze irrazionali. A buon diritto Pascal ricordava che “il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce”164.
Anche se non fosse dimostrabile razionalmente, l’ipotesi Dio
potrebbe quindi essere tuttavia plausibile, e magari più credibile di quella di una natura divinizzata. L’esperienza, infatti, ci
dice che la realtà è a un tempo affascinante e terribile: bellezza che riempie l’animo di ammirazione e problematicità che
interroga la ragione, e non solo la ragione. Inevitabile allora
chiedersi: il mondo ha o no un senso? E si può essere davvero
certi che tale senso ci sia o non ci sia? Mentre il pensiero s’interroga, la vita pone di fronte alla necessità di fare delle scelte
andando non contro ma oltre la pura ragione. Credere che la
realtà abbia un senso, guardare alla vita con fiducia nonostante i suoi aspetti drammatici non è certo un’opzione irragione62
vole, e anzi questa fiducia è tanto più ragionevole quanto più
essa trova il suo fondamento in quella X che chiamiamo Dio165.
In tale prospettiva, l’esistenza di Dio è dunque non oggetto di
dimostrazione ma di fede, intesa come fiducia, certo spesso
condizionata da fattori accidentali166, nella possibilità che il
mondo e la storia e la vita umana abbiano un senso. E in effetti
“coloro che professano tale fede, siano essi cristiani o non-cristiani, vengono definiti a ragione credenti in Dio”167. Come nel
caso dell’ateismo, che crede che il mondo dell’esperienza non
esiga ulteriori spiegazioni, si tratta qui certamente di una scelta di fede, non però arbitraria ma plausibile; di una decisione,
sempre esposta al dubbio, che crede “nella pienezza ultima di
significato e valore della realtà, nell’origine, nel senso e valore
supremo che [in qualche modo] traspaiono in superficie”168.
Limiti del linguaggio religioso
Se non è detto che l’esperienza religiosa sia qualcosa d’irrazionale, resta vero che un linguaggio che parla di Dio come di un
Padre o di uno Sposo, e che in questi termini gli si rivolge nella
preghiera, ha però i suoi pericoli, perché tali immagini rischiano costantemente di essere prese alla lettera, suscitando l’illusione di conoscere la realtà ultima169. Tuttavia, questo rischio
è ineliminabile170, perché l’uomo non può riferirsi a Dio che
muovendo dalla propria esperienza umana, tanto che non solo
le immagini più grossolane ma persino il linguaggio teologico
più rigoroso e raffinato sono sempre inadeguati per parlare di
Dio, che resta in se stesso inconoscibile171.
Per evitare di cadere nell’antropomorfismo più ingenuo è perciò necessario che i credenti abbiano una coscienza, costantemente rinnovata, del fatto che sia le immagini mitiche sia
i concetti utilizzati per offrirne un ripensamento sistematico
sono prodotti dell’uomo e non raggiungono la realtà di Dio.
Il valore puramente simbolico delle rappresentazioni di Dio è
efficacemente messo in rilievo dal Kaufman mediante la di63
stinzione di due termini di riferimento per la parola ‘Dio’: uno
accessibile, l’immagine costruita dall’uomo mediante le metafore del linguaggio religioso, e uno reale, che resta inevitabilmente misterioso.
È solo grazie al termine di riferimento accessibile che Dio influisce sulla vita dei credenti, mentre “il vero termine di riferimento che corrisponde a ‘Dio’ non ci è mai accessibile, come
non è offerto alla nostra osservazione o alla nostra esperienza.
Esso deve restare sempre un X sconosciuto, una semplice idealimite senza contenuto. Ciò consegue dal fatto che Dio trascende la nostra conoscenza secondo modi e forme che non conosceremo mai e di cui non abbiamo neanche alcun sospetto”172.
In conclusione
L’interpretazione in termini religiosi della realtà resta, dunque,
frutto di una libera scelta, che ha tuttavia le sue ragioni. L’identificazione del mistero ultimo con Dio è, infatti, opera di
quell’atteggiamento, che nell’esperienza religiosa è chiamato ‘fede’, per cui si accetta qualcosa che non è verificabile in
modo puramente razionale. E la giustificazione più efficace
della ragionevolezza della scelta religiosa, della sua capacità
di fondare, con la speranza in Dio, l’impegno volto, nonostante
tutte le smentite della storia, alla costruzione di un mondo più
umano, potrebbe essere costituita, ancor più che dagli argomenti teorici, dalla vita stessa dei credenti.
Infatti, pur divise quanto alla dottrina, le grandi tradizioni religiose – dal confucianesimo al buddismo e all’induismo, dall’ebraismo al cristianesimo e all’islamismo – non pongono tutte
l’accento su una prassi che renda la vita umanamente degna?
Non concordano su un principio che, pur con numerose varianti, si può sintetizzare così: non fare agli altri ciò che non
vorresti fosse fatto a te? E forse proprio i testi fondativi dell’esperienza cristiana suggeriscono qualcosa del genere, esigendo più che una rigorosa ortodossia, e cioè una corretta cono64
scenza della verità, una generosa ortoprassi, e cioè una vita
fondata sulla giustizia e sull’amore. Conosce veramente Dio chi
difende il povero e l’indigente173, si legge nell’Antico Testamento, perché, conferma il Nuovo, “nessuno mai ha visto Dio; se
ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è
perfetto in noi”174.
65
MARIO TROMBINO
CHI È DIO?
LA RICERCA FILOSOFICA SU DIO, NEL SUO RAPPORTO COL MONDO
E CON L’UOMO, NELL’ETÀ DELLA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA
All’inizio del Seicento Francesco Bacone ha sostenuto che «la
natura si comanda obbedendole».
Diceva una cosa ovvia, ma a volte le cose ovvie, se usate come
linee-guida per la ricerca e l’azione, possono assumere un ruolo dirompente.
Qui le ovvietà poi sono due:
- È ovvio che se vogliamo che la natura si comporti secondo i
nostri desideri dobbiamo dominarla: di per sé la natura non è
affatto sotto il nostro comando.
- È ovvio che dominare la natura non significa cambiarne le
leggi, ma solo sfruttarle ai nostri fini.
Corollario a quanto diceva Bacone è quindi una sua seconda
massima, davvero lapidaria: «sapere è potere». Vogliamo dominare la natura perché esegua i nostri ordini? Non possiamo
fare questo cambiandone le leggi: niente miracoli. Ma possiamo far sì che le sue leggi siano sfruttate ai nostri fini. È quindi
ovvio che queste leggi dobbiamo conoscerle. È questo a darci
il potere sulla natura: sapere è quindi potere.
66
Immagino che stiate pensando: cosa c’entra questo con Dio, e
soprattutto con la domanda “chi è Dio?”
Non è forse la scienza ad occuparsi della ricerca sulle leggi della natura, e non è alla scienza che i tecnici si rivolgono per avere gli strumenti tecnologici con cui dominarla? E la scienza non
si pone problemi teologici: si ferma ai problemi che riguardano
la natura.
Ora, è indubbiamente così finché non si pongono domande
che riguardano le leggi che definiscono l’architettura profonda
della natura. Ma è ancora così quando ci si chiede che cosa
sono lo spazio e il tempo? È ancora così quando ci si chiede
perché le leggi della natura sono queste e non altre?
Gli scienziati sono persone prudentissime, quando sono davvero scienziati. E non usano spesso la parola Dio. O meglio non
la usano più, se non metaforicamente (come quando Einstein
dice che Dio non gioca a dadi). Bene, usiamo anche noi un altro termine. Ma di cos’altro sta parlando uno scienziato quando si chiede quali sono le forze fondamentali della natura che
la unificano sino a formare un Tutto, e qual è il loro fondamento, cioè la ragione per cui sono così e non altrimenti?
Al contrario di adesso, nel linguaggio scientifico del Seicento il
termine Dio è ancora di casa. Non indica mai, in nessun caso,
il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe – cioè il Dio della rivelazione che per i filosofi-scienziati del Seicento è ancora pericoloso da indagare (si rischia il carcere, o la vita, e non solo
in aree cattoliche). Indica il fondamento della natura. L’ente su
cui riposano le sue leggi, la sua architettura profonda e quindi,
in primo luogo, lo spazio e il tempo.
Perché è decisivo conoscere questo fondamento, se vogliamo
davvero comandare alla natura obbedendole? Perché finché
non avremo davvero capito quali sono le leggi che strutturano
questa architettura non potremo dire di sapere, e noi vogliamo
sapere perché sapere è potere.
67
Nel Seicento per gli scienziati Dio è quindi all’interno della loro
problematica scientifica. Ma non fa miracoli, non manda qualcuno a salvare gli uomini, non è oggetto di adorazione. È il fondamento su cui riposa la struttura della realtà. Quindi è ovvio
che ci sia: non è mai in discussione la sua esistenza, ma chi è, o
che cosa è. L’ateismo è di un’altra e ben diversa età: nasce nel
Seicento, quando porre domande sul fondamento della natura
non è più di moda e altre preoccupazioni governano la mente
degli scienziati, che ben raramente sono ancora filosofi. Il problema di Dio governa ancora la mente dei filosofi, ma ben difficilmente si tratta ancora di scienziati: scienza e filosofia hanno
ormai preso direzioni diverse.
È mia opinione che sia utile tornare al Seicento, e riunificare
filosofia e scienza – anzi filosofia e qualsiasi altra forma del sapere. Ho due argomentazioni da portare a sostegno di queste
tesi, ma ne accennerò solo brevemente, perché esulano dal
nostro argomento, che è limitato al Seicento:
- la prima argomentazione si basa sul fatto che un fondamento
delle leggi di natura, cioè una ragione per cui sono così e non
altrimenti, deve esserci, visto che la natura ha una architettura
interna e non un’altra;
- la seconda argomentazione si basa sul fatto che, come filosofo (cioè persona che vuole conoscere questo fondamento) è
del tutto irrilevante usare una via o l’altra (la filosofia, la scienza, l’arte, o altro): è rilevante conoscere qual è questo fondamento.
Sarà il caso di precisare che a questo fondamento in passato,
oltre che il nome di Dio, è stato a volte dato il nome di essere,
da Parmenide in poi in diretta contrapposizione col termine
nulla. Ora, il termine nulla (in frasi del tipo: perché c’è l’essere
piuttosto che il nulla?) non indica un contenuto del pensiero
(un’idea), ma due: l’essere e la negazione. Non si pensa mai
il nulla, come potrete rendervi conto con un semplice esperi68
mento mentale che adesso vi proporrò, ma solo qualcosa che
c’è, per poi negarlo. Il termine essere invece è una idea, non
due. Non che noi si sappia che cosa è (è quello che andiamo
cercando), ma non è affatto dubbio che ci sia: qualcosa c’è, lo
sappiamo attraverso l’esperienza del mondo esterno e attraverso le nostre sensazioni interne, a meno di non avere capito
nulla di nulla (cosa mai da escludere del tutto, per la necessaria prudenza di chi vuol sapere davvero). In discussione è che
cos’è l’essere di questa cosa che c’è, non se questo essere c’è.
Così ragiona uno scienziato del Seicento, che non dubita mai
che Dio esista, ma vuol sapere chi (o che cosa) è.
(Sull’impensabilità del nulla: guardatevi bene intorno, qui
ed ora; potete facilmente formarvi un’immagine mentale di
questa stanza e di me che vi parlo, e poiché venite da fuori
e sapete che lì c’è il centro storico di Leonessa, potete con la
memoria collocare le immagini che vedete adesso nello spazio
circostante; ma se nel corso di un esperimento mentale provate a eliminare a una a una le cose che vedete, poi Leonessa,
poi il vostro corpo, poi tutto il resto, non riuscirete a portare
sino in fondo l’esperimento e a togliere anche quel colore di
fondo che vi rimane in mente, scomparso tutto il resto: finché
pensate, pensate qualcosa; non accade mai che pensiate nulla;
il nulla, non essendo qualcosa, è impensabile.)
Le teorie che sono state elaborate nel corso del Seicento sono
riconducibili a tre famiglie:
- teorie che fanno riposare il fondamento del mondo su un Dio
unico, perfetto ed esterno alla fisicità della natura, quindi altro
rispetto allo spazio e al tempo: vedremo due esempi di questa
visione del fondamento delle leggi di natura, parecchio diversi
tra loro, nelle teorie di Cartesio e di Newton;
- teorie che ritengono impossibile sapere quale sia questo
fondamento, e quindi se l’immagine del Dio della tradizione
cristiana è corretta; ovviamente questa teoria lascia la scienza
69
stessa senza basi teoriche unitarie, perché sono queste basi
ad essere considerate inconoscibili (inconoscibili non vuol dire
che non ci sono: vuol dire che non possiamo sapere di che si
tratta); ne vedremo un esempio celeberrimo in Pascal;
- teorie che fanno riposare il fondamento del mondo su una
architettura interna ed eterna, sicché lo spazio e il tempo sono
visti come una delle infinite manifestazioni del Tutto (e quindi
il nostro universo fisico come una delle infinite realtà che esistono); l’esempio più celebre di questa visione è nelle teorie
di Spinoza.
È forse opportuno prima di descrivere queste teorie su Dio riflettere un momento sul fatto che le leggi di natura, per un
filosofo-scienziato del Seicento, riposano su due entità non direttamente riconducibili alla materia eppure dal preciso significato fisico: lo spazio e il tempo. Che cosa sono?
La difficoltà di sapere che cos’è lo spazio dipende dal fatto che
non ha caratteristiche che ci consentano di inquadrarlo nel
contesto delle nostre esperienze della materia: vediamo oggetti materiali nello spazio, facciamo esperienza dello spazio
attraverso il nostro corpo, ma lo spazio non sembra interagire
con la materia né è una cosa tra le cose. Ad esempio: di che
cosa è fatto? che cosa è lo spazio vuoto?
Anche da un punto di vista concettuale è una vera sfida: è finito
o infinito? Ne derivano paradossi nell’uno come nell’altro caso
(è finito: cosa c’è intorno? è infinito: come fanno due punti
nello stesso spazio ad essere ad una distanza infinita tra loro?).
Per il tempo le cose sono ancora più complesse: sulla base delle riflessioni dei Greci, è Agostino a sintetizzare il problema in
questi termini: il passato non c’è più, il futuro non c’è ancora, il
presente passa e non è mai identificabile in un momento che
non passi, sospeso quindi tra il passato e il futuro; dunque la
realtà del tempo, il suo essere, che cos’è?
Partiamo da qui perché qui è il problema. Non possiamo avere
70
alcuna comprensione reale delle leggi che governano la natura
(e quindi, baconianamente, non possiamo avere alcuna speranza di dominarla davvero) finché non avremo capito la realtà
dello spazio e del tempo, che fanno parte dell’architettura interna alla natura, non essendoci nessun ente naturale a nostra
conoscenza al di fuori dello spazio e del tempo. Dove hanno un
fondamento? e a quando risale questo fondamento?
Le due domande sono poste utilizzando lo spazio (dove?) e
il tempo (quando?), ma riguardano il loro fondamento. Ora,
questo fondamento è nello spazio e nel tempo?
Cartesio e Newton ritengono di no. Entrambi riposano su una
realtà eterna.
71
1. DIO COME FONDAMENTO UNITARIO
DELLA NATURA, ALTRO DALLO SPAZIO
E DAL TEMPO: CARTESIO
Cartesio scrive una quarantina d’anni prima di Newton, ed è
quindi corretto partire dalla sua risposta al problema. Con un
complesso ragionamento che si affida solo alle procedure interne alla mente senza nessun ricorso all’esperienza, Cartesio
ha ritenuto di poter dimostrare con certezza razionale che esiste un ente eterno, che ha le caratteristiche dell’infinità e della
perfezione.
Benché ne abbia proposto una versione ben integrata al contesto della sua teoria generale della mente, Cartesio riprende
di fatto un argomento sull’esistenza di Dio che risale a molti
secoli prima, essendo stato proposto da Anselmo d’Aosta già
nell’XI secolo. È il celebre argomento ontologico, argomento
che richiede una notevole attenzione per essere valutato.
Anselmo (in una cornice medioevale che in questo contesto
non gioca alcun ruolo importante, per cui non la riproporrò)
fa dialogare tra loro un credente e un non credente. Il credente porta il suo interlocutore ad accettare questa definizione di Dio: ciò di cui non si può pensare nulla di più grande.
I due non sono affatto d’accordo se un simile ente esista, ma
per poter discutere hanno bisogno di intendersi sulle parole,
e quindi innanzitutto sulla parola Dio. Esiste o non esiste?
È chiaro che una questione preliminare è: di cosa, o di chi,
stiamo parlando, chiedendoci se esiste o non esiste? Ebbene stiamo parlando dell’ente più grande, il più grande che io
possa pensare.
Ovvio che esista: deve esistere per forza, perché se penso
quest’ente non esistente non è il più grande che io posso pensare. Io, infatti, posso pensarne uno che ha tutte le “grandezze” del primo, e in più l’esistenza.
72
L’argomento è apparso a molti un sofisma, uno di quei ragionamenti di cui ti chiedi dov’è il trucco, come in uno spettacolo
di illusionismo. Ma non è affatto stato proposto come un sofisma, e Anselmo (e Cartesio, e molti altri prima e dopo di lui,
e io concordo con loro) lo difende contro le accuse: il punto è
che un ente totale può essere pensato, ed è difficile sostenere
che non esiste, visto che esiste qualcosa.
Anselmo, e poi Cartesio, non lo identificano con la totalità della realtà, perché utilizzano la nozione cristiana di creazione,
sostenendo che qualsiasi ente deriva da questo fondamento
assoluto.
Cartesio lo considera del tutto indipendente dallo spazio e dal
tempo perché la sua realtà non può essere soggetta a nessuna
incompletezza: e qualsiasi realtà nello spazio-tempo lo è, perché non è mai tutta insieme. Diviene, non semplicemente è.
Eternità non significa dunque affatto la permanenza in tutti i
tempi, perché sono i tempi a non coesistere tra loro (il passato
non coesiste col presente, e così via). Eternità è piuttosto l’esistere senza tempo, qualcosa di cui noi – figli del tempo – possiamo solo formarci concetti vagamente nebulosi, matematica
a parte (ma Cartesio ragiona proprio da matematico: e gli enti
matematici non hanno tempo).
Nella visione cartesiana della natura Dio ha quindi il ruolo di
fondamento. Ed avendo la natura caratteri spazio-temporali,
ha il ruolo di fondamento esterno. Dio non è natura. Ma la conoscenza di Dio è essenziale per la conoscenza della natura
perché altrimenti non conosceremmo il fondamento delle leggi di natura, che invece sono per Cartesio molto chiare una
volta posto il loro fondamento in Dio.
La natura e lo spazio coincidono, non esiste alcuno spazio vuoto per la semplice ragione che dire spazio e dire materia è la
stessa cosa: due nomi per lo stesso ente.
Questo spazio-materia (il termine latino cartesiano è res esten73
sa, cioè sostanza estesa) è dotato di leggi interne che trovano
la loro ragion d’essere nell’azione “eterna” di Dio che crea così
la natura, e non altrimenti. Dio è un Dio-geometra, e la natura
è una macchina spazio-temporale in cui le forze interne sono
in movimento così come, all’origine, è stato definito.
Questa visione della natura come macchina, alla quale apparteniamo anche noi avendo un corpo materiale, pone in Cartesio un serio problema, definibile in questi termini: poiché l’uomo non è solo corpo, ma anche qualcosa di non riconducibile
alla materia, cioè il pensiero, l’uomo appartiene interamente
alla natura?
La risposta cartesiana, molto celebre, è negativa: l’uomo non è
affatto solo natura, è anche un ente che non ha caratteristiche
spazio-temporali: è una sostanza che pensa (nel latino di Cartesio: res cogitans) totalmente altra rispetto alla natura.
Due enti in uno. Letteralmente. Ed entrambi riconducibili,
quanto ai loro fondamenti, a Dio. Questo spiega perché è pensabile che l’anima-mente (che per Cartesio è pensiero) sopravviva dopo la morte: semplicemente perché non appartiene
allo stesso ordine spazio-temporale della natura, ma vi è solo
(provvisoriamente) collegato nell’unità della vita umana. Ma
l’anima-mente-pensiero non ne dipende in realtà nel suo essere.
La lucida visione cartesiana crollerebbe interamente senza il
Dio-geometra che spiega sia la natura che la mente. Le leggi
che governano questi enti risulterebbero incomprensibili: potrebbero forse essere descritte, enunciate in termini logici e
matematici, ma non compresi. In effetti, si pensi all’analogia
con una macchina. Se un ente capace di far ricerca scientifica
proveniente da un altro pianeta visitasse il nostro pianeta e
studiasse le automobili parcheggiate nel parcheggio del nostro
albergo senza badare agli uomini, e si chiedesse che cosa sono,
74
potrebbe senza difficoltà (se possiede le stesse conoscenze sulla natura che possediamo noi – e soprattutto che possiedono
gli ingegneri che le hanno progettate!) comprendere le leggi
che ne consentono il funzionamento, ma fino a che non risalisse a chi le ha costruite e al motivo per cui sono state costruite
non potrebbe dire di avere capito che cosa sono le automobili.
Se guardiamo, come faremo stasera, il cielo stellato, questa
immensa e complessa macchina di cui conosciamo ormai le
leggi matematiche che ne governano il movimento e l’intima
struttura, che senso ha non cercare di risalire al loro fondamento?
Forse Cartesio ha torto e le cose non stanno come pensa lui.
Ma in qualche modo devono pur stare, no?
75
2. DIO COME FONDAMENTO UNITARIO
DELLA NATURA, ALTRO DALLO SPAZIO
E DAL TEMPO: NEWTON
Una quarantina d’anni dopo l’elaborazione delle teorie cartesiane, l’idea che la natura sia una macchina aveva conquistato i
cuori e le menti degli scienziati. Ma, certo, una macchina veramente complessa. Complessa al punto da non poterne definire le leggi in modo unitario e coerente? Diciamo mediante un
numero limitato di equazioni?
L’unificazione completa delle forze che formano l’architettura
interna della natura attraverso la loro descrizione in un complesso organico di teorie a base matematica è un compito che
la scienza si è dato, ma non è stato portato a termine neppure
oggi. Un tassello decisivo però venne proposto da Newton alla
fine del Seicento nel suo celebre Principi matematici della filosofia naturale, in cui tutti i fenomeni riconducibili alla gravità
venivano interpretati unitariamente e unificati in una teoria
rigorosa e descritta matematicamente.
Nei decenni successivi si poté osservare che il grado di precisione con cui la teoria newtoniana poteva descrivere (e quindi
prevedere) il comportamento della natura era altissimo. Il modello galileiano-newtoniano finì col diventare, e restò a lungo,
il paradigma stesso della scienza.
In una sorta di commento al testo, aggiunto in una seconda
edizione, Newton precisò che il fondamento della sua teoria
riposava su un preciso ruolo assegnato a Dio nell’ordine fisico
del mondo. Non che di questo Dio si possa dire molto: Newton
riconosce anzi il fatto che non sappiamo quasi nulla di Lui e
soprattutto del modo in cui conosce il mondo e agisce. Ma è
assolutamente necessario – da un punto di vista fisico – ammetterne l’esistenza e assegnargli un ruolo perché lo spazio e
il tempo nella teoria newtoniana sono “assoluti”, realtà dalle
caratteristiche immutabili e costanti che non possono essere
76
spiegate se non ricorrendo ad un fondamento in una realtà
assoluta.
Ed è questa assolutezza il carattere di Dio che importa sottolineare: “Dura sempre ed è presente ovunque, ed esistendo
sempre ed ovunque, fonda la durata e lo spazio”. Così Newton
nel suo Scolio generale, che avete in fotocopia.
Questa necessità di un ancoraggio assoluto della fisica in Dio
è tipica dell’impostazione newtoniana della teoria della gravitazione universale. Nel corso del Settecento, insoddisfatti del
mistero che questa impostazione porta con sé sui fondamenti
gli scienziati cercheranno altre strade, che non prevedono un
ancoraggio in Dio. Non che sia venuta meno la questione dei
fondamenti: non è mai venuta meno, nemmeno nel XXI secolo.
È che la scienza ha cominciato a muoversi sul suo terreno, là
dove la luce che la ricerca può fare sul comportamento della
natura è, per così dire, a portata di mano, per quanto complesso sia il lavoro dei ricercatori, e lungo nel tempo. I problemi sui
fondamenti sono rimasti sullo sfondo, ripresi solo dalle ultime
generazioni di scienziati a noi più vicini.
Newton non sarebbe d’accordo. È passato alla storia per la teoria della gravitazione universale e per altre teorie fondamentali
(ad esempio sulla natura della luce), ma la sua ricerca non si è
mai limitata all’ambito della teoria fisica. È stato un grandissimo
esperto di metalli, e nei laboratori annessi al suo studio a Cambridge i forni erano accesi giorno e notte. Studiava antichi testi,
la tradizione teologica era al centro dei suoi interessi. Cosa cercava nella chimica dei metalli, nella Sacra Scrittura, in ricerche
estese in ogni direzione, a 360 gradi, del tutto al di fuori di quelli
che dopo sarebbero diventati i confini della scienza?
Ceracava quello che cercava con le sue ricerche di ottica, di
fisica teorica, di matematica: la comprensione profonda delle
leggi che governano la realtà. La natura? Non solo: la realtà.
Tutta. Dio compreso.
77
3. DIO COME FONDAMENTO UNITARIO
DELLA NATURA, MA IL FONDAMENTO
NON SI TROVA: PASCAL
Negli anni che stanno tra Cartesio e Newton, Pascal si è dedicato alla stesura di materiali per una sorta di apologia del Cristianesimo. Non si trattava affatto del “Dio dei filosofi”, ma di
quello “di Abramo, di Isacco e di Giacobbe”. La differenza è notevole, perché il primo è oggetto di una conoscenza che chiede
di essere scientifica, il secondo è oggetto di fede. Ed è a questa
che Pascal pensa, dedicando al contempo riflessioni fondamentali al Dio della scienza (e, per conseguenza, alla stessa natura
della scienza). E, vale la pena anticiparlo, Pascal scrive per le
persone della sua cerchia, molti dei quali erano scienziati, ma
“libertini”, profondamente scettici in sede religiosa.
Certo, nell’ambiente giansenista in cui Pascal viveva e a cui
aderiva, non è scontato che avesse senso una apologia del
Cristianesimo. Tutto sommato, infatti, per un giansenista Dio
salva chi vuole, e la schiera degli eletti è piccola; è inoltre del
tutto incomprensibile per l’uomo sulla base di quale criterio
Dio conceda la sua grazia che salva, né esiste il benché minimo indizio che permetta di stabilire se un uomo sia o meno
tra gli eletti. Dunque, non potendo l’uomo di fatto far nulla di
concreto per ottenere questa grazia, ed essendo essa un libero dono di Dio, che senso ha un’apologia del Cristianesimo,
che inviti gli uomini, e i libertini in specifico, ad aderire alla
fede? La stessa fede, in fondo, è un dono di Dio, e se non si ha
questo dono non si riesce a credere neppur volendo (Pascal lo
chiarirà nel celebre brano sulla “scommessa” a favore dell’esistenza di Dio).
Per rispondere a questi interrogativi sollevati da vari interpreti,
è opportuno riportare un passo del giansenista Barcos citato
da Goldmann: “Quanto a voi che mi dite: se io sono nel numero dei reprobi, che cosa mi vale praticare il bene? Non siete
78
forse troppo crudele verso voi stesso destinandovi alla peggiore infelicità, senza sapere se Iddio vi abbia o no destinato
ad essa? Egli non vi ha rivelato il segreto della sua decisione
sulla nostra salvezza o la nostra dannazione. Perché vi attendete più i castighi della sua giustizia che non le grazie della sua
misericordia? Forse egli vi concederà la sua grazia, e forse no,
ma perché non sperate nella stessa misura in cui temete (…)?
Con la disperazione perdete infallibilmente quello che forse la
speranza vi potrebbe dare. (…) Ma a che cosa mi serviranno le
buone opere, se non sono predestinato? Che cosa perdete se
obbedendo al vostro creatore, amandolo, facendo la sua volontà, o meglio, che cosa non guadagnerete se vivete e perseverate nell’amarlo? (…) Non costituisce forse il vostro bene e
la vostra felicità sia sulla terra che in cielo l’adorarlo, l’amarlo
e il seguirlo?”.
Se erano queste le idee che circolavano negli ambienti giansenisti vicino a Pascal, la decisione di spendere le proprie ultime energie (Pascal era molto malato, e ormai vicino alla fine,
al momento in cui mise mano al progetto di una apologia del
Cristianesimo) per convincere il “mondo” a convertirsi e ad
cercare Dio – il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non
quello dei filosofi! – appare motivata: come dirà nelle battute
conclusive del brano sulla scommessa, è bene per l’uomo vivere come se Dio esistesse. Nella insensatezza della vita, in Lui
risiede la concreta felicità.
E non sappiamo se esiste!
Infatti, che cosa significa sapere? Si tratta di individuare quali
sono le fonti della conoscenza. Su quale fondamento è possibile costruire un percorso di ricerca della verità?
Sono i grandi temi della ricerca filosofica di Cartesio, temi che
all’epoca della formazione giovanile di Pascal erano all’ordine
del giorno nella Francia colta alla quale la famiglia Pascal apparteneva. Più in generale sono i temi del secolo, dominato
79
dalla questione del metodo della ricerca scientifica e dallo studio della mente dell’uomo.
Ora, Pascal distingue radicalmente
- la fondazione teologica della conoscenza, che riposa su
una fonte esterna (le Scritture in quanto verità rivelata) e
su una interna all’uomo (la facoltà di conoscenza che Pascal
chiama cuore);
- la fondazione filosofica della conoscenza, che si basa
esclusivamente sulle facoltà di conoscenza dell’uomo, che
operano con stili e modalità diverse, ma dipendono comunque solo da lui (e, a monte, dal doppio ordine della natura
di cui l’uomo è espressione: l’ordine materiale a cui appartiene il corpo, l’ordine spirituale a cui appartiene lo spirito).
Tra le due fondazioni non c’è né ci potrà essere alcuna comune
misura né mai il sapere umano potrà avere una sola fondazione.
Le ragioni sono riassumibili in sintesi in questo modo:
a) le facoltà di conoscenza dell’uomo non possono, per la
loro stessa natura, accedere all’infinito e al tutto (e la teologia appartiene a quest’ordine); hanno però nello stesso campo
scientifico l’esigenza insopprimibile di accedere all’infinito e al
tutto, un’esigenza che non può essere né soppressa né soddisfatta: infatti
- l’infinito è chiamato in causa in qualsiasi tipo di conoscenza come possibilità o necessità logica (lo richiede l’immaginazione che vede il finito e si chiede che cosa c’è oltre; lo
richiede la ragione, che pone domande sulla infinità dello
spazio, dei numeri, e così via);
- qualsiasi conoscenza parziale è, in modo compiuto, comprensibile solo come frammento del tutto (quindi senza conoscere il tutto la conoscenza delle parti rimane per forza
di cose parziale e, in fondo, limitata);
80
b) la facoltà del cuore è fondamentale
- tanto per la conoscenza scientifica, perché è quella che
consente di intuire in modo compiuto i principi delle scienze (ad esempio gli assiomi e i postulati della matematica),
- quanto per la conoscenza di Dio, perché Dio nel rivelarsi
all’uomo con la rivelazione parla al cuore e non alla ragione; ma il cuore può non essere sensibile a questa rivelazione (serve la fede perché l’uomo sia sensibile e ascolti Dio)
né la conoscenza che ne deriva può essere armonizzata con
le conoscenze che derivano all’uomo dall’uso delle altre facoltà.
Uno stesso uomo, quindi,
- con la ragione ha l’esigenza di accedere al mondo dell’infinito e del tutto, e non può;
- con il cuore è in grado di accedere ai principi delle scienze (che comunque non appartengono all’ordine dell’infinito e del tutto, ma restano al finito), dai quali la ragione parte per la costruzione delle teorie scientifiche;
- sempre con il cuore è anche in grado di comprendere la
rivelazione con cui Dio gli parla, se ha fede;
- non è però mai in grado di integrare la conoscenza razionale con la conoscenza di Dio, perché la ragione non può
fare sull’intuizione di Dio offertale dal cuore (se gliela offre,
e non è detto che lo faccia) lo stesso tipo di operazioni che
compie sull’intuizione che lo stesso cuore offre (sempre)
dei principi scientifici: sull’intuizione dei postulati la ragione costruisce una geometria; sull’intuizione di Dio non costruisce nulla.
L’infinito e il tutto, quindi anche Dio, sono al di fuori della sua
portata. Non solo Dio, s’intende, ma tutto il campo dell’infinito
e del tutto: quindi una teoria scientifica sulla natura dell’infinito è impossibile da costruire e altrettanto lo è una teoria del
81
tutto. A maggior ragione è impossibile costruire una teoria del
tutto che comprenda Dio (il contrasto con la metafisica, ed anche con la concezione della scienza, cartesiana non potrebbe
essere più netto).
Lo ripetiamo: tra le due fondazioni non c’è né ci potrà essere
alcuna comune misura né mai il sapere umano potrà avere una
sola fondazione.
Tuttavia...
Tuttavia Pascal ha un problema pratico: intende, da cristiano,
scrivere un’opera apologetica che è innanzitutto rivolta alle
persone della sua cerchia; quindi a intellettuali colti, spregiudicati, abituati alla logica della ricerca scientifica, a volte libertini,
a volte scettici. Deve parlare alla loro ragione, non solo al loro
cuore.
Deve quindi mostrare due cose:
- che la ragione non può sapere nulla su Dio: nulla, neppure
qualcosa che ne neghi l’esistenza; quella di Dio è quindi una
possibilità aperta per l’uomo di scienza, non in contraddizione con le sue ricerche scientifiche e con il sapere consolidato che la scienza consente (peraltro, per le ragioni che
prima elencavamo, quello scientifico è un sapere sempre
frammentario, parziale, anche se progressivamente estendibile);
- che c’è un motivo preciso per cui il cuore può non essere
disponibile ad ascoltare la rivelazione che Dio fa all’uomo:
il cuore può essere reso insensibile dalle passioni, che vanno quindi (per calcolo razionale) tenute sotto controllo (tesi
che non può non suonar bene ad orecchie abituate alla filosofia e ai suoi modelli tradizionali di razionalità).
Pascal si trova quindi, per così dire, a ragionare ai bordi dell’inconoscibile. Ad usare le armi della ragione restando nel suo
82
campo, ma al confine. E il confine, naturalmente, ha un versante che è al di là del conoscibile, proprio perché è un confine.
Ora, la ragione opera con l’obiettivo di conoscere la realtà, che
tuttavia ha più di una caratteristica strana: non è mai interamente presente, non è mai, per così dire, reale tutta insieme.
È infatti soggetta al fluire del tempo e ha aspetti, con tutta evidenza, infiniti. Ma Pascal ha sostenuto che la conoscenza di
una parte non è pienamente possibile se non si conosce il tutto
di cui è parte. Quindi per l’uomo non è mai possibile usare la
ragione in modo da poter dire di conoscere pienamente l’oggetto studiato. La ragione richiede un’apertura verso ciò che
non c’è, o è diversamente, e che (non essendoci, o essendo
diversamente) è tuttavia parte dello stesso tutto di cui è parte
ciò che c’è: il riferimento è
- a ciò che non c’è più (il passato);
- a ciò che non c’è ancora (il futuro);
- alle realtà infinite di cui abbiano notizia ma che non sappiamo che realtà hanno (ad esempio il numero infinito, o
l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande nello spazio).
La dimensione della realtà in cui vive l’uomo, e alla quale appartiene (non interamente) è collocata tra due confini, che la
ragione conosce come confini, ma che non supera (non ne conosce quindi il bordo esterno, che pure sa esistere, essendo
un confine):
- rispetto al tempo è nel presente; questo significa che l’uomo esiste e vive tra i confini del passato (la cui realtà è al
di là della sua comprensione) e del futuro (la cui realtà è
egualmente al di là, e soprattutto è fuori dal suo controllo);
- rispetto allo spazio l’uomo esiste e vive nella dimensione
finita del suo corpo e dell’ambiente esterno, tra i confini
dell’infinitamente piccolo (basta pensare alle parti di cui
è composto un acaro per averne l’immagine simbolica) e
83
dell’infinitamente grande (basta guardare il cielo per averne un segno).
Da qualsiasi parte la ragione osservi il mondo, lo trova circondato nella sua realtà da un mistero di cui nulla sa e verso cui
non ha strumenti.
Non sorprende quindi che Pascal abbia usato le armi della
ragione per esplorare questi confini, senza mai superarli per
l’impossibilità per l’uomo di farlo. E tuttavia senza rinunciare a
nessuna delle sue armi.
Nasce così uno dei più “strani” e controversi argomenti razionali a sostegno dell’esistenza di Dio: è il celebre argomento
della scommessa, su cui la letteratura filosofica riporta molte
posizioni.
L’argomento è costruito intorno alla nozione di probabilità,
uno di quei concetti matematici che avevano attratto l’attenzione di Pascal. Era successo non nel contesto di ricerche
scientifiche, ma ai tavoli da gioco: proprio in quel mondo che
Pascal aveva ben frequentato nel suo periodo mondano a cui
appartenevano le persone a cui con la sua apologia del cristianesimo intendeva rivolgersi.
Pascal aveva scambiato molte osservazioni con altri su questo
tema, e aveva, da matematico, costruito alcuni ragionamenti
e sostenuto alcune tesi che, per noi, costituiscono le basi del
moderno calcolo della probabilità (ci restano alcune lettere di
Pascal su questo tema).
Nessuno obietterà che ci si stia movendo al di fuori dei limiti
del finito e delle possibilità di conoscenza della ragione. È vero
che ogni ragionamento sulla probabilità è un calcolo di tipo
matematico
- su realtà che non si conoscono ancora (qual è la probabilità che, gettando i dadi, esca una certa combinazione delle
loro facce?)
84
- e che implicano un ragionamento sul nulla (gettando i
dati, comparirà una e una sola combinazione, ma il calcolo
riguarda anche tutte le possibili, che non saranno mai reali
in quel lancio di dati e sono quindi un puro nulla).
Questo non spaventa certo un matematico, abituato a ragionare, e quindi a calcolare, trattando lo zero come un numero,
quindi come una realtà, seppure molto diversa dalle altre. (Ai
tempi di Pascal, ed anche sotto il suo impulso, stava anche sviluppandosi il calcolo che tratta l’infinito come una realtà calcolabile: Pascal era ancora molto sospettoso sul tema, ben a
ragione dato il livello a cui era giunta la discussione nei suoi
anni, ma la generazione successiva alla sua è quella dei Leibniz
e dei Newton, che di questo calcolo sarebbero venuti a capo).
Siamo ai confini della realtà e della conoscibilità del reale, ma
sul bordo interno. Lì, e senza spostarsi da lì, Pascal scommette
sull’esistenza di Dio, proponendo il suo argomento ad un ipotetico interlocutore. È essenziale comprendere che Pascal non
sta affatto portando la ragione del suo interlocutore al di fuori
dei limiti delle sue possibilità. Se lo facesse, l’argomento non
sarebbe più razionale e cadrebbe, agli occhi di chi non ha fede.
E infatti non cade (non per questa ragione, almeno!):
- si parte dalla constatazione che la ragione non ha nulla
da dire, né in positivo né in negativo, sull’esistenza di Dio,
perché questa ricerca è al di fuori dei confini su cui ha strumenti per operare;
- si constata che l’uomo (non la ragione: l’uomo, come soggetto pensante che ha una dimensione esistenziale assai
più ampia e complessa rispetto a quella sola della ragione)
non può non scegliere se Dio esiste o meno, ma deve farlo
necessariamente (non è libero di essere libero se scegliere
o meno);
- si enunciano le probabilità che Dio esista, e le si trovano
perfettamente pari (è un calcolo razionale quello che viene
85
proposto);
- si propone un calcolo razionale degli esiti delle due possibilità, e si trova che puntare su una (che Dio esista) è infinitamente più conveniente che puntare sull’altra.
Non sono importanti tanto i dettagli di quest’ultimo calcolo,
molto tecnico e legato agli studi sulla teoria della probabilità
di Pascal; è importante sapere che di un calcolo matematico si
tratta: Pascal non fa un ragionamento su cose che la ragione
non sa (se esiste Dio), ma su cose che sa benissimo (che cosa
dobbiamo supporre accada all’uomo nel caso che una delle
due possibilità, pari tra loro, sia reale – e una delle due non
può non essere reale: Dio esiste o non esiste).
La ragione non è andata oltre se stessa. Ha calcolato la possibilità dell’essere totale e del nulla e le ha trovate uguali; ha posto
a confronto il finito con ciò che è possibile stia al bordo esterno
dei suoi limiti (il nulla e l’infinito). Ha calcolato.
Né più né meno che chiedersi che cosa accade, per riproporre
il celebre esempio di Pascal, se sottraiamo 4 da 0. O se ci chiediamo se la metà di un infinito è infinito e quindi pari al tutto
di cui è metà.
La scommessa di Pascal non dice se Dio esiste o meno: non è in
senso stretto una prova dell’esistenza di Dio, ma un argomento
a favore della scelta per l’esistenza di Dio. Il testo esamina se,
all’uomo che intende seguire la sua ragione e solo la sua ragione, conviene scommettere che esiste o che non esiste. Perché
scommettere, dice Pascal, è necessario.
È un calcolo dell’utile, analogo ad ogni altro calcolo dell’utile
che le filosofie utilitariste non hanno mai smesso di proporre,
da Epicuro agli utilitaristi contemporanei: si parla di cose che
sono al di là di quelle che sappiamo, ma restando nei limiti di
quelle che sappiamo (che cosa conviene fare? è la domanda;
quando? nel futuro, anche immediato, ma comunque futuro,
che appunto non c’è ancora, non siamo certi se – per noi – ci
86
sarà, non è ancora reale e ha aspetti necessariamente ignoti; eppure una creatura razionale deve ben calcolare, se vuole
comportarsi in modo razionalmente tale da mirare al proprio
utile; sulla base di cosa calcolerà? sulla base dei dati che ha, e
non su altri).
87
4. DIO COME NATURA O, SE SI PREFERISCE,
COME TUTTO: SPINOZA
Negli stessi anni di Pascal, Spinoza ha elaborato una teoria che
suscitò subito un vasto interesse, ma era nota solo a una ristretta cerchia di studiosi di tutta Europa con cui Spinoza era in
contatto epistolare e ai suoi amici di Amsterdam che si riunivano per leggere i suoi scritti. Ma la sua opera principale, che
si intitola semplicemente Etica, venne pubblicata solo dopo la
sua morte, proprio dagli amici del circolo spinoziano di Amsterdam, quando ormai non c’erano più rischi per il filosofo.
Chiedo scusa se sarò costretto a introdure alcuni conceti molto
tecnici, ma la filosofia di Spinoza lo richiede. Ha una elevata
complessità tecnica, benché sia stata scritta in termini per nulla complessi.
Il concetto fondamentale è quello di sostanza, che ha una lunga storia prima di Spinoza. Il termine era presente nel lessico
di Cartesio, che lo usava per indicare ciò che non ha bisogno
d’altro per essere concepito. Seguendo questa definizione, sostanza potrebbe essere solamente Dio in quanto unica realtà
originaria e auto-sussistente. Cartesio aveva però definito sostanze anche la res cogitans (la realtà fisica) e la res extensa (la
realtà del pensiero) in quanto entrambe non hanno bisogno
d’altro per sussistere se non di Dio.
Spinoza riprende il significato originario in piena e completa coerenza: sostanza è “ciò che in sé e per sé si concepisce,
vale a dire ciò il cui concetto non ha bisogno del concetto di
un’altra cosa da cui debba essere formato”. Ciò significa che
per Spinoza la sostanza contiene in sé il proprio fondamento
ontologico e gnoseologico: essa, cioè, non ha bisogno di altro
né per esistere né per essere conosciuta, essendo una realtà
autonoma ontologicamente e concettualmente. Sono nozioni
che conosciamo, le abbiamo viste in Cartesio applicate a Dio.
Ma se si vuole essere coerenti, non può esistere null’altro oltre
88
la sostanza, quindi la Sostanza è, semplicemente, tutto – o, per
essere più chiari, è un nome per il Tutto. Nel lessico spinoziano
i termini Sostanza, Dio, Natura175, sono sinonimi e indicano il
Tutto.
Dire: totalità del reale, significa dire una cosa che va intesa in
senso assoluto e non relativo: non una realtà o l’altra, non un
tipo di realtà particolare (ad esempio: una realtà di fatto, una
mentale, una fisica, una potenziale, una virtuale, e così via),
non una forma o l’altra assunta dalle cose o dai pensieri nel
continuo trasformarsi a cui sono soggetti. Spinoza parla del
tutto: qualunque forma assuma, in qualsiasi tempo, in qualsiasi luogo, in qualsiasi dimensione, a noi nota o ignota.
Dove cercheremo il fondamento di questa totalità? Visto che
è la totalità, pensare che esista qualcosa di esterno ad essa
sarebbe contraddittorio, quindi la sua origine va cercata al suo
interno: nel linguaggio spinoziano, il Dio-Natura (il Tutto) è
causa di sé.
Abbiamo appena utilizzato due termini: interno/esterno per
riferirci alla ricerca dell’origine della totalità. Bisogna però prestare attenzione perché interno/esterno sono termini relativi:
ha un senso parlare di interno in relazione ad un esterno, e
viceversa. Ma il Dio-Natura non ha alcun esterno, e quindi in
senso proprio non ha neppure nulla di interno. Questa terminologia e questo apparato concettuale non possono essere
utilizzati in riferimento al Tutto, ma possono essere utilizzati
in modo proprio se si parla dell’una o dell’altra forma che la
realtà assume.
Quindi:
- utilizzerò la nozione di assoluto per indicare ciò a cui non
si possono applicare i termini che hanno senso solo in relazione a termini opposti (come interno-esterno, sé-altro);
diremo quindi che il Dio-Natura è un essere assolutamente
89
infinito: non cioè un infinito che possa essere contrapposto
o distinto dal finito o da altri infiniti (ad esempio: l’infinitamente piccolo contrapposto all’infinitamente grande; l’infinito della serie dei numeri distinto dall’infinità dello spazio,
e così via), ma un infinito in assoluto, fonte di ogni distinzione e di ogni possibile relazione; va precisato che dire che il
Dio-Natura deve essere concepito come infinito è del tutto
ovvio, perché altrimenti si dovrebbe concepire qualcosa di
esterno che lo limita e lo rende finito;
- utilizzerò invece le nozioni relative (sé-altro, finito-infinito,
bene-male, e così via) per indicare il carattere di una particolare modalità dell’essere del Dio-Natura: parleremo secondo verità a patto di ricordare che non si tratta di nozioni
assolute, e cioè che niente è in sé bene e niente è in sé
male, ma si dice bene o male di qualcosa solo in relazione
a qualcos’altro.
Spinoza, con una catena di deduzioni, individua le proprietà
della sostanza:
- è increata perché non ha bisogno di altro per esistere essendo causa di sé;
- è eterna perché possiede l’esistenza che non riceve da altro;
- è infinita perché se fosse finita dipenderebbe da altro da
sé;
- è unica perché se ci fossero molteplici sostanze della stessa natura, queste si limiterebbero reciprocamente.
Queste deduzioni, a partire dalla definizione di sostanza fornita, portano Spinoza ad affermare che la sostanza, come abbiamo anticipato all’inizio, coincide con Dio o l’Assoluto. E questo
Dio, avendo in sé la propria ragione d’essere, non può non esistere.
90
Se, utilizzando una definizione vera, ossia una frase che individui la vera essenza della cosa definita, definiamo Dio (o Natura, o Sostanza) come un essere assolutamente infinito, ebbene
questo essere necessariamente esiste.
La nozione a cui il filosofo si riferisce, al di là delle dimostrazioni tecnicamente molto complesse, è intuitivamente comprensibile: l’ente di cui si parla è il Tutto (ciò di cui ogni cosa
esistente nella realtà delle cose e del pensiero è parte) ed è
quindi ovvio che esista per il solo fatto che lo si sta pensando e
se ne sta parlando. Qualcosa infatti esiste, ed è quindi razionalmente contraddittorio dire che il Tutto può non esistere.
Non si tratta quindi tanto di dimostrare che il Dio-Natura esiste, ma di accorgersi che è una contraddizione il pensiero che
non esista o che possa non esistere. Il che è lo stesso che dire
che il Dio-Natura esiste necessariamente.
Se il Dio-Natura è assolutamente infinito, allora la sua essenza
è infinita, e quindi nessuna specifica modalità in cui si esprime
può esaurirne la realtà. La mente vive in un mondo di pensieri,
che Cartesio ha definito come res cogitans, e concepisce il corpo come appartenente ad un universo fisico, che occupa una
estensione, un universo definito da Cartesio come res extensa.
Spinoza nota che queste due res (la traduzione italiana è sostanze) sono del tutto indipendenti l’una dall’altra, e Cartesio
ha molto ragione a sottolinearlo; ma appartengono comunque
al Tutto, e devono quindi essere concepite non come sostanze
a se stanti, ma come espressione di essenze diverse del DioNatura: propone di chiamarli attributi, intendendo con questo
termine le qualità essenziali o strutturali della sostanza, e di
utilizzare il termine sostanza esclusivamente per il Dio-Natura,
perché solo il tutto è realmente assoluto. Il pensiero e l’estensione sono quindi, scrive Spinoza, attribuiti della sostanza assoluta, perché ciascuno di essi ne esprime una certa essenza.
91
Bisogna a questo punto fare attenzione perché quando Spinoza parla del Dio-Natura non si riferisce all’universo fisico o
all’universo della mente, ma alla totalità che si esprime per
queste due vie. E poiché questa totalità è infinita in modo assoluto (e non relativamente a qualcosa), devono esistere infiniti attributi: ossia oltre all’estensione e al pensiero, devono
esistere infinite dimensioni dell’essere che esprimono infinite
essenze del tutto.
Tuttavia di questi infiniti attributi della totalità noi nulla sappiamo perché apparteniamo soltanto alla dimensione del pensiero e della materia estesa. Il dualismo cartesiano di pensiero ed
estensione deve conseguentemente essere rifiutato: pensiero
ed estensione non sono due realtà autonome, ma solo due
aspetti di un’unica realtà. E così pure Dio non può essere ridotto e racchiuso né nell’universo fisico né nella sola dimensione
del pensiero.
Se poi partiamo dalla considerazione delle singole cose e dei
singoli pensieri, si osserverà che ciascuna cosa e ciascun pensiero esprime in un certo modo, e non in un altro, una particolare essenza del Dio-Natura (l’essenza-pensiero o l’essenzaestensione: delle infinite altre essenze nulla possiamo dire,
se non che devono necessariamente esistere). Ma una cosa
o un pensiero ora c’è, ora non c’è. La loro realtà è instabile,
passa. Il loro passare non è però senza conseguenze e come
tutto ha una causa così tutto ha un effetto: dunque se si vuole
comprendere che cosa sono realmente una cosa e un pensiero, è necessario interpretarli come punti di una rete di cause
e di effetti. Presi isolatamente, sono incomprensibili. Diremo
dunque che ciascuna singola cosa e ciascun singolo pensiero è,
rispettivamente, un modo in cui nell’attributo dell’estensione e
nell’attributo del pensiero si esprime il Dio-Natura.
Schematizzando abbiamo quindi: il Dio-Natura, sostanza unica
e totale, realtà assolutamente infinita che esprime ciascuna
92
delle sue infinte essenze in infiniti suoi attributi che hanno infinite modalità, o modi, di essere.
L’Etica, l’opera in cui Spinoza espone questa teoria sul Tutto,
ha una specifica finalità etica: vuole indicare la strada per una
vita libera e felice. Il terzo, il quarto e il quinto libro si occupano
di questo ed espongono una teoria delle passioni, che applica
all’uomo quanto abbiamo fin qui detto.
Per iniziare ad indagare la vita emotiva dell’uomo e il modo in
cui questi può raggiungere la felicità, dobbiamo partire da due
domande fondamentali:
- il Dio-Natura è libero o agisce secondo l’intima necessità
della sua natura?
- l’uomo è libero, o il libero arbitrio è solo un’illusione?
La prima domanda ha una risposta che abbiamo già anticipato: Dio non è un soggetto, non è una persona che sceglie; non
potrebbe non esprimere le sue essenze nei modi in cui le esprime, per ciascuno dei suoi attributi. Ma la parola libertà è perfettamente adeguata a descrivere questa situazione perché,
ovviamente, il Dio-Natura non agisce condizionato da qualcosa di diverso da sé, perché nulla è diverso da sé: è il Tutto, è
assoluto, e quindi è libero, nel senso che esprime se stesso,
esprime quel che è. Non subisce mai alcun condizionamento
dall’esterno.
La tesi che abbiamo appena esposto è chiara solo se si tiene
presente che quando Spinoza usa la parola «libertà» rispetta
la seguente definizione (che Spinoza propone come vera, cioè
adeguata alla natura dell’oggetto definito): “Una cosa è libera
quando esiste per la sola necessità della sua natura e non è
determinata ad agire che da se stessa” (è la definizione 7 della
Parte Prima dell’Etica). Dunque Dio è assoluta libertà in quanto agisce per la sola necessità della propria natura.
93
Da qui deriva che il libero arbitrio dell’uomo è un’illusione. Se
l’uomo conoscesse dettagliatamente le singole cause che determinano le sue scelte (c’è sempre una ragione per cui accade
quel che accade) saprebbe di non essere lui a scegliere, ma
di essere parte di un flusso di eventi fisici e mentali (o fisicomentali, perché il corpo e la mente sono espressione della
stessa sostanza secondo due essenze diverse). La natura, del
resto, segue leggi che l’uomo in parte conosce e sono leggi deterministiche, necessarie. Le leggi di natura sono invarianti (su
questo scienziati e filosofi del Seicento concordano). In quanto
ente immerso nella natura, e sua parte, è del tutto ovvio che
l’uomo non costituisca alcuna eccezione rispetto a tutti gli altri
enti: scrive Spinoza nella Prefazione alla terza parte dell’Etica
che “le leggi e le regole della natura, secondo le quali tutte le
cose avvengono e si mutano da una forma all’altra, sono ovunque e sempre le stesse”. Quindi anche l’uomo è sottoposto a
quelle stesse leggi. Altrimenti bisognerebbe concepire il libero
arbitrio, sulla cui base il corpo è determinato ad agire, come
una eccezione alle leggi di natura. Il che è assurdo perché le
leggi di natura sono costanti, invarianti.
Riprendiamo la definizione di libertà vista fin qui: la mente è
determinata ad agire da cause a lei esterne, che controlla solo
in parte. Non agisce per la sola necessità della sua natura, perché la sua natura non è quella di una sostanza che sia in se
stessa: la mente (come il corpo) è in altro e quindi è da altro
determinata.
Spinoza si propone di conseguenza di studiare (come ha già
fatto Cartesio) le passioni come forze naturali che determinano la mente ad agire come agisce. Non è diverso studiare il
comportamento fisico di un corpo e la struttura psichica di un
uomo: entrambe seguono leggi deterministiche. Spinoza dedica quindi molta attenzione nell’Etica alla costruzione di una
teoria generale delle passioni, considerate come forze.
94
Coerentemente con queste premesse, Spinoza procede ad una
trattazione delle passioni a partire da due nozioni di base.
- La prima ha una validità molto generale: la mente possiede
una energia interna che la fa essere ciò che è, una energia che
si esprime innanzitutto nello sforzo di conservare se stessa
(l’espressione latina è conatus sese conservandi). Il principio
non è specifico della mente, ma di qualsiasi individualità, che
se così non fosse non potrebbe mantenere se stessa: qualsiasi
ente, infatti, “si sforza di perseverare nel suo essere per una
certa durata indefinita”. Anche una pietra resiste ai tentativi di
frantumarla. Così la mente ha una organizzazione interna che
la difende mantenendola nel suo specifico modo d’essere.
Tuttavia, al contrario di una pietra, la mente ha coscienza di sé
a vari gradi, da un minimo a un massimo, e ha parallelamente coscienza generica del corpo (ne ha invece una conoscenza di dettaglio molto bassa: Spinoza sottolinea con forza che
noi non conosciamo a fondo e dettagliatamente la struttura
del nostro corpo). Lo sforzo di conservare se stessa è quindi
nell’uomo consapevole, ed entra nel gioco complessivo delle
cause che ne determinano l’azione. Questo sforzo, se riferito
alla sola mente, viene definito da Spinoza volontà; se riferito al
corpo e alla mente si chiama appetito.
- La seconda nozione di base è specifica e riguarda direttamente le passioni, che possono essere tutte ricondotte ad alcune
elementari:
- il desiderio, che è lo stesso sforzo della mente di conservare se stessa divenuto consapevole;
- la gioia, che è l’emozione connessa alla conservazione e al
perfezionamento del proprio essere;
- la tristezza, che è l’emozione contraria, e dipende dal fatto che questa conservazione e questo perfezionamento del
proprio essere diminuiscono.
95
Da questi tre affetti primari discendono tutte le altre passioni,
e il gioco delle forze psichiche è in grado di spiegare la loro
azione. Ad esempio, l’amore è la gioia accompagnata dall’idea
di una causa esterna; l’odio è il dolore accompagnato dall’idea
di una causa esterna.
Tutte le passioni dipendono, in ultima analisi, dall’energia psichica di fondo che ci costituisce, cioè dall’energia che si esprime nello sforzo di conservare noi stessi. Poiché questo principio di autoconservazione è universale e vale per ogni ente, anche inanimato e privo di coscienza, è chiaro che la vita psichica
è solo la presa di coscienza del gioco delle forze necessarie che
agiscono in noi.
Se la mente subisce l’effetto delle passioni, senza comprenderne le dinamiche necessarie, non è libera: secondo la definizione prima data, infatti, non è determinata ad agire da se
stessa, ma da altro, essendo le passioni legate al movimento
complessivo della natura e degli eventi esterni e interni al corpo. Conoscere queste dinamiche significa spiegare il comportamento umano e le sue ragioni. Non c’è libero arbitrio, ma
forze naturali in atto. L’uomo si illude di essere il padrone delle
proprie scelte e delle proprie azioni. Ma non è così, non lo è.
Immerso nella natura, di cui è parte ed espressione, ne segue
semplicemente le leggi.
L’uomo però non è solo un insieme di forze fisiche e psichiche,
accompagnate da immagini del mondo eterno di cui comprende la verità in modo non sempre preciso. È anche una mente che può avere vari gradi di consapevolezza. È chiaro che se
rimane prigioniero della sfera dell’immaginazione comprende
poco quanto accade, e prevede ancora meno, essendo la sua
esperienza sempre limitata.
Le cose tuttavia cambiano molto se l’uomo attiva quei processi
intellettivi che lo portano ad una conoscenza adeguata delle
cose, secondo le indicazioni della scienza. Allora la sua com96
prensione delle ragioni per cui accade quel che accade – ivi
comprese le ragioni che lo portano a provare determinate passioni e non altre – cresce moltissimo.
Ora, se la mente ha idee adeguate delle passioni, le vedrà in
modo diverso perché potrà prevederne il corso e seguirne
mentalmente la dinamica. Non ne sarà dominato nello stesso modo, benché non possa certo modificare le leggi della
natura, che costituiscono la sua stessa più profonda identità.
Possiamo quindi affermare che se le passioni, dettate da idee
inadeguate, guidano il nostro comportamento, siamo schiavi;
se invece a guidare il nostro comportamento sono idee chiare
e adeguate, allora saremo consapevoli delle forze che ci muovono, e dunque saremo meno passivi.
Date queste premesse dobbiamo quindi introdurre un’importante distinzione concettuale:
- chiamiamo passioni le forze psichiche quando non vengono comprese adeguatamente in quanto la mente le conosce attraverso l’immaginazione;
- chiamiamo affezioni le stesse forze psichiche quando vengono comprese secondo la loro effettiva realtà nell’ordine
della natura.
Questa distinzione non è soltanto una precisazione terminologica, perché la passività della mente nei confronti delle passioni dipende dalla inadeguatezza della conoscenza che ne ha e
diminuisce a mano a mano che la conoscenza diviene più adeguata. Quando è del tutto adeguata (è il caso della esposizione
che Spinoza ne fa nel terzo libro dell’Etica), la mente non le
vive passivamente. Comprende infatti che l’ordine della natura
e la realtà di cui è testimone conoscendo le passioni è immutabile e necessaria. Comprende che non è né buona né cattiva,
che l’universo dei valori che costituiscono la dimensione etica
del mondo è determinata dall’immaginazione sulla base del
fatto che le passioni sono vissute passivamente; che nell’or97
dine reale delle cose non esistono valori positivi o negativi, e
che tutto è come deve essere e non potrebbe non essere, né
potrebbe essere diversamente. L’atteggiamento filosofico corretto è quello non della valutazione moralistica delle passioni,
bensì della loro comprensione in quanto si tratta di forze e leggi che regolano il comportamento dell’uomo: solo attraverso
idee adeguate l’uomo può sottrarsi alle conseguenze negative
delle passioni.
La realtà dell’uomo e della natura, se osservate dalla prospettiva ora esposta, appaiono alla mente non secondo l’angolazione specifica di un particolare interesse o di un particolare
ente, ma nella dimensione dell’eternità, secondo l’espressione
latina utilizzata da Spinoza, sub specie aeternitatis. Lo sguardo
del filosofo diviene allora libero e quelle che prima erano vissute come passioni e rendevano la mente schiava, dominata
da altro da sé, sono ora concepite correttamente come affezioni nell’ordine universale necessario che costituisce ogni cosa,
quindi anche la stessa mente, e l’io.
L’eternità non è una dimensione del tempo (non è ciò che
esiste sempre nel tempo), ma ne è del tutto indipendente.
Concepire una cosa nella dimensione dell’eternità significa,
secondo la definizione che ne dà Spinoza, concepirla nella
necessità della sua esistenza, una necessità che può essere
compresa solo se si ricorda che (tranne il Dio-Natura) nessuna cosa è semplicemente se stessa, ma tutte sono in altro e la loro esistenza deve quindi essere concepita rispetto
a quest’altro. All’origine dell’esistenza c’è dunque Dio, che
esprime necessariamente una propria essenza in un determinato modo, ed è questa espressione necessaria che chiamiamo l’esistenza di una cosa. Nessuna cosa è allora al di
fuori dell’eternità, e tutte sono eterne, non nel senso che
esistono sempre nel tempo (è vero il contrario: tutto passa
nel tempo), ma nel senso che la loro esistenza esprime la
98
realtà eterna di Dio in un determinato e specifico modo.
Solo se lo sguardo della mente sul mondo cambia radicalmente, solo se ci si abitua a vedere le cose sotto la dimensione
dell’eternità, allora anche se le affezioni non cambiano, cambia
il loro effetto sulla mente, perché non sono più vissute passivamente, ma attivamente, e la mente le riferisce non a sé, ma a
Dio come loro fonte (questo infatti significa riconoscere l’eternità in ogni cosa: riconoscere che tutte esprimono una essenza
di Dio nel modo che è loro proprio).
È questo il terzo genere di conoscenza, che consente di intuire
il legame che unisce l’essere di ciascuna cosa e della mente
stessa al Dio-Natura. Spinoza propone l’espressione “amore
intellettuale di Dio” per indicare il legame che la mente percepisce intuitivamente quando comprende che i desideri in cui si
manifesta la forza che mira alla conservazione di sé (conatus
sese conservandi) sono espressione del Dio-Natura, che la sua
stessa vita e quella del corpo sono sua espressione (l’espressione, nel tempo, dell’eternità).
Spinoza utilizza il termine amore coerentemente con la definizione che ne ha dato: come abbiamo già visto, l’amore è
la gioia accompagnata dall’idea di una causa esterna. Ma in
questo ed unico caso questa causa non è realmente esterna,
perché il Dio-Natura non è veramente altro rispetto alla mente dell’uomo, al corpo e a tutte le altre cose che esistono, perché tutte queste realtà sono in quanto sono in altro, cioè nel
Dio-Natura.
La gioia allora accompagna la mente (da qui il ricorso al temine amore) quando percepisce intuitivamente col terzo genere
di conoscenza che la fonte della propria gioia è Dio.
Tutto questo è difficile, perché la mente continua a dover
conoscere le cose sensibilmente, e quindi mediante l’immaginazione, che abbiamo visto essere all’origine di un tipo di
conoscenza molto diverso. E tuttavia la strada è percorribile.
L’Etica di Spinoza si conclude ricordando la concretezza della
99
dimensione dell’eternità con cui guardare le cose e la vita.
E la difficoltà di farlo: tutte le cose belle sono tanto difficili
quanto rare, scrive, omnia praeclara tam difficilia quam rara
sunt176.
100
5. C’È UNA VIA PRIVILEGIATA
PER LA RICERCA DEL FONDAMENTO DEL TUTTO?
Sono stato molte volte attaccato, o anche irriso, avendo sostenuto tesi che tre secoli fa appartenevano al comune modo
di sentire tra filosofi e scienziati, benché non senza eccezioni.
L’idea che il problema di Dio, cioè del fondamento della realtà,
o del Tutto, sia troppo importante per lasciarlo al di fuori della
ricerca razionale e scientifica appare a molti un’ingenuità. Ad
altri una sorta di sacrilegio.
Io ritengo che esitano buone ragioni per sostenere che non è
un’ingenuità. E men che meno un sacrilegio. Sostengo infatti la
tesi che non esiste alcuna via privilegiata per la ricerca di Dio, o
del fondamento del Tutto, e che nessuna via può avere la pretesa di essere l’unica. Se la verità ci appare, deve reggere all’esame di qualsiasi via, per la semplice ragione che è del Tutto
che stiamo parlando. E non può esserci un ambito della realtà,
o delle facoltà di conoscenza dell’uomo, che ne sia fuori.
È per questa ragione che i filosofi del Seicento si sono impegnati nell’esame di quelli che certamente sono errori della nostra conoscenza: il Sole non è di dimensioni uguali alla Luna,
perché dunque così ci appare? Se non fossero riusciti a spiegare questo, le loro teorie sarebbero crollate, perché anche allo
scienziato che conosce con grande precisione le loro dimensioni reali essi appaiono uguali. Ci deve essere una ragione per cui
ci appaiono così, e deve essere coerente con la loro dimensione reale, con le nostre capacità di conoscenza, e così via.
L’arte, la religione, la scienza, la filosofia, e le altre vie, sono
strade. Da qualche parte portano, e la realtà comprende tutti
questi percorsi. Escluderne uno, significa escludere una parte
della realtà.
Questo discorso appare a molti viziato da relativismo, figlio
dello scetticismo. Ma non è affatto scetticismo rispondere con
un sereno “Non lo so” ad una domanda di cui non conosciamo
101
la risposta. Ci sono semplicemente moltissime cose che non
sappiamo, moltissime che non riusciamo a spiegare. Il non
sapere non implica scetticismo, implica piuttosto la necessità
della ricerca. E se una via è cieca, come accade nelle grotte
molte lunghe, forse ci sono passaggi laterali. Ogni via è buona.
È del Tutto che parliamo. Del fondamento, ed è troppo importante sapere.
Vorrei fare un esempio. Noi regoliamo la nostra vita collettiva
sulla base di principi che sono politici ed etici, separatamente o insieme. Ma non conoscendo il fondamento della realtà,
questi principi sono per noi privi di basi. Non poggiano su solida roccia. Poggiano su convinzioni, speranze, e spesso solo
sulla punta della baionetta dei vincitori dell’ultima guerra, in
attesa della prossima.
È troppo importante sapere. Ma sapere è cosa davvero diversa
che credere, ed è del sapere che adesso parlo.
102
FRANCESCO DIPALO
IL DIVINO DOP O LA
MORT E DI DIO:
VERSO UN NUOVO CONCETTO DI SPIRITUALITÀ ECUMENICA
NEL MONDO CONTEMPORANEO
La “svolta soggettocentrica” della filosofia moderna
Dal cogito ergo sum cartesiano in avanti la filosofia moderna si
era caratterizzata per il progressivo spostamento del baricentro della riflessione dall’oggetto della conoscenza al soggetto
conoscente, come dire dal “mondo”, inteso come totalità dei
fenomeni, all’“uomo”. L’irruzione sul palcoscenico storico-filosofico del soggetto conoscente come componente fondamentale dell’atto conoscitivo, in grado di modificarlo e dirigerlo
sino ad assorbire totalmente in sé l’oggetto, ha senza dubbio
determinato una svolta decisiva anche nella concezione del divino, cifra ultima e totalizzante della realtà in sé.
Se l’attività del pensiero precede l’essere – “penso dunque
sono” –, allora la coscienza di sé (o “auto-coscienza”) precede
la coscienza del mondo, cioè delle cose che lo compongono:
prima che il mondo mi si dia è necessario che Io sia, ma dato
che la dimensione del mio essere risulta connaturata con l’atto del pensare, esso finisce col risultare fondativo rispetto allo
stesso darsi del mondo. La via che conduce dal cogito cartesia103
no al trascendentalismo kantiano è aperta: ciò che di distintivo
e di razionalmente ordinato si ritrova nell’oggetto conosciuto
è lo stesso soggetto a mettercelo, un soggetto trascendentale,
ovvero le cui funzioni catalogative e rielaborative di ciò che si
presenta alla coscienza (il fenomeno, “ciò che appare”) precorrono e fondano la possibilità di comprensione razionale dello
stesso.
Dal soggetto kantiano al soggetto assoluto dell’idealismo hegeliano il passo è breve. Ad essere messa in discussione e negata è l’autonomia ontologica dell’oggetto della conoscenza,
che pure in Kant (1724-1804) persisteva come “cosa in sé”,
sostrato solo pensabile (noumeno), ma non conoscibile, del
dato fenomenico. L’essere delle cose si annulla completamente nell’“esser pensato”: dal soggetto non dipendono soltanto
le caratteristiche razionali dell’oggetto, bensì la sua stessa esistenza. Il pensare diviene atto creativo, che pone in essere le
cose.
Protagonista di questa vicenda al contempo gnoseologica e
creativa non è, beninteso, l’io psicologico individuale, bensì il
soggetto trascendentale, un “esser pensiero totalizzante” che
ha del tutto soppiantato l’“esser cosa”, l’oggettualità del reale.
Il mondo ci appare razionale in quanto prodotto dello Spirito
Assoluto che è Razionalità e che, nel suo processo auto-conoscitivo, si fa Storia: il divenire storico, di cui il filosofo può
riuscire a darsi conto attraverso la nuova dialettica triadica (tesi-antitesi-sintesi), è il luogo in cui lo Spirito si manifesta, si fa
“fenomeno” (da cui Fenomenologia dello Spirito, il titolo della
celebre opera hegeliana del 1807).
Possiamo dire che con Hegel (1770-1831) il trapasso dal realismo – l’atteggiamento di fondo di gran parte delle filosofie antiche e medievali – al soggettivismo idealistico è compiuto: la
Verità non si consegue più con l’adeguare l’intelletto alla cosa
(e viceversa), come uno specchio che “riflette” oggettivamente la realtà in sé, data una volta per tutte; essa è piuttosto “at104
tività veritativa”, “processualità auto-cosciente”, di cui si può
ri-conoscere nella storia dell’umanità la direzione e il senso
ultimo, tappa dopo tappa, ovvero figura dopo figura.
Ebbene, il concetto di Dio, l’Ens realissimum della tradizione
medievale, e ancora in Cartesio (1596-1650) “garante” della
corrispondenza delle idee con le cose in sé, non poteva non
risentire di questa vera e propria rivoluzione copernicana in
ambito gnoseologico e metafisico. Con progressione lenta ma
inesorabile, le principali prerogative attribuite al Dio dei filosofi vengono assorbite dal soggetto conoscente, sempre più
razionalizzato e dunque “antropomorfizzato”. Non rimane
spazio per la trascendenza e per il mistero: lo Spirito Assoluto hegeliano, è assimilabile ad una sorta di Dio immanente,
spersonalizzato, che dispiega la sua intima essenza razionale
nella dialettica del divenire storico. L’“ente realissimo” è infine
trasformato in “soggettualità”, calato giù nel mondo, fatto anzi
coincidere con il mondo stesso. Ecco perché “ciò che è reale è
razionale e il razionale reale”.
L’annuncio nietzschiano della morte di Dio
Queste per sommi capi le premesse. È come se il tradizionale
concetto di Dio si fosse a poco a poco svuotato di senso e significato, accrescendo a dismisura, dall’altra parte, la funzione
della Raison scientifica ed illuministica. Una specie di travaso
da vasi comunicanti. Visto da quest’ottica il pensiero moderno rappresenta un ponte che va dal teocentrismo medievale
all’antropocentrismo tutto dispiegato dell’idealismo ottocentesco.
L’evento culminante di questo percorso, da cui, potremmo
dire, prende simbolicamente le mosse la contemporaneità, è il
celebre annuncio nietzschiano della morte di Dio. Parlare del
divino nella filosofia e nella cultura europea tra Ottocento e
105
Novecento significa essenzialmente evocare la graduale presa
d’atto collettiva della scomparsa del Dio della tradizione cristiana, provare a giustificarla, farci i conti a vari livelli. E non si tratta di un’operazione indolore. Non basta dire: “toh, Dio non c’è
più: era solo un’illusione”. Realizzare che il tempo del Dio con
cui l’Occidente si era identificato per secoli è finito o in procinto di finire, significa essenzialmente assumersi la responsabilità di dover ripensare il senso della collocazione dell’uomo nel
mondo, i confini entro cui si estende il suo orizzonte culturale,
esistenziale, etico e socio-politico. Se Dio altro non è stato che
lo specchio in cui l’uomo si misurava con la propria immagine deformata in senso infinitivo e moralmente positivo, come
ad esempio sostiene Feuerbach, c’è da chiedersi ora a quale
immagine di sé si possa fare riferimento e su quale sfondo,
da quale prospettiva diventi lecito osservarsi. Giacché, come
ebbe a dire Dostoevskij, «se Dio non esiste tutto è permesso».
Ma se tutto è permesso, qual è il discrimine tra bene e male,
realtà e illusione, senso comune e pazzia?
Non a caso è un uomo “folle” a proclamare che Dio è morto (Gott ist tot!) nell’aforisma 125 della Gaia scienza (1882) di
Friedrich Nietzsche (1844-1900). Vale la pena leggere attentamente il passo, è agghiacciante:
«L’uomo folle. – Avete sentito di quel folle uomo che accese una
lanterna alla chiara luce del mattino, corse al mercato e si mise
a gridare incessantemente: “Cerco Dio! Cerco Dio!”. E poiché
proprio là si trovavano raccolti molti di quelli che non credevano in Dio, suscitò grandi risa. “È forse perduto?” disse uno. “Si
è perduto come un bambino?” fece un altro. “Oppure sta ben
nascosto? Ha paura di noi? Si è imbarcato? È emigrato?” – gridavano e ridevano in una gran confusione. Il folle uomo balzò in
mezzo a loro e li trapassò con i suoi sguardi: “Dove se n’è andato Dio? – gridò – ve lo voglio dire! Siamo stati noi ad ucciderlo:
voi e io! Siamo noi tutti i suoi assassini! Ma come abbiamo fatto
106
questo? Come potemmo vuotare il mare bevendolo fino all’ultima goccia? Chi ci dette la spugna per strusciar via l’intero orizzonte? Che mai facemmo, a sciogliere questa terra dalla catena
del suo sole? Dov’è che si muove ora? Dov’è che ci moviamo
noi? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno precipitare? E
all’indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora un
alto e un basso? Non stiamo forse vagando come attraverso un
infinito nulla? Non alita su di noi lo spazio vuoto? Non si è fatto
più freddo? Non seguita a venire notte, sempre più notte? Non
dobbiamo accendere lanterne la mattina? Dello strepito che
fanno i becchini mentre seppelliscono Dio, non udiamo dunque
nulla? Non fiutiamo ancora il lezzo della divina putrefazione?
Anche gli dèi si decompongono! Dio è morto! Dio resta morto!
E noi lo abbiamo ucciso! Come ci consoleremo noi, gli assassini
di tutti gli assassini? Quanto di più sacro e di più possente il
mondo possedeva fino ad oggi, si è dissanguato sotto i nostri
coltelli; chi detergerà da noi questo sangue? Con quale acqua
potremmo noi lavarci? Quali riti espiatori, quali giochi sacri dovremo noi inventare? Non è troppo grande, per noi, la grandezza di questa azione? Non dobbiamo noi stessi diventare dèi,
per apparire almeno degni di essa? Non ci fu mai un’azione più
grande: tutti coloro che verranno dopo di noi apparterranno,
in virtù di questa azione, ad una storia più alta di quanto mai
siano state tutte le storie fino ad oggi!”. A questo punto il folle
uomo tacque, e rivolse di nuovo lo sguardo sui suoi ascoltatori:
anch’essi tacevano e lo guardavano stupiti. Finalmente gettò a
terra la sua lanterna che andò in frantumi e si spense. “Vengo
troppo presto – proseguì – non è ancora il mio tempo. Questo
enorme avvenimento è ancora per strada e sta facendo il suo
cammino: non è ancora arrivato fino alle orecchie degli uomini. Fulmine e tuono vogliono tempo, il lume delle costellazioni
vuole tempo, le azioni vogliono tempo, anche dopo essere state compiute, perché siano vedute e ascoltate. Quest’azione è
ancora sempre più lontana da loro delle più lontane costellazio107
ni: eppure son loro che l’hanno compiuta!”. Si racconta ancora
che l’uomo folle abbia fatto irruzione, quello stesso giorno, in
diverse chiese e quivi abbia intonato il suo Requiem aeternam
Deo. Cacciatone fuori e interrogato, si dice che si fosse limitato
a rispondere invariabilmente in questo modo: “Che altro sono
ancora queste chiese, se non le fosse e i sepolcri di Dio?».
Quest’uomo folle rappresenta un personaggio fino ad allora
del tutto sconosciuto alla cultura europea, perché inedita è
la forma di pensiero divergente attraverso cui si manifesta la
sua pazzia. Negare l’esistenza di Dio, in passato, costituiva un
chiaro segno di insania, se non di possessione diabolica. O altrimenti si poteva diventar “pazzi di Cristo”, come Jacopone
da Todi, per eccesso di devozione. La lucida demenza del personaggio nietzschiano – che si richiama da presso alla figura
di Diogene il Cinico, detto “Socrate Pazzo”, il quale, lanterna
alla mano in pieno giorno, andava a caccia dell’uomo – consiste invece nel cercare Dio in un’epoca e in mezzo a gente che,
semplicemente, non si pone più il problema della presenza del
divino nel mondo, che da tempo vive “come se Dio non ci fosse” (etsi Deus non daretur). Per secoli filosofi e teologi si erano
arrovellati nella ricerca di argomenti razionali che sostenessero l’esistenza di Dio. A guidarli era stato il pungolo della fede, il
comune humus culturale di appartenenza, nonché la necessità
di convincere, caritatevolmente, l’ateo dissidente. Di contro, in
età moderna gli alfieri del laicismo e dello scientismo avevano
cercato di comprovare la sua non-esistenza. Anche quel tempo
è passato giacché, afferma Nietzsche in Aurora (1881), «oggi si
mostra come ha potuto avere origine la fede nell’esistenza di
un Dio, e per quale tramite questa fede ha avuto il suo peso e
la sua importanza: in tal modo una controdimostrazione della
non-esistenza di Dio diventa superflua».
La fede, o piuttosto l’istinto di vita, precedono la ragione e le
sue pretese onnicomprensive. Figlio di un pastore luterano, il
108
filosofo tedesco ben sapeva che Dio non si dimostra, si teme
e si adora. Il disamore degli uomini, il credere di poter fare a
meno di Lui, l’essersi arrogati prerogative divine ne ha decretato la morte. Si è trattato dunque di un deicidio. Ma chi lo ha
ammazzato – la gente del mercato, ovvero tutti noi, la nostra
desacralizzante visione del mondo, il nostro concreto stile di
vita – non è ancora cosciente di avere le mani macchiate del
sangue divino, non si capacita dell’enormità del gesto. La “sacra pazzia” del novello Diogene sta tutta nella sua capacità di
profetizzare le conseguenze vicine e remote di questo evento
epocale presagendo ciò che ai più sfugge. Essi non sanno della loro condizione di “ateo-devoti”, di orfani alle prese con un
complesso edipico di portata planetaria: sono “nichilisti inconsapevoli”, giacché la notizia del deicidio è ancora per strada.
Eppure già si fa buio e un vento gelido alita su tutti noi.
Il destino dell’Occidente ha dunque per nome “nichilismo”, di
cui Nietzsche fu uno dei primi teorizzatori. Un dramma metafisico, che si riverbererà nella storia del Novecento, proiettando
ombre inquietanti sin su questo scorcio di inizio secolo. La parola “nichilismo” è composta dal latino nihil, “nulla”, unitamente al
suffisso –ismo che generalmente si riferisce ad un’ideologia, una
dottrina, un movimento politico o religioso. Nichilista è dunque
chi sceglie l’assenza di senso e di valore al posto della pienezza
ontologica e morale assicurata dalla presenza divina, chi, consapevolmente o meno, mette il Nulla al posto dell’Essere.
Perché la sanguinosa dipartita del Dio ebraico-cristiano non
riguarda soltanto la sfera religiosa. Il grande defunto reca con
sé nella tomba l’intera metafisica occidentale basata sull’Essere parmenideo, sul concetto di parola-Verità salvifica, sul
principio che esista qualcosa di immutabile e di permanente
al di là della disorganica mutevolezza del mondo sensibile, in
grado di fornirgli in sommo grado ordine e sensatezza. Con
Dio è giunta al tramonto la credenza in quel mondo delle idee
platonico specchio razionale e perfetto della nostra umbratile
109
terrestrità. Il velo è caduto, la Natura mostra il suo volto di Gorgone: la finzione non sta più in piedi giacché la sua funzione
“consolatoria” si è di fatto esaurita. Non rimane alcuno spazio
per la trascendenza, per un Bene superno, per un Fine ultimo.
Nessun “oltre” è più in vista. Questa vita qui nel suo caotico,
tragico – e, al contempo, meraviglioso – fluire circolare rappresenta la cifra ultima del nostro destino, che dovrebbe aprire
e ultimare il nuovo orizzonte metafisico dell’Occidente. Ma
occorre voler essere degli “oltre-uomini” (übermenschen) per
sposare in pieno una visione del genere, avere occhi e stomaci
da aquila, per poter lungi-mirare e digerire quel che profetizzerà lo Zarathustra nietzschiano. Per andare oltre la voragine
del nichilismo apertasi con l’uccisione di Dio, è necessario farsi
creatori di nuovi valori, ovvero, in primo luogo, di una nuova
idea di “sacralità”. Una responsabilità che si è rivelata troppo
grande per un’umanità, quella del Novecento, passivamente
nichilista e “senza qualità”, come è stata descritta nel celebre
romanzo di Robert Musil.
Anche se l’uomo folle dichiara d’esser giunto “troppo presto”,
poiché “fulmine e tuono vogliono tempo”, troppo profonda
e vasta è la portata dell’evento, la civiltà occidentale e la sua
“auto-coscienza filosofica” da quel momento in poi non saranno più le stesse. L’annuncio della morte di Dio segna dunque
uno spartiacque storico, di cui conosciamo abbastanza bene il
“prima”, ma, ad oltre un secolo di distanza, riusciamo solo ad
intravedere il “dopo”.
Il divino come alienazione in Feuerbach e Marx
Anche se la pubblicazione della Gaia Scienza di Nietzsche è
solo del 1882, la morte di Dio, come si è detto, è nell’aria già
da tempo. Celebre è l’espressione marxiana “la religione oppio
del popolo”, che compare in un’opera giovanile del filosofo di
110
Treviri (Per la critica della filosofia del diritto di Hegel, 1844).
Dio è «la realizzazione fantastica dell’essere umano» e la religione un sogno ad occhi aperti cui danno consistenza emozionale ed immaginativa uomini e donne in carne ed ossa, concretamente dati, sfogando la loro insofferenza verso un sistema
economico e sociale che li immiserisce e disumanizza. Pertanto «la miseria religiosa è ad un tempo l’espressione della miseria reale e la protesta contro di essa. La religione è il singhiozzo della creatura oppressa, è il senso effettivo di un mondo
senza cuore, come è lo spirito di una vita priva di spirito. Essa
è l’oppio del popolo». Abolire la religione significherebbe dunque aiutare le masse proletarie a risvegliarsi alla realtà degli
effettivi rapporti di produzione in cui sono coinvolte, a prender
coscienza di come il loro lavoro sia sfruttato, la loro esistenza
quotidiana angariata e svilita. Contro gli “spacciatori di Dio”
che alla domenica provvedono a somministrare la giusta dose
di narcotico, vagheggiando di “mondi alla rovescia” affinché
nulla concretamente cambi, occorre attraverso la critica della
religione «disilludere l’uomo, onde pensi, operi, atteggi il suo
essere reale, come uomo spogliato d’illusioni, che ha aperti gli
occhi della mente onde si muova intorno a se stesso».
Va da sé che nella concezione marxiana non c’è posto per il
divino in senso metafisico e teologico. La religione è, da una
parte, alienazione consolatoria, dall’altra strumento di dominio dell’uomo sull’uomo, basato sullo stato di insipienza, in cui
viene mantenuta, giocoforza, la gran parte degli oppressi. Alla
nuova scienza sociale e all’internazionale socialista – il mondo
va trasformato, non basta più soltanto interpretarlo – spetterà
il compito di dissipare le tenebre dell’ignoranza, promuovendo lo sviluppo di un’effettiva coscienza di classe attraverso la
diffusione dei moderni mezzi di informazione e di istruzione.
Antidoti all’avvelenamento da religione sono dunque da considerarsi la scienza e la prassi economico-politica. Grazie ad esse
l’umanità progrediente, superando dialetticamente le contrad111
dizioni implicite nel sistema capitalistico, sarà in grado di costruire una società di eguali, senza più oppressi né oppressori,
in cui l’uomo, risvegliato infine alla propria essenza, potrà fare
a meno una volta per tutte della “favola” religiosa.
In Marx (1818-1883) la questione del divino è palesemente assorbita da una logica estranea al tradizionale discorso metafisico e teologico e declassata a mera sociologia della religione.
In questa prospettiva portare delle prove a sostegno dell’esistenza o della non esistenza di Dio, come affermerà qualche
anno dopo Nietzsche, non ha più alcun senso. Già al culmine
dell’età illuministica, del resto, Kant aveva messo in luce a quali inevitabili contraddizioni giunga la ragione qualora pretenda applicarsi ad ambiti che vanno oltre l’esperienza possibile.
Nella Dialettica trascendentale, parte della Critica della Ragion
Pura (1781), il filosofo aveva ampiamente dimostrato l’inconcludenza dei vari argomenti prodotti nel corso dei secoli dalla
teologia razionale a favore o contro la divinità. Del sovrasensibile, dunque, non si dà alcuna scienza.
Alle scienze sociali interessa piuttosto spiegare l’eziologia e la
genesi del sentimento religioso in relazione al soggetto umano nonché le sue implicazioni culturali e socio-politiche. Marx
si limita a constatare che esso attecchisce soprattutto presso
gli ultimi, come estremo grido di protesta e sogno di rivincita
dinanzi ad un sistema che, in nome della riproduzione del capitale, li priva della loro umanità, trasformandoli in forza-lavoro,
merce di scambio, che il capitalista può comprare a suo piacimento. È difficile tirare innanzi se si ha la pancia vuota. Ma
senza speranza non si va da nessuna parte. A questa necessità,
nella migliore delle ipotesi, supplisce la religione. Da qui, se
si vuole, la straordinaria assonanza tra alcuni passaggi dell’Evangelo e la promessa di “palingenesi” rivoluzionaria offerta
agli uomini del XIX e XX secolo dal marxismo, all’insegna del
materialismo storico e dell’ingegneria sociale. In un orizzonte
storico oramai svuotato dell’ingombrante presenza della Prov112
videnza divina, dovrà essere l’Uomo, inteso in senso collettivo,
a provvedersi con le sue sole forze di un futuro radioso, dando
risposta concreta, immanente e terrena, alla sete di uguaglianza e giustizia che gli arde dentro. Infatti «compito della storia
è […] di stabilire la verità del di qua dopo che si è dileguata la
verità del di là. Prima di tutto il compito della filosofia che è al
servizio della Storia, è quello di smascherare l’annientamento
della persona umana nella sua forma profana, dopo che è stata smascherata la forma sacra dell’annientamento della persona umana. La critica del cielo si muta così nella critica della
terra, la critica della religione nella critica del diritto, la critica
della teologia nella critica della politica».
L’utopia marxiana – “utopia” perché non ha sin qui trovato
piena realizzazione nella storia – si basa su una concezione
antropologica, tutto sommato, positiva. Non l’individuo, ma la
classe, la società, la storia in ultima istanza, dovrebbero fare
le veci di quel Dio, il quale, in quanto prodotto di alienazione,
va messo da parte come un vecchio, polveroso schermo, reso
oramai inutile dal progresso scientifico, su cui l’umanità, vagheggiante, proiettava un tempo la propria sembianza.
Ma il vero autore del “ribaltamento” del discorso teologico in
discorso antropologico, poi ripreso e riutilizzato da Marx in termini storico-materialistici è il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach (1804-1872), uno dei più importanti esponenti della cosiddetta “Sinistra hegeliana”. A lui si deve l’invenzione del concetto di “alienazione religiosa”, che, declinando in maniera positivista la dialettica hegeliana, aprirà inediti spazi di manovra
alle antropologie contemporanee e alla storia delle religioni.
Il rapporto tra l’uomo e il divino, a ben guardare, si è sempre
caratterizzato nel tempo per un’ingenua “inversione dei termini”: si è considerato oggettivo quel che era in realtà soggettivo
e viceversa. Quel Dio-persona (soggetto) che nella tradizione
giudaico-cristiana avrebbe plasmato Adamo (oggetto) a sua
immagine e somiglianza è in realtà frutto del processo di au113
toconsapevolezza dell’umanità. Nella figura del Dio vivente,
infatti, viene oggettivizzata l’essenza soggettiva delle diverse
stirpi di uomini, civiltà dopo civiltà. L’idea della divinità diventa
sempre più spiritualmente densa e concettualmente elevata,
dai politeismi arcaici ai monoteismi fondati sulla rivelazione
biblica, dal paganesimo al cristianesimo. Per questo al progresso delle religioni corrisponde un costante progresso civile
e scientifico. Nel tracciare l’evoluzione del pensiero religioso,
dalle mitografie alle teologie razionali, ci è dunque dato cogliere la storia di un’umanità che diventa sempre più lucidamente
consapevole di sé, riappropriandosi di quel che aveva “spostato” nella sfera del divino. Ascoltiamolo dalla “viva voce” del
nostro, in un passaggio centrale de L’essenza del cristianesimo,
che fu dato alle stampe nel 1841:
«L’uomo, prima ancora di trovare la sua essenza in sé, la traspone fuori di sé. In un primo tempo la sua propria essenza gli
è oggetto come se fosse l’essenza di un altro. Nelle religioni il
progresso storico consiste quindi in questo, che ciò che per la
religione precedente era considerato qualche cosa di oggettivo
è adesso qualche cosa di soggettivo; in altri termini, ciò che era
contemplato e pregato come Dio viene ora conosciuto come
qualche cosa di umano. Per i posteri la religione precedente
è idolatria: l’uomo ha pregato la propria essenza. L’uomo si è
oggettivato, ma non si è reso conto che l’oggetto era la sua
essenza; la religione successiva fa questo passo. Ogni progresso nella religione è quindi una più approfondita conoscenza
di sé. […] Dato che ha un altro oggetto e un altro contenuto,
dato che si è innalzata su un piano superiore al contenuto della religione precedente, essa si illude di essersi sottratta alle
leggi necessarie ed eterne che costituiscono l’essenza della
religione: si illude che il suo oggetto, che il suo contenuto sia
sovrumano. Ma, in cambio, a penetrare in quella essenza della
religione che a lei stessa è nascosta è il pensatore; per lui la
114
religione è oggetto, come essa non può essere a se stessa. E il
nostro compito sarà appunto di dimostrare che l’opposizione
di divino e di umano è del tutto illusoria, e che, per conseguenza, anche l’oggetto e il contenuto della religione cristiana
è interamente umano».
Il compito del filosofo, pertanto, consiste in primo luogo nello
svelare l’illusione su cui si fonda la religione, chiudendo, per
così dire, il “cerchio” del processo auto-conoscitivo di una
umanità incarnata, sensibilmente e naturalmente data – e non
di un soggetto astratto, quale lo Spirito Assoluto di Hegel, una
specie di “uomo capovolto sulla testa” che tanto Feuerbach
quanto Marx si adopereranno a rimettere con i piedi ben piantati a terra. Successivamente, attraverso lo studio “scientifico”
della religione si potrà indagare sempre più a fondo l’essenza
umana, in maniera sociologicamente produttiva, mettendo in
luce le sue caratteristiche precipue, nonché quanto di più puro
e nobile si cela in fondo ai nostri cuori.
Giacché in una società in cui la laicità giunga a piena maturazione l’uomo può rivelarsi a sé bastante, sia in relazione alla
propria persona che al prossimo. Dando rinnovato significato al noto adagio di Cecilio Stazio, anche secondo Feuerbach
homo homini deus est (“l’uomo è per l’uomo un dio”): un punto di vista rivoluzionario in grado di trasformare ogni residuo
“amor di Dio” in filantropia a tutto tondo, impegno solidale a
favore della comunità e dell’Altro. Sotto questo profilo il messaggio del cristianesimo – data l’epoca il nostro filosofo non
poteva affatto andar esente da un certo “eurocentrismo” – si
era storicamente dimostrato quello più adatto ad esprimere in
modo compiuto l’essenza filantropica e sociale che caratterizza
la specie umana. Prefigurando l’avvento di un “umanesimo del
tutto compiuto”, nel mito cristiano Dio si fa uomo innalzando l’uomo a sé attraverso il Cristo. Proprio la figura di Gesù
rappresenta, infatti, l’ultima tappa del processo di alienazione
115
dell’uomo da sé. L’atto di “alienare” (dal latino alienus, “appartenente ad altri”, “estraneo”) era consistito nel concepire un
essere a se stante (la divinità) estraniando a suo favore ciò che
gli stava più a cuore (la propria amorevole essenza). L’“incarnazione” del Figlio – che considerata sotto questa luce perde
l’aureola di “mistero della fede” – preannunzia allora l’estremo
momento sintetico, in cui l’umanità, letteralmente, si “riappropria” di quanto si era inconsapevolmente deprivata. Dinanzi
alla presa di coscienza dei propri limiti individuali, alla propria
precarietà e finitudine, l’uomo aveva cercato di eternarsi in
Dio, di dare comunque consistenza ad una facoltà desiderante interiormente avvertita come incommensurabile e tendente all’infinito. In una temperie, quella idealistica e positivista,
dove la dimensione della Storia e del Progresso hanno oramai
soppiantato l’immobile fissità ontologica della divinità premoderna, a tale “brama d’infinito” potranno fornire adeguata
risposta, così almeno parrebbe, «dell’umana gente le magnifiche sorti e progressive».
Il tempo di “quel Dio” è giunto al suo giorno estremo. L’ateismo di Feuerbach, infatti, rappresenta qualcosa di inedito, che
è impossibile confondere con la critica alla religione di stampo illuministico o con un anticlericalismo di maniera. «Non è
compito dei miei scritti – troviamo in un passo di Spiritualismo e materialismo (1866) – negare l’esistenza della divinità e
dell’immortalità – chi può negare che esistono almeno in libri
e immagini, nella fede e nella rappresentazione? – bensì solo
riconoscere il senso e il motivo vero, il testo originale e non
falsificato della divinità e dell’immortalità o, che è tutt’uno,
della fede in esse, un riconoscimento attraverso cui la questione della loro esistenza o non esistenza si risolve da sé». Con
questo la teologia si è definitivamente volta in antropologia. Il
passaggio dal divino all’umano, la svolta “soggettocentrica” e
“antropocentrica” della modernità si può dire compiuta: «tanto meno è Dio, tanto più è l’uomo; tanto meno l’uomo, tanto
116
più Dio. Se vuoi avere Dio, devi perciò rinunciare all’uomo; e
se vuoi avere l’uomo devi rinunciare a Dio; altrimenti tu non
hai né l’uno né l’altro» (in Tesi provvisorie per la riforma della
filosofia, 1843). Dio e uomo sono diventati “incompatibili”.
Scelto l’uomo, in Marx la stessa alienazione religiosa passerà in
secondo piano. Ben più grave del fatto religioso, ridotto, come
si è detto, ad oppiaceo, sul capo delle plebi pesa la continua
e sistematica espropriazione del prodotto del loro lavoro, che
sovente si svolge in condizioni assolutamente disumanizzanti (alienazione economica), l’estromissione dal controllo della
cosa pubblica (alienazione politica), nonché la profonda diseguaglianza sociale determinata dalla divisione della società in
classi (alienazione sociale). La salvezza dell’anima non è più un
problema all’ordine del giorno.
Dio sul lettino dello psicanalista
Ne Il visitatore, pièce teatrale in un solo atto rappresentata per
la prima a volta a Parigi nel 1993, Éric-Emmanuel Schmitt, filosofo e drammaturgo francese, immagina il dottor Sigmund
Freud (1856-1939), oramai vecchio e malato, alle prese con
un misterioso visitatore, che, d’improvviso, fa capolino nel suo
studio viennese. Siamo alla fine di aprile 1938. Da un mese
l’Austria è stata annessa al Terzo Reich e per le strade infuria
la violenza nazista. Freud è in ansia per la figlia Anna arrestata
dalla Gestapo. Il visitatore, all’apparenza giovane e brillante, si
rivela un personaggio ambiguo. Sulle prime il suo eloquio volutamente sibillino e provocatorio suscita l’irritazione dell’anziano e compassato signore che vorrebbe sbatterlo fuori. Ma
poi, deformazione professionale, inizia a sospettarlo affetto da
qualche forma di delirio psicotico e lo fa accomodare sul lettino riservato ai suoi pazienti. La seduta psicoanalitica ha luogo
ma a parti invertite. Il visitatore dimostra di conoscere nei mi117
nimi dettagli i ricordi d’infanzia e il vissuto interiore del padre
della psicanalisi, uno dei campioni dell’ateismo novecentesco,
il quale finisce con il confessare l’angoscia che lo coglie dinanzi
alla prospettiva della morte incombente (un tumore alla gola
lo condurrà alla tomba l’anno dopo), del vuoto esistenziale,
del non-senso. In un crescendo di battute tragiche e umoristiche al tempo stesso, l’identità del visitatore è svelata: egli
è nientepopodimeno che Dio, e quella del giovanotto un po’
petulante è la forma che ha scelto per manifestarsi a Sigmund.
Una forma che, dopo tutto, esprime grande comprensione ed
amorevolezza, dinanzi alla corrosiva incredulità dello scienziato. Mentre a Vienna vanno in scena le prove generali dell’Olocausto – simbolo della peggiore offesa che l’umanità abbia
arrecato e continui ad arrecare a se stessa – questo Dio disarmato ed impotente, che non può opporsi all’arroganza e
alla dilagante stupidità criminale degli uomini perché ha loro
donato la libertà, si dilegua dalla finestra, lasciando di sasso il
suo interlocutore. «C’è stato un tempo in cui l’uomo si accontentava di sfidare Dio, oggi prende il suo posto» – afferma il
giovane. E, nel bene e nel male, l’uomo dimostrerà tutta la sua,
spaventosa, manchevolezza: Freud, che pure ha speso tutta la
vita ad elaborare un approccio clinico atto ad alleviare le sofferenze psichiche dei pazienti, è consapevole d’esser disarmato
nell’affrontare la sua personale disperazione e ha il presentimento che al cospetto delle questioni ultime ben poco potrà
la scienza.
Il soggetto della commedia di Schmitt è assai esemplificativo
per il tema che stiamo trattando. Terzo dopo Nietzsche e Marx
tra i cosiddetti “maestri del sospetto” – l’espressione è stata
coniata nel 1965 dal filosofo francese Paul Ricœur – Freud riconduce l’origine del divino alla sfera della psiche, in quel “sottosuolo” a-razionale che è costituito dall’inconscio. In esso,
come nella struttura economica marxiana e nella volontà di
potenza nietzschiana, è destinato a naufragare ogni tentativo
118
di spiegazione razionale della realtà o di ordine metafisico fondato su un’idea forte di Dio.
Una volta ridotta a mero fatto antropologico, l’essenza della
religione si presta ad esser indagata in termini psicoanalitici.
La domanda, anche in questo caso, non verte più su Dio come
problema in sé, bensì sul significato e sull’eziologia del sentimento e della credenza religiosa. Dunque non “Dio esiste?” o
“Dio chi è?”, ma “che senso ha credere in Dio?”, o meglio “quale ipotesi scientifica è più adatta a spiegare l’origine psichica
del fatto religioso?”.
Ne L’avvenire di un’illusione (1927) Freud giunge alla conclusione che la devozione religiosa rappresenti una sorta di “surrogato” dell’amore rivolto alla figura paterna, ovvero risponda al desiderio di poter godere anche in età adulta di quelle
cure genitoriali da cui discendeva il senso di rassicurazione e
di benessere emotivo tipico dell’infanzia. Dio è “padre” perché la sua immagine “spirituale” si costruisce individualmente
e collettivamente sull’aspirazione nostalgica d’esser protetti
ed etero-guidati, beneficiando d’una specie di prolungamento indefinito della fanciullezza. Dunque, deresponsabilizzazione e protezione (illusoria) contro i colpi della sorte in cambio
della propria obbedienza cieca ed incondizionata: il padre va
compiaciuto perché il suo affetto e le sue salvifiche attenzioni devono “meritarsi”. Questo il significato psicologico di quel
che correntemente chiamiamo “fede”. In barba al principio di
realtà la religione è una specie di panacea naturalmente autoindotta, uno psico-farmaco lenitivo, da assumersi quando si
intravedono tutti i dolorosi limiti della condizione umana, ovvero l’ineludibile finitezza contro cui sono destinate ad infrangersi le smisurate energie libidiche dell’Ego-bambino:
«Il motivo che la psicoanalisi adduce per il formarsi della religione è uno solo: il contributo infantile alla sua motivazione
manifesta [...]. Il motivo del desiderio ardente del padre coin119
cide pertanto col bisogno di protezione contro le conseguenze
della debolezza umana; la difesa contro l’insufficienza infantile
lascia il suo segno caratteristico sul modo di reagire dell’adulto
contro la sua fatale impotenza, ossia sulla formazione della religione».
Ma anche di questo “complesso del padre” ci si può e ci si deve
liberare quando, esaurita la sua funzione palliativa, produca
veri e propri sintomi nevrotici. La stessa ritualità del culto religioso, la coazione a ripetere atti che non trovano motivazioni
realistiche, del resto, presenta tutti i connotati sintomatologici
delle cosiddette “nevrosi ossessive”, mentre fanatismi e fondamentalismi variamente declinati possono essere avvicinati a
veri e propri deliri psichiatrici. I loro effetti nefasti – è la storia
ad insegnarcelo – sono sotto gli occhi di tutti. L’ignoranza, peraltro, non può più esser considerata una seria giustificazione
della credenza in Dio, dal momento che la scienza positiva, pur
con tutti i suoi limiti, ne ha svelato il carattere illusorio: «Se mai
ci sia stato il caso di una cattiva scusa, ecco noi lo abbiamo qui.
L’ignoranza è ignoranza; nessun diritto a credere in qualcosa
può essere derivato da essa».
L’ateismo manifestato da Freud si colloca, chiaramente, al di
là dell’evento “morte di Dio”. Esso non entra nel merito della
questione in termini metafisici – essi sono stati del tutto banditi dalle nuove scienze umane. Quello dello scienziato moderno
è un ateismo, per così dire, “funzionale”, giacché obbedisce
alle esigenze del nuovo paradigma filosofico e culturale impostosi a cavallo tra i secoli XIX e XX. In effetti sono ora i criteri del
positivismo imperante a marcare la differenza tra “realtà” ed
“illusione”: «la nostra scienza – afferma il nostro – non è un’illusione. Sarebbe invece un’illusione credere di poter ottenere
da altre fonti ciò che essa non è in grado di darci».
Per converso, come ha ben evidenziato Éric-Emmanuel Schmitt ne Il visitatore, da questo quadro rimane esclusa la sfera
120
personale ed autobiografica, la sola da cui, in effetti, trae origine ed alimento la religione intesa come spiritualità e scelta di
vita. In presenza degli abissi interiori, che ci si spalancano nelle
cosiddette “situazioni limite” – l’angoscia legata al presentimento della morte o la noia generata dall’incalzante necessità
di provvedere il mondo di senso compiuto – le distinzioni intellettuali sfumano, le certezze positive scoloriscono lasciandoci,
come il protagonista del dramma, dubbiosi ed afasici.
E proprio alla dimensione personale, sia con argomenti razionali che con metafore tendenti al mistico, e comunque inventando un linguaggio filosofico che va oltre gli stilemi della metafisica classica e dello scientismo psicologista, proveranno a
parlare, come vedremo, i filosofi esistenzialisti.
In ogni modo, a prescindere dalla visione del mondo di ciascuno, laica o religiosa che sia, siamo tenuti a riconoscere ai “maestri del sospetto” il grande merito di averci fornito delle argomentazioni valide, e in alcuni casi conclusive, per individuare
i principali errori prodotti dalla nostra tendenza, più o meno
inconsapevole, ad “umanizzare” il divino. È proprio grazie all’ateismo critico (e post-metafisico) di Nietzsche, Marx e Freud,
che siamo oggi in grado di distinguere le forme di religiosità
veritiere e autenticamente vissute, dalle credenze basate rispettivamente sulla superstizione, sulla banalizzante ortodossia di facciata dietro cui occhieggia l’odierno nichilismo da supermarket, sul dato sociologico e politico, sulla miseria economica o, peggio, sulla nevrosi individuale. Potrebbe suonar
paradossale, ma proprio a loro, tutti quanti, credenti o meno,
siamo debitori dei nuovi orizzonti di spiritualità ecumenica
che, in questo principiar di secolo, paiono dischiuderci dinanzi
modelli alternativi di globalizzazione, più centrati sull’uomo e
dunque più gravidi di speranza.
121
Il divino al vaglio delle filosofie novecentesche
La tradizionale concezione della metafisica e del divino si
è definitivamente infranta contro il frangiflutti della critica
nietzschiana, marxiana e psicoanalitica. Con il positivismo lo
spazio speculativo della filosofia viene progressivamente colonizzato dalle nuove discipline basate sul metodo sperimentale
e sulla matematica. L’indagine filosofica, in particolare nei paesi anglosassoni, viene retrocessa in posizione “ancillare”, al
servizio della scienza. Se nel medioevo essa era considerata
propedeutica all’esperienza intellettuale e spirituale del sacro,
la teologia, ora è chiamata a fornire supporto al lavoro dello
scienziato, come analisi volta a depurare il linguaggio da “incrostazioni” metafisiche e non-sense, o, al più, ad affinare gli
strumenti logici e metodologici delle neoscienze, come loro
organon. È all’interno del cosiddetto Circolo di Vienna (organizzato da Moritz Schlick negli anni Venti e poi diffusosi nel
resto d’Europa dopo la diaspora provocata dall’avvento di regime hitleriano) che s’inizia a parlare di “morte della filosofia”.
Il panorama della conoscenza si avvia ad essere vieppiù desacralizzato: se i grandi pensatori ottocenteschi avevano “archiviato” il dibattito intorno alla divinità e ai suoi attributi, sul
palcoscenico del Novecento scientista pare non dover andare
più in scena nemmeno il dramma del rapporto uomo-dio – che
pure dopo la rivoluzione soggettocentrica continuava a venir
rappresentato, benché, rispetto al passato, a parti rovesciate.
Eludendo il vicolo cieco dello scientismo e la conseguente
morte della filosofia, le filosofie novecentesche si muovono
su due tracciati speculativi diversi (ma complementari), lungo
i quali si ripropone in maniera sostanziale il tema del divino.
In entrambi i casi, sebbene alcuni spunti di riflessione affondino chiaramente le loro radici nella storia della filosofia precedente la dipartita di Dio e l’avvento del nichilismo profetizzati
da Nietzsche, le derive e gli approdi teoretici e pratici, il lin122
guaggio utilizzato nonché alcune domande di fondo appaiono
inedite. A saper prestar loro orecchio, esse interrogano senza
mezzi termini la nostra contemporaneità.
Il primo percorso è quello dei filosofi esistenzialisti. Il termine
“esistenzialismo” può essere utilizzato in due accezioni. In primo luogo indica un movimento di pensiero specificamente novecentesco cui appartengono alcuni autori, per esempio JeanPaul Sartre (1905-1980) o Karl Jaspers (1883-1969), cui faremo
riferimento più avanti. In subordine serve a connotare un particolare approccio filosofico – come pure il genere letterario ad
esso collegato, narrativo ed autobiografico – senza tempo, se
tra i grandi “esistenzialisti” possiamo annoverare pensatori del
calibro di Sant’Agostino, Michel de Montaigne, Blaise Pascal o,
nell’Ottocento, il danese Søren Kierkegaard.
Qualunque sia l’esito dell’orientamento esistenziale, fideistico,
agnostico o dichiaratamente ateo – nel Novecento le diverse
correnti sono state tutte degnamente rappresentate – la questione del divino è ricondotta nello spazio interiore e morale
del “singolo”, affidata alla sua responsabilità e messa alla prova nell’autobiografia. Quel che più preme al filosofo è definire
il senso della propria esistenza alla luce di una scelta impegnativa, che vien maturando nel crogiuolo della riflessione quotidiana. Quando è il proprio destino personale ad esser messo
in gioco, non si danno, in effetti, verità indiscutibili, razionali o
rivelate che siano. Con esse, al limite, si è “in relazione” (razionale o fideistica) e il passaggio dal concepirle intellettualmente
all’incarnarle nella vita di tutti i giorni è sempre e comunque
drammatico; ha, per usare un termine tratto dal lessico di Pascal, il sapore aspro di una “scommessa”.
Anche l’esistenzialismo è, dunque, “soggettocentrico”. Ma non
si tratta qui del soggetto trascendentale di kantiana memoria
colto nella sua purezza disincarnata, bensì della persona in
carne ed ossa, storicamente data, questo-uomo-qua, ecceità
vivente e relazionale. Se la morte di Dio, come evento epoca123
le, ha fatto venir meno l’assolutezza della dimensione religiosa
e spirituale in termini sociologici e civili – non essendoci più
alcun Assoluto, Essere o Verità, a garantire l’ordine supremo,
tutto si è relativizzato, persino spazio e tempo secondo la teoria della relatività di Einstein –; ebbene, è ora la persona, nel
chiuso della sua singolarità, a doversi accollare la domanda
fondamentale e a portarne il peso schiacciante della responsabilità. In metafora, giacché non è più Dio, la Chiesa o lo Stato
a “tenermi legato” (secondo una possibile etimologia la parola “religione” deriverebbe dal verbo latino re-ligare, “unire
insieme”), sono chiamato io, in prima persona, a produrre
una qualche “forza di attrazione gravitazionale”, se non voglio
correre il rischio di andare alla deriva nell’infinita vuotezza del
Tutto. All’uomo del Novecento, resosi individuo-massa, si confà un gran senso di solitudine. In una società in cui tutto è relativamente privo di valore, se non siamo noi a darglielo, anche
proclamarsi “atei” ha poco senso.
L’esistenzialismo novecentesco parte da questa presa d’atto.
Nulla è più come prima. Con il diffondersi della prospettiva
nichilista alla coscienza dell’uomo occidentale si presenta un
dilemma, in certo senso, sconosciuto, inaudito, terribile: non si
è più chiamati a configurare la propria “forma di vita” in base
ad un “Bene” e ad un “Male” predefiniti e “garantiti” una volta
per tutte dalla misericordia d’un Dio trascendente, ma a dover
stabilire contestualmente il “bene” e “male” su cui poi orientare la propria, terrestre, scelta di vita, senza l’assicurazione di
alcuna prova d’appello ultraterrena. Una responsabilità, come
si capirà, ben più radicale e spiazzante di quella dell’uomo medievale o moderno, il quale, al massimo, disponeva del libero
arbitrio di sottomettersi o no all’infallibile Verbo divino. Dopo
il parricidio di Dio, l’effimera libertà da un ordine prestabilito
reca con sé la necessità di pensarsi individualmente liberi di
creare nuovi valori – anche di sottomettersi al Signore di Abramo ed Isacco o di abbracciare la croce con il Cristo. Ma lo si
124
deve soggettivamente volere. Ecco perché l’esistenzialismo,
ateo o cristiano che sia, prefigura comunque un modo del tutto diverso di vivere e pensare l’assenza o la presenza di Dio in
rapporto con se stessi.
Il secondo percorso, pervaso anch’esso di spunti esistenzialisti,
riconduce la filosofia verso il tema originario e fondamentale
dell’Essere e dell’Intero, ossia del senso ultimo della realtà. Le
scienze positive, per loro natura, sono specialistiche e settoriali, si muovono all’interno dei recinti, più o meno ristretti,
del loro oggetto, una specie di “ragione sociale” esclusiva (o
quanto meno parziale). Ad esempio il “bio-logo” si occupa,
previa sperimentazione, di produrre argomenti razionali intorno alle cose viventi (bìos in greco significa “vita”), ma non
sottopone ad esame il necessario collegamento tra il vivente
e il non-vivente, l’organico e l’inorganico. Gli sfugge la visione
d’insieme, l’“interezza”. Di questo si occupa, in ultima istanza,
la filosofia, al di là della presunta “morte della filosofia”. È uno
sguardo che tende ad abbracciare l’intero orizzonte del reale,
impiegando la ragione nel tentativo di dare vita a discorsi complessivi, come pure indagando i confini dello stesso linguaggio,
al di là dei circoscritti tecnicismi del lessico positivista.
Si tratta, in effetti, di immaginare un pensiero metafisico inusitato, che facendo propria la lezione nietzschiana, vada oltre
la superata ontologia occidentale, basata sull’Essere di Parmenide e sulla Sostanza di Aristotele – in tal senso esso si manifesterà paradossalmente come “anti-metafisico” – senza
per questo rinunciare a porsi la domanda fondamentale: “che
cos’è l’Essere?”. Da questa prospettiva privilegiata, potremmo
dire che la riflessione filosofica, lungi dal calare nella tomba, riguadagna nel corso del Novecento un suo spazio specifico, più
ampio ed arioso. Liberata dal peso della multidisciplinarietà e
della sistematicità che ancora caratterizzavano l’hegelismo e le
dottrine di ispirazione hegeliana – a comporre un quadro completo dell’umanesimo scientifico provvedono ora antropolo125
gia, sociologia, economia politica, psicologia e le altre scienze
sociali – la filosofia può aspirare a riconsiderare il molteplice
alla luce dell’unità, tracciando originali itinerari teoretici, in
grado di farci ripensare il rapporto dell’uomo con il pianeta e
con il Tutto. Il disegno di una metafisica innovativa risponde,
in ultima istanza, al bisogno dell’uomo contemporaneo di riconsiderare sotto una diversa luce, relazionale, globalizzata,
ecumenica e, soprattutto, “pratica” il tema del divino.
Tra i protagonisti di questa straordinaria avventura metafisica ci
accosteremo a due personaggi che hanno lasciato un’impronta
decisiva nella storia del pensiero novecentesco, entrambi pensatori profondissimi dalle biografie controverse e tormentate:
il tedesco Martin Heidegger (1889-1976) e l’austriaco Ludwig
Wittgenstein (1889-1951). L’accostamento dei due pensatori
non risponde a rigorosi criteri storico-filosofici, ma è senz’altro
funzionale al discorso che stiamo portando avanti.
Sartre: Dio è il Silenzio, Dio è l’Assenza, Dio è la Solitudine
degli uomini
Jean-Paul Sartre è considerato uno dei maggiori esponenti
dell’esistenzialismo ateo del Novecento. Filosofo, romanziere,
commediografo, critico letterario, egli ha rappresentato il prototipo dell’intellettuale engagé, politicamente e socialmente
impegnato, una vera e propria icona per la gioventù europea
degli anni Sessanta.
Con Sartre l’esistenzialismo diventa una concezione e, soprattutto, una prassi libertaria. L’uomo è l’unico ente in cui l’esistenza precede l’essenza: la consapevolezza di esser vivi, il
sentirsi gettati nel mondo, vien prima rispetto al senso e alle
connotazioni che daremo alla nostra vita, al destino che ci procureremo. È un fatto. Non abbiamo scelto di venire alla luce,
né di dover chiudere gli occhi per sempre: moriremo e basta,
comunque, un giorno. Tra i due estremi, però, tutto è possibile
126
e siamo noi a determinarlo. Impugnata la penna, ogni giorno
scriviamo la nostra personale, inimitabile storia, sfidando la
bianchezza del taccuino che la sorte c’ha messo tra le mani.
Così facendo progettiamo e realizziamo la nostra essenza, ovvero la nostra autobiografia. Anzi v’è di più: siamo costretti a
farlo. Non possiamo decidere in assoluto di non scegliere, perché anche questa è, in ogni caso, un’opzione. “Mi sono risolto
a non scegliere”, “ho stabilito di lasciarmi vivere” o “di sottomettermi all’altrui volontà”: comunque la si metta è un atto
di libertà. Per questo, «l’uomo è condannato ad esser libero».
L’uomo di cui parla Sartre non è un’entità metafisica o psicologica, non l’homo oeconomicus delle scienze sociali o il sapiens
dell’antropologia. È un’entità personificata e storicizzata, sei
proprio tu o sono proprio io, è il protagonista del pensiero ottocentesco di Kierkegaard, al quale dobbiamo l’invenzione in
chiave esistenziale ed antihegeliana del concetto di “singolarità”. La realtà umana non è composta di generi ideali, di categorie statistiche, di classi sociali, ma di singole persone. Sono loro
ad interpretare quella drammatica avventura che chiamiamo
vita. Il resto è astrazione.
Ma perché l’esser liberi è “condanna”? Perché libertà significa
affrontare la dimensione del “possibile” e l’angoscia ad essa intimamente connessa. Per ogni possibilità che incarno, un’altra,
ineluttabilmente, scivola via, si nullifica. Se con Dio è sfumato
quel Bene-in-sé di platonica memoria, non solo giudice a posteriori del mio agire, bensì legislatore io sono: a me spetta
determinare non solo cosa fare dei miei giorni e delle mie ore,
ma anche perché e in nome di che cosa farlo. E avere l’ardire di
scegliere, nel mio piccolo, per l’intera collettività, perché ogni
mio pensiero, ogni mia azione, non importa quanto essa possa
sembrare insignificante, si riflette sul destino complessivo del
genere umano.
Come “forzato” della libertà, l’individuo è costretto, in almeno un senso, a far le veci della divinità. Egli è sostanzialmente
127
impotente, fragile, meschino, insipiente, costantemente sotto
scacco. Eppure nei limiti della sua finitudine è libero di stabilire, agendo, cos’è bene e cos’è male. Come Dio egli è “al di là
del bene e del male”, perché il bene corrisponde, di fatto, alla
sua volontà, che nelle faccende umane si estende prospetticamente all’umanità intera. In un famoso passaggio della conferenza intitolata L’esistenzialismo è un umanismo (tenuta nel
1945, poi data alle stampe l’anno successivo) Sartre afferma:
«Scegliere d’essere questo piuttosto che quello è affermare, nello stesso tempo, il valore della nostra scelta, giacché non possiamo mai scegliere il male; ciò che scegliamo è sempre il bene
e nulla può essere bene per noi senza esserlo per tutti. Se l’esistenza, d’altra parte, precede l’essenza e noi vogliamo esistere
nello stesso tempo in cui formiamo la nostra immagine, questa
immagine è valida per tutti e per tutta intera la nostra epoca.
Così la nostra responsabilità è molto più grande di quello che
potremmo supporre, poiché essa coinvolge l’umanità intera».
Una responsabilità schiacciante: ecco cosa è inestricabilmente intrecciato a quella libertà cui siamo condannati. È la croce
che anche il laico di buona volontà, tutto teso ad un agire filantropicamente orientato, deve portare. Sartre, ad esempio,
aveva abbracciato in politica la fede marxista e ad essa rimase
coerente sino alla morte, cercando di conciliarvi le principali
idee esistenzialiste. Dopo la dipartita del Dio della metafisica
classica, come un orfano cresciuto troppo in fretta, l’uomo
del Novecento si trova a dover sostenere il fardello della responsabilità paterna, angustiato dalla consapevolezza di fondo
che le sue spalle non saranno mai abbastanza larghe per sostenere un simile peso. Perché nel progettare e determinare
praticamente la propria essenza, in termini etici e politici, è
ora irrimediabilmente solo. In tale fondamentale circostanza
– una sorta di a priori dell’esistenzialismo –, indipendentemen128
te dall’esito ultimo della propria auto-determinazione, per lui
Dio simboleggia l’oceano di silenzio ove riecheggia inane la sua
voce, l’assenza di significato assoluto, l’estrema metafora della
propria solitudine. Nella scelta esistenziale sono solo: anche
nel momento in cui scegliessi di convertirmi, di gettarmi tra
le braccia del Cristo (come ad esempio avevano deciso di fare
Pascal e Kierkegaard), in quel preciso istante sarei comunque
chiamato a risponderne unicamente a me stesso. Ecco perché
l’esistenzialismo di Sartre è irrimediabilmente “ateo”. Ma in
ciò, d’altra parte, consiste il suo eroismo. L’impegno ad autodeterminarsi, affrontando coraggiosamente l’angosciosa vertigine del possibile, dà comunque valore alla vita, la rende degna d’esser vissuta. È dunque foriero, checché se ne dica, di un
atteggiamento produttivo e ottimista. Alle polemiche suscitate
dalle sue prese di posizione “irreligiose” Sartre replica così:
«L’esistenzialismo non vuole essere ateo in modo tale da esaurirsi nel dimostrare che Dio non esiste; ma preferisce affermare: anche se Dio esistesse, ciò non ci cambierebbe nulla, ecco il
nostro punto di vista. Non che noi crediamo che Dio esista, ma
pensiamo che il problema non sia quello della sua esistenza;
bisogna che l’uomo ritrovi se stesso e si persuada che niente
può salvarlo da se stesso, fosse pure una prova valida dell’esistenza di Dio. In questo senso l’esistenzialismo è un ottimismo, una dottrina d’azione, e solo per malafede confondendo
la loro disperazione con la nostra, i cristiani possono chiamarci
‘disperati’».
Jaspers: il naufragio nella Trascendenza
La specificità dell’esistenzialismo di Karl Jaspers sta nel rilievo
da lui dato all’idea di Trascendenza. Rispetto alla “terrestrità”
laica ed impegnata di Sartre, l’esito della riflessione di Jaspers è
129
di tipo, per così dire, “mistico”. Se l’esistenza precorre quell’essenza che ognuno è chiamato ad auto-determinare attraverso
la chiarificazione e l’incarnazione coerente del proprio credo
in senso autobiografico, la condizione umana – l’esserci (in tedesco Dasein, “essere lì”, “trovarsi in una determinata situazione personale e storica”), inteso come sinonimo di esistenza
– data la sua finitudine non può non rimandare al supremamente Altro-da-sé.
Detto altrimenti, non vi è esistenza senza Trascendenza. Esserci per ciascuno di noi significa sporgersi momentaneamente,
transitoriamente fuori dal Tutto-indistinto cui sentiamo, in
ultima istanza, di appartenere. Non si dà alcun esserci senza
Essere. Soltanto a partire dall’indeterminatezza dell’Essere
prendiamo corpo in quanto enti dotati della particolare consapevolezza di essere-al-mondo, obbligati a progettare la nostra parabola di vita. La quale parabola, però, a prescindere
dalla qualità peculiare di ciascun progetto, non può che essere
orientata verso quell’Ulteriorità che infine tutto e tutti sovrasta e “divora”. Essa sfugge a qualunque abboccamento di tipo
intellettuale o razionale. L’Essere è per sua natura un Oltre,
indistinto e dunque indistinguibile, alogico e perciò non razionalizzabile: assomiglia all’Àpeiron anassimandreo, oppure al
Tao della tradizione taoista cinese.
Ad esso la mia individualità transeunte si accosta nel presentimento della Trascendenza, nello scoprire che la caducità del
proprio essere-in-sé rimanda a ciò che semplicemente è. La
vita è come il volteggiare d’un trapezista che nel bel mezzo
della traiettoria matura la consapevolezza d’esser senza rete.
Egli farà di tutto per rimanere concentrato, se è buon acrobata.
Ma alla fine, accetterà il vuoto che lo circonda da ogni lato, e
dopo aver lottato per la sua salvezza, ad esso infine si abbandonerà, un giorno. Meraviglioso ed enigmatico questo celebre
brano di Filosofia (1932) in cui Jaspers tratteggia il significato
esistenziale del naufragio:
130
«Da ultimo c’è il naufragio; lo dimostra l’orientazione nel mondo che inesorabilmente si attiene ai fatti. [...] Per l’orientazione
nel mondo, il mondo in quanto esserci naufraga, perché in sé
e da sé non si lascia comprendere. [...] Nella chiarificazione
dell’esistenza naufraga l’inseità [l’essere in sé] dell’esistenza:
infatti là dove sono propriamente me stesso, non sono solamente me stesso. [...] Se dunque il naufragio, a cui io mi abbandono a piacere, è solo il nulla vuoto, allora il naufragio che
mi coglie, quando ho fatto veramente di tutto per evitarlo, bisogna che non sia solo naufragio. Allo stesso modo, io sperimento l’essere quando nella sfera dell’esserci ho fatto quello
che potevo per difendermi; e analogamente, quando, come
esistenza, rispondo completamente di me, e da me tutto esigo; ma non posso sperimentare l’essere quando, nella coscienza della mia nullità di creatura di fronte alla Trascendenza, mi
abbandono alla caducità propria dell’essere creatura».
L’Essere non si capisce. È inafferrabile. Nella sua abissale indeterminatezza, che come un gorgo ogni ente particolare inghiotte, in ultimo si fa naufragio. La metafora jaspersiana del naufragio è assai profonda. Da una parte, essa si riferisce a quella
prodigiosa capacità umana – tutti quanti in fondo ne disponiamo – di avvertire distintamente il limite e, nello stesso tempo,
di intuire ciò che questo limite preannunzia: quella sensazione
di infinito e di immensità in cui, come dice il poeta, «s’annega il pensier mio: e il naufragar m’è dolce in questo mare».
Dall’altra, indica un evento preciso, il compiersi inesorabile di
una disposizione che c’accompagna lungo tutta la vita e riecheggia sino a stordirci nei momenti di maggiore discernimento, una campana che, impassibile, rintocca il suo Es muß sein!
(“Dev’essere!”). L’evento può essere “premeditato” in tutta la
sua drammaticità: non a caso la praemeditatio mortis è uno
degli esercizi spirituali più comuni e filosoficamente rilevanti
di tutti i tempi. Di portata universale, esso è pure quanto di più
131
autenticamente personale ci è dato immaginare e sperimentare. Nel momento in cui la nostra “navicella s’infrange” (“naufragio” dal latino navis frangere, “rompere”, “frantumare” la
“nave”) durante la tempesta finale siamo soli. Eppure se non ci
attacchiamo alla nostra condizione di creature, se accettiamo,
dopo esserci sino all’ultimo fatti carico della nostra responsabilità umana, “ciò che sta oltre”, paura e dolcezza si fondono
insieme. Il naufragio, è chiaro, apre la porta ad una concezione
del divino che ben si concilia con i presupposti dell’esistenzialismo novecentesco e, contemporaneamente, richiama alla
mente tematiche romantiche e contemplative. Un Dio, quello
cui Jaspers fa indirettamente riferimento, senza-nome e senzavolto, non Essere immutabile e promessa di salvezza, inteso
come “permanenza”, bensì “indefinitezza tutt’avvolgente”, “divenire”, autentica “imprevedibilità”. Eppure, a ben guardare, è
in grado di riconciliarci con il mondo, di farci sentire, nel rapportarci con esso, “a casa nostra”:
«Insensibile, né benevolo, né spietato, sottomesso a leggi rigorose o affidato al caso, il mondo non sa di sé. Non lo si può
capire perché si presenta impersonalmente, se lo si riesce a
chiarire in qualche particolare, resta comunque incomprensibile nella sua totalità. Ciò non toglie che io conosca il mondo
anche in un altro modo. Un modo che me lo rende affine e che
mi consente di sentirmi, in esso, a casa mia, al sicuro. Le sue
leggi sono quelle della ragione, per cui, sistemandomi in esso,
mi sento tranquillo, costruisco i miei strumenti e li conosco. Mi
è familiare nelle piccole cose e in quelle che mi sono presenti,
mentre mi affascina nella sua grandezza; la sua vicinanza mi
disarma, la sua lontananza mi attira. Non segue i sentieri che
attendo, ma anche quando mi sorprende con insospettate realizzazioni o inconcepibili fallimenti, alla fine conservo, anche
nel naufragio, un’indefettibile fiducia in esso».
132
La “rivoluzione” ontologica di Heidegger
Se con la pubblicazione di Essere e tempo (1927) Martin Heidegger aveva tracciato la strada maestra degli esistenzialismi
novecenteschi, che gli sono in gran parte debitori sia in termini concettuali che lessicali, è con Lettera sull’umanismo (1947)
che egli inaugura una visione ontologica veramente “rivoluzionaria”. La domanda intorno all’Essere, già centrale nelle prime
opere, è qui riproposta in maniera più attenta alle sue implicazioni etiche e storiche e tiene conto, in maniera coerente
ed efficace, della morte di Dio, cui Heidegger dedicherà uno
scritto, La sentenza di Nietzsche “Dio è morto” (pubblicato nel
1950 in Sentieri interrotti), e alcuni corsi universitari.
Ad esser scomparso dal panorama ideale e civile delle società
occidentali – anche se ancora di ciò non si ha una percezione
del tutto chiara – è il Dio-Essere della tradizione, la cui nozione
era fondata sulla ontologia del padre Parmenide, così come
era stata recepita da Platone, Aristotele e Plotino, per citare
solo i più grandi filosofi dell’antichità, e ripresa in chiave cristiana da Tommaso d’Aquino nel medioevo. Di questo avvenimento Nietzsche si era fatto interprete profetico. Heidegger
gli riconosce il merito di aver intuito la portata epocale della
scomparsa di Dio. Essa era inscritta, in un certo senso, nel destino della stessa metafisica occidentale. L’opera di Nietzsche
si era però interrotta sul crinale che separava il vecchio dal
nuovo. La pars construens della filosofia nietzschiana era stata solo abbozzata attraverso le metafore della volontà di potenza, dell’eterno ritorno e dell’oltreuomo, dalle quali erano
derivate visioni senz’altro portentose, ma che alla fine risultavano ambigue ed incomplete. Heidegger ritiene pertanto che
occorra pensare una metafisica, che “superi” effettivamente il
concetto di Essere antico-medievale, svelando nuovi orizzonti
alla nostra civiltà. Giacché, in effetti, sul diverso modo in cui
ci collochiamo dinanzi alla domanda fondamentale, “che cos’è
133
l’Essere?”, poggia tutto l’impianto culturale, istituzionale, sociale ed economico della nostra epoca: non possiamo non fare
i conti con il divino “sconosciuto” che si staglia oltre il Dio della
scolastica. Un Dio-Essere forse più “debole”, “aperto”, “sfuggente”, non riducibile a mera nozione concettuale. Tant’è: Heidegger lo paragona ad una foresta oscura ed intricata lungo
i cui sentieri si è costretti a vagare per giungere, di tanto in
tanto, ad una “radura”, dalla quale è possibile averne una visione più estesa ed integrale, pur rimanendovi dentro. Prima
di avventurarci nell’intrico della foresta heideggeriana è però
opportuno ripercorrere, in estrema sintesi, il cammino della
metafisica classica.
Secondo la teologia della scolastica Dio è Ens perfectissimum,
ossia l’ente (la cosa che è) a cui tutti gli attributi devono essere riferiti al massimo grado (per esempio la bontà, Dio è il
Bene; il vero, Dio è la Verità; ecc.). In senso squisitamente ontologico, Egli è l’ente che ha per essenza l’Essere in sé. Detto
altrimenti, ciò che definisce Dio in quanto tale (la sua essenza)
è l’Essere, ovvero la pura, adamantina, incontrovertibile pienezza ontologica. Tra il Dio dell’Antico Testamento israelitico e
l’Essere della filosofia greca si è così venuta a stabilire, nei secoli, una relazione identitaria, tenuta saldamente dal principio
di non-contraddizione. In questa maniera, negare l’esistenza
di Dio equivale, necessariamente, ad affermare il Non-essere,
cadendo in contraddizione. Su tale nesso si basa, ad esempio,
la prova ontologica dell’esistenza di Dio formulata da Anselmo
d’Aosta.
La definizione scolastica veniva suffragata, tra l’altro, dall’autorità della Sacra Scrittura. In un passo del Libro dell’Esodo
(3, 14) Jahvè parlando con Mosè afferma: “io sono colui che
sono” (o “io sono io-sono”). Trasposta nei termini della metafisica classica, tale espressione suonerebbe così: “io sono colui
che per propria natura è Essere”, “io sono l’Essere di per sé”.
Del tutto estranea alla mentalità greca antica – vale la pena qui
134
rammentarlo di passaggio – è invece l’idea di un Dio “persona”
o “personificazione” di un concetto astratto. In realtà, l’esegesi biblica novecentesca ha dimostrato come tale traduzione,
dall’ebraico al latino, abbia prodotto, nei secoli, un fraintendimento di fondo. Il verbo “essere”, in ebraico, ha infatti un
valore “causativo” piuttosto che “esistenziale”. Stando così le
cose, la locuzione “io sono io-sono” andrebbe correttamente
resa con “io sono colui che fa essere”, “colui che decide”, “colui
che guida il popolo d’Israele”, e non con “colui che riassume in
sé l’Essere di tutte le cose”. Quest’ultimo concetto sarebbe del
tutto estraneo alla visione del mondo e al linguaggio veterotestamentario. Il che vanificherebbe l’argomentazione medievale basata sull’autorità della Bibbia.
Resta il fatto che sin dalle origini la filosofia occidentale ha considerato teologia ed ontologia in stretta connessione, di modo
che l’interrogativo intorno all’Essere e quello intorno al Divino
si siano vicendevolmente implicati sino a coincidere. Difficile,
e anche, tutto sommato, inutile, provare a stabilire tra i due
ambiti di ricerca un rapporto “gerarchico” di priorità (ovvero: è
una specifica concezione del divino a determinare quella data
visione ontologica o viceversa?). Va da sé, dunque, che ponendosi in maniera originale la questione intorno all’Essere si dia
luogo, esplicitamente o meno, ad una diversa visione del divino. Quando si ragiona intorno ai massimi sistemi, provando
ad investire di significato l’interezza del reale, è inevitabile che
ci si imbatta nel tema del “sacro”, a prescindere dal retroterra
culturale ed esperienziale di cui si è portatori.
Ma in cosa consiste esattamente la “rivoluzione ontologica”
proposta da Heidegger? Facendosi la fatidica domanda intorno all’Essere la metafisica classica secondo il filosofo si era in
realtà chiesta “che cos’è l’ente?” ovvero “come viene ad essere
ciò che è?”. L’Essere aveva finito con l’obliarsi, perché era stato
di fatto confuso con l’ente, con il mero “esser presente delle
cose che sono”. Ma l’Essere in sé è altro rispetto all’ente, non
135
si esaurisce in ciò che è. In parole povere, ciò che fa essere
quest’albero ciò che è, non deve esser confuso con l’albero,
perché lo trascende, lo sovrasta, va oltre il puro darsi dell’albero inteso come semplice presenza ovvero disponibilità a venir
percepito come qualcosa che mi sta dinanzi nel qui e nell’ora.
La concezione originata da tale modo di porsi la questione ontologica è stata, in certo senso, fuorviante e va, dunque, superata.
Occorre dunque ripensare la domanda fondamentale (e fondante: in tedesco Grundfrage) dell’ontologia in forma rigorosa:
“che cos’è l’Essere?”, ossia “come giunge ad esprimersi l’Essere
(attraverso l’ente)?”. Questo è il problema originario. Da esso
si diparte un sentiero di ricerca che mira ad andare oltre l’ente
– e la sua “entificazione” (ossia il suo “farsi ente”) – per aprire
un panorama attraverso il quale l’Essere in sé possa mostrarsi
come ulteriorità rispetto al mero “esser cosa” (cosalità) degli
enti. L’errore in cui era incorsa la metafisica platonico-aristotelica consisteva nel considerare l’Essere come causa degli enti,
ovvero come qualcosa che, pur gerarchicamente superiore,
condivide con l’ente il suo modo d’essere, come “universale”
rispetto ad un “particolare”. Una specie di “super-ente”, un
“genitore” (Dio è padre), che pur nella sua alterità, risulta dotato dello stesso codice genetico.
Insomma, una volta trasformato in concetto-parola con l’apposizione dell’articolo determinativo all’infinito del verbo “essere”, l’Essere-Dio è stato catapultato tra le cose del mondo, una
cosa speciale, certo, “motore immobile” o “pensiero di pensiero” per Aristotele, fine ultimo cui tende il cosmo o, per dirla
con l’Alighieri, «l’amor che move il sole e l’altre stelle». Ma pur
sempre “ente”. In questo consiste l’oblio dell’Essere, ovvero il
progressivo venir meno della splendente ulteriorità del dio, il
suo terrestrizzarsi, desacralizzarsi, condividendo infine con gli
enti il destino di morte.
Per distinguere i due concetti di ente ed Essere Heidegger usa
136
rispettivamente gli aggettivi “ontico”, riferito al primo, ed “ontologico”, riferito propriamente soltanto al secondo. La dimensione “ontica” nel momento storico attuale è così configurata
che l’ente si presenta essenzialmente sotto il controllo della
“tecnica”. Se oggi ci interroghiamo sull’ente sarà la tecnica a
fornirci la risposta: «quale esso ‘è’ ci vien detto dal predominio
dell’essenza della tecnica moderna, il cui dominio si manifesta
in tutti i campi della vita, come appare dal fatto che si hanno
espressioni caratteristiche come funzionalizzazione, massimo
rendimento (Perfection), automazione, burocratizzazione, informazione» (in La concezione onto-teo-logica della metafisica, 1967).
Il modo di rivelarsi dell’Essere, invece, è onto-logico ciò “discorsivo”, “linguistico”: «Nel pensiero l’Essere perviene al linguaggio. Il linguaggio è la casa dell’Essere. Nella sua dimora
abita l’uomo. I pensatori ed i poeti sono i custodi di questa
dimora” (in Lettera sull’umanismo). Non la tecnica, non la
scienza positiva, quindi, ma un nuovo approccio teoretico che
rimetta al centro l’uomo nella sua integralità – un “umanismo”
appunto – è il solo in grado di avvicinarci davvero all’Essere.
Così facendo l’uomo diventa il “pastore dell’Essere”, “la cui dignità consiste nell’esser chiamato dall’Essere stesso a custodia
della sua verità».
Dunque, di contro ad una concezione “presenzialistica”
dell’Essere Heidegger ne propone una “de-entificata”. L’Essere
è propriamente “ni-ente”, cioè “non-ente”. Il che non equivale affatto a nullificarlo, facendolo coincidere con il famigerato
“Non-essere” parmenideo. La terribile trappola del principio di
contraddizione che aveva condizionato la filosofia sin dal suo
sorgere può essere evitata là dove si arrivi a comprendere che
la negazione dell’ente, ovvero del particolare, non comporta
la negazione, bensì l’affermazione dell’Essere, inteso come totalità di apertura, possibilità, vuotezza di determinazioni prestabilite. Se l’Essere fosse qualcosa invece che “ni-ente”, gli
137
enti vedrebbero chiudersi quello “spazio generativo”, “quella
assenza ontica” che sola permette loro di manifestarsi come
tali. Potremmo dire che esso rappresenta la pura bianchezza
dello schermo che rende possibile la messa in scena delle cose
del mondo, il flusso continuo del loro emergere dal ni-ente per
poi in esso rituffarsi.
Un’ontologia basata su tali presupposti consente di evitare sia i
rischi dell’eternalismo che quelli del nichilismo. Da un lato non
è possibile parlare di sostanze sempiterne; dall’altro non si può
propriamente dire che le cose divengano nulla. Grazie ad un
Essere vuoto di determinazioni ontiche, gli enti hanno la possibilità di manifestarsi, di venire temporaneamente alla luce. Le
cose del mondo sono nel tempo; l’Essere invece è temporalità,
avvenimento. Il rapporto che c’è tra Essere ed enti assomiglia,
in metafora, a quello che si dà tra la luce e le cose visibili. La
luce non è in sé visibile, né si può affermare sia qualcosa di
particolare. Essa è piuttosto la “condizione di visibilità” di tutto
ciò che viene illuminato. Così come il silenzio è la “condizione
di udibilità” di tutti i suoni. Senza il silenzio non si produrrebbe
alcuna melodia.
Questa è la caratteristica principe dell’Essere e, dunque, del divino. Esso è propriamente “inconcepibile” (“non capibile”, dal
latino capio, “piglio”, ossia non afferrabile con la mente, non
intellettualmente classificabile), poiché si rivela nel suo “toglimento”, nell’atto di auto-sottrarsi affinché gli enti possano venire ad essere. Come la luce e il silenzio, questo Dio misterioso
non lo si può “comprendere” perché rappresenta esso stesso
la possibilità di comprensione degli enti. Si possono “prendere
insieme”, “abbracciare” – questo il significato del verbo latino
cum-prehendere – le cose che si stagliano sull’orizzonte, ma
non l’orizzonte in sé: lo si contempla, ne si rimane abbacinati
e in esso, come aveva detto Jaspers, si finisce con l’affondare.
Quella di Heidegger è una concezione del divino “debole” e “al
femminile”. Un Dio absconditus (nascosto) che non “riempie”,
138
ma “contiene”, non s’impone attraverso la violenza del concetto, ma gentilmente si fa da parte affinché le sue creature
– gli enti – possano dar vita ad una fenomenicità danzante. Un
Dio siffatto, non essendo concettualizzabile, non dogmatizza,
non si lascia strumentalizzare, né dà adito a fondamentalismi.
Ad esso l’Occidente può pervenire recuperando quello spazio
di spiritualità che la tecnica trionfante sembra aver del tutto
estinto. Non questo o quel Dio, non il Dio dei cattolici o quello
dei musulmani, ma la verdeggiante regione del sacro, che giace inespressa in ciascun essere umano. A simili pascoli dovrà
condursi l’uomo in quanto “pastore dell’Essere”, poetando, di
contro alla prosaicità della tecnica, in attesa di salvezza divina,
giacché – come ebbe a dichiarare il filosofo in un’intervista rilasciata al quotidiano Der Spiegel nel 1976 – «soltanto un Dio
può ancora salvarci. La sola possibilità che ci resta nel pensiero
e nella poesia, è la possibilità per la manifestazione di questo
Dio».
Wittgenstein: il Mistico si colloca al di là delle possibilità del
linguaggio
All’ineffabilità dell’Essere heideggeriano fa eco, idealmente, la
non dicibilità del concetto di “Mistico” formulato da Ludwig
Wittgenstein nel celebre Tractatus Logico-Philosophicus
(1921). Alla sua pubblicazione, realizzata su interessamento
dei filosofi inglesi Bertrand Russell e George Edward Moore, l’opera dell’allora giovane e sconosciuto Wittgenstein fu salutata
come una sorta di manifesto del neopositivismo logico. Il Tractatus avrebbe dovuto contribuire a sgombrare definitivamente
il campo del linguaggio dai tanti fraintendimenti e non-sense
introdottivi nel corso dei secoli dal suo uso filosofico. La metafisica occidentale, infatti, aveva costruito il proprio impianto
teoretico su una serie di asserzioni che apparivano scientifica139
mente insensate, giacché ad esse non corrispondevano stati di
cose verificabili. La sensatezza di una proposizione è data dalla
sua idoneità a descrivere un fatto, ovvero a “fotografare” un
accadimento possibile. Solo a tali condizioni la si può effettivamente utilizzare nelle scienze positive. Un pensiero che non
sia “immagine logica” dei fatti, non conduce ad alcuna conoscenza effettiva, in quanto non produce asserti che si possano
dimostrare veri o falsi attraverso la sperimentazione. Pertanto,
le proposizioni di contenuto teologico o religioso, come pure
quelle etiche od estetiche, non hanno alcuna valenza scientifica. Compito della filosofia analitica è depurare il linguaggio dal
vecchiume di incrostazioni metafisiche accumulato nei secoli,
consegnando alle scienze uno strumento neutro, atto a descrivere il mondo in termini squisitamente fattuali:
«Il Metodo corretto della filosofia sarebbe questo: nulla dire
se non ciò che può dirsi; dunque proposizioni della scienza naturale; dunque qualcosa che nulla ha a che fare con la filosofia,
e poi, ogni volta che altri voglia dire qualcosa di metafisico,
mostrargli che, a certi segni nelle sue proposizioni, egli non ha
dato significato alcuno» (Tractatus 6.53).
In realtà, l’interpretazione del Tractatus si è successivamente
rivelata – anche alla luce degli altri scritti del filosofo austriaco
pubblicati solo dopo la sua morte – assai più complessa ed articolata di quanto avessero ipotizzato i neopositivisti nei primi
anni Venti. Al punto che, secondo un’altra linea interpretativa, il pensiero di Wittgenstein, lungi dal “neutralizzare” qualsivoglia prospettiva metafisica sul mondo, andrebbe riletto in
chiave mistica e spirituale. La filosofia non è propriamente dottrina, bensì “attività”, pratica razionale di chiarificazione dei diversi modi di utilizzo del linguaggio. Partendo dall’indagine del
linguaggio ordinario si giungono infine a scandagliare i limiti
estremi delle nostre possibilità di significazione, oltre i quali il
140
mondo c’appare come un “tutt’intero” che rimanda a ciò che
è fuori da sé:
«La soluzione dell’Enigma della vita nello spazio e tempo è
fuori dello spazio e tempo» (6.4312).
Dunque, l’Enigma del senso della vita, che nondimeno ci si
presenta al di qua dello spazio-tempo, non trova soluzione nel
mondo. A tale Enigma la scienza non è in grado di fornire nessuna risposta. Anzi, per quanto si percorrano in lungo e in largo
i sentieri logici e matematici delle scienze naturali, si ha la netta sensazione che le questioni per noi essenziali non giungano
neanche minimamente a porsi:
«Noi sentiamo che anche qualora tutte le possibili domande
scientifiche avessero avuto risposta, i problemi della vita non
sarebbero stati ancora neppure toccati. Certo, allora non resta
più domanda alcuna, e questa appunto è la risposta» (6.52).
Non resta più domanda perché i confini del linguaggio sono
stati toccati e con essi quel che si poteva dire su “come” il mondo si configurasse ai nostri occhi. Ma come l’occhio che guarda
non vede se stesso nell’atto del guardare, così il dire non può
spingersi oltre la constatazione che il mondo è:
«Non come il mondo è, è il Mistico, ma che esso è» (6.44).
Questa è la “risposta”. Ma non ha nulla di logico, nulla che, per
quanto sforzi si facciano, possa esser espresso in termini razionali. Qui s’arresta la pretesa della filosofia di raziocinare sul
senso complessivo delle cose. La struttura formale del mondo
e le modalità con cui si danno i fenomeni sono oramai dominio dell’analisi scientifica. A questo conduce, invero, la stessa
riflessione filosofica. Eppure, sulla cresta che separa il regno
141
dello scibile-dicibile (non esistono propriamente domande
che non abbiano risposta, perché esse non si possono nemmeno formulare) da quello dell’inconoscibile-indicibile al vero
ricercatore si rivela l’esperienza del Mistico. Esperienza, non
conoscenza; un “vedere” piuttosto che un “capire”. Una sorta
di illuminazione:
«Le mie proposizioni illustrano così: colui che le comprende,
alla fine le riconosce insensate, se è salito per mezzo di esse, su
esse, oltre esse. (Egli deve, per così dire, gettare la scala dopo
esservi salito). Egli deve superare queste proposizioni. Allora
vede rettamente il mondo» (6.54).
Lì è il Mistico, cui si può accennare soltanto in maniera afasica. È il regno del silenzio. Tanto che il Tractatus si chiude con
la nota asserzione numero 7, che a differenza delle prime sei,
intorno a cui si sviluppa il complesso ordito dell’opera, rimane
senza commento:
«Di ciò di cui non si può parlare, si deve tacere».
Dopodiché, al lettore di Wittgenstein non rimane che chiudere il libro. Ma come onde sonore prodotte dal rintocco di una
campana, queste parole sembrano dilatarsi senza fine nella
sua coscienza.
Al Mistico possiamo assimilare lo spazio del divino, per come ci
è dato intenderlo. L’unica traccia che ci è dato scorgere di Dio,
paradossalmente, è la sua non-presenza intra-mondana, il suo
non-palesarsi nell’ordine naturale:
«Come il mondo è, è del tutto indifferente per ciò che è più
alto. Dio non rivela sé nel mondo» (6.432).
Anche in Wittgenstein, dunque, il divino si configura come ul142
teriorità. La sua “indicibilità” non produce affatto un silenzio
rassegnato, nichilistico, ma sviluppa nuove possibilità di comprensione, in senso meditativo ed esperienziale. Non a caso
alcuni studiosi hanno provato ad accostare in termini comparativistici il contenuto del Tractatus al buddhismo Zen.
Ad ogni modo, a prescindere dalle abissali profondità del silenzio wittgensteiniano, nonché da certe derive spiritualiste,
va riconosciuto alla filosofia del linguaggio del Novecento il
merito d’aver svolto un incontestabile lavoro di delimitazione
e chiarificazione degli ambiti di ricerca, ripulendo il campo dai
“residui” della vecchia metafisica. Operazione comunque necessaria affinché una concezione del divino veramente nuova
possa avere in futuro agio di manifestarsi.
Che ne è di Dio dopo Auschwitz?
Posta dinanzi alla terrifica incommensurabilità della Shoah la
coscienza dell’uomo contemporaneo ha vacillato, ammutolita.
A scavalcare le possibilità denotative del linguaggio, questa
volta, non è il Mistico, ma l’orrore: impossibile trovare le parole per significare l’abisso di disumanità in cui il Terzo Reich
ha sprofondato la civiltà europea. Nei crematori dei campi di
sterminio insieme ai cadaveri di milioni di ebrei, zingari, omosessuali, testimoni di Geova, sacerdoti cattolici e protestanti,
prigionieri politici e altre minoranze, sono andati in fumo gli
stessi ideali settecenteschi ed ottocenteschi di un umanismo
progressivo e filantropico. L’uomo non si è rivelato un dio per
il prossimo, tutt’altro. Alcuni hanno contribuito fattivamente a
raschiar via il volto stesso dell’Uomo, hanno scelto l’abiezione.
Altri hanno girato la testa per non vedere, defraudandosi della
loro coscienza. Altri ancora hanno assaggiato l’erba amara di
un’immensa, sconsolata, impotenza. Su tutti si è allungata –
non ancor oggi dissipata – l’ombra del nichilismo.
143
La morte di Dio profetizzata dall’uomo folle della Gaia Scienza di Nietzsche, con Auschwitz è sembrata fare irruzione nella
storia, prender corpo in un evento preciso, imprimersi nella
memoria collettiva di un’intera generazione a livello planetario. Nulla è stato più come prima. Perché, comunque la si pensi, tutto quel che avviene nella sfera dell’umano si riflette in
quella del divino. E viceversa.
Nel secondo dopoguerra, dunque, la filosofia non ha potuto
fare a meno di interrogarsi sulla questione del rapporto uomodivinità dopo l’Olocausto. Fondamentale è stato il contributo
di alcuni pensatori di origine ebraica. Passeremo in rassegna,
in breve, le posizioni di Lévinas, Rubenstein e Jonas.
Se pure Dio esiste, è stato detto, ad Auschwitz Egli ha taciuto.
Dallo stupore dinanzi al “silenzio di Dio” è germogliata, tra le altre, la riflessione di Emmanuel Lévinas (1906-1995). A mettere
in moto il pensiero, nota il filosofo francese di origini lituane, è
sempre un evento traumatico, che genera incertezza, profondo
scoramento, incapacità, nell’immediato, di verbalizzare. Il silenzio di Dio lascia storditi. Ma nello stesso tempo ci parla di una
Trascendenza, di una forma di “Alterità” assoluta, che pure ci
viene incontro, disvelandosi nelle relazioni umane, nel modo
in cui accogliamo il “diverso”. Nel volto dell’Altro uomo Dio si
esprime. È lì, nel campo dell’etica, dell’autobiografico che si gioca la partita decisiva: accettare l’assoluta diversità del prossimo,
senza cercare di ridurlo a sé, di trasformare l’alterità in identità,
significa prestare orecchio alla parola di Dio, permettere che
Egli ci parli. Dipende da noi. Nostra è la responsabilità, di uomini dinanzi ad altri uomini. Preso nelle maglie dell’accadimento
storico «nessuno, in questo momento può dire: ho fatto tutto
il mio dovere». Si tratta di un’apertura etica volta all’infinito,
un compito progressivo di testimonianza di responsabilità reciproca cui nessuno può sottrarsi, pena il disumanizzarsi. Di conseguenza, il silenzio di Dio rappresenta, per un verso, la nostra
incapacità di ascoltare, per l’altro, accenna alla Sua irraggiungi144
bilità e irriducibilità alle categorie umane.
Lo statunitense Richard Rubenstein (1924), in un saggio pubblicato nel 1966 intitolato Dopo Auschwitz, è stato decisamente più radicale: se si vuole essere intellettualmente onesti
occorre ammettere che parlare del Dio di Israele dopo l’Olocausto non ha più alcun senso. Del Dio di Abramo, Isacco e
Giacobbe, si è persa ogni traccia nella storia. La Sua tomba è
ad Auschwitz: lì è seppellito il ricordo della Sua onnipotenza
e dell’Alleanza stretta con il popolo eletto. Con Dio è morta la
speranza che la vita umana abbia un significato e un destino ultimo. Impossibile illudersi ancora o trovare consolazione nella
preghiera. A chi crede che l’ateismo sia una strada impercorribile, non resta per il futuro che immaginare una qualche forma
di neopaganesimo.
Più articolata la posizione formulata dal tedesco, naturalizzato
statunitense, Hans Jonas (1903-1993) ne Il concetto di Dio dopo
Auschwitz. Una voce ebraica (1984). Dopo Auschwitz, che per il
popolo d’Israele (e l’umanità tutta) ha simboleggiato l’irrompere sul palcoscenico della storia mondiale del Male assoluto, un
Dio che sia al tempo stesso sommamente buono, comprensibile per l’uomo ed onnipotente non è più dato concepirlo. Se non
si vuole fare a meno di Dio, s’impone, quanto meno, la formulazione di una diversa teodicea, che risponda in maniera inedita
alla domanda intorno all’origine del male (unde malum?).
Disgiungere il Bene dall’idea di Dio ci risulta assurdo. Il Male
è del tutto estraneo alla divinità: la Shoah, in ebraico “tempesta devastante”, “distruzione”, non può essere opera di Dio. A
meno che, dati i limiti della capacità di comprensione umana,
non ci sfugga il Suo disegno provvidenziale. Forse che dietro
il Male assoluto possa celarsi il Bene? No. Anche questa via
sembra sbarrata. Infatti, se è vero che l’essenza ultima di Dio è
destinata a restarci fatalmente ignota, Egli si è rivelato al Suo
popolo attraverso i Profeti e la Scrittura, stringendo con l’umanità un Patto si è reso ad essa sufficientemente comprensibile.
145
Il concetto di un Dio totalmente alieno rispetto all’uomo, di cui
non si possa comprendere la Parola, cantare le lodi o invocare
la compassione, è per noi – ebrei e cristiani (anche se Jonas si
riferisce ai primi) – inammissibile.
Non rimane che l’ultimo degli attributi divini, l’onnipotenza:
«Di fronte alle cose veramente inaudite che, nel creato, alcune
creature fatte a sua somiglianza, hanno fatto ad altre creature
innocenti, ci si dovrebbe aspettare che il Dio, somma bontà,
[...] intervenga con un miracolo di salvezza. Ma questo miracolo non c’è stato; durante gli anni in cui si scatenò la furia di
Auschwitz Dio restò muto. [...] Dio tacque. Ed ora aggiungo:
non intervenne, non perché non lo volle, ma perché non fu in
condizione di farlo».
«Per ragioni che in modo decisivo derivano dall’esperienza contemporanea, propongo quindi l’idea di un Dio che per
un’epoca determinata – l’epoca del processo cosmico – ha abdicato ad ogni potere di intervento nel corso fisico del mondo.
[...] La creazione fu l’atto di assoluta sovranità, con cui la Divinità ha consentito a non essere più, per lungo tempo, assoluta
– una opzione radicale a tutto vantaggio dell’esistenza di un
essere finito capace di autodeterminare se stesso – un atto infine dell’autoalienazione divina».
Questa, dunque, la conclusione di Jonas: ad Auschwitz il Dio di
Abramo non ha proferito parola né alzato un dito per salvare
la Sua gente perché impossibilitato a farlo. Rispetto al mondo
degli uomini Dio si rivela impotente. Sua è stata la scelta ab
origine: all’atto della creazione Egli ha deliberato di rinunziare
a qualsivoglia potere sul creato, si è, in un certo senso, de-assolutizzato e de-potenziato affinché l’uomo potesse assumersi
appieno la responsabilità personale e collettiva della propria
autodeterminazione.
146
La concezione di Jonas ha senza dubbio contribuito ad aprire
nuovi scenari alla riflessione teologica contemporanea, sia in
ambito ebraico che cristiano. L’idea di un Dio che abdica volontariamente alla Sua onnipotenza suggerisce quella di un amore
sconfinato per l’umanità, di una infinita “apertura di credito”
per delle creature che Egli ha voluto a propria immagine e
somiglianza e dunque essenzialmente libere. Perché non vi è
vero amore, né vero bene senza libertà.
È un divino apparentemente “debole” quello che ci lascia in
eredità l’indicibile barbarie della Shoah. Ma è grazie a questa sua intrinseca debolezza che agli uomini di buona volontà
s’impone oggi chiara e coerente la distinzione, a nostro avviso
decisiva, tra brama di potere e spiritualità, sete di dominio ed
amore, paternalismo e cura genitoriale. Se Auschwitz è l’estremo prodotto di una volontà di potenza cieca ed insensata,
di una libertà fraintesa e mal utilizzata, il vicolo cieco in cui si
è cacciata un’umanità che ha creduto di poter fare a meno
di Dio, avocando a sé quella che riteneva essere la Sua principale peculiarità, ossia la potenza su tutto e tutti; ebbene,
attribuire alla divinità, al principio dei tempi onnipotente, la
libera preferenza per l’impotenza estrema, significa prendere
le distanze in maniera radicale e definitiva da una concezione
del divino basata sulla forza, sulla violenza, sulla prevaricazione, sul terrore. Ecco, quel Dio lì non c’è più. L’orizzonte è
finalmente libero.
Da questa vicenda si ricava un grande insegnamento: il potere infine nulla può contro la paura. C’eravamo illusi – e c’illudiamo ancora – che acquistando sempre più potere, politico, economico, tecnologico, saremmo stati in grado di curare
l’angoscia che ci prende dinanzi allo sconosciuto, alla virulenta
labilità del tutto. Avevamo inventato un Dio forte, giudicante,
paternalistico, che sopperisse alla nostra comprovata incapacità. Quando, grazie alla scienza moderna, ci siamo sentiti più
sicuri, abbiamo provato a sostituirlo con la tecnica. Pensava147
mo di poter controllare tutto. Il sogno di un’umanità trionfante, “superomistica”, si è trasformato nell’incubo del campo di
sterminio, vera e propria industria di disumanizzazione in cui
tanto la vittima innocente quanto lo spietato carnefice hanno
perduto ogni attributo di umanità (l’una ne è stata barbaramente deprivata, l’altro, col suo agire, ha perso il diritto a dirsi
umano). Paura e potere sono facce della stessa medaglia. L’uno non è antidoto all’altra: al contrario si alimentano vicendevolmente.
Trasposto dall’ebraismo al cristianesimo il divino debole di Jonas ci fa intravedere un Dio-Uomo scalzo, reietto, impotente,
ultimo tra gli ultimi, una specie di Cristo redivivo, spogliato
di ogni simbolo forte, antidogmatico, innamorato del volto
dell’uomo al di là di ogni confine ideale e politico, un Cristo
ecumenico. Solo l’amore libera.
Verso un nuovo concetto di spiritualità ecumenica
Come è emerso da questa sintetica – e niente affatto esauriente – carrellata dedicata alla filosofia contemporanea, la morte
di Dio, provocata dalla svolta soggettocentrica della modernità, segna la fine di un percorso metafisico che, sin dalle origini,
ha legato il divino e l’Essere ad un’idea di Verità “epistemica”
(scientifica), incrollabile ed immutabile. Dio ha rappresentato
per secoli l’icona stessa della permanenza, della sostanzialità
dell’Essere, suprema garanzia contro l’angosciosa liquidità del
Divenire, bastione di Verità contrapposto alle tenebrose regioni dell’ignoto, del Non-essere. Questo concetto del divino ha
simboleggiato, per così dire, la proiezione dell’esigenza, tutta
umana, di “capire”, “afferrare” la realtà, per possederla, tenerla sotto controllo, prevenendone l’imprevedibilità. Una reazione antropologicamente comprensibile all’ambiente, basata su
di un uso aggressivo della forza intellettuale (come metafora
148
della forza fisica) in risposta al “sacro” terrore dello sconosciuto. Riplasmare l’ambiente circostante a propria immagine e
somiglianza in senso simbolico (oltre che tecnico): questa la
sfida che si è posta la civiltà occidentale. E sin dall’antichità
ha cominciato a farlo, prima attraverso la produzione di miti
poi con l’invenzione della metafisica razionale, nella quale, col
tracciare il confine sacro e profano, ha riposto la speranza di
dare risposte significative e consolatorie alle sue domande più
radicali: “chi sono?”, “da dove vengo?”, “perché mi trovo qui?”,
“perché soffro?”, “che ne sarà di me?”.
Alla visione metafisica imperniata su un’idea dell’Essere (e del
divino) stabile, piena, a tutto tondo, si è accompagnata anche
una ben determinata concezione dei rapporti tra esseri umani, nonché tra uomo e mondo, ossia di quella che chiamiamo
“politica” e “organizzazione sociale”. Ad una metafisica (e religione) che si pretende “forte” – perché della forza in senso
intellettivo e psicagogico fa uso – è corrisposta una visione politica altrettanto “forte”, edificata sul binomio “potere-paura”
e sul cosiddetto “principio di autorità”.
Con la modernità questa concezione entra in crisi sia dal punto
di vista storico-politico che filosofico. Impossibile distinguere
le due prospettive. Così, eventi epocali come la rivoluzione
scientifica – “rivoluzione” è, in origine, il termine che utilizza Niccolò Copernico per indicare il movimento che la Terra
compie intorno al Sole – e la rivoluzione francese costituiscono
altrettante tappe della progressiva disgregazione della roccia
metafisica su cui si era innalzato per secoli l’edificio della civiltà
e del potere politico europeo. Non a caso nell’Ancien Régime
“trono” e “altare” formano un binomio indissolubile: la sovranità, ossia la legittimazione all’esercizio del potere, è di diritto
divino. Il sovrano regna “per grazia di Dio”.
All’interno di siffatta visione del mondo, ideologicamente ed
istituzionalmente incarnata dalla chiesa cattolica (e, dopo la
riforma protestante, in certa misura, dalle nuove chiese ri149
formate), religione e spiritualità, “ortodossia” e “ortoprassi”,
sono state a lungo tenute confuse insieme. Dalla chiesa son
germinati, indifferentemente, sia santi che inquisitori, tanto
uomini di pace quanto banditori di crociate. Ancor oggi, a ben
guardare, ad alcuni preti cristianamente autentici, ammazzati
delle mafie o dal tiranno di turno, fanno da contrappunto paradigmatico i tanti ecclesiastici collusi col potere. La riflessione
filosofica contemporanea con il suo mettersi in costante rapporto critico nei riguardi della tradizione, producendo un progressivo disvelamento delle contraddizioni presenti nel sistema della metafisica classica (sia in senso religioso che politico),
ha avuto il merito di “liberare” l’Essere dal dominio della Verità
epistemica, dalla tirannia del “concetto-dogma”. Processo che
storicamente è corrisposto, come abbiamo visto, ad un rivolgimento epocale della civiltà occidentale che ha generato indicibili tragedie: all’annichilimento di Dio ha fatto da corollario
quello dell’umanità nei tanti lager di cui è costellata la storia
del XX secolo e di questo scorcio di XXI.
Con ciò si è aperto un nuovo cammino, che intuiamo ricco di
prospettive seppur in gran parte ancora da esplorare. Esso
dipende dalla nostra capacità di immaginare l’Essere come
possibilità, apertura, disponibilità, e, di conseguenza, un Dio
la cui amorevolezza verso il mondo si manifesterebbe nella
sua assenza, nel lasciar essere, nel dileguarsi a favore dei fenomenico. Un “luogo divino” meravigliosamente “vuoto”, che
richiama da vicino l’idea di “vacuità” (śūnyatā), declinata in
base ai principi essenziali della metafisica buddhista di nonsostanzialità (anattā), impermanenza (anicca) e interdipendenza condizionata tra i molteplici aspetti della realtà (paṭicca
samuppāda).
Il richiamo al buddhismo non è casuale. Si tratta di una forma di
spiritualità che in passato alcuni studiosi hanno sbrigativamente giudicato atea, in quanto ispirata ad una visione del mondo non conforme all’idea “forte” di Dio tipica della metafisica
150
greco-cristiana. In realtà, tanto più “debole” ed insostanziale
viene considerato il divino, tanto più ampio e permeabile risulta essere lo spazio di sacralità che da esso promana. In ultimo
è la stessa natura delle cose ad essere sacralizzata, a divenire
un tutt’uno con il divino. L’atteggiamento etico-esistenziale
del praticante buddhista è tendenzialmente opposto a quello
sotteso alla metafisica occidentale tradizionale: tanto l’uno si
sforza di afferrare il concetto, di dominare l’aleatorietà della
natura, di controllare il divenire, tanto l’altro invece si esprime nell’accettazione dell’impermanenza di tutte le cose, nel
liberarsi dalla morsa dei giudizi intellettuali, nel “lasciar andare”. Questa è la via che conduce all’estinzione della sofferenza,
capace di placare paura e rabbia, di vincere insicurezza ed aggressività. In questa scoperta consiste il cuore del messaggio di
Siddhartha Gautama, il Buddha storico, come ci racconta con
parole semplici ed alate il monaco Zen vietnamita Thich Nhat
Hanh (1926) in questo passo tratto dal suo Vita di Siddhartha
il Buddha (1992):
«Illuminando i fiumi del corpo, delle sensazioni, delle percezioni, delle formazioni mentali e delle coscienza, Siddhartha
comprese che l’impermanenza e l’assenza di un sé sono le
condizioni indispensabili alla vita. Senza impermanenza, senza
mancanza di un sé, nulla potrebbe crescere ed evolversi. Se un
chicco di riso non avesse la natura dell’impermanenza e del
non sé, non potrebbe trasformarsi una piantina. Se le nuvole non fossero prive di un sé e impermalenti, non potrebbero
trasformarsi in pioggia. Senza natura impermanente e priva di
un sé, un bambino non potrebbe diventare adulto. «Quindi»
pensò, «accettare la vita significa accettare l’impermanenza e
l’assenza di un sé. La causa della sofferenza è la falsa nozione
della permanenza e di un sé separato. Vedendo ciò, si giunge
alla comprensione che non c’è né nascita né morte, né creazione né distruzione, né uno né molti, né dentro né fuori, né
151
grande né piccolo, né puro né impuro. Sono tutte false distinzioni create dall’intelletto. Penetrando nella natura vuota delle
cose, le barriere mentali vengono scavalcate e ci si libera dal
ciclo della sofferenza».
I nuovi orientamenti metafisici germinati in Europa dopo la
morte di Dio – pensiamo soprattutto all’ontologia heideggeriana –, da una parte, hanno il merito di liberare le energie
spirituali che il defunto Dio teneva, per così dire, compresse
e impuramente mescolate ad una concezione forte ed autoritaria del mondo. Dall’altra, consentono ad un uomo occidentale sempre più globalizzato di guardare verso il sol levante,
di confrontarsi con modelli metafisici e stili di vita più vicini
alla nuova idea di Essere. In questo senso, dall’Oriente e dal
buddhismo in particolare abbiamo molto da imparare.
In primo luogo, perché il buddhismo ha dalla sua parte una
ininterrotta tradizione plurimillenaria di pratiche spirituali e
stili di vita conformi a questa nuova – per la cultura “ufficiale”
dell’Occidente, ma non per quelle indiana e cinese – concezione dell’Essere. Il mondo non è più lo stesso neanche al di là del
fiume Indo. Ne siamo consapevoli. Il modello di globalizzazione che soffia da Occidente e parla la lingua dei prodotti ultimi
e nichilisti della sua antica metafisica “forte”, il tecnicismo e
lo scientismo, il liberismo selvaggio, il feticismo della merce e
la mercificazione dell’umano, ha già mutato, più o meno profondamente, equilibri sociali ed economici delicati e preziosi,
inquinando insieme all’ambiente – Fukushima docet – rituali
e dinamiche culturali ancestrali. Ma facendo tesoro, ecumenicamente, delle consuetudini spirituali ed etiche basate sul
concetto buddhista di vacuità o su quello taoista di wu wei,
“non-azione” o “azione senza sforzo”, “agire in armonia con il
Tutto”, possiamo immaginare di dare vita ad un’inedita visione
umanistica del mondo, una sorta di “contro-globalizzazione”,
o meglio, “co-globalizzazione”, in cui l’umano e la natura ri152
guadagnino nella pratica quell’idea di sacralità che gli antichi
attribuivano loro.
Gli “antichi”, beninteso, sono anche i “nostri” antichi. Perché,
questo è il secondo punto, l’esperienza c’insegna che con l’accostarsi a forme di spiritualità apparentemente aliene alla comune mentalità occidentale molti praticanti hanno avuto modo
di riscoprire e di irrorare con nuova linfa vitale molti aspetti
della propria tradizione religiosa e filosofica. È un po’ come
guardarsi allo specchio: praticando la meditazione buddhista
si finiscono col ritrovare le proprie radici cristiane, rinverdendole. Un “ritrovare” che non implica un tornare indietro, bensì
un andare avanti: ci si scopre più disponibili all’ascolto, vuoti di
pregiudizi, attenti alla realtà umana dell’ortopratica piuttosto
che alle sottigliezze dell’ortodossia. In una parola, più disponibili ad accogliere l’Altro in nome di un divino senza nome, che
ha il volto di tutti e non si lascia “afferrare” da nessuno.
La sfida che abbiamo dinanzi – per la prima volta nella storia
mondiale quel “noi” è da intendersi come l’umanità intera –
non è di votarci ad un Dio comune, di imporci l’un l’altro una
qualche “Verità”, quanto piuttosto di riuscire a contemplare
con occhi puri e mente limpida l’infinita bellezza che ci pervade
da dentro a fuori, ad accettarci per quel che autenticamente
siamo, a considerare nostro inderogabile e sacro dovere il provare a vivere una vita relazionale dignitosa, intelligente, grata.
Per tutto questo era necessario che Dio morisse. Perché «se il
granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo;
ma se muore, produce molto frutto» (Giovanni 12,24).
153
TAVOLA ROTONDA CONCLUSIVA
177
RICCARDO APOLLONI
LEONESSA 2013
SINTESI DEGLI INTERVENTI
PREMESSA
Nelle pagine che seguono presenterò una sintesi degli interventi fatti dai professori Elio Rindone, Mario Trombino e Francesco Dipalo in occasione della sedicesima “Settimana filosofica per…non filosofi” svoltasi a Leonessa (Rieti), dal 24 al 30
agosto. Il tema dei seminari – che prevedevano, due volte al
giorno, una lezione tenuta dal docente seguita da un dibattito
aperto – è stato “Il divino al vaglio della filosofia”. In particolare, il prof. Rindone ha illustrato le concezioni fondamentali del
divino e degli dèi nella cultura (sia mitologica che filosofica)
greca, nella sapienza ebraico-cristiana e nella filosofia medievale; il prof. Trombino ha presentato – spesso attualizzandoli
– alcuni esempi emblematici di ricerca razionale (filosofica e
scientifica) volta al problema di Dio nell’Età moderna; il prof.
Dipalo, infine, ha trattato la contemporaneità concentrandosi
in particolare sulla “morte di Dio” e, inoltre, su alcune riflessioni che hanno condotto a un nuovo concetto di spiritualità
ecumenica.
155
Gli interventi, culminati con una passeggiata serale organizzata
da Trombino per contemplare il cielo stellato, hanno sempre
catturato l’interesse dell’uditorio, dando luogo a vivi dibattiti.
La sintesi seguente tratta però solo degli interventi dei relatori,
riportando anche, inevitabilmente, quella lieve discontinuità
presente nel passaggio da un approccio all’altro la quale, forse,
ha contribuito a formare un’atmosfera coerente ma allo stesso
tempo diversificata, rituale e allo stesso tempo democratica.
1. L’ETÀ ANTICA E IL MEDIOEVO
Il mondo greco
Nella sapienza mitologica – ha spiegato Rindone – il mondo è
percepito come un Tutto in divenire che racchiude in sé una
particolare energia vitale. Questa energia, insieme alle sue
espressioni dinamiche nei vari livelli – in primis gli dèi (che si
manifestano antropomorficamente), ma anche le cose tangibili – è il divino. Il divino è, in altre parole, il mondo nel suo
contenuto essenziale, i cui elementi si esperiscono come accadimenti della natura, la perpetua attività generatrice (physis).
Benché queste siano intuizioni profonde, esse non rappresentano ancora quella ricerca razionale delle cause ultime che è
tipica della filosofia greca; soltanto agli albori di questa, infatti,
nella natura – che da sola basta a offrire una valida comprensione della realtà – si ricerca un principio generatore permanente (arche): l’acqua, l’illimitato, l’aria, il fuoco... Un passo
decisivo viene fatto col pensiero di Parmenide, poiché si ha un
passaggio dal concetto di una natura (o physis) in senso letterale (una realtà che si rinnova continuamente in un processo
di generazione-corruzione) al concetto di una realtà immobile: l’essere è, esso è qualcosa di immutabile che rimane tale,
come argomenta l’eleate mostrando l’illogicità dei vari passaggi dall’essere al non-essere e quindi, in definitiva, del divenire.
156
Molti caratteri fondamentali dell’essere parmenideo – eternità, immutabilità, perfezione – vengono trasferiti, dalla filosofia di Platone, alle sostanze o essenze (o, ancora, idee), ossia
quelle realtà universali e intellegibili che sono l’essenza delle
cose di questo mondo, cioè i paradigmi del mondo sensibile
(mutevole, materiale, imperfetto). Nella realtà – che è stata
plasmata da un demiurgo – c’è dunque un dualismo che condanna la materia e postula, peraltro, un aldilà (riprendendo
elementi della sapienza mitologica orfica). Con Platone, in sostanza, la natura non è più autosufficiente e divina: la realtà
divina è infatti il principio eterno e immutabile presente nella
realtà sovrasensibile (iperuranio). Nella filosofia di Aristotele
– che supera la contraddittorietà del divenire denunciata da
Parmenide – tale concezione è ripresa solo in parte: il Dio è il
motore immobile che è causa indivenibile (“atto puro”) del divenire che vediamo intorno a noi; tuttavia, vi sono altri motori
incorporei e, in generale, divino è tutto ciò che è eterno.
Il monoteismo rimane – come si vede – estraneo al mondo greco, sebbene col pensiero di Plotino venga descritta una Sorgente di tutto l’essere che trabocca, détta Uno: da questa Fonte
deriva la molteplicità di ciò che ci circonda. Siamo qui di fronte,
evidentemente, a un ulteriore distacco dalla physis così come
era stata descritta dalla mitologia e dai filosofi naturalisti.
Infine, tra le svariate correnti dell’antichità passate un po’
nell’ombra nel corso della storia – ma non per questo meno
rilevanti dal punto di vista filosofico – possiamo ricordare, ad
esempio, l’atomismo (Leucippo, Democrito, Epicuro): secondo
tale concezione naturalistica e materialistica, la realtà è fatta
di atomi e vuoto che rispondono a leggi meccaniche necessarie. Lo spazio per gli dèi, in questo contesto, è assai limitato;
secondo Epicuro, per esempio, essi, incuranti del nostro mondo, vivrebbero negli spazi tra un mondo e l’altro. Interessante
la posizione di Socrate che, abbandonata la via della ricerca
cosmologica, perviene al divino grazie all’esperienza morale.
157
La sapienza ebraico-cristiana
Dopo aver trattato il mondo greco, Rindone è passato alla descrizione del Dio ebraico – indiscusso protagonista della Bibbia
(affrontata semplicemente in quanto testo letterario) – il quale, seguendo l’ordine del canone ebraico, dapprima interviene
con gesti clamorosi nel mondo: Egli plasma (barah) il mondo
e si rapporta all’uomo con atteggiamenti talvolta vendicativi;
si pensi, a tal proposito, all’“indurimento” del cuore del faraone (Esodo 11, 10) perché non lasci partire gli Ebrei o, ancora,
all’invito rivolto a Saul di sterminare gli Amaleciti (1 Samuele
15, 3). Non mancano, inoltre, atteggiamenti collerici (è celebre il racconto del diluvio universale). Il “primo” Jahvè appare
sempre più come il Dio guerriero di Israele; Egli diviene poi
anche legislatore, e dall’obbedienza alla sua legge dipenderà
ogni benedizione.
Il Dio ebraico assume nuove caratteristiche con i libri profetici:
in particolare, ai tratti di violenza si affiancano tratti pacifisti.
La violenza, tuttavia, non scompare, tanto che poi – per fare un
esempio – nella vicenda di Giobbe vediamo Jahvè che, quasi
per diletto, fa soffrire una persona retta. Ci si può chiedere criticamente, di fronte ad atteggiamenti come questi, se un tale
Dio sia effettivamente buono e giusto, o se non sia il caso, piuttosto, di non fidarsi di lui.
In effetti, la sfiducia comincia a serpeggiare nella Scrittura,
tanto che, come è attestato dal tenore pessimistico e disilluso dei dodici capitoli del Qoèlet, ci si orienta verso un’accettazione della vita così com’è, con i suoi beni e con i suoi mali.
Infine, in Daniele, il Signore appare un’ultima volta come un
vegliardo stanco, ormai lontano dall’idea di intervenire direttamente nella storia umana. Nei Vangeli, infine, Dio apparirà
direttamente solo per dire di esser compiaciuto del figlio e per
esortare gli uomini ad ascoltarlo; il Dio nei Vangeli si mostra
sempre più come agápe: amore gratuito, disinteressato.
Una nota conclusiva: nella tradizione ebraica, a differenza che
158
in quella greca, l’accento non è posto sulla natura ma sulla
storia: il dio agisce, fondamentalmente, nella storia (ora più
marcatamente in quella del popolo ebraico, ora più “cattolicamente” in quella di tutti gli uomini).
La riflessione medievale
Giustificare razionalmente l’esistenza dell’essere personale di
cui abbiamo appena parlato è stata l’impresa improba dei filosofi cristiani. Di Tommaso d’Aquino, massimo rappresentante
della teologia medievale, Rindone ha ricordato la visione della
realtà (e la connessa ripresa e correzione dell’aristotelismo) e
ha illustrato la terza delle cinque vie, secondo cui Dio è un essere necessario che esiste di per sé e che dà l’esistenza agli enti
possibili e contingenti. Sulla validità della terza via sono stati
sollevati dei dubbi: in particolare, se la contingenza dei singoli
enti è parsa confermata dall’esperienza, non si è trovata una
sufficiente giustificazione della contingenza della natura nel
suo insieme. In effetti, Rindone ha avanzato l’ipotesi secondo
cui l’idea di Tommaso non derivi dall’esperienza (che di fatto
non mostra passaggi dall’essere al non-essere) ma piuttosto
dalla volontà di giustificare l’“Io sono colui che è” dell’Esodo
(3, 14), inteso come affermazione di un Essere necessario opposto agli esseri contingenti. Ma tale passo, secondo una moderna linea esegetica, significherebbe piuttosto “io sono con
voi” o “io agirò” (nel senso di essere coinvolto nell’avventura
dell’uomo).
Possiamo affermare in conclusione – come ha fatto il relatore
– che, rispetto ai Greci, siamo di fronte a una desacralizzazione
del mondo, separato dal Creatore da un abisso. Questo è, in
fondo, il nostro mondo secolarizzato: quello che il Medioevo
ha consegnato alla modernità.
159
2. LA MODERNITÀ
Un principio fondamentale del pensiero moderno (ma, in qualche modo, da sempre impiegato) è – ha spiegato Trombino –
quello secondo cui la natura si comanda obbedendole. Tuttavia, per rispettare le leggi naturali (ossia per obbedirvi) occorre
conoscerle e bisogna, quindi, penetrare il senso della natura.
Un tale compito, secondo Trombino, non è strettamente filosofico, bensì anche scientifico e, poiché la realtà è una sola,
non v’è nulla di male nell’accettare che le scienze siano in grado di descriverla a fondo e in modo chiaro (sebbene esse non
rappresentino l’unica via di conoscenza). Così, Dio o il fondamento della natura, si trovano in stretta relazione alla ricerca
scientifica. Per fare un esempio, nella concezione di Newton
ci deve essere un Dio: Egli deve sorreggere lo spazio, ossia il
contenitore del mondo, e il tempo, il “metronomo universale”.
Uno dei problemi principali della modernità è quello di individuare il fondamento della natura e comprendere se esso
possa essere conoscibile oppure no. La risposta di Cartesio a
quest’ultimo problema è affermativa. Senza fare affidamento
sull’esperienza – in un’indagine aprioristica (deduttiva) tipica
del matematico – Cartesio si rende conto della possibilità di
poter elaborare diversi mondi; ma, proprio per questo, si rende anche conto della necessità di un Dio benevolo che confermi e garantisca il metodo e quindi la nostra conoscenza effettiva del mondo fisico. In altri termini, il compito di Dio è quello
di porre i fondamenti della realtà o, per meglio dire, delle due
realtà (res cogitans e res extensa). Differentemente da Cartesio, Pascal offre invece alla suddetta domanda – è conoscibile
il fondamento della natura? – una risposta negativa: la strada d’indagine sperimentale conduce Pascal ad affermare, in
modo scettico, che il fondamento è inconoscibile e che, sullo
stesso Dio, dobbiamo scommettere.
Non è difficile, nel pensiero moderno – ha continuato Trom160
bino – rintracciare il concetto secondo cui siamo noi uomini,
facenti parte della natura intesa come un tutto, a porre il senso
nelle cose. Così, secondo Spinoza, nella natura esiste semplicemente un ordine necessario percepibile guardando la natura o Dio – che è lo stesso – sub specie aeternitatis. Dunque,
non c’è in natura un ordine morale gerarchico che definisca il
bene e il male in senso assoluto: siamo noi che facciamo queste attribuzioni verso le cose del mondo in base alla loro utilità.
Le conclusioni di Leibniz a tal proposito sembrerebbero dover
essere le stesse, poiché egli descrive un Dio che ha scelto per
noi questa realtà, che è il miglior mondo possibile. In realtà,
però, la scelta sembrerebbe necessaria, perché la natura di
Dio è ultra-buona e quindi non avrebbe potuto fare altrimenti: dunque questo discorso sulla possibilità non sembrerebbe
essere in effetti diverso dalla identificazione tra libertà e necessità in Spinoza.
3. IL PENSIERO CONTEMPORANEO
Con l’intervento di Dipalo l’uditorio è stato messo di fronte al
fatto che il concetto di Feuerbach secondo cui la religione altro
non è che la coscienza umana (e di conseguenza l’essenza divina è, in fondo, l’essenza umana oggettivata) ha avuto una forte eco nella contemporaneità. Tant’è che con Marx – qualche
anno più in là – il fondamento della critica religiosa sarebbe
stata la denuncia che l’uomo fa la religione e quindi Dio, non
viceversa. La religione secondo il filosofo tedesco è, in quanto
proiezione fantastica, una droga – un oppio – a cui l’uomo ricorre perché la realtà socio-politica è opprimente.
Il messaggio tipico della contemporaneità, strettamente connesso al suddetto capovolgimento, è – secondo Dipalo – quello
della “morte di Dio”, evidente nelle suggestive parole de La
gaia scienza (aforisma 125) di Nietzsche. Noi uomini abbiamo
161
ucciso Dio (per Dipalo si tratta sia di quello dei teologi che di
quello della gente comune); la nostra condizione attuale è rappresentata – e ben descritta da Nietzsche – come un eterno
precipitare da tutti i lati (“...all’indietro, di fianco, in avanti ...”).
Non sono certo argomenti razionali contro il teismo quelli appena descritti – ha ammesso il relatore – ma non per questo
tali pensieri sono meno filosofici. La stessa cosa si può dire per
l’altro distruttore della ratio filosofica, per l’altro “maestro del
sospetto”: Freud. Se avesse ragione questi, secondo cui Dio altro non è se non il surrogato della figura paterna, potremmo
dire di aver smarrito nostro padre.
Quanto detto non esaurisce tuttavia le tendenze del pensiero
contemporaneo in cui è presente anche – come ha mostrato
Dipalo – un atteggiamento mistico o un desiderio di interrogarsi sul tutto. Di ciò hanno dato la prova, tra gli altri, due filosofi molto diversi. Da una parte Wittgenstein, il quale, con
la sua emblematica prudenza, fa trapelare l’importanza della
dimensione mistica: Dio non si rivela nel mondo e, comunque,
non ci è dato parlarne. Dall’altra parte abbiamo Heidegger che,
all’interno delle sue tipiche denunce verso la tecnica (che ci
sradica e ci strappa dalla terra), propone la critica della ragione calcolante e l’apertura al mistero dell’esistenza. L’appello di
Heidegger è, anzi, rivolto a un dio; il che echeggia una soluzione mistico-religiosa al problema dell’uomo, gettato nel mondo
e usato dalla sua stessa tecnica.
Il passaggio da Heidegger al buddhismo sembra spontaneo per
Dipalo, che connette, in particolare, la critica heideggeriana
della “cosità” all’anatta (assenza di atman, ossia di sostanza
individuale permanente) buddhista. Secondo Thich Nhat Hanh
– monaco buddhista vivente – occorre penetrare nel cuore
della realtà e farne così esperienza diretta. Scopriremmo, allora – spiega il monaco in Vita di Siddharta il Buddha – che in una
foglia, ad esempio, c’è l’intero universo; sentiremmo, inoltre,
l’impermanenza delle cose e, allo stesso tempo, la loro inter162
dipendenza. Tutto è dentro di noi e noi siamo dentro tutto. Nascita e morte non sono che apparenza, come lo sono le onde
che nascono e muoiono solo apparentemente poiché in realtà
esse sono parti indissolubili dell’oceano eterno. Per dirla con
Heidegger, l’essere è un non-ente – conclude Dipalo – spiegando che il buddhismo è terapia filosofica senza quel vecchio
Dio: il divino, infatti, è la realtà stessa (come pure, potremmo
aggiungere, nella mitologia e agli albori della filosofia).
4. SINTESI DELLA SINTESI: A MO’ DI CONCLUSIONE
Può essere interessante notare, ricorda Dipalo, che l’illuminazione del Buddha raccontata da Thich Nhat Hanh non si limita
a essere un’esperienza di massima gioia, liberazione e appagamento individuale. Gautama realizza infatti – scrive il monaco – che la comprensione (che dissolve l’odio capendo le vere
cause dell’agire umano) e l’amore sono un tutt’uno. In particolare, l’autore scrive che “la comprensione origina compassione
e amore, i quali a loro volta determinano la giusta azione”.
Quanto appena detto sembra confermare la tesi che Rindone aveva avanzato nella conclusione dei suoi interventi, e cioè
che le principali religioni si concentrano sull’azione umana nel
senso più alto del termine (si pensi, ad esempio, alla “regola aurea”). Forse la fede autentica – aveva suggerito Rindone
– è quella esemplificata dalla vita dei credenti, in difesa della
giustizia, della comprensione reciproca, di quel divino che, in
fondo, è l’amore agapico.
E già Socrate, messe da parte le speculazioni cosmologiche sulla
totalità della natura, era giunto al divino passando attraverso la
morale (la ricerca personale e collettiva della virtù, cioè del vero
bene, era la missione religiosa del filosofo). Alla valorizzazione
dell’ortoprassi potrebbe indurre anche l’affermazione, più volte
ribadita, di Tommaso: noi conosciamo Dio come inconosciuto.
163
Tutto ciò è parso piuttosto divergente rispetto alla visione
offertaci da Trombino: infatti, secondo questi – che si è fatto
in qualche modo portavoce della modernità – spetta alla filosofia, in dialogo con la scienza, scoprire concretamente se
esiste Dio: sapere ciò è una necessità teoretica (sebbene possa anche avere, consequenzialmente, risvolti pratici)! Lungi
dall’esser interessato, almeno in questo contesto, alla religione o al problema (ritenuto, in fondo, meramente sociologico)
della “morte di Dio”, Trombino ha sostenuto che è opportuno
compiere un’indagine per mezzo della più matura delle forme
di conoscenza, ossia la scienza, a partire dall’assunto secondo
cui il nulla non ha proprietà. Problemi astratti? Nient’affatto:
il fondamento della natura possiede evidenti sviluppi di tipo
pratico (etico, politico, economico), come mostra una lezione
di Trombino che prende piede a partire dall’analisi della politica statunitense.
Seguendo Spinoza nel negare qualsivoglia gerarchia nella natura e ventilando – con forte distacco dallo spirito heideggeriano – l’identificazione di scienza e filosofia, Trombino sembra
criticare la sfiducia nella possibilità di scoprire i fondamenti del
mondo. Ma ciò non conduce il relatore a cadere in una rigida
epistemologia razionalista: l’ordine a cui le leggi dell’Universo
partecipano si rivela a noi non soltanto attraverso la ragione,
ma anche attraverso un sentimento di assoluto, nutrito dal
silenzio (interiore ed esterno); quando la notte stellata, cioè,
sussurra i suoi misteri, donando profonde intuizioni. Ne emerge una consapevolezza di quella sacra armonia universale analoga – si direbbe – a ciò che Einstein chiamò “il dio di Spinoza”.
164
INTERVENTO DI SALVATORE FRICANO
Permettetemi di dividere il mio intervento in più parti. Difatti desidero fare osservazioni che vanno in due direzioni, non
collegate fra di loro. E sono quelle che più hanno sollecitato e
catalizzato i miei pensieri, sia durante che dopo i nostri incontri giornalieri.
Ma prima di indicare queste mie considerazioni, una piccola
premessa, per ringraziare.
Avevo promesso a voi e a me stesso che avrei posto la massima attenzione a quanto avrebbero esposto i nostri relatori e
più in generale alle sollecitazioni che arrivavano da tutti noi.
L’argomento “Il divino al vaglio della filosofia” è nelle mie corde e non ho faticato a porre attenzione, per quel che può dipendere dalle mie forze, a tutto quanto veniva di volta in volta
comunicato.
Ho apprezzato i contenuti e lo stile, pur diverso, di Elio, Francesco e Mario.
Quindi un affettuoso grazie soprattutto rivolgo a loro.
La prima considerazione
Non possiamo non tenere conto di 2500 anni di storia del pensiero, almeno per quanto riguarda il versante occidentale. Il
lavorio incessante di grandi pensatori sul tema del Divino ha
prodotto esiti non sempre conciliabili: Dio c’è, è una proiezione delle ambizioni umane, atto puro privo di materia, Dio è
plurale, Dio catalizzatore delle sofferenze, e così via. Dato che
lo spinoso argomento viene declinato nei suoi aspetti filosofici
e non, ad esempio, negli aspetti teologici, ho tenuto a mente
soprattutto le argomentazioni che man mano ci prospettavano
i nostri amici relatori.
Forse ha scombinato un poco le carte del sentiero logico l’aver
esposto prima Francesco178, che ci ha parlato della contemporaneità, e poi Mario che ha invece approfondito il razionalismo
165
classico. I 2500 anni di pensiero li dobbiamo sentire comunque sulle nostre spalle.
Sebbene la filosofia abbia cercato, e continui a cercare affannosamente, un proprio statuto il più possibile identitario, ritengo
che lo strumento principe che la caratterizza rimanga la razionalità, l’argomentazione. Con tutto quello che si può intendere come ragione, logica, tesi ed esposizione argomentata. Ad
esempio, l’aspetto profetico che hanno assunto spesso i filosofi
è per me sbagliato. È un peccato veniale perdonabile solo nella
misura in cui il filosofo si senta incompreso dai contemporanei,
ma non può attecchire ab aeterno. Così hanno poco da dire,
secondo me, l’ascolto delle emozioni e delle passioni dato che,
strutturalmente, non argomentano. Così si sa, al cuore non si
comanda, perché il cuore non ascolta… ‘ragioni’!
Ritorniamo quindi alle argomentazioni. Qual è l’argomento più
forte sul senso del divino, ora?
“Dio è morto”, senz’altro. Ormai la metafisica occidentale ha
fatto il suo corso, almeno quella metafisica che pensava di
risolvere tutte le questioni a tavolino, deducendo da principi
‘primi’.
Mi sembra quindi di fondamentale importanza tenere conto
dell’esito più drammatico nel quale si è ritrovata la filosofia
contemporanea, ovvero l’annuncio della morte di Dio, operato
da Nietzsche (accidenti, proprio un filosofo che fa di tutto per
apparire profetico – quindi inviso a chi, come me, non accetta
profezie – ma cela un pensiero profondissimo, strutturato179,
che tiene tutto il peso della storia del pensiero occidentale).
Quindi, la morte di Dio è un evento filosofico, solo marginalmente può apparire come un momento sociologico o storico,
quindi transeunte. È invece un passaggio fondamentale, una
pietra miliare diremmo con Francesco Bacone, che mette in
evidenza l’impotenza del pensiero dinnanzi al divino. Il nichilismo è l’esito filosoficamente più visibile nella società e nel
pensiero di ciascuno di noi.
166
“Dio è morto” è dunque una affermazione squisitamente filosofica, come lo era “Pan è morto”, che riferisce Plutarco, relativamente alla consapevolezza dello spegnersi dello spirito
greco arcaico e che non a caso non è più risorto. Ce lo ricorda
lo stesso Nietzsche nella Nascita della Tragedia180.
Che significa, per quello che ci riguarda, ciò? Significa questo:
è estremamente aumentata la consapevolezza della complessità. Il pensiero forte, di stampo seicentesco, quello di Cartesio, Leibniz e soprattutto di Spinoza, come ci ha brillantemente
proposto Mario non può più, ahimè, essere praticato. Rischieremmo l’ingenuità.
È tanta la complessità che adesso la filosofia arranca rispetto
ai risultati a cui perviene la scienza. Fino a quando si era nel
sentiero della cosiddetta ‘rivoluzione scientifica’ galileiana i filosofi più avveduti riuscivano a capirci qualcosa. Locke poteva
andare a trovare Newton per chiedere delucidazioni, ad esempio. Hegel, Schopenhauer e a quanto pare anche Nietzsche
erano avidi di letture scientifiche. Ma è negli ultimi 150 anni
che il sapere scientifico ha veramente visto tante epocali rivoluzioni. E i filosofi, così assimilabili idealmente – ha ragione
Mario – ai fisici teorici, non hanno più arrancato, con il fiato
corto, ma ho l’impressione che si siano fermati. Sono al palo,
come si usa dire.
Non dobbiamo nasconderci che la filosofia, rispetto al sapere
che cerca ancora il vero, viva attualmente ai margini. Per un
filosofo odierno è assai arduo seguire da presso le discussioni
scientifiche, entrare nei dettagli, proporre seriamente qualcosa all’attenzione dei ‘pensatori scientifici’181.
Ben venga, nonostante tale difficoltà, il confronto con gli esiti
della scienza. Anzi è necessario leggere Godel, Heisenberg182,
il carteggio Bohr-Einstein, le riflessioni sulla epistemologia. Ma
lo stesso Mario ha dovuto affermare che affrontare il carteggio fra Pascal e Fermat sul calcolo della probabilità è illeggibile
per un non specializzato in matematica… Quindi mettiamo in
167
dubbio che possa esistere adesso un pensiero filosofico forte.
In futuro, anche se lo ritengo altamente improbabile, chissà!
La seconda considerazione
Ecco adesso proverò ad esporvi la seconda riflessione. Se volete,
di carattere più tecnico, dato che tengo ferma la più convincente
argomentazione, secondo me, su Dio proposta in questi giorni.
È quella esposta da Mario che, ripercorrendo i grandi razionalisti del Seicento, riafferma Dio come Essere Necessario. Tutta
la natura comprende se stessa. Tutto è nella natura. Tutto è
(uguale) Natura. Non è possibile quindi pensare un Dio trascendente, perché già sarebbe altro rispetto alla Natura. Spinoza
è stato il pensatore più conseguente rispetto a tale principio.
Difatti ne fa conseguire che l’Essere Necessario è impersonale,
non giudica, non distingue bello da brutto, buono da cattivo.
La musica è bella per uno, brutta per un altro, indifferente per
un sordo! Tutto è stretto da una tetragona necessità alla quale
nessuno, cosa o essere vivente, si può sottrarre. La tesi stoica
della Ragione del Mondo viene qui dispiegata alla massima potenza. Se l’Essere è necessario allora valgono solo le leggi della
Natura. Il male può esistere solo nelle singole situazioni, ma
sub specie aeternitatis non ha senso parlare del Male. Mentre
Leibniz appronta una gerarchia a partire da Dio-Tutto, Spinoza
spazza via qualsiasi rapporto gerarchico. Tutte le cose, i modi,
stanno sullo stesso piano. Un filo d’erba vale quanto vale un
individuo. E viceversa.
Ebbene, non è bellissimo? Il divino è ovunque, in ogni aspetto
della realtà. Abbiamo gustato tutti noi, qualche sera fa su proposta di Mario, gli stimoli che ci provenivano dall’osservazione
dell’immensità del cielo notturno. Potremmo gustare Dio in
tutte le condizioni e considerarci beati se riusciamo a coglierne i fili sottili che legano logicamente, necessariamente, tutte
le cose. Va bene dunque un Essere Necessario. È convincente.
Ma ciò che non convince, e pongo quindi alla vostra attenzio168
ne, è che avremmo così terminato la corsa! Anzi proprio questo ci spinge a rimboccarci le maniche, eccome! Come tenterò
di argomentare adesso.
Anche ammesso – e non abbiamo problemi ad affermarlo –
che valga l’Essere Necessario di Spinoza, esistono ancora milioni di cose da fare e pensare. E a chi tocca? A noi, mortali che ci
agitiamo nei pensieri, che poniamo incessantemente delle domande, anche forse presentendo che non troveremo risposta.
In sostanza, c’è uno specifico dell’uomo. Non perché l’uomo
sia superiore oppure ontologicamente distinto dagli altri esseri
viventi o dalle altre cose. È proprio perché siamo quello che
siamo (la nostra natura, potremmo dire) che ci tocca in sorte di
avventurarci in problemi che non vengono posti dalla natura.
La specificità degli umani deve comprendere almeno la politica, l’etica, l’estetica. Ammesso questo ne conseguono problemi affatto nuovi, che la natura non si è posta e non si porrà
mai. Il terremoto di Lisbona del 1755 o il recente tsunami del
2004 per la natura sono fatti, ma fatti di nessuna importanza!
La realizzazione della bomba atomica e il successivo utilizzo
sono per gli umani invece della massima importanza!
Il campo politico, etico ed estetico è quello dove l’uomo è chiamato a dover dire qualcosa. E proprio un dovere. Perché è necessario per gli umani, ma non esiste in natura.
L’indifferenza del divino postula lo specifico antropologico
Va costruito un mondo se non in opposizione alla natura – voglio sperare – almeno accanto. In ogni caso va distinto.
E se tutto ciò dipende da quanto l’uomo direziona, sancisce,
dispone, sarà l’uomo stesso a risponderne. Non può essere diversamente.
Viene quindi qui affermata la responsabilità originaria, ineliminabile.
Siamo quindi responsabili di fronte alle nostre scelte politiche,
etiche ed anche estetiche.
169
Dobbiamo dedurne infine che, se siamo responsabili, siamo
liberi. Spinoza ne sarebbe inorridito, come tutti i deterministi
duri e puri. Ma, con buona pace del Dio di Spinoza (che è pure
quello di Einstein), proprio quest’Essere Necessario ci ha dato
un campo sconfinato di ricerca, dove tutto ciò che viene proposto è nuovo, tutto è lecito, tutto può essere sbagliato.
Siamo condannati, sì, ad essere liberi (come affermava Sartre).
170
INTERVENTO DI MARIO MERCANTI
Al termine di questa intensa ed appassionante settimana, ho
maturato la convinzione che delle tre celeberrime domande
nelle quali Kant riassume tutta la problematica filosofica: “che
cosa possiamo conoscere? che cosa dobbiamo fare? che cosa
possiamo sperare?” sia suscettibile di un tentativo di risposta
fondato sul “vaglio della ragione” soltanto la seconda, concernente il problema etico. Le questioni teoretico-metafisiche
concernenti l’inizio e la fine del Cosmo (in senso spaziale e
temporale), l’esistenza di Dio, l’esistenza dell’Anima e la sua
(eventuale) immortalità trascendono infatti – come lo stesso
Kant insegna – l’ambito dell’intelletto umano, che per sua intrinseca e non superabile natura può solo ordinare attraverso
le categorie i “dati” forniti dall’esperienza.
A questa conclusione sono giunto anche con il conforto dell’insegnamento di Giambattista Vico, secondo cui può comprendere veramente un oggetto solo chi ne è l’artefice. Questi, infatti, ne conosce la causa efficiente (se stesso), la causa materiale (ciò di cui è fatto) la causa formale (la struttura che ne realizza l’idea), la causa finale (lo scopo che intende realizzare).
Il mondo della storia è costruito dall’uomo e, quindi può, in
linea di principio, essere da lui conosciuto. Il problema etico
attiene, a sua volta, al dispiegarsi nella storia dei rapporti tra
gli uomini che abitano il mondo e quindi può essere sottoposto
ad un’indagine che abbia delle possibilità di riuscita.
Preliminarmente, riguardo alla dibattuta questione dei fondamenti ultimi dell’etica – salve le personali convinzioni religiose di
ciascuno – si dovrebbe comunque convenire, a mio parere, che:
a) i tentativi di fondarla sulla Volontà rivelata di un Dio legislatore non soltanto ripropongono la domanda teoreticometafisica sulla sua esistenza, ma presuppongono anche la
specifica concezione della Divinità propria delle tre religioni
monoteiste abramitiche;
171
b) la fondazione religiosa dell’etica ha la conseguenza logica che “se Dio non esiste tutto è permesso” e quindi per
l’ateo i rapporti umani rimarrebbero privi di qualsiasi criterio che non sia quello del capriccio, dell’arbitrio, della legge
del più forte.
Io sono invece convinto che sia possibile costruire su basi immanenti e razionali un’“etica minima”, da tutti condivisibile,
consistente in un insieme di principi e regole intesi a rendere
possibile l’ordinata convivenza umana.
Sono inoltre convinto che il punto di partenza per tale “etica
minima” sia quello che Spinoza chiama “conatus sese conservandi”, l’amore che ogni uomo, per natura, ha verso se stesso,
il desiderio di conservare il proprio essere, che lo spinge a ricercare tutto quanto sia utile a tal fine.
Ma per conservare il proprio essere l’uomo – che non ha zanne,
non ha artigli, non ha una vista, un udito, un odorato particolarmente sviluppati, non è particolarmente veloce nella corsa – ha
avuto a sua disposizione nella lotta per la sopravvivenza alcune peculiari caratteristiche fisiche, come la mano e la stazione
eretta, che gli hanno consentito di potere materialmente fabbricare utensili e armi, e degli organi vocali in grado di emettere
suoni articolati in linguaggio nonché, soprattutto, una caratteristica neuro-psichica, l’intelligenza, unita strettamente ad uno
spiccato istinto di socialità. Un’unione talmente intensa da rendere l’uomo un essere essenzialmente socio-culturale, in grado
di sopravvivere e realizzare la propria umanità esclusivamente
all’interno del consorzio con i propri simili. Solo in tale ambito,
infatti, è possibile la collaborazione nell’affrontare e trasformare l’ambiente naturale, la trasmissione delle esperienze e delle
conoscenze accumulate dalle precedenti generazioni nonché,
per l’aspetto che qui rileva, l’elaborazione delle norme morali
che rendono possibile l’ordinata convivenza.
È interessante, in proposito, notare che Nietzsche, volendo
motivare il suo disprezzo per tali norme, sostiene, per l’ap172
punto, che esse sono dipendenti dall’istinto di conservazione
e che, formatesi storicamente per l’utilità comune, sono poi
state sublimate come principi metafisico-religiosi.
Si può essere d’accordo con Nietzsche riguardo alla “sublimazione”. Il ragionamento secondo cui le norme morali per il fatto
di essere meramente utili alla sopravvivenza del genere umano sarebbero prive di intrinseca validità appare invece spiegabile solo con l’indifferenza che egli ostenta per la sorte degli
“uomini comuni”. Mi sembra infatti che una filosofia fondata
sul buon senso dovrebbe ritenere, al contrario, che proprio in
tale utilità (riconosciuta da Nietzsche) esse abbiano il loro più
saldo fondamento razionale.
Rimane, naturalmente, il problema di trovare un criterio oggettivo che consenta di determinare – nella varietà delle comunità umane e dei relativi sistemi economici, sociali, politici,
ideologici, religiosi – le norme di comportamento necessarie
all’ordinata convivenza, che è garanzia di sopravvivenza delle
comunità stesse.
A mio parere il genio di Kant ci ha fornito la risposta più adeguata a tale problema con la celebre formulazione dell’imperativo categorico: “Agisci in modo che la massima della tua azione possa valere come principio di una legislazione universale”.
Tale formula – se ho ben compreso – esprime, in estrema sintesi, un criterio di valutazione dei comportamenti umani basato sulla possibilità ovvero sull’impossibilità logica della loro
generalizzazione. Quei comportamenti che risultano logicamente suscettibili di una applicazione generalizzata sono da
considerare eticamente ammissibili, quelli che non la tollerano
sono da considerare contrari alla ragione e quindi eticamente
inammissibili.
Come esempio tipico si può pensare all’atto del rubare – comprendendo in esso ogni comportamento inteso ad impadronirsi con la destrezza, con la frode o con la forza dei beni che
gli altri hanno prodotto o acquistato come frutto del proprio
173
lavoro – e chiedersi se sarebbe logicamente possibile che tutti
vogliano vivere a spese degli altri. Ciò non è evidentemente
possibile. Di conseguenza il furto risulta un comportamento
contrario all’imperativo categorico. Innumerevoli altri esempi
si potrebbero fare (dall’uccidere, al mentire e – perché no – al
non pagare le tasse, al gettare i rifiuti dove capita, etc.) tutti sostanzialmente accomunati dal fatto di essere in contrasto con
l’ordinata convivenza.
Secondo molti commentatori, peraltro, la formulazione kantiana dell’imperativo categorico corrisponde, declinata in termini
“psicologici”, alla celeberrima “regola aurea” delle grandi tradizioni religiose e sapienziali: “non fare agli altri quello che non
vorresti fosse fatto a te”, nel senso che chi adotta un determinato comportamento nei confronti del prossimo deve mettere in conto, se tale comportamento venisse generalizzato, di
essere trattato allo stesso modo dagli altri e chiedersi se ciò gli
piacerebbe o meno.
Conclusivamente, riguardo alla concezione etica fondata su
basi razionali, vorrei fare le seguenti considerazioni.
- Tale concezione non esclude affatto il soccorso e l’assistenza
verso chi si trova in situazioni di difficoltà. Al contrario essa
svincola tali attività da credenze religiose e sentimenti compassionevoli - che possono esserci o non esserci – e le fonda
razionalmente. Tutti, infatti, possiamo trovarci, prima o poi, in
situazioni di difficoltà. Risulta pertanto pienamente coerente
con lo spinoziano “conatus sese conservandi” prevedere che
in tali casi intervenga a sostegno la mano pubblica, con azioni
che possono essere logicamente suscettibili di ordinaria applicazione. Purché si precisi che l’assistenza deve essere erogata
subordinatamente ad un rigoroso accertamento delle effettive
e non colpevoli condizioni di bisogno. Sì, dunque, all’assistenza
no all’assistenzialismo! (distinzione non sempre chiara a cittadini, amministratori e politici italiani) .
Un’etica fondata su basi razionali non implica costitutivamente
174
gesti straordinari di altruismo ma – ovviamente – non impedisce in alcun modo, a chi vuole, di porli in essere, purché se ne
assuma la responsabilità e gli oneri.
Ritengo peraltro che vi sia necessità non di straordinari (ed isolati) gesti eroici (infelice quel popolo che ha bisogno di eroi!)
quanto, piuttosto, di cittadini consapevoli che i loro interessi
possono ricevere efficace tutela solo nel quotidiano rispetto
delle regole di una comunità bene ordinata secondo principi
razionali, che – in quanto tali – siano comprensibili da tutti e
vincolanti per tutti.
175
NOTE
1 Le “vacanze filosofiche per...non filosofi”, avviate sperimentalmente sin
dal 1983, si sono svolte regolarmente dal 1998. Per saperne di più si possono leggere: A. Cavadi, Quando ha problemi chi è sano di mente. Breve introduzione al philosophical counseling (Rubbettino, Soveria Mannelli 2002)
oppure Autori vari, Filosofia praticata. Su consulenza filosofica e dintorni (Di
Girolamo, Trapani 2008) oppure, A. Cavadi, Filosofia di strada. La filosofiain-pratica e le sue pratiche (Di Girolamo, Trapani 2010). È attivo anche il sito
www.vacanzefilosofiche.altervista.org curato da Salvatore Fricano (Bagheria).
2 M. Ruggenini, Il Dio assente. La filosofia e l’esperienza del divino, San Vittore Olona 1997, p. 9.
3 “Dio è la risposta alla questione che soggiace alla finitudine dell’uomo; è
il nome di ciò che preoccupa l’uomo ultimamente. […] Ciò significa che tutto
ciò che preoccupa l’uomo ultimamente diviene Dio per lui, e, inversamente,
ciò significa che l’uomo non può essere ultimamente preoccupato che da
ciò che è Dio per lui” (P. Tillich, Théologie systématique, II vol., Paris 1970,
p. 105).
4 M. Ruggenini, op. cit., p. 28. Similmente Panikkar: “Qualsiasi ideologia
e qualsiasi cosmologia non fanno che tentare di risolvere, ciascuna a suo
modo, il problema dell’ultimo e definitivo. Qualsiasi sistema filosofico,
inoltre, finisce per scontrarsi, in un modo o nell’altro, con il limite ultimo
del prprio filosofare e deve vedersela con quello che, tradizionalmente, si
chiamerebbe il problema di Dio” (R. Panikkar, Il silenzio del Buddha, Milano
2011, p. 248).
5 Traccia di questa esperienza originaria si ritrova nel Nuovo Testamento:
“Dio è luce e in lui non ci sono tenebre”(Giovanni 1, 5) e ancora nel Credo cristiano, che afferma che Gesù è “Dio da Dio, Luce da Luce”. Basandosi
sull’etimologia del termine, uno scrittore contemporaneo rilegge così il Credo: “Credo in una sola Luce […]. Credo in Gesù Cristo, figlio della Luce” (G.
Squizzato, Il Dio che non è “Dio”. Credere oggi rinunciando a ogni immagine
del divino, Verona 2013, p. 54).
6 “Muse che sull’Olimpo avete dimora, raccontate il principio, e chi fu il primo di loro [degli dèi] a nascere” (Esiodo, Teogonia, vv. 114-115).
176
7 L. Ferry, Imparare a vivere. La saggezza dei miti, Milano 2012, p. 78.
8 Crono voleva imporre da solo il suo dominio mentre, “Con Zeus al potere,
lo scenario dell’universo che si viene disegnando è alquanto diverso. Sono
le divinità sue pari a sceglierlo come re e fra loro Zeus spartisce, con grande
giustizia, gli onori: a ciascuno quello che più merita” (J.-P. Vernant, L’universo, gli dei, gli uomini, Torino 2001, p. 30).
9 “Medesima origine fu agli dèi e ai mortali. Prima una stirpe aurea di uomini mortali fecero gli immortali che hanno le olimpie dimore. Erano ai tempi
di Crono, quand’egli regnava nel cielo; come dèi vivevano, senza affanni nel
cuore, lungi e al riparo da pene e miseria, né per loro arrivava la triste vecchiaia, ma sempre ugualmente forti di gambe e di braccia, nei conviti gioivano, lontano da tutti i malanni; morivano come vinti dal sonno, e ogni sorta
di beni c’era per loro; il suo frutto dava la fertile terra senza lavoro, ricco e
abbondante, e loro, contenti, sereni, si spartivano le loro opere in mezzo a
beni infiniti, ricchi d’armenti, cari agli dèi beati. Poi, dopo che la terra coprì
questa stirpe, essi sono démoni, per il volere di Zeus grande, benigni, sulla
terra; custodi degli uomini mortali della giustizia hanno cura e delle azioni
malvagie, vestiti di nebbia, sparsi dovunque per la terra, datori di ricchezza:
ebbero infatti questo onore regale” (Opere e giorni vv. 108-126).
10 Con ironia Zeus sentenzia: agli uomini “darò un male, e di quello tutti
nel cuore si compiaceranno, il loro male circondando d’amore” (ivi, vv. 5758). Cedendo alla seduzione femminile, infatti, gli uomini sono così stolti da
non rendersi conto che abbracciano con amore proprio la causa dei mali che
riempiono la terra: “infinite sciagure si aggirano fra gli uomini e piena è la
terra di mali, pieno n’è il mare; le malattie giungono agli uomini, sia di giorno
che di notte, ai mortali malanni recando” (ivi, vv .100-103).
11 La realtà esiste di per sé, da sempre, e non comincia ad esistere, perché
sarebbe impossibile un passaggio dal nulla all’essere. Anzi, “per i Greci, come
per gli antichi Germani, il nulla è qualcosa d’inconcepibile; perciò anche la
loro matematica ignora lo zero” (M. Pohlenz, L’uomo greco, Firenze 1989,
p. 68).
12 S. Natoli, La salvezza senza fede, Milano 2008, p. 248. Anche Raimon
Panikkar afferma che “Theós è semplicemente un nome generico, che indica
un evento, un evento divino. Con il diffondersi del cristianesimo, il termine
generico – proveniente da ambiente ‘politeista’ – fu attribuito al padre di
Gesù di Nazaret, nella versione greca e latina (theós, deus). [E così, col tempo,] il nome comune ‘dio’ finì con l’assumere la funzione di nome proprio di
Dio per antonomasia” (R. Panikkar, op. cit., p. 189).
177
13 “Quando qualcosa di indefinito e possente scuote la mente e le fibre, fa
tremare la gabbia di ossa, quando la stessa persona, fino a un attimo prima
torpida e agnostica, si sente squassata dal riso o dalla smania omicida o dallo
struggimento amoroso […], allora il Greco riconosce di non essere solo. C’è
qualcuno accanto a lui, ed è un dio” (R. Calasso, Le nozze di Cadmo e Armonia, Milano 1988, pp. 274-275).
14 “Nel mondo proprio dell’uomo greco le forze che dominano la vita umana e che noi conosciamo come disposizioni dell’animo, inclinazioni, entusiasmi, sono figure dell’essere, di natura divina, che come tali non hanno solo
da fare con l’uomo ma, infinite ed eterne, dominano la terra e il cosmo” (W.
F. Otto, Theophania, Genova 1996, p. 62).
15 “L’antropomorfismo degli dèi greci, quale lo possiamo cogliere nei miti e
che sarà più tardi aspramente rimproverato dai filosofi, ritrova il suo significato religioso nella statuaria divina. […] la perfezione del corpo umano [è vista] come la rappresentazione più adeguata degli dèi” (Mircea Eliade, Storia
delle credenze e delle idee religiose, vol. I, Milano 2006, p. 287).
16 M. Pohlenz, op. cit., p. 78.
17 Ivi. Quando ci si stupisce dei comportamenti immorali degli dèi greci, ci
si dimentica che essi sono forze della natura, a cui sono evidentemente inapplicabili i criteri morali. L’unico atteggiamento inaccettabile, come abbiamo
visto, è quello dell’eccesso, della dismisura che mette in pericolo l’equilibrio
dell’universo.
18 Divino è “il fondamento di ogni essere e di ogni accadere, e tale fondamento traspare così chiaramente attraverso ogni cosa e fatto, che [se ne
parla] anche in rapporto alle cose e ai fatti più naturali e comuni” (W. F. Otto,
Gli dèi della Grecia, Milano 2004, p. 25).
19 M. Pohlenz, op. cit., p. 82.
20 “Per i Greci gli dèi sono così evidenti e naturali che essi non riescono
nemmeno a immaginare che altri popoli possano avere un’altra fede o altri
dei” (B. Snell, La cultura greca e le origini del pensiero europeo, Torino 1963).
21 L. Ferry, op. cit., p. 84.
22 La visione tragica della realtà non li porta al disinteresse per la vita, che
pur sanno essere effimera; al contrario, quella visione implica la “valorizzazione religiosa del presente; il semplice fatto di esistere, di vivere nel tempo,
comporta già una dimensione religiosa. La gioia di vivere scoperta dai Greci
non è però un godimento di tipo profano: rivela la beatitudine di esistere,
di partecipare – anche in modo fuggevole – alla spontaneità della vita e alla
178
grandiosità del mondo. Come tanti altri prima e dopo di loro, i Greci hanno
appreso che il mezzo più sicuro di sfuggire al tempo è quello di sfruttare
fino in fondo la ricchezza, a prima vista insospettabile, dell’attimo fuggente”
(Mircea Eliade, op. cit., p. 288).
23 L. Ferry, op. cit., p. 100.
24 R. Calasso, op. cit., p. 307.
25 Ivi, p. 308.
26 “La religione dei Greci, come ogni religione positiva, sta con la filosofia
di questo popolo in relazioni che sono in parte di affinità, in parte di opposizione. Ciò che per altro la differenzia dalle religioni di tutti gli altri popoli, è
la libertà che essa ha lasciato fin da principio allo sviluppo del pensiero” (E.
Zeller-R. Mondolfo, La filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico, par. I, vol. I,
Firenze 1967, pp. 102-102).
27 Il logos, cioè la ragione, è “lo spirito umano in quanto attivo in due direzioni, nel raccogliere il materiale empirico e nel rielaborarlo soggettivamente
con l’ausilio delle capacità intellettive” (M. Pohlenz, op. cit., p. 317).
28 Il termine physis “indica ancora con evidenza l’atto del phynai, cioè il
crescere e nascere in quanto processo” (W. Jaeger, La teologia dei primi pensatori greci, Firenze 1961, p. 32). Lo stesso rapporto c’è, in latino, tra natura
e nascor.
29 Quindi il termine physis “abbraccia anche l’origine dalla quale sono sorte
e continuano a sorgere [le cose che vediamo], vale a dire la realtà che sta alla
base delle cose della nostra esperienza” (W. Jaeger, ibidem).
30 La physis “comprende e regola tutto ciò che accade nel mondo, seguendo le sue proprie leggi immanenti e inviolabili, le quali non richiedono alcun
intervento dall’esterno” (M. Pohlenz, op. cit., p. 319).
31 Zeller-Mondolfo, op. cit,, par. I, vol. II, p. 60.
32 Ivi, p. 61.
33 “Il sentimento-nozione di un’universale potenza di vita, di generazione,
di fecondità è dunque la forma in cui primamente si costituiscono e si affermano il senso e l’idea del divino” (Ivi, p. 69).
34 Ivi, pp. 62-63.
35 Ivi, p. 69. Non è difficile, a questo punto, scorgere la sintonia, già rilevata
a suo tempo da Aristotele, tra la sapienza mitologica e il pensiero dei primi filosofi: “Il concetto generale unitario del divino (to theion), che tutto abbrac179
cia […] risulta, per testimonianza di Aristotele, documentato fra gli antichi ed
antichissimi teologi, anteriori al sorgere della filosofia. Fra i quali appunto il
divino ha rispetto alla totalità cosmica quella funzione di περιέχον, che non
ha un significato soltanto spaziale, di abbracciare, ma anche e più quello attivo di alimentare e governare”(ivi, p 62). Il rapporto tra mitologia e filosofia
è sottolineato anche dallo Jaeger: “Il pensiero filosofico che subentrerà a
quello di Esiodo cercherà, in contrasto con la teologia sorta dalla Genesi, il
divino nel mondo, non al di là di esso. Seguirà non tanto l’Esiodo teogonico
quanto il cosmogonico e sulle sue orme cercherà il divino nelle forze che
hanno prodotto tutto ciò” (W. Jaeger, op. cit., p. 20).
36 “Non si può separare la componente teologica dalla fondamentale struttura fisica o ontologica del loro [di un Anassimandro o di un Eraclito] pensiero” (Ivi, p. 8).
37 Ivi, p. 42.
38 Platone, Fedro, 247 d-e.
39 Platone, Timeo, 29 a.
40 Platone, Timeo, 30 b.
41 “Come tutto sarebbe stato posto in movimento, se non ci fosse una causa in atto? Il materiale di una casa certamente non può muovere se stesso,
ma lo muove l’arte del costruttore” (Aristotele, Metafisica, XII, 6, 1071 b).
42 “È impossibile che il movimento cominci o finisca: esso fu sempre. E così
il tempo: perché non potrebbe esserci il prima e il poi se il tempo non esistesse” (ibidem).
43 “Deve, dunque, esserci un principio tale che la sua sostanza sia l’atto
stesso. Inoltre, sostanze del genere debbono essere senza materia, perché
debbono essere eterne” (ibidem).
44 “C’è qualcosa che muove senza essere mosso, eterno, che non è altro se
non sostanza e atto. Ma in questo modo, per l’appunto, muovono l’oggetto
del desiderio e dell’intelligenza: muovono non mossi. […] Dunque [il motore
immobile] muove come ciò che è amato, e per mezzo di ciò che da esso è
mosso muove tutto il resto” (Aristotele, Metafisica, Λ, 7, 1072 a-b).
45 Aristotele, Metafisica, XII, 7, 1072 b.
46 Aristotele, Metafisica, XII, 9, 1074 b.
47 Aristotele, Metafisica, XII, 7, 1072 b.
48 Aristotele è un deciso sostenitore del primato della vita teoretica: “L’uo180
mo non deve, come dicono alcuni, conoscere in quanto uomo le cose umane, in quanto mortale le cose mortali, ma deve rendersi per quanto possibile
immortale e far di tutto per vivere secondo quanto c’è in lui di più alto” (Aristotele, Etica Nicomachea, X, 7, 1177 b), tanto che sarà bene tutto ciò che
favorisce la vita contemplativa, mentre “qualsiasi cosa che, per eccesso o
per difetto, impedisce di servire e contemplare Dio, sarà cattiva” (Aristotele,
Etica Eudemia, VIII, 3, 1249 b).
49 “Noi siamo incerti sulle parole che dobbiamo adoperare e parliamo
dell’Ineffabile ed escogitiamo dei nomi con il desiderio di denominarlo, per
quanto ci è possibile” (Plotino, Enneadi, V, 5, 6).
50 Cfr. Plotino, Enneadi VI, 8, 15.
51 L’emanazione è “un irradiamento che si diffonde da lui, da lui che resta
immobile, com’è nel sole la luce che gli splende tutt’intorno; un irradiamento che si rinnova eternamente, mentre Egli resta immobile” (Plotino, Enneadi, V, 1, 6).
52 “Coloro che ripongono l’essere nei corpi fanno come chi sogna; costui
ritiene che esistano attualmente cose che vede come essere: ma non sono
altro che sogni!” (Plotino, Enneadi, III, 6, 6).
53 Plotino, Enneadi, VI, 9, 11.
54 Questa concezione rigorosamente panteistica si ritrova in tutti i principali esponenti della scuola, da Zenone di Cizio (333-263 a. C.) a Cleante di Asso
(330-232 a. C.) e a Crisippo di Soli (278-208 a. C.), per i quali ci sono “due
principi del tutto, il principio attivo e quello passivo. Quello passivo è la sostanza senza proprietà, la materia, e quello attivo è la ragione che si trova in
essa, la divinità; quest’ultima, che è eterna, scorrendo per la materia foggia
tutte le realtà” (Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, VII, 134,).
55 “Democrito, lasciate da parte le cause finali, riconduce alla necessità
[meccanica] tutte le operazioni della natura” (DK 68 A 66).
56 “Gli uomini primitivi, nell’osservare i fenomeni celesti, come tuoni lampi
e fulmini […], furono presi di terrore e credettero che ne fossero causa gli
dei” (DK 68 A 75).
57 “Per quanto riguarda i corpi celesti, non bisogna credere che i loro moti
e le loro rivoluzioni, e il sorgere e il tramontare e altri fenomeni di questo
tipo avvengano per opera di qualche essere che così disponga o così abbia
disposto” (Epicuro, Lettera a Erodoto, 76). Anche per Lucrezio di Pompei (9450 a. C.) il mondo esiste di per sé, formato da un’aggregazione di atomi: gli
uomini “vedono accadere sulla terra e in cielo molte cose, del cui prodursi
181
non riescono a scorgere la causa, e che perciò attribuiscono alla potenza divina. Ma quando avremo capito che nulla può nascere dal nulla, allora comprenderemo più chiaramente ciò che stiamo indagando: donde ogni cosa si
generi e in che modo ognuna accada, senza intervento degli dei” (Lucrezio,
La natura, I, 155-158).
58 “Gli dei esistono: abbiamo di essi conoscenza evidente. Ma non esistono
nella forma in cui li concepisce il volgo […]. Empio non è colui che rinnega
gli dei del volgo, ma colui che applica le opinioni del volgo agli dei” (Epicuro,
Lettera a Meneceo, 123).
59 Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, IX, 51.
60 “Io credo che per la prima volta un uomo astuto e saggio inventò per gli
uomini il terrore degli dei, perché i malvagi temessero anche per ciò che in
modo occulto facessero o dicessero o pensassero. […] Così, ritengo, in principio qualcuno indusse gli uomini a credere che gli dei esistano” (DK 88 B 25).
61 Socrate “non discuteva sulla natura dell’universo, come la maggior parte
degli altri, indagando in che modo esista quello che i dotti chiamano cosmo
e per quali necessità accadano i vari fenomeni celesti: quanti si mettevano in
tali ricerche li definiva insipienti” (Senofonte, Memorabili, I, 1, 11).
62 Senofonte, Memorabili, IV, 7, 6.
63 Platone, Apologia di Socrate, 28 e.
64 “Gli dei non si disinteressano delle faccende dell’uomo buono” (Platone,
Apologia di Socrate, 41 d).
65 Platone, Apologia di Socrate, 31 d.
66 Per descrivere lo sviluppo dell’immagine di Dio nella religiosità ebraica
sembra infatti corretto seguire l’ordine originario, perché “La Bibbia ebraica
e l’Antico Testamento […] sono due edizioni molto diverse della medesima
raccolta” (J. Miles, Dio. Una biografia, Milano 1998, p. 26). A questo autore
faremo spesso riferimento nelle pagine seguenti.
67 Il monoteismo non si trova certo al punto di partenza di questa esperienza religiosa: infatti, anche se del politeismo iniziale del popolo ebraico
restano solo poche tracce nella Bibbia, essa attesta tuttavia senza ombra
di dubbio che c’è stato un processo che va “dal politeismo al monoteismo
passando attraverso la monolatria” (H. Küng, Ebraismo, Milano 2012, p. 49).
Persino nelle lettere paoline si trovano echi della credenza in potenze sovraumane: “La nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue
e di carne ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo
mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano le regioni celesti”
182
(Efesini 6, 12). Va qui ricordato che il modo di leggere la Bibbia è cambiato
molto negli ultimi decenni. Per una rapida informazione sulle novità riguardanti le nozioni di rivelazione, ispirazione, fede, cfr. E. Rindone, L’ispirazione
della S. Scrittura dal Vaticano I al Vaticano II, Palermo 1982.
68 Genesi 1, 1. Gli studiosi riconoscono, come è noto, nella Genesi la presenza di diverse tradizioni letterarie precedenti: la prima pagina del libro appartiene alla tradizione sacerdotale.
69 Genesi 1, 27. Simile, anche se utilizza un linguaggio più marcatamente
antropomorfico, il racconto della tradizione jahvista, anteriore a quella sacerdotale: “Quando Jahvè, il dio, [comunemente tradotto con il Signore Dio]
fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra […], allora
plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e
l’uomo divenne un essere vivente. […] [Poi] plasmò con la costola, che aveva
tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo” (Genesi 2, 4-5. 7. 22).
70 La massa ‘informe e deserta’ sembra dunque preesistere all’azione divina. In effetti, “non c’è solo il fatto che nella Bibbia la dottrina cattolica della
creatio ex nihilo è assente; occorre anche aggiungere che i testi biblici presentano la creazione come avvenuta a partire da una materia preesistente
informe e caotica” (V. Mancuso, Il principio passione, Milano 2013, p. 224).
Lo stesso teologo, nelle pagine successive, mostra quanto sia poco credibile
la tesi che quella dottrina si possa fondare su 2 Maccabei 7, 28.
71 Le prime pagine della Genesi non hanno, infatti, una valenza metafisica
ma “mostrano un Dio che organizza e domina il caos al fine di rendere la vita
possibile per tutto ciò che si muove sulla terra” (E. Schillebeeckx, L’histoire
des hommes, récit de Dieu, Paris 1992, p. 355). Non si comprende nulla della
Scrittura se si dimentica che essa utilizza un linguaggio non concettuale ma
immaginifico per parlare di Dio sempre e soltanto come salvezza dell’uomo,
e va letta perciò in chiave soteriologica e non come descrizione rigorosa della
natura e delle azioni di Dio.
72 Genesi 3, 1. Nell’antica Mesopotamia si credeva il mondo frutto della
vittoria divina sul caos, “rappresentato come una divinità rivale, uno spaventoso drago acquatico […]. I materiali mitici antichi sono stati riscritti così
integralmente che il serpente […] non è più un dio rivale ma […] null’altro che
una delle creature di Dio” (J. Miles, Dio. Una biografia, p 43).
73 Genesi 3, 14.
74 Genesi 3, 16.
75 Genesi 3, 18.
183
76 Genesi 6, 5.
77 Genesi 6, 6-7. Mentre nel mito babilonese è Tiamat, il mostro del caos
acquatico, che si oppone al dio buono Marduk, nella Genesi è lo stesso Jahvè
che scatena il diluvio e che salva da esso.
78 Genesi 8, 20-21.
79 Genesi 9, 11.
80 Genesi 17, 1-2. 7-8.
81 Esodo 3, 14.
82 “Con questa risposta non viene affatto definita in maniera statico-ontologica l’essenza di Dio, come ritenevano alcuni teologi cristiani antichi, medievali e moderni […]. Qui viene annunciata in forma di promessa la volontà
di Dio: l’esistenza dinamica, l’essere presente e operante di Dio” (H. Küng,
Ebraismo, p. 60). E ancora: “Il nome rivelato a Mosè non aveva in sé alcun
nesso con l’Essere dei filosofi. […] [Ciò che Yahveh rivela] non è tanto il suo
essere quanto la sua azione salvifica” (R. Panikkar, op. cit., p. 191). Si tratta
di un dato ormai acquisito: “L’esegesi biblica sia essa giudaica o cattolica o
protestante ritiene, infatti, che il termine ‘sono’ sia da intendere non tanto nell’accezione di puro essere e neppure di esistente quanto piuttosto in
quello di essere presente, di intervenire, di stare accanto” (S. Natoli, op. cit.,
p. 252).
83 “Il Signore aveva reso ostinato il cuore del faraone, il quale non lasciò
partire gli Israeliti dal suo paese” (Esodo 11, 10). L’attribuzione a Jahvè di
intenzioni che potremmo dire malvagie è una conseguenza del monoteismo,
mentre nelle religioni politeistiche intenzioni diverse possono essere riferite
a divinità differenti. Lo stesso Jahvè che ha scelto Mosè per liberare il popolo, per esempio, a un certo punto sembra volersene sbarazzare: infatti,
mentre Mosè “si trovava in viaggio, nel luogo dove pernottava, il Signore gli
venne contro e cercò di farlo morire” (Esodo 4, 24.).
84 Esodo 10, 1.
85 Esodo 12, 12-13.
86 Esodo 12, 14.
87 “Baal era contemporaneamente un dio della guerra, un dio della tempesta e un dio della montagna o del vulcano” (J. Miles, op. cit., p. 120). Similmente, Jahvè è chiamato talvolta dio della montagna e parla da un roveto
ardente.
88 Esodo 20, 23.
184
89 Esodo 32, 27.
90 Esodo 32, 34. Un volto più mite rispetto al guerriero dell’Esodo presenta
Jahvè nel Levitico, esortando, per esempio, a un atteggiamento benevolo nei
confronti dei poveri e addirittura degli stranieri: “Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo; il salario del bracciante al tuo servizio
non resti la notte presso di te fino al mattino dopo. […] Quando un forestiero
dimorerà presso di voi nel vostro paese, non gli farete torto. Il forestiero dimorante fra di voi lo tratterete come colui che è nato fra di voi” (Levitico 19,
13. 33-34). Riguardo alla condizione degli stranieri, tuttavia, non mancano
passi che vanno in altra direzione, ammettendo, per esempio, che i loro figli
possono essere ridotti in schiavitù: “Potrete anche comprarne [di schiavi] tra
i figli degli stranieri, stabiliti presso di voi” (Levitico 25 45).
91 Deuteronomio 6, 4-7.
92 Deuteronomio 28, 1.
93 Deuteronomio 28, 15.
94 Giosuè 6, 21. Similmente il Signore, per bocca di Samuele, ordina a Saul:
“Colpisci Amalek e vota allo sterminio quanto gli appartiene, non lasciarti
prendere da compassione per lui, ma uccidi uomini e donne, bambini e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini” (1 Samuele 15, 3).
95 2 Re 17, 6.
96 2 Re 24, 14.
97 “Il Signore stenderà di nuovo la mano per riscattare il resto del suo popolo superstite dall’Assiria e dall’Egitto” (Isaia 11, 11).
98 Isaia 2, 3-4.
99 Isaia 5, 23.
100 Isaia 6, 3. La santità esprime la distanza incolmabile che separa il mondo da Jahvè, che si allea con l’uomo e che tuttavia è l’assolutamente altro. In
termini filosofici, si parlerà di trascendenza.
101 Isaia 11, 6.
102 Isaia 25, 8.
103 Isaia 45, 1.
104 Isaia 56, 7. Non mancano gli studiosi che attribuiscono i capitoli 56-66
a un Tritoisaia.
185
105 Isaia 45, 15. Vantandosi di causare sia il bene che il male, Jahvè conserva sempre un carattere ambiguo: “Io sono il Signore e non v’è alcun altro.
Io formo la luce e creo le tenebre, faccio il bene e provoco la sciagura; io, il
Signore, compio tutto questo” (Isaia 45, 6-7).
106 “Come una madre consola un figlio così io vi consolerò” (Isaia 66, 13).
107 Isaia 54, 6-7. E poco dopo: “Come gioisce lo sposo per la sposa, così il
tuo Dio gioirà per te” (Isaia 62, 5). La stessa passione di Jahvè per il suo popolo, che pure lo ha tradito più volte, ritroviamo in Osea: “Ti farò mia sposa
per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza
e nell’amore” (2, 21).
108 Isaia 53, 10-11.
109 Come testimonia il libro dei Salmi, per il pio israelita è uno scandalo
continuo vedere “la prosperità dei malvagi. Non c’è sofferenza per essi, sano
e pasciuto è il loro corpo. Non conoscono l’affanno dei mortali e non sono
colpiti come gli altri uomini. […] Ecco, questi sono gli empi: sempre tranquilli,
ammassano ricchezze. Invano dunque ho conservato puro il mio cuore e ho
lavato nell’innocenza le mie mani, poiché sono colpito tutto il giorno, e la
mia pena si rinnova ogni mattina” (Salmo 73, 3-5. 12-14).
110 Giobbe 1, 8.
111 In effetti, “Giobbe cambia l’argomento, provocando sulla giustizia di
Dio, anziché sulla propria, un interrogativo nella mente del lettore” (J. Miles,
op cit., p. 382).
112 Giobbe 38, 4.
113 Giobbe 42, 6. Questa traduzione sembra più corretta di quella, che capovolge il senso delle parole di Giobbe, proposta dalla CEI: “Perciò mi ricredo
e ne provo pentimento sopra polvere e cenere”.
114 Giobbe 42, 12-13.
115 J. Miles, op. cit., p. 383.
116 Da questo momento in poi, infatti, Dio non parla più, tanto che non è
eccessivo affermare che “È Giobbe ad avere ridotto Dio al silenzio” (ivi, p.
385).
117 Qoèlet 7, 13-14. Meglio affidarsi, per la riuscita di una vita umana, al
buon senso spicciolo: “Non esser troppo scrupoloso né saggio oltre misura.
Perché vuoi rovinarti? Non esser troppo malvagio e non essere stolto. Perché vuoi morire innanzi tempo?” (Qoèlet 7, 16-17).
186
118 Daniele 7, 9.
119 Daniele 7, 13-14.
120 J. Miles, op. cit., p. 433.
121 Marco 1, 11.
122 Marco 9, 7.
123 Marco 1, 15.
124 Nel Nuovo Testamento non si trova “nessun trattato De Deo, tipico della manualistica teologica” (G. Barbaglio, Gesù di Nazareth e Paolo di Tarso,
Bologna 2006, p. 167).
125 Gesù non è certo il primo a chiamare Dio padre. Tale appellativo si ritrova non solo nella tradizione veterotestamentaria ma anche presso i greci
e i romani: “il fenomeno si registra già nei poemi omerici, dove Zeus, figlio di
Crono, figura padre della famiglia degli dei [e degli uomini]. […] [La novità dei
vangeli è costituita dal fatto che Gesù] riferisce la paternità anche ai reprobi
e agli ingiusti, motivando con questa integrale paternità di Dio quell’amore
dei nemici che è specificamente suo” (H. Küng, Essere cristiani, Milano 2011,
pp. 410, 412).
126 Barbaglio, op. cit., p 182. Vedi, per esempio: “Avete inteso che fu detto:
Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri
nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siete figli del Padre vostro
celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere
sopra i giusti e sopra gli ingiusti” (Matteo 5, 43-45). Quello di Gesù non è
certo il Dio dei vincitori e dei potenti: se ha una predilezione, questa è per i
deboli, i disprezzati e i vinti, e solo “il nostro secolare imborghesimento, la
nostra appartenenza a una comunità di ‘benpensanti’ ci hanno probabilmente resi ciechi di fronte al senso ovvio del messaggio di Gesù e delle parabole
che l’illustrano” (E. Schillebeeckx, op. cit., p. 185).
127 “Il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi
eletti” (Matteo 22, 13-14).
128 J. Dupont, Le Dieu de Jésus, in NRT 1987, p. 323.
129 Giovanni 14, 9.
130 Certamente si può dire che “là dove il bene trionfa e dove la sofferenza
e l’ingiustizia sono sconfitte, ‘Dio’ è messo in pratica”(E. Schillebeeckx, op.
cit., p. 199), ma Dio è presente anche quando è il male che ha la meglio se,
187
come nel caso di Gesù, si è condannati perché si lotta per la liberazione degli
oppressi: infatti la sua “morte è la conseguenza di una vita radicalmente a
servizio della giustizia e dell’amore, la conseguenza di una scelta per gli ultimi e gli esclusi” (ibidem).
131 Giovanni 10, 30.
132 1 Giovanni 4,8. Siamo, qui, molto lontani dalla prospettiva greca: infatti,
mentre le migliori pagine bibliche presentano un Dio innamorato dell’uomo,
Plotino, al contrario, concepiva l’Uno come invaghito della propria perfezione e ripiegato sull’amore di sé stesso (cfr. Plotino, Enneadi VI, 8,15).
133 “Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e la
luce minore per regolare la notte” (Genesi 1, 16).
134 Ad agire, nella Bibbia, sono soltanto Dio e gli uomini, e non c’è “una
terza alternativa: né Fato, né Natura, né Cosmo, né Fondamento di tutto
l’essere” (J. Miles, op. cit., p. 464).
135 Tommaso, Somma teologica I, 2, 2 ad 1.
136 Tommaso parla di ‘vie’, percorsi che conducono alla scoperta di Dio, ma
ciò non significa che per lui l’esistenza di Dio sia solo un’ipotesi ragionevole.
È bene ribadire, infatti, che per Tommaso si tratta di argomenti cogenti: “Che
Dio esista si può provare per cinque vie” (I, 2, 3; salvo diversa indicazione,
anche le altre citazioni di Tommaso si riferiscono a questo articolo della Somma teologica), tanto che, almeno nelle prime tre, la conclusione è introdotta
da un perentorio “necesse est” (ibidem).
137 Una cosa non potrebbe infatti, nello stesso tempo e dallo stesso punto
di vista, essere principio motore e cosa mossa; la causa, quindi, deve essere
esterna a ciò che cambia: per esempio, “il fuoco che è caldo attualmente
rende caldo in atto il legno, che era caldo soltanto potenzialmente, e così lo
muove e lo altera”.
138 L’affermazione dell’esistenza di un motore immobile “non è che la trasformazione da negativo in positivo del principio di causalità: ciò che diviene,
in quanto diviene, non ha in sé la ragione sufficiente del suo divenire” (A.
Masnovo, La filosofia verso la religione, Milano 1963, p. 66).
139 Secondo alcuni studiosi, al motore immobile della prima via si arriva facendo leva sulla serie non di cause efficienti ma di cause finali. A ogni modo,
a proposito della seconda via Gilson nota che “ciò che abbiamo detto delle
cause del movimento, possiamo dirlo delle cause in generale” (E. Gilson, La
philosophie au moyen âge, Paris 1962, p. 531).
140 Ecco il testo: ci sono enti “che possono esistere e non esistere; infatti,
188
alcune cose nascono e periscono, il che vuol dire che possono essere e non
essere. Ora, è impossibile che tutte le cose di tal natura siano sempre state,
perché ciò che può non essere, un tempo non esisteva. Se dunque tutte le
cose esistenti sono tali che possono non esistere, in un dato momento niente esistette. Ma se questo è vero, anche ora non esisterebbe niente, perché
ciò che non esiste, non comincia ad esistere se non ad opera di qualche cosa
che è. Perciò, se non c’era ente alcuno, è impossibile che qualche cosa cominciasse ad esistere, e così anche ora nulla esisterebbe, il che è evidentemente falso. Dunque non tutti gli esseri sono contingenti, ma bisogna che
nella realtà vi sia qualcosa di necessario […] e questo tutti lo chiamano Dio”.
141 In effetti, non abbiamo “l’esperienza dell’incominciare assoluto; noi vediamo sempre e soltanto trasformazioni, non inizi dal nulla: la pianta nasce
dal seme” (S. Vanni Rovighi, Elementi di filosofia, Brescia 1964, vol. II, p. 105).
Questa constatazione, che infirmerebbe la validità dell’argomento, sarebbe
però superata, secondo la Vanni Rovighi (ma io resto piuttosto perplesso),
dall’esperienza della soggettività umana, qualcosa cioè di radicalmente nuovo che non potrebbe perciò ridursi a semplice trasformazione di una realtà
precedente: “quando guardo in me stesso mi accorgo che io non sono affatto
l’atteggiarsi di un tutto impersonale, ma sono una persona distinta da ciò che
mi circonda” (ivi, p 108).
142 E. Gilson, Introduction à la philosophie chrétienne, Paris 1960, p. 53.
143 Ivi, p. 113.
144 Già a suo tempo il nostro autore era informato dei dubbi interpretativi
formulati dagli esegeti: “Dio è l’essere; la Scrittura lo dice o, almeno, si afferma spesso che la Scrittura lo dice” (ivi, p. 59).
145 Ivi, p. 55.
146 “La creatura non ha l’essere se non da altri; se abbandonata a se stessa,
in sé considerata essa è nulla” (Tommaso, De aeternitate mundi contra murmurantes, in Opuscola philosophica, Torino 1954, capitolo 7, p. 106). Senza
l’atto creatore, infatti, per Tommaso non ci sono non solo le cose ma neanche la materia prima aristotelica, perché la creazione è productio ex nihilo sui
(cioè della cosa che si crea) et subiecti (cioè della sua materia).
147 E. Gilson, La philosophie au moyen âge, p. 534. Solo in quanto ne è
causa si può dire che Dio è intimo al creato: “Dio stesso è causa propria e
immediata di ciascuna realtà, e in qualche modo causa più intima a ciascuna
natura di quanto essa non lo sia a se stessa” (Tommaso, De veritate q 8, a
16, ad 12).
148 “Ancora con Platone e Aristotele la filosofia non va alla ricerca del Dio,
189
ma è presso la divinità e nutre di questa prossimità la propria esperienza del
mondo. La meraviglia è rivelazione di quanto di divino è nascosto in ciò che
è […]. Il pensiero platonico-aristotelico della separatezza del divino non desacralizza il mondo, perché al contrario adempie la necessità che la filosofia
avverte di pensare convenientemente il divino fondamento del tutto. Il divino è così separato di quel tanto che permette di pensarlo come riferimento
indefettibile della realtà” (M. Ruggenini, op. cit.,, p. 40).
149 Da Esodo 3, 14 “è ispirata una concezione del divino che lo svincola radicalmente dal mondo nel momento in cui sospende alla sua libera volontà e
potenza creatrice ogni rapporto con una realtà diversa da lui e per ciò stesso
creata. Dio viene così sciolto dal mondo, definitivamente ab-solutus” (M.
Ruggenini, op. cit., p. 44).
150 Si può dire che per Tommaso Dio è non solo trascendente ma anche
immanente? Per rispondere è necessaria qualche precisazione terminologica. Gli scolastici distinguono le cause transeunti, la cui attività si esaurisce
nel momento in cui producono il loro effetto, da quelle immanenti, la cui
attività permane sia nel soggetto agente che nell’effetto prodotto. Solo in
questo senso si può dire che Dio, l’Essere trascendente, è immanente, presente nel mondo: in quanto, cioè, causa permanente del suo emergere dal
nulla. Tommaso afferma, infatti, che Dio si trova in tutto il creato come un
re, che esercita il suo potere in tutto il suo regno, come un padrone, che
conosce tutto ciò che c’è nella sua casa e come creatore, che dona l’essere:
“Egli è in tutte le cose con la sua potenza, perché tutte sono soggette alla sua
potestà; vi è con la sua presenza, perché tutto è nudo e scoperto davanti ai
suoi occhi; vi è con la sua essenza, perché è presente a tutte le cose quale
causa dell’essere” (Tommaso, Somma teologica I, 8, 3). Gli esempi su riportati, proposti da Tommaso stesso, mostrano con quali limiti si possa parlare
di immanenza del creatore in una creatura che è soltanto soggetta al suo
potere, da lui interamente conosciuta e a lui debitrice del proprio essere.
Non sarebbe corretto, invece, usare il termine immanenza per designare una
realtà che sussiste senza potersi separare ontologicamente da un’altra alla
cui costituzione essa contribuisce, perché, al contrario, il Dio di Tommaso è
trascendente, in quanto esiste al difuori e al disopra del mondo, che dipende
da lui mentre egli non dipende da esso. Trascendenza e immanenza sono
perciò, nel significato oggi corrente, termini antitetici, e per Tommaso Dio
non è immanente ma trascendente.
151 “Ciò che esprime nel modo più netto la distanza insormontabile che
separa il pensiero cristiano da quello greco, e li fa appartenere a mondi collegati, ma semplicemente intraducibili l’uno nell’altro, nonostante ogni conclamata continuità speculativa, è proprio la riduzione della natura a prodotto
190
dell’onnipotenza divina” (M. Ruggenini, op. cit., p. 53).
152 Tommaso infatti, tra gli errori dei filosofi riguardanti la creazione, indica
prima quello di Democrito ed Epicuro, per i quali gli atomi si aggregavano
tra loro senza alcun intervento divino, poi quello di Platone e di Anassagora,
che ammettevano una materia esistente di per sé, e come terzo quello di
Aristotele “che affermò che il mondo non aveva avuto inzio ad opera di Dio
ma esiste dall’eternità, contro quanto si dice in Genesi 1, 1: In principio Dio
creò il cielo e la terra” (De articulis fidei). Secondo Tommaso, però, la verità
che il mondo non sia eterno è solo oggetto di fede e non può essere dimostrata con la ragione.
153 Dall’idea della trascendenza è derivato il disincanto del mondo: “Nella
trascendenza il divino si denaturalizza ed è in forza di tale denaturalizzazione
che la natura può apparire effettivamente e nudamente come natura, spazio
per l’azione libera dell’uomo” (S. Natoli, op. cit., p. 242). Non era così per i
greci: “Non era soltanto mondo il cosmo antico, inabitato dagli dei. Diventa
soltanto mondo quest’universo creato, separato da Dio dalla sua insormontabile finitezza, dunque disertato da una divinità che da esso non si lascia
contenere” (M. Ruggenini, op. cit., p. 61).
154 E. Gilson, Constantes philosophiques de l’être, Paris 1983, p. 226.
155 Cfr. Tommaso, Somma teologica I, 12, 12.
156 “Quando procediamo verso Dio per via di esclusione, anzitutto allontaniamo da lui le caratteristiche sensibili, poi anche quelle spirituali, nella
forma in cui sono nelle creature, come bontà e sapienza; allora rimane nella
nostra intelligenza solo che è, e niente di più: per cui essa resta in una certa
confusione. Infine anche questo stesso essere, come si trova nelle creature,
lo allontaniamo da lui, e allora l’intelligenza resta in una specie di notte di
ignoranza che ci unisce a Dio nel modo più perfetto, per quanto é possibile in questa vita” (Tommaso, Commento alle Sentenze I, d. 8, a. 1 ad 4m).
Commentando un analogo passo della Somma, il Sertillanges osserva: “l’esclusione di ogni elemento di definizione riguardante Dio si estende sino alla
qualificazione di Dio come essere. Dio non è un essere, nel senso umano
della parola [...]. Noi non sappiamo dunque affatto, per nulla, in alcuna misura, ciò che Dio è. Sappiamo che é; ma in questa proposizione ‘Dio è’, il
verbo essere non significa affatto l’essere reale, l’essere considerato come
un attributo; esso non è che il legame logico di una proposizione vera” (Saint
Thomas d’Aquin, Somme Théologique I, 12-17, Paris-Tournai-Rome 1956, a
cura di A.-D. Sertillanges, p. 383).
157 E. Gilson, Constantes philosophiques de l’être, pp. 207-208. Mediante
l’analogia infatti, scrive il Sertillanges nel commento già citato, “non si vuol
191
definire Dio, ma pensarlo in funzione della creatura, che ne deriva, e che
esige questo mistero per avere un senso e per sussistere” (Saint Thomas
d’Aquin, Somme Théologique, p. 388).
158 Tommaso, De Potentia q. 7, a. 5 ad 14m. Tommaso, del resto, riecheggia
una lunga tradizione. Scoto Eriugena, per esempio, scrive: Dio “si conosce
meglio non conoscendolo; l’ignoranza di lui è vera sapienza” (Tommaso, De
divisione naturae I, 510b).
159 Tommaso, In Boëtium de Trinitate q. 1, a. 2 ad 1m. L’esistenza di Dio,
quindi, non appare in sostanza che la condizione di intelligibilità del relativo,
sicché il filosofo, come ribadisce anche il De Lubac, “si riposerà della sua
ricerca nella contemplazione dell’effetto ormai pienamente compreso” (H.
De Lubac, Sur les chemins de Dieu, s.l. 1966, p. 178).
160 Esperienza che ha un suo linguaggio che, se usato con critica consapevolezza dei suoi limiti, ha una sua autonomia e una sua validità: “Le possibilità del nostro linguaggio sono molto più ampie di quelle della tradizionale
ontologia e proprio per questo l’uscita da quella ontologia non significa l’uscita dal linguaggio” (S. Natoli, op. cit., p. 232).
161 Come notava Kant, “La ragione umana ha il particolare destino di venir
assediata da questioni, che essa non può respingere, poiché le sono assegnate dalla natura della ragione stessa, ma alle quali essa non può neppure dare risposta, poiché oltrepassano ogni potere della ragione umana” (I.
Kant, Critica della ragion pura, Torino 1965, p. 7). È vero, poi, che i progressi
delle scienze hanno dato risposta a domande impropriamente in passato rivolte alla filosofia o alla religione, tanto da esigere, specie su alcune questioni riguardanti il mondo della natura, una “rimessa in discussione dei propri
convincimenti filosofici” (T. Pievani, La vita inaspettata. Il fascino di un’evoluzione che non ci aveva previsto, Milano 2011, p. 161); sarebbe tuttavia un
errore cadere nell’eccesso opposto, affidandosi solo alla scienza, perché “noi
sentiamo che se pure tutte le possibili domande della scienza ricevessero
una risposta, i problemi della nostra vita non sarebbero nemmeno sfiorati”
(L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Milano-Roma 1954, prop.
6. 52).
162 È un’ovvietà, ma può essere utile ricordare che Dio, se esiste, trascende
“ogni pensiero e ogni riflessione; noi non ascoltiamo da nessuna parte la
sua voce, non vediamo da nessuna parte il suo volto. La realtà di Dio non è
verificabile; essa è oggetto di controversie che dividono gli uomini” (E. Schillebeeckx, op. cit., p. 125). È bene, perciò, prendere atto che “per il credente
l’interpretazione religiosa [della vita] è più intelligibile e più ragionevole. Il
non-credente, al contrario, trova una maggiore ragionevolezza nell’interpre192
tazione agnostica” (ivi, p. 158).
163 Accanto alla conoscenza concettuale, anche “la dimensione emotiva
possiede un suo proprio valore conoscitivo, capace di rivelare la realtà. Essa
non è, dunque, un semplice fenomeno senza significato proprio, che si accompagna alla dimensione scientifica dichiarata portatrice esclusiva di valori
conoscitivi. L’intenzionalità conoscitiva della fede in Dio non può essere oltre
identificata con la conoscenza concettuale” (ivi, p. 105).
164 B. Pascal, Pensieri 477/277. E ancora: “L’ultimo passo della ragione sta
nel riconoscere che vi è un’infinità di cose che la sorpassano: essa non è che
debole cosa se non arriva a riconoscere questo” (Pascal, Pensieri 466/267).
L’esperienza religiosa, quindi, ha un suo senso, una sua intelligibilità, “sprovvista tuttavia di forza razionale dimostrativa universalmente persuasiva” (E.
Schillebeeckx, op. cit., p. 140).
165 La meraviglia e il timore che la realtà suscita sono all’inizio non soltanto della filosofia, ma anche della religione. “Con che cosa, partendo da che
cosa si dovrà spiegare questa realtà così universalmente problematica? Che
cosa la rende possibile? Qual è la condizione della possibilità di questa realtà
problematica?” (H. Küng, Essere cristiani, p. 83). L’ipotesi-Dio proposta dalla
religione potrebbe essere questa ‘condizione di possibilità’.
166 Il paese e la famiglia in cui si nasce hanno, innegabilmente un peso rilevante nelle scelte di fondo: “Trovarsi a proprio agio nella tradizione religiosa
o areligiosa ricevuta nell’infanzia è uno dei fattori decisivi condizionanti la
fede o l’incredulità di un individuo” (E. Schillebeeckx, op. cit., p. 136).
167 H. Küng, Essere cristiani, p 88. Può essere opportuno ribadire che per
‘fede’ si intende qui non l’accettazione di una rivelazione soprannaturale ma
l’apertura fiduciosa alla vita, nonostante le sue pur ineliminabili oscurità e
contraddizioni. In tale prospettiva, con la parola Dio si vuol significare “la
Verità che cerchiamo in ogni nostra conoscenza, il Bene che vogliamo in ogni
atto di amore, la Giustizia che perseguiamo in ogni nostra decisione, tutti
quei valori, cioè, che sono la ragione costante delle nostre tensioni e che
cogliamo presenti nelle situazioni storiche, anche se mai perfettamente realizzati in esse” (C. Molari, La fede e il suo linguaggio, Assisi 1972, p. 47).
168 H. Küng, Essere cristiani, p. 93. I sistemi filosofici più rigorosi si rivelano, in effetti, “o una razionalizzazione o tematizzazione teorica di una fede
religiosa in Dio, precedentemente ammessa, oppure una razionalizzazione
di una tradizione atea, anch’essa ammessa precedentemente. La negazione o l’affermazione filosofiche di Dio non sono in effetti conclusioni di quei
sistemi filosofici in quanto tali. La fede in Dio o il rifiuto di questa fede si
trovano al punto di partenza delle loro riflessioni, non al loro termine” (E.
193
Schillebeeckx, op. cit., p. 113). Se quella dell’ateo, che scommette sull’autosufficienza del mondo, è una scelta, lo è anche quella del credente. Fede
e incredulità “sono quindi un rischio. Proprio la critica delle prove dell’esistenza di Dio fa emergere che la fede in Dio ha un carattere decisionale e,
viceversa, la decisione in favore di Dio ha un carattere di fede” (H. Küng, Dio
esiste?, Roma 2012, p. 764). È una decisione che non riguarda solo la ragione
ma investe “l’uomo intero nella sua vitale concretezza di spirito e corpo, ragione e istinti, nella sua ben precisa situazione storica, nella sua dipendenza
da tradizioni, autorità, schemi di pensiero e scale di valori, nei suoi interessi
personali e nelle sue relazioni sociali” (H. Küng, Essere cristiani, p. 94).
169 Le antiche tradizioni religiose ci presentano le esperienze di uomini che
parlano del mistero divino secondo le possibilità umane, con un linguaggio poetico-mitologico che mescola inevitabilmente profonde intuizioni,
immagini inadeguate e addirittura idee francamente inaccettabili. Chi legge la Bibbia con metodo storico-critico si accorge che essa non costituisce
affatto un’eccezione alla regola: infatti, sebbene la religiosità ebraica abbia
conosciuto un’evoluzione che ha portato, “nell’ultimo periodo dell’Antico Testamento e all’inizio dell’era cristiana, a una concezione purificata di Dio in
quanto essere morale, Yahvé resta sino alla fine essenzialmente una creazione dell’immaginazione poetica, non controllata da un’analisi critica sistematica. Non c’è quindi da stupirsi che nei miti, negli inni, nelle preghiere, nelle
profezie e nelle storie della Bibbia si trovino eccessi e illogicità di ogni tipo;
è molto più sorprendente costatare che un discorso così metaforico possa
essere preso per la descrizione letterale di un essere divino al quale ci sarebbe domandato di credere” (G. D. Kaufman, La question de Dieu aujourd’hui,
Paris 1975, p. 220, nota 6).
170 Si tratta di un rischio ineliminabile perché l’alternativa sarebbe un assoluto silenzio: infatti, “se cerchiamo di epurare il nostro concetto di Dio da
tutti i predicati che non possono essergli attribuiti con precisione letterale, il
concetto stesso tende a svuotarsi di ogni contenuto [… e] per molti e, forse,
il più delle volte, per tutti, non potrà assolvere nella vita religiosa a quelle
funzioni che erano svolte da analogie e immagini” (F. C. Copleston, Religione
e filosofia, Brescia 1977, p. 124).
171 Le religioni sono grandi macchine narrative che rinviano a ciò che non è
altrimenti dicibile, sistemi simbolici che generano strutture di senso, alludendo a qualcosa che deve restare inafferrabile. La sapienza mitologica contiene
grandi intuizioni, capaci di fecondare, come attesta la storia della filosofia,
la stessa indagine filosofica: il simbolo, infatti, dà a pensare perché in fondo,
seppur in forma di mito, sono state già toccate tutte le questioni essenziali.
Sarebbe, invece, un errore interpretare le immagini mitiche come adegua194
ta descrizione della realtà, cosa che accade quando la teologia, con le sue
straordinarie e spesso affascinanti acrobazie concettuali, e il magistero, che
si dichiara addirittura infallibile, pretendono che i loro umani, troppo umani
insegnamenti siano accettati come informazioni oggettive sulla realtà divina.
E se è vero, come ritengono José María Vigil e altri teologi cattolici, che stiamo entrando in una fase post-religiosa della storia dell’umanità, prendere
coscienza della valenza puramente simbolica delle immagini tradizionali del
divino potrà favorire il superamento della contrapposizione teismo-ateismo.
Panikkar parla “della necessità di una purificazione e riforma dell’idea stessa
di Dio. Forse la parola stessa deve essere sostituita” (R. Panikkar, op. cit., p.
248). La nostra epoca non possiede ancora gli strumenti intellettuali necessari per una nuova formulazione, ma è certo che “non è sufficiente il Dio delle religioni così come esse ce lo rappresentano, non è sufficiente l’assoluto
dei filosofi, né il limite indefinito degli scienziati o l’orizzonte indescrivibile
dei poeti” (ivi, p. 249).
172 G. D. Kaufman, op. cit., p. 114. E già il Sertillanges, riecheggiando una
lunga tradizione, metteva in guardia contro il pericolo di scambiare Dio con
l’idea che ci facciamo di lui, perché, “divenuto verità in noi, non è più allora
il vero Dio, e il pensiero non si indirizza che a un idolo” (A.-D. Sertillanges,
Les grandes thèses de la philosophie thomiste, Paris 1928, p. 68). Oggi si
é giustamente sensibili al pericolo di considerare Dio ‘oggetto’ della conoscenza umana. L’errore di credere che le rappresentazioni della filosofia o
della teologia corrispondano alla realtà, scrive un pensatore cristiano contemporaneo, “é ciò che Paul Ricoeur chiama, nel suo linguaggio filosofico
particolare, il rischio dell’oggettivazione, che egli oppone alla categoria di
orizzonte, ‘metafora di ciò che si avvicina senza mai divenire oggetto posseduto’. Ora questa condizione di orizzonte ha anch’essa le sue vicissitudini,
che Paul Ricoeur esprime in un passo assolutamente decisivo: ‘sembra proprio che un tale orizzonte, per una specie di conversione diabolica, tenda
incessantemente a convertirsi in oggetto. Kant, per primo, ci ha insegnato
a considerare l’illusione una struttura necessaria del pensiero dell’incondizionato. Lo Schein [illusione] trascendentale non é un semplice errore, puro
accidente della storia del pensiero; é un’illusione necessaria [...]’ [P. Ricoeur,
De l’interprétation. Essai sur Freud, p. 509]. Proiettare i propri schemi su Dio,
progettare un Dio per poterselo appropriare, per poter fare se stessi Dio,
ecco ciò che apparirà ben presto come il rischio fondamentale dell’illusione religiosa. [...] Appartiene dunque alla fede lottare perpetuamente contro
questa illusione oggettivante del Tutt’Altro” (J.-M. Pohier, Au nom du Père.
Recherches théologiques et psychanalytiques, Paris 1972, p. 34-35).
173 Rimproverando il re Ioakim, Geremia gli ricorda che il padre di lui “tutelava la causa del povero e del misero e tutto andava bene; questo non
195
significa, infatti, conoscermi? Oracolo del Signore” (Geremia 22, 16).
174 1 Giovanni 4,12. E oggi i cristiani possono rendere intelligibile ai noncredenti che cosa intendono col termine ‘Dio’ se si dimostrano capaci di
incarnare in forme nuove l’amore di cui parla la Scrittura riconoscendo “la
necessità di partecipare con tutto il cuore e con tutte le forze all’opera contemporanea di emancipazione politica, culturale e sociale” (E. Schillebeeckx,
op. cit., p. 208).
175 Li indico con la maiuscola, come vuole la tradizione, perché sia più chiaro che si tratta di sinonimi.
176 Nella relazione di Leonessa ho fatto cenno, in chiusura, ad un confronto
tra Spinoza e Leibniz, mostrando come le teorie del secondo siano meno
lontane di quanto sembri da quelle del primo. Nel dibattito questo cenno è
stato poi sviluppato da diversi interventi, sicché lo si ritrova, correttamente,
nella sintesi proposta da Riccardo Apolloni e qui pubblicata più avanti. Nel
testo non ho ritenuto di dover inserire questo confronto perché ha un marcato carattere tecnico.
177 La tavola rotonda conclusiva è stata coordinata da Rossella Cocchi e ha
visto un ampio dibattito a seguito della sintesi proposta da Riccardo Apolloni. Di questo dibattito riportiamo solo due interventi ampi e strutturati.
178 Per esigenze organizzative Francesco Dipalo a Leonessa ha tenuto le
sue relazioni prima di Mario Trombino. La sequenza storica non si è quindi
potuta rispettare nel suo ordine cronologico.
179 Come ha ben mostrato Alberto Giovanni Biuso, e personalmente mi ha
convinto in modo definitivo, in Nomadismo e benedizione: Ciò che bisogna
sapere prima di leggere Nietzsche, Di Girolamo Editore, Trapani 2006.
180 Cfr. F. Nietzsche, La nascita della tragedia, Laterza, Roma-Bari 1978,
cap. XI, p. 106.
181 Preferisco chiamare così quegli scienziati che hanno a cuore i problemi
ultimi, almeno quanto i filosofi.
182 Heisenberg ha scritto un buon libro sui rapporti fra pensiero e scienza
che può essere una serena introduzione alla storia del pensiero filosofico
vista dalla prospettiva ‘scientifica’. Il libro è: W. Heisenberg, Fisica e filosofia,
Il Saggiatore, Milano 2008.
196