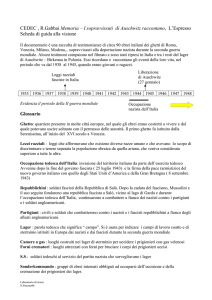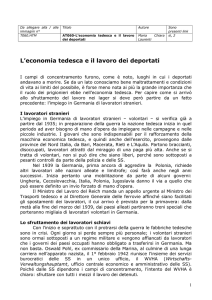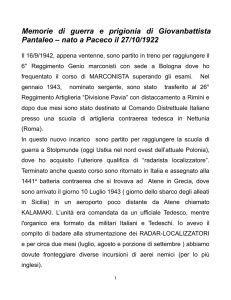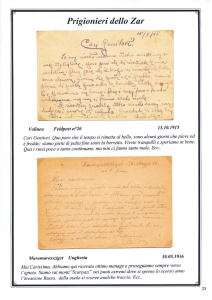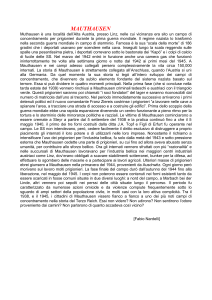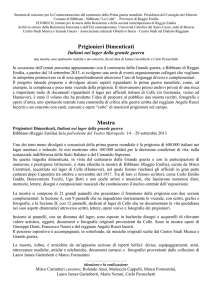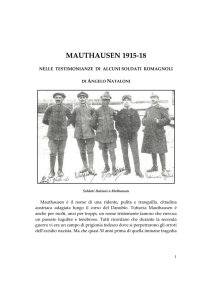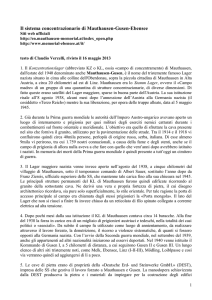Enzo Zatta
LA STAFFETTA
Delfina Borgato
ex deportata a Mauthausen
2
In copertina:
Incisione di una deportata polacca nel lager
di Ravensbrück, eseguita il 25 dicembre 1944,
giorno del suo compleanno e regalata a
Maria Zonta, operaia alla Viscosa di Padova:
rappresenta delle deportate in marcia nel
bosco di Fürstenberg-Havel.
o Stampa giugno 1995 a cura
del Comune di Saonara (Pd)
o Aggiornato a febbraio 2010
Graphic supporter: Roberto Cavazzin
[email protected]
3
PRESENTAZIONE
“E' stata l'esperienza dei lager a costringermi a scrivere: non ho
avuto da combattere con la pigrizia, i problemi di stile sembravano ridicoli
...... mi pareva, questo libro, di averlo già in testa tutto pronto, di doverlo
solo lasciare uscire e scendere sulla carta .
Una mia amica, che era stata deportata giovanissima al lager
femminile di Ravensbück, dice che il campo è stata la sua Università: io
credo di poter dire altrettanto, e cioè che vivendo e poi scrivendo e
meditando quegli avvenimenti, ho imparato molte cose sugli uomini e sul
mondo”.
( Primo Levi )
Ho voluto lasciare alle parole di un grande narratore,
deportato nei campi di concentramento, l'introduzione al
commento di questo piccolo, ma intenso libro, al quale
l'Amministrazione di Saonara ha con sincero piacere concesso il
patrocinio. Le testimonianze della quotidiana follia vissuta in
tutta Europa durante l'oppressione nazista, stanno ancora oggi
completando un immenso mosaico, cui si unisce questo tassello,
che vede protagonisti la nostra gente, la nostra terra. E quando il
racconto si fa straziante esperienza di vita, l'animo di chi legge
non può restare impassibile, perché i luoghi e i volti sono
conosciuti e fanno parte sì della storia universale, ma anche
della nostra storia personale. Ringrazio tutti i promotori di
questa significativa pubblicazione, degna appendice delle
celebrazioni per il cinquantenario della lotta di Liberazione:
leggendolo potremo anche noi imparare molte cose sugli uomini
e sul mondo.
Il Sindaco di Saonara
( Fabio Amato)
4
INTRODUZIONE
Scrivere una pagina di storia sulla Resistenza
attraverso la testimonianza di una donna, allora
sedicenne, che attivamente vi prese parte, è quanto si
prefigge questa memoria. Tuttavia, ascoltare Delfina
Borgato, questo è il nome della protagonista, rievocare
la sua sofferta storia personale, scritta con il sangue e
le oppressioni ferocemente infertale dalla violenza
fascista e nazista, è quanto di più malinconico e
struggente si possa immaginare ma, almeno, si spera
che tutto ciò faccia riflettere su quanto costò
riacquistare la libertà dalla dittatura, nonché la
riaffermazione di valori positivi indispensabili in una
società civile e democratica. La partecipazione delle
donne alla lotta di Liberazione non è stato solo un
prezioso e mero contributo sotto il profilo politico,
sociale e umano, ma una condizione indispensabile per
la vittoria stessa della Resistenza. La Resistenza, ossia
l’opposizione attiva della popolazione oppressa, si
sviluppò nel nostro Paese, durante la Seconda guerra
mondiale, su due fronti: contro l’invasione germanica,
da una parte, e contro la dittatura fascista, dall’altra. In
quest’ambito hanno assunto notevole rilevanza gli
episodi e le azioni organizzate da donne, senza
riscontro alcuno nel passato. Per lo più giovani, non
5
sempre appartenenti a gruppi o comitati clandestini
organizzati, spinte soprattutto da ideali di solidarietà, di
carità nonché di avversione e giusto sdegno per gli
oppressori, dimostravano un sempre più crescente
atteggiamento antifascista e antinazista che, il più delle
volte, le rese valorose e anonime militanti. Non
mancavano, inoltre, manifestazioni di solidarietà
spontanea e istintiva da gran parte della popolazione,
desiderosa di collaborare con gli alleati affinché la
guerra finisse al più presto. Nel Veneto le partigiane
attive, appartenenti alle varie brigate, furono più di
seicento e il prezzo che gran parte di loro pagò fu
durissimo in termini di sofferenze fisiche e psichiche,
quali gli interrogatori, le umiliazioni, le sevizie, il
carcere, la lontananza da casa e, per molte, la
deportazione nei lager, la detenzione in campi di
lavoro, la tortura ed anche la morte. Dagli oltre mille
campi di concentramento - i più famigerati dei quali
furono Auschwitz1, Treblinka, Dachau, Mauthausen,
Ravensbrück, Bergen Belsen - veri lager, il novanta per
cento dei primi internati non fece ritorno2. Alcuni dei
superstiti3, più di altri segnati dalla atroce esperienza, a
guerra finita sentirono la necessità di raccontare, di
scrivere le proprie memorie per far giustamente
1
Il lager di Auschwitz fu liberato il 27 gennaio 1945 dall’esercito russo. Dal 2001 lo Stato
italiano ed altri Paesi europei hanno decretato questa data “Giorno della memoria”.
2
La più grande strage dell’umanità mai avvenuta, che impropriamente viene definita “Olocausto”.
3
Si suggerisce la lettura di “Se questo è un uomo”, ed. Einaudi, di Primo Levi.
6
conoscere la verità. Tuttavia gran parte di loro, ancora
prigionieri di quei ricordi, rimasero in silenzio per
l’intera vita, evitando di parlare persino ai propri
familiari dei patimenti e delle crudeltà subite. La
Resistenza in Italia prese le mosse all’indomani
dell’arresto di Mussolini (il 24 luglio 1943 su ordine di
Vittorio Emanuele III) e della nomina del Maresciallo
Pietro Badoglio capo del Governo, il quale, nonostante
le trattative segrete in corso con gli anglo-americani
per giungere ad un armistizio, commise il gravissimo
errore di dichiarare alla radio che la guerra a fianco dei
tedeschi sarebbe continuata. Gli Anglo-Americani,
non fidandosi della improvvisa quanto equivoca
“conversione” italiana, continuarono a bombardare le
città italiane, causando altre migliaia di morti
soprattutto tra la popolazione inerme.
L' 8 settembre 1943 (l’armistizio in realtà fu firmato in
Sicilia a Cassibile il 3 settembre), Badoglio commise il
secondo grave errore quello cioè, dopo l’annuncio
dell’avvenuto armistizio, di lasciare le truppe italiane
senza ordini precisi e senza un adeguato
coordinamento strategico-militare, di fuggire assieme
al re Vittorio Emanuele, a Brindisi sotto la protezione
degli americani. Fu il caos: sfascio dell’esercito
italiano; prigionieri alleati e soldati italiani allo sbando;
deportazioni da parte dei tedeschi di militari italiani nei
campi di concentramento in Germania; tremendi
7
eccidi4 militari e civili. A Saonara, un piccolo paese in
provincia di Padova, dove oltre cento prigionieri, per lo
più inglesi-sudafricani, lavoravano alle dipendenze dei
fratelli Sgaravatti, la solidarietà degli abitanti nei
confronti di questi giovani militari, finalmente liberi
ma in preda allo smarrimento, braccati dalle brigate
nere e dai tedeschi, non si fece attendere. Molti di essi
si nascosero, per qualche tempo, nelle vicine campagne
e la loro sorte sarebbe stata ben presto segnata se la
popolazione non li avesse aiutati, nascondendoli nei
fienili e nelle stalle, dividendo con loro il poco cibo a
disposizione. Saonara era anche il paese dove Delfina
Borgato, primogenita di dieci fratelli, abitava con la
sua famiglia, in una casa in aperta campagna di
proprietà degli Sgaravatti. La sua, come tante altre, era
una famiglia patriarcale di umili origini contadine dai
sani e onesti principi morali. Era composta dai genitori
di Delfina, da una sorella e otto fratelli, dai nonni
paterni e dalla zia Maria, sorella del padre di Delfina.
enzo zatta
4
Il massacro di Cefalonia comportò oltre 8.000 vittime.
8
Cenni storico-introduttivi.
Erano militari inglesi sudafricani e neozelandesi, i
prigionieri catturati durante la Campagna d’Africa, tra
il 1940 e il 1941, dall’esercito italo-tedesco, che
lavoravano nei campi di proprietà della famiglia
Sgaravatti. Custoditi e sorvegliati da soldati italiani
nella “boaria” dell'attuale via 28 aprile, classificato
come campo di concentramento “C-120”, erano trattati
bene e nessuno di loro cercò mai di fuggire.
Nonostante vivessero isolati dal resto del paese,
riuscivano ugualmente ad avere sporadici contatti con
gli abitanti di Saonara, duranti i quali scambiavano
sigarette, cioccolata ed altro, con piccoli lavori di
cucito o derrate alimentari. Gli anziani del paese li
ricordano di passaggio negli spostamenti da una coltura
all’altra o a lavorare nei vivai, tra le piante da curare e
da potare, sotto il vigile controllo dei soldati. Con
l'armistizio, tutti i prigionieri della tenuta Sgaravatti
fuggirono e si sparpagliarono, dapprima per il paese,
poi tentarono la fuga via mare verso la Iugoslavia e
successivamente cercarono di raggiungere la Svizzera.
Molti però rimasero nascosti nei fienili, nel bosco di
villa Cittadella-Vigodarzere-Valmarana o sistemati
nelle cantine delle case, sostenuti ed aiutati da famiglie
saonaresi e del piovese. I tedeschi si misero ben presto
alla caccia di questi fuggiaschi, senza tuttavia
9
catturarne alcuno, per cui favoriti da spie
collaborazioniste fasciste, si vendicarono arrestando
coloro che presumevano avessero dato loro
accoglienza e assistenza. Il 13 marzo del '44 ci furono i
primi arresti. L’accusa: favoritismo al nemico angloamericano. Tra questi c'erano Delfina Borgato di sedici
anni, il padre Giovanni e la zia Maria di 45 anni.
I Lager - fabbriche di morte
Durante la Seconda guerra furono gravemente infranti
gli accordi internazionali da quasi tutti i paesi coinvolti
nel conflitto, in particolare, nei lager tedeschi,fu
violato il trattato sui diritti dei prigionieri di guerra e
degli internati civili. I KL5 dislocati in Germania, in
Austria, in Polonia..., si contavano a centinaia ed erano
tutti luoghi di maltrattamento e di umiliazione. Campi
muniti di torrette armate, recintati da filo spinato carico
di alta tensione, erano sorvegliati da guardie-aguzzini.
La fuga da questi luoghi, salvo qualche rarissima
eccezione, era impensabile ed impossibile.
Furono milioni coloro che trovarono la morte nei
campi di sterminio, in gran parte ebrei. A stenderli per
5
Konzentrationslager: campi di sterminio e annientamento di massa come Auschwitz o Dachau,
Bergen Belsen nonché campi di sperimentazione su uomini e donne come Ravensbrück.
Da non confondere con i campi di internamento per deportati obbligati a lavorare nelle
fabbriche belliche tedesche o i campi di concentramento italiani, attivi fino all’8 settembre
‘43, per prigionieri alleati. Il totale dei campi di sterminio, di concentramento e di lavoro del
Terzo Reich, disseminati in Europa dal 1933 al 1945, fu di oltre 1800.
10
terra, la catena umana risulterebbe lunga oltre
quindicimila chilometri. Dopo l’arresto di Mussolini, il
25 luglio del '43, e soprattutto dopo l'Armistizio, l'Italia
si trovò coinvolta in un dramma spaventoso. Gli
italiani si resero colpevoli, secondo i tedeschi, di
tradimento. Per l’Italia, invece, l’armistizio fu la sola
via di uscita da una guerra ormai fallita. Per l’esercito
tedesco, dopo l’abbandono del Re e di Badoglio, fu
gioco facile sopraffare, catturare e deportare in
Germania un terzo del nostro esercito sparso in mezza
Europa. Oltre 615.000 furono i militari italiani6 che, a
fronte della opzione di combattere a fianco dei
tedeschi, scelsero di non collaborare e quindi l’ignara
via dei lager e dei campi di concentramento. Più di 32
mila non fecero ritorno da questi luoghi di sterminio,
altri vennero massacrati da ex camerati, altri ancora
finirono fucilati all’istante dai tedeschi. Ad innescare la
miccia della Resistenza furono anche queste
deportazioni, oltre alla necessità di liberarsi dell’odiato
nemico tedesco. I soldati italiani, catturati dai tedeschi
dopo l’8 settembre e spediti in carri bestiame piombati
in Germania, subirono un trattamento peggiore dei
soldati di altre nazioni, in quanto ritenuti dai tedeschi
rei di tradimento. Per non contrastare le convenzioni di
Ginevra, il Terzo Reich declassò i soldati di tutte le
nazionalità deportati da prigionieri di guerra a
6
IMI Internati Militari Italiani.
11
“internati militari”. Questo nuovo stato giuridico fu
creato artificiosamente dai tedeschi per eludere le
norme della convenzione, le quali garantivano ai
prigionieri di guerra un trattamento umano e dignitoso
tra cui il diritto di sottrarsi al lavoro7 coattivo, cioè
imposto contro la propria volontà. Il primo rito nazista,
che si svolgeva nei lager di prima categoria, era
l'immatricolazione dell'individuo, cui seguiva la
requisizione di qualunque oggetto e indumento, la
presa delle impronte digitali e la foto segnaletica8.
L'essere umano, nudo anche del nome, veniva fatto
passare sotto la doccia, ora gelata, ora bollente, quindi
poteva rivestirsi con luridi indumenti appartenuti ad
altri internati passati a miglior vita. I più fortunati
venivano inviati nei campi di lavoro, trattati come
schiavi e, al pari di animali da soma, subivano
malvagità e barbarie indescrivibili. E’ successo che
molti internati sopravvissuti per mesi alla fame, alle
malattie, alle torture, siano finiti ugualmente nelle
camere a gas o nelle fosse comuni da loro stessi
scavate, affinché di essi non rimanesse traccia. Altri
ancora, in particolare gli ebrei9, entravano nei forni
crematori lo stesso giorno di arrivo o entro pochi
giorni. Purtroppo, ancora oggi, nonostante tante vite si
7
Furono migliaia i soldati italiani catturati dai tedeschi dopo l’8 settembre costretti a lavorare,
in condizioni spesso disumane, nelle fabbriche belliche tedesche.
8
Agli ebrei veniva contrassegnato sul braccio sinistro il numero progressivo di arrivo.
9
La Shoah, cioè lo sterminio ebraico perpetrato dalla Germania nazista.
12
siano sacrificate in nome della libertà, dell'uguaglianza
e del rispetto alla vita umana e sia trascorso oltre
mezzo secolo, la storia si ripete ogni giorno in altre
parti del mondo sotto gli occhi di tutti. L'uomo
malvagio, egoista, senza scrupoli e assetato di potere, è
sopravvissuto e continua imperterrito a creare disastri.
Per contrastarlo, non solo bisogna dar voce alla
memoria, quale espressione di libertà e di democrazia,
ma è necessario compiere un ulteriore passo,
impegnandosi personalmente con ogni mezzo affinché
tutto ciò non abbia a ripetersi mai più.
Ravensbrück è una località della Germania a ottanta
chilometri da Berlino, tristemente conosciuta perché è
stata sede di un campo di concentramento nazista
principalmente per donne. Costruito nel 1939 ospitò
circa 130 mila prigioniere, 92.700 delle quali perirono.
Le detenute erano sottoposte a lavoro coatto, in
condizioni penose tanto nutritive quanto igieniche e,
quando si ammalavano, venivano eliminate. Il campo,
però, deve la sua fama sinistra soprattutto agli
“esperimenti biologici” che si attuarono sulle persone
tra il 1942 e il 1943. Ma chi erano queste donne?
Dapprima al campo erano destinate le avversarie del
regime, uccise e buttate nelle fosse comuni scavate da
detenuti comuni privi di scrupoli, poi in massa le
13
francesi, strappate alle file della Resistenza, poi le
migliaia di ebree, le russe, le polacche e... le italiane.
A Ravensbrück la sveglia suonava alle quattro e trenta
del mattino e dopo l'estenuante appello, che durava un
paio d’ore, le prigioniere si incamminavano al lavoro
attraversando un lugubre bosco di conifere, con una
coperta sul capo, in fila per cinque, verso la fabbrica
che, prima del conflitto, produceva dischi per
grammofoni e, in seguito, fu convertita per la
produzione di componenti per aeroplani. Qui, dopo una
breve sosta a mezzogiorno per mangiare una gavetta di
brodaglia e una fetta di pane nero, lavoravano fino alle
sei di sera, quindi, ritornavano stanche e affamate al
campo. Non vestivano calze e portavano ai piedi
pesanti zoccoli o sandali. Passavano mesi tra un
cambio di biancheria e l'altro. Dormivano in sudici
pagliericci dividendo una coperta in tre e si lavavano di
rado; qualche volta attingevano di nascosto, con la
gavetta, l’acqua dagli abbeveratoi dei cavalli. Chi
tentava la fuga veniva frustato con 25 nerbate; ciò
significava debilitare ulteriormente il fisico e favorire
l'insorgere di malattie che costituivano l'anticamera del
forno crematorio. Donne contro donne e, fra le tante,
c'era Dorothea Binz: la malvagità in persona! Era
entrata nel lager a 19 anni come cuoca ed era diventata
“aufseherin” (ispettrice). Il suo frustino e i suoi stivali
rappresentavano il terrore delle prigioniere. Nel 1947 i
14
tedeschi di questo campo furono processati per le loro
barbarie. Allora Binz aveva 27 anni, finì impiccata nel
carcere di Hamelin. Quanti deportati riuscirono a
tornare vivi dall'inferno dei campi di sterminio? Ben
pochi rispetto ai milioni di uomini, donne e bambini
che vi erano entrati. Quando i soldati degli eserciti
avversari riuscirono a penetrare, nella ormai lontana
primavera del '45, nei lager abbandonati dagli aguzzini
in fuga, lo spettacolo che si presentò ai loro occhi fu
superiore ad ogni, sia pur pazzesca, previsione. Là
giacevano file interminabili di cadaveri. Là si
aggiravano pallidi spettri di detenuti ancora in vita, dai
grandi occhi pieni di una paura senza fine.... Allora,
solo allora, si cominciò a conoscere i particolari
dell'inaudita macchina da sterminio. A guerra finita, a
Norimberga, dal 20 novembre 1945 al 31 agosto ‘46,
vennero processati e condannati all'impiccagione
dodici degli oltre mille principali responsabili della
follia nazista. Di certo la giustizia umana fu fin troppo
magnanima con i responsabili di tante atrocità, tuttavia
i tanti crimini di guerra, nazisti e non nazisti,
commessi, non potranno mai essere cancellati dalla
storia dell'umanità. Ciò che rimane viva è la speranza
in un mondo migliore, come scrisse Anna Frank pochi
giorni prima di essere deportata ad Auschwitz:
“Quando guardo il cielo, penso che un giorno il bene
dovrà tornare tra gli uomini”.
15
CAPITOLO UNICO
8 settembre 1943 - Saonara
Dovetti interrompere la scuola terminate le elementari,
perché in casa c'era bisogno di aiuto. Successivamente
fui mandata da un signora che abitava in paese a
imparare il mestiere di sarta. Fu durante questo
periodo che oltre cento prigionieri inglesi, che
lavoravano nei campi degli Sgaravatti furono lasciati
liberi, in attesa, allora si sperava, di un rapido
avanzamento del fronte e della fine della guerra.
Invece, dopo otto giorni dalla firma dell'armistizio,
iniziarono i rastrellamenti dei tedeschi aiutati da
fascisti italiani. Cosicché i prigionieri si diedero alla
macchia, nascondendosi nella vicina campagna,
vivendo alla meno peggio. Erano aiutati dalle famiglie
che vi abitavano poiché avevano proprio bisogno di
tutto: cibo, medicine, abiti borghesi e, con
l'avvicinarsi dell'inverno, di un rifugio dove ripararsi
dal freddo, almeno la notte. Zia Maria, spinta da
sentimenti di carità e incurante dei rischi che correva,
iniziò ad aiutare questi giovani sbandati come poteva:
si recava, nonostante zoppicasse vistosamente a causa
di una malformazione congenita, dalle famiglie
benestanti del paese a chiedere quanto potessero
16
offrire per aiutarli. All'insaputa della famiglia io
collaboravo con lei inconsapevole dei rischi che
correvo, animata anche da spirito di avventura ma
soprattutto orgogliosa di rendermi utile a persone più
grandi di me. Le cose si complicarono e diventarono
più rischiose quando sulla popolazione incombette
l'ordinanza militare tedesca, con la quale si
minacciavano di ritorsioni e pene severissime coloro
che fossero stati scoperti a collaborare col nemico.
Contemporaneamente erano iniziate le perquisizioni
nelle case sospette e, ad aggravare ulteriormente la
situazione, contribuì, nel mese di ottobre, l'istituzione
di taglie su quanti avrebbero aiutato gli ex prigionieri
e gli alleati. Ciò nonostante la nostra attività continuò
per tutto l'autunno del '43 e proseguì anche l'inverno.
La notte facevamo dormire i prigionieri nel fienile di
casa o nella stalla, mentre di giorno si nascondevano
nei campi tra le “pannocchie”. Ricordo quanto mio
padre si adirasse con Maria perché di notte gli ospiti
fumavano, col rischio di dar fuoco al fienile adiacente
la casa. Anche mia madre non dormiva sonni
tranquilli. Temeva per la sorte della famiglia. Quando,
per l’ennesima volta, chiese a Maria di smettere, la zia
le rispose: “Un giorno anche i tuoi figli potrebbero
essere in giro per il mondo e trovarsi in una
situazione simile! Non vorresti che fosse fatto per loro
quanto si fa ora per questi poveretti?”.
17
Una volta, essendo necessario far partire in gran fretta
un prigioniero che indossava ancora la divisa da
militare, quindi facilmente riconoscibile, Maria chiese
a mia madre il vestito da sposo di mio padre. Dopo
qualche insistenza la mamma glielo diede e il soldato
inglese poté ripartire. Ad ogni modo, il pericolo che ci
scoprissero e ci denunciassero ai nazifascisti era reale,
si rischiava la fucilazione ma, per niente intimorite,
continuavamo ad ospitare i prigionieri. Maria ogni
volta diceva: “sono gli ultimi”. C'erano due ospiti
fissi, i cui nomi non ricordo, poi ne arrivarono degli
altri, ed altri ancora, alternandosi non appena questi
riuscivano a partire. Venivano anche da fuori paese, in
fuga da altri campi di lavoro o da centri di raccolta di
altre località. Tra loro si passavano parola che in
fondo a una stradina, in mezzo ai campi, vicino a villa
Valmarana, c’era una casa abitata da brave persone a
cui chiedere aiuto e delle quali ci si poteva fidare. Sul
finire dell’anno, un’impiegata della Prefettura di
Padova, di nome Elsa, ci fece conoscere le sorelle
Martini: Teresa e Liliana. Esse appartenevano ad una
rete clandestina che aiutava ebrei, ex prigionieri e
soldati allo sbando, a fuggire all’estero. Della stessa
rete faceva parte anche padre Placido Cortese, un frate
della basilica di S. Antonio, direttore del Messaggero.
Era padre Placido che, tra le altre cose, si incaricava di
fornire le fotografie, prese tra gli ex voto nella
18
Basilica, da utilizzare nelle carte d’identità false da
consegnare a ricercati prossimi alla partenza per la
Svizzera: gli espatri verso la Iugoslavia erano falliti,
dopo che alcune spie si erano infiltrate nella
organizzazione, per cui la frontiera era strettamente
controllata dai tedeschi. Fu così che iniziai a tenere i
contatti con le sorelle Martini, telefonando dall'unico
apparecchio pubblico nel bar del paese, dicendo loro:
“Sono pronti due o tre polli, per quando li preparo?”.
Poi, saputo il giorno dell’appuntamento, partivamo a
piedi da Saonara, di notte, durante il coprifuoco, col
cuore che ci saltava in gola per la paura d'essere
arrestati; mia zia davanti con uno o due fuggiaschi, io
dietro, bicicletta alla mano, con altri due, verso la
stazione ferroviaria di Padova, dove eravamo attesi da
altre militanti che, fingendosi sorelle o fidanzate, li
accompagnavano in treno fino a Milano, da dove
proseguivano con altri mezzi di fortuna verso il
confine Svizzero. Alla stazione ferroviaria di Padova
arrivavano ex prigionieri e ricercati da vari comuni
della provincia, ed erano in molti a tentare l’espatrio
che rappresentava l'unica via di scampo, poiché
restare significava rischiare di essere arrestati. Nel
mese di febbraio del ‘44, vennero da fuori paese delle
brigate nere, che radunarono mio padre e mia madre,
assieme ad altri paesani, nel cortile di villa Sgaravatti
e iniziarono ad interrogarli sulla presenza di nemici
19
nel territorio, ma, soprattutto, li minacciarono di
arrestarli e bruciar loro la casa, se avessero trovato un
solo prigioniero in casa. Preoccupate dalle difficoltà e
dai problemi sempre più presenti, decidemmo di
limitare l’attività assistendo questi giovani fuori di
casa. Nella prima decade di marzo conoscemmo due
inglesi ospiti della famiglia Battan di S. Angelo di
Piove di Sacco. Una sera, all' imbrunire, mentre
tornavo dal lavoro, mi aspettarono lungo la stradina
che conduceva alla mia casa, per chiedermi se
effettivamente c'era la possibilità di essere aiutati a
fuggire all'estero. Riuscimmo, dopo alcuni contatti, ad
organizzare anche la loro fuga. Il giorno, dopo la loro
partenza, fu accompagnato a casa nostra, dalla signora
Battan un certo Franz, ex prigioniero sloveno fuggito
dopo l' 8 settembre che, a suo dire, sentendosi a
rischio di cattura, era venuto a conoscenza della
recente partenza dei due inglesi da noi aiutati a S.
Angelo prima e a Saonara poi. A casa c’era mia madre
che, ingenuamente, gli diede informazioni sufficienti
per capire che effettivamente avevamo dato asilo a
due inglesi i giorni precedenti. Franz chiese, così, se
si potevano aiutare cinque prigionieri inglesi che,
nascosti in casa Battan, non potevano rimanervi oltre,
poiché correvano il pericolo di essere scoperti. Come
d'abitudine, telefonai alle Martini per avvertire che
altri cinque “polli” erano pronti, affinché procurassero
20
loro i documenti. Mi chiesero, come al solito,
particolari sul loro aspetto, che però non seppi dare
perché non li avevo ancora conosciuti, ma le rassicurai
che presto sarei stata in grado di rispondere. Il giorno
seguente venne a casa mia Liliana Martini con alcune
foto, per scegliere quelle più somiglianti ai cinque e a
quell'incontro, purtroppo, era presente anche Franz:
l'unico ad averli visti. La sera stessa, dopo il lavoro,
mi recai in bicicletta a S. Angelo in casa Battan dove,
in una stanza al primo piano, c'erano i cinque inglesi.
Appena li vidi, rimasi subito colpita dal loro
atteggiamento: erano in piedi, quasi sull'attenti, vestiti
elegantemente e col cappello in testa. Dubitai
immediatamente che fossero veri prigionieri. Mi
rivolsi a loro in dialetto per chiedere da dove
venissero e quale fossero le loro intenzioni. Nessuno
dei cinque capì una sola parola di quello che avevo
detto, mentre, invece, i prigionieri, che fino allora
avevo conosciuto, qualche parola l’avevano sempre
capita. Franz parlò per tutti e ribadì la loro necessità di
fuggire al più presto. Gli risposi che presto sarebbero
potuti partire aggiungendosi a un gruppo di altri tre
prigionieri. Lungo la strada di ritorno ero tormentata
da molti dubbi. Col passare dei minuti mi stavo
sempre più convincendo che quelli non fossero
prigionieri inglesi, bensì spie tedesche.
21
A casa dissi a mia zia: “Se questa volta passa, è un
miracolo”. Le esposi tutti i miei dubbi e non ultimo,
quello sul loro aspetto e sul loro atteggiamento, quasi
arrogante, mentre, al contrario, gli inglesi conosciuti
fino ad allora, erano mal vestiti e, consci dei rischi che
si correvano per aiutarli, erano molto rispettosi nei
nostri confronti.
22
Maria Borgato a 41 anni
23
13 marzo ‘44 - l’arresto
Quella stessa sera c'era nell'aria una strana atmosfera:
quasi un presentimento funesto. Verso le undici
sentimmo bussare alla porta con una decisione tale da
farci sobbalzare per lo spavento. Capimmo subito che
non si trattava certamente di amici o di prigionieri
inglesi; loro venivano con tutti i riguardi e le
accortezze possibili. Persino il nostro cane abbaiava
come mai aveva fatto prima. Benché preoccupata dissi
alla zia: “Vado io ad aprire e qualora fosse Franz gli
parlerò, poiché l'ho incontrato solo io, gli dirò di
lasciare in pace il resto della famiglia”. Avevo degli
indirizzi di prigionieri già partiti, li diedi a mia madre
che li nascose tra le fasce dell'ultimo fratellino nato,
che teneva in braccio, e scesi ad aprire. La casa fu
presto invasa da fascisti e da SS: correvano su e giù
per le scale e si misero a rovistare le stanze, la
barchessa, la stalla. Non trovando alcun prigioniero
inglese, iniziarono, con atteggiamento minaccioso, a
farmi delle domande riguardanti i tre inglesi, ma io
negai qualunque circostanza. Mi ordinarono di
vestirmi e così pure a mio padre e a mia zia, ma
soprattutto di far zittire il cane che, legato alla catena,
abbaiava a più non posso. La spedizione era
comandata dal giuda Franz, il quale ci ordinò di uscire
in cortile al freddo e, dopo averci messo in fila,
24
continuò a farmi domande sui prigionieri inglesi, alle
quali rispondevo di non sapere nulla. Franz mi accusò
di mentire, in quanto mia madre, qualche giorno
prima, gli aveva detto che gli inglesi avevano dormito
nella stalla. E continuava: “Dove sono adesso, dove li
avete nascosti?”. Fu allora che iniziò a percuotermi
alla presenza di tutti gli adulti della famiglia che, pur
fremendo dalla rabbia, nulla potevano fare, poiché
reagire equivaleva ad una condanna di fucilazione. Ci
caricarono sul camion: io davanti, tra una SS e Franz,
mio padre e mia zia dietro con gli altri tedeschi. Franz,
rifilandomi qualche pugno e tirandomi per i capelli,
insisteva nel farmi domande sui prigionieri, alle quali
rispondevo sempre allo stesso modo: “Non so dove
siano, io li ho incontrati per i campi e in casa non
sono mai entrati”. Ero sicura che se avessi confessato
di aver dato ospitalità anche a un solo prigioniero, mi
avrebbero costretta ad ammettere che ne avevamo
aiutati altri e, quindi, a raccontare l’intera storia,
coinvolgendo di conseguenza anche altre persone.
Perciò decisi di non parlare, ad ogni costo. Passarono
per S. Angelo di Piove di Sacco, dove arrestarono la
signora Battan e suo figlio, proseguirono per Arzarello
e qui prelevarono i fratelli Gelmini, quindi si diressero
verso la caserma dei carabinieri di Piove di Sacco.
Mio padre, mia zia e tutti gli altri furono rinchiusi in
uno stanzone, mentre a me fecero fare il giro delle
25
camerate, dalle quali dei giovani fascisti mi coprirono
di insulti e, uno di loro vedendomi, mi schernì ad alta
voce: “Sarebbe questa l'artefice di tanto putiferio?”.
Arrivata nell'ufficio del capitano delle SS, iniziarono
ad interrogarmi e a picchiarmi, con calci, pugni e a
pestarmi le dita dei piedi ma io, risoluta, continuavo a
ripetere che non sapevo nulla e che non conoscevo
nessuno. Dopo alcune ore venni rinchiusa in una cella
di isolamento per il resto della notte. La mattina
seguente, vennero altri fascisti a vedermi per
schernirmi; per tutta risposta girai loro le spalle senza
rispondere alle provocazioni. Decisero di tenermi
isolata dagli altri reclusi, convinti che, essendo la più
giovane, cedessi e raccontassi ciò che era stato fatto
fino ad allora. Ripetutamente mi chiesero a quale
organizzazione appartenessi, come si tenessero i
collegamenti e chi ne facesse parte. Da come mi
ponevano le domande, capii che sapevano molte più
cose di quante ne sapessi io. Evidentemente avevano
bisogno della testimonianza di qualcuno del gruppo e
anche il più piccolo particolare poteva tornare loro
utile per smascherare altre persone. Verso
mezzogiorno il fascista che piantonava il corridoio,
preso da compassione, mi offrì la sua parte di rancio,
raccomandandomi però di non farmi scoprire. Non
feci in tempo ad accettare che entrarono quelli che la
sera precedente ci avevano arrestati, per portarci a fare
26
un altro viaggio: destinazione Padova, via Galilei, in
una casa antica, dove abitavano le sorelle Martini. Lì
trovammo solo Teresa: Liliana era andata in stazione
ad accompagnare sua madre che doveva raggiungere
la località a lei assegnata come sfollata. Teresa non
capì subito che le persone con le quali mi presentai
erano fascisti e, quasi sorpresa, mi chiese: “Delfi,
come mai qui a quest' ora? Non dovevamo vederci
domani?”. Con gli occhi le feci cenno di non parlare
ma Franz e gli altri non si persero d'animo e, con
maniere brusche, vollero sapere dov'era Liliana.
Immediatamente mandarono qualcuno in stazione a
verificare se Teresa avesse detto la verità. Quel giorno
sfuggì alla cattura un'altro dei dodici figli dei Martini,
Lidia di vent'anni; fortunatamente si trovava a Milano
per un “trasferimento”. In casa Martini viveva a
pensione Milena Zambon, un’impiegata della Banca
d’Italia; fu arrestata anche lei. Da Padova, in camion,
ci trasferirono tutti a Venezia dove giungemmo
all’imbrunire. Durante il viaggio, benché sorvegliati a
vista, feci in tempo a bisbigliare a mio padre che
dicesse di non sapere nulla dell'attività mia e della zia.
Arrivati a Venezia, in piazzale Roma, ci
incamminammo in fila per due, sorvegliati dai
tedeschi attraverso le calli tra gli sguardi incuriositi
della gente. Attraversammo piazza s. Marco ed
entrammo nel carcere di S. Maria Maggiore: gli
27
uomini da una parte, le donne da un'altra. Ci accolse
una donna alta, magra, vestita di nero, con le chiavi
alla cintola: sembrava donna Lucia del Carducci nella
poesia “Davanti S. Guido”. Attraversate quattro o
cinque porte chiuse a più mandate, arrivammo
all'ufficio matricole: qui ci presero le impronte
digitali, ci tolsero i lacci, la cintura, gli orecchini e ci
condussero in cella. La prima sera mi rinchiusero
assieme ad altre quattro donne detenute per reati
comuni e con una signora di cognome Raimondi, di
Piove di Sacco, che pianse tutta la notte, così una
delle detenute le disse: “Piangi pure oggi, ma domani
ti abituerai, come ci si abitua a tutte le situazioni,
anche le peggiori”. La mattina seguente ci divisero:
io in una cella di isolamento - la numero dieci - le altre
in celle comuni. I giorni che seguirono ad
interrogarmi, usando le maniere forti, furono sempre
Franz e uno delle SS. Volavano calci e schiaffi con
una tale violenza da farmi sbattere la testa contro il
muro. Pretendevano che facessi i nomi degli
appartenenti all'organizzazione e confessassi che, in
casa nostra, si dava alloggio ai prigionieri inglesi. Se
avessi ceduto avrei distrutto la mia famiglia, perciò,
ostinata e determinata, sostenni che gli incontri
avvenivano fuori, casualmente, lontano dall'abitato. Il
vile spione Franz, buon conoscitore del nostro
dialetto, insisteva nell'affermare che gli inglesi
28
avevano dormito a casa nostra e voleva sapere quante
volte e che fine avessero fatto. Mi faceva tante altre
domande alle quali non intendevo rispondere, conscia
del fatto che la colpa sarebbe ricaduta su mio padre,
unico sostegno della famiglia. Forse si accanivano
tanto su di me perché mi ritenevano l'anello più debole
della catena o depositaria di chissà quali segreti. Un
giorno, dopo la solita razione di botte e le solite
domande senza risposta, Franz, perduta la pazienza,
diede ordine alla carceriera di riportarmi in cella e di
lasciarmi senza mangiare per tre giorni. Furono ore
interminabili, sempre sola, durante le quali non udii
alcun scuotimento di chiavi, nessuna offerta di cibo.
Così il tempo passava e l'isolamento, che ormai
durava da un mese, mi pesava molto: la cella dai muri
spessi era umida e angusta. C’era una grande finestra,
che prendeva luce da una apertura a bocca di lupo, una
branda in ferro attaccata al muro e, sul pavimento, un
buco munito di sportello in ferro, che conteneva il
secchio per i bisogni. Passavo gran parte del tempo
pregando e camminando su e giù, dalla finestra alla
porta e viceversa, in attesa di quei due schifosissimi
pasti: unico privilegio, perché minorenne, un caffè di
orzo la mattina. Compii diciassette anni in quella
lurida cella e, a parte i fascisti, non parlavo e non
vedevo mai nessuno. Trovavo conforto nella preghiera
e nella grande fede che ho sempre avuto in Gesù
29
Cristo. Fu senz’altro questo il periodo più triste della
mia vita. Dopo oltre un mese, forse stanchi di
interrogarmi, i tedeschi mi sottoposero il verbale per
la firma, che però rifiutai, perché scritto in lingua
tedesca. La SS si arrabbiò moltissimo, ma dovette far
riscrivere tutto il testo in italiano. Firmai, convinta che
il peggio fosse passato e ci rimandassero tutti a casa.
Ma non fu così: seguirono altri giorni di isolamento e
altre sofferenze. Un dì venne il cappellano del carcere
a confessarmi. Durante il breve incontro lo pregai di
riferire a mio padre, chiuso nello stesso carcere, di non
lasciarsi coinvolgere e che continuasse a dire di non
sapere nulla di quanto facevo fuori casa. Questi,
dapprima, rifiutò per paura di essere scoperto poi, su
mia insistenza, accettò. Verso la metà del periodo di
isolamento, mi fece compagnia per qualche giorno una
donna che, spacciandosi per prigioniera, mi chiedeva
con troppa insistenza perché mi trovassi in carcere e
che cosa avessi fatto di così grave da meritarmi un
simile trattamento. Mi consigliava di parlare, di dire
tutta la verità, poiché conosceva un comandante
fascista che poi mi avrebbe fatto uscire.
Capii subito che era della stessa pasta di Franz, così le
risposi: “Se sei tanto amica di un comandante, perché
non fa uscire anche te da qui?”. Questa presunta
prigioniera passò anche nelle altre celle, dove riuscì
sicuramente a sapere ciò che le interessava. Fatto sta
30
che mi richiamarono per l'ennesimo interrogatorio al
termine del quale mi dissero: “Avevamo deciso di
mandarti a casa, ma, visto che non hai collaborato,
per punizione ti mandiamo in Germania”.
Probabilmente a casa non sarei tornata ugualmente!
L'unica buona notizia la ebbi da mia madre il giorno
che le permisero di farmi visita: dopo circa quaranta
giorni dall'arresto, mio padre era stato liberato e poté
tornare a casa dagli altri nove figli. Quel pomeriggio
del quattro maggio, infatti, le avevano concesso di
farmi visita e di portarmi un pacco con qualcosa da
mangiare e da vestire. Continuavo ad essere
fermamente decisa a non parlare, per non vanificare i
tanti sacrifici fatti da tutti e anche per non darla vinta a
persone tanto malvagie e prepotenti. Mi consolavo
pensando ai tanti giovani aiutati: più di trenta, tra
settembre e ottobre, e un paio di dozzine fino a marzo.
Il mio atteggiamento nei confronti degli aguzzini
doveva averli indispettiti parecchio, poiché non c’era
occasione in cui non mi facessero dei dispetti: rinvio
del colloquio, sospensione del pacco o di qualcosa da
leggere, o assistere alla messa sulla soglia della porta.
Anche durante l'ora d'aria, in uno stretto corridoio
all'aperto, ero da sola, così decisi di rinunciarvi.
31
27 luglio ‘44 -Partenza per Bolzano
Una mattina ci avvertirono di tenerci pronti perché
presto saremmo partiti per una destinazione ignota. Da
Venezia partimmo in treno, con me c'erano: zia Maria,
che finalmente rividi dopo quattro mesi, le sorelle
Martini, la Battan, la Zonta, la Raimondi col marito e
il figlio, la Zambon, Erika e Gabri di Gorizia, altre due
donne di Piove di Sacco che non conoscevo ed alcuni
prigionieri uomini. Quando il treno passò per la
stazione di Padova, gettammo dal finestrino dei
biglietti indirizzati alle nostre famiglie, nella speranza
che qualcuno li facesse giungere a destinazione.
Arrivammo a Bolzano assieme a centinaia di
prigionieri provenienti da altre città e ci rinchiusero
nelle carceri locali, ancora più schifose di quelle
veneziane: lì, cimici, pidocchi e scarafaggi erano di
casa. Dopo una settimana, selezionarono tra i più
giovani quelli che avrebbero dovuto partire per la
Germania. Zia Maria era avvilita perché mi inserirono
nell'elenco di quelli in partenza. Supplicò un militare
tedesco di farmi restare. Un prigioniero, che
conosceva il tedesco, ci tradusse ciò che le aveva
risposto: “Per ciò che ha fatto, merita di partire”. Fu
la prima volta che vidi zia Maria disperarsi, non tanto
per la sua sorte, quanto per la mia. Fu anche l'ultimo
32
giorno che la vidi. Ci fecero firmare un registro e,
insieme ad altre compagne di sventura, tra le quali una
giovane quindicenne di Castel Cerino di nome
Pasquina Chiarotto. Rinchiuse in un carro bestiame
facente parte di un convoglio che trasportava centinaia
di uomini e donne, partimmo con destinazione
Mauthausen. Zia Maria, la signora Zonta e la signora
Raimondi col marito e il figlio, furono
successivamente deportati in un campo di
concentramento in Germania chiamato Ravensbrück il
7 ottobre 1944. Un viaggio così lungo non lo avevo
mai fatto e ne avrei fatto volentieri a meno, di certo
non mi accorsi quanto erano belle le nostre montagne.
Ricordo solo di essere stata rinchiusa per giorni in
quel carro come un animale, con la puzza di
escrementi e la fame che non mi dava tregua. Il mio
più grande tormento era però il pensiero che a casa
non sarei più tornata.
Mauthausen - Lager 39
Arrivammo nella cittadina di Mauthausen poco prima
di mezzanotte. Ad attenderci c'erano le SS che, con in
mano la frusta, colpivano dove capitava. Così,
incolonnati come bestie verso il macello,
percorremmo una strada in salita, recintata da filo
spinato che portava (noi non lo sapevamo) al campo di
33
sterminio. Lungo il percorso alcune donne tedesche ci
sputavano addosso, chiamandoci traditori e amici di
Badoglio.
Mi sembrava di vivere un incubo! Oltrepassammo il
portone del campo di concentramento sul quale c'era
la scritta, crudelmente ironica: “Arbeit Macht Frei” il lavoro rende liberi-. Restammo nel cortile, in piedi,
per tutta la notte. L'angoscia e lo sgomento ci
facevano tremare come foglie al vento. Eravamo
ammutoliti dallo spavento. “Da qui” - pensai - “Non si
esce vivi”. La mattina seguente, dopo aver firmato su
un registro, ci ordinarono di spogliarci e di fare un
fagotto di tutto il vestiario perché si doveva andare
alla disinfestazione. Dopo una doccia di gruppo con
acqua gelata, passammo in un altro stanzone dove
rimanemmo lì, in piedi, intirizziti dal freddo fino alle
ossa, come nostra madre ci aveva fatto, per
ventiquattro ore. Ci restituirono quindi il nostro
fagotto di vestiti e a me toccò un paio di zoccoli di
misura più grande.
34
Delfina Borgato a Mauthausen
Nel frattempo ci assegnarono delle baracche dalle cui
finestre vedevamo passare dei prigionieri, in fila come
35
delle processionarie, che sembravano scheletri viventi.
Erano rasati in capo e indossavano la nostra stessa
divisa: si diceva che stessero lavorando a un'arma
segreta. Ancora una volta meditai: “Questa è la sorte
che toccherà anche a noi”. Il giorno seguente ci
diedero qualcosa da mangiare e facemmo la visita
medica che consisteva nella rasatura di peli e capelli.
<< I prigionieri del campo erano divisi per categorie e
contraddistinti da un numero e da un triangolo
colorato a seconda dell’appartenenza cucito sulla parte
sinistra della divisa a strisce: nero per gli zingari,
verde per i criminali comuni, rosa per gli omosessuali,
rosso per i politici, la stella di Davide per gli ebrei,
viola per i testimoni di Geova. Il mio era rosso con la
punta rivolta verso il basso. I criminali detenuti che
diventavano kapò avevano un carattere molto duro,
arroganti e crudeli, dettavano legge sugli altri
prigionieri, comportandosi anche peggio delle SS.
Dovevano meritarsi il posto che occupavano e, tra i
lavori che dovevano svolgere, avevano anche il
compito di togliere la vita e poi bruciare i prigionieri.
In cambio ricevevano cibo, medicazioni e il privilegio
di dormire in una branda singola. Ogni camerata
misurava dieci metri per quindici, ospitava più di
centottanta persone (due per tavolaccio) e il cibo
consisteva in una fetta di pane nero quasi trasparente e
un mestolo di brodaglia scura due volte al giorno.
36
Ogni sei settimane c’era la doccia. Mauthausen, sorto
nel 1939, era il campo amministrativo di altri
quarantanove campi di concentramento sparsi in tutta
l’Austria ed era comandato direttamente dalle SS. Si
raccontava che il comandante del campo, il giorno in
cui suo figlio compì diciotto anni, gli regalò una
rivoltella con la quale il ragazzo uccise a sangue
freddo diciotto prigionieri. Un altro nazista, per farci
vedere che il filo spinato era attraversato dall’alta
tensione, vi scaraventò un bimbo di tre anni sotto gli
occhi della madre. Gran parte dei prigionieri maschi
lavorava nella cava sottostante il campo. Dovevano,
prima di sera, estrarre a colpi di scalpello un masso di
roccia a testa, poi ognuno col suo macigno in spalla,
risaliva la scalinata della morte. In molti cedevano
prima di sera o lungo quella lunghissima, maledetta
scalinata. Questo era Mauthausen >>. I primi giorni di
agosto, a Linz, vi fu un cruento bombardamento ad
opera di aerei alleati: una fabbrica bellica fu centrata
in pieno. Vi morirono molte persone, quasi tutti
internati, tra i quali molti italiani. Fu quindi necessario
rimpiazzarle con altri prigionieri. Dio volle che toccò
a noi partire per Linz per prendere il loro posto. Pur
consapevoli che la morte di tante persone innocenti ci
stava risparmiando dal martirio certo, si risvegliava in
noi un barlume di speranza, forse la salvezza. Era
questa una delle tante assurdità di una guerra crudele
37
ed inutile. Mentre ci apprestavamo a salire sul camion
in partenza per Linz, suonò l'ennesimo allarme.
Entrammo in un grande stanzone privo di finestre, con
delle strane docce sul soffitto: sembravano delle rose
di latta. Prese dallo sgomento del bombardamento
alcune di noi gridavano. Entrò, allora, un tedesco che
con voce minacciosa ci ordinò di smetterla, altrimenti
avrebbe aperto il gas. Una compagna di sventura,
arrivata al lager prima di noi, che conosceva la lingua
tedesca, ci spiegò: “Questa è la stanza dove vengono
gassati i prigionieri, oltre quella porta c'è il forno
crematorio dove vengono carbonizzati i loro corpi”.
Linz - lager n. 3
Giunti a Linz, ci fotografarono col numero di
matricola sul petto e ci fecero firmare un foglio, sul
quale c'era scritto: “Al minimo sbaglio, al più piccolo
atto di sabotaggio, si ritorna a Mauthausen; al
secondo tentativo di fuga c'è la fucilazione”. La vita
nel lager, se così la si poteva definire, era una
conquista quotidiana: la brodaglia nauseante, a base di
cetrioli, pomodori e patate, non bastava mai; l'igiene
personale,
soprattutto
di
noi
donne,
era
approssimativa. La temperatura di notte raggiungeva
anche i meno venticinque gradi e il pavimento era
bagnato d’acqua che, ghiacciandosi, imprigionava gli
38
zoccoli al pavimento. Sudiciume e sporcizia
favorivano il proliferare di pidocchi, cimici e malattie
che debilitavano il fisico e la mente dei prigionieri. La
situazione era talmente drammatica che, alcuni di noi
invocavano la morte come una liberazione. La lager
fùhrerin10 ci trattava con durezza, pronta a punirci
severamente ad ogni minimo sbaglio. Nella nostra
baracca vivevano circa 30 donne (alcune erano madri
e figlie), di diverse nazionalità: greche, armene,
francesi, polacche, rumene, slave, italiane e Pasquina.
Pasqui fu arrestata assieme al padre perché i tedeschi,
non trovando il fratello che faceva il partigiano sui
colli veronesi, si vendicarono deportando loro due. Io
e Pasqui eravamo diventate inseparabili e ci
aiutavamo a vicenda. Lei, dal carattere più timoroso,
non faceva un passo senza di me e quel niente che
avevamo ce lo dividevamo: un pezzo di sapone,
qualche cencio stralavato e soprattutto la paura di
morire sotto le bombe. Insieme affrontavamo anche le
crisi di nervi alle quali Erika, la ragazza slava
incontrata a Venezia, andava spesso soggetta. Nella
fabbrica dove lavoravano circa duecento persone, in
gran parte internati, si facevano turni di dodici ore al
giorno; il sonno non ci dava tregua e c'era sempre il
pericolo di finire sotto un macchinario. Il meister
(maestro) era un brav’uomo: un giorno, vedendomi
10
Comandante delle baracche.
39
esausta per la febbre e la stanchezza, mi sostituì al
trapano per un po'. Un'altra volta, quando rischiai di
finire con una treccia sotto il trapano, mi procurò una
retina per raccogliere i capelli. Era pesante sostenere
quel ritmo e, a volte, di proposito, rompevo la punta
del trapano così, in attesa che venisse sostituita,
Pasqui ed io potevamo riposarci qualche minuto.
C'erano anche momenti o situazioni che mi
esasperavano e allora rispondevo ai capi per le rime in
dialetto veneto. Pasqui in lacrime mi supplicava:
“Taci, taci, per carità lascia perdere perché questi a
casa non ci mandano più”. Ma, quando si è giovani, si
è anche incoscienti e alle conseguenze, spesso, non ci
si pensa. Ma c'era di peggio! I continui e improvvisi
bombardamenti di notte e di giorno, che ci
costringevano a precipitose fughe nei rifugi con il
conseguente salto del pasto, mettevano a dura prova lo
stato psichico, già duramente provato. Se alzavo lo
sguardo verso l'alto, era per veder passare squadre di
aerei che minacciosi oscuravano il cielo, altre volte il
tramonto infuocato dopo un bombardamento. Quando
suonava l'allarme, mentre eravamo al lavoro,
scappavamo fuori e poco lontano, scesi tre gradini, ci
riparavamo dietro un muro che nulla avrebbe potuto
contro una bomba. La domenica non si lavorava e,
quindi, non si mangiava. Si andava allora in città alla
ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti o,
40
semplicemente, a trovare riparo nella galleria-rifugio.
A volte non c'era posto per tutti e allora, noi internati,
venivamo spinti dai cittadini tedeschi in fondo alla
galleria ancora in costruzione, dove si era
maggiormente esposti alle schegge delle bombe.
Durante una di queste uscite domenicali, il venti
agosto 1944, incontrammo, vicino al Duomo di Linz, i
due padovani che avevamo conosciuto al campo di
smistamento 39, anch’essi deportati per motivi
politici. Uno si chiamava Andrea Redetti, un’amicizia
che si consolidò e ci permise di affrontare con più
ottimismo il dramma che stavamo vivendo; la
malinconia, le umiliazioni e la nostalgia di casa ci
pesavano meno. Noi internati eravamo legati da un
forte sentimento di amicizia vera che ci legava ed un
profondo senso di solidarietà; si dividevano le grandi
paure e le piccole gioie: mezza patata o un tozzo di
pane raffermo trovato sotto le macerie di qualche
abitazione appena bombardata, rendevano la giornata
meno triste. A volte si riusciva persino a scherzare e a
ridere. Il 17 settembre Liliana Martini partì per Grein
a lavorare in un'officina situata sotto il castello; venne
raggiunta, dopo nove giorni, dalla sorella Teresa e da
Gabri. Dopo tante sofferenze e tanti giorni passati
insieme a darci reciproco aiuto e conforto, ci
separammo. Veniva così a mancare il sostegno morale
che la vera amicizia può dare nel momento del
41
bisogno. Per me fu un periodo molto triste poiché non
riuscivo a trovare alcuna motivazione per la quale
valesse la pena di continuare a vivere, se non quella di
resistere per tornare dai miei cari che, sicuramente
stavano soffrendo, non sapendo nulla di me. Mi
sentivo terribilmente sola e abbandonata, in preda allo
sconforto e col terrore di finire sotto le bombe senza
rivedere i miei cari. I ricordi della mia infanzia, di
quando giocavo e correvo spensierata, sembravano
frutto della mia immaginazione, tanto era crudele e
ingiusta la realtà del presente. I bombardamenti sui
campi, sull'officina e sulla città continuavano senza
sosta, soprattutto di domenica, perché gli alleati
sapevano che non si lavorava e quindi erano persuasi
di fare meno vittime. Il 4 novembre trovarono la
morte, sotto le bombe, numerosi italiani ed altri
restarono per giorni senza baracca. L'otto novembre
arrivò la prima neve e anche la prima rara lettera da
casa che però mi fu consegnata, per punizione, dopo
otto giorni dalla lager-fùhrerin: disse di aver trovato il
mio letto in disordine durante l’ispezione mattutina. A
casa stavano tutti bene, era nata mia sorella Giovanna.
Benché fossi demoralizzata e rassegnata ad accettare
una situazione senza via di scampo, ero contenta di
sapere che mio padre stesse bene e non avesse subito
la mia stessa sorte. Una parte di me era orgogliosa per
aver resistito ai fascisti e alle SS, che tanto avevano
42
fatto per farmi “confessare”, e gratificata al pensiero
di aver potuto aiutare tanti giovani. “A volte mi chiedo
quali motivazioni mi avessero spinta a mettere a
repentaglio la tranquillità mia e della famiglia per
aiutare degli sconosciuti. Certamente fu l'esempio di
mia zia, nonché una buona dose di incoscienza, ma
soprattutto la compassione che provavo guardando gli
occhi imploranti di quei giovani nel momento del
bisogno: tutto il giorno non pensavo che a loro e a
come li avrei potuto aiutare”. Verso la fine di
novembre si rese necessaria una visita sanitaria
generale, poiché alcune di noi avevano contratto la
scabbia. La conseguenza fu: digiuno per tutti e pulizia
a fondo delle baracche. Alle acari della scabbia si
aggiungevano i pidocchi che, insinuati tra le coperte e
i vestiti, ci succhiavano il sangue. Inoltre pulci e
scarafaggi formavano un altro esercito col quale
lottare quotidianamente. A dicembre, febbre e tosse
mi costrinsero a letto. Al posto del medico venne un
poliziotto a sgridarmi e la lager fùhrerin a rispedirmi
al lavoro. La vigilia e il Natale li passai a letto, mentre
fuori si susseguivano ininterrottamente preallarmi,
allarmi e bombardamenti. Il giorno di s. Stefano,
mentre lavoravo in officina con la febbre, suonò
l'ennesimo allarme e fummo costretti ad uscire fuori al
gelo: quel giorno ci fu un fortissimo bombardamento
durante il quale una bomba cadde così vicino al nostro
43
paraschegge che ci salvammo per miracolo. Quando
gli alleati bombardavano, anche per due o tre ore di
seguito, nulla veniva risparmiato. La terra tremava in
continuazione e, come il lampo del temporale precede
il tuono, così ad ogni sibilo seguiva uno scossone.
Spesso pregavo Iddio che fosse l'ultimo ma, quasi
sempre, mi sbagliavo. Durante la prigionia
conoscemmo un ex maggiore dell’aviazione di Novara
di nome Cleto. Egli svolgeva il lavoro di lager-posttrager11. La sua posizione gli consentiva il libero
accesso al campo. Fu così che nacque tra noi una forte
simpatia: mi regalava una patata o un po' di carta per
scrivere lettere che mai sarebbero arrivate a
destinazione ma, soprattutto, dopo la partenza delle
compagne per Grein, la sua presenza mi risollevò il
morale. Un giorno Cleto fu picchiato perché sorpreso
a rubare in un campo di patate: lo salvò la sua
padronanza della lingua tedesca. La speranza che la
guerra sarebbe presto finita si faceva sempre più
concreta; Cleto ci assicurava che gli alleati erano
ormai vicini ed era questione di giorni. Ma, col
passare delle settimane, l'unico cambiamento fu
l'intensificarsi dei bombardamenti. Verso la fine di
febbraio, nel bunker della stazione, incontrammo dei
padovani di Pontelongo, del Bassanello, di Vigonovo
e di Ponte S. Nicolò. Questo incontro ci risollevò il
11
Portalettere
44
morale e ci aiutò a non perdere la speranza di tornare a
casa. Arrivò anche il giorno di Pasqua e come
“regalo” venne centrata la cucina, così restammo tre
giorni senza mangiare. A volte, Pasqui ed io
scavavamo tra le macerie alla ricerca di cibo, ma con
scarsi risultati.
12 aprile '45 – fuga dal Campo
La prima settimana di aprile in fabbrica c’era poco
lavoro dato che i tedeschi stavano trasferendo i
macchinari a Grein per cui ricevemmo l'ordine di
tenerci pronti a partire. Da Grein ci scrissero le
Martini, avvertendoci di sottrarci alla partenza perché
Vienna era ormai occupata e il cannone dei soldati
russi sparava vicino al Danubio. Ci consigliavano di
tentare la fuga dal campo. La sera del 12 aprile, Pasqui
ed io decidemmo di scappare dal campo. Fuori faceva
buio e pioveva, riuscimmo ad eludere le guardie e,
superata la recinzione, ci dirigemmo verso la città
dove, lungo la strada, ci stavano aspettando Cleto ed
un suo amico di nome Bruno. Pasqui andò avanti con
Bruno, Cleto ed io li seguimmo a distanza. Arrivati in
città un poliziotto fermò Pasqui e Bruno. Girammo per
un'altra strada ad aspettarli. Poco dopo, con nostra
gioia, ci raggiunsero.
45
Trovammo ospitalità presso una signora che
conosceva Bruno, proprietaria di un forno e alla quale
raccontammo di essere le sue cugine sfollate da
Vienna. Presa da compassione ci mise a disposizione
una stanza priva di vetri e piena di calcinacci, ma che
per noi andava benissimo. Ci promise pure che si
sarebbe recata all'Arbaissant12 a chiedere un permesso
di lavoro per noi. Nel frattempo io trovai da lavorare
presso l'hotel Scharmùller. Il lavoro era duro. Più di
sessanta stanze da riordinare erano tante per me e la
sera tornavo distrutta dalla fatica. Il diciotto di aprile
passarono per Linz Erika e Gabri, anche loro fuggite
dal campo, volevano tentare il rientro in Italia. Il loro
distacco mi rattristò perché ci volevamo molto bene.
Due giorni dopo anche Teresa e Liliana riuscirono a
raggiungerci ma, non trovando i giusti contatti per
comunicare con gli alleati, furono costrette a ritornare
a Grein. Intanto i bombardamenti continuavano
sempre più incessanti sulla città e l’eventualità di
morire sotto le bombe era reale. La mattina del 25
aprile mentre stavo riordinando una stanza che dava
sulla piazza speravo che almeno quel dì, l'allarme non
suonasse, invece si udì l'ennesima sirena. Pasqui
venne a chiamarmi ma io, stanca di correre ad ogni
suono di sirena, le risposi che al rifugio non ci sarei
andata. Poco dopo ritornò con Cleto al quale risposi
12
L' ufficio dove venivano rilasciati i permessi di lavoro.
46
allo stesso modo, perché volevo essere lasciata in
pace. “Hai per caso perso la testa” mi gridò “Vuoi
forse morire ora che sono gli ultimi giorni”. Così
dicendo mi spinse giù per le scale obbligandomi a
seguirlo al rifugio. Bombardarono ininterrottamente
per ore: le bombe scendevano a grappoli facendo
tremare l'intera galleria. La sabbia ci ricopriva e i
continui spostamenti d'aria ci facevano pensare che
fosse giunta la fine. Per lo spavento Pasqui perse la
voce, e Cleto, se gli chiedevamo qualcosa, rispondeva
a stento. Passò una prima ondata di bombe, ne arrivò
un'altra e un'altra ancora: la paura diventava terrore,
non si parlava più e anche chi, come Cleto, era solito
dire qualcosa di spiritoso per dare coraggio, era
ammutolito. Venne colpita l'entrata della galleria e
noi, che eravamo i più vicini, fummo coperti di
polvere e di detriti. Dopo cinque interminabili ore il
bombardamento smise. Ancora sotto shock, uscimmo
dalla galleria. Il fumo degli incendi copriva il sole, la
città era un cumulo di macerie. Alcuni prigionieri
russi, scortati da sentinelle tedesche, scavavano tra le
macerie in soccorso dei superstiti. A pochi passi da
noi, un prigioniero, che stava scavando tra le macerie,
toccò inavvertitamente con la pala una bomba
facendola esplodere, senza rimanere fortunatamente
ucciso. In tutta fretta ci avviammo verso quello che
rimaneva del centro della città. Giunti all' hotel dove
47
lavoravo, lo trovammo completamente distrutto. Un
brivido mi percorse la schiena: ero viva grazie a
Cleto! Da quel momento la nostra preoccupazione più
grande fu come procurarci da mangiare e dove
dormire. Girovagammo da un posto all'altro, scavando
tra le macerie e mangiando ciò che trovavamo. La sera
si dormiva in galleria per terra: unico lusso, un paio di
coperte che ci furono rubate quasi subito da un
italiano che pareva onesto. La mattina del 27 aprile,
non sapendo dove andare, decidemmo di tornare dalla
proprietaria del forno. Da lontano la vedemmo parlare
con dei poliziotti. Cleto si avvicinò per ascoltare e
sentì che stava denunciando due italiane (cioè noi) per
il furto di un sacco di zucchero, il che non era vero!
Dovemmo, nostro malgrado, allontanarci in fretta
poiché, oltre ad essere ricercate dai soldati del campo,
da quel momento correvamo il rischio di essere
arrestate per furto dalla polizia locale.
Il primo maggio, vagabondando lungo il Danubio alla
ricerca di qualche negozio aperto, per barattare un
buono valido per due chili di patate con un chilo di
pane, sentimmo la radio che comunicava la notizia
della morte di Hitler, cosa che in quel momento ci
lasciò abbastanza indifferenti tanta era la confusione
che si era creata. Capimmo senz'altro che la Germania
aveva perso definitivamente la guerra. Sporchi e
affamati ci dirigemmo in un campo profughi, ma
48
anche lì cominciarono ad arrivare le cannonate degli
americani e perciò fummo costretti a ripararci dietro
un paraschegge per due giorni e due notti. La mattina
del terzo giorno smisero di sparare; Cleto uscì per
vedere com’era la situazione e tornò poco dopo
gridando: “Sulla ciminiera c'è la bandiera bianca! La
guerra è finita”. Questo accadde il cinque maggio
1945 giorno che segnò finalmente la fine di un incubo.
La gioia della gente era indescrivibile. Tutti i cattivi
propositi di vendicarsi di questo o quel tedesco, a
guerra finita, lasciarono il posto a manifestazioni di
incontenibile gioia per la speranza ormai concreta di
tornare a casa molto presto. La sera si festeggiò in
baracca fino a tarda notte. Purtroppo non fu possibile
tornare subito a casa perché non c'erano mezzi. Gli
americani, che nel frattempo avevano occupato la
città, organizzarono centri di assistenza sanitaria e
sociale. Iniziò una lunga attesa durante la quale Pasqui
ed io, cercavamo di renderci utili come potevamo. A
volte si andava all’ospedale di Linz per assistere e
dare conforto a quanti vi erano ricoverati. Qui regnava
una confusione indescrivibile: continuava ad arrivare
gente da ogni parte, persone gravemente ferite a causa
dei bombardamenti, o affette da malattie molto gravi.
Molti degli internati di Mauthausen e di altri campi,
gravemente denutriti, una volta usciti dai lager,
trovarono la morte rimpinzandosi delle prime cose
49
commestibili capitate loro sottomano, ciò creava nel
loro organismo, fortemente debilitato, un tale
malessere che spesso diventava letale. Altre persone,
scavando tra le macerie alla ricerca di un familiare o
di quello che restava delle proprie cose, restarono
uccise dallo scoppio di una bomba inesplosa. La
guerra continuava a mietere vittime innocenti anche
dopo la sua fine! Dopo tante peripezie riuscimmo, il
venticinque giugno, a raggiungere Bolzano e da lì, un
po' a piedi e grazie a qualche passaggio di fortuna,
giungemmo a Verona. Pasqui, Cleto ed io ci
salutammo affettuosamente con la promessa che
presto ci saremmo rivisti. La domenica del 29 giugno,
giorno dei santi Pietro e Paolo, giunsi a Saonara dove
venni accolta festosamente dall'intero paese e
naturalmente dalla mia famiglia. Ero felice di poter
riabbracciare i miei cari, di rivedere la mia casa i
luoghi della mia infanzia e poter respirare i profumi
della mia amata terra che per tanto tempo avevo solo
sognato. Un unico pensiero offuscava la mia gioia,
non trovare zia Maria a casa ad aspettarmi. Da
Bolzano era stata deportata a Ravensbrück lager 17,
assieme a Milena Zambon e a Maria Zonta, che,
successivamente furono trasferite Fürstenberg-Havel
per cui scamparono alla morte, e fecero ritorno,
mentre di Maria non si ebbero più notizie. Coloro che
la videro gli ultimi giorni dissero che si era ammalata
50
gravemente e ciò non le permise di salvarsi. Venni
pure a sapere della grande tragedia che aveva colpito
la comunità di Saonara poche settimane prima del mio
ritorno: l’eccidio di Villa Bauce13.
Qualche giorno dopo il mio ritorno accadde un fatto
che mi fece comprendere quanto la triste e dura
esperienza vissuta non aveva lasciato in me sentimenti
di odio o di risentimento verso alcuno.
<<Una sera, tornando a casa dal lavoro, sempre lungo
quella stradina che tanti guai mi aveva procurato,
incontrai un giovane militare tedesco prigioniero degli
alleati, che viveva alla meno peggio nella barchessa di
villa Valmarana. Come tanti suoi commilitoni,
aspettava di essere rimpatriato. Nel frattempo, visto
che la sorveglianza era pressoché inesistente, usciva la
sera in cerca di qualcosa da mangiare presso le
famiglie del posto. Aveva in mano un paio di scarpe
da militare da scambiare con qualcosa da mettere sotto
Villa Bauce di Saonara evoca tristemente l’eccidio del 28
aprile 1945. Quella sera, l’incoscienza di alcuni partigiani
comandati da Luigi Tombola di Camin portò al ferimento di tre
soldati tedeschi presso villa Pimpinato. Ciò scatenò la furia del
comandante di cinquecento soldati della Wermacth, ormai in
ritirata, che si trovava a villa Bauce, poco distante. La reazione
tedesca fu immediata: un rastrellamento che ebbe come
epilogo la drammatica morte di dieci civili, tra cui un bimbo,
Agostino, di appena cinque anni. A questo seguì l’eccidio di
trentaquattro uomini mediante esecuzione con un colpo alla
nuca sul ciglio del fossato di villa Bauce.
13
51
i denti. Dopo quanto mi era successo avrei voluto
dirgliene quattro ma, presa da compassione e
ricordando per esperienza personale che cosa
significasse la parola fame, lo condussi a casa. La mia
famiglia lo ospitò quella sera ed altre ancora. Un
pomeriggio, forse per sdebitarsi per l’ospitalità che
riceveva, arrivò con in mano un paio di briglie da
cavallo prese chissà dove e ce le regalò. Recuperò in
fretta le forze necessarie per riprendere il cammino e
non lo rivedemmo più >>.
***
52
Elenco di alcuni Lager
Auschwitz
Belzec
Bergen Belsen
Bolzano
Buchenwald
Chelmno
Dachau
Dora Mittelbau
Esterwegen
Flossenbürg
Fossoli
Gross Rosen
Majdanek
Mauthausen
Natzweiler Struthof
Neuengamme
Ravensbrück
Risiera di San Sabba
Sachsenhausen
Sobibor
Stutthof
Treblinka
53
anno di apertura
1940
1942
1943
1944
1937
1941
1933
1943
1943
1938
1942
1940
1941
1938
1941
1938
1938
1943
1936
1942
1939
1942
I dati relativi al numero dei luoghi di detenzione
sono stati estrapolati dal libro “La mappa
dell’inferno” di Gustavo Ottolenghi – ed. Sugarco
Edizioni – 1993.
54
Bibliografia
1.
A.N.P.I. Padova (a cura di), Donne nella Resistenza. Testimonianze
di partigiane padovane. Milano, Zanocco, 1981.
2. L. BECCARIA ROLFI - A. M. BRUZZONE, Le donne di Ravensbrück.
Testimonianze di deportate politiche italiane. Torino, Einaudi, 1978.
3. E. GATTI, Lager. Storia inedita dei campi di sterminio d’Europa,
Modena, Toschi, 1993.
4. G. Ottolenghi, La mappa dell’inferno. Sugarco Edizioni,1993
5.
P. GIOS, Dal soccorso ai prigionieri inglesi ai campi di sterminio
tedeschi. Padova, Associazione volontari della libertà,1987.
6. V. MARANGON, Resistenza padovana tra memoria e storia.
Padova, Centro studi Ettore Luccini-Il Poligrafo, 1994.
7. S. NAVE, 50°. L’offensiva aerea alleata. Le missioni militari alleate e la
Resistenza nel Veneto 1943-1945. Comune di Padova, 1993.
8. V. PAPPALETTERA, Nei lager c’ero anch’io. Milano, Mursia, 1973.
9. A. SALMASO, Saonara,Villatora, Tombelle, Celeseo. Storia e antologia.
Comune di Saonara, 1995.
10. C. SAONARA (a cura di), Le missioni militari alleate e la Resistenza nel
Veneto. Venezia, Marsilio, 1990.
11.
L. SCALCO (a cura di), Numero monografico per il 50° anniversario
della Resistenza, in “Storia e cultura” n° 13-14, gennaio-giugno 1994,
Centro studi O. Peron, Cittadella.
12.
L. STERPELLONE, Le cavie dei lager, Milano, Mursia, 1978.
13.
G. TEDESCHI, C’è un punto nella terra. Firenze, Loescher, 1997.
14.
P. A . TOTTOLI, Ho soccorso Gesù perseguitato, in “Messaggero
di S. Antonio”. Padova, 2001.
15.
E. ZATTA, Maria Borgato, Una vita firmata dono. Cleup, 2002.
55
Delfina Borgato, classe 1927, cresce a Saonara (Pd) in una famiglia
di umili origini, trascorrendo un’infanzia serena e felice. Il 13 marzo
1944, a sedici anni, Delfina e sua zia Maria Borgato, per aver prestato
soccorso a ex prigionieri alleati, vengono arrestate dai nazifascisti. Nel
carcere di santa Maria Maggiore di Venezia Delfina subisce violenti
interrogatori, che però non la piegano; chiusa in carro bestiame, viene
deportata nel lager di Mauthausen e in seguito trasferita nel campo di
concentramento di Linz. Sopravvissuta ai campi di concentramento,
ritorna a Saonara il 29 giugno 1945. Per molti anni cerca di dimenticare
la terrificante esperienza, evitando di raccontare persino ai propri
familiari i mesi di prigionia. Nel 1979 il Comune di Saonara intitola la
piazza principale a Maria Borgato. Per Delfina, a questo punto, il
parlare dei patimenti e delle crudeltà subite è inevitabile, soprattutto
agli incontri con gli studenti nelle scuole delle province di Padova,
Vicenza e Verona che sempre più spesso la invitano. Il 20 dicembre 2005
il Capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi, nomina Delfina Borgato
“Cavaliere della Repubblica italiana”. Il 28 gennaio 2006, al Teatro Verdi
di Padova, viene presentato il dramma in due tempi di Luigi Francesco
Ruffato “Maria Borgato vittima del nazifascismo”. Tra i personaggi del
dramma figurano: Delfina diciassettenne e Delfina da adulta. Nel 2008 il
Comune di Padova consegna a Delfina Borgato il sigillo della città e lo
stesso giorno, nel Giardino dei Giusti di Padova, scopre una stele col
suo nome. Da molti anni Delfina vive a San Bonifacio (Vr).
Enzo Zatta è nato a Padova nel 1953. Sensibile cultore di storia locale,
nel 2002 ha scritto la biografia di Maria Borgato dal titolo “Maria
Borgato - Una vita firmata dono”. (Cleup 2002). Dal 1995 raccoglie
testimonianze di reduci ed internati della Seconda guerra mondiale,
promuovendo incontri ed audizioni, soprattutto nelle scuole, incentrati
sulla memorialistica dell’Ultimo conflitto.
56