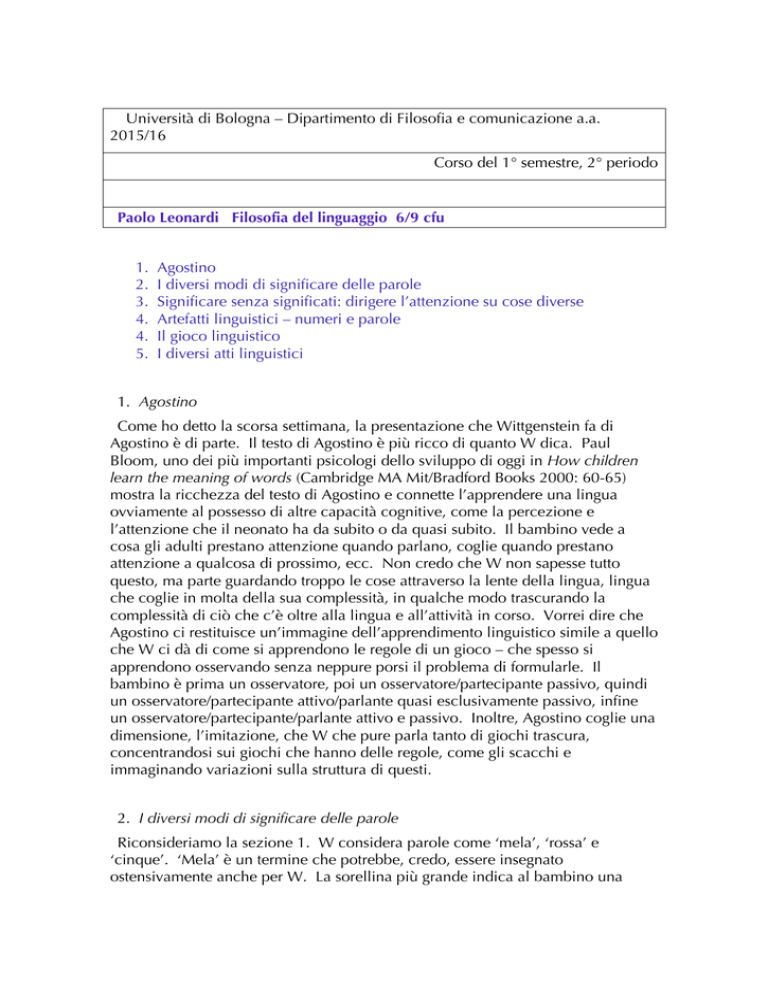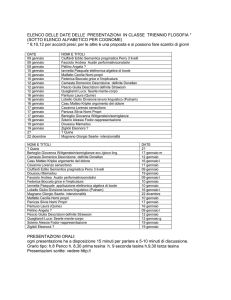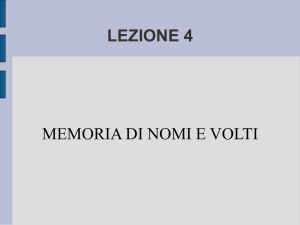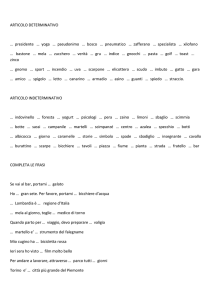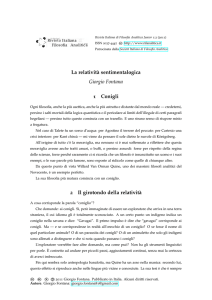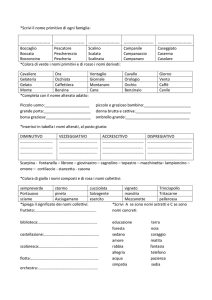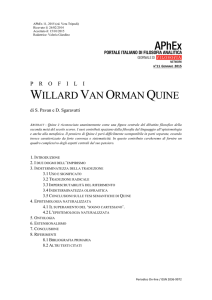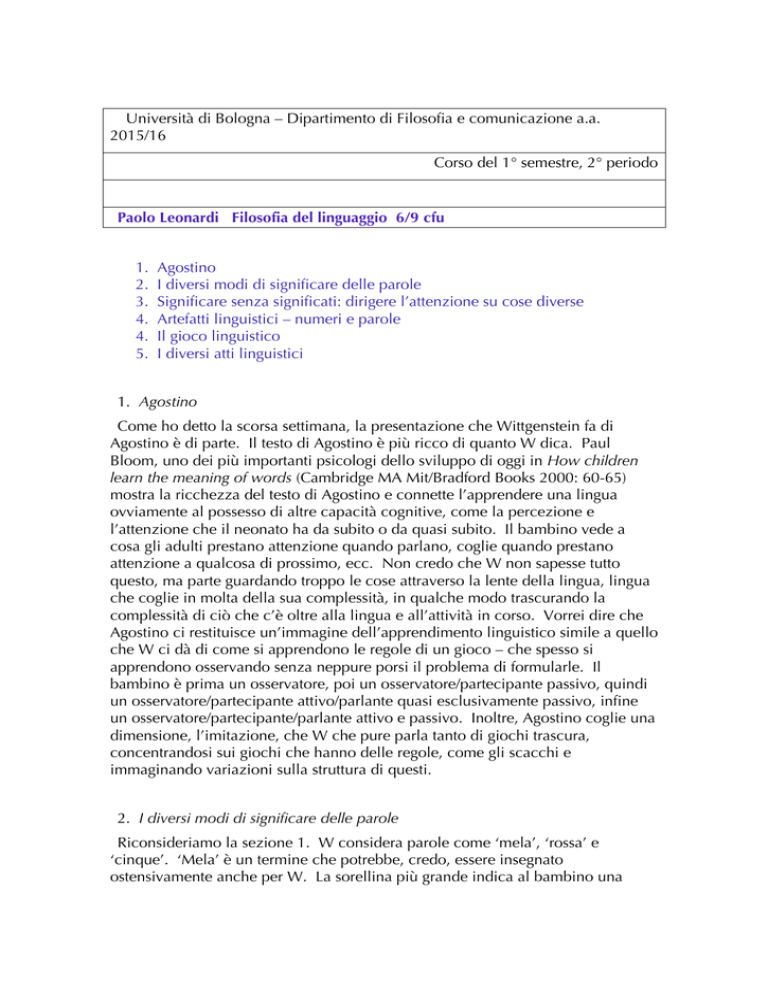
Università di Bologna – Dipartimento di Filosofia e comunicazione a.a.
2015/16
Corso del 1° semestre, 2° periodo
Paolo Leonardi Filosofia del linguaggio 6/9 cfu
1.
2.
3.
4.
4.
5.
Agostino
I diversi modi di significare delle parole
Significare senza significati: dirigere l’attenzione su cose diverse
Artefatti linguistici – numeri e parole
Il gioco linguistico
I diversi atti linguistici
1. Agostino
Come ho detto la scorsa settimana, la presentazione che Wittgenstein fa di
Agostino è di parte. Il testo di Agostino è più ricco di quanto W dica. Paul
Bloom, uno dei più importanti psicologi dello sviluppo di oggi in How children
learn the meaning of words (Cambridge MA Mit/Bradford Books 2000: 60-65)
mostra la ricchezza del testo di Agostino e connette l’apprendere una lingua
ovviamente al possesso di altre capacità cognitive, come la percezione e
l’attenzione che il neonato ha da subito o da quasi subito. Il bambino vede a
cosa gli adulti prestano attenzione quando parlano, coglie quando prestano
attenzione a qualcosa di prossimo, ecc. Non credo che W non sapesse tutto
questo, ma parte guardando troppo le cose attraverso la lente della lingua, lingua
che coglie in molta della sua complessità, in qualche modo trascurando la
complessità di ciò che c’è oltre alla lingua e all’attività in corso. Vorrei dire che
Agostino ci restituisce un’immagine dell’apprendimento linguistico simile a quello
che W ci dà di come si apprendono le regole di un gioco – che spesso si
apprendono osservando senza neppure porsi il problema di formularle. Il
bambino è prima un osservatore, poi un osservatore/partecipante passivo, quindi
un osservatore/partecipante attivo/parlante quasi esclusivamente passivo, infine
un osservatore/partecipante/parlante attivo e passivo. Inoltre, Agostino coglie una
dimensione, l’imitazione, che W che pure parla tanto di giochi trascura,
concentrandosi sui giochi che hanno delle regole, come gli scacchi e
immaginando variazioni sulla struttura di questi.
2. I diversi modi di significare delle parole
Riconsideriamo la sezione 1. W considera parole come ‘mela’, ‘rossa’ e
‘cinque’. ‘Mela’ è un termine che potrebbe, credo, essere insegnato
ostensivamente anche per W. La sorellina più grande indica al bambino una
2
mela e dice «Mela!» ‘Rossa’ – mettete fra parentesi la flessione femminile – non
potrebbe davvero essere insegnata allo stesso modo, o quasi? La sorellina indica
la stessa mela e dice «Rossa!», poi indica una macchinina con cui il fratellino
gioca e di novo dice «Rossa!» Mi obietterete che indica due oggetti diversi e non
un oggetto, e quindi che ‘rossa’ non designa alcunché, o è ambiguo, perché
designa più oggetti appunto. Ma ‘rossa’ non è ambiguo in questo senso, e se è
ambiguo lo è perché esistono più sfumature di quel colore. Che rosso sia un
oggetto diverso dalla mela? La bambina potrebbe chiamare mela tanti altri
oggetti, che potrebbero davvero essere tutte mele, mentre rossa è in effetti diverso,
è il nome dell’aspetto di un oggetto – mela o non mela che sia – ma non di un
tipo di oggetto. E sfumature a parte uno vorrebbe dire che rossa coglie in tutti i
casi lo stesso aspetto, che, sfumature a parte, di rossi ce n’è uno solo. Proprio qui
però verrebbe voglia di dire che l’aspetto è un oggetto diverso da ciò di cui è
aspetto. Questa è una possibilità che nelle sezioni 10-29 W considera più volte,
e che però ritiene più produttrice di confusione che di chiarificazione, perché
allora bisognerà che oggetto o designare vengano intesi in molti modi diversi.
C’è però una ragione per insistere contro W: le parole rimandano a
qualcos’altro, e questo qualcosa non è affatto detto che sia tutto di un tipo, ma
resta un qualcos’altro. Una parola è come un doppio di una cosa. C’è la mela e
c’è la parola mela. C’è il rosso e c’è la parola rosso. C’è lo specificare qualcosa e
c’è un genitivo magari espresso dalla preposizione di.
I numeri sono un caso più complesso. Ci sono cinque oggetti e c’è la serie dei
primi cinque numeri naturali. Così caso per caso i numerali della serie
costituiscono un doppio degli oggetti che contiamo. Ma i numerali costituiscono
esse stessi un artefatto che è studiato non per le sue proprietà linguistiche bensì
per le sue proprietà strutturali, e a partire dal quale costruiamo altri manufatti
numerici che ci servono per misurare altre cose come le infinite posizioni che ci
sono fra due interi, che possono essere numerabili, e tali che fra due numeri interi
ce ne sono infiniti, come accade con i numeri razionali, che però non possono
essere messi in una successione ordinata, o più che numerabili come accade con
i numeri reali che sono densi e, si dice, completano la retta, e sono insomma di
un infinito superiore.
3. Significare senza significati: dirigere l’attenzione su cose diverse
Qualunque sia la nostra scelta sulla designazione e gli oggetti, W pensa che non
ci siano entità che sono i significati. Il significato di una parola è il uso. Quello
che facciamo producendo segni può però essere, penso, ancora unificato dicendo
che le parole che usiamo vogliono tutte attirare la nostra attenzione su qualcosa:
un oggetto, un aspetto, un ordinamento (quando usiamo numeri), un’operazione
sintattica, ecc. I segni si aggiungono alle cose, le manipolano con la voce o con
il tratto, e possono essere usati a distanza, direi, per farne una mappa, per
organizzarle in un diagramma o in una flow chart.
3
4. Artefatti linguistici – numeri e parole
Parole e numeri (che qui tratto come particolari sequenze di parole) sono
artefatti e W nel Tractatus sembra pensare che numeri e enunciati siano entrambi
il prodotto di un processo di generazione, con la differenza che conosciamo
l’ordine dei numeri naturali, e quindi in qualche modo l’origine dei numeri,
mentre non c’è un enunciato all’origine degli enunciati della lingua, ma un
numero indefinito di enunciati elementari. Successivamente, parole e numeri
sembrano più distanti in W di quanto non appaiano nel Tractatus, ma molte delle
cose che W dice di quelle sembra valere anche per questi, in particolare tutta la
trattazione delle regole, che vedremo ha un ruolo importantissimo nelle Ricerche.
5. Il gioco linguistico
Non amo questa metafora, e penso che in parte sia fuorviante. W, come
ricordavo la scorsa settimana, è molto più brillante di Saussure, perché non
paragona semplicisticamente la lingua agli scacchi, ed è consapevole di quanto si
ricca e difforme la tipologia dei giochi, seppure neanche lui la tratti in tutta la sua
completezza, trascurando i giochi di imitazione. Quello che mi convince meno
però è che parlare non è un gioco, non è qualcosa ce è, come dire, incorniciato e
distaccato dalla vita, che non ha effetti reali. La lingua e un filo intessuto nella
vita, e molti fili di questa non li conosciamo, cosicché per quanto parlare possa
anche mettere ordine, il livello di complessità dell’attività in cui una lingua è
parlata è tale che il numero degli imprevisti, la quantità dei fattori rilevanti rischia
sempre di superarci.
6. I diversi atti linguistici
John L. Austin (1911-1960) in Come fare cose con le parole uscito nel 1962
sostiene che parlare comprende azioni locutorie – come l’emettere suoni,
l’emettere suoni appartenenti al lessico di una lingua rispettandone la
grammatica, emettere suoni del genere per parlare di una cosa e caratterizzarla –,
azioni illocutorie – come l’emettere giudizi, l’esercitare autorità, il prendere
impegni, funzioni fatiche come il salutare ecc, esporre e informare – e azioni
perlocutorie – che corrispondono al conseguire effetti su chi ci ascolta, così
dando un consiglio possiamo riuscire a persuadere qualcuno come possiamo
invece irritarlo (di solito il primo è un obiettivo cui si mira e il secondo è un
effetto non voluto).
Wittgenstein rifiuta di impegnarsi in una classificazione sistematica dell’agire
linguistico. Per quanto una classificazione possa essere insoddisfacente, un conto
è produrne una seppure insoddisfacente, e un altro e non produrne alcuna. In
questo secondo caso, tutto sembra più aperto, forse, ma molte cose sfuggono,
anche nella nostra comprensione del parlare come di un’attività.
4
Significato come uso. Se leggete il Cratilo di Platone, vedrete che lì la
contrapposizione fra i due protagonisti, Ermogene e Cratilo, è fra convenzionalità
e naturalità della lingua, posizioni sulle quali Socrate riflette, opponendo al primo
il naturalismo e al secondo il convenzionalismo, a mio avviso cercando una via
intermedia che però non viene propriamente fuori ed è rimandata a un seguito del
dialogo che non è mai seguito. Ora Wittgenstein nel Tractatus sembra proporre
una soluzione naturalista abbastanza inventiva. Platone nel Cratilo considera
l’opinione che le parole prime – cioè quelle il cui significato non deriva da quello
di altre parole per composizione di più parole, o, come avviene negli usi
metaforici, per sottrazione di alcuni tratti di una parola – considera, dicevo, che le
parole prime siano immagini sonore di ciò che nominano. Nel Tractatus, W
afferma che la proposizione elementare (l’enunciato elementare) sia l’immagine
di uno stato di cose, col quale condivide la struttura. Dunque i nomi non
sarebbero immagini, ma gli enunciati elementari sì. Nelle Ricerche, invece, l’idea
che il significato di una parola sia il modo del suo uso, sembra una posizione
convenzionalista. Gli uomini usano una parola per parlare di una cosa, o per
caratterizzarla, o per contare le cose, e quella parola sarà quindi un nome
proprio, per es, un nome comune o un numero.
Negli ultimi 60 anni sono state proposte moltissime specificazioni del significato
come uso, tutte più “tecniche” di quella di W. Il comportamentismo linguistico di
Willard van Orman Quine, le condizioni di asseribilità di Michael Dummett, e
poi in versione diversa di Dag Prawitz – ispirate rispettivamente dalla logica
intuizionista e dalla teoria della dimostrazione, la semantica basata sulla teoria
dei giochi di Jaakko Hintikka, la semantica del ruolo concettuale – con le sue
sottovarianti dovute a Hartry Field, Bas van Fraassen e Gilbert Harman – e, negli
anni ‘90, l’inferenzialismo semantico di Robert Brandom e il minimalismo
semantico di Paul Horwich. (Per citare solo le varianti principali.) Tutte queste
teorie assumono che le parole abbiano un significato e che questo funzioni come
dice una teoria comportamentista, o come accade in una logica costruttivista, o
nella teoria dei giochi, ecc. Questo può forse essere riespresso sostenendo che
una lingua è un prodotto culturale, e aggiungendo che ci è possibile imparare una
lingua perché siamo naturalmente dotati di quanto serve per impararla (e c’è
molto da discutere su cosa serva per imparare una lingua). La mia impressione è
però che nessuna di queste teorie entri nel dettaglio e spieghi come un uso si
stabilisca, come si mantenga e come muti (qualcuno accenna qualcosa, come
Horwich). (Non che non ci siano linguisti, come David Lightfoot, che se ne siano
occupati meglio.)
La questione centrale, dal mio punto di vista, però è quali elementi cognitivi
siano implicati in questi dettagli – percezione, attenzione, memoria, ecc. Perché
il primo uso in qualche modo è già significante.
5
Gli autori da studiare nell’antologia Filosofia del linguaggio (Milano Cortina
2003) curata da Paolo Casalegno e altri sono: Frege, Russell, Wittgenstein, il
secondo saggio di Quine, Kripke, Putnam, Grice. Inoltre ci sono tutti i materiali
obbligatori che trovate in rete (dove ci sono anche alcuni materiali indicati come
supplementari).
Oggi si chiude questo corso e vorrei fare il punto del nostro viaggio con una
puntata su 24 secoli fa, e una corsa tra fine ’800 e ’900.
La mia tesi era che molti dei temi filosofico-linguistici che si trovano nel Cratilo
di Platone, che è il primo testo che abbiamo che si occupi quasi esclusivamente
di quei temi, sono quasi tutti i temi di cui ci occupiamo ancora oggi, ma che le
nostre conoscenze su di essi sono cresciute e ne abbiamo una visione che direi,
senza togliere nulla a Platone, più sofisticata e più complessa.
Brevemente i temi che Platone tocca: l’ipertema è correttezza naturale vs
accordo convenzionale (Cratilo vs Ermogene). I temi sono: la verità dei nomi
(‘nome’ in Platone è un iperonimo e vale espressione linguistica, voce lessicale),
per i nomi propri, ovvero i nomi nomi, questo vuol dire concepirli come i
predicati o i nomi predicati, il cambiamento linguistico (che Ermogene dice
introdotto dall’individuo e accettato dalla comunità) e io contatto fra lingue. A
margine c’è un accenno alla relatività della verità, e il suo rifiuto da parte di
Ermogene come di Socrate. Viene proposta una definizione, seppure non
formale, di verità: il discorso che dice gli esseri come sono è vero, e quello invece
che li dice come non sono è falso. Si discute della natura delle cose che oppone
resistenza alle nostre rappresentazioni linguistiche e pretende che queste si
adeguino ad essa. Fra le cose cita le azioni, e dice che il nominare e il dire sono
azioni. Il nome è uno strumento e il linguaggio tutto, che è costituito da nomi, è
uno strumento per insegnare e distinguere come stanno le cose, per coglierne
l’essenza. L’artefice dei nomi, il nomoteta, è per Platone il poeta, Omero su tutti,
avrà un ruolo importante all’inizio della parte sulle etimologie. Ciò che i nomi
nominano, per Socrate, è l’essenza delle cose, ovvero l’idea – l’idea di uomo, di
spola, ecc. L’idea per Platone, nel Fedro, un altro dialogo, è un’entità
incorruttibile, collocata nell’iperuranio, cioè al di là del cielo. Come il falegname
fa la spola con legni diverse, così l’artefice delle parole le fa con suoni diversi, ma
esse tutte significano le idee. Siccome il dialettico (il filosofo, lo scienziato) è
colui che studia la natura delle cose, è questi che giudica della qualità del lavoro
dell’artefice delle parole, del nomoteta. Il dialettico è detto anche colui che sa
interrogare e rispondere. Socrate sembra sostenere la posizione naturalista, ma
Ermogene non è convinto dalle sue argomentazioni.
Discutendo con Cratilo, successivamente tornano alcuni di questi temi ed altri
ancora. Gli altri: i nomi veri sono simili al nominato. Socrate tratta la questione
per diverse categorie fondamentali dell’analisi del linguaggio: nome, verbo,
enunciato. “Se posso attribuire nomi così come ritratti agli oggetti, la loro
attribuzione corretta possiamo dirla vera e quella scorretta falsa. Ora se ci può
essere l’attribuzione errata di nomi, ci può anche essere l’attribuzione errata di
6
verbi, e se di nomi e di verbi, anche di enunciati che sono costituiti da quelli.”
Quanto simili? Un nome non può essere identico a ciò che nomina, cioè deve
distinguersene. “Vorrei dire invece che se un’immagine presentasse punto punto
la realtà, non sarebbe un’immagine. Supponiamo che esistano due cose, Cratilo e
l’immagine di Cratilo, e supponiamo, inoltre, che un dio non solo rappresentasse
il tuo aspetto e i tuoi colori, ma rendesse anche la tua struttura interna, lo stesso
calore, la stessa morbidezza, e gli donasse movimento, anima e mente, come a te,
in poche parole copiasse tutte le tue qualità in un altro essere – ci sarebbero
Cratilo e l’immagine di Cratilo o due Cratili?”
Ma capiamo anche i nomi che non sono simili, nel linguaggio ci sono
espressioni naturali e espressioni convenzionali. Ci capiamo anche per abitudine
e per convenzione.
L’ultima parte del dialogo è dedicata a nomi e conoscenza. Come si consce la
natura delle cose? Per Cratilo chi conosce i nomi conosce gli oggetti che
nominano. Fra i diversi argomenti con cui Socrate contrasta Cratilo, il più
importante sembra essere che se si conoscesse per mezzo delle parole i primi
legislatori non potevano avere conoscenza delle cose.
“Se è possibile conoscere gli oggetti attraverso i nomi, ma lo è anche attraverso
loro stessi, qual è il modo più bello e più chiaro di apprendere? Dall’immagine, se
l’immagine e la verità che esprime sono state concepite correttamente, o dalla
verità la verità stessa e se l’immagine la rappresenti a dovere? / Direi che
dovremmo impararlo dalla verità.” C’è poi la negazione che il linguaggio sia un
dono divino – il legislatore non è un essere sovrumano.
Poco prima di chiudere si discute se la conoscenza sia o no stabile. Se la
conoscenza non fosse stabile, e tutte le cose cambiassero continuamente, le cose
non potrebbero essere conosciute da nessuno.
Abbiamo quindi visto il Tractatus logico-philosophicus di Ludwig Wittgenstein,
un teso del 1921, e l’idea che i nomi siano arbitrari, ma gli enunciati (elementari,
cioè privi di congiunzioni, disgiunzioni, frasi secondarie e negazioni) siano
immagini degli stati di cose che rappresentano. Abbiamo letto poche righe di
Russell tratte dal saggio “Sul denotare” del 1905, in cui Russell basa il significare
su ciò con cui abbiamo familiarità, e su cui non ci possiamo sbagliare, che come
accade in tutta la tradizione empirista sono i fenomeni della nostra esperienza, o
se si è più stretti, come sarà il Russell più tardo, le nostre sensazioni. Abbiamo
anche visto come David Lewis, nel 1969, nel testo Convenzione definisce la
convenzione, definizione sulla quale costruisce l’idea della convenzione
linguistica. La convenzione può essere spiegata con matrici della teoria dei
giochi, in cui ci sono diversi esiti possibili, con premi o danni più o meno alti.
Linguisticamente il premio è l’intendersi e dunque scegliere espressioni che i
nostri interlocutori siano in grado di capire. Lewis arriva a questo attraverso la
simulazione di un complesso ragionamento che naturalmente ciascuno di noi fa
sui propri interlocutori e su se stesso.
7
Successivamente abbiamo toccato quanto Gottlob Frege nel 1892 scrive nel
saggio “Sul senso e il significato”. La posizione di Frege è che ogni espressione
abbia sia un senso (che esprima quello che noi chiamiamo un concetto) e un
significato (che con quel concetto colga un oggetto che sotto quel concetto cade).
E abbiamo visto come affronta le eccezioni a questo schema, e come abbia nei
confronti del senso quasi la stessa posizione che Platone ha sulle idee.
Putnam e Grice, cui ci siamo quindi dedicati, offrono delle importanti variazioni
sulla relazione fra parole e cose – quindi su temi come la naturalità e la
convenzionalità di questa relazione, sulla determinazione via idee o concetti di
ciò che significhiamo. Per Putnam c’è una relazione diretta con le cose. Le
nostre espressioni indicano in qualche misura le cose di cui parliamo usandole,
cose su cui abbiamo idee forse convergenti ma diverse, fra l’altro più precise e
meno precise. La nostra concezione di ciò di cui parliamo più che un’idea
platonica o un senso fregeano è uno stereotipo che caratterizza spesso
imperfettamente ciò di cui parliamo, anche se in molti casi ci sono nella nostra
comunità esperti che usano stereotipi migliori dei nostri e alla cui autorità
deferiamo, un esempio di tutti i giorni sono i medici quando parlano di malattie e
medicine. Nell’articolo “Meaning”, del 1957, e poi nelle lezioni tenute a
Harvard, la più antica università statunitense, nel 1967, Grice invece sostituisce le
intenzioni alle convenzioni. Abbiamo in mente una cosa, quando parliamo, e
dobbiamo trovare i modi espressivi in modo che i nostri interlocutori riconoscano
ciò che abbiamo in mente. In molti casi, in cui parliamo di cose comuni, le
parole comuni vanno benissimo, in altri casi il lavoro linguistico che dobbiamo
fare è più complesso. A un tempo, per natura e perché è ragionevole,
cooperiamo quando partecipiamo a una conversazione, a uno scambio
linguistico, e questo aggiunge a ciò che alla lettera diciamo un secondo livello di
significazione, un di più che con ciò che diciamo lasciamo intendere. La
relazione dunque fra le nostre parole, ciò che esse significano, e la comunità
linguistica con cui interagiamo è a questo punto assai più ricca e complessa di
quanto non risulti leggendo il dialogo fra Ermogene, Socrate e Cratilo.
Lo stesso brevissimo, eppure importante, accenno di Platone all’agire linguistico
l’abbiamo visto ramificarsi e fiorire nella teoria degli atti linguistici, sviluppata da
John L. Austin nelle lezioni tenute a Harvard nel 1955, che alla fine distinguono
tre livelli dell’agire linguistico, quello locutorio (a sua volta distinto in fonetico
(emettere suoni), fatico (emettere i suoni propri di una lingua) e retico (emettere
suoni propri di una lingua e dotati di senso e riferimento)), quello illocutorio (in
cui fa uno schizzo di cinque tipi – verdettivo (dare verdetti, esprimere giudizi),
esercitivo (esercitare un’autorità), commissivo (dal latino ‘committere’ prendere
impegni), comportativo e espositivo) e quello perlocutorio, che tratta degli effetti
del parlare su chi ci ascolta, effetti cercati, obiettivi, e effetti prodotti ma non
cercati, seguiti.
Infine, abbiamo visto qualcosa dalle Ricerche filosofiche di Ludwig Wittgenstein,
un testo finito nel 1945, ma pubblicato solo postumo nel 1953. Qui ci siamo
soffermati sull’idea del significato come uso e sui giochi linguistici. Wittgenstein
8
concepisce il significare come un’attività che si intreccia con altre attività non
linguistiche – parliamo, ma spesso il nostro parlare dirige o condiziona le nostre
azioni non linguistiche. Pensate all’importanza quando si agisce di avere le
informazioni appropriate. Informazioni che, di solito, ricuperiamo via la lingua –
parlando con qualcuno o leggendo dei testi.
Ho, en passant, accennato a cos’è un paradosso, facendo l’esempio del
paradosso del mentitore – eccolo in due forme diverse: dico ‘Io mento’ o dico
‘Questo enunciato è falso’. Prendete ‘Io mento’: se dico il vero, allora dico il
falso, cioè mento; se dico il falso, allora dico il vero perché dico ‘Mento’.
Ci sono molti altri autori, molti altri temi che avrebbero meritato di entrare in
questa rassegna, ma il tempo era poco. Qualcosa potrete ricuperare nei testi
d’esame. Uno che potete scaricare dalla mia homepage personale è ‘La filosofia
del linguaggio’ che è una breve, e limitata, storia della filosofia del linguaggio dal
1879 al 1983. Un altro è l’antologia curata da Paolo casalegno e altri con alcuni
articoli che non ho avuto modo di introdurre – in particolare quello sulla relatività
ontologica di Quine, e quello sul riferimento di Saul Kripke.
Su Quine. Quine cerca di trovare un punto di equilibrio fra oggettività e
soggettività del significare.
1. La tesi dell’indeterminatezza della traduzione
In Parola e oggetto, Quine formula la tesi dell’indeterminatezza della traduzione.
Espressa in termini astratti, la tesi è la seguente: possiamo tradurre testi in ogni
lingua in modi complessivamente equivalenti, tutti cioè altrettanto buoni, pur
rendendo singole espressioni (un enunciato o una sua parte) in modi diversi e
perfino incompatibili.1 I vincoli che Quine pone sulla traduzione sono, come ho
detto, due: preservare i valori di verità degli enunciati verificabili per osservazione
diretta – come ‘Piove’– e le relazioni logiche – nella sostanza il significato dei
connettivi, che in italiano si rendono con ‘e’, ‘o’, ‘non, ‘se …, allora ___’, dei
quantificatori, come ‘tutti’ e ‘qualche’, e inoltre del predicato di identità. Tutti gli
enunciati non osservativi che non contengono parametri logici ci richiedono solo
di usare coerentemente diverse serie di ipotesi. In questi casi, appunto, uno
scostamento nel modo di volgere un’espressione può essere compensato da altri
scostamenti nel volgere altre espressioni.
L’affermazione che ci siano traduzioni incompatibili, eppure altrettanto buone,
non sorprende chi è abituato a tradurre. Rendere ciò che si è detto in una lingua
1
Ecco come Quine introduce la tesi dell’indeterminatezza della traduzione:
La tesi è allora questa: manuali per tradurre da una lingua in un’altra possono essere
composti in modi divergenti, tutti compatibili con la totalità delle disposizioni verbali,
eppure incompatibili fra di loro. In innumerevoli punti essi divergeranno nel fornire, come
loro rispettive traduzioni di un enunciato di una lingua, enunciati dell’altra lingua fra i quali
non sussiste alcuna sorta di equivalenza, per quanto intesa in senso ampio. (1960, p. 39)
9
in una seconda lingua richiede spesso riformulazioni, che portano ad altre
riformulazioni ancora, magari appunto per compensare quei primi scostamenti.
Qualche esempio per chiarire cosa sia l’indeterminatezza della traduzione,
secondo Quine, e per addomesticarla. Quine non ne fa molti, ma il primo
esempio è suo. Nell’originale, l’esempio riguarda la traduzione dal giapponese
all’inglese (Quine 1968, p.192.),2 ma lo adatto, forzando le cose, a una
traduzione dall’inglese all’italiano. Un americano parla di «five oxen», come lo
rendo in italiano? Con ‘cinque buoi’ o con ‘cinque capi di carne bovina’?3 Nel
primo caso uso un count noun, cioè un nome di specie che mi permette di
contare quanti elementi di quella specie ci sono; nel secondo caso uso un termine
massa, ‘carne bovina’, e ne esprimo la quantità servendomi di un count noun
generico, ‘capo’.
Un secondo esempio, più complesso.4 Immaginate una cultura che più della
nostra tenga conto dell’origine delle cose, immaginate che quella italiana sia una
cultura del genere. Un americano dice ‘The apple is red’. Siccome per ogni fiore
che genera una mela, c’è la mela che genera, e per ogni mela c’è il fiore che la
genera, invece che tradurre, banalmente, ‘La mela è rossa’, traduciamo ‘Il fiore di
melo è un fiore che ha generato una mela rossa’. In ogni caso in cui è vero ‘La
mela è rossa’ è vero anche l’altro enunciato che parla del fiore di melo da cui la
mela ha avuto origine, e viceversa. Probabilmente al liceo non ce l’avrebbero
passata, perché è verbosa. Non usa solo più parole, ma cita elementi (il fiore da
cui ha origine la mela) che nell’originale non ci sono.5 In questo esempio, la
traduzione del predicato compensa lo scostamento prodotto dalla traduzione del
2
3
4
5
I giapponesi preferirebbero parlare di ‘cinque capi di carne bovina’ invece che di ‘cinque bovini’.
Il secondo modo di esprimersi è forse più naturale, da noi, per chi commercia in carni – e questo
mostra una prospettiva, per così dire, culturale diversa.
Questo esempio è modellato sulla nozione di funzione di procura, o di sostituzione, che Quine 1964
introduce, che torna fra l’altro in Quine 1968 e 1990.
Nel 1990, in Pursuit of Truth, Quine afferma che la tesi dell’indeterminatezza della traduzione è
«banale e indiscutibile» (50), e la dice illustrata astrattamente dall’uso di funzioni di procura, o di
sostituzione. Una funzione di procura mette in corrispondenza uno-uno gli elementi di due insiemi.
Una volta stabilita una funzione di procura per l’elemento soggetto di un enunciato è possibile, con
un adattamento opportuno del predicato, produrre oltre a una traduzione, diciamo così, letterale,
una traduzione apparentemente incompatibile con la prima. L’esempio nel testo chiarisce come.
Si noti però che l’enunciato non gioca sull’aggiunta “vuota” di verità logiche, come fa l’enunciato ‘La
mela è rossa, e, se nevica, nevica’. L’esempio nel testo è costruito sul modello delle funzioni
sostitutive, o di procura, di cui Quine parla dal 1964, e che sono discusse sia in Quine 1968 sia in
Quine 1990. Le funzioni sostitutive richiedono che alcune condizioni siano soddisfatte. Scrive
Quine:
Una funzione di procura è una trasformazione uno-uno esplicita, f, definita sugli oggetti di un
universo inteso. Supponiamo allora di mutare la nostra ontologia reinterpretando ciascun
predicato come vero del correlato fx dell’oggetto x di cui era vero. Allora, laddove ‘Px’
originariamente significava che x era un P, reinterpretiamo ‘Px’ come se significasse che x è l’f
di un P. Lasciamo tutti gli enunciati così com’erano, lettera per lettera, meramente
reinterpretando. Gli enunciati d’osservazione restano associati con le stesse stimolazioni di
prima, e le interconnessioni logiche restano intatte. Tuttavia gli oggetti della teoria sono stati
soppiantati, talvolta drasticamente. (Quine 1990, pp. 31-2).
10
soggetto.6 Se parlare del fiore del melo anziché della mela vi sembra strano,
pensate all’uso dei patronimici, che per esempio in russo sono obbligatori.
Un terzo esempio, estremo, basato su una congettura ardita. Immaginate che
nella nostra cultura sia una convinzione diffusa che l’Italia sia al centro del
mondo, che l’universo sia finito, e che chi si allontani dal centro del mondo non
mantenga dimensioni costanti, ma rimpicciolisca vieppiù (così da non arrivare
mai al limite del mondo). In questo quadro, potremmo tradurre «Marius has gone
far away» con «Mario è rimpicciolito» o con «Mario è ingrandito» a seconda del
luogo da cui Mario è partito e della direzione che ha preso.7 Nell’ipotesi standard,
in cui un individuo ha dimensioni costanti, entrambe le affermazioni sono
evidentemente false. Le compensazioni di questi scostamenti nella traduzione
emergeranno quando si confronteranno la descrizione dell’universo
dell’americano e quella che ho finto essere la nostra.
Un quarto esempio, questo abbastanza semplice, che tocca un’area marginale
delle lingue, gli onorifici. Mentre nel nostro paese le persone sono signore e
signori, ragionieri, geometri, periti, dottoresse e dottori, avvocati, ingegneri,
professoresse e professori, onorevoli, eccellenze, presidentesse e presidenti, ecc,
negli Stati Uniti sono quasi tutti solo signore e signori, tranne quando si citano
nelle loro funzioni e diventano, per esempio, Professor o President. Il giapponese
ha diversi onorifici, obbligatori almeno fino a qualche decennio fa, e più
obbligatori, se mi permettete questo comparativo, quando ci si rivolga a una
donna o a una persona più anziana. Traducendo dal giapponese in italiano
possiamo omettere tutti gli onorifici giapponesi senza cercare di renderli in alcun
modo, sostituirli con i nostri, usare forme che non hanno un vero corrispondente
in giapponese e non sono più in uso da noi come ‘illustre’ e ‘molto illustre’. Chi
traduce dal giapponese all’inglese, può usare gli onorifici americani, o cercare di
rendere il giapponese con ‘honorable’ o ‘most honorable’. La cultura americana è
quasi senza onorifici, la cultura italiana ha onorifici legati ai ruoli sociali, la
cultura giapponese ha onorifici legati all’età, alla familiarità e al livello sociale. Le
traduzioni proposte sono scostamenti marginali, che però hanno impatti diversi
nelle tre culture considerate. Un giapponese può essere offeso dalla mia versione
italiana, e un italiano può trovare lezioso o adulatorio il mio uso di ‘illustre’ e
‘molto illustre’.
Un ultimo esempio, tratto da quella forma minore di indeterminatezza che è
l’indeterminatezza del riferimento.8 In Parola e oggetto, Quine immagina che
6
7
8
Se ci limitiamo ai cosiddetti termini referenziali, in particolare alle descrizioni definite, possiamo
immaginare la sostituzione di un’espressione con qualunque altra descrizione dello stesso oggetto.
Dunque, potremmo rendere ‘The apple is red’ anche con ‘La fase della mela è la fase di un frutto
rosso’, ‘Il frutto che mio figlio maggiore ha colto è un frutto rosso’, ecc. (Quine [1960] 1970, p. 69.)
Lascio le espressioni riflessive come ‘Mario si è rimpicciolito’ a casi in cui Mario, rimasto alla stessa
distanza, come accade nella vecchiaia, è diventato lui stesso più piccolo.
Nel 1960, Quine preferiva chiamare l’indeterminatezza del riferimento “inscrutabilità del
riferimento”, distinguendo quasi sempre questa forma di indeterminatezza da quella della traduzione
che considera più generale. Non credo che questa distinzione regga, e penso che dipenda da una
questione ideologica che riguarda come trattare i termini singolari.
11
persone diverse leggano in modi differenti alcune espressioni come ‘coniglio’.
Ogni volta che c’è un coniglio, c’è un particolare esemplare di coniglità, ci sono
tracce di un coniglio, c’è la sagoma di un coniglio, c’è la fase temporale di
coniglio, c’è il complesso di parti non staccate di coniglio, c’è la materia
coniglina, ecc. Come legge chi ci ascolta la parola ‘coniglio’? Immagina che si
riferisca al coniglio o alla fase temporale di un coniglio, o un particolare
esemplare di coniglità, ecc? Tra le mie vecchie carte trovo un diario della mia
adolescenza, dove descrivo un pomeriggio in cui andando a trovare un’amica in
campagna, avevo osservato diversi animali. Fra gli altri, dei conigli. Quindicenne,
parlando di conigli, li vedevo come animaletti a quattro zampe, caratterizzati
dalle orecchie, gli occhi mobili, il pelo, la coda, la voracità nel mangiare erba,
ecc. A diciannove anni, mi sono iscritto a Filosofia, e diversi anni dopo ho
studiato i lavori di David Lewis.9 Adesso, inciampando nel diario, lo sfoglio e
leggo fra l’altro la pagina di quella visita in campagna. Convinto da Lewis,
ritengo che propriamente gli individui siano fasali, cioè fasi temporali, e così
leggo il mio parlare quel giorno di conigli come un parlare di fasi di conigli,
magari senza neppure far caso a come concepivo i conigli a quindici anni. Le
differenze dei modi di concepire le cose possono insomma addirittura non
comparire sulla superficie della lingua,10 come avviene nelle discussioni fra chi
ritiene che un coniglio sia l’animaletto che per lo più pensiamo che sia e chi, letto
Lewis, pensa che l’animaletto sia una somma di fasi temporali e che ciò che ogni
volta esiste davvero è solo una fase. Temendo che qualcuno possa fraintendere,
riponendo il diario, correggo ogni occorrenza di ‘coniglio’ con ‘fase di coniglio’.
Mi fraintenderanno comunque, però.
L’indeterminatezza riguarda anche l’autotraduzione? Evidentemente, sì. Se
sapessi il giapponese e mi volessi tradurre in giapponese potrei incontrare
problemi come quello di ‘cinque bovini’ visto per primo o come quello degli
onorifici che abbiamo visto per ultimo. Se mi dovessi tradurre nella lingua di una
cultura come quella del secondo o quella del terzo esempio, di nuovo dovrei
affrontare il problema. Evidentemente il problema ce l’ho in casi come quello
dell’ultimo esempio. Anche su questo punto, Quine assume una posizione più
radicale. Il problema, scrive nel 1968 in Relatività ontologica, tocca anche il
tradurre espressioni della nostra lingua … nella nostra stessa lingua.
[…] [S]upponete che ci sia un’espressione in una lingua remota che potrebbe
essere tradotta in [italiano] in due modi entrambi difendibili […] Non parlo di
un’ambiguità nella lingua indigena. Suppongo che a uno stesso uso indigeno
dell’espressione possa essere data una o l’altra traduzione [italiana], sistemando
ciascuna con aggiustamenti compensativi nella traduzione delle altre parole. […]
ricorrere a una lingua remota non era essenziale. Riflettendo meglio, la
traduzione radicale comincia da noi. (Quine 1968, pp.30 e 46, traduzione mia)
Un caso ben esemplificato dal penultimo esempio visto sopra, che può essere
adattato anche ad alcuni esempi precedenti e a quello successivo. Posso
9
10
Lewis 1976. L’esempio è fittizio, e non condivido nel merito le idee di Lewis.
Questa possibilità è considerata esplicitamente in Quine 1981.
12
reinterpretare ‘coniglio’ con ‘fase di coniglio’, ‘cinque buoi’ con ‘cinque capi
bovini’, ‘la mela è rossa’ con ‘Il fiore di melo è un fiore che ha generato una mela
rossa’.
Riflettere sulla tesi di Quine fa risaltare una certa sistematicità
nell’indeterminatezza della traduzione, come ne rivela alcune forme insospettate.
Su Kripke. Kripke non parla di stereotipi come Putnam, ma insiste sulla
precedenza delle cose sulle parole. Nominiamo le cose, e poi ci serviamo dei
nomi per caratterizzarle, i nomi di per sé non caratterizzano. Una posizione
diversa da quelle di Ermogene e da quella di Cratilo.
La nuova teoria del riferimento ha origine, però, soprattutto dal lavoro di Saul
Kripke, ed è stata presentata sistematicamente in Naming ad necessity (Nome e
necessità), una serie di tre lezioni tenute alla Princeton University nel 1970,
pubblicate nel 1972 come articolo, e nel 1980 come libro, e nell’articolo
“Identity and necessity” (“Identità e necessità”), del 1971.
Secondo la teoria fregeana del riferimento, a quelli che comunemente
chiamiamo nomi propri (Frege ha un uso tecnico della locuzione ‘nome proprio’)
ciascuno di noi associa delle descrizioni. Al nome Immanuel Kant, per esempio,
si associano le descrizioni ‘Il filosofo di Koeningsberg’, ‘L’autore de La critica del
gusto’, ‘L’allievo di Martin Knutzen’, ‘L’autore di un’ipotesi sull’origine del
sistema solare molto simile all’ipotesi di Laplace’, ecc. Ciascuno di noi associa al
nome Immanuel Kant alcune di queste descrizioni, o altre descrizioni ancora. Le
descrizioni associate al nome Immanuel Kant ne costituiscono il senso. Questo è
problematico -- e se n’era accorto bene anche Frege -- perché comporta che
quasi tutti noi parliamo lingue diverse, se i nomi propri fanno parte della lingua
che parliamo, e se la conoscenza del senso delle espressioni è parte della nostra
competenza linguistica. Infatti, ciascuno di noi associa di solito sensi diversi a
molti dei nomi propri che usa rispetto ai sensi che gli altri vi associano.
Trascuriamo del tutto l’ultima difficoltà che ho indicata, e prendiamo due delle
descrizioni citate sopra come descrizioni che ci danno il senso del nome
Immanuel Kant. Prendiamo le descrizioni ‘Il filosofo di Koeningsberg’ e ‘L’autore
de La critica del gusto’. Una prima difficoltà, circa la prima descrizione, sta nel
fatto che essa non descrive unicamente Kant, ma, per esempio, anche Knutzen,
eppure, nessuno di noi direbbe che chi usa il nome Immanuel Kant associandovi
solo questo senso non faccia riferimento a Immanuel Kant, perché la descrizione
definita associata a quel nome è impropria ed è soddisfatta tanto da Immanuel
Kant quanto da Martin Knutzen. Nessuno di noi risponderebbe (e strettamente in
quella teoria non potrebbe neanche farlo): “Vuoi parlare di Immanuel Kant o di
Martin Knutzen?” Prendiamo l’altra descrizione, invece. Supponiamo, questa
volta, che Reinhard Brandt, che attualmente cura l’edizione dell’opera kantiana
per conto dell’Accademia di Goettingen, faccia una scoperta sensazionale, e
certamente impossibile, anche per le differenti capacità di scrittura dei due
13
personaggi, e scopra che Kant rubò a Goethe una serie di appunti, in effetti il testo
della Critica del gusto, e lo pubblicò a proprio nome, come già sappiamo. Non ci
interessa sapere perché Goethe non protestò mai pubblicamente. Rispetto al
nostro problema, il riferimento del nome Immanuel Kant, diremo allora che
Johann Wolfgang von Goethe è il riferimento del nome Immanuel Kant? E come
faremo a dire che Immanuel Kant non è l’autore della Critica del gusto? Queste
difficoltà suggeriscono, secondo Kripke, che c’è qualcosa che non funziona nella
teoria del riferimento di Frege.
Per Kripke, un nome proprio, come già per Mill, ha una denotazione ma non ha
alcuna connotazione, o, fregeanamente, alcun senso. Un nome viene ‘attaccato’
a ciò cui si riferisce attraverso un atto, per così dire di battesimo, a volte
servendosi occasionalmente di una descrizione appunto per fissarne il
riferimento. Successivamente il nome è usato, con l’intenzione di usarlo così
come lo si era usato in precedenza, o come l’aveva usato chi l’aveva introdotto,
in una catena di riferimenti derivati abbastanza normale. Ma una volta introdotto
un nome ha, a
differenza di una descrizione, un riferimento rigido, e si riferisce a uno stesso
individuo, in tutti i mondi in cui quell’individuo esiste. A differenza delle
descrizioni definite, che, dicevo, possono, in mondi diversi, esser soddisfatte da
individui diversi. Potremmo immaginare, per esempio, un mondo in cui il padre
di Kant si fosse traferito, intorno al 1721, a Berlino, cercandovi miglior fortuna, e
che Kant fosse nato, vissuto, avesse insegnato e fosse morto a Berlino. E
potremmo immaginare anche che in quello stesso mondo Georg Wihlelm
Frieedrich Hegel fosse nato a Koeningsberg, e qui fosse vissuto, avesse insegnato,
essendovi stato trattenuto pagandolo con uno stipendio per l’epoca altissimo, e
qui fosse poi morto. Allora, lasciando da parte per un momento Martin Knutzen,
la descrizione ‘Il filosofo di Koeningsberg’ sarebbe in questo altro mondo Hegel e
non Kant. Ma, nell’abbozzo di teoria del riferimento presentato da Kripke, Kant
continuerebbe in ogni caso a far riferimento a Kant. (Kripke, in verità, introduce
una restrizione importante, quando esclude che si possa immaginare che
Immanuel Kant possa essere stato generato da uno spermatozoo e da un uovo
diversi da quelli da cui è stato generato.)
La teoria del riferimento rigido risolve l’identificazione transmondi di individui,
in quanto l’identificazione di un individuo è fatta nel mondo attuale, nel nostro
mondo, e resta fissa in tutti gli altri mondi possibili.
Kripke applica questa teoria del riferimento, oltre che ai nomi propri, anche ai
termini masso o di sostanza e ai termini di specie naturale, come ‘oro’, ‘tigre’,
ecc. Cosa significa ‘tigre’? Guardando il dizionario si potrebbe rispondere: “Una
tigre è un grande felino quadrupede carnivoro, con il manto fulvo rossiccio con
strisce trasversali nere e la pancia bianca”. Ma, primo, non solo non sarebbe
contraddittorio chiamare tigre un’animale che corrispondesse alla descrizione
precedente tranne per il fatto di avere tre zampe anziché quattro. Inoltre,
secondo, un animale che soddisfacesse la descrizione precedente, ma che avesse
una struttura interna diversa da quella di una tigre, non lo diremmo una tigre. E
14
l’argomentazione potrebbe andare avanti, mostrando, che per i nomi di specie
naturale, come per quelli di sostanze come l’oro, l’acqua, ecc., come per certe
proprietà naturali quali il calore, la situazione nonostante le apparenze è assai
simile a quella dei nomi propri di cui abbiamo parlato poco fa. Una volta che
abbiamo dimostrato che le tigri sono una specie naturale, allora soltanto un
animale che è come la tigre che abbiamo, in una gabbia, davanti a noi, diremo
che è una tigre, o soltanto un animale che è come un animale di quelli che gli
zoologi chiamano tigre lo chiameremo appropriatamente tigre.