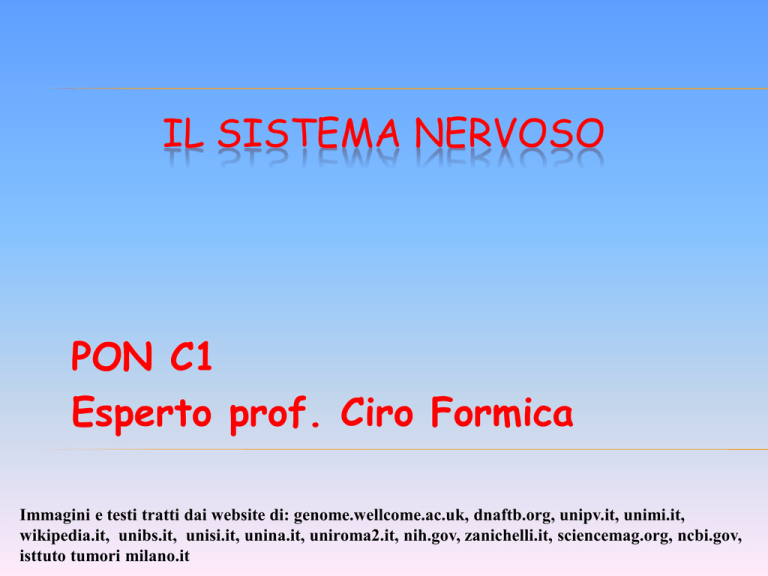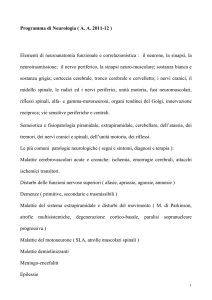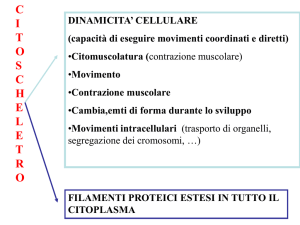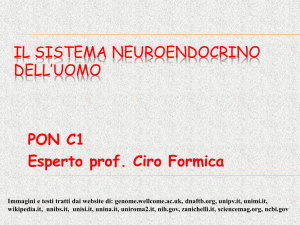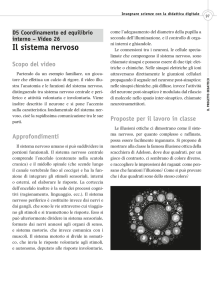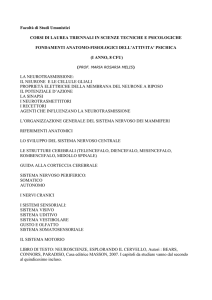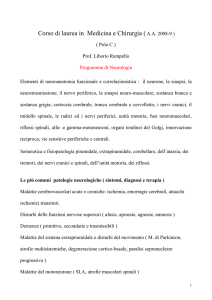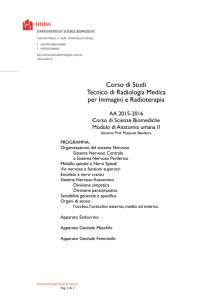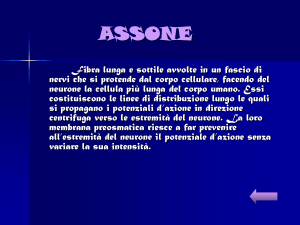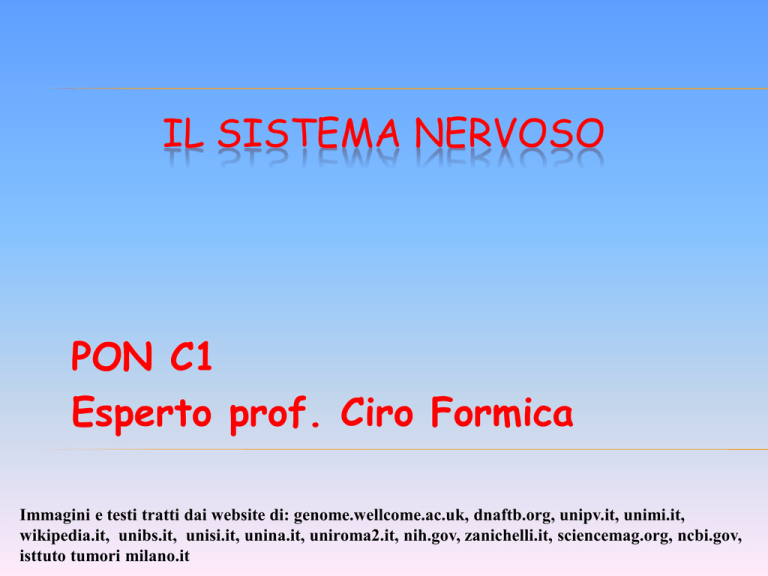
IL SISTEMA NERVOSO
PON C1
Esperto prof. Ciro Formica
Immagini e testi tratti dai website di: genome.wellcome.ac.uk, dnaftb.org, unipv.it, unimi.it,
wikipedia.it, unibs.it, unisi.it, unina.it, uniroma2.it, nih.gov, zanichelli.it, sciencemag.org, ncbi.gov,
isttuto tumori milano.it
IL NEURONE
I dendriti sono sistemi di ricezione di messaggi
provenienti da altri neuroni. In alcuni casi sono
ricoperti da strutture specializzate chiamate
spine dendritiche
≈1011 neuroni nel sistema nervoso umano
≈1014 connessioni nel sistema nervoso umano
2
CELLULE GLIALI O NEVROGLIA
Molto più numerose dei neuroni (10x)
oligodendrociti
produzione mielina SNC
c. Schwann
produzione mielina SNP
astrociti
sostegno, riparazione, scambi metabolici
c. ependimali
rivestimento, staminali
microglia
macrofagi
3
TRASMISSIONE IMPULSO NERVOSO
Quando l’assone si depolarizza l’impulso si propaga mediante il potenziale
d’azione. In assenza di impulsi nervosi, l’interno della membrana dell’assone è
carico negativamente rispetto al’esterno. Ai due lati la differenza di potenziale è –
70 mV (potenziale di membrana a riposo).
I canali Cl- normalmente sono chiusi. I soli ioni che possono efficacemente
attraversare la membrana plasmatica di un neurone sono gli i cationi Na+ e K+.
L’esterno a riposo è carico positivamentemaggiore concentrazione di Na+ , i cui
canali sono chiusi, anche se il gradiente elettrochimico è favorevole
l’interno negativamentele cariche negative delle proteine prevalgono sui K+
(anche se molti canali K+ sono aperti) e li trattengono all’interno (fig.1). Per
mantenere il pot.membrana la pompa sodio-potassio (un’ATPasi elettrogenica)
spinge 3 Na+ all’esterno e 2 K+ all’interno della membrana. La pompa
contribuisce anche a mantenere la pressione osmotica normale della cellula.
DEPOLARIZZAZIONE diminuzione del PRM (meno negativo) verso il valore
0 in seguito ad apertura dei canali Na+ (che entra nella cellula) a causa di uno
stimolo ne consegue ECCITAZIONE
IPERPOLARIZZAZIONE aumento del PRM in seguito ad apertura dei canali
K+ (lo ione esce all’esterno) e chiusura dei canali Na+ a causa di uno stimolo
INIBIZIONE
RIPOLARIZZAZIONE ripristino potenziale di riposo (PRM)
4
Una depolarizzazione oltre un valore critico di soglia induce il
POTENZIALE D’AZIONE (PA), fluttuazione elettrica che viaggia lungo
la membrana della cellula eccitabile, con rapida inversione della polarità
di membrana in presenza di un impulso: l’interno diventa
temporaneamente positivo rispetto all’esterno. Durata: nervoso 1-2 ms,
muscolare 5-10, cardiaco 2-400 ms. Fasi del PA:
1) PRM
2) stimolo depolarizzante
3) depolarizzazione soglia. GNa
(apertura canali Na V-dip.) ingresso
Na+. Inizia GK (apertura canali K Vdip.)
4) entrata rapida Na+ inversione
polarità.
5) inattivazione canali Na+, GK
6) uscita di K+ ripolarizzazione.
7) perdura apertura canali K+
iperpolarizzazione postuma.
8) i canali K+ si chiudono.
9) conduttanza di membrana e PM
tornano al valore di riposo.
5
PERIODO REFRATTARIO Breve periodo in cui la membrana non risponde ad
alcuno stimolo, anche se di intensità elevata, oppure risponde a stimoli molto
intensi con potenziali d’azione più frequenti.
CONDUZIONE SALTATORIA Nelle fibre mieliniche la guaina ha proprietà
isolanti, quindi per la propagazione dell’impulso le modificazioni elettriche della
membrana si possono verificare solo nei nodi di Ranvier, in cui la guaina si
interrompe. È in questi nodi che sono presenti i canali del sodio e del potassio e il
flusso di corrente “salta” la guaina mielinica da un nodo a un altro. La velocità di
conduzione dipende da:
- diametro: se maggiore + veloce è la conduzione degli impulsi;
-presenza o assenza MIELINA: fibre mieliniche conducono gli impulsi più
velocemente di quelle amieliniche . Fibre più veloci, innervano i muscoli
scheletrici, (V=130 m/s=450 km/h ). Fibre+lente: corpuscoli cutanei (v=0,5 m/s)
Le cellule di Schwann (oligodendrociti) sono cellule gliali che si avvolgono a
spirale attorno agli assoni formando una guaina isolante costituita da mielina. La
guaina mielinica non è continua, ma presenta un certo numero di interruzioni, i
nodi di Ranvier, a intervalli regolari.
La mielina costituisce buona parte della sostanza bianca del sistema nervoso.
La sostanza grigia è costituita dai corpi neuronali
6
SINAPSI CHIMICHE
Tipi di sinapsi:
asso-dendritica
asso-somatica
asso-assonica
Le sinapsi eccitatorie causano depolarizzazione
Le sinapsi inibitorie causano iperpolarizzazione
Principali neurotrasmettitori
Amminoacidi
Ammine biogene (catecolamine)
GABA e glicina (inibitorie) Serotonina (ecc/inib)
Glutammato (eccitatoria)
Neuropeptidi
Endorfine
Dopamina (eccitatorie)
Adrenalina/Noradrenalina (Ecc/inib)
Acetilcolina (eccitazione muscoli)
citosol
Terminale
presinaptico
Molecole di trasmettitore
in vescicole sinaptiche
citosol
recettore
Dendrite
postsinaptico
recettore
flusso unidirezionale dell’informazione
7
Le sinapsi chimiche sono caratterizzate da neurotrasmettitori
chimici che, passando dal neurone pre-sinaptico a quello postsinaptico, trasmettono l'impulso nervoso. Questo tipo di
trasmissione rende la giunzione unidirezionale. Inoltre c’è un
addensamento di mitocondri e di vescicole sinaptiche che si trovano
all'interno dei bottoni sinaptici. Le tipiche vescicole sinaptiche sono
piccole e chiare e contengono un mediatore chimico, acetilcolina,
noradrenalina, dopamina, o altri neurotrasmettitori (ogni vescicola
ne contiene circa 10'000 molecole). Nella zona presinaptica vi sono
enzimi capaci di sintetizzare le molecole dei mediatori chimici
(colinoacetilasi, dopaminaidrossilasi), mentre lungo la membrana
post-sinaptica vi sono altri enzimi capaci di distruggere le molecole
di tali mediatori (acetilcolinaesterasi, monoaminossidasi).
Le sinapsi elettriche sono invece giunzioni attraverso le quali il
potenziale si trasmette senza interruzioni neuroneneurone o
neuroneorgano, es. cuore e canale digerente
8
LA GIUNZIONE NEUROMUSCOLARE
È detta anche placca motrice ed è
l'area di contatto fra fibra nervosa e
fibra muscolare. È una sinapsi
chimica e come in tutte le sinapsi,
l'assone perde la guaina mielinica, si
scompone in un numero elevato di
filamenti (arborizzazioni terminali)
ed ogni filamento forma il bottone
sinaptico. All'interno dei bottoni si
trovano i mitocondri, le vescicole
sinaptiche (400-500 Å) piene di
acetilcolina e l'enzima che la
sintetizza. Nella membrana postsinaptica sono presenti proteine
integrate che costituiscono recettori
specifici per l'acetilcolina
Gli assoni di un nervo motore,
nel muscolo scheletrico, si
ramificano enormemente
giungendo ad ogni singola
fibra muscolare. Ogni gruppo
di fibre posto sotto il controllo
di un singolo assone è
denominato unità motoria
9
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE
L’ENCEFALO SI SUDDIVIDE IN:
CERVELLETTO
Rombencefalo e
mesencefalo (parte
antica)
Tronco encefalico
EMISFERI CEREBELLARI
bulbo (midollo allungato)
ponte
mesencefalo
PROSENCEFALO
(parte + recente)
Diencefalo (talamo e
ipotalamo)
TELENCEFALO
EMISFERI CEREBRALI
10
ENCEFALO: TELENCEFALO, CERVELLETTO, TRONCO
ENCEFALICO
11
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE
Il cervello è in grado di modificare la sua attività elettrica in risposta
a diversi stimoli (ad esempio un dato da memorizzare). Tali
modifiche possono avvenire sia a livello dei neuroni, che formano i
circuiti cerebrali, che di sinapsi.
Il corpo calloso, struttura connette i due emisferi cerebrali
Il sistema sensomotorio è organizzato gerarchicamente (aree
corticali primarie, aree secondarie, aree associative). Al livello "più
alto" si trova la corteccia parietale posteriore, su cui convergono
informazioni visive, somestesiche, uditive (coordinate spaziali). A
livello "intermedio" sono la c. motoria supplementare
(coordinamento di movimenti complessi) e quella premotoria
(inibizione di movimenti riflessi e controllo dei programmi motori).
12
Il cervello possiede un’attività elettrica spontanea, come il cuore, i muscoli, la
retina, che è possibile misurare mediante l’elettroencefalogramma EEG come per
il cuore c’è l’ECG. i muscoli l’EMG. . Per eseguirlo si collocano alcuni elettrodi
sulla superficie del cuoio capelluto, collegandoli all’apparecchio che registra le
onde cerebrali, sia durante la veglia che durante il sonno, il momento più adatto
per esaminare il cervello.
•REM = rapid eye movement Sonno tranquillo o profondo. Costituisce il 25%
del sonno
•NREM (No RapidEyeMovement) Sonno attivo. 75%
In totale nel sonno si alternano 4-6 cicli di sonno REM/NREM.
La maggior parte dei sogni si verifica al risveglio dal sonno
REM (sogni carichi di emotività)
la restante al risveglio dal sonno non-REM (sogni più realistici).
Forse il sonno REM e il sogno servono alla cancellazione e/o consolidamento delle
informazioni in memoria
Onde elettriche cerebrali (EEG):
delta, theta sonno profondo
alfa rilassamento ad occhi chiusi
beta, gamma veglia con attenzione e concentrazione.
Vengono misurati potenziali elettrici dell’ordine dei millivolt e microvolt
13
All’ipotalamo giungono informazioni
sullo stato degli organi interni (visceri),
relative all’appetito, gli stimoli sessuali,
sonno-veglia; sensazioni termiche,
dolorifiche,
temperatura, concentrazione di ormoni
•osmolarità plasmatica (osmocettori),
•glicemia (glicocettori),
Sistema limbico. È un’area di integrazione che collega l’ipotalamo
con la corteccia cerebrale. Partecipa all’elaborazione delle emozioni
e alla regolazione del sonno. È costituito da: ippocampo e amigdala
che, insieme alla corteccia prefrontale e al talamo, partecipano alla
fissazione della memoria
14
SISTEMA NERVOSO PERIFERICO
Nel SNP sono presenti:
-33 paia di nervi SPINALI, che hanno una
disposizione metamerica nel senso che
originano dal midollo spinale e si dirigono, a ds
e a sn, verso i rispettivi organi.: nel torace e
nell’addome gli organi sono generalmente allo
stesso livello dei rispettivi nervi, mentre i nervi
lobo-sacrali si dirigono ad angolo acuto verso il
basso.
- 12 paia di nervi
CRANICI o encefalici,
che hanno origine dal
tronco encefalico e si
dirigono in alcune
regioni della testa e del
collo, e in parte nel
torace e l’addome
(nervo VAGO)
15
LE 12 PAIA DI NERVI CRANICI O ENCEFALICI
1 – OLFATTIVO
2 – OTTICO
3 – OCULOMOTORE
COMUNE
4 – TROCLEARE
5 – TRIGEMINO
6 – ABDUCENTE
7 – FACIALE
8 – STATOACUSTICO
9 – GLOSSOFARINGEO
10 – VAGO
11– ACCESSORIO
12 – IPOGLOSSO
16
ESEMPI DI NERVI CRANICI: II E III
Paio
Nome
II
Ottico
III
Funzione
Trasmette le immagini dalla
retina al cervello (area corticale
visiva lobo occipitale)
Origine: cellule gangliari
retiniche. Si distribuisce alle
cellule bipolari e quindi ai coni (45 milioni, colori e visione diurna)
e ai bastoncelli (75 milioni, visione
notturna) della retina
Oculomotore Costrizione della pupilla;
Accomodazione = messa a fuoco
da vicino: si contraggono il
m.ciliare, il cristallino e la pupilla,
convergono gli assi visivi
Controlla i muscoli che muovono
le palpebre e ruotano il globo
oculare in alto/basso/medialmente
Conseguenze
della lesione dei
nervi
Cecità o visione
ridotta
Note
Tipologia nervo
Impossibilità di
messa a fuoco.
Mancata risposta
agli stimoli
luminosi
Miosi
Visceroeffettore
(parasimpatico): Somatomotore
costrizione
pupilla
Midriasi
(ortosimpatico):
dilatazione
pupilla
Viscerosensitivo
17
SISTEMA NEUROVEGETATIVO O AUTONOMO
Origine nervi
Reg. toracica e
lombare
Assone pregangliare
Vicino al SNC
Post-gangliare
neurotrasmettitori
Lontano da organo
bersaglio
principalmente
noradrenalina
ORTOSIMPATICO
PARASIMPATICO
Reg. cranica e
sacrale
Lontano dal
SNC
vicino o dentro
l’organo bersaglio
acetilcolina
18
SISTEMA NERVOSO AUTONOMO
Organi sui quali agisce
19
SISTEMA NERVOSO AUTONOMO
Le azioni dell’ORTOSIMPATICO sono di norma opposte a quelle del PARASIMPATICO.
ORTO
PARA
Secrezione salivare
Diametro bronchiale
Diametro pupillare
secrezione enzimi
dilatazione
midriasi (dilata)
secrezione acquosa
costrizione
miosi (restringe)
Frequenza cardiaca
Motilità e secrezione
apparato digerente
Vescica urinaria
accelera
riduce
rallenta
aumenta
inibisce
stimola
20