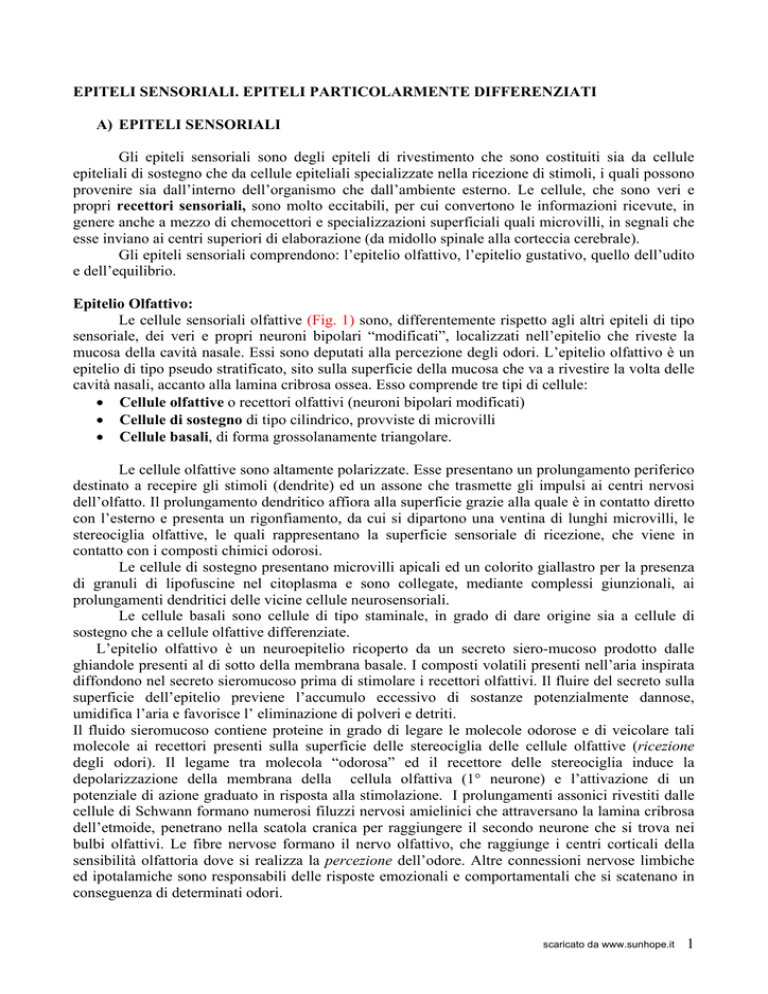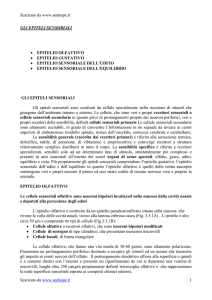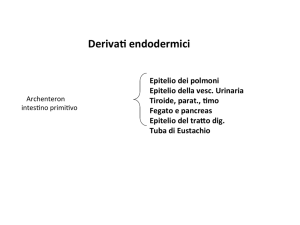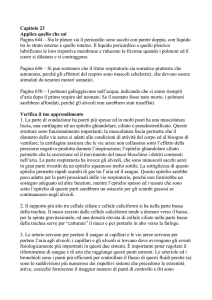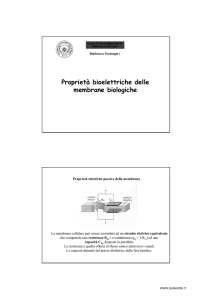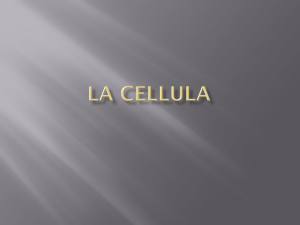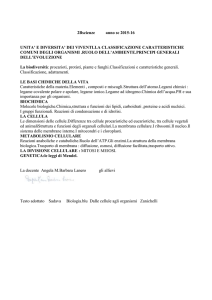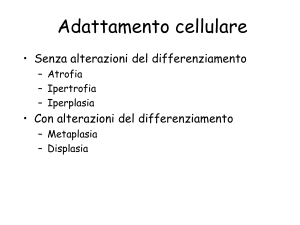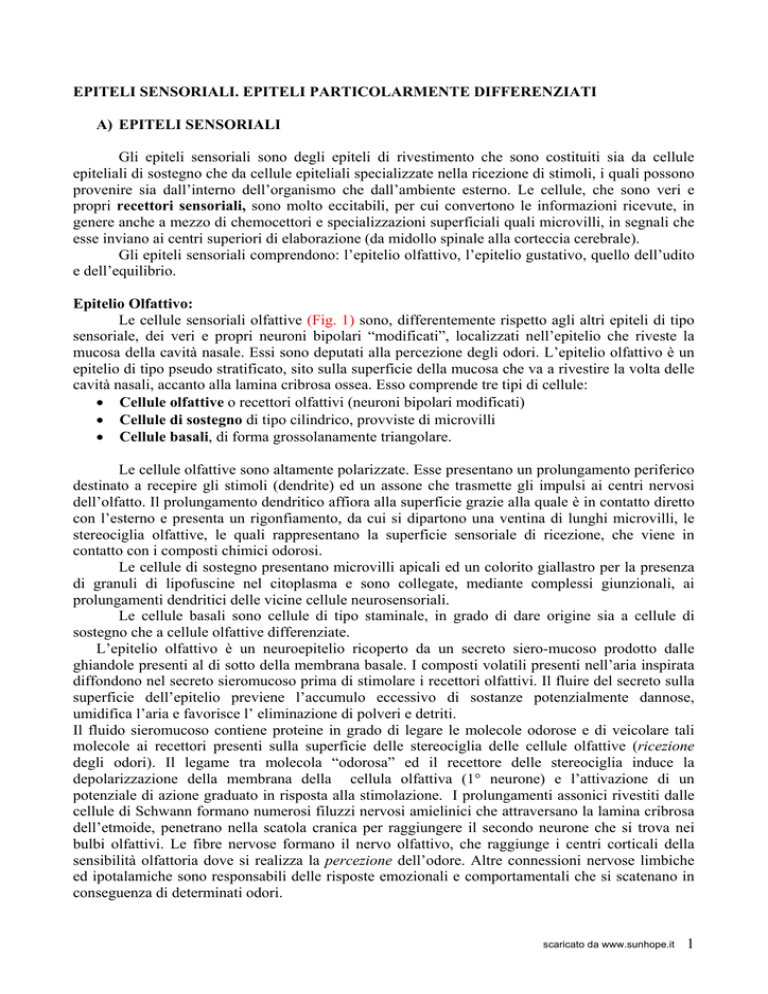
EPITELI SENSORIALI. EPITELI PARTICOLARMENTE DIFFERENZIATI
A) EPITELI SENSORIALI
Gli epiteli sensoriali sono degli epiteli di rivestimento che sono costituiti sia da cellule
epiteliali di sostegno che da cellule epiteliali specializzate nella ricezione di stimoli, i quali possono
provenire sia dall’interno dell’organismo che dall’ambiente esterno. Le cellule, che sono veri e
propri recettori sensoriali, sono molto eccitabili, per cui convertono le informazioni ricevute, in
genere anche a mezzo di chemocettori e specializzazioni superficiali quali microvilli, in segnali che
esse inviano ai centri superiori di elaborazione (da midollo spinale alla corteccia cerebrale).
Gli epiteli sensoriali comprendono: l’epitelio olfattivo, l’epitelio gustativo, quello dell’udito
e dell’equilibrio.
Epitelio Olfattivo:
Le cellule sensoriali olfattive (Fig. 1) sono, differentemente rispetto agli altri epiteli di tipo
sensoriale, dei veri e propri neuroni bipolari “modificati”, localizzati nell’epitelio che riveste la
mucosa della cavità nasale. Essi sono deputati alla percezione degli odori. L’epitelio olfattivo è un
epitelio di tipo pseudo stratificato, sito sulla superficie della mucosa che va a rivestire la volta delle
cavità nasali, accanto alla lamina cribrosa ossea. Esso comprende tre tipi di cellule:
• Cellule olfattive o recettori olfattivi (neuroni bipolari modificati)
• Cellule di sostegno di tipo cilindrico, provviste di microvilli
• Cellule basali, di forma grossolanamente triangolare.
Le cellule olfattive sono altamente polarizzate. Esse presentano un prolungamento periferico
destinato a recepire gli stimoli (dendrite) ed un assone che trasmette gli impulsi ai centri nervosi
dell’olfatto. Il prolungamento dendritico affiora alla superficie grazie alla quale è in contatto diretto
con l’esterno e presenta un rigonfiamento, da cui si dipartono una ventina di lunghi microvilli, le
stereociglia olfattive, le quali rappresentano la superficie sensoriale di ricezione, che viene in
contatto con i composti chimici odorosi.
Le cellule di sostegno presentano microvilli apicali ed un colorito giallastro per la presenza
di granuli di lipofuscine nel citoplasma e sono collegate, mediante complessi giunzionali, ai
prolungamenti dendritici delle vicine cellule neurosensoriali.
Le cellule basali sono cellule di tipo staminale, in grado di dare origine sia a cellule di
sostegno che a cellule olfattive differenziate.
L’epitelio olfattivo è un neuroepitelio ricoperto da un secreto siero-mucoso prodotto dalle
ghiandole presenti al di sotto della membrana basale. I composti volatili presenti nell’aria inspirata
diffondono nel secreto sieromucoso prima di stimolare i recettori olfattivi. Il fluire del secreto sulla
superficie dell’epitelio previene l’accumulo eccessivo di sostanze potenzialmente dannose,
umidifica l’aria e favorisce l’ eliminazione di polveri e detriti.
Il fluido sieromucoso contiene proteine in grado di legare le molecole odorose e di veicolare tali
molecole ai recettori presenti sulla superficie delle stereociglia delle cellule olfattive (ricezione
degli odori). Il legame tra molecola “odorosa” ed il recettore delle stereociglia induce la
depolarizzazione della membrana della cellula olfattiva (1° neurone) e l’attivazione di un
potenziale di azione graduato in risposta alla stimolazione. I prolungamenti assonici rivestiti dalle
cellule di Schwann formano numerosi filuzzi nervosi amielinici che attraversano la lamina cribrosa
dell’etmoide, penetrano nella scatola cranica per raggiungere il secondo neurone che si trova nei
bulbi olfattivi. Le fibre nervose formano il nervo olfattivo, che raggiunge i centri corticali della
sensibilità olfattoria dove si realizza la percezione dell’odore. Altre connessioni nervose limbiche
ed ipotalamiche sono responsabili delle risposte emozionali e comportamentali che si scatenano in
conseguenza di determinati odori.
scaricato da www.sunhope.it
1
Disturbi nella percezione degli odori: Nell’ambito dei milioni di neuroni sensoriali, ogni recettore
rivela un sottogruppo di 10.000 diversi tipi di odori. E’ probabile che esistano almeno 30 diversi tipi
di recettori olfattivi in grado di percepire altrettanti diversi odori primari, dal momento che sono
state individuate almeno 30 anosmìe (incapacità nel percepire un determinato odore). L’anosmia
può essere causata anche da traumi cranici o da tumori che comprimano i nervi olfattivi. Le cellule
di sostegno, insieme al fluido sieromucoso, contribuiscono alla rimozione dei residui di molecole
odorose, in quanto contengono enzimi in grado di inattivare tali molecole mediante processi di
idrossilazione e glucuronidazione .
Con l’aumentare degli anni si osserva un declino nel numero dei recettori olfattivi e,
conseguentemente, una diminuzione della percezione olfattiva.
Come si dirà più avanti, l’ipo-osmìa si associa sovente alla diminuzione della percezione dei sapori
(ipogeusìa).
Anche la semplice congestione della mucosa nasale dovuta, per esempio, ad un raffreddore,
determina una eccessiva secrezione di muco e diminuzione dell’olfatto.
Epitelio Gustativo
Gli organi sensitivi specializzati nella percezione del gusto sono localizzati nei calici gustativi (Fig.
2), distribuiti nella mucosa della lingua e del palato. I recettori gustativi, organizzati in gemme o
calici gustativi, sono distribuiti in aree determinate della lingua, la cui regione dorsale presenta
rilievi macroscopici di connettivo ed epidermide, chiamati papille linguali (Fig. 3), delle quali si
distinguono quattro tipi:
• Papille filiformi
• Papille fungiformi
• Papille circumvallate
• Papille foliate
Le papille filiformi sono appendici coniche presenti in gran parte nella parte anteriore della
lingua, le cui cellule apicali sono fortemente cheratinizzate e vanno incontro a continua
esfoliazione. Le papille fungiformi, disperse tra le filiformi e presenti prevalentemente nei due terzi
anteriori della lingua, hanno la parte superiore di forma emisferica e presentano un asse connettivale
ed un epitelio che lateralmente è provvisto di gemme gustative.
Le papille circumvallate (in numero che varia da 6 a 14) sono confinate nella parte
posteriore della lingua, ove formano il V linguale e sono costitutite da un epitelio pluristratificato
che ai lati presenta circa 100 gemme gustative per ciascuna papilla.
Le papille foliate, ben evidenti nel bambino, nell’adulto sono solo rudimentali.
Le gemme gustative sono quindi organi del gusto particolarmente protetti perché si trovano
in posizione intraepiteliale, ai lati delle sole papille fungiformi e circumvallate, oltre che
nell’epitelio del palato. Morfologicamente sono pertanto formazioni ovoidali infraepiteliali
costituite da 50-75 cellule allungate fusiformi, disposte a “doghe di botte” attorno ad una piccola
escavazione che si apre all’esterno attraverso un poro gustativo, attraversato dalle molecole
contenute negli alimenti. Sono in numero di circa 3000 nella lingua umana e hanno una vita media
di circa 14 giorni.
Nelle gemme gustative vengono distinti vari tipi cellulari:
• Cellule del gusto di tipo allungato (cellule recettoriali)
• Cellule di sostegno
• Piccole cellule basali indifferenziate (cellule staminali)
Istofisiologia
Le cellule del gusto sono chemiocettori in grado di rilevare quattro categorie di gusto: dolce,
acido, salato e amaro. Sono provviste di numerosi microvilli sulle membrane apicali e presentano
nel citoplasma vescicole contenenti neurotrasmettitori.
scaricato da www.sunhope.it
2
•
I recettori dei microvilli delle cellule del gusto, attivati a seguito del legame con le molecole
contenute negli alimenti, inducono la depolarizzazione della membrana cellulare.
• Il potenziale che ne risulta induce a sua volta la liberazione dei neurotrasmettitori che
stimolano le terminazioni nervose presenti al di sotto di delle cellule della gemma gustativa.
• Le fibre nervose sensitive fanno capo a diversi nervi cranici e trasportano l’informazione
gustativa alla corteccia cerebrale.
La secrezione delle piccole ghiandole sierose di Von Ebner, presenti nel tessuto connettivo
sottostante, deterge continuamente le papille e le gemme gustative limitando la sensazione di un
determinato gusto ad un breve lasso di tempo.
I gusti percepiti o sensazioni specifiche per ciascun recettore corrispondono al: dolce, amaro, salato
e glutammato di sodio, al grasso (recettore per la glicoproteina CD36).
La percezione è determinata dalla penetrazione della sostanza gustativa nel poro; la sostanza si lega
ad un recettore (TR1 o TR2) sito sulla membrana dei microvilli di una delle cellule recettoriali,
quindi si determinano modificazioni della polarizzazione della membrana che inducono un aumento
della concentrazione intracellulare degli ioni calcio, favorendo così la liberazione di
neurotrasmettitori che stimoleranno le terminazioni nervose collegate dalle giunzioni cito-neurali.
Le sensazioni gustative sono strettamente legate a quelle del gusto e ciò è comprovato ad esempio
dalla perdita di entrambe le sensibilità (ageusia ed anosmìa) con il raffreddore, come accennato
sopra.
Aree di sensibilità al gusto: esistono differenze sensoriali riguardo alla sensibilità primaria. Il
gusto dolce e quello salato sono percepiti prevalentemente sulla punta della lingua, il gusto acido
sui margini laterali, il gusto amaro sulla superficie posteriore della lingua. Le gemme gustative sono
molto più sensibili ai sapori amari (una parte su un milione) e questo rappresenta probabilmente un
meccanismo di protezione nei confronti di sostanze tossiche di tipo acido e nei confronti di molti
potenti veleni. Già verso i 50 anni, la quantità di papille gustative diminuisce e per tale motivo negli
anziani i cibi risultano spesso insipidi e meno appetibili. La riduzione della sensazione gustativa
viene detta ipogeusìa, la sua scomparsa ageusìa, la sua alterazione (sia in incremento che
decremento) disgeusìa.
EPITELIO SENSORIALE DELL’UDITO
I suoni vengono percepiti a livello dell’organo del Corti, formato da cellule del canale cocleare che
poggiano sulla membrana basilare. L’epitelio sensoriale dell’udito è presente nella coclea, una
struttura dell’orecchio interno che, per la sua struttura a spirale, è detta anche chiocciola. La coclea,
(Fig.5) è divisa longitudinalmente da due membrane, la membrana basilare e la membrana
vestibolare o di Reissner da cui si dipartono tre rampe: la rampa timpanica e la rampa vestibolare
(contenente entrambe la perilinfa) e la rampa media ( contenente l’endolinfa). L’elemento che
presiede al senso dell’udito è l’organo del Corti (Fig. 6), posto sopra la membrana basilare e al di
sotto della membrana tectoria, istologicamente è costituito da più serie di fila longitudinali di
cellule capellute e da altri elementi cellulari che nell’insieme comprendono:
• Cellule di sostegno : cellule epiteliali di Hensen, cilindriche, con funzioni di supporto, la
cui porzione apicale avvolge il polo basale delle cellule capellute sensoriali.
• Cellule di Deiters : cellule di sostegno con porzione basale più slargata che poggia sulla
membrana basale e una porzione apicale anch’essa più ampia che delimita una “placca”.
• Cellule capellute esterne : cellule sensoriali di aspetto cilindrico disposte in 3-5 ordini, in
numero di circa 15.000, provviste di 50-100 stereociglia
• Cellule capellute interne :anch’ esse di forma cilindrica, in numero di circa 3.500, allineate
in un solo ordine e che presentano nella regione apicale circa 20 stereociglia.
scaricato da www.sunhope.it
3
•
Pilastri interni ed esterni : disposti in un’unica fila che si uniscono all’apice a guisa di
contrafforti e delimitano la cavità della galleria del Corti.
Istofisiologia
Le cellule capellute sono meccanocettori sensibili a spostamenti del liquido contenuto nella
coclea. Le varie fasi che portano alla trasformazione di un’onda sonora in sensazione uditiva
vengono di seguito solo schematizzate:
• l’onda sonora raggiunge, tramite il condotto auditivo, la membrana del timpano
• le vibrazioni della membrana del timpano vengono trasmesse alla catena degli ossicini
(martello, incudine, staffa) presenti nell’orecchio medio
• lo spostamento della staffa contro la finestra ovale, trasmette oscillazioni alla perilinfa
dell’orecchio interno
• le onde di pressione che si creano determinano vibrazioni della membrana di Reissner che a
sua volta fa vibrare la membrana basilare
• per effetto di tali vibrazioni si creano onde di pressione dell’endolinfa che permettono alla
membrana tectoria di toccare le stereociglia delle cellule capellute sottostanti
determinandone una distorsione.
• la stimolazione meccanica che ne consegue induce l’attivazione del nervo cocleare che
trasmette l’informazione auditiva ai centri acustici corticali del lobo temporale.
Alterazioni sensoriali: Lesioni delle cellule sensoriali capellute della coclea o l’esposizione
cronica a rumori elevati può portare a sordità neurosensoriale. La presbiacusia che è
presente nell’anziano, è causata da una riduzione delle cellule cigliate e dei neuroni dei
gangli spirali.
EPITELIO SENSORIALE DELL’EQUILIBRIO.
Nelle macule dell’utricolo e del sacculo e nelle ampolle dei canali semicircolari sono presenti
speciali recettori preposti alla percezione della posizione statica e dell’accelerazione di gravità.
L’epitelio sensoriale che presiede al senso dell’equilibrio è localizzato nell’apparato vestibolare,
una struttura dell’orecchio interno comprendente l’utricolo, il sacculo e i canali semicircolari. Gli
elementi cellulari di tale epitelio sono situati nelle macule utriculare e sacculare e nelle ampolle dei
canali semicircolari e sono rappresentati da
• cellule capellute di tipo I
• cellule capellute di tipo II
• cellule di sostegno
Le cellule capellute di tipo I e II differiscono tra di loro solo per la localizzazione più o
meno periferica nella macula e per la forma delle terminazioni nervose afferenti. Presentano
apicalmente 50-60 stereociglia e un solo lungo chinociglio. Apicalmente sono rivestite da una
cupola gelatinosa costituita da uno strato mucoso in cui si trovano immersi piccoli cristalli di
carbonato di calcio detti otoliti (Fig. 7).
Le cellule di sostegno presentano brevi microvilli e sono prive di stereociglia.
Istofisiologia
Principali funzioni:
• I cambiamenti di posizione della testa rispetto alla gravità portano ad una diversa
distribuzione degli otoliti che, distorcendo le stereociglia sottostanti, stimolano
meccanicamente le cellule capellute.
scaricato da www.sunhope.it
4
•
•
Lo spostamento delle sterociglia verso il chinociglio depolarizza le cellule capellute e
incrementa la frequenza degli impulsi nervosi registrabili nelle fibre afferenti; il movimento
opposto le iperpolarizza e riduce tale frequenza.
Gli impulsi afferenti inviano le informazioni al cervelletto e alla corteccia cerebrale
fornendo una sensazione cosciente della postura e del movimento.
Alterazioni: Disturbi derivanti da attività motorie non coordinate o inusuali o una eccessiva
produzione di endolinfa, causano distorsioni a livello delle stereociglia dell’epitelio
sensoriale degli organi vestibolari e possono causare vertigini.
EPITELI PARTICOLARMENTE DIFFERENZIATI
Alcuni epiteli del nostro organismo vanno incontro ad una differenziazione così
peculiare da alterare cospicuamente i caratteri morfo-funzionali che ci permettono di poterli
classificare come tali. Difatti, per l’espletamento di funzioni particolari, vanno incontro a
processi differenziativi tali da renderli non riconoscibili come epiteli. Essi sono: l’epitelio
del cristallino, le cui cellule epiteliali originariamente cubiche si sono trasformate in prismi
definite fibre esagonali appiattite, che ne permettono la funzione diottrica; i peli e le unghie,
che sono dei derivati cornei epidermici e lo smalto dei denti, costituito da prismi di
carbonato di calcio, risultato del prodotto di secrezione di cellule, gli adamantoblasti, che
degenerano (per lo smalto vedi capitolo sui tessuti del dente).
Cristallino. La lente o cristallino è una struttura trasparente che ha la forma di una lente
biconvessa (Fig. 8) posta subito dietro la pupilla ed interposto fra l’umor acqueo ed il corpo
vitreo, tutti mezzi diottrici dell’occhio. Esso ha la funzione di mettere a fuoco sulla retina il
fascio luminoso delle immagini grazie al potere di accomodazione-convergenza che gli
permette di variare il proprio raggio di curvatura.
Nell'adulto ha uno spessore di circa 5 mm e un diametro di 9 mm; tuttavia, questi parametri
possono variare.
E’ costituito, sulla superficie anteriore, da un solo strato di cellule epiteliali cubiche (epitelio
cubico semplice) e per il resto da fibre più o meno allungate. Esso è avvolto da un involucro
glicoproteico e collagenico detto capsula del cristallino. Le cellule cubiche dell’epitelio
anteriore, specie verso la zona equatoriale della lente, elaborano proteine, le quali,
accumulandosi trasformano le cellule, che si allungano e si dispongono lungo i meridiani,
differenziandosi in fibre, prismi appiattiti con sei facce, unite a quelle vicine grazie ad una
sostanza cementante. La porzione centrale della lente costituisce il nucleo del cristallino. La
trasparenza delle fibre è dovuta alle proteine specifiche secrete. chiamate alpha-cristalline e
beta-cristalline. Le proteine sono sistemate in circa 20.000 livelli concentrici, con un indice
di rifrazione (per le onde visibili) che può variare da 1,406 nei livelli centrali, fino a 1,386
nella corteccia della lente più densa.
Con l’età il potere di accomodazione-convergenza del cristallino diminuisce così che intorno
ai 40 anni d’età il soggetto non riesce più a mettere a fuoco oggetti di piccole dimensioni e
scritti (libri, giornali etc.) necessitando di occhiali (presbiopia). La presbiopia si accentua
con l’età. Oggi è possibile correggerla anche chirurgicamente. A seguito di malattie o con
l’invecchiamento è anche possibile che il cristallino vada incontro ad opacizzazione per un
processo di ossidazione delle proteine che lo costituiscono, per cui si ha la cosiddetta
cataratta che oggi viene operata con metodica laser e sostituzione con cristallino artificiale.
Altra alterazione della curvatura del cristallino è il cheratocono, deformazione che rende la
lente di tipo grossolanamente conica nella parte centrale e riduce considerevolmente la vista,
scaricato da www.sunhope.it
5
potendosi trattare, nelle fasi iniziali con l’applicazioni di lenti a contatto e, se progredisce,
solo con il trapianto della cornea.
Peli-Capelli
Sono derivati cornei dell’epidermide, accolti in parte nella cute (Fig. 9). Peli e capelli non
hanno differenze se non di spessore.
Ciascun pelo è situato in una invaginazione a fondo cieco che si estende nel derma
sottostante, definita follicolo pilifero. Occorrerà pertanto tener distinte le strutture proprie
del pelo da quelle del follicolo che lo riveste fino all’emergenza.
In ciascun pelo distinguiamo:
-Il fusto, formato da cellule epidermiche disposte in 3 strati concentrici, definiti:
1. Midollare, presente solo nei peli più grossi, formante l’asse centrale, costituita da
cellule poliedriche ricche in glicogeno, granuli di tricoialina (acidofila, simile alla
cheratoialina) e pigmento;
2. Corticale, parte preponderante del fusto, formata da cellule fusiformi fittamente
stipate, cheratinizzate, acidofile, con nucleo picnotico, e pigmento in gran quantità.
Fra le cellule compaiono spazi contenenti aria. L’aumento di tali spazi e la
diminuzione del pigmento che si ha con l’avanzare dell’età, provoca l’incanutimento
o canizie. I peli biondi, rispetto a quelli neri, contengono una minore quantità di
granuli di melanina, laddove quelli rossi contengono melanina solo parzialmente
ossidata.
3. Cuticola o Epidermicola strato sottile, formato da elementi cornificati senza nucleo,
simili a squame, embricate fra di loro come le tegole di un tetto.
-La radice, ha, nella parte più profonda, un rigonfiamento detto bulbo, formato da cellule
disposte attorno alla papilla dermica (piriforme o a forma di lingua di fuoco) e che si
connettono, da una parte con la restante parte della radice e dall’altra con l’epidermide della
parete del follicolo (invaginata) e con la guaìna interna della radice. Quest’ultima circonda
il fusto del pelo subito al di sotto dello sbocco delle ghiandole sebacee ed è costituita,
andando dall’interno verso l’esterno da:
• Cuticola, simile a quella propria del pelo;
• Strato dello Huxley, costituito da 1 a 3 file di cellule con granuli di tricoialina;
• Strato di Henle, formato da 1 solo strato di cellule con granuli, che all’esterno
aderisce all’epidermide del follicolo.
Lo strato profondo del bulbo che è a contatto con la papilla dermica è detto matrice del pelo
costituita da cellule analoghe a quelle dello strato basale dell’epidermide o progenitrici.
Origine del pelo
Il pelo, così come l’epidermide e la ghiandola sebacea annessa in genera ai peli, hanno una
origine comune da un gruppo o nicchia di cellule staminali, localizzate in un’area in
prossimità proprio della ghiandola sebacea e fra questa ed il pelo, definita bulge. Le cellule
del bulge tuttavia non sono le uniche cellule staminali ivi presenti, in quanto sono
annoverate anche i cheratinociti interfollicolari, di tipo staminale e le cellule mesenchimali
della papilla dermica. Orbene, a tutt’oggi non sono ben noti i meccanismi di relazione e
comunicazione fra tali cellule, né la loro perfetta gerarchia nel meccanismo di
differenziamento e crescita del pelo, così come dell’epidermide e della ghiandola sebacea,
pur se sembrerebbe che le cellule progenitrici del pelo, site nella papilla, sono guidate nella
crescita dal “motore” delle cellule del bulge, che ne mantiene il processo di
differenziamento.
Altri autori hanno evidenziato che soltanto in caso di traumi le cellule staminali del bulge
differenziano in cellule epidermiche. Pertanto le cellule staminali delle varie parti
sembrerebbero non solo diversamente indirizzate, ma necessiterebbero, in alcuni casi, di
stimolazioni specifiche e le cellule del bulge differenzierebbero prevalentemente in cellule
della ghiandola sebacea.
scaricato da www.sunhope.it
6
La calvizie è la perdita dei capelli, frequente nei soggetti di sesso maschile e di razza
caucasica (androgenetica), a causa sia dell’attività degli ormoni androgeni, che di fenomeni
vasocostrittori in loco. In corso di alcune malattie si ha alopecia ossia perdita dei capelli o
dei peli spesso a chiazze (aereata).
Unghie
Le unghie (Fig. 10) sono differenziazioni cornee dell’epidermide, presenti sulla faccia
dorsale delle falangi distali delle dita di mani e piedi.
Esse sono costituite da.
• Una lamina, quadrilatera, abbastanza trasparente, poggiante sul letto ungueale, o
piano cutaneo;
• Il vallo ungueale, che la circonda e delimita una doccia detta solco ungueale. Il vallo
ricoprente la porzione prossimale dell’unghia è detta eponichio o cuticola.
Il corpo costituisce la maggior parte dell’unghia, mentre la radice è nascosta in gran parte
dal vallo. L’estremità distale non ha più rapporti con il letto. La parte opposta è detta matrice
e rappresenta lo strato onicogeno che fa crescere l’unghia. La parte restante del letto
ungueale è detta iponichio.
L’unghia lascia intravedere il colore del letto ungueale, costituito dal solo strato germinativo
e spinoso. In corrispondenza della radice si opaca per scarsa cheratinizzazione e
disidratazione, formando la lunula.
L’unghia è formata da numerose lamelle cornee sovrapposte e strettamente adese l’una
all’altra.
LETTURE CONSIGLIATE
1. Greco V, Chen T, Rendl M, Schober M, Pasolli HA, Stokes N, Dela Cruz-Racelis J,
Fuchs E. A two-step mechanism for stem cell activation during hair regeneration.
Cell Stem Cell. 2009 4:155-69.
2. Ma DR, Yang EN, Lee ST A review: the location, molecular characterisation and
multipotency of hair follicle epidermal stem cells. Ann Acad Med Singapore. 2004;
33:784-8. Review.
3. Levy V, Lindon C, Harfe BD, Morgan BA. Distinct stem cell populations regenerate
the follicle and interfollicular epidermis. Dev Cell. 2005, 9:855-61.
4. Ying V. Zhang, Janice Cheong, Nichita Ciapurin, David J. McDermitt, Tudorita
Tumbar Distinct Self-Renewal and Differentiation Phases in the Niche of
infrequently Dividing Hair Follicle Stem Cells Cell Stem Cell, 2009; 5: 267-278
scaricato da www.sunhope.it
7