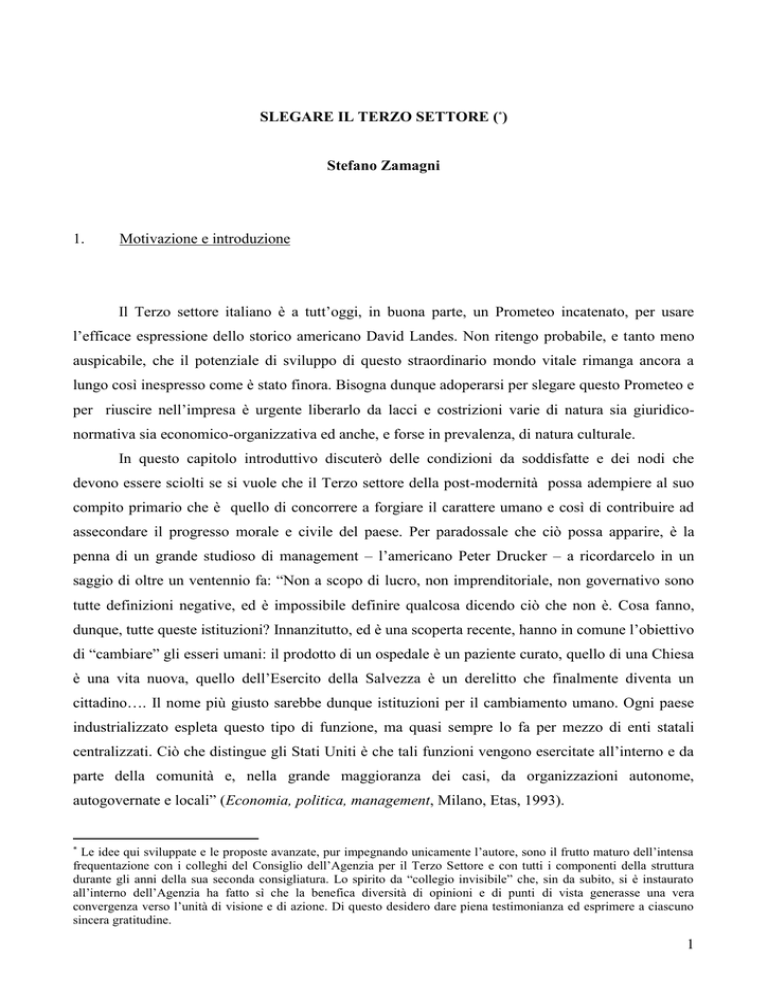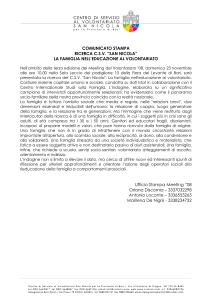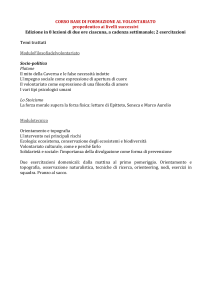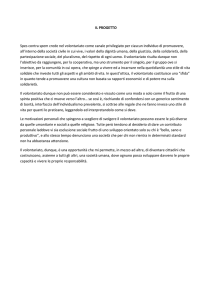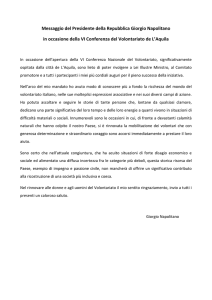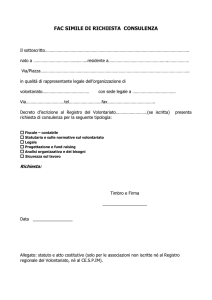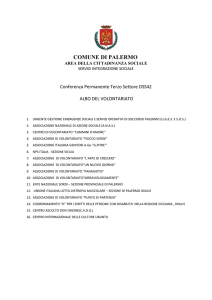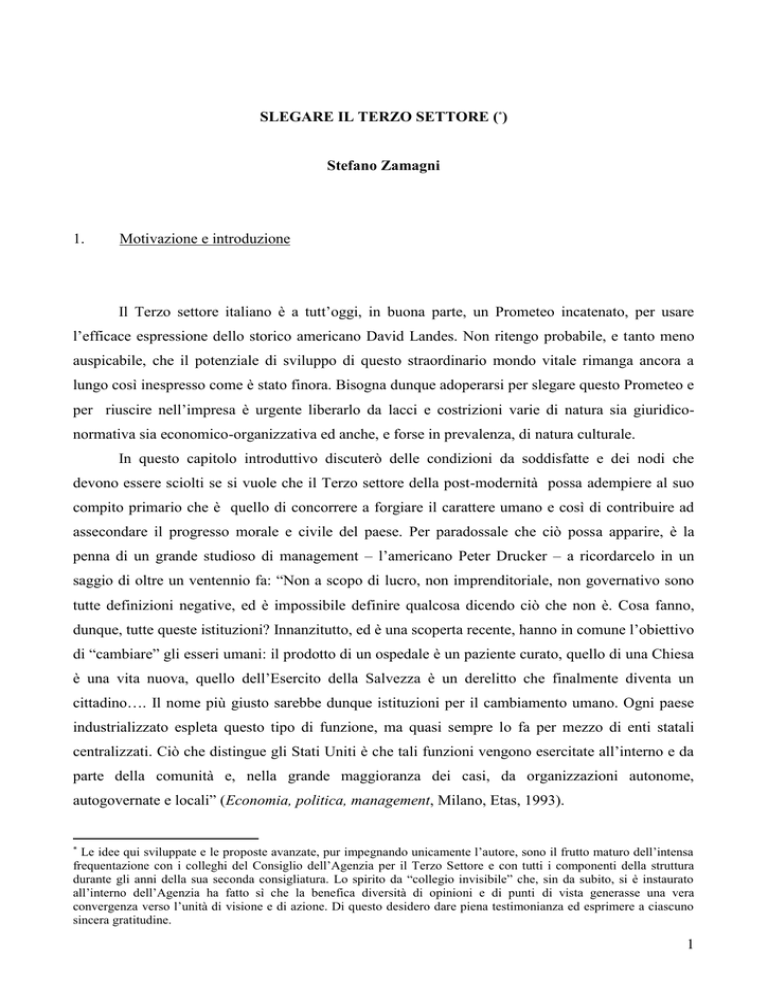
SLEGARE IL TERZO SETTORE (*)
Stefano Zamagni
1.
Motivazione e introduzione
Il Terzo settore italiano è a tutt’oggi, in buona parte, un Prometeo incatenato, per usare
l’efficace espressione dello storico americano David Landes. Non ritengo probabile, e tanto meno
auspicabile, che il potenziale di sviluppo di questo straordinario mondo vitale rimanga ancora a
lungo così inespresso come è stato finora. Bisogna dunque adoperarsi per slegare questo Prometeo e
per riuscire nell’impresa è urgente liberarlo da lacci e costrizioni varie di natura sia giuridiconormativa sia economico-organizzativa ed anche, e forse in prevalenza, di natura culturale.
In questo capitolo introduttivo discuterò delle condizioni da soddisfatte e dei nodi che
devono essere sciolti se si vuole che il Terzo settore della post-modernità possa adempiere al suo
compito primario che è quello di concorrere a forgiare il carattere umano e così di contribuire ad
assecondare il progresso morale e civile del paese. Per paradossale che ciò possa apparire, è la
penna di un grande studioso di management – l’americano Peter Drucker – a ricordarcelo in un
saggio di oltre un ventennio fa: “Non a scopo di lucro, non imprenditoriale, non governativo sono
tutte definizioni negative, ed è impossibile definire qualcosa dicendo ciò che non è. Cosa fanno,
dunque, tutte queste istituzioni? Innanzitutto, ed è una scoperta recente, hanno in comune l’obiettivo
di “cambiare” gli esseri umani: il prodotto di un ospedale è un paziente curato, quello di una Chiesa
è una vita nuova, quello dell’Esercito della Salvezza è un derelitto che finalmente diventa un
cittadino…. Il nome più giusto sarebbe dunque istituzioni per il cambiamento umano. Ogni paese
industrializzato espleta questo tipo di funzione, ma quasi sempre lo fa per mezzo di enti statali
centralizzati. Ciò che distingue gli Stati Uniti è che tali funzioni vengono esercitate all’interno e da
parte della comunità e, nella grande maggioranza dei casi, da organizzazioni autonome,
autogovernate e locali” (Economia, politica, management, Milano, Etas, 1993).
Le idee qui sviluppate e le proposte avanzate, pur impegnando unicamente l’autore, sono il frutto maturo dell’intensa
frequentazione con i colleghi del Consiglio dell’Agenzia per il Terzo Settore e con tutti i componenti della struttura
durante gli anni della sua seconda consigliatura. Lo spirito da “collegio invisibile” che, sin da subito, si è instaurato
all’interno dell’Agenzia ha fatto sì che la benefica diversità di opinioni e di punti di vista generasse una vera
convergenza verso l’unità di visione e di azione. Di questo desidero dare piena testimonianza ed esprimere a ciascuno
sincera gratitudine.
*
1
Chiaramente, all’illustre economista d’impresa sfugge che non gli Stati Uniti ma l’Italia
dell’Umanesimo civile è il luogo in cui hanno preso avvio ed hanno iniziato ad operare quelle
“istituzioni per il cambiamento umano” che oggi chiamiamo Terzo settore. E’ a partire, infatti, dal
XIV secolo che inizia a prendere forma quel modello di civiltà cittadina per il quale l’Italia è
giustamente famosa nel mondo. (Per i riferimenti puntuali e per una storia di lungo periodo delle
organizzazioni della società civile, rinvio a L. Bruni, S. Zamagni, Economia Civile, Bologna, Il
Mulino, 2005).
Il fine ultimo al quale mirano queste pagine è quello di portare argomenti a sostegno della
seguente tesi. Come oltre due secoli fa, al tempo della prima rivoluzione industriale, fu la nascente
classe borghese ad inaugurare la nuova stagione, rompendo il vecchio equilibrio sociale centrato
sull’aristocrazia e sulla classe dei rentiers, così oggi sarà una nuova classe di imprenditori sociali e
civili e il complesso dei soggetti della società civile portatori di cultura a trovare la soluzione ai
nuovi problemi dell’attuale fase di sviluppo. Penso, in particolare all’aumento scandaloso delle
disuguaglianze che procede di pari passo con l’aumento della ricchezza; al paradosso della felicità –
il fatto cioè che al di sopra di un certo livello di reddito pro-capite, ulteriori aumenti dello stesso
provocano una diminuzione dell’indice aggregato della felicità pubblica; alle difficoltà crescenti per
risolvere il problema dei commons (i beni di uso comune); alla divaricazione in aumento continuo
tra mercato e democrazia. Si pensi anche al nuovo welfare di cui tanto si va parlando di questi
tempi: esso non verrà né dal privato for profit né dagli apparati politico-amministrativi della sfera
pubblica, ma dalla fioritura dell’area del civile la quale però dovrà conquistarsi quello spazio che
ancora non occupa.
Il Novecento ha cancellato la terziarità nella sua furia costruttivista. Tutto doveva essere
ricondotto o al mercato o allo Stato o tutt’al più ad un mix di queste due istituzioni basilari a
seconda delle simpatie ideologico-politiche dei vari attori societari. E’ oggi diffuso il
convincimento secondo il quale il paradigma bipolare “stato-mercato” abbia ormai terminato il suo
corso storico e che ci si stia avviando verso un modello di ordine sociale tripolare: pubblico,
privato, civile. Una conferma autorevole ci viene dalla riforma del 2001 del Titolo V della nostra
Carta Costituzionale, laddove si afferma esplicitamente che anche i singoli cittadini e i corpi
intermedi della società (art.2) hanno titolo per operare direttamente a favore dell’interesse generale
e dunque devono essere posti nelle condizioni concrete di poterlo fare. La modernità si è retta su
due pilastri: il principio di eguaglianza, garantito e legittimato dallo Stato; il principio di libertà,
reso fattivamente possibile dal mercato. La post-modernità ha fatto emergere l’esigenza di un terzo
pilastro: il principio di reciprocità, che è la cifra delle organizzazioni della società civile, cioè del
Terzo settore.
2
In quel che segue, mi occuperò dapprima della questione definitoria: quale definizione
adottare per il Terzo Settore se si vuole che esso svolga i compiti suggeriti dalla tesi di cui sopra.
Passerò poi a trattare il tema dell’identità specifica del volontariato e del suo compito primario.
Successivamente, volgerò l’attenzione alle implicazioni che discendono dal visualizzare il Terzo
settore come fenomeno emergente anziché come realtà additiva. Da ultimo, mi soffermerò sulla
questione dell’ancoraggio etico del Terzo settore e sulla necessità di arrivare a definire una metrica
per misurare il valore aggiunto sociale. Non scenderò in questa sede sulle implicazioni di ordine
pratico che discendono dai vari argomenti sviluppati, né mi attarderò più di tanto sulle proposte
operative che un Libro Bianco sempre deve offrire. Ad entrambi gli scopi provvedono i capitoli del
presente volume, ai quali farò rinvio di volta in volta.
2.
La questione definitoria
2.1
E’ noto che le tante definizioni di Terzo settore riscontrabili nella letteratura dell’ultimo
quarto di secolo fanno quasi tutte esclusivo riferimento a tre termini, che costituiscono altrettanti
elementi di distinzione: chi; cosa; perché. Quanto a dire che i vari enti non profit si differenziano
tra loro o per l’elemento soggettivo (chi sono gli attori) o per l’elemento oggettivo (la specifica
attività svolta o il settore di intervento) o per l’elemento teleologico (il fine particolare che l’ente si
propone di conseguire) oppure ancora per una combinazione di tutti e tre gli elementi. Ciò che
questa prassi classificatoria lascia in ombra è un quarto termine: come; vale a dire il modo in cui il
soggetto di cui trattasi cerca di conseguire il fine che dà senso alla sua missio nel particolare settore
di intervento in cui ha deciso di operare. Eppure, in un mondo come quello del Terzo settore, il
come si produce (o si opera) è altrettanto importante del cosa e del perchè si produce.
Per rendersene conto, valga il seguente esperimento mentale. Si ponga a confronto l’attività
di una fondazione con quella di una associazione di promozione sociale. Può accadere, come è dato
di osservare, che entrambe le figure giuridiche si rivolgano agli stessi portatori di bisogni, si
occupino di fornire i medesimi servizi e siano costituite dalla stessa tipologia di persone. Dove
risiede allora la differenza? Nel come i due tipi di enti operano nel concreto: mentre l’associazione
agisce sulla base del principio di democraticità – l’associazione, infatti, è un libero coerire di
persone che si organizzano per raggiungere un fine comune – la fondazione non consente la
partecipazione democratica e ciò per l’ovvia ragione che la fondazione è un fondo di risorse
(monetarie e non) per uno scopo, gestito secondo regole fissate dal fondatore (privato o pubblico
che sia). Un Terzo settore costituito esclusivamente (o anche prevalentemente) di soggetti
3
fondazionali non costituirebbe certo un avanzamento sul fronte del progresso civile di una
comunità, anche se sul fronte dell’efficienza e dell’efficacia il modello fondazionale potrebbe
assicurare risultati superiori a quello associativo. La democrazia, infatti, è un valore finale, un
valore cioè che appartiene all’ordine dei fini; l’efficienza invece è un valore strumentale che
appartiene all’ordine dei mezzi. Non è dunque lecito istituire trade-off tra democrazia e efficienza:
la logica dello scambio ha senso ed è ammissibile solamente se applicata a termini che
appartengono al medesimo ordine di cose.
La conseguenza che traggo da quanto precede è che la pluralità delle figure giuridiche nel
Terzo settore è un bene che il legislatore deve difendere ad ogni costo, anche contro i tentativi, di
tanto in tanto ricorrenti, di procedere ad una sorta di reductio ad unum. Il modo di agire (il come) di
fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative, cooperative sociali, imprese sociali è
necessariamente diverso l’uno dall’altro ed è questa diversità ad assicurare la spinta propulsiva del
Terzo settore. Guai dunque a lasciarsi abbacinare da quel pensiero unico che, in nome di un’errata
concezione del principio di efficienza, suggerisce di procedere a cosiddette semplificazioni del
quadro normativo operando per mezzo degli incentivi fiscali o di strumenti regolamentari. Ciò
costituirebbe un pericoloso regresso, dal momento che se si guarda alle origini e agli sviluppi delle
organizzazioni della società civile (OSC), è possibile individuare, all’interno di questo
vasto
mondo una pluralità di modelli identitari, che a loro volta determinano logiche diverse di
funzionamento e di gestione. Tenere conto di ciò è rilevante, oltre che ai fini della governance
interna, anche in riferimento al tipo di relazioni che i soggetti del Terzo Settore intrattengono con le
altre sfere della società.
Tre sono, in particolare, i modelli identitari che è possibile individuare (Cfr. S. Zamagni, Il
Terzo settore nel nuovo welfare, Reggio Emilia, Diabasis, 2010). Il modello di più antica
apparizione, vede le OSC come espressione diretta della società civile, cioè come libera adesione
di persone ad un progetto da realizzarsi in comune per perseguire interessi collettivi, ancorche’ non
universalistici. Al fondo di tale modello troviamo l’accettazione esplicita della sussidiarietà
orizzontale, così come questo principio ha iniziato ad affermarsi all’epoca dell’Umanesimo civile
(XV secolo) per poi trovare una prima sistemazione formale in Ugo Grozio oltre che in Luis
Althusius già nel 1615. Un secondo modello che vede le OSC come emanazione e supporto della
sfera pubblica (da non confondersi con la sfera politica). Rientrano in tale quadro le realtà nonprofit create da soggetti collettivi/categoriali istituzionalizzati (es. il sindacato che crea cooperative
sociali; Enti Locali che promuovono la nascita di ONP; enti pubblici locali trasformati in fondazioni
di partecipazione etc.). Il principio regolativo di tale modello è il decentramento, cioè la
sussidiarietà verticale: “Non faccia lo Stato ciò che possono fare gli enti di livello inferiore e i
4
soggetti della società civile”. Si noti la differenza: mentre con la sussidiarietà verticale si ha una
cessione di quote di sovranità, con la sussidiarità orizzontale si ha una condivisione di sovranità.
Infine, il modello di più recente affermazione vede il Terzo settore come espressione diretta del
settore for profit. Rientra in questo ambito la recente e diffusa pratica di creazione di ONP specialmente di fondazioni di impresa- da parte di imprese for profit.
Si pensi al corporate
philanthropy che si sta diffondendo anche nel nostro paese. Alla base di tale modello troviamo il
“principio di restituzione”: il soggetto for profit “restituisce” alla società una parte del profitto
conseguito, perché quest’ultimo è stato ottenuto anche grazie alla esternalità che la società è stata in
grado di porre a disposizione dell’impresa. Un esempio recente e notevole di tale modello è
costituito dal progetto “giving pledge” (impegno di dare) promosso negli USA da Bill Gates e
Warren Buffet, finora sottoscritto da una cinquantina di miliardari che si sono impegnati a
devolvere fino al 50% del loro patrimonio a favore di cause socialmente rilevanti.
L’indagine storica delle dinamiche di ibridazione dei tre modelli identitari, per un verso, ci
testimonia una contaminazione reciproca degli stessi, e per l’altro verso, dice dell’esigenza di
comprendere il senso, cioè la direzione del movimento. La legislazione comunitaria europea viene
assumendo sempre più, negli ultimi anni, un ruolo cruciale per lo sviluppo e la diffusione delle
OSC, sancendo opportunità di crescita e ponendo inevitabili vincoli organizzativi, che vanno ad
incidere, in maniera, a volte massiccia, sull’identità dell’organizzazione stessa. La questione
cruciale con cui è urgente fare i conti è allora decidere se si vuole che i diversi modelli si pongano
tra loro in modo conflittuale così che alla fine un solo modello sarà nei fatti destinato a prevalere,
oppure si vuole che essi possano coesistere. (Cfr. P. Donati (a cura di), Verso una società
sussidiaria, Bologna, Bononia University Press, 2011).
2.2
Non è difficile cogliere le implicazioni delle due alternative. Scegliere la prima significa, di
fatto, favorire la dominanza, a lungo andare, del terzo modello identitario. Ora, chi ritiene – e chi
scrive è tra questi – che vi siano ragioni forti per ritenere non desiderabile un esito del genere deve
esprimersi a favore della seconda alternativa. Ma quali sono queste ragioni forti? Ne indico due.
La prima di queste chiama in causa quel principio personalista che l’Assemblea Costituente
volle porre a fondamento della nostra Carta Costituzionale, preferendolo sia al principio
individualista sia a quello collettivista. Fu Giuseppe Dossetti con un ordine del giorno del 9
settembre 1946, nella prima sottocommissione della Commissione dei Settantacinque a ottenere il
consenso su tale principio. Conviene riportare il brano di straordinaria chiarezza e lungimiranza:
“La Sottocommissione, esaminate le possibili impostazioni sistematiche di una dichiarazione dei
5
diritti dell’uomo; esclusa quella che si ispiri ad una visione soltanto individualistica; esclusa quella
che si ispiri ad una visione totalitaria la quale faccia risalire allo Stato l’attribuzione dei diritti dei
singoli e delle comunità fondamentali, ritiene che la sola impostazione veramente conforme alle
esigenze storiche cui il nuovo statuto dell’Italia debba soddisfare, è quella che: a) riconosca la
precedenza sostanziale della persona umana… rispetto allo Stato e la destinazione di questo al
servizio di quella; b) riconosca ad un tempo la necessaria socialità di tutte le persone le quali sono
destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e
spirituale: anzitutto in varie comunità intermedie disposte secondo una naturale gradualità… e
quindi per tutto ciò in cui tutte quelle comunità non bastino, lo Stato; c) che perciò affermi sia
l’esistenza dei diritti fondamentali delle persone sia dei diritti della comunità anteriormente ad ogni
concessione da parte dello Stato”. Come si può intendere, si tratta di parole che si commentano da
sole e che dicono quanto distanti siano tra loro spirito e lettera del Libro I, Titolo II del Codice
Civile del 1942 e quelli della Costituzione. Basterebbe questa osservazione per giustificare
l’urgenza della riforma del Codice Civile, rimasto ancorato ad una impostazione di natura
concessoria.
La seconda ragione ha a che vedere con la dimensione giustificativa delle OSC. Come noto,
il proprium di queste organizzazioni è quello di creare valore sia strumentale misurato dai beni e
servizi prodotti – sia espressivo – le OSC consentono a coloro che in esse operano di esprimere la
propria identità attraverso le opere. Il valore strumentale è misurato in termini di efficienza e di
efficacia; il valore espressivo (o simbolico) delle OSC è misurato, invece, dalla loro capacità di
produrre significati e di soddisfare il bisogno di riconoscimento delle persone; dalla capacità cioè di
generare relazionali interpersonali. In altri termini, il Terzo settore non si limita alla semplice cura
delle persone portatrici di bisogni, ma ambisce a curarle in modo relazionale. E’ questo che fa la
differenza tra un servizio di cura offerto – poniamo – del Comune e il medesimo servizio offerto da
un ente non profit. Ecco perché qualità strumentale e qualità espressiva devono marciare assieme
nel Terzo settore, proprio come ci ricorda la celebre metafora di Platone nel Fedro: “Il solco sarà
diritto se i due cavalli che trainano l’aratro avanzano alla medesima velocità”. In caso contrario, il
solco piegherà a destra o a sinistra ed il raccolto sarà modesto.
Ebbene, qualora fosse il terzo modello identitario ad affermarsi in modo egemonico è chiaro
che il valore espressivo delle ONP verrebbe sacrificato a vantaggio di quello strumentale. Ma di un
non profit tutto sbilanciato sul lato della sola efficienza (allocativa) non è che se ne avverta una
grande necessità – soprattutto nell’epoca presente. La posizione da favorire è dunque quella di un
non profit plurale, all’interno del quale possono convivere liberamente i tre modelli identitari di cui
si è detto, lasciando ai cittadini la scelta dell’opzione che più ritengono adeguata, tenendo conto del
6
contesto ambientale e del quadro istituzionale. (Cfr. G. Moro, Cittadini in Europa, Roma, Carocci,
2009).
2.3
Chiudo con una considerazione di carattere generale. Il fatto che a tutt’oggi non si sia
addivenuti ad una definizione univoca di Terzo Settore – non così invece per le altre due grandi
formazioni sociali e cioè lo Stato e il mercato – non deve meravigliarci, né tanto meno
preoccuparci. Il nostro Gianbattista Vico ci ha insegnato che nomina sunt consequentia rerum (i
nomi sono conseguenza delle cose); è dunque illusorio pensare di poter catturare entro i confini
fissati da una definizione – per quanto elaborata essa sia – la varietà delle forme espressive dei
soggetti del Terzo settore. Mai potrà esistere una teoria generale delle OSC e ciò per la
fondamentale ragione che il Terzo settore è un tipico fenomeno morfogenetico: una realtà cioè che
muta sia per spinte endogene sia per le trasformazioni dell’ambiente circostante. Il legislatore
saggio farà allora bene a non cadere nella trappola definitoria; a non lasciarsi cioè prendere dalla
mania di porre limiti alla fantasia creatrice della società civile organizzata.
Per l’importanza che riveste, conviene chiarire meglio il punto toccato. Come si sa, la
definizione corrente di Terzo settore lo vede come la sfera cui afferiscono tutti quei soggetti che non
hanno titolo per rientrare né nel mercato (primo settore) né nello Stato (secondo settore). Si noti
subito l’asimmetria: mentre la distinzione tra Terzo Settore e Stato si appoggia su un fondamento
oggettivo, quale è quello basato sulla dicotomia pubblico-privato, la distinzione tra Terzo Settore e
mercato – entrambi enti di diritto privato - postula, per avere senso, che il mercato venga
considerato come lo spazio occupato esclusivamente da agenti che sono motivati all’azione dal fine
lucrativo. Solo così, infatti, si possono tenere tra loro separati soggetti – pensiamo ad una
cooperativa sociale e ad un’impresa commerciale – che appartengono al medesimo universo
giuridico (quello di enti privati) ma che perseguono obiettivi diversi. E’ per questa ragione che,
negli ambienti anglosassoni, le organizzazioni di cui qui si tratta vengono preferibilmente indicate
con l’espressione di enti non profit, per sottolineare appunto il fatto che la loro specificità sta nel
rispetto del vincolo di non distribuzione degli utili.
Ora, se le organizzazioni della società civile – ovvero le organizzazioni delle libertà sociali
come le ha chiamate Gustavo Zagrebelski - appartengono alla sfera del privato ma non a quella del
mercato, ne deriva che la loro distintività non può essere posta su un particolare modo di fare
economia, ma va ricercata sul piano del sociale. Ecco perché, agli inizi degli anni ’80 del secolo
scorso, tali organizzazioni vennero opportunamente indicate con l’espressione di “privato sociale”.
(Cfr. P. Donati, La teoria relazionale della società, Milano, Angeli, 1991; Id. “La qualità civile del
sociale” in P. Donati e I. Colozzi, (a cura di) Generare il civile, Bologna, Il Mulino, 2002). Ebbene,
7
mentre allora tale espressione rappresentava fedelmente ed efficacemente la realtà del tempo, le
cose sono andate progressivamente mutando in seguito all’affermazione in senso quantitativo e alla
diffusione su tutto il territorio nazionale, di soggetti imprenditoriali connotati da due elementi
specifici. Primo, una organizzazione produttiva del tutto simile a quella delle imprese for profit (e
dunque connotata da elementi quali professionalità, attenzione all’efficienza, continuità produttiva,
capacità di competere, innovatività); secondo, il perseguimento di interessi collettivi o la tutela di
interessi generali affatto analoghi a quelli perseguiti da associazioni (di volontariato; di promozione
sociale, ONG) e da fondazioni (di impresa; di comunità). Si pensi alle cooperative sociali e alle
neonate imprese sociali: si tratta di soggetti che stanno nel (cioè dentro il) mercato, pur non
accettando il fine dell’agire capitalistico che è quello del profitto. In quanto operanti con
sistematicità e regolarità nel mercato, tali soggetti sono simili alle società commerciali e dissimili da
fondazioni e associazioni; in quanto non mirano al profitto, essi sono simili a fondazioni e
associazioni e dissimili dalle società di cui al Libro V del Codice Civile.
E’ noto che la vera novità dell’ultimo trentennio sul fronte del Terzo settore è proprio
l’irrompere nella nostra società di questa nuova tipologia di soggetti imprenditoriali (Cfr. C.
Borzaga e L. Fazzi, “Processes of institutionalization and differentiation in the Italian Third sector”,
Trento, EURICSE DP, Nov. 2010). Figure simili alle attuali associazioni e fondazioni esistono da
secoli. Basti pensare alle Misericordie e alle varie confraternite le cui radici affondano nel tardo
Medioevo. Ecco perché l’auspicata riforma del Libro I, Titolo II del Codice Civile dovrà sciogliere
il nodo della configurazione concettuale di quei soggetti del Terzo settore (fondazioni operative,
cooperative sociali, imprese sociali) che, in analogia ai soggetti del privato sociale (volontariato,
associazioni, comitati), potremmo chiamare del privato civile per distinguerli appunto dai soggetti
del privato commerciale. La duplicità di codici simbolici – quello del mercato e quello della
socialità – che contraddistingue l’identità di questi veri e propri Giano bifronte è ciò che li rende un
unicum. (Si rammenti che la figura della cooperativa sociale è un’invenzione tipicamente italiana;
mentre a Inghilterra e Francia si deve l’invenzione della impresa cooperativa). (Per approfondimenti
rinvio a Stefano e Vera Zamagni, La cooperazione, Bologna, Il Mulino, 2009). Ma tale duplicità è
anche ciò che rende ardua la loro governance. Infatti, quando diviene dominante il codice del
mercato, i soggetti del privato civile divengono indistinguibili da una qualsiasi altra impresa
commerciale; quando diviene dominante il codice della socialità, essi conoscono il declino. In
entrambi i casi, e non solo nel primo – si badi - l’impresa sociale o la cooperativa sociale si
snaturano perdendo la propria identità. (Cfr. L. Fazzi, Governance per le imprese sociali e il non
profit, Roma, Carocci, 2007). Riuscire a tenere in equilibrio dinamico i due codici, facendo sì che
marcino assieme come i cavalli di Platone, così che dalla loro contaminazione reciproca discendano
8
complementarità strategiche è la vera grande sfida che il legislatore riformatore del Codice Civile
dovrà raccogliere e saper vincere.
3.
Dell’identità propria del volontariato
3.1
Se le considerazioni svolte nella sezione precedente valgono in generale per tutto il Terzo
settore, esse richiedono una puntualizzazione ulteriore quando si volge l’attenzione a quella sua
fondamentale espressione che è il volontariato. Intorno al quale così tanto è stato scritto che non
mette conto aggiungere altro. Le ricerche di tipo empirico, che sono ormai schiera, ci raccontano
una realtà in grande espansione, anche organizzativa. (Cfr. E. Alecci, M. Bottaccio (a cura di),
Fuori dall’angolo. Idee per il futuro del volontariato e del terzo settore, Napoli, L’Ancora, 2010).
Conviene allora spendere qualche riga su una questione assai meno dibattuta, eppure di grande
rilevanza. Si tratta di questo. Due sono le concezioni di volontariato presenti nel dibattito pubblico,
oltre che in letteratura – concezioni entrambe legittime, beninteso, ma con implicazioni affatto
diverse sul piano del modello di ordine sociale che si ha in mente di realizzare.
La prima concezione, che possiamo chiamare additiva, vede il volontariato come un settore
societario che si aggiunge agli altri già in esistenza, tanto che più di uno studioso ha avanzato la
proposta di dare vita ad un “quarto settore” distinto sia dal primo (mercato), sia dal secondo (Stato),
sia dal Terzo settore (cooperative sociali, imprese sociali, fondazioni). I volontari andrebbero così
ad occupare una nicchia ben circoscritta della società, una nicchia che manterrebbe bensì rapporti
di buon vicinato con gli altri tre settori, ma da essi separata. La seconda concezione, invece, è quella
emergentista, secondo cui quella del volontariato è una forma di agire che, una volta raggiunta la
massa critica, va a modificare anche le relazioni già in esistenza tra le altre sfere della società.
L’immagine che subito viene alla mente è quella del lievito che, una volta aggiunto alla massa di
pasta, la fermenta tutta quanta e non solo una sua parte. Per la concezione emergentista – che è
quella accolta da chi scrive – missione specifica e ad un tempo fondamentale del volontariato è
quella di costituire la forza trainante per cambiare il modo di funzionare delle istituzioni sia
politiche sia economiche. Di operare cioè per la propagazione, nelle sfere sia politica sia
economica, di una concezione non individualistica dell’identità personale secondo la quale l’altro
non è una mera proiezione del mio io, un qualcosa di cui posso fare l’uso che voglio. A tale
concezione, il volontariato oppone l’idea di una identità in relazione con l’altro, per la quale l’io si
produce solo attraverso un processo di relazione con l’altro. Per gli “additivisti”, invece il
volontariato potrebbe accontentarsi di svolgere ruoli di supplenza o di supporto dei compiti affidati
9
alle pubbliche istituzioni. Ma se così accadesse sarebbe difficile che esso possa scongiurare una
graduale perdita di legittimazione sociale. E ciò per l’ovvia ragione che per assolvere a tali compiti
bastano – e avanzano - la filantropia organizzata, per un verso, e lo Stato benevolente, per l’altro
verso.
Il limite più serio della concezione additiva è quello di esporre il volontariato ad un duplice
“strattonamento”, quello che gli viene dal pensiero neoliberista e quello che gli viene dalla
posizione neostatalista, sebbene con motivazioni e argomenti tra loro diversi. I neoliberisti si
appellano all’azione volontaria per portare sostegno
alle ragioni del loro “conservatorismo
compassionevole” al fine di assicurare quei livelli minimi di servizi sociali ai segmenti deboli della
popolazione che lo smantellamento del welfare state da essi invocato lascerebbe altrimenti senza
copertura alcuna. Ma ciò genera un paradosso a dir poco sconcertante. Come si fa a parlare in
favore di comportamenti di tipo filantropico, come si fa cioè a incoraggiare lo spirito donativo
quando la regolazione dell’attività economica attraverso il mercato viene basata esclusivamente
sull’interesse proprio e sulla razionalità strumentale, vale a dire sull’assunto antropologico
dell’homo oeconomicus? Solamente se la società fosse composta di individui schizofrenici ciò
sarebbe possibile – individui talmente dissociati da seguire la logica del self-interest quando
operano nel mercato e la logica della gratuità quando vestono i panni del filantropo o dell’operatore
sociale.
Non intendo affatto negare che talvolta ciò possa accadere – come in effetti accade – ma
nessun ordine sociale può durare a lungo se i suoi membri mantengono un codice dicotomico di
comportamento, tenendo separate le sfere di vita personale. Il volontariato autentico risolve questo
paradosso perché ci mostra che l’attenzione a chi è nel bisogno non è oggettuale, ma personale.
L’umiliazione di essere considerati “oggetti” sia pure di filantropia o di attenzione compassionevole
è il limite grave della concezione neo-liberista. Il volontario che dona il suo tempo sconvolge invece
la logica dell’efficienza, come essa viene tradizionalmente intesa. Le ore trascorse con il portatore
di bisogni potrebbero – secondo quella logica - essere dedicate a produrre un reddito che il
volontario potrebbe poi destinare a suo favore, mediante
l’azione filantropica. Per una chiara
dimostrazione pratica di dove può condurre una tale linea di pensiero rinvio alla ricerca della United
Nations Volunteers pubblicata in occasione dell’anno internazionale dei volontari e condotta dalla
organizzazione statunitense Independent Sector. Se si legge il rapporto di Kofi Hannan alla 56°
Assemblea Generale delle Nazioni Unite (5 dicembre 2001) si troverà l’icastica affermazione,
basata su quella ricerca, secondo cui “il volontariato contribuisce alla formazione del prodotto
nazionale lordo”. Come a dire che il volontariato tanto più vale quanto maggiore è il valore
aggiunto mercantile che esso genera. Una linea di pensiero questa che L. Salamon e H. Anheier, nel
10
loro ben noto volume Global Civil Society (Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1999),
avevano caldeggiato parlando del volontariato come “fattore di riserva” a disposizione degli altri
settori della società.
Non diverso è lo “strattonamento” che viene al volontariato dal pensiero neostatalista.
Anch’esso genera un paradosso analogo, sia pure simmetrico. Presupponendo una forte solidarietà
dei cittadini per la realizzazione dei diritti di cittadinanza, lo Stato Sociale rende obbligatorio il
finanziamento della spesa sociale. Ma in tal modo, esso spiazza il principio di gratuità, negando, a
livello di discorso pubblico, ogni valenza a principi che siano diversi da quello di solidarietà, ad
esempio al principio di fraternità. Ma una società che elogia a parole il volontariato e poi non
riconosce il valore del servizio gratuito nei luoghi più disparati del bisogno, entra, prima o poi, in
contraddizione con se stessa. Se si ammette che il volontariato svolge una funzione profetica o –
come è stato detto – porta con sé una “benedizione nascosta” e poi non si consente che questa
funzione diventi manifesta nella sfera pubblica, perché a tutto e a tutti pensa lo Stato Sociale, è
chiaro che quella virtù civile per eccellenza che è lo spirito del dono non potrà che registrare una
lenta atrofia. Non si dimentichi infatti che la virtù, a differenza di una risorsa scarsa, si decumula
con il non uso. L’assistenza per via esclusivamente statuale tende a produrre soggetti bensì assistiti
ma non rispettati, perché essa non riesce ad evitare la trappola della “dipendenza riprodotta”.
Sono dell’idea che il volontariato debba opporre resistenza a queste due contrapposte
sirene, pena la sua progressiva irrilevanza e uscita di scena. La sfida che esso deve raccogliere è
quella di battersi per restituire il principio del dono come gratuità alla sfera pubblica. Per dirla in
altro modo, il contributo più significativo che, per gli “emergentisti”, il volontariato può dare alla
società è quello di affrettare il passaggio dal dono come atto privato compiuto a favore di parenti o
amici ai quali si è legati da relazioni a corto raggio, al dono come atto pubblico che interviene sulle
relazioni ad ampio raggio. A ciò devono mirare l’advocacy (cioè la denuncia di quel che non va) e
il counselling (cioè il coraggio di avanzare proposte concrete di intervento) che sono le modalità
primarie, anche se non uniche, dell’azione volontaria. Il volontariato autentico, affermando il
primato della relazione sul suo esonero, del legame intersoggettivo sul bene donato, deve poter
trovare spazio di espressione ovunque, in qualunque ambito dell’agire umano e non solamente in
una nicchia particolare. Questo sempre che si vogliano ricercare i modi per civilizzare il mercato,
per superare cioè quella visione polemologica del mercato che, a fronte di costi umani inaccettabili,
non riesce più a soddisfare i canoni della stessa razionalità economica.
3.2
Quali conseguenze di ordine pratico discendono dall’accoglimento della concezione
emergentista del volontariato? Ne scelgo alcune soltanto per evidenti ragioni di spazio. In primo
11
luogo, occorre
prendere atto dei mutamenti del quadro normativo a livello costituzionale
intervenuti dopo l’entrata in vigore della legge n. 266/1991. La riforma del Titolo V della
Costituzione ha inciso in maniera molto significativa sul contesto ordinamentale in cui si colloca la
disciplina del volontariato.
Infatti va rilevata e sottolineata l’innovazione rappresentata dal
riconoscimento, all’art. 118, comma 4, del principio di sussidiarietà “orizzontale” – principio che in
nessuna altra Costituzione appare in modo così esplicito. Tale riconoscimento ha un’evidente
ricaduta sulla legittimazione del ruolo delle organizzazioni di volontariato, che operano nello
svolgimento di “attività di interesse generale”.
Inoltre, il riconoscimento in capo alle Regioni della competenza legislativa in parecchie
delle materie in cui si svolge l’attività di volontariato ha messo gli enti territoriali in condizione di
incidere, anche attraverso l’esercizio della loro funzione programmatoria, sulla delineazione della
cornice entro cui devono muoversi le organizzazioni stesse. Va ricordato, tuttavia, che la sentenza n.
75/1992 della Corte Costituzionale ha chiarito inequivocabilmente che il volontariato non è una
materia, ma “un modo di essere della persona nell’ambito dei rapporti sociali”, che può realizzarsi
“all’interno di qualsiasi campo materiale della vita comunitaria”, costituendo “la più diretta
realizzazione del principio di solidarietà sociale”. E’ dunque urgente ripensare la ripartizione delle
competenze, in tale ambito, tra Stato e regioni e ciò soprattutto in vista della trasformazione in
senso federalista del nostro Stato unitario.
In secondo luogo, occorre trovare il modo di precisare, con grande cura, cosa debba
intendersi per gratuità delle prestazioni. Vuol forse dire che il volontario non riceve remunerazione
alcuna né in denaro né in natura? Non basta. Infatti, non pochi sono i casi di persone che decidono
di svolgere gratuitamente una certa attività per un determinato lasso di tempo presso una
organizzazione di volontariato (OV) in cambio della promessa, ovviamente non formalizzata, di una
sistemazione lavorativa successiva. E che dire delle situazioni, tutt’altro che infrequenti, del
professionista (avvocato, commercialista, notaio, medico, ecc.) che si avvale dell’attività svolta
gratuitamente in qualità di volontario presso una OV come forma di investimento specifico in
reputazione? Come si sa, la reputazione è un vero e proprio asset patrimoniale che può essere
accumulato o decumulato e che conferisce al suo possessore la possibilità di godere di una specifica
rendita di posizione. Non è difficile comprendere come in casi del genere la non rimuneratività
possa diventare facile paravento per fini non propriamente disinteressati. In buona sostanza, il non
pagamento delle prestazioni non assicura, di per sé, la gratuità, la quale è prima di tutto una precisa
disposizione d’animo.
Mi spiego con un esempio. Se un certo numero di persone ben intenzionate e ben disposte
verso gli altri, cioè altruiste, decidono di dare vita ad un’organizzazione alla quale forniscono
12
gratuitamente risorse di vario tipo per “fare cose” a favore di determinate tipologie di portatori di
bisogni, questa sarà un’organizzazione filantropica, certamente benemerita e socialmente utile, ma
non ancora per ciò stesso una OV. La specificità di quest’ultima, infatti, è la costruzione – come si
è detto - di nessi di relazionalità fra persone. Laddove l’organizzazione filantropica fa per gli altri,
l’OV fa con gli altri. E’ proprio questa caratteristica che differenzia l’azione autenticamente
volontaria, tipica delle OV, dalla beneficenza privata, tipica della filantropia. Infatti, la forza del
dono gratuito non sta nella cosa donata o nel quantum donato – così è invece nella filantropia, tanto
è vero che esistono le graduatorie o le classifiche di merito filantropico – ma nella speciale qualità
umana che il dono rappresenta per il fatto di costituire una relazione tra persone.
In altri termini, mentre la filantropia genera quasi sempre dipendenza nel destinatario
dell’azione filantropica, il volontariato autentico genera invece reciprocità e quindi libera colui che
è il destinatario dell’azione volontaria da quella “vergogna” di cui parla Seneca nella X Lettera a
Lucilio: “La pazzia umana è arrivata al punto che fare grandi favori a qualcuno diventa
pericolosissimo: costui, infatti, perché ritiene vergognoso non ricambiare, vorrebbe togliere di
mezzo il suo creditore. Non c’è odio più funesto di quello che nasce dalla vergogna di aver tradito
un beneficio”. Non è propriamente volontaria l’azione di chi, al di là delle intenzioni soggettive,
non consente al beneficiario di porre in essere un contro-dono. Se chi riceve gratuitamente non
viene posto nelle condizioni concrete di reciprocare, in qualche misura e in qualche forma, costui
finirà per sentirsi umiliato e alla lunga finirà con l’odiare il suo benefattore, come appunto ci
ricorda Seneca. Ciò in quanto il dono, per sua natura, provoca sempre l'attivazione del rapporto di
collaborazione sociale per eccellenza, che è quello di reciprocità.
Perché è importante definire la gratuità del volontariato nei termini di cui sopra? Per la
ragione che, come la scuola francese del MAUSS (Cfr. A. Caillè, Il terzo paradigma: antropologia
filosofica del dono, Torino, Bollati Boringhieri, 1998), ha chiarito a tutto tondo, c’è una concezione
del dono tipica della premodernità, che però continua a sussistere ancora in alcuni strati nelle nostre
società contemporanee, secondo cui il dono va ricondotto sempre ad una soggiacente struttura di
scambio. E’ questa la concezione del dono come munus, come regalo, come strumento per
impegnare l’altro, fino ad asservirlo. Per una concezione del genere, si ha che il dono diventa,
paradossalmente, un obbligo per preservare il legame sociale: la vita in società postula di necessità
la pratica del dono, la quale diventa per ciò stesso una norma sociale di comportamento, vincolante
al pari di tutte le norme di tale tipo. Non ci vuol molto a comprendere come una tale concezione del
dono non salvi né la spontaneità né la vera gratuità dell’azione donativa. Eppure, per strano che ciò
possa apparire, è un fatto che ancora molto radicata è l’idea in base alla quale il volontariato
genuino è quello che si appoggia sulla nozione di dono come munus, come regalo.
13
Come darsi conto della difficoltà culturale a comprendere che l’autentica gratuità è quella
del dono come reciprocità? Duplice la risposta. La prima è che la relazione di reciprocità continua
ad essere confusa con quella di scambio di equivalenti. Il fatto è che la nostra cultura è talmente
intrisa di economicismo che ogni qualvolta sentiamo parlare di relazione biunivoca tra due soggetti
siamo istintivamente portati a leggervi un sottostante, sia pure indiretto, rapporto di scambio di
equivalenti. E’ questa una delle pesanti eredità intellettuali della modernità. “Perché vi sia dono –
scrive Jacques Derrida – bisogna che il dono non appaia, che non sia percepito come dono”
(Donare il tempo e la moneta falsa, Torino, Bollati Boringhieri, 1996, p.18). Ma un tale dono non
può esistere, è impossibile - secondo Derrida - perché l’uomo è un essere ontologicamente autointeressato, cioè egocentrico. La cultura dominante vede dunque il dono come una sorta di assoluto
che, proprio perché tale, essa stessa dichiara impossibile attuare. E' la questione - centrale nel
dibattito filosofico contemporaneo - della "sospettabilità" del dono quale gesto che pretenderebbe di
essere gratuito e che tuttavia appare costantemente attraversato da elementi di interesse che ne
inquinano la purezza. L’unico atteggiamento possibile è allora quello della beneficenza privata, cioè
della filantropia, che, come si è detto, è perfettamente compatibile con l’assunto antropologico del
self-interest.
La seconda risposta all’interrogativo sopra posto è che si stenta ancora ad afferrare che la
categoria del dono ricomprende al suo interno la dimensione dell’interesse. Invero, il termine
interesse – dal latino “inter-esse” – significa propriamente “essere in mezzo” e ciò a significare che
per perseguire un interesse bisogna interagire con l’altro, utilizzandosi reciprocamente perché ne
derivino frutti a entrambi. Eppure, la concezione oggi dominante di interesse si è talmente
allontanata dal suo significato originario che quando questo termine viene usato esso viene quasi
sempre inteso con connotazioni negative sotto il profilo morale. In realtà il dono non è affatto
incompatibile con l’interesse del donante, se questo viene inteso come interesse a stare nella
relazione con l’altro. Il filantropo, invece, non ha questo interesse, tanto è vero che il filantropo
puro (quello che vuole conservare l’anonimato) neppure vuol conoscere l’identità di coloro ai quali
la sua beneficenza si indirizza. E non v’è dubbio che l’atto filantropico sia un atto gratuito nella
accezione volgare di cui si è detto sopra.
Invero, è proprio l’esistenza di un forte interesse a dar vita alla reciprocità tra donante e
donatario a costituire l’essenza dell’azione volontaria. Perfino nel cosiddetto dono ad estranei c’è
restituzione, cioè contro-dono: questo risiede nel valore di legame. Nonostante la pervasività di una
certa vulgata economicistica, non v’è da pensare che solo due siano le categorie di valore: valore
d’uso e valore di scambio. Esiste anche il valore di legame: la relazione tra persone, tra loro in
qualche modo “col-legate”, è di per sé un bene che, in quanto tale, genera valore. In definitiva, la
14
differenza ultima tra la gratuità del volontario e la gratuità del filantropo (o dell’altruista puro) sta in
ciò che il volontario non pretende la restituzione, accetta l’asimmetria, rinuncia all’equivalenza, ma
tutto ciò non implica affatto che il volontario non coltivi un interesse: l’interesse per l’altro (e non
già all’altro) che nasce dal desiderio del legame. Un’idea questa che venne magistralmente
compresa e illustrata da G. B. Vico quando previde che il declino di una società inizia nel momento
in cui gli uomini non trovano più dentro di sé la motivazione per legare il proprio destino a quello
degli altri; quando cioè viene a scomparire l’inter-esse. Alla luce di ciò si può dire che, tra tutte le
strutture di interazione personale, il volontariato è quella che con più forza e incisività contrasta la
riduzione del legame sociale al cash nexus.
Terzo, è necessaria una più ampia libertà della configurazione giuridica della OV,
ammettendo, ad esempio, la possibilità di deroghe al requisito della democraticità (come, peraltro,
stabilito dalla legge 383/2000 sull’associazionismo di promozione sociale). Non è un astratto
principio di democraticità in senso formale a garantire l’efficacia dell’azione del volontariato.
Talvolta è di fondamentale importanza che nelle organizzazioni di volontariato possa essere tracciata
una linea guida, che poi viene seguita dai rappresentanti che compongono i consigli direttivi delle
organizzazioni ad opera di soggetti promotori / ispiratori (Si pensi al parroco in quelle associazioni
che operano nell’oratorio o alle associazioni scoutistiche). Il punto qualificante che assicura la piena
democraticità di una organizzazione è il modo in cui vengono prese le decisioni, più ancora che il
modo in cui vengono nominati o eletti coloro che entrano a far parte dell’organo direttivo. In buona
sostanza, si tratta di andare oltre una definizione meramente procedurale di democrazia per
indirizzarsi piuttosto verso una qualche versione di democrazia deliberativa. (Cfr. E. Rossi,
“Proposte dell’Agenzia per le ONLUS per una riforma organica della legislazione sul Terzo settore”,
Aretè, 3, 2009).
Un tale avanzamento consentirebbe anche di avviare a soluzione sia il problema del
riconoscimento delle organizzazioni di volontariato di secondo livello che operano su base
nazionale, sia il problema di consentire alle OV una più ampia libertà di scelta dei settori di
intervento. In particolare, l’espressione “fine di solidarietà” deve essere intesa anche nel senso di
ammettere che le OV possano devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento, non solo ad
altre organizzazioni di volontariato, ma ad una più ampia categoria di enti senza scopo di lucro.
Come l’evidenza fattuale suggerisce, spesso realtà che nascono come organizzazioni di volontariato,
crescendo, trovano questa veste giuridica non più adeguata a interpretare la propria missione. È
importante allora che le eventuali trasformazioni – sempre che si materializzino entro il Terzo
settore e con la giusta attenzione a impedire operazioni fiscalmente elusive – non trovino
sbarramenti o impedimenti di sorta. Ad esempio, se una associazione di volontariato ritiene di dover
15
dare vita ad una fondazione oppure ad una impresa sociale, la devoluzione del patrimonio, in tutto o
in parte, non deve andare soggetta a restrizioni irragionevoli. Guardare al volontariato come ad un
fenomeno emergente implica infatti che si rafforzi e non che si indebolisca la sua capacità di
contagio nei confronti sia del mercato sia dello Stato.
A quest’ultimo riguardo, è urgente andare oltre l’impianto della L.266/1991 che – come noto
– si limita a disciplinare i rapporti tra organizzazioni del volontariato e istituzioni pubbliche. È
necessario considerare tutti i tipi di rapporto che le OV intendono stringere con soggetti vari,
indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano soggetti pubblici o meno. Vanno dunque regolati
anche i rapporti che possono intercorrere tra associazioni di volontariato e istituzioni private, siano
esse profit o non profit. Si pensi alle forme, in costante diffusione nel nostro paese, del cosiddetto
volontariato d’impresa. (Si veda l’articolata e minuziosa analisi in ASTRID, Dove lo Stato non
arriva. Pubblica amministrazione e Terzo settore, Firenze, Passigli, 2008).
Infine, la semplificazione amministrativa è una richiesta che il mondo del volontariato da
tempo avanza, ma con scarso successo. Nello snellimento delle procedure bisogna però seguire un
criterio di ragionevolezza, per tener conto della consistenza dimensionale dei soggetti e degli ambiti
di intervento. Non si possono imporre le stesse procedure amministrative e contabili alla grande e
alla piccola OV (Cfr. Propersi, cap. VIII). Pure urgente è la revisione del rapporto tra Fondazioni di
origine bancaria – enti nati dopo il 1991 e quindi successivi alla legge 266 – e Comitati di Gestione
regionali che ricevono i fondi destinati alle OV dalle prime per poi distribuirli ai Centri di Servizio
per il Volontariato. Se si vuole andare nella direzione qui auspicata occorre intervenire sull’attuale
legislazione che, oltre ad essere fonte di conflittualità tra grandi e piccole organizzazioni di
volontariato, induce a inefficienze sistemiche. A tale riguardo va osservato che poiché le
associazioni di volontariato sono ONLUS di diritto, (ex D. Lgs.460/1997), è auspicabile un maggior
coinvolgimento dell’organo di controllo e di vigilanza, cioè dell’Agenzia per il Terzo Settore, la
quale deve essere chiamata in causa in modo costruttivo; per esempio, prevedendo che i pareri che
attualmente essa rilascia diventino vincolanti (e non solo obbligatori come è ora), ogniqualvolta essi
abbiano ad oggetto OV. Un tale provvedimento permetterebbe che il punto di giudizio non
rimanesse solo ed esclusivamente quello fiscale-tributario come fino ad oggi è stato. C’è infatti un
disperato bisogno di un soggetto terzo capace di tener conto, nei suoi pronunciamenti, del valore
aggiunto sociale creato dal volontariato, e non soltanto del rispetto formale delle norme di legge.
Chiudo questo paragrafo con una considerazione di natura generale. Una lettura, anche
superficiale, dell'attuale passaggio d'epoca ci obbliga a prendere atto che i tratti antisociali del
comportamento economico hanno ormai raggiunto livelli di intensità preoccupanti. E' ampiamente
riconosciuto che lo star-bene (well-being) delle persone è associato non solamente al
16
soddisfacimento dei bisogni materiali e immateriali, ma anche a quello dei bisogni relazionali. Ed
è altresì noto che, mentre le nostre economie avanzate sono diventate "macchine"
straordinariamente efficienti per soddisfare bisogni della prima categoria, non altrettanto si può dire
di esse per quanto attiene i bisogni relazionali. La ragione è che questi ultimi non possono essere
adeguatamente soddisfatti con beni privati, quale che ne sia il volume e la qualità. Piuttosto, essi
richiedono beni relazionali, beni cioè la cui utilità per il soggetto che lo consuma dipende, oltre che
dalle sue caratteristiche intrinseche e oggettive, dalle modalità di fruizione con altri soggetti.
Charles Taylor – il celebre filosofo canadese - ha tracciato la distinzione tra "beni convergenti", che
possono essere prodotti solo dall'unione degli sforzi, ma che sono poi goduti individualmente, e
"beni comuni" che richiedono un'azione comune anche nel momento finale della loro fruizione. I
beni relazionali appartengono a quest'ultima categoria.
Ora, il punto è che la produzione di beni relazionali non può avvenire secondo le regole di
produzione dei beni privati. Né può avvenire secondo le modalità di fornitura dei beni pubblici da
parte dello Stato - la coercizione e il principio burocratico annullano o neutralizzano la relazionalità
– anche se hanno tratti comuni con i beni pubblici (sono consumati, e prodotti, insieme). Ecco
perché se si vogliono scongiurare i rischi devastanti di trappole di povertà sociale, dovute alla
crescita ipertrofica della sfera "privata" dell'economia, le nostre società hanno bisogno di far posto a
soggetti capaci di fare il “salto della gratuità” suscitando così rapporti nuovi, rapporti di reciprocità.
Ce lo ricorda, in modo esemplare, la penna brillante di uno scrittore assai noto, Antoine de SaintExupery, quando al suo “Piccolo principe” fa dire: “Gli uomini non hanno più tempo per conoscere
nulla. Comprano dai mercanti le cose già confezionate. Ma siccome non esistono mercanti di amici,
gli uomini non hanno più amici”. L’amicizia – si rammenti - è il prototipo di bene relazionale. (Cfr.
L. Becchetti, Il denaro fa la felicità?, Roma, Laterza, 2007).
4.
Terzo settore e costituzionalizzazione del civile
4.1
Quanto precede mi porta ad affrontare, per così dire, la questione delle questioni. Se non si
desidera che il Terzo settore si limiti a svolgere funzioni meramente redistributive di una ricchezza
prodotta da altri soggetti ovvero che esso si limiti a compiti di supplenza di quanto non riescono a
fare il mercato e/o lo Stato, a cos’altro il Terzo settore può mirare? Non esito a rispondere che nelle
attuali condizioni storiche compito primario e, ad un tempo, esclusivo del Terzo settore è quello di
soggetto facilitatore della transizione nella nostra società dall’ordine di tipo bipolare fondato sulla
diade pubblico-privato ad un ordine sociale tripolare fondato sulla triade pubblico-privato-civile.
17
Per afferrare di che si tratta è necessario un inquadramento, sia pure breve, della nascita e
dell’evoluzione di quell’istituzione così centrale nelle nostre società che è il mercato.
E' alla scuola di pensiero francescana che si deve principalmente, a partire dal XIV secolo,
l'invenzione e la creazione di quel modello di ordine sociale che chiamiamo "economia di mercato",
un modello che ha avuto la sua culla in terra di Toscana e Umbria. Quattro sono i pilastri di tale
modello, che valgono a farci intendere la differenza tra economia di mercato in senso proprio e
attivazione di un insieme di mercati per facilitare gli scambi. (Si rammenti che già nell'antichità
esistevano mercati).
Il primo pilastro è la divisione del lavoro, ideata per dare a tutti, anche ai meno dotati in
senso fisico e psichico, la possibilità concreta di lavorare. (Già nel Trecento, l'omiletica francescana
diffondeva il seguente pensiero: "L'elemosina aiuta a sopravvivere, ma non a vivere; perché vivere è
produrre e l'elemosina non aiuta a produrre"). Dal principio della divisione del lavoro discende poi
quello della necessità dello scambio di mercato e da quest'ultimo l'idea per cui l'altro non è il
nemico da vincere, ma un soggetto delle cui abilità e professionalità ho bisogno per soddisfare le
mie esigenze. Il primo grande autore ad intendere questa notevole conseguenza pratica del principio
in questione fu Erasmo da Rotterdam il quale nel suo Enchiridion Militi Christiani del 1503
anticipa quella che diverrà la nota tesi di Kant sul nesso tra pace e scambi commerciali.
Il secondo pilastro è la nozione di sviluppo, ignota nelle epoche precedenti: "s-viluppo"
significa, letteralmente, "togliere i viluppi" e dunque dilatare gli spazi di libertà dei singoli e delle
comunità. Proprio come ha titolato A. Sen il suo celebre saggio del 2000: "Sviluppo è libertà". Cosa
implica l'accettazione dell'idea di sviluppo? L'accumulazione di beni e risorse; cioè a dire il
processo di produzione non deve arrestarsi nel momento in cui si è prodotto quanto è necessario ai
bisogni della generazione presente. Si deve pensare, infatti, anche ai bisogni delle generazioni
future, accantonando, cioè risparmiando, risorse non solo per far fronte a imprevisti e calamità
naturali, ma anche per contribuire al benessere di chi viene dopo. Chiaramente, questa concezione
dell'accumulazione è legata alla nozione di tempo come kairos, e non già come chronos.
Il terzo pilastro di un'economia di mercato è la libertà di impresa: chiunque ha i talenti
(propensione al rischio; capacità innovativa; ars combinatoria) e il desiderio di fare l'imprenditore,
deve essere lasciato libero di perseguire il proprio beruf (avrebbe poi scritto Max Weber), senza
dover chiedere l'autorizzazione ad alcuna autorità, religiosa o civile che sia. E' l'emergenza della
figura carismatica dell'imprenditore a rompere l'ordine feudale fondato sulla triade: oratores,
bellatores, laboratores. E' vero che le parole impresa e imprenditore sono introdotte nel lessico
economico, per la prima volta, dall'economista irlandese Richard Cantillon in un saggio del 1730,
ma i concetti che quelle parole esprimono si concretizzano a far tempo dall'Umanesimo Civile. Dal
18
principio della libertà di impresa discende, come logica conseguenza, quello di competizione, la cui
funzione basilare è quella di portare in equilibrio domanda e offerta. Con la libertà di impresa,
infatti, non può esserci, alcun controllo a monte dei livelli di produzione delle varie categorie di
beni. Ciascun imprenditore porta al mercato le quantità di beni che ha congetturato (o sperato) di
poter vendere. La competizione serve allora a selezionare tra i produttori quelli più bravi; quelli cioè
che offrono la merce al migliore rapporto qualità-prezzo; gli altri dovranno cambiare linea di
produzione oppure scegliersi altri luoghi in cui esercitare la propria attività. (Chiaramente, in
un'economia centralmente pianificata non v'è bisogno alcuno di competizione).
L'ultimo pilastro dice del fine che un'economia di mercato deve proporsi di perseguire.
Storicamente, questo fine è stato dapprima il bene comune, inteso come produttoria dei beni
individuali. E' precisamente il fine del bene comune a qualificare l'economia di mercato di prima
generazione come economia civile di mercato. L'aggettivo "civile" rinvia alla civitas romana, un
modello di organizzazione sociale assai diverso da quello della polis greca. La civitas, a differenza
della polis, è una società includente di tipo universalistico. (Si rammenti che nell’agorà della polis
non tutti erano ammessi: donne, servi, incolti vi erano esclusi). Non deve dunque sorprendere se le
prime forme di welfare si siano realizzate in parallelo con la diffusione dell'economia civile di
mercato, come traduzione pratica del principio del bene comune. Si pensi alle gilde, alle
corporazioni di arti e mestieri, alle confraternite che gestivano ospedali e case di ricovero, alle
Misericordie (che sono state le prime organizzazioni di volontariato), ai Monti di Pietà dei
francescani nel Quattrocento italiano che combattevano, con i fatti, l'usura facilitando l'accesso al
credito dei non abbienti; e così via.
La stagione dell'economia civile di mercato è stata però di breve durata. In Italia, essa è
continuata, ma a tassi progressivamente decrescenti, fino al periodo dell'Illuminismo di marca sia
milanese (Verri, Beccaria e poi Romagnosi) sia napoletana (Genovesi, Galiani, Dragonetti,
Filangieri). Già a partire dal Seicento le cose iniziano a mutare. Decisiva a tale riguardo è stata
l'influenza del pensiero di Hobbes (1651) e dell'antropologia negativa che da esso prende avvio.
Con l'arrivo poi del contributo di Mandeville (1713) e soprattutto di Bentham (1789), il creatore
dell'utilitarismo, si realizza la svolta: il fine cui tende l'economia di mercato non è più il bene
comune, ma il bene totale, inteso - come Bentham aveva scritto - quale sommatoria dei beni
individuali. Accade così che i primi tre pilasti che sorreggono l'economia di mercato restano
nominalmente gli stessi; quel che muta è la loro interpretazione. La divisione del lavoro, nata per
includere tendenzialmente tutti gli uomini nell'attività lavorativa, diviene strumento per escludere i
meno dotati e soprattutto gli inefficienti; l'accumulazione, introdotta come espressione di solidarietà
intergenerazionale, viene invocata per accrescere la produzione di profitto; la competizione, pensata
19
come un cum-petere, si trasforma in concorrenza, per dare corpo all'aforisma hobbesiano "mors tua,
vita mea". Con l'avvento della rivoluzione industriale, infine, l'economia civile di mercato scompare
completamente dall'orizzonte per lasciare posto all'economia capitalistica di mercato. E la disciplina
stessa dell’“economia civile" diviene "economia politica". (Si noti: civile rinvia a "civitas", così
come politica rinvia a "polis").
Adam Smith - il cui impianto filosofico è quello dell'etica delle virtù di derivazione
aristotelica, di cui dirò nel prossimo paragrafo - è il primo a rendersi conto della "grande
trasformazione". Geniale e ammirevole il suo tentativo di far stare assieme sotto il medesimo tetto
concettuale le due versioni dell'economia di mercato, quella civile e quella capitalistica. Invero, il
senso profondo del teorema della mano invisibile è tutto qui: se ciascun agente persegue
razionalmente l'interesse proprio - come vuole la linea di pensiero Hobbes-Mandeville-Bentham sotto ben specifiche condizioni la mano invisibile del mercato trasforma gli egoismi individuali in
bene comune, proprio come gli umanisti civili volevano che il mercato facesse. Oggi sappiamo
perché quelle condizioni non possono mai darsi nella realtà, e quindi perché quel teorema è
divenuto di fatto inservibile per lo stesso pensiero neoliberista. La principale di tali ragioni è che il
teorema in questione funziona solamente quando si ha a che fare con i beni privati e quando non
esistono rilevanti esternalità pecuniarie (da non confondersi con le esternalità tecnologiche e con
quelle posizionali). Con beni pubblici e soprattutto con i commons (beni di uso comune) – beni la
cui rilevanza si accresce man mano che un paese avanza lungo il sentiero dello sviluppo – il
teorema della mano invisibile cessa di funzionare. In situazioni del genere, la smithiana virtù della
prudenza non basta più; bisogna attivare le virtù relazionali, la più importante delle quali è la
reciprocità.
Il tentativo riconciliatorio smithiano ha vita breve. Già a partire dai primi decenni
dell'Ottocento diviene a tutti evidente cosa comporta il passaggio dalla logica del bene comune a
quella del bene totale. Interessante, al riguardo, è la posizione di Marx. Non conoscendo la
distinzione tra mercato civile e mercato capitalistico e identificando l'economia di mercato con il
sistema capitalistico tout court, Marx non può che vedere nell'eliminazione del mercato il rimedio
allo sfruttamento e all'alienazione allora galoppanti. (Come si legge nel volume II de Il Capitale, il
mercato - la cui radice latina, mereo, rinvia a prostituzione - va tuttavia eliminato per via evolutiva e
non già rivoluzionaria, come farà poi Lenin in Russia. Si badi anche che il sottotitolo dell'opera
principe di Marx è: "Per la critica dell'economia politica").
Il mondo democratico non può certo accogliere una prospettiva di discorso del genere. Sulla
scia di importanti suggestioni, dapprima, di J.S. Mill e poi di A. Marshall l’alternativa che viene
avanzata è quella del welfare state, quale si realizzerà appieno nel Novecento. Per comprendere
20
perché il welfare state viene da subito salutato con favore occorre considerare che, come già
Aristotele aveva anticipato, la democrazia presuppone un certo grado di uguaglianza tra i cittadini
per poter funzionare. Pertanto, delle due l'una: o si riducono le diseguaglianze oppure si riduce la
pratica democratica. James Madison nei Federalist Papers aveva preferito questa seconda
soluzione; ma nel XX secolo continuare in quella direzione sarebbe stato troppo pericoloso, e pour
cause. Ebbene, il senso ultimo del welfare state è stato quello di aver reso socialmente e
politicamente accettabile l'economia capitalistica di mercato. Riduzione delle diseguaglianze e
riconoscimento dei diritti di cittadinanza è ciò che serve alla bisogna; quel che serve cioè per
garantire la crescita senza eccessive tensioni sociali. Alla mano invisibile del mercato si sostituisce
così la mano visibile (e pesante) dello Stato e quella riconciliazione che non era riuscita a Smith
riesce alfine a J.M. Keynes. (Per approfondire, si veda L. Becchetti, L. Bruni, S. Zamagni,
Microeconomia. Scelte, Relazioni, Economia Civile, Bologna, Il Mulino, 2010).
4.2
L'arrivo della globalizzazione, a partire dalla fine degli anni 70 del secolo scorso - è infatti
con il primo summit del G.6 a Rambouillet (Parigi) nel novembre 1975 che ha "ufficialmente"
inizio il processo di globalizzazione - modifica radicalmente il quadro. Le diseguaglianze
aumentano più che proporzionalmente rispetto all'aumento del reddito a livello sia transnazionale
sia intranazionale. (Cfr. Angus Madison, 2003). E tutto ciò senza che la spesa sociale pubblica sia
diminuita. Anzi. (Si pensi che in Italia, oltre il 50% del PIL è ancor'oggi generato dal settore
pubblico e la stessa spesa pubblica per il sociale è andata aumentando negli ultimi decenni, eccetto
che negli ultimissimi anni).
Cosa c'è dunque alla radice del "fallimento" (nel senso di failure) del welfare state? C'è che
questo modello si regge su un presupposto fallace; vale a dire sulla logica dei due tempi di
ascendenza kantiana: "facciamo la torta più grande e poi ripartiamola con giustizia". E' da qui che
discende la ben nota divisione di ruoli: al mercato (capitalistico) si chiede di produrre quanta più
ricchezza possibile, dato il vincolo delle risorse e della tecnologia, e senza soverchie preoccupazioni
circa il modo in cui questa viene ottenuta (perché "business is business" e "competition is
competition" – come a dire che la dimensione etica nulla ha a che vedere con l'agire economico);
allo Stato poi il compito di provvedere alla redistribuzione secondo un qualche criterio di equità,
quale quello di Rawls o di altri ancora. Eppure già il grande economista francese Leon Walras, alla
fine dell'Ottocento, aveva provveduto a "rispondere" a Kant scrivendo: "Quando porrete mano alla
ripartizione della torta non potrete ripartire le ingiustizie commesse per farla più grande".
Il limite notevole del vecchio welfare state è quello di accettare, più o meno supinamente,
che il mercato capitalistico segua appieno la sua logica, salvo poi intervenire post-factum, mediante
21
interventi ad hoc dello Stato, per mitigarne gli effetti indesiderati, ma lasciando intatte le cause. Si
osservi che il modello dicotomico di ordine sociale stato-mercato ha prodotto conseguenze nefaste
anche a livello culturale, facendo credere a studiosi e policy-makers che l'etica, mentre avrebbe
qualcosa da dire per quanto concerne la sfera della distribuzione della ricchezza, nulla c'entrerebbe
con la sfera della produzione, perché quest'ultima sarebbe governata dalle “ferree leggi del
mercato”.
Aver legittimato politicamente la separazione (e non già la distinzione) tra sfera economica e
sfera sociale, attribuendo alla prima il compito di produrre ricchezza e alla seconda il compito di
ridistribuirla è stata la grande "colpa" del welfare state. Perché ha fatto credere che una società
democratica potesse progredire tenendo tra loro disgiunti il codice dell'efficienza - che basterebbe a
regolare i rapporti entro la sfera dell'economico - e il codice della solidarietà che presiederebbe ai
rapporti intersoggettivi entro la sfera del sociale. Donde il paradosso che affligge le nostre società:
per un verso, si moltiplicano le prese di posizione a favore di disabili, di poveri di vario tipo, di chi
resta indietro nella gara di mercato. Per l'altro verso, tutto il sistema di valori (i criteri di valutazione
dell'agire individuale, lo stile di vita) è centrato sull'efficienza, sulla capacità cioè di generare valore
aggiunto mercantile. E’ oggi a tutti chiaro il contrasto fondamentale su cui si è retto finora il welfare
state. Si tratta del contrasto tra il rispetto dovuto alle persone in quanto individui – e quindi
essenzialmente diversi – e il rispetto dovuto alle stesse in quanto esseri umani – e quindi
essenzialmente eguali. Come ha scritto un liberal-democratico di rango, Michael Ignatieff (I bisogni
degli altri, Il Mulino, 1986): “Avremmo dovuto aspettarci che con la sanzione di una visione del
bene comune nel welfare state ci saremmo avvicinati gli uni agli altri. Il welfare state ha cercato di
realizzare la fraternità, dando a ciascun individuo il diritto di attingere alle risorse comuni. Tuttavia,
anche se si soddisfano i bisogni fondamentali di ognuno, non si soddisfa necessariamente il bisogno
di solidarietà sociale” (sic!, p. 133).
Non ci si deve allora meravigliare se oggi non solamente le diseguaglianze continuano ad
aumentare ma addirittura gli indicatori di felicità pubblica registrano diminuzioni costanti. Né c'è
da meravigliarsi se il principio di meritorietà viene confuso (maldestramente) con la meritocrazia,
come se si trattasse di sinonimi. (E dire che Aristotele fu il primo a scrivere che la meritocrazia è
pericolosa per la democrazia). Infine, non c’è da meravigliarsi se la reciprocità viene confusa con
l’altruismo e se i beni comuni vengono confusi con i beni pubblici.
La crisi fiscale dello Stato e l'allargamento della forbice tra risorse disponibili e
ampliamento della gamma dei bisogni - entrambi i fenomeni conseguenza sia della globalizzazione
sia della terza rivoluzione industriale, quella delle tecnologie info-telematiche - ha reso palese a tutti
la crisi entropica (e non già congiunturale) del welfare state. Ebbene, è in questo quadro che si
22
spiega la ripresa di interesse al modello civile di welfare, un modello che affonda le sue radici,
come si è detto, nell'economia civile di mercato. Oggi, sono soprattutto le c.d. scarsità sociali e non
tanto quelle materiali a fare problema nelle nostre società. Si pensi ai commons, beni di uso
comune come l'aria, l'acqua, le foreste, la conoscenza, ecc. Sappiamo che lo Stato non è attrezzato
per risolvere questo tipo di scarsità, come già F. Hirsch nel suo famoso libro del 1976 (I limiti
sociali allo sviluppo, Milano, Bompiani, 1986), aveva ampiamente dimostrato. E sappiamo anche
che non tutti i bisogni possono essere espressi in forma di diritti politici e sociali. Bisogni quali
quello di felicità, dignità, senso di appartenenza, di riconoscimento ecc., non possono essere
rivendicati come diritti di cittadinanza. Mai lo Stato potrà mettersi a capo di processi di
aggregazione della domanda che, soli, possono sortire l'effetto desiderato per rispondere alle nuove
scarsità. D'altro canto, anche le virtù tipicamente individuali (come la ricerca prudente del proprio
interesse) non danno la garanzia di saper affrontare la sfida dei beni comuni - come già Katharine
Coman aveva anticipato nel suo saggio sull'American Economic Review del 1911.
Per raccogliere e vincere tali sfide ci vogliono virtù di reciprocità, che esprimano da subito
un legame tra le persone. La prima di tali virtù è la fraternità. Si badi che mentre libertà e
uguaglianza sono valori individuali, la fraternità è un valore essenzialmente relazionale. Senza
riconoscimento dei legami che uniscono gli uni agli altri non si supera la "tragedy of commons" nel
senso di R. Hardin. Il welfare state, attribuendo al solo ente pubblico il compito di farsi carico della
giustizia distributiva, ha finito per creare un cuneo tra fraternità e solidarietà, e ora se ne vedono le
conseguenze.
4.3
Il nuovo welfare, che chiamo civile - e che ha poco a che spartire con la tedesca economia
sociale di mercato – deve allora recuperare ciò che durante l'ultimo secolo si è lasciato per strada.
Non ci sono solamente i beni privati e i beni pubblici; ci sono anche i beni comuni di cui si avverte
un crescente bisogno. Ecco perché accanto al principio dello scambio di equivalenti e al principio di
redistribuzione – bisogna dare spazio al principio di reciprocità, che né il nostro Codice Civile né la
nostra Carta Costituzionale prendono in considerazione. Quest'ultima ha bensì incorporato nel 2001,
nel Titolo V, il principio di sussidiarietà, ma se non si consente al principio di reciprocità di trovare
un suo spazio di azione entro il mercato - e non già fuori di esso, come oggi avviene salvo rare
eccezioni - la sussidiarietà continuerà a rimanere lettera morta. Tutt’al più, essa prenderà la forma
della compassione, pubblica o privata che sia. Eppure i nostri Costituenti avevano ben compreso il
punto qui sollevato. Ad esempio, l'art.42 della Costituzione sancisce che la proprietà è o pubblica o
privata. Ma l'articolo seguente riconosce che comunità di lavoratori o di utenti possano intestarsi
23
proprietà comuni; quanto a dire che si ammette la terza tipologia di proprietà – quella appunto
comune.
In buona sostanza, la transizione dal welfare state al welfare civile postula che si passi dal
binomio "pubblico e privato" al trinomio "pubblico, privato e civile", intervenendo con urgenza
sull'assetto istituzionale a livello sia giuridico (riforma del Libro I, titolo Il del Codice Civile; legge
quadro degli enti di terzo settore; riforma della normativa sulle mutue, ecc.) sia economicofinanziario (introduzione di strumenti finanziari per il civile; adeguamento delle regole di
funzionamento della concorrenza; creazione di una borsa sociale). A ben considerare, il senso
ultimo del nuovo Titolo V della nostra Carta Costituzionale e in particolare dell’art.118, è quello di
parlare a favore della costituzionalizzazione del civile. Invero, la distinzione, introdotta nella
modernità, tra pubblico e privato non fa più presa sulla realtà non solamente perché essa lascia fuori
segmenti importanti della società – come appunto non pochi dei soggetti del Terzo settore – ma
anche perché c’è conflazione tra le due sfere. Come osserva il costituzionalista tedesco G. Teubner,
(La cultura del diritto nell’epoca della cooperazione. Le costituzioni civili, Armando, Roma,
2005.), la conflazione deriva dalla circostanza che il contratto – che è lo strumento principe che
muove la sfera del privato – deve sempre più includere i problemi di carattere pubblico che esso
provoca. Ciò in quanto la contrattazione privata produce sempre esternalità pecuniarie (positive o
negative a seconda dei casi) che ricadono in capo a soggetti terzi rispetto alle parti in causa. La
ricerca di Teubner ci conferma che la società odierna può darsi ordini di tipo costituzionale che
emergono dalla società civile, e non solo dal corpo politico. Chiaramente, se si desidera che il
civile possa svolgere questa funzione integratrice, esso non può non porsi il problema dei modi
della propria rappresentanza, come sostengono E. Rossi et Al. nel cap.II.
In buona sostanza, chi ritiene che il modello di ordine sociale basato sulla dicotomia
pubblico-privato continui ad essere valido non ha bisogno di porsi il problema della rappresentanza
del civile, dal momento che quest’ultima viene, per così dire, incorporata ovvero sussunta nella
rappresentanza politica. Proprio come ancor oggi accade: il sistema politico vede il Terzo settore
come forza di sostegno agli attori politici in campo e non già come espressione di una modalità
nuova e originale di realizzare opere che hanno bensì ricadute sul pubblico, ma sono di natura
civile. Chi invece riconosce al Terzo settore un “potere istituente”, (M. Magatti, Il potere istituente
della società civile, Roma, Laterza, 2005), ed è convinto che, nelle attuali condizioni storiche, esso
già abbia acquisito la capacità di mirare ad un assetto costituzionale, deve ammettere che la
questione della rappresentanza non può essere ulteriormente procrastinata.
Su quale base poggia una tale preoccupazione? Sulla constatazione che il sistema politico
non riesce più ad assolvere il compito della rappresentanza dell’intera area del sociale. Infatti, la
24
crescita rapida del pluralismo sociale è oggi tale che gli individui non possono più dirsi
rappresentati da una sola organizzazione – fosse pure un grande partito oppure un grande sindacato.
E’ il fatto della pluriappartenenza, il fatto cioè che le persone nella società odierna possono
scegliere la propria identità come risultato di appartenenze plurime, a far sì che il tradizionale
sistema della rappresentanza non sia più sufficiente a coprire tutti gli ambiti in cui si esprime
l’esistenzialità delle persone. Posso anche aderire ad un partito politico ed essere iscritto ad un
sindacato, ma questi due luoghi istituzionali non mi bastano più per dare piena espressione alla mia
identità; oltre che piena tutela ai miei interessi.
Fino ad un passato recente, al tavolo della decisione pubblica partecipavano solo coloro che
avevano titolo, vale a dire coloro che potevano dimostrare di rappresentare interessi organizzati di
gruppi o di categorie di cittadini. Lo spiazzamento del civile ad opera del pubblico che ne è derivato
ha fatto sì che fino a tempi recentissimi la società fosse organizzata attorno a pochi attori sociali e
nella quale la capacità di azione collettiva era controllata da alcuni grandi partiti che operavano in
collegamento con reti di associazioni collaterali. Tanto è vero che per i soggetti della società civile
portatori di cultura avere accesso alla sfera pubblica significava, basicamente, far eleggere alcuni
dei propri membri in questa o quella organizzazione partitica. Nulla di più. (Cfr. S. Zamagni, Non
profit come economia civile, Bologna, Il Mulino, 1998).
Ebbene, la novità importante di questo nostro tempo è la presa d’atto della inefficienza oltre
che della inadeguatezza democratica che il modello fordista di organizzazione sociale ci ha lasciato
in eredità. E’ quando ci si confronta con i problemi connessi ai nuovi rischi sociali, alla nuova
configurazione del mercato del lavoro, ai conflitti identitari, ai paradossi della felicità, e così via,
che si inizia a percepire cosa significa aver lasciato ai margini il civile, impedendogli di fatto di
esprimere tutta la sua carica progettuale. E’ motivo di soddisfazione sapere che il Consiglio
d’Europa, nel febbraio 2011, ha avviato il progetto denominato “Responsabilità Sociale Condivisa”
rivolto al mondo delle imprese nel quale si riconosce il ruolo coessenziale dei soggetti di Terzo
settore nella implementazione della “governance multistakeholder”.
5.
L’ancoraggio etico del Terzo settore e la metrica del valore aggiunto sociale.
5.1
Di un ultimo argomento desidero qui trattare, anche se in breve. Come si sa, parecchie sono
le matrici etiche che dirigono l’azione dei singoli e delle varie formazioni sociali. Ognuna di queste
ha la sua propria storia e le sue proprie radici filosofiche e ideologiche. Quelle più rilevanti nella
stagione della modernità sono l’utilitarismo legato soprattutto all’opera di Jeremy Bentham (1789)
25
la cui prima parola è utilità; il contrattualismo hobbesiano rinverdito da John Rawls (1971) la cui
prima parola è giustizia; il deontologismo kantiano la cui prima parola è dovere; l’etica delle virtù,
di ascendenza aristotelica, e sviluppata nel Novecento dal personalismo filosofico la cui prima
parola è bene. (Per una illustrazione delle principali differenze tra le quattro matrici, rinvio al mio
saggio,”La critica delle critiche alla CSR e il suo ancoraggio etico”, in L. Sacconi (a cura di), La
responsabilità sociale dell’impresa, Roma, Bancaria Ed. 2005). Chiaramente, l’adozione dell’una o
dell’altra teoria etica comporta conseguenze di rilievo non solamente sul piano dei comportamenti
individuali, ma anche sul disegno dell’assetto istituzionale, in particolare giuridico, della società.
Ciò vale, e a fortiori, per il Terzo settore: vi sono soggetti e organizzazioni che
privilegiano l’ancoraggio utilitaristico; altri quello neo-contrattualista e così via. Tutte tali opzioni
sono legittime, perché fanno parte della visione del mondo che ciascuno deve essere lasciato libero
di abbracciare. Ma una condizione sempre deve essere soddisfatta: che ci si renda conto delle
conseguenze che ne derivano e soprattutto che si faccia conoscere a coloro con i quali si entra in
dialogo la propria scelta. Per quanto mi riguarda, la mia scelta è per l’etica delle virtù, perché
ritengo che questa sia la matrice filosofica maggiormente afferente ad un tipo di agire come quello
proprio dei soggetti del Terzo settore. Cerco ora di darne ragione.
Come Adam Smith, sulla scia della linea di pensiero inaugurata dagli umanisti civili italiani
del XV e XVI secolo aveva compreso, l’assetto istituzionale di una società che desidera progredire
deve essere forgiato in modo tale da favorire la diffusione tra i cittadini delle virtù civiche. Se gli
agenti economici – si legge nella Teoria dei Sentimenti morali (1759) - non accolgono già nella loro
struttura di preferenze quei valori che si vuole vengano affermati nella società non ci sarà molto da
fare. Per l’etica delle virtù, infatti, l’esecutorietà delle norme dipende, in primo luogo, dalla
costituzione morale delle persone; cioè dalla loro struttura motivazionale interna, prima ancora che
da sistemi di enforcement esogeno, come possono essere gli schemi di incentivo o le norme di
legge.
Il punto che merita una sottolineatura è che la cifra dell’etica delle virtù è la sua capacità di
risolvere, superandola, la contrapposizione tra interesse proprio e interesse per gli altri, tra egoismo
e altruismo. E’ questa contrapposizione, figlia della tradizione di pensiero individualista, a non
consentirci di afferrare ciò che costituisce il nostro bene. Una delle false necessità cui quella
tradizione di pensiero ci ha abituati è il vedere i termini che descrivono le coppie indipendenzaappartenenza, efficienza-equità, autointeresse-solidarietà come alternativi. Ogni rafforzamento del
senso di appartenenza viene visto come una riduzione della sfera di libertà; ogni avanzamento sul
fronte dell’efficienza come una minaccia all’equità o alla solidarietà; ogni miglioramento
dell’interesse individuale come un affievolimento di quello generale. Occorre liberarsi di queste
26
antinomie perché false:
entrambi i termini di queste coppie devono stare assieme, al modo dei
cavalli di Platone.
La vita virtuosa è la vita migliore non solo per gli altri ma anche per se stessi. E’ in ciò il
significato proprio della nozione di bene comune, il quale non è riducibile – come si è detto - alla
mera sommatoria dei beni individuali. Piuttosto, il bene comune è il bene dello stesso essere in
comune. Cioè il bene dell’essere inseriti in una struttura di azione comune, quale è, in generale,
l’azione dei soggetti del Terzo settore. Si noti che mentre pubblico è contrario di privato, comune è
contrario di proprio. Al tempo stesso, però, il bene comune non è dissociabile dal bene individuale.
Il bene del singolo non scompare, in modo indifferenziato, all’interno di una grandezza che è la
sommatoria dei beni dei singoli. E’ in ciò la differenza profonda tra bene comune e bene totale.
Il guadagno specifico che ci offre l’etica delle virtù è quello di indicarci che il bene è
qualcosa che avviene, che si realizza mediante le opere. Qui sta la chiave per dare risposta alla
domanda riguardante il motivo per “essere etici”. Infatti, se non è bene per se stessi comportarsi in
modo etico, perché non fare ciò che è bene per sè, anziché fare ciò che è raccomandato dall’etica?
D’altro canto, se è bene per sè “essere etici”, che bisogno c’è di offrire incentivi ai soggetti
economici perché facciano ciò che è nel loro stesso bene fare? La soluzione al problema della
motivazione morale dell’agente non è quella di fissargli vincoli (o dargli incentivi) per agire contro
il proprio interesse, ma di offrirgli una più completa comprensione del suo bene. Solo se l’etica
cessa di essere considerata come puro insieme di regole, (come esige il deontologismo) quello della
motivazione morale cessa di essere un problema, dal momento che siamo automaticamente motivati
a fare ciò che crediamo sia bene per noi. (Cfr. L. Bruni, A. Smerilli, La leggerezza del ferro. Una
teoria economica delle organizzazioni a movente ideale, Milano, Vita e Pensiero, 2011).
Ecco perché coltivare virtù come quella della reciprocità è compito irrinunciabile non
solamente dal punto di vista della cittadinanza – cosa da tempo risaputa – ma anche da quello
dell’economia. Poiché le istituzioni economiche influenzano – e tantissimo – i risultati economici,
occorre fare in modo che l’assetto economico-istituzionale della società incoraggi – e non penalizzi,
come oggi stoltamente avviene – la diffusione più larga possibile tra i cittadini delle pratiche di
reciprocità. I risultati poi seguiranno, nonostante quel che pensano gli scettici di varia appartenenza
filosofica.
Il segreto dell’azione reciprocante sta tutto qui: essa ci aiuta a rovesciare la tradizionale (e
diciamolo pure, spesso consolatoria) etica della filantropia privilegiata dagli utilitaristi, portandoci a
riflettere intorno alla essenzialità del principio di reciprocità in qualunque momento dell’esperienza
umana, e dunque anche in quella economica. La quale se non è certamente l’unica, neppure può
essere considerata una dimensione di secondaria importanza. Se è vero – come a me pare – che la
27
reciprocità può essere pensata come la cifra della condizione umana, allora essa deve caratterizzare
il modo di essere anche dell’economicità. Far comprendere come sia possibile fare economia,
ottenere risultati di rilievo stando nel mercato, senza recidere il rapporto con l’altro, è il grande
contributo di un Terzo settore che pone il proprio fondamento valoriale nell’etica delle virtù. Un
tale Terzo settore non si accontenta dell’orizzonte dell’economia solidale, ma mira all’economia
fraterna, che include, senza negarla, la prima, mentre non è vero il contrario. Infatti, mentre quello
di solidarietà è il principio di organizzazione della società che tende a rendere eguali i diseguali, il
principio di fraternità consente a persone che sono già riconosciute eguali di esprimere la propria
diversità, di affermare cioè la propria identità.
5.2
Come accade per ogni altro sistema di pensiero, anche l’etica delle virtù va coltivata e
sostenuta, intervenendo sia sul piano propriamente culturale sia su quello giuridico-istituzionale. A
seconda che si sostenga l’etica utilitarista o una delle altre matrici sopra ricordate si avranno
conseguenze diverse e di grande momento. Per cogliere le implicazioni pratiche di tale asserto
volgiamo l’attenzione ai sistemi motivazionali che troviamo all’origine dei comportamenti degli
individui. Si distingue tra motivazioni estrinseche (compio una certa azione per il vantaggio,
monetario o di altro tipo, che ne traggo); intrinseche (la mia azione ha per me un valore non
strumentale, ma finale; vale a dire ha un valore in sè); trascendenti (realizzo una certa opera perché
desidero che altri ne traggano vantaggio; in altro modo, perché voglio coscientemente produrre
esternalità positive a favore di altri). Dalla prevalenza nelle persone dell’uno o dell’altro tipo di
motivazione discendono i comportamenti che si osservano nella realtà: antisociali (è tale, ad
esempio, il comportamento dell’invidioso che trae vantaggio dalle disgrazie altrui e che è pertanto
disposto a sostenere costi specifici pur di conseguire un tale scopo); asociali (quello dell’homo
oeconomicus che intende né danneggiare né avvantaggiare gli altri; avendo preferenze
individualistiche, è interessato solamente al proprio io); prosociali (l’altruista più o meno
estrenìmo; l’homo reciprocans; chi pratica il dono come gratuità e così via).
Come la storia insegna e l’esperienza quotidiana conferma, i tre tratti comportamentali sono
sempre presenti nelle società di umani, quali che esse siano. Quel che muta da una società all’altra è
la loro combinazione: in alcune fasi storiche prevalgono comportamenti antisociali e/o asociali, in
altre quelli prosociali, con esiti sul piano economico e su quello del progresso civile che è facile
immaginare. (Per fare un esempio di grande attualità, si pensi al modello della commons-based peer
production, di cui la forma più nota è quella del progetto Wikepedia, un fenomeno di cooperazione
sociale il cui successo sarebbe stato impossibile immaginare ancora una decina di anni fa. La
produzione tra pari è un modello sociale di produzione caratterizzato da due elementi. Il primo è la
28
decentralizzazione; il secondo è che non sono i prezzi né i comandi ad indurre all’azione una
pluralità di soggetti partecipanti, ma le motivazioni intrinseche e trascendenti). Si pone la domanda:
da cosa dipende che in una data società, in una data epoca storica, la combinazione dei tratti
comportamentali sia dell’un tipo o dell’altro? Il fattore decisivo, anche se non unico, è, per un
verso, il modo in cui si fanno le leggi; per l’altro verso, il modo in cui si organizza il processo
lavorativo. Mi soffermo sul primo elemento. Se il legislatore, facendo propria una antropologia di
tipo hobbesiano, secondo cui l’uomo è un ente malvagio fin nello stato di natura e quindi è un
soggetto tendenzialmente antisociale, confeziona norme che caricano sulle spalle di tutti i cittadini
sanzioni e punizioni pesanti
allo scopo di assicurarne la esecutorietà, è evidente che i tipi
prosociali, che non avrebbero certo bisogno di quei deterrenti, non riusciranno a sopportare a lungo
il peso conseguente e quindi, sia pure obtorto collo, tenderanno a modificare per via endogena il
proprio sistema motivazionale.
E’ questo il cosiddetto meccanismo del crowding out (spiazzamento): leggi di marca hobbesiana
tendono a far aumentare nella popolazione la percentuale delle motivazioni estrinseche e quindi ad
accrescere la diffusione dei comportamenti di tipo antisociale. Proprio perchè i tipi antisociali non
sono poi così tanto disturbati dal costo dell’enforcement delle norme legali, dal momento che
cercheranno in tutti i modi di eluderle. Ebbene non v’è chi non veda come il punto sollevato trovi
piena e concreta applicazione al Terzo settore. Troppo spesso accade di imbattersi in leggi e
regolamenti che con l’intenzione lodevole di colpire comportamenti illeciti (che talvolta si annidano
nel variegato mondo del Terzo settore) finiscono con il fiaccare la spinta motivazionale della
stragrande maggioranza di chi vi opera, spegnendone la passione civile.
Non possiamo non ricordare, a tal riguardo, la posizione dell’illuminista napoletano Giacinto
Dragonetti, autore nel 1766 del celebre Delle virtù e dei premi: “Un altro mezzo di prevenire i
delitti è quello di ricompensare le virtù. Su di questo proposito osservo un silenzio universale nelle
leggi di tutte le nazioni del dì d’oggi. Se i premi proposti dalle Accademie ai discopritori di utili
verità hanno moltiplicato e le cognizioni e i buoni libri, perché i premi distribuiti dalla benefica
mano del sovrano non moltiplicherebbero altresì le azioni virtuose? La moneta dell’onore è sempre
inesausta e fruttifera nelle mani del saggio distributore”. E’ difficile trovare, nel XVIII secolo,
pensatori più lucidi e lungimiranti del Nostro sul tema in discussione. Si confronti tale brano con
quello corrispondente di Cesare Beccaria in Dei delitti e delle pene del 1765: “Le leggi sono
condizioni colle quali uomini indipendenti e isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un
continuo stato di guerra, e di godere una libertà resa inutile dall’incertezza di conservarla. Essi ne
sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità”. E’ agevole verificare
l’applicazione, in tale brano,della linea di pensiero hobbesiana quale emerge sia dal De Cive (1642)
29
sia dal Leviatano (1651), le due grandi opere del filosofo inglese Thomas Hobbes. In definitiva, il
punto importante da sottolineare è che una società che offre opportunità per facilitare l’esercizio di
comportamenti virtuosi è una società che favorisce concretamente la proliferazione dei soggetti del
Terzo settore. E viceversa.
L’argomentazione di cui sopra abbisogna tuttavia di una qualificazione importante. Si tratta
della distinzione tra premio e incentivo. Nonostante la confusione di pensiero che, complice un
certo modo di fare comunicazione, continua a dominare, notevoli sono le differenze tra questi due
concetti che troppo spesso vengono presi come equivalenti. (Si tenga presente che anche una
sanzione o una punizione sono un incentivo ma col segno meno, cioè un disincentivo). Ne indico
alcune, quelle più significative ai fini del presente discorso. Primo, con l’incentivo il principale di
una qualsivoglia relazione di agenzia induce il suo agente – si pensi al rapporto tra proprietà e
dirigenti di un’impresa; tra il responsabile di una organizzazione e i suoi stretti collaboratori; tra un
genitore e il figlio – ad operare nell’interesse privato del principale. In altro modo, fine ultimo dello
schema di incentivo è quello di allineare l’interesse dell’agente con quello del principale. Nel caso
dell’impresa, questo significa assumere che l’interesse personale del dirigente coincida con quello
di coloro per conto dei quali egli agisce (cioè i proprietari). Non così con il premio, che, invece,
mira al bene comune. “Il premio – scrive Dragonetti – è il vincolo necessario per legare l’interesse
particolare col generale, e per tenere gli uomini sempre intenti al bene”.
In secondo luogo, la struttura formale dell’incentivo è quella di un contratto che, una volta
sottoscritto dalle due parti di una relazione di agenzia, diviene vincolante per entrambe anche se è
vero che l’agente cercherà di manipolare gli incentivi per trarne vantaggio. Esso è dunque ex-ante
rispetto allo svolgimento dell’azione, e ciò nel senso che i termini contrattuali devono essere noti
all’agente prima ancora che questi si ponga all’opera. Al contrario, il premio è ex-post, essendo un
atto volontario del principale che, in quanto tale, non istituisce un’obbligazione in capo alle parti.
La natura del premio è dunque quella del dono, mentre quella dell’incentivo è l’attribuzione
all’agente di parte del valore aggiunto che questi ha creato. Ne deriva che la pratica, su larga scala,
e per lunghi periodi di tempo, degli schemi di incentivo, tende a lungo andare ad affievolire nella
comunità lo spirito del dono, dato che si fa solo ciò per cui è previsto un incentivo.
Terzo, uno degli effetti maggiormente indesiderati dell’impiego degli incentivi è l’erosione
del rapporto di fiducia tra principale e agente. Pensiamo ad un qualsiasi esempio di contratto
incentivante. E’ inevitabile che, prima o poi, l’agente si chieda perché mai il suo principale gli offre
l’incentivo. Infatti, delle due l’una: se quel che viene chiesto all’agente rientra nei compiti
specificati nel contratto di lavoro (o nel contratto d’opera), l’offerta dell’incentivo costituisce il
prezzo che il principale paga per la mancata fiducia nell’integrità morale del suo agente; se invece
30
all’agente si chiede di fare di più rispetto a quanto previsto dal contratto o dall’accordo oppure si
chiede di fare qualcosa che viola il codice di moralità dell’agente, allora l’incentivo si configura o
come forma di parziale sfruttamento dello sforzo extra compiuto dall’agente – nel primo caso –
oppure come il pagamento versato per indurre l’agente a vincere le sue resistenze morali – nel
secondo caso, che è quello oggi più frequente. (Si pensi all’incentivo rappresentato dalla
corresponsione di stock options ai top manager dei grandi istituti finanziari per indurli a fare ciò che
diversamente mai farebbero, come la recente crisi ha dimostrato ad abundantiam).
In entrambi i casi, quel che si va a produrre è una perdita dell’autostima da parte dell’agente
– il manager di una banca che per incassare l’incentivo inganna il cliente che gli chiede consiglio
circa l’acquisto di prodotti finanziari, perde la stima in sé e dopo un pò anche il proprio benessere
spirituale. Nulla di tutto ciò accade col premio che, invece, accrescendo l’autostima, rafforza il
legame sociale. (Il figlio che, impegnandosi molto nello studio, riceve, alla fine del percorso
scolastico, il premio del genitore rafforza la fiducia in sé e quindi sarà pronto per ulteriori sfide.
Non così, invece, il giovane che “negozia” col genitore l’incentivo in una forma del tipo “se sarai
promosso con una certa media, otterrai X; con un’altra media, otterrai Y”. Il giovane attribuirà
verosimilmente l’offerta dell’incentivo al fatto che il proprio genitore conosce la sua indole pigra
oppure la sua modesta capacità di apprendimento. In situazioni del genere, l’effetto indiretto
negativo dell’incentivo, che opera sul sistema motivazionale del giovane oppure sulla sua
costituzione morale, dominerà l’effetto diretto positivo che invece opera sullo sforzo profuso nello
studio: il giovane studia di più, ma impara di meno, perché come ricordava Goëthe “si apprende
solo ciò che si ama”).
Di un’ultima differenza tra incentivi e premi mette conto di dire. E’ vero che nel breve
periodo l’uso di incentivi può aumentare la produttività e può comportare un abbassamento dei costi
di gestione. Un esempio proposto da Dari-Mattiacci e De Greet in un recente studio fa al caso in
questione. (Citato in E. Carbonara, “Incentivi e premi”, in L. Bruni e S. Zamagni, Dizionario di
Economia Civile, 2009). Un dittatore tiene sotto scacco la popolazione del suo paese con la
minaccia (incentivo negativo) assicurata dalla possibilità di impiego di un solo proiettile: il primo
che oserà ribellarsi verrà ucciso. Con il costo di un solo proiettile, il dittatore riesce pertanto a
conservare il proprio potere. Cosa succederebbe, invece, se, anziché l’incentivo (negativo), il
dittatore volesse adottare un sistema di premi a favore di tutti coloro che, non ribellandosi,
accettano la perdita della democrazia? Che il costo di implementazione di un tale sistema
diverrebbe proibitivo. Di qui la conclusione sopra riferita: i premi sono troppo costosi da gestire. E’
questa mentalità che spiega ad esempio, perché l’Italia occupa, tra i paesi avanzati, l’ultimo posto
nel ranking del numero dei premi pro-capite. Mi limito a pochi dati: il Canada è il primo paese con
31
6,82 premi a testa; poi viene l’Inghilterra con 6,78; la Polonia con 6,16; l’Australia con 5,66. Gli
USA registrano un 3,80; la Francia 3,60 e l’Italia 1,96.! (Cfr. B. Frey, “Abundant but neglected:
awards as incentives”, Economists’ Voice, Feb.2009).
Cosa rispondere all’argomento di cui sopra? Per un verso, che il modello elaborato dagli
autori si regge sull’assunto antropologico secondo cui tutti i soggetti sono individualisti ed edonisti.
Il che non è, perché, come sopra suggerito, non è empiricamente vero che tutti gli individui sono
mossi all’azione da motivazioni estrinseche. Come la storia del Terzo settore indica sono milioni
nel nostro paese coloro che agiscono con motivazioni intrinseche e trascendenti. Per l’altro verso,
che è proprio l’impiego a lungo andare di incentivi a modificare, in una certa direzione, la struttura
motivazionale delle persone, cambiandone il sistema di valori. L’uomo, ci confermano le neuroscienze, è l’animale più capace di adattamento all’ambiente in cui vive: se questo è “tenuto su” con
gli incentivi è ovvio che, a lungo andare, anche la sua mente comincerà a funzionare secondo un
meccanismo omeostatico di adattamento. Un punto questo che il grande economista Alfred
Marshall aveva già compreso alla fine dell’Ottocento, quando osservava che l’impresa, prima
ancora di essere luogo di produzione di beni e servizi, è luogo di formazione del carattere di chi in
essa lavora: a seconda di come l’impresa viene organizzata, si formeranno uomini di un tipo o
dell’altro.
Gli incentivi creano sempre, tanto o poco, dipendenza – ed è per questo che sono
inflazionistici: basti guardare alle remunerazioni del top management di oggi e confrontarle con
quelle del top management di alcuni decenni fa – e abbassano i costi personali della tentazione – ed
è per questo che generano effetti perversi. Non è così con i premi. Ecco perché Dragonetti può
scrivere: “Essendo le virtù un prodotto non del comando della legge [né del contratto], ma della
libera nostra volontà, non ha su di esse la società diritto veruno. La virtù per verun conto non entra
nel contratto sociale; e se si lascia senza premio, la società commette un’ingiustizia simile a quella
di chi defrauda l’altrui sudore”. (Corsivo aggiunto). Non v’è chi non veda come queste parole
sembrano pronunciate apposta per il nostro Terzo settore.
5.3
Sorge spontanea la domanda: poiché per assegnare premi occorre stilare un ordinamento
di meritori età, quale metrica adottare per valutare il merito delle varie realtà del terzo settore? E’
questo l’Hic Rhodus, hic salta del Terzo settore. Perché mai il principio della massimizzazione del
profitto, nelle sue molteplici varianti, è diventato così onnipresente nelle nostre società, giungendo
ad invadere sfere ben lontane da quella commerciale? Per la semplice ragione che il profitto è un
efficace segnalatore di successo non solo di un’impresa, ma di una qualsiasi altra organizzazione. Il
32
non profit non ha un segnalatore equivalente di successo – si sostiene. Possiede bensì leve
motivazionali – si ammette – ma non di performance. Bisogna riconoscere che la sfida è seria e non
può non essere raccolta. Però può essere vinta.
Ma perché – ci si può chiedere - sarebbe così rilevante arrivare ad un ordinamento di
meritorietà dell’attività svolta dai soggetti del Terzo settore? Non è forse vero che questi soggetti
hanno già dato e continuano a dare prova della loro meritorietà? Si possono certo capire, ma non
giustificare, perplessità del genere. La ragione è presto detta. Infatti, se è vero che la cifra di tali
soggetti è la qualità relazionale, è del pari vero che l’attività da essi svolta richiede pur sempre
investimenti specifici e nel momento stesso in cui si parla di investimento sorge la necessità di
disporre di un criterio sulla cui base procedere alla allocazione dei fondi. Si badi che il problema
non si porrebbe se il Terzo settore fosse chiamato a svolgere funzioni meramente redistributive
ovvero di supporto agli altri due settori. In tale caso, il finanziamento prenderebbe l’una o l’altra
delle tante forme delle erogazioni liberali o della filantropia d’impresa (corporate philantropy), per
un verso. Come ben sanno gli esperti di fund-raising, il filantropo o il donatore non hanno certo
bisogno di un giudizio di carattere comparativo e controfattuale quando vanno a porre mano al
proprio portafoglio. Per l’altro verso, quando il Terzo settore agisce per conto delle pubbliche
amministrazioni, sono queste ultime a formulare un giudizio di meritori età sul suo operato. Ma nel
momento in cui il Terzo settore si dichiara pronto (e desideroso) di spiccare il salto verso una piena
autonomia e indipendenza – come qui si auspica – è evidente che il problema di arrivare a definire
un ordinamento (ranking) di meritorietà non può più essere eluso. Si pensi solo a quel che
succederà quando cooperative sociali, imprese sociali e fondazioni avranno accesso a capitali di
rischio.
In buona sostanza, c’è oggi nella nostra società una domanda crescente di valutazione del
valore aggiunto sociale (VAS) e ciò per un duplice ordine di circostanze. In primo luogo, perché
sempre più forte dai cittadini sale la richiesta di accountability: non si chiede solamente il rispetto
degli adempimenti formali nell’uso delle risorse disponibili, ma anche che si dia conto dei risultati
ottenuti. In secondo luogo, perché la diffusione sempre più ampia a livello popolare del principio
di sussidiarietà orizzontale esige che, nella erogazione dei fondi, soprattutto pubblici, i criteri basati
su regole procedurali vengano almeno affiancati, se non proprio sostituiti, da criteri che tengano
conto dell’impatto sul ben-essere delle persone del modo in cui i cosiddetti servizi sociali vengono
erogati. Non è difficile darsene conto. Mentre per i meccanismi allocativi basati sul principio di
gerarchia bastano le procedure burocratico-amministrative, quelli fondati sul principio di
sussidiarietà non possono non tenere conto delle esternalità positive che enti come le cooperative
sociali, le imprese sociali, le fondazioni sono in grado di generare.
33
Ma è possibile valutare – molti si chiedono - cioè dare un valore alla qualità? In altri termini,
è possibile esprimere un giudizio argomentato razionalmente intorno ad un oggetto quale la qualità
tacita (o relazionale), considerato che non può darsi un’unità di misura riconosciuta universalmente,
e perciò univoca, per un attributo basicamente qualitativo? Si tratta di questione antica e intrigante
quanto poche. Conosciamo tutti la risposta dell’epistemologia neo-positivista secondo cui
solamente le quantità possono essere misurate; ma già il grande matematico francese Emile Borel,
nel suo trattato Space and Time del 1926, aveva provveduto a porre le basi di una risposta
alternativa. La tesi che vi viene discussa è che tutta la conoscenza, tutta la scienza e tutta la
matematica sono prodotti della coscienza umana e, come tali, devono essere visti come strutture
intellettuali relative alla posizione degli esseri umani entro l’universo. Scrive il celebre scienziato:
“Il valore della scienza non è in alcun modo diminuito dall’osservazione che essa è relativa
all’uomo. Quale interesse potremmo avere in una conoscenza non connessa a noi stessi – sempre
che il concetto stesso di una conoscenza del genere possa risultare non contradditorio?” (p.42).
Secondo Borel, le incomprensioni nascono dall’equivoco secondo cui il misurabile viene
identificato con la dimensione del quantitativo – una idea questa che trae origine dalla rivoluzione
scientifica del XVII secolo e dalla coupure epistemologica che ne è derivata. Col risultato che i
numeri presero ad essere considerati non soltanto come entità in sé, ma anche come “nomi” per
altre realtà, una volta che queste fossero state sottoposte ad un processo di quantificazione. Ma ciò
non implica affatto che attributi qualitativi come la relazionalità, la reciprocità, il VAS non possono
essere misurati. E’ dal contributo di Borel che è derivata la nozione di oggettività posizionale, come
categoria di pensiero per così dire intermedia tra quella di oggettività e quella di soggettività. Come
spiega Amartya Sen – lo studioso che più di ogni altro si è avvalso nel proprio lavoro scientifico
della oggettività posizionale - non ci sono solamente verità soggettive e verità oggettive ma anche
proposizioni il cui status di verità “dipende dalla nostra posizione rispetto all’oggetto di
osservazione”. E aggiunge: “La visione posizionale dell’oggettività considera la dipendenza
parametrica delle osservazioni, delle credenze, delle decisioni riguardanti gli aspetti posizionali
degli individui. Essa conduce ad una visione dell’oggettività che contraddice la formulazione
classica dell’invarianza necessaria nell’oggettività. L’approccio suggerito riguarda l’invarianza
personale senza, al tempo stesso, formulare una domanda generalizzata di invarianza posizionale”.
(La ricchezza della ragione, Bologna, Il Mulino, 2005, p.322).
Come si comprende, l’idea è in sé semplice. Una volta fissati i parametri di giudizio che il
valutatore ritiene di dover adottare e dunque una volta scelta la prospettiva di sguardo sulla realtà, è
possibile procedere a valutare in modo posizionalmente oggettivo la performance di quegli enti che
costituiscono il Terzo settore. Ripeto, la valutazione di meritorietà e il conseguente ordinamento
34
saranno oggettivi rispetto alla posizione scelta dal valutatore, cambiando la quale muterà anche la
misurazione del VAS. Ma ciò non costituisce affatto problema, come il caso della misurazione del
PIL (prodotto interno lordo) chiaramente indica. Si tenga presente, infatti, che pure la metodologia
di calcolo del PIL si appoggia sulla nozione di oggettività posizionale. Eppure, nessuno oggi pone
in discussione tale metrica. Al solo scopo di fissare le idee, mi limito qui ad indicare alcuni
parametri di giudizio sulla base dei quali costruire degli indicatori di successo dei vari enti .
Un primo parametro è certamente la reputazione acquisita dall’ente nel corso di un
prefissato periodo di tempo. Come noto, il capitale reputazionale è figlio di storie di successo che
dicono della trasparenza, della affidabilità e della professionalità del soggetto in causa e dunque
della fiducia che ha saputo guadagnarsi. Bisogna essere depositari di tanta fiducia se si vuole
riuscire nel proposito di aggregare la domanda dei portatori di bisogni. E che ci sia oggi urgente
necessità di aggregare la domanda per sollecitare i soggetti di offerta a corrispondervi ci viene
rivelato da una pluralità di indagini empiriche.
Un secondo parametro deve misurare la capacità di sospingere all’esterno la frontiera delle
opportunità di scelta delle persone. Perché si tratta di qualcosa di importante? La tradizione del
welfarismo ci ha indotto a pensare che le opzioni debbono essere valutate sulla base del grado in cui
le preferenze individuali sono soddisfatte. Ma in tal modo essa non dà adeguata rilevanza alla
libertà di scelta. Il che è particolarmente grave in periodi, come l’attuale, caratterizzati da forte
evoluzione dei bisogni. Ora, se si ammette – come penso si debba – che la libertà di scelta è un
elemento importante del benessere individuale, indipendentemente da ciò che viene poi scelto,
allora una dilatazione del campo di scelta è qualcosa di intrinsecamente buono, che in quanto tale
merita di essere premiato.
Terzo, la capacità di accrescere il pluralismo dei soggetti di offerta di un determinato
servizio e/o bene. E’ noto che uno dei principali impedimenti all’accumulazione del capitale sociale
è il cosiddetto group-think (pensiero di gruppo) secondo la definizione che ne ha dato L. Janis
(Victims of group-think, Boston, Houghton, 1972), l’autore che per primo lo ha introdotto. Il
pensiero di gruppo- da non confondersi con il conformismo – è il modo di pensare di coloro che,
fortemente coinvolti in un gruppo coeso, posti di fronte ad una decisione da prendere desiderano –
senza peraltro esserne costretti – raggiungere l’unanimità dei consensi e di conseguenza rinunciano
ad ascoltare altre voci e a narcotizzare il conflitto interno al gruppo. Pertanto, quanto più un ente di
Terzo settore si struttura in modo da scongiurare il rischio del group-think, tanto più meritoria sarà
la sua attività, perché tanto più sarà in grado di fornire risposte a gruppi minoritari di persone, le cui
esigenze raramente riescono ad entrare nei programmi standard di intervento. E’ noto, infatti, che il
35
cosiddetto universalismo selettivo tende a ridurre sempre più, per le note ragioni di bilancio, la
platea degli aventi diritto.
Quarto, l’effetto moltiplicatore sullo sviluppo locale. In breve, si tratta di questo. La
globalizzazione, contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, ha fatto rinascere l’importanza della
“città”, cioè del territorio, come spazio non solo civile, ma anche economico e sociale. Sono le
cosiddette economie di agglomerazione a rendere le città attrattori sempre più credibili delle attività
di impresa. E’ un fatto che le attività produttive ad alta intensità di conoscenza sono basicamente
attività cittadine. Questo significa che le “industrie creative” tendono a raggrupparsi attorno a quelle
città che sanno offrire opportunità culturali adeguate. E’ la città il luogo per eccellenza in cui si
forma e si rafforza l’identità culturale di una comunità di persone e dove si coltivano le virtù
civiche. Per sua natura, il Terzo settore è un generatore di economie di agglomerazione. Ecco
perché una città senza soggetti di Terzo settore è come se avesse ali tarpate e quindi è meno capace
di osare vie nuove.
Infine, non si può non tenere conto della capacità effettiva di networking, la capacità cioè di
fare rete con altri soggetti (pubblici o privati) per il raggiungimento di obiettivi comuni,
promuovendo quel modello di sussidiarietà che chiamo circolare e che costituisce, oggi, la versione
più avanzata e più promettente di risultati positivi del principio di sussidiarietà. L’idea,
basicamente, è di mettere in interazione i tre vertici del triangolo magico: enti pubblici; mondo delle
imprese; società civile organizzata per arrivare a dare corpo a quel modello di amministrazione
condivisa che, a tutt’oggi, solo pochissime realtà territoriali sono riuscite ad attuare. Ebbene, non
v’è bisogno di grande esperienza per comprendere che solo il Terzo settore può svolgere il ruolo di
attivatore e facilitatore di tale interazione. Un’ultima osservazione. Si badi, che è lo stesso Terzo
settore che deve arrivare a proporre la propria metrica; non può delegare ad altri, per quanto esperti,
un tale compito. Mai si dimentichi, infatti, che quel che si misura determina, alla lunga, quel che si
fa e come lo si fa.
6
Al posto di una conclusione
“Non dobbiamo essere come una voragine, che prende senza restituire, ma dobbiamo
restituire ciò che ci è stato dato” (Dante, De Monarchia). Come il Poeta aveva chiaramente
compreso, è l’agire reciprocante il cemento duraturo della società; e il Terzo settore ne è il
principale produttore. Ma a quale condizione esso riesce a svolgere con successo un tale compito?
Alla condizione di riuscire a far marciare assieme, alla medesima velocità, i due cavalli della
36
celebre metafora platonica di cui si è ripetutamente scritto nelle pagine precedenti: efficienza e
solidarietà; produzione e distribuzione della ricchezza; libertà e responsabilità; spontaneità e
professionalità; pensiero calcolante (quello che insegna a risolvere problemi) e pensiero pensante
(quello che sa indicare la direzione). Queste coppie di termini sono applicabili a contesti diversi,
come si è visto in questo saggio, ma il messaggio è sempre lo stesso: i soggetti del Terzo settore
fioriscono quando riescono a mantenere in equilibrio i due termini di ciascuna coppia.
Diversamente, lo snaturamento, nell’un caso,
ovvero l’involuzione regressiva, nell’altro,
diverrebbero una triste conseguenza.
Questo comporta che quello del Terzo settore è un pensiero che non può che essere ellittico,
vale a dire un pensiero che ruota attorno a due fuochi in maniera tale che la distanza da entrambi
rimane sempre la stessa quale che sia il punto dell’ellissi nel quale ci si trova. Da ciò discende una
precisa responsabilità in capo al legislatore, nazionale o regionale che sia. Si consideri infatti che tre
sono i tipi di norme che stanno al fondamento dell’ordine di qualunque società: le norme legali; le
norme sociali; le norme morali. Le prime sono espressione del potere coercitivo dello Stato e la loro
esecutorietà è legata a ben definiti sistemi di punizioni; le norme sociali, invece, sono il precipitato
di convenzioni e tradizioni di più o meno antica data, e la loro esecutorietà dipende dalla vergogna
che sempre accompagna la stigmatizzazione di comportamenti devianti da parte della comunità
(perdita di status e discriminazione sociale); le norme morali, infine, sono associate alla prevalenza
di ben definite matrici culturali (di tipo religioso e non), e la loro violazione fa scattare negli
individui il senso di colpa. (Per una ricostruzione storica dei tre tipi di norme e del loro significato
pratico, rinvio al mio Avarizia. La passione dell’avere, Bologna, Il Mulino, 2009).
Quale il nesso fra le tre tipologie di norme? Che se le leggi che vengono promulgate
“marciano contro” le norme sociali e, ancor più, contro le norme morali prevalenti nella società, non
solamente le prime non produrranno i risultati desiderati, perché non saranno rispettate - non è certo
possibile sanzionare tutti i violatori - ma quel che è peggio andranno a minare la credibilità e/o
l’accettabilità delle altre due categorie di norme, minacciando così la stabilità dell’ordine sociale
stesso. E’ quel che succede con quelle che la letteratura giuridica chiama “inexpressive laws”, cioè
leggi che non riescono ad esprimere quei valori che configurano l’architettura di una determinata
società.
Ecco perché sarà bene che il Terzo settore vigili con grande accortezza affinchè le
imminenti leggi di riforma che lo riguardano direttamente non abbiano a prendere la forma di leggi
non espressive. Meglio allora sarebbe non fare alcunchè.
Chiudo con un’immagine che prendo a prestito da Fiori del male di Charles Baudelaire:
l’immagine dell’albatros, un uccello che, al contrario del calabrone, possiede ali amplissime e
zampe corte e sottili, comunque di dimensioni non proporzionate all’apertura alare. Quando si
37
impadronisce delle correnti ascensionali dell’aria, l’albatros vola con tale agilità e con così stupenda
maestà da sembrare che il suo volo non gli richiede grande sforzo. Non appena si posa a terra, però,
diventa maldestro, sgraziato e incapace, senza l’aiuto del vento, di spiccare il volo. Più agita le sue
grandi ali, più appare goffo: e il risultato è che non sa fare altro che ridicoli balzi in avanti. Il Terzo
settore è un po’ come l’albatros: quando vola alto riceve consenso e ammirazione; quando si posa a
terra, e non tende le ali al vento, svela una certa impotenza, perché “a terra” è molto più facile
scontrarsi (e per ragioni quasi sempre meschine) che non “in cielo”. E’ bene allora che il Terzo
settore non presti ascolto a chi gli suggerisce di volare basso; si acconci piuttosto per intercettare le
correnti ascensionali dell’aria.
38