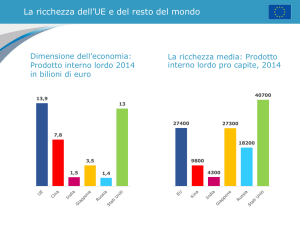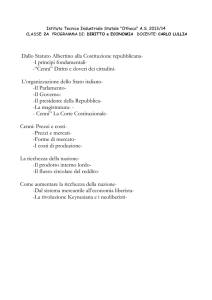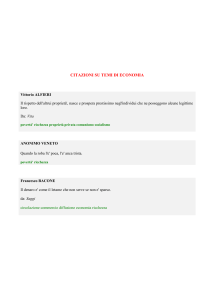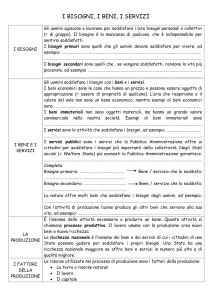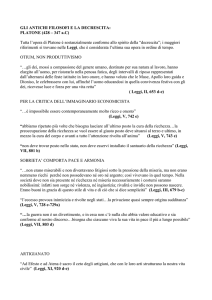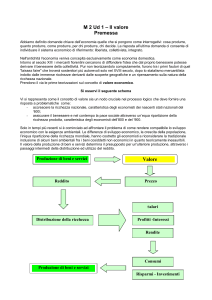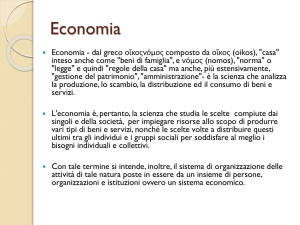Compendio di
Diritto
tributario
Raffaello Lupi
in questa collana:
Compendio di Diritto Penale – Parte Generale
Compendio di Diritto Penale – Parte Speciale
Compendio di Diritto Costituzionale
Compendio di Ordinamento e Deontologia Forense
Compendio di Diritto dell’Unione Europea
Compendio di Diritto del Lavoro
Compendio di Diritto Civile
Compendio di Procedura Civile
Compendio di Diritto Internazionale Privato
Compendio di Diritto Amministrativo
Compendio di Procedura Penale
Compendio di Diritto Ecclesiastico
Compendio di contabilità di Stato e degli enti pubblici
© Copyright – DIKE Giuridica Editrice, S.r.l. Roma
La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione
con qualsiasi mezzo (compresi i film, le fotocopie), nonché
la memorizzazione elettronica, sono riservate per tutti i Paesi.
Copertina
Chiara Damiani
Realizzazione editoriale
Studio Editoriale Cafagna, Barletta
Finito di stampare nel mese di giugno 2014
Indice generale
Premessa
I due volti della tassazione,tra aziende e uffici tributari......... XI
parte prima
DETERMINAZIONE TRIBUTARISTICA DELLA RICCHEZZA
TRA ISTITUZIONI, AZIENDE E INDIVIDUI
Capitolo 1
PATRIMONIO, TARIFFE E TRIBUTI NEL FINANZIAMENTO DELLA
SPESA PUBBLICA: IMPOSTE E DETERMINAZIONE DELLA RICCHEZZA TRA UFFICI TRIBUTARI E AZIENDE...............................................3
1.1. Fiscalità e tassazione dalle “entrate patrimoniali” ai tributi................................3
1.2. La finanza tributaria: il riferimento delle “imposte” alla ricchezza e le
sue esigenze logiche di determinazione...........................................................4
1.3. Uffici pubblici e gruppi intermedi nella valutazione preindustriale della
ricchezza .......................................................................................................6
1.4. Segue: la determinazione ragionieristica della ricchezza attraverso le
aziende ..........................................................................................................7
1.5. Segue: differenza tra tassazione attraverso le aziende e c.d. “autotassazione”............8
1.6 Segue. Disorientamento tributario e bagaglio economico-sociale di pub
blica opinione e classi dirigenti........................................................................9
1.7. Segue. Le divagazioni sul rapporto “stato –mercato” e sugli effetti eco
nomici dei tributi: “pressione fiscale”, “redistribuzione” e determina
zione della ricchezza.....................................................................................10
1.8. Determinazione della ricchezza tra diritto ed economia: beneficio
sacrificio, redditi, consumi e costi..................................................................11
1.9. Determinazione della ricchezza tra esigenze logiche e gettito........................13
1.10.Tipologie economico-giuridiche di imposte e relativo gettito........................14
1.11. Segue. Tipologie di tributi e criteri di determinazione della ricchezza.............14
IV
Compendio di Diritto Tributario
Capitolo 2
RUOLO E LIMITI DELLA LEGISLAZIONE NELLA DETERMINAZIONE TRIBUTARISTICA DELLA RICCHEZZA .................................................16
2.1. La funzione organizzativa e garantistica della legislazione tributaria (ri
serva di legge e statuto del contribuente) ......................................................16
2.2. Il richiamo alla determinazione della ricchezza nell’art. 53 della Costi
tuzione e l’equivoco della “capacità contributiva globale individuale”.............19
2.3. Tassazione attraverso le aziende come illusione di poter amministrare
per legge: il diritto tributario sostanziale........................................................21
2.4. Segue: la sopravvalutazione della legislazione nell’autotassazione.....................23
2.5. Determinazione della ricchezza e controllo della Corte costituzionale ..........25
2.6. Libertà comunitarie, vincoli al legislatore tributario e determinazione
della ricchezza..............................................................................................26
Capitolo 3
DETERMINAZIONE CONTABILE E VALUTATIVA DELLA RICCHEZZA TRA TASSAZIONE ATTRAVERSO LE AZIENDE E AUTOTASSAZIONE (PUNTI FORTI DELL’ADEMPIMENTO E DELL’EVASIONE)..................................................................................................................29
3.1. Le aziende come “corpi sociali intermedi” nella determinazione della
ricchezza .....................................................................................................29
3.2. Rigidità gestionali come strumento di determinazione della ricchezza
attraverso le aziende......................................................................................31
3.3. La riutilizzazione di documenti contabili per la determinazione tri
butaristica della ricchezza..............................................................................35
3.4. Ulteriori adempimenti esclusivamente tributari: scontrini, dichiarazioni
e versamenti..................................................................................................37
3.5. Tassazione attraverso le aziende di ricchezza di terzi:“contribuenti di
diritto” e “di fatto” tra rivalse, ritenute, segnalazioni e controversie pri
vate con oggetto tributario............................................................................41
3.6. Segue. Il sostituto d’imposta come strumento di tassazione delle somme
erogate a terzi (ritenute alla fonte tra funzione esattiva e segnaletica)..............43
3.7. La ricchezza fiscalmente non registrata, a beneficio dei titolari di orga
nizzazioni aziendali (ipotesi sulla “grande evasione”)......................................47
3.8. Costo dei tributi, “cunei fiscali”, concorrenza sleale e ricchezza non re
gistrata per finalità aziendali..........................................................................51
3.9. Qualificazione giuridica della ricchezza registrata e logiche dell’inter
pretazione nella tassazione attraverso le aziende (le “simmetrie concet
tuali” tra soggetti diversi e tempi diversi) ......................................................54
3.10. Segue: Evasione interpretativa, pianificazione fiscale ed elusione come ti
pici comportamenti aziendali (rinvio alle contestazioni interpretative co
me “diversivi istituzionali”)...........................................................................58
3.11. Evasione internazionale tra contestazioni interpretative e ricchezza non
registrata.......................................................................................................63
indice
V
3.12.Riepilogo: simmetrie della tassazione attraverso le aziende ed “arbi
traggi”, tra correttezza sistematica, elusioni e frodi.........................................64
3.13. Dove le aziende non arrivano: l’inutile “ragionierizzazione” dei lavora
tori indipendenti (il diversivo della “contabilità fiscale”) ................................66
3.14.Mancata registrazione degli incassi nel lavoro indipendente verso con
sumatori finali...............................................................................................68
3.15. La crescente “ricchezza non osservabile”, discontinua, collaterale, anche
di sopravvivenza............................................................................................70
3.16. Professionisti tra tassazione attraverso le aziende e attraverso gli uffici:
prospettive per un loro uso più efficiente.......................................................73
Capitolo 4
Determinazione della ricchezza, studiosi, pubblica
opinione e spiegazioni dell’evasione fiscale................................77
4.1. Conferme macroeconomiche della prevalenza dell’evasione da ricchez
za non registrata............................................................................................77
4.2. Utilità della propaganda nell’autotassazione ed esagerazioni controproducenti.........................................................................................................79
4.3.Mancata spiegazione della determinazione della ricchezza ai fini tri
butari: lo “pseudonormativismo” accademico................................................81
4.4. Segue: impossibilità di avere spiegazioni organiche da altri studiosi so
ciali, dai professionisti, dalle istituzioni, dai mezzi di informazione..................91
4.5. I riferimenti sensati, ma semplicistici, al “senso civico”, alle “aliquote”,
al “contrasto di interessi”, alla “ragionierizzazione delle stime”.......................94
4.6. Segue: le spiegazioni politicamente strumentali e socialmente laceranti ..........97
4.7. Spiegazioni istituzionalistiche in una cornice di unità del diritto e col
legamento con altre scienze sociali.............................................................. 100
Capitolo 5
LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE TRA RICCHEZZA NON REGISTRATA E CONTESTAZIONI INTERPRETATIVE ........... 105
5.1. Poteri amministrativi ed entrate pubbliche (tariffe, tasse in senso stretto,
monopoli, contributi, imposte etc...) ........................................................... 105
5.2. Le istituzioni tributarie (Agenzia delle Entrate – Guardia di Finanza –
uffici comunali – concessionari, etc.) .......................................................... 108
5.3. Le amministrazioni tributarie tra immagine istituzionale e protezione
del singolo.................................................................................................. 110
5.4. Le istruzioni ai contribuenti come funzione amministrativa tributaria
(modulistica, assistenza e interpretazioni amministrative).............................. 114
5.5. L’acquisizione delle dichiarazioni, e il loro controllo di correttezza for
male e documentale.................................................................................... 116
5.6. Indagini interne e internazionali, relativi vizi e poteri di verbalizzazio
ne amministrativa........................................................................................ 117
VI
Compendio di Diritto Tributario
5.7. Gestione dei dati e finalità del controllo valutativo degli uffici: la “tax
compliance” ............................................................................................... 121
5.8. Empirismo probabilistico e valutativo nella determinazione della ric
chezza non registrata. (Le questioni di fatto nel diritto tributario)................ 125
5.9. Segue: necessità di coordinamento tra controlli contabili e valutativi:
gli “indizi contabili”.................................................................................... 126
5.10. Stima della ricchezza non registrata, discrezionalità e “indisponibilità”
del credito tributario................................................................................... 128
5.11. Segue. I sospetti di connivenza o negligenza come ostacolo a una sere
na valutazione della ricchezza...................................................................... 130
5.12. Segue. Inadeguatezze della normativa sulla prova della ricchezza non
registrata (ambiguità dei concetti di accertamento analitico contabile e
induttivo extracontabile)............................................................................. 133
5.13.Valutazione amministrativa della ricchezza non registrata, tra indizi fisi
co-economici e studi di settore (rinvio agli indizi finanziari al par. 5.16).......... 135
5.14.Tenore di vita e spesa “privata” come indizio di ricchezza non registra
ta (accertamenti “sintetico-redditometrici”)................................................. 140
5.15. Quale intervento amministrativo su manifestazioni collaterali o spora
diche di ricchezza?...................................................................................... 142
5.16. Incroci, banche dati, e tracciabilità: illusioni e realtà su altri “indizi contabili”.......................................................................................................... 145
5.17. Le aziende come paradossale capro espiatorio dei malesseri creati dal
loro ruolo di “esattori del fisco” ................................................................. 146
5.18.Richiami ed esemplificazioni sulle contestazioni interpretative: la dif
ficile difesa contro “l’inferno del dichiarato”................................................ 148
5.19. Segue: il controproducente controllo obbligatorio delle grandi aziende:
quando i controlli fiscali “si sprecano”......................................................... 151
5.20. La tassazione per condono: una conferma della tendenza ad “ammi
nistrare per legge”....................................................................................... 154
Capitolo 6
SEGUE IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE ................................................................................................................. 157
6.1. I provvedimenti amministrativi degli uffici tributari..................................... 157
6.2. Segue: motivazione e prova della richiesta dei tributari................................. 160
6.3. Provvedimenti degli uffici tributari verso coobbligati solidali e con
tribuenti di fatto......................................................................................... 162
6.4. Il contenzioso amministrativo: accertamento con adesione, conciliazio
ne giudiziale, “mediazione” e prospettive..................................................... 164
6.5. Segue. Inadeguatezze del ricorso in opposizione e necessità di ulteriori
livelli di responsabilità: prospettive della “mediazione tributaria” .................. 167
6.6. Le varie funzioni del ritiro degli atti in autotutela, tra correzione, abbat
timento e definitivo abbandono.................................................................. 170
indice
VII
6.7.Il contenzioso giurisdizionale: controllo dell’istituzione amministrati
va o suo motivo di paralisi?......................................................................... 170
6.8. Segue: reclutamento dei giudici e avvio del processo.................................... 173
6.9. La procedura: difficile coesistenza tra sostanza impugnatoria ed ispira
zione civilistica........................................................................................... 177
6.10. Il fallimento della “via giurisdizionale alla determinazione della ricchez
za”: ostacoli al funzionamento degli uffici e possibili vie di uscita................. 182
6.11.Riscossione coattiva ed evasione da riscossione (l’esattore – Equitalia
come diversa autorità amministrativa esattrice delle imposte)....................... 186
6.12. La “sicurezza della riscossione” e la sua celerità in pendenza di ricorso......... 189
6.13. Impossibilità di rimpiazzare con inasprimenti sanzionatori l’insuffi
cienza dei controlli 1) le sanzioni amministrative......................................... 191
6.14. Segue: 2 Il confuso palliativo penaltributario tra mancata registrazione
della ricchezza e contestazioni interpretative................................................ 195
PARTE SECONDA
IL REGIME DELLA RICCHEZZA REGISTRATA
Capitolo 7
I REDDITI E I CONSUMI DETERMINATI UNITARIAMENTE ATTRAVERSO LE AZIENDE ............................................................................... 201
7.1. La determinazione unitaria dei consumi e dei redditi nella tassazione
attraverso le aziende: Iva e imposte dirette................................................... 201
7.2. Imposte sui consumi: dalla visibilità materiale delle merci a quella con
tabile del “valore aggiunto” (l’IVA).............................................................. 203
7.3. Segue: le tecniche per raggiungere il consumo tra detrazione e “non imponibilità”................................................................................................... 205
7.4. L’IVA nei rapporti internazionali e intracomunitari..................................... 208
7.5. Il concetto di “impresa fiscale”, tra aziende, “lavoratori indipendenti”
ed enti “no profit”....................................................................................... 210
7.6.Operazioni attive “tipiche” (“cessioni di beni” e “prestazioni di servi
zi”) tra “volume d’affari” (o di ricavi) e “valore aggiunto”............................ 212
7.7. Supporti documentali delle operazioni attive, dei costi e dei consumi
(registrazioni, fatture, scontrini, note di credito)........................................... 213
7.8. Segue: dai documenti ai libri contabili (richiami e integrazioni rispetto
ai paragrafi 3.3-3.4)..................................................................................... 216
7.9. L’inerenza nelle imposte sui redditi e nell’IVA: 1) la distinzione tra costi
e consumi................................................................................................... 219
7.10. Segue: 2) Inerenza e operazioni attive non soggette a tributo – deduzio
ne interessi passivi....................................................................................... 221
7.11. Principali elementi rilevanti ai fini della dell’IVA e principio di onni
comprensività delle imposte sui redditi........................................................ 223
VIII
Compendio di Diritto Tributario
7.12. Il momento impositivo nella tassazione attraverso le aziende (cassa,
competenza, irrilevanza delle mere valutazioni: rinvio alle operazioni
straordinarie)............................................................................................... 224
7.13. Il valore fiscalmente riconosciuto e l’esposizione in bilancio dei beni di
impresa, tra criteri patrimoniali e reddituali ................................................ 226
7.14.Valutazioni fiscali di fine esercizio e rapporti col bilancio............................. 229
7.15. Le valutazioni del patrimonio di fine esercizio 1) ammortamenti e accantonamenti.............................................................................................. 232
7.16. Le valutazioni di fine esercizio: 2) rimanenze di beni e servizi...................... 233
7.17. Coordinamento tra tassazione delle società e dei soci................................... 234
7.18. I criteri di collegamento della ricchezza al territorio nazionale.................... 237
7.19. Segue: simmetrie fiscali e rapporti internazionali, concorrenza fiscale
dannosa, transfer price, cfr............................................................................ 238
7.20.Realizzo e neutralità nelle operazioni straordinarie d’impresa...................... 241
7.21. Determinazione tributaristica della ricchezza e procedure concorsuali......... 243
Capitolo 8
ATTIVITÀ “NON AZIENDALI”: PROFESSIONI LIBERALI, LAVORO
DIPENDENTE, AGRICOLTURA, FABBRICATI, RISPARMIO E ATTI
OCCASIONALI.................................................................................................. 246
8.1. Le modeste specificità rispetto all’impresa del lavoro autonomo “professionale”................................................................................................... 246
8.2.Ricchezza agricola tra catasto e IVA (tracce di forfettizzazione nella tas
sazione attraverso le aziende?)...................................................................... 247
8.3.Tassazione ragionieristico-documentale del lavoro dipendente..................... 249
8.4.Redditi dei fabbricati e fiscalità immobiliare: l’importanza delle se
gnalazioni dell’inquilino.............................................................................. 251
8.5.Tassazione attraverso le aziende di redditi di capitale e plusvalenze finanziarie..................................................................................................... 252
8.6. Le principali ipotesi residuali (“redditi diversi”)........................................... 255
Capitolo 9
REALITÀ E PERSONALITÀ DEI TRIBUTI: DAL RISULTATO DELLE
ATTIVITÀ ALLE IMPOSTE DOVUTE ............................................................ 256
9.1. I flussi reddituali nell’IRES, nell’IRPEF e nell’IRAP................................... 256
9.2.Realità e personalità dei tributi: concetti generali........................................ 257
9.3. La personalità dell’IRPEF: riporto perdite, oneri deducibili, detrazioni
e “contrasto di interessi”.............................................................................. 258
9.4. Segue. Calcolo dell’imposta, progressività delle aliquote e personalità
del tributo.................................................................................................. 260
9.5. Limitata rilevanza della pluriennalità dei redditi ai fini della limita
zione della progressività .............................................................................. 261
9.6. L’IRAP come esempio di tassazione attraverso le aziende............................ 262
indice
IX
Capitolo 10
“TRIBUTI MINORI” TRA TASSAZIONE ATTRAVERSO GLI UFFICI E LE AZIENDE.............................................................................................. 265
10.1.Una geografia dei “tributi minori”............................................................. 265
10.2. I tributi sugli atti giuridici solenni o visibili................................................ 266
10.3. Istituzioni e organizzazioni nella tassazione dei documenti giuridici
(bollo e concessioni pubbliche).................................................................. 268
10.4. “Ricchezza patrimoniale”e difficoltà di una sua gestione “attraverso
le aziende” ................................................................................................ 269
10.5. Successioni e donazioni: una difficile determinazione di ricchezza pa
trimoniale, senza l’aiuto delle aziende......................................................... 271
10.6.Altri tributi speciali su consumi di determinati beni e servizi (inclu
so accise e dogane)..................................................................................... 273
10.7. La metamorfosi comunitaria dei tributi doganali......................................... 274
10.8.Tributi locali tra tassazione attraverso le aziende e attraverso gli uf
fici: aspetti tributari del “federalismo fiscale”............................................... 275
10.9. La tassazione patrimoniale locale sugli immobili (ICI e IMU)..................... 277
10.10. Aspetti concettuali di altri “tributi minori”................................................. 278
Premessa
I due volti della tassazione,
tra aziende e uffici tributari
Q
uesto volume cerca di non appiattirsi sulla “legislazione tributaria” e gli altri “materiali
normativi”, ponendosi nell’ottica classica del diritto come studio di istituzioni pubbliche.
Sotto questo profilo la particolarità del diritto tributario degli ultimi decenni è proprio la provenienza della maggior parte del gettito attraverso un coinvolgimento “solo potenziale” degli uffici
tributari. Si tratta della “tassazione attraverso le aziende”, cioè dell’’utilizzazione in chiave
tributaria della contabilità gestionale delle organizzazioni aziendali. Facendo leva sui documenti
e le registrazioni contabili, lo stato determina senza fatica la ricchezza che transita attraverso le
aziende. Si tratta soprattutto di ricchezza di consumatori, collaboratori dipendenti e autonomi,
ovvero risparmiatori, di gran lunga prevalenti rispetto alla ricchezza dei titolari dell’azienda, cioè
i profitti. Attraverso questo caso tipico di esternalizzzione di pubbliche funzioni (come la determinazione della ricchezza ai fini tributari) viene però individuata solo una parte della ricchezza.
Il tradizionale intervento valutativo degli uffici tributari resterebbe infatti necessario per la sostanziosa quota di ricchezza che non transita dalle aziende, ma resta di “lavoro indipendente verso
consumatori finali”, oppure che viene acquisita direttamente dal titolare dell’azienda, che scavalca
a danno del fisco le procedure da lui stesso dettate per controllare i dipendenti.
Si crea in questo modo non solo una falla economica nel gettito, ma anche una falla politica
perché la pubblica opinione avverte una sperequazione fiscale, non voluta e incontrollata, collegata
alla diversa visibilità delle forme di ricchezza. E’ un fenomeno che la pubblica opinione, senza
punti di riferimento tra gli studiosi, neppure riesce a mettere a fuoco, divagando su spiegazioni
confuse, come gli effetti economici dei tributi, la disonestà e l’onestà, l’eccessività delle aliquote,
l’inefficienza della spesa pubblica, fino al fantomatico “partito degli evasori”. Nessuno capisce che,
molto serenamente, la causa principale è la diversa esposizione della ricchezza al più efficiente
esattore del fisco, cioè le organizzazioni aziendali. Ne nascono sperequazioni, recriminazioni e
polemiche, alla base di inconcludenti e pluridecennali interventi legislativi, che riflettono la confusione delle classi dirigenti e delle istituzioni. La diversa determinabilità della ricchezza dovrebbe
essere fronteggiata dagli uffici tributari, il cui compito è però ostacolato sia dalle drammatizzazioni
suddette sia dal mancato coordinamento teorico tra i già indicati criteri ragionieristici e la secolare
tradizione estimativa. Persino la definizione del sistema come ”autotassazione” è riduttiva rispetto
alla sostanza del fenomeno, perché non valorizza l’importanza di un intervento valutativo degli
uffici, adeguatamente sistematico, sulla ricchezza non intercettata dalle aziende. Questo spiega
la necessità di un volume “di diritto” , che eviti da un lato la parafrasi normativa e dall’altro la
dispersione nella casistica professionale, inquadrando per gli operatori del diritto i veri problemi
della determinazione dei tributi.
Il primo capitolo del volume innesta la suddetta utilizzazione delle aziende sugli aspetti strutturali, storici, stabili, della tassazione come esercizio di potere “politico-amministrativo” ; rispetto
XII
Compendio di Diritto Tributario
a quest’ultimo è importante la prospettiva del legislatore, cioè della politica, su cui si sofferma il
capitolo secondo: in quella sede emerge che la preoccupazione della politica non è sistematizzare i concetti della determinazione tributaristica della ricchezza, ma perseguire al meglio gettito,
consenso, coesione sociale, principi costituzionali e obblighi europei. Seguono (capitolo terzo) i
comportamenti delle istituzioni private (aziende) e degli individui, sulle decisioni di quanta parte
della ricchezza registrare fiscalmente e come inquadrarla giuridicamente. Inizia al capitolo quarto
l’esame di come le istituzioni, gli studiosi, le classi dirigenti, le associazioni di categoria, gli organi
di informazione, e più in generale la pubblica opinione reagisce ai problemi indicati sopra. Questa
reazione, confusa e disorientata, è il punto di riferimento delle istituzioni di settore, analizzate al
successivo capitolo quintoLa valutazione, da parte del fisco, della ricchezza non registrata, è ostacolata dal diffuso preconcetto che essa debba svolgersi con la precisione ragionieristica tipica delle
aziende. Vi contribuisce una degenerazione del principio di legalità, che spinge i pubblici uffici a
non assumersi iniziative né responsabilità di stima della ricchezza, mentre la determinazione della
ricchezza non dichiarata è strutturalmente valutativa. Sono deficit culturali che rendono poco sistematico, e dispersivo, l’intervento degli uffici. Che preferiscono le contestazioni interpretative su come
i contribuenti hanno inquadrato la ricchezza registrata. Da questi fattori emerge un contenzioso
enorme, che dovrebbe essere gestito più in via amministrativa che giurisdizionale, conformemente
alla matrice della materia.
Nella parte seconda si esamina il sistema delle imposte, sotto il profilo del regime della ricchezza fiscalmente registrata, trattando in parallelo la tassazione dei redditi e dei consumi (IVA)
attraverso le aziende.
Il libro non si dirige ai casi particolari dei professionisti, e proprio per questo può servire anche
a loro, nonché a tutti gli operatori del diritto, come premessa per comprendere i nodi reali della
tassazione in generale, ed in Italia in particolare. Dove le spiegazioni legalistico-processuali hanno
portato il settore nel caos più totale, rendendo necessario per la pubblica opinione e le classi dirigenti
un nuovo punto di riferimento “amministrativistico-economico”; in cui cioè il diritto amministrativo si intreccia con l’oggetto economico della determinazione della ricchezza. La riscoperta e la
valorizzazione della matrice amministrativistica del diritto tributario è infatti uno degli obiettivi
cui questo testo vuole contribuire, assieme ai siti internet www.giustiziafiscale.com e www.fondazionestuditributari.com.
parte prima
DETERMINAZIONE TRIBUTARISTICA
DELLA RICCHEZZA TRA ISTITUZIONI,
AZIENDE E INDIVIDUI
Capitolo 1
PATRIMONIO, TARIFFE E TRIBUTI
NEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA:
IMPOSTE E DETERMINAZIONE DELLA RICCHEZZA
TRA UFFICI TRIBUTARI E AZIENDE
Sommario: 1.1. Fiscalità e tassazione dalle “entrate patrimoniali” ai tributi – 1.2. La finanza tributaria: il
riferimento delle “imposte” alla ricchezza e le sue esigenze logiche di determinazione – 1.3. Uffici
pubblici e gruppi intermedi nella valutazione preindustriale della ricchezza – 1.4. Segue: la determinazione ragionieristica della ricchezza attraverso le aziende – 1.5. Segue: differenza tra tassazione attraverso
le aziende e c.d.“autotassazione” – 1.6 Segue. Disorientamento tributario e bagaglio economico-sociale
di pubblica opinione e classi dirigenti – 1.7. Segue. Le divagazioni sul rapporto “stato –mercato” e sugli
effetti economici dei tributi: “pressione fiscale”, “redistribuzione” e determinazione della ricchezza –
1.8. Determinazione della ricchezza tra diritto ed economia: beneficio-sacrificio, redditi, consumi e
costi – 1.9. Determinazione della ricchezza tra esigenze logiche e gettito – 1.10.Tipologie economicogiuridiche di imposte e relativo gettito – 1.11. Segue. Tipologie di tributi e criteri di determinazione
della ricchezza
1.1. Fiscalità e tassazione dalle “entrate patrimoniali” ai tributi
I tributi riguardano, da millenni, l’attività dei pubblici poteri, cioè dell’espressione
politica di un gruppo sociale che, attraverso suoi funzionari o suoi incaricati chiede
una prestazione agli individui, direttamente o attraverso altri gruppi sociali “intermedi”.
L’intervento, attuale o potenziale, di autorità amministrative, o loro incaricati, è
quindi strutturale, caratterizzante, della materia.
Si può anche fare a meno dei tributi quando la spesa pubblica (difesa, sicurezza, infrastrutture, sanità, etc.) può essere finanziata con altri tipi di entrate, derivanti da un patrimonio pubblico, come l’affitto delle terre, lo sfruttamento delle
miniere, frequente nei moderni paesi petroliferi. Anche per questo la tassazione
è solo una parte della fiscalità, costituita dall’insieme delle entrate e delle spese
pubbliche. Alla fiscalità, più che alla tassazione (che potrebbe come detto anche
mancare) si addice l’aforisma di Beniamino Franklin, secondo cui nulla è certo,
meno la morte e le tasse.
4
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
Oltre che dal suddetto sfruttamento di un “patrimonio pubblico”, entrate
possono derivare dalla remunerazione di servizi specifici resi agli utenti di servizi
pubblici (tariffe, secondo il principio del beneficio, di cui già al par. 1.8 e quindi 5.1),
dall’esercizio di funzioni pubbliche (tasse in senso stretto par. 5.1), e infine dalle
vere e proprie “imposte”, collegate a manifestazioni di ricchezza (ed oggi prevalente
fonte di entrata).
Lo sfruttamento del patrimonio comune era, nell’area soggetta al controllo del gruppo, il primo nucleo della “finanza patrimoniale”; si pensi all’uso collettivo delle risorse
naturali come la cacciagione e i corsi d’acqua, poi la legna, ed infine i terreni agricoli, le
miniere, i pascoli, le infrastrutture stradali o portuali; questo patrimonio comune, gestito
attraverso la politica, era chiamato “erario” o “fisco”. Dal suo sfruttamento derivavano entrate, che consentivano di accumulare metalli preziosi, anch’essi appartenenti al
“tesoro”.
Questo patrimonio, tipico della c.d. “finanza patrimoniale”, e non ancora “tributaria”, poteva alimentarsi in molti altri modi, tutti in ultima analisi basati sulla forza del
gruppo; c’erano anche prede belliche, tributi imposti ai popoli vinti, riscatti di nemici
catturati, concessioni per attività economiche, come i commerci d’oltremare, confische a individui o sottogruppi caduti in disgrazia, sanzioni per piccole irregolarità,
contributi spontanei di personaggi illustri o facoltosi, destinati a conseguire titoli nobiliari, investiture religiose o visibilità politica.
Costituiva una fonte di finanziamento anche il monopolio della monetazione,
un tempo attraverso la diminuzione del contenuto di metallo prezioso, e oggi – semplicemente – stampando moneta per finanziare la spesa o emissioni di debito pubblico;
quest’ultimo può anche essere alimentato mediante prestiti c.d. forzosi.
La “forza”, connessa all’autorità politico-amministrativa, caratterizza la maggior parte di queste entrate, prima di tutto verso il nemico esterno, ma anche all’interno del gruppo. Già nella finanza patrimoniale emergono i profili autoritativi e amministrativistici tipici della tassazione. Se persino i patrimoni privati esistono in base
a un riconoscimento della collettività, quello “pubblico” appartiene “alla collettività”,
ed è utilizzato nelle forme tipiche del diritto amministrativo, come la “concessione”.
A maggior ragione il potere amministrativo caratterizza le confische, le espropriazioni,
le sanzioni e la monetazione, come pure quelle organizzazioni di servizi pubblici cui si
connettono le entrate “tariffarie” (par. 5.1).
1.2. La finanza tributaria: il riferimento delle “imposte” alla ricchezza e
le sue esigenze logiche di determinazione
La finanza patrimoniale, descritta al paragrafo precedente, era insufficiente a coprire
le spese pubbliche, si era costretti ad introdurre “imposte”, cioè tributi commisurati
a manifestazioni di ricchezza. Emerge quindi il carattere “socialmente residuale”. Per questo, se da un lato al pubblico potere piace avere margini di intervento
(quindi spendere) al tempo stesso le imposte sono politicamente sgradite alla base
CAPITOLO 1 – PATRIMONIO, TARIFFE E TRIBUTI
5
consensuale del potere politico, salva la percezione di necessità gravi, come guerre o
altre calamità.
Al diritto tributario interessano soprattutto i criteri giuridici per determinare le
imposte, commisurate per natura a manifestazioni di ricchezza. Quest’ultima deve prima di tutto essere determinata, il che è sempre tradizionalmente avvenuto, da parte
di pubblici uffici o di loro emissari, con metodi tradizionalmente valutativi. Ciò
può avvenire solo attraverso un’iniziativa concreta sufficientemente sistematica, anche
se non diretta a tutti, secondo un filo conduttore del testo, ripreso al par. 1.5.
La richiesta dell’imposta, infatti, non può fare leva sulla mancata erogazione di un
servizio pubblico agli inadempienti, e deve quindi prevedere una richiesta autoritativa,
da parte delle pubbliche autorità.
La coercizione amministrativa è meno importante nei piccoli gruppi sociali
dove le necessità collettive sono avvertite, ci si osserva reciprocamente, e ci si chiede
cosa fa ognuno per il gruppo. L’intervento di pubblici uffici diventa sempre più importante nella misura in cui il gruppo diventa più numeroso, e gradualmente si attenua la
percezione dell’utilità del tributo per il bene comune.
Possono esserci anche contributi personali all’organizzazione sociale, e questo
spiega le esenzioni fiscali esistenti, nelle società preindustriali, per i guerrieri e i dirigenti politico-religiosi, dediti all’organizzazione della collettività. Le stesse ragioni,
all’inverso, spiegavano i maggiori oneri tributari a carico di categorie sociali esonerate
dal servizio militare per ragioni, ad esempio, etniche o religiose.
Questi privilegi e aggravi tributari divennero gradualmente anacronistici col
passare del tempo; con l’illuminismo, la rivoluzione francese e l’età liberale si affermò
sempre più l’idea di una tassazione commisurata alla ricchezza nelle sue varie manifestazioni, su cui già il prossimo paragrafo 1.3.
Qui parleremo di “ricchezza” per indicare “entità economicamente valutabili”, intese in senso aggregato, non riferito a singoli individui, riferibile quindi anche ai
magri consumi dell’indigente che acquista un po’ di cibo al supermercato, al salario di
un operaio o al modesto reddito di un artigiano. La maggior parte della ricchezza di
un paese, da sempre, si distribuisce sulla massa della popolazione, in gran parte povera,
ma presso cui si colloca la maggior parte della ricchezza liquida del paese (vedremo ai
par. 7.13 e 7.20 che l’avviamento delle aziende non è invece liquido, rappresentando
l’attualizzazione di redditi futuri).
La determinazione della ricchezza è quindi il principale passaggio che giustifica
concettualmente il diritto tributario come disciplina giuridica; la decisione sulla parte
di ricchezza da prelevare a titolo di imposta è infatti più “politica” che “giuridica” e
dipende da un articolato insieme di variabili che non dipendono dai tributaristi.
La determinazione della ricchezza accompagna logicamente la richiesta delle imposte. Nel termine imposta è contenuta l’idea di un potere, di qualcuno che “imponga”
di pagare, con una richiesta autoritativa legittimata dalla presenza di ricchezza.
La determinazione della ricchezza comporta una serie di esigenze come la precisione, la snellezza, la semplicità, l’effettività, ed altre, da riferire alle informazioni
disponibili sulla ricchezza di riferimento.
6
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
La “precisione” spinge a valorizzare al meglio le informazioni disponibili, che
possono essere economico-materiali o giuridico-contabili, nei termini indicati
al prossimo paragrafo, per l’era preindustriale, nonché ai paragrafi 1.4.-1.8.-1.10 per i
giorni nostri. La precisione va però contemperata con la semplicità e la sistematicità,
necessarie a perseguire la perequazione tributaria, cioè una tassazione non troppo
squilibrata su contribuenti diversi e ricchezze similari.
Su questo sfondo si inseriscono ulteriori esigenze, più giuridiche (anche se non
legislative), come la certezza e stabilità dei rapporti, intesa come prevedibilità dei
comportamenti delle istituzioni, la possibilità dei privati di interloquire con gli uffici tributari, e – se necessario – di difendersi davanti a giudici, le cautele contro evasioni
e stratagemmi per ridurre il carico tributario.
Su questi “principi di settore”, derivanti dalla forza delle cose, si inseriscono poi gli
effetti economici delle imposte, sul piano politico del gettito, della sopportabilità
dei tributi, della promozione dell’attività economica (definita variamente in termini
di “sviluppo” e “crescita”), del sostegno ad attività o servizi socialmente meritevoli.
Quello degli effetti delle imposte è chiaramente un momento logico successivo a quello
della determinazione della ricchezza.
1.3. Uffici pubblici e gruppi intermedi nella valutazione preindustriale
della ricchezza
Incrociando le esigenze indicate al paragrafo precedente (precisione, semplicità, etc.)
si possono capire e spiegare tutte le fasi della tassazione nel tempo, iniziando dall’economia agricolo-artigianale (preindustriale). In quest’epoca la ricchezza era prodotta essenzialmente attraverso l’agricoltura, l’allevamento e l’artigianato. La tassazione delle
attività agricole comportava la stima diretta dei relativi frutti, ovvero un più sofisticato
censimento e misurazione del territorio e delle coltivazioni (lo ritroveremo al par.
8.2 per l’attuale catasto).
Era anche relativamente agevole la tassazione della movimentazione delle merci,
trasportate attraverso luoghi presidiabili, come porti, ponti, mercati (su questi antenati
dei tributi sui consumi vedi il par. 7.2, introduttivo all’imposta sul valore aggiunto).
In altri casi la ricchezza diventava visibile proprio per la solennità degli eventi
giuridici in cui si manifestava, come la cessione della proprietà fondiaria, la successione
ereditaria (par. 10.2 sull’imposta di registro), la liberazione di uno schiavo.
L’individuazione e determinazione della ricchezza era qualche volta troppo complessa per gli scarni apparati burocratici dell’epoca, e quindi ci si serviva di corpi
sociali intermedi (territoriali) oppure di “appaltatori delle imposte”, cui veniva
demandato l’esercizio di pubblici poteri, con rischi di abusi e favoritismi. I corpi sociali
intermedi della società “agricolo-artigianale”, erano territoriali (cittadine, feudi, aree
rurali), etnico religiosi o professionali (corporazioni artigianali), ed erano destinatari
di richieste complessive di imposte basate sulla stima della ricchezza complessiva facente
capo ai loro membri. Queste richieste venivano poi, all’interno del gruppo, ripartite
CAPITOLO 1 – PATRIMONIO, TARIFFE E TRIBUTI
7
sulle famiglie o sugli individui in base a una stima delle loro condizioni economiche
individuali, in un sistema denominato “a ripartizione”, tipico di antichi tributi, come
il focatico e il testatico. Qui la ricchezza non era determinata “in assoluto”, ma era
idealmente comparativa rispetto agli altri individui e alle altre famiglie del gruppo, per
ripartire proporzionalmente la somma richiesta, secondo un criterio simile a quello
dell’odierno condominio. Qui era possibile tener conto della complessiva posizione
personale e familiare dei singoli (oggi invece velleitaria, come vedremo al par. 2.2 sulla
capacità contributiva). Le incertezze e i favoritismi di queste ripartizioni, nonostante la
forte conoscenza reciproca interna al gruppo, provocarono penalizzazioni o favoritismi,
talvolta in parte fronteggiati elaborando “catasti” (da non confondere con quelli indicati
sopra per l’agricoltura), diretti a schedare le complessive situazioni economiche come
punto di riferimento per la determinazione valutativa e personalizzata.
1.4. Segue: la determinazione ragionieristica della ricchezza attraverso le
aziende
Col graduale passaggio dalla produzione agricolo-artigianale a quella di serie attraverso le “aziende tecnologiche” (capitolo 3) divenne possibile la determinazione
contabile della ricchezza; la documentazione aziendale, come descritta ai paragrafi
3.3-3.5, consentiva una “visibilità giuridica della ricchezza”, per certi versi analoga a
quella indicata al paragrafo precedente per gli “atti solenni”.
Le aziende come organizzazioni pluripersonali (par. 3.1) erano un nuovo “corpo sociale intermedio”, analogo a quelli indicati al termine del paragrafo precedente,
per la determinazione della ricchezza ai fini tributari.
Attraverso le aziende, la tassazione viene esternalizzata, rispetto ai pubblici uffici,
e la contabilità aziendale crea una nuova opportunità di determinazione della
ricchezza, che il fisco non si è fatto sfuggire, e su cui ha fatto, anzi, un affidamento eccessivo e disordinato instaurandola anche dove le aziende non esistevano o
non ne avevano bisogno (par. 3.13 sulla ragionierizzazione degli artigiani e dei piccoli
commercianti, e 4.5 sulla c.d. ragionierizzazione delle stime). Come tutti gli operatori
economici, le aziende filtrano la ricchezza acquisendo consumi e restituendo
redditi, lasciandone traccia nelle relative registrazioni contabili, cui solo le aziende,
come organismi pluripersonali, hanno interesse per ragioni gestionali.
Il fisco vi si inserisce per tassare consumatori da una parte e beneficiari del reddito
dall’altra. Attraverso la contabilità delle aziende, si colpisce quindi la ricchezza che viene
a contatto con esse: cioè i consumi che acquisiscono e i redditi che erogano, al netto dei
passaggi intermedi, per retribuzioni, interessi, canoni di locazione o dividendi.
L’intervento delle aziende nella tassazione di ricchezza altrui crea una sorta di “cuneo fiscale”; nella tassazione dei consumi si tratta di una differenza tra la somma sborsata dal consumatore e il ricavo aziendale; inversamente, per la tassazione “in uscita” il
“cuneo fiscale” consiste nella differenza tra costo dell’azienda e reddito del percettore
(è frequentemente menzionato in proposito il “cuneo fiscale” sul lavoro). Vedremo al
8
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
par. 3.8 gli espedienti fraudolenti per ridurre questi onerosi differenziali, rendendo più
competitiva l’azienda, in una sorta di concorrenza sleale tributaria.
La tassazione attraverso le aziende sfrutta le informazioni gestionali da esse
acquisite nell’ordinario, tipico, ciclo amministrativo: i clienti delle imposte sui consumi
sono quindi conosciuti solo per quanto riguarda la relativa solvibilità, quando le vendite avvengono a credito; le vendite con strumenti di pagamento affidabili sono invece
anonime, perché l’azienda si concentra sulla “bontà” del pagamento, ed è impensabile
imporle ulteriori obblighi di identificazione fiscale del cliente.
Nella tassazione “in uscita” il fornitore è invece per altri versi conosciuto, soprattutto
nel caso dei lavoratori indipendenti e dei risparmiatori, il che consente al fisco di accedere alle relative informazioni, come vedremo al capitolo terzo per le ritenute alla fonte.
Le aziende non hanno altra conoscenza formale, e quindi giuridicamente gestibile, di ulteriori informazioni rispetto a quelle necessarie per la gestione dei rapporti
economici con le controparti. Per questo, la tassazione attraverso le aziende, efficientissima finché asseconda l’operatività gestionale degli uffici contabili, si blocca non appena
la legislazione fiscale pretende informazioni ulteriori, rilevanti solo ai fini fiscali, e che
l’azienda non ha modo, né poteri, di controllare.
Dalle statistiche si comprende che il gettito tributario italiano proviene in massima parte da qualche migliaio di “aziende di grandi dimensioni”, con una presenza
insufficiente dell’amministrazione tributaria sulla ricchezza non determinabile attraverso le aziende, soprattutto lavoro indipendente, materiale (d’impresa) e intellettuale
(professioni liberali par. 8.1).
Proprio la precisione contabile della determinazione della ricchezza attraverso le
aziende crea paradossalmente gli squilibri, che ci accompagneranno in tutto il testo
(qui par. 1.6, infra cap.4) rispetto alla tradizionale tassazione valutativa, ancora fondamentale per la ricchezza non intercettata dalle aziende. Coordinare queste diverse
modalità di determinazione della ricchezza è la principale giustificazione del diritto
tributario in quanto scienza sociale, come vedremo al par. 4.3. L’obiettivo è evitare le
sperequazioni politicamente non giustificate, connesse solo alla diversa determinabilità
della ricchezza, e che ci accompagneranno nel corso del testo.
1.5. Segue: differenza tra tassazione attraverso le aziende e c.d. “autotassazione”
La determinazione “ragionieristica” della ricchezza, attraverso le rigidità contabili
delle organizzazioni aziendali è molto efficiente, se sussistono le condizioni, dando
quasi l’impressione di un sistema in grado di funzionare da solo. Dove però le aziende
non arrivano, occorre mantenere la tradizionale determinazione valutativa della ricchezza, descritta al paragrafo 1.3 per i tributi del passato.
Per coordinare queste due modalità di determinazione della ricchezza fu elaborato
il fuorviante concetto di “autotassazione”, estendendo forzatamente agli individui
la richiesta di tributi per legge, concepibile per le aziende; era un’espressione fuorviante
CAPITOLO 1 – PATRIMONIO, TARIFFE E TRIBUTI
9
perché confondeva la tassazione attraverso organismi pluripersonali privi di bisogni personali (aziende) e individui, provvisti invece di tali bisogni, e quindi tendenti
ad evadere. Per questi ultimi la richiesta delle imposte per legge funziona efficacemente solo se accompagnata da una richiesta concreta sufficientemente sistematica, tale
da indurre a pagare, di propria iniziativa, molti soggetti cui in concreto gli uffici non
si rivolgeranno mai. Serve però un intervento degli uffici abbastanza esteso per farne
percepire la presenza anche ai contribuenti non controllati, inducendoli a una credibile
autodeterminazione del tributo.
L’“autotassazione” è diversa dalla tassazione attraverso le aziende, e rappresenta un
adeguamento della secolare tradizione valutativa della tassazione (par. 1.3); l’autotassazione non si dirige alle aziende, ma agli individui, con una sfera personale cui il pagamento dei tributi sottrae risorse; in questo caso la tassazione non
è mai “auto”, ma è sempre “etero”, cioè provocata da un impulso esterno, ancorché
potenziale. Senza un adeguato intervento degli uffici, l’autotassazione è quindi una contraddizione in termini, contraddicendo la già indicata necessità che “le imposte siano
imposte”, anche solo potenzialmente, ma con sistematicità.
In una certa misura l’autotassazione è sempre esistita, in quanto una “cooperazione
coatta” dei contribuenti col potere tributario è ineliminabile. Nella società moderna la
richiesta della collaborazione del contribuente è resa più agevole dalla rapidità di circolazione delle informazioni, delle comunicazioni e di una serie articolata di servizi di
trasmissione e consulenza. Un intervento amministrativo adeguatamente diffuso resta
però fondamentale, nonostante gli effetti di annuncio mediatici (par. 4.2) e la prospettiva di sanzioni (par. 6.13). Per questo gli interventi degli uffici tributari devono
essere sistematici, nel senso di riguardare un numero di contribuenti sufficiente a spingere la massa ad un adempimento credibile.
All’autotassazione si addice quindi la teoria degli economisti, secondo cui la ricchezza dichiarata dipende da una combinazione di “aliquote sanzioni e controlli”. Le aliquote, a parità di sanzioni, esprimono il vantaggio immediato dell’evasione
tributaria, le sanzioni – unite alle aliquote – esprimono l’ipotetico pregiudizio futuro
dell’evasore, la cui probabilità dipende però dall’intensità dell’intervento amministrativo.
1.6 Segue. Disorientamento tributario e bagaglio economico-sociale di
pubblica opinione e classi dirigenti
Dovrebbe essere a questo punto già abbastanza chiaro che lo squilibrio della tassazione italiana sulla determinazione della ricchezza attraverso le aziende non deriva
da un consapevole e programmato disegno. È stata, piuttosto, istintivamente
colta dalle istituzioni l’opportunità di determinazione della ricchezza attraverso la
contabilità aziendale, di cui empiricamente sono stati cercati surrogati dove le aziende
non arrivavano; del resto, come vedremo al par. 4.3, non è compito delle istituzioni,
politiche o amministrative, teorizzare fenomeni complessi, come le varie forme di determinazione della ricchezza.
10
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
Il disorientamento della pubblica opinione e della classe dirigente in materia
tributaria riguarda non solo e non tanto “la maggioranza numerica delle persone o
dell’elettorato” quanto piuttosto la “classe dirigente”, che opera nella politica, nelle
istituzioni, nella rappresentanza dei ceti produttivi, nell’alta burocrazia, nei mezzi di
informazione, nella cultura, influenzando le tendenze della collettività. Sulla tassazione si riflette l’inadeguatezza del bagaglio socioeconomico complessivo della
pubblica opinione, sulle cui ragioni storico-formative si veda il mio compendio di
scienza delle finanze sempre della Dike.
In materia tributaria, sul concetto stesso di azienda, si ritrovano gli ostacoli derivanti dalle vicissitudini storiche italiane degli ultimi secoli, e gli ostacoli a una serena
sedimentazione spontanea di un bagaglio culturale sull’organizzazione sociale in genere e pubblica in particolare; verso le istituzioni la storia italiana ha infatti
generato un diffidente, superficiale e opportunistico alternarsi di aspettative
miracolistiche e critiche distruttive (par. 2.4).Vi si aggiungano le tensioni sociopolitiche create dall’industrializzazione, che hanno reso imbarazzante affrontare
questi temi nelle scuole e nelle università, dando luogo a una forte arretratezza
socioculturale, non contrastata dall’insieme delle c.d. “scienze sociali”.
La conseguente confusione di idee sulla ricchezza, spesso vista come qualcosa da spartire e non “da produrre”, si riflette sulla sua determinazione ai
fini tributari. Classe dirigente e pubblica opinione sono attente agli squilibri sociali
connessi a una sperequata allocazione dei carichi tributari, ma non ne capiscono le
ragioni, fantasticando di disegni politici complessi e occulti, senza capire
l’importanza della determinazione della ricchezza ai fini tributari, come vedremo al capitolo quarto.
1.7. Segue. Le divagazioni sul rapporto “stato –mercato” e sugli effetti
economici dei tributi: “pressione fiscale”, “redistribuzione” e determinazione della ricchezza
Una reazione ai disorientamenti accennati al paragrafo precedente consiste
nelle divagazioni sull’utilità dei tributi, avventurandosi sul rapporto tra “mercato e stato, lo sviluppo, la solidarietà, etc... Si tratta però di un problema generale, diverso dalla determinazione dei tributi. È certo che l’intervento pubblico
non poteva che crescere nell’“era aziendale”, come ho rilevato nel compendio
di scienza delle finanze. Il problema è piuttosto l’efficienza della sua gestione, relativa ormai alla più grande azienda nazionale, coi suoi oltre tre milioni di
addetti, che solo di stipendi assorbono la maggior parte della spesa. Se si aggiungono gli interessi passivi sul debito si capisce la rigidità della spesa pubblica,
in gran parte politicamente e giuridicamente obbligatoria. Le esigenze di
cassa per coprirla diventano quindi una specie di “variabile indipendente” rispetto
alle decisioni politiche del breve periodo (vedi infra par. 1.9), di cui è inutile che
discutano i tributaristi.
CAPITOLO 1 – PATRIMONIO, TARIFFE E TRIBUTI
11
Brusche riduzioni delle spese pubbliche, diminuendo così le imposte, non
sono quindi praticabili, e questo elimina sul nascere tanta propaganda estemporanea.
La sfida di una società complessa non è quella di vivere senza macchina pubblica, ma di
vivere con una macchina pubblica efficiente, anche sul piano della determinazione
tributaristica della ricchezza; vedremo che i già individuati squilibri non dipendono da
distorsioni private, ma da disfunzioni pubbliche, a loro volta dovute alla mancanza di
adeguate spiegazioni sul tema (par. 5.3).
Un altro diversivo ricorrente riguarda la pressione fiscale, concetto tecnico che
può essere chiarito subito. Si tratta infatti solo di un rapporto numerico tra gettito
tributario e PIL, che esprime la percentuale di ricchezza nazionale assorbita dai tributi, per decenni attorno al 43 percento e oggi leggermente aumentata; indirettamente
la pressione fiscale esprime l’intensità del suddetto intervento pubblico in
economia, senza però fornire alcuna indicazione sulla qualità e quantità dei servizi
pubblici forniti a fronte dei tributi. La pressione fiscale si riferisce quindi al PIL (reddito
nazionale) e non al’impatto dei tributi per tipologie di individui, ad esempio “la famiglia media”, con un certo reddito, un certo assetto patrimoniale, etc.
La pressione fiscale non ha poi nulla a che vedere con l’equilibrio nella distribuzione
del carico tributario tra le varie categorie di contribuenti e le varie tipologie di ricchezza; la pressione fiscale può essere bassa e squilibrata o alta, ma equilibrata.
Un diversivo ancora più estraneo alla determinazione della ricchezza riguarda la sua “redistribuzione”, cui qualche volta i tributi vengono ideologicamente
finalizzati. Far “pagare i ricchi” è un diversivo demagogico, perché avranno anche
tanto, ma sono pochi, perché in genere possiedono prevalentemente il valore di
avviamento delle loro aziende (che non è “liquido” come vedremo al par. 7.13),
mentre immobili e investimenti finanziari sono relativamente minori. Non è che “i
ricchi” siano intoccabili, ma occorre sostituirli nell’organizzazione sociale, altrimenti
la “redistribuzione” rischia di portare all’“uguaglianza nella povertà”, dove non si
toglie al ricco per dare al povero, bensì per il parassitismo “politico-burocratico”. La
redistribuzione è importante in società statiche, man mano che i ricchi sono tali
per rendite di posizione dei loro antenati, dove il consumo pubblico può
essere più efficiente di quello privato. Tutto dipende però dalla qualità della
burocrazia, aspetto solo limitatamente collegato alla determinazione della ricchezza
ai fini tributari.
1.8. Determinazione della ricchezza tra diritto ed economia: beneficiosacrificio, redditi, consumi e costi
La determinazione della ricchezza, ai fini della finanza pubblica, è rilevante anche
quando le spese sono fronteggiate col c.d. criterio “del beneficio”, cioè facendole
pagare a chi trae vantaggio dai relativi servizi; la determinazione della ricchezza in questi casi rileva indirettamente, come giustificazione di riduzioni ed esoneri, come
vedremo al par. 5.1, in materia di tariffe e “tasse in senso stretto”.
12
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
Le “imposte” sono invece riferibili a tre concetti economici di fondo, espressivi
di ricchezza cioè consumi, patrimonio e reddito. Quest’ultimo è però fondamentale, in quanto le imposte, anche se applicate alla ricchezza che si manifesta in occasione
di un consumo o di una eredità, sono sempre pagate “coi redditi”, in quanto frutto dell’attività economica. Se non ci sono attività produttive, da cui derivino redditi,
il consumo è finanziato da debiti o da trasferimenti gratuiti di altri, ed anche i valori
patrimoniali diminuiscono. È un punto su cui gli economisti concordano, riferendosi a
risparmi di redditi passati, prospettive di redditi futuri, trasferimenti di altri individui, e
credito che qualcuno è disposto a riconoscerci a fronte di redditi futuri.
Il collegamento col reddito conferma che la ricchezza non è qualcosa di
statico, una specie di tesoro nascosto da spartire al meglio (cfr. il concetto di redistribuzione di cui al precedente paragrafo 1.6), ma va riprodotta nel tempo, con contributi
variamente remunerati, che continuamente si intrecciano, si producono e si rinnovano;
non può essere insomma “redistribuita” una ricchezza che non si produce attraverso
prestazioni, e creazioni di reddito. Quest’ultimo è una astrazione che misura capacità di soddisfare bisogni, sia in proprio (autoconsumo) sia attraverso rapporti con altri
soggetti, cioè diritti di proprietà e di credito. Il reddito non è suscettibile di acquisizione fisica, che riguarda invece denaro o crediti, cui si riferiscono anche eventuali
ammanchi o furti. L’“astrazione reddito” deriva a sua volta dalla somma algebrica
tra due astrazioni, cioè le entrate e le spese necessarie alla relativa attività economica; in gergo contabile le suddette astrazioni, da cui deriva differenzialmente il reddito,
sono, come vedremo al paragrafo 7.6, i ricavi e i costi.
Proprio quest’elevata astrazione del concetto di reddito ne limitò per molti secoli
l’uso tributario alle attività agricole, cui del resto si dedicava la maggior parte degli
individui, mentre i redditi non agricoli (artigianali, commerciali, professionali) furono
tassati come tali soltanto in epoca moderna (vedremo subito a partire dall’inizio dell’ottocento); essi furono definiti appunto “redditi mobiliari” per contrapporli alla rendita
fondiaria, proveniente da beni “immobili”. La tassazione generalizzata dei redditi “mobiliari” subentrò abbastanza tardi, nella Gran Bretagna delle guerre napoleoniche, avendo persino bisogno di una modifica costituzionale negli Stati uniti del primo novecento.
I redditi “mobiliari” erano in precedenza tassati “indirettamente”, attraverso i consumi,
i patrimoni o il tenore di vita dei titolari.
La misurazione dei redditi è normalmente monetaria (i rari redditi in natura sono convertiti secondo il parametro monetario) e quindi al lordo dell’eventuale
inflazione, oggetto solo di correttivi specifici e occasionali. Solo quando essa diventa
macroscopica, come avvenuto in alcuni stati sudamericani, si introducono correttivi
generali, assai complessi.
Le manifestazioni di ricchezza suddette (redditi, consumi, costi e patrimoni) sono tra
loro collegate, sia nel loro già indicato riferimento ultimo al reddito, sia nel rapporto tra
“reddito” e “consumo”. Nelle prestazioni al consumo, il consumo del cliente concorre a formare il reddito del fornitore. Quando il fornitore effettua la prestazione
a un altro operatore economico si hanno le c.d. operazioni “business to business”, dove
l’acquirente non esprime un consumo, bensì “un costo”.
CAPITOLO 1 – PATRIMONIO, TARIFFE E TRIBUTI
13
Oggi, la tassazione attraverso le aziende collega quindi la produzione e il consumo,
col corrispettivo di vendita che esprime sia il reddito del fornitore sia il consumo per
il cliente. I passaggi intermedi tra operatori economici idealmente si compensano e restano redditi e importazioni da un lato, e consumi, investimenti e importazioni dall’altro (operazioni business to business abbreviate in b2b). Le operazioni al
consumo riguardano, ripetiamo, le prestazioni usate dall’acquirente per la propria
sfera personale, familiare o istituzionale, indicate come “business to consumer”
(abbreviazione b2c).
1.9. Determinazione della ricchezza tra esigenze logiche e gettito
La determinazione della ricchezza non coinvolge, in prima battuta, valori morali e politici, ma questioni empirico-valutative, cioè “di fatto” (nel senso indicato
al par. 5.8), nonché concettuali a proposito di concetti economicamente rilevanti, come
consumi, redditi, ricavi, costi, etc.
Queste questioni logico-conoscitive comportano anch’esse una serie di scelte,
soprattutto riguardanti i tempi ed i costi connessi a diverse modalità di determinazione della ricchezza. Abbiamo già indicato al par. 1.2 i relativi valori di settore,
cioè precisione, semplicità, etc... La mancata percezione, da parte della pubblica
opinione (par. 1.6) del problema di determinare la ricchezza si riflette purtroppo
sulle istituzioni, ostacolando il coordinamento delle relative esigenze nell’attività
legislativa e in quella amministrativa. Molti obiettivi di perequazione tributaria non
vengono quindi raggiunti perché neppure percepiti, persino dagli studiosi, come
indicato al par. 4.3.
Una volta determinata la ricchezza, con questi condizionamenti logici, la quota da
prelevarne è una questione politica, estranea alle competenze specifiche dei tributaristi, come detto al par. 1.7..
Il disorientamento sulla determinazione tributaristica della ricchezza confonde i
due suddetti profili. Spesso sono confusioni intenzionali, per non chiamare direttamente col loro nome agevolazioni e penalizzazioni, preferendo trincerarsi dietro motivazioni tecniche (razionalizzazioni nella determinazione della ricchezza), politicamente
meno imbarazzanti. A rigore però si tratta di due livelli decisionali diversi, ancorché interdipendenti. In prima battuta, penalizzazioni o agevolazioni dovrebbero esprimersi attraverso le aliquote, con trasparenza, senza alterare la corretta determinazione della ricchezza. Le disposizioni di diritto sostanziale tributario (su questo concetto
par. 3.9) devono prima di tutto avere un senso sul piano della determinazione della
ricchezza, dopodiché subentrano, in seconda battuta, le scelte sul gettito e le disposizioni agevolative, punitive, dirette ad ottenere determinati effetti economicosociali attraverso le imposte.
La determinazione della ricchezza non è un’approvazione o un biasimo di
fatti noti, ma dipende dalla acquisizione e gestione di informazioni, rendendo del tutto naturale che alcune ricchezze siano determinate in modo più preciso
(soprattutto attraverso le aziende) ed altre secondo stime ipotetiche. Non è una
14
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
violazione del principio di eguaglianza, come spesso si farnetica equivocando sulla
capacità contributiva (par. 2.2), ma un riflesso di diversità conoscitive, gestibili, ma
non eliminabili.
1.10.Tipologie economico-giuridiche di imposte e relativo gettito
La principale preoccupazione delle classi dirigenti è il gettito, e la sua composizione, non la determinazione della ricchezza, che sfugge persino agli studiosi. Quindi
i tributi sono classificati riferendoli alle già identificate astrazioni economiche
di reddito consumo e patrimonio, trascurando le modalità di determinazione
delle ricchezza, profilo che del resto la pubblica opinione e gli studiosi del settore
neppure riescono a cogliere. Le stesse informazioni, fisiche (un negozio al dettaglio o
un laboratorio) o giuridico-contabili possono invece portare al tempo stesso alla determinazione di redditi e consumi, guardandole semplicemente dal punto di vista dei
venditori (redditi), degli acquirenti (consumi) o dei proprietari (patrimonio).
Per quanto riguarda il riferimento alle astrazioni economiche tutti i sistemi
fiscali si basano su una combinazione di imposte sul reddito, sui consumi e sul
patrimonio.
Il gettito complessivo, rispetto al PIL, non ha grandi variazioni nel tempo, ed è
sufficiente, ai fini di questo volume, un ordine di grandezza comparativo, anziché un
millimetrico computo ragionieristico. Nel complesso le entrate tributarie statali del
2010 ammontavano a circa 410 miliardi di Euro più 70 miliardi circa di tributi
regionali e comunali, inclusa l’IRAP. Le principali, incrociando gettito e riferimento economico, sono le imposte sui redditi delle persone fisiche (165 milioni), uniti
a 37 miliardi di imposte sul reddito delle persone giuridiche (sul relativo coordinamento par. 7.17), e circa 7 miliardi di imposte sostitutive sulle rendite finanziarie. Per
quanto riguarda la tassazione del consumo, l’IVA totalizza circa 100 miliardi, mentre le
altre imposte su specifici consumi (c.d. “accise”, par. 10.6) fruttano circa 30 miliardi. Gli
esempi più significativi di tassazione del patrimonio e degli atti giuridici riguardano
le imposte comunali sugli immobili (circa 20 miliardi) e le imposte di bollo e registro
(circa 15 miliardi). Sul piano delle relative informazioni, la maggior parte del gettito suddetto deriva dalla ricchezza visibile in modo contabile attraverso le
aziende. Quando esamineremo altre “imposte minori”, al capitolo 10, daremo altre
indicazioni sul relativo gettito.
1.11.Segue. Tipologie di tributi e criteri di determinazione della ricchezza
Sul piano giuridico, della determinazione della ricchezza, ripetiamo che i dati
indicati al paragrafo precedente mostrano che le principali imposte sui redditi
e sui consumi derivano da un’unica determinazione contabile della ricchezza
attraverso le aziende. Il grosso del gettito arriva dalla ricchezza determinata con criteri “amministrativo-contabili”, mentre quelli “estimativo – valutativi”, fondati sul-
CAPITOLO 1 – PATRIMONIO, TARIFFE E TRIBUTI
15
la visibilità “materiale” della ricchezza (terreni, laboratori, stabilimenti, palazzi, etc.),
sono secondari. Lo stesso per la provenienza da catasti pubblici, oppure atti giuridici
solenni.
Tuttavia – come vedremo ai par. 3.13 e 4.2 – il contributo dei lavoratori indipendenti è proporzionalmente superiore alla sistematicità della richiesta concreta delle
imposte nei loro confronti, smentendo anche sotto questo profilo i laceranti luoghi
comuni sulla disonestà fiscale degli italiani (par. 4.5).
La tipologia economica dei principali tributi vigenti nei paesi sviluppati non è
molto dissimile, confermando che il successo o il fallimento di un sistema tributario
dipende dalla capacità di valorizzare, sul piano gestionale e amministrativo,
le informazioni esistenti sulla determinazione della ricchezza ai fini tributari. Gli stati
con minori necessità finanziarie, comunque, confermano l’evoluzione descritta, dal
punto di vista storico, al paragrafo 1.3, secondo cui la rilevanza generale dei redditi da
attività “non agricola” (c.d. “mobiliare” par. 1.8) subentra abbastanza tardi. I processi di
tassazione si innescano infatti sui consumi, e su determinate tipologie di “affari”, come
le imposte di registro o di bollo. Man mano che aumentano le necessità finanziarie, gli
stati si organizzano con un sistema di determinazione della ricchezza, in
ultima analisi dipendente da come le classi dirigenti e la pubblica opinione (par. 1.6)
percepiscono questo problema (par. 5.3).
L’utilizzazione di varie tipologie di tributi deriva anche da ragioni di perequazione fiscale, essendo difficile evitare tutte le forme di prelievo. Anche chi riesce a
nascondere al fisco i propri redditi subisce infatti tributi sui consumi, acquista merci
al supermercato, paga utenze, consuma benzina, utilizza conti correnti bancari, magari
fuma o gioca alla lotteria, compra casa, pagando le relative imposte sui consumi o sugli
atti giuridici. La pluralità di tributi limita quindi le evasioni fiscali, anche se aumenta
il carico tributario su chi non riesce a sfuggire ad alcun tributo. Ne derivano
esasperazioni e recriminazioni analizzate al capitolo quarto.
Capitolo 2
RUOLO E LIMITI DELLA LEGISLAZIONE
NELLA DETERMINAZIONE TRIBUTARISTICA
DELLA RICCHEZZA
Sommario: 2.1. La funzione organizzativa e garantistica della legislazione tributaria (riserva di legge e
statuto del contribuente) – 2.2. Il richiamo alla determinazione della ricchezza nell’art. 53 della Costituzione e l’equivoco della “capacità contributiva globale individuale” – 2.3. Tassazione attraverso le
aziende come illusione di poter amministrare per legge: il diritto tributario sostanziale – 2.4. Segue: la
sopravvalutazione della legislazione nell’autotassazione – 2.5. Determinazione della ricchezza e controllo della Corte costituzionale – 2.6. Libertà comunitarie, vincoli al legislatore tributario e determinazione della ricchezza
2.1. La funzione organizzativa e garantistica della legislazione tributaria
(riserva di legge e statuto del contribuente)
Calcolare e riscuotere i tributi è una delle tante funzioni pubbliche, come difendere il territorio, amministrare la giustizia, l’ambiente, le infrastrutture, l’istruzione, la
sanità, etc. Tutte queste funzioni sono svolte da istituzioni (par. 5.3); in una prima fase
esse si fanno direttamente interpreti dei valori del gruppo, facendo riferimento ai valori
e con criteri in senso ampio “politici”. Man mano che la politica esprime istituzioni organizzate, si sviluppa l’area del diritto, gestibile oltre che in base ai “valori”, anche con
“regole formali”, importanti per evitare abusi e favoritismi, soprattutto nella funzione pubblica di amministrazione della giustizia; alla valutazione personale del
giudice sugli interessi in conflitto si cercano di imporre criteri prestabiliti, il che ha portato
a una sopravvalutazione delle “regole formali”, rispetto ai valori e rispetto al diritto come
studio di “istituzioni” (par. 4.3). Si è così creato, con riferimento a queste valutazioni del
giudice, l’equivoco mito dell’onnipotenza legislativa, fuori luogo sia nella “funzione
di giustizia”, ma soprattutto negli altri “pubblici poteri”, come difesa, sicurezza, infrastrutture, sanità, ambiente, etc,. Qui è auto evidente che la legge “non governa”, ma è
uno strumento del “governo degli uomini”, per stabilire i compiti di ciascuno.
Nel nostro caso non è certo la legge a determinare la ricchezza ai fini tributari, ma è utile per organizzare, nei limiti delle rispettive possibilità, gli uomini e i
mezzi necessari allo scopo.
CAPITOLO 2 – RUOLO E LIMITI DELLA LEGISLAZIONE
17
Al di là di queste funzioni organizzative, la legislazione indica anche alcuni compiti dei vari uffici, nonché nel nostro caso le principali caratteristiche della ricchezza
da tassare, le modalità per reagire contro negligenze e abusi. L’insieme di questi aspetti
è stato definito “potestà normativa tributaria”, come potere politico di imporre
tributi attraverso organismi titolari della distinta potestà amministrativa di imposizione.
Questa distinzione dell’apparato amministrativo tributario dal potere politico è
una necessità organizzativa che prescinde dalla forma di stato e di governo,
democratico, autoritario o addirittura totalitario. Anche quest’ultimo lascia agli uffici
tributari il compito di determinare i tributi, perché in concreto non se ne può fare a
meno, come pure non si può fare a meno dei giudici per la soluzione delle controversie.
Queste esigenze organizzativo-politiche emergono nell’art. 23 della costituzione, non riferito alla sola materia tributaria, ma a tutte le prestazioni personali o
patrimoniali, che riprenderemo al paragrafo 5.1 sulla comune matrice amministrativa
di tutte le entrate pubbliche. Sul piano organizzativo viene così demandata all’autorità
politica di vertice, espressione del gruppo nel suo insieme, anche nei regimi dittatoriali,
la scelta di chi tassare; se questa scelta fosse infatti attribuita agli uffici tributari, questi
potrebbero alleggerire o appesantire la tassazione, intromettendosi senza controllo nei
più vari settori della vita sociale.
In un regime “democratico parlamentare” l’art. 23 garantisce, “a monte” dell’introduzione di una prestazione imposta, un atto del potere politico, cioè un “avallo parlamentare”. In questo modo si assicura più direttamente la rappresentanza
dei cittadini nel loro complesso. Se infatti legiferasse il governo a maggioranza, potrebbero essere imposte leggi fiscali con il 51 percento del 51 percento dei consensi
popolari. Inoltre, su problemi particolarmente delicati, la stessa maggioranza potrebbe
dividersi, ed alcuni parlamentari dei partiti di governo potrebbero votare assieme alle
opposizioni.
Questo avallo parlamentare può avvenire sia con le leggi in senso formale, sia
con decreti legge, decreti legislativi, emanati dal governo in base a previa
legge delega, con principi e criteri direttivi (art. 76 Cost.). Rispettano la riserva di
legge anche i tributi introdotti con leggi regionali, costituzionalmente previste, ma
poco frequenti, in quanto la maggior parte dei tributi locali, a favore dei comuni, sono
previsti con leggi statali (cfr. il par. 10.8, sui tributi locali).
A parte gli aspetti di ampia rilevanza politico-mediatica, come la decisione di tassare
o meno certe manifestazioni di ricchezza, la tipologia di tributo, le aliquote, le esenzioni, come pure alcuni dettagli di forte visibilità, l’organo politico di vertice (nel nostro
caso il parlamento) ha scarsa capacità e poco interesse alla determinazione della
ricchezza ai fini tributari. La possibilità di un completamento “non legislativo” della
disciplina dei tributi trova riscontro nella natura “relativa” della “riserva di legge”
in esame, differente da quelle “assolute”, ad esempio in materia penale, dove l’intera
disciplina deve trovarsi nella legge.
Con la riserva di legge in esame sono quindi compatibili atti normativi secon-
18
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
dari (in senso ampio «atti regolamentari»), per disciplinare i numerosi dettagli della
determinazione della ricchezza, soprattutto quando avviene “attraverso le aziende”.
Si ripropone anche qui la differenza tra atti normativi regolamentari, approvati in
Italia previo parere del consiglio di stato, e atti amministrativi generali, come ad esempio
quelli di approvazione dei modelli per gli adempimenti amministrativi tributari (dichiarazioni, versamenti ed altri indicati al par. 3.4).
Perché sia rispettata la riserva di legge, gli atti legislativi devono tuttavia indicare alcuni elementi minimi, come la tipologia di ricchezza colpita dal tributo,
i suoi debitori, i criteri-guida per la determinazione dell’imponibile, i criteri per
determinare l’imposta, cioè l’aliquota o una fascia di aliquote. Si tratta degli aspetti
politicamente più delicati dei tributi, come la scelta se istituire o meno una
nuova imposta, tassare o non tassare determinate forme di ricchezza, le modalità di
massima con cui determinare la base imponibile, le aliquote (paragrafo 9.4), eventuali
inasprimenti o agevolazioni.
La riserva di legge sulle sanzioni deriva, oltre che dall’art. 23, anche dall’art. 25
della costituzione, riferita anche alle sanzioni amministrative, non solo a quelle penali.
Gli squilibri della tassazione attraverso le aziende (par. 1.5.-1.7.) generano, negli stessi settori dell’opinione pubblica, reazioni contraddittorie e confuse, che in Italia hanno
anche dato luogo a reazioni legislative con lo “statuto dei diritti del contribuente”
(legge 212 del 2000). Quest’ultimo si compone di una carrellata di disposizioni un
po’ dispersive, enfatiche e rigide, mostrando gli inconvenienti delle “leggi manifesto”, sbilanciate su un valore (tutela del contribuente) che invece dovrebbe essere
tenuto presente in tutta la legislazione tributaria, contemperandolo con le altre esigenze,
sia politiche sia tecniche, indicate in questo manuale, comprese le drammatizzazioni
antievasione (par. 1.1.2 e 4.6).
Tecnicamente lo statuto è privo di rango costituzionale, e quindi derogabile
da leggi ordinarie, ma comunque ha costituito, negli ultimi decenni, un appiglio
normativo per molte interpretazioni sensate, magari raggiungibili comunque,
ma cui giovava un fondamento legislativo; mi riferisco ad alcuni principi di buonsenso, tra cui la buona fede, il contraddittorio, la motivazione, la mancanza di danno
per l’erario.
Erano conclusioni comunque raggiungibili anche attraverso la riflessione, spesso
sostituita dal riferimento allo statuto. Sotto questo profilo, anche quando lo statuto
ha contribuito ad avallare conclusioni sensate, il suo impatto è stato negativo, perché
la soluzione non è infatti giunta a seguito di un ragionamento, ma di un riferimento
normativo.
Il formalismo dello statuto ne comporta la frequente utilizzazione strumentale, da parte dei contribuenti, per invalidare atti impositivi su aspetti di dettaglio,
come la sottoscrizione del responsabile del procedimento, il termine per le deduzioni
difensive, la durata della verifica. Lo statuto è un indizio ulteriore dell’illusione di
poter “amministrare per legge” (par. 2.4). La mancanza di consapevolezza sulla
determinazione tributaristica della ricchezza rende lo statuto inadeguato su aspetti
fondamentali come gli effetti del comportamento procedimentale, le conse-
CAPITOLO 2 – RUOLO E LIMITI DELLA LEGISLAZIONE
19
guenze delle invalidità, le rimessioni in termini, e tutta la dialettica tipica di una funzione amministrativa, regolata col decreto 241 del 1990 in materia di procedimento
amministrativo, invalidità degli atti e simili.
La geografia legislativa tributaria segue le varie tipologie di tributi indicate al
paragrafo 1.10, essendo influenzata anche dalle modalità con cui le varie forme di ricchezza si manifestano. I due principali tributi che caratterizzano la tassazione attraverso
le aziende, cioè IVA e imposte sui redditi, hanno disposizioni procedurali distinte, ma
abbastanza ben coordinate. Altre disposizioni tributarie, relative anch’esse alla tassazione
attraverso le aziende, sono sparse in leggi a sé stanti, ad esempio l’IRAP, la tassazione
delle rendite finanziarie, l’IVA intracomunitaria. Ci sono però le numerosissime imposte estranee alla tassazione attraverso le aziende (capitolo decimo), riferite a forme di
ricchezza peculiari, per le quali il ruolo delle istituzioni pubbliche è diverso e quindi
inadatto ad una codificazione omogenea. Riferire quest’ultima a tutti i tributi,
compresi quelli ispirati al principio del “beneficio” (par. 1.8 e 5.1) appiattirebbe fenomeni diversi in una disciplina unitaria.
Codificare la legislazione non equivale infatti a padroneggiare il diritto, presupposto necessario a riequilibrare tassazione contabile attraverso le aziende e valutativa
attraverso gli uffici. Un presupposto della codificazione è chiarirsi le idee sul settore, nel
nostro caso sulla determinazione della ricchezza ai fini tributari. Chi invece si
aspetta la soluzione dal legislatore, come vedremo al par. 4.3, non è per definizione in
grado di codificare alcunché.
2.2. Il richiamo alla determinazione della ricchezza nell’art. 53 della Costituzione e l’equivoco della “capacità contributiva globale individuale”
Lo statuto del Regno d’Italia, redatto nel 1848 (c.d. “statuto Albertino”, dal sovrano che l’aveva promulgato) conteneva un’enunciazione di principio sul dovere di
concorrere alle pubbliche spese in proporzione agli “averi”, espressione equivalente a
quella di “ricchezza”; era una innocua enunciazione di principio, che la commissione
sui rapporti economici per la redazione dell’attuale costituzione propose addirittura di
non riprodurre, e che fu inserita nell’ultima fase di discussione in aula.
Trattandosi tutto sommato di una questione di secondo piano agli occhi di una assemblea agitata da ben altri problemi, gli interventi ruotarono anche attorno all’esigenza
di non tassare il c.d. “minimo vitale”, trovando una convergenza sull’attuale formula. Che sostituì il vecchio riferimento agli “averi”, diretto ancorché grossolano, con la
“capacità contributiva”; anche questa volta, secondo una caratteristica tipica della
legislazione, una espressione ellittica, ambigua e un po’ tautologica, consentiva
di trovare il consenso. L’eliminazione di un diretto riferimento alla ricchezza non era
il miglior punto di partenza per inquadrare i relativi problemi di determinazione,
e la ricerca di compromessi tra i relativi valori, indicati al par. 1.7 (precisione, semplicità,
controllabilità, etc). All’art. 53, che ribadisce un principio abbastanza pacifico, l’ambien-
20
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
te normativista (par. 4.3) fa oggi dire di tutto, anche in senso opposto, per lo stato o
per il mercato, a seconda delle rispettive tesi. Si presuppone anche una fantomatica
capacità contributiva globale dei singoli individui, che già all’epoca della costituzione era ingestibile ai fini pratici, e dopo lo è diventata ancora di più. Neppure la
costituzione può esprimere formule magiche per aggregare, ai fini della determinazione
della ricchezza, informazioni che nessuno possiede, contrastando la tradizionale, storica,
individuazione della ricchezza, in modo disaggregato tra varie forme di consumo, di
reddito e di patrimonio.
Il principio di capacità contributiva ci ricorda quindi solo il riferimento della
tassazione a manifestazioni di ricchezza, determinate senza discriminazioni o favoritismi. Ripetiamo che questo richiamo costituzionale non elimina la differente
visibilità e determinabilità della ricchezza ai fini tributari, con la necessità dei
noti compromessi tra precisione, semplicità, cautela contro le evasioni e le scappatoie,
certezza dei rapporti giuridici, effettività etc... Invece, non appena qualcuno prova a
ragionare sulla determinazione della ricchezza, viene subito accusato di parlare di una
questione che nella costituzione non esiste. Un fantomatico schedario (tipo “tabella
condominiale”) da usare come parametro per la divisione delle spese pubbliche risolverebbe tutti i problemi di diversa determinabilità della ricchezza, lasciando solo
le questioni interpretative e le scelte politiche sul collegamento tra spese pubbliche
e tributi (par. 1.7).. Sarebbe bello, ma non può essere, checché ne dica la costituzione.
Anche il minimo vitale, su queste premesse, è poco gestibile: ad esempio, la tassazione dei consumi avviene inevitabilmente senza poter considerare se l’acquirente è
un mendicante che acquista un po’ di cibo spendendo le elemosine, oppure un ricco
possidente: la cassiera del supermercato vede solo uno che sta facendo la spesa, e non
può certo indagare sulle condizioni economiche della gente in fila alle casse. Le condizioni patrimoniali generali, al fine di esoneri da ticket, sussidi e altre provvidenze,
sono accertate da indicatori non tributari, che si portano in parte dietro tutta l’incertezza sulla determinazione tributaristica della ricchezza (cfr. l’ISEE, in cui riemerge
la rilevanza “in negativo” della determinazione della situazione economica, al fine di
confermare una povertà e non di tassare la ricchezza).
L’articolo 53 è l’utile ripetizione dell’ovvia rilevanza della ricchezza ai fini
tributari, e consente di raggiungere più rapidamente alcune soluzioni altrimenti raggiungibili facendo leva sui principi di ragionevolezza ed uguaglianza, ad
esempio vietare costituzionalmente tassazioni retroattive, riferite cioè a ricchezza ormai
venuta meno al momento di pagare il tributo, il cumulo dei redditi tra coniugi, o la
tassazione come redditi di fonte patrimoniale di redditi che tali non erano (ILOR sul
lavoro autonomo, per chi ricorda la vicenda). Tuttavia, in questi casi, la ricchezza di
riferimento, cioè una “capacità contributiva” c’era, ma era trattata in modo irragionevolmente discriminatorio rispetto ad altre.
L’articolo 53 non entra, né è utilizzabile, nelle polemiche tra “stato e mercato” indicate al par. 1.7, in quanto non prende posizione su quali spese debbano
essere “pubbliche”; questa scelta casomai dipende da altre disposizioni costituzionali
CAPITOLO 2 – RUOLO E LIMITI DELLA LEGISLAZIONE
21
“di settore”, come quelle sulla “scuola pubblica”, la “sanità pubblica”, l’“assistenza pubblica” etc... Il principio di capacità contributiva non è neppure un argomento per
coprire le spese pubbliche con le imposte, anziché con tasse e tariffe, secondo il
principio del beneficio, di cui al par. 1.8.
Desumere dall’art. 53 soluzioni preconfezionate a temi di politica tributaria, come
i fantomatici “limiti costituzionali all’imposizione fiscale” è ingenuo o mistificante, come all’opposto far leva sull’art. 53 per divagare su “limiti costituzionali
all’imposizione fiscale”. Senza divagare sul ruolo dello stato e del mercato, ripetendo i
diversivi criticati al par. 1.7, l’art. 53 è conforme a un clima sociopolitico ben diverso
da quello di un secolo prima, quando era stato varato lo statuto Albertino, ma questo
riguarda tutta la costituzione; a questi valori è conforme il riferimento alla progressività,
dei cui problemi parleremo al par. 9.4.
Ci si può richiamare all’art. 53 anche per sostenere l’effettività della ricchezza
ai fini della tassazione, il che non vuol dire determinazione contabile e documentale. Gli indizi materiali e gli altri elementi di stima (par. 5.9) indispensabili per valutare
la ricchezza dove le aziende non arrivano, con le loro stime, valutazioni, presunzioni, servono anch’essi a perseguire un’effettività “pragmaticamente praticabile”.
L’articolo 53 conferma anche l’inaccettabilità politica di tassare qualcuno su ricchezza
inesistente, presunta dalla legge, solo perché qualcun altro, con lo stesso criterio, viene
esonerato dal pagamento di tributi su ricchezza esistente. Per questo le forfetizzazioni
(come quella catastale di cui al par. 8.2) sono praticabili, soprattutto in un contesto di
tassazione ragionieristico-documentale solo se non ci rimette nessuno, o ci rimettono
in pochissimi. Per questo tutte le tassazioni “forfettarie”, dal catasto agli studi di settore
“si tengono basse”, in modo da ridurre proteste e recriminazioni “interne” ai settori
della società su cui sono applicate.
Il principio di capacità contributiva ha anche l’inconveniente di generare,
nell’opinione pubblica e negli studiosi sociali, la sensazione fuorviante che il dovere
tributario scatti, in base all’art. 53, solo perché si è titolari di qualche forma di
ricchezza; una previsione legislativa è invece necessaria sia per motivi logici sia per il
già ricordato art. 23, e non costituisce “un optional”, secondo una tendenza che qualche
volta emerge anche in sede amministrativa e giurisprudenziale; non a caso l’articolo 53
è stato usato dalla corte di cassazione come retroterra argomentativo per introdurre
nell’ordinamento (peraltro comprensibilmente) un divieto di abuso del diritto di
origine giurisprudenziale (infra par. 3.10).
2.3. Tassazione attraverso le aziende come illusione di poter amministrare per legge: il diritto tributario sostanziale
Nella tassazione attraverso le aziende, come vedremo al cap.3, il pubblico potere si
rivolge a una organizzazione (appunto “l’azienda”), che in quanto tale, non avendo
una sfera privata (par. 3.1) non ha alcun motivo di mentire al fisco; tale menzogna
comporterebbe infatti una responsabilità personale cui gli individui coinvolti vanno
22
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
incontro solo nell’interesse proprio, come nell’esempio classico del titolare dell’azienda,
che non nasconde ricchezza “per l’azienda”, ma la nasconde per sé.
Nella misura in cui la ricchezza viene fatta emergere contabilmente dalle organizzazioni aziendali, il legislatore può rivolgersi direttamente alle aziende, in una sorta
di “partita a due”. Una volta determinata affidabilmente la ricchezza in modo
ragionieristico, a cura degli uffici di contabilità aziendale, il legislatore tributario può
sbizzarrirsi nell’indicarne alle aziende la qualificazione tributaria. Ciò avviene con la
“legislazione tributaria sostanziale”, riguardante l’inquadramento giuridico della ricchezza, successivo alla sua determinazione materiale. Questo inquadramento riguarda
dapprima i modi, i tempi, la collocazione nello spazio, l’imputazione soggettiva della ricchezza, la distinzione tra costi e consumi. Momenti logici ancora successivi,
sempre del diritto tributario sostanziale, riguardano le aliquote di imposta, compresi
tutti i regimi, premiali e talvolta punitivi, indirizzati agli effetti economici delle imposte,
ivi compresi quelli agevolativi. Con le disposizioni organizzative di cui al par. 2.1,
nonché quelle procedurali delle aziende, dei professionisti e delle istituzioni, si completa la panoramica della legislazione tributaria.
È un meccanismo prodottosi in modo spontaneo, per intuizioni delle classi dirigenti,
inconsapevoli che le aziende odierne erano lo strumento con cui il pubblico potere
“Imponeva le imposte”. La possibilità di chiedere per legge le imposte, attraverso le aziende, così come ieri le si chiedevano attraverso comunità intermedie, rurali,
territoriali, religiose, feudali, economiche (par. 2.3), è stata seguita, ma non è stata
razionalizzata e interiorizzata; per questo, come vedremo, in una specie di delirio
di onnipotenza legislativa, è stata istintivamente estesa dove non ne sussistevano i
presupposti, cioè su ricchezza non raggiunta dalle aziende. Si è in questo modo
autoalimentato il preconcetto di una fantomatica onnipotenza legislativa, come se la
legge potesse trovare la ricchezza non registrata; l’evidente insuccesso di questo fantomatico “potere” era addebitato al capro espiatorio di imprecisati “evasori”, secondo
un filo conduttore del testo, emergente al capitolo quarto. Il tentativo di governare la
fiscalità “per legge” si è inserito sulla tendenza generale ad “amministrare per legge”,
assecondata dalla deresponsabilizzazione amministrativa, diffusa in tutti i settori della
macchina pubblica, nei termini indicati al par. 5.3.
È stata così messa in secondo piano la valutazione amministrativa che caratterizza da sempre la richiesta delle imposte, e il cui cattivo funzionamento produce gli
squilibri avvertiti dalla pubblica opinione. Determinare la ricchezza ai fini tributari,
dove le aziende non arrivano, è una funzione pubblica non effettuabile per legge,
come educare i giovani, curare i malati, dirigere il traffico, smaltire i rifiuti, difendere
i confini, gestire i flussi migratori (l’unica funzione pubblica effettuabile per legge, e
neppure tanto, è infatti quella di giustizia, una volta accertati i fatti). A questa sopravvalutazione della legge si è accompagnato il mito della dell’onnipotenza della politica e
la deresponsabilizzazione degli uffici, che ha rapidamente condotto agli inconvenienti
di cui al capitolo quarto, superficialmente imputati alle perversioni private di fantomatici “evasori”, oppure ad altrettanto fantomatiche vessazioni poste in essere dagli uffici
tributari. Nessuno si è accorto che il problema è teorico metodologico in tema
CAPITOLO 2 – RUOLO E LIMITI DELLA LEGISLAZIONE
23
di determinazione della ricchezza. Anticipiamo al prossimo paragrafo, visto che
qui parliamo di fonti normative, gli equivoci che ne sono derivati sul ruolo della legislazione.
2.4. Segue: la sopravvalutazione della legislazione nell’autotassazione
L’illusione di poter determinare la ricchezza “per legge” è stata alimentata da
vari altri fattori, di ordine generale, che si aggiungono alla possibilità, descritta al paragrafo precedente, di dirigere la tassazione attraverso le aziende mediante la legislazione.
L’idea di cambiare il mondo attraverso le leggi cerca di influire, dai tempi della
rivoluzione francese, sul comportamento del “servizio giustizia”, cercando di predeterminarne il più possibile il contenuto. Vi contribuiva l’esigenza di certezza e prevedibilità dei rapporti privati, tipica di una società complessa, come pure il ruolo
organizzativo della legislazione in un intervento pubblico ormai esteso in tutti i settori,
ben al di là dell’amministrazione della giustizia. L’importanza della legislazione nella
funzione pubblica di giustizia, l’ha fatta sopravvalutare negli altri settori del diritto
contribuendo al paralizzante pseudonormativismo di cui al par. 4.3. Già discutibile
nella “funzione giustizia”, questa pretesa onnipotenza diveniva paradossale negli
altri “pubblici poteri”, come difesa, sicurezza, infrastrutture, sanità, ambiente, etc,.
Quest’onnipotenza diventava anzi un ostacolo al buon funzionamento di istituzioni pubbliche, composte da uomini che si fanno interpreti delle proprie funzioni,
secondo un misto di regole, valori, opportunità e gestione pragmatica delle contingenze
(par. 4.3 e par. 5.10 sulla discrezionalità). Rispetto alla varietà di funzioni pubbliche, non
certo limitate all’amministrazione della giustizia, come la sicurezza, la sanità, l’istruzione,
l’ambiente, i beni culturali, la ricerca, l’integrazione etnica, compresa la determinazione
della ricchezza ai fini tributari, il mito del “governo della legge” alimenta la tendenza
(par. 5.3) ad “essere a posto”, proteggersi da critiche, non mettersi in gioco, non cercare la soluzione di volta in volta più opportuna nell’interesse generale; è una comoda
deresponsabilizzazione, o una strumentalizzazione per convenienze, pigrizie o scambi
di favori.
La sopravvalutazione della legislazione crea una specie di schizofrenia sociale,
con aspettative esagerate, seguite da delusioni, cui corrispondono altalenanti invocazioni e denigrazioni del potere politico, confuso con antiche mitiche entità sovrumane. I politici alimentano queste aspettative, magari compiacendosene e diventando
inconsapevolmente ostaggi della pubblica opinione e delle conferenze stampa. Il
timore di perdere consenso e di togliere un punto di riferimento alla “pubblica opinione”, trattiene spesso la politica dallo sconfessare le aspettative in essa riposte.
Ne discende un frenetico interventismo normativo, che asseconda diverse e
contraddittorie emotività intrecciate nella pubblica opinione, in modo inevitabilmente
ambiguo e spesso con una mera finalità “mediatica”.
La legislazione sulla determinazione della ricchezza viene ispirata anche dalle categorie economiche coinvolte, per quanto riguarda gli adempimenti, le modalità di
24
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
determinazione della ricchezza di terzi, l’utilizzazione e integrazione fiscale di adempimenti documentali, eventuali provvedimenti agevolativi di settore. Si tratta in genere
di “micro-interventi”, molto di dettaglio, tipici della tassazione attraverso le aziende; le
riduzioni indirette dell’ordinario carico fiscale sono imputate al termine, vagamente
spregiativo, di “lobbismo”. Anche le istituzioni fiscali (agenzia delle entrate e Guardia
di finanza) promuovono spesso disposizioni legislative, per chiudere in via legislativa
specifici problemi operativi.
La politica, in quanto emanazione del gruppo sociale, ne riproduce il disorientamento sulla determinazione della ricchezza, e cerca empiricamente di massimizzare l’impatto dei propri interventi in materia in termini di consenso e coesione
sociale.
Si alimenta così la già indicata strutturale ambiguità normativa, dove aspetti
diversi dei medesimi interventi legislativi lanciano messaggi diversi ai settori della
pubblica opinione in tutto o in parte coinvolti; mi riferisco ai sindacati dei lavoratori, alle associazioni di categoria di commercianti e imprenditori, alle istituzioni europee, ai mercati finanziari, agli enti locali, alle associazioni di consumatori, ai proprietari
di immobili. Oltre a questi interessi organizzati ci sono anche le varie tendenze della
pubblica opinione che indicheremo al capitolo 4 sulle varie ricette spontanee
contro l’evasione fiscale, e sulla posizione dei mass media in merito. L’ambiguità legislativa è quindi uno strumento per gestire la coesione sociale e il consenso, e cresce
in proporzione al disorientamento su un determinato tema (come la determinazione
tributaristica della ricchezza), in modo da avere qualcosa da dire in tutte le sedi suddette, anche a prezzo di fortissime incoerenze, nel c.d. “effetto di annuncio”, fatto di
discussioni effimere, di conferenza stampa e titoli di apertura dei giornali, di espressioni
ambigue, dove conta inevitabilmente più l’apparenza che la sostanza. Quest’ultima diventa comprensibile solo nel lungo periodo, mentre l’opinione pubblica è volubile,
distratta, presa dai propri problemi, inevitabilmente miope, e smemorata al tempo
stesso; i comunicatori più smaliziati sanno bene che, quando l’effetto di annuncio
sarà smentito dai fatti, a distanza di tempo, nessuno lo ricorderà più, o potrà essere
liquidato con qualche immaginifica trovata. Da questa mancanza di comprensione e di
spiegazioni sulla determinazione dei tributi deriva il numero e l’ambiguità delle leggi, con “disposizioni manifesto”, finalizzate a massimizzare l’effetto di comunicazione
politica, anche a costo di dispersioni e contraddittorietà, come l’intreccio tra istanze
di riforma e di tregua normativa. Intervenire senza capire stratifica “effetti di annuncio”, che non risolvono i problemi, ma li creano, a causa di una legislazione
fatta per dire qualcosa in conferenza stampa. Essa magari resta inerte dove dovrebbe
intervenire, e interviene dove ne manca qualsiasi necessità. Si autoalimenta il
circolo vizioso secondo cui difetti delle vecchie normative innescano la produzione
di nuove, su questioni che magari in altri paesi si risolvono con una banale circolare
amministrativa; l’insieme della legislazione vive di vita propria e, come il letame, più si
rivolta e più puzza, cioè diventa indecifrabile. Per venirne fuori bisogna comprendere
che la soluzione non sta nelle leggi, ma nelle istituzioni, a loro volta dipendenti,
come vedremo al par. 5.3, da come la pubblica opinione percepisce il settore.
CAPITOLO 2 – RUOLO E LIMITI DELLA LEGISLAZIONE
25
Il vizio sta nell’atteggiamento verso le leggi, nell’illusoria aspettativa di risolvere per
legge i problemi della determinazione della ricchezza ai fini tributari, anziché nelle
leggi “in sé”. Ci ritorneremo al par. 4.7, coordinando determinazione tributaristica
della ricchezza ed effetti sociopolitici dei tributi, concettualmente non demandati ai
tributaristi.
2.5. Determinazione della ricchezza e controllo della Corte costituzionale
Il diritto è emanazione del gruppo sociale, la cui organizzazione “politica” può
essere talmente sofisticata da prevedere addirittura un “giudice della politica”,
operante anche sulle leggi tributarie. Si tratta delle corti costituzionali, collocate in una zona intermedia tra politica e diritto, densa di scelte “valoriali”; esse
servono soprattutto a sovraintendere al contemperamento, da parte del legislatore,
dei valori “politicamente caratterizzati” indicati dalla costituzione, piuttosto che ai
valori neutri, come la determinazione della ricchezza ai fini tributari, di cui ci occupiamo in questo libro.
I valori rilevanti ai fini della determinazione della ricchezza, coi compromessi concettuali tra precisione, semplicità, stabilità dei rapporti e altri, sfuggono alla maggior
parte dell’opinione pubblica e delle classi dirigenti, e non si acquisiscono certo con la
nomina a giudice costituzionale; si tratta in genere di uomini di legge, provenienti
dalla magistratura, dalla dottrina, dalla carriera forense nelle più svariate discipline, sforniti di molti concetti necessari alla comprensione della determinazione tributaristica
della ricchezza (in particolare quelli economici e aziendali, secondo la combinazione
descritta più volte in questo testo, in particolare al paragrafo 1.5/1.6).
Anche per i giudici costituzionali, i più vicini alla politica, vale un denominatore comune, ricorrente in questo testo e che ritroveremo per la generalità dei giudici,
concepiti per risolvere controversie, non per sistematizzare i concetti (vedi
anche par. 4.4 e 6.7). È normale che cerchino di svolgere questo compito nel modo più
elegante, meno imbarazzante, cioè meno esposto a potenziali obiezioni. Essi non
possono quindi portare sistematicità e razionalità nella determinazione della ricchezza ai fini tributari, e si trincerano legittimamente dietro formule stereotipe (par. 4.3),
come riduttivi riferimenti a un generico «interesse fiscale», all’«esigenza di garantire la
riscossione dei tributi». Talvolta vengono salvate alcune soluzioni legislative ispirate
non tanto al contrasto di evasioni o abusi, ma alla mera comodità operativa degli uffici tributari; altre volte vengono dichiarate incostituzionali norme con una loro
logica sul piano della determinazione della ricchezza. Da un certo punto di vista, se
critiche si possono fare alla prassi della Corte Costituzionale degli ultimi decenni, non
riguardano tanto il dispositivo delle sentenze, quasi sempre di rigetto, quanto la relativa
motivazione. Che risente di ordinanze di rimessione, formulate in modo confusionario
e mal impostate da giudici tributari sbrigativi e eterogenei, come vedremo al paragrafo
6.7 ss.;; anche per questo le pronunce di rigetto diventano quasi automatiche, con motivazioni spesso stereotipe e travolgendo magari quei pochi casi che poteva-
26
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
no avere un fondamento. È quindi comprensibile la suddetta cautela da parte della
Corte, che respinge la maggior parte delle questioni sottopostele, non tanto per timore
di contraccolpi sulla finanza pubblica, ma per la sensazione di mettere le mani su
un oggetto misterioso, temendo oltre tutto di scompaginare l’organizzazione degli
uffici finanziari. Per una serie di questioni esaminate dalla corte vedi i riferimenti al
precedente par. 2.2 sulla capacità contributiva.
2.6. Libertà comunitarie, vincoli al legislatore tributario e determinazione della ricchezza
Le logiche della determinazione tributaristica della ricchezza attraverso le
aziende vanno inserite in un contesto comunitario, che condiziona il potere legislativo anche in materia tributaria; il meccanismo costituzionale è quello, consueto,
secondo cui l’art. 11 della costituzione consente «limitazioni di sovranità necessarie a un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni».
L’appartenenza alle comunità non interferisce però sulle combinazioni tra
spese e tributi che ciascuno Stato decide di scegliere, come indicato al par. 1.7 a
proposito del rapporto tra “stato e mercato”. Possono quindi far parte della Comunità
stati con diversissime combinazioni tra organizzazione pubblica e organizzazione di
mercato della convivenza sociale; nella comunità possono coesistere stati con poche
imposte, pochi servizi pubblici e più «mercato» (relativamente «liberisti»), e stati
con più imposte, più servizi pubblici e quindi meno mercato (relativamente «socialdemocratici»).
Nello spirito di libera circolazione cui è improntata la Comunità, questi due modelli competeranno in relazione alla maggiore efficienza raggiunta in concreto da
ciascuno di essi, combinando “stato” e “mercato”.
Le imposte non devono quindi distorcere il mercato, favorendo merci o industrie residenti rispetto a merci o industrie di altri paesi comunitari; la stessa distorsione
ci sarebbe attirando investimenti stranieri con regimi di favore destinati soltanto ad
essi, e cioè “selettivi”. Queste penalizzazioni o questi favoritismi, finirebbero per
alterare, all’interno del territorio comunitario, una concorrenza basata sull’efficienza
economica delle aziende private e delle macchine pubbliche.
Per questo sono vietate sin dall’inizio le imposte doganali tra paesi dell’unione, imponendone la riformulazione nei rapporti esterni al territorio comunitario di
cui riparleremo al par. 10.5;; anche ogni altro tributo indiretto ad effetto equivalente a
quelli doganali fu proibito.
Dato che i diversi meccanismi tecnici per portare tassazione del solo consumo, descritti al par. 7.2, avrebbero potuto intralciare gli obiettivi suddetti, è stata imposta
l’IVA come modello generale europeo di tributo sui consumi. Per queste imposte si
può parlare di “armonizzazione comunitaria” (imposte armonizzate).
Sono vietate anche le agevolazioni fiscali in grado di condizionare la neutralità
nell’allocazione degli investimenti all’interno dell’Unione Europea; molte agevola-
CAPITOLO 2 – RUOLO E LIMITI DELLA LEGISLAZIONE
27
zioni fiscali, prime tra tutte quelle territoriali, devono quindi essere soggette ad autorizzazioni degli organi dell’Unione Europea.
Anche per le imposte “non armonizzate”, come quelle sui redditi, non regolate dai
trattati delle Comunità Europee, sussistono i suddetti divieti generali di discriminazione e di aiuti di stato, che riguardano prima di tutto il sistema delle aliquote, il
carico tributario, e non la determinazione della ricchezza; tuttavia anche le regole sulla
determinazione della ricchezza ai fini tributari possono incappare nei divieti comunitari; molto spesso, infatti, tali regole presuppongono interdipendenze tra regimi
fiscali, di contribuenti diversi e tempi diversi (c.d. “simmetrie fiscali” di cui al paragrafo
3.9), con una giustificazione solo all’interno dello stesso sistema tributario.
Tuttavia, quando le controparti risiedono in altri paesi comunitari il principio di “non
discriminazione” impedisce di negare pregiudizialmente il regime tributario altrimenti
applicabile se tali eventi avvenissero in patria. È insomma comunitariamente vietato
“fare figli e figliastri”, nel senso di dover riconoscere anche le “simmetrie” avvenute in
altri paesi comunitari.
Qualche distinzione è legittimata talvolta dalla Corte di Giustizia in base al concetto di «coerenza del sistema fiscale», che riconosce il diverso peso delle solite esigenze (come precisione, semplicità etc.) da coordinare nella determinazione
tributaristica della ricchezza. È per certi versi ammirevole il modo in cui la corte di
giustizia europea, non specializzata in materia tributaria, con giudici di decine di paesi
diversi, abbia saputo destreggiarsi con buonsenso in simmetrie giuridico-contabili molto specialistiche; evidentemente, in sede europea, si procede più per concetti che per
“documentazione normativa”, modalità del resto impossibile data la mole del materiale
interno e comunitario di riferimento (par. 4.3).
Parleremo più avanti (paragrafo 7.19) anche dell’abuso delle libertà europee da
parte di piccoli stati membri che mettono a disposizione di altri non già reali prestazioni economiche, ma “protezioni legislative” per regimi finanziari o fiscali di
favore, indifferenti sul piano interno e che danneggiano la sfera di sovranità tributaria
di altri stati comunitari.
Un vincolo indiretto, per i paesi appartenenti all’euro, è quello di limitare i deficit
di bilancio, e quindi di “non poter consumare a debito”, di non poter “svalutare la
moneta”, né “stampare moneta unilateralmente”.
Oltre ai trattati istitutivi, già citati, la normativa comunitaria è composta prevalentemente da regolamenti e direttive.
I regolamenti comunitari sono atti delle Comunità, direttamente esecutivi nel
nostro ordinamento, indipendentemente da un recepimento da parte delle singole legislazioni nazionali; questa diretta esecutività pone problemi molto delicati, che hanno
indotto a limitare l’utilizzo dei regolamenti a settori dove è maggiore il grado di internazionalizzazione, come quello doganale e dei traffici comunitari (par. 10.5).
Le direttive Europee, a differenza dei regolamenti, non hanno efficacia diretta
negli ordinamenti nazionali, essendo dirette agli organi legislativi dei singoli stati, che
devono recepirle negli ordinamenti nazionali, spesso con significativi margini di discrezionalità per effettuare tale recezione.
28
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
Quando però le direttive sono sufficientemente dettagliate, incondizionate
(nel senso di non lasciare margini di discrezionalità al legislatore nazionale) ed è scaduto
inutilmente il termine previsto per il relativo recepimento, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione, avallata dai giudici nazionali, ha reagito all’inadempimento
dei singoli stati affermando la diretta applicabilità, in tali casi, delle direttive negli ordinamenti interni.
È ormai affermato, dalla giurisprudenza interna e comunitaria, l’obbligo delle istituzioni nazionali di disapplicare il diritto interno in contrasto con le suddette
disposizioni comunitarie. Ove non sia chiaro se questo contrasto sussista, il giudice
nazionale dovrà trasmettere gli atti del processo alla Corte di Giustizia delle Comunità
Europee, che si pronuncerà in proposito.
Quanto indicato sopra rileva non solo per i giudici, ma anche per le amministrazioni, comprese quelle tributarie. È noto, infatti, che non esiste una pubblica amministrazione della comunità europea, che agisce invece attraverso le amministrazioni
degli stati membri. Anche le nostre pubbliche amministrazioni, sempre preoccupate
di avere una “copertura normativa”, si trovano quindi davanti a convergenze confusionarie di disposizioni interne e comunitarie, con ulteriori disorientamenti, equivoci
e inutili cautele.
Capitolo 3
DETERMINAZIONE CONTABILE E VALUTATIVA
DELLA RICCHEZZA TRA TASSAZIONE
ATTRAVERSO LE AZIENDE E AUTOTASSAZIONE
(PUNTI FORTI DELL’ADEMPIMENTO
E DELL’EVASIONE)
Sommario: 3.1. Le aziende come “corpi sociali intermedi” nella determinazione della ricchezza – 3.2.
Rigidità gestionali come strumento di determinazione della ricchezza attraverso le aziende – 3.3. La riutilizzazione di documenti contabili per la determinazione tributaristica della ricchezza – 3.4. Ulteriori
adempimenti esclusivamente tributari: scontrini, dichiarazioni e versamenti – 3.5. Tassazione attraverso
le aziende di ricchezza di terzi:“contribuenti di diritto” e “di fatto” tra rivalse, ritenute, segnalazioni
e controversie private con oggetto tributario – 3.6. Segue. Il sostituto d’imposta come strumento di
tassazione delle somme erogate a terzi (ritenute alla fonte tra funzione esattiva e segnaletica) – 3.7. La
ricchezza fiscalmente non registrata, a beneficio dei titolari di organizzazioni aziendali (ipotesi sulla
“grande evasione”) – 3.8. Costo dei tributi,“cunei fiscali”, concorrenza sleale e ricchezza non registrata
per finalità aziendali – 3.9. Qualificazione giuridica della ricchezza registrata e logiche dell’interpretazione nella tassazione attraverso le aziende (le “simmetrie concettuali” tra soggetti diversi e tempi
diversi) – 3.10. Segue: Evasione interpretativa, pianificazione fiscale ed elusione come tipici comportamenti aziendali (rinvio alle contestazioni interpretative come “diversivi istituzionali”) – 3.11. Evasione
internazionale tra contestazioni interpretative e ricchezza non registrata – 3.12. Riepilogo: simmetrie
della tassazione attraverso le aziende ed “arbitraggi”, tra correttezza sistematica, elusioni e frodi – 3.13.
Dove le aziende non arrivano: l’inutile “ragionierizzazione” dei lavoratori indipendenti (il diversivo
della “contabilità fiscale”) – 3.14. Mancata registrazione degli incassi nel lavoro indipendente verso
consumatori finali – 3.15. La crescente “ricchezza non osservabile”, discontinua, collaterale, anche di
sopravvivenza – 3.16. Professionisti tra tassazione attraverso le aziende e attraverso gli uffici: prospettive
per un loro uso più efficiente
3.1. Le aziende come “corpi sociali intermedi” nella determinazione della
ricchezza
Le aziende utilizzabili per la determinazione ragionieristica della ricchezza, come
indicato già al paragrafo 1.4, sono pluripersonali, ed autosufficienti rispetto all’opera
di uno dei loro singoli componenti, compreso il titolare; in questo senso, le aziende
non sono entità “senzienti”, antropomorfiche, ma “corpi sociali”, da non confondere coi “lavoratori indipendenti”, cioè tendenzialmente artigiani e piccoli commer-
30
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
cianti; la cosiddetta “azienda” del lavoratore indipendente, è infatti tale solo nel diverso
senso “materiale”, di insieme di beni necessari all’attività.
L’azienda pluripersonale è invece una organizzazione di individui con una divisione di compiti, separazioni di responsabilità e necessità di rendicontazione,
prima di tutto interna. Come per tutti i gruppi sociali intermedi, quali associazioni
politico-sindacali, comunità religiose, gruppi sportivi, enti pubblici “settoriali” etc, l’azienda è priva di bisogni personali in nome dei quali nascondere ricchezza al
fisco.
L’azienda è un gruppo sociale a base economica, nel senso di essere tenuto assieme
dalla produzione di beni e servizi per il mercato. Come organismo pluripersonale,
l’azienda non si preoccupa dei bisogni personali del titolare, ma dell’equilibrio, che
dipende dalla remunerazione di tutti gli elementi dell’organizzazione attraverso il concetto di “valore aggiunto” (par. 7.2). Il “tornaconto” dell’imprenditore come persona,
se l’azienda crea valore, sussiste anche senza profitto, a differenza di quanto accade per
il lavoratore indipendente. Un’altra confusione, che ritroveremo al par. 7.5, è tra
“azienda”, in senso pluripersonale o al limite “materiale” (insieme di beni di un unico
lavoratore indipendente), e “società”, come forma giuridica, anche priva di operatori
economici al suo interno.
Gli equivoci generali sull’idea di azienda, e le carenze di formazione economico-sociale di cui al par. 1.6, hanno ostacolato la percezione del suddetto suo
ruolo ai fini della determinazione tributaristica della ricchezza. Si tratta di una
“esternalità positiva”, cioè di un contributo delle aziende alla convivenza sociale,
che non è stata colta neppure da quanti vi operano, assorbiti dall’attività che
tiene insieme l’azienda come gruppo, cioè produzione di merci e servizi, siano essi
farmaci, calzature, comunicazioni telefoniche, trasporti e via enumerando; neppure
gli operatori delle aziende capiscono la “tassazione attraverso le aziende”, e si spiega
quindi il suo mancato riconoscimento da parte della pubblica opinione in genere;
rinviamo ai paragrafi 5.17 e seguenti sull’incapacità delle aziende di rispondere, in materia tributaria, a una cultura di massa che non le comprende, e le colpevolizza come
forma organizzativa.
Insospettisce forse la “struttura proprietaria” caratterizza l’azienda rispetto ad altri “corpi sociali” intermedi, con base associativa (sindacati, partiti, gruppi religiosi,
etc.) ovvero istituzionale, come i corpi militari, la magistratura, etc... Quest’appartenenza privata, con matrice “non democratica”, dell’azienda ha provocato una serie di
equivoci e tensioni sociali di vario tipo.Tali equivoci hanno innescato un circolo vizioso
col ruolo operativo della proprietà nelle piccole aziende italiane, poco organizzate
al vertice, venate di paternalismo e invidie, che contribuiscono ulteriormente a confondere il gruppo sociale “azienda” con il suo titolare. Sono facilissimi gli equivoci tra
l’“azienda a conduzione familiare”, dove coniugi o figli prestano materialmente la loro
opera, spesso con altri collaboratori, e “azienda a proprietà familiare”, magari con centinaia di operai e impiegati. Anche per via di questo “capitalismo familiare”, l’immagine
dei piccoli commercianti e degli artigiani si proietta sulle aziende, come se avessero i
bisogni personali e familiari di lavoratori indipendenti “troppo cresciuti”.
Capitolo 3 – DETERMINAZIONE CONTABILE E VALUTATIVA DELLA RICCHEZZA
31
Per questo, in Italia, a differenza di altri paesi dove non c’è diffidenza per le organizzazioni, le aziende non riescono ad evolversi verso un assetto istituzionale in cui la
proprietà si frammenta in una governance tra molteplici investitori istituzionali e risparmiatori.
La determinazione tributaristica della ricchezza, tuttavia, trae vantaggio dalle necessità contabili e documentali che sussistono, anche per le aziende a proprietà familiare, come per tutti i corpi sociali. Grazie a tali rigidità amministrative
aziendali la tassazione arriva sulla ricchezza che passa attraverso l’azienda, relativa ai
consumatori, ai collaboratori (dipendenti o autonomi), ai risparmiatori e infine
agli stessi titolari dell’azienda. Queste necessità ragionieristico-contabili delle aziende private sono determinanti per l’attuale gettito tributario, e la loro utilizzazione va
coordinata con la tradizionale determinazione estimativa e valutativa, dove le aziende
non arrivano.
La tassazione attraverso le aziende non è limitata a quelle produttive e private, ma
utilizza tutti i corpi sociali, comprese le aziende pubbliche “di erogazione” indicate
sopra, soprattutto quando esse pagano stipendi e altri compensi in veste di
sostituto di imposta (par. 3.5). La macchina pubblica, destinataria del gettito dei
tributi, partecipa quindi anch’essa alla tassazione attraverso le aziende quando essa
eroga ricchezza a terzi; in questo caso, anzi, le rigidità amministrative che rendono affidabile il sistema sono massime.
3.2. Rigidità gestionali come strumento di determinazione della ricchezza
attraverso le aziende
Abbiamo già rilevato che le aziende, e gli operatori economici, acquisiscono consumi dall’insieme dei clienti, ed erogano redditi ai dipendenti, ai finanziatori ed
all’imprenditore (ripartizione del “valore aggiunto” come indicato al par. 7.6 sull’IVA e
9.1 sull’IRAP). L’azienda acquisisce i consumi in veste di fornitore, ed eroga i redditi
in veste di “cliente-datore di lavoro”: è lo stesso grande filtro rappresentato dall’attività economica in genere, solo che qui viene svolto da organizzazioni con la già indicata
rigidità amministrativa, punto di forza per il fisco.
Quest’ultimo inserisce quindi tributi sui flussi in entrata e in uscita suddetti, come
avviene nell’IVA, sulle entrate rappresentate da consumi (par. 7.2 ss);; lo stesso
avviene per le ritenute sulle uscite, rappresentate da redditi (stipendi, compensi
professionali, interessi, dividendi, par. 3.6). In questo modo la ricchezza, già visibile
ai fini amministrativi, lo diventa anche ai fini tributari; alcuni di questi istituti,
che riprenderemo ampiamente, esauriscono l’imposizione, come l’IVA o i tributi sostitutivi sui redditi finanziari (par. 8.5); altri sono “provvisori”, come le c.d.
“ritenute d’acconto”, ma spingono l’interessato a completare l’autotassazione (par. 3.6). Emerge così anche la ricchezza facente capo all’azienda, soprattutto il
suo reddito (cfr. capitolo 7), di cui però l’azienda non è la consumatrice definitiva,
in quanto essa è un luogo di produzione, non di consumo. Rispetto a questa
32
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
massa di ricchezza, che transita presso l’azienda, ma non è dell’azienda, la
ricchezza riferibile ai titolari delle aziende (il profitto) è ben poca cosa; per questo
sarebbe riduttivo parlare di “tassazione delle aziende”, mentre l’espressione “tassazione attraverso le aziende”, ne mette in risalto l’oggettiva funzione di
moderni esattori del fisco.
Ricordiamo che, in quanto “gruppi sociali”, e non persone fisiche, le aziende –
nelle persone dei loro impiegati – non hanno motivo di nascondere ricchezza al
fisco, assumendosi la responsabilità di eventuali sanzioni, ed esponendosi alle conseguenti critiche da parte degli altri membri dell’azienda. Prendersi la responsabilità
di violazioni tributarie non porterebbe ai funzionari aziendali vantaggi personali se
tutto fila liscio, mentre l’eventuale scoperta della violazione, con connesse sanzioni,
sarebbe loro addebitata all’interno dell’azienda. Quando la proprietà aziendale (par.
3.7-3.8) impone ai contabili di non registrare fiscalmente quote di ricchezza,
essi sono imbarazzati dalla necessità di manovrare risorse “fuori bilancio”, mentendo
quindi “per conto terzi”, ed esponendosi a pagare di persona, col rischio di essere “scaricati” dall’organizzazione se la vicenda fosse scoperta. Da questo desiderio di ripararsi
da responsabilità estranee al proprio compito nasce la tendenza delle organizzazioni a
rispettare le leggi, che non dipende da intrinseca “onestà o disonestà”; ritroveremo questa tendenza comportamentale anche per le istituzioni pubbliche al paragrafo
5.3.
Il principale punto di forza del fisco sono infatti le esigenze, tra gli individui operanti
nell’azienda, di controllo reciproco, coordinamento e documentazione; la spersonalizzazione, e la complessità amministrativa, della gestione aziendale, creano contrasti di interessi tra gli individui operanti nell’azienda. Man mano che i diversi settori
aziendali si irrigidiscono, a seconda delle merci vendute, della tipologia di prestazioni,
dei mezzi di pagamento, il fisco usa queste rigidità per una affidabile determinazione tributaristica della ricchezza. Questa necessità di delegare funzioni a collaboratori non si presenta tuttavia ugualmente per tutte le operazioni aziendali, ma soprattutto
per quelle numerose e ripetitive, mentre altre continuano a essere gestibili direttamente
in prima persona dal titolare.
Nella medesima azienda possono quindi coesistere aree amministrative di grande
rigidità, molto affidabili ai fini della determinazione tributaristica della ricchezza, e
aree dove al titolare restano margini per nascondere ricchezza al fisco; vedremo al
paragrafo 3.7 quali altre operazioni, più rare, restano ancora gestibili dall’imprenditore
o da suoi fiduciari, con residue possibilità di evadere le imposte. Per ora l’importante è
capire che lo stesso organismo aziendale può essere, al tempo stesso, un ausiliario del fisco nell’emersione di alcuni tipi di ricchezza, ed un ausiliario del titolare che
invece vuole nasconderne una quota a proprio uso e consumo.
Il principale punto di rigidità è il ciclo delle vendite, quando esse sono verso
altre aziende oppure verso una pluralità di consumatori finali, da parte di un’organizzazione amministrativa complessa e per piccoli importi. Nel primo caso la documentazione è richiesta dal cliente, mentre se gli acquirenti sono consumatori finali,
la difficoltà nel nascondere ricchezza al fisco sta nella ripetitività e nel numero delle
Capitolo 3 – DETERMINAZIONE CONTABILE E VALUTATIVA DELLA RICCHEZZA
33
operazioni sottostanti, individualmente di piccolo importo. La registrazione ripetitiva
di tante prestazioni modeste è il principale presidio della relativa determinazione trbutaristica della ricchezza, perché non è verosimile che il titolare scavalchi i propri dipendenti, facendosi individuare mettendosi a rischio di ammanchi o pressioni.
A questa registrazione dei ricavi si collega, in capo alle controparti, la tassazione del
consumo dell’acquirente, come vedremo a proposito dell’IVA e delle altre imposte sui
consumi (paragrafi 7.2 e 10.6), e la rilevazione del valore aggiunto, e quindi del reddito,
dell’azienda.
Il ciclo amministrativo di rilevazione dei costi è molto più vario di quello dei
ricavi. Abbiamo costi per le materie prime, per energia, per il personale dipendente e
autonomo, per servizi di impresa (trasporto, manutenzione etc.), per servizi immobiliari
e finanziari. Alcuni costi presentano talvolta caratteristiche di serialità e forti
contrasti di interessi (lavoro dipendente), che li rendono rigidi, difficili da “gonfiare” in
modo da far uscire denaro per il titolare; altre tipologie di costi possono però offrire
notevoli possibilità di manipolazione, con le possibili infedeltà fiscali di cui al par.
3.7.
L’affidabilità delle procedure contabili aziendali dipende molto dalla serialità, dalla
conflittualità potenziale con le controparti, dalla loro possibilità di connivenza, sia
in acquisto sia in vendita. Questa conflittualità potenziale rende rigido il lavoro dipendente, nei termini indicati al paragrafo 3.8, sui “fuori busta” e 8.3 sull’utilizzabilità del
“lavoro totalmente nero” come arma di pressione del lavoratore verso il datore di lavoro;
analoga rilevanza del contrasto d’interessi sarà indicata al par. 8.4 sulle locazioni abitative
“in nero” (il tema delle segnalazioni sarà ripreso anche al par. 9.3, sulla deduzione di
spese di consumo per innestare un “contrasto di interessi” rispetto ai consumatori
finali).
Si tratta di aree amministrative diverse, che si creano man mano che l’azienda
si sviluppa, di solito da un’attività di lavoro indipendente che gradualmente “si ingrandisce” attraverso collaboratori “tecnico-produttivi”, poi “commerciali” (addetti alla
vendita:marketing) e quindi “amministrativi”. Con l’aumento delle dimensioni aziendali, il titolare si concentra sugli affari, delegando all’amministrazione contabile di registrarne i risultati, e i documenti. Al personale amministrativo l’imprenditore attribuisce
funzioni in precedenza svolte da lui personalmente, dove la componente fiduciaria
è fondamentale; lo scopo è di evitare frodi o negligenze, cioè assicurarsi che tutti i
ricavi siano stati registrati, e tutti i crediti incassati, pagando solo i debiti effettivi, ed evitando di farlo due volte. In questo compito, fondamentale per la determinazione della
ricchezza, la creatività, la fantasia, sono secondarie, e la radice del termine “ragionieria”
non riguarda il “ragionamento”, ma il termine latino “rationem”, riferito appunto al
“fare conti”. Si tratta di emettere ordinatamente documenti di incasso, e poi
classificare documenti di spesa, da registrare su libri contabili e conservare, con
una serie di operazioni elementari e ripetitive, dove la meticolosità e lo scrupolo
sono le doti più importanti. È questo il segreto del successo delle aziende come esattori del fisco, più che come ausiliari della mancata registrazione di ricchezza da parte
del titolare.
34
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
Concettualmente si tratta di annotazioni identiche, quale che sia l’importanza dell’evento da registrare, dall’acquisto milionario di un impianto a quello
di un po’ di carta per le fotocopie. Non a caso si teorizzava la quadratura come
strumento di controllo, dove anche minime differenze potevano indicare
errori macroscopici parzialmente compensati: l’uguaglianza costante tra “dare
e avere” era un indizio della mancanza di errori. Oggi questa preoccupazione dei
“conti che non tornano” è stata eliminata dai computers, e il contabile deve
preoccuparsi soprattutto della aggregazione e classificazione dei documenti,
dei passaggi procedurali di controllo, che si ingigantiscono, e si irrigidiscono, con le
dimensioni aziendali.
All’interno dell’amministrazione aziendale si crea quindi un enorme contrasto di interessi, dove il contabile disonesto può anche frodare il suo datore di
lavoro, che si preoccupa più dell’onestà dei dipendenti che della propria evasione fiscale. Mentre il lavoratore indipendente può omettere la registrazione fiscale della ricchezza in proprio, facendo tutto da solo, l’imprenditore in genere
deve esporsi, cioè deve dare ordini parzialmente in controtendenza rispetto
alle proprie necessità di trasparenza e controllo amministrativo; è il “management
overriding”, cioè lo scavalcamento delle procedure amministrative da parte della
proprietà-dirigenza, oppure di suoi fiduciari, che si è disposti a far diventare quasi
complici. Questa difficoltà, unita alle condizioni economiche personali, generalmente floride, dei titolari di aziende pluripersonali, rendono meno probabile
la mancata registrazione fiscale della ricchezza, su cui comunque torneremo al par.
3.7..
Questo uso fiscale della contabilità non deve far dimenticare che la sua funzione
è prima di tutto aziendale, e non fiscale. La contabilità può essere utilizzata fiscalmente, quando c’è e fin dove arriva, tenendo conto che serve al controllo interno,
a non dimenticarsi di chiedere e incassare i ricavi, a non pagare per prestazioni mai ricevute; l’azienda non nasce però per svolgere funzioni di polizia tributaria, ma
per produrre e vendere sul mercato. Non possono quindi esserle delegate eccessive
funzioni improprie tributarie, troppo lontane dall’attività tipica. Va bene utilizzare a
vantaggio del fisco le rigidità amministrative dove ci sono, ma dove mancano
non possono essere create ad arte.
Il legislatore può quindi fare affidamento sulle rigidità amministrativo-contabili, e
trasformare gli organismi aziendali in una specie di “sostituti del fisco”, al punto che da
essi viene una percentuale altissima del gettito tributario (le prime 4000 grandi aziende
portano circa il 60 percento del gettito, su oltre 5 milioni di operatori economici!). Non
è una questione di onestà o disonestà, sentimenti umani, fuori luogo per corpi
sociali come le aziende. Si tratta piuttosto di rigidità, di contrasti di interessi, derivanti
dall’inevitabile ripartizione dei compiti all’interno dell’azienda; l’esigenza extrafiscale
di controllo reciproco apre la via alla visibilità contabile della ricchezza, già indicata
esternalità positiva della tassazione attraverso le aziende. Di cui vedremo adesso l’aspetto
documentale.
Capitolo 3 – DETERMINAZIONE CONTABILE E VALUTATIVA DELLA RICCHEZZA
35
3.3. La riutilizzazione di documenti contabili per la determinazione tributaristica della ricchezza
La base documentale della tassazione attraverso le aziende consiste nei documenti
e nelle registrazioni utilizzate in prima battuta dalla stessa azienda per le proprie finalità
informative interne; su tali documenti si innesta, in seconda battuta, la determinazione tributaristica della ricchezza. Qualche volta esiste solo una registrazione, come
per gli incassi da parte di clienti consumatori finali, ed altre volte esistono documenti,
riepilogati a loro volta in registrazioni sui libri contabili, per gruppi omogenei.
Il libro contabile, quindi, enuncia eventi aziendali elementari, come gli incassi,
o riepiloga documenti sottostanti; sia le registrazioni sia i documenti riguardano i
rapporti interprivati interni all’azienda, rilevanti ai fini dei rapporti con clienti e fornitori, nonché per il controllo interno degli incarichi attribuiti ai vari dipendenti. Anche
qui la tassazione si innesta sulla documentazione “amministrativo-contabile”
dei rapporti economici interprivati, in cui si forma e circola la ricchezza; il diritto amministrativo dei tributi si inserisce quindi sul diritto dei privati, riutilizzandone, e
parzialmente condizionandone, meccanismi e documentazione.; documenti, nati per
fini contabili e civilistici vengono integrati con informazioni ulteriori, di valenza
esclusivamente tributaria; si tratta spesso di informazioni irrilevanti per gli ordinari
rapporti di diritto civile e commerciale tra le parti, ma che occorre inserire per disposizioni tributaristiche, spesso tendenti a contrastare l’evasione, talvolta con gli adempimenti superflui di cui al par. 4.5.
Sono documenti civilisticamente e aziendalisticamente molto informali, che si
trasfigurano in strumenti di diritto amministrativo tributario, per determinare la
ricchezza, propria e di terzi, clienti, fornitori, risparmiatori, consumatori finali; un documento emblematico, tanto per fissare questa riutilizzazione tributaria, è la fattura,
di cui anticipiamo alcune caratteristiche, comprensibili anche prima di aver esposto, al
paragrafo 7.3, il meccanismo dell’imposta sul valore aggiunto.
La fattura è un tipico documento commerciale, ripreso ai fini tributari (paragrafo 7.3); con esso il fornitore manifesta al cliente non solo l’IVA, ma anche
le proprie richieste contrattuali, in esecuzione dei precedenti accordi, spesso solo
verbali. La valenza tributaria della fattura si inserisce quindi su quella commerciale, che
le preesiste, nei rapporti tra le parti. In questo solo documento si fondono gli adempimenti amministrativi, nei confronti del fisco, e le comunicazioni commerciali,
nei confronti della controparte privata; la fattura, conformemente alla prassi contabile, è
un documento non sottoscritto dall’emittente, ma semplicemente redatto su sua
carta intestata, e diretto al destinatario, di cui riporta le generalità. La sua legittimazione
probatoria, come vedremo spesso, e anche in questo paragrafo, non deriva quindi da un
suo formalismo intrinseco, ma nell’inserimento in una attività aziendale e da
una sua verosimiglianza economica.
In prima battuta si potrebbe affermare che la tassazione attraverso le aziende determina la ricchezza in modo “contabile”, ma la contabilità è solo una procedura di
organizzazione di informazioni su quelle relazioni giuridiche, tra fornitori e clienti,
36
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
attraverso cui si forma la ricchezza. Per interpretare e contestualizzare la documentazione aziendale occorre calarla nel contesto della snella formalizzazione corrente dei rapporti giuridici di impresa; le parti, a seconda del tipo di cliente,
del rapporto più o meno fiduciario, o delle caratteristiche qualitative e quantitative
dell’operazione, redigono la documentazione ritenuta più opportuna, contemperando la tracciabilità documentale, le esigenze di cautela verso la controparte e la snellezza gestionale.
La registrazione aziendale dei ricavi ha una rilevanza “confessoria”, secondo cui
se il contribuente ha registrato un ricavo vuol dire che c’è, salve eccezionali ragioni
che rendessero conveniente affermare un ricavo fittizio; il problema – per il fisco –
sono invece ulteriori ricavi non registrati, ma ne riparleremo al par. 3.14, nonché
5.13.
L’idoneità probatoria nella documentazione dei costi deve essere invece contestualizzata rispetto alla prassi commerciale dell’azienda, dove sono rari i contratti solenni; al contrario, la prassi aziendale delle vendite al dettaglio è ispirata agli scambi
informali di “cosa contro prezzo”; i rapporti tra operatori economici, come la generalità degli acquisti aziendali, sono formalizzati con fatture passive, spesso precedute
da moduli prestampati per ricevere gli ordini; tali ordini contengono clausole standard,
continuamente “personalizzate” in base agli accordi fiduciari, specie con controparti
conosciute o affidabili.,
L’adeguatezza probatoria della documentazione aziendale va quindi riferita
agli eventi concreti da rappresentare; astratti formalismi documentali sono infatti fuori luogo per realtà dinamica come le aziende; la credibilità probatoria della documentazione aziendale dipende da valutazioni di normalità aziendale, di “id quod plerumque
accidit” sul comportamento degli operatori economici di una determinata dimensione,
anche in relazione alla tipologia di rapporto da registrare, alla natura dell’acquisto,
alla relazione col fornitore, alle modalità di pagamento, etc.
In genere, è sufficiente una fattura passiva, accompagnata dalle prove del
pagamento, e da un riscontro dei beni ricevuti, se esistono. Qualche volta neppure
si può pretendere una fattura, ad esempio per documenti “anonimi” come biglietti
ferroviari, ricevute autostradali, scontrini per piccole consumazioni, spese sostenute in contesti ambientali (paesi esteri) dove la documentazione è molto più informale che da noi. Questo relativismo documentale emerge anche per le c.d. “fatture per operazioni inesistenti”, cioè documenti materialmente o ideologicamente
falsificati.
Riassumendo, la “prova” delle vicende economiche, sia generali sia corredate
da indizi contabili, è strutturalmente presuntiva (par. 5.8); la sua valutazione,
nelle aziende, dipende dagli eventi da descrivere e dai controlli interni e i “contrasti di interesse” tipici delle catene di comando delle organizzazioni. Un filo conduttore del testo è che la prova, da parte del fisco, della ricchezza non registrata,
è una “prova economica”, cioè di un evento con rilevanza economica su cui, a
maggior ragione, non si possono trasferire i formalismi civilistici degli “atti
solenni”.
Capitolo 3 – DETERMINAZIONE CONTABILE E VALUTATIVA DELLA RICCHEZZA
37
3.4. Ulteriori adempimenti esclusivamente tributari: scontrini, dichiarazioni e versamenti
Le riutilizzazioni tributarie dei documenti civilistici, naturale riflesso della tassazione attraverso le aziende, si completano con adempimenti esclusivamente tributari, come la contabilità dei piccoli commercianti, professionisti e artigiani (par. 3.13),
quella di magazzino o lo scontrino e la ricevuta fiscale (par. 7.7).
L’adeguamento fiscale della documentazione aziendale, e la creazione di nuova documentazione solo fiscale devono tener presente l’impossibilità di esportare la tassazione attraverso le aziende dove l’organizzazione amministrativa manca, e
non ha senso ricrearla per decreto; se un documento è “aziendale” deve giustificarsi con
esigenze gestionali e non fiscali.
Esclusivamente tributari sono invece le dichiarazioni fiscali e i versamenti dei
tributi, oltre che le già indicate contabilità dei piccoli imprenditori e dei professionisti,
previste solo fiscalmente.
Il versamento delle imposte è il più elementare adempimento verso “l’ente creditore”; non basta però pagare, perché l’amministrazione finanziaria, in quanto organizzazione, ha spesso bisogno di informazioni su chi ha pagato determinati tributi e chi no,
in modo che gli inadempienti siano potenzialmente individuabili.
La maggior parte dei pagamenti è quindi accompagnata da alcune informazioni
all’amministrazione finanziaria, che servono anche come “ricevuta di pagamento”
per il contribuente, di cui in genere indicano le generalità.
Ciò avviene in una prima fase attraverso i documenti di versamento; si pensi ad
esempio ai bollettini di conto corrente postale, ai pagamenti presso i concessionari (ad
es. tabaccai) dei circuiti telematici Lottomatica e simili, fino ai modelli unificati bancari (F24) con cui si pagano i principali tributi vigenti, inserendo nel modulo i relativi
codici. In questo modo, l’acquisizione diretta di denaro, assegni o altri titoli di credito,
da parte degli uffici tributari si è ridotta fino ad essere del tutto soppressa, con l’eliminazione (alla fine degli anni novanta del secolo scorso) degli uffici di cassa presso gli
uffici tributari. È un altro riflesso non solo della (positiva) aziendalizzazione e proceduralizzazione della funzione tributaria, ma anche della sua esternalizzazione su circuiti
finanziari esterni, che è un sintomo di rigidità.
La tempistica del pagamento è abbastanza ravvicinata rispetto al momento in cui
i debiti tributari sono determinabili. È quindi del tutto logico che le ritenute, o
l’IVA mensile, debbano essere versate entro il 16 del mese successivo, in quanto sono
determinazioni circoscritte, ormai compiute, salvo conguagli e correzioni, che sono
sempre ammessi (la prima quindicina del mese successivo dovrebbe essere sufficiente,
come periodo cuscinetto, per organizzare i relativi dati e versare il 16). Sulle imposte
da calcolarsi nelle dichiarazioni ci soffermeremo più avanti, a proposito dei sistemi di
“saldo e acconto”. In questo capitolo ci fermiamo alla tempistica “fisiologica” di pagamento, mentre i ritardi e le omissioni saranno trattate al paragrafo 6.11, sulla riscossione
coattiva.
38
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
I modelli di versamento qualificano l’imposta pagata, e indicano le generalità
del contribuente, ma spesso non è ancora una informazione sufficiente, e subentrano le già indicate “dichiarazioni fiscali”. Di esse si sente il bisogno man mano
che la determinazione del tributo diventa più complessa, influenzata da numerose
variabili; gli esempi che molti conoscono sono la dichiarazione annuale dei redditi,
nonché dell’IVA, dell’ICI-IMU, ed altre, vigenti a proposito dei tributi più diversi,
ecc.
La dichiarazione è un classico adempimento di diritto amministrativo, come
i già indicati documenti con funzione esclusivamente tributaria (ricevute fiscali), i moduli di versamento etc... Essa va indirizzata all’ufficio tributario competente per territorio, in relazione alla residenza anagrafica delle persone fisiche o alla sede legale delle
società ed enti.
È quindi manifestamente fuorviante analizzare le dichiarazioni tributarie con
chiavi di lettura di diritto civile e commerciale, radicate cioè nel diritto dei privati.
Questa natura di adempimento amministrativo delle dichiarazioni fu per lungo
tempo trascurata dalle spiegazioni riferite alle categorie concettuali civilistico-privatistiche, delle dichiarazioni di volontà o delle dichiarazioni di scienza, della confessione
e simili; era un riflesso della fuorviante trascuratezza verso la matrice “amministrativistico-economica della tassazione.
Volendo restare alle soluzioni di matrice civilistica, cui è oggi legata la prassi, la
“dichiarazione di scienza” è la meno insoddisfacente perché esclude il contenuto
negoziale della dichiarazione. Il riferimento pecca però di semplicismo, perché si addice
a eventi elementari, e trascura la pluralità di operazioni di registrazione, rendicontazione
e soprattutto di qualificazione giuridica presupposte dalle dichiarazioni in esame.
È quindi più appropriato inquadrare le dichiarazioni nell’ambito del diritto amministrativo dei tributi, in particolare come manifestazioni di giudizio, con una
componente materiale ed una di qualificazione giuridica (cfr. al paragrafo 3.10 la
funzione anche interpretativa demandata ai contribuenti nella tassazione attraverso
le aziende).
Sullo sfondo amministrativistico vanno inquadrate anche le opzioni, ad
esempio tra vari regimi di determinazione della ricchezza, il rimborso o il riporto in
avanti dei crediti di imposta, etc... Si tratta di scelte, demandate al contribuente, e per
questo a prima vista simili a quelle negoziali, ma in un contesto diverso da quello dei
rapporti con un altro contraente, di cui occorre salvaguardare la buona fede, l’affidamento, i preparativi per eseguire una controprestazione. La destinazione delle dichiarazioni non è una controparte specifica, ma un archivio di milioni di documenti, che
nessuno esamina per molto tempo dopo la scadenza del termine per l’opzione. Che
non ha quindi alcun motivo per essere guardato come un feticcio rispetto a successive
correzioni. Che non sono “ripensamenti”, come potrebbero essere definiti quelli di un
accordo contrattuale. Le opzioni, con le loro possibilità di scelta, si inseriscono infatti in
doveri amministrativi previsti “ex lege”. Dove sono normali le distrazioni, le ansie
da scadenza, gli equivoci, una cui correzione non lede affatto le esigenze erariali. Anche
qui però sembra riflettersi la schizofrenia sospettosa che pervade tutto il volume,
Capitolo 3 – DETERMINAZIONE CONTABILE E VALUTATIVA DELLA RICCHEZZA
39
con le amministrazioni pubbliche, preoccupate di essere accusate di fare eccessive concessioni, che si ritengono in dovere di essere al tempo stesso formaliste e sostanzialiste
“pro fisco”.
Il principale terreno pratico, in cui si inserivano le fuorvianti spiegazioni della “natura della dichiarazione”, riguardava le integrazioni, gli errori, di cui indicheremo
subito l’assetto attuale.
Il contribuente può ritrattare in tutto o in parte la dichiarazione, in quanto
errata per eccesso; questa ritrattazione è condizionata a limiti ed esigenze di diritto
amministrativo, come la stabilità del riscosso e la snellezza dell’attività amministrativa
e dei controlli (il termine è quello della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello di riferimento, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/98). Entro questo termine
il contribuente può direttamente auto-liquidare, a proprio favore, le rettifiche rispetto
alla dichiarazione originaria. Dopo questo termine restano le istanze amministrative di rimborso al fisco (art. 38 d.P.R. 602 del 1973 su cui par. 6.7); vanno segnalate,
nell’interpretazione amministrativa e giurisprudenziale, striscianti tendenze restrittive
verso queste rettifiche della dichiarazione, come se il problema della tassazione fosse chi
“dichiara troppo e ci ripensa” anziché chi non dichiara affatto, o dichiara percentuali
irrisorie, senza ovviamente ripensarci.
Anche la possibilità di dichiarare somme ulteriori rispetto a quelle in precedenza dichiarate, per “ravvedersi” e sanare precedenti dimenticanze o consapevoli
evasioni, conferma quest’ottica amministrativistica; è un istituto generale applicabile
anche ai ritardi dei versamenti e di altri adempimenti (art. 13 D.P.R. 472 del 1997 sulle
sanzioni tributarie); il contribuente deve non solo pagare l’imposta, o regolarizzare
l’adempimento omesso, ma anche “autosanzionarsi” e liquidare anche eventuali
interessi, per beneficiare di sanzioni più miti di quelle ordinarie. Equiparare il ritardo
alla omissione indurrebbe infatti il contribuente a non far nulla, confidando nella
bassa probabilità di essere controllato. L’intuitiva condizione per questa procedura
è che non siano iniziati controlli fiscali nei confronti dello specifico contribuente, altrimenti sarebbe troppo comodo evadere pensando di «ravvedersi» dopo l’inizio di un
controllo.
La finalizzazione all’attività di autorità amministrative emerge chiaramente dai “modelli di dichiarazione”, che hanno l’importantissima funzione organizzativa di «filtrare»
in schemi omogenei l’enorme massa di dati annualmente forniti all’amministrazione
finanziaria e da immagazzinare nelle banche dati del fisco, anche ai fini di un efficiente
uso ai fini degli “incroci” tra informazioni diverse (ad es. tra dichiarazione del cliente
sostituto di imposta e del fornitore).
All’interno delle dichiarazioni si trovano dei singoli prospetti (denominati
«quadri»), ciascuno destinato ad essere utilizzato per un determinato tipo di ricchezza o di elemento rilevante per la determinazione del tributo. Tutti parlano di “dichiarazione dei redditi”, spesso rilevando che il relativo modulo è di oltre cento pagine
considerando le istruzioni. Gli interessati devono però compilare solo i riquadri
relativi ai tipi di reddito di cui sono titolari, ad esempio di lavoro dipendente o
autonomo, dei fabbricati, d’impresa, nonché quelli di riepilogo per la condizione perso-
40
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
nale o familiare rilevante ai fini della determinazione dell’imposta (spese mediche, figli
a carico, e altri elementi indicati al par. 9.3).
L’autorità amministrativa, nel predisporre i quadri delle dichiarazioni, cerca di acquisire i dati nel modo più proficuo per la sua attività conoscitiva ed operativa; l’obiettivo è
quello di conoscere le tipologie di ricchezza nel modo ritenuto più utile per la gestione
amministrativa e statistica, anche ai fini degli interventi di politica tributaria.
Le principali dichiarazioni fiscali sono ormai inoltrate per via telematica,
tramite intermediari abilitati, (aziende di credito, dottori commercialisti e altri professionisti, associazioni di categoria e centri di assistenza fiscale su cui par. 3.16); redatte
su schemi conformi a quelli approvati dall’autorità fiscale, le dichiarazioni acquisiranno
consistenza cartacea soltanto con la stampa.
Quando la documentazione contabile era esclusivamente cartacea, né le imprese né
i lavoratori autonomi hanno mai dovuto allegare alla dichiarazione i documenti
giustificativi dei vari elementi del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, come ad
esempio le fatture passive che documentano i costi sostenuti. Con la presentazione telematica delle dichiarazioni, nessun allegato cartaceo ad esse è più richiesto né concepibile. Potrebbe farsi strada, invece, a causa delle nuove possibilità offerte dalla tecnologia,
l’invio al fisco di documenti, persino dell’intera contabilità aziendale, su supporti
ottici.
Tendono ad essere dichiarate con maggiore frequenza, soprattutto da individui
non organizzati, le somme segnalate al fisco da terzi, come i sostituti di imposta. Vedremo infatti (par. 4.6) che l’evasione diminuisce quanto più aumenta
la consapevolezza di una presenza effettiva del fisco, e di una sua possibilità
di intervento; quest’ultimo può essere anche potenziale, ma deve essere percepibile
e sistematico.
Le dichiarazioni più conosciute, come quelle in materia di imposte sui redditi, costituiscono anche la sede per determinare l’imposta dovuta. In questo caso, quindi,
la dichiarazione contiene sia l’autodeterminazione (autoliquidazione) del tributo, sia
un conguaglio con le anticipazioni, come le ritenute d’acconto e gli acconti, versate in
precedenza.
Qualche volta, come accade per la dichiarazione dei sostituti d’imposta o per la
dichiarazione IVA, la dichiarazione serve solo a riepilogare adempimenti che
(di regola) devono essere stati effettuati in precedenza in modo del tutto autonomo (versamenti mensili o trimestrali IVA e versamenti delle ritenute alla fonte
da parte dei sostituti d’imposta); la dichiarazione dei sostituti d’imposta serve anche
a segnalare i percettori al fisco, inducendoli a dichiarare, come vedremo al successivo
par. 3.6.
La dichiarazione è spesso usata come base per versamenti provvisori, c.d. acconti
di imposta,tra cui segnaliamo quelli da effettuare entro i mesi di maggio e di novembre,
commisurandoli alle imposte dovute per l’anno precedente; la dichiarazione dei redditi contiene sempre un prospetto espositivo di questi acconti e dei successivi
conguagli; si noti che primo versamento deve avvenire, entro il 20 giugno, anche se il
termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente, entro il 30 settem-
Capitolo 3 – DETERMINAZIONE CONTABILE E VALUTATIVA DELLA RICCHEZZA
41
bre; ciò comporta un calcolo dell’imposta ai soli fini del versamento e lascia margini
temporali, prima della dichiarazione, per dedicarsi agli aspetti formali, ad esempio le
indicazioni statistiche, estranee al calcolo dell’imposta, sia per “aggiustare il tiro” dei calcoli del tributo. Se infatti, redigendo più correttamente i calcoli, emerge un versamento
eccessivo, questo sarà evidenziato, nella dichiarazione, come un credito compensabile
coi successivi versamenti; se invece il versamento è carente “per difetto” potrà essere
integrato col già indicato “ravvedimento operoso”, che comporta una riduzione della
sanzione per omesso o tardivo versamento, indicata al par. 6.13 e pari al 30 percento
della relativa imposta (art. 13 del d.lgs. n. 472/1997).
Il versamento può avvenire al netto di crediti di imposta, ed anche per contributi
sociali, anche relativi ad altri tributi e contributi. Nell’esternalizzazione della tassazione su aziende e privati, costoro possono trovarsi a credito per un tributo, e a debito
per altri, con facoltà di “compensazione amministrativa”, da esercitare unilateralmente nei modelli di versamento dei tributi. Anche se denominata “compensazione”, questa facoltà non deve essere confusa con la compensazione civilistica, che
avviene davanti al giudice, in via di eccezione, all’interno di una controversia. Nel
nostro istituto amministrativistico non c’è una controversia, ma un coordinamento
tra debiti e crediti relativi a una pluralità di tributi diversi, applicati per di più con
continuità nel tempo. Per evitare abusi, da parte di chi fa valere crediti fittizi, sono
previste una serie di cautele, la cui trattazione (tecnicistico-professionale) esorbita dai
limiti del presente manuale.
Il contribuente che si trovi in difficoltà finanziarie, può chiedere la rateazione
automatica di quanto dovuto, a tassi di interesse e per periodi massimi previsti dalla
legge, che riprenderemo al par. 6.11.
3.5. Tassazione attraverso le aziende di ricchezza di terzi:“contribuenti
di diritto” e “di fatto” tra rivalse, ritenute, segnalazioni e controversie private con oggetto tributario
La tassazione attraverso le aziende riguarda prevalentemente a ricchezza di terzi,
anche perché le aziende non hanno un proprio patrimonio personale; esse tassano
chi ha a che fare con loro, in quanto consumatore, lavoratore, risparmiatore, o persino titolare-imprenditore.; basti pensare alle ritenute fiscali alla fonte per i lavoratori
ed all’IVA applicata ai consumatori, che vedono entrambi l’azienda come strumento
del fisco. La “tassazione attraverso le aziende” si ricollega in questo alle tassazioni del
passato (par. 1.3), quando si utilizzavano i corpi sociali per colpire chi vi apparteneva, o i commercianti per tassare i consumi; ciò conferma la tendenza del potere
amministrativo tributario di chiedere le imposte concentrandosi nei punti in cui la
ricchezza, è individuabile, con minore sforzo. Rispetto al passato, quando era
necessario un forte impulso amministrativo, la tassazione di terzi attraverso le aziende
“funziona da sola”, almeno nella misura in cui le aziende sono complesse, organizzate
e quindi affidabili.
42
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
Emerge quindi la frequente differenza tra chi ha rapporti con l’amministrazione finanziaria, denominato “contribuente di diritto” (tipicamente “l’azienda”), e il
titolare della ricchezza colpita dal tributo, cioè il contribuente di fatto, senza rapporti, o con rapporti residuali, con l’amministrazione tributaria, come il consumatore,
il risparmiatore o per molti versi (vedi infra) il lavoratore. È la conferma di un tradizionale sfasamento tra la controparte giuridico-amministrativa degli uffici tributari,
identificata in base alla concentrazione della ricchezza, e i soggetti, molto più numerosi
e frammentati, cui tale ricchezza si riferisce.
Sia ai “contribuenti di diritto”, sia ai “contribuenti di fatto”, manca qualcosa rispetto al contribuente in senso pieno, cui è al tempo stesso riferibile la manifestazione
di ricchezza e l’obbligo di pagare il tributo al fisco, essendo soggetto direttamente (e
non attraverso terzi) a controlli in caso di inadempienza. L’espressione “contribuente
(soltanto) di diritto” già sottintende che il soggetto non è anche “contribuente di fatto”, cioè titolare della ricchezza cui il tributo si riferisce; l’espressione “contribuente di
fatto” spiega ancora più facilmente che egli sopporta solo il carico economico del
tributo, senza esser direttamente gravato da adempimenti verso il fisco né intrattenere
relazioni dirette con esso.
Le espressioni “contribuente di fatto” e “di diritto”fanno pensare solo al pagamento
del tributo, in quanto furono coniate prima della tassazione attraverso le aziende, e prima dell’esternalizzazione, sui contribuenti, della penetrante serie di obblighi di diritto
amministrativo descritti ai paragrafi 3.3-3.6, non riconducibili al solo “pagamento del
tributo”. Oggi vi si sono aggiunti altri adempimenti come segnalare al fisco le generalità dei fornitori, nella dichiarazione dei sostituti di imposta (paragrafo successivo),
le certificazioni delle ritenute, ed altri obblighi di diritto amministrativo (come era già
dall’origine il pagamento del tributo).
Il fornitore al consumo finale, ad esempio il venditore per l’IVA, è “contribuente di diritto” (cioè interagisce col fisco) in luogo del cliente consumatore finale,
come nei modi indicati in questo paragrafo. Chi eroga invece somme rilevanti ai fini
del reddito di propri fornitori, soprattutto di lavoro (dipendente o autonomo, cioè in
senso ampio collaboratori) è contribuente di diritto per le “ritenute alla fonte”,
di acconto o di imposta, che approfondiremo al prossimo paragrafo su “sostituto” e
“sostituito”.
In entrambi i casi siamo di fronte a istituti di diritto amministrativo, impossibili da
sistematizzare con spiegazioni civilistiche. Quest’ottica “civilistico-processuale”, trascurò la spiegazione più a portata di mano del sostituto e del responsabile di imposta, cioè
quella di soggetti tenuti ad adempimenti di diritto amministrativo, imposti
dalla legge in relazione a determinate operazioni economiche di diritto privato; tali adempimenti di diritto amministrativo si insinuano nei rapporti civilistici tra
clienti e fornitori, finendo in parte per condizionarli nei modi che diremo.
Un primo condizionamento si ritrova nei meccanismi con cui il contribuente di diritto si rivale, sul contribuente di fatto, per l’ammontare del tributo. I
meccanismi per trasferire sui contribuenti di fatto il peso economico delle imposte, appartengono alla categoria generale della «traslazione». Mentre la traslazione è
Capitolo 3 – DETERMINAZIONE CONTABILE E VALUTATIVA DELLA RICCHEZZA
43
un concetto economico, la richiesta dell’imposta al contribuente di fatto è
denominata giuridicamente “rivalsa”; civilisticamente sarebbe una forma di
“regresso”, con cui chi paga una somma a beneficio economico di altri, chiede
loro di essere rimborsato, ovvero la acquisisce in anticipo, inglobata nel proprio
corrispettivo, come vedremo al par. 7.3 per l’IVA. Un concetto giuridico di diritto
amministrativo, come l’imposta, entra quindi a far parte di negoziazioni tra i privati,
condizionate da profili tributari.
La rivalsa può essere talvolta solo economica, come nel caso delle imposte di
fabbricazione, fino al diritto (talvolta persino obbligo!) di rivalsa giuridica, come
nell’imposta di registro dovuta dal notaio o nell’IVA. Nella traslazione economica, che
tutti hanno sperimentato almeno per la benzina, l’imposta entra a far parte indistintamente del prezzo, attraverso il quale viene messa a carico del consumatore. In questi
casi il fornitore, che agisce nel ciclo delle vendite, dovrà attivarsi per ottenere, dal contribuente di fatto (in genere un consumatore finale), l’importo dell’imposta – ad esempio sul valore aggiunto – dovuta al fisco. Non è solo il caso dell’IVA o delle imposte
sui consumi, ma può essere anche quello dell’imposta di registro dovuta dal notaio, o
dell’imposta di bollo dovuta dalla banca.
In tutti questi casi possono esserci contrasti tra contribuente di diritto e contribuente di fatto sul regime fiscale applicabile all’operazione. Analoghe controversie
possono verificarsi quando il contribuente di diritto deve effettuare, in qualità di “sostituto d’imposta”, ma ne parleremo al prossimo paragrafo nei dettagli..
Il caso più uniformemente risolto in giurisprudenza riguarda l’IVA, dove il cliente, intenzionato a contestare l’imposta addebitatagli dal fornitore, ad esempio perché
ritiene applicabile una esenzione o una aliquota inferiore, deve resistere davanti al
giudice civile, cui può anche chiedere la restituzione di IVA che, a suo avviso, il fornitore ha erroneamente applicato. Già intravediamo rischi di contrasto tra giudizio
civile e tributario, che ritroveremo per i rapporti tra sostituto e sostituito nelle imposte sui redditi (dove esiste una situazione giurisprudenziale altalenante di cui diremo al
prossimo paragrafo). L’atteggiamento giurisprudenziale univoco, nell’IVA, che nega la
possibilità del cliente di rivolgersi al fisco, si spiega col tentativo di concentrare sul solo
fornitore i rapporti con l’amministrazione finanziaria.
3.6. Segue. Il sostituto d’imposta come strumento di tassazione delle somme erogate a terzi (ritenute alla fonte tra funzione esattiva e segnaletica)
Esiste però anche il ciclo inverso a quello (tipico delle imposte sui consumi) descritto al paragrafo precedente, in quanto le aziende (paragrafo 3.1) non solo acquisiscono consumi, ma restituiscono elementi di reddito ai rispettivi fornitori. Qui il
contribuente di diritto, tipicamente l’azienda, ha ricevuto una prestazione da quello
“di fatto” (tipicamente il dipendente), verso il quale è debitore. Si inserisce a questo
punto la legislazione tributaria, imponendo al debitore di saldare una parte del proprio
44
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
debito non già al creditore, ma al fisco. Emerge così la figura del “sostituto d’imposta”,
come debitore di somme costituenti reddito per il percettore, denominato «sostituito»,
come vedremo più avanti; Il sostituto, per esercitare la rivalsa, “non ha bisogno
di chiedere”, perché può direttamente trattenere, “alla fonte”, cioè in sede di pagamento del proprio debito, la somma che deve versare al fisco. Che appunto si chiama
«ritenuta alla fonte», attraverso la quale viene esercitata la già indicata rivalsa sul contribuente di fatto.
Il sostituto d’imposta si colloca generalmente nell’ambito dei tributi sui redditi,
erogati dal sostituto medesimo. Il sostituto, nella tassazione attraverso le aziende ed in
un’ottica amministrativistica, “sostituisce il fisco”, che gli “chiede di chiedere le imposte” ai percettori di somme da lui stesso erogate, e che concorrono a formare il reddito dei beneficiari. Sulle somme erogate al percettore (“sostituito”), e che concorrono
a formarne il reddito, il sostituto deve operare le ritenute alla fonte, che possono
essere – come vedremo subito – d’imposta o d’acconto.
La ritenuta alla fonte era originariamente, in un sistema di imposte “reali”
(paragrafo 9.2), a titolo definitivo, chiamata oggi “a titolo d’imposta”, come è
ancora per molti redditi finanziari (par. 8.5); questa ritenuta “definitiva”, esaurisce
il prelievo tributario, e sotto certi profili costituisce una vera e propria «imposta
sostitutiva».
Anche se il sostituto avesse, di fatto, omesso l’applicazione della ritenuta medesima, il fisco recupererà perciò, insieme alle sanzioni e agli interessi, solo l’importo della
ritenuta evasa, ma non le imposte ordinarie.
Se effettuata invece “a titolo d’acconto”, la ritenuta alla fonte costituisce, come
emerge dalla sua stessa denominazione, un prelievo provvisorio; in buona sostanza si
tratta di una anticipazione rispetto alle imposte dirette (IRPEF od IRES, capitolo 9),
dovute sul complesso dei redditi del percettore (c.d. “sostituito”).
I relativi proventi concorrono perciò a formare il reddito secondo le regole generali,
al lordo della ritenuta, poi confrontata con l’imposta complessiva, con diritto al
rimborso delle eventuali eccedenze o versamento delle ulteriori imposte dovute (è
la tipica operazione definita «di conguaglio» tra le anticipazioni e l’imposta definitivamente calcolata, cfr. paragrafo 3.4).
Le ritenute a titolo di acconto nacquero, trasformando alcune precedenti ritenute
a titolo di imposta, con l’obiettivo di realizzare la “tassazione personale progressiva” di
cui al già indicato par. 9.2. Esse ebbero però effetti ulteriori, che nessuno aveva adeguatamente previsti. Le ritenute d’acconto sui redditi di lavoro dipendente aumentarono a
dismisura il numero delle dichiarazioni tributarie da gestire, soprattutto con riferimento
ai lavoratori dipendenti con “altri redditi ed oneri deducibili” (par. 3.4, 3.16 sull’assistenza professionale e 5.5 sul controllo di correttezza formale). La ritenuta d’acconto,
inoltre, segnalava all’autorità fiscale il reddito che vi era assoggettato, dissuadendo il
percettore dall’ometterne la dichiarazione; la ritenuta d’acconto è diventata così, forse
casualmente, un’architrave della tassazione attraverso le aziende.
In genere le ritenute sono applicate con aliquote proporzionali, differenziate per tipologia di redditi (lavoro autonomo 20%, capitale 15% etc.), mentre
Capitolo 3 – DETERMINAZIONE CONTABILE E VALUTATIVA DELLA RICCHEZZA
45
per i redditi lavoro dipendente, dove il rapporto con l’erogante è continuativo,
la ritenuta d’acconto è infatti progressiva tentando di farla coincidere con
l’imposta dovuta, in assenza di altri redditi, consentendo di non presentare alcuna
dichiarazione (i dati affluiranno all’anagrafe tributaria attraverso la già indicata dichiarazione del sostituto d’imposta). Per questo, alla fine dell’anno il sostituto dovrà
effettuare (art. 23 comma 3) il conguaglio tra le ritenute operate mensilmente e
quelle dovute sui complessivi compensi del periodo. La ritenuta progressiva è basata quindi sulle aliquote IRPEF, ragguagliando al periodo di paga (ad es. il mese)
i relativi scaglioni annui e le detrazioni d’imposta. La ritenuta resta comunque di
acconto come conferma l’ipotesi in cui il percettore abbia altri redditi, oneri deducibili, etc.
Tra i redditi soggetti a ritenute definitive d’imposta ricordiamo gli interessi bancari
ed obbligazionari percepiti da persone fisiche (paragrafo 8.5) nonché i redditi erogati a
soggetti non residenti, per redditi che si considerano prodotti in Italia, secondo quanto
rilevato al paragrafo 7.18.
Sono considerati sostituti di imposta tutti gli operatori economici, in forma
individuale o societaria, più le organizzazioni non commerciali (art. 23 comma 1 d.P.R.
600/1973. Anche piccoli commercianti, artigiani, e professionisti, spesso senza alcuna
organizzazione, devono quindi svolgere tutti gli adempimenti del sostituto d’imposta,
magari solo per lo stipendio erogato all’unico commesso, alla cassiera o all’apprendista,
se non addirittura per la parcella erogata al commercialista che li assiste.
Prima di tutto il sostituto deve effettuare la ritenuta (attraverso la quale adempie
anche il già indicato obbligo di rivalsa sul sostituito), da versare entro brevi termini all’erario, indicando poi nella dichiarazione dei sostituti d’imposta le generalità dei
percettori di somme soggette a ritenute di acconto, segnalati così all’amministrazione
finanziaria; ciò induce i percettori a dichiarare a loro volta, anche per scomputare le
relative ritenute..
Le ritenute devono essere effettuate al momento del pagamento del corrispettivo e seguono quindi il criterio di cassa, che ritroveremo per l’imputazione della
ricchezza al periodo di imposta. In relazione a tale momento sono individuati anche il
versamento della ritenuta e l’indicazione del provento nella dichiarazione dei sostituti
d’imposta.
Ai fini dello scomputo della ritenuta di acconto da parte del sostituito non rileva,
invece, il relativo versamento da parte del sostituto. Il percettore viene infatti privato delle relative somme con la rivalsa e non può essergli addebitato il successivo
omesso versamento del sostituto, che tra l’altro egli non può controllare.
Le ritenute effettuate devono essere versate cumulativamente per tipologia, tramite delega bancaria (il c.d. modello amministrativo f24) entro il 16 del mese successivo
a quello di effettuazione.
L’omessa applicazione di ritenute definitive di imposta è sanzionata solo sul sostituto,
con una responsabilità solidale del percettore, ove la ritenuta non sia stata neppure versata. L’omessa applicazione della ritenuta d’acconto comporta invece intrecci complessi
tra la posizione del sostituito e quella del sostituto, tra i quali non c’è una coobbliga-
46
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
zione solidale, trattandosi di importi e di titoli di pagamento diversi; tuttavia esistono
modalità per evitare duplicazioni di prelievo.
Il sistema basato sulle ritenute e le rivalse, tutto sommato, “funziona”, assicurando
un gettito adeguato al bisogno della macchina pubblica italiana. Non ci si è però chiesti
perché l’efficienza di, non si è accompagnata una analisi delle ragioni per cui era difficile
trasferire l’efficienza di questi meccanismi su altre tipologie di ricchezza. Nessuno si è
accorto della funzione segnaletica della ritenuta d’acconto, nella tassazione attraverso
le aziende, è di come essa fosse stata intralciata proprio dalla originaria funzione esattiva delle ritenute d’imposta. Non sono stati quindi progettati strumenti per portare le
segnalazioni al fisco su elementi reddituali dove la ritenuta non era praticabile, per le
ragioni che diremo subito. La ritenuta d’acconto, soprattutto con le elevate aliquote
inizialmente utilizzate, è infatti praticabile solo per attività ad elevato valore aggiunto,
concetto intuitivo, ma comunque definito al paragrafo 7.6.
La ritenuta può essere infatti commisurata solo al corrispettivo erogato dal
sostituto, unico dato che l’erogante con certezza conosce. Per le attività a basso valore
aggiunto, le ritenute d’acconto potrebbero sottrarre risorse finanziarie al sostituito, con
ingenti crediti di imposta, ed immobilizzi finanziari. Per chi avesse un margine di utile
del 20 percento rispetto ai costi, la ritenuta praticata sui corrispettivi lordi assorbirebbe
l’intero reddito, trasformato in un credito verso il fisco, con grandi problemi finanziari
e di rimborso. Per questo la ritenuta d’acconto è prevista solo su attività, ripetiamo “ad
alto valore aggiunto”, dove i costi sono irrilevanti (lavoro dipendente e capitale) oppure
sono solitamente modesti, come il lavoro artistico o professionale.
Per le attività d’impresa, in genere a valore aggiunto più basso, la ritenuta fu
invece tendenzialmente esclusa, senza però essere sostituita con altre segnalazioni
al fisco. La cui mancanza di informazioni a riguardo rende abbastanza frequente, da
parte di lavoratori indipendenti d’impresa (senza ritenuta) e piccole aziende padronali
la mancata registrazione delle fatture emesse (è un filo conduttore che riprenderemo ai
paragrafi 5.13 e 9.3 sul c.d. contrasto di interessi).
Questa sostituzione delle segnalazioni alle ritenute, si è verificata solo episodicamente, attraverso gli elenchi clienti e fornitori (poi soppressi), nelle rare ipotesi di
“contrasto di interessi”, e poi, recentemente e oltre una certa elevata soglia (3000
euro), per raccogliere dati finalizzati al c.d. “spesometro” (par. 5.14, in una sorta di
elenco fornitori “oltre una certa soglia”). Comunque, fuori dal sistema delle ritenute
d’acconto, mancano segnalazioni aggregate e mirate, idonee ad indurre ad una corretta autotassazione, facendo intravedere ai contribuenti un potenziale e sistematico
intervento del fisco sul “lavoro indipendente d’impresa” (sull’utilità di una segnalazione sistematica del lavoro indipendente da parte delle aziende clienti vedi anche
infra, par. 5.13).
Veniamo alle liti tra sostituto e sostituito, che riprendono quelle, analizzate al
precedente paragrafo, tra contribuente di diritto e di fatto. Il soggetto che subisce le
ritenute alla fonte, d’imposta o d’acconto, ha la materiale possibilità di chiedere l’integrale pagamento del suo credito; il sostituto potrà eccepire di aver pagato il suo debito
trattenendo e versando al fisco la ritenuta da lui considerata applicabile; potrebbe però
Capitolo 3 – DETERMINAZIONE CONTABILE E VALUTATIVA DELLA RICCHEZZA
47
essere caduto in eccesso di zelo, ed assoggettare a ritenuta somme che – ad avviso del
sostituito – non lo sarebbero state affatto. È stata qui concepita una azione civile del
percettore (contribuente di fatto) verso il sostituto d’imposta (contribuente di diritto),
chiedendo l’integrale pagamento del credito, ed investendo incidentalmente di una
questione tributaria il giudice civile; quest’ultimo avrebbe dovuto interpretare la norma fiscale per stabilire se la ritenuta fosse applicabile o meno; il sostituto condannato
dal giudice civile non necessariamente avrebbe prevalso nell’eventuale successiva lite
con l’amministrazione finanziaria, nel qual caso si sarebbe trovato esposto a pagare due
volte tale somma, una prima volta all’amministrazione e una seconda volta al sostituito.
Ecco perché la giurisprudenza sul punto è stata altalenante, tendendo spesso a negare al
percettore-sostituito, cui spetta per legge esplicita azione di rimborso verso il fisco, una
parallela azione civile verso il sostituto; l’unico antidoto, contro ritenute cervellotiche
avrebbe potuto essere un’azione di risarcimento danni nei confronti del sostituto che,
per superficialità o eccessiva prudenza, fosse stato eccessivamente cauto, ferma restando
la necessità di rivolgersi alle commissioni tributarie per ottenere il rimborso della ritenuta.Tuttavia di recente è riemersa una tendenza della cassazione ad ammettere l’azione
civile suddetta, per l’integrale pagamento del credito del sostituito, da parte del sostituto,
con possibile contrasto di giudicati.
Tra le controversie private con oggetto tributario segnaliamo l’accollo contrattuale, o convenzionale, d’imposta; nei rapporti tra privat, cui è connesso un tributo, ciascuna delle parti può cercare di porlo a carico dell’altra. Ciò potrebbe avvenire
tramite una mera maggiorazione di prezzo (c.d. «traslazione economica dell’imposta»), cui si accompagnano però, talvolta, pattuizioni specifiche, secondo cui civilisticamente le imposte ricadevano su una delle parti. Tali clausole, operando solo tra le
parti, non limitano i poteri amministrativi del fisco, che potrà rivolgersi ai debitori
indicati dalle leggi tributarie; tra le parti, tali clausole sono state considerate lecite
dalla giurisprudenza maggioritaria, che le considera mere determinazioni del
corrispettivo (sulle liti tra privati aventi ad oggetto “responsabilità di imposta” vedi
invece il paragrafo 6.3).
3.7. La ricchezza fiscalmente non registrata, a beneficio dei titolari di organizzazioni aziendali (ipotesi sulla “grande evasione”)
In quanto corpo sociale intermedio, come indicato al par. 3.1, le aziende sono
prive di bisogni personali, cui destinare ricchezza fiscalmente non registrata. Anche affermare che la grande azienda è rigida, e quindi non nasconde ricchezza
al fisco, benché esatto, è fuorviante, in quanto paragona individui e organizzazioni.
Queste ultime invece non hanno una sfera privata, non mangiano, non si vestono, non
hanno mogli, figli né hobbies; al limite le aziende nascondono ricchezza al fisco per
i bisogni aziendali “non ufficiali”, non confessabili, indicati al prossimo paragrafo 3.8,
tra cui corruzioni e tangenti. Le persone fisiche con un ruolo proprietario (soci
di maggioranza della società che possiede l’azienda) hanno invece bisogni personali,
48
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
e spesso sono in grado di soddisfarli anche sottraendo ricchezza al fisco, a propri fini
privati. La destinazione di entrambi questi fenomeni a persone fisiche conferma che
anche la ricchezza non registrata, come tutta quella che transita per l’azienda, è
destinata a persone, siano esse dipendenti, finanziatori, soci, locatori di immobili,
etc.
Le aziende seguono anche una evoluzione, verso la spersonalizzazione della proprietà, che però nel capitalismo italiano rimane personale e familiare, spesso in capo
agli eredi del fondatore. Il fondatore gestisce l’azienda, e per definizione la conosce
come le sue tasche, ma anche i successori hanno spesso, di diritto o di fatto, un ruolo
organizzativo-direzionale molto intenso. Le procedure aziendali, in questa fase, sono
spesso state disegnate, per evitare malversazioni e negligenze, dallo stesso titolare,
che può scavalcarle abbastanza facilmente; dopotutto è verosimile che ex muratori o
ex pasticceri, divenuti industriali delle costruzioni o imprenditori dolciari, cerchino di
perpetuare comportamenti di quando erano “lavoratori indipendenti” (par. 3.13). È
un fenomeno simile al “management overriding della teoria aziendalistica anglosassone, solo che qui il “titolare” ha, in quanto tale, un potere superiore a quello dei
dirigenti. È quindi frequente che l’azienda sia un mezzo per la determinazione
della ricchezza, verso consumatori, dipendenti, risparmiatori, etc., e un mezzo per
nasconderla al fisco a beneficio del titolare. Se tutto il sistema si regge sulla “tassazione attraverso le aziende”, si può ipotizzare anche una “evasione” (cioè ricchezza non
registrata) attraverso le aziende.
È qui che, in termini di ricchezza non registrata, può innestarsi la “grande evasione”,
che peraltro neppure compare nelle stime macroeconomiche, su cui par. 4.1. Forse il fenomeno è modesto, in termini macroeconomici in quanto questi individui sono pochi
rispetto al totale degli operatori economici. Forse, per via dell’utilità marginale decrescente del denaro, al crescere dell’organizzazione, è possibile soddisfare adeguatamente
le necessità personali (sia pure cospicue) pagando le imposte.
L’azienda non è, per i soggetti in esame, un mezzo di sostentamento analogo alle
attività di lavoro indipendente, giustificata solo se fonte di reddito per chi la svolge; il
titolare di organizzazioni pluripersonali prima di tutto ha in genere risorse
economiche adeguate al proprio mantenimento, e poi non svolge personalmente
attività specifica, demandata al personale, ma si dedica all’azienda anche solo per salvaguardarrne il valore di avviamento (par. 7.13); per questo anche un pareggio fiscale
o un reddito modesto appaiono verosimili, a differenza di quanto accade per un
lavoratore indipendente. L’esame di ragionevolezza esterna, significativo per il lavoro
indipendente (par. 5.13) non fornisce qui indicazioni particolari.
Per quanto probabilmente poco diffusa, e forse irrilevante sul piano del gettito,
quest’evasione ha una vasta portata simbolico-politica per le cifre che individualmente può coinvolgere. Sono ipotesi che generano imbarazzo, perché riguardano
figure economicamente di rilievo, oggetto già di una certa invidia sociale, con riflessi
di cui al capitolo 4.. Anche il solo sospetto di una quota apprezzabile di ricchezza non
registrata da parte di chi è già visto come “ricco”, crea lacerazioni e recriminazioni da
parte dei lavoratori indipendenti, che evadono “tanto di poco”, come sinteticamente
Capitolo 3 – DETERMINAZIONE CONTABILE E VALUTATIVA DELLA RICCHEZZA
49
indicato sopra, sono una cospicua parte della pubblica opinione e si sentono “sotto accusa” (paragrafo 4.6 ss.).
La geografia fiscale delle “organizzazioni aziendali” presenta 50 mila aziende da 20 a
50 addetti e 150 mila da 10 a 20 addetti. In questi casi è verosimile un forte coinvolgimento personale del titolare in ruoli direttamente operativi, anche se l’azienda
ha ormai una certa autosufficienza. È abbastanza normale che costui non sia facile da
tassare attraverso la sua stessa azienda, che invece tassa dipendenti e consumatori. Anche
nelle 22 mila aziende da 50 a 250 addetti e nelle 3500 con oltre 250 addetti, il coinvolgimento operativo della proprietà è tutt’altro che raro, con margini di manipolabilità
della ricchezza, anche se qui il c.d. “capitalismo familiare” è sempre meno bisognoso di
questi artifici, e si affianca ad aziende controllate da gruppi multinazionali, enti pubblici
o con una compagine sociale variegata, cioè con una certa dialettica societaria, magari
due-tre gruppi di soci. Man mano che le dimensioni crescono, allontanano la proprietà dalla gestione, ostacolando ulteriormente i suddetti tentativi di scavalcare le
procedure per nascondere ricchezza al fisco.
In generale, anche dove ne esistono le condizioni, è ipotizzabile che non si tratti
di quote significative di ricchezza anche perché, con il passaggio alle seconde, e terze,
generazioni, gli eredi sono da un lato benestanti, senza particolare bisogno di nascondere ricchezza al fisco dall’altro hanno meno familiarità nella gestione e disponibilità a
rischiare di esporsi col personale aziendale nel solito già indicato “management overriding”.
Controllare la ricchezza non registrata in questa vasta area intermedia tra lavoro
indipendente e azienda pienamente spersonalizzata richiede, da parte degli uffici tributari, capacità valutativa, disponibilità ad esporsi, e assunzione di responsabilità, le
stime della ricchezza non registrata da parte di titolari di aziende “medio-piccole” non
seguono infatti nozioni diffuse di esperienza comune, paragonabili a quelle formulabili
per il lavoro indipendente, dove già gli uffici sono molto restii ad esporsi (par. 5.13); per
questa ipotetica ricchezza non registrata, i margini di errore sono maggiori; è possibile
cercare con esito negativo, salvo scoprire frodi per eventi fortuiti sopravvenuti;
come disattenzioni fortuite dei contribuenti, legate a indagini bancarie estere, a liti
familiari o societarie. È anche utile l’accertamento in base alla spesa, e al tenore di vita,
quando i redditi palesi, pur apprezzabili, risultano palesemente insufficienti alle spese
pazze cui spesso questi soggetti vanno incontro, come vedremo al par. 5.14.
Anche qui, tuttavia, c’è timore di indagare verso la ricchezza non registrata, con
argomenti anche qui presuntivi, indicati al par. 5.13. In caso di indagini infruttuose,
infatti, una successiva emersione dell’evasione, per vicende familiari o societarie,
farebbe nascere sospetti di negligenza, o peggio; questo rende riluttanti gli uffici
tributari a indagare in questo senso, disperdendosi invece verso le inutili contestazioni
interpretative, come vedremo al par. 5.18. Queste ultime sono il surrogato con cui le
istituzioni cercano di rispondere alla diffusa sensazione della pubblica opinione secondo
cui, anche all’interno dei ceti imprenditoriali del “capitalismo familiare”, sia frequente
la ricchezza non registrata; magari non moltissima sul piano macroeconomico, ma con
un forte valore simbolico sul piano politico-mediatico.
50
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
Le possibilità del titolare di scavalcare, a proprio personale beneficio, le procedure
aziendali dipendono dalla familiarità del titolare con l’azienda, ma anche dal
suo settore operativo. In alcuni casi sarà possibile anche scavalcare la funzione di
incasso dei ricavi aziendali. Benché questa funzione sia una delle prime a proceduralizzarsi, per esigenze di controllo, il titolare potrà mantenere margini quando l’azienda
svolge poche prestazioni di rilevante valore unitario, ad esempio nell’edilizia di lusso o
nella nautica. Può anche essere possibile agire in due tempi, dapprima controllando
i dipendenti, assicurandosi che tutti gli incassi vengano registrati. Poi, quando il titolare
o il suo fiduciario restano soli col contante, o con assegni, ne omettono parzialmente
la registrazione.
Per i pagamenti ricevuti con moneta elettronica (carte di credito) occorre studiare
in quale misura possono essere utilizzati conti di appoggio “non ufficiali”. Non ci
dilunghiamo su altre possibilità più rischiose e spregiudicate, di cui le cronache hanno
offerto esempi concreti. Qualche volta la ricchezza non registrata “risale dal basso”,
quando il cliente è un ambulante o un negoziante che a sua volta evade “al consumo
finale”, e quindi cerca di non essere gravato da un’IVA sugli acquisti che non potrebbe detrarre, avendo intenzione di non registrare le proprie vendite; può accadere
nei settori dei generi alimentari, dei prodotti tessili o per la casa, come vedremo al
termine del par. 7.3.
I ricavi sono parzialmente sottratti al fisco anche quando vengono interposte società intermedie, falsamente indipendenti, intestate a prestanome-fiduciari.
Queste ultime concentrano presso di sé il profitto e quindi lo stornano all’imprenditore,
in una posizione uguale e contraria alle analoghe interposizioni che vedremo tra un
attimo per i costi. Talvolta è possibile “dirottare” sul titolare dell’azienda erogazioni
straordinarie, come gli sconti dei fornitori, oppure pagamenti parziali da parte dei clienti a fronte di rinunce a crediti, per insolvenza, da parte dell’azienda.
Non sempre, nelle organizzazioni, anche piccole, sussistono le suddette condizioni
di omettere ricavi agendo “da sopra”; spesso infatti le relative procedure aziendali
sono impossibili da “scavalcare” persino per una proprietà aziendale che non voglia
destare sospetti; questo per l’elevata frammentazione delle vendite, la loro gestione
seriale, etc...
Questo spinge gli imprenditori intenzionati a nascondere ricchezza al fisco verso
una via più rischiosa all’esterno, ma aziendalmente più gestibile, cioè la registrazione
di costi totalmente o parzialmente fittizi; metaforicamente, agendo sui ricavi la
ricchezza veniva tolta “da sopra”, mentre per i costi si tratta di farlo “da sotto”, con
documenti di spesa in tutto o in parte fittizi; sono comportamenti che lasciano tracce
in contabilità, e quindi fiscalmente più rischiosi, ma che interferiscono meno con le
procedure gestionali dell’azienda.
Mentre i ricavi provengono da prestazioni tipologicamente omogenee, e rigidamente proceduralizzate, le materie prime e i servizi necessari alla produzione sono più
diversificati; al loro interno al titolare è più facile inserire eventuali documenti
fittizi, purché verosimili; la struttura amministrativa, una volta liberata dal sospetto di
negligenza verso l’azienda farà il proprio lavoro senza porsi domande di sorta, e senza
Capitolo 3 – DETERMINAZIONE CONTABILE E VALUTATIVA DELLA RICCHEZZA
51
sospettare il già indicato “management overriding” del titolare. Per evitare
questi sospetti del personale, il titolare deve astenersi da intromissioni in procedure standardizzate, come quelle relative alle materie prime, procedendo su altri
acquisti meno consueti, non proceduralizzati; basta infatti la verosimiglianza del
costo, e l’avallo del titolare, per mettere in pagamento la relativa fattura, non solo senza
discutere, ma neppure senza sospettarne una totale o parziale fittizietà.
Questa registrazione di spese fittizie spesso richiede una collaborazione esterna,
cioè un percettore che poi lo retroceda alla proprietà aziendale. I sistemi possono essere differenti, a partire dalla complicità di fornitori “fidati”, che per loro motivi
non pagano imposte, ad esempio perché “non commerciali, esteri, in perdita cronica
o in regime forfettario; costoro possono gonfiare i prezzi di acquisto per importi
successivamente retrocessi ai titolari dell’azienda, in modo riservato, dai contanti ai
conti esteri.
Senza affidarsi alla “riservatezza” di una controparte reale, che potrebbe un
giorno usare queste informazioni per indebite pressioni (temute soprattutto da chi ha
un certo prestigio imprenditoriale da salvaguardare), si creano società apparentemente indipendenti, interposte rispetto ai fornitori reali ed in mano a fiduciari
o prestanome dell’imprenditore; queste società possono interporsi tra l’azienda e le
controparti effettive, in genere fornitori, praticando un prezzo maggiorato rispetto a
quello del fornitore. Gli uffici di contabilità aziendale non hanno motivi per ulteriori indagini a vantaggio del fisco: se i beni sono arrivati in magazzino, nella quantità
indicata sulla fattura, nessuno entra nel merito della congruità del prezzo, rispetto a
quanto si sarebbe potuto ottenere presso altri fornitori; non c’è poi motivo per simili domande, soprattutto se l’acquisto è stato gestito integralmente dal titolare, con
controparti di fiducia.
Mentre la ricchezza non registrata dai “lavoratori indipendenti” di cui al precedente
paragrafo 4.1 viene in gran parte spesa per consumi, quella descritta in questo paragrafo
viene anche “tesaurizzata”; buona parte di essa si forma direttamente all’estero, senza
venirvi portata in un secondo tempo; i relativi fondi esteri potranno poi garantire, sempre dall’estero, finanziamenti o investimenti finanziari del titolare effettivo nelle aziende,
in eventuali momenti di difficoltà.
Rinviamo al paragrafo 6.12, sull’evasione da riscossione, le strategie evasive tendenti a rendersi nullatenenti, lasciandosi dietro, senza pagarli, i debiti fiscali e contributivi.
3.8. Costo dei tributi, “cunei fiscali”, concorrenza sleale e ricchezza non
registrata per finalità aziendali
Se le aziende sono “organizzazioni” prive di bisogni personali, a differenza dei loro
titolari, non avvertono le imposte come costo in sè, secondo quanto indicato al par.
1.5 sulla differenza tra “tassazione attraverso le aziende” e “autotassazione”. Su questo
presupposto occorre esaminare criticamente la diffusa affermazione secondo
52
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
cui molte aziende, se pagassero tutte le imposte, dovrebbero chiudere. Le imposte
sul reddito dell’azienda non sono “un costo”, ma una quota di ricchezza determinata
“al netto” dei costi, cui non è soggetto chi è in perdita o chiude a zero; questa affermazione in parte trasla sulle aziende, anche per le imposte sui profitti, l’atteggiamento dei
lavoratori indipendenti, che valutano la convenienza del proprio lavoro in relazione al
reddito al netto delle imposte.
Il problema non sono le imposte sul reddito dell’azienda, dopotutto un anticipo di
quelle dei suoi titolari (par. 7.17), ma quelle connesse alla funzione economica delle
aziende come “filtro” della ricchezza, che acquisiscono consumi ed erogano redditi. Nel
noto “filtraggio di ricchezza” le imposte provocano un “cuneo” tra l’azienda e
i suoi interlocutori, come emerge dalla stessa espressione “cuneo fiscale”, diffusa nel
dibattito politico-economico. Tra quanto spende il consumatore e il ricavo aziendale
c’è una differenza (cuneo) rappresentata dall’IVA, e tra il “costo del lavoro” e il salario
netto c’è il tipico “cuneo fiscale” (di contributi e ritenute) citato nel dibattito politico.
Le imposte non sono quindi costi “in sé”, ma decrementi di ricavi o aggravi di costi.
È un riflesso dell’utilizzazione dell’azienda come esattore su ricchezza economicamente
riferibile a terzi, secondo quanto già anticipato ai par. 3.5-3.6 sul contribuente di fatto
e di diritto.
Le iniziative legislative sulla “riduzione del cuneo fiscale”, sono velleitarie in quanto,
come rilevato al par. 1.3, la maggior parte della ricchezza fluisce alla maggior parte della
popolazione, relativamente povera; tuttavia per l’equilibrio economico aziendale, o per
mettere da parte risorse da attribuire ai proprietari delle aziende (paragrafo precedente),
c’è la tendenza a “sabotare” i compiti esattivi delle aziende.
Il meccanismo di “convergenza di interessi” più a portata di mano è con i lavoratori
dipendenti; questi ultimi, nelle piccole organizzazioni, chiedono spesso di ricevere “in
nero” lo straordinario e il lavoro festivo, semplicemente perché il maggior reddito verrebbe falcidiato dalle aliquote fiscali, e farebbe spesso superare le soglie reddituali cui
sono condizionati gli esoneri da tickets, gli assegni familiari e altre provvidenze dello
stato sociale. In questi casi i lavoratori dipendenti, nelle realtà paternalistiche del “piccolo capitalismo familiare” praticamente impongono la remunerazione degli straordinari
“fuori busta”; l’alternativa, per pagare “in bianco” il dipendente, è tenerlo indenne dalle
controindicazioni suddette, aumentando la remunerazione degli straordinari, con un
costo aziendale proibitivo.
Il bisogno di “pagare in nero” sorge anche per remunerare il “secondo lavoro” di pubblici dipendenti, non remunerabile come tale per via dell’esclusività del
rapporto di pubblico impiego. Sono esempi di soggetti che effettuano prestazioni utili
all’azienda, ma non possono o non vogliono comparire, e questo vale anche per
divi dello spettacolo o rinomati calciatori, che un tempo pretendevano di essere pagati
in modo occulto, o con sostanziose erogazioni “in natura” (case, autovetture, etc.).
C’è anche chi, per abbassare i costi del lavoro dipendente spinge i dipendenti
a costituire cooperative e consorzi, spesso promossi tra lavoratori senza nulla da
perdere, che non versano contributi sociali né ritenute fiscali; è una via “fatta in
casa” al taglio del costo del lavoro abbattendo gli oneri fiscali e contributivi.
Capitolo 3 – DETERMINAZIONE CONTABILE E VALUTATIVA DELLA RICCHEZZA
53
Analogo schema serve a ridurre i costi di acquisto delle merci, attraverso le
“frodi IVA” indicate al termine del par. 7.3, per rendere l’azienda molto più competitiva sui prezzo.
A questa tipologia di erogazioni rispondono anche quelle “sollecitate” da manager
di importanti aziende clienti, o personaggi pubblici, che non possono essere remunerati
per varie ragioni; abbiamo qui un punto di contatto tra tassazione e corruzione, dove
le tangenti devono essere “coperte” da giustificativi ricevuti a titolo diverso (è
un altro caso di “evasione aziendale”, in cui l’organizzazione “paga” per essere avvantaggiata o “non sfavorita”). Si pensi a costi di consulenza, provvigioni, intermediazioni
o sponsorizzazioni verso determinate controparti, con cui l’interlocutore dell’azienda è
collegato, senza che l’azienda ne sappia nulla. A questo schema appartengono, al limite,
anche le estorsioni di gruppi criminali, i quali tuttavia manifestano un sorprendente pragmatismo, visto che i giornali hanno parlato di cosche mafiose che, a fronte del
“pizzo”, procuravano “regolari fatture”.
Su scala molto più ampia, possono essere riportate a questa tipologia anche le sovvenzioni erogate, in molti paesi, da grandi società multinazionali, a gruppi politici, persino insurrezionali, ostili ad un governo ostile all’azienda. La necessità di “giustificare”,
nella contabilità aziendale, queste erogazioni, con un motivo parzialmente diverso non
deriva da esigenze fiscali, ma da un imbarazzo di immagine (si tratta anche qui di una
genuina esigenza aziendale, che prescinde dal profilo tributario).
Per i dirigenti aziendali coinvolti in questi flussi di ricchezza non registrata, costretti a mentire a beneficio di terzi, si creano gravi imbarazzi. Per loro il problema
non è tanto la violazione fiscale, quanto il coinvolgimento nella manovra di risorse
“fuori bilancio”, coi sospetti di vantaggi personali, il rischio di essere “scaricati” dalla
loro stessa azienda, se qualcosa dovesse andare storto e mettere a repentaglio il suo buon
nome.
L’evasione dei redditi propri, o anche dell’IVA su ricavi modesti, derivanti in
buon parte dal lavoro del titolare, altera la concorrenza in modo molto inferiore,
perché qui non abbiamo “organizzazioni”, ma lavoratori indipendenti, per i quali le
imposte in esame non sono “costi di produzione”, bensì “quote di valore aggiunto”.
La mancata registrazione fiscale del profitto è “già profitto”, che si trova “a valle” della
formazione del prezzo, per queste attività “flessibili”, dove i comportamenti sono tutti
sostanzialmente omogenei, e quindi la “concorrenza sleale” da evasione non si avverte.
Un idraulico che paga le tasse, e al tempo stesso vuole vivere decorosamente, dovrà
fare prezzi maggiori di un idraulico che, per vivere decorosamente, nasconde ricchezza al fisco, solo che le differenze tendono a sfumare a parità di condizioni, in quanto
tutti profittano della possibilità, se esiste, di nascondere un po’ di ricchezza
al fisco.
Se si omogeneizzano le attività economiche, la questione della concorrenza sleale da
evasione si sdrammatizza fortemente. Perché i comportamenti tendono ad assomigliarsi tra operatori economici omogenei. Anticipando quanto diremo al par. 4.6,
l’accusa di concorrenza sleale fa parte dell’uso ideologico-retorico dell’evasione fiscale
come strumento denigratorio degli operatori economici e delle aziende; che in questo
54
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
modo vengono tendenziosamente accusati di non rispettare neppure i propri stessi
valori di “libera concorrenza” e “competizione”, inquinandoli con la “concorrenza da
evasione”.
Tra settori dimensionalmente eterogenei non è detto che “l’evasore prevalga”,
come dimostra la sconfitta di operatori flessibili, che facilmente potevano nascondere
ricchezza, da parte di soggetti rigidi più efficienti con un peso dei costi fissi inferiore
rispetto a un dettagliante. La fortuna economica può però girare, ed oggi, con la crisi
e la proletarizzazione dei ceti medi, stanno riprendendo quota gli ambulanti, “i mercatini”, i “pakistani col transit”, totalmente in nero, senza costi di struttura e senza
costi fiscali, che diventano competitivi anche con la grande distribuzione nella
misura in cui riescono ad evitare di essere incisi dall’IVA, ma questo è solo uno spunto
per altri approfondimenti.
Appartiene invece all’evasione aziendale, in senso ampio e senza occultamento
di imponibili, la violazione interpretativa cioè l’inquadramento giuridico di ricchezza registrata nelle forme più convenienti per l’azienda; ne parleremo ampiamente
ai paragrafi successivi, a proposito delle “contestazioni interpretative”.
3.9. Qualificazione giuridica della ricchezza registrata e logiche dell’interpretazione nella tassazione attraverso le aziende (le “simmetrie
concettuali” tra soggetti diversi e tempi diversi)
La registrazione della ricchezza, da parte delle aziende e dei privati, comporta
una qualificazione giuridico-tributaria di quanto registrato, anch’essa necessariamente svolta in prima battuta dai contribuenti. Anche qui c’è un margine di
valutatività, che anche nei casi facili, risolti d’istinto in modo fulmineo, logicamente
esiste benché impercettibile. Questi margini di valutatività dell’interpretazione
variano con le solite graduali sfumature delle scienze sociali, dipendendo dall’applicazione della legislazione a un caso; l’incertezza non sta infatti nella regola
giuridica, ma nella sua applicazione a un qualche caso; ogni disposizione legislativa
di senso compiuto è almeno in un caso “chiarissima” e viceversa persino le disposizioni elementari possono dar luogo, in casi particolari, a disquisizioni interpretative
interminabili.
Su questo sfondo vengono allo scoperto gli argomenti interpretativi letterali e sistematici, fatti di logicità, coerenze spesso molto numerose, fino a creare quella che in altra
sede ho definito “discrezionalità interpretativa”; si tratta di una mediazione complessa
tra spunti letterali e logico-sistematici, dove non rilevano le priorità etico-politicosociali e contano profili concettuali, intellettivi, argomenti interpretativi letterali, sistematici, logici.
Anche l’interpretazione è quindi “valutazione”, riferita però a fatti pacifici tra
le parti, la cui controversia riguarda qui questioni di diritto, da risolvere con i suddetti
argomenti interpretativi di natura letterale e sistematica, variamente combinati tra loro
secondo le tecniche dell’ermeneutica; si tratta dei consueti parametri di fondatezza,
Capitolo 3 – DETERMINAZIONE CONTABILE E VALUTATIVA DELLA RICCHEZZA
55
letterale e sistematica, tipici dell’interpretazione giuridica, spesso molto ingarbugliati e
complessi.
Con queste caratteristiche, l’interpretazione è abitualmente riferite a un organo indipendente, come il giudice, nel diritto dei privati; qui invece spetta anche
all’autorità amministrativa, e prima ancora alle aziende e ai privati, nel contesto
dell’autotassazione. I privati e gli uffici non sono però nella stessa posizione di
indipendenza del giudice, ma esposti anche ad altre pressioni: i privati ad utilizzare
i margini suddetti per avvalorare, nei limiti del possibile, le soluzioni in concreto più
convenienti, sia sul piano del tributo, sia degli adempimenti amministrativi, del rapporto con le controparti, della snella gestione dell’azienda. È normale e legittimo che
contribuenti, e uffici, davanti ai margini dell’interpretazione, tengano conto
in una certa misura di convenienze personali, aziendali o istituzionali, come il
“risultato di servizio” delle pubbliche amministrazioni; per entrambi non si tratta
insomma di una interpretazione del tutto indipendente, “super partes”; l’importante è
mantenere buona fede, senza forzature strumentali.
Si intrecciano, in materia tributaria, due interpretazioni in un certo senso “di parte”, quelle dei contribuenti e degli uffici. Iniziamo dalla prima, rinviando la seconda al
paragrafo successivo.
La determinazione giuridica di concetti economici rappresenta quindi
la prima “ratio legis” delle disposizioni tributarie che l’interprete deve tenere in
considerazione.
Questa specie di “stella polare” di tutte le questioni interpretative costituirà un filo
conduttore del volume, su cui si innesta anche la valutazione dei termini civilistici in chiave economico-tributaria; la determinazione della ricchezza ai fini
tributari, cioè la precisazione dei concetti economicamente rilevanti indicati al par.
1.8, passa anche per l’individuazione, attraverso la documentazione aziendale, di concetti giuridici civilistici, come “vendita”, «mutuo», «proprietà», «socio», diritto reale,
«locazione»,”risarcimento del danno”, ecc.. Rapporti e concetti del diritto civile
o di altri settori giuridici (anche di diritto dei poteri pubblici), regolati ai fini contrattuali “inter partes”, diventano strumenti per i concetti economici rilevanti ai fini
della determinazione tributaristica della ricchezza. Da elementi di autonomia
negoziale, cioè “atti di volontà”, diventano elementi della fattispecie economica cui si
riferisce la normativa tributaria sulla determinazione tributaristica della ricchezza (si
tratta della c.d. “digressione degli atti in fatti”, di cui parlava anche Massimo Severo
Giannini).
Quest’utilizzazione di termini civilistici da parte della legislazione tributaria si è generalizzata da quando la tassazione attraverso le aziende consente di analizzare,
attraverso la documentazione contabile descritta ai primi paragrafi di questo capitolo,
i rapporti giuridici di diritto sostanziale (ad esempio civile e commerciale). La
finalità di questa analisi è però la determinazione tributaristica della ricchezza.
Questo diverso contesto d’uso può influenzare l’interpretazione dei termini indicati
sopra, in quanto le singole espressioni linguistiche vanno anche interpretate
nel contesto in cui si inseriscono; questo non esclude la rilevanza interpretativa
56
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
del significato civilistico dei termini, da calare però nel contesto della determinazione tributaristica della ricchezza. Quest’interpretazione in funzione della determinazione della ricchezza non è “economicistica”, ma è pur sempre di diritto, però di
“diritto tributario”.
Sullo sfondo della determinazione della ricchezza si inserisce la solita dialettica tra argomenti interpretativi letterali e sistematici, desumibili dai valori
rilevanti per la determinazione della ricchezza, indicati al par. 1.9, come precisione,
semplicità, effettività, certezza dei rapporti, controllabilità, cautela contro gli abusi
(par. 3.10).
Quest’interpretazione economicistico-funzionale va quindi mantenuta nei
limiti della legislazione, senza avallare estemporanee tassazioni senza base legislativa
di qualche fenomeno per cui – nel caso singolo – le informazioni sussistono. Anche
l’“interpretazione economico-funzionale” è infatti giuridica, e non può prescindere
da come la legislazione ha cristallizzato le consuete esigenze sulla determinazione della
ricchezza.
Quanto precede vale non solo per i termini civilistici, ma anche per gli accordi
contrattuali di ogni genere, le operazioni societarie, i bilanci aziendali, la collocazione
di attività o società in un paese o in un altro, i concetti del diritto amministrativo
generale, delle sovvenzioni pubbliche, delle disposizioni regolatorie, in materia di
comunicazioni, trasporti, energia, sanità, istruzione, commercio internazionale e via
enumerando. Tutti questi aspetti giuridici “extratributari” diventano, secondo la già
indicata gianniniana digressione degli atti in fatti, nel nostro caso strumenti per la
determinazione tributaristica della ricchezza. Vanno pertanto contestualizzate a questi fini le affermazioni della dottrina e la giurisprudenza civilistica, o
comunque extratributaria, che originariamente, nella loro sede propria, si pongono
sotto profili del tutto diversi da quelli della determinazione della ricchezza
ai fini tributari.
Mentre la ricchezza non registrata comporta “questioni di fatto” (par. 3.7 e 5.13)
l’interpretazione costituisce “questione di diritto sostanziale”, attinente cioè
al successivo inquadramento giuridico delle questioni di fatto; le questioni di diritto
sostanziale tributario, quindi, attengono alla qualificazione della ricchezza registrata, o
palese, ai fini della determinazione dei tributi.
Sono le questioni cui si indirizza tutta la parte seconda del testo, più frequenti da
quando sono aumentate, per via della tassazione attraverso le aziende, le questioni interpretative, un tempo frequenti soprattutto nei tributi sugli atti giuridici solenni (par.
1.3 e 10.2).
In questa prima parte del testo, occorre però segnalare in generale un elemento comune all’interpretazione delle questioni di tassazione aziendale. Si tratta delle coerenze
contabili tra soggetti diversi, come fornitori e clienti, nonché tra periodi di
imposta diversi; mentre in passato, con la tassazione valutativa attraverso gli uffici (paragrafo 1.3), ogni contribuente andava per conto proprio, oggi tra contribuenti diversi
e periodi di imposta diversi c’è una notevole interdipendenza dei meccanismi
impositivi della tassazione attraverso le aziende. Molti regimi fiscali si spiegano
Capitolo 3 – DETERMINAZIONE CONTABILE E VALUTATIVA DELLA RICCHEZZA
57
per la presenza di regimi fiscali passati o futuri, uguali e contrari, in capo agli stessi
soggetti o alle loro controparti. Dalla sintesi di questi flussi di ricchezza emerge – per
differenza – la ricchezza che giustifica l’imposizione fiscale, come reddito, consumo o
valore aggiunto.
Ne ritroveremo esempi nel regime dei beni di impresa, con le sue continuità
e discontinuità, nel coordinamento tra tassazione di società e soci, nella neutralità dell’IVA rispetto al consumo, nell’imputazione a periodo, negli aspetti fiscali
delle valutazioni di fine esercizio, nelle operazioni straordinarie, nella tassazione
internazionale, tutti argomenti trattati al capitolo settimo.
Queste simmetrie non vanno ovviamente assolutizzate, pretendendo che ogni regime fiscale sia giustificato da un simmetrico regime, uguale e contrario, applicabile alla
controparte sullo stesso elemento di ricchezza.
Ogni contribuente, infatti, ha un suo status soggettivo, che non può essere
alterato da quello della controparte: ad esempio un costo di acquisto di gioielli e
mobili antichi sarà deducibile, per un’impresa antiquaria, anche se il venditore è un privato che non realizza redditi, in base a quanto rilevato al par. 8.6 sui redditi diversi. Analogamente, il reddito di portinai, colf e badanti è imponibile anche se non è deducibile
per il condominio o la famiglia erogante (lo stesso vale –su scala molto più ampia – per
tutti gli stipendi dei pubblici impiegati). Il reddito – per il percettore – è imponibile
anche se non dedotto dall’erogante.
Le simmetrie sono molto più chiare quando il fornitore è un operatore
economico, il cui ricavo è un consumo se il cliente non è un operatore economico,
mentre se lo è rappresenta “un costo di produzione”. Di norma il costo o il consumo
del cliente sono ricavi per il fornitore, ma ripetiamo che un costo resta deducibile anche
quando il ricavo per il fornitore non rileva fiscalmente.
Nell’interpretazione non ci sono solo i margini valutativi “ex post”, perché è
possibile una “previsione interpretativa”, in cui determinati obiettivi economici vengono realizzati giuridicamente in uno tra vari modi possibili anche in
funzione di una convenienza, personale o aziendale. Quest’ultimo profilo è
importante per le aziende, organismi impersonali in cui le stesse ragioni che ostacolano la mancata registrazione di ricchezza ai fini tributari rendono importante la
“pianificazione fiscale” di quella registrata, cioè la scelta di regimi che minimizzino
il carico tributario. Per questo è del tutto normale che un certo obiettivo aziendale
sia realizzato utilizzando consapevolmente “ex ante” determinati strumenti
giuridici piuttosto che altri, anche in funzione della convenienza tributaria.
All’interno dell’organizzazione, i responsabili della fiscalità devono contemperare due
esigenze, cioè salvaguardare l’azienda da sanzioni (par. 6.13). È il riflesso della tendenza aziendale all’efficienza, che sussiste dalla produzione, al marketing, alla finanza, alla
gestione dei rapporti fiscali. In parole povere, i managers aziendali temono di essere
accusati dai loro colleghi, magari interessati a minarne la posizione aziendale, di
aver pagato imposte eccessive rispetto a quelle legalmente dovute. Pur essendo
una preoccupazione secondaria nelle aziende, rispetto al prodotto, l’ottimizzazione
fiscale è importante in quanto si riflette appunto sulla convenienza della produzio-
58
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
ne, e sulle modalità organizzative. La degenerazione di questi comportamenti è la
violazione dello spirito delle leggi, cioè l’elusione fiscale, di cui parleremo però al
successivo paragrafo 3.10, anche a proposito delle “convenienze interpretative” degli
uffici tributari.
Ultimiamo ora le riflessioni generali sull’interpretazione, a proposito dell’analogia, che è una particolare forma di interpretazione, utilizzata quando
esistono «lacune», cioè è impossibile «risolvere una controversia facendo riferimento a una specifica disposizione di legge» (art. 12 preleggi). Quando si tratta di
«norme impositrici», sull’imponibilità o meno di un certo fenomeno, la soluzione a favore dell’intassabilità è obbligata, senza necessità di colmare lacune
tramite l’analogia. La lacuna, in questi casi, non c’è, perché in mancanza di una
disposizione la controversia è già risolta per la non tassabilità; i principi generali
sull’analogia sono quindi sufficienti ad escludere la sua utilizzabilità per tassare
fenomeni che non lo sono.
Quando invece qualcosa è tassato, ma ci sono lacune sulle modalità di tassazione, come pure sulle relative procedure, l’analogia non trova ostacoli di sorta.
3.10.Segue: Evasione interpretativa, pianificazione fiscale ed elusione
come tipici comportamenti aziendali (rinvio alle contestazioni interpretative come “diversivi istituzionali”)
La ricerca dell’inquadramento giuridico-tributario più conveniente, da
parte delle aziende e dei contribuenti in genere, qualche volta può portare a delle
forzature. Dove cioè gli elementi dell’interpretazione, gli spunti letterali e logici
indicati al paragrafo precedente sono combinati in modo discutibile, o addirittura
forzato, cioè sostenibile, ma erroneo rispetto ad altre interpretazioni più rispondenti
alla consueta combinazione di lettera e spirito delle norme. Ne risultano dubbi interpretativi che spaziano, secondo varie sfumature intermedie, da soluzioni “certamente
esatte” a quelle altrettanto “certamente sbagliate”. Tra questi estremi si collocano le
controversie interpretative tra fisco e contribuenti. È la c.d. “evasione interpretativa” connessa all’inquadramento giuridico di ricchezza registrata, o
palese, senza occultamento di imponibili, ma con forzature intenzionali, o errori, di
tipo interpretativo.
Anche se è adottata, per convenienza tributaria, una interpretazione erronea, non
viene qui materialmente occultata ricchezza; questi casi non rappresentano
la realtà in modo distorto, ma tendenzialmente giocano a carte scoperte. Le loro
forzature interpretative devono essere corrette, però non è questo, come indicato al
par. 4.1, il problema della determinazione della ricchezza in Italia, perché l’allarme
sociale deriva invece dalla ricchezza non registrata. Solo che, siccome quest’ultima è
difficile e imbarazzante da trovare, le contestazioni interpretative diventano soluzioni di ripiego anche per gli uffici tributari, in vista della “copertura” e del “risultato di servizio”, parametri rilevanti per “l’immagine sociale” delle istituzioni, come
Capitolo 3 – DETERMINAZIONE CONTABILE E VALUTATIVA DELLA RICCHEZZA
59
vedremo al par. 5.3; anche da queste contestazioni emerge infatti una “maggiore
imposta accertata”, e sono più facili da formulare e meno responsabilizzanti sul piano
della stima della ricchezza non registrata. Viene quasi il sospetto che qualche volta
queste contestazioni per “questioni di diritto”, siano gradite a uffici che temono
di esporsi nelle sfuggenti quantificazioni della ricchezza non registrata, o a imprenditori preoccupati della possibile scoperta di ben più gravi rilievi sul fronte
della ricchezza non registrata. Per questo, come vedremo al capitolo 5 (spec.te
par. 5.7, 5.11.5.17 ss.) molte risorse disponibili per i controlli sono state distolte dalla
vera emergenza tributaria italiana, secondo le quantificazioni indicate al par. 4.1, cioè
la ricchezza non registrata.
L’interpretazione del fisco è imparziale, ma non indipendente, essendo influenzata dai parametri generali indicati al par. 5.3, e dalle tensioni sociali sull’evasione, indicate al capitolo 4. Ne derivano suggestioni e condizionamenti “ambientali”, in
termini di “risultato di servizio”, con la solita esigenza di copertura individuale
verso sospetti di negligenza e corruzione; ci sono poi convenienze operative, come
l’impegno necessario a motivare una determinata pretesa la coerenza con altre soluzioni
adottate in precedenza, le possibili discussioni con colleghi che, in casi simili, si comportano diversamente, etc...
Le colpe della ricchezza nascosta ricadono quindi sulla reinterpretazione di
quella registrata sempre riconducibile all’equivoco concetto di “governo della legge”, che asseconda il desiderio di “copertura normativa” (par. 5.3). Per questo gli
uffici seguono, sulla ricchezza registrata, l’interpretazione “più fiscale”, come diversivo rispetto alle difficoltà valutative sulla ricchezza non registrata; questa inutile
casistica di contestazioni interpretative assorbe una quota eccessiva delle risorse
degli uffici tributari, come vedremo al par. 5.7. Inoltre molte contestazioni di
diritto addirittura spesso dovrebbero finire “a somma zero”, quando le
maggiori imposte accertate su un contribuente sono state pagate da altri, o lo saranno, a seguito delle simmetrie ragionieristiche indicate al paragrafo precedente
(per esempi par. 5.18).
Tra le contestazioni di diritto, spiccano quelle sull’“elusione fiscale”, dove le
regole sono rispettate nella forma, ma violate solo nello spirito; è un’applicazione al diritto amministrativo dei tributi della figura generale della frode alla
legge o dell’abuso del diritto, espressioni che in questa sede possiamo considerare
analoghe; in entrambi i casi sostanzialmente si aggira lo spirito della legge, con scappatoie giuridiche, conosciute nel diritto privato soprattutto per tentativi di aggirare
norme indisponibili a tutela delle c.d. “parti deboli”, ad esempio il lavoratore, il debitore, l’inquilino, etc.
L’etimologia dell’elusione è proprio quella di “prendersi gioco” dello spirito del
sistema. L’elusione consiste in un abuso (non a caso è chiamata anche “abuso del diritto”) delle lecite possibilità di scelta del contribuente, anche in funzione di
convenienza fiscale, tra i regimi giuridici diversi offerti dall’ordinamento per inquadrare
la ricchezza registrata. La legittima scelta del regime fiscale più conveniente degenera
in elusione quando tradisce lo “spirito del sistema”,spesso profittando delle sim-
60
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
metrie e delle correlazioni tra regimi fiscali, di soggetti diversi, e di periodi diversi, che
caratterizzano la tassazione attraverso le aziende.
Questi artifici giuridici, effettuati alla luce del sole e senza alcuna falsità materiale o ideologica, possono essere contrastati prima di tutto con l’interpretazione sistematica economico-sostanziale; tale interpretazione considera, senza
stravolgerle, le esigenze di determinazione della ricchezza, che ispirano la normativa
tributaria, con i suoi compromessi tra precisione, certezza, semplicità, effettività, indicati al par. 1.9.
In questo modo è spesso possibile contrastare il comportamento elusivo prima
che nasca. Quando ciò non è possibile, tutti i paesi tendono a consentire all’autorità
fiscale di disconoscere, in modo personalizzato, il vantaggio, formalmente legittimo, ma
sostanzialmente indebito, conseguito dal contribuente attraverso le scappatoie suddette.
In Italia una disposizione legislativa (l’art. 37-bis d.P.R. 600, introdotto nel 1997) si è
sovrapposta ad una successiva tendenza giurisprudenziale, che ha considerato immanente nell’ordinamento una analoga possibilità (il c.d. “abuso del diritto”, vagamente
giustificato in base ai principi costituzionali).
Le tematiche elusive hanno carattere sostanziale, in quanto riguardano l’inquadramento giuridico di questioni materialmente rappresentate al fisco in modo fedele, ma
inquadrate nella normativa tributaria forzandone la “ratio”, lo spirito. L’elusione resta,
come tutte le questioni di diritto, una questione “sostanziale”, cioè sull’inquadramento
della ricchezza registrata, in funzione di esigenze di semplicità/precisione/cautela fiscale, etc.; è una normale questione di diritto che involge lo spirito del sistema,
e comporta valutazioni interpretative che non hanno nulla a che fare con quelle
procedurali sull’impiego dell’attività degli uffici, tipiche delle disposizioni procedimentali.
Nessuna disapprovazione sistematica è configurabile per la scelta delle possibilità
strutturali e fisiologiche che il sistema tributario offre, tutte collocate su un
piano di pari dignità. Ad esempio, se la legge vuole che un bene venga detenuto
per un certo periodo di tempo per maturare un regime fiscale vantaggioso, venderlo
un attimo dopo, anche se è stato fatto per motivi fiscali, rispetta la “ratio legis”, non la
aggira, ma la rispetta, sia nella forma sia nella sostanza.
Il vantaggio fiscale va considerato nel suo complesso, perché spesso, ad esempio
guardando agli anni precedenti o successivi, o ad altri soggetti (paragrafo 2), apparenti
vantaggi sono controbilanciati da corrispondenti pagamenti d’imposta. Si elude quindi un principio del sistema e per stabilirlo occorre una attenta valutazione comparativa dei principi, cioè dei bilanciamenti tra precisione, semplicità, cautela fiscale,
certezza dei rapporti, e tutti gli altri profili variamente contemperati dalla legislazione
fiscale di settore. L’applicazione di una disposizione antielusiva richiede una grande
sensibilità e padronanza nell’estrarre un principio, dando valenza sistematica ad alcune disposizioni, come la tassazione delle plusvalenze latenti al momento
della chiusura del ciclo fiscale d’impresa, il divieto di commercio delle perdite, il divieto di conseguire maggiori valori fiscali a fronte di operazioni societarie «neutre»,
etc... Nella misura in cui la padronanza condivisa delle logiche sistematiche è debole
Capitolo 3 – DETERMINAZIONE CONTABILE E VALUTATIVA DELLA RICCHEZZA
61
e il clima è drammatizzato (par. 5.17) c’è il rischio di contestazioni grossolane,
come la stravagante idea secondo cui il contribuente dovrebbe scegliere sempre il
regime più oneroso, a meno di avere valide ragioni economiche per sceglierne
uno più conveniente.
Non è al momento agevole prevedere l’orientamento futuro dei giudici e degli stessi
livelli più alti dell’amministrazione fiscale verso questa preoccupante degenerazione
del concetto di elusione; è una degenerazione che si salda con la cultura del sospetto,
indicata al paragrafo 5.17, verso le grandi organizzazioni: ci sono poi il disorientamento
tipico degli uomini di legge verso gli equilibri numerici e concettuali degli uomini di
azienda, e soprattutto la comodità di procedere a tavolino, semplicemente disquisendo
sulle vicende dichiarate, e sulla possibilità di regimi giuridici alternativi, sollevando polveroni solo apparentemente di senso compiuto, ma proprio per questo paradossalmente
difficilissimi da contestare (paragrafo 6.5).
Per tutte le operazioni presenti nell’elenco di cui all’art. 37 bis comma 3, gli accertamenti sembrano far derivare una presunzione di elusione, per addossare subito
al contribuente l’onere di provarne “valide ragioni economiche”, senza che il
fisco adduca l’aggiramento dei principi del sistema, indicando quale sarebbe il
vantaggio fiscale indebito. Le «valide ragioni economiche» sono invece una
esimente, imitando le diverse strade seguite dalla giurisprudenza di «common law». Il
concetto di «valide ragioni economiche», introdotto come ulteriore salvaguardia per
il contribuente, sta diventando il punto di riferimento di improvvisate scorciatoie interpretative dove diventa elusivo tutto quello che dà l’impressione di non avere valide
ragioni economiche alle spalle. Ne derivano, intuitivamente e da ambo le parti, atteggiamenti ipocriti, fortuiti e di facciata.
Si mette in crisi in questo modo la stessa necessità che il contribuente, su cui è esternalizzata la tassazione, non solo registri la ricchezza, ma la qualifichi giuridicamente, nei
termini indicati al par. 3.10. Questa esternalizzazione implica necessariamente la
possibilità di scegliere, tra i vari regimi giuridici, anche in base alla convenienza
fiscale, salvo tradire lo spirito del sistema. È un circuito distruttivo sulle organizzazioni aziendali, che strutturalmente mirano a conoscere le opportunità fiscali consentite,
distinguendole da quelle elusive. Queste ultime non sono mai state un problema comparabile a quello della ricchezza non registrata e, come indicato al par. 4.1, neppure sono
quantificate dalle stime dell’evasione.
Tuttavia per alcuni anni il formalismo legalistico, unito alla mancanza di una disposizione legislativa antielusiva, spinse ad operazioni molto spregiudicate, proposte
da banche d’affari e studi di consulenza, magari avallate da pareri pro veritate di
studiosi che in pubblico predicavano rigorismi antievasione. A partire dal 2005, con
riferimento a periodi d’imposta anteriori all’introduzione della già menzionata legislazione antielusiva, le censure amministrative verso queste operazioni furono avallate
dalla cassazione con riferimento alla già indicata figura di “abuso del diritto”, anche
non codificata; l’abuso del diritto non è che un altro modo per indicare i comportamenti elusivi senza esporsi all’obiezione secondo cui la legislazione ha vietato l’elusione solo successivamente. Da allora le operazioni di pianificazione fiscale aggressiva
62
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
sono rapidamente diminuite (anche se lo sarebbero state comunque, vista l’introduzione del già citato art. 37 bis), ma nelle aziende si è anche sparso un clima
di grande incertezza del diritto, anche per operazioni pienamente conformi alla
logica dei rispettivi sottosistemi tributari. Il fondamento dei vecchi fenomeni elusivi
era tipicamente aziendale, e diverso dalla mancata registrazione fiscale della ricchezza,
in quanto bisogna ricordare dal par. 3.7 che l’azienda non ha bisogni personali da alimentare con la ricchezza fiscalmente non registrata. La “molla” delle antiche elusioni
era più la preoccupazione imitativa che altre aziende potessero trarne vantaggi finanziari e competitivi. Oggi l’elusione di fatto nelle aziende non è più di moda,
mentre gli scavalcamenti delle procedure da parte dei titolari, desiderosi di risorse
“in proprio” presumibilmente non accennano a diminuire. Ciononostante gli uffici
tributari, desiderosi di fare, come vedremo al par. 5.7, “risultato di servizio” senza
esporsi con la stima di ricchezza non registrata, inventano elusioni anche dove
ormai non ci sono più.
Ne riparleremo al par. 5.18 a proposito dell’inferno sulla ricchezza registrata, sui riflessi negativi per le aziende e l’economia di un paese sempre più in preda agli isterismi
di cui al par. 4.5 ss.
La stessa dialettica tra lettera e spirito della legislazione si ritrova nella disposizione
(art. 37-bis comma 4) secondo cui il contribuente può chiedere la disapplicazione di
disposizioni antielusive specifiche, quando nei casi di specie non ne sussiste la “ratio”;
è una disposizione “di simmetria”, in cui è il contribuente, inversamente rispetto a
quanto avviene in materia di elusione, a far valere lo spirito della disposizione
contro il suo tenore letterale.
È evidente, in entrambi i casi, che di “ratio legis” può parlarsi solo in quanto
ci sia una “ratio”; quest’ultima consiste nella determinazione della ricchezza, con
tutti i compromessi che essa comporta, tra precisione, semplicità, cautela fiscale, certezza,
continuità, effettività, e vari altri valori ancora autonomi dal “gettito”. Se però neppure
ci si è mai chiesti quale sia la ratio del diritto tributario sul piano della determinazione della ricchezza, parlare di elusione come “abuso del diritto” porta dritti
verso confusioni, nocive soprattutto alle organizzazioni su cui si fonda la tassazione
attraverso le aziende.
Un altro caso di cerniera tra possibile “evasione interpretativa”, ed evasione materiale, è il c.d. comportamento “antieconomico”, che rende verosimile una
economicità occulta, nascosta, dietro il comportamento che altrimenti non si spiegherebbe. È verosimile che il costo apparentemente troppo elevato, o il ricavo inverosimilmente troppo basso, sospettati di essere “antieconomici” siano in realtà parzialmente falsi, cioè il ricavo sia sottofatturato o il costo sia “gonfiato”, per avere poi
una qualche retrocessione occulta degli stessi importi, a favore del titolare dell’azienda o di suoi beneficiari. In tutti questi casi, mancando la prova della ricchezza
non registrata, della parte occulta dell’operazione, viene attaccata quella palese,
in genere con argomenti insinuanti e fumosi (perché i reali motivi di sospetto non
possono essere dimostrati).
Capitolo 3 – DETERMINAZIONE CONTABILE E VALUTATIVA DELLA RICCHEZZA
63
3.11.Evasione internazionale tra contestazioni interpretative e ricchezza
non registrata
Le situazioni descritte ai precedenti paragrafi si possono intrecciare, soprattutto in
un contesto economico globalizzato, con i rapporti commerciali con l’estero.
Quest’ultimo, in una materia amministrativistica, è innanzitutto il luogo dove il potere
delle pubbliche autorità non giunge, come pure il relativo prelievo tributario.
Oltrepassata la frontiera il potere amministrativo viene sostituito da quello
di un altro stato, in termini sia di uso della coercizione, sia di regimi tributari sulla
ricchezza registrata, sia di capacità di individuare quella nascosta.
L’espressione “evasione internazionale” può riguardare la ricchezza non registrata,
e materialmente depositata in uno stato diverso, per sottrarla al fisco del paese dove si
svolge l’attività del titolare; si tratta semplicemente di una “base estera” per frodi
documentali a danno del paese dove l’attività economica è realmente basata. L’estero è
infatti in molti modi una sponda per la ricchezza fiscalmente non registrata. La
principale riguarda varie forme di dirottamento di una parte del prezzo, di acquisto o di vendita, su società estere interposte, riconducibili al titolare dell’azienda italiana. Non serve la collaborazione dell’effettiva controparte economica estera, che deve
solo trattare, anziché con l’azienda italiana, con una diversa società estera, riconducibile
al titolare dell’azienda italiana, che poi opererà col soggetto interposto. Le controparti
estere sono infatti tendenzialmente fuori dalla sfera di indagini tributarie del fisco italiano, che ha difficoltà valutative nel controllare se, molto banalmente, le vendite sono
fatturate a meno del valore normale, o gli acquisti – inversamente – sono sovrafatturati.
Le somme accumulate nella società estera interposta sono poi a disposizione del titolare
o di chi per lui.
Su questi presupposti si comprende la disposizione (art. 110 del tuir) secondo cui
i costi verso fornitori residenti in paesi a bassa fiscalità sono deducibili in presenza di
condizioni più rigorose. Questa disposizione “antievasiva” presuppone sia il suddetto rischio di “ristorni in nero”, rafforzando però anche il controllo dei rapporti infragruppo;
la disposizione richiede una attenta analisi del ruolo economico-tributario dell’entità
estera, che potrebbe essere stata interposta dal fornitore effettivo ad un acquirente che
le è totalmente estraneo (cfr. par. 7.19).
C’è però anche una versione internazionale dell’“evasione interpretativa”,
connessa alla qualificazione della ricchezza visibile, registrata o comunque palese; è un
riflesso della qualificazione giuridico-tributaria della ricchezza, stavolta in relazione alla
sovranità statale in cui essa si colloca sul territorio. Entro certi limiti questa collocazione
riflette circostanze materiali genuine, ma poste in essere in funzione di una convenienza tributaria; si pensi alla dislocazione di una parte delle funzioni aziendali,
ad alto valore aggiunto, per spostare la relativa tassazione dove le medesime
sono ubicate. In molti di questi casi la convenienza tributaria passa attraverso
la manovra può dei corrispettivi infragruppo come diremo al par. 7.19 a proposito
del Transfer Pricing. Lo stesso accade quando l’allocazione della ricchezza dipende da
elementi con un collegamento territoriale “debole”, come la proprietà intellettuale, i
64
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
marchi, i brevetti, la ricchezza finanziaria, il software, le provvigioni, di cui riparleremo
al par. 7.19. In quella sede tratteremo anche l’esterovestizione, le CFC, o le stabili organizzazioni erroneamente definite “occulte”. Si tratta generalmente di contestazioni
“interpretative”, facilmente individuabili.
La liberalizzazione degli scambi, anche comunitari, di libertà “di circolazione” non è
seguita da altrettanta libertà di controlli oltre confine, perché qui non si tratta di
attività economiche, ma di un pubblico potere: ne riparleremo al par. 5.6.
La ricchezza non registrata fiscalmente viene sempre meno “portata all’estero”, ma
più spesso si forma direttamente all’estero nei modi sopra indicati (delocalizzazione di
ricavi o fatture gonfiate).
Il regime del c.d. “monitoraggio fiscale” delle attività estere è invece concepito
per un problema diverso, cioè per evitare che i titolari di redditi finanziari trasferissero
all’estero i relativi capitali per “detassarne il frutto”. È un meccanismo di segnalazione
basato sulla cooperazione delle banche e sull’“autodichiarazione” del destinatario, accompagnato da sanzioni a prima vista fortissime. Il monitoraggio non è però accompagnato da una possibilità di investigare all’estero da parte del fisco, se non con richieste
nominative ai paesi stranieri (ovviamente impraticabili su larga scala).
È il già indicato meccanismo con la ricchezza non registrata che nasce all’estero,
mentre le auto che vanno in Svizzera col bagagliaio pieno di contanti appartengono
ormai a un folklore anni settanta. Su questo equivoco giocavano i vari “scudi fiscali”,
che avevano un senso a fronte della mancata dichiarazione degli interessi, ma cui era
stata aggiunta una sanatoria eccessivamente vantaggiosa dell’eventuale capitale (formato
con ricchezza non registrata). Ne derivava, per chi aveva costituito i capitali esteri in
evasione d’imposta, ancora accertabile, un’occasione troppo conveniente di condono
fiscale (paragrafo 5.20).
3.12.Riepilogo: simmetrie della tassazione attraverso le aziende ed “arbitraggi”, tra correttezza sistematica, elusioni e frodi
La tassazione attraverso le aziende, prima di giungere al “consumo finale”, coinvolge
numerosi operatori economici con varie funzioni, in operazioni “business to business”,
dove al ricavo del fornitore corrisponde un “costo” del cliente, a sua volta fiscalmente
rilevante “a valle” (sulla distinzione tra “costi” e “consumo finale” par. 1.8). Quando un
ricavo è soggetto a regime fiscale meno oneroso, ed il costo per la controparte rileva
in regime fiscale ordinario, si crea un “arbitraggio fiscale”. Quest’ultimo può anche essere del tutto lecito, rispondente alla logica del sistema, persino previsto e
voluto dal legislatore per “fare cassa “, anticipando imposte future, ad aliquote convenienti. Altre volte l’arbitraggio può essere il frutto di una forzatura interpretativa del
contribuente (quindi “contra legem”) ed altre volte consistere in una scappatoia formalmente legittima, che tradisce lo spirito del sistema e quindi elusiva (par. 3.10).
Anche la ricchezza non registrata “togliendo da sotto”, come la deduzione delle
fatture fittizie, può essere riportata all’arbitraggio, in cui si inventa un costo dedotto a
Capitolo 3 – DETERMINAZIONE CONTABILE E VALUTATIVA DELLA RICCHEZZA
65
fronte di un ricavo fittizio, mai dichiarato, o dichiarato senza pagare imposte. A questo
concetto di “arbitraggio” in senso ampio appartiene anche l’interposizione di società,
riconducibili al socio, nell’acquisto di materie prime o servizi dal fornitore effettivo,
rivenduti alla società operativa con un margine positivo (par. 3.7). Ne riparleremo al
par. 7.19, ma già da ora si può sistematizzare un concetto generale: la frammentazione
dei flussi economico-finanziari tra soggetti diversi (le “simmetrie” della tassazione attraverso le aziende, già indicate anche al par. 3.11), ciascuno coinvolto in parte,
ostacola la responsabilizzazione degli operatori economici per violazioni commesse
dalle controparti.
Il compratore non ha titolo per sapere se il venditore versa o meno
l’IVA o le imposte sui redditi, o le ritenute sui dipendenti, o se ha realizzato
dall’operazione una plusvalenza tassata in Italia. È una autonomia del tutto fisiologica, della quale però non bisogna abusare, montando di proposito operazioni in cui
la parte meno visibile scompare senza onorare i debiti tributari, e l’altra si fa forte
della propria autonomia.
L’unica contromossa del fisco in questi casi è la dimostrazione dei titolari effettivi delle società “scatole vuote”, gli indizi di una spartizione avvenuta nell’ombra
con una controparte indipendente, ovvero di una riconducibilità di venditore e acquirente a una stessa compagine sociale.
Per dimostrarlo occorrono però indagini, valutazioni controverse, non riconducibili a una precisa disposizione di legge e ostacolate dai soliti equivoci dottrinali sulla vincolatezza dell’attività degli uffici, la legalità, l’indisponibilità del
credito tributario, quasi che ogni azione amministrativa debba essere “sempre guidata,
praticamente telecomandata, dalla legge”.
Tutto questo apparato pseudo teorico alimenta la tendenza (inevitabilmente
diffusa in tutti gli uffici tributari) a rimanere “al coperto”, concentrandosi sulle c.d. contestazioni interpretative (paragrafo 5.17), ivi compresi gli “arbitraggi
alla luce del sole”; si tratta dei già indicati prezzi di trasferimento, degli
aumenti dei valori fiscali in base a imposte sostitutive (par. 7.13), delle strutturali
divergenze tra regimi fiscali; si pensi ai casi in cui il socio totalitario di una società, decide di percepire una remunerazione a titolo di interessi attivi, compensi di
amministratore, corrispettivi per la vendita di beni anziché dividendi. Quello che
conta, per lui, è il carico fiscale complessivo, dato dalla somma di tutti quelli delle
varie parti coinvolte. Si tratta di una somma algebrica, dove il carico fiscale complessivo risulta dalla differenza tra elementi imponibili per il fornitore e deduzioni
per la società cliente (il risultato netto, insomma, delle simmetrie fiscali suddette). Vedremo ai paragrafi successivi come questi meccanismi di sistema vengono
attaccati dal fisco per le più varie alchimie di cui al par. 5.18, come l’abuso del
diritto (o elusione: par. 3.10), la non inerenza (par. 7.9), la fantomatica antieconomicità (par. 5.17) o un loro incomprensibile miscuglio (par. 5.19 sulle rettifiche
solo apparentemente provviste di filo conduttore). Sono episodi dell’inferno della
ricchezza registrata, indotti dagli “opposti isterismi” di cui al par. 4.6, e di cui riparleremo al par. 5.18.
66
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
3.13.Dove le aziende non arrivano: l’inutile “ragionierizzazione” dei lavoratori indipendenti (il diversivo della “contabilità fiscale”)
La tassazione attraverso le aziende lascia scoperta la ricchezza da esse non
raggiunta. Al di là di quella “evasa attraverso le aziende” (paragrafo 3.7), c’è la massa
di lavoratori indipendenti, non particolarmente ricchi singolarmente, ma molto
numerosi. Le rigidità organizzative delle aziende non esistono per due milioni e mezzo
di operatori economici senza collaboratori (attività “monoaddetto”) e di un milione e
mezzo da due a nove addetti, in cui rientrano tutte le attività svolte da coniugi, genitori
e figli, a consistenza quindi esclusivamente familiare. Sono quattro milioni di posizioni
IVA dove l’azienda esiste solo in senso materiale, di attrezzature o merci, non in
senso personale.
Qui non ci sono rigidità aziendali da scavalcare, perché i lavoratori indipendenti sono privi di una organizzazione, e trattano direttamente col consumatore
finale. Il problema del mancato funzionamento, in questi casi, della tassazione attraverso
le aziende, è stato eluso col solito artificio verbale tipico dei governanti italiani,
cioè fingendo che i lavoratori indipendenti fossero anch’essi aziende. Essi sono
stati così trasformati “per legge” in “aziende fiscali”, tenute ad una contabilità
(fiscale) senza alcun retroterra di affidabilità gestionale.
Siccome la tassazione attraverso le aziende è efficiente dove il fisco può far leva
sulle rigidità aziendali, allora si cerca di crearle anche dove non ci sono. La definizione fiscale di impresa, fu ampliata fino al punto di accomunare fabbriche,
ipermercati, artigiani e venditori ambulanti. Un imprenditore dolciario può così
essere un pasticcere o la Ferrero, un imprenditore della ristorazione può essere un
barista o Autogrill, un imprenditore dell’arredamento può essere un tappezziere o
Natuzzi. Insomma, la definizione di impresa è stata talmente ampliata da diventare
inservibile, sempre bisognosa di precisazioni per capire di cosa si sta parlando ed
evitare equivoci.
La trasformazione di milioni di piccoli commercianti ed artigiani in altrettanti “imprenditori fiscali”, avvenne attraverso una definizione fiscale di impresa che trascurava
il requisito dell’organizzazione.
L’assurdità di questa imposizione è confermata indirettamente dall’esclusione civilistica da obblighi contabili per le attività organizzate in prevalenza col lavoro proprio
e della famiglia (piccoli imprenditori). Per le professioni liberali la contabilità era poi
civilisticamente esclusa qualunque fosse la dimensione dell’attività (compreso quindi il
grande studio legale o medico).
Qualsiasi lettore può capire l’inefficienza di questa soluzione, anche solo pensando
alla propria dichiarazione dei redditi, alla complessità di ritrovare i documenti necessari; già pochi pezzi di carta, tra spese mediche, certificati di versamento delle imposte,
certificati dei sostituti di imposta, contributi della Colf, interessi passivi e poco altro,
mandano rapidamente in confusione.
Anche se la ragioneria è una partizione delle scienze umane, basta dover raccogliere
e classificare anche pochi documenti per capire che è un lavoro grigio e preciso, del
Capitolo 3 – DETERMINAZIONE CONTABILE E VALUTATIVA DELLA RICCHEZZA
67
tutto inutile dove manca la spersonalizzazione di una azienda fortemente pluripersonale
(par. 3.1) cbe possa permettersi alcuni addetti “dedicati”.
Gli adempimenti contabili dei lavoratori indipendenti senza organizzazione diventano così un inutile esorcismo di facciata, tenuto da un professionista esterno,
che fa il direttore amministrativo per fini fiscali di tanti artigiani o piccoli commercianti,
che lo pagano senza averne affatto bisogno, e senza avergli mai fatto vedere neppure
la bottega o il laboratorio. Per le aziende pluripersonali gli uffici contabili sono una
parte necessaria della gestione complessiva, imposta da genuine necessità organizzative,
non dal fisco, anche se poi quest’ultimo vi fa affidamento. Se l’azienda esiste invece solo
in senso materiale, consistendo solo di attrezzature, ma non di una pluralità di persone,
che debbano darsi reciprocamente conto dei loro compiti, la contabilità è un fastidio
inutile per chi dopotutto è solo un lavoratore indipendente, al tempo stesso
proprietario, dirigente, operaio e fattorino della propria attività; ai piccoli commercianti
e agli artigiani non serve un contabile per sapere quanto guadagnano, perché operando
da soli (o quasi) sono i migliori conoscitori della loro attività.
Vedremo anche al par. 3.16 che era inconcepibile affidare a questo contabile professionista, pagato dal cliente, mansioni di “polizia tributaria” a favore del fisco; se il
cliente decide di rischiare, magari non registrando fatture o dichiarando
cifre inferiori a quelle risultanti nelle scritture contabili, il professionista non
ha motivi per opporsi, né può essere tenuto a delazioni di sorta agli uffici tributari.
Abbiamo creato quindi centinaia di migliaia di strutture contabili inutili, disperdendo
risorse dove non serviva, e creando lavoro inutile, mentre si perdevano occasioni di
lavoro professionale utile al fisco.
La tenuta della inutile contabilità assorbiva infatti tempi e risorse, in un lavoro ripetitivo e ottuso, mentre al cliente serve un ausilio in adempimenti burocratici amministrativo tributari, a partire dalle dichiarazioni fiscali, agli “studi di settore” (par. 5.13), agli
adempimenti previdenziali, per i tributi comunali e tanti altri. Insomma, i professionisti
esterni dei “lavoratori indipendenti” hanno dovuto accantonare, viste le ristrettezze
di budget dei clienti, un insieme di importanti funzioni, diciamo così “consulenzialburocratiche”, per recitare l’inutile pantomima della contabilità fiscale. Che tuttavia gli
organi professionali difendono perché temono che gli iscritti protestino, a loro volta nel
timore di perdere lavoro, che invece non perderebbero, guadagnando anzi in qualità,
come dimostra l’esperienza dei “minimi”, con la determinazione analitica senza contabilità (paragrafo 7.8).
Tuttavia piccoli commercianti e artigiani sanno di essere fiscalmente visibili,
perché in genere devono esserlo agli occhi della clientela, e non possono evitare di esserlo a quelli del fisco. Non è la contabilità che li rende visibili, ma il bisogno di
interagire coi clienti; la loro ricchezza è visibile in modo “materiale”, “fisico”,
non “contabile”. Sapendo di essere materialmente visibili, si registrano fiscalmente,
prendono la partita IVA, e tengono la contabilità, evitando – in genere – rappresentazioni manifestamente non verosimili.
Su questa premessa l’inutile “contabilità fiscale” viene tenuta, ma le cifre da scriverci
sono nell’assoluto dominio del lavoratore indipendente. Che potrebbe comunque facil-
68
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
mente occultare ricchezza al fisco “a monte” della contabilità, registrando fiscalmente
solo una parte dei propri introiti.
Quando precede ha però portato l’autorità amministrativa sulla falsa pista della determinazione ragionieristica della ricchezza non registrata (parr.5.9/5.11), inutile dove
manca un reale interesse aziendale alla contabilità.
3.14.Mancata registrazione degli incassi nel lavoro indipendente verso
consumatori finali
Per riequilibrare il sistema dovrebbe quindi tornare in gioco, su questa tipologia di
ricchezza, una richiesta amministrativa delle imposte adeguatamente sistematica
e inevitabilmente valutativa, cioè basata su stime per ordine di grandezza. A
prima vista è una apparente anomalia rispetto alla determinazione ragionieristica della
ricchezza, però è un riflesso della tradizione millenaria della tassazione, che si è sempre
ispirata a criteri di stima, e rispetto alla quale la tassazione attraverso le aziende è – se si
vuole – una eccezione, non la regola.
Ci troviamo anche qui davanti a uno dei fili conduttori del testo, cioè il coordinamento tra moderna “tassazione ragionieristica”, basata sulle aziende, e tradizionale “tassazione valutativa”, basata sugli uffici: a tal fine, come rilevato al par. 1.5,
è del tutto insufficiente il concetto di autodeterminazione dei tributi” o “autotassazione”
(in versione inglese “tax compliance”, ma il concetto è lo stesso). L’abbiamo anticipato al
par. 1.5, ma ripetiamo che “le imposte”, per definizione, devono essere “imposte”
da qualcuno: dove non si riesce a farlo attraverso le organizzazioni aziendali devono
tornare in gioco gli uffici tributari, in modo valutativo e con sufficiente sistematicità.
Questo “lavoro indipendente”, sia commerciale, sia artigianale, sia professionale, rivolto alle persone fisiche consumatrici finali è la classica figura mediatica della ricchezza
fiscalmente non registrata. Piccoli commercianti e artigiani non sono “aziende”, ma
“persone”, con vita privata e famiglie, con necessità personali da soddisfare,
a differenza delle aziende (par. 3.1). A queste necessità serve la ricchezza nascosta
al fisco. Se si considera la ridottissima presenza valutativa degli uffici tributari
sulla ricchezza non determinata dalle aziende, le somme dichiarate appaiono relativamente alte, sufficientemente per smentire i luoghi comuni sugli italiani come popolo
di evasori. Non certo per una paradossale “onestà “di chi può nascondere ricchezza al
fisco, ma per la propaganda di cui diremo al par. 4.2, che accredita l’immagine di uffici
tributari molto più presenti di quanto siano realmente, sulla ricchezza non raggiunta
dalle aziende. Il pasticcere, il carrozziere, il veterinario o l’oste, così spesso accusati di
“non fare lo scontrino, la fattura o la ricevuta fiscale”, non hanno infatti alcuna necessità
organizzativa di tali documenti, costituenti solo un “obbligo fiscale”; cioè un tentativo
dello stato di portare la tassazione attraverso le aziende dove esse non esistono, trasformando in “azienda fiscale” una attività prevalentemente di lavoro, dove non c’è neppure
l’ombra delle rigidità amministrative che caratterizzano le aziende, ed in cui il fisco si
inserisce (par. 3.1).
Capitolo 3 – DETERMINAZIONE CONTABILE E VALUTATIVA DELLA RICCHEZZA
69
Non c’è quindi alcun ostacolo gestionale, in questi casi a evitare la registrazione
fiscale della ricchezza “togliendola da sopra”, cioè omettendo la registrazione degli incassi, con l’“occultamento dei ricavi”, detto anche “il nero”.
Non si tratta, ripetiamo, di tutti i “lavoratori indipendenti”, ma di quelli operanti
al consumo, mentre quelli segnalati dalle aziende (come i professionisti soggetti a ritenuta) hanno possibilità relativamente basse di nascondere ricchezza.
Quando il cliente del piccolo commerciante è un consumatore finale le imposte
non possono essergli “imposte” con la gazzetta ufficiale, perché incidono sul tenore
di vita. Oltre alla massiccia offensiva mediatica di cui diremo più avanti, serve
la percezione delle probabilità di richiesta (o di “controllo”); l’idea di “autodeterminazione delle imposte”, generata nella tassazione attraverso le aziende, crea l’equivoco secondo cui la richiesta delle imposte in concreto sarebbe superflua, come se
ognuno fosse solo davanti alla legge in compagnia del proprio senso civico. Anche
qui ritroviamo la confusione che mette sullo stesso piano, nell’equivoco concetto di
“contribuente” le aziende e le persone, preparando le isterie sociali di cui diremo al
capitolo quarto.
Alla facilità di questa modalità di occultamento degli incassi, si accompagnano i
riflessi sul tenore di vita degli interessati, come vedremo al par. 4.5, sulle motivazioni
dell’evasione: chi lavora da solo, e non è tassato dalle aziende, nasconde con facilità la
ricchezza al fisco, ma non ne crea molta col suo solo lavoro, e quindi è spinto ulteriormente a diminuire la quota dichiarata, per l’elevata utilità marginale del denaro.
Le somme versate al fisco inciderebbero su aspetti relativamente importanti del suo
tenore di vita, come le vacanze, alcuni divertimenti, le cene fuori, la seconda macchina,
di persone che “al lordo delle tasse” guadagnano magari 100 mila euro, e per le quali
dichiarare tutto, o dichiararne trentamila, comporta forti differenze in termini di reddito spendibile. Anche se da soli si evade bene, i guadagni restano modesti, finché non si
organizza il lavoro degli altri, e quindi si è spinti a nasconderli al fisco. Al paragrafo 4.1,
sulla stima dell’evasione, vedremo la verosimile prevalenza numerica di tanti “lavoratori
indipendenti”, che nascondono al fisco una quota elevata di cifre relativamente basse
Accanto a questa utilità marginale alta del denaro risparmiato, la mancata registrazione fiscale della ricchezza dipende dalla percezione, diretta e mediatica, dei controlli,
di cui riparleremo al par. 4.5, sulle determinanti dell’evasione.
Proprio le statistiche dei redditi dichiarati da queste categorie, incrociate con le dimensioni, lasciano presumere molta ricchezza non registrata; anche se le statistiche dovrebbero essere depurate dalle quote di reddito imputate ai collaboratori familiari (par.
7.17), delle attività appena iniziate, in liquidazione o esercitate part time, i dati fanno
presumere che la ricchezza nascosta sia forte (cfr. par. 4.1).
Anzi, se si ragiona freddamente, l’enfasi sulla “disonestà fiscale”, e la mancanza
di senso civico, appare un diversivo, qualche volta usato in buona fede, qualche altra
con una certa strumentalità politica (paragrafo 4.5) per sfruttare politicamente il disorientamento collettivo in materia di tassazione. Vedremo che l’ipotetica perversione
privata dell’“evasore” è utilizzata come scusante per disorganizzazioni in tutta la macchina pubblica, a loro volta provocate da deficit culturali della pubblica opinione, più o
70
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
meno intensi a seconda dei vari settori d’intervento pubblico, come vedremo al par. 5.3.
Uno dei settori dove il disorientamento è maggiore è proprio la determinazione della
ricchezza ai fini tributari, dove la classe dirigente (par. 1.6) non si rende conto dello
squilibrio tra calcolo ragionieristico “attraverso le aziende” e “autotassazione”, effettuata
nella prospettiva di un intervento valutativo degli uffici.
L’effetto propaganda è sufficiente a generare un livello di autotassazione non
manifestamente indecoroso, se si considerano i redditi dei lavoratori indipendenti:
ad esempio, un idraulico senza sede fissa che incassa 50 mila euro e ne dichiara 25 può
quasi definirsi “credibile” (“onesto”?) rispetto all’attuale sistematicità dell’intervento del
fisco sulla sua tipologia di ricchezza; vedremo a proposito del “senso civico” (par. 4.5)
che non ha senso confrontare questo contribuente con l’impiegato di banca
costretto, a parità di reddito, a dichiarare tutto dal datore di lavoro, ma che – a parti
invertite – forse dichiarerebbe anche meno di quella somma. Quando si tratta di lavoratori indipendenti e di titolari di piccole organizzazioni, per cui il denaro ha una fortissima utilità marginale, la pressione mediatica aiuta ma non basta, e serve una credibile
presenza valutativa del fisco sul territorio, nelle strade, presso conoscenti, nella cerchia,
territoriale o economica di altri contribuenti.
Torneremo al capitolo quarto sulla nocività delle drammatizzazioni sociali connesse
alla ricchezza non registrata e alla lotta all’evasione in televisione, come pure alle strambe proposte mediatico politiche in merito; i risultati in termini di attività amministrativa
saranno indicati ai paragrafi 5.7, sulla distribuzione degli interventi, nonché 5.13-5.14
sulle relative metodologie.
3.15.La crescente “ricchezza non osservabile”, discontinua, collaterale,
anche di sopravvivenza
Ai paragrafi precedenti abbiamo parlato in prevalenza di ricchezza non registrata
in attività continuative, svolte da operatori economici stabilmente visibili. Cioè
dotate di una sede fissa, o di beni strumentali da cui si potesse stimare l’intensità
dello svolgimento dell’attività. Qui la ricchezza è visibile, anche se in modo fisicomateriale, non contabile.
Ci sono però sia operatori economici privi di una sede fissa o di una struttura,
come i venditori ambulanti, gli artigiani operanti a domicilio, elettricisti, idraulici, non
a caso considerati per lunghi anni sinonimo di evasori fiscali.
A questi operatori economici “sfuggenti”, neppure visibili sulla pubblica via, si
aggiungono soggetti che non sono operatori economici. Mi riferisco alle “locazioni in nero”, agli affitti di stanze, ai bed and breakfast, ai secondi lavori “in nero”
(coperti dalla presenza del primo lavoro “in bianco”,magari di dipendente pubblico),
alle ripetizioni in nero di insegnanti, ai lavoretti in nero, ai subaffitti di stanze, al
piccolo commercio di beni usati, agli ambulanti abusivi sul marciapiede e
sulla spiaggia, ai posteggiatori abusivi, ai “servizi personali”, dalla colf in nero, al
dog sitter, al trainer sportivo, ai posteggiatori abusivi fino all’accaparramento dei nu-
Capitolo 3 – DETERMINAZIONE CONTABILE E VALUTATIVA DELLA RICCHEZZA
71
meretti elimina code all’ufficio postale. Si pensi anche alla prostituzione indipendente, tipico esempio di “servizio personale”, privo di strutture. La possibilità di tassare
questo fenomeno, mediante una sua regolamentazione, e gestione imprenditoriale,
come nei centri benessere tedeschi, costituisce una riprova della “tassazione attraverso le aziende”. Sarà sempre difficile tassare la prostituta indipendente, come è difficile
tassare l’idraulico, mentre la “casa chiusa”, organizzata benché si chiami “bordello”,
consente di applicare anche a questo tipo di ricchezza la consueta determinazione
ragionieristica. Per la prostituta individuale, non organizzata, invece, l’accertamento
in base alla spesa è tutto sommato il più efficiente, come per il fisioterapista (dopotutto sempre servizi personali sono!).
Queste situazioni confermano che la mancata registrazione fiscale della ricchezza non dipende da intrinseche malvagità, bensì da un misto di necessità ed
opportunità, connesse alla mancata richiesta delle imposte quale “disfunzione pubblica”, come tante altre.
La ricchezza non registrata, “collaterale” ad altre attività tendenzialmente tassate,
oppure occasionali, sporadiche, costituisce spesso un vero e proprio espediente di
integrazione del reddito, e conferma la frammentarietà della determinazione della
ricchezza. In Italia non abbiamo solo le grandi imprese che sono piccole rispetto a
quelle europee, una enorme polverizzazione di lavoratori indipendenti “alla luce del
sole”, ma anche tante persone che si arrangiano. Al par. 5.15 vedremo l’utilità di
un certo controllo valutativo del territorio da parte del fisco, anche su queste aree.
È ben vero che le difficoltà di determinazione della ricchezza per il lavoro indipendente, dove almeno esiste una visibilità statica della ricchezza (botteghe, laboratori,
etc.) aumentano per queste attività sfuggenti. Neppure è agevole capire con quanta
intensità sono esercitate le attività in esame, legate alle opportunità e ai bisogni, spesso
schermate da un parallelo reddito di lavoro. Spesso il lavoro dipendente, ancorché
modestamente retribuito è una entrata continuativa, sicura, cui non si vuole rinunciare, come in tanti impieghi pubblici o parapubblici. qualche volta l’attività da cui
deriva il reddito “ufficiale” è anche generatrice di quello “occulto”, come nel caso
delle già indicate ripetizioni degli insegnanti.
Con la crisi economica ci sono anche attività collaterali alla percezione di una pensione o di una forma di sussidio, ad esempio la “cassa integrazione”. Accanto a questi
modesti sussidi si sviluppa l’“arte di arrangiarsi”, necessaria a mantenere almeno in parte
il tenore di vita anteriore alla crisi o al prepensionamento. All’insufficienza della remunerazione del lavoro principale si risponde, all’Italiana, con la moltiplicazione dei lavori,
o più esattamente dei “lavoretti”.
In entrambi i casi si tratta di riflessi dell’impoverimento della società, dell’appiattimento degli stipendi e della proletarizzazione dei ceti medi (parr.
9.2/10.4/10.5); è una specie di “economia di sussistenza” postindustriale, in cui
riemergono aspetti importanti della società agricolo-artigianale, per non dire di quella,
ancora anteriore, dei cacciatori raccoglitori, riferiti oggi a sfridi del sistema, dal riciclo
di beni usati alla ricerca di alimentari scaduti, alla “banca del cibo”. È un contesto dove
fioriscono nuove forme di baratto e la moneta di quartiere, piccole manutenzioni e
72
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
riparazioni, subaffitti, bed and breakfast. Non sono “start up” di aziende, ma tecniche di
sopravvivenza “postaziendali”, da deindustrializzazione senza sbocchi.
Finché erano situazioni marginali, le si potevano trascurare, ma oggi è un sottobosco
vastissimo, fatto di milioni di persone. Al suo interno occorre distinguere le situazioni di
effettiva difficoltà, che meritano di percepire sussidi, da quelle in cui redditi tassati forfettariamente (agricoltura par. 8.2) e redditi soggetti a imposta sostitutiva, magari grazie
ad abitazioni di proprietà, riducono i bisogni o li soddisfano. Possono poi esserci anche
sussidi pubblici non spettanti o rilevanti evasioni tributarie.
Se si vedono le statistiche delle dichiarazioni dei redditi, queste situazioni riguardano
gruppi troppo numerosi di contribuenti per essere del tutto ignorate, anche per evitare
che il fenomeno si allarghi.Vedremo al par. 5.15 che non si tratta di interventi punitivo
–fiscalistici, ma diretti semplicemente al monitoraggio di questa moderna e crescente forma di “economia di sussistenza”. Non si tratta cioè di tassare situazioni
di disagio, ma di controllare il territorio per capire se apparenti morti di fame
lo sono effettivamente. Man mano che dalle dichiarazioni dei redditi aumentano gli
apparenti morti di fame, deve tornare in mente il già menzionato paradosso secondo
cui bisogna “tassare i poveri, che hanno poco ma sono tanti”. Declinato correttamente,
il paradosso si spiega con la necessità di non trascurare “la ricchezza dei poveri” o almeno di trattarla in modi non troppo sperequati, a seconda che gli interessati lavorino per
organizzazioni rigide (che li tassano) o meno.
Anche questo mostra l’insufficienza delle aziende ai fini della tassazione, e la necessità di una macchina pubblica valutativa ed efficiente, non solo per intervenire dove esse non arrivano, ma anche per permetterne la crescita oltre la dimensioni
padronale, come vedremo al par. 5.18/5.19. La tassazione ragionieristica attraverso le
aziende resta fondamentale per il gettito, ma deve essere integrata ai nostri fini, per
evitare settori della società “senza Stato” (nel senso di “pubblico potere”), con la società
che regredisce a una economia parallela “semitecnologica”, in cui si raccolgono fortunosamente residuati e rifiuti della produzione di serie, come nelle grandi discariche a
cielo aperto del terzo mondo, o dentro i nostri cassonetti dei rifiuti, in uno scenario da
“day after” post atomico.
Man mano che procede la proletarizzazione dei ceti medi, e diminuisce l’importanza del reddito da stipendio rispetto alla situazione economica complessiva degli
individui (paragrafi 2.2, 9.2, 9.3, 10.4), diventa sempre più insufficiente una tassazione ragionieristica basata solo sulle aziende, senza un sistematico intervento
valutativo degli uffici tributari, di cui riprenderemo le fila, anche per queste
attività, al par. 5.15.
Anche per questo è importantissimo diffondere tra la pubblica opinione (par. 1.6)
la praticabilità della determinazione degli imponibili per ordine di grandezza. Naturalmente deve restare ferma, per ragioni di continuità del gettito, la tassazione
ragionieristica attraverso le aziende, sperando anche che esse riescano a mantenere le
posizioni ed ampliarle, il che significherebbe progresso industriale del paese. La macchina fiscale può contribuirvi riducendo le sperequazioni tra odierna tassazione ragionieristica attraverso le aziende e tradizionale tassazione valutativa attraverso gli uffici. È un
Capitolo 3 – DETERMINAZIONE CONTABILE E VALUTATIVA DELLA RICCHEZZA
73
circolo virtuoso su cui ritorneremo, sul piano del bagaglio culturale delle classi dirigenti
(e del contributo della dottrina) al paragrafo 4.7.
3.16.Professionisti tra tassazione attraverso le aziende e attraverso gli uffici: prospettive per un loro uso più efficiente
La tassazione attraverso le aziende coinvolge una pluralità di addetti ai relativi uffici
contabili interni, mentre l’autotassazione cerca di imitarla, e quindi coinvolge la pluralità di consulenti di piccoli commercianti, artigiani, e di semplici contribuenti
tenuti ad adempimenti tributari che, come vedremo, sarebbe antieconomico svolgere
da soli. Nelle aziende, i compiti in esame si innestano, come già visto al par. 3.3 e seguenti, sull’ordinaria tenuta della documentazione contabile, riutilizzata e integrata ai
fini tributari.
Questi servizi professionali non sono un’eccezione, esistendo in tutti i paesi
sviluppati, soprattutto per la predisposizione e l’invio di dichiarazioni tributarie (par. 3.4), adempimenti contabili e consulenza. In molti paesi i professionisti sono
l’anello di congiunzione tra operatori economici, soprattutto piccoli, e uffici tributari;
attraverso di loro sono canalizzate le informazioni, organizzandole in modo gestibile
dagli uffici; è una funzione sostanzialmente di assistenza-consulenza, talvolta di certificazione di alcuni aspetti esteriormente rilevanti dell’attività del contribuente, offrendo
agli uffici elementi oggettivi per stimare la ricchezza determinabile solo in modo valutativo.
La specializzazione dei compiti, nelle società moderne, rende sempre più rari
gli individui che preparano e spediscono da soli le comunicazioni al fisco.
il “cittadino contribuente” che bada da solo ai propri adempimenti fiscali è una figura
retorica come quella dell’antico “cittadino soldato”; l’idea dell’ufficio tributario che
invia bollettini precompilati al contribuente è evidentemente antieconomica, così come
improvvisarsi fiscalisti solo per se stessi, informandosi e tenendosi aggiornati per gestire
in autonomia solo la propria posizione. Oggi, anziché gestire da soli gli adempimenti,
è sempre più importante coordinarsi con chi presta assistenza, sapendo bene “chi deve
fare cosa”; l’invio di informazioni precompilate, da parte del fisco, è anche opportuno,
purché coinvolga le strutture di assistenza, preparando loro il lavoro per le personalizzazioni successive, in base ad informazioni che solo il contribuente conosce. Le
strutture professionali assorbono infatti il necessario investimento in conoscenze, distribuendolo su tutti i clienti, con intuitive economie di scala.
I professionisti sono fondamentali sulla ricchezza dove le aziende non arrivano, per
raccogliere e canalizzare, verso gli uffici tributari, informazioni provenienti da “lavoratori indipendenti” privi di qualsiasi struttura contabile, come visto al par. 3.13. È una
attività simile, in piccolo, agli uffici di contabilità aziendale, senza però la corrispondente affidabilità, in quanto il professionista non vi è coinvolto direttamente, riceve
le informazioni, e la remunerazione, direttamente dal titolare. Anche sui professionisti si
riflettono però, come vedremo al termine di questo paragrafo, il disorientamento e la
74
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
drammatizzazione sulla determinazione tributaristica della ricchezza (capitolo 4), con
adempimenti inutili, a partire dalla contabilità dei lavoratori indipendenti (par. 3.13),
fino agli estenuanti contenziosi per pratiche “rinviate al giudice” (par. 6.6), e alla gestione delle contestazioni interpretative basate su litanie solo apparentemente pertinenti
(par. 5.17 ss).
La figura più diffusa è il commercialista del lavoratore indipendente, che si
differenzia dal direttore amministrativo delle aziende in quanto è solo una sovrastruttura
imposta dalla legge tributaria; questo professionista non ha alcun tornaconto personale a
suggerire modalità per omettere la registrazione della ricchezza, anche perché il cliente,
soprattutto se lavoratore indipendente al consumo finale, se la cava benissimo da solo.
I professionisti hanno insomma un ruolo complessivamente marginale nella
mancata registrazione tributaristica della ricchezza, conosciuta molto meglio
dal contribuente. È quest’ultimo a decidere quanto nascondere e quanto dichiarare, e
non a caso molti commercialisti confessano di aver imparato dai loro clienti i modi in
cui i medesimi nascondevano la ricchezza al fisco.
Il consulente tende piuttosto a “coprirsi le spalle”, rispetto a potenziali corresponsabilità verso il fisco per violazioni tributarie commesse dal cliente,
nonché rispetto alla tendenza del cliente a prendersela col professionista per eventuali
accertamenti tributari sopravvenuti.Vedremo che questa seconda eventualità spinge addirittura i professionisti a convincere i clienti ad adeguarsi agli studi di settore, nei modi
e coi limiti di cui diremo al par. 5.13.
Verso le poche decine di migliaia di aziende organizzate pluripersonali, che
possono permettersi un ufficio contabile “in proprio”, il professionista si dedica
all’inquadramento giuridico, di ricchezza registrata, cioè alle possibili contestazioni
interpretative descritte al par. 3.9 e ss.. Il titolare di aziende che scavalca le proprie
procedure contabili per nascondere ricchezza al fisco (par. 3.7) casomai si consulta
col professionista a posteriori, ipotizzando la rilevabilità da parte del fisco di tali
manipolazioni; queste ultime però sono effettuate in prima persona da chi conosce
l’azienda meglio del suo consulente. C’è poi forse qualche “professionista dell’evasione”, procura ai clienti fatture false, prestanome o società “offshore”, ma si tratta
verosimilmente di casi marginali.
L’intervento professionale più diffuso è anche quello meno remunerativo, e riguarda
le persone fisiche che non sono operatori economici, ma che devono “personalizzare” la tassazione documentale attraverso le aziende; queste ultime segnalano il reddito
principale, ma i percettori devono aggiungere redditi ulteriori (ad es. immobiliari), oneri e detrazioni personali di cui al par. 9.3, scomputare acconti e ritenute. Per tutto questo, come per la tassazione immobiliare (ad es. IMU di cui al par. 10.9), serve assistenza,
prestata a basso costo sia da professionisti sia da “centri di assistenza fiscale”, facenti capo
ad associazioni sindacali e di categoria, patronati e simili; qui il contribuente presenta
i documenti e fornisce sotto la sua responsabilità le relative informazioni, ricevendo i
moduli per il versamento, da effettuare poi in banca. Gli intermediari o i professionisti
possono essere chiamati ad una verifica della regolarità formale dei documenti alla base
degli oneri detraibili o deducibili delle persone fisiche, di cui riparleremo al par. 9.3
Capitolo 3 – DETERMINAZIONE CONTABILE E VALUTATIVA DELLA RICCHEZZA
75
anche per il “contrasto di interessi” (cioè la deduzione a fronte di spese per consumi
particolarmente “a rischio” di evasione da parte del fornitore). Ulteriori corresponsabilizzazioni dei professionisti sui dati rilevanti ai fini degli studi di settore (par. 5.13), sulla
emissione delle fatture e la loro registrazione, e su altre incoerenze “professionalmente
rilevabili”, sono ostacolate dal disorientamento imperante sulla determinazione tributaristica della ricchezza (capitolo 4).
Alcuni ambienti sociali, soprattutto di economisti, collegano spesso il malessere fiscale italiano ad una specie di congiura degli esperti del settore, che avrebbero creato
ad arte la confusione in cui ci si dibatte, per trarne vantaggio professionale. Un fondo
di verità della critica si riferisce alle difficoltà progettuali dei giuristi, indicate al par. 4.3,
incapaci di essere il riferimento di cui le istituzioni hanno bisogno. In generale però il
professionista non crea, ma legittimamente sfrutta, come vedremo al par. 4.4, gli equivoci che lo studioso sociale dovrebbe siegare e contribuire ad eliminare.
Anzi, la massa dei professionisti subisce gli effetti negativi dei disorientamenti e delle drammatizzazioni sul fisco, su cui capitolo 4. Ne derivano adempimenti contabili e dichiarativi inutili (par. 4.5), e rapporti difficili con gli uffici
tributari; i relativi funzionari avvertono le drammatizzazioni sociali, e diventano più
sospettosi e diffidenti, per timore di essere considerati negligenti o “malleabili” (par.
5.11); ostacoli vengono anche dalla parcellizzazione tra uffici diversi (ispettori, ufficio accertatore, giudici, Equitalia), ciascuno dei quali vede prevalentemente il proprio
segmento di attività. Ciascun ufficio tende a liberarsi dei problemi difficili da risolvere,
anche utilizzando legalismi, e spesso il giudice, come vedremo al par. 6.5, rappresenta
una miope valvola di sfogo per non decidere.
Resta un danno da incertezza che ricade sul professionista, in quanto difficile da
ribaltare sul cliente, soprattutto per pratiche di modesto valore, riguardanti un gran numero di contribuenti medio-piccoli. Il lavoro intellettuale connesso alla determinazione
tributaristica della ricchezza è infatti sostanzialmente indipendente dall’ammontare delle cifre coinvolte e quindi proporzionalmente maggiore sui piccoli contribuenti, senza
margini per ripagare lo sforzo del professionista. Per questo la “ragionierizzazione
forzata” (par. 3.13) della determinazione della ricchezza non raggiunta dalle aziende
ha i suoi costi professionali. Anche le pratiche piccole diventano un dramma
e diminuiscono sempre più, con la crisi economica, quelle di ammontare tale da consentire una adeguata remunerazione del professionista; quest’ultimo spesso tende giustamente a dimensionare la qualità e l’impegno nel lavoro rispetto a quanto il
contribuente può pagare, con cadute di tutela e crisi di rigetto descritte al par. 4.6.
La convenienza di trattare una pratica dipende ormai prevalentemente dalla rapidità con
cui la si inquadra concettualmente, la si interiorizza e la si descrive efficacemente ad
uffici e giudici, superando le difficoltà comunicative di avvocati e contabili.
Altrimenti, ogni pratica diventa un dramma per il professionista, ed anche quelle
verso aziende più strutturate richiedono spesso tempi ed energie sempre proporzionalmente eccessive rispetto al compenso sostenibile dal cliente. Ciò sia per la crisi economica sia per la tendenza delle pratiche a generarsi, complicarsi e vivere di vita propria,
richiedendo un impegno spesso sproporzionato alle loro dimensioni economiche.
76
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
Ne deriva un forte malessere dei circa 200 mila operatori delle aziende e
degli studi professionali, impegnati in adempimenti tributari. Il mancato coordinamento “culturale”, di cui diremo al capitolo quarto, tra tassazione ragionieristica attraverso le aziende, e valutativa attraverso gli uffici, provoca adempimenti inutili, genera
disguidi ed equivoci professionalmente logoranti, e non adeguatamente ripagati, nella
confusione e nel disorientamento indicati al capitolo 4, e che intralciano l’operatività
delle aziende ed i processi decisionali degli uffici (par. 5.3).
Capitolo 4
Determinazione della ricchezza,
studiosi, pubblica opinione
e spiegazioni dell’evasione fiscale
Sommario: 4.1. Conferme macroeconomiche della prevalenza dell’evasione da ricchezza non registrata
– 4.2. Utilità della propaganda nell’autotassazione ed esagerazioni controproducenti – 4.3. Mancata
spiegazione della determinazione della ricchezza ai fini tributari: lo “pseudonormativismo” accademico
– 4.4. Segue: impossibilità di avere spiegazioni organiche da altri studiosi sociali, dai professionisti, dalle
istituzioni, dai mezzi di informazione – 4.5. I riferimenti sensati, ma semplicistici, al “senso civico”, alle
“aliquote”, al “contrasto di interessi”, alla “ragionierizzazione delle stime” – 4.6. Segue: le spiegazioni
politicamente strumentali e socialmente laceranti – 4.7. Spiegazioni istituzionalistiche in una cornice
di unità del diritto e collegamento con altre scienze sociali
4.1. Conferme macroeconomiche della prevalenza dell’evasione da ricchezza non registrata
Nel precedente capitolo terzo abbiamo già analizzato, dal punto di vista delle
aziende e degli individui, le varie forme di evasione tributaria. Prima di ipotizzarne
una quantificazione, in questo paragrafo, cerchiamo di riepilogarne i diversi contenuti. L’evasione da ricchezza non registrata tende ad occultare la materia
altrimenti imponibile, e si pone quindi sul piano delle questioni di fatto;
queste ultime, rilevanti per il diritto nei modi che vedremo al par. 5.8, possono
essere anche contabili e documentali (si pensi alla scoperta di un documento non
registrato), in genere sono “presuntivo-valutative”. L’evasione interpretativa riguarda invece le maggiori imposte accertate per un diverso inquadramento giuridico di vicende comunque rendicontate, sul piano materiale, o comunque di dominio
pubblico. In genere ciò non accade per disattenzione del contribuente, bensì
a seguito di una scelta consapevole di convenienza o indifferenza tributaria. La
sostenibilità di una determinata tesi è valutata anche in relazione alla sua onerosità tributaria (sulla diversa mediazione alla base delle contestazioni interpretative
del fisco vedi par. 3.10 e 5.17 ss.); nell’ambito dell’evasione interpretativa si colloca
anche l’elusione, dove ad essere violato è solo lo spirito del sistema, come indicato
al par. 3.10. C’è poi l’“evasione da riscossione” (par. 6.11), basata sull’attribuzione di
detrazioni, crediti e costi, da parte di chi omette di versare le corrispondenti imposte
78
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
(par. 7.3 per le frodi carosello IVA), violando le simmetrie della tassazione attraverso le aziende (par. 3.9). Vediamo quindi il rapporto tra questi fenomeni e le stime
dell’evasione fiscale.
La stima della ricchezza non registrata è metodologicamente complessa.
Se persino il PIL “registrato” è stimato per ordine di grandezza, la ricchezza “non registrata” può essere solo oggetto di ipotesi, ancora più congetturali.
La metodologia di stima più diffusa, alla base delle quantificazioni diffuse sui “media” è l’eccedenza tra chi si dichiara “occupato”, ipotizzandone un reddito
medio di sussistenza, e gli occupati “ufficiali”, con relativo reddito dichiarato; vi si
comprendono i “lavoratori indipendenti” che dichiarano redditi inferiori a livelli generali di credibilità, come indicato al par. 5.13. Ne deriva una ricchezza non registrata
fiscalmente, stimata poco meno di 300 miliardi di euro (17 percento del PIL), cui corrispondono i circa 120 miliardi di imposte evase, di cui si parla ordinariamente sui mezzi
di informazione.
Questa stima non considera la ricchezza non registrata da chi dichiara comunque cifre superiori ai livelli di sussistenza, come chi dichiara cinquantamila
euro, e ne evade altrettanti. Non è considerata neppure l’“evasione aziendale” (par. 3.8),
tra cui i “fuori busta” dei lavoratori dipendenti, l’evasione da riscossione (frodi carosello
etc...: par. 6.11), gli occultamenti collaterali di cui al par. 3.15.
Queste stime non considerano neppure l’evasione interpretativa sulla ricchezza palese o registrata (par. .10 e 5.18), da cui viene una quota importante del
gettito dei controlli (par. 5.7); queste ultime non sono cifre significative, né sono particolarmente insidiose per il fisco, perché non comportano occultamenti di sorta. Quanto
sopra spinge a ritenere che ci sia una probabile sottostima dell’evasione, confermata
dal numero ridottissimo di contribuenti con redditi dichiarati superiori ai centomila
euro, il che stride rispetto alle abitudini di vita percepite in Italia.
Anche se ci fosse una stima precisa del “nero”, sarebbe scorretto calcolare le imposte
perdute applicando puramente e semplicemente a questa cifra le aliquote di imposta.
L’importo sopra stimato (120 miliardi) deve infatti essere anche affinato sul presupposto
che molte attività “precarie”, se dovessero pagare le imposte, puramente e
semplicemente chiuderebbero, in quanto non più convenienti. Nel senso che la
ricchezza residua, dopo quella prelevata dal fisco, non compenserebbe il rischio e la penosità del lavoro, salvi aumenti di prezzo che potrebbero non essere assorbiti dai clienti.
Ad esempio, la baby sitter a sette euro l’ora, o il manovale a giornata per 50 euro, se dovessero pagare imposte e contributi, non lavorerebbero affatto, oppure aumenterebbero
le tariffe; se però queste ultime non fossero sopportabili dai clienti, scatterebbero aggiustamenti nell’offerta di lavoro indipendente, con una reazione a catena difficile da
stimare in questa sede.
Si può ipotizzare che una parte delle attività sommerse sparirebbe, in quanto non
più conveniente, una parte rimarrebbe perché troppo difficile da individuare, e una
parte emergerebbe, a prezzi più elevati. Il dosaggio tra questi assestamenti dipende
da una serie di variabili del contesto economico sociale, come le opportunità
alternative di impiego e di offerta dei servizi oggetto dell’evasione.
CAPITOLO 4 – DETERMINAZIONE DELLA RICCHEZZA...
79
Comunque, in ultima analisi, sarebbe probabilmente un circolo virtuoso per la coesione organizzativa nazionale, dove si creerebbe una macchina pubblica capace
di stimare valutativamente la ricchezza, operatori economici più strutturati, una
opinione pubblica più consapevole, mentre oggi le recriminazioni di cui al paragrafo
successivo rischiano di portarci in direzione contraria.
Bisognerebbe capire se nel calcolo suddetto confluisce l’attività economica “illegale”, data ad esempio dalla prostituzione, dalle scommesse clandestine, dal commercio di generi contraffatti o di contrabbando. L’economia criminale, basata su furti,
estorsioni (il c.d. “pizzo”) e truffe, e quindi priva di un contenuto di scambio, neppure
è attività “economica” ed è oggetto di stime a parte; quest’ultimo tipo di economia
criminale non va certamente “tassata”, quanto piuttosto “estirpata”.
4.2. Utilità della propaganda nell’autotassazione ed esagerazioni controproducenti
La percezione della richiesta delle imposte è il principale fattore su cui si fonda
la c.d. ”autotassazione”, sulla cui diversità rispetto alla tassazione attraverso le aziende vedi par. 1.5. La percezione, da parte degli individui, di un intervento del fisco abbastanza sistematico, li spinge ad adempiere, anche sulla ricchezza non intercettata dalle
aziende (le quali “impongono le imposte”, che si pagano quando qualcuno le richiede
secondo l’etimologia stessa del termine “imposta”). Qualche volta però le aziende, oltre
a “prelevare le imposte”, effettuano segnalazioni al fisco, che agli occhi dei soggetti segnalati ne rendono più probabile l’intervento, e li spingono ad adempiere.
Questa percezione dei controlli è valutata anche in relazione all’utilità
marginale del denaro, cioè al sostegno del tenore di vita, cioè svaghi, acquisto di una
bella casa, di un’auto, etc., rispetto a un pagamento delle imposte, la cui richiesta è vista
come “improbabile”. Per un artigiano o piccolo commerciante, a differenza del titolare
di una organizzazione, evadere una percentuale consistente dei ricavi effettivi,
comporta, come già rilevato, un aumento significativo delle risorse disponibili per i
bisogni personali, e quindi del tenore di vita.
Al deficit di presenza valutativa diretta sul territorio da parte degli uffici tributari
cerca comprensibilmente di supplire la propaganda; quest’ultima è importante
per “suscitare credenze”, in qualsiasi settore della convivenza umana. Nella vita sociale,
comunicazione e contenuti sono interdipendenti, perché i primi vivono attraverso le
persone che li conoscono, ed a questa conoscenza è strumentale la comunicazione. Anche sulla determinazione della ricchezza quindi occorre un equilibrio tra propaganda e
sistematicità reale dell’azione pubblica.
Nasce invece il fuoco di sbarramento mediatico che potremmo chiamare “lotta all’evasione in televisione”; in una certa misura, anche questa è una
richiesta delle imposte, un invito pressante ad una corretta autotassazione. Si deve
appunto alla propaganda se la ricchezza dichiarata nei settori non raggiunti dalla
tassazione attraverso le aziende mantiene un minimo di credibilità. Mi riferisco so-
80
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
prattutto alla massa dei lavoratori indipendenti al consumo finale, cui da un lato sono
ascrivibili la maggior parte degli imponibili non registrati, ma dall’altro dichiara cifre
consistenti, se si considera il ridottissimo intervento valutativo concreto degli uffici
tributari nei loro confronti. Questo da un lato smentisce le accuse di mancanza di
senso civico (par. 4.5) fiscale, ma dall’altro non può accreditare elogi di “maggior
onestà” rispetto alla media nazionale. È semplicemente l’effetto della propaganda,
trasmesso anche attraverso i commercialisti, unito alla naturale tendenza a “salvare le
apparenze”, apparendo credibili (nonostante l’evasione) rispetto alle caratteristiche
esteriori dell’attività.
Una volta salvate le apparenze, la propaganda non basta più e il contribuente
deve percepire direttamente, nell’ambiente in cui opera, anche se non
direttamente su di lui, una serena e sistematica attività valutativa degli uffici
tributari. Altrimenti, una volta raggiunto un livello “minimo credibile” di ricavi, il
lavoratore indipendente non è più disposto a dichiarare di più, intaccando il proprio tenore di vita; l’unica soluzione è avvertire la sistematicità dell’intervento del
fisco, che non può essere sostituito con la propaganda. Se trasformata in violenza
verbale, essa è controproducente sotto molti profili. I lavoratori indipendenti, chiamati “ladri” perché non dichiarano al fisco parte della ricchezza che si guadagnano,
replicano rilevando quanti dipendenti (soprattutto pubblici) non si guadagnano la
ricchezza su cui pagano le tasse. Si cominciano a vedere quindi i laceranti isterismi
collettivi descritti ai par. 4.5-4.6.
L’enfasi comunicativa rischia anche perdite di credibilità, quando la pubblica opinione avverte l’inadeguatezza della risposta al problema da parte della macchina pubblica,
nel nostro caso a proposito di determinazione valutativa della ricchezza dove le aziende
non arrivano; le generiche invettive contro l’evasione, senza una adeguata azione amministrativa sulla ricchezza non raggiunta dalle aziende, ricordano quel personaggio del
cabaret che, dopo averle buscate in una rissa, dice “me le ha date, ma quante gliene ho
dette”.
Ma c’è di peggio perché l’eccesso di comunicazione si trasforma nel tentativo di
risolvere a chiacchiere i problemi di bagaglio culturale e di intervento amministrativo
indicati al par. 5.3. Al paragrafo 4.6 vedremo i diversivi, grossolani e opposti, di mettere sul banco degli accusati la tassazione in genere, oppure gli operatori economici,
gli organizzatori della produzione del paese, i creatori di posti di lavoro, trasformati in
una specie di “nemici pubblici”. In quest’ultima prospettiva l’enfasi verbale della c.d.
“lotta all’evasione”, innesca un clima guerresco dove tutti si improvvisano generali, la
confusione cresce, si parla per slogan, si smette di ragionare. L’“evasore” entra nel mito,
diventa “un nemico”, viene strumentalizzato a fini politici, creando il fantomatico “partito degli evasori”di cui diremo al par. 4.6.
Si crea così un circolo vizioso che ostacola l’attività degli uffici, nuoce alla società e
paradossalmente spinge chi può a nascondere ricchezza al fisco secondo un filo conduttore del testo, su cui ampiamente paragrafi 4.6, 5.3 e 5.19. Il rimedio è lo studio della
funzione pubblica di determinazione della ricchezza ai fini tributari, cui sono dedicati
i paragrafi seguenti.
CAPITOLO 4 – DETERMINAZIONE DELLA RICCHEZZA...
81
4.3. Mancata spiegazione della determinazione della ricchezza ai fini tributari: lo “pseudonormativismo” accademico
Prima della tassazione attraverso le aziende, i tributi non ponevano autonomi problemi giuridici per giustificare un gruppo di studiosi loro appositamente dedicato; la
determinazione valutativa della ricchezza, da parte di appositi pubblici uffici (par. par.
1.3) era spiegabile col bagaglio culturale generale degli operatori del diritto, mescolando principi di diritto comune e di diritto dei pubblici poteri.
Con la tassazione attraverso le aziende e l’autotassazione (par. 1.4-1.5), questo bagaglio culturale è divenuto insufficiente a coordinare i noti criteri di determinazione
della ricchezza, ragionieristici e valutativi. È stata quindi assecondata, a partire dagli anni
settanta del ventesimo secolo, la formazione di una comunità accademica dedicata allo
studio giuridico dei tributi, forte di circa 200 docenti, relativamente numerosi rispetto
al diritto amministrativo, dove circa 400 docenti devono occuparsi di tutto il resto dei
pubblici poteri; l’urbanistica, l’istruzione, l’ambiente, le infrastrutture, la sanità, l’immigrazione, l’arte e la cultura fanno tutte fanno capo al diritto amministrativo; la suddetta
sproporzione di personale docente è solo in parte spiegata dall’insegnamento del diritto
tributario anche nelle facoltà di economia, in modo molto più sistematico di quello del
diritto amministrativo.
Questa comunità scientifica, benché relativamente numerosa, non è tuttavia
diventata un punto di riferimento, e di aggregazione, delle discussioni sulla
determinazione tributaristica della ricchezza. Restano inevasi gli interrogativi delle
classi dirigenti e della pubblica opinione (par. 1.6), che cerca di supplire nei modi
grossolani indicati ai parr.4.5-4-6. Questo insuccesso non dipende da carenze personali degli appartenenti all’accademia, ma da un problema culturale del diritto in
genere, particolarmente distruttivo, come vedremo, nelle materie complesse come
la nostra.
La causa ultima è l’imbarazzo del diritto, come tutte le scienze sociali, davanti al
prestigio e all’oggettività delle scienze della materia. Gli studiosi sociali, consapevoli dell’indimostrabilità delle scelte di valore, secondo la nota “legge” denominata
“di Hume”, intuivano l’affinità delle loro riflessioni con i discorsi comuni delle persone
sugli stessi temi, senza un chiaro confine tra chiacchiere e “scienze”. Insomma, le scienze sociali, nel loro complesso, giuristi compresi, avvertivano un problema di legittimazione, davanti al quale, invece di una risposta unitaria, sono andate a gruppi in
ordine sparso.
Mentre l’economia si è legittimata con le sue formalizzazioni matematiche, i giuristi hanno risposto con varie idee di scientificità. Una di esse, il c.d. “normativismo”
o “giuspositivismo” (Kelsen, Bobbio, etc.), si preoccupava di distinguere il diritto dai
giudizi di valore, dalla politica, dalla morale, dalla religione e dalle altre scienze sociali; il
normativismo si opponeva al fantomatico “diritto naturale”, incompatibile con la mutevolezza non solo del diritto, ma di tutte le “scienze sociali”. Anche il normativismo
è perfettamente compatibile con la concezione del diritto come studio delle
istituzioni del gruppo sociale, prospettiva di più ampio respiro, adeguata a calare il
82
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
diritto nel tempo e nello spazio, dando conto della sua natura di disciplina “umanisticosociale”.
Nella prassi, però, il normativismo degli studiosi, è stato travisato in una banalizzazione diffusa, appiattendo il diritto sulla legislazione e gli altri “materiali
normativi”; intendo per tali la legislazione, le sentenze, gli atti di organi interni e
sovranazionali, persino le opinioni dottrinali, estrapolate dal contesto e ridotte ad
oggetto, a “riferimento”. Nessun teorico “normativista” del diritto ha mai seriamente sostenuto il suddetto appiattimento sui “materiali”, visto che il normativismo
teorico aveva gli altri obiettivi indicati sopra. Tuttavia una tendenza a considerare
giuridici solo discorsi riferibili ai suddetti materiali normativi, si è autoprodotta,
persino tra gli studiosi.
A questa deriva, oltre che la comprensibile pigrizia mentale degli operatori pratici,
hanno contribuito il mito dell’“onnipotenza legislativa” (par. 2.4), la figura del
giudice (civile) come pietra di paragone delle istituzioni; nel contingente hanno contribuito le codificazioni ottocentesche, connesse al passaggio dal diritto romano, dove
era più forte il ruolo dei “giuristi”, a quello legislativamente stabilito; la codificazione,
utile a mettere ordine nel pensiero, che acquistava certezza, ma perdeva flessibilità è stata
però ulteriormente travisata, nel periodo del trionfo delle scienze fisiche, dal suggestivo
parallelismo tra il loro “dato naturale” e il c.d. “dato normativo”, davanti al quale il giurista si sarebbe dovuto porre come il biologo davanti ai microbi.
La diffusione di questo preconcetto deriva però soprattutto da una caratteristica
del diritto rispetto alle altre scienze sociali, come economia, storia, filosofia, sociologia,
politologia, ed altre in cui domina lo studio, senza bisogni pratici, né operatori pratici;
i relativi cultori sono intellettuali che si rivolgono all’opinione pubblica e alla classe
dirigente, per certi versi “dilettanti” nel senso nobile del termine, appassionati delle loro
ricerche e riflessioni.
Nel diritto sono invece sempre stati dominanti “i professionisti”, che – come
vedremo – non sono studiosi sociali, ma operatori pratici. La loro presenza è stata
probabilmente decisiva per rispondere nel modo più comodo al suddetto problema di
legittimazione delle scienze sociali rispetto a quelle fisiche. Lo pseudonormativismo ha
semplicemente negato il problema ribaltandolo sulle istituzioni redattrici dei “materiali”, e appiattendo il diritto su di essi. I giuristi, sempre minoranza rispetto agli
avvocati, sono stati in parte cannibalizzati culturalmente, appiattendoli sui “materiali”,
e in parte ghettizzati in torri d’avorio prive di contatto con la realtà.
Questo passaggio del diritto dall’analisi delle istituzioni a quella dei loro materiali
era anche comodo per le istituzioni. Queste ultime hanno infatti il problema di
una buona immagine e di gestire obiettivi pragmatici, come già visto per il legislatore
al par. 2.4, ripeteremo al par. 5.3 per le istituzioni amministrative e al par. 6.7 per il
giudice; l’appiattimento del diritto sui “materiali” è una scorciatoia per motivare
decisioni sostanzialmente corrette nel merito e prese comunque in buona fede,
ma dove una razionalizzazione compiuta dei passaggi logici appare troppo impegnativa, sia in termini di tempo sia in termini di rispondenza del risultato
scritto alle intenzioni dell’istituzione redattrice. Riferire la decisione a una “volontà
CAPITOLO 4 – DETERMINAZIONE DELLA RICCHEZZA...
83
estranea”, motivando mediante un “riferimento normativo”, è operativamente
comodo, perché evita di mettersi in gioco, esponendo le scale di valori utilizzate, le
sfumature del proprio ragionamento, evitando che esso possa essere decontestualizzato
o criticato, magari creando un precedente, applicato a situazioni dove sarebbe criticato
dal suo stesso redattore. I riferimenti ai “materiali”, gli stereotipi, le frasi solo
apparentemente in tema e di senso compiuto, di cui diremo pi avanti in questo
paragrafo, alleggeriscono molto queste preoccupazioni di essere criticati o travisati. È un
espediente che snellisce il lavoro e consente di rispettare agevolmente gli obblighi
motivazionali imposti per ragioni di controllo sociale sulle istituzioni. Ne discende un
rafforzamento della posizione di supremazia della pubblica autorità. Non
sono le istituzioni ad aver creato questa situazione, ma neppure hanno il compito di
contrastarla, e legittimamente vi si adattano.
Anche gli avvocati erano poi felicissimi di liberarsi da incombenze teorico
scientifico progettuali, demandate alle autorità da cui provengono i materiali. Queste
risposte praticoidi si sono in buona parte estese a chi avrebbe dovuto essere un teorico,
soggetto però in tutto o in parte alla comoda e inconsapevole mutazione di molti giuristi in avvocati.
Nascevano così, per comodità e strumentalità, gli inconvenienti metodologici del “normativismo teorico”, degenerato in pseudonormativismo. Il principale
difetto è quello di parlare “per riferimenti”, cioè attraverso i materiali normativi, proprio per questo paradossalmente travisati, come vedremo. Questa rudimentale
prospettiva pretenderebbe che qualsiasi riflessione sulle istituzioni, per essere giuridica,
traesse spunto in qualche “dato normativo”, equiparato al dato naturale delle scienze
fisiche; non ci si potrebbe cioè richiamare direttamente al bagaglio culturale
degli ascoltatori, per proporre loro una riflessione, un’ipotesi su cui chiedere una
verifica, ma servirebbe sempre e comunque l’intermediazione di un dato normativo”.
Il dibattito si sposta così “dagli argomenti” ai “riferimenti”, e questo rappresenta
il primo passo verso gli stereotipi apparentemente in tema e quindi verso la progressiva
“morte mentale”; si comincia col sostenere le tesi non perché intrinsecamente convincenti, ma perché conformi, spesso fortuitamente, a un certo “materiale normativo”.
Anche il pensiero di altri studiosi diventa un “materiale”, ed il loro pensiero viene
ridotto ad “oggetto”. La ricerca di scientificità e di legittimazione sociale sostituendo
il “dato naturale” col “dato normativo” è stata più dannosa, per il diritto, di quanto sia
stata l’analoga ricerca, degli economisti, attraverso la “socio matematica” (Lupi, Manuale
giuridico, cit., cap. 5).
Sia pure con varie sfumature, da settore a settore, il diritto ha così perso terreno,
in generale, rispetto alle altre discipline che analizzano la convivenza sociale.
È diminuito agli occhi della pubblica opinione il prestigio dei giuristi come studiosi
sociali, percepiti sempre più come avvocati, tecnici del dettaglio, senza visione di insieme. Si è bloccato il naturale ruolo dei giuristi come studiosi sociali delle
istituzioni pubbliche, con un ruolo analogo a quello che, per il mercato, svolge
l’economia. Gli economisti hanno anzi legittimamente invaso il campo di indagine
dei giuristi con l’“analisi economica del diritto”, mentre l’intervento pubblico in
84
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
economia è in buona sostanza “diritto”. Studiando “i materiali”, anziché le istituzioni,
il diritto si è invece inaridito rispetto alle altre scienze umane, senza avvicinarsi a quelle
della materia, considerato né carne né pesce, a Dio spiacente e a li nimici sui. Il diritto si è
così trasformato in una materia “professionale”, per fornitori di “servizi legali”, incapaci
di trovare la propria collocazione tra gli “studiosi sociali”, e di difenderla dalle conseguenti incursioni di altri studiosi sociali, tendenti istintivamente a occupare lo spazio
vuoto lasciato da altri.
Con la trasformazione dei giuristi in avvocati, essi hanno perso la capacità di essere un punto di riferimento culturale per le “autorità”, redattrici dei “materiali
normativi”; al massimo, sono rimasti a svolgere una funzione notarile, di segreteria legislativa, senza contenuti progettuali. La subordinazione dei giuristi all’autorità politicoistituzionale è un riflesso dello pseudonormativismo e della tendenza degli operatori
del diritto ad attendersi passivamente le soluzioni dalla politica, oppure a gettare il cuore
oltre l’ostacolo, ricadendo disordinatamente nelle divagazioni politico-valoriali cui il
normativismo teorico intendeva rimediare.
Il suddetto preconcetto di parlare per riferimenti ha appesantito la letteratura,
giuridica, frammentando il diritto in tanti compartimenti stagni, ciascuno abbarbicato ai
propri “materiali”. Parlare per riferimenti ha condotto ad una specializzazione esasperata, dove si sapeva sempre di più su sempre di meno, fino a redigere tomi su questioni
liquidabili con una battuta. Questa frammentazione ha accentuato l’autoreferenzialità e
gli aspetti relazionali nella selezione degli studiosi (infra), ostacolato il controllo reciproco dei giuristi, e il controllo sociale “sui giuristi”, con rischi di personalismi,
inquinamenti carrieristici e varie forme di mistificazione.
A questa avvocatizzazione dei giuristi corrisponde una burocratizzazione delle istituzioni, comprese quelle giudiziarie, con la necessità di superare sempre maggiori pastoie per raggiungere la soluzione di volta in volta più sensata.
La tendenza a parlare per riferimenti, anziché analizzare direttamente le istituzioni
ha appiattito il diritto sul presente, danneggiando anche le comparazioni tra società diverse, molto difficili accostando contingenti “materiali “. Benché il diritto, come
modo di argomentare, sia unitario, le legislazioni sono “settoriali”, e quindi sono una
zavorra per i confronti internazionali, la comparazione tra epoche diverse, il dialogo tra
giuristi di settori appena un po’ differenti.
Le ricadute sulla macchina pubblica, e sugli stessi operatori del diritto, che con essa
interagiscono, sono state diverse, per nazione e per settore. La nazione ha i suoi bagagli
cultuali storico –formativi (par. 1.6), che preesistono ai vari settori del diritto, sulle cui
specificità il suddetto atteggiamento pseudonormativistico si inserisce.
Nei settori del diritto più tradizionali, e accessibili al bagaglio culturale della classe
dirigente, i danni sono relativamente limitati; la pubblica opinione qui ha necessità di
specialisti solo come “tecnici”, che possono perciò dedicarsi a questioni sottili, ancorché
poco rilevanti come peso sociale, oppure alla professione. Si tratta di una giuridicità che si esplica nel processo, e guarda al giudice, anche per casi rari, oltre che
accessibili, come incidenti stradali, prestazioni mal eseguite, liti condominiali, recupero
crediti e altri incidenti abbastanza occasionali.
CAPITOLO 4 – DETERMINAZIONE DELLA RICCHEZZA...
85
Nelle funzioni pubbliche di giustizia, e in parte di sicurezza, inoltre, la politica è
meno coinvolta ideologicamente, meno condizionata da aspettative del gruppo
sociale e dalle necessità di rispondergli gli effetti di “comunicazione politica” di cui al
par. 2.4, più attente ad una equilibrata sintesi delle tendenze della società.
Comunque, benché la sostanza di queste materie sia raggiungibile attraverso i
materiali, pur faticosamente, l’appiattimento su di essi è stato sempre criticato dai
teorici.
Lo pseudonormativismo è più dannoso quando la giuridicità si esplica prima
del processo, come appunto in tutto il diritto dei pubblici poteri diversi dalla funzione
pubblica di giustizia (dove anche il giudice è un funzionario pubblico, secondo il filo
conduttore di questo volume, dove anche il diritto civile è in un certo senso amministrativo). Lo pseudonormativismo è devastante per le istituzioni pubbliche non
chiamate a giudicare, bensì a “fare”, ad operare, come in materia militare, ambientale,
sanitaria, urbanistica, infrastrutturale, di sicurezza, e tante altre, compresa la determinazione dei tributi.
Lo pseudonormativismo mette in ombra ogni giuridicità “amministrativa”, tipica
di questi settori, dove un giudice indipendente può anche mancare, persino in paesi
pluralisti e democratici, come è stato per l’Italia (consiglio di stato a parte) fino alla
seconda metà inoltrata del secolo scorso. Lo pseudonormativismo, comunque, produce
ancora danni relativamente limitati quando i pubblici poteri sono alla portata del bagaglio culturale delle classi dirigenti, come accade per sicurezza, difesa, sanità, ambiente,
istruzione, cultura, etc...; inconvenienti nel diritto tributario.
La particolare pericolosità dello pseudonormativismo emerge invece per le materie
amministrativistiche complesse, come la determinazione della ricchezza ai fini tributari.
Sono argomenti troppo sofisticati perché la sostanza delle questioni sia raggiungibile attraverso riferimenti “ai materiali”; questi ultimi, d’altra parte, sono
prodotti da classi dirigenti cui manca il supporto esplicativo degli studiosi, indicato
all’inizio del paragrafo. Ciò allontana i materiali dalla sostanza delle questioni, come
indicato al par. 2.4. Arrivare alla sostanza attraverso “i materiali” è qui ostacolato anche
dai complessi intrecci di segmenti di materie diverse, coordinabili solo in
funzione della determinazione tributaristica della ricchezza.
Oltre che più complesso, il diritto tributario è anche più diffuso, troppo diffuso per
essersi esaurito nella già indicata dialettica civilistica “legge-giudice”; basta pensare che
la maggior parte delle persone non varca la soglia di un tribunale nel corso di una intera
vita, mentre le imposte sono dovute con ricorrenze infrannuali.
Inoltre, il principale problema tributario agli occhi della pubblica opinione,
cioè la ricchezza non registrata dove le aziende non arrivano, è prevalentemente “di
fatto”, e quindi sfugge “ai materiali”. Da qui a non considerarlo problema “giuridico”
il passo è breve, e lo conferma l’atteggiamento sul tema della maggior parte dei manuali
universitari, che inconsapevolmente confondono la “giuridicità” con l’esposizione di
“materiali”, e la ricerca dei contenuti attraverso di essi.
Lo pseudonormativismo porta a zigzagare tra parafrasi dei materiali, collegate tra
loro con espressioni apparentemente in tema, ma prive di un reale senso compiuto sul
86
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
piano della determinazione della ricchezza, condite però con le divagazioni politiche
di cui diremo. Anziché accostare e coordinare riflessioni e pensieri, si parla attraverso
terzi, perdendo pian piano la capacità stessa di pensare. Fino ad arrivare al punto di
chiedersi “dove sta scritto” davanti a qualsiasi ragionamento sensato, nel nostro caso sulla
determinazione tributaristica della ricchezza, con cui pian piano si perde il contatto.
Come è puntualmente successo, tlo pseudonormativismo si è trasformato in una specie
di ”oppio dei tributaristi”, che ne intacca la capacità stessa di esaminare la sostanza del
proprio settore, facendoli superare da altri analisti, come vedremo al par. 4.5.
I primi sintomi dell’indebolimento del pensiero si avvertono con la mancata contestualizzazione dei materiali, alcuni dei quali vengono momentaneamente sopravvalutati, poi dimenticati, altri messi in dubitative contraddizioni, altri del tutto ignorati;
invece di coordinare, contestualizzandoli, gli spunti circolanti nel settore, l’accademia
si presenta riportando i materiali di passaggio &&&&&&, restando sempre al punto
di partenza. Senza avvicinarsi alla soluzione e senza neppure capire il problema, cioè la
determinazione della ricchezza ai fini tributari.
Si doveva arrivare alla sostanza passando attraverso i materiali, e invece vi si passa attraverso per non arrivare da nessuna parte, ma con estenuanti serie di citazioni, che sembrano liste della spesa, adombrando imprecisate “verità nascoste” nei
materiali, spesso per nascondere la mancanza di contenuti. A forza di scrivere in
questo modo, di non poter richiamare il bagaglio culturale dei lettori, in funzione
dei nostri ragionamenti e delle nostre intuizioni, viene meno la voglia stessa di
scrivere. Dover “pensare attraverso i materiali” somiglia a una specie di divieto di
pensare, e fa passare, alla lunga la voglia di scrivere e di riflettere. Un polverone
ricopre così il settore tributario negli studi professionali (par. 3.16), nelle aziende, negli uffici, inceppando l’esame diretto della determinazione tributaristica della
ricchezza.
Si producono così litanie di stereotipi riproduttivi di materiali normativi o dottrinali, collegati da frasi di cerniera, che ammiccano a potenziali interpretazioni dei
materiali, lasciate sullo sfondo in modo prolisso, tortuoso, sussiegoso, tendenzioso o
deferentemente rispettoso, a seconda di come si colloca l’autore nella gerarchia accademica. Questo passaggio attraverso i materiali consuma quantità enormi di energie
intellettuali, rendendo tortuoso il ragionamento, più di quanto avrebbe potuto essere
andando direttamente alle questioni. La mancanza di un senso effettivo all’interno di
questi scritti non è però immediatamente evidente. Si tratta quindi di opere difficilissime da contestare, proprio perché si presentano apparentemente in tema;
non è facile dimostrare a terzi che in questi casi la sostanza è solo apparenza. Se nessun
passaggio è convincente, ma nessuno è palesemente fuori tema, è sempre più facile difendersi da una critica. Se invece ci si richiama ai contenuti ci si espone, perché nessun
discorso di sostanza analizza tutta la sostanza, né la potrebbe analizzare bene, esponendosi quindi alla critica proprio a causa della propria accessibilità. Le decine, o centinaia
di pagine, omogeneamente prive di contenuto, ma apparentemente in tema, si difendono invece l’un l’altra. Sono falangi macedoni di stereotipi inattaccabili prendendone
una parte e chiedendosi cosa voglia dire, in quanto tutta l’opera è chiusa a difesa, nella
CAPITOLO 4 – DETERMINAZIONE DELLA RICCHEZZA...
87
propria ineffabile inaccessibilità. Che consente di replicare al critico di non aver capito
il “senso complessivo dell’opera”.
Questi discorsi ineffabili, fumosi ed ellittici, né giusti né sbagliati, sono una
costante nelle relazioni sociali, e le motivazioni possono anche essere comprensibili e
nobilissime, come vedremo al prossimo paragrafo. Se però i discorsi apparentemente in
tema prendono piede presso uomini di sapere, le attenuanti svaniscono e ci troviamo
davanti a una mistificazione dolosa, con l’unica scusante di essere in buona compagnia. Impostore è chi cerca di accreditarsi come possessore di conoscenze di
cui è privo, e a questo scopo cerca legittimazione, disorientando l’interlocutore con
sussiegosi discorsi apparentemente in tema. Per le istituzioni, usare stereotipi e frasi di
circostanza è un legittimo strumento per gestire in modo efficiente una posizione di
potere; per chi aspira a una posizione “di sapere”, parlare senza dire nulla significa oggettivamente usurpare ruoli, in una impostura più o meno consapevole, attenuata solo
dalla sua diffusione. Davanti al problema di legittimazione delle scienze sociali (sopra),
il sussiegoso sproloquio è una risposta subdola, che diventa mistificazione, autodifesa
preventiva dalle accuse di essere un bluff, rintuzzate accusando i critici di “non capire
la profondità del messaggio”. Gli impostori giocano appunto sulla difficoltà di distinguere discorsi provvisti di senso (infra) e discorsi solo apparentemente tali, dove però
la mancanza di filo conduttore viene presentata come indizio di chissà quali significati
reconditi. L’appiattimento sui materiali si diffonde infatti per contagio in un ambiente
timoroso e imitativo, che conferma la frase esoterica abyssus abyssum vocat. Questi
scritti facili da redigere, che non impegnano il pensiero, lo fanno svanire gradualmente
e inconsapevolmente, conducendo pian piano in un “buco nero” senza contenuti, che
per le scienze sociali è l’inverso della scientificità.
Manca infatti la sensatezza, che nelle scienze sociali, è per molti versi l’equivalente della verificabilità o falsificabilità nelle scienze della materia. La sensatezza è un presupposto indispensabile per valutare un’opera, un articolo, un discorso, che si sottrae in partenza all’analisi se invece disorienta il destinatario, mettendolo in
difficoltà e impedendogli un assenso o consenso consapevole. È infatti impossibile esaminare “nella sostanza” ciò che di sostanza è privo, ma che finge di esserne provvisto ed
è quindi solo in apparenza provvisto di “sensatezza”, o significanza (Scarpelli); sensatezza vuol dire solo presenza di quel filo conduttore necessario ad una valutazione da parte di un uditorio. Una volta superata questa fase si può passare al merito,
alla condivisione o alla disapprovazione, tenendo conto dell’indimostrabilità empirica
dei giudizi di valore (legge di Hume). Su questa premessa le riflessioni “disapprovate”
sono molto meno insidiose dei discorsi solo apparentemente sensati. Vediamo però gli
interlocutori degli studiosi sociali, cioè in campi dove mancano i ristretti gruppi di
specialisti delle scienze fisiche, dove il controllo sociale avviene attraverso i risultati; le
scienze sociali dovrebbero invece offrirsi in modo trasparente, lineare, al bagaglio
culturale di vasti gruppi di interlocutori, in gran parte pubblica opinione e classe
dirigente (par. 1.6); lo confermano gli antichi filosofi, che non discutevano certo tra
loro, ma con la classe dirigente, gli spiriti elevati, le elites dell’epoca. Complicare le cose
semplici, legittimandosi abilmente come “esperti” è una facile scorciatoia per avere
88
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
un po’ di credito nelle scienze sociali; è sufficiente infatti complicate ad arte
questioni semplici; a quelle complesse, semplificate male, spesso sfugge, ma ci si orienta
subito tenendo presenti i requisiti della sensatezza e della accessibilità, tipici delle scienze umane, dove la complicazione consiste nel coordinare molti concetti semplici, senza
perdere la sensatezza. Chi ci prova tentare di semplificare concetti complessi, si espone
alle critiche, se si fallisce, ed alle gelosie, se si riesce; con varie combinazioni intermedie.
Per questo i discorsi apparentemente in tema sono socialmente pericolosi non
per il loro contenuto, il che presupporrebbe un giudizio di valore, ma per la loro
consistenza piena di vuoto, intrisa di riferimenti e divagazioni prive di senso compiuto. Per questo la determinazione della ricchezza ai fini tributari diventerà scientifica
solo quando si comincerà a non considerare scientifici tali scritti; queste tortuose litanie,
scritte per sfondare a colpi di monografie le porte delle università, non sono un danno
in sé, ma screditano tutti i libri; il loro dilagare ha infatti bloccato le riflessioni sulla
determinazione tributaristica della ricchezza, destrutturato la pratica del settore (cfr. il
prossimo paragrafo), lacerato di polemiche inutili la società (par. 4.6), a conferma che il
sonno della ragione produce mostri.
Scatta così la curiosa contraddizione di criticare “il legislatore”, invocandolo
subito dopo, perché risolva problemi di cui lo pseudonormativismo neppure mette
a fuoco i termini, per via dei suddetti preconcetti metodologici di pensare attraverso
i materiali. Non ci si accorge di alimentare, in questo modo, il circolo vizioso di cui
al par. 2.4, con leggi emanate per rispondere a queste “critiche-invocazioni”; queste
“critiche – invocazioni” fondono la bestemmia e la preghiera, senza capire che i giuristi
dovrebbero aiutarsi da soli. Viene così alimentato il circolo vizioso, già indicato al par.
2.4, delle leggi emanate per dire di aver fatto qualche cosa, creando più problemi di
quelli che risolvono.
Il pregiudizio di dover “pensare attraverso i materiali” impedisce agli studiosi di
essere un punto di riferimento per le istituzioni nella materia loro affidata; ci si restringe quindi in un approccio praticoide avvocatesco, secondo cui i mali del diritto
starebbero nella politica, senza rendersi conto che il malato è proprio il diritto, inteso come punto di osservazione della convivenza sociale e dell’intervento pubblico. Pensando attraverso “i materiali”, quelli che dovrebbero essere studiosi sociali, si
impantanano in questioni di dettaglio che le classi dirigenti neppure prendono in
considerazione, dalla loro prospettiva. Oppure divagano, come vedremo più avanti, su
temi di politica generale, venendo meno appunto ai già indicati obiettivi “di rigore”
proposti dal normativismo.
Questa disaffezione priva la classe dirigente e le istituzioni dei punti di riferimento
che avrebbero dovuto venire dall’accademia, e quindi i “materiali” tendono a peggiorare. Nella pubblica opinione di intrecciano e coesistono spunti, intuizioni, molteplici
e scoordinati, sulla determinazione tributaristica della ricchezza, cui in modo estemporaneo di cerca confusamente di dare un qualche seguito, creando un ginepraio. Ne
deriva un aumento quantitativo (par. 2.4) e un peggioramento qualitativo dei “materiali normativi”. Lo pseudonormativismo indirettamente provoca “cattivi materiali
normativi”, in un circolo vizioso dove, attraverso di essi, è sempre più difficile com-
CAPITOLO 4 – DETERMINAZIONE DELLA RICCHEZZA...
89
prendere la sostanza. Questo circolo vizioso condiziona la stessa attività legislativa, presa
tra invocazioni e delusioni della pubblica opinione, indicate al par. 2.4.
Appiattendosi sui “materiali”, l’accademia imputa il malessere al legislatore, invocandone al tempo stesso l’intervento per rimediarvi. Queste simultanee critiche e invocazioni al “potere” dimenticano che esso è solo l’espressione del gruppo sociale, con tutte
le sue incertezze e contraddizioni. È paradossale che studiosi del diritto, benché appiattito sulla legislazione, confidino nella razionalità di politici selezionati per lo meno in
modo estemporaneo. Se neppure gli studiosi hanno colto la determinazione tributaristica della ricchezza, è strano che se le attendano da una politica preoccupata
di coesione e consenso sociale, non di sistematizzazione dei concetti, spettante invece
agli studiosi (par. 2.4).
Qualche volta, le crisi di rigetto dell’appiattimento sui materiali spingono a cadere nell’eccesso opposto, sconfinando nelle divagazioni politiche che il positivismo giuridico voleva combattere. Dal pregiudizio di subalternità del diritto verso
la politica si cade nella pretesa di insegnare alla politica a fare il suo mestiere,
divagando sull’effetto economico-sociale dei tributi, sulla crescita, lo sviluppo, lo stato e
il mercato, in una prospettiva politico economica distinta da quella della determinazione dei tributi, come indicato al par. 1.7. Il rapporto poco sereno con la politica spinge
molti studiosi sociali a “scendere” in una politica già pletorica, che invece ha
bisogno di supporti esterni. Invece di analisi delle istituzioni e della determinazione
della ricchezza, chi si allontana dai materiali normativi divaga genericamente su profili
economico politici (una volta si diceva la “butta in politica”), confermando il rapporto
poco sereno tra diritto e politica indicato al par. 2.4.
Anche quando si rimane più sul piano concettuale, riferendosi a valori giuridici
come contraddittorio, trasparenza, difesa, buona fede, codificazione, ed altri, essi vengono enunciati isolatamente ed enfaticamente (come se fossero “valori assoluti), eludendone il coordinamento, che è poi il vero compito dello studioso sociale.
Attribuire ad un fantomatico “legislatore” le disfunzioni sulla determinazione della ricchezza ai fini tributari, è per molti versi un alibi per esorcizzare i sensi di colpa
derivanti dalla trasformazione dei giuristi in avvocati, venendo meno – come rilevato
sopra – al loro ruolo di studiosi delle istituzioni sociali. È infatti normale l’estraneità
del civilista rispetto alle patologie sociali oggetto del processo, trascurando che invece
l’oggetto del suo studio è l’“istituzione-giudice”. In materia tributaria l’attenzione alla
professione (processuale) anziché alle istituzioni (amministrative) è confermata dalle
energie dedicate ad aspetti “di rito”, soprattutto processuali e professionali (consulenzial-avvocateschi) ed alle lucrose pratiche sul regime della ricchezza registrata (il diversivo delle contestazioni interpretative di cui al par. 3.10) anziché al tema strutturale della
determinazione della ricchezza e di quella “non registrata” (che tanto turba la pubblica
opinione).
Questa deriva professionale è accresciuta dal notevolissimo lavoro di consulenza generato dalla confusione di cui stiamo parlando. È un lavoro socialmente
inutile nel suo complesso, ma professionalmente profittevole per la mancanza di retroterra teorico, di cui stiamo parlando. Lo sbilanciamento degli avvocati rispetto
90
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
ai giuristi è fortissimo, anche se i due ruoli possono sovrapporsi, in capo agli stessi
individui, con varie sfumature.
Il giurista sistematizza le riflessioni della classe dirigente in un settore, mentre l’avvocato legittimamente gestisce le pratiche che gli sono capitate; la professione offre al giurista utili spunti, ma rischia la dispersione casistica, senza collegamenti di ampio respiro
e sacrificando la sistematizzazione. Del tutto legittimo fare professione, ma il giurista
si distingue per aver affinato la sistematizzazione e il collegamento. Soprattutto senza
confondere la realtà professionale, rilevante per il cliente, con la realtà sociale, rilevante
per le istituzioni e le classi dirigenti con necessità di punti di riferimento, spiegazioni e
risposte. Ritorneremo però al prossimo paragrafo sull’equivoco della “cultura professionale” come supplenza della cultura istituzionale.
È questa la radice della confusione sociale sulla determinazione tributaristica
della ricchezza, priva di un punto di riferimento per la pubblica opinione e le classi
dirigenti. Queste ultime infatti, di fronte alla mancanza di un’accademia in grado di
far loro da guida, riprendendo e organizzando le loro riflessioni, non perdono tempo: si rendono conto dell’inadeguatezza e dell’inutilità dei discorsi dell’accademia, la
ringraziano cortesemente e tentano poi di andare per proprio conto, improvvisando
nei modi indicati ai prossimi paragrafi. Lo stesso distacco è manifestato, nel loro
complesso, dagli operatori pratici di cui al par. 3.16; salva l’imitazione acritica di
pochi, la maggioranza si fa una idea distorta e negativa della “teoria”, cadendo senza
accorgersene nell’appiattimento sui materiali “in versione professionale”, di cui al
prossimo paragrafo.
Ne riparleremo al par. 4.7, mentre ora torniamo agli effetti di quanto precede sulla
stessa comunità scientifica, dove il già indicato appiattimento sui “materiali”
ostacola le cooptazioni sui contenuti. La già indicata “alienazione” sui “materiali”
distrae rispetto alla determinazione tributaristica della ricchezza, alimenta parametri
inevitabilmente relazionali, inevitabili in tutti gli ambienti scientifici, ma qui non più
arginati dai contenuti. Smarrendo questi ultimi, l’accademia perde il senso della
propria esistenza, diventando una “espressione burocratica ”, finalizzata alla
spartizione di cattedre. Alle quali corrisponde una capacità di inquadramento della determinazione dei tributi inferiore a quella diffusa nelle classi dirigenti. Senza contenuti,
in preda ai noti sproloqui pseudoscientifici, senza ruolo sociale, la comunità scientifica trova il proprio collante solo nella riproduzione accademica dei singoli. Come se
l’importanza dei giuristi dipendesse dagli allievi piazzati ad occupare le università, non
dalla riflessione sulle istituzioni. Anche le questioni dei concorsi universitari sono un
corollario deprimente dello svuotamento sostanziale del diritto, e andranno a posto
quando il pensiero riacquisterà importanza rispetto ai già indicati sussiegosi sproloqui
sui “materiali”.
In materia tributaria questo svuotamento dell’accademia crea i danni sociali indicati
ai prossimi paragrafi, dove vedremo che nessuno riesce a sostituirsi a un gruppo di studiosi dedicati, come polo di aggregazione delle idee. Poi parleremo delle vie di uscita
al par. 4.7.
CAPITOLO 4 – DETERMINAZIONE DELLA RICCHEZZA...
91
4.4. Segue: impossibilità di avere spiegazioni organiche da altri studiosi
sociali, dai professionisti, dalle istituzioni, dai mezzi di informazione
La carenza di spiegazioni sulla determinazione della ricchezza, indicata al precedente paragrafo, genera un vuoto che molti cercano vanamente di riempire,
per varie ragioni che indicheremo. In questo paragrafo parleremo di studiosi di altre
scienze sociali, di professionisti, di associazioni di categoria e istituzioni. Nel prossimo parleremo delle spiegazioni spontaneistiche, che si autoproducono nella pubblica
opinione.
Gli economisti furono i primi studiosi sociali a dedicarsi ai tributi, ponendosi però dal punto di vista economico, degli effetti sulla produzione e gli scambi; in
quest’ottica essi giustamente valutavano anche la qualità della spesa, come precisato
all’inizio del par. 1.7; sono analisi estranee alla determinazione della ricchezza ai fini
tributari, collocata invece nella cornice delle istituzioni “politico-amministrative”.
Alla determinazione della ricchezza sono estranei anche i ragionamenti economicopolitici sull’equità sociale dei diversi tributi, la progressività etc., anch’essi diffusi tra
gli economisti. Qualche volta viene lambito anche il nostro tema, che però non è
“centrale” in questi studi, molto di sostanza, ma un po’ astratti, specie se accompagnati
da formalizzazioni matematiche e grafiche. L’analisi economica, proprio in quanto
elaborata sugli scambi di mercato, è infatti inadeguata da sola a spiegare i comportamenti delle istituzioni “politico-giuridiche”, su cui torneremo al par. 5.3. Pur potendo utilmente integrarsi coi giuristi, specie analizzando il “peso sociale” dei fattori
che incidono sulla determinazione tributaristica della ricchezza, gli economisti non
possono sostituirli.
Se per gli economisti hanno difficoltà di supplenze per il diverso indirizzo della
loro vocazione teorica, i professionisti hanno il problema opposto. Qui l’indirizzo sarebbe anche giusto, però manca la vocazione teorico-sistematica. L’ambiente dei professionisti, e delle loro associazioni di categoria, è più giuridico e aziendale, ma non è sistematico proprio in quanto “pratico”; legittimamente infatti la
professione è priva di ambizioni concettuali, seguendo contingenze e preoccupazioni
più immediate. Il professionista non è infatti uno studioso sociale, come l’economista o il giurista, ma un prestatore di servizi a pagamento. Il suo orizzonte
non è l’elaborazione di una teoria aderente alla realtà, ma la soddisfazione di bisogni
pratici. I professionisti non vedono le riflessioni delle classi dirigenti come un oggetto
da sistematizzare, considerandole invece uno strumento legittimo per i propri obiettivi professionali di convincere una qualche istituzione. L’orizzonte professionale è
infatti inevitabilmente quello della gestione del contatto col cliente,della “raccolta del
mandato”, dell’espediente tattico, della valorizzazione del risultato. L’obiettivo dei
professionisti è il caso singolo, non la sistematizzazione dei concetti, ed il
loro dinamismo mentale è perciò distorto dalla questione specifica, e disperso su innumerevoli dettagli, specialistico nel modo effimero e casuale commentato al paragrafo
precedente. Il professionista non ha motivo di imporsi gratis sforzi di astrazione, analisi
degli spunti generali nati nella pubblica opinione e loro comunicazione. Il punto di
92
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
vista professionale è il servizio al cliente, e si può essere ottimi avvocati senza una visione sistematica di ampio respiro.
I professionisti, specie se scrupolosi, hanno però spesso bisogno di riflettere e confrontarsi sulle loro questioni, ed anche di contestualizzare un minimo il proprio ruolo e
le proprie priorità, nel contesto di confusione indicato al par. 3.16.Vista l’inadeguatezza
della pubblicistica accademica rispetto a questa necessità sono nate una editoria e una
convegnistica dirette ai professionisti. Anch’esse però hanno risentito sia pure in modo
diverso degli inconvenienti indicati al paragrafo precedente. Operatori editoriali di vario tipo hanno infatti alimentato un appiattimento più schematico-praticoide cercando
di riempire, rivolgendosi ai professionisti, lo spazio lasciato vuoto dall’accademia.
Gli autori sono spesso dei professionisti, che da un lato amano scrivere e dall’altro si
accreditano con la pubblicistica, alimentando il proprio sistema di relazioni coi clienti.
È una pubblicistica virtuale, effimera, che riparte ogni giorno da zero, senza
sedimentarsi: queste aziende editoriali, molto utili per le banche dati online e per i
software per la tenuta di contabilità e altri adempimenti, sono estranee ai contenuti
sostanziali della determinazione tributaristica della ricchezza. È una letteratura
adatta a un pubblico aziendal-professionale, ma anch’essa appiattita sui materiali, senza
ragionamento. La possibilità di queste organizzazioni di valutare solo indirettamente i
contenuti ha dato luogo ad una serie di equivoci, che hanno bloccato il tentativo di
riuscire dove gli studiosi avevano fallito; l’unico aspetto positivo di questa letteratura
è forse che non si preoccupa di “mostrarsi scientifica” complicando sussiegosamente
questioni semplici. Del resto, vista la sua finalità professionale, quest’editoria neppure si
pone il problema di sostituirsi all’accademia nel coordinare e organizzare le riflessioni
della classe dirigente sulla determinazione della ricchezza ai fini tributari; ciò persino
quando queste organizzazioni, come il sole24ore, cercano di creare una “accademia
parallela”, a proprio uso e consumo.
Un enorme polverone sensazionalistico-praticoide di materiali normativi, più o
meno parafrasati e chiosati, si riversa quindi sugli addetti ai lavori, aumentando il disorientamento già indicato al par. 3.16. Per attrarre e vendere, queste pubblicazioni sostituiscono il ragionamento con l’“aggiornamento”, le “novità”, legislative, amministrative o giurisprudenziali; questo continuo aggiornamento del nulla ha creato uno stato di
incertezza e confusione, dove quest’editoria cannibalizza se stessa.
Gli operatori del settore infatti progressivamente si disaffezionano, sempre più consapevoli di avere i materiali alla loro portata con ricerche ipertestuali nelle banche dati.
Alcune riviste continuano ad essere acquistate per abitudine, e lette solo se
spinti da un interesse professionale; le vendite diminuiscono anche per la moltiplicazione dell’offerta a causa di internet, che scalfisce l’intermediazione editoriale.
La conseguente moltiplicazione dell’offerta editoriale non si è accompagnata ad
un corrispondente aumento del tempo disponibile per i lettori, cartacei e informatici.
Quindi la quota di lettori per pubblicazione è inevitabilmente minore, con un eccesso
di informazione che ostacola il ragionamento, e quindi la formazione. Anche qui la
moneta cattiva, sovrabbondante, scaccia quella buona, come avevamo visto per la pubblicistica universitaria (par. 4.3). Quest’ultima è indotta anzi a rivolgersi “ai professioni-
CAPITOLO 4 – DETERMINAZIONE DELLA RICCHEZZA...
93
sti” anziché alle classi dirigenti, perdendo ulteriormente la propria funzione di punto di
riferimento settoriale per la pubblica opinione.
Alla fine gli scritti incisivi e gradevoli si diluiscono, molti operatori smettono di leggere qualsiasi cosa per aver trovato troppi scritti che, anche qui, parlano senza dire nulla.
Neppure le aziende possono paradossalmente colmare le carenze formative sulla tassazione ragionieristica di cui esse stesse sono parte essenziale; proprio in quanto gruppi sociali tenuti assieme dalle prestazioni per il mercato, le aziende
sono incapaci di spiegare i fenomeni sociali, in quanto ciascuna è legittimamente assorbita dal proprio specifico “business”.Vedremo ai par. 5.17 e ss. che le aziende, incapaci
di rendersi conto della “tassazione attraverso le aziende”, che pure le coinvolge direttamente, sono a maggior ragione incapaci di spiegarla alla pubblica opinione. Anche le
associazioni di categoria delle aziende, o gli organi di informazione di loro proprietà
(sole24 ore), sono comunque troppo assorbiti dalle contingenze per essere poli di aggregazione delle riflessioni sulla determinazione tributaristica della ricchezza. Maggiore
concretezza emerge spesso in associazioni di categoria “minori”, ma con sensibilità
mediatica, come la CGIA di Mestre, associazioni di consumatori, e simili.
Questa elaborazione non compete neppure alle istituzioni politico-amministrative, Agenzia delle Entrate in testa, che pure capiscono molto di quanto descritto
in questo testo. La loro dirigenza, negli ultimi decenni, è stata anche quella più reattiva
e propositiva nel comprendere la determinazione tributaristica della ricchezza. Il che
è apprezzabile se si considera la “comodità istituzionale” dello “pseudonormativismo”,
indicata al par. 4.3, dove le istituzioni, in un contesto drammatizzato e di discorsi solo
apparentemente in tema, vedono enormemente aumentare il loro potere e la possibilità
di profittarne.
Tuttavia le istituzioni non hanno modo di supplire al ruolo esplicativo di una comunità di studiosi, non solo perché devono rendere conto alla pubblica opinione nei modi
indicati al par. 5.3, rispettando le diverse concezioni dell’evasione tributaria, diffuse nella cultura di massa, quantunque intrecciate e contraddittorie (par. 4.5/4.6). Nel contesto
socialmente lacerato che circonda la determinazione della ricchezza ai fini tributari, un
ruolo esplicativo delle istituzioni rischierebbe anche di innescare polemiche politiche.
Infine, esse hanno anche poche energie per immaginare e proporre sistematizzazioni concettuali della determinazione tributaristica della ricchezza, dovendo mantenere
sbrigare contingenze operative, autoamministrarsi, gestire la quotidianità comunicazionale, gli eventi di circostanza, etc...
Dispersiva, non derivando da istituzioni stabilmente collegate alla materia tributaria,
è anche l’analisi di organi privi di una tradizione istituzionale nel settore; ricordiamo i c.d. “ispettori tributari”, il soppresso “comitato per l’interpello antielusivo”,
la scuola centrale tributaria (oggi scuola superiore dell’economia e delle finanze), la
Corte dei Conti, con analisi che ogni tanto “bucano” i mezzi di informazione, i vari
servizi studi, come quello di Banca d’Italia. Analogamente dispersive le varie commissioni di volta in volta istituite da questo o quel ministro; perché quando la politica comprende l’importanza di un problema su cui non vede soluzioni, prende legittimamente
tempo e mostra attivismo istituendo una commissione.
94
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
Una spiegazione non può venire neppure dai mezzi di informazione, che inevitabilmente risentono il disorientamento della pubblica opinione, amplificandolo; ne
derivano riscontri altalenanti dei diversi atteggiamenti della pubblica opinione davanti
al fenomeno, indicati al par. 4.5. I “media” devono poi ottimizzare spazi brevissimi interessando lettori e ascoltatori, alle cui ricettività ed attenzione devono relazionarsi. Più
sono brevi i pezzi, più diminuiscono le ricadute formative dei “media” e si rischia di
impantanarsi sui luoghi comuni.
I mezzi di informazione sono tuttavia importantissimi, per l’efficienza delle istituzioni, proporzionale alla capacità di valutazione della pubblica opinione nei vari settori,
come vedremo al par. 5.3. Le scienze sociali, del resto, a differenza di quelle della materia, non si spiegano coi loro obiettivi e risultati, ma devono relazionarsi a un numero
indeterminato di interlocutori, seguendone il bagaglio culturale e l’attenzione.
Anche la determinazione tributaristica della ricchezza può essere veicolata in “pillole di comunicazione”, adeguate alle diverse circostanze, senza sussiego
professorale nè facile enfasi “pro fisco” o “antifisco” (par. 4.6). In quest’ottica studiosi
capaci di comunicare dovrebbero interagire con l’informazione, desiderosa di contestualizzare le notizie, oltre che di “audience”. È un dovere civico per entrambi.
4.5. I riferimenti sensati, ma semplicistici, al “senso civico”, alle “aliquote”, al “contrasto di interessi”, alla “ragionierizzazione delle stime”
Davanti a una disorganizzazione, apparentemente inspiegabile, della determinazione della ricchezza, la pubblica opinione reagisce per proprio conto in ordine
sparso. Sono risposte inevitabilmente estemporanee, in quanto chi le elabora è dedicato ordinariamente ad altri compiti (si pensi ad esempio alla varietà di argomenti cui
deve interessarsi un politico o un giornalista). È la sorte delle ipotesi formulate da chi
affronta queste tematiche per una funzione istituzionale occasionale, come quella di
alto magistrato, presidente di una commissione parlamentare, di un gruppo di ricerca,
o di una istituzione di settore. L’interesse alla determinazione della ricchezza ai
fini tributari è diffuso, ma variabile in relazione ai punti di vista: la politica guarda
al consenso e alla coesione sociale (par. 2.4), l’amministrazione pubblica deve “coprirsi”
rispetto alla legge e fare “risultato di servizio” (par. 5.3), il giudice deve risolvere una
controversia nel modo più agevole e meno criticabile possibile (paragrafo 6.10), i professionisti sono ingolfati come indicato al par. 3.16, gli studiosi sono paralizzati dagli
equivoci metodologici di cui al par. 4.3, i giornalisti devono riempire una pagina o un
programma TV, gli studenti ingurgitano qualsiasi cosa serva a superare l’esame. Uno sfacelo, insomma, dove nessuno, isolatamente considerato, riesce a smuovere gli stereotipi,
teorici o pratici, che ricoprono il settore e inceppano il pensiero.
Il bagaglio culturale della classe dirigente consente a molti di capire che il problema è la ricchezza non registrata, e di intuire alcune linee di intervento a prima
vista sensate, ma scoordinate e riduttive rispetto alla complessità del problema. Sulla
determinazione della ricchezza si intrecciano infatti varie culture giuridiche, azien-
CAPITOLO 4 – DETERMINAZIONE DELLA RICCHEZZA...
95
dali, economiche e politiche, rispetto alle quali il bagaglio delle classi dirigenti, con le
carenze di cui al par. 1.6, non permette una visione d’insieme e un controllo sociale
sufficiente (che invece è possibile, come abbiamo visto al par. 4.3, per altri settori del
diritto strutturalmente più semplici, come quelli civili e penali).
Molti economisti, politici, pubblicisti, giornalisti, scrittori, organi professionali e istituzioni, tentano comunque una supplenza davanti alle mancate risposte accademiche.
Davanti ai noti squilibri nella determinazione della ricchezza, molti esponenti della
classe dirigente forniscono, nella massima buona fede, ricette per salvare la
Patria. Sono tentativi apprezzabili, ma discontinui, scollegati tra loro, inevitabilmente personalistici, dove idee semplicemente sensate, ma ancora limitate, sono presentate come una ricetta risolutiva. L’affinamento, il coordinamento e la valutazione di
realizzabilità di questi spunti richiederebbe l’impegno costante di un gruppo di studiosi
dedicati, capaci di padroneggiare la realtà. Altrimenti alla cortina fumogena dei “materiali parafrasati” si affianca quella dei discorsi sensati, ma scoordinati, e ripetuti ripartendo sempre da zero. Senza questo polo di aggregazione, questi tentativi sono destinati
a rimanere isolati, perché i rispettivi promotori sono a loro volta impegnati in altre
parallele incombenze, politiche, istituzionali o giornalistiche.
Qualcuno tenta di spiegare l’evasione fiscale con le aliquote troppo alte; ne
derivano proposte, a prima vista accattivanti, di “aumentare il gettito diminuendo
le aliquote”.Visto che in sede di controllo è difficile chiedere, per le grandi imposte
(tra aliquote, interessi e sanzioni), più della ricchezza evasa, aumentare le aliquote
“toglie spazio” alla portata dissuasiva delle sanzioni. Gli automatismi ragionieristici
della tassazione attraverso le aziende, funzionano invece a prescindere dall’eccessività
delle aliquote, e la loro riduzione incide pochissimo sull’evasione, mentre incide negativamente sul gettito. Abbassare le aliquote per tutti provoca infatti una perdita di
gettito sulla ricchezza raggiunta dalle aziende, lasciando sostanzialmente indifferente,
in assenza di un sistematico intervento valutativo degli uffici, quella dove le aziende
non arrivano.
Qualche fortuna ha anche la spiegazione basata sul “senso civico”, già anticipata al par. 4.2 a proposito dell’impatto della propaganda sull’autotassazione, e delle
sue ricadute in termini di lacerazioni sociali. Queste spiegazioni trascurano infatti che il
senso civico risponde a una media nazionale, senza frammentarsi per categorie economiche, secondo la determinabilità della ricchezza di ciascuno.
Non esiste cioè un senso civico “fiscale”, un senso civico “ambientale”, un
senso civico “educativo”, un senso civico “sanitario”, un senso civico “culturale”, un
senso civico “sportivo” e via enumerando. Il senso civico, quindi, non cambia a seconda
della distanza delle varie forme di ricchezza rispetto alla tassazione attraverso le aziende. Il senso civico non cambia a seconda delle tipologie di ricchezza possedute o con
cui si ha a che fare, come se esistesse un senso civico dei lavoratori indipendenti, uno
degli impiegati, uno dei risparmiatori, uno dei proprietari di appartamenti, uno degli
esercenti un secondo lavoro e così via. Ciascuna categoria economica e sociale include
contribuenti più timorosi e più spregiudicati, ma i comportamenti di massa dipendono dalla determinabilità della ricchezza, e dalla percezione della propa-
96
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
ganda (par. 4.2). Per questo la ricchezza dichiarata dove le aziende non arrivano, pur
sottodimensionata rispetto alla realtà, è maggiore di quanto sarebbe se i contribuenti
considerassero la probabilità di un controllo del fisco solo in base alla loro esperienza
diretta, trascurando l’impatto dei “mass media”. Se i lavoratori indipendenti al consumo
finale, pur evadendo ampiamente, dichiarano – nell’insieme – cifre non manifestamente
inverosimili, non dipende da un loro superiore “senso civico”, ma dall’impatto della
propaganda di cui al par. 4.2. Per questo è opportuno smetterla di chiamare “ladro di
tasse” o “parassita” chi non è raggiunto del tutto dalla tassazione attraverso le aziende,
con gli effetti sociali laceranti connessi all’equivoco concetto di “lotta all’evasione”, già
indicato al par. 4.2 e di cui riparleremo al prossimo capitolo a proposito delle polemiche
sul fisco.
Anche i confronti internazionali confermano che quando si tratta di determinazione
della ricchezza ai fini tributari nessuno è patriota; dove la ricchezza non è determinabile
attraverso le aziende, una presenza, sistematica e valutativa, del fisco, è necessaria alla credibilità della ricchezza registrata. Secondo studi economici recenti, persino i lavoratori
indipendenti di paesi con forte senso civico, e dove il contante è scarsissimo (par. 5.16),
tendono a omettere la registrazione fiscale di buona parte della ricchezza.
Nonostante questa mancanza di punti di riferimento, la pubblica opinione,
intuisce la tassazione attraverso le aziende, e istintivamente tende a trasferirla dove le aziende non ci sono. È un filo conduttore che lega numerosissimi fenomeni apparentemente diversi, dalla “contabilità fiscale” del lavoratore
indipendente (parr. 3.13 e 7.8), al c.d. “contrasto d’interessi” (cfr. paragrafo 9.3),
agli scontrini e le ricevute fiscali di artigiani e piccoli commercianti (par. 7.7), alla
“tracciabilità”(par. 5.9 e 5.16), ai divieti di usare il contante (par. 5.16 in fine), all’anagrafe dei conti bancari (par. 5.16). A tutti questi documenti viene attribuita una
valenza quasi magica, mentre essi non assicurano la registrazione e dichiarazione
fiscale del provento sottostante; tuttavia possono essere utili indizi contabili per una
determinazione valutativa, come indicato al par. 5.9.
In generale, la pubblica opinione non si accorge che la determinazione ragionieristica della ricchezza si giustifica solo dove esiste una azienda pluripersonale, con necessità
di controllo interno, che il fisco utilizza poi a proprio uso e consumo. Esportare la
contabilità presso casalinghe, pensionati, artigiani, studenti e venditori ambulanti è
velleitario un po’ come “esportare la democrazia” in contesti tribali e feudali. La contabilità infatti non ha senso dove manca il controllo reciproco dei membri
di un gruppo sociale, con procedure di emissione e archiviazione dei documenti, uno
scadenziario degli adempimenti, e tanti altri passaggi solo pallidamente imitati dai professionisti incaricati della inutile “contabilità fiscale” di cui al par. 3.13.
Con questa tendenza a “estendere la tassazione contabile”, si intreccia quella parallela a “ragionierizzare le stime”, su cui è tradizionalmente basata la tassazione valutativa
attraverso gli uffici tributari. Sono entrambi sintomi, uguali e contrari, di un desiderio
di coordinamento, di una inconscia aspirazione all’omogeneità del sistema, ottenibile
invece solo diventando consapevoli della diversa determinabilità della ricchezza. Altrimenti si innesca la tendenza, in un contesto di tassazione ragionieristica attraverso
CAPITOLO 4 – DETERMINAZIONE DELLA RICCHEZZA...
97
le aziende, a “ragionierizzare le stime”, su cui si basava per secoli, e deve continuare a
basarsi, la valutazione della ricchezza da parte degli uffici. Forzatamente si tende invece
a omologare questa stima al contesto ragionieristico tipico della tassazione attraverso le
aziende. Istintivamente, istituzioni senza punti di riferimento cercano di formalizzare le
valutazioni degli uffici in passaggi predeterminati, come negli studi di settore (par. 5.13),
nell’accertamento “sintetico di massa” (par. 5.14), nell’utilizzazione ragionieristica degli
“indizi contabili” (par. 5.9 e 5.16).
Sono due istintive aspirazioni estemporanee alla sistematizzazione della determinazione tributaristica della ricchezza, su cui si inseriscono curiosi effetti di
annuncio, tipici della lotta all’evasione in televisione (par. 4.2), e leggende metropolitane, come quella della tracciabilità, della fatturazione elettronica, del
computer che sa tutto, una specie di meccanico Golem della lotta all’evasione, come
se il grande fratello fiscale informatico potesse sostituirsi alle aziende dove gli
uomini hanno fallito.
Sono illusioni cui si collegano dichiarazioni pubbliche, messaggi politici e leggi
manifesto, generiche, enfatiche e contraddittorie. Nascono innumerevoli “trovate normative”, anche sensate, ma riduttive e scoordinate, che ogni governo si ritiene in dovere
di esibire per mostrare di “fare qualcosa contro l’evasione”; nasce una emergenza
permanente, e inconcludente, fatta di “opposti isterismi ”, spesso provenienti,
a singhiozzo, dalle medesime aree politico-culturali, il cui risultato è la moltiplicazione
di adempimenti e rituali inutili sulla ricchezza registrata. Tra i vari filoni di pensiero
sull’evasione quest’ultima diventa così una specie di “colpa collettiva”, da espiare caricando di adempimenti inutili la ricchezza registrata, cioè scontrini, ricevute, scritture
contabili, spesometri, tracciamenti, divieti di uso del contante, digitalizzazione, codici
fiscali anche sulle lettere d’amore etc... Nasce così una specie di inutile “cilicio fiscale”,
come se queste incombenze fossero la penitenza per determinare magicamente, ai fini
tributari, la ricchezza che non passa attraverso le aziende.
La percezione della classe dirigente, senza spiegazioni e sistematizzazioni, arriva fin
qua: riesce a intravedere alcuni aspetti della determinazione tributaristica della ricchezza, ma in modo sfocato, come nella caverna platonica che studiavamo al liceo. È una
confusione in cui si inseriscono le strumentalizzazioni politiche e le lacerazioni sociali
di cui al prossimo paragrafo.
4.6. Segue: le spiegazioni politicamente strumentali e socialmente laceranti
Le sperequazioni nella determinazione tributaristica della ricchezza sono strumentalizzate, sul piano del consenso mediatico-politico, a seconda delle ideologie e delle convenienze politico-elettorali; ci si disperde su questioni irrilevanti rispetto
alla determinazione della ricchezza, divagando sul rapporto “stato mercato”, sulla elevata pressione fiscale “nominale” (par. 1.7), sull’evasione come “perversione privata”,
anziché “disfunzione della macchina pubblica” (par. 3.14 e infra). Sono diversivi sensa-
98
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
zionalistici mediatico-comunicazionali, disorganizzati, inconcludenti, ma riportabili a
due tendenze di fondo.
Per il vasto, e trasversale, partito della spesa pubblica l’evasione fiscale è
un diversivo contro le accuse, generalizzate, di inefficienza e di sprechi nella
macchina pubblica, alla base di un debito pubblico enorme, di una pressione fiscale
più che nordeuropea, ma con servizi da terzo mondo; rispetto a queste accuse di inefficienza, l’evasione è vista come un diversivo rispetto alla disorganizzazione
sprecona dell’intervento pubblico in tanti settori, compresa la determinazione della
ricchezza ai fini tributari. Invece di ammettere un fallimento organizzativo, si utilizzano come capro espiatorio gli “evasori fiscali”. Alla cui fantomatica perversione
privata viene data, probabilmente in buona fede (il che è anche peggio), la colpa di
una gigantesca disfunzione pubblica. L’incapacità di determinare in modo adeguatamente sistematico la ricchezza non raggiunta dalle aziende è infatti una disfunzione
della macchina pubblica, e della percezione della publica opinione. Sono fuori luogo,
in un testo diretto alla determinazione tributaristica della ricchezza, interrogativi su
cosa sarebbe successo se tutti avessero pagato le tasse, ma probabilmente ci sarebbe stata la stessa leggerezza nella spesa, e i conti pubblici non sarebbero migliori
di oggi. Sono diversivi che cercano anche di far leva sull’invidia sociale, visto che le
maggiori possibilità di evasione riguardano gli operatori economici, ed i lavoratori
indipendenti; non c’è da stupirsi che la “lotta all’evasione”, di matrice burocraticosindacale, sia usata, ai fini del consenso politico, in una specie di istintiva e fantomatica
“via fiscale alla lotta di classe”.
Una tendenza uguale e contraria spiega invece i malesseri fiscali con
un’eccessiva presenza dello stato, cavalcando la già indicata inefficienza di tante
funzioni pubbliche; le accuse di evasione fiscale ai lavoratori indipendenti sono rintuzzate con riferimenti al “doppio lavoro” (spesso in nero) di tanti dipendenti, alla
loro pretesa pigrizia (in realtà riflesso della disorganizzazione dei pubblici uffici), alla
c.d. ”evasione di sopravvivenza”, dall’affermazione sensazione dell’inutilità dei tributi,
infine dall’eccessività delle aliquote. Anche gli inutili rituali della “lotta all’evasione”,
indicati al paragrafo precedente, diventano un motivo di polemica verso un fantomatico
“stato di polizia tributaria”.
Tra questi estremi ci sono poi infinite sfumature intermedie, a seconda delle
contingenze, dello stato d’animo e di come si combinano di volta in volta diverse
intuizioni e sensazioni; alla maggioranza della pubblica opinione, l’idea dell’evasione non piace, anche se ne coglie le opportunità quando gli capitano.
La sintesi di questi atteggiamenti è non tanto la ritrosia a pagare, ma il timore di non
approfittare di opportunità fruite da altri. Si oscilla tra l’“io pagherei se pagassero tutti”,
e il “su questo non pago perché nessuno al posto mio lo farebbe”. Ce n’è abbastanza
per escludere che l’opinione pubblica accetti l’idea degli “evasori per tendenza”, per
carattere, per intrinseca disonestà, come pure la sua spiegazione come “perversione
privata” dei contribuenti; la pubblica opinione intuisce che per molti versi l’evasione è
causata dal cattivo funzionamento della macchina pubblica, e segue abbastanza, quando
gli viene presentata, la spiegazione proposta in questo libro, sul mancato coordinamento
CAPITOLO 4 – DETERMINAZIONE DELLA RICCHEZZA...
99
tra tassazione attraverso le aziende e attraverso gli uffici; la pubblica opinione intuisce che, sulla ricchezza non raggiunta dalle aziende, l’apparato pubblico
mostra inefficienze superiori a quelle percepite in altri settori, senza rendersi
conto di quanto vedremo al par. 5.3, cioè che è proprio la sua vaghezza di idee sul tema,
e quindi la sua scarsa capacità di valutazione, a rendere poco efficiente l’attività degli
uffici tributari.
La mancanza di punti di riferimento in materia tributaria della pubblica opinione
(par. 4.3 e ss), e le suddette spiegazioni socialmente laceranti, ostacolano non solo la
macchina pubblica del settore, ma creano polemiche inutili; ci si disperde in inconcludenti accuse reciproche, sofismi, pretesti, salti logici e cortine fumogene, diversivi sui
“grandi evasori”, costi della politica, economia criminale, ricette miracolose e altre divagazioni non pertinenti.Vedremo al par. 5.18 come questa tensione si scarichi alla fine,
attraverso il diversivo delle contestazioni interpretative, proprio su quanto le aziende
registrano, in un circolo vizioso che ostacola lo sviluppo del paese e l’organizzazione
sociale, contribuendo alla sua crescente burocratizzazione e povertà.
Su questi sfondi si collocano i battibecchi, sterili sul piano della determinazione
tributaristica della ricchezza, tra fantomatici “partiti delle tasse” e “partiti degli evasori”, che riflettono le eccessive aspettative e le esagerazioni sull’importanza
della politica, di cui al par. 2.4. Nessuna parte politica cerca ovviamente consenso propagandando l’evasione, anche perché i lavoratori dipendenti, facilmente tassabili attraverso le aziende, sono ben più numerosi degli “autonomi”. C’è piuttosto un diverso
atteggiamento verso l’evasione, in cui alcune forze politiche capiscono che la criminalizzazione degli “autonomi” è elettoralmente perdente. Semplicemente perché, pur
essendo meno numerosi dei dipendenti, il consenso perso presso di loro è maggiore
di quello acquisito presso i dipendenti. Se dal punto di vista del consenso politico
è intuitivo l’errore dalla criminalizzazione degli autonomi, dal punto di vista della
ricerca sociale è ancora più distruttiva la criminalizzazione delle aziende, nei modi
indicati ai par. 5.17 e ss., cui rinviamo. Il partito degli evasori è piuttosto un diversivo
rispetto all’inefficienza dell’intervento pubblico, sbrigativamente giustificata da una
ipotetica mancanza di fondi, mentre deriva dai problemi, purtroppo molto più gravi,
di mancanza di bagaglio culturale, di organizzazione e di iniziativa. In questa cornice, i sostenitori i “duri e puri” della spesa pubblica finanziata dai tributi, continuano
(sempre meno numerosi) a spiegare i mali italiani con l’evasione come “perversione
privata”, senza capire le mille ragioni della sua natura di “disfunzione pubblica”. Da
qui ad accusare di intelligenza col nemico chiunque cerchi di capire il fenomeno rifiutando atteggiamenti manichei il passo è breve. Questa grossolana spiegazione non
si rende conto che la possibilità di evadere riflette la disorganizzazione, prima di tutto
mentale, della pubblica opinione in materia di determinazione tributaristica della
ricchezza; non serve, quindi, ai titolari di ricchezza non tassata attraverso le aziende,
una concessione politica per evadere, perché gli basta la confusione contingente, che
si auto produce, anche se nessuno la vuole.
La situazione è talmente drammatizzata e schizofrenica che i tentativi di riflessione
sono accusati di debolezza e connivenza, vuoi verso le tasse, vuoi verso gli evasori, con
100
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
atteggiamenti allucinati e intransigenti, simili a quelli degli antichi inquisitori. La pacatezza della riflessione, la coesione sociale, la consapevolezza della pubblica opinione, e la
serenità del lavoro degli uffici certamente non ci guadagnano.
La sintesi di questo polverone confusionario è una strisciante crescita, negli ultimi
anni, delle tendenze “antifisco”, dovute forse alla crescente percezione della quantità di
spesa pubblica improduttiva, a prescindere dalla presunta perversione degli “evasori”.
Si percepisce anche in quale misura la macchina fiscale riflette, come vedremo al par.
5.3, il disorientamento diffuso nel paese, finendo per funzionare male, al di là delle intenzioni. Cresce pian piano la consapevolezza che il problema è la “richiesta
amministrativa delle imposte dove le aziende non arrivano. Anche per questo
la pubblica opinione è sempre meno sensibile alle gogne mediatiche, per fantomatiche
evasioni fiscali, di operatori economici che creano ricchezza e lavoro. Tuttavia la macchina pubblica, in una società complessa, non va smantellata, bensì fatta funzionare, anche a proposito della determinazione della ricchezza ai fini tributari. È questo il nucleo
della funzione degli studiosi del diritto tributario, che dobbiamo riprendere al prossimo
paragrafo.
4.7. Spiegazioni istituzionalistiche in una cornice di unità del diritto e collegamento con altre scienze sociali
La mancata comprensione della determinazione tributaristica della ricchezza provoca danni sociali gravi, che occorre superare. Prima di tutto comprendendo che un
settore oggettivamente meno semplice degli altri ha bisogno di una teoria fatta di
ragionamenti, non di riferimenti ai “materiali normativi”.
Il punto di partenza è capire di cosa stiamo parlando, cioè di determinazione
dei tributi, e quindi della (spesso difficile) determinazione della ricchezza. È un punto
da spiegare alla pubblica opinione e alla classe dirigente, perché qui – a differenza
della sanità, dell’istruzione, dell’ambiente, dove la percezione sociale della
funzione pubblica sottostante è chiara, qui sfugge persino il concetto di determinazione tributaristica della ricchezza.
Superando il circolo vizioso tra parafrasi dei materiali e divagazioni
politiche, ci si deve chiedere quali variabili influiscono sulla determinazione dei
tributi, e come devono essere coordinate e contemperate, dando a ciascuna un peso
specifico.
Iniziamo dalle forze utilizzabili per teorizzare la determinazione della
ricchezza ai fini tributari, che richiede uno sforzo affrontabile solo facendo appello
alle energie mentali rimaste in tutti gli ambienti culturali indicati ai paragrafi precedenti, cioè accademico, professionale, istituzionale, dell’informazione e di settori contigui
delle scienze sociali.
Il punto di partenza è andare direttamente alle questioni, senza la mediazione
dei “materiali”, secondo il concetto di “scientificità” illustrato al par. 4.3. È l’unico
modo per contestualizzare i “materiali” in funzione delle istituzioni, og-
CAPITOLO 4 – DETERMINAZIONE DELLA RICCHEZZA...
101
getto del giurista come scienziato sociale; in relazione alle istituzioni vanno
poi organizzate le riflessioni diffuse tra le classi dirigenti e la pubblica opinione sulla
determinazione della ricchezza. È questo il “dato sociale” da sostituire al “dato
normativo”, nel ruolo del “dato naturale” delle scienze fisiche, su cui ci siamo
soffermati al par. 4.3.
La difficoltà è il coordinamento di molte riflessioni semplici, che gli interlocutori
singolarmente intravedono, ma tra cui si disperdono, in quanto numerose, intrecciate e
di diversa importanza. Lo studioso sociale deve solo metterle in ordine in modo sensato,
mantenendole vitali, riadattandole ai diversi contesti, mantenendo l’interesse dell’interlocutore senza disorientarlo. La pietra di paragone è la semplificazione di intrecci
complessi tra riflessioni semplici, non la complicazione di una riflessione semplice,
resa esteriormente scientifica con divagazioni prolisse e pedanti.
Si tratta piuttosto di mantenere la semplicità anche coordinando una pluralità di
riflessioni sulla determinazione della ricchezza, come quelle già anticipate al par. 1.9;
cioè la precisione, la semplicità, la snellezza amministrativa, la prevedibilità dei comportamenti, la cautela contro le evasioni. Tra queste ed altre esigenze le varie istituzioni
cercano, dal loro punto di vista, di porsi come interpreti dell’interesse generale. Tra i
profili appena accennati, nonostante lo pseudonormativismo di cui al par. 4.3, solo la
prevedibilità dei comportamenti ha a che fare con i “materiali normativi”, rendendo
ingiustificato, nonostante lo pseudonromativismo, l’appiattimento su di essi. Il criterio
per considerare “giuridico” un ragionamento non è quindi il suo diretto riferimento a “norme”, bensì la sua idoneità a spiegare, con riferimento a “norme”, valori e
buonsenso, il comportamento delle istituzioni (e degli individui con riferimento
ad esse). Queste considerazioni giuridiche confinano con la politica, quando vengono
in considerazione coesione e consenso sociale, e con l’economia, quando si tratta di
scambi di merci e servizi (la sociologia è invece genericamente finalizzata a tutti i comportamenti dei gruppi sociali in genere).
Con questa metodologia istituzionalista sarà finalmente possibile capire di volta in volta il peso dei “materiali” e riuscire a contestualizzarli, come indicato al par.
4.3; è così evitata l’incertezza del diritto di ritorno, cioè quella specie di anarchia dove
tutti i materiali sono sullo stesso piano, e ognuno punta su quelli che ritiene più adatti
alla tesi che ritiene più corretta, o che gli conviene. Si recupererebbe così, secondo il
proposito della premessa, il “diritto tributario” rispetto alla “legislazione”, ormai del
resto accessibile attraverso qualsiasi banca dati, mentre mancano i giuristi per contestualizzarla, coordinando le riflessioni della pubblica opinione sulla determinazione
dei tributi.
Quest’antico ruolo analitico-propositivo dei giuristi, in parte superato dalle
codificazioni per la funzione di giustizia, deve essere trasferito nei nuovi spazi
giuridici aperti dall’espansione dell’intervento pubblico, compresa la determinazione della ricchezza ai fini tributari, cui si riferisce questo libro.
A tal fine sono necessari poli di aggregazione e di confronto, che saranno indispensabili finché durerà la tassazione attraverso le aziende, e quindi le aziende,
cioè una società relativamente organizzata, con ruoli articolati. Se per ipotesi si dovesse
102
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
arretrare verso un’era analoga a quella “agricolo-artigianale”, cioè il medioevo post
industriale di cui al par. 5.19, tornerà necessariamente centrale la tassazione valutativa
attraverso gli uffici; a questo punto, probabilmente, una opinione pubblica imbarbarita
non avrà più bisogno di un punto di riferimento per la determinazione della ricchezza
ai fini tributari.
Un gruppo di studiosi sociali dedicati al tema può contribuire ad evitare questo
epilogo; la politica deve infatti pensare alla coesione sociale e al consenso, i giudici a
smaltire le pratiche, i pubblici uffici all’immagine e al “risultato di servizio” (par. 5.3), le
aziende a produrre merci (par. 4.4), i giornalisti a fare audience (par. 4.4) etc... Nessuno
di questi organismi ha compiti di formazione sociale, di spiegazione al resto
della società, di cui essi stessi sono a loro volta emanazioni, facendovi corto circuito.
Il coordinamento delle idee spetta quindi a un gruppo di studiosi, e
sarebbe per certi versi più semplice trovare le energie necessarie in una accademia
molto numerosa, rispetto alla settorialità della materia; bisognerà vedere se i danni
metodologici indicati al par. 4.3 sono superabili, o se è preferibile costruire un polo di
aggregazione nell’alveo del diritto dei pubblici poteri, come accaduto per le materie
urbanistiche, ambientali, sanitarie, della sicurezza, dell’istruzione, della cultura, etc. La
ridotta dimensione del settore scientifico è infatti forse una delle cause delle degenerazioni relazionali indicate al termine del par. 4.3, del suo ripiegamento sui dettagli
professionali, dell’inadeguatezza del suo livello di comunicazione e padronanza del
proprio settore rispetto a quello medio della classe dirigente che vi si dedica. Inoltre
la tendenza all’unitarietà istituzionalistica del diritto si fa strada, ed è stata recuperata
anche per altri campi del sapere giuridico, come quello agrario, quello delle procedure
fallimentari, quello delle assicurazioni, quello della contabilità di stato. Ciò si inquadra
perfettamente nel filo conduttore secondo cui il diritto è unitario, e solo “la legislazione” ha oggetti diversi.
Studiosi incardinati in una comunità più generale di giuristi potrebbero forse valorizzare meglio la determinazione della ricchezza in una cornice amministrativistica,
oggi messa in secondo piano dalle aziende, come organizzazioni incaricate della determinazione dei tributi.
Staremo a vedere se l’accademia riscoprirà il proprio ruolo culturale, la propria
giuridicità amministrativistica finalizzata alla determinazione della ricchezza anziché ai
“materiali” e agli “effetti economico-sociali delle imposte”. In caso contrario bisognerà
spiegare, ad una pubblica opinione desiderosa di un colpevole, che l’accademia continua ad essere, sia pure per disfunzioni metodologiche generali indicate al par. 4.3, il
problema, anziché la soluzione. L’importante non è comunque l’etichetta o la geografia
accademica, ma la serietà delle riflessioni, cui speriamo di contribuire anche con la rivista “dialoghi tributari” e i siti internet.La determinazione tributaristica della ricchezza
deve essere analizzata andando al di là dei “materiali normativi”, e senza cadere nelle
divagazioni politico-ideologiche che la corretta impostazione del normativismo voleva
contrastare (par. 4.3).
Trattandosi della determinazione della ricchezza ai fini tributari, l’impostazione sarebbe naturalmente “amministrativistico-economica” conformemente alla collocazione
CAPITOLO 4 – DETERMINAZIONE DELLA RICCHEZZA...
103
della tassazione nell’ambito dell’attività dei poteri pubblici, esistenti sullo sfondo anche
quando in concreto non intervengono. Il passaggio più complesso è la determinazione
della ricchezza, utile a spiegare serenamente le apparenti sperequazioni e le possibilità
di attenuarle, senza le laceranti criminalizzazioni e le fantomatiche disonestà, indicate
al paragrafo 4.6.
Il passo successivo, in questa cornice, è coordinare la tassazione ragionieristica della
ricchezza attraverso le aziende e quella valutativa attraverso gli uffici. Questa spiegazione più serena riporterebbe la ragionevolezza negli uffici, superando le diffidenze e i timori di cui ai par. 5.3, 5.7, 5.11; svanirebbe così il timore di assumersi responsabilità, che
spinge alla cautela e complica l’intervento degli uffici, riducendone l’impatto proprio
per il loro timore di esporsi a critiche. Spiegando in modo sereno, e non “criminalistico”, la ricchezza non raggiunta dalle aziende, gli uffici si esporranno serenamente nella
relativa stima per ordine di grandezza.
Una volta capito l’obiettivo di perequata (per quanto possibile) determinazione della
ricchezza, l’intervento degli uffici potrà così essere più sistematico, riconducendolo ad
una ordinaria funzione pubblica, superando la mentalità dell’emergenza e le più volte
indicate drammatizzazioni. Esse si collegano all’idea fuorviante di “lotta all’evasione”, che mette in ombra e disorienta la funzione pubblica di determinazione della
ricchezza, come se la funzione educativa fosse chiamata “lotta all’ignoranza”, quella sanitaria “lotta alla malattia”, quella ambientale “lotta ai rifiuti”, quella della viabilità “lotta
al traffico”, quella economica “lotta alla povertà” etc... Recuperare la serenità sociale
sulla determinazione tributaristica della ricchezza è quindi il presupposto
per interrompere il circolo vizioso in cui le colpe della ricchezza non registrata
ricadono su quella palese, esposta alle pignolerie interpretative di cui al par. 5.17 ss., col
boomerang sociale ivi indicato.
L’aumento del controllo valutativo del territorio, secondo le modalità indicate al par. 5.7, si aggiungerebbe all’attuale impatto propagandistico indicato al par. 4.2, e
consentirebbe di avvicinarsi al famoso obiettivo di “pagare meno pagare tutti”.
Una volta spiegata, e sdrammatizzata, la determinazione tributaristica della ricchezza,
tutti gli imbarazzi istituzionali, i disorientamenti, le strumentalizzazioni, i discorsi tortuosi svanirebbero. Non può esservi infatti semplificazione legislativa, nella determinazione della ricchezza, senza una semplificazione mentale. In questo settore, come
in tutti gli altri, paragonando la società a un corpo umano, il funzionamento del cervello
è la precondizione perché funzioni tutto il resto, e quindi occorre il coordinamento, qui
sostenuto, tra determinazione contabile ed estimativa della ricchezza, evitando equivoci
col diverso profilo degli effetti economici dei tributi.
Su queste basi sarà possibile semplificare e sdrammatizzare, raggiungendo così serenità e certezza del diritto, che non si trovano nelle leggi, ma nelle istituzioni. A questo
punto sarebbe possibile superare la situazione da incubo degli operatori del settore (par.
3.16), la maggior parte dei quali vuole solo fare un lavoro chiaro, guadagnarsi da vivere
e tornare a casa tranquilla. Questo rasserenamento ambientale consentirebbe ai professionisti di superare l’attuale situazione da incubo descritta al par. 3.16, lavorando più
sereni e vedendosi riconosciuto il proprio ruolo, a tutti i livelli. La pubblica opinione e
104
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
la classe dirigente, una volta tranquillizzate, inevitabilmente affideranno la determinazione tributaristica della ricchezza a chi se ne intende, cioè ai tributaristi, senza
interferenze, faticose per chi le fa e per chi le subisce. Sarebbe così rilanciato, sul piano
della determinazione tributaristica della ricchezza, anche il ruolo dei teorici. Che in
un’ottica consulenziale sono tecnici di controversi dettagli, avvocati anziché coordinatori dei vari profili che influenzano la determinazione della ricchezza ai fini tributari.
Ricordiamo infatti che, nei paesi tributariamente più sereni, gran parte degli aspetti tecnici, gestiti in Italia per legge (par. 2.3), sono affrontati col buonsenso di amministrazioni
e organi professionali, in grado di sistematizzare il loro settore a beneficio delle classi
dirigenti; le quali ricambiano con un riconoscimento di autorevolezza, e con la delega
ad occuparsi degli aspetti specialistici.
Questo supporto alle istituzioni e alla classe dirigente è la premessa, per la comunità
degli studiosi del settore, di vedersi attribuita una “competenza riservata” sulla determinazione tributaristica della ricchezza, di cui la politica sarebbe ben felice di alleggerirsi,
concentrandosi sugli effetti economici dei tributi e sulle aliquote. Gli studiosi della
determinazione tributaristica della ricchezza, fornendo alle classi dirigenti lo strumento
per esercitare il loro “controllo sociale” su questo aspetto, otterrebbero un po’ di voce in
capitolo anche su quelli contigui, come gli effetti economici dei tributi. Solo dedicandosi alla determinazione tributaristica della ricchezza, anziché ai “materiali normativi”,
ai dettagli professionali o alle divagazioni sociologiche, gli studiosi del settore potranno
guadagnarsi una “competenza riservata “. È questa l’essenza del giurista come tecnico
dedicato alle istituzioni di un determinato settore, con le istituzioni politiche in genere
che ne ascoltano il parere, e l’opinione pubblica che valuta nel complesso gli effetti
sociali dei tributi. Speriamo bene.
Capitolo 5
LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
TRA RICCHEZZA NON REGISTRATA
E CONTESTAZIONI INTERPRETATIVE
Sommario: 5.1. Poteri amministrativi ed entrate pubbliche (tariffe, tasse in senso stretto, monopoli, contributi, imposte etc...) – 5.2. Le istituzioni tributarie (Agenzia delle Entrate – Guardia di Finanza –
uffici comunali – concessionari, etc.) – 5.3. Le amministrazioni tributarie tra immagine istituzionale
e protezione del singolo – 5.4. Le istruzioni ai contribuenti come funzione amministrativa tributaria
(modulistica, assistenza e interpretazioni amministrative) – 5.5. L’acquisizione delle dichiarazioni, e il
loro controllo di correttezza formale e documentale – 5.6. Indagini interne e internazionali, relativi
vizi e poteri di verbalizzazione amministrativa – 5.7. Gestione dei dati e finalità del controllo valutativo
degli uffici: la “tax compliance” – 5.8. Empirismo probabilistico e valutativo nella determinazione della
ricchezza non registrata. (Le questioni di fatto nel diritto tributario) – 5.9. Segue: necessità di coordinamento tra controlli contabili e valutativi: gli “indizi contabili” – 5.10. Stima della ricchezza non
registrata, discrezionalità e “indisponibilità” del credito tributario – 5.11. Segue. I sospetti di connivenza
o negligenza come ostacolo a una serena valutazione della ricchezza – 5.12. Segue. Inadeguatezze della
normativa sulla prova della ricchezza non registrata (ambiguità dei concetti di accertamento analitico
contabile e induttivo extracontabile) – 5.13.Valutazione amministrativa della ricchezza non registrata,
tra indizi fisico-economici e studi di settore (rinvio agli indizi finanziari al par. 5.16) – 5.14. Tenore di
vita e spesa “privata” come indizio di ricchezza non registrata (accertamenti “sintetico-redditometrici”)
– 5.15. Quale intervento amministrativo su manifestazioni collaterali o sporadiche di ricchezza? – 5.16.
Incroci, banche dati, e tracciabilità: illusioni e realtà su altri “indizi contabili” – 5.17. Le aziende come
paradossale capro espiatorio dei malesseri creati dal loro ruolo di “esattori del fisco” – 5.18. Richiami
ed esemplificazioni sulle contestazioni interpretative: la difficile difesa contro “l’inferno del dichiarato” – 5.19. Segue: il controproducente controllo obbligatorio delle grandi aziende: quando i controlli
fiscali “si sprecano” – 5.20. La tassazione per condono: una conferma della tendenza ad “amministrare
per legge”
5.1. Poteri amministrativi ed entrate pubbliche (tariffe, tasse in senso
stretto, monopoli, contributi, imposte etc...)
Le varie entrate pubbliche, con le loro diverse sfumature già indicate al capitolo 1,
devono qui essere collegate col ruolo delle pubbliche autorità, che in questa materia
sussiste sempre, ed il cui contenuto è spesso intuitivo, altre volte complesso. Tale ruolo
sussiste non solo per le imposte, ma anche per le tariffe, per molti aspetti puri e
semplici “prezzi”.
106
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
Le c.d. “tariffe”, riferite a servizi idrici, elettrici, di trasporto, sono però corrispettivi
un po’ diversi dal prezzo di un bene qualsiasi, come un vestito o una bicicletta, perché
dipendono da un ruolo regolatorio o concessorio delle pubbliche autorità.
In un ruolo di concessione, supervisione e controllo è infatti in genere presente
un’autorità amministrativa, spesso regolatrice del servizio; l’autorità analizza il modello
aziendale di fornitura del servizio per premiare l’efficienza col profitto; la già indicata
matrice amministrativa non riguarda quindi tanto il rapporto tra utente e fornitore,
quanto nell’assetto organizzativo di cui il fornitore fa parte, con i già menzionati interventi pubblici di regolamentazione del servizio e di controllo. È un compromesso tra
stato e mercato, che reciprocamente interagiscono, secondo il solito gradualismo delle
scienze sociali, prive di compartimenti stagni.
Il relativo finanziamento avviene grazie ai corrispettivi degli utenti, esempio classico del c.d. “principio del beneficio” (anticipato ai paragrafi 1.2 e 1.8). In
tale sede abbiamo visto che col principio “del beneficio” la spesa pubblica è posta in
prima battuta a carico di chi si serve del relativo servizio, organizzato direttamente o
indirettamente dall’autorità pubblica. Biglietti di trasporto, allacci fognari, utenze idriche, occupazioni di aree pubbliche, sono “servizi divisibili”, cui è possibile collegare una
tariffa. Chi se ne serve paga una somma, calcolata dal pubblico potere simulando per
quanto possibile criteri “di mercato”; ciò dovrebbe portare a maggiore efficienza, ed è
compatibile con sovvenzioni per consentire ai più bisognosi di ottenere servizi essenziali, per i quali non possono pagare.
Per molti versi le tariffe pongono problemi di incasso coattivo, da parte dell’ente
pubblico o del suo concessionario, con strumenti di coercizione diretta amministrativa
(è una “zona grigia” tra pubblico e privato su cui sarebbero opportuni approfondimenti,
anche se appare abbastanza chiara l’irrilevanza delle tariffe ai fini del calcolo della c.d.
“pressione fiscale” di cui al paragrafo 1.7).
Le c.d. tasse in senso stretto rientrano invece già tra i tributi, in quanto percepite da un soggetto che esercita non solo “un servizio”, ma “una funzione”
pubblica; all’esercizio di tale funzione corrisponde la richiesta di una somma (tassa)
al destinatario della rispettiva competenza funzionale. Le istituzioni esercitano qui le
loro funzioni secondo criteri che neppure simulano quelli di mercato, come avviene
invece per le tariffe; si pensi ad aspetti dell’organizzazione sociale di stretta competenza pubblica, come l’anagrafe e lo stato civile, la giustizia, l’urbanistica, la sanità,
l’istruzione, etc...
Sono interventi necessari per finalità generali, secondo l’assetto politico di volta in
volta dominante, ma che costituiscono anche il presupposto della richiesta di contribuzione; si pensi a ticket sanitari, tasse scolastiche, contributi di urbanizzazione, varie
forme di diritti “anagrafici” o “di giustizia”, oppure “di trasporto”, come le “tasse di
imbarco” aeroportuali”, per il rilascio di licenze, documenti o certificati. In tutti questi
casi il potere politico di vertice decide di istituire una determinata funzione pubblica,
sostenendone le spese, ma richiedendo anche un contributo a chi interagisce con esse.
La giustizia, la sanità, l’urbanistica, l’istruzione, sono funzioni che il pubblico potere
decide di allestire indipendentemente dalle contribuzioni di chi interagisce con esse.
Capitolo 5 – LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
107
Qui non c’entra l’economicità del servizio, come nelle tariffe, né la ricchezza, come
vedremo per le imposte; per questo, giustamente, la corte costituzionale ha escluso
l’applicabilità alle tasse dell’art. 53. Nelle tariffe e nelle tasse, quindi, la ricchezza potrebbe rilevare “alla rovescia” rispetto alle imposte, nel senso che dovrebbero essere
previste delle esenzioni a favore dei soggetti bisognosi; è un terreno scivoloso per via
delle incertezze sulla valutazione dello stato di bisogno, indicate al paragrafo 2.2 a
proposito dell’ISEE.
Trattandosi in genere di importi modesti, non si giustificano i costi fissi di un contenzioso, e per questo sono casi rari, a quanto ora mi risulta; sarebbe da approfondire,
ma non me ne constano esempi, l’eventualità di un contenzioso tra l’ente pubblico, che
rifiuta l’esercizio della funzione, ove sia omesso il pagamento della tassa (o della tariffa),
ed il privato che la ritiene non dovuta.
Quanto precede costituisce un ostacolo alla tendenza degli ultimi anni a trasformare
molte tasse in “tariffe”, la cui finalità è consentire il controllo della qualità del servizio
da parte dei clienti, introducendo parametri di efficienza aziendale, secondo il principio
del beneficio, su cui par. 1.8; l’apparato pubblico quindi si aziendalizza, e sbiadiscono
i ricordi di quando erano militarizzati, e in divisa, persino netturbini, portalettere e
bigliettai del tram. Questa tendenza a trasformare le tasse in prezzi è ostacolata dalla
difficoltà di “”misurare” il godimento di taluni servizi, come quello di smaltimento dei
rifiuti (paragrafo 10.10).
Si parla di «contributi» per definire entrate pubbliche di diversa natura, e costituisce
un sinonimo per qualsiasi “tributo”, attraverso cui genericamente si contribuisce alle
pubbliche spese. Ci sono poi i “contributi previdenziali”, percepiti da un ente pubblico (prevalentemente l’INPS) a tal fine dotato di poteri autoritativi; il collegamento
col beneficio specifico rappresentato dalla pensione è il motivo per cui non lo si inserisce a pieno titolo nel concetto di “tributo”. Ci sono poi i contributi a carico degli
appartenenti a una certa collettività, indistintamente beneficiaria di un’attività dell’ente
percettore, come i contributi di urbanizzazione o di bonifica.
Per reperire entrate, il pubblico potere ha spesso riservato a sé stesso alcune attività
particolarmente profittevoli, in regime di “monopolio”. La storia ci ricorda esempi
generali di antichi monopoli, come quello del sale, quello delle banane, oppure quello
dei tabacchi e del gioco d’azzardo. In alcuni casi, come quello del sale, la produzione
veniva gestita da aziende statali, ma è più frequente la concessione a privati, come accade per i suddetti monopoli dei tabacchi e del gioco d’azzardo. L’affidamento in concessione, attraverso gare trasparenti e aperte a tutti, è l’unica modalità di esercizio del
monopolio compatibile coi principi comunitari (par. 2.6).
Le entrate pubbliche sopra indicate esprimevano in varia misura una correlazione
con una qualche attività verso il soggetto chiamato a pagare, e quindi col cosiddetto
“principio del beneficio”; quest’ultimo cerca di mettere la spesa pubblica a carico di
chi utilizza le relative attività pubbliche, mentre il grosso delle entrate pubbliche è
coperto con le imposte, a fronte delle quali non si riceve direttamente nulla
e che quindi rendono necessaria una attività amministrativa di “richiesta”; l’espressione
“le tasse si pagano quando qualcuno le richiede” utilizzata spesso in questo libro, si ri-
108
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
ferisce tecnicamente alle “imposte”, dove l’espressione stessa richiede qualcuno “che ne
imponga” il pagamento ai titolari delle relative manifestazioni di ricchezza.
L’imposta prescrive quindi “un sacrificio” alle manifestazioni di ricchezza, e il “principio del sacrificio” si contrappone nella letteratura economica a quello del “beneficio”
indicato sopra. Il beneficio imita maggiormente criteri di mercato, responsabilizzando sia l’utenza sia i centri di spesa pubblica, per ragioni esposte in altra sede.
La natura tributaria, o meno, delle suddette entrate pubbliche, rileva soprattutto sotto il profilo processuale, indicato al successivo paragrafo 6.7. Esaminando, in quest’ottica
di “riparto di giurisdizione” le varie entrate pubbliche suddette va registrata una tendenza ad ampliare la nozione di tributo, inserendovi anche contributi a consorzi, quote
di iscrizione ad albi professionali, diritti aeroportuali di imbarco dovuti dalle compagnie
aeree alle società di gestione degli aeroporti, operanti in regime di concessione, le quote
di iscrizione alla camera di commercio, la TIA (tariffa per lo smaltimento dei rifiuti) ed
altre entrate caratterizzate da una imprecisata “coattività”. Quest’ultima viene riferita
anche a casi dove manca una amministrazione pubblica, ed un atto autoritativo. Persino le quote di iscrizione ad albi professionali e alle camere di commercio sono state
ritenute “tributi”; lo stesso per le decurtazioni stipendiali per alti dirigenti pubblici e
magistrati, palesemente riduzioni stipendiali, finalizzate al contenimento ex lege della
spesa pubblica. È un aspetto di un più generale disorientamento concettuale, che ci
accompagna in tutto il testo, e che solo punti di riferimento teorici possono contrastare
(par. 4.7).
5.2. Le istituzioni tributarie (Agenzia delle Entrate – Guardia di Finanza
– uffici comunali – concessionari, etc.)
Anche in materia di tributi, le autorità amministrative esercitano poteri unilaterali
autoritativi, come vedremo al par. 6.1 per gli atti impositivi, le indagini inquisitorie, i poteri certificativi (par. 5.6 sulle verbalizzazioni, che fanno fede fino a querela di
falso), la possibilità di infliggere sanzioni, e molte altre prerogative esercitabili senza l’ausilio del giudice; non si tratta di scelte legislative contingenti, ma di un riflesso
delle istituzioni amministrative come emanazione del gruppo sociale, investite di poteri
esercitabili in via di autotutela amministrativa. Il giudice subentra se richiesto
dai privati contro abusi e negligenze dell’autorità amministrativa; esso è, come
in tutte le articolazioni del diritto amministrativo, una seconda istituzione pubblica, con
funzioni di controllo della prima (capitolo sesto).
La giuridicità del diritto tributario è prima di tutto amministrativa, nonostante il diffuso preconcetto processualistico, secondo cui fisco e contribuente
andrebbero spiegati come due “parti che litigano” tra cui il giudice decide a chi dare
ragione. Vedremo al capitolo sesto in quale misura questa concezione “processualistica” danneggi il contribuente, inducendo gli uffici, a seconda delle convenienze, a comportarsi come pubbliche autorità o come “parti processuali” (cfr. anche
il par. 6.2 sull’onere della prova). Anche nel presente capitolo, ai paragrafi da 5.8 a
Capitolo 5 – LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
109
5.10, vedremo altresì in quale misura il preconcetto “legalistico.processuale” ostacoli
la ricerca della ricchezza non registrata dove le aziende non arrivano, che è questione
strutturalmente empirica. Questi grossolani preconcetti, secondo cui solo il
giudice sarebbe sinonimo di “giuridicità” e di applicazione della legge, generano un ibrido socialmente dannoso per tutti, ostacolando l’efficienza dell’azione
amministrativa, oltre che la comprensione del ruolo del legislatore (par. 2.4) e del
giudice (facilmente inquadrabili invece nell’intuitiva spiegazione amministrativisticoeconomica, proposta al par. 4.7).
La più importante istituzione pubblica in materia tributaria è l’Agenzia delle Entrate, generata a inizio secolo dallo scorporo degli uffici del ministero delle Finanze,
dedicati alla gestione dei tributi e articolata in uffici centrali e locali, che gestiscono il
rapporto con i singoli contribuenti; a tali scopi sono utilizzati circa 45 mila dipendenti,
considerando anche quelli provenienti dall’agenzia del territorio, dedicata alla fiscalità
immobiliare e recentemente accorpata con quella delle entrate. Resta autonoma l’agenzia delle dogane.
Conformemente alla matrice amministrativistica del diritto tributario, le Agenzie
suddette sono istituzioni pubbliche, per le quali valgono i relativi doveri di imparzialità, trasparenza etc., ma dotate di forti poteri di “auto-organizzazione” rispetto alle
amministrazioni facenti capo ai tradizionali ministeri.
Il passaggio alle Agenzie si inquadra comunque in una evoluzione di tutte le
amministrazioni pubbliche che, dopo secoli in cui furono ispirate a un modello
gerarchico militare, perseguono – almeno nelle intenzioni – un modello aziendalistico-manageriale. Vedremo al prossimo paragrafo le difficoltà di trapiantare il modello aziendale in una realtà “intermediata”, senza “clienti che pagano”,
ma al massimo “utenti”, che ricevono servizi pagati dai contribuenti o comunque
con risorse generali della collettività. La trasformazione in agenzia, ha avuto
fortissimi vantaggi sul piano dell’“auto-organizzazione”, e va considerata
irreversibile; forse però ha generato una necessità di immagine, di visibilità statistica
esterna, che ha ancorato maggiormente l’Agenzia ai disorientamenti tributaristici
della pubblica opinione, secondo i legami indicati al prossimo paragrafo 5.3. A parte
questo buon argomento per una tesi di dottorato, siamo davanti a un’amministrazione pubblica dove si ritrovano, sia pure in modo particolare, le deresponsabilizzazioni, i desideri di copertura normativa, e le esigenze di immagine tipiche della
più grande azienda italiana, cioè di un settore pubblico in bilico tra la prestazione di
servizi alla società, la percezione di sussidi sotto forma di stipendi e la produzione
di visibilità mediatica per giustificare il proprio ruolo. La gravità e le sfumature
di queste disfunzioni in materia tributaria sono un ulteriore riflesso della mancata spiegazione da parte degli studiosi, della determinazione della ricchezza ai fini
amministrativo-tributari.
Sulle agenzie vigila il ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite il
dipartimento delle Politiche fiscali, con una attività di coordinamento politico e di alta
amministrazione; il ministero promuove anche la redazione di normativa regolamentare,
e l’effettuazione di studi di politica tributaria.
110
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
In Italia i controlli tributari sono svolti anche dalla Guardia di Finanza, corpo militare cui competono poteri amministrativistici di indagine, e anche compiti di polizia
giudiziaria, sotto la direzione della magistratura inquirente (procura della repubblica). Il
potere di valutare i risultati delle indagini della Guardia di finanza ai fini dell’accertamento tributario spetta all’Agenzia delle entrate, cui vengono trasmessi i risultati delle
indagini dei finanzieri, cioè i processi verbali di cui diremo al par. 5.6.
Il dualismo tra agenzia delle entrate e guardia di Finanza richiede un coordinamento, che dovrebbe tendenzialmente basarsi sull’attribuzione all’Agenzia delle valutazioni empiriche sui lavoratori indipendenti e delle questioni di diritto, mentre le frodi
contabili, ramificate sul territorio, e che richiedono indagini articolate, anche antifrode,
dovrebbero spettare alla Guardia di Finanza, come polizia economica.
Analoghi poteri amministrativistici, senza particolari problemi di coordinamento, spettano anche agli uffici tributari degli enti locali, per i tributi di loro competenza, nonché alle società per la riscossione dei tributi (Equitalia) di cui diremo al
paragrafo 6.11.
5.3. Le amministrazioni tributarie tra immagine istituzionale e protezione del singolo
Le istituzioni fiscali fanno parte della pubblica amministrazione, l’organizzazione di maggiori dimensioni, con oltre tre milioni di addetti; le sue articolazioni funzionali, dalla difesa, alla giustizia, alla sicurezza, alla determinazione della ricchezza ai
fini tributari, alla sanità, all’istruzione, alla cultura, hanno spesso più dipendenti delle
maggiori aziende operanti sul mercato.
Su queste premesse, la matrice, inizialmente politica, delle istituzioni, rapidamente si
colora di diritto, per quelle che – in ultima analisi – sono burocrazie, nel senso buono
del termine, proprio in quanto non operanti sul mercato.
L’antenato più remoto dell’apparato pubblico era l’esercito, inteso in senso ampio
come apparato destinato alla difesa/conquista del territorio e alla sicurezza interna; successivamente l’era aziendale ha provocato la dilatazione dell’apparato pubblico, che
vive di vita propria, indipendentemente da una misurazione “di mercato”.
Sono istituzioni che, per molti versi, ricordano le aziende come corpi sociali intermedi; anch’esse si compongono di una pluralità di individui come abbiamo
detto al par. 3.1. per l’azienda. Al loro interno troviamo la stessa suddivisione dei compiti, senza però i parametri di controllo del mercato e del fatturato. Manca quindi per
l’azienda pubblica, la necessità di un equilibrio di mercato, col relativo bisogno di efficienza, tipico dell’azienda privata. L’azienda pubblica partecipa invece all’esercizio del
potere nel proprio settore; essa vive di trasferimenti o fruisce di rendite di posizione
anche quando opera sul mercato delle “tariffe”. Essa vive infatti attraverso la pubblica
opinione, la sua maturità, il suo bagaglio culturale di settore, nel “corto circuito” di
cui diremo subito.
Gli operatori del settore privato, viste le suddette, somiglianze organizzative tra
aziende private e istituzioni, trasferiscono sulle istituzioni pubbliche il proprio bagaglio
Capitolo 5 – LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
111
organizzativo e i propri incentivi all’efficienza. Pensano cioè che nelle istituzioni pubbliche ci sia una catena di comando e un organo preciso dotato di un’“ultima parola”,
al limite il CDA o l’assemblea.
Invece strutturalmente non funziona così, perché i servizi pubblici non sono valutabili in termini diretti “di scambio bilaterale”, bensì in termini di “utilità percepita”,
passando cioè attraverso obiettivi valoriali, di tipo qualitativo, percepiti dal bagaglio
culturale della comunità di riferimento, rappresentata dalla pubblica opinione, non dai
diretti interessati, che però influenzano la pubblica opinione in vari modi. Pur essendo
anch’essi “corpi sociali intermedi”, come le aziende, le istituzioni pubbliche sono prive
dell’“assetto proprietario” che caratterizza le imprese private, con consigli di amministrazione e assemblee, facendo invece “corto circuito” col gruppo sociale,
anche quando – come di recente si tende a fare – assumono la forma giuridica di società
di diritto privato.
Le istituzioni pubbliche sono quindi in osmosi col gruppo e ne subiscono
la pressione, a seconda della sua maturità nei settori cui l’istituzione è preposta, come
sanità, istruzione, infrastrutture, etc... Le istituzioni pubbliche non sono legittimate
da un inesistente fatturato, ma dalla loro utilità sociale, percepita dalla pubblica
opinione e dalle classi dirigenti (par. 1.6) e tradotta in “immagine istituzionale”,
espressa dai mezzi di formazione-informazione (par. 4.4) e filtrata dalla politica. Il bagaglio culturale della pubblica opinione su un determinato tipo di attività pubblica, si riflette sul funzionamento della medesima. Per questo, valutare l’efficienza della
macchina pubblica, pur con alcuni elementi generali in comune, dipende dal bagaglio
culturale della pubblica opinione. Qualche volta basta poco, come nel caso della difesa, mentre già serve un miglior retroterra per valutare la sicurezza o la giustizia,
fino alle difficili analisi razionali di sanità o istruzione; a tal fine si intrecciano,
confusamente, le esperienze personali, con varia intensità, le opinioni di seconda mano,
o mediante la stampa.
Le varie funzioni pubbliche sono valutate attraverso il bagaglio culturale della pubblica opinione e le sue scale di valori, in una sorta di “domanda senza mercato”; in buona misura, il funzionamento dei pubblici uffici dipende dagli individui che vi operano,
dal momento che anche “i carabinieri”, “la magistratura”, “gli ospedali”, “le università”,
sono anch’essi “corpi sociali intermedi”, come definiti sopra (e già al par. 3.1 per l’azienda). Le persone che li compongono sono in buona parte influenzate dall’“immagine
sociale” dell’istituzione in cui operano, ed in parte da legittimi interessi personali di cui
diremo al termine del presente paragrafo. Più che una indistinta “macchina pubblica”,
abbiamo varie istituzioni settoriali, ciascuna delle quali interagisce col bagaglio culturale
della pubblica opinione, relativamente al settore cui è preposta.
La matrice di partenza delle istituzioni pubbliche era – come detto – quella militare, da cui derivarono modelli autoritativi; Oggi la frequenza dei servizi a specifici utenti
spinge verso un limbo vagamente aziendalistico-sindacale (Lupi, manuale giuridico di
scienza delle finanze, al paragrafo 6.4). Non abbiamo comunque “clienti”, ma al massimo, “utenti”, ed in materia tributaria abbiamo addirittura un interesse “oppositivo”,
e non pretensivo, nel senso che il contribuente non “chiede”, ma “si difende”.
112
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
Questa appartenenza generale delle organizzazioni pubbliche rischia di deresponsabilizzarle, anche per via del fraintendimento sul “governo della legge” (paragrafo
2.4), col rischio delle degenerazioni di cui diremo, fino alla produzione di equivoci,
propaganda, fastidi, burocrazia e sussidi. La macchina pubblica è ostaggio delle disfunzioni di comprensione e spiegazione esistenti nella pubblica opinione nel suo
settore di operatività; il controllo sociale sulle istituzioni pubbliche passa attraverso
la comprensione del rispettivo settore da parte della pubblica opinione. Nei settori
complessi questo controllo è più difficile davanti a settori complessi, anche perché
la gente è assorbita dal proprio “privato”. La determinazione della ricchezza ai fini
tributari è anche meno alla portata della pubblica opinione, risentendo maggiormente delle carenze formative in materia economico sociale, indicate per l’Italia al
par. 1.6. Per questo la situazione, in materia tributaria, è peggiore che nella sanità,
nell’istruzione, nelle infrastrutture, nell’ambiente e in altri comparti dell’azione
amministrativa sono più comprensibili da parte delle classi dirigenti e della pubblica
opinione. Anche i dirigenti delle istituzioni rendono conto al gruppo sociale attraverso i mezzi di informazione e la politica. Per questo sono importanti, come indicato
al par. 4.4, i mezzi di comunicazione di massa, per il controllo dell’opinione pubblica
sulle istituzioni amministrative.
Questo rapporto con la pubblica opinione è ancora più forte per le istituzioni
del diritto tributario, dove manca quella domanda di attività pubblica “dal
basso”, esistente per la sanità, l’istruzione, le infrastrutture, e gli interessi pretensivi. La
mancanza di una sistematica richiesta valutativa delle imposte, dove le aziende non arrivano, non provoca invece le lamentele che sarebbero connesse al cattivo funzionamento
di scuole, trasporti, ospedali, etc. Non perché la gente sia “complice” di fantomatici evasori, ma per la già indicata estraneità del funzionamento del settore al bagaglio culturale
della pubblica opinione e della classe dirigente. Se neppure gli studiosi capiscono che i
problemi della determinazione dei tributi derivano dalla determinazione della ricchezza, non può certamente intuirlo da sola la pubblica opinione.
In questo disorientamento è rimarchevole l’attitudine progettuale, espressa
nell’ultimo ventennio dai vertici dell’Agenzia delle Entrate. Benché le istituzioni pubbliche non abbiano il compito e le energie per darsi carico di sistematizzazioni concettuali (par. 4.4), i pochi spunti progettuali, soprattutto in tema di “deprocessualizzazione”
sono appunto riferibili all’agenzia delle entrate. L’attenzione della pubblica opinione
alla determinazione tributaristica della ricchezza ha portato ad una accurata selezione
dei suoi dirigenti, almeno dal 1996 a questa parte (cioè da quasi vent’anni).
Il rovescio della medaglia della drammatizzazione sociale e mediatica di cui al capitolo 4 è però che anche una maggiore pressione sui vertici delle istituzioni, ancora più ostaggio della pubblica opinione, di cui devono accontentare un po’ tutte le
tendenze. Ne derivano ostacoli all’azione amministrativa, in quanto, così come manca
sempre il vento per i marinai che non sanno dove andare, le istituzioni tributarie, benché animate dalle migliori intenzioni, sono disorientate dal miscuglio di spiegazioni
diverse sulla determinazione tributaristica della ricchezza (par. 4.6). In ultima analisi,
una amministrazione motivata e determinata, caratterizzata da un ottimo spirito
Capitolo 5 – LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
113
di servizio, perde efficacia per via del disorientamento della pubblica opinione
sulla determinazione della ricchezza ai fini tributari.
La confusione del bagaglio culturale della pubblica opinione e delle classi dirigenti
sul tema influenza il comportamento delle istituzioni amministrative; esse devono interagire con la confusione mentale della pubblica opinione, senza potersi contrapporre
frontalmente ad alcuna delle spiegazioni, tutte per certi versi sensate, che vi si intrecciano.
Benché nessuno capisca meglio di loro, che ci lavorano, la determinazione tributaristica della ricchezza, i vertici delle istituzioni sono in una certa misura “ostaggio” di come le classi dirigenti ed i loro terminali politici si rappresentano il fenomeno. Le drammatizzazioni indicate al capitolo quarto disperdono le energie
in una pluralità di iniziative, che cercano di seguire le varie tendenze diffuse nella
pubblica opinione. Ne risente anche la posizione individuale dei funzionari, in uffici già caratterizzati per ragioni dimensionali, da una maggiore spersonalizzazione
e parcellizzazione di compiti rispetto agli addetti al settore negli studi professionali,
descritti al par. 3.16.
I comportamenti individuali dei suoi funzionari, in un clima di confusione, tendono ad essere “autoprotettivi”, anche tenendo conto dei sospetti di favoritismi e abusi
indicati al par. 5.11.
Man mano che il contesto diventa controverso e sfuggente, aumentano le
riluttanze ad assumersi responsabilità, i desideri di “copertura”, di “essere a posto”,
latenti in tutte le burocrazie. È un riflesso del sano desiderio di quieto vivere della gente
normale, con una sua vita privata, cui non si possono chiedere eroismi e sistematizzazioni concettuali, omesse da quanti vi erano preposti (par. 4.3-4.5). Gli uffici pubblici
fanno sempre il proprio dovere, solo che il proprio dovere passa attraverso quanto la
pubblica opinione si aspetta da loro, e se sul tema c’è disorientamento, esso si ripercuote
sui pubblici uffici. In tutti i settori giustamente i pubblici funzionari si faranno interpreti della propria funzione, tenendo conto di come se ne fa interprete la pubblica opinione e la classe dirigente. Con l’aumento della drammatizzazione e della confusione i
funzionari tenderanno a “rispettare le regole, “essere a posto”.
Questa tendenza è aggravata, nel nostro settore, dallo pseudonormativismo di cui al
par. 4.3, col suo appiattimento sui “materiali normativi”, coi martellanti riferimenti alla
vincolatezza, all’indisponibilità del credito tributario, ad una legalità che diventa legalismo immobilistico, secondo fili conduttori del testo, soprattutto nei paragrafi da 5.8
a 5.11. Una concezione distorta del “governo della legge” (par. 2.4.) finisce per ostacolare lo spirito di iniziativa degli uffici nel valutare con sistematicità la ricchezza
non raggiunta dalle aziende; diventa comodo far durare i controlli, indugiarvi molto,
e cautelarsi formulando comunque qualche contestazione, vuoi per risultato di servizio,
vuoi per esorcizzare i sospetti di negligenza o corruzione di cui al par. 5.11. Questo riduce la sistematicità degli interventi del fisco dove le aziende non arrivano, spingendoli
invece sulle “contestazioni interpretative”; ne ritroveremo applicazioni in varie sedi,
tra cui il par. 5.9 sulla discrezionalità, 5.17 e seguenti sulle contestazioni interpretative
alle aziende, 6.5, sul contenzioso amministrativo.
114
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
5.4. Le istruzioni ai contribuenti come funzione amministrativa tributaria (modulistica, assistenza e interpretazioni amministrative)
Sulle premesse generali di cui al paragrafo precedente, iniziamo dall’attività amministrativa dei c.d. “servizi al contribuente”, necessaria sia per la tassazione
attraverso le aziende, ma soprattutto per la c.d. “autotassazione” (par. 1.5), relativa agli
individui (par. 3.16).
È una attività amministrativa di indicazione e chiarimento necessari a chi deve
“autodeterminare” la ricchezza. Sia alle aziende, sia gli individui servono infatti istruzioni.
In ogni paese, del resto, le modalità di registrazione della ricchezza ai fini tributari,
di acquisizione di versamenti, di dichiarazione e comunicazione di informazioni (ad
esempio sull’inizio di attività economiche, sui rapporti con altri operatori economici,
etc) sono in gran parte regolati da atti amministrativi generali (paragrafo 2.1 sulla
riserva di legge) e da indicazioni amministrative fornite in via preventiva (“ex
ante”, come spesso si dice).
Analogo supporto amministrativo ex ante riguarda il coinvolgimento degli uffici tributari negli adempimenti dei contribuenti, nell’attribuzione dei codici fiscali, nella
ricezione delle dichiarazioni e delle altre comunicazioni “seriali”, nel supporto ai
professionisti e ai centri di assistenza fiscale (C.A.F.); c’è anche l’assistenza a singoli
contribuenti sulla classificazione della ricchezza da loro stessi registrata, anche ai fini
della predisposizione delle dichiarazioni.
In quest’ambito si colloca il ruolo interpretativo “ex ante” dell’amministrazione, fondamentale supporto (già anticipato al par. 3.10 sull’interpretazione) nell’inquadramento giuridico, da parte degli stessi contribuenti, della ricchezza registrata; ricordiamo dal par. 3.10 che quest’interpretazione non è “indipendente”, come quella
del giudice, ma si intreccia con profili di cautela da censure (ci ritorneremo subito),
convenienza del contribuente e di immagine sociale degli uffici tributari. La presa di
posizione preventiva, da parte dei competenti uffici (tendenzialmente centrali) dell’autorità fiscale, garantisce una certa uniformità all’interpretazione degli uffici periferici,
ed informa i contribuenti su come si comporteranno questi ultimi sui punti esaminati.
E quindi il caso di richiamare e sviluppare, a proposito dell’autorità amministrativa, le riflessioni generali sull’interpretazione, svolte al paragrafo 3.10. Abbiamo già
rilevato che tutti interpretano conformemente ai propri ruoli, da quello indipendente
del giudice a quello imparziale delle autorità amministrative (influenzate dalla funzione), a quello parzialmente orientato da legittime convenienze economiche, dei privati
(par. 3.10).
L’interpretazione ufficiale, di un organo tributario di grado superiore, condiziona quella degli uffici inferiori, gerarchicamente dipendenti, in un normale riflesso della matrice di diritto amministrativo della tassazione. All’interno di un’istituzione pubblica ordinata gerarchicamente, l’interpretazione ufficiale della normativa
“è legge”, almeno nella normalità, semplicemente perché non ci sono argomenti logici
che gli uffici dipendenti possano invocare per disattenderla, proprio perché legata all’a-
Capitolo 5 – LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
115
strattezza della normativa, non alle contingenze operative. Questo “valore gerarchico” dell’interpretazione amministrativa la rende particolarmente importante rispetto
alle tradizionali interpretazioni che ne sono prive, nel diritto comune, come i «lavori
preparatori “, i rari, e spesso equivoci, precedenti giurisprudenziali e la pubblicistica.
La qualificazione giuridico-tributaria della ricchezza registrata è molto importante,
a prescindere dal tipo di atto che la contiene, in cui sono contenute, purché ovviamente
si tratti di un atto con funzione interpretativa; l’interpretazione adottata da un ufficio
tributario per determinare l’imposta verso un certo contribuente è priva di effetti verso
un altro ufficio tributario alle prese con un altro contribuente.
Interpretazioni con valenza generale possono essere contenute nel commento a
istituti generali, come avviene nelle c.d. circolari, in risposte a specifici quesiti,
come nelle c.d.”risoluzioni”, in risposte ad attività di consulenza giuridica, ad
istanze di interpello in base al c.d. “statuto del contribuente (par. 2.1), nelle istruzioni
ai modelli di dichiarazione dei redditi (par. 3.4), in comunicati stampa o nelle
risposte ai quesiti della stampa “specialistica”.
Nella matrice amministrativistica del diritto tributario si comprende bene la tutela
di un “affidamento istituzionale”, generata nei contribuenti dalle interpretazioni in esame. Tali interpretazioni ultime, in estrema sintesi, giovano al contribuente, se a
lui favorevoli, in base alla tutela della buona fede, generata dall’autorità amministrativa.
Si crea infatti, nel contribuente, una aspettativa, giuridicamente rilevante, che gli uffici
finanziari, sottoposti per subordinazione gerarchica all’interpretazione dei superiori, vi
si attengano.
Pertanto, nei casi di modifica “peggiorativa” dell’interpretazione, i contribuenti, in
base alla tutela dell’affidamento e della buona fede, saranno comunque immuni da
sanzioni, per le mancate applicazioni del tributo, conseguenti all’osservanza delle indicazioni interpretative successivamente modificate.
Sono applicazioni dei comuni principi di ragionevolezza, secondo cui ognuno può
impegnare se stesso, e non gli altri; verso i terzi si può creare affidamento, ma non creare
vincoli ulteriori, non previsti dal potere di cui si è investiti.
Per questo, l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria non nuoce ai
contribuenti. Non può imporre cioè obblighi non previsti dalla legge, né per quanto
riguarda le regole sostanziali di determinazione della ricchezza (par. 2.3), né per
quanto riguarda i regimi tributari applicabili, né per quanto riguarda gli adempimenti
amministrativi.
Le interpretazioni ministeriali ritenute prive di base normativa possono quindi essere disattese dai giudici senza particolari formalità, annullando l’atto amministrativo individuale che vi si è conformato. Le interpretazioni, come tali, non hanno
carattere immediatamente provvedimentale, e ne è tendenzialmente esclusa una
diretta impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
Sono del tutto estemporanee, rispetto al quadro descritto sopra, alcune svalutazioni, accademiche e giurisprudenziali, dell’interpretazione amministrativa rispetto
a quella giurisdizionale; sono implicazioni inconsapevoli del già indicato atteggiamento
“ragionieristico-processuale” (anziché amministrativistico-economico) secondo cui il
116
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
diritto tributario vede “due parti in lite” tra cui i giudici decidono, esclusivamente in
base alla legge, a chi dare ragione. Le autoreferenziali sentenze svalutative dell’interpretazione amministrativa sarebbero interessante oggetto di studio, sia come esempio dei
disorientamenti diffusi tra gli operatori giuridici sulla collocazione del diritto tributario,
sia sul desiderio generale delle istituzioni, comprese quelle giurisdizionali, di ampliare le
proprie prerogative rispetto a quelle di altre istituzioni.
Molto spesso l’ufficio fiscale periferico si difende considerando non pertinente, l’interpretazione amministrativa addotta dal contribuente. Si innesta quindi una
“interpretazione dell’interpretazione”, con la controversia che si incentra sulla
reale portata dell’interpretazione emessa dagli uffici centrali.
L’importanza delle interpretazioni amministrative, in un contesto di autotassazione è
così forte da essere fortemente avvertita dalle istituzioni fiscali, sotto i due parametri che,
in prima battuta, ne caratterizzano il comportamento: dal punto di vista dell’“immagine
pubblica” le istituzioni fiscali avvertono la richiesta ambientale di diffuse ed esaurienti
interpretazioni. Dall’altro sanno bene, dal punto di vista della “cautela”, che eventuali
disattenzioni interpretative potrebbero essere strumentalizzate dai contribuenti proprio
in nome della già indicata “tutela dell’affidamento” e della più generale coerenza che si
richiede alle istituzioni amministrative. Per questo, anche le interpretazioni amministrative sono spesso improntate a grande cautela, e sono “auto protettive” e “di parte” nel
senso indicato al par. 3.10.
5.5. L’acquisizione delle dichiarazioni, e il loro controllo di correttezza
formale e documentale
L’attività amministrativo-tributaria inizia dall’acquisizione dei dati delle dichiarazioni fiscali, che vengono prima di tutto archiviati nelle banche dati del fisco;
quest’acquisizione informatica è oggi abbastanza agevole, in quanto le dichiarazioni
sono redatte e presentate in modo “informatico”-”telematico” (paragrafo 3.6).
L’acquisizione delle dichiarazioni nelle banche dati dell’amministrazione fiscale consente alcuni controlli formali, verificando informazioni riportate nella dichiarazione
con quelle trasmesse da altri soggetti, come le banche per i versamenti delle imposte.
Un primo riscontro di regolarità esteriore (art. 36-bis decreto 600-1973) avviene su larga scala mediante controllo numerico, incroci informatici attinenti all’effettivo versamento delle imposte dichiarate, che potrebbe essere stato
omesso, ad esempio per difficoltà finanziarie (par. 6.11). Si effettua, nella stessa sede, una
quadratura formale dei dati indicati sulle dichiarazioni, eliminando contraddizioni
direttamente desumibili dalle dichiarazioni medesime.
In tutti questi casi si avverte il contribuente dell’esito della liquidazione, ai sensi
del comma 3 dell’art. 36-bis, con una comunicazione informale, tendente a consentirgli la presentazione di chiarimenti; se questi ultimi non sono presentati, o non
sono convincenti, si iscrive a ruolo la differenza e il contribuente dovrà presentare ricorso.
Capitolo 5 – LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
117
Per una piccola parte delle dichiarazioni, circa il 5 percento, gli uffici richiedono i
documenti giustificativi di oneri deducibili “personali”, come assicurazioni vita,
alimenti al coniuge separato, spese mediche etc. (paragrafo 9.3), detrazioni per familiari
a carico, ritenute d’acconto, etc. (art. 36-ter). Anche qui, in caso di mancata documentazione, la richiesta delle maggiori imposte avverrà con iscrizione a ruolo.
Queste fasi sono talvolta denominate, nella prassi, «liquidazioni della dichiarazione». In tali sedi avvengono anche i rimborsi dei crediti d’imposta con un ordinativo
di rimborso senza le caratteristiche di un atto impositivo formale; un interrogativo
concettuale stabile e curioso è se il rimborso di una somma inferiore a quella richiesta
costituisca atto impugnabile.
Analogamente è da chiedersi se la dichiarazione a credito non tempestivamente
rettificata dall’ufficio tributario, cristallizzi il diritto al rimborso della relativa
somma.
Siamo comunque in una fase “seriale” della tassazione attraverso le aziende, in cui
emergono tutte le difficoltà degli uffici di gestire direttamente, in modo “analitico” e
“personalizzato” milioni di posizioni individuali. Anche questo conferma le difficoltà di ogni tipo di tassazione quando mancano strutture intermedie, come le organizzazioni aziendali di oggi, i piccoli borghi rurali, i feudi o le parrocchie di ieri.
È quindi importante aumentare il coinvolgimento delle strutture private come i
centri di assistenza fiscale e i professionisti, che oltre a raccogliere le dichiarazioni da
trasmettere all’Agenzia, potrebbero controllare i documenti degli oneri deducibili, sviluppando quei controlli formali già indicati al paragrafo 5.5..
5.6. Indagini interne e internazionali, relativi vizi e poteri di verbalizzazione amministrativa
Le indagini fiscali hanno un contenuto inquisitorio, basato sulla possibilità di
infliggere, in caso di inadempimento, sia sanzioni afflittive sia determinazioni dell’imposta influenzate dalla mancata collaborazione del contribuente nel fornire documenti
e riscontri. Questo potere inquisitorio si giustifica anche con l’attuale estraneità degli
uffici rispetto alle circostanze da accertare.
Manca un potere generalizzato degli uffici tributari come tali di chiedere,
a chiunque, informazioni o documenti, sotto pena di sanzioni in caso di non collaborazione; un simile potere, in quanto troppo indeterminato, contrasterebbe forse con
le due già esaminate “riserve di legge”, quella sulle prestazioni imposte e quella sulle
sanzioni; si imporrebbe infatti al contribuente una prestazione personale (obbligo di
rispondere, fornire documenti, etc.), sanzionandolo in caso di inadempienza. Molte disposizioni consentono però indagini ad ampio raggio, come quelle che legittimano
qualsiasi richiesta, ai clienti di soggetti IVA, di informazioni sui loro fornitori.
Sono utilizzabili anche informazioni spontaneamente fornite da chi poteva
disporne a pieno titolo, anche se gli uffici non avrebbero avuto il potere di richiederle in modo coercitivo; le richieste informali degli uffici, effettuate fuori da tali poteri,
118
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
facendo appello al senso civico della spontanea collaborazione col pubblico potere sono
legittime se al destinatario della richiesta non sono minacciate sanzioni o altre conseguenze negative non previste dall’ordinamento.
I poteri istruttori degli uffici, in materia di imposte dirette e di IVA sono sostanzialmente omogenei, e si basano su richieste di informazioni e documenti da esibire
presso gli uffici, oppure su indagini presso il contribuente, nei modi che vedremo; nelle
grandi linee chiunque può immaginarne il contenuto con un minimo di fantasia, senza
bisogno di parafrasare qui, nei soliti sterili schemini, le lunghe elencazioni contenute
negli articoli suddetti.
Per i piccoli commercianti, artigiani e persone fisiche è frequente la convocazione in ufficio, per rispondere a domande, che vengono verbalizzate, oppure per
presentare documenti. Queste richieste devono essere portate a conoscenza legale del
destinatario, come presupposto per potergli applicare, in caso di inadempimento,
una pena pecuniaria, procedendo eventualmente a un accertamento meno rigoroso (induttivo).
Gli accessi, ispezioni e verifiche, sono accomunati dallo svolgimento di indagini presso il contribuente. Si può parlare di accesso in senso generico, come ogni
ipotesi in cui i funzionari si recano presso il contribuente, oppure come “accesso breve” effettuato per rendersi conto direttamente delle caratteristiche di una certa attività,
a supporto di una indagine veloce, effettuata prevalentemente in ufficio (ad esempio su
piccoli commercianti e artigiani).
Il caso più diffuso è la verifica che non si innesta su un monitoraggio iniziale e
permanente, sia pure a distanza, delle attività economiche, sia quelle individuali sia quelle di una certa dimensione organizzativa, come abbiamo indicato al par. 5.5.
I resoconti delle verifiche, cioè i verbali di cui diremo più avanti, sembrano
partire da zero, senza un retroterra di partenza, da parte degli uffici, sulla natura
dell’attività svolta, e soprattutto i suoi punti forti e deboli nella determinazione della
ricchezza ai fini tributari. È una conferma dell’episodicità dell’attività amministrativa in
materia tributaria, cui si connettono equivoci e dispersioni di risorse, che ostacolano la
ricerca e la stima della ricchezza non registrata. Questo monitoraggio permanente delle
attività economiche ai fini tributari consentirebbe di contestualizzare le verifiche,
che oggi sono compartimenti stagni, avulse da una complessiva attività di controllo del
territorio ai fini tributari, iniziando con asettiche descrizioni dell’attività svolta,
come se nulla fosse stato effettuato “a monte”. Il mancato inserimento delle verifiche
nel quadro amministrativo di un controllo valutativo permanente spinge i funzionari
che le svolgono ad “autoproteggersi” con rilievi in genere formalistico-interpretativi.
Viene così dato un senso a questi disorganizzati interventi, riparando chi li effettua da
accuse di negligenza e corruzione.
La scelta di quali poteri istruttori utilizzare in concreto, nonché l’intensità
con cui utilizzarli, per dirigere l’istruttoria in una certa direzione, piuttosto che in un’altra, rientra comunque nella sfera di discrezionalità (par. 510) di chi conduce le
indagini, ferme restando le sue responsabilità (anche disciplinari) in caso di negligenze
o abusi.
Capitolo 5 – LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
119
Le indagini fiscali, come qualsiasi altro esercizio di poteri amministrativi, possono
parzialmente intralciare lo svolgimento dell’attività economica o la vita privata, ma sono preoccupazioni da valutare caso per caso, tenendo conto della complessità delle indagini, del fastidio concreto che l’attività degli uffici provoca al contribuente
o alla sua azienda. Non sono questioni che si prestano ad essere risolte dall’alto, con
una asettica disposizione legislativa, come l’art. 12 dello statuto del contribuente (legge
n. 212/2000) secondo cui le indagini presso il contribuente non possano durare più
di trenta giorni (motivatamente prorogabili per altri trenta). I trenta giorni di “effettiva
presenza” possono essere eccessivi o insufficienti, in relazione a ciò che occorre verificare.
Per accedere in locali adibiti ad attività d’impresa è sufficiente l’autorizzazione
del capo dell’ufficio, mentre per gli accessi domiciliari e gli atti più lesivi della riservatezza (ad es. apertura forzata di borse, plichi sigillati, mobilio, casseforti, ecc. ex art. 52
comma 3, nonché perquisizioni personali) occorre un’autorizzazione del procuratore della repubblica, da richiedere in base a gravi indizi di violazioni tributarie.
Le informazioni acquisite esercitando i poteri istruttori senza le autorizzazioni a tutela di diritti costituzionalmente garantiti, come il domicilio, l’integrità
personale o la riservatezza, sono inutilizzabili come elementi probatori del successivo atto di accertamento. Quest’ultimo è quindi annullabile se non giustificato anche da altre informazioni legittimamente ottenute. Questa inutilizzabilità, sancita
dopo molte incertezze giurisprudenziali, è una sorta di “sanzione” per avere leso un
diritto del contribuente senza le prescritte cautele.
La giurisprudenza tende invece ragionevolmente a non annullare gli avvisi di accertamento basati su indagini dove i verificatori hanno violato disposizioni attinenti
all’organizzazione amministrativa interna della loro struttura; si tratta ad esempio della verbalizzazione di violazioni su periodi di imposta non ricompresi nell’ordine
di verifica, o su soggetti emersi nel corso delle indagini verso altri contribuenti. Questo
attiene alla snellezza organizzativa interna dell’amministrazione fiscale e potrebbe avere
rilevanza esterna solo qualora fosse un sintomo di “abuso di potere amministrativo”, dimostrando che le indagini sono sorte per finalità persecutorie, vessatorie, estorsive etc...
Il sistema contenzioso attuale, sbrigativamente riferito agli atti di determinazione
del tributo (paragrafo 6.8), non consente una tutela giurisdizionale immediata contro
l’invasività delle indagini o gli altri danni immediati che da esse derivano. Ciò non ha
tuttavia provocato particolari lamentele, a conferma di un filo conduttore di questo
volume, cioè quello secondo cui la giuridicità non è necessariamente “giurisdizionale”,
ma anche amministrativa.
In caso di rifiuto di esibire documentazione o di fornire informazioni richieste in sede di indagine è prevista l’inutilizzabilità di tali informazioni e documenti, in sede amministrativa, o nel corso del processo tributario. Questa normativa
è destinata a combattere atteggiamenti ostruzionistici dei contribuenti; questi ultimi potrebbero rinviare a una sede successiva l’esibizione di documenti per
certi versi a loro favorevoli, in modo da impedire riscontri durante la verifica, dove
120
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
i verificatori potrebbero trarre spunto da tali documenti per vanificarne la portata
oppure scoprire altre violazioni con essi collegate. La norma vuole quindi impedire questo differimento di esibizione (ad es. in sede processuale dove i riscontri
sarebbero difficili) e scatta ovviamente solo qualora la richiesta del fisco sia
specifica e circostanziata.
La libera circolazione delle merci, dei capitali, delle imprese etc. (paragrafi 2.6, 3.11)
si accompagnano alla difficoltà dei poteri amministrativi interni (compreso quello
degli uffici tributari) di indagare autoritativamente oltre confine; le libertà europee di
circolazione non riguardano infatti i controlli amministrativi, compresi quelli di indagine tributaria, che rimangono “radicati al territorio”; vi contribuisce anche la deresponsabilizzazione e il desiderio di “copertura legislativa”, timoroso di prendere iniziative
fuori ordinanza, sprovviste di copertura.
L’unico ausilio è la collaborazione amministrativa, cui gli stati sono sempre abbastanza restii, ma che in un quadro comunitario è stata formalmente garantita. Questa
collaborazione avviene però per adesso in forme molto verticistiche, attraverso normative comuni europee ed organi di coordinamento nazionali, che sono diventati spesso
un collo di bottiglia, generando una complessità nociva alla sistematicità dell’intervento
degli uffici.
Veniamo ora alla documentazione delle indagini fiscali, effettuata con lo
strumento generale dei “processi verbali”, in cui si descrivono le operazioni
avvenute e degli incontri svolti; ritroviamo qui un potere tipico delle autorità amministrative, come il “potere di certazione”, che riflette la nota matrice amministrativistica del diritto tributario e della natura di pubblici ufficiali dei funzionari
del fisco.
Il verbale costituisce «prova fino a querela di falso», conformemente ai principi
generali sugli atti pubblici, delle operazioni materiali accadute in presenza del verbalizzante o da lui compiute. Nessuno speciale valore probatorio spetta invece alla parte
logico-critica del verbale, in cui il verbalizzante utilizza i dati osservati per formulare
deduzioni ulteriori (di solito argomenti presuntivi) rispetto ad essi.
Il verbale chiude l’istruttoria e come tale è un atto ancora preliminare rispetto
agli avvisi di accertamento, che eventualmente verranno emessi sulla base dei verbali
medesimi, e verso i quali saranno proposti i ricorsi del contribuente (l’impugnazione
del verbale di fronte alle commissioni tributarie sarebbe prematura, e come tale inammissibile).
La rilevanza esterna immediata del verbale attiene quindi principalmente alla possibilità dell’amministrazione di ottenere misure cautelari di garanzia patrimoniale, come
l’ipoteca o il sequestro di beni del contribuente, a fronte dei debiti tributari calcolati dal
verbale, nonché alla possibilità del contribuente di prestarvi acquiescenza, col pagamento integrale delle imposte, ma con un forte sconto sulle sanzioni, come vedremo meglio
al paragrafo 9.6, sull’acquiescenza e l’accertamento con adesione.
Le indagini nei confronti di altre istituzioni pubbliche, di diversa natura, nazionali o
estere (come le amministrazioni finanziarie di altri stati) si svolgono su un piano paritetico e sono tendenzialmente incoercibili e non sanzionabili.
Capitolo 5 – LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
121
5.7. Gestione dei dati e finalità del controllo valutativo degli uffici: la “tax
compliance”
La tassazione attraverso le aziende, con i suoi dati contabili, consente al fisco la
formazione di ampie “banche dati”; in esse confluiscono non solo le dichiarazioni,
ma anche numerosissime informazioni raccolte attraverso il codice fiscale; si
pensi al possesso di autovetture, imbarcazioni, beni immobili, polizze assicurative, utenze domestiche, e tanti altri elementi economicamente rilevanti, tra cui le informazioni
bancarie e finanziarie di cui riparleremo al par. 5.16, per inserirle nelle metodologie di
accertamento, di cui parleremo più avanti.
Qui precisiamo che il codice fiscale viene recapitato in automatico dagli uffici
di anagrafe per le persone fisiche, e rilasciato su richiesta negli altri casi; per gli operatori economici (imprenditori individuali e professionisti) al codice fiscale si affianca
la partita IVA (par. 7.1). Per le società e gli enti, senza sfera privata, partita IVA e
codice fiscale in genere coincidono.
Queste banche dati del fisco espressamente ritenute legittime dalla normativa
sulla privacy; ciononostante, il garante per la privacy è stato spesso coinvolto per l’accertamento sintetico (par. 5.14), per le indagini bancarie (par. 5.16), per la pubblicazione
dei redditi dichiarati; alcuni passaggi delle prese di posizione dell’autorità appaiono fuori fase rispetto al suo ruolo, facendo trasparire tentativi di mantenere o allargare le prerogative di una istituzione che, anche per altri versi, andrebbe radicalmente riformata.
Queste banche dati sono anche importanti per confermare o smentire chiavi di
lettura generali della tassazione attraverso le aziende, cioè la provenienza del gettito
per categorie economico-dimensionali; la mancanza di chiavi di lettura sistematiche della tassazione, le condizioni della “comunità scientifica” (par. 4.3) impediscono
di formulare le domande giuste a chi possiede questi dati, e può governarli in funzione
mediatica. È normale che le istituzioni fiscali, che gestiscono i dati, accreditino chiavi di
lettura tranquillizzanti, o non alimentino interpretazioni “scomode” su cui torneremo
al par. 5.7.
Le informazioni contenute nelle banche dati del fisco qualche volta consentono
correzioni contabili “a colpo sicuro”, come per le imposte dichiarate e non versate, oppure i proventi segnalati dal sostituto e non dichiarati (par. 3.5 sul sostituto d’imposta),
oppure gli affitti registrati per canoni non dichiarati dal proprietario; queste correzioni
contabili, su cui faremo ulteriori riflessioni al par. 5.16, sono del tutto comprensibili,
ma non riguardano il grosso della ricchezza fiscalmente non registrata, per
come descritto al par. 4.1).
Più importante è l’uso “non contabile” delle banche dati per stimare, per ordine
di grandezza, i risultati di attività economiche estranee alla tassazione attraverso le aziende. Si tratta degli “indizi contabili”, che un filo conduttore del volume
(cfr. soprattutto par. 5.9) inserisce nella tradizionale “tassazione valutativa”, attraverso gli
uffici tributari.
Per sapere quali informazioni scegliere nelle banche dati, e come aggregarle, occorre
quindi una consapevole teoria della determinazione della ricchezza. A tale proposito
122
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
dobbiamo tener presente che, anche sulla ricchezza non raggiunta attraverso le aziende,
ci troviamo pur sempre in un contesto di autotassazione (par. 1.5) dove cioè l’intervento
degli uffici non è “capillare”, ma deve essere il più possibile “sistematico”, spingendo
cioè alla “compliance”.
Occorre quindi ottimizzare l’uso di queste informazioni, cosa che molti uffici
dell’agenzia delle entrate riesce saggiamente a fare, ma di propria iniziativa. Le indicazioni generali, infatti, rispecchiando inevitabilmente la confusione generale, di cui
anche le istituzioni centrali sono ostaggio, non indicano in modo univoco che la
principale funzione degli uffici tributari non è procurare gettito ma sorvegliare e stimolare l’autodeterminazione dei tributi, detta “tax compliance”
nel solito slang anglosassone. Le banche dati devono quindi agevolare l’attività (qualcuno la chiama di “intelligence”), finalizzata al controllo valutativo del territorio,
per spingere a una dichiarazione credibile le tipologie di ricchezza non determinate
dalle aziende.
Il punto di partenza dovrebbe essere un profilo personalizzato del contribuente, non solo contabile, ma anche descrittivo e fotografico (come consente di fare la
moderna tecnologia). Questo “supporto alla valutazione” dovrebbe includere le caratteristiche strutturali dell’attività, narrandone gli aspetti principali, e stabili nel tempo. Potrebbero accompagnarvisi le informazioni su patrimonio personale e spese di consumo,
utili per l’accertamento in base al tenore di vita, di cui al par. 5.14. Sarebbe così possibile
coordinare, attorno a questo “dossier personalizzato” l’insieme di dati grezzi risultanti
dell’anagrafe tributaria; si potrebbe così agevolare, senza neppure allontanarsi dall’ufficio
tributario, il controllo valutativo del territorio, necessario alla stima della ricchezza non
determinata ragionieristicamente dalle aziende. Si potrebbe così evitare di iniziare ogni
verbalizzazione ispettiva con una “indagine conoscitiva”, perché essa sarebbe effettuata
un volta sola, salvo aggiornamenti eventuali. Su questa cornice si inserirebbero tutte le
altre informazioni specifiche, comprese le “indagini bancarie” di cui al par. 5.16.
Un significativo incremento dei livelli di “autotassazione” (par. 1.5), spingendo ad
un adempimento credibile sulla ricchezza non tassata dalle aziende più giungere da
un uso più consapevole del personale complessivo di Agenzia delle entrate,
Guardia di finanza, Esattorie e uffici tributari degli enti locali; il personale
disponibile è probabilmente più numeroso che in altri paesi di analoga struttura economica; anche perché l’elevata esternalizzazione degli adempimenti fiscali sulle aziende
ed i professionisti, libera risorse amministrative per i controlli.
Resta quindi numeroso personale destinabile a valutare la ricchezza non registrata,
controbilanciando, l’elevato numero di “piccole organizzazioni” e di “lavoratori indipendenti” esistenti in Italia, rispetto a paesi di analoghe dimensioni economiche. Per
la mancata consapevolezza istituzionale sulla tassazione attraverso le aziende, l’intervento degli uffici risente della forza d’inerzia del passato, con l’azione amministrativa
contraddittoriamente valutata in termini di “obiettivo monetario”, anziché
di stimolo all’autotassazione, di comunicazione della presenza valutativa del fisco sul
territorio. La mancata percezione della pubblica opinione sulla tassazione attraverso le
aziende e la collocazione della ricchezza non registrata (par. 4.1) si riflette sull’attività
Capitolo 5 – LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
123
di controllo. Invece di essere usata per indurre a registrare la ricchezza non determinata attraverso le aziende, l’attività amministrativa viene in buona parte dispersa,
su questioni di classificazione e di inquadramento giuridico della ricchezza registrata.
L’imbarazzo politico, dopo che si è avventatamente data una spiegazione criminalistica
del fenomeno (par. 4.6), si vede anche nello spostamento degli uffici di controllo
tributario nelle città capoluogo di provincia; vi si connetteva anche una maggiore comodità nella gestione aziendalistica dell’agenzia, ma diminuiva il controllo
del territorio e la sistematicità degli interventi. Con la conseguenza che spesso, per
controllare piccoli commercianti e artigiani, occorrono oggi trasferimenti di centinaia
di chilometri.
La stratificazione delle imposte “recuperate” dall’attività di controllo dell’agenzia
delle entrate è troppo sofisticata per essere qui analizzata in dettaglio (su cui vedi gli
appositi post su www.giustizia fiscale.com cercando su “search” controlli fiscali 2011:da
dove viene l’aumento). Comunque, dei 12 miliardi circa di euro riscossi nel 2012 circa 5
derivano da imposte dichiarate, ma non versate, verosimilmente per difficoltà finanziarie
del contribuente. 2 da aziende di grandi dimensioni (verosimilmente per contestazioni
interpretative), e poco più di uno da “contribuenti di piccole dimensioni”, in cui rientrano i lavoratori indipendenti. Ulteriori disaggregazioni delle cifre fornite dovrebbe
essere più approfondita, ma occorrerebbero spiegazioni di cui non disponiamo. È verosimile però che il gettito da recupero di imposte su ricchezza non registrata sia probabilmente inferiore al costo delle istituzioni fiscali, ma questo non sarebbe un problema; mi
risulta che l’imposta recuperata dal fisco tedesco sia in linea con quella italiana. Il punto
è piuttosto indirizzare l’attività amministrativa non a un recupero diretto attraverso
gli accertamenti, ma ad indurre i contribuenti ad una corretta autodeterminazione della ricchezza non determinata attraverso le aziende. Dove non sono queste ultime
a imporre le imposte, l’intervento degli uffici deve essere adeguatamente sistematico
da indurre all’adempimento. Il nostro rudimentale bagaglio culturale ha invece trasferito avventatamente, in un contesto di autotassazione (par. 1.5), spiegazioni anteriori,
elaborate in periodi in cui erano gli uffici a chiedere capillarmente le imposte, e non era
concepibile un adempimento senza contatti con l’ufficio tributario. Questa fuorviante
tendenza a valutare gli uffici tributari attraverso l’imposta direttamente riscossa, trascura
che essi oggi servono invece a provocare ed alimentare una corretta autotassazione sulla
ricchezza dove le aziende non arrivano.
Ne deriva quindi una necessità di controllare più il territorio, in maniera
valutativa, che i conti della ricchezza registrata. Questa sistematica visibilità del fisco
renderebbe più credibile la pressione mediatico-propagandistica, pur efficace, descritta
al par. 4.2.
La dispersione dei controlli è aggravata anche dalla loro effettuazione su periodi
di imposta molto remoti, invece di concentrarsi “sul presente” per influire “sul futuro”; confrontare la situazione economica visibile con l’ultima dichiarata, renderebbe
molto più rapida. valutativa, e quindi sistematica, la richiesta amministrativa delle imposte, facendo avvertire la presenza del fisco. Inoltre guardare al passato è del tutto inutile
per le attività più pericolose, quelle dove prima si nasconde la ricchezza al fisco”, e poi si
124
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
sparisce, senza che gli uffici tributari riescano a capire chi manovrasse l’evasione dietro
le quinte; inoltre, frequentemente, anche l’individuo che “evade senza sparire”, dopo
cinque anni ha già speso tutto, come vedremo ai paragrafi 6.11 e 6.12, sulla riscossione
coattiva. Per questo, perdere tempo valutando ricchezze remote, di 4 o 5 anni prima,
disperde inutilmente energie amministrative.
Il vero tutoraggio fiscale non dovrebbe essere quello che vedremo al par. 5.17
ss. sulle aziende, ma dovrebbe indirizzarsi dove le aziende non arrivano; questi
interventi, diretti a conciliare il dichiarato con la percezione esterna dell’attività,
dovrebbero essere molto più rapidi, e quindi più numerosi, cioè nel loro complesso
“sistematici”, su un numero di contribuenti anche triplo o quadruplo. Il relativo
“risultato di servizio” non dipenderebbe più dall’Agenzia, ma da in base al livello
degli imponibili dichiarati nella circoscrizione territoriale di competenza, sterilizzando statisticamente l’impatto del ciclo economico. Dopo questi sistematici “screenings” di un numero elevato di lavoratori indipendenti e piccole aziende
operanti al consumo finale, si potrebbero individuare i soggetti fiscalmente più
riottosi; in questo caso, secondo un filo conduttore del testo, si dovrebbe passare
dal “monitoraggio-preventivo” alla “repressione-dissuasiva”. Ciò per essere al tempo
stesso in una prima fase “amichevoli” con la generalità dei contribuenti, e quindi
rigorosi verso l’ostruzionismo a rideterminazioni del reddito serie e credibili.
L’esempio della repressione si giustifica, insomma, come la fase finale (per pochi) di
un percorso amministrativo fatto di prevenzione e monitoraggio (che giustificano
e legittimano la repressione).
Per questo sarebbe importante l’interazione col contribuente nel più necessario
intervento degli uffici tributari, sulla ricchezza non raggiunta dalle aziende. Sarebbe
un tutoraggio valutativo, con un contraddittorio amministrativo permanente, dove ogni tanto passa il funzionario per “chiedere di fare” (adeguare gli incassi)
e dopo qualche tempo ripassa per controllare cosa è stato fatto. Il fisco, in questo
modo, “si fa vedere”, ma in genere non “accerta”, limitandosi a monitorare;
cioè far vedere al contribuente, in modo personalizzato, che lo tiene d’occhio. Sarà il
contribuente – quando gli affari vanno male – ad interagire col funzionario, sempre
ragionando per ordini di grandezza, per credibilità economica, non per dettagli ragionieristici. Ne deriverebbero risultare, dove le aziende non arrivano, valutazioni
estimative diffuse e trasparenti, in quanto “condivise” e accessibili dai soggetti
“similari”, dove contribuenti e uffici (controllandosi reciprocamente in massa) costruiscono insieme una “perequazione fiscale”. È l’unico modo per coordinare l’anima
contabile, efficacissima quando c’è di mezzo una organizzazione, con la vecchia anima
“estimativa” della fiscalità (è un filo conduttore che riemergerà al par. 6.5 per il contenzioso amministrativo).
Alla fine, pur facendosi vedere da un gran numero di contribuenti, e quindi recuperando sistematicità (par. 1.5 sull’autotassazione) la presenza sul territorio sarebbe
molto più elevata, ma gli accertamenti meno numerosi di oggi. Essi sarebbero in gran
parte chiusi in adesione amministrativa, secondo gli auspici di cui al successivo capitolo
sesto. Semplicemente perché non fa archeologia sul passato, ma chiede chiarimenti sul
Capitolo 5 – LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
125
presente e invita a pagare sul futuro, controllando l’ordine di grandezza del dichiarato.
Alla sempre utile propaganda (par. 4.2), si affiancherebbe una presenza valutativa sul
campo, adeguatamente sistematica e quindi realmente “autorevole”. È lo sviluppo del
concetto di “deterrenza”, che non si basa su sanzioni feroci applicate a pochi malcapitati
(par. 6.13), ma spinge all’adempimento la massa.
5.8. Empirismo probabilistico e valutativo nella determinazione della ricchezza non registrata. (Le questioni di fatto nel diritto tributario)
La determinazione della ricchezza ai fini tributari comporta prima di tutto un giudizio di fatto, il cui cui inquadramento giuridico-tributario avviene in un secondo
momento, come già visto ai capitoli precedenti distinguendo tra “ricchezza occultata” (questione di fatto) ed “evasione interpretativa”, dov’è adottato indebitamente
un regime giuridico più vantaggioso di quello dovuto, come indicato ai paragrafi 3.93.10.
È una differenza strutturale alla formazione giuridica, in ogni tempo e luogo,
dove le questioni di fatto si pongono sul piano conoscitivo, non su quello della meritevolezza, delle scale di valori (c.d. “assiologico” o più semplicemente valoriale); anche
nelle questioni di fatto è presente una “valutatività”, ma si pone sul piano conoscitivo, degli ordini di grandezza di entità materiali o economiche, come appunto le stime
del guadagno ritraibile da un certo bene o da una certa attività. Le questioni di fatto
si ispirano prima di tutto a criteri empirici, valutati in base ai concetti di “fondatezza/infondatezza, qualunque sia la sede, processuale, amministrativa, o privata, in cui si
pongono; le questioni di diritto, sia procedurali sia di inquadramento giuridico, vengono chiamate “di legittimità” (con una dicotomia dove in genere l’espressione “fondatezza” è riferita al fatto, e l’espressione “legittimità” al suo inquadramento giuridico).
Il giudizio di fatto ha quindi la propria logica empirico-conoscitiva diretta a
capire cosa è accaduto, autonoma rispetto alle scale di valori con cui approviamo
o disapproviamo il risultato di queste scoperte, cioè lo qualifichiamo socialmente; solo
per questo secondo passaggio la legge è rilevante, mentre il primo è – ripetiamo
– in prima battuta “empirico-conoscitivo”, anche se talvolta condizionato dalle c.d.
“prove legali” cioè da interventi legislativi sulla formazione del giudizio di fatto; sono
condizionamenti di varia intensità, cui sono riconducibili già i casi in cui la legislazione consente o vieta di utilizzare certi mezzi di prova (ad esempio divieto di prova per
presunzioni o per testimoni); l’intensità cresce quando certe circostanze si considerano
provate in presenza di determinate condizioni (ad es. efficacia probatoria dell’atto pubblico o della confessione), o proibisce di considerare determinati elementi in quanto
non esibiti in determinati tempi e luoghi.
La prova “legale” non si contrappone certo, concettualmente, ad una fantomatica “prova illegale”, ma all’ordinaria “prova empirica” (chiamata anche “prova
libera” nei termini indicati sopra), che ne costituisce lo sfondo, ed un utile criterio
orientativo nei casi di dubbio interpretativo delle disposizioni di “prova legale”.
126
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
Per determinare la ricchezza non registrata è fondamentale comprendere il carattere frequentemente valutativo e probabilistico del giudizio di fatto, caratterizzato anch’esso da una fase interpretativa. Anche per i fatti determinati in modo
documentale e ritenuti affidabili c’è sempre una riflessione, una istintiva, fulminea,
valutazione, così rapida che neppure viene percepita, per l’interpretazione di immagini,
dichiarazioni, documenti, fotografie, reperti fisici, ecc..
Queste fonti delle informazioni sono prove in senso materiale, mentre la loro
utilizzazione conoscitiva, più o meno istintiva o razionalizzata, è “prova” nel senso
diverso di interpretazione, di ragionamento; il linguaggio giuridico anglosassone,
per evitare confusioni connesse all’uso dello stesso termine, parla di “evidence” per la
prova in senso materiale e di “proof ” per la prova come ragionamento.
La prova in senso materiale (evidence) viene interpretata dalla prova
come ragionamento (proof), confermando l’ineliminabile valutatività del giudizio
di fatto”.
L’appena indicata componente interpretativa conferma la portata essenzialmente
probabilistica della prova, aspetto su cui c’è convergenza tra i giuristi, e totale disorientamento tra i pratici.
Questo probabilismo segue il consueto gradualismo delle scienze sociali, passando
secondo ininterrotte sfumature intermedie dai casi in cui “mancano ragionevoli
dubbi” sull’esistenza di un fatto a quella dove mancano ragionevoli dubbi della sua
“non esistenza”. Il concetto stesso di “certezza” è solo un modo di indicare un’alta
probabilità, in presenza della quale ci sentiamo al riparo dal dubbio.
Queste probabilità non sono numericamente esprimibili, secondo formule matematico-statistiche, ma solo “valutate”, con argomenti di senso comune, il più possibile
organizzati e convincenti.
Questa valenza probabilistica c’è anche per la tassazione ragionieristica attraverso
le aziende, visto che i documenti sottostanti potrebbero essere stati in tutto o in parte
manipolati; il giudizio di probabilità, oltre a riguardare elementi “puntuali”, circoscritti,
identificati, può riferirsi anche ad entità globali, come la stima degli incassi, dei redditi
o di determinati costi di operatori economici. A questo fine informazioni contabili
e valutazioni per ordine di grandezza si fondono, secondo le varie combinazioni
indicate al prossimo paragrafo.
5.9. Segue: necessità di coordinamento tra controlli contabili e valutativi:
gli “indizi contabili”
La ricchezza che passa attraverso le aziende, determinata in modo ragionieristico,
deve essere coordinata con la tradizionale secolare stima della ricchezza che – invece
– continua a non transitare attraverso le aziende. Non si tratta però di due mondi del
tutto separati, in quanto aziende e lavoratori indipendenti interagiscono tra loro, come
pure aziende più o meno organizzate. Il contesto contabile-ragionieristico, come
vedremo, modifica anche i criteri di stima della ricchezza non intercettata dalle
Capitolo 5 – LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
127
aziende, che spesso lascia comunque gli “indizi contabili” di cui parleremo in questo
paragrafo.
Appare preliminarmente improponibile l’idea stessa di un fantomatico “accertamento contabile” della ricchezza non registrata, che l’ufficio tributario
dovrebbe determinare ragionieristicamente. Se è complesso, per gli stessi contabili
di azienda, tenere in ordine, e quadrare contabilmente, quanto si intende registrare e
dichiarare, è impensabile che l’ufficio tributario possa ricostruire in modo
ragionieristico la ricchezza evasa, che i contribuenti volevano nascondere. Per
questo l’idea di “accertamento analitico-contabile” è miseramente fallita, in quanto
fuorviante in partenza, e risoltasi nel comodo diversivo delle contestazioni interpretative su ricchezza registrata. Possono essere certamente reperite tracce di ricchezza
non registrata, come appunti, ricevute, persino contratti, liste di crediti e debiti, tenuti però per memoria dei rapporti con le controparti, e quindi rapidamente
distrutti, non appena il credito viene riscosso, o il debito pagato. Sono informazioni
troppo rare e volutamente scarne per fondarvi una determinazione contabile della
ricchezza evasa. Sono piuttosto “tracce contabili”, che richiedono interpretazioni presuntive. L’accertamento della ricchezza non registrata è infatti strutturalmente presuntivo, spaziando da presunzioni riguardanti specifici corrispettivi omessi,
o costi gonfiati, fino a presunzioni su masse di operazioni non registrate, come quelle
del piccolo commerciante al dettaglio, con le percentuali di ricarico di cui al par. 5.13.
La valutazione della ricchezza non registrata, in sede di controllo da parte degli
uffici tributari, torna quindi valutativa, secondo la tradizione della fiscalità e nel
quadro dell’empirismo probabilistico del giudizio di fatto (sopra par. 5.8). L’idea
stessa di “accertamento contabile” è stata però molto dannosa, perché ha alimentato
la ritrosia degli uffici tributari, abituati al cauto legalismo del pubblico impiego, verso
valutazioni per ordine di grandezza basate su ragionamenti personali, non corroborati da quella copertura normativa, cui i pubblici funzionari aspirano, come indicato
al par. 5.3. “Mettere la faccia”, da parte degli uffici, sulla stima della ricchezza
non registrata, era ancora più difficile quando quella registrata era determinata in
modo ragionieristico. Le drammatizzazioni sociali indicate al capitolo precedente, la
mancanza di riferimenti teorici, i sospetti ambientali di cui al par. 5.11, hanno trasformato la stima della ricchezza non registrata, da funzione istituzionale in un
motivo di imbarazzo, da cui si cerca di stare lontani finché si può. Questo spinge
gli uffici verso le contestazioni interpretative, che del resto sono le uniche compatibili
con la confusione tra “diritto” e “legislazione”: se solo “la legislazione” costituisce “il
diritto”, solo le questioni di diritto sono rilevanti, mentre la ricchezza non registrata,
essendo “di fatto”, è come se non esistesse per il mondo giuridico (tanto è vero che
nei principali manuali universitari non si parla proprio di questa distinzione, né della
ricchezza non registrata).
La ricchezza non registrata, quindi, può essere determinata solo confrontando
quanto rappresentato al fisco con una serie di elementi che il contribuente non
può negare; le divergenze valutative tra ufficio e contribuente riguardano quindi in
generale la valutazione economica di caratteristiche materiali condivise da entrambi. Ci
128
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
sono le tradizionali caratteristiche economiche dell’attività, cioè le dimensioni dell’esercizio, gli addetti e gli altri indicati al par. 5.13.
Ci sono però anche indizi ulteriori, come quelli “contabili”, cioè i versamenti
bancari, la distribuzione degli scontrini nell’arco del mese, le somme scontrinate
in un giorno in cui il locale era piantonato dai finanziaeri, i ricavi segnalati da clienti
organizzati e istituzionali, gli incassi acquisiti con bancomat o assegni. Anche i versamenti e i prelevamenti bancari, indicati al par. 5.16, sono “indizi contabili”, come quelli
– più tradizionali – dei costi di lavoro dipendente o di energia. Da elementi contabili di
un calcolo ragionieristico, queste informazioni cambiano natura, e si calano in
un ragionamento presuntivo, destinato a valutazioni per ordine di grandezza.
Queste due tipologie di indizi devono essere integrate, nella misura in cui rilevano
per un medesimo contribuente. È un coordinamento da svolgere in modo rapido, visto
il numero di operatori economici coinvolti, con le finalità preventive di cui al par. 5.7,
da associare all’impatto propagandistico-mediatico di cui al par. 4.2. Prima di riprendere
il discorso, al par. 5.13, indichiamo alcuni impatti teorico generali di questa “valutatività” nella determinazione della ricchezza (paragrafo successivo), alcuni ostacoli ambientali alle valutazioni (par. 5.11) e inadeguatezze legislative (par. 5.12).
5.10.Stima della ricchezza non registrata, discrezionalità e “indisponibilità” del credito tributario
La valutazione amministrativa della ricchezza, dove le aziende non arrivano, è un
riflesso particolare della valutatività generale del diritto, che a ben guardare, esiste
anche davanti al giudice. A maggior ragione la necessità di valutare sussiste per le istituzioni pubbliche chiamate a “fare”, come le autorità amministrative (par. 2.4). L’istintiva
concezione processualistica del diritto tributario ha spinto a trasferire sugli uffici tributari la posizione valutativa dei giudici. Ne è derivata una fuorviante idea di “vincolatezza” fuori luogo persino con riferimento ai magistrati; anche questi ultimi hanno infatti
notevolissimi margini di valutazione, essendogli solo sottratto l’apprezzamento diretto
degli interessi in gioco, mediato dalla legge, e restandogli quella che ho in altra sede
denominato “discrezionalità interpretativa”.
Come tutte le altre autorità pubbliche, gli uffici tributari devono invece anche “agire
”, allocando risorse scarse per il perseguimento della propria funzione e proprio qui sta la valutatività della determinazione della ricchezza dove le aziende non arrivano. In questi casi, infatti, sussiste ancora una catratteristica della tassazione tradizionale,
indicata al par. 1.3, e connaturata alla sistematica valutazione della ricchezza da parte
degli uffici, dove è naturale che, con tutta la buona fede, prescindendo da favoritismi ed
abusi, non vi sia una omogeneità valutativa assoluta.
La credibilità economica nella stima della ricchezza, infatti, non conduce a valori
puntuali, ma a fasce di valori, che si assestano a seconda dell’intensità dell’intervento
amministrativo, dei contribuenti valutati in precedenza, delle sfumature tra i diversi indizi disponibili, come vedremo al par. 5.13 per gli studi di settore.
Capitolo 5 – LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
129
Su questa complessa situazione la fantomatica vincolatezza paralizza il ragionamento, secondo lo pseudo-normativismo di cui al par. 4.3. Si ripresenta in sede
amministrativa l’appiattimento del diritto sui “materiali normativi”, con la deresponsabilizzazione, creazione di ostacoli, scaricabarile, trasmissione delle pratiche da un ufficio
all’altro, in attesa che si risolvano da sole, diventando invece alla fine incomprensibili
per tutti. La fantomatica vincolatezza si trasforma in uno strumento di “comodità
istituzionale” ed i preconcetti sull’indisponibilità del credito tributario, sulla mancanza
di discrezionalità, sulla vincolatezza, etc., hanno obiettivamente agevolato la deresponsabilizzazione della macchina pubblica italiana in materia tributaria. Ne sono derivate
paralisi, drammatizzazioni, sceneggiate (par. 5.19), sprechi di controlli fiscali, loro sbilanciamento sulle questioni di diritto (par. 5.7), enormi dispersioni di energie, che rendono
il settore tributario un allarmante campanello d’allarme per la macchina pubblica italiana in genere. Anche la fantomatica vincolatezza offre quindi una sponda teorica al
desiderio di quieto vivere latente in tutte le amministrazioni pubbliche, alla tendenza
a scaricare le decisioni su qualcun altro. Nell’insieme, una serie di fattori culturali (o
meglio subculturali) trattengono i funzionari dalla stima della ricchezza non determinata dalle aziende. Facendo un paragone con altre funzioni pubbliche, sarebbe come se
i medici fossero spaventati dai malati, i maestri dagli alunni, i netturbini dai cassonetti, i
giudici dalle cause, i carabinieri dagli scippatori, i vigili urbani dalle macchine in divieto
di sosta. È un riflesso di una confusione prima di tutto mentale, dove la fantomatica
“vincolatezza” dell’azione amministrativa la allontana dalla ricerca del pubblico
interesse, indirizzandola verso le coperture e le auto protezioni di cui al termine del
par. 5.3. Il pubblico servizio di determinazione della ricchezza assomiglia sempre più a
quei giochi di carte dove tutti cercano di non rimanere con “la peppa” o l’“uomo nero”
in mano, entrambe allegorie della responsabilità.
Sono tutti freni alla ricerca delle migliori modalità degli uffici di perseguire la propria funzione di governo della fiscalità, e di determinazione condivisa della ricchezza. I
sistemi fiscali esteri non sono diversi dai nostri, ma spingono a valutazioni ragionevoli, secondo buonsenso, senza esorcizzare le proprie scelte, rispettando chi ha valutato
e prendendosi le proprie responsabilità, frase che in Italia sembra una minaccia.
La pretesa “vincolatezza” è anche uno strumento per costruire ostacoli, trasformare i diritti in favori, con le degenerazioni di cui diremo al prossimo paragrafo a proposito della corruzione, e delle piccole schermaglie di ufficio indotte dal sospetto,
nonché dal desiderio di mostrarsi rigorosi e zelanti per acquisire “peso specifico”, tra
uffici e colleghi, nella gestione dei rapporti interni e con altre organizzazioni.
Prima di parlare di questo cerchiamo però di capire cosa devono valutare gli uffici, e in quale modo, ai fini della determinazione tributaristica della ricchezza. Rispetto
alla discussione se chiamare “discrezionali” o meno queste valutazioni, è più importante
capire cosa bisogna valutare, cioè di quali profili devono tenere conto gli uffici e
quali devono invece considerare irrilevanti.
Un punto fermo è la non spettanza agli uffici tributari, come già rilevato per
la riserva di legge (par. 2.1), di valutazioni sull’impatto economico-sociale dei
tributi, sullo sviluppo, sul gettito e la tutela patrimoniale, ed altri riflessi politico-
130
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
economici coinvolti nell’applicazione dei tributi. Sono profili importanti, ma riguardano altri settori della macchina pubblica, al cui interno esistono specifiche attribuzioni di
funzioni, ad esempio assistenziali, di sviluppo economico, di ricerca, cultura etc...
Si tratta di profili non valutabili dagli uffici tributari in quanto “estranei alla funzione da essi svolta, cioè la determinazione della ricchezza; quest’ultima però comporta la necessità di contemperare varie esigenze, quando avviene attraverso la valutazione degli uffici, dove le aziende non arrivano. Occorre in questo caso contemperare
i profili già indicati al par. 1.9, come precisione, semplicità, etc., con la sistematicità
dell’intervento degli uffici tributari, in relazione alla massimizzazione dell’impatto
sull’adempimento (par. 5.7). Si tratta di allocare risorse amministrative per definizione scarse, massimizzandone l’efficacia complessiva, il che comporta per definizione,
a vari livelli, valutazioni di opportunità (“costi benefici”, dette anche “trade off ” in
linguaggio anglo-aziendale).
Sono diversi modi per farsi interpreti dell’interesse pubblico, contemperando
qualità e quantià degli interventi ed i loro risultati, in relazione alle tipologie di ricchezza raggiunte, e soprattutto sul contributo alla credibile autodeterminazione (tax
compliance). Emergono quindi profili in cui ciascuno, sia essa autorità fiscale centrale,
articolazioni regionali, singoli uffici e funzionari, deve farsi interprete dei propri compiti. Con margini di scelta influenzati dalle informazioni disponibili, dai carichi di lavoro,
dalle circostanze. Sono profili di valutazione che non possono essere esorcizzati con una
malintesa vincolatezza, e che tanto vale definire come discrezionali nei limiti suddetti. Ne ritroveremo ulteriori esempi anche a proposito della gestione delle liti, della
riscossione e di vari altri profili indicati nel testo.
Sono profili da metabolizzare concettualmente, sia per la serenità operativa degli
uffici sia per la trasparenza del rapporto coi contribuenti; sono discorsi imbarazzanti
perché anche ad alcuni settori delle pubbliche amministrazioni conviene, spesso inconsapevolmente, un’affermazione esteriore di vincolatezza, in modo da sottrarsi a qualunque controllo su come i margini di valutazione suddetti sono stati esercitati. Senza
una riflessione sul tema la pur apprezzabile tendenza “aziendalistica” di pragmatismo
e flessibilità, soprattutto dell’agenzia delle Entrate, rischia di essere insufficiente; qui è
importante il lavoro degli studiosi (par. 4.7), perché gli uffici tributari sono un luogo di
lavoro, non di riflessione. Gli “uomini d’ufficio” che vi lavorano devono misurarsi con
problemi contingenti, senza giustamente interrogarsi troppo sui preconcetti sbagliati
che li hanno prodotti, e di cui riparleremo anche al prossimo paragrafo.
5.11.Segue. I sospetti di connivenza o negligenza come ostacolo a una serena valutazione della ricchezza
La necessaria sistematicità, indicata al par. 5.7, del monitoraggio sulla ricchezza
non intercettata dalle aziende, è ostacolata, come più volte anticipato, dall’imbarazzo
per i rischi di corruzione connessi ai relativi margini di stima, tipici di questa tassazione valutativa.
Capitolo 5 – LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
131
Il timore di essere considerati corrotti, per determinazioni “ragionevoli”, o “a posteriori” anche troppo ragionevoli, spinge infatti i funzionari a “non scoprirsi” e ad
attestarsi nella fascia elevata dell’ordine di grandezza della possibile stima. La rigidità,
il fiscalismo, persino l’ottusità sono simboli che dovrebbero (in apparenza) allontanare i sospetti di negligenza o corruzione. Quest’ultima è quindi dannosa non tanto
dove esiste, quanto perché ostacola la ragionevole stima della ricchezza non raggiunta
dalle aziende. Ne derivano lungaggini sulla durata dei controlli, una forte litigiosità,
un formalismo auto-protettivo, più dannoso della corruzione stessa.
L’imbarazzo aumenta perché è verosimile che chi manovra cifre fuori bilancio
ne prometta una parte al verificatore. Esorcizzare in modo moralistico queste eventualità contribuisce a un clima di generalizzato sospetto, che drammatizza l’azione
amministrativa, dove le aziende non arrivano, togliendole serenità, rendendola meno
sistematica.
Tutta questa apparenza di rigore paradossalmente, come vedremo tra poco, aumenta le occasioni di corruzione. La valtuazione della ricchezza dove le aziende
non arrivano dovrebbe essere infatti snella e sistematica, diffusa e condivisa, quindi,
“economicamente ragionevole” rispetto alle informazioni di massima possedute. Una
stima ragionevole e serena della ricchezza non registrata potrebbe spesso essere rapida,
massimizzando gli interventi del fisco, rendendoli sistematici e perequando la tassazione
dove le aziende non arrivano.
Questo sereno circolo virtuoso è bloccato dal sospetto che poi, per circostanze
sopravvenute, dovesse emergere che la ricchezza non registrata era maggiore, trasformando a posteriori la “ragionevolezza” in una colpa, o in un sospetto: non a caso,
l’espressione “funzionario ragionevole” è spesso usata come sinonimo di “sensibile ad
ammorbidimenti” di vario genere.
L’azione di controllo “sistematica e ragionevole”, che diventa proprio per questo anche “socialmente trasparente” è proprio quella “meno cauta”, che massimizza i rischi di
essere considerati corrotti quando non lo si è. Questo distoglie i controlli dalla ricchezza
non registrata, spingendoli su contestazioni “di diritto” (par. 5.17 ss.), ed al tempo stesso
è uno dei motivi del dilagare delle “prove legali” e della “ragionierizzazione delle stime”
(filo conduttore del testo, cfr. par. 4.5, 5.13 etc), che alleggerisce queste assunzioni di
responsabilità necessarie a valutare la ricchezza non registrata.
Oltre a pregiudicare gravemente l’azione di controllo, questo clima è paradossalmente favorevole proprio per i corrotti, consentendo loro maggiori occasioni. Alla
fine i pochi veri corrotti vivono tranquilli, mentre l’attività degli uffici è fortemente
ostacolata dai tentativi degli altri di “proteggersi” dal sospetto.
Quando infatti tutto si drammatizza e si paralizza, i diritti diventano favori, e
si può chiedere una tangente per qualsiasi cosa, anche per quanto spetterebbe al contribuente di diritto, in automatico. Ricordiamo incidentalmente che i corrotti sono i
primi beneficiari delle affermazioni stereotipe in tema di vincolatezza e di fantomatica
carenza di “discrezionalità”, su cui paragrafo 5.10.
Molte delle distorsioni che precedono derivano proprio dall’imbarazzo delle istituzioni verso la corruzione come problema strutturale della determinazione valutativa
132
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
della ricchezza; la rimozione del problema lo fa pesare come più di quanto dovrebbe,
mettendone in ombra le particolarità.
In materia tributaria manca il correttivo dei “contro interessati”, che possano
notare e denunziare favoritismi sospetti, come avviene ad esempio nell’edilizia, nell’urbanistica, nelle concessioni commerciali, negli appalti pubblici. È un altro motivo per
rendere trasparente il modo in cui è stata valutata la ricchezza di “attività economiche
comparabili”; è un aspetto del “diritto di accesso agli atti”, da contemperare col diritto
alla riservatezza, in modi che non possono essere approfonditi in questa sede (proporremo ancora al par. 6.5 di rendere accessibili al pubblico le definizioni della ricchezza
“in adesione”).
Ricercare la negligenza o la corruzione in base ai criteri per determinare la ricchezza finisce per deresponsabilizzare, in quanto aumenta l’esposizione al sospetto e le
tendenze all’autoprotezione (ostacolando così l’azione valutativa degli uffici, e alimentando determinazioni esagerate, per cautelarsi dai sospetti di corruzione). È un andazzo
che oggettivamente favorisce la ricchezza non registrata, davanti alla quale spesso si fa
finta di non vedere, anche con la massima buona fede, per evitare una “grana”. Non per
timore di azioni di responsabilità davanti alla corte dei conti, escluse per legge, ma per
serenità ambientale.
Il punto di partenza più utile contro la corruzione sono invece le denunce dei
soggetti coinvolti, siano essi i contribuenti o i funzionari; questi ultimi dovrebbero
essere istruiti ad aderire sempre a proposte corruttive, mettendo poi le autorità in condizioni di acquisire le prove inconfutabili per incriminare il tentato corruttore; all’opposto, chi denuncia richieste di denaro dovrebbe essere premiato, ove ci siano riscontri,
e protetto da “accertamenti punitivi” da parte dei colleghi dei denunziati.
La serena sistematicità dei controlli è il miglior antidoto contro la corruzione, perché
genera “prassi comportamentali”, accessibili come rilevato dai contribuenti esercenti attività similari. Ai corrotti giova invece un modesto numero di controlli, potenzialmente
vessatori, che possono diventare “ragionevoli a pagamento”. Abbiamo la conferma che i
miti del “governo della legge”, a danno del buonsenso, producono non solo confusione,
ma anche abusi.
Parzialmente collegato è il sospetto di essere considerati negligenti, e quindi potenzialmente oggetto di responsabilità per danno erariale davanti alla corte dei conti,
la magistratura contabile preposta tra l’altro al recupero dei danni provocati alle casse
statali da pubblici dipendenti. Qui si potrebbe approfondire, in tesi di laurea o di dottorato, la necessità di estendere la già indicata esclusione da responsabilità colpose, dalle
valutazioni effettuate in sede di contenzioso amministrativo (par. 6.4 e seguenti) a tutte
le attività valutative della ricchezza non determinabile attraverso le aziende, se non a
tutta l’attività determinativa della ricchezza in genere. L’ordinaria responsabilità contabile, infatti, riguarda la gestione dei beni e dei diritti ormai entrati nel patrimonio degli
enti pubblici, e che sono suscettibili di essere ordinatamente amministrati. Per questo
una responsabilità contabile, anche per colpa, può sussistere in caso di mancata notifica
di un accertamento già redatto, o di mancata riscossione di un credito tributario già
determinato. Appare invece fuori luogo considerare la ricchezza ancora da de-
Capitolo 5 – LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
133
terminare, non ancora acquisita al bilancio pubblico, e soggetta a tutte le scelte discrezionali indicate al par. 5.10, come un bene o un credito di cui i funzionari possono
proceduralizzare la gestione.
5.12.Segue. Inadeguatezze della normativa sulla prova della ricchezza non
registrata (ambiguità dei concetti di accertamento analitico contabile
e induttivo extracontabile)
Le valutazioni della ricchezza non registrata, dove le aziende non arrivano, pur essendo empiriche, non sono neppure incoraggiate dalle indicazioni contenute nella legislazione vigente. Il cui impianto sembra ancora risentire dell’illusione contabilistica
della riforma del 1973, con la velleitaria pretesa di determinare in modo ragionieristico
la ricchezza non registrata. Le diposizioni in materia appaiono il parto frettoloso di
un empirismo istituzionale, di matrice economicistica, senza il supporto sistematico
di studiosi dedicati alla determinazione giuridica della ricchezza, nella dialettica tra
“tradizionale” determinazione valutativa attraverso gli uffici, e “nuova” determinazione
contabile attraverso le aziende
Anche per questo abbiamo una elencazione normativa composta di stereotipe e tautologiche elencazioni di casi in cui l’ufficio “procede alla rettifica o all’accertamento”;
sono menzionate espressamente ipotesi di rettifica inverosimili, ovvie o ingenue
come la mancata corrispondenza tra elementi dichiarati e indicati nel conto dei profitti
e delle perdite, oppure tautologiche; non serve un articolo di legge per consentire
l’accertamento “quando risultano” “attività non dichiarate”. È altrettanto ovvio che
quando non risultano esattamente applicate le regole di inquadramento giuridico della
ricchezza registrata, l’ufficio effettua le relative correzioni.
Dalla sfilata di stereotipi contenuti nella normativa suddetta non viene alcuna
indicazione sulle vere ipotesi di rettifica, cioè il probabile occultamento di ricchezza,
descritto ai par. 3.7 e 3.13 dal punto di vista del contribuente, e ripreso ai successivo par.
5.13 dal punto di vista degli uffici.
Le stereotipe disposizioni suddette si dilungano sterilmente sulle scritture contabili, trascurando l’affidabilità dell’organizzazione, le sue rigidità, la verosimiglianza
economica del dichiarato, e tutti gli altri aspetti, indicati al capitolo terzo, che determinano l’adempimento o l’evasione.
Più che erronee sono disposizioni inconsistenti, composte di formule criptiche prive di contenuto, né vere né false (si ricordi la tecnica di “parlare senza dire nulla”
con espressioni apparentemente in tema, anticipata al par. 4.3 e che ritroveremo al 5.18).
Meglio sarebbe stato tacere, e lasciar operare i consueti criteri empirici del giudizio di
fatto, indicati al par. 5.8-5.9, prendendo atto (e incanalando) la discrezionalità di cui al
par. 5.10.Trattandosi di disposizioni superflue, come tutte quelle in materia di questioni
empiriche, in loro assenza ci sarebbero stati meno equivoci, meno immobilismi e più
riflessione.Vent’anni di equivoci, e di polemiche sterili, confermano che sarebbe stato
meglio lasciar valutare caso per caso, anziché indicare, con formule inevitabilmen-
134
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
te vaghe, il grado di probabilità astratto che le argomentazioni degli uffici dovevano
raggiungere.
La velleitaria enfasi normativa sulla regolarità o irregolarità delle scritture contabili, porta fuori strada rispetto alla determinazione tributaristica della ricchezza. Ciascuno degli operatori interessati adatta queste normative stereotipe alle
proprie contingenti convenienze, accertative, professionali o difensive, del caso specifico,
le ripete ossessivamente e finisce anche lui per parlare senza dire nulla.
L’inutile e confusionario balletto legislativo indicato sopra ha portato alla elaborazione di due compartimenti stagni, cioè l’accertamento “analitico” e quello “induttivo o extracontabile” L’aggettivo induttivo significa “presuntivo” e “probabilistico”, mentre “extracontabile” significa che prescinde dal risultato contabile, pur
magari utilizzando alcuni dati contabili per effettuare delle presunzioni.
Le rettifiche “di diritto”, attinenti al regime della ricchezza registrata, si inseriscono facilmente nell’accertamento “analitico” (o “contabile”), cioè basato sulla riqualificazione giuridica dei documenti forniti dai contribuenti, reinterpretati in modo
diverso.
Sulla ricchezza non registrata (questione di fatto), l’accertamento “analitico”
può riguardare casi di scuola in cui emerga la prova specifica di un ricavo non registrato,
ad esempio da un documento non registrato, un contratto etc... Quanto più però il fisco
si allontana da “singoli ricavi” rideterminando presuntivamente “gruppi di operazioni”,
tanto più l’accertamento «analitico», si avvicina, secondo il consueto gradualismo delle
scienze sociali, a quello induttivo-globale o extracontabile, di cui agli artt. 39 comma 2
dpr 600 e art. 55 del dpr IVA).
I motivi (o «presupposti») formali dell’accertamento induttivo, per omissioni contabili e documentali, come l’omessa dichiarazione del reddito d’impresa o l’omessa
tenuta di un libro contabile, sono casi limite trascurabili e rarissimamente utilizzati.
Quando l’organizzazione è di notevoli dimensioni, l’accertamento in base alle caratteristiche e alle dimensioni dell’impresa è semplicemente improponibile, mentre emerge
quasi automaticamente per il “lavoro indipendente”, verso consumatori finali,
come anticipato spesso qui e vedremo anche al par. 5.13.
Il problema vero c’è quando la contabilità è formalmente regolare, ma economicamente non verosimile. Ove non si usino gli studi di settore (par. 5.13), l’accertamento
induttivo extracontabile è in genere basato su caratteristiche esteriori dell’azienda, quali la capacità produttiva dei macchinari, la resa delle materie prime o il rendimento degli addetti (ne vedremo esempi ai paragrafi successivi). La rideterminazione
dell’importo complessivo dei ricavi, in base a indizi tipicamente estimativi, disattende la contabilità nella sua affidabilità di base. Simili rideterminazioni “estimative”,
presuppongono che la rappresentazione contabile dei ricavi sia infedele, per il sistematico occultamento di una parte notevole, anche se imprecisata, di essi. A rigore queste
argomentazioni dovrebbero appartenere al c.d. accertamento “induttivo extracontabile”; più brevemente, la giurisprudenza le giustifica con la formula dell’accertamento “analitico induttivo”, affermando che viene rettificato solo l’importo dei ricavi.
Sono scorciatoie per rigettare comunque le obiezioni dei contribuenti, che cercano di
Capitolo 5 – LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
135
farsi scudo con contabilità formalmente regolari, asserendo che il fisco dovrebbe previamente scardinare l’impianto contabile. Invece di stare a discutere sull’idoneità a questo
scopo della rettifica, i giudici tagliano corto, inserendola nell’accertamento contabile
(art. 39 comma 1 e art. 54 dell’IVA).
I ricavi non registrati rilevano in genere simultaneamente, per definizione, sia ai
fini delle imposte sui redditi sia ai fini dell’IVA; quest’ultima avrebbe dovuto gravare sul cliente, ma sarà accertata in capo al fornitore. Si tratta di un riflesso sistematico
dell’oggetto economico del diritto tributario, dove l’IVA e i redditi tassano due facce
della stessa medaglia, cioè il consumo del cliente e il reddito del fornitore.
Anche gli elementi negativi fittizi comportano in genere una indebita detrazione di
IVA, e sono anch’essi rilevanti ai fini dei due tributi.
Le questioni di “riqualificazione giuridica del dichiarato”, come tutte le questioni valutative del reddito di impresa, o connesse ad elusioni fiscali vere o presunte, o ai
regimi IVA applicabili a operazioni dichiarate, rilevano separatamente per ciascuno
dei due tributi.
5.13.Valutazione amministrativa della ricchezza non registrata, tra indizi
fisico-economici e studi di settore (rinvio agli indizi finanziari al par.
5.16)
La mancata registrazione della ricchezza, descritta al capitolo terzo dal punto di
vista dei contribuenti, deve essere qui esaminata, invece, dal punto di vista dei controlli
tributari.
Dal punto di vista degli uffici tributari, il controllo della ricchezza non registrata
da parte di titolari di organizzazioni aziendali pluripersonali (“grande” evasione dei
titolari sopra le aziende di cui al par. 3.7) non può essere riportato a tipologie precise
e l’unico denominatore comune in sede di controllo è la maggiore credibilità esteriore dei relativi risultati. Il controllo fiscale delle aziende di una certa dimensione deve
passare in rassegna le procedure contabili interne, in relazione alla loro scavalcabilità dal
titolare. L’analisi del rischio tributario, cui fa riferimento la delega fiscale del 2013
per le grandi aziende, come pure il progetto pilota varato a metà del 2013, dovrebbe
riguardare proprio questo, ma le idee sono ancora molto vaghe. In pratica però sembra
che le poche contestazioni per ricchezza non registrata verso aziende strutturate
siano nate per ragioni fortuite, cioè liti societarie, familiari, corruzioni di pubblici ufficiali, etc… Comunque Anche alla grande azienda si addicono alcune argomentazioni
presuntive indicate in questo paragrafo, e anche alla spesa degli imprenditori si addice
il valore segnaletico di spese personali incongrue, rispetto ai redditi dichiarati, di cui
diremo al prossimo paragrafo.
Iniziamo quindi dal controllo degli uffici tributari sul lavoro indipendente verso
consumatori finali, esaminato al par. 3.14. Si tratta di piccolo commercio e artigianato, in grado di omettere la registrazione delle componenti attive, togliendo ricchezza da
sopra; questo comportamento, molto più facile per le note flessibilità gestionali, rende
136
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
poco convenienti costi fittizi, fiscalmente più visibili e quindi rischiosi. Neppure sono
rilevanti, ai fini del controllo, i “regimi giuridici del dichiarato”, che possono limitarsi a
deduzioni di spese personali (par. 7.9) sull’inerenza.
Sono soggetti dove non c’è una contabilità occulta da scoprire, al massimo c’è qualche promemoria dei crediti da riscuotere e dei debiti da pagare, distrutto non appena gli
incassi e i pagamenti ci sono stati: altrimenti, il lavoratore indipendente prende i soldi,
li spende, senza bisogno di alcuna annotazione per se stesso. È la solita differenza tra
“aziende” e lavoratori indipendenti, per i quali l’unica visibilità della ricchezza è quella
materiale, economica, stimabile solo per ordine di grandezza dagli uffici tributari. In
base appunto alle caratteristiche materiali ed economiche dell’attività svolta.
Per le attività indipendenti con caratteristiche stabili nel tempo, esiste però una certa
facilità di determinazione valutativa della ricchezza, stimandola per ordine di grandezza
in base a nozioni di esperienza comune. La ricchezza non registrata in queste attività
deriva essenzialmente, come anticipato al paragrafo 3.14, da incassi occultati; individuare specificamente singole omissioni è possibile solo in casi particolari, di rilevante
importo, come l’edilizia o la nautica da diporto.
Per attività diffuse, piccole e tradizionali, è facile stimare la credibilità del giro d’affari
in base a parametri presuntivi. Si tratta dell’ubicazione, della continuità e dell’intensità dell’impegno del titolare e degli eventuali collaboratori, dei beni strumentali, dei
consumi di materie prime o de i margini di guadagno sulle merci rivendute. Alcuni di
questi indizi riguardano tutti, altri si addicono a specifiche attività, in cui esistono
correlazioni stabili tra alcuni fattori produttivi e i ricavi.
Rispetto al passato, la collocazione della stima in un contesto contabile, consente di
utilizzare anche gli indizi documentali e finanziari indicati al par. 5.9, come i canoni di
locazione degli immobili, i consumi di energia risultanti dai fornitori di utenze, i versamenti bancari, gli incassi con carte di credito, gli scontrini emessi, le retribuzioni del
commesso, gli acquisti fatturati di merci.
Le stime presuntive dei ricavi possono basarsi su vari ragionamenti indiretti, a
seconda della loro persuasività economica e della loro credibilità nel caso concreto.
Si pensi alla individuazione di un ordine di grandezza di operazioni che il contribuente non possa negare di aver realizzato, in quanto corrispondenti alle
caratteristiche esteriori del suo negozio, del suo laboratorio, della sua attività
professionale. Moltiplicando questo ordine di grandezza per le tariffe grossomodo
praticate, si può stimare un ordine di grandezza dei ricavi. Ci sono poi indizi valutativi
per varie tipologie di attività, dal consumo di energia per un parrucchiere, ai camerieri di un ristorante, agli acquisti di scarpe di un rivenditore di calzature, alla ricettività
di un albergo, alla percorrenza minima di un trasportatore, etc...
Per i rivenditori di merci al dettaglio, il rapporto tra prezzo al pubblico e prezzo di
acquisto, denominato “percentuale di ricarico” (rispetto appunto al costo) è una
presunzione abbastanza frequente. Applicando questa percentuale ai costi di acquisto, si
dovrebbe giungere a un ordine di grandezza dei ricavi, considerando i diversi margini
di ricarico per le varie merci, le liquidazioni, le stagionalità, i deperimenti, etc... Quando
la percentuale di ricarico è bassa, e le merci sono numerose, la rivendita in nero di una
Capitolo 5 – LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
137
modesta quantità di merci acquistate in bianco, e dedotte, può essere difficile da dimostrare in modo convincente, da parte dell’ufficio tributario (una quota, anche piccola, di
ricavi non registrati può essere molto rilevante rispetto al reddito).
Per le imprese di servizi (albergatori, baristi, autoriparatori, parrucchieri, ecc.)
si può utilizzare, oltre che la ricettività dell’esercizio, un consumo correlato con le
prestazioni rese. Si pensi ad esempio al consumo di farina per una pizzeria, di energia
elettrica per una lavanderia, di caffè per un bar, di vernice per un carrozziere, di gasolio
per un autotrasportatore.
Gli indizi sono meno numerosi, e meno univoci, per le attività senza una sede
fissa, o di cui comunque non sono certe la continuità nel tempo e l’intensità dell’impegno del titolare. Si pensi a chi consegna merci a domicilio, senza avere un deposito
“visibile”, agli artigiani e ai professionisti che lavorano presso i clienti, spesso anche qui
a domicilio; sono attività economiche ad intensità molto variabile, come a maggior
ragione attività fortemente personali, come le ripetizioni, i trattamenti fisioterapici, di
“personal trainer”, le lezioni di musica o di ballo, e tutti i modi con cui si cercano mezzi
per vivere, come indicato al par. 3.15, fino alla prostituzione; in tutti questi casi, vista la
limitatezza delle informazioni sull’intensità del lavoro, nel tempo ha senso l’utilizzazione, di supporto, del tenore di vita (par. 5.14).
Queste determinazioni presuntivo-valutative, da effettuare tipicamente per
ordine di grandezza, andrebbero coordinate con la precisione ragionieristica della
tassazione attraverso le aziende, facendo accettare socialmente l’apparente sfasamento rispetto alla determinazione ragionieristica del reddito di un impiegato o di
un operaio.
Si fanno strada, altrimenti, quelle che abbiamo chiamato “ragionierizzazioni delle stime” (par. 4.5 e 5.9), tra cui rientrano gli strumenti parametrici che, dopo varie
effimere evoluzioni, sono arrivati ai c.d. «studi di settore». Essi ripercorrono, formalizzandole numericamente, e irrigidendole in formule prestabilite, le già indicate stime
dei ricavi, in base alle suddette caratteristiche economico-strutturali dell’attività. Le stime personalizzate per ordine di grandezza sono state però cristallizzate in correlazioni
numerico-statistiche che individuano, per ciascuna attività commerciale e di servizi
con ricavi inferiori a una certa soglia (7,5 milioni di euro), una serie di caratteristiche
economico strutturali in base alle quali presumere le operazioni attive (ricavi) ai fini
delle imposte sui redditi e dell’IVA. Sono automatismi in cui, inserendo una serie di dati
((ubicazione, attività, addetti, costi, attrezzature, etc.), emerge un “intervallo di confidenza” in cui collocare i ricavi. In questa “ragionierizzazione delle stime” gli studi non
coordinano le diverse modalità per stimare i ricavi, ad esempio basandosi al tempo stesso
su varie presunzioni, basate sulle materie prime, sulla percentuale di ricarico, sui beni
strumentali, sull’energia elettrica, sul lavoro dipendente, sulla remunerazione figurativa
del titolare. Ciascun elemento indiziante, di stima, porta ad un ricavo presunto, e tra
tutti i ricavi presunti occorrerebbe calcolare un “ricavo medio”, tenendo conto della
più intensa portata indiziante di alcuni parametri nel caso di specie: Non c’è traccia di
come gli studi di settore, nelle loro formalizzazioni numerico-esoteriche, risolvano il
problema. Fino all’assurdo che, aggiungendo un certo ammontare di acquisti ad una
138
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
azienda con elevata percentuale di ricarico, secondo gli studi i ricavi aumentano di poco
più che i maggiori costi inseriti nel modello. Questi concetti economico statistici
sono estranei alla cultura sia degli uomini di legge sia degli uomini di azienda, annoverando espressioni per loro misteriose, come regressione lineare multipla, reti neurali,
cluster, intervalli di confidenza etc... Anche espressioni apparentemente normali, come
“congruità”, “coerenza”, indicatori di normalità economica, si colorano di strano esoterismo, quando sono usate, ad esempio, per indicare “soggetti congrui, ma non coerenti”. Questa estraneità degli studi alla determinazione tributaristica della ricchezza
emerge anche dal perfezionismo asettico dei raggruppamenti delle attività rispetto agli
indizi personalizzati di incassi non registrati, come le dimensioni, la clientela privata o
aziendale, la valutabilità empirica della credibilità del dichiarato.
I ricavi accertabili in base agli studi paiono spesso assai modesti rispetto a quanto presumibile in base alle caratteristiche concrete dell’attività. Ciò in base alla più
volte rilevata tendenza delle forfetizzazioni e delle parametrazioni a “tenersi basse”,
essendo politicamente più tollerabile un errore per difetto di uno per eccesso (paragrafo 6.5).
Quanto precede spiega la diffidenza, nell’ambiente avvocatesco-ragionieristico
verso gli studi, che appaiono come un misterioso rito economico-statistico; essi quindi
sono spesso valutati “partendo dalla fine”, cioè chiedendosi se il risultato dello studio appare più o meno credibile delle cifre dichiarate, a prescindere dalla metodologia
sottostante. Se i ricavi dichiarati sono bassi, e dagli studi emerge un importo più verosimile, questo è sufficiente a preferirlo, anche senza razionalizzare il criterio di determinazione. Lo studio prevale non per intrinseca bontà metodologica, ma se il suo
risultato è più credibile considerando le caratteristiche dell’attività. La spiegazione di
questi confronti è spesso intellettualmente complessa, e quindi i giudici preferiscono la
scorciatoia argomentativa sulla sufficienza o meno dello studio alla rettifica.
La logica “estimativo-formale” degli studi va coordinata anche con quella “analitica,
degli scontrini, delle altre certificazioni dei corrispettivi, delle altre segnalazioni, delle
indagini bancarie ed annesse presunzioni di rilevanza fiscale di versamenti e prelevamenti, con le limitazioni all’uso del contante (pensate in chiave antiriciclaggio, ma con
un palese secondo fine di contrasto all’evasione fiscale). Anche l’applicazione degli studi
ad attività, come le costruzioni edilizie, in cui i beni ceduti non possono essere nascosti,
appare priva di senso economico.
È parimenti irragionevole applicare gli studi verso chi non lavora al consumo
finale, ma opera verso aziende o enti pubblici, magari anche assoggettato a ritenuta; in
questi casi infatti i i pagamenti in nero sono semplicemente “inverosimili”. La trascuratezza culturale per la determinazione (contabile o valutativa) della ricchezza conduce a
una grossolana presunzione di evasione per chiunque abbia ricavi inferiori a una certa
cifra, indipendentemente dalla tipologia di clientela e quindi dalla possibilità di ricchezza non registrata.possono esserci anche aziende con fatturato inferiore a 5 milioni, ma
alto valore aggiunto, magari appartenenti a gruppi multinazionali rigidamente organizzati, o a enti pubblici, teoricamente soggette agli studi di settore senza avere margini per
occultare corrispettivi.
Capitolo 5 – LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
139
L’obiezione secondo cui gli studi di settore non possono considerare le diverse abilità e attitudini è particolarmente calzante per il lavoro intellettuale; mi riferisco soprattutto alle libere professioni (avvocato, o chirurgo), dove la prestazione è meno fungibile
di quella di un tassista o di un parrucchiere. L’applicazione degli studi ai professionisti,
pur dettata da esigenze di uniformità “politico-comunicazionale”, deve quindi fare i
conti la minore omogeneità delle relative prestazioni, e soprattutto la possibile diversa
intensità lavorativa.
C’è chi attacca gli studi ritenendoli troppo favorevoli ai contribuenti; effettivamente
i ricavi dichiarati dagli “autonomi”, distinti per categoria, sono ancora troppo modesti,
ma relativamente elevati rispetto all’effettivo controllo del territorio da parte del fisco
(paragrafo 4.6); queste critiche non considerano che qualche incremento c’è stato, e
che gli studi possono velocizzare e rendere sistematica una valutazione amministrativa
personalizzata della ricchezza.
In questa prospettiva si colloca anche il rischio che soggetti con ricavi superiori a
quelli risultanti dagli studi di settore, ma con una certa visibilità contabile, ad esempio
per la documentazione richiesta dai clienti, tendano ad “appiattirsi sugli studi”, utilizzandoli come una sorta di catasto, di forfetizzazione dell’imponibile, dichiarando quel
che risulta dagli studi; la coerenza rispetto agli studi potrebbe spingere questi soggetti
a non registrare le somme risultanti da fatture emesse, scontrini, bonifici bancari, o
persino compensi assoggettati a ritenuta. Gli studi neppure riescono a valorizzare i
frequentissimi squilibri in cui magari il soggetto è congruo, ma “stranamente” le sue
fatture sono emesse in prevalenza verso clienti che potevano “scaricare” (par. 9.3 sul
contrasto di interessi).
Ne deriva la tendenza frequente a mostrarsi coerenti basandosi sui ricavi necessari a
coprire i costi, molti dei quali sono però esclusi da IVA (lavoro dipendente, locazioni);
essendo i ricavi soggetti a tributo, c’è la tendenza a registrare soprattutto le prestazioni
verso clienti “operatori economici”, che detraggono l’IVA e deducono i costi. Di tutto
ciò negli studi non c’è traccia, perché lo strumento in esame dimentica la tassazione
attraverso le aziende, cercando banalmente di “mummificare” in un marchingegno parametrico le valutazioni che dovrebbero caratterizzare la tassazione attraverso gli uffici.
Oggi come oggi l’adeguamento agli studi di settore è sollecitato soprattutto
dai commercialisti, che in questo modo si cautelano rispetto a future lamentele
dei clienti nel (remoto) caso di controllo; è quindi un caso di “tassazione attraverso i
professionisti” (par. 3.16), che spingono i clienti all’adeguamento per cautelarsi rispetto
a responsabilità proprie; questo anche andando contro l’interesse reale del cliente, basato su una razionale valutazione del rischio di controllo, spesso presentato in misura
superiore a quella effettiva dal commercialista, per le suddette ragioni di cautela. Anche
questo conferma l’utilità di questo strumento, anche se ovviamente “non risolutivo”,
nell’attesa di un affinamento graduale della sensibilità valutativa degli uffici e dell’ambiente tributaristico in generale.
Gli studi garantiscono un primo livello di credibilità e sono adatti per una prima
richiesta “adeguatamente sistematica”, cioè diffusa, con istruttoria snella, e senza pregiudizio per ulteriori stime personalizzate. È infatti da escludere che qualcuno registri
140
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
ricchezza che non possiede solo per essere congruo e coerente con gli studi di settore.
Dopo aver quindi profittato della suddetta “tassazione attraverso i commercialisti”, si
potrebbe svolgere il controllo valutativo del territorio da parte degli uffici, di cui al
par. 5.7. Si tratta di un confronto personalizzato di credibilità esteriore, tra quanto
dichiarato e le caratteristiche dell’attività. Sarebbe un passaggio molto rapido, di
prevenzione – monitoraggio senza analisi ragionieristiche, da svolgere in modo
sistematico, che si trasformerebbe in una attività accertativo –repressiva solo per le
posizioni più spregiudicate, secondo la distribuzione (e la finalità) dei controlli di cui
al paragrafo 5.7.
L’obiettivo dovrebbe essere una corretta rappresentazione delle attività, e una iniziale
personalizzazione degli studi di settore. L’area di “franchigia fiscale” connessa alla
difficoltà di determinazione dei redditi di queste categorie, sarebbe finalmente gestita
in modo valutativo, e non scaramanticamente ignorata. Senza un’impossibile determinazione “al centesimo” su pochi lavoratori indipendenti, l’obiettivo sarebbe una
credibilità complessiva dell’insieme delle attività dove le aziende non arrivano. È questo (paragrafo 5.7) il vero “tutoraggio fiscale” amministrativo, in cui va
inquadrata anche l’utilizzazione della spesa personale (redditometro) di cui diremo al
prossimo paragrafo.
5.14.Tenore di vita e spesa “privata” come indizio di ricchezza non registrata (accertamenti “sintetico-redditometrici”)
Finora abbiamo parlato in prevalenza di determinazione della ricchezza, in
modo contabile o valutativo, guardando la relativa produzione. Si tratta del
metodo più efficiente nei contesti economici aziendal-tecnologici come quelli in cui
viviamo da alcuni secoli; la tassazione ragionieristica attraverso le aziende è un caso
emblematico di determinazione della ricchezza alla produzione. Anche la tassazione dei consumi è sempre avvenuta attraverso gli operatori economici che fornivano
prestazioni ai consumatori finali. La determinazione della ricchezza reddituale al
consumo appare concettualmente meno efficiente, ma ha dato risultati apprezzabili
su alcune tipologie di ricchezza. Nell’era agricolo-artigianale la tassazione reddituale alla produzione riguardava solo i redditi agricoli e veniva integrata con
tassazioni reddituali basate sul tenore di vita (sistemi a ripartizione, di cui al par.
1.3), che finivano per colpire anche artigiani, piccoli commercianti, ed altri operatori
non agricoli; da quando anche dei redditi non agricoli sono stati tassati alla produzione
(paragrafo 1.8) la tassazione del reddito al consumo è divenuta meno importante. Ne
rimaneva traccia, in Italia, nella c.d. ’imposta di famiglia, fortemente devitalizzata già
prima della sua abolizione formale, con la riforma fiscale del 1973; la determinazione
del reddito in base ai consumi fu in quella sede prevista a proposito del c.d. “accertamento sintetico”.
È un metodo alternativo e complementare, una soluzione di ripiego, per i casi in
cui appare troppo difficile o complessa la tassazione del reddito alla produzione.
Capitolo 5 – LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
141
Non è certo il caso del lavoro indipendente al consumo finale, di cui al paragrafo
precedente, dove alla mancanza di determinabilità contabile della ricchezza, si può supplire con le stime indicate al paragrafo precedente. L’esame delle attività sottostanti offre
in genere indizi valutativi più numerosi, più univoci, più stringenti di quelli ricavabili
dal consumo personale del titolare.
In prima battuta, la determinazione tributaristica della ricchezza è più agevole alla
fonte, nei luoghi di produzione, cioè officine, laboratori, negozi e studi professionali,
di scambio (dove il fornitore tassa il consumo del cliente), di deposito (investimenti
immobiliari e finanziari).
In genere un individuo guadagna in un modo soltanto, o al massimo due,
mentre spende in tanti modi diversi. Per questo, risalire al reddito in base ai consumi è macchinoso, e vale la pena di farlo solo quando gli indizi derivanti dall’attività
sono molto deboli, o collocabili in una “forchette” di valori molto vaste. Il consumo
può quindi essere uno strumento per mettere a punto la determinazione della ricchezza in base all’attività, senza però mai abbandonarla. Sarebbe invece impraticabile e
inefficiente procedere solo in base ai consumi, anche se i dipendenti dell’Agenzia delle
entrate fossero trecentomila anziché trentamila.
Per questo sono state utilizzate, per anni, solo spese “ad alta visibilità”, come il mantenimento di autovetture, di residenze secondarie, di imbarcazioni da diporto, investimenti patrimoniali, come la sottoscrizione di capitale societario o l’acquisto di beni di
valore. Anche qui si tratta di determinazioni valutative, con cui gli uffici hanno scarsa
familiarità, e che si è cercato di forzare nella in una predeterminazione automaticostatistica, simile a quella già incontrata al paragrafo 5.13 per gli studi di settore, e qui
denominata “redditometro”.
Regolamenti applicativi si innestavano quindi sulle spese “visibili” indicate sopra,
per esprimere le spese ulteriori di “minimo vitale” non rilevabili specificamente, come
alimentazione, vestiario, etc...
La determinazione del reddito in base alla spesa è stata usata spesso come diversivo politico davanti alle lacerazioni sociali tra lavoro dipendente, tassato attraverso le
aziende, e lavoro indipendente. Basarsi sulla spesa, trascurando la produzione, consente di
mettere in secondo piano le differenze tra piccoli commercianti, artigiani, dipendenti e
professionisti. Tutti diventano uguali davanti alla spesa, e alle sue conseguenze sul piano
della determinazione della ricchezza, tanto più che le categorie produttive sono molto
meno “sindacalizzate” sul punto rispetto ai consumatori, il che crea meno imbarazzi politici. Quest’utilizzazione “politico-mediatica” dell’accertamento sintetico è stata riproposta nel 2010, con evidenti finalità di marketing comunicazionale (par. 2.4), cercando di
ampliare la banca dati analitica sulle spese di consumo effettive di rilevante ammontare,
rilevate attraverso il c.d. “spesometro”, di cui abbiamo parlato al par. 3.6 a proposito
dell’uso segnaletico delle ritenute di acconto. Ovvie ragioni pratiche comportarono di
nuovo l’utilizzazione di “indici Istat” per le spese minute di mantenimento. È stato un
effetto di annuncio, in cui si è girato a vuoto per circa quattro anni con inutili discussioni,
chiacchiere e polemiche, relative anche alla privacy, che confermano l’arretratezza, in
Italia, della riflessione sulla determinazione della ricchezza ai fini tributari.
142
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
La spesa potrebbe essere invece un utile soluzione di ripiego per le attività che
lasciano pochi indizi “alla produzione”, perché ad intensità variabile nel tempo,
potenzialmente discontinue, come indicato ai paragrafi 3.15, 5.13 e 5.15. Un riferimento alla fonte produttiva della ricchezza ha sempre e comunque una certa importanza necessario, ma il tenore di vita può servire a mettere a fuoco determinazioni
che, in base all’attività esercitata, sono ancora troppo vaghe. Nell’empirismo del giudizio
di fatto (par. 5.8) è del tutto logico utilizzare la villa al mare dell’idraulico per rettificarne gli incassi lavorativi, sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte sui redditi. Lo stesso
vale per le spese personali di parecchi industrialotti, magari con un reddito dichiarato
“rispettabile”, ma che acquistano di continuo auto di lusso, natanti, gioielli e servizi
costosi, incompatibili cui redditi dichiarati negli anni, e il finanziamento verosimilmente
proviene dalla ricchezza non registrata presso l’azienda.
Questo coordinamento tra argomenti “alla produzione” e “al consumo” sarebbe
possibile anche “a legislazione vigente”, ma la presenza di norme diverse asseconda la
solita tendenza a “non esporsi” in valutazioni troppo personali. Viene quindi abbandonata, nella prassi, la possibile utilizzazione combinata di argomentazioni riguardanti
l’attività e la spesa personale.
Questa rigidità, e ritrosia verso le valutazioni, ostacolano anche la determinazione, in
base agli incrementi patrimoniali, della ricchezza ricevuta per successioni e donazioni,
soprattutto quelle “informali”, come vedremo al paragrafo 10.5.
La determinazione dei redditi al consumo deve infatti considerare l’eventuale finanziamento delle spese con somme non costituenti reddito imponibile, prima
di tutto per erogazioni di altri soggetti, come genitori o coniugi, o redditi esenti o soggetti a imposta sostitutiva, smobilizzi patrimoniali o prestiti. Di tutte queste forme “alternative” di finanziamento è ovviamente possibile dare la prova, neutralizzando queste
rettifiche, ma con notevoli dispersioni di tempo per uffici e contribuenti.
5.15.Quale intervento amministrativo su manifestazioni collaterali o sporadiche di ricchezza?
Vediamo ora i riflessi accertativi sulle forme di ricchezza “poco visibili e sfuggenti”,
indicate al par. 3.15. Ricordiamo che si tratta di operatori economici senza sede fissa,
dell’utilizzazione di cespiti molto frammentati sul territorio (ad es. fitti e subaffitti non
dichiarati al fisco), di lavoro discontinuo, precario e saltuario.
Ci sono poi, sul piano dei redditi di fonte patrimoniale, le plusvalenze occasionali e
i redditi di capitale da prestito, spesso tra ristretti circuiti di conoscenti.
Se il controllo valutativo sul territorio, da parte del fisco, è già difficile per le attività
“visibili”, come quelle di commercio e servizi “tradizionali”, dotate di una struttura
esterna, figuriamoci per queste situazioni. Talvolta la ricchezza è determinabile ancora
più difficilmente perché “schermata” da altre “”fiscalmente visibili”. Sono fenomeni
tralasciati da qualsiasi sistema tributario, fino a che però si mantengono in un ordine di
grandezza trascurabile, mentre in caso contrario, man mano che diventano consistenti,
Capitolo 5 – LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
143
sono un altro motivo di intervento valutativo degli uffici tributari, ovvero della loro
perdita di controllo del territorio. Sono casi di inadeguatezza della tassazione contabile attraverso le aziende, che confermano il bisogno di integrazione attraverso una
tassazione valutativa attraverso gli uffici adeguatamente sistematica.
Questa difficoltà trascurabile, finché si mantiene su piccola scala, diventa un notevole problema politico, di governo della fiscalità, quando le aziende si disgregano, e si
regredisce a una economia di piccoli scambi, in un certo senso di autoconsumo,
spostato però in una società al tempo stesso postindustriale, deindustrializzata e
disorganizzata..
Non mi voglio qui dilungare sul probabile circolo vizioso dove la disorganizzazione
della macchina pubblica destruttura le aziende private, rinviando a vari post su www.organizzazionesociale.com e per i tributi ai paragrafi 5.17 ss. Tuttavia una crescente fascia
di popolazione “si arrangia”, con attività che sfuggono sia alla tassazione attraverso le
aziende sia a quella valutativa attraverso il fisco; questa perdita di controllo del territorio da parte della macchina pubblica rivela una disgregazione sociale che non si può
combattere con qualche comunicato stampa, in cui si esaltano poche azioni sporadiche.
Più la ricchezza è frammentata, più l’attività valutativa deve essere sistematica, e quindi
rapida, efficiente e con pochi strascichi, gestendo i tempi, le risorse e i risultati nei modi
indicati al par. 5.10 sulla discrezionalità.
Quando l’attività neppure è stabilmente “visibile”, riemerge l’importanza del tenore
di vita, ai fini della determinazione della ricchezza. In quel caso le spese personali, di
consumo o patrimoniali, rappresentano uno strumento per comprendere l’attività svolta, e quindi mettere a fuoco una valutazione della ricchezza basata su una stima
“mista” tra consumi personali e attività produttiva.
In un contesto in cui è insufficiente persino il controllo di attività radicate sul territorio, è facile comprendere la difficoltà di individuare direttamente i fenomeni che
precedono, quantificando la ricchezza che manifestano. Oltre che difficili da stimare, il
loro complessivo impatto economico non è straordinario, e singolarmente i percettori
non sono neppure particolarmente ricchi. Per questo, gli interventi amministrativi sono
di fatto rarissimi, ed è sorprendente la cifra annua di meno di 10 mila evasori totali
individuati, quando passeggiando in alcune strade della periferia di Roma si vede materialmente un probabile evasore totale ogni cinque metri.
Accanto a questa visibilità “fisica” sul territorio, che pone solo problemi di stima, c’è
una visibilità che potremmo definire “pubblicitaria”, soprattutto per i prestatori di
servizi a domicilio, dall’assistenza, alla manutenzione, a varie forme di servizi personali.
Spesso trasmissioni televisive di giornalismo di inchiesta rispondono a inserzioni che
pubblicizzano, magari su internet o mediante volantini, lavori a domicilio, manutenzioni elettriche, idriche, informandosi sulla fattura e registrando le risposte negative, o
guardinghe; anche queste attività, se non operano attraverso un ristretto giro di conoscenze personali, hanno infatti bisogno di rendersi visibili, a costo di esporsi agli occhi del fisco. I cui uffici potrebbero consentire un’identificazione di chi propone questi
servizi, agevolando la redazione dei “fascicoli informativi permanenti” di cui abbiamo
detto al par. 5.7.
144
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
Emerge anche sotto questo profilo l’insufficienza delle attuali “banche dati” e la
necessità di un supporto permanente valutativo delle singole attività economiche, ricordato anche al par. 5.13 per l’accertamento induttivo.
Questa profilatura tributaria individuale dei contribuenti, con agganci alle
fonti di sussistenza, compresa la “situazione familiare”, è sempre più necessaria
per affiancare le rilevazioni contabili provenienti dalle aziende. Questa “schedatura
fiscale”, per certi versi una riedizione degli antichi catasti (par. 1.3) è tanto più
necessaria quando si riducono gli spazi per la tassazione attraverso le aziende, e milioni di persone e famiglie, guardando le statistiche delle dichiarazioni, sembrano
un mistero fiscale, perché non si capisce come facciano a vivere. Bisognerebbe
capire in quale misura sono veri poveri, finti poveri o titolari di redditi soggetti a
tassazione forfettarie (agricoltura par. 8.1) o sostitutive (rendite finanziarie di cui al
par. 8.5). La risposta a questa domanda è completamente fuori dal controllo
del fisco. Molti contribuenti, che dichiarano redditi immobiliari o occasionali
di poche decine di euro, vivono probabilmente a carico di altri, oppure possiedono fonti di sostentamento patrimoniali, da non indicare in dichiarazione. Poi
ci saranno anche, nascoste in quest’area, ricchezze fiscalmente non registrate, ma
il problema non è di tassazione, quanto piuttosto di conoscenza e di gestione
delle informazioni necessarie a una efficiente determinazione amministrativa
della ricchezza.
Il problema non è “tassare”, ma semplicemente “conoscere” milioni di individui
che, come i gigli dei campi, “non seminano, non raccolgono, eppure il signore li nutre”.
La consapevolezza di questa conoscenza spingerebbe molti contribuenti rientranti in
quest’area ad una autotassazione meno infedele. In questa prospettiva, ripetiamo che
il già indicato schedario della posizione lavorativo-patrimoniale dei contribuenti (par. 5.7) potrebbe efficientemente reinterpretare, adeguandola al contesto
economico moderno, la funzione degli antichi catasti, descritta al par. 1.3, reinterpretata al contesto odierno con lo schedario delle attività economiche di cui al par. 5.7,
eventualmente integrato con informazioni patrimoniali.
Potrebbe trattarsi di un supporto descrittivo, a cura degli interessati, basato anche
su loro autocertificazioni, da fare oggetto di riscontri empirici. Sarebbe un primo
strumento per evitare che milioni di persone e famiglie diventino tributariamente
un “oggetto misterioso”, come è accaduto a forza di appiattirsi sulla tassazione attraverso le aziende e sul suo contabilismo. Questa necessità di “anagrafe tributaria”
emerge anche nelle confusioni della pubblica opinione, che scambia le dichiarazioni
dei redditi per un archivio patrimoniale sulla ricchezza individuale, di cui invece in
Italia non c’è traccia.
Per le note ragioni “culturali”, gli uffici tributari vedono invece la valutazione per
ordine di grandezza come “una grana” (par. 5.10 sulla paralisi indotta dalla deresponsabilizzante idea di “vincolatezza”), inseguendo i fantasmi contabili di cui al paragrafo
successivo, nell’illusione di utilizzare la determinazione contabile della ricchezza anche
dove ne mancano i presupposti.
Capitolo 5 – LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
145
5.16.Incroci, banche dati, e tracciabilità: illusioni e realtà su altri “indizi
contabili”
Nell’era aziendal tecnologica, la determinazione della ricchezza presenta sempre
una trama di tracce finanziarie, che vanno adattate alle varie tipologie di attività
economiche. L’insieme degli indizi finanziari, costituiti dalle modalità di pagamento,
dalla diffusione della c.d “tracciabilità”, dal tema del “contante” e della riduzione della
sua circolazione.
Abbiamo già visto che è inutile mettere in piedi una contabilità con incroci dei dati
della ricchezza dichiarata, tipici della tassazione attraverso le aziende. Come indicato al
par. 4.5 si tratta di una forzatura che trasforma la tecnologia, applicata a dati giuridicamente qualificati all’interno delle aziende, nella mitologia di una magica qualificazione
fiscale di dati raccolti per altre finalità.
I dati che transitano nei canali di pagamento delle banche, costituiscono “indizi
contabili” nel senso già indicato al par. 5.9, e devono essere oggetto, da parte degli uffici,
delle tipiche, tradizionali, valutazioni presuntive per ordine di grandezza.
La tracciabilità e le indagini bancarie sono utili, ma non possono essere un sostituto della determinazione contabile della ricchezza anche quando non ci si può inserire
sulle registrazioni effettuate dalle aziende a fini gestionali. La “tracciabilità” non può
avere gli stessi effetti miracolistici della “contabilità aziendale”. Solo che si tratta di dati
aggregati ad altri fini, e non può esserci una quadratura contabile, in funzione del contribuente, dei relativi indizi.
Il pagamento può avvenire tramite assegni, bonifici, carte di debito prepagate, carte
di credito, ed i proventi sono indirizzabili sui conti più disparati; su cui è possibile far
transitare versamenti, prelevare per poi rapidamente chiudere i conti, oppure intestarli
a familiari o prestanome, ovvero ancora collocarli all’estero. Il numero di contribuenti
coinvolti, a ciascuno dei quali corrisponderebbero innumerevoli operazioni da controllare e interpretare, è elevatissimo, il che esclude una adeguata sistematicità degli
interventi del fisco.
Va segnalata poi l’impossibilità di abolire del tutto il contante, e anche la
possibilità di utilizzare monete parallele di vicinato, o al limite nuove forme di baratto. Quest’insieme di circostanze conferma che neppure la tracciabilità può portare la
determinazione contabile della ricchezza dove non arriva la tassazione ragionieristica
attraverso le aziende.Tanto è vero che questa mancata registrazione resiste anche in
paesi in cui la moneta cartacea è stata pressoché abbandonata.
La tracciabilità, e la moneta elettronica, offrono al fisco maggiori garanzie
rispetto al contante, ma non qualificano e quantificano direttamente la ricchezza,
come i documenti aziendali. La moneta elettronica deve essere trattata come un “indizio contabile”, nei termini chiariti al par. 5.9, come supporto per una valutazione
presuntiva. Soprattutto senza attendersi dalle rilevazioni bancarie una supplenza alla
contabilità.
Non esiste infatti una aggregazione delle informazioni bancarie in funzione
dei concetti economico-tributari di reddito, consumo e patrimonio. La banca,
146
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
per il suo stesso ruolo “passivo” di depositaria delle somme versate, non ha modo
di classificarle in funzione dei concetti indicati sopra; essa non possiede infatti informazioni sulle ragioni effettive di versamenti e prelevamenti, dovendo stare a quanto
indicano gli interessati.
Sul piano operativo, le indagini bancarie sono notevolmente snellite a seguito
dell’anagrafe generale dei conti bancari, attraverso la quale l’amministrazione finanziaria conosce in tempo reale dove il contribuente intrattiene i conti, e in prospettiva
anche quanto sono stati movimentati, in modo da poter chiedere solo i dettagli rilevanti
alla singola banca interessata.
La difficoltà per gli uffici di collegare i movimenti bancari con operazioni economiche ha condotto a presunzioni legali vessatorie, secondo cui tutti i versamenti
e i prelevamenti non spiegati dal contribuente, si considerano come ricavi o compensi evasi (art. 51 comma 2 decreto IVA e art. 32 n. 2 decreto 600). La disposizione,
per molti versi irrazionale, soprattutto per la contraddittoria rilevanza reddituale dei
prelevamenti asseconda la solita deresponsabilizzata tendenza degli uffici di “non
valutare”, lasciando che il contribuente si tragga d’impaccio in sede giurisdizionale,
cosa molto difficile vista la sbrigatività del processo tributario. La consapevolezza
umana, da parte dei funzionari degli uffici, del carattere vessatorio di questa normativa
finisce per dissuaderli spesso, giustamente, dall’effettuare queste indagini (è un caso in
cui il “rigore normativo” diventa controproducente e una legislazione assurda diventa
controproducente).
Anche restrizioni all’uso del contante e tracciabilità delle movimentazioni bancarie,
dettate contro il riciclaggio, possono avere ricadute fiscali; le istituzioni intuiscono
che il monopolio pubblico dell’emissione di moneta può contribuire alla determinazione tributaristica della ricchezza. Anche se però si eliminasse del tutto l’uso del
contante non ci sarebbe comunque una aggregazione della ricchezza secondo i concetti
economici indicati sopra. Anche qui c’è l’illusione di utilizzare “la tracciabilità” come
sostituto della tassazione ragionieristica attraverso le aziende sulla ricchezza da esse non
raggiunte; una strana “tassazione attraverso gli intermediari finanziari” non può sostituire la “tassazione attraverso le aziende” dove esse non arrivano. Le informazioni degli
intermediari finanziari sono invece uno strumento per la tassazione attraverso gli uffici.
La tassazione attraverso le aziende presuppone infatti che esse siano “parti” (cliente o
fornitore) delle operazioni tassate o segnalate al fisco. L’intermediario finanziario non
può sapere se dietro a innumerevoli operazioni effettuate con bancomat, assegni o bonifici c’è né una erogazione di reddito o una percezione di spese per consumi; anche
per questo gli imponibili non registrati, sia pure inferiori ai livelli italiani, restano
notevoli anche in paesi dove la moneta elettronica prevale su quella cartacea.
5.17.Le aziende come paradossale capro espiatorio dei malesseri creati
dal loro ruolo di “esattori del fisco”
L’insufficiente monitoraggio valutativo della ricchezza non registrata alimenta
malesseri sociali (capitolo 4) e tensioni che hanno bisogno di scaricarsi, come l’ener-
Capitolo 5 – LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
147
gia sprigionata da un temporale. La confusione tra lavoratori indipendenti, imprenditori
e organizzazioni si intreccia con la base padronale del capitalismo italiano, creando le
premesse per sfogare sulle aziende, come organizzazioni, le tensioni sociali create
dall’evasione dei lavoratori indipendenti, dalle frodi di alcuni imprenditori, e dall’inevitabile inefficienza della burocrazia, indotta dal disorientamento in materia (par. 5.3).
Molti motivi spingono a usare le organizzazioni aziendali come capri espiatori per
una ricchezza non registrata a beneficio di persone fisiche; in pochi colgono la mancanza di motivi, per l’azienda come organizzazione, di nascondere ricchezza al fisco, in
quanto priva di bisogni personali (sopra paragrafi 3.7-3.8). La fuorviante spiegazione
dell’evasione in base a disonestà, egoismo, senso civico e simili, si intreccia con la confusione in materia di aziende. Su questa premessa le aziende possono essere facilmente etichettate come “grandi evasori” da una opinione pubblica priva di retroterra in materia.
Benché di fatto esattori del fisco, le aziende hanno tutte le caratteristiche per un ruolo
di capro espiatorio: sono grandi, impersonali, viste in modo antropomorfo, e quindi
poco simpatiche, poco numerose, “non votano” e anche misteriose nei loro meccanismi
contabili. Le aziende insospettiscono già con i loro bilanci, che chiudono sempre in
pareggio al centesimo, quando anche l’uomo della strada smarrisce con indifferenza
cifre molto superiori L’immaginario collettivo confonde la strutturale mancanza di
umanità delle organizzazioni aziendali, con una imprecisata immoralità umana,
connessa alla già indicata spiegazione dell’evasione in base al “senso civico”; partiamo
dall’idea diffusa delle aziende come “omoni” dediti al profitto, che sfruttano i dipendenti, li lasciano morire con indifferenza negli infortuni sul lavoro, inquinano l’ambiente,
suggestionano i consumatori, truffano i risparmiatori, corrompono i pubblici ufficiali
e chi più ne ha più ne metta.Quest’utilizzazione delle aziende come capro espiatorio
avvia un percorso socialmente dannosissimo, già anticipato in altri paragrafi del
volume
La rigidità organizzativa, che è il punto forte dell’esternalità positiva aziendale,
consistente nella determinazione tributaristica della ricchezza, viene letta paradossalmente come un motivo di “asocialità aziendale”, e quindi (seguendo le fuorvianti
spiegazioni dell’evasione fiscale in base al senso civico), per la suddetta indicazione
delle aziende come capri espiatori della sperequata determinazione tributaristica della
ricchezza. Del resto le aziende non sono “elettori”, non sono “persone”, e quindi sono
ottime per lo scaricabarile, come ai tempi in cui si diceva “la colpa è della società”, o
oggi si dà la colpa a una imprecisata “finanza”, sempre seguendo il desiderio di dare
la colpa a qualcuno. Le aziende non protestano mai, in quanto, come detto al paragrafo 3.1, sono aggregazioni sociali coagulate dalle loro specifiche produzioni di beni o
servizi, con grande ingenuità verso questioni
a ciò estranee; ogni azienda è appiattita sui propri problemi, riguardanti il prodotto, ed è riluttante a esporsi su questioni generali.
Queste premesse fanno passare in secondo piano che le aziende come organizzazioni non hanno alcun motivo per nascondere ricchezza al fisco (par. 3.7). La maggiore imposta accertata per contestazioni interpretative viene considerata “risultato di servizio”
e data in pasto alla pubblica opinione, preoccupata della ricchezza non registrata. Un
148
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
apprezzabile risultato di servizio è facilmente raggiungibile variando un po’ il regime
giuridico applicato da aziende che movimentano volumi importanti di ricchezza; ne
deriva incidentalmente un grande scorno di chi ha registrato tutto, e viene accusato
di averlo registrato male, mentre la ricchezza non registrata è per definizione immune
da contestazioni interpretative.
I controlli fiscali presso le aziende tendono quindi a concentrarsi sulle contestazioni
interpretative, quantitativamente secondarie rispetto alla ricchezza non registrata (par.
4.1); tuttavia queste contestazioni fanno –come detto – “risultato di servizio”, essendo
valutati in termini di maggiore imposta accertata, indipendentemente dalla scoperta di
ricchezza non registrata, sfuggente e imbarazzante per i motivi più volte indicati.
La contestazione interpretativa consente di esporsi poco, confrontarsi con
aziende collaborative, primari studi professionali, facendo un lavoro pulito in punto di diritto, in cui ci si sente un po’ professori, “coperti” da articoli di legge, circolari,
sentenze e altri materiali normativi. Anche quando queste contestazioni interpretative sono esatte, sono poco insidiose rispetto alla massa enorme di ricchezza non
registrata e alla perdita di controllo del territorio da parte del fisco.
Vengono soprattutto censurati comportamenti che non alterano la rappresentazione
della realtà, documentando nei modi ordinari i propri comportamenti senza mascherare
alcunché.
5.18.Richiami ed esemplificazioni sulle contestazioni interpretative: la difficile difesa contro “l’inferno del dichiarato”
Per le principali contestazioni interpretative, sul regime di ricchezza registrata o comunque palese, rinviamo ad altri paragrafi del testo per evitare duplicazioni; richiamiamo le forzature sull’“abuso del diritto” di cui al paragrafo 3.10, le divergenze sulla
tempistica di imputazione della ricchezza, di cui al paragrafo 7.12, la ripartizione dei
flussi di ricchezza palese, sui prezzi di trasferimento paragrafo 7.19, la collocazione territoriale del contribuente nei rilievi sulla residenza e le stabili organizzazioni, par. 7.18.
Altre volte le contestazioni creano materia imponibile forzando le correlazioni concettuali della tassazione attraverso le aziende (par 3.11), dove la convenienza tributaria
era conforme alla logica normativa o mancava del tutto. In quest’ottica si disconosce alla
società la deduzione del compenso all’amministratore, da lui regolarmente dichiarato, o
si presumono interessi su finanziamenti, accertando interessi attivi in capo al creditore,
ma non riconoscendoli al debitore. Le combinazioni tra forma giuridica e sostanza
economica sono oggetto di manipolazioni argomentative, riferendosi ora all’una ora
all’altra in modo da massimizzare la contestazione interpretativa.
I rapporti commerciali e industriali vengono pignolescamente ripercorsi dal fisco,
anche dal lato dei ricavi, accertando nientepopodimeno che con l’infamante etichetta
di “omessi ricavi”, i diritti che formalmente l’azienda poteva far valere, astenendosene
per prospettica antieconomicità dell’azione di recupero, o per convenienze commerciali (risarcimenti).Vengono disconosciuti i costi sostenuti a fronte di un interesse
Capitolo 5 – LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
149
commerciale, senza formali obblighi giuridici, ad esempio riparazioni di prodotti
non più in garanzia, sconti, piccoli omaggi, fornitura di beni strumentali in comodato a
clienti, che vi allocano le merci vendute. Gli uffici adottano un opposto criterio, sostanzialistico, davanti alla deduzione di costi obbligatori contrattualmente, ma di scarsa
convenienza economico gestionale. Quando insomma il contribuente ha rispettato
la forma, l’ufficio invoca la sostanza, e quando ha rispettato la sostanza invoca la
forma, con buona pace di ogni ragionevolezza economica. Gli aspetti formali e quelli
sostanziali sono combinati in modo da massimizzare il carico tributario, non perché le
cifre coinvolte siano rilevanti per le casse dello stato (par. 5.7), ma per massimizzare la
rendicontazione del servizio del’istituzione, come indicato al par. 5.3.
Le contestazioni basate sulla c.d. antieconomicità costituiscono la riaffermazione
dell’oggetto economico del diritto tributario.
Anche qui il vero obiettivo, cioè la ricchezza non registrata, resta nell’ombra e uno
schema di contestazione che dovrebbe essere lineare diventa confusionario, con forti
danni per la dialettica amministrativa e giurisprudenziale, dove non si capisce più esattamente di che cosa si parla, in ultima analisi a danno del contribuente (infra 5.19). Il
percorso logico più breve è utilizzare le circostanze registrate come indizio di ricchezza
non registrata, come indicato al par. 5.13 per le percentuali di ricarico, le rese delle
materie prime, dei dipendenti, e tutte le altre relazioni tra i fattori produttivi. Parlare di
antieconomicità fa invece pensare a un sindacato delle scelte imprenditoriali, mentre
nessuno discute che l’imprenditore possa sbagliare: l’ipotesi, invece, è che non abbia sbagliato, ma abbia rappresentato la ricchezza in modo distorto, allo scopo di nasconderla al
fisco o di realizzare stratagemmi elusivi (par. 4.8). La confusione aumenta per l’utilizzo
dello stesso concetto per contestare deduzioni di costi non inerenti (par. 7.10), nel qual
caso la spiegazione dell’antieconomicità è un consumo personale “mascherato da costo
aziendale”.
Col progressivo abbandono delle pratiche elusive da parte delle aziende (par.
3.10), sono diminuite le occasioni complessive per contestazioni interpretative; la
drammatizzazione mediatica dell’evasione fiscale, l’equivocata mitologia dei “grandi
evasori”, le diffidenze della pubblica opinione verso le aziende come organizzazioni
(par. 5.17), alimentano un accanimento verso le aziende. In un masochismo sociale
di cui gli uffici sono ostaggi, come indicato al par. 5.3 e non possono smentire. Vengono quindi almanaccate contestazioni interpretative senza un vero e proprio filo
conduttore, basate su parafrasi di materiali solo apparentemente in tema, richiami a
disposizioni legislative, precedenti giurisprudenziali decontestualizzati, vicende fattuali
in sé vere, ma esposte in modo tendenzioso, insinuante e selettivo. È comprensibile e
legittimo che gli uffici tributari imitino le espressioni, sussiegose e inconcludenti, presenti nell’accademia, nell’editoria e nella pubblicistica, come indicato ai par. 4.3 e 4.4.
si espongono infatti solo quegli aspetti della situazione, magari del tutto innocua per
il Fisco, che possono disorientare il lettore, facendo balenare sullo sfondo chissà quali
sospetti. Lo si vede negli interminabili e scaramantici “visto, visto, visto”, simili a una
celebrazione liturgica, con cui iniziano tanti verbali e accertamenti, che diventano ineffabili, né veri né falsi, apparentemente in tema, e quindi immuni da critiche di colleghi,
150
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
superiori e giudici. Del resto, se questa è la forma di espressione dominante in sede
accademica e professionale è del tutto legittimo il suo utilizzo da parte dei funzionari
delle istituzioni, di ogni ordine e grado. La litania apparentemente in tema, ma priva di
senso reale, è un elemento di forza quando proviene da una autorità, perché il destinatario non può smentire quanto non comprende, ma fare appello all’insensatezza è difficile
quando il discorso proviene da un istituzione amministrativa ed è “apparentemente in
tema”, benché sostanzialmente senza filo conduttore. Il discorso fumoso e incomprensibile è del resto, da sempre, uno strumento di esercizio del potere, che si sottrae a una
critica nel merito, disorienta l’interlocutore, e mantiene i margini per aggiustare il tiro
successivamente.
Ne deriva una perdita di trasparenza sostanziale, al di là di ipocriti formali omaggi
alle disposizioni sul procedimento, ai diritti del contribuente, alle informazioni da riportare negli atti, etc... Non è un effetto voluto, ma un riflesso della cautela amministrativa indotta dal disorientamento sociale nel settore (capitolo quarto) che drammatizza i
rapporti e oggettivamente rende meno serena l’attività degli uffici.
Queste litanie prive di senso compiuto, sono oggettivamente un osso duro contro cui difendersi. Per spiegare la mancanza di filo conduttore bisogna sia avere buona
padronanza della materia sia conoscere la situazione specifica. Come per la pubblicistica,
la tortuosità ineffabile, piena di stereotipi, ostacola la critica, mettendo in difficoltà
i destinatari, non i redattori. La confusione, creata anche dall’editoria “accademico-professionale” (par. 4.3 e 4.4) si ritorce quindi a danno delle aziende e dei loro difensori.
Vedremo al par. 6.10 che davanti a queste contestazioni il giudice si sente inevitabilmente più tranquillo, a parità di tutti gli altri fattori, ad appiattirsi sulle tesi del fisco,
che si rafforzano proprio in quanto disorientanti.
Il compito più difficile di chi assiste i contribuenti non è confutarne il contenuto, solo apparente, ma proprio smascherare questa inconsistenza, ed esorcizzare
il già indicato sospetto dei lettori di “non aver capito bene” col timore di annullare
una pretesa potenzialmente fondata. Contestare con ragionamenti di senso compiuto
espressioni che ne sono prive è logicamente impossibile, come pure dare a queste
litanie un senso per poi confutarlo; l’unica possibilità è quindi «scomporre» la contestazione, destrutturarla con tutto il rispetto per le istituzioni, alimentando la sensazione di mancanza di senso compiuto che il lettore prova leggendola. Può aiutare la
redazione di un «controverbale» in cui l’inconsistenza stereotipa del verbale viene passo
passo mostrata, confermando la sensazione che sia un polverone solo apparentemente in tema. A questo punto si è ancora a metà dell’opera, perché l’interlocutore
istituzionale (superiore o giudice) si chiederà se, pur sbagliando, la contestazione investiva altre criticità; per questo, dopo aver destrutturato la contestazione, bisogna indicare
quale potrebbe essere il punto vero, il vero problema, oppure spiegare che non c’è alcun
vantaggio fiscale indebito, né violazione diretta di norme, nè a maggior ragione ricchezza non registrata.
Alla pars destruens dello smontaggio deve insomma seguire una che tranquillizza il lettore sull’assenza di violazioni sostanziali. È una operazione davvero difficile,
vista la legittima tendenza all’“auto protezione istituzionale” da parte degli uffici, e
Capitolo 5 – LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
151
la inaffidabilità – su queste tematiche – del contenzioso tributario, come vedremo al
par. 6.5.
5.19.Segue: il controproducente controllo obbligatorio delle grandi aziende: quando i controlli fiscali “si sprecano”
La tendenza a considerare le grandi aziende come capro espiatorio delle schizofrenie
sociali indotte dalla ricchezza non registrata si è tradotta in legge nel 2000, con l’obbligo di controllo annuale per le aziende con più di 50 milioni di euro di giro d’affari,
il c.d. tutoraggio fiscale; è una linea adottata da governi di qualsiasi indirizzo politico,
dal centrosinistra al centro destra, fino ai governi c.d. “tecnici”, anch’essi incapaci di
distinguere la maggiore imposta accertata dalla ricchezza non registrata (sopra par. 4.6).
In questo modo è stato travisato un istituto esistente anche in altri paesi europei,
che hanno giustamente abbandonato il concetto stesso di “verifica tributaria”, a favore di un monitoraggio stabile di credibilità economica, come quelli che avevamo
ipotizzato al par. 5.7 per i piccoli contribuenti. Da noi “il tutoraggio” è diventato una
successione di “verifiche contabili”, dove neppure ci si pone il problema se possa esserci
ricchezza eventualmente nascosta dal titolare dell’azienda nei modi di cui al par. 3.7,
cioè scavalcando le procedure amministrative dell’azienda; in questo caso il tutoraggio
avrebbe anche una utilità, non tanto per il gettito recuperato, quanto come dissuasione
da frodi che oggi emergono quasi solo per caso fortuito (par. 5.13) e per legittimare
l’opportuno analogo monitoraggio sistematico dei lavoratori indipendenti e delle micro aziende senza rigidità amministrativa.
Invece il controllo privilegia l’inquadramento giuridico della ricchezza registrata, cioè le questioni di diritto, risolvendosi nelle contestazioni interpretative
descritte al par. 5.18. Il fisco si dilunga sulle reinterpretazioni di circostanze
dichiarate, o comunque palesi, riqualificandole in modo più oneroso. È vero che
i controlli su grandi contribuenti rappresentano il 2 percento del totale, ma durano
molto di più, e soprattutto non dissuadono i contribuenti dall’occultamento degli
imponibili (anzi, se possibile spingono in questa direzione chi ne ha la possibilità).
In questo modo, invece di cercare la ricchezza non registrata, i funzionari del fisco
sono catapultati sulle grandi aziende, ed inevitabilmente spinti alle già indicate “contestazioni interpretative”; i controlli sui “grandi contribuenti”, una volta avviati per
le ragioni indicate al par. 5.17, vivono di vita propria, perché occorre dar loro un
senso, facendo “risultato di servizio”; solo raramente si può chiudere una verifica
senza rilievi, e quindi crescono le solite forzate e capziose contestazioni interpretative,
che poi si autoalimentano nelle successive fasi amministrative e contenziose (magari
anche penal-tributarie, cfr. par. 6.14). Quest’atteggiamento è poi contagioso: anche sui
contribuenti di dimensioni più piccole, i controlli privilegiano le questioni di diritto,
dove ci si “espone di meno”.
L’unica valenza di queste inutili contestazioni riguarda il lavoro professionale di assistenza e contenzioso, nonché di pareristica preventiva. Per questo tali contestazioni non
152
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
dispiacciono alla categoria dei tributaristi, assorbendo in veste professionale le migliori
energie dell’accademia, come rilevato al par. 4.3. La maggior parte delle contestazioni
interpretative, come indicato al par. 3.10, sono un diversivo rispetto alle difficoltà di
stima della ricchezza non registrata. Senza le nostre assurde drammatizzazioni sul
fisco (par. 4.6), queste questioni di inquadramento giuridico si risolverebbero con pochi
incontri, senza una defatigante e inutile (parcelle a parte) attività professionale. Davanti
a questa situazione il giurista dovrebbe sdrammatizzare le disfunzioni ambientali
da cui viene il suo lavoro come avvocato. Anche a proposito della determinazione
tributaristica della ricchezza emerge che le disfunzioni dei vari settori della machcina
pubblica dipendono dal diverso grado di comprensione dei singoli settori da parte della
pubblica opinione e delle classi dirigenti (par. 5.3) Sono disfunzioni con matrice giuridica, davanti alle quali i giuristi devono elevarsi dal ruolo di “tecnici dei “materiali
normativi” (par. 4.4), perché che né la politica né gli economisti riescono a governare
questi problemi da soli.
Le aziende, come organizzazioni, sono infatti incapaci di replicare alla loro etichettatura mediatica di capri espiatori, descritta al paragrafo 5.17.
Le aziende, come indicato al par. 4.4, sono gruppi sociali tenuti insieme dal prodotto, cui si dirige la loro comunicazione. Non si può pretendere che esse comunichino una idea generale delle funzioni delle aziende come tali. Sarebbe una “autocoscienza” che travalica la finalità delle aziende come corpo intermedio a vocazione
economica. La loro cultura riguarda il loro specifico settore di mercato, non
una concezione del mondo che esse stesse hanno creato. Le singole aziende, in quanto
gruppi sociali a vocazione economica, sono tese a comunicare “prodotti” non chiavi
di lettura dell’organizzazione sociale. Per questo non può venire da loro la sdrammatizzazione delle schizofrenie sociali sul fisco di cui al par. 4.6. Ad esse le aziende
inevitabilmente reagiscono in ordine sparso, perse dietro il tecnicismo di dettaglio
che, di volta in volta, le interessa, spesso delegando i problemi a costose macchine
da soldi professionali. L’idea di azienda, come gruppo sociale tenuto assieme dal prodotto, si porta dietro anche la propria incapacità di valorizzare il ruolo dell’azienda
nella determinazione tributaristica della ricchezza.
Questo oggettivamente rallenta la crescita delle aziende, ed è uno dei tanti
fattori che trattengono il capitalismo familiare dall’aprirsi a terzi, perdendo il precedente controllo assoluto, burocratizzando l’azienda, esponendosi a contestazioni di
vario genere (anche con gli altri soci), a maggiori bisogni di credito, nonché alle contestazioni interpretative tributarie. Anche sul fisco troviamo un riflesso della incapacità
generale della nostra organizzazione sociale di “fare gruppo”, di darsi un “capitalismo renano”, come è denominato quello tedesco, riuscendo solo (quando va bene) a
salvaguardare un sistema produttivo “nano”. La concezione antropomorfica dell’azienda
impedisce l’istituzionalizzazione del capitalismo a proprietà familiare, il che alimenta
ancora la visione antropomorfica dell’azienda, e ostacola la massa critica di ricerca, innovazione e organizzazione necessarie a seguire scienze e tecnologie.
Fosse solo per il fisco, forse il titolare preferirebbe un giro d’affari di cento milioni in
bianco che uno di venti, di cui tre in nero, ma la difficoltà di gestire con buonsenso or-
Capitolo 5 – LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
153
ganizzazioni complesse, la sfiducia verso gli altri e le istituzioni, nonchéla sfiducia delle
istituzioni e degli altri, spingono a restare relativamente piccoli. In una dimensione in
cui sono ancora possibili gli scavalcamenti delle procedure aziendali, a proprio beneficio
personale, indicati al par. 3.7. Diventando grandi, smettendo di nascondere ricchezza, gli
imprenditori rischiano, grazie al tutoraggio fiscale, più contestazioni di prima. Si auto
produce un circolo vizioso dove la ricchezza nascosta al fisco, anziché “il problema”, diventa “la soluzione”. È uno dei tanti riflessi, socialmente distruttivi, della
confusione tra “maggiore imposta accertata” e “ricchezza non registrata”, uno dei fili
conduttori di questo testo.
Questo confusionario intreccio di miopi e inconsapevoli convenienze particolari,
riflette il difficile rapporto della pubblica opinione, e quindi delle istituzioni italiane con gli organismi aziendali, ne impedisce la crescita, le spinge all’estero e le respinge
alla frontiera, se sono aziende multinazionali che si affacciano dall’estero. Questi atteggiamenti, che però contribuiscono a una generale disaffezione verso un paese non
amichevole verso le organizzazioni. Le aziende non scioperano, non manifestano, non reagiscono perché non esistono come persone; le aziende sono metafore, senza sentimenti ed emozioni umane, ma anche così –senza saperlo – “i capri espiatori
si vendicano”. Quando infatti c’è da chiudere un impianto, da collocare un nuovo
investimento o da de localizzarne un altro, le incomprensioni, anche tributarie, col
sistema Italia si fanno sentire. Ed alimentano una disorganizzazione sociale che potrebbe
essere simile a quella già verificatasi in Grecia, con un regresso rispetto all’era agricolo
artigianale, in una versione moderna dei “cacciatori-raccoglitori”, alla ricerca di prestiti
internazionali, sussidi, redditi minimi di cittadinanza, residuati produttivi abbandonati
nei cassonetti, anziché frutti spontanei e selvaggina, ormai assenti in un disgregato ambiente postindustriale. Nel settore tributario già si percepisce un medioevo prossimo
venturo in cui si aprono i rubinetti e non esce nulla, si spingono gli interruttori e la luce
non si accende, anche a causa del mito deresponsabilizzante del “governo della legge”,
e della correlativa mortificazione del buonsenso, indicati al par. 2.4.
È una strana reazione a catena, dove carenze teoriche generali, incidendo sulla distribuzione dei controlli, ostacolano la diffusione della stessa tassazione attraverso le aziende, su cui si basa il sistema, paradossalmente agevolando frammentazione ed evasione,
compromettendo lo sviluppo, gli investimenti, e la determinazione dei tributi attraverso
le aziende. Lo si vede nell’ampiezza stessa dell’economia non osservata, indicata ai paragrafi 4.1, 3.15 e 5.15, e connessa alla deindustrializzazione, a sua volta sintomo di un
più generale “nichilismo sociale” della pubblica opinione, indicato al par. 4.6.
Nel nostro settore, il rischio è una “perequazione fiscale alla rovescia”, dove
invece di determinare valutativamente la ricchezza che sfugge alle aziende, si distrugge
pian piano la tassazione attraverso le aziende, contribuendo così alla disgregazione sociale. Quando infatti una azienda chiude, non solo si perdono posti di lavoro,
ma spingono parte degli “ex addetti” a sopravvivere con attività indipendenti, totalmente o parzialmente nascoste al fisco. Il rischio è la graduale destrutturazione
degli organismi aziendali, con una polarizzazione della società tra un enorme
apparato pubblico improduttivo perché paralizzato dal legalismo, ed un operoso
154
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
insieme di lavoratori indipendenti e titolari di piccole organizzazioni, povere di investimenti, di ricerca, e dove si nascondono quote ingentissime di ricchezza al fisco. È un
circolo vizioso dove la paralisi burocratico-istituzionale pubblica genera “anarchia economica privata”, entrambe accomunate dalla disorganizzazione. Anche le disfunzioni
tributaristiche in esame sembrano un aspetto di una specie di suicidio sociale indotto
dalle carenze formative della pubblica opinione italiana, indicate al par. 1.6.
La cultura delle singole aziende non può invertire questo circolo vizioso, ma la cultura di quanti ci operano, come parte importante della classe dirigente, può contribuire
alla comprensione del ruolo delle aziende e della macchina pubblica. Che poi è la versione tributaria di una comprensione generale dell’“era aziendale”. Di cui fa parte il
ruolo tributario delle aziende, che non possono continuare a essere viste in maniera antropomorfica, ma come organizzazioni pluripersonali. Non come “bottegai troppo
cresciuti”. Dopodiché le questioni di dettaglio, su cui si collocano le contestazioni alle
aziende, si risolveranno da sole, in quell’auspicabile rasserenamento culturale di cui dicevamo al par. 4.7.
5.20.La tassazione per condono: una conferma della tendenza ad “amministrare per legge”
L’espressione “condono fiscale” ricorre spesso nella storia, ma assume significati particolari nel nostro contesto di “tassazione attraverso le aziende-autotassazione”;
quando le imposte erano chieste dagli uffici tributari, si trattava di un abbattimento
di crediti già determinati, per imposte già richieste dagli esattori, o già stabilite in
via preventiva per il futuro. Il condono arcaico era una “remissione del debito”,
motivata da fortunati eventi bellici, dalla ricerca di rilancio economico e di favore popolare, insomma da motivi politici.Vi si faceva cioè ricorso quando era possibile fare a
meno delle relative entrate, sostituite da altre, ed i condoni erano insomma strumenti
di politica economica, così come i tributi, e potevano anche essere dovuti alla presa
d’atto della difficoltà economica dell’insieme dei debitori, e rappresentare un tentativo
di rilancio produttivo.
I condoni attuali, succedutisi negli ultimi quarant’anni, non appaiono invece come
uno strumento di politica tributaria, ma come uno strumento di gettito; essi costituiscono un estremo tentativo di raggiungere la ricchezza non determinata dalle
aziende e non emersa in autotassazione. Oggi il condono è una specie di “seconda richiesta delle imposte”, effettuata anch’essa per legge (come la prima!), con cui si spera
di recuperare una parte della massa di ricchezza fiscalmente non registrata.
Il condono è appunto una “seconda richiesta” dei tributi in base alla legge, che pragmaticamente tenta di “vendere” ai contribuenti una tranquillità da un “rischio virtuale”
di un controllo; la contropartita è il “prezzo del condono”, e può essere variamente
costruita.
I primi condoni chiedevano una maggiorazione dell’imposta a suo tempo
pagata, il che premiava platealmente chi aveva dichiarato di meno; il condono del
Capitolo 5 – LE ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
155
1982 arrivava alla possibilità estrema di definire anche le omesse dichiarazioni, con una
cifra forfettaria.
I condoni successivi, ciclicamente succedutisi fino al 2002, hanno introdotto dei
correttivi, col tentativo di calcolare imponibili “standard” con cui confrontare il dichiarato, anche in base alla “coerenza e congruità” rispetto agli studi di settore (paragrafo
5.13); come sempre, questa maggiore equità, comportava maggiori complessità, su cui
non è il caso di dilungarsi qui, ma sarebbero interessanti tesi di laurea o di dottorato.
Al fondo dei condoni ci sono alcune intuizioni, sfocate ma corrette, da parte della
classe dirigente, istituzionale e politica, con un orizzonte estremamente breve, di
una manovra annuale di bilancio. Questi politici comprendevano le difficoltà di superare la situazione descritta in questo testo nel breve arco del loro governo, per mancanza
di tempo e di strumenti culturali per progettare una tassazione valutativa sulla ricchezza
non registrata.
Davanti alla difficoltà di stimare la ricchezza non registrata, ed all’assurdità (esattamente intuita) di criminalizzare gli organizzatori di buona parte dell’economia italiana,
il condono appariva come una specie di compromesso. Con cui la politica profittava
delle stesse asimmetrie informative grazie alle quali i “lavoratori indipendenti” nel complesso sovrastimano le capacità di intervento dei pubblici uffici nella determinazione
della ricchezza (paragrafo 4.2); la politica cercava di profittare della consapevolezza di
tanti operatori di aver occultato una quota cospicua di ricchezza, e di un loro timore
di essere controllati, eccedente le possibilità effettive di credibile controllo valutativo da
parte degli uffici.
È quindi riduttivo spiegare i condoni come “favori agli evasori”, che per parte
loro avrebbero preferito evitarne il relativo costo; lo confermano le frequenti affermazioni di molti lavoratori indipendenti che dichiarano di non aver mai pagato
tante imposte come nel periodo del condono.
Il condono si presentava bene, sul piano della gestione del consenso, perché era una
“imposta volontaria”, evitava gli attacchi politici collegati all’introduzione di nuovi
tributi, o all’inasprimento di quelli esistenti, e rappresentava un espediente per costruire
manovre finanziarie di breve periodo. Gli inconvenienti del condono ne superavano
largamente, nel complesso, i vantaggi. Solo che questi ultimi erano immediati, in
termini di gettito e confezionamento delle manovre di bilancio, mentre gli inconvenienti erano differiti al futuro. La politica, attenta al consenso e alla coesione sociale,
è inevitabilmente più preoccupata dell’immediato, anche in assenza di sistematizzazioni
della tassazione attraverso le aziende. Inoltre, basta vedere le cifre per capire che il gettito annuale dei condoni era molto superiore a quello dei controlli fiscali;
inoltre i condoni si conciliavano bene con la tendenza ad “amministrare per legge”, e
con la tendenza degli uffici a “non valutare” la ricchezza non registrata: col condono le
valutazioni della ricchezza non registrata, su cui gli uffici temono di esporsi, vengono
spostate verso l’altro, verso il vertice, con una responsabilità “solo politica”.
Il lato oscuro dei condoni non era tanto la rinuncia alle possibilità di controllo
effettive, da cui veniva senza dubbio un gettito inferiore ma la sensazione di debolezza della richiesta delle imposte. Erano pregiudicati non tanto i controlli “sul
156
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
passato”, ma la credibilità dei controlli futuri, rafforzando a parità degli altri fattori
la tendenza a non registrare la ricchezza ai fini tributari.
Alla lunga, quindi, la suddetta tassazione per condono non può funzionare, perché i contribuenti semplicemente “mangiano la foglia”, e non sono più disposti a
pagare per mettersi al riparo da un controllo che vedono sempre meno probabile;
per questo i ricorrenti condoni cannibalizzano se stessi, vanificando l’effetto dissuasivo dei controlli, e incoraggiando per il futuro la mancata registrazione fiscale
della ricchezza.
L’espediente dei condoni rifletteva il consueto disorientamento collettivo
sulla determinazione della ricchezza ai fini tributari. Era il disorientamento a
provocare i condoni, e non viceversa. Invece di criticare i condoni con le solite riflessioni estemporanee alla portata di tutti, gli studiosi avrebbero dovuto capirne le cause
remote sul piano della determinazione della ricchezza. La trascuratezza per la spiegazione amministrativistico-economica dei tributi è oggettivamente l’anticamera dei
condoni. Al limite, comprendendo queste spiegazioni e riposizionando i controlli “sul
futuro” (paragrafo 5.7) un ultimo condono per la “rottamazione del’evasione passata”,
ci potrebbe anche stare. Perché i condoni sono il riflesso, non la causa, del disorientamento collettivo in materia di determinazione tributaristica della ricchezza.
Capitolo 6
SEGUE IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
E GIURISDIZIONALE
Sommario: 6.1. I provvedimenti amministrativi degli uffici tributari – 6.2. Segue: motivazione e prova della
richiesta dei tributari – 6.3. Provvedimenti degli uffici tributari verso coobbligati solidali e contribuenti
di fatto – 6.4. Il contenzioso amministrativo: accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, “mediazione” e prospettive – 6.5. Segue. Inadeguatezze del ricorso in opposizione e necessità di ulteriori
livelli di responsabilità: prospettive della “mediazione tributaria” – 6.6. Le varie funzioni del ritiro degli
atti in autotutela, tra correzione, abbattimento e definitivo abbandono – 6.7. Il contenzioso giurisdizionale: controllo dell’istituzione amministrativa o suo motivo di paralisi? – 6.8. Segue: reclutamento dei
giudici e avvio del processo – 6.9. La procedura: difficile coesistenza tra sostanza impugnatoria ed ispirazione civilistica – 6.10. Il fallimento della “via giurisdizionale alla determinazione della ricchezza”:
ostacoli al funzionamento degli uffici e possibili vie di uscita – 6.11. Riscossione coattiva ed evasione da
riscossione (l’esattore – Equitalia come diversa autorità amministrativa esattrice delle imposte) – 6.12.
La “sicurezza della riscossione” e la sua celerità in pendenza di ricorso – 6.13. Impossibilità di rimpiazzare con inasprimenti sanzionatori l’insufficienza dei controlli 1) le sanzioni amministrative – 6.14.
Segue: 2 Il confuso palliativo penaltributario tra mancata registrazione della ricchezza e contestazioni
interpretative
6.1. I provvedimenti amministrativi degli uffici tributari
Gli uffici tributari chiedono le imposte, a loro avviso dovute, con provvedimenti amministrativi, espressione di un pubblico potere stavolta riguardante la funzione amministrativa di determinazione dei tributi. L’emissione
di questi atti è una caratteristica generale dei pubblici poteri, in qualsiasi settore
operino come difesa, sicurezza,urbanistica, ambiente, salute pubblica, istruzione,
gestione dei flussi migratori, e – nel nostro caso – determinazione della ricchezza
ai fini tributari.
Questo potere preesiste all’eventuale processo giurisdizionale, che anzi potrebbe
anche mancare, come è frequentemente avvenuto in molti tempi e luoghi. La pubblica
autorità è infatti esercitata in modo unilaterale, secondo la c.d. “autotutela amministrativa”. Se si considera che anche il giudice è una pubblica autorità con funzioni di giustizia (par. 2.4) è normale che le pubbliche autorità possano realizzare i propri fini senza
passare attraverso di lui. Saranno casomai i destinatari dei provvedimenti amministrativi,
che non concordino col loro contenuto, a doverli impugnare tempestivamente da-
158
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
vanti a un giudice, a pena di decadenza, salvo avviare il contenzioso amministrativo
di cui ai paragrafi 6.4 e seguenti.
Questo carattere “provvedimentale” impone agli atti in questione una certa solennità, e un certo rigore. La competenza territoriale dell’ufficio è individuata in modo
formale, in genere in relazione al domicilio fiscale del contribuente al momento di
presentazione della dichiarazione.I relativi atti sono portati a conoscenza dei destinatari
mediante formale notifica, cui gli uffici tributari possono anche procedere direttamente.
Esistono anche dei termini entro i quali il potere amministrativo deve essere esercitato nel tempo, in modo da non lasciare i contribuenti esposti a tempo indeterminato a richieste di tributi, su cui dopo lunghi anni neppure saprebbero come
interloquire. Ci sono quindi termini di decadenza per la notifica, che ad esempio, per
le rettifiche delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA, deve avvenire entro il quarto
anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; qualora il potere sia
tempestivamente esercitato, ma l’atto presenti “vizi formali”, rilevati dopo la scadenza
del termine, in sede contenziosa, si pone un problema di sanatoria o di rimessione in
termini, cui dovrebbero essere dedicate riflessioni specifiche.
Nella tassazione attraverso le aziende e nell’autotassazione passa in secondo piano
la vecchia globalità della determinazione valutativa della ricchezza, effettuata attraverso gli uffici tributari. Oggi gli interventi possono essere innescati da successive
informazioni, e quindi l’accertamento può sempre essere “parziale”, cioè limitato
agli elementi di cui l’ufficio tributario in quel momento dispone. L’unica cautela è
quella di evitare che la persistente esposizione ad accertamenti futuri sia utilizzata
dall’ufficio per fare pressione sul contribuente, inducendolo ad accettare richieste
eccessive e ingiustificate. È però più uno scrupolo che un problema reale, nell’esperienza concreta dei controlli e quindi può ritenersi sostanzialmente superata la finalità
della disposizione che consentiva ulteriori accertamenti solo per sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi (c.d. «accertamento integrativo» di cui agli artt. 43,
d.P.R. n. 600 e 57, comma 3, decreto IVA).
Su queste premesse amministrativistiche si comprende bene l’importanza della
motivazione degli atti di accertamento, presupposto per la comprensione del loro
contenuto e l’esercizio del diritto di difesa. La motivazione si comprende solo in una
cornice amministrativistica della tassazione, mentre appare equivoco fino a che si spiegano i tributi attraverso fantomatici rapporti di credito debito tra fisco e contribuente,
equiparati a “due privati in lite”, tra i quali il giudice decide a chi dare ragione. L’atto di accertamento è autoritativo come la sentenza, ma è anche unilaterale giungendo
da una autorità non indipendente, nel senso indicato per il giudice al paragrafo 2.1. Per
questo la necessità della motivazione degli atti di imposizione è ancora più forte della
necessità di motivazione della sentenza; quest’ultima chiude infatti un processo dove le
parti hanno potuto interloquire; senza una adeguata motivazione dell’atto di accertamento, invece, il contribuente dovrebbe agire in giudizio al solo scopo di conoscere
le ragioni della richiesta unilaterale dell’autorità amministrativa, presentando
ricorso alla cieca. L’indicazione delle ragioni della rettifica da parte dell’ufficio sareb-
Capitolo 6 – SEGUE IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO...
159
be così rinviata al processo, con deresponsabilizzazione dell’amministrazione, e
ulteriori lungaggini ed equivoci connessi a quella specie di “imposizione giudiziale” di
cui riparleremo a proposito del contenuto dell’intervento del giudice al par. 6.9 (dedicato alla dialettica tra giudizio sull’atto e sul rapporto).
Quest’importanza della motivazione dell’atto impositivo è evidente per individuare
quali elementi dell’imponibile sono stati rettificati, nonché le ragioni di fatto e di
diritto per cui tale rettifica è avvenuta. Ad esempio l’accertamento di un certo importo
di maggiori ricavi potrebbe essere fondato su una molteplicità di ragioni, ed anche la
deduzione dei costi può essere disconosciuta per le ragioni più varie, come la mancanza
di documentazione, l’estraneità all’attività dell’impresa (mancanza di inerenza), l’imputazione a un periodo d’imposta sbagliato ecc. In entrambi i casi il contribuente, per
valutare se e come difendersi, deve essere informato sulle ragioni di fatto e di diritto
della contestazione, cui si dirigerà l’eventuale processo.
L’importanza di queste indicazioni è confermata dalla normativa, che assoggetta
i più importanti atti impositivi, ad una motivazione a pena di nullità, concetto da
intendere nel consueto senso amministrativistico, secondo cui il difetto di motivazione
va eccepito impugnando tempestivamente l’atto cui si riferisce.
La motivazione può anche rinviare ad altri atti già in possesso del contribuente, come ad esempio i processi verbali di constatazione di cui abbiamo detto al
par. 5.6 (c.d. “motivazione per relationem”).
L’adeguatezza della motivazione dipende dal contenuto sostanziale della pretesa, ed
anche sulle prove adducibili nel relativo eventuale contenzioso. Se il fondamento è documentale, occorrerà menzionarlo, o descrivere dettagliatamente quanto il documento
riferisce; Se il fondamento è presuntivo – come avviene spesso – occorrerà indicare i
relativi fatti indizianti ed i passaggi argomentativi che da essi prendono le mosse.
I collegamenti tra motivazione (amministrativa) e prova (processuale) saranno indicati
al prossimo paragrafo, mentre qui completiamo l’esame del versante amministrativo degli atti degli uffici tributari, dalla cui sottovalutazione dipendono gran parte
degli attuali inconvenienti del settore. Esso appare infatti come un corpo estraneo al
resto delle pubbliche funzioni, cui la comunità scientifica, come indicato al par. 4.3,
non è riuscita a ricollegarlo. Pertanto, gli stessi studiosi del diritto amministrativo
considerano il diritto tributario come un “oggetto misterioso” dal che deriva l’inapplicabilità espressa al nostro settore di molte disposizioni della legge generale
sui procedimenti amministrativi (L. n. 241 del 1990). Eppure molte disposizioni della
suddetta legge 241 avrebbero potuto essere semplicemente adattate ad una teoria del
“diritto amministrativo delle imposte”, a cominciare da quella del contraddittorio e
dell’accesso agli atti. Tale diritto di accesso, sancito, dall’art. 22 della legge generale
suddetta viene consentito solo dopo il termine delle indagini e l’emanazione dell’atto
impositivo, adducendo ostacoli, per accessi effettuati prima, allo svolgimento ulteriore
delle indagini.
La mancata sistematizzazione, prima di tutto concettuale, del contraddittorio
amministrativo in materia tributaria, porta ad eccessi opposti. Oggi un atto impositivo può essere emesso senza neppure aver invitato previamente il destinatario a
160
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
dare indicazioni o chiarimenti; è il riflesso dell’incapacità di distinguere le richieste
seriali, dove il contraddittorio può essere “successivo”, da quelle specifiche e
personalizzate, dove l’interlocuzione con gli uffici dovrebbe precedere l’emanazione dell’atto amministrativo; nella pratica, il destinatario dell’atto di imposizione
si trova ad essere di fatto informato della vicenda sottostante solo perché, in genere, i
poteri istruttori si svolgono nei suoi confronti. Quando invece le indagini si svolgono
presso terzi, ed il contribuente non è oggetto di richieste d’informazioni, può ricevere
una richiesta di tributi senza alcuna previa informazione.
Si cerca di contrastare questa eventualità in base al principio comunitario sul diritto di essere ascoltati prima di essere destinatari di un provvedimento amministrativo
tributario, o in genere restrittivo, anche in materia sanzionatoria, previdenziale, urbanistica, etc...
Ne sono derivate frequenti mortificazioni del contraddittorio, dovute a deresponsabilizzazione amministrativa, su questioni complesse, dove sarebbe sostanzialmente
utile (si pensi al caso delle indagini bancarie, di cui al par. 5.16); inversamente la valorizzazione del contraddittorio è spesso invocata, in modo avvocatescamente
strumentale, dove il contraddittorio è sostanzialmente inutile.
6.2. Segue: motivazione e prova della richiesta dei tributari
Abbiamo visto al paragrafo precedente che la motivazione serve a informare il
destinatario degli atti degli uffici tributari, consentendogli di comprendere e di
valutare la pretesa. A tal fine la motivazione deve descrivere i passaggi logicogiuridici su cui si fonda la richiesta del tributo, spiegare, informare, descrivere, ma
non ha l’obbligo di dimostrare definitivamente, anche sul piano probatorio, l’effettiva
esistenza di quanto l’ufficio afferma. Per utilizzare una formula sintetica, si potrebbe
dire che la motivazione deve «descrivere la determinazione della ricchezza da parte
dell’ufficio, e l’inquadramento giuridico alla base della maggiore imposta». Il ruolo
informativo della motivazione può quindi avvenire anche senza produrre tutte le
prove che l’ufficio potrebbe utilizzare in sede contenziosa. Insomma la motivazione può
anche comporsi di “allegazioni”, cioè indicazioni di fatti e circostanze, ivi comprese
risultanze istruttorie o circostanze comunque non contestate (documenti, ammissioni,
verbali di ispezione, ecc.). È una prospettiva informativa parzialmente diversa da quella
della prova, che presuppone un dissenso su determinate circostanze del mondo
empirico, come indicato al par. 5.8 sul giudizio di fatto. Sono quindi concepibili,
come confermato dalla giurisprudenza, accertamenti motivati, ma successivamente
annullati perché non provati in sede contenziosa. Dovendo indicare gli elementi
e le argomentazioni su cui si fonda l’atto impositivo, la relativa motivazione concorre a delimitare la materia del contendere del successivo eventuale processo giurisdizionale (par. 6.7): in esso l’ufficio non potrà perciò far valere altre possibili ragioni
di rettifica e si discuterà solo degli elementi cui si riferisce l’atto impugnato, nell’ambito
delle ragioni di fatto e di diritto indicate nell’atto stesso. Non si discuterà quindi se la
Capitolo 6 – SEGUE IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO...
161
maggiore imposta accertata sia dovuta per una ragione qualsiasi, ma se sia dovuta
per le ragioni indicate nell’atto: nell’ambito così delimitato l’ufficio potrà portare
prove, svolgere ulteriori illustrazioni del proprio punto di vista, ecc.
La concezione ragionieristico-processuale del diritto tributario trasferisce dal processo civile all’azione amministrativa tributaria la spettanza all’ufficio dell’onere della
prova; viene colta, ma travisata, l’intuizione, quasi banale, lapalissiana, che debba essere
l’ufficio tributario a dare una convincente dimostrazione dei propri assunti fattuali,
non potendo certo il contribuente dimostrare il contrario di quanto l’ufficio meramente afferma.
Questa evidente constatazione deve però essere calata in un contesto amministrativistico, in cui una “parte pubblica” agisce in autotutela, prima del processo, e non ha
motivo di affermare circostanze false. Tanto è vero che la base materiale degli accertamenti tributari è quasi sempre ammessa dai contribuenti, mentre le controversie si
appuntano sulle conseguenze, le illazioni ipotetico-presuntive, formulate dagli uffici su
queste basi.
L’insufficiente dimostrazione della ricchezza è invece più semplicemente un “vizio
dell’atto”, tipico del nostro naturale contesto amministrativistico. Su queste premesse è più corretto affermare che il contribuente deve assumere un atteggiamento attivo, tipico di un processo impugnatorio, e far rilevare la mancanza di convincenti
elementi di prova, alla base dell’atto di imposizione. È quindi il contribuente che deve
addurre (tecnicamente “allegare”), in questa logica amministrativistica, la carenza di
fondamento fattuale, come vizio dell’atto.
La vicenda dell’onere della prova è un altro aspetto della concezione processualistica del diritto tributario, caldeggiata dagli accademici-avvocati, e rivoltatasi contro
di loro come professionisti, favorendo il fisco sul piano processuale (e spingendolo alla
deresponsabilizzazione amministrativa). L’onere della prova, a carico del fisco, viene
infatti considerato assolto dai giudici secondo criteri di normalità economica, di “id
quod plerumqe accidit”, perché si tratta di una “parte pubblica”, di cui i giudici
“si fidano”, che non ha bisogno di mentire sull’andamento dei “fatti materiali”.
Seguendo lo stesso meccanicismo dell’onere della prova, quegli stessi giudici sono
rigorosissimi quando quest’ultimo viene attribuito ai contribuenti, ad esempio dal
lato dei costi, delle detrazioni IVA, degli oneri deducibili, dei presupposti per le
esenzioni, come pure delle richieste di rimborso. In tutti questi settori i giudici
applicano meccanicamente lo schema dell’onere della prova contro il contribuente,
fuori dalla logica amministrativistico-economica, di normalità aziendale. I contribuenti, e ancora di più le “aziende” (par. 5.17) godono una fiducia molto inferiore a
quella degli uffici, anzi generano sospetti. Per questo i giudici non si fidano delle loro allegazioni di normalità economica come si fidano di quelle degli uffici tributari. Non
si tratta di un preconcetto “favor fisci”, ma del riflesso della mancata razionalizzazione
della determinazione della ricchezza nel quadro amministrativistico. Il giudice non si
rende conto neppure di fidarsi più degli uffici, verso cui non sospetta malafede, che
dei contribuenti. Non ci si rende così conto di avallare la deresponsabilizzazione degli
uffici nel sostenere pratiche infondate, per forza di inerzia ed auto protezione.
162
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
A forza di calare la parità processualcivilistica delle parti, in un contesto amministrativistico, è stata creata una oggettiva disparità. Gli uffici tributari si considerano e
vengono considerati “parte” o “autorità pubblica” a seconda delle convenienze contingenti. La sbrigatività processuale avalla l’atteggiamento deresponsabilizzato, tendenzioso e insinuante degli uffici tributari, teso a “frastornare gli interlocutori”, anche
oltre le contestazioni prolisse e tortuose, sulle fantomatiche “evasioni interpretative”
indicate al par. 5.18. Ai fini della determinazione della ricchezza la prova viene intesa
a corrente alternata, accontentandosi della normalità economica quando si tratta degli
uffici tributari, e richiedendo fantomatici riscontri documentali quando si tratta dei
contribuenti. La logica avvocatesca della “parità delle parti”, mettendo in ombra la
matrice amministrativistica della tassazione, provoca una sostanziale disparità, a danno
del contribuente. Non a caso la parte pubblica, a seconda delle convenienze, si presenta
come privato oppure come pubblica autorità. La vera parità delle parti è invece prendere atto della loro diversità, della matrice amministrativistica del diritto tributario e
soprattutto del relativo processo.
6.3. Provvedimenti degli uffici tributari verso coobbligati solidali e contribuenti di fatto
Riferiamo adesso ai controlli quanto indicato ai paragrafi 3.5-3.6, sullo sfasamento tra “contribuenti di diritto e di fatto”, in relazione al quale soggetti diversi da quelli
cui si riferisce la ricchezza colpita possono essere tenuti a pagare il tributo. L’istituto
civilistico dell’obbligazione solidale (artt. 1292 e ss. c.c.) si trasferisce quindi nella
nostra materia amministrativistica, con lo scopo di non costringere il creditore ad intentare tante azioni quanti sono i suoi debitori, consentendogli invece di escutere ciascuno
di essi per l’intero.
Come principio generale, il fisco può richiedere l’imposta, mediante i consueti
atti amministrativi di cui al par. 6.1, ad uno qualsiasi dei coobbligati solidali senza
doversi preventivamente rivolgere a colui che ha posto in essere il fatto imponibile, il
c.d. «debitore principale».
Qualora l’atto impositivo venga notificato solo ad alcuni debitori solidali, i principi
di cui all’art. 1306 c.c. si adattano al nostro contesto amministrativistico. Ne discende
che l’atto avrà effetti sfavorevoli solo verso chi lo ha ricevuto, non lo ha impugnato
o è stato sconfitto nel relativo processo; resta così impregiudicata la posizione degli altri
condebitori, cui l’atto non è stato notificato.
A questa soluzione la giurisprudenza giunse solo nei primi anni settanta, dopo aver
sostenuto per lungo tempo che l’atto impositivo notificato ad uno solo dei coobbligati
dovesse estendersi anche a quelli cui l’atto non era stato invece notificato.
L’atto può essere notificato a vari condebitori, e qualora solo alcuni di loro propongano ricorso, la giurisprudenza applica l’art. 1306 c.c., consentendo anche al condebitore che non ha impugnato di giovarsi del giudicato favorevole ottenuto da un altro
condebitore; questa soluzione è conforme alla tendenza ragionieristico-processuale, che
Capitolo 6 – SEGUE IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO...
163
concepisce il diritto tributario come una lite tra due parti mentre, secondo la matrice
amministrativistica di questo testo, la definitività dell’atto verso un condebitore resta in
linea di principio impregiudicata nonostante il giudicato favorevole ottenuto dall’altro
condebitore.
Un caso particolare di solidarietà (responsabilità di imposta) serve a indurre terzi, estranei alla ricchezza cui il tributo si riferisce, a non pregiudicare gli interessi del
fisco(si tratta, per riprendere le classificazioni di cui al par. 3.5, di contribuenti solo “di
diritto”, in quanto esposti alle pretese del fisco, ma estranei alla ricchezza cui si riferisce
l’imposta); è una responsabilità che scatta solo per patologie o disguidi, come quella
dei notai per l’imposta dovuta sugli atti da essi redatti, degli spedizionieri doganali per
i diritti di confine dovuti dai loro clienti, degli amministratori e liquidatori che non
soddisfano crediti tributari, soddisfacendo invece crediti di ordine inferiore, dei soci per
gli utili percepiti in base a bilanci che non consideravano debiti verso il fisco. In alcuni
casi c’è una responsabilità solidale del cliente per l’IVA non applicata in fattura dal
fornitore, qualche volta anche in capo al consumatore, che ad esempio occulta in parte
il prezzo di immobili.
Analoghi sono i casi del terzo che garantisce per il contribuente a favore del fisco,
con una fideiussione, o del socio che risponde per legge dei debiti della società (art.
2267 cc), ivi compresi perciò i debiti nei confronti del fisco.
Anche verso i coobbligati la pretesa tributaria si manifesta, come già accennato,
in via di “autotutela amministrativa, con gli atti autoritativi di cui al par. 6.1, senza cioè
che l’ufficio tributario debba rivolgersi al giudice, cui devono invece ricorrere gli altri
ordinari creditori. Il diritto di difesa del coobbligato, ed una parità di trattamento rispetto al debitore principale, imporrebbe però la notifica di un avviso di accertamento;
nella prassi sembra che ciò avvenga solo per la solidarietà paritetica, mentre negli altri
casi sembra vengano notificati solo atti di riscossione, ferma restando la possibilità del
destinatario di far valere ogni vizio della pretesa tributaria, anche quelli fatti inutilmente
valere dal debitore principale. Formalmente il diritto di difesa di tali soggetti non
è violato, in quanto i coobbligati dipendenti possono impugnare, sotto tutti
i profili, tali atti della riscossione di fronte alle commissioni tributarie, ma devono
contestare atti esattivi privi di motivazione, perdono il beneficio della «riscossione frazionata» in caso di ricorso (paragrafo 6.12). Questa prassi corrisponderebbe, in diritto
civile, a un’esecuzione forzata in base a una sentenza ottenuta nei confronti di un altro
coobbligato.
I debiti tributari dei contribuenti deceduti, secondo la regola generale, si trasmettono agli eredi, salva la non trasmissibilità dei debiti per sanzioni, di cui si dirà al
paragrafo 6.13. In caso di due o più eredi, per la generalità dei tributi si ritiene operante il criterio civilistico secondo cui ciascun erede risponde solo in proporzione
alla sua quota. Solo per le imposte sui redditi, in virtù di specifica disposizione espressa
(art. 65, d.P.R. n. 600) sussiste la coobbligazione solidale tra i coeredi, in deroga al
suddetto criterio generale.
Anche a favore del fisco esistono “privilegi”, cioè diritti del creditore di soddisfarsi prioritariamente su alcuni beni, chiunque ne sia il proprietario; il titolare di beni
164
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
gravati da privilegio fiscale non è un coobbligato solidale, e perciò non risponde con
tutto il suo patrimonio, ma solo con il bene gravato da privilegio. Qualora tale bene sia
andato distrutto oppure sia stato ulteriormente alienato a un altro soggetto, il terzo sarà
libero da qualsiasi coinvolgimento nell’applicazione del tributo. Da un punto di vista
procedimentale e processuale anche al terzo proprietario è stato di recente concesso,
dalla giurisprudenza, di contestare la richiesta del tributo.
Una volta soddisfatto il credito del fisco, il coobbligato solidale può agire in via
di regresso, cioè rivolgersi agli altri coobbligati per ottenere la loro “quota parte” di
debito (si pensi ai coeredi o ai soci di società di persone, che hanno pagato debiti della
società, intendendo rivalersene nei confronti degli altri soci). È una delle controversie
civili con oggetto tributario, simile a quelle già indicate al par. 3.6. Anche qui i convenuti potranno far valere, in sede civilistica, eventuali tesi secondo cui il tributo non era
invece dovuto, ed è stato avventatamente pagato da chi agisce in rivalsa verso di loro.
6.4. Il contenzioso amministrativo: accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, “mediazione” e prospettive
La tassazione valutativa attraverso gli uffici, basata per sua natura su stime e presunzioni, era strutturalmente contenziosa; in tutti i casi degli antichi tributi di cui al
par. 1.3, la ricchezza era valutata dagli uffici secondo stime, sul cui ordine di grandezza erano naturali varie forme di reclamo. È una naturale implicazione dell’opinabilità
delle stime, davanti alla quale sono normali le obiezioni e le controproposte
dei contribuenti, tendenti a una rideterminazione a loro avviso più verosimile; solo
indirettamente ne deriva una diminuzione della somma da pagare, e quindi sarebbe
concettualmente improprio considerare questi reclami come “richiesta di uno sconto”
sull’imposta, dovendosi invece inserire nel quadro, ormai familiare ai lettori, della determinazione della ricchezza ai fini tributari. Un contenzioso amministrativo
ante litteram, era la sede naturale e più elementare in cui questi reclami venivano discussi. In generale questi reclami potevano essere indirizzati allo stesso ufficio tributario
(come vedremo accade oggi in Italia), o ad altri organi pubblici;sono comunque organi
privi di “indipendenza e terzietà”, ma “imparziali”, ed esperti nella valutazione della
ricchezza ai fini tributari, in modo da dare soddisfazione agli interessati. Ciò non
vuol dire “accogliere le loro richieste” ma trattarle in maniera adeguata, in modo
che il richiedente non si senta discriminato rispetto ad altri contribuenti. In questo
modo, con passaggi successivi di contraddittorio amministrativo contenzioso, si giunge,
nella maggior parte dei paesi sviluppati, a una valutazione condivisa della ricchezza.
Questa strutturale dialettica tra istituzioni e contribuenti ha sempre caratterizzato la determinazione tributaristica della ricchezza, con rispettose proteste alle
autorità di grado superiore, eventualmente anche politiche; tutti i gruppi sociali caratterizzati da una certa articolazione, anche se non democratici come li immaginiamo
oggi, cercavano di gestire in qualche modo le rimostranze sulla determinazione
dei tributi. Anche in materia di tributi vale infatti la regola generale del diritto ammi-
Capitolo 6 – SEGUE IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO...
165
nistrativo, secondo cui la forma più diretta di giustizia è interna alla stessa amministrazione, e dove l’intervento dei giudici è residuale.
In tutti i settori del diritto dei pubblici poteri, la prima forma di risoluzione delle
controversie è infatti interna alla stessa amministrazione, come “rimedio gerarchico
politico” ed un giudice indipendente serve solo –nei paesi più garantisti e raffinati – a
chiudere il sistema. Agli amministrati non serve un “giudice indipendente”, come
nelle liti tra privati, ma un riesame competente e imparziale, di un organo che dia
ascolto a chi ritiene di aver subito un torto dai funzionari di grado inferiore. È importante, per la coesione sociale, al di là dell’esito, la possibilità di “avere ascolto”, esprimere
le proprie ragioni, di essere presi in considerazione, di capire quali interessi, diversi dai
nostri, hanno provocato una decisione, anche negativa, della pubblica autorità..
A loro volta, i detentori del potere politico, sapendo di interagire col gruppo sociale,
in una certa misura si preoccupavano di avere una amministrazione “credibile”; che cioè
non incrinasse consenso politico e coesione sociale, con abusi di potere dei funzionari; i
soprusi di questi ultimi potrebbero scontrarsi coi valori del gruppo sociale, provocando
cali di consenso, malcontento, rimostranze, disaffezioni, proteste e infine rivolte, pericolose per la stessa autorità politica. Questa esigenza andava però contemperata con quella
di mantenere la fedeltà ed il controllo della propria burocrazia, dei propri collaboratori
più stretti, in una catena di rapporti fiduciari su cui non ci possiamo dilungare in questa
sede.
Osserviamo semplicemente che la tassazione, come area di intervento amministrativo molto diffuso e potenzialmente creatore di malcontento, diede luogo
agli esempi più antichi di “amministrazione contenziosa”; in altri settori dell’attività
pubblica, meno capillari, il controllo sull’amministrazione, attraverso organi superiori
o autorità politiche, poteva essere più empirico, improntato a valutazioni caso per caso,
politico-paternalistiche, sviluppatesi poi anch’esse verso il “diritto amministrativo”.
Nella determinazione ragionieristica, attraverso le aziende, mancava questa
necessità di affinare gradualmente le stime della ricchezza. La stima per ordine di
grandezza veniva soppiantata dalla contabilità, e l’interlocuzione con gli uffici descritta sopra, appariva contraddittoria rispetto alla determinazione ragionieristicodocumentale attraverso la contabilità aziendale.
Per questo, con la riforma del 1973, nell’illusione di determinare ragionieristicamente ogni forma di ricchezza (paragrafo 3.13) il contenzioso amministrativo, all’epoca denominato correntemente “concordato fiscale”, fu avventatamente
abolito, sbilanciando così sul processo la determinazione tributaristica della ricchezza.
Ne derivarono decenni di deresponsabilizzazione, indebolimento della capacità valutativa degli uffici, permanenza di corruzione, moltiplicazione dei processi, spreco di energie amministrative ed altre disfunzioni diffuse ancor oggi (ne riparleremo al
par. 6.10). Solo nel 1994 si iniziarono a reintrodurre contenziosi amministrativi,
oggi regolati dal Dlgs 218 del 1997, sull’accertamento con adesione e la conciliazione
giudiziale. Il grande successo di queste procedure, benché ancora timide, conferma il
contenzioso amministrativo come primo rimedio per le controversie nella determinazione dei tributi, smentendo le sovrastrutture avvocatesco-processuali; queste ultime
166
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
sono però tuttora talmente radicate da far definire gli istituti suddetti come “strumenti deflativi del contenzioso”; questa formula rivela l’erroneo pregiudizio
secondo cui la naturale definizione delle controversie sulla determinazione tributaristica della ricchezza sia davanti a un giudice, abbandonata a malincuore solo per
“deflazionare il contenzioso giurisdizionale”. È un modo invertito di ragionare
che scambia la patologia processuale con la fisiologia amministrativa; la dialettica
con uffici tributari è infatti, soprattutto nei paesi con una amministrazione più responsabile e attenta alla tutela dei privati, il primo strumento per gestire le loro lamentele,
conformemente alla funzione di giustizia delle pubbliche amministrazioni.
Nel nostro sistema di accertamento con adesione, mancano limiti formali alle
controversie definibili in via amministrativa, con istanza presentata allo stesso ufficio. Al
limite sarebbero definibili persino questioni di diritto isolate, traducendo in una decurtazione dell’imponibile accertato le possibilità che le tesi del contribuente siano accolte
dalle commissioni tributarie.
In concreto, si prestano meglio a essere definite le stime e le valutazioni
marcatamente presuntive, come il valore di un immobile o l’ammontare dei ricavi
di artigiani, commercianti.Vedremo al prossimo paragrafo che proprio sulla stima della
ricchezza non registrata, per pratiche di piccolo importo, il funzionamento delle procedure conciliative è relativamente meno brillante.
Sotto il profilo del contenuto si tratta di un atto amministrativo cui il contribuente presta acquiescenza, e che viene redatto in un certo modo proprio in funzione della manifestata disponibilità del contribuente ad accettare una certa modalità di
determinazione del tributo, passando per la determinazione della ricchezza e il relativo
inquadramento giuridico; ad essi segue poi una somma da pagare, che non può essere
l’oggetto diretto della dialettica tra le parti; ricordiamo che la trattativa non riguarda la
somma da pagare nella grossolana e deresponsabilizzante logica dello sconto, ma
gli aspetti controversi di diritto e di fatto, a monte della determinazione del tributo.
Questa premessa spiega che l’accertamento con adesione è un istituto di diritto amministrativo delle imposte, che è fuori luogo spiegare facendo riferimento
all’istituto di diritto privato della transazione. Possono esserci somiglianze esteriori, soprattutto quando la transazione è effettuata nell’interesse di terzi, e quindi deve essere motivata. Nel nostro contesto di diritto amministrativo i profili da contemperare
(discrezionalmente nel senso di cui al par. 5.10) sono il grado di fondatezza delle
rispettive tesi, i rischi del contenzioso, le energie amministrative per la sua gestione, gli eventuali precedenti, l’ammontare dell’imposta in discussione rispetto ai
costi di gestione della lite, la costituzione di un precedente su altri contribuenti, in
relazione all’omogeneità dell’azione amministrativa.
Sono invece irrilevanti, secondo quanto indicato al par. 5.10 sulla discrezionalità,
profili economico industriali, di correttezza nel comportamento fiscale, ed
altri aspetti relativi alle condizioni personali e familiari. La diversa questione della solvibilità del contribuente, ai fini della riscossione, è un aspetto concettualmente distinto
dalla determinazione della ricchezza, non considerabile in questa sede dagli uffici; il
profilo esattivo sopravviene in un secondo momento rispetto alla determinazione della
Capitolo 6 – SEGUE IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO...
167
ricchezza, e ne parleremo per la “transazione fiscale” ai paragrafi 6.11 e 7.21. Ripetiamo
che la valutazione comparativa tra questi profili comporta una ipotesi tra quelle che al
paragrafo 5.10 abbiamo ricondotto al concetto di “discrezionalità amministrativa
in materia tributaria”.
La procedura dell’accertamento con adesione è scarsamente disciplinata normativamente, essendo materia più appropriata per circolari o regolamenti, questi ultimi
peraltro oggi mancanti. Il decreto 218 prevede una istanza del contribuente, destinata
allo stesso ufficio che ha emesso l’atto impugnato, una sua audizione ed una verbalizzazione dei relativi colloqui; si tratta di previsioni insite nella natura dell’istituto,
il cui funzionamento è intralciato dalla condizione normativa superlfua e contingente
di “definizione intergale” della pretesa tributaria. Si tratta nel complesso di un
embrione di procedimento amministrativo, dove le valutazioni dovrebbero essere
accompagnate da una compiuta motivazione, che dia atto delle controdeduzioni del
contribuente.
L’adesione è oggi ammessa fino al primo grado di giudizio, nelle forme dell’accertamento con adesione, prima del ricorso. Successivamente è ammessa nelle forme della
conciliazione giudiziale prima della sentenza della commissione tributaria provinciale. In entrambi i casi suddetti, alla definizione amministrativa si accompagna una
riduzione delle sanzioni (per cui rinvio al paragrafo 6.13, in materia di sanzioni).
È però di fatto possibile anche successivamente una rideterminazione condivisa
della pretesa, attraverso l’istituto della ritiro parziale dell’accertamento in autotutela,
col contribuente che fa acquiescenza alla parte residua (sull’autotutela in genere infra
al par. 6.6). In tal caso però la conciliazione avviene “fuori tempo massimo” e quindi
restano applicabili le sanzioni, senza riduzioni.
6.5. Segue. Inadeguatezze del ricorso in opposizione e necessità di ulteriori livelli di responsabilità: prospettive della “mediazione tributaria”
Gli istituti descritti al paragrafo precedente si ispirano al ricorso amministrativo
“in opposizione”, indirizzato allo stesso ufficio che aveva emesso l’atto impugnato,
di solito allo stesso funzionario. Quest’ultimo, avendo già deciso, incontrerà i consueti imbarazzi, compreso il timore di essere considerato negligente o corrotto,
come indicato al par. 5.11. Nonostante il supporto fornito dai vertici dell’agenzia delle
entrate agli istituti in esame, e nonostante la loro ampia diffusione, rispondente a schemi
di buonsenso, essi non esplicano ancora appieno le loro potenzialità; tanto è vero che il
contenzioso tributario giurisdizionale, pur non aumentando, neppure diminuisce rispetto ai livelli eccessivi di cui diremo al par. 6.10.
Il maggiore successo dei ricorsi amministrativi in esame riguarda infatti paradossalmente le contestazioni interpretative sui “grandi contribuenti” indicate ai
paragrafi 3-11, 5.17, 5.18; qui gli uffici non temono infatti di contaminarsi con
la valutazione della ricchezza non registrata; in questi casi si ha infatti a che fare con
aziende, i cui funzionari non maneggiano ricchezza nascosta al fisco, potendo offrirne
168
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
una parte agli uffici. Soprattutto però le controversie in esame sono poche e di grande ammontare, il che consente il coinvolgimento di varie articolazioni degli uffici
tributari, con una condivisione delle responsabilità tra funzionari diversi: la natura e
le dimensioni delle pratiche consentono di consultarsi con capi ufficio, dirigenti, direzioni regionali e centrali, in diverse vesti formali. In questo modo la responsabilità
si frammenta, e pian piano la vicenda “si risolve da sola”; la pratica transita di mano
in mano, finché l’“esposizione” di ciascuno è compatibile col desiderio di “copertura”
delle nostre pubbliche amministrazioni, indicato al par. 5.3.
Trattandosi in genere del regime di “ricchezza registrata” l’onere della definizione è
spesso in parte recuperabile in altri periodi di imposta o su controparti in vario modo
correlate, secondo le note “simmetrie” di cui al par. 3.12. È proprio questo riposizionamento economicistico, e spesso forzato, delle stesse vicende materiali, a rendere
possibili accordi su “questioni di diritto”, che in genere non dovrebbero consentire
compromessi.
I ricorsi amministrativi sarebbero invece più utili, per la stima della ricchezza non
intercettata dalle aziende, dispersa in genere tra moltissime pratiche di piccolo
importo, dove mancano i presupposti per la suddetta “condivisione di responsabilità”,
tra funzionari e uffici diversi. Il contenzioso amministrativo diventa quindi paradossalmente troppo rigido proprio dove sarebbe più necessario a massimizzare il controllo valutativo del territorio; queste pratiche, individualmente di modesto ammontare,
impongono però valutazioni più personalizzate della ricchezza, e sono quindi trascurate, perché il funzionario dovrebbe esporvisi da solo (con tutte le incertezze di cui
al par. 5.11). Anche se il contribuente adduce circostanze verosimili, il funzionario non
ha tempo per svolgere adeguati riscontri, visto il gran numero di posizioni di importo relativamente piccolo. Questa valutazione di ricchezza sfuggente comporta quindi
un costante sospetto di non avere informazioni sufficienti, anche per la mancanza di
quel dossier valutativo permanente indicato ai paragrafi 5.7 e 5.13. Questo spinge
a una rigidità “autoprotettiva”, dipendente anche dalla sfiducia verso i contribuenti,
e quindi dal timore che circostanze sopravvenute facciano apparire “eccessivamente
benevole” determinazioni a suo tempo ritenute, in tutta la buona fede, “ragionevoli”.
Dovendo agire, visto il numero dei contribuenti, con informazioni limitate, gli uffici
tendono a “non fidarsi”, ed essere rigidi, in funzione appunto autoprotettiva; nel dubbio
sulla stima della ricchezza, essere rigidi “protegge”, al di là della questione del gettito.
Quest’ultimo è irrisorio rispetto a quello complessivo (par. 1.10), non va certo a beneficio dei funzionari coinvolti, e soprattutto sarebbe superiore se –invece di irrigidirsi
sulle pratiche trattate – esse fossero liquidate rapidamente e si impiegassero energie su
altri soggetti. È quindi una questione di autoprotezione, che va anche a scapito del
gettito e dell’interesse generale, per colpa dei Soloni che hanno messo in circolo le
espressioni paralizzanti della vincolatezza, dell’indisponibilità del credito tributario, della
legalità degenerata in legalismo, etc. (par. 5.10). Il contenzioso amministrativo finisce per incepparsi proprio dove sarebbe più utile, in quanto il problema tributario
italiano(par. 4.1) non sono le contestazioni interpretative delle aziende, bensì la mancata
sistematicità nella stima della ricchezza che sfugge ai loro circuiti.
Capitolo 6 – SEGUE IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO...
169
La responsabilità contabile davanti alla corte dei conti è un ulteriore pretesto per
la rigidità, in quanto è tra l’altro stata esclusa per legge sulle valutazioni in esame; esse
sono invece intralciate dai condizionamenti ambientali e dalle schermaglie interne agli
uffici, per le carriere, il “peso specifico”, il “potere” e tutte le ripicche e punzecchiature
reciproche di grandi strutture.
Per questo gli uffici cercano di standardizzare i propri comportamenti, affermando
improbabili divieti di ridurre oltre importi prestabiliti le somme accertate; dopodiché
sono ben contenti di rinviare la decisione al giudice, con una inefficienza complessiva, ma una copertura individuale.
Per snellire queste determinazioni si è cercato di abbandonare lo schema del “ricorso amministrativo in opposizione”, cioè allo stesso ufficio redattore dell’accertamento;
le richieste di riesame, in via sperimentale e per le pratiche di minore ammontare ((fino
a 20 mila euro) sono state infatti indirizzate ad un diverso ufficio dell’agenzia delle
entrate, accostandosi al modello del ricorso gerarchico improprio. Si tratta della c.d.
“mediazione tributaria”, impropria denominazione di un ricorso amministrativo
ad un diverso organo della stessa amministrazione; il coinvolgimento di un ufficio
diverso, non condizionato da proprie precedenti valutazioni, dovrebbe rendere sistematiche le condivisioni di responsabilità descritte sopra per i “grandi contribuenti”. I primi risultati sono stati molto lusinghieri per riabituare gli uffici a decidere, e
potrebbero essere oggetto di approfondimenti specifici.
Si tratta di un punto di partenza di una deprocessualizzazione della determinazione della ricchezza ai fini tributari, per superare il fallimento della “via giurisdizionale”, trattato al par. 6.10.
Un ulteriore passaggio potrebbe essere quello dell’arbitrato tributario, con la
partecipazione di un funzionario “edotto” della pratica, a titolo di continuità, di un
esperto designato dal contribuente, e di un terzo da enti esterni, ad esempio la commissione tributaria, o scelto di comune accordo.
Uno spunto ulteriore per l’istituzionalizzazione e lo snellimento delle valutazioni
consensuali della ricchezza non registrata, superando le diffidenze e i sospetti di negligenza o corruzione, è anche una certa pubblicità delle definizioni. Queste ultime,
per assicurarne la trasparenza, ed anche in funzione anticorruzione, dovrebbero essere
rese accessibili agli esercenti attività similari; è uno strumento di controllo sociale
e di trasparenza, oltre che di reciproca coerenza economica delle definizioni. Si ricordi
infatti che la vigilanza reciproca svolge un fondamentale ruolo anticorruzione per tutte
le attività pubbliche, come indicato al par. 5.11.
A tale scopo sarebbe sufficiente, per le attività comparabili, soprattutto diffuse e di
lavoro indipendente (artigiani e piccoli commercianti) pubblicizzare i criteri di rideterminazione dei ricavi, dove c’è una “base comune”, mentre i redditi di ciascuno differiscono in relazione all’impegno nell’attività e al numero di collaboratori, anche familiari,
come pure alla proprietà o meno delle mura, risparmiando il canone di locazione, e
quindi aumentando il reddito. Questa confrontabilità è molto importante per la trasparenza e la sistematicità della determinazione tributaristica della ricchezza; è molto più
importante l’orientamento dell’amministrazione di quello della giurisprudenza.
170
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
6.6. Le varie funzioni del ritiro degli atti in autotutela, tra correzione,
abbattimento e definitivo abbandono
Riconoscere i propri errori, con l’annullamento unilaterale di propri atti è uno
degli aspetti generali del potere amministrativo di autotutela, nel curare gli interessi
pubblici cui è preposto senza la mediazione del giudice.
Abbiamo già del resto anticipato sopra la rideterminazione condivisa della pretesa,
come un normale esercizio di potere amministrativo, che riemette un atto diverso, cui
il contribuente aderisce, nel corso del processo tributari.
L’autotutela amministrativa, cioè la rideterminazione unilaterale dell’atto può
anche essere finalizzata alla sua integrazione motivazionale oppure alla eliminazione di
qualche vizio formale e procedurale. Questa è una autotutela potenzialmente peggiorativa per il contribuente, in quanto gli toglie una possibilità di far annullare l’atto in
sede giurisdizionale; quindi deve essere esercitata nei termini di decadenza dell’azione
amministrativa e giustificata da elementi oggettivi.
Al contribuente giova invece l’autotutela destinata alla totale eliminazione
della pretesa fiscale. A tal fine l’ufficio deve solo contemperare l’esigenza di certezza
dei rapporti (cioè di mantenere ferme le situazioni giuridiche definite) con quella di
salvaguardare situazioni meritevoli di tutela. In questi casi l’ufficio dovrà chiedersi se
l’illegittimità dell’atto (o la spettanza del rimborso) sia talmente grave ed evidente da
giustificarne l’annullamento d’ufficio. Solo in concreto potrà stabilirsi se ad un vizio
debbano essere riconosciute queste caratteristiche, che è improduttivo tentare di fissare
una volta per tutte in una formula astratta, da applicare poi meccanicamente.
L’esperibilità dell’autotutela solo per queste gravi patologie consente di non trasformare l’istituto in una indiscriminata scappatoia per riproporre qualsiasi eccezione
dalla quale i contribuenti siano decaduti. L’autotutela è quindi esperibile anche quando
i contribuenti si siano lasciati sfuggire i termini per ricorrere o chiedere il rimborso.
Sono però incerti, in questo caso, gli strumenti di tutela giurisdizionale qualora l’amministrazione resti inerte; la giurisprudenza tende a negare un sindacato processuale,
adducendo una pretesa duplicazione di tutela rispetto al contribuente che ha lasciato
scadere i termini di impugnazione dell’atto. Il punto, che riprende le tendenze del diritto amministrativo generale, è tuttavia ancora abbastanza indefinito.
6.7. Il contenzioso giurisdizionale: controllo dell’istituzione amministrativa o suo motivo di paralisi?
Arriviamo finalmente al giudice, cui si rivolge il contribuente per sindacare i comportamenti dell’amministrazione; a differenza del giudice dei privati, questo “giudice
del potere” è una figura molto sofisticata, rara e circondata di cautele anche nelle democrazie; persino in queste ultime, infatti, il potere amministrativo, come indicato al
par. 5.3, ha come referente il gruppo sociale, intermediato dalla politica. La prima
giustizia dovrebbe quindi essere “all’interno dell’amministrazione” e il ricorso
Capitolo 6 – SEGUE IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO...
171
a una diversa istituzione, indipendente dal potere esecutivo, è molto raffinato, ha
funzione di chiusura ed è mancato per secoli. Durante i quali, contro gli errori
o gli abusi dei funzionari, si protestava prima in via gerarchica, e poi in sede
politica; non a caso i primi “consigli di stato”, furono organi “di staff ” del principe,
per istruire le lamentele dei sudditi verso “abusi di potere” e per vessazioni o scorrettezze dei funzionari regi.
Si trattava di rimedi “eccezionali”, perché occasionali dovrebbero essere le suddette
deviazioni dei pubblici funzionari, in quanto gli organismi pubblici dovrebbero automaticamente agire in modo oggettivo, senza abusi; gli uffici pubblici dovrebbero
cioè strutturalmente essere strumenti di giustizia, dandosi ragionevolmente carico
anche delle aspettative degli individui e dell’interesse generale, filtrato dalla propria
funzione. Per questo, in materia amministrativistica, molto più che in materia civile, il
processo è un danno in sé, perché vi si discute del (preteso) cattivo funzionamento di
una autorità pubblica (e può innescarne, come vedremo, una deresponsabilizzazione).
I riesami amministrativi, esaminati ai paragrafi precedenti, o paragiurisdizionali sono
la prima sede per “dare giustizia” all’individuo attraverso l’amministrazione, e
non contro di essa. Per molti secoli e in molti paesi, questa possibilità di riesame, fino
all’Italia della seconda metà del novecento, fu ritenuta sufficiente, senza bisogno di un
organo giurisdizionale; mentre il processo civile è un rimedio giuridico a una patologia sociale, tra creditore e debitore, danneggiante o danneggiato, etc., la giurisdizione
amministrativa fronteggia già una patologia giuridica, data dal cattivo funzionamento
dell’attività amministrativa contro cui si ricorre. L’attuale eccesso di contenzioso in materia tributaria, è una dimostrazione del cattivo funzionamento delle istituzioni, come
riflesso della confusione diffusa nelle classi dirigenti e nell’opinione pubblica (par. 5.3).
Doversi rivolgere al giudice per errori, omissioni, equivoci, deresponsabilizzazioni e
negligenze, eliminabili dall’amministrazione, è infatti socialmente costoso. Il giudice,
pur indipendente, è più distante dalla specifica materia sia essa urbanistica, sanitaria,
ambientale, educativa o tributaria.
Il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni in un processo, davanti a un giudice indipendente, non deve farne dimenticare le diversità rispetto alla ordinaria lite tra
privati, dove lo scontro di opposti egoismi rende fisiologiche le controversie.
Le amministrazioni, come “parti pubbliche”, non perseguono infatti convenienze egoistiche, non hanno motivo di mentire, e al massimo si preoccupano per il “risultato di servizio”, l’“immagine pubblica”, la “copertura”, come rilevato al par. 5.3.
Questo comporta, al massimo, quelle forzature prolisse e tendenziose (indicate al
par. 5.18), ma non tecnicamente “false”, che avrebbero, se scoperte, conseguenze molto
negative proprio in termini di immagine e di copertura formale.
Il giudizio sull’azione amministrativa generale ha ad oggetto la correttezza, dei comportamenti amministrativi sottostanti, in genere espressione di autorità ed autotutela.
Il controllo del giudice è generalmente di legittimità-annullamento, ma il giudice amministrativo non si sostituisce all’amministrazione, annullandone invece gli atti,
e casomai imponendole un comportamento attraverso il c.d. “commissario ad acta”,
stante anche la sua estraneità alla gestione dei diversissimi settori coinvolti (ad esempio
172
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
urbanistica, sanità, istruzione etc.). Ordinariamente, come detto,la giurisdizione generale amministrativa (TAR – consiglio di stato) è di impugnazione-annullamento; l’atto
invalido viene annullato dal giudice, e casomai l’amministrazione ne emetterà un altro
immune da vizi.
Vedremo invece che in materia tributaria la giurisdizione è di impugnazione, ma –
per motivi di semplicità – si estende alla rideterminazione del tributo, nell’ambito
della materia del contendere definita dall’atto impugnato e dal ricorso (c.d. “giurisdizione di impugnazione-merito”, di cui riparleremo e che si ricollega alla tradizione del
contenzioso amministrativo tributario. Nella determinazione estimativa della ricchezza
era naturale, da parte dell’organo di riesame, una rideterminazione del tributo,
piuttosto che un annullamento puro e semplice.
Un contenzioso amministrativo è infatti indispensabile alla determinazione
valutativa della ricchezza, mentre è fuori luogo in quella ragionieristico contabile. Per questo un sistema di contenzioso amministrativo, in Italia come negli altri
ordinamenti, esisteva quando la giustizia amministrativa era invece ancora allo stadio
embrionale. In un certo senso il contenzioso amministrativo appartiene alla normalità della valutazione della ricchezza in base a stime degli uffici tributari. Queste
stime richiedono infatti una dialettica tra uffici e contribuenti, che può collocarsi prima o dopo l’atto di accertamento, ma è comunque ineludibile. In un certo senso questa
dialettica è molto vicina all’amministrazione attiva anziché a quella contenziosa.
Non a caso nel contesto prefigurato al par. 5.7, per la ricchezza non determinabile attraverso le aziende, il relativo monitoraggio degli uffici dovrebbe svolgersi prima degli
accertamenti e indipendentemente da essi.
La proterva riforma del 1973, ignorò la ricchezza non determinabile ragionieristicamente (cfr. par. 3.13 sulla contabilità del lavoro indipendente) e quindi anche la
dialettica del contenzioso amministrativo. Quest’ultimo fu soppresso (par. 6.4 sull’abolizione del concordato) e fu varato un processo giurisdizionale guardando al contenzioso
civile, anche perché non esisteva un modello amministrativo cui fare riferimento per
una dialettica fisiologica e di massa.
Nacque quindi un “giudice speciale” nel senso di “specifico per le controversie
tributarie”, ma tutt’altro che “speciale” sul piano della qualità del giudizio, come
vedremo oggi gravemente insoddisfacente.
Prima di tutto ha pesato l’eredità delle commissioni del vecchio contenzioso amministrativo tributario, esistenti dal diciannovesimo secolo, che si sono perpetuate, con
imbellettamenti di giurisdizionalità esteriore, nel contenzioso giurisdizionale. Vi ha
contribuito la matrice processualcivilistica, anziché di diritto amministrativo, di
alcuni capiscuola dell’accademia tributaria, la professione forense esercitata dalla
maggior parte di essi e il desiderio degli uffici tributari di “non decidere”, scaricando le questioni sui giudici. Questi ultimi sono infatti non solo indipendenti, ma
sottratti ad un inquadramento gerarchico di controlloo reciproco, e con margini di
decisione per questo amplissimi.
L’inutile proliferazione di processi tributari improvvisati non rivela apertura alla tutela dei privati, ma uffici che non vogliono decidere e avvocati bramosi di liti, nella de-
Capitolo 6 – SEGUE IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO...
173
generazione “legalistico processuale” in cui la materia si sta avvitando, vivendo ormai di
vita propria, nell’incubo indicato al par. 3.16. La giurisdizione ha paralizzato l’amministrazione, ed il processo non è più una tutela dei contribuenti, ma una valvola di
sfogo per pratiche tendenti a vivere di vita propria. In uno scaricabarile dove uffici e
giudici si palleggiano una pratica che ad ogni passaggio allenta il proprio contatto con
la realtà, e alla fine “si decide da sola”, per forza di inerzia, non importa se in modo
imprevedibile e sconclusionato. Per questo i processi tributari italiani sono centinaia di
volte più numerosi di quelli di altri paesi europei, come la Germania, la Francia o la
Gran Bretagna, con un circolo vizioso che li rende sbrigativi e insoddisfacenti. L’attuale
prospettiva giurisdizionale, per i contribuenti, soprattutto quando hanno ragione, è
peggio di un ponderato ed imparziale rimedio amministrativo.
Il processo dovrebbe infatti essere una via di uscita residuale per ipotesi particolari cui la serialità dell’intervento degli uffici non fornisce una soluzione soddisfacente.
Il giudice, non condizionato da rigidità gerarchico burocratiche, dovrebbe poter trovare,
senza formalismi, la soluzione più sensata in base ai principi. Sono casi eccezionali
rispetto alla funzione amministrativa di determinazione della ricchezza, da svolgere a
cura degli uffici.
6.8. Segue: reclutamento dei giudici e avvio del processo
Le commissioni tributarie risentono ancor oggi della loro matrice storica,
anteriore alla tassazione attraverso le aziende, e radicata nella fiscalità valutativa a
cura degli uffici tributari. Per quel contesto erano sufficienti il senso comune relativo
alla valutazione di terreni e fabbricati e piccole attività economiche o la preparazione
giuridica generalista sulle imposte “tipo registro”.
È forse per queste che ancor oggi nel reclutamento dei giudici tributari, sono
sufficienti titoli di studio economico-giuridici e altre qualifiche formali, prestabilite dalla legge, in relazione soprattutto all’anzianità di servizio in pubblici uffici e
assimilati. Non è richiesta alcuna preparazione in materia tributaria e troviamo nel
migliore dei casi le sensibilità giuridico generaliste dei magistrati ordinari (cd.
membri togati), nonché altri professionisti (avvocati, etc.), dirigenti e funzionari
di enti o amministrazioni pubbliche; non si può neppure contare sull’esperienza
di una qualche attività tributaristica collaterale, in quanto rigide incompatibilità escludono dalle commissioni chi svolge una qualche attività professionale nel
settore. Questa variegata provenienza dei giudici li rende quindi eterogenei, e
rappresenta un oggettivo ostacolo per prevedere l’atteggiamento e la sensibilità
dei magistrati (accentuando le carenze di istruttoria e di contraddittorio di cui
diremo).
La remunerazione è simbolica, collegata al numero delle sentenze redatte dai
singoli giudici e dal collegio; l’impegno è collaterale, incentrato attorno alle udienze,
in genere ogni due settimane, più la redazione delle sentenze, effettuata a domicilio,
ciascuno per conto proprio, dopo che il dispositivo è stato concordato con gli altri
174
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
giudici; su questa premessa, una importante preoccupazione del giudice è smaltire
le sentenze.
Le occasioni di incontro sono quindi ben minori di quelle tra funzionari di uno
stesso ufficio, che si frequentano stabilmente; il che ostacola ulteriormente il superamento delle già indicate eterogeneità di partenza, ostacolando il controllo reciproco e agevolando “deviazioni ambientali”, dallo scambio di favori fino al vero
e proprio inquinamento corruttivo larvatamente somigliante a quello descritto per
gli uffici al par. 5.11 e salito spesso agli onori della cronaca; la carenza di dialettica processuale spinge a sostituire in modo relazionale la facile dialettica amministrativa con
gli uffici tributari. Col giudice è impossibile una analoga interlocuzione, e non a caso
la parola “avvicinamento” si carica subito di sospetti se a lui riferita. Sulle pratiche
loro assegnate i giudici tributari sono infatti nella condizione ideale per fare e chiedere
favori, anche innocenti espressioni di un “interessamento”, cioè un piccolo potere,
“relazionale”. Qualche volta il favoritismo è “pro fisco”, dove la possibilità dei giudici
di favorire gli uffici in pratiche importanti e “visibili”, costituisce una “lecita” moneta
di scambio per un trattamento amministrativo di favore su pratiche “minori” e “segnalate”, direttamente o indirettamente dal giudice.
L’indipendenza di questi giudici rispetto alle parti in conflitto, che senza dubbio
sussiste nel senso di cui al par. 2.1, diventa secondaria rispetto ai suddetti inconvenienti.
Tale indipendenza è salvaguardata da un organo elettivo di autogoverno (il «consiglio
superiore della giustizia tributaria»), e la dipendenza delle dotazioni logistiche e del
personale tecnico delle segreterie dal ministero dell’Economia sono inidonee a comprometterla.
Giudice indipendente non vuol dire però giudice competente: la già indicata
mancanza, in capo ai giudici, di sensibilità sulla tassazione attraverso le aziende, assieme
alla sbrigatività della tempistica processuale, rende troppo frequenti le sentenze casuali.
Molti giudici fanno del loro meglio, per il già indicato compenso simbolico, soprattutto
quando si tratta dell’ordinaria stima “valutativa” della ricchezza non registrata “attraverso gli uffici” o di questioni procedurali alla portata della sensibilità giuridico-economica
comune; nel complesso però la valanga di contenzioso, anche specialistico, rovesciata su
una magistratura “part time” e senza selezione tecnica, provoca una confusione enorme,
confermata dall’intollerabile imprevedibilità del processo, dove la media tra sentenze
sbrigative ed approfondite genera una specie di lotteria; per certi aspetti questa disomogeneità nuoce più di sentenze sistematicamente disattente e sbrigative; si aggiunge
infatti l’ulteriore aleatorietà rappresentata dal non sapere “cosa sarà esaminato”, “con
quale interpretazione” e “con quale approfondimento”.
Una massa enorme di pratiche di controllo, spesso sofisticate e importanti, sono
scaricate su uno sbrigativo processo in cui un giudice “generalista” ed “onorario”, deve
avventurarsi, nel corso di processi sbrigativi, senza contraddittorio formale, in vicende
cui non ha partecipato, spesso ormai remote, filtrate da resoconti di parte facili da equivocare.
Fuorviante è anche, per un processo di impugnazione, il riferimento ai modelli del
processo civile, cui si ispira il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sul rito processuale tribu-
Capitolo 6 – SEGUE IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO...
175
tario; l’ispirazione al rito processualcivilistico comporta molte complessità esteriori,
senza giovare alla sostanza del giudizio. Che resta, come dicevamo sopra, sbrigativo e
con forti difficoltà di interlocuzione, specialmente davanti a pratiche complesse.
La giurisdizione speciale tributaria sussiste per tutti i tributi, e a tal fine la giurisprudenza adotta una nozione ampia di tributo, considerando tali persino i contributi di bonifica, il diritto aeroportuale di imbarco, i contributi ad ordini professionali.
Visto il contesto amministrativistico deve essere il privato a rivolgersi al giudice,
in quanto l’ufficio tributario non ne ha bisogno, incidendo di propria iniziativa nella
sfera del privato con gli atti unilaterali di cui al par. 6.1.
Il ricorso è ammesso contro atti di determinazione del tributo, (atti impugnabili), individuati normativamente, come l’avviso di accertamento, l’avviso di liquidazione
delle imposte indirette, l’iscrizione a ruolo, l’irrogazione di sanzioni.
Per altri atti, o meri comportamenti, l’impugnazione è differita a quando daranno luogo ad atti impositivi, in quanto è ritenuta “prematura”, come nel caso dei “verbali
di constatazione” (paragrafo 5.6). Più che parlare di divieto civilistico di “accertamento
preventivo”, tale divieto si spiega con la natura “endoprocedimentale” dei relativi atti
(interni a un procedimento ancora da definire). Per alcuni comportamenti, come quelli
istruttori, non è prevista tutela, come indicato al par. 5.6, mentre di alcuni atti cautelari
parleremo più avanti.
Qualche volta la pretesa tributaria viene presentata con atti meno formali, come la
fattura ai fini del tributo sulla raccolta dei rifiuti (par. 10.10), i c.d. “avvisi bonari” non
notificati (par. 5.5) o atti interpretativi personalizzati. Tali atti, quantunque tipologicamente diversi dagli atti impositivi, indicano in modo compiuto una pretesa tributaria.
Per gli atti non notificati si delinea una “impugnazione facoltativa” di fatto, nel senso
che l’impugnazione è ammessa, ma il contribuente potrà sempre impugnare l’atto successivo, mancando una conoscenza legale di quello precedente Il ricorso va presentato
nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto, effettuata da messi con la qualità di
pubblici ufficiali, anche mediante particolari modalità di utilizzo dei servizi postali; di
fronte a queste modalità di conoscenza legale è irrilevante una diversa conoscenza di
fatto dei provvedimenti di imposizione.
Spesso si tratta di atti emessi in sequenza (ad esempio l’avviso di accertamento precede l’iscrizione a ruolo), e quindi gli atti successivi sono impugnabili solo per la
parte non riproduttiva di un atto precedente in modo da non vanificare i termini per
impugnare quest’ultimo o gli esiti del processo pendente su di esso (art. 19 comma 3).
Il processo può anche essere “di rimborso”, senza atti dell’amministrazione, ma
innestandosi sulle istanze di rimborso, presentate agli uffici finanziari nei termini
previsti dalle singole leggi d’imposta ovvero, in base all’art. 21, comma 2, entro due anni
dal pagamento o dal sopravvenuto diritto al rimborso.
Il rifiuto espresso dell’ufficio finanziario va impugnato secondo le regole generali,
ma in genere si verifica un suo silenzio; quest’ultimo, dopo 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, è un presupposto per ricorrere alla commissione tributaria, entro il
termine di prescrizione decennale (art. 21, comma 2). Questo silenzio non è equiparato
a un provvedimento amministrativo di implicito diniego di rimborso, che costringereb-
176
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
be a ricorrere tempestivamente, anche quando la mancata risposta dell’ufficio è dovuta
solo ad inerzia, senza alcuna intenzione di negare il rimborso; il silenzio è insomma solo
un «presupposto processuale», necessario per rivolgersi al giudice, ma non il simulacro
(la fictio iuris) di un atto impugnabile, il che contrasterebbe con le tendenze più recenti
del diritto amministrativo, in cui – casomai – il silenzio vale sempre più spesso come
“assenso”.
In queste liti di rimborso si tende ad attribuire al contribuente la posizione
di attore in senso sostanziale, trascurando che ci si trova pur sempre in un contesto amministrativistico, e si sta esaminando il comportamento di una istituzione
pubblica rispetto a una istanza del privato; ciò dovrebbe trattenere da applicazioni
troppo meccaniche, a carico del contribuente, del criterio dell’onere della prova;
al paragrafo 6.2 abbiamo infatti già visto il rischio di utilizzare in maniera troppo
sbrigativa lo stereotipo dell’onere della prova quando l’amministrazione è inerte
e ostruzionistica davanti alla richiesta di rimborso; quando quest’ultimo deriva da
vicende ragionieristiche complesse, difficili da spiegare a un giudice esposto anche
ai disorientamenti difensivi dell’amministrazione, vengono spesso negati rimborsi
assolutamente fondati.
La disciplina processuale è totalmente inadeguata quando si tratta di atti diversi
dalla determinazione del tributo, collocati in una fase precedente o successiva; si
pensi ai provvedimenti cautelari, sequestri e ipoteche, atti istruttori illegittimi, rifiuti di
esercitare l’autotutela (paragrafo 9.6), risposte negative ad interpelli «autorizzatori» (ad
esempio in tema di società controllate in paradisi fiscali, o in tema di «ruling internazionale»), etc...
Le tutele cautelari sono infatti regolate in modo episodico, cioè su casi singoli, come
la sospensione della riscossione delle somme richieste con l’atto impugnato.
Un’altra tutela cautelare recentemente demandata alle commissioni riguarda il fermo degli autoveicoli (c.d. “ganasce fiscali”) e le ipoteche sugli immobili, da parte del
concessionario per la riscossione. Alla giurisdizione tributaria spetta anche il reclamo
contro i provvedimenti di sequestro cautelare contenuti nel decreto legislativo sulle
sanzioni.
Si tratta comunque di inserimenti casistici, mentre manca una tutela generale
del contribuente rispetto ad altre attività amministrative, diverse dalla determinazione del tributo; possono essere attività istruttorie o di cautela patrimoniale amministrativa, rispetto alla futura esecuzione fiscale. Una tutela del giudice amministrativo
o di quello civile frammenterebbe la competenza tra giudici diversi, contrariamente
alla tendenza verso una giurisdizione esclusiva «per materia», affidata ad un unico
giudice, senza distinguere le questioni di diritto soggettivo da quelle di interesse
legittimo.
Per avvalorare la giurisdizione tributaria e attribuire una tutela, si potrebbe sostenere
anche una interpretazione restrittiva dell’elenco degli atti impugnabili, di cui all’art. 19,
riferendone la tassatività solo agli atti di determinazione del tributo; questo dovrebbe
attrarre, “per materia”, alle commissioni tributarie tutte le liti del settore, persino quelle
sull’accesso agli atti, di cui avevamo detto al paragrafo 6.1.
Capitolo 6 – SEGUE IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO...
177
6.9. La procedura: difficile coesistenza tra sostanza impugnatoria ed ispirazione civilistica
Il ricorso va prima notificato, presentato o spedito all’ufficio finanziario, non in
quanto autorità amministrativa di riferimento, ma in quanto “controparte”, ricalcando
le modalità del codice di procedura civile. È prevista, sul modello civilistico, anche la
notifica a mezzo ufficiale giudiziario, procedura più formale e costosa, che in questo caso è superflua; ed invero, essendo la controparte una amministrazione pubblica, è
possibile ottenere formale ricevuta della presentazione del ricorso anche senza utilizzare
l’ufficiale giudiziario. Questa presentazione deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica
dell’atto impugnato, tenendo conto che –secondo le regole generali – in caso di spedizione a mezzo posta vale il termine di spedizione; si crea quindi, il solito “doppio termine”, col limbo costituito dagli imprecisati tempi tecnici della posta, tra la spedizione
del ricorso e la sua ricezione.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione o spedizione, il
ricorso va depositato o spedito alla segreteria della commissione (artt. 21 e
22 d.lgs. n. 546); la perentorietà di questa costituzione in giudizio si giustifica in
quanto solo con questo deposito (denominato, riprendendo un’espressione del processo civile, «costituzione in giudizio del ricorrente») la commissione viene investita della
controversia, venendone legalmente a conoscenza (cfr. art. 22). In tale sede il ricorrente
deve depositare, in allegato al ricorso, la copia dell’atto impugnato e i documenti che
produce, pagando altresì il contributo unificato, in relazione alla fascia di valore in
cui si colloca la lite.
Il ricorso deve contenere una serie di dati identificativi (art. 15) e soprattutto i
«motivi del ricorso», cioè i vari profili sotto i quali si chiede l’annullamento totale o
parziale dell’atto impugnato (od il rimborso dell’imposta). Tali motivi concorrono, assieme alla motivazione dell’atto impositivo, a «delimitare la materia del contendere», in
un processo strutturalmente impugnatorio Come in tutti i processi amministrativi,
al giudice si chiede l’esame della correttezza di un atto della pubblica amministrazione;
la determinazione dell’imposta rileva indirettamente, perché i suoi vizi logici o
giuridici diventano un “vizio” dell’atto impugnato; sotto questo profilo, quindi, rileva
anche la carenza di motivazione o di prova (par. 6.2). La già indicata possibilità
del giudice di rideterminare l’imposta, nei limiti della materia del contendere (motivazione dell’atto impugnato e motivi del ricorso) è perfettamente compatibile con
la natura impugnatoria del processo, trattandosi di un annullamento parziale.
L’oggetto del processo tributario è dato quindi non dall’imposta dovuta, ma dall’imposta dovuta per una determinata contestazione adeguatamente motivata, solo
nel cui ambito sono ammesse rideterminazioni da parte del giudice; esso non è investito
dell’imposta dovuta, ma di una certa contestazione inquadrata in fatto e in diritto.
L’incardinamento del processo su una giurisdizione civile ha spesso provocato, in
relazione a particolari situazioni di fatto, affermazioni di principio tendenti apparentemente ad ampliare l’intervento del giudice, come se fosse non già un processo
di impugnazione, ma di accertamento. Dietro alla relativa equivoca espressione di “im-
178
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
pugnazione merito”, non c’è nessuna teoria alternativa rispetto a quella del processo
di impugnazione; si tratta solo di espressioni coniate per giustificare un intervento
“di sostegno” del giudice verso atti magari impostati male dall’ufficio tributario, ma
dove era chiaro che l’imposta era dovuta. Sono sensazioni corrette, ma che rischiano di
essere fuorvianti provocando, anche a causa della sbrigatività del processo e del contesto
pasticciato, decisioni a sorpresa, violazioni della dialettica processuale, del principio del
contraddittorio e in definitiva del diritto di difesa.
Per arrivare a questo condivisibile obiettivo, il giudice ha ampi margini, all’interno
della motivazione dell’accertamento (par. 6.2), senza bisogno di teorizzare una grossolana imposizione giudiziale. Spesso una determinata contestazione, di fatto o di diritto,
può essere ritenuta motivata (par. 6.2) anche se non tutti gli elementi di sostegno sono
indicati nell’atto di accertamento; si pensi ad esempio a tutte le caratteristiche di un
immobile o di una azienda ai fini della relativa valutazione, o i vari punti di vista per
stimare i ricavi non registrati, par. 5.13 ss.; un intervento attivo del giudice, nel rispetto
del principio del contradditorio, può estendersi a questi aspetti, che restano all’interno
della materia del contendere, senza stravolgere i ruoli delle parti in omaggio a una singola decisione giusta.
La parte contro cui il ricorso è proposto (c.d. «parte resistente», cioè (in primo grado) l’ufficio finanziario, l’ente locale o il concessionario per la riscossione) ha 60 giorni
di tempo per “costituirsi in giudizio”, cioè prendere posizione sul ricorso con un
atto di controdeduzioni; l’inerzia del resistente non comporta alcuna sua automatica
sconfitta, già nel processo civile; il giudice ben potrebbe infatti respingere il ricorso,
in quanto non fondato in fatto o in diritto, anche se il resistente non ha partecipato al
giudizio; la mancata costituzione comporta solo pregiudizi di rito, come il mancato invio dell’avviso di udienza (art. 31) o la mancata comunicazione della sentenza (art. 37),
riservate alle parti costituite.
Il ricorso deve essere esaminato preliminarmente, per verificarne alcune caratteristiche formali: a tale scopo viene assegnato a una delle sezioni giudicanti di cui si
compone la commissione, e subisce un «esame preliminare» a cura del presidente, che
individua i ricorsi palesemente inammissibili (artt. 27 ss.), per tardività, per mancata
sottoscrizione, per tardiva costituzione del ricorrente, ecc.. Contro tali provvedimenti
le parti possono presentare reclamo alla commissione (cioè al collegio), che conferma
l’inammissibilità con sentenza impugnabile, ovvero accoglie il reclamo, e dispone con
ordinanza la prosecuzione del processo.
In questa fase preliminare il ricorso può essere riunito ad altri eventuali procedimenti soggettivamente o oggettivamente connessi, viene fissata la data di trattazione,
comunicata al contribuente e all’ufficio, se costituitosi (art. 31).
Le parti possono presentare documenti e «memorie illustrative» dei motivi
già fatti valere, nei termini di dieci giorni prima dell’udienza (per le memorie) e di 20
giorni per i documenti. Questi termini servono a dar modo alla controparte di controdedurre e, se non vengono rispettati, l’altra parte può appunto chiedere che, ai fini della
decisione, non si tenga conto delle memorie e dei documenti tardivamente presentati;
in tal caso la motivazione della sentenza non potrà essere basata su questi elementi, che
Capitolo 6 – SEGUE IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO...
179
tuttavia potrebbero influenzare psicologicamente il giudice, col solo vincolo di non
indicarli formalmente nella motivazione, da basare su altre argomentazioni. Queste ultime memorie vanno presentate alla segreteria della commissione in due copie, una
delle quali per la controparte, che potrà ritirarla in segreteria della commissione, senza
ricevere a tale scopo alcun avvertimento specifico.
L’attuale processo tributario prevede l’udienza pubblica solo se una delle parti la
richiede, altrimenti la controversia viene decisa in camera di consiglio, alla presenza cioè
dei soli giudici e del segretario.
Nella pubblica udienza, cui possono partecipare il contribuente e il rappresentante
dell’ufficio finanziario, il componente della commissione che funge da relatore illustra
la questione. Una volta ascoltato il relatore, le parti sono ammesse alla discussione,
consistente in realtà di brevi illustrazioni di quanto già scritto, una per parte e a compartimenti stagni, con difficoltà di interlocuzione e sacrificio della dialettica processuale; l’udienza non è preceduta da alcuna attività preparatoria, in contraddittorio, per
mettere a fuoco i punti salienti della questione. Essa dura in genere, per le cause tipo,
una decina di minuti, davanti a giudici spesso spazientiti dallo scorrere del tempo, dove
è difficile interloquire, precisare punti specifici, chiarire dubbi, replicare.
La controversia è in genere decisa senza ulteriori udienze (art. 35), in modo sbrigativo, salvo il raro caso in cui la commissione formuli richieste istruttorie, molto rare
a causa delle già descritte caratteristiche della giustizia tributaria; tutt’al più viene talvolta ordinata, ai sensi dell’art. 7, la presentazione di atti e documenti destinati a
confermare la veridicità di alcune affermazioni di parte. Ricordiamo che questi poteri
istruttori non possono comunque essere usati per dare all’accertamento una base diversa
da quella indicata nella relativa motivazione, o per accogliere il ricorso per motivi non
indicati dal ricorrente (paragrafo 6.2 sulla motivazione); il “principio della domanda”,
con la necessità di indicare i motivi di invalidità dell’atto impugnato, è quindi perfettamente conciliabile con la natura oggettivamente amministrativa del processo.
Questa sbrigatività del processo tributario è alla base del divieto di prova testimoniale, confermando la sommarietà del rito, in cui si mortificano quei principi
dell’oralità, del contraddittorio e della formazione giudiziale della prova cui è stata data
addirittura rilevanza costituzionale.
Questa sommarietà rischia di avvantaggiare oltremisura gli uffici fiscali, che
nelle indagini possono acquisire dichiarazioni di terzi, per poi utilizzarle nel processo,
con una valenza pratica di prova testimoniale, sottratta al diretto vaglio critico della
controparte e del giudice. Un ragionevole compromesso, per salvaguardare al tempo
stesso il divieto di prova testimoniale e la valenza probatoria di quanto raccolto a verbale dagli uffici, potrebbe interpretare restrittivamente il divieto di prova testimoniale ed
ammettere nel processo anche le dichiarazioni scritte di terzi, prodotte dal contribuente
a proprio vantaggio.
La sbrigatività suddetta asseconda una tendenza latente in tutte le giurisdizioni, dove
le sentenze e le massime non esteriorizzano del tutto le sfumature che hanno portato
alla decisione; si ricordi infatti dal par. 4.3 e 4.4 in fine che i giudici non hanno il compito di sistematizzare concetti, ma di risolvere controversie nel modo “sostanzialmente
180
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
più corretto”, e meno criticabile. Le singole sentenze non “fanno storia”, non “insegnano”, non sono “opere letterarie”, e quindi sono normali, da parte dei giudici, ibridi
motivazionali improntati a valutazioni di economicità. Ne fa parte anche lo sfasamento tra ragioni della decisione, intuite, ma difficili da comunicare, e lrelativa motivazione,
spesso basata sui consueti stereotipi solo per questo apparentemente in tema, e proprio
per questo meno criticabili, secondo gli schemi di comodità istituzionale indicati al par.
4.3. Le divergenze tra motivazione palese e ragionamento effettivo non rivelano mala
fede, ma solo una istintiva comodità di svolgimento della funzione di giustizia;
quest’ultima è infatti un servizio, teso a “governare il caso”, mentre la legge cerca (sia
pure con le incoerenze di cui al par. 2.4) di “governare il sistema”.
Dopo l’udienza non esiste un termine preciso entro il quale i giudici debbano comunicare l’esito del giudizio e depositare le motivazioni della sentenza in segreteria.
Una volta che ciò sia avvenuto, si può ottenere copia della sentenza. La parte vittoriosa può notificarla, facendo scattare il termine “breve” di 60 giorni per l’appello (art.
51). Senza tale notifica subentra il «termine lungo» di cui all’art. 327 c.p.c., secondo cui
la sentenza passa comunque in giudicato se non impugnata entro sei mesi dal suddetto
deposito.
La sentenza decide anche sul rimborso delle spese processuali; da alcuni anni è
stata infatti introdotta la condanna del soccombente al rimborso delle spese processuali
(art. 15, D.lgs. n. 546/1992), sempreché la commissione non ritenga di compensarle tra
le parti per la particolare complessità della controversia.
La presentazione dell’appello avviene secondo gli stessi criteri previsti per il
ricorso (art. 53, comma 2, che rinvia all’art. 20). La segreteria della commissione regionale, destinataria dell’appello, richiederà quindi alla commissione provinciale il fascicolo
contenente il resto della documentazione (sentenza, ricorso introduttivo, controdeduzioni, memorie, documenti ecc.).
Entrambe le parti possono essere scontente della sentenza del primo giudice, e quindi avere interesse a fare appello. È importante osservare che l’appello può essere presentato, a differenza del ricorso di primo grado, anche dall’ufficio tributario, che può
essere stato soccombente in primo grado. In tal caso, la parte che presenta l’appello per
seconda deve farlo con l’appello incidentale (art. 54), proposto nelle già indicate forme
della costituzione in giudizio, cioè senza notificazione alla controparte, ma con deposito
alla segreteria della commissione.
L’appello non ha in genere la funzione di rimediare a specifici vizi della sentenza appellata, ma costituisce un nuovo giudizio, nei limiti definiti in primo grado ed
in quelli – eventualmente più ristretti – definiti dai motivi di appello. Anche se, in base
all’art. 53, il ricorso in appello deve contenere i «motivi specifici dell’impugnazione»,
non si tratta di un “processo impugnatorio”, che presuppone la scoperta di “vizi logico
giuridici” della sentenza impugnata, come vedremo per il giudizio di cassazione. Si
tratta solo delle ragioni per cui l’appellante chiede un secondo, e possibilmente diverso,
giudizio; naturalmente, di fatto, l’appellante indicherà gli aspetti della sentenza appellata
che non persuadono, le argomentazioni che avrebbero dovuto essere convincenti e non
sono state prese in considerazione, ecc.. I giudici di appello non sono però “giudici del
Capitolo 6 – SEGUE IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO...
181
giudice”, come la cassazione, ma accedono direttamente alla questione, e la sentenza di
primo grado può essere ribaltata anche senza individuarne “vizi” in senso tecnico.
L’interesse alla stabilità dei rapporti giuridici e ad evitare lo spreco di attività giurisdizionale, subordinano questo nuovo esame a richieste molto specifiche, come l’indicazione degli «specifici» motivi dell’appello, e l’abbandono delle questioni ed
eccezioni formulate in primo grado e non riproposte in appello (art. 56, che riprende
il principio processualcivilistico di cui all’art. 346 c.p.c.).
Un vero e proprio “vizio” della sentenza è invece il presupposto della c.d. “revocazione”, diretta allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, ed applicabile anche
in materia tributaria, soprattutto per gli evidenti errori di fatto di cui all’art. 395 n.4
c.p.c., che possono verificarsi nella frettolosa sbrigatività del processo tributario. Lo stesso vale per la correzione in presenza di palesi errori di calcolo risultanti estrinsecamente
confrontando motivazione e dispositivo.
L’appello segue le stesse regole procedurali del giudizio primo grado (fissazione dell’udienza, le memorie, discussione, notificazione della sentenza, etc.).
Le sentenze di entrambe le commissioni tributarie (provinciale e regionale) devono
essere corredate di motivazione; la funzione della motivazione delle sentenze rispetto a
quella degli atti autoritativi unilaterali, come l’avviso di accertamento (par. 6.2) meriterebbe studi specifici. La motivazione della sentenza serve infatti alla trasparenza della
funzione di giustizia, anche nei confronti delle parti, che possono valutarla in relazione
alle precedenti argomentazioni addotte da entrambe nel giudizio.
Le sentenze delle commissioni sono impugnabili per cassazione (artt. 62 e
ss.), per vizi di legittimità (violazione di legge, questioni di diritto), ed anche carenza
dell’appena citata motivazione. Il ricorso per cassazione è il tipico rimedio «impugnatorio», articolato su “motivi di ricorso”; ove la cassazione ritenga sussistente il
vizio, potrà decidere direttamente ove non occorrano ulteriori accertamenti di fatto,
altrimenti rinvierà a una diversa sezione del giudice «a quo», che dovrà rinnovare il
giudizio, seguendo se del caso il principio di diritto fissato dalla cassazione.
La cassazione giudica insomma “sulla sentenza”, a differenza del giudice di appello,
come sopra rilevato. Già nel processo civile la cassazione è “il giudice del giudice”, ed
a maggior ragione lo è in un processo amministrativo come quello tributario. Se ne
comprende così la lontananza rispetto alle questioni da decidere, cui si aggiunge lo
scrupolo della cassazione di giungere a una “sentenza esatta nel caso concreto”, cioè
che riconosca –per quanto visibile dai “filtri” suddetti – chi ha torto e chi ha ragione.
Per questo, il massimo risultato che ci si può aspettare da tutti i giudici, compresa la
cassazione tributaria, sono “sentenze corrette” nel caso concreto; l’“insegnamento”
(della cassazione, del consiglio di stato, del tribunale, etc.) è al massimo un utile sottoprodotto, frequente soprattutto nel diritto dei privati, dove il giudice è l’istituzione di
riferimento (anche qui la sistematizzazione concettuale viene dopo, anche agli occhi del
giudice, rispetto alla correttezza sostanziale della decisione). Gli “insegnamenti giurisprudenziali” e le “sistematizzazioni” sono invece molto più rare nel diritto dei pubblici
poteri, compreso quello tributario; dove non si deve perciò guardare alla cassazione
come l’istituzione particolarmente qualificata e competente, in grado di sciogliere i
182
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
nodi della determinazione della ricchezza, e che rimedia ai danni logico-sistematici delle commissioni tributarie. Non stiamo togliendo nulla al suo impegno e alla sua fatica,
se non il superfluo, semplicemente perché non si tratta di un compito cui è destinata e
per cui è preparata.
La legittima preoccupazione della cassazione è infatti un’altra, soprattutto di fronte
alla valanga di ricorsi che le vengono presentati; come tutti i giudici, nei limitati margini
di cui essa dispone, si preoccupa di fronteggiare le singole controversie nel modo più
equilibrato. Quello che viene chiamato ”insegnamento della cassazione” è secondario
rispetto alla soluzione di controversie “di diritto”, ma in materia tributaria è ancora più
secondario di quanto sia nel diritto civile. Qui, infatti, le istituzioni di riferimento sono
quelle amministrative, e la giurisdizione si pone il problema di correggerne negligenze
e illegittimità, non di rideterminare il tributo. Benché la determinazione del tributo sia
in genere strumentale per rendersi conto se l’amministrazione ha sbagliato e il contribuente merita giustizia, essa non è l’oggetto diretto dell’intervento del giudice.
Sotto questo profilo è faticoso comprendere, dalle presentazioni tortuose e spesso
tendenziose delle parti, i reali termini delle questioni. Per questo è difficile contestualizzare le affermazioni della cassazione, non a caso tante volte fraintese dai commentatori,
che si limitano alla “massima”, senza calarla nel contesto concreto della decisione. Per
questo sentenze corrette vengono spesso generalizzate in modo sbagliato, contribuendo
al fallimentare bilancio di cui al paragrafo successivo.
6.10.Il fallimento della “via giurisdizionale alla determinazione della ricchezza”: ostacoli al funzionamento degli uffici e possibili vie di uscita
La valutazione di sintesi del sistema giurisdizionale va effettuata per tipologie di
controversie, a seconda della possibilità di ricondurle facilmente al bagaglio culturale
del giudice. Questa riconducibilità è elevata per le controversie valutative, come gli
accertamenti induttivi dei “lavoratori indipendenti”, sul valore di terreni e fabbricati, e
questioni simili, dove occorre ragionare per ordine di grandezza. Lo stesso vale per le
pratiche di liquidazione, ripetitive e facilmente comprensibili; spesso si tratta infatti di
contenziosi innescati dalla ripetitività anonima (ed informatica) nella gestione amministrativa di grandi masse di dati, dove possono verificarsi degli errori, e il giudice serve a
superare irrigidimenti e pastoie interne alla macchina tributaria.
Per entrambe queste controversie la già rilevata sbrigatività del processo consente un
rapido smaltimento di un gran numero di cause, con un buon rapporto “costi-benefici”,
salvo quanto diremo in generale al termine del paragrafo.
L’inadeguatezza del processo tributario riemerge per le questioni specialistiche di
reddito d’impresa, soprattutto riguardanti le contestazioni interpretative (par. 3.11, par.
5.17 ss) o le poche attinenti a ipotetica ricchezza non registrata scavalcando le procedure aziendali (par. 3.7). Qui la sbrigatività del processo, un bagaglio culturale degli
operatori del diritto insufficiente rispetto alle complesse simmetrie della tassazione attraverso le aziende, la scarsa familiarità con le aziende e la contabilità aziendale, la caren-
Capitolo 6 – SEGUE IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO...
183
te formazione “socioeconomica” (par. 1.6) si intrecciano con la natura inevitabilmente
impugnatoria del processo tributario.
Mettiamoci nei panni di un giudice di un processo inevitabilmente impugnatorio,
davanti a questioni estranee al suo bagaglio culturale, dove si trova fortemente disorientato. Su questo premesse non c’è bisogno di tirare in ballo un ipotetico “in dubio pro
fisco” per spiegare la tendenza a respingere i ricorsi. L’indipendenza del giudice non dipende infatti solo da conflitti di interessi e condizionamenti culturali, ma anche dalla sua
capacità di padroneggiare le questioni, evidente soprattutto nei processi “impugnatori”
di matrice amministrativa, ma anche nei gradi successivi al primo di tutti i processi, dove
la questione è filtrata da una precedente sentenza. Una istituzione che deve esaminare
una controversia di cui non padroneggia i contenuti, cerca di trovare una via d’uscita
per non esprimersi, come conferma il numero di “sentenze procedurali”, emanate per
questioni di “rito”.
In mancanza di meglio, se si deve entrare nel merito, è istintivo far riferimento ad
altre istituzioni e quindi respingere il ricorso diventa la soluzione più agevole; d’altro
canto, quando il giudice titubante è costretto ad andare sulla fiducia, si sente più tranquillo a non vanificare un atto proveniente dalle istituzioni amministrative. Spingono in
questa direzione anche i condizionamenti mediatici sull’evasione fiscale e i fraintendimenti sui “grandi evasori”, di cui ai paragrafi 4.6 e 5.17 ss. In questo modo entra in crisi,
spontaneamente e inconsapevolmente, a seconda della difficoltà della singola pratica,
l’indipendenza dei giudici, magari anche di quelli tutt’altro che favorevoli al fisco, sulle
questioni che si sentono di aver inquadrato.
Su queste premesse gli uffici hanno buon gioco a introdurre elementi di dubbio,
che facciano scattare nel giudice i meccanismi mentali indicati sopra. È del tutto legittimo, rispetto alla spiegazione processualistica della tassazione, che gli uffici adottino
tutte le astuzie dell’avvocato, conformemente alle fuorvianti spiegazioni avvocatesche
indicate al par. 4.3. Se gli studiosi sono i primi a far uso dei noti disorientanti sproloqui
apparentemente in tema, è del tutto legittimo che anche funzionari remunerati meno
di duemila euro al mese utilizzino queste “armi di distruzione (cerebrale) di massa”. In
questa impostazione avvocatesca, che non viene da loro, essi lanciano legittimamente
sul giudice cortine fumogene apparentemente in tema, ma sostanzialmente senza filo
conduttore; la tattica è far scattare lo stato d’animo indicato sopra, secondo cui, in estrema sintesi, “giudice frastornato ricorso rigettato”.
È normale che questo avvenga con sentenze ineffabili, in cui si snodano espressioni
di stile, senza un reale filo conduttore, nello stile dei discorsi apparentemente in tema, di
cui abbiamo iniziato a parlare al paragrafo 4.3 a proposito della dottrina e che ci accompagnano in tutto il testo. Per questa “mancanza di giustizia”, che delegittima la giustizia
tributaria agli occhi di una quota sempre maggiore di operatori e di appartenenti alla
pubblica opinione, basta una cospicua minoranza di sentenze, ampiamente superata
negli argomenti in esame. Lo confermano udienze imbarazzanti, dove si deve spiegare a
giudici che non capiscono perché gli uffici fanno finta di non capire.
Anche qui, la mancata comprensione della tassazione attraverso le aziende si ritorce
sulle aziende, cioè sul regime di quello che esse dichiarano, contribuendo alla disgrega-
184
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
zione organizzativa indicata al par. 5.18 ss. Assorbite dai loro prodotti, e dal loro particolare, le aziende neppure si rendono conto di non avere “un giudice a Berlino”; tuttavia
la loro crescente tendenza a fare affidamento esclusivamente sugli uffici tributari, sottoponendosi alle conseguenti “taglie di stato” conferma il fallimento del contenzioso.
E il suo contributo, sia pure in piccolo, alla mancata crescita delle aziende italiane e ai
mancati investimenti di quelle estere, secondo quanto indicato al par. 5.19.
Gli ambienti accademici e professionali avvertono i malesseri descritti sopra, ma non
ne comprendono le cause. E si illudono di superarle invocando dal legislatore imprecisate modifiche del processo, secondo lo schema “legislatore incapace, aiutaci tu”(par.
4.3). Nessuno si accorge delle disfunzioni connesse ad una fuorviante impostazione
processualistica di una materia amministrativistica, dove il problema del processo viene
prima del processo, e riguarda l’attività amministrativa di determinazione tributaristica
della ricchezza.
L’insoddisfazione per il processo sussiste sia dove è efficiente, cioè per le piccole
controversie di massa, sia dove è inadeguato, come le questioni aziendali specialistiche.
In entrambi i casi il processo nasce per questioni non risolte in sede amministrativa, ed
è innescato proprio dal diffuso preconcetto, imitativo del diritto dei privati, secondo
cui la soluzione sarebbe “il processo”. È un deficit culturale che rende difficili le decisioni all’interno degli uffici, inceppando la funzione pubblica di determinazione della
ricchezza in materia tributaria. L’enfasi sul processo spinge infatti gli uffici a “non decidere” a rimettere le valutazioni al giudice, e poi –una volta sorte le controversie – a
coltivarle fino ad esaurimento; questo costringe le parti, stancamente, a tornare ciclicamente, e sempre più stancamente, dopo archi temporali pluriennali, su controversie
ormai remote nel tempo, di cui pian piano impallidisce il ricordo.
È un gioco dove esistono piccole, immediate, convenienze settoriali, ma dove su
larga scala “perdono tutti”. Il già indicato successo processuale degli uffici sulle contestazioni interpretative del regime giuridico della ricchezza registrata distoglie risorse
dalla ricerca e valutazione degli imponibili occultati, provocando inutili incertezze per
le organizzazioni imprenditoriali oggetto di questo diversivo. Si apre così un circolo
vizioso in cui gli uffici tendono sempre più verso le contestazioni interpretative di cui
al par. 5.18 ss., il che ostacola il controllo del territorio sulla ricchezza non registrata,
che dovrebbe seguire i criteri di cui al par. 5.7.
Anche per le già indicate “pratiche seriali” di lavoratori indipendenti, e “di liquidazione”, benché il giudice si orienti meglio, il processo rappresenta un costo spesso
sproporzionato rispetto al valore della lite, e alle energie professionali impiegate. Proprio la valvola di sfogo del processo spinge infatti gli uffici a trattare queste pratiche
“di massa” con la maggiore sbrigatività di cui al par. 6.5. La prospettiva di gestione
processuale di queste pratiche “bagatellari” ne alimenta paradossalmente la nascita; la già
indicata efficienza processuale, comunque relativa, contribuisce così a una inefficienza
amministrativa.
Tra queste due opposte forme di insoddisfazione possono esserci le solite sfumature
intermedie delle nostre discipline, ma il bilancio della via processuale alla tassazione è
comunque fallimentare. Il processo, che dovrebbe difendere i contribuenti da negligen-
Capitolo 6 – SEGUE IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO...
185
ze degli uffici, finisce oggettivamente per contribuire a queste ultime; vedere il processo
come “normale valvola di sfogo” ostacola la determinazione della ricchezza nella sua
naturale sede amministrativa; essa innesca un palleggio, tipicamente italiano, dove ogni
organo coinvolto dice la sua, per darsi tono, ma non decide, con la riserva mentale che
“tanto c’è il giudice”.
Paradossalmente, forse, concentrarsi sulla tutela amministrativa, responsabilizzerebbe gli uffici, migliorando la situazione generale. Non siamo infatti davanti a
controversie civili, dove l’alternativa alla funzione di giustizia è risolvere le liti
coi duelli rusticani. In materia tributaria, come in tutto il diritto dei pubblici
poteri il diritto passa attraverso le rispettive istituzioni pubbliche di sicurezza, di difesa,
ambiente, urbanistica, educazione, sanità, determinazione dei tributi, e un eccesso di
giustizia può deresponsabilizzarle e peggiorarne il funzionamento. Come appunto
è avvenuto in materia di determinazione dei tributi, al punto di ritenere preferibile
alla situazione attuale persino una abolizione secca della giurisdizione tributaria,
lasciando solo la protesta politica, facendo sentire gli uffici “senza rete” e costringendoli
a decidere. Senza arrivare a questo estremo, comunque preferibile alla situazione
odierna, la tutela giurisdizionale deve tornare ad essere una valvola di sfogo per casi
particolari in cui la determinazione dei tributi da parte delle aziende o degli uffici
giunge a una situazione di stallo. Per riportare entro limiti di normalità l’intervento
giurisdizionale rinviamo al potenziamento dei ricorsi amministrativi (par. 6.5), lo
spostamento dell’attività degli uffici verso la prevenzione-dissuasione, indicato al
par. 5.7.. Anche questa deprocessualizzazione si inquadra nella de professionalizzazione, di un settore che deve essere sdrammatizzato e normalizzato, gestendo in
via amministrativa le numerosissime pratiche valutative di importo “medio – piccolo”,
dei lavoratori indipendenti. Al minor numero di processi corrisponderebbe un loro
maggiore approfondimento, a parità di remunerazione e di numero dei giudici,
anche quelli attuali. Questi ultimi, con più tempo a disposizione, ed un processo più
articolato, smetterebbero di assecondare gli uffici sulle contestazioni interpretative, cominciando a pronunciare, come genitori lungimiranti, quei “no che aiutano a crescere”,
contribuendo a indirizzare gli uffici verso una serena stima della ricchezza dove le
aziende non arrivano. Si interromperebbe così il suddetto circolo vizioso dove i giudici,
davanti a contestazioni interpretative complicate, dando ragione agli uffici, assecondano
lo spreco di controlli fiscali di cui al par. 5.19.
In questo modo si potrebbe anche aumentare l’interlocuzione diretta col giudice,
con un contraddittorio processuale degno di questo nome, che prevenga gli equivoci
e che, indipendentemente dall’esito della controversia, dia alle parti la soddisfazione di
avere un interlocutore reale, che si sforza a comprendere le loro tesi. La diminuzione
del contenzioso, tendente a “processare meno, processando meglio”, gioverebbe
quindi sia ai giudici, sia agli uffici, sia ai professionisti, sia ai contribuenti. Il rimedio
alle disfunzioni del processo è quindi fuori dal processo, e presuppone adeguate
spiegazioni della determinazione della ricchezza ai fini tributari. Perché una parte non
può funzionare bene, se l’insieme funziona male, come è inevitabile quando non se ne
è capito il meccanismo.
186
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
6.11.Riscossione coattiva ed evasione da riscossione (l’esattore – Equitalia
come diversa autorità amministrativa esattrice delle imposte)
Solo dopo aver determinato la ricchezza, e quindi le imposte, nasce un credito
tributario da riscuotere, ed anche questo passaggio può essere complicato; la ricchezza fiscalmente non registrata potrebbe essere stata spesa, al momento del controllo,
e comunque il fisco potrebbe non rinvenire più elementi patrimoniali su cui soddisfarsi.
C’è un rischio di evasione da riscossione, che non riguarda solo le maggiori
imposte accertate, ma anche quelle dichiarate. Queste ultime potrebbero non essere
versate nei termini indicati al paragrafo 3.6. A prima vista, dichiarare o fatturare senza
versare è un comportamento irragionevole, in quanto sarebbe più conveniente a prima
vista, per chi vuole fare il furbo, non dichiarare affatto.Vedremo subito i motivi per cui
non sempre è così, e si configura una evasione da riscossione anche in questi casi.
Un primo ostacolo è reale, potendo consistere nella mancanza, in capo al contribuente, della liquidità necessaria a versare le imposte su ricchezza registrata.
Una prima causa tecnica di questa difficoltà finanziaria dipende dalla tassazione di ricchezza “non liquida”, né accompagnata da altra ricchezza “liquida”, come vedremo al
paragrafo 7.12, sul momento impositivo.
Ci sono poi le difficoltà finanziarie generali dell’attività produttiva, seguite da
quelle personali del contribuente. Basta pensare a una azienda in crisi di liquidità, senza
credito bancario, e che si trova sprovvista di denaro sufficiente a pagare contributi e ritenute, sul lavoro dipendente, oltre ai salari netti. Lo stesso può riguardare l’IVA, o le stesse
imposte sui redditi, che tanti contribuenti si accorgono di dover pagare, a maggio dell’anno successivo, quando hanno già impiegato le relative risorse finanziarie
in altri aspetti dell’attività produttiva o per consumi personali. Invece di indebitarsi
per pagare le imposte è possibile “indebitarsi con il fisco”, sia dichiarando e non
versando, sia rateizzando i versamenti, in un arco temporale che può giungere ad alcuni
anni, con pagamento di interessi.
È una situazione diversa da quella di chi sin dall’origine progetta di rendersi
inadempiente, per non pagare mai, magari creando società debitrici di comodo,
intestate a prestanome senza nulla da perdere. Qui poi bisogna ulteriormente distinguere varie sfumature da chi vuole semplicemente “ridurre il costo del lavoro”, in
una specie di “evasione di azienda” (paragrafo 3.8) a chi si appropria di quanto necessario a pagare ritenute e contributi, rendendosi insolvente agli occhi dei relativi creditori.
C’è anche chi non vuole versare tributi a fronte di fatture che hanno dato alle controparti i presupposti contabili per effettuare deduzioni e detrazioni: le fatture emesse da
chi non verserà l’IVA e le ritenute danno infatti diritto alle relative detrazioni dell’IVA
e deduzioni dei costi.
A questo scopo si utilizzano società prive di sostanza patrimoniale aggredibile, in
una specie di insolvenza fraudolenta tributaria; quest’ultima è premeditata, e quindi
ancora più insidiosa del comportamento di chi (a posteriori) cerca di occultare i beni
cui l’esecuzione forzata potrebbe dirigersi; quest’ultimo è invece il caso classico, in cui
il contribuente tenta di sottrarsi alla riscossione delle maggiori imposte accertate tra-
Capitolo 6 – SEGUE IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO...
187
sformando i beni in liquidità difficile da individuare, intestandoli a terzi, prestanome o
società interposte.
Di questi comportamenti mancano i presupposti quando si tratta di aziende strutturate, con un avviamento molto personalizzato o con una clientela esigente, e
quindi una immagine da rispettare. Quando invece la clientela è interessata soprattutto
“al prezzo”, come nella distribuzione all’ingrosso, nei servizi logistici, l’organizzazione
non è molto sofisticata, i suoi effettivi titolari non sono particolarmente riconoscibili
ed è possibile trasferire il contenuto societario, dipendenti compresi, in altre società
destinate a fare la stessa fine. Questa tendenza alle “organizzazioni fantasma” è agevolata,
oltre che dal noto scarso controllo del territorio da parte del fisco, anche da un regime
estremamente lassista di costituzione delle società e di rilascio della partita IVA.
Per fronteggiare questi comportamenti, il fisco, dopo aver “visto la ricchezza con gli
occhi delle aziende”, utilizza un organo ancora diverso, pur sempre di proprietà
pubblica, per la riscossione: mi riferisco all’Agente della riscossione “Equitalia spa”, o
semplicemente “esattore”, come lo chiameremo nel prosieguo. In Italia infatti, l’autonomia del citato “agente della riscossione” conferma la tendenza alla frammentazione,
moltiplicazione e perpetuazione delle istituzioni; gli antichi esattori avevano infatti
una funzione finanziaria, in quanto anticipavano le imposte per poi rivalersi sui
contribuenti, con poteri autoritativi delegati dallo stato. Nella tassazione attraverso le
aziende “l’esattore” era del tutto ingiustificato, ma con varie trasformazioni si è perpetuato, sotto il nome di “agente” per la riscossione, all’interno di una società (la suddetta
Equitalia spa) controllata pariteticamente dall’agenzia delle entrate e dall’INPS.
Anche Equitalia ha dei costi di struttura, che potrebbero ricadere sulla fiscalità generale, dove chi non evade verrebbe gravato di costi generati da chi evade. Per questo si
è cercato di imputare tali costi ai debitori delle somme iscritte a ruolo, con una remunerazione obbligatoria percentuale, fissata normativamente, e denominata “aggio
esattoriale”. La sua misura è determinata in relazione all’andamento dei costi per la
riscossione, e non è insignificante in quanto può andare all’incirca dal 5 al 9 percento
delle somme richieste. Si potrebbe persino ipotizzare una natura tributaria di questo
pagamento, ma è il caso di rinviare ad altri approfondimenti su questo tema.
Anche se Equitalia è sostanzialmente incardinata nel sistema degli enti pubblici,
restano tuttavia i consueti rischi italiani di scoordinamento tra strutture pubbliche soggettivamente diverse. Anche all’interno dello stesso ente ci sarebbe una divisione funzionale tra chi si occupa della determinazione della ricchezza, con relativo contenzioso,
e chi si occupa della riscossione. L’importante è che la diversità soggettiva non renda più
difficile il coordinamento tra enti impositori ed esattori, contro la già indicata «evasione
da riscossione».
I rischi sulla solvibilità del contribuente sono più facilmente valutabili dall’ufficio che lo ha conosciuto, avendone determinato la ricchezza; queste informazioni
dovrebbero essere condivise con l’esattore, per aiutare la sua valutazione dei rischi di
solvibilità. Lo scoordinamento tra Equitalia ed enti impositori comporta 1) in precauzioni inutili e invasive verso contribuenti solvibili, a fronte di crediti fiscali contestati; 2) difetti di vigilanza e di indagini verso situazioni di elevata pericolosità per
188
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
la riscossione. Nel complesso, l’impostazione aziendalistica di Equitalia ha portato
ad una maggiore efficienza della riscossione coattiva. È stato frequente l’utilizzo di
poteri parasanzionatori, come il fermo della circolazione dei veicoli (“ganasce fiscali”)
e l’iscrizione di ipoteche su immobili, in caso di mancato pagamento.
In tutti questi casi, in cui è aggredibile un patrimonio individuato, come immobili
o autovetture, crediti verso amministrazioni pubbliche o banche, Equitalia è stata molto
efficiente.
Fino al punto di essere accusata di accanimento vessatorio, con campagne mediatiche, ed anche con riflessi terroristici contro gli uffici della società. È un riflesso del
malessere collettivo dell’opinione pubblica in materia tributaria, dove non ci si rende
conto che funzionari sostanzialmente pubblici non hanno motivo di essere vessatori, né
convenienze personali ad accanirsi verso i debitori.
Il problema, piuttosto, sono le solite rigidità e deresponsabilizzazioni, i meccanicismi
procedurali, con difficoltà a valutare le singole situazioni di solvibilità fiscale e fragilità
economica. Il timore “auto protettivo” di essere accusati di favoritismi o negligenze,
così come ostacola la valutazione della ricchezza non registrata, riemerge verso la valutazione delle prospettive di solvibilità dei debitori, con la ritrosia verso l’inevitabile
assunzione di responsabilità (parola terribile!) che essa comporta.Vi si aggiungono le già
indicate difficoltà di coordinamento tra esattore ed enti impositori, che rendono frequente la riscossione di crediti già pagati, prescritti, etc, senza cattiva volontà, ma solo
per sfasamenti nella gestione delle informazioni, dovuti al numero elevatissimo di
pratiche; la serialità viene scambiata per vessatorietà, trasformando Equitalia in
un capro espiatorio dei malesseri tributari diffusi.
È una confusione di cui si avvantaggiano gli insolventi di professione, più accorti e
previdenti, rischiando di vanificare gli ampi poteri di indagine, per la ricerca di beni da
espropriare, concessi all’esattore.
A quest’ultimo in buona sostanza sono concessi gli stessi poteri degli uffici tributari.
Ad esempio è concesso di indagare nel sistema dell’anagrafe tributaria, e di esercitare
altri poteri investigativi corrispondenti a quelli degli uffici. Sono stati aggiunti anche il
potere di indagare sui conti bancari, e l’obbligo per gli enti pubblici debitori di imposta, prima di pagare forniture, di verificare che il beneficiario del pagamento non abbia
debiti verso Equitalia.
Andrebbe verificato con quale frequenza questi poteri sono efficacemente esercitati.
Specie nei casi in cui il “debitore d’imposta” non è neppure ben identificato, in quanto si fa scudo di una girandola di società-schermo, con amministratori prestanome; il
relativo organizzatore, come un “burattinaio”, emette fatture del tutto fittizie, oppure
canalizza prestazioni economiche effettive, rese da fornitori terzi, senza versare IVA,
contributi e ritenute, ma dando diritto a detrazioni o crediti per imposte mai versate.
Non si tratta di una attività economica, ma di una attività interamente truffaldina, dove
Equitalia ben potrebbe surrogarsi in via amministrativa nei crediti delle società schermo
verso il relativo amministratore di fatto, per le somme da lui indebitamente sottratte,
rendendo le società fiscalmente insolventi.
Veniamo ora alla procedura di riscossione coattiva, dove si mescolano il diritto
Capitolo 6 – SEGUE IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO...
189
amministrativo e il diritto civile. L’esattore (Equitalia) riceve elenchi formati dagli
uffici tributari (c.d. “ruoli”) e notifica a ciascun contribuente ivi indicato una cartella di pagamento, cioè quella parte del ruolo che lo riguarda.
Dopo la scadenza del termine per il pagamento del ruolo, l’esattore non ha
bisogno di notificare alcun ulteriore atto di intimazione per procedere con l’esecuzione coattiva. Quest’ultima può addirittura iniziare anche senza iscrizione a ruolo, in
presenza del c.d. “accertamento esecutivo” di cui diremo al prossimo paragrafo, e dove
l’esecuzione coattiva non è preceduta dal ruolo..
La procedura esecutiva esattoriale ricalca quella civilistica, per pignorare beni
del debitore e convertirli in denaro, vendendoli all’asta, soddisfacendo col ricavato il credito tributario nonché altri eventuali creditori (muniti di titolo esecutivo)
intervenuti nella procedura. Queste operazioni, simili a quelle dell’esecuzione ordinaria,
sono svolte però da ufficiali esattoriali sotto la vigilanza del giudice dell’esecuzione,
cui sono demandate le contestazioni che possono sorgere, nelle fasi di pignoramento
e vendita dei beni. Per tutti questi aspetti, se non direttamente disciplinati dalla norma
fiscale, si fa riferimento alla parte del codice di procedura civile dedicata al «processo di
esecuzione» (art. 49 del d.P.R. n. 602/1973).
Gli accordi concernenti la determinazione della ricchezza ai fini tributari, indicati
al par. 6.5, non sono estensibili alla diversa ipotesi in cui il contribuente sia sprovvisto
delle risorse per pagare una imposta ormai già determinata. Sono ammissibili in questo
caso piani di decurtazione e rateazione del debito tributario, denominati “transazione
fiscale”, da svolgere secondo le procedure del diritto fallimentare, in genere sotto la
sorveglianza del magistrato competente, e previa verifica dell’esistenza di altri creditori,
che devono poter partecipare alle decisioni. Proprio la presenza di tali creditori “terzi”,
induce qui a trattare l’amministrazione fiscale come un qualsiasi soggetto privato creditore, in modo da non ledere la “par condicio” dei creditori. L’inserimento di questi
accordi col fisco nel quadro delle procedure concorsuali finisce però per escluderli
per i contribuenti che non falliscono, come privati o enti non commerciali. Inoltre,
spesso, quando Equitalia è l’unico creditore e non c’è problema di “par condicio” dei
creditori, la necessità di avventurarsi nelle procedure fallimentari complica ulteriormente la riscossione dei crediti erariali.
6.12.La “sicurezza della riscossione” e la sua celerità in pendenza di ricorso
Nella tradizionale tassazione valutativa, quando il gettito dipendeva direttamente dall’attività degli uffici (paragrafo 1.3), la celere riscossione delle imposte
accertate era fondamentale. Oggi invece, come rilevato in tutto il volume (par. 5.7),
le entrate conseguenti all’attività di controllo sono insignificanti rispetto al gettito
“autoliquidato”, ed è più importante la “sicura riscossione” rispetto alla “pronta riscossione”.
Ancora oggi, tuttavia, il ricorso del contribuente contro l’atto impositivo
non ferma la riscossione, che procede in attesa della sentenza del giudice, con le
190
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
seguenti riduzioni per le somme dovute in base ad avvisi di accertamento. Le imposte
risultanti da atti di accertamento impugnati devono essere infatti versate per un terzo
in caso di ricorso, fino alla sentenza di primo grado, e salvo che il giudice accordi la
sospensione cautelare di cui diremo.
La somma da pagare viene poi conguagliata rispetto alle sentenze “di merito”
del giudice, ancorché impugnate, con successivi ricalcoli man mano che il giudizio
procede (art. 68, d.lgs. n. 546/1992).
Le sanzioni connesse a tali imposte sono riscosse dopo la sentenza di primo grado,
nello stesso ammontare previsto per la riscossione del tributo.
Il ricorso contro il ruolo, primo atto impositivo per le somme dichiarate e non
versate, oppure dovute a seguito dei controlli formali della dichiarazione, indicati al par.
5.5, non comporta alcuna sospensione automatica della riscossione, neppure
parziale; chi vuole sospendere il pagamento in attesa della sentenza deve richiederlo
in via amministrativa o giurisdizionale, come diremo subito per l’“accertamento esecutivo”.
Tradizionalmente, per la riscossione provvisoria occorreva un’iscrizione a ruolo, che
si aggiungeva al precedente atto di accertamento, con una inutile duplicazione, eliminata a partire dal 2012, col c.d. accertamento “esecutivo”. In base a quest’ultimo
il contribuente deve pagare di propria iniziativa, o chiedere al giudice la sospensione
dell’efficacia dell’atto impugnato, altrimenti scatterà, senza bisogno di ulteriori intimazioni, la riscossione coattiva da parte di Equitalia.
I suddetti pagamenti provvisori, in pendenza di ricorso, espongono il contribuente
alla anticipazione finanziaria, spesso gravosa, di somme che al termine del processo
potrebbero dovergli essere restituite. È il già indicato “solve et repete”, eredità della
tassazione attraverso gli uffici, quando il gettito affluiva in questo modo; il criterio è
però del tutto ingiustificato nella tassazione attraverso le aziende e nell’autotassazione.
In questi contesti, piuttosto, è importante la “certezza della riscossione”, alla fine del
processo, in modo da riscuotere l’imposta effettivamente dovuta. Invece di affannarsi
per riscuotere una quota del tributo prima che la sua procedura di determinazione si
esaurisca, ci si dovrebbe assicurare di riscuotere in prospettiva il dovuto. A questo punto
si potrebbe tranquillamente differire l’incasso al termine dell’iter contenzioso. L’anticipazione della riscossione è, invece, del tutto inutile, uno dei tanti relitti del passato
che si trascinano per forza d’inerzia. Ingenti risorse, soprattutto umane, che potrebbero
dedicarsi alla ricerca della ricchezza non registrata, si logorano invece nel “vai e vieni”
di riscossioni e restituzioni provvisorie, nonché nelle “sospensioni” (amministrative e
giurisdizionali) di cui diremo subito.
Un primo rimedio, già anticipato, contro la riscossione provvisoria in pendenza di
ricorso, è la possibilità delle commissioni tributarie provinciali di sospendere la
riscossione prima di decidere la causa (art. 47 del decreto sul contenzioso tributario); a
tal fine le commissioni devono valutare il pericolo di danno «grave ed irreparabile» (c.d.
periculum in mora), ivi compreso il danno economico, quando l’anticipazione sottragga
le risorse necessarie al proseguimento dell’attività produttiva e magari esponga al rischio
di fallimento, o di dover svendere beni per un prezzo irrisorio. Questi rischi vanno
Capitolo 6 – SEGUE IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO...
191
valutati alla luce delle probabilità d’accoglimento del ricorso (il c.d. fumus boni
iuris), con la possibilità di subordinare la sospensione a idonea garanzia, in un giudizio
discrezionale in senso proprio (par. 5.10), in quanto vengono contemperati interessi
diversi (non è una eccezione, ma una soluzione tipica per tutte le decisioni cautelari).
La sospensione suddetta opera fino alla sentenza di primo grado, ma si stanno aprendo spiragli ad una sospensione dell’atto impugnato anche da parte del giudice di appello, dopo che quello di primo grado ha respinto il ricorso del contribuente. Ci sono
margini persino per la sospensione dopo la sentenza di appello, quando il processo pende in cassazione. Non mi dilungo su tecnicismi di rinvio al codice di procedura civile,
sulle richieste di cauzione e sulle argomentazioni con cui il diritto vivente riflette sul
tema. Le istituzioni giurisdizionali sembrano però rendersi conto di quanto rilevavamo
sopra, cioè che, nella tassazione attraverso le aziende, le imposte riscosse coattivamente
in pendenza di ricorso sono irrilevanti rispetto alla stabilità e continuità del gettito erariale, ormai proveniente da altre fonti.
È quindi logico concedere al giudice, abilitato ad annullare l’atto, anche il potere
di sospenderne l’esecuzione; per il fisco, insomma, come sopra rilevato, è più importante la riscossione “sicura”, al termine del contenzioso, che la riscossione “celere”,
mentre il contenzioso è in atto.
Ovviamente, a questa sospensione giurisdizionale, si affiancano sempre, vista la matrice amministrativistica della nostra materia, le possibilità di sospensione amministrativa, per motivi eccezionali, cui fa riferimento l’art. 19 del decreto n. 602, e di rateazione,
prevista sia per somme definitivamente dovute, sia per somme ancora in contestazione,
ma per le quali la sospensione sia stata negata. La riscossione provvisoria, così come
sopra descritta, è un ramo secco sul piano logico, rispetto alle già indicate esigenze di
riscossione sicura, dove il vero “periculum in mora” ripetiamo è che il fisco non abbia
più beni su cui soddisfarsi al termine del contenzioso. A questo del resto mira l’anticipazione della riscossione mediante il c.d. “ruolo straordinario”, che consente al fisco
di mettere in riscossione l’intero importo per la cui esazione, in prospettiva, sussista
il suddetto “fondato pericolo”. Quest’ultimo va inteso come rischio che il contribuente
approfitti dei tempi tecnici del processo per nascondere i beni su cui il fisco, una volta
vittorioso, potrebbe soddisfarsi. Evitato questo rischio, non c’è motivo per anticipare la
riscossione rispetto alla definizione della controversia, esattamente come accade per il
contribuente che agisce in un processo di rimborso.
6.13.Impossibilità di rimpiazzare con inasprimenti sanzionatori l’insufficienza dei controlli 1) le sanzioni amministrative
Nella fiscalità preindustriale, le sanzioni punitive, anche molto gravi (di solito
criminali) si dirigevano prevalentemente a resistenze attive ai funzionari del fisco,
oppure tentativi di frode, ad esempio attraverso il contrabbando (vero e proprio
reato a fronte del quale, secoli or sono, venne creata negli stati Sabaudi la Guardia
di Finanza). Oggi, finché sono le aziende a determinare contabilmente la ricchezza,
192
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
non servono sanzioni perché le aziende, secondo un filo conduttore del testo, non
hanno bisogno di nascondere ricchezza al fisco, incorrendo tutt’al più nell’evasione interpretativa di cui ai parr.3.10 ss..Le sanzioni servono nell’autotassazione
dove le aziende non arrivano, e sono in ballo individui, con bisogni personali. Se
mancassero sanzioni, cioè se il fisco recuperasse, in sede di controllo, solo l’imposta
e gli interessi, gli individui tenderebbero a restare inerti, sperando di non ricevere
alcuna richiesta degli uffici.
Tuttavia, anche nell’“autotassazione”, le sanzioni non possono controbilanciare l’insufficienza degli interventi valutativi degli uffici nella richiesta delle imposte,
ed il carente controllo del territorio (paragrafo 3.14-5.13).
Dopo quanto indicato sulle cause della mancata registrazione della ricchezza ai fini
tributari sono chiare tanto l’importanza delle sanzioni quanto l’inutilità di inasprimenti sanzionatori come surrogato della richiesta delle imposte dove le aziende non arrivano. Puntare troppo sulle sanzioni creerebbe un sistema irrazionale, in cui
tutti evadono, in modo diversamente grave, ma la pena non dipende dall’insidiosità del
comportamento, bensì dalla casualità di essere individuati. Si creerebbe un sistema
kafkiano, in cui tutto è sanzionato, ma è punito solo qualche malcapitato, senza che
gli altri modifichino il loro comportamento. Un’idea dove gli uffici non si vedono
mai, e passano a caso dopo anni, controbilanciando la loro assenza con sanzioni feroci
su pochi malcapitati è una delle sindromi demenziali dell’idea di onnipotenza legislativa. Che trasforma i contribuenti sanzionati in vittime casuali, screditando l’azione
amministrativa, degradata in una specie di lotteria, dove la punizione perde autorevolezza, non dipendendo più dalla gravità oggettiva del fatto, ma dalla casualità del
suo accertamento. Su queste premesse la sanzione diventa rapidamente odiosa e controproducente perché la punizione arriva non preceduta da una richiesta, o peggio ancora
preceduta da una richiesta velleitaria, effettuata con la gazzetta ufficiale, come grida di
manzoniana memoria. Il vecchio motto, “colpirne uno per educarne cento”, poteva forse andar bene per fantomatici nemici del proletariato, ma non per il rapporto
tributario degli operatori economici di un paese moderno. Sostituire la sistematicità
dell’azione amministrativa con una ferocia rara e casuale è addirittura controproducente, ostacolando lo strumento sanzionatorio anche nei (rari) casi di particolare gravità, in
cui potrebbe essere effettivamente utile.
La sanzione va invece inserita in un circolo virtuoso in cui l’ufficio tributario “si
fa vedere”, il potere appare “effettivo”, diligente, presidia il territorio, si guadagna credito con la autorevolezza della propria azione, sa individuare i comportamenti
insidiosi e finalmente sanzionarli come meritano. Su questo sfondo di efficienza, le
devianze gravi possono essere punite con durezza, come avviene negli Stati Uniti, dove
la sanzione penale è l’estrema reazione di un sistema di determinazione tributaristica
della ricchezza ben funzionante.
L’attento monitoraggio amministrativo, complementare alla tassazione attraverso le aziende, indicato al par. 5.7, consente di individuare i comportamenti più
spregiudicati e sanzionarli come meritano. Se invece si sanziona chi capita, si ottiene
l’effetto contrario, delegittimando l’amministrazione.
Capitolo 6 – SEGUE IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO...
193
Nella nostra materia, finalizzata alla determinazione della ricchezza, quest’ultima indirettamente indica anche la misura massima della sanzione; il limite tendenziale
è quello secondo cui imposte e sanzioni devono trovare spazio nella ricchezza
tributariamente non registrata; oltre questo limite si perde il contatto con la ricchezza non registrata e si aggrediscono altre forme di ricchezza del contribuente, che
tra l’altro potrebbero mancare. Questo vincolo si attenua per tributi economicamente
poco significativi, dove il resto del patrimonio del contribuente è comunque di norma “capiente”, o dove occorre reprimere evasioni altamente insidiose. Per chi registra
due volte una fattura, per chi interpone una propria società fittizia avrebbe senso una
sanzione anche più elevata della ricchezza non registrata, proprio perché quest’ultima
si dimostra adeguatamente capiente ed il comportamento non è puramente omissivo,
ma più insidioso.
La matrice amministrativistica del diritto tributario si ritrova nell’irrogazione
delle sanzioni con atti autoritativi suscettibili di diventare definitivi se non impugnati, come quelli di applicazione del tributo (par. 6.1).
Anche per il diritto tributario valgono le regole garantistiche secondo cui le sanzioni devono essere in astratto previste dalla legge, nel rispetto sia della riserva
di legge di cui all’art. 23 (par. 2.1) sia di quella in materia di punizioni (art. 25 della
costituzione).
La particolarità delle sanzioni amministrative tributarie è la proporzionalità rispetto al tributo non dichiarato o non versato, di solito prevista tra un minimo e un
massimo, in percentuale, del tributo medesimo. Per le imposte sui redditi e l’IVA l’ordine di grandezza tipico delle sanzioni è da una a due volte l’imposta, ed è riducibile in
base agli strumenti “adesivi” (di contenzioso amministrativo) indicati ai precedenti paragrafi 6.4-6.5 (acquiescenza, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, etc.).
Si tende in questo modo ad adeguarsi al vantaggio economico connesso all’illecito; è un
obiettivo non perseguibile in altre tipologie di violazioni amministrative.
Massimi e minimi prestabiliti, in cifra assoluta e non percentuali, sussistono invece
per le violazioni di obblighi formali, indipendenti da una evasione (dall’omessa
effettuazione di una comunicazione, all’omessa risposta alle richieste di informazioni
del fisco, etc.).
Entro i suddetti limiti, assoluti o percentuali al tributo, l’ufficio finanziario dovrebbe
determinare la pena da infliggere nel caso concreto, valutando alcuni parametri come la gravità della violazione, la personalità del reo, le violazioni commesse in
anni precedenti etc.; è comunque possibile il sindacato giurisdizionale su applicazioni
della pena in misura eccessiva rispetto alle circostanze del caso specifico, secondo i classici criteri del controllo giurisdizionale di anomalie, irragionevolezze e altre patologie
dell’azione amministrativa.
La suddetta determinazione personalizzata della sanzione si scontra con la
solita ritrosia degli uffici tributari verso le valutazioni dei casi concreti, e con la
loro preferenza per gli automatismi legalistici. Al di là delle stereotipe formule legislative
sulla determinazione delle sanzioni tra massimi e minimi, c’è quindi un notevole meccanicismo, con le rigidità di cui diremo subito.
194
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
L’applicazione concreta delle sanzioni tende a non distinguere tra “maggiore imposta accertata” per ricchezza non registrata ovvero contestazioni interpretative; si rischiano quindi deficit punitivi nel primo caso, ed eccessi nel secondo.
L’applicazione di sanzioni a fronte di maggiori imposte accertate su questioni di diritto (cioè su ricchezza registrata o comunque palese) è escludibile, per simili questioni
interpretative, quando la loro applicazione al caso in esame è obiettivamente incerta
(questo principio di ragionevolezza è oggi contenuto nell’art. 6 comma 2 decreto 4721997).
Una chiave di lettura sistematica è la distinzione tra sanzioni per omesso versamento di imposte determinate correttamente o con errori formali, facilmente rilevabili, ed imposte determinate in modo insufficiente, vuoi per ricchezza non
registrata o per erroneo inquadramento giuridico di ricchezza registrata (contestazioni interpretative, par. 3.10). La prima tipologia di sanzioni è meno grave, sanzionata con la pena pecuniaria del 30 percento dell’imposta non versata, come
indicato al par. 3.6 (art. 13 del d.lgs. n. 472/1997).
In generale, quando si tratta di sanzioni collegate al tributo, cioè comminate per l’infedele autodeterminazione da parte del contribuente, la loro irrogazione avviene con
lo stesso atto impositivo con cui viene richiesto il tributo, e quindi un avviso di
accertamento o un’iscrizione a ruolo (art. 17, D.lgs. n. 472); tale atto deve essere motivato a pena di nullità, anche in relazione ai criteri di individuazione della violazione e
di determinazione della sanzione.
Quando si tratta di sanzioni non collegate al tributo gli uffici devono notificare uno
specifico atto motivato di contestazione della violazione, che indichi i fatti attribuiti al
trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate e i criteri seguiti dall’ufficio per
determinare la sanzione (art. 16 del d.lgs. n. 472/1997). Il destinatario può estinguere la
violazione pagando un quarto della sanzione inflitta, ovvero presentare deduzioni difensive su cui l’ufficio, se intende insistere, deve motivare un successivo atto di irrogazione
di sanzioni. In assenza di definizione o deduzioni all’ufficio, l’atto di contestazione si
considera automaticamente atto di irrogazione di sanzioni, impugnabile di fronte alle
commissioni tributarie (segnaliamo la particolarità di un atto amministrativo mutevole,
a seconda delle reazioni del destinatario, ma non si tratta certo di un aspetto strutturale
della tassazione).
Su questo scenario si inseriscono le riduzioni delle sanzioni per acquiescenza
agli atti impositivi: può trattarsi dei verbali di constatazione (par. 5.6) con riduzione a un
sesto del minimo, delle richieste dell’ufficio precedute da verbale o dell’accertamento
con adesione (con riduzione inizialmente a un quarto del minimo, poi a una percentuale superiore), fino alla conciliazione giudiziale (procedure trattate al par. 6.4). Qualora
l’imposta dovuta sia calcolata in modo corretto, o addirittura sia sottostimata rispetto
all’evasione effettiva, queste indiscriminate riduzioni possono rendere conveniente, considerata la scarsa probabilità di accertamento, un qualche maggior rischio fiscale. D’altra
parte, tali riduzioni possono essere insufficienti per le contestazioni “interpretative”, o
dove manca un sostanziale danno erariale; le economie amministrative connesse alla
acquiescenza non dovrebbero rendere conveniente l’occultamento degli imponibili,
Capitolo 6 – SEGUE IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO...
195
confidando comunque sulla bassa probabilità di accertamento. Rinviamo invece al par.
3.6 sulla riduzione delle sanzioni in caso di c.d “ravvedimento” unilaterale del contribuente, prima dei controlli (e quindi prima dell’esercizio del potere amministrativo).
Le società o enti con personalità giuridica rispondono in proprio delle violazioni
amministrative tributarie, senza coinvolgimento dei rappresentanti, che invece possono
essere chiamati a risponderne per le società personali e gli enti senza personalità giuridica; anche chi coopera in violazioni commesse da altri, essendone stato ad esempio
l’istigatore, il consigliere o il partecipe, può essere chiamato a risponderne a titolo di
concorso, ivi compreso il professionista (art. 9 del decreto n. 472/1997).
Una differenza tra sanzioni «risarcitorie» e «punitive» riguarda la non trasmissibilità agli eredi delle seconde, sancita anche dall’art. 8 del decreto n. 472/1997.
Quando un unico comportamento, anche ripetuto nel tempo, dia luogo a più violazioni, viene attenuato il cumulo materiale delle sanzioni, per evitare che una violazione
lieve, ripetuta tante volte, sia punita più severamente di violazioni molto più gravi. Si
passa quindi dal cumulo materiale al “cumulo giuridico”, con una sanzione
unica basata su un aumento della sanzione per la violazione più grave (art. 12 comma 1
d.lgs. 472); tale principio si applica anche quando il fatto riguarda tributi diversi, ipotesi
frequente per omessa dichiarazione di corrispettivi ai fini delle imposte sui redditi e
dell’IVA, anche per più periodi di imposta.
6.14.Segue: 2 Il confuso palliativo penaltributario tra mancata registrazione della ricchezza e contestazioni interpretative
La matrice amministrativistica della tassazione, filo conduttore del testo, trova le sue
conferme anche in materia penale-tributaria. La repressione penale di gravi devianze
economico-finanziarie appartiene alla tradizione, già dai tempi dell’ostruzionismo
violento (sedizione fiscale), del contrabbando, del conio di monete false, per cui era
in genere prevista, fino alla rivoluzione francese, persino la pena di morte.
In materia tributaria, però, per molti secoli, vista la struttura della tassazione (paragrafo 1.2), basata sull’iniziativa dei pubblici uffici, non c’era bisogno di punire, ma
era sufficiente “chiedere” e se del caso “prendere”, salvo punire intensamente
devianze palesi, come la già citata resistenza ai funzionari del fisco.
L’importanza delle sanzioni, nella tassazione attraverso le aziende e nell’autotassazione, crea spazi anche per la repressione penale; già le ordinarie sanzioni penali, in materia
di falso e di truffa, potrebbero essere usate per reprimere molti comportamenti di forte
insidiosità, soprattutto quelli descritti al par. 3.7 per la ricchezza non registrata dagli
imprenditori attraverso le aziende. Sulla ricchezza nascosta al fisco dai titolari di
aziende, scavalcando le relative procedure amministrative nei modi indicati al par. 3.7
ci sarebbero i presupposti per applicare reati comuni come falso (a seconda
dei casi materiale o ideologico), oppure truffa ai danni dello stato; anche senza applicare
meccanicamente queste disposizioni, sarebbe facile mantenerle come cornice, personalizzandole poi al contesto amministrativistico della tassazione.
196
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
Per la ricchezza che invece sfugge alla determinazione contabile attraverso le aziende, principalmente da parte di lavoratori indipendenti, non ci sono procedure amministrative “scavalcate” per nascondere ricchezza al fisco, e quindi hanno più senso
reati tributari specifici, per comportamenti sostanzialmente “omissivi”, cioè
incassare soldi non registrati fiscalmente.
In entrambi i casi comunque vale, a maggior ragione, quanto rilevato al paragrafo
precedente per le sanzioni amministrative, cioè l’impossibilità della punizione di sostituire, a pena di crisi di rigetto, un intervento adeguatamente sistematico degli uffici
tributari. Insomma, anche la punizione penale, in certi casi aiuta, ma non sostituisce un
intervento adeguatamente sistematico degli uffici.
I disorientamenti e le schizofrenie sociali di cui al capitolo quarto hanno dato
luogo ad apparati sanzionatori penal-tributari insoddisfacenti e quindi instabili
nel tempo. Mettiamo però qualche punto fermo, secondo cui l’esistenza di disposizioni penali tributarie ha ostacolato l’applicazione dei reati comuni anche per quei
tributi cui le sanzioni penali tributarie erano inapplicabili. Il diritto penale tributario
è infatti riferito esclusivamente alle imposte sui redditi e all’IVA, dove si inserisce buona parte della tassazione attraverso le aziende. Sanzioni specifiche tradizionali
restano da sempre per i reati di contrabbando in materia doganale (par. 10.6 ss.).
Le violazioni in materia di imposte dirette e di IVA sono contenute nel d.lgs. n.
74/2000, che prevede oggi esclusivamente delitti punibili a titolo di dolo specifico, cioè al fine di evadere determinate imposte. C’è una rilevanza dei documenti fittizi,
emessi o ricevuti, che spesso sono prodromici alla “dichiarazione infedele”. Quest’ultima è punita, indipendentemente dall’importo evaso, quando si basa su documenti
alterati o fittizi (art. 2), ed oltre soglie di ammontare relativamente modesto quando
si basa su artifici diversi dal documento fittizio (art. 3), mentre è punita oltre soglie di
ammontare elevato nelle altre ipotesi (art. 4).
È inutile dilungarsi sui dettagli di una disciplina penal tributaria che, in assenza di
spiegazioni generali della tassazione attraverso le aziende, presenterà sempre squilibri,
cioè eccessi e deficit punitivi. La normativa attuale è meno consapevole, rispetto
alla precedente (in vigore dal 1982 al 2000) della distinzione tra “mancata registrazione
della ricchezza” ed “evasione interpretativa” (par. 3.9 e 3.10). Fino al 2000, per una serie di circostanze fortunate, il riferimento penale era alla mancata registrazione
di ricchezza nelle scritture contabili, definito erroneamente come comportamento
“prodromico”, come se ci fosse qualcuno che prima non registra gli incassi e poi, come
Saulo sulla via di Damasco, “si pente” e li inserisce in dichiarazione.
La riforma del 2000 intendeva dirigersi a fattispecie più “serie” identificate con la
falsità dei documenti e la quantità di imposta “evasa”, ma le sue intenzioni si sono
realizzate in modo formalistico, vista la mancanza di familiarità con la tassazione attraverso le aziende. Facendo riferimento alla “maggiore imposta dovuta” spesso infatti
si criminalizzano situazioni irrilevanti o innocue (evasione interpretativa),
senza incidere su quelle più insidiose.
La mancanza di soglie di punibilità sulle contraffazioni o alterazioni di documenti
porta alla teorica punizione di violazioni assolutamente trascurabili, ad esempio sulle
Capitolo 6 – SEGUE IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO...
197
carte carburanti, le ricevute taxi o le note spese dei dipendenti. Si è dimenticato che le
fatture sono documenti aziendali (par. 3.5) che in assenza di organizzazione è facilissimo
manipolare, e che la vera garanzia per il fisco è la rigidità delle strutture amministrative.
Le soglie comunque elevate di punibilità per le omissioni comportano invece
la mancata punizione anche di chi emette fatture per decine di migliaia di euro e poi
“dimentica” di registrarle, confidando nella loro difficile individuazione in sede di controllo.
Gli equivoci maggiori sono però legati alla mancata distinzione tra “maggiore
imposta accertata” e “ricchezza non registrata”, tra occultamento di imponibile
ed “evasione interpretativa”. Il reato di infedele dichiarazione accomuna la ricchezza
nascosta al regime giuridico di quella dichiarata, come detto al paragrafo 3.9, finendo
per contribuire a inutili drammatizzazioni e tensioni proprio sulle aziende (par. 5.19);
le situazioni penalmente rilevanti sono quindi potenzialmente addirittura aumentate
per la grande impresa, con intromissioni in sofisticate questioni di fiscalità specialistica
sul regime giuridico di vicende comunque rappresentate nei documenti, nei conti, nei
bilanci e nelle dichiarazioni. Solo la necessità del dolo specifico mette al riparo
da sanzioni penali chi abbia fatto affidamento su soluzioni giuridico interpretative
dotate di una certa fondatezza; l’esito dipende però dalla sensibilità e disponibilità del
giudice penale, tipico uomo di legge, ad avventurarsi sul diritto tributario sostanziale della tassazione attraverso le aziende. L’adozione consapevole, in base a
riflessioni e studi, di un regime fiscale poi contestato dall’Ufficio, è però diversa dal
“fine di evadere le imposte”; il fine era infatti solo quello di qualificare la ricchezza
nel modo al tempo stesso più corretto e fiscalmente conveniente. Ignorando questo
punto di vista, spesso attoniti amministratori delegati di società multinazionali si sono trovati sotto inchiesta penale per questioni di puro diritto, di cui
era stata loro assicurata la totale legittimità dai più stimati professionisti e
studiosi. Comunque i procuratori della repubblica, in genere persone di buonsenso, prive di condizionamenti gerarchici (e quindi in grado di decidere e assumersi
le proprie responsabilità), sanno gestire le situazioni, valorizzando nell’insieme le
differenze tra evasione interpretativa e ricchezza non registrata. L’impatto negativo sulle
aziende di queste estemporanee contestazioni, dove nulla è stato nascosto, contribuisce
notevolmente alla fuga delle aziende dall’Italia, come indicato al par. 5.19. Persino sulla
ricchezza non registrata, del testo, l’interesse generale è avere le imposte pagate e
le fabbriche aperte, non imprenditori in carcere e fabbriche chiuse.
Il rapporto penale alla Procura della Repubblica è comunque un inevitabile
strascico, una volta superate le soglie di punibilità, dei rilievi fiscali sul regime giuridico del dichiarato, indicati al par. 3.10. Si tratta infatti, come noto, di reati perseguibili
d’ufficio, e non a querela, come è abbastanza ovvio nel nostro sistema.
A proposito dell’evasione da riscossione (paragrafo 6.11) il decreto legislativo 74
puniva originariamente solo chi “occultava” il patrimonio per sottrarlo all’esecuzione
forzata; veniva irragionevolmente sottratto alle sanzioni penali chi fin dall’origine, attraverso aziende prive di consistenza patrimoniale, svolgeva prestazioni reali tramite le
strutture di terzi, addebitava IVA, ritenute e contributi senza avere l’intenzione di ver-
198
Parte prima – Determinazione tributaristica della ricchezza tra istituzioni, aziende e individui
sarle. Le norme correttive introdotte successivamente hanno però inconsapevolmente criminalizzato tutti i tardivi versamenti, compresi quelli svolti da aziende con
sostanza economica, in semplice difficoltà finanziaria, e senza alcuna intenzione di
rendersi nullatenenti. Sono nati quindi orientamenti giurisprudenziali tesi a distinguere,
in modo abbastanza confusionario, queste due ipotesi, escludendo le sanzioni penali per
chi vuole solo “finanziarsi a carico dello stato” (par. 6.12) senza rendersi definitivamente
inadempiente.
Infatti, di principio, la sanzione penale è autonoma rispetto ad istituti tributari, come accertamento con adesione o conciliazione giudiziale (par. 6.4),
per cui è previsto solo un dimezzamento di pena e non la sua totale eliminazione.
La disciplina penaltributaria sopra descritta segue ovviamente i criteri generali del
diritto penale, quanto a identificazione del reato in base alla pena, alla dialettica
tra pubblico ministero e giudice, all’irretroattività ed all’applicazione della legge
successiva più favorevole al reo, al concorso di reati ed alla punibilità del rappresentante delle persone giuridiche, al rapporto tra giudicato penale e processo tributario; in quest’ultima sede non c’è alcuna automatica valenza di prova legale di quanto
accertato in sede penale, che comunque il giudice può tenere in considerazione nella
formazione del proprio convincimento.
Il sistema penaltributario non può che risentire di tutti gli inconvenienti di quello
tributario, e della mancata sistematizzazione della tassazione attraverso le aziende. Le
sdrammatizzazioni dottrinali di cui al par. 4.7 sono un presupposto per rasserenare anche il diritto penale tributario. Che attualmente sembra una preoccupazione soprattutto
per le contestazioni interpretative di chi dichiara e viene accusato di aver dichiarato
male, lasciando indifferente la ricchezza non registrata affatto. Forse, per una vera “lotta
all’evasione” bisognerebbe abolire le disposizioni sulle “manette agli evasori”,
anch’esse frutto avvelenato dell’illusoria onnipotenza legislativa descritta al par. 2.4,
integrando invece le disposizioni penali generali in modo da colpire anche
comportamenti fraudolenti posti in essere a fini tributari.
PARTE SECONDA
IL REGIME DELLA RICCHEZZA REGISTRATA
Capitolo 7
I REDDITI E I CONSUMI DETERMINATI
UNITARIAMENTE ATTRAVERSO LE AZIENDE
Sommario: 7.1. La determinazione unitaria dei consumi e dei redditi nella tassazione attraverso le aziende:
Iva e imposte dirette – 7.2. Imposte sui consumi: dalla visibilità materiale delle merci a quella contabile del “valore aggiunto” (l’IVA) – 7.3. Segue: le tecniche per raggiungere il consumo tra detrazione
e “non imponibilità” – 7.4. L’IVA nei rapporti internazionali e intracomunitari – 7.5. Il concetto di
“impresa fiscale”, tra aziende, “lavoratori indipendenti” ed enti “no profit” – 7.6. Operazioni attive
“tipiche” (“cessioni di beni” e “prestazioni di servizi”) tra “volume d’affari” (o di ricavi) e “valore
aggiunto” – 7.7. Supporti documentali delle operazioni attive, dei costi e dei consumi (registrazioni,
fatture, scontrini, note di credito) – 7.8. Segue: dai documenti ai libri contabili (richiami e integrazioni
rispetto ai paragrafi 3.3-3.4) – 7.9. L’inerenza nelle imposte sui redditi e nell’IVA: 1) la distinzione
tra costi e consumi – 7.10. Segue: 2) Inerenza e operazioni attive non soggette a tributo – deduzione
interessi passivi – 7.11. Principali elementi rilevanti ai fini della dell’IVA e principio di onnicomprensività delle imposte sui redditi – 7.12. Il momento impositivo nella tassazione attraverso le aziende
(cassa, competenza, irrilevanza delle mere valutazioni: rinvio alle operazioni straordinarie) – 7.13. Il
valore fiscalmente riconosciuto e l’esposizione in bilancio dei beni di impresa, tra criteri patrimoniali
e reddituali – 7.14. Valutazioni fiscali di fine esercizio e rapporti col bilancio – 7.15. Le valutazioni
del patrimonio di fine esercizio 1) ammortamenti e accantonamenti – 7.16. Le valutazioni di fine
esercizio: 2) rimanenze di beni e servizi – 7.17. Coordinamento tra tassazione delle società e dei soci
– 7.18. I criteri di collegamento della ricchezza al territorio nazionale – 7.19. Segue: simmetrie fiscali
e rapporti internazionali, concorrenza fiscale dannosa, transfer price, cfr. – 7.20. Realizzo e neutralità
nelle operazioni straordinarie d’impresa – 7.21. Determinazione tributaristica della ricchezza e procedure concorsuali
7.1. La determinazione unitaria dei consumi e dei redditi nella tassazione
attraverso le aziende: Iva e imposte dirette
La determinazione contabile della ricchezza attraverso le aziende, riguarda in
modo coordinato i redditi e i consumi. Ricordiamo infatti che l’insieme degli
operatori economici (aziende comprese) tolti i passaggi intermedi tra loro (c.d. “business to business”), percepiscono consumi ed erogano redditi, nel circuito unitario
indicato varie volte, tra cui al par. 1.8. Il ricavo del fornitore al consumo finale costituisce sia il parametro per tassare il consumo dei clienti, sia punto di partenza per
determinare i redditi del fornitore. Se invece il cliente agisce come operatore economico, abbiamo un passaggio intermedio e anziché il consumo del cliente finale
202
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
abbiamo il costo di un altro operatore commerciale, secondo il solito filo conduttore
del testo, di cui già al par. 1.8.
Mentre le distinzioni economicistiche tra “reddito” e “consumo”, inducono la manualistica tradizionale a trattare separatamente IVA e imposte sui redditi, qui teniamo
presente che sul piano della determinazione della ricchezza reddito del fornitore
e consumo (o costo) del cliente sono, come indicato sopra, due facce della stessa
medaglia, determinate secondo gli stessi criteri, siano essi, a seconda del tipo di operatore, contabili o valutativi. Pur disciplinate da testi normativi diversi, IVA e imposte
dirette sono infatti parti di un unico sistema “analitico documentale” con cui le
aziende, determinano contabilmente la ricchezza con lo stesso apparato di informazioni; ciò sia per la ricchezza reddituale sia per qualla manifestata dal consumo,
secondo un filo conduttore del testo.
La posizione tributaria di tutti gli operatori economici “non agricoli” è uguale per IVA e imposte sui redditi, ed analoghi si presentano criteri identificativi delle
attività (par. 7.5), i presupposti oggettivi (cessioni di beni e prestazioni di servizi),
come pure il volume dei ricavi (volume d’affari, par. 7.6), il momento impositivo
(par. 7.12), l’inerenza (par. 7.9) e le scritture contabili (par. 7.7-7.8). È infatti inconcepibile che un corrispettivo sia registrato per le imposte sui redditi e nascosto
per l’IVA, o viceversa. La ricchezza determinabile attraverso i cicli amministrativi delle
aziende, lo è sia per l’Iva sia per le imposte sui redditi; lo stesso vale per la ricchezza
determinabile in autotassazione e, in sede di controllo, con stime o presunzioni, dove
parimenti troviamo reddito del fornitore e consumo (o costo) del cliente.
Per questo, nei prossimi paragrafi, esamineremo in modo unitario, per imposte
dirette ed IVA, le principali tematiche della “tassazione attraverso le aziende”, dal
concetto di impresa, al momento impositivo, all’inerenza, alla territorialità. La differenza
è che, partendo dalla stessa documentazione aziendale, i due tributi guardano la stessa
ricchezza da due punti di vista diversi, cioè il ricavo per il fornitore, e il consumo (o il
costo) per l’acquirente.
Anche la gestione anagrafico-amministrativa dei contribuenti, da parte
dell’autorità fiscale, è unica. Le attività fiscalmente di impresa e professionali sono infatti censite unitariamente ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi.
L’archivio degli uffici tributari si alimenta con la comunicazione del contribuente
di intraprendere una attività d’impresa o professionale. A seguito di questa comunicazione si riceve un numero di partita IVA, indispensabile per procedere alla fatturazione e adempiere altri obblighi formali. Questo inquadramento rileva unitariamente,
ai fini dell’individuazione dell’ufficio tributario competente per territorio e per tipologia di contribuente, della classificazione in un “codice di attività economica”, anche ai
fini degli studi di settore (par. 5.13).
Benché la documentazione contabile cui fanno riferimento IVA e imposte sui
redditi, sia la stessa, la loro diversità di oggetto economico (consumo rispetto a reddito)
comporta qualche differenza nella procedura di determinazione.
Il reddito è il concetto più semplice, rappresentato dalla differenza tra componenti positive (ricavi) e negative (costi) dell’attività economica. Il reddito di un operatore
Capitolo 7 – I REDDITI E I CONSUMI...
203
economico è quindi incerto fino al termine dell’unità di tempo cui è riferito, in quanto
consiste nella somma algebrica di elementi positivi e negativi, molti dei quali valutativi e convenzionali (paragrafi 7.14/7.16 su rimanenze, ammortamenti, etc.). Solo i
redditi di chi non svolge attività di operatore economico, non avendo il riconoscimento
dei costi, possono essere determinati in modo isolato, senza essere riferiti a un periodo
di tempo.
Vedremo che il consumo riguarda invece masse di operazioni che, una volta poste
in essere, sono indifferenti rispetto alle vicende successive, coi riflessi sulle dichiarazioni
fiscali, individuati al paragrafo 3.4 (differenza tra le dichiarazioni riepilogative IVA e
quelle destinate alla determinazione della ricchezza ai fini delle imposte sui redditi).
La determinazione della ricchezza in relazione al consumo è idealmente più
semplice, salve le incertezze su come evitare le duplicazioni, eliminando la tassazione delle operazioni “intermedie”, avvenute cioè tra operatori economici, all’interno
della filiera produttiva e distributiva, quindi “a monte” del consumo finale. Si tratta
perciò di distinguere tra prestazioni ad altri operatori economici (business to business)
ovvero al consumo (business to consumer). Dedicheremo i prossimi paragrafi (par. 7.27.4) alle tecniche utilizzabili a tal fine, per poi riprendere dal par. 7.5 in poi la trattazione
unitaria della determinazione di redditi e consumi “attraverso le aziende”.
7.2. Imposte sui consumi: dalla visibilità materiale delle merci a quella
contabile del “valore aggiunto” (l’IVA)
Le tradizionali imposte sui consumi, trattate già al paragrafo 1.3 si basavano sulla
visibilità materiale delle merci, colpendo le loro quantità fisiche, senza complessi
calcoli sul loro valore o sui corrispettivi della loro vendita.
Questa visibilità “materiale” della ricchezza, legata alla movimentazione delle merci,
colpiva i consumi di servizi solo limitatamente alle merci consumate per effettuarli; ad esempio i consumi presso un falegname pagavano le imposte solo sul relativo
legno, e quelli presso un oste solo sui relativi cibi e bevande.
Questa tassazione a quantità neppure considerava il diverso valore di merci
tipologicamente omogenee; inoltre questa tassazione “per natura” non riusciva a
stare dietro alle diversità di beni indotte dalla produzione industriale. Ma soprattutto il
riferimento della tassazione ai passaggi fisici di merci rischiava di provocare duplicazioni, colpendo anche alcuni passaggi di merci non destinate al consumo, ma alla produzione. Ad esempio la tassazione della farina acquistata dal fornaio finiva per cumularsi
con quella del pane prodotto da quest’ultimo, la tassazione del legname destinato ai
falegnami finiva per cumularsi con quella del mobilio prodotto da tali artigiani, etc...
Più le merci “giravano” prima di arrivare al consumo finale, più cresceva l’imposizione
sui consumi.
Per questo, grazie alla diffusione delle aziende, fu gradualmente concepita una tassazione delle merci non più collegata alla loro visibilità fisica, ma alla documentazione contabile, e quindi, finalmente, ai corrispettivi contrattuali tra fornitore e
204
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
cliente. La tassazione attraverso le aziende arrivava così alle imposte sui consumi; in particolare, la tradizionale visibilità fisica delle merci poteva essere sostituita dalla visibilità
contabile, che quindi tassava anche i consumi di servizi e poteva distinguere, grazie al
diverso corrispettivo, i consumi popolari dai consumi più ricercati di tipologie di beni
per altri versi omogenee (vestiario, cibo, mobili, etc.).
Un primo esperimento di questa “tassazione ragionieristica dei consumi” fu l’imposta generale sull’entrata (IGE); era un’imposta riferita ai corrispettivi contrattuali e
non più alle merci, colpendo quindi anche i servizi e diversificando la tassazione in base
al diverso corrispettivo. L’inconveniente concettuale di questo tributo restava quello
di colpire ogni stadio della produzione, dando luogo alla già indicata tassazione
cumulativa, più gravosa quanto più fossero numerosi i passaggi di beni e servizi “a
monte” del consumo.
Le tecniche per evitare questi inconvenienti non potevano basarsi solo sulla distinzione tra operazioni al consumo ed operazioni verso altri operatori economici.
Questa distinzione è talvolta praticabile perché la destinazione della prestazione è evidente dalle sue caratteristiche oggettive (ad esempio un’autobotte di nafta o un camion
di lavatrici non si acquistano per consumi personali!). Altre volte però occorre utilizzare
altre tecniche, e ci si è basati a tal fine sulla detrazione dall’imposta relativa agli acquisti degli “operatori economici” dall’imposta relativa alle loro vendite, in modo
da tassare solo “i consumi finali” attraverso il “valore aggiunto”.
Quest’ultimo è infatti parzialmente diverso dal reddito dell’operatore economico, riflettendo per certi versi l’insieme dei redditi che, attraverso la sua attività,
sono erogati a chi vi prende parte, cioè anche lavoratori e finanziatori. Ricordiamo infatti dal paragrafo 1.4, ma anche da diversi altri, che le aziende acquisiscono
consumi e restituiscono redditi, a loro volta suscettibili di essere spesi per consumi, in
quanto economicamente si consuma sempre qualcosa che, per altri, è stato un reddito
(chi consuma un reddito da lui non prodotto, comporta qualcuno che produce un reddito che non consuma, donando le corrispondenti risorse a chi materialmente le spende). Considerando oggettivamente l’attività economica, costituisce valore aggiunto
quanto eccede la remunerazione di altri operatori economici (materie prime, energia,
servizi di impresa, professionisti) ed è quindi disponibile per consumi dei dipendenti,
dei finanziatori, dei titolari, o dello stato attraverso le imposte. Il valore aggiunto, in altri
termini, esprime i flussi verso tutti quelli che traggono sostentamento diretto dall’attività economica, senza essere essi stessi operatori economici, cioè i lavoratori, i percettori
di interessi o di rendite fondiarie. Per arrivare dal “valore aggiunto” (paragrafi 7.6, 9.5
sull’IRAP) al consumo bisogna solo eliminare le esportazioni, dove c’è produzione, ma non consumo, ed aggiungere le importazioni, dove c’è consumo senza
produzione.
L’insieme della ricchezza riferibile a lavoratori, risparmiatori, imprenditori, titolari
di immobili, cioè alle persone fisiche e alle organizzazioni non economiche (enti pubblici) è astrattamente suscettibile di essere spesa per consumi e investimenti, cioè “consumata”. Sotto questo profilo l’IVA, universalmente e correttamente considerata sui
consumi, è stata riferita anche “al valore aggiunto”, “sterilizzando” le sue applicazioni su
Capitolo 7 – I REDDITI E I CONSUMI...
205
quelli che gli economisti chiamano consumi intermedi e noi giuristi chiamiamo semplicemente “costi”; questa denominazione è stata probabilmente scelta anche perché
dava l’idea della già indicata “neutralità del tributo” rispetto agli scambi tra operatori economici, sterilizzati coi già indicati meccanismi della detrazione o della non
imponibilità. Ribadiamo che la principale macroscopica differenza tra valore aggiunto
di contabilità nazionale (cioè redditi) e insieme dei consumi riguarda le operazioni con
l’estero, perché le esportazioni esprimono reddito, ma non consumo, mentre il contrario avviene per le importazioni.
Da qui nasce la denominazione dell’IVA, che è una imposta sui consumi, come
“imposta sul valore aggiunto”, al netto cioè dei “consumi intermedi”, maggiorata dei
consumi di beni importati e senza considerare i beni esportati (infra par. 7.4).
L’idea di “reddito individuale”, relativo a singoli operatori, segue uno schema
logico molto intuitivo, schematizzato persino alle scuole elementari, dove il guadagno
(“reddito”) è dato da “incassi meno spese”. Sottrarre le spese dagli incassi esprime la
natura intrinsecamente differenziale del reddito derivante da attività produttive, in
relazione alle quali è logicamente necessario considerare i costi di produzione,
ad esempio le materie prime, l’energia, i costi pluriennali etc. (lo vedremo più avanti
meglio al par. 7.9 a proposito dei costi inerenti).
Definire “ad alto valore aggiunto” una attività economica vuol dire, in prima approssimazione che essa è “molto redditizia”, ponendosi però dal punto di vista dell’attività
e non del titolare. Ad esempio un’azienda di pulizie, rispetto a un supermercato, è “ad
alto valore aggiunto” perché richiede, a parità di giro d’affari, pochi costi per materie
prime e merci. Su questo punto di partenza si innesta poi la redditività, che dipende
da circostanze di mercato e dal grado di impegno –personale e patrimoniale – del titolare. A seconda che si impieghino capitali propri o di debito, una parte diversa del
valore aggiunto sarà impiegato per pagare gli interessi passivi. Se si assume un direttore
generale, il relativo stipendio assorbirà una quota di valore aggiunto che, altrimenti, sarebbe profitto. Se le mura dei locali sono di proprietà, la rendita fondiaria confluirà nel
valore aggiunto. Precisato questo rapporto col valore aggiunto, rinviamo al par. 1.8 per
le altre caratteristiche del reddito, l’inflazione monetaria, il rapporto col patrimonio, la
sua natura etc...
7.3. Segue: le tecniche per raggiungere il consumo tra detrazione e “non
imponibilità”
L’obiettivo di tassare il consumo nei modi indicati al paragrafo precedente fu realizzato con l’IVA, istituita col decreto 633 del 1972 ”, ma ispirata a uno schema base analogo in tutti gli stati dell’Unione Europea. L’imposta fu infatti introdotta e modificata
in base a direttive comunitarie, che costituiscono un ausilio per interpretare la norma
nazionale, o anche per disapplicarla, quando contrasta con le suddette disposizioni (par.
2.6 sui condizionamenti comunitari alla potestà normativa tributaria). Su questo schema base comunitario, gli stati membri possono effettuare “variazioni sul tema”
206
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
per determinati settori, tipologie di operazioni, categorie di contribuenti (ad esempio
quelli di piccole dimensioni) ed infine “forchette” di aliquote minime e massime.
Gli organi comunitari hanno coordinato le due tecniche per neutralizzare i
“passaggi intermedi”, già indicate sopra, che ritroveremo in settori diversi del tributo. La tecnica originaria, ancora molto diffusa e più agevole per le piccole operazioni, neutralizza l’applicazione dell’IVA tra operatori economici con la detrazione
dell’imposta sugli acquisti da quella dovuta sulle vendite. La soluzione alternativa,
più adatta alle grandi operazioni, rende fiscalmente irrilevanti i passaggi intermedi tra produttori; si tratta della c.d. “non imponibilità”, che cerca di individuare
direttamente le prestazioni al consumo finale, esonerando da IVA quelle verso altri
operatori economici c.d. “business to business”).
Il fornitore addebita l’IVA al cliente, e la registra tra i propri debiti verso il
fisco: se il cliente agisce come imprenditore o professionista, la paga e la registra tra i
propri crediti verso il fisco. Gli imprenditori e i professionisti versano a scadenze
periodiche (mensili, par. 3.4), per masse di operazioni, le suddette differenze tra
IVA sulle operazioni attive e IVA sugli acquisti. Il cliente consumatore finale paga e
basta, facendo giungere il tributo alla sua naturale destinazione del consumo.
L’altro sistema per tassare solo il consumo è non applicare l’IVA a chi si qualifica, di fronte ai propri fornitori, come imprenditore e professionista; questo criterio
evita la detrazione dell’imposta a monte, ma rende necessario un controllo delle suddette qualificazioni, e della destinazione dei beni; va tenuto presente, come anticipato
in varie sedi e ribadito al paragrafo 7.7, che il fornitore non è in grado di indagare sulle
generalità effettive del cliente, essendo interessato ad approfondire solo la solidità dei
suoi mezzi di pagamento. Quest’ultimo meccanismo, definibile “non imponibilità” tra
operatori economici, è affidabile solo per grandi forniture, le cui caratteristiche escludono che l’acquirente possa essere un consumatore finale che si dichiara imprenditore
per evitare l’IVA. Questa tecnica si è diffusa prima di tutto dove la detrazione trova
ostacoli perché fornitore e cliente risiedono in stati diversi, come vedremo al
prossimo paragrafo sull’IVA tra paesi dell’Unione Europea, tra cui non esistono dogane.
Successivamente, questa tecnica si è estesa in una serie di scambi interni, per ragioni
antievasive contro il già indicato mancato versamento dell’IVA da parte del fornitore,
cioè le c.d. “frodi carosello”.
La detrazione dell’IVA è simile alla deduzione dei costi nelle imposte sui redditi,
che però non sono tutti gravati da IVA: lo sono le materie prime, i servizi di impresa, le
consulenze professionali, ma non lo sono le retribuzioni ai dipendenti, molte locazioni
e in genere quanto spettante a altri privati non imprenditori (ad esempio i privati che
vendono a commercianti beni usati). Il criterio della detrazione “imposta da imposta”, anziché della deduzione (“base da base”) è stato preferito anche perché gestiva
facilmente la diversità di aliquote.
L’imposta “passiva”, dovuta ai fornitori, viene detratta da quella “attiva”, addebitata
ai clienti, con credito d’imposta per eventuali eccedenze.
Anche qui ritornano i concetti indicati al par. 3.7 sul contribuente di diritto, cioè
il fornitore, che intrattiene i rapporti col fisco. Il contribuente di fatto, il consumatore
Capitolo 7 – I REDDITI E I CONSUMI...
207
finale, non ha rapporti con gli uffici fiscali, e sopporta (magari senza saperlo) il peso
economico del tributo.
Il fornitore si rivale sul cliente per l’importo dell’imposta (art. 18), e quindi nei rapporti economici, è a priori è noto che:
1) negli acquisti da dettaglianti il prezzo è comprensivo di IVA, come stabilisce l’art. 18
comma 2;
2) negli acquisti da altri soggetti-IVA il corrispettivo deve essere maggiorato dell’imposta.
In base a queste previsioni, il cliente dovrà corrispondere l’IVA in aggiunta al
corrispettivo pattuito, mentre il commerciante al minuto non ha alcun diritto di imporre maggiorazioni di prezzo a chi richiedesse la fattura (dovendo invece scorporare
l’IVA dal prezzo esposto iva inclusa).
L’aliquota generale, applicata al corrispettivo contrattuale nei modi indicati alla
postilla precedente, è del 22 per cento, ma esistono aliquote ridotte speciali (4 e 10),
previste, per categorie merceologiche estremamente dettagliate, nelle tabelle allegate al
decreto IVA.
Una volta chiarito il funzionamento dell’imposta, ricolleghiamoci a quanto detto al
paragrafo precedente, ricordando che le organizzazioni produttive ricevono consumi e restituiscono redditi a chi, a sua volta, li usa per consumare. L’imposta
sul valore aggiunto si chiama così perché economicamente guarda ai “redditi spendibili
per consumi”, cioè che ritornano verso gli individui in veste di privati consumatori, in
buona parte sotto forma di salari, profitti e interessi (cfr. par. 1.8, secondo cui –anche se
non sono “sui redditi”, tutte le imposte si pagano “coi redditi”).
Una sistematica posizione di credito IVA va però chiarita, in quanto le imprese dovrebbero creare almeno un po’ di valore aggiunto, sufficiente a remunerare
una parte del lavoro dipendente e degli interessi passivi, importanti voci di costo non
gravate da IVA. Anche una impresa redditualmente in perdita, per effetto degli
interessi passivi e del lavoro dipendente, dovrebbe essere a debito di IVA; praticamente tutte le operazioni attive sono infatti “con IVA”, o rilevanti ai fini IVA (esportazioni e settoriali esenzioni, come operazioni finanziarie o spese mediche); non sono
infatti gravati da IVA i costi per lavoro dipendente, gli interessi passivi e tutti quelli
erogati a enti pubblici o a privati non operatori economici. Un pareggio di bilancio
ai fini delle imposte sui redditi dovrebbe corrispondere comunque a un’IVA a
debito.
Una posizione di credito sistematica può derivare da esportazioni (vedi infra paragrafo 7.4) o dall’applicazione, sulle vendite, di aliquote agevolate, molto inferiori a quelle
applicabili sugli acquisti.
Una posizione di credito “occasionale” può derivare dall’effettuazione di investimenti, dove l’IVA viene detratta immediatamente, senza seguire l’eventuale ammortamento dei beni acquistati.
A parte le spiegazioni suddette, il credito IVA potrebbe anche celare frodi o vendite
non registrate, che rendono opportuna, nei casi concreti, una analisi di credibilità economica delle ragioni del fenomeno.
208
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
L’IVA viene liquidata “per masse”, non operazione per operazione, e quindi
non esiste, da parte del fornitore, un versamento specifico dell’IVA detratta dal cliente,
a sua volta “per masse”. Chi detrae non può quindi avere la certezza legale del
versamento da parte del fornitore dell’IVA che gli è stata addebitata; quest’ultimo
potrebbe infatti avere altre detrazioni su cui il cliente non può indagare. Ne deriva
il rischio che l’IVA incassata dal fornitore non sia versata al fisco, senza responsabilità
dell’acquirente, salva la prova di una sua connivenza col fornitore (c.d. frodi carosello,
già più volte menzionate e rientranti nel concetto di arbitraggio fiscale in senso ampio,
tratteggiato al paragrafo 3.12). Questa connivenza è presumibile quando l’acquisto
avviene a un prezzo inferiore a quello corrente, nel qual caso l’unica spiegazione del
comportamento del venditore è l’intenzione di intascare l’IVA; in questi casi scatta è,
una responsabilità solidale del compratore per l’imposta non versata dal venditore
(art. 60-bis decreto IVA).
Contro le frodi in esame si potrebbe perseguire un maggiore utilizzo, anziché della
detrazione, del già indicato sistema della “non imponibilità”, il cui inconveniente è
però quello di non poter coinvolgere il fornitore, soprattutto per gli acquisti di piccolo
importo, in una verifica delle dichiarazioni con cui l’acquirente, affermando di agire
come operatore IVA, chiede che non gli venga applicata l’imposta.
La combinazione tra i punti forti di entrambi i sistemi potrebbe basarsi per gli
acquisti “al dettaglio” sulla detrazione, che garantisce l’applicazione dell’imposta
da parte del fornitore e salvaguarda tutta l’imposta che è stata applicata fino a quel
momento. La “non imponibilità” è opportuna solo dove l’ultimo stadio della catena
distributiva verso il consumo finale è fiscalmente molto affidabile sulle vendite, e quindi
i meccanismi fraudolenti per “eliminare l’IVA” passano necessariamente attraverso il
mancato versamento del tributo “a monte” (le già indicate “frodi carosello” tendenti
appunto a spezzare le simmetrie IVA). Quanto più il settore degli dettaglio è presidiato
da grandi aziende rigide, tanto più è opportuno creare spazio per il sistema della “non
imponibilità”; si eviterebbe così un balletto di “versamenti e detrazioni”, destinato a
chiudersi fisiologicamente “a somma zero”, e fonte dei suddetti rischi di frode.
7.4. L’IVA nei rapporti internazionali e intracomunitari
Il coordinamento tra i criteri di non imponibilità e di detrazione, descritti al
paragrafo precedente, si pone in modo particolare nei rapporti internazionali, dove
la detrazione è impraticabile, persino nei rapporti comunitari.
Essa infatti richiederebbe una complicatissima stanza di compensazione tra tutti i
paesi comunitari, che pure era stata progettata, ma è stata rinviata a tempo indeterminato per intuitive difficoltà gestionali; queste ultime sono connesse soprattutto alla
detrazione dell’IVA, da parte del cliente, in un paese diverso da quello in cui il fornitore
ha proceduto al versamento.
Resta quindi il vecchio criterio della “imponibilità in dogana” per i beni in
arrivo da paesi extracomunitari. L’applicazione dell’IVA in dogana riguarda sia i con-
Capitolo 7 – I REDDITI E I CONSUMI...
209
sumatori finali sia gli operatori economici, per i quali tale importo è detraibile
secondo le regole IVA degli acquisti domestici, e comprovata dai documenti doganali,
non dalla fattura del fornitore.
Anche i beni esportati verso paesi extracomunitari passano per la dogana, ed
ovviamente non scontano alcun tributo in quanto l’IVA, come tutte le imposte sui
consumi, segue l’elementare criterio di territorialità del paese del compratoreconsumatore finale. Pertanto, il regime di «non imponibilità» IVA delle esportazioni
extra-unione europea, senza limiti alla detrazione dell’imposta sui correlativi acquisti,
con eventuale rimborso delle eccedenze, discende dai principi generali, senza alcun
carattere agevolativo.
È del tutto normale, quindi, come già anticipato al precedente par. 7.3, che gli
esportatori abbiano eccedenze dell’IVA sugli acquisti rispetto a quella sulle vendite, e siano in una posizione di credito. Per evitare i tempi burocratici richiesti per il rimborso
dei crediti IVA è consentito acquistare beni e servizi «senza applicazione dell’imposta»
fino a concorrenza delle esportazioni dirette dell’anno precedente (è un altro caso in
cui l’applicazione dell’IVA riguarda un dato “di periodo”).
Il rischio è che, non essendoci alcuna possibilità di trasformare il fornitore in investigatore sulla correttezza della posizione globale IVA del proprio cliente, vengano utilizzate partite IVA reali, ma “di comodo”, da parte di chi non è affatto esportatore, ma
vuole semplicemente acquistare i beni senza IVA per rivenderli “in nero” sul mercato
nazionale, in una delle frodi indicate al termine del precedente paragrafo 7.3.
Scontano l’IVA anche i consumi effettuati in Italia da soggetti esteri (ad es. turisti), salva la dimostrazione del trasporto dei beni all’estero, in proprio, secondo una
procedura che prevede la certificazione doganale dell’uscita del bene.
I rapporti economici tra operatori di stati appartenenti all’unione sono
invece caratterizzati dall’assenza di una dogana, che a sua volta si inquadra nelle
aspirazioni politiche alla creazione di un mercato unico dei paesi dell’Unione, che
superi i confini nazionali. Tuttavia, a parte l’abolizione delle dogane, gli effetti sulla
attribuzione del gettito non sono molto diversi. Al di là di una modesta franchigia (alcune decine di migliaia di euro) il fornitore comunitario a consumatori finali di un altro
paese comunitario, è tenuto a nominare un rappresentante per versare l’imposta
allo stato dove risiedono i consumatori. Solo all’interno della suddetta franchigia
il fornitore applicherà l’IVA come se la vendita fosse avvenuta sul proprio mercato interno, che ne acquisisce il gettito.
Quando invece il cliente comunitario è un operatore IVA, in luogo della detrazione dell’imposta estera si utilizza il sistema della “non imponibilità” in base alla citata
legge 427 del 2003; il cliente comunicherà quindi al fornitore dell’altro stato U.E. la
propria partita IVA (che funge da “codice di identificazione”), acquistando senza applicazione dell’imposta.
Anche qui c’è il rischio che, non essendoci alcuna possibilità di trasformare il fornitore in investigatore sulla correttezza della posizione globale IVA del proprio cliente,
vengano utilizzate partite IVA estere per “mascherare” cessioni interne senza IVA, rivendendo i beni “in nero” sul mercato nazionale o al limite su quello estero; in quest’ul-
210
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
timo caso il trasporto potrà anche avvenire a cura del venditore, non in grado però
di controllare l’effettiva destinazione dei beni. Non è infatti sufficiente il controllo
informatico sull’effettività della partita IVA del cliente cui viene richiesto di intestare
la fattura.
7.5. Il concetto di “impresa fiscale”, tra aziende, “lavoratori indipendenti” ed enti “no profit”
Possiamo iniziare la trattazione unitaria (ai fini IVA e delle imposte sui redditi)
del regime della ricchezza registrata nella tassazione attraverso le aziende e nell’autotassazione. Vi ritroviamo innanzitutto quel concetto esageratamente ampio e quindi
confusionario di “impresa fiscale”, già rilevato al par. 3.13. Ricordiamo infatti da tale
paragrafo l’espediente legislativo di trasformare in “imprese fiscali” lavoratori indipendenti senza alcun interesse genuino alla contabilità e senza una organizzazione in forma
di impresa. L’art. 4 IVA e l’art. 55 TUIR adottano un concetto di “azienda in senso
materiale”, considerando imprenditore chiunque eserciti una attività abituale di tipo
“non intellettuale”; solo il lavoro intellettuale costituisce invece fiscalmente “lavoro
autonomo”, come indicato al par. 8.1.
È una cosmesi giuridica che ha accomunato le (poche) grandi aziende pluripersonali e milioni di attività indipendenti, basate solo sull’opera dei titolari. Ricordiamo
dal par. 3.13 il filo conduttore che ha visto gelatai, pasticceri, parrucchieri, tassisti, osti,
fornai, salumieri, venditori ambulanti, e chi più ne ha più ne metta, assimilati legislativamente a grandi capitalisti. In questo modo si rese automaticamente fuorviante
l’espressione “impresa”, costringendo a precisare ogni volta se si stava parlando
del bottegaio o dell’industriale, e per questo oltre il 90 percento delle “imprese” (si fa
per dire) italiane sono “monoaddetto”, compreso il titolare). È stato un altro dei casi in
cui un espediente legislativo, adottato in mancanza di meglio, ha generato confusione sociale e incomprensioni col resto degli studiosi e delle classi dirigenti, che
in questo caso tendono di solito a parlare di “lavoro indipendente”, o genericamente
“autonomo”.
Sono gli aberranti risultati di aver messo in secondo piano l’organizzazione,
mantenendo come unici elementi caratterizzanti per l’impresa fiscale la già indicata
indipendenza formale e una certa continuatività nel tempo, definita “abitualità”. L’atto
occasionale, isolato, privo di una continuità temporale, è invece irrilevante ai fini IVA,
mentre ai fini delle imposte dirette va inquadrato nella categoria residuale dei “redditi
diversi” (paragrafo 8.6).
La proliferazione formale degli “imprenditori fiscali”, in assenza di aziende, dipende
anche dall’inserimento in tale categoria di tutte le società commerciali”, di capitali e di persone, a prescindere dall’attività in concreto svolta. Quest’inserimento delle
società tra le “imprese fiscali”, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, in virtù della
loro mera forma giuridica, ha ulteriormente moltiplicato i soggetti che ricadono in questo regime; è stata una moltiplicazione inutile, perché la società non è un
Capitolo 7 – I REDDITI E I CONSUMI...
211
“gruppo sociale”, come l’azienda (par. 3.1), ma una forma giuridica, potenzialmente
intestataria di beni. Attribuire una posizione tributaria di impresa al milione circa di
società esistenti in Italia, spesso meramente intestatarie di beni immobili, partecipazioni
etc., oppure senza alcun contenuto, in attesa di un possibile futuro utilizzo, provoca
equivoci di ogni tipo. Rispetto a questa massa di società senza organizzazione, le aziende come organizzazioni di persone (paragrafo 3.1) o quantomeno operatori economici,
sono numericamente irrilevanti. Le poche decine di migliaia di aziende pluripersonali, che danno lavoro a milioni di persone, scompaiono in un mare di società senza
contenuto, o passivamente titolari di singoli beni, come quelle di mero godimento,
intestatarie di beni materiali, come immobili o imbarcazioni, materialmente utilizzate
dai soci.
Quest’intestazione non nasconde ricchezza al fisco, quanto piuttosto ai creditori;
invece la confusione tra società e azienda trascina da vent’anni uno strano miscuglio di tassazione patrimoniale e presuntiva sui beni intestati a società c.d. “di comodo” (tecnicamente “non operative”). Invece di distinguere tra “forma societaria” e
“azienda”, una tendenza politico-mediatica (par. 2.4) alimenta da quasi vent’anni una
disciplina assurda sul piano della determinazione della ricchezza, in materia di “società
di comodo”, o “non operative”; l’assurdità consiste nel presumere un reddito proprio
sul presupposto della “non operatività” della società; è una assurdità rispetto alla quale
nessuno osa alzare la voce, in quanto “le società di comodo” non sono organizzate sindacalmente; nessuno fa quindi valere questa assurdità solo per ragioni di principio, ed il
problema non diventa pressante, fortunatamente, solo perché le società in esame sono in
un cono d’ombra dell’attività di accertamento (troppo particolari per gli accertamenti
in base agli studi di settore e troppo piccole per il tutoraggio delle grandi aziende, come
indicato al par. 5.7 sulla distribuzione dei controlli fiscali).
Questo concetto di impresa fiscale, amplissimo e variegato, continua ad escludere le
imprese agricole (paragrafo 8.2), gli investimenti di capitale finanziario a titolo
di partecipazione o prestito (paragrafo 8.5), le già indicate attività libero professionali e
assimilate, determinate, come già anticipato, con criteri differenziali molto simili a quelli
d’impresa.
Anche enti non societari possono essere operatori economici, esercitando in
modo abituale attività commerciali “collaterali” a quella istituzionale, di ente pubblico o
privato (ad esempio ente religioso), organizzando scuole private, prestazioni di ospitalità
simile a quella alberghiera o di ristorazione. Sono prestazioni che assumono rilevanza
IVA, se “abituali”, a prescindere dal “fine di lucro”, in quanto l’IVA colpisce i consumi, e non i redditi. Questi ultimi, se esistenti, sono comunque tassati in modo “finale”
nell’Ires, in quanto non esistono “partecipanti o soci” cui effettuare una distribuzione
(paragrafo 7.17 e 9.1). Lo stesso vale per i trusts.
Le associazioni sportive, politiche, ricreative, culturali, etc. esprimono una sorta
di “consumo collettivo”, finanziandosi coi contributi dei soci (quote associative) e senza
essere “commerciali”, in quanto appunto consumatrici finali; l’associazione, di norma,
è quindi gravata di IVA per i propri acquisti, mentre non deve applicare l’IVA sulle
quote associative e altri “rimborsi spese specifiche” ricevuti dagli associati; è un consu-
212
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
mo collettivo simile a quello esistente nel condominio degli edifici, e che può evolversi verso il mercato (quindi la commercialità e l’assoggettabilità ad IVA), man mano
che si opera indiscriminatamente verso “non soci”; le cautele, esistenti ed ipotizzabili,
per evitare imprese mascherate da associazioni si basano sul “diritto di voto” in assemblea e sui criteri di determinazione della quota associativa, tendenzialmente orientati al
rimborso dei costi di struttura. Per le associazioni definibili “democratiche”, secondo
i parametri suddetti, sono escluse da IVA anche le somme erogate a fronte di servizi
specifici resi al socio, come una consumazione al bar di un circolo sportivo.
Le attività rivolte al mercato, invece, devono scontare l’IVA sui corrispettivi, anche
se sono rese per finalità benefiche e socio assistenziali, altrimenti verrebbe falsata la concorrenza rispetto alla generalità degli operatori economici. Nelle imposte sui redditi,
invece, operare in modo volontaristico, tendendo solo alla copertura dei costi, fa venir
meno in prima battuta un reddito imponibile; la mancanza di scopo di lucro, in prima approssimazione, si vede nella tendenziale parità tra entrate e uscite, e nella gratuità
del lavoro organizzativo (spesso promosso da associazioni religiose, politiche, sportive o
ambientalistiche). Se invece i ricavi eccedono stabilmente i costi, la mancanza di scopo
di lucro, pur solennemente enunciata negli statuti, è smentita dai fatti.
7.6. Operazioni attive “tipiche” (“cessioni di beni” e “prestazioni di servizi”) tra “volume d’affari” (o di ricavi) e “valore aggiunto”
I corrispettivi relativi alle prestazioni tipiche verso la clientela costituiscono i
ricavi e sono la grandezza più significativa per esprimere le dimensioni delle imprese: ciò sia ai fini IVA, dove il concetto è indicato con l’espressione “volume d’affari”,
sia ai fini delle imposte sui redditi; i ricavi comprendono anche le prestazioni al consumo finale, come indicato al paragrafo 3.3 non accompagnate da fattura, ma solo da
registrazioni contabili cumulative o da documentazione di diritto amministrativo, come
gli scontrini fiscali.
Al relativo importo si collegano le classificazioni delle aziende ai fini di numerosi adempimenti dei controlli fiscali (capitolo quinto), tra contribuenti minori,
medie imprese e contribuenti di grandi dimensioni.
Accanto a questo indice dimensionale dell’azienda c’è il valore aggiunto economico (il “plusvalore”), rispetto alle materie prime e ai servizi di impresa consumati nella
produzione, che si distribuisce, tra salari, interessi e profitti; ne abbiamo già parlato a
proposito del concetto di “valore aggiunto” al par. 7.2 e lo ritroveremo al paragrafo
9.5 per l’IRAP. A parità di fatturato, infatti, crea molta più ricchezza per i lavoratori, i
risparmiatori, i fornitori (il c.d. “indotto”), i soci, una azienda ad alto valore aggiunto. A
parità di ricavi, un rivenditore di merci ha un valore aggiunto molto inferiore rispetto
a quello di un artigiano, ad esempio un pasticcere, che frequentemente uso come metafora di un lavoro indipendente con buoni margini di guadagno rispetto agli incassi.
L’inquadramento dei rapporti giuridici, ai fini della determinazione tributaristica
della ricchezza, è molto elementare. Mentre il diritto civile, dedicato ai rapporti inter-
Capitolo 7 – I REDDITI E I CONSUMI...
213
privati, conosce un altissimo strumentario di contratti, per determinare la ricchezza
ai fini tributari, basta molto meno. Le categorie concettuali in cui inquadrare le operazioni attive (e correlativamente gli acquisti), sia ai fini dell’IVA che delle imposte sui
redditi, sono in ultima analisi soltanto due, e cioè:
– cessioni di beni, cui corrispondono obbligazioni di “dare”, ad esempio di trasferire la titolarità giuridica di beni (proprietà o altro diritto reale);
– prestazioni di servizi aventi in genere ad oggetto un obbligo di fare, sempre dietro
corrispettivo.
Le operazioni attive, com’è naturale nella tassazione attraverso le aziende, rilevano
in base ai corrispettivi contrattuali, risultanti dai documenti giustificativi; la
documentazione contabile rende visibile la pattuizione giuridica, di diritto privato, tra
cliente e fornitore, consentendo di analizzarla in chiave economica, secondo uno dei
pilastri della tassazione attraverso le aziende (paragrafo 1.4).
Tra le operazioni attive rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’IVA qualche sfasamento c’è, visto il diverso oggetto delle due imposte; tutte le operazioni rilevanti
ai fini IVA influenzano anche il reddito; inoltre costituiscono componenti positive
del reddito anche entrate irrilevanti ai fini IVA, perché non riconducibili a cessioni di
beni o prestazioni di servizi, come sovvenzioni pubbliche generiche, incentivi, risarcimenti di danni, indennizzi, interessi moratori, etc...
Il corrispettivo può essere ovviamente sia in denaro sia in natura, nel qual caso
occorre esprimerlo in denaro, stimandone il valore normale. In presenza di un corrispettivo contrattuale in denaro, il valore normale della prestazione resa o ricevuta può
invece costituire un indizio dell’occultamento di parte del prezzo.
Il valore normale, invece, ha una rilevanza sostanziale, che non richiede la suddetta prova della falsità del corrispettivo, solo nelle imposte sui redditi, per i rapporti
intragruppo con l’estero di cui diremo al par. 7.19.
7.7. Supporti documentali delle operazioni attive, dei costi e dei consumi
(registrazioni, fatture, scontrini, note di credito)
Quanto indicato sui concetti di reddito e di consumo, rilevanti ai fini tributari, consente di integrare la cornice indicata al capitolo terzo, sulla rilevanza fiscale della
documentazione contabile genuinamente utile all’azienda, su cui poi si innestano alcuni
documenti ulteriori di diritto tributario (paragrafi 3.2-3.4).
Ricordando che l’azienda è un’organizzazione che acquisisce consumi (tassati con
l’IVA) e restituisce redditi (tassati con le ritenute o segnalati al fisco), partiamo dalle
operazioni al consumo finale, verso persone fisiche che non hanno alcun interesse a
documentare l’operazione. In linea di principio, qui, l’azienda organizzata non emette
alcun documento identificativo del cliente, di cui non ha motivi di conoscere l’identità,
preoccupandosi solo dell’effettività del pagamento.
Per questo neppure le grandi aziende operanti al dettaglio identificano il
cliente, ma emettono al massimo un documento anonimo che identifica l’operazione,
214
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
cioè uno “scontrino”. L’adempimento aziendale tipico, in questi casi, è solo la diretta
registrazione contabile dell’ammontare cumulativo delle vendite giornaliere, in genere
distinto per punto vendita; la documentazione della singola operazione di vendita viene
quindi “saltata”, e –anche quando viene emesso uno scontrino – non ne viene effettuata
alcuna registrazione contabile. Molti settori economici specifici documentano le prestazioni rese nei modi più conformi alla loro operatività aziendale; ad esempio le società di
trasporti emettono i biglietti, le assicurazioni le polizze, mentre le banche inseriscono i
corrispettivi per servizi alla clientela nelle documentazioni periodiche inviate ai clienti
(anche qui ovviamente la registrazione sui libri contabili è cumulativa, non avviene
documento per documento).
Qualora però il cliente si qualifichi come operatore economico e richieda un
documento personalizzato col dettaglio della prestazione resa, idoneo ad effettuare la
detrazione IVA, le aziende si organizzano per emetterlo. Di questo prende atto anche la
normativa fiscale, che esclude l’obbligo di fatturazione per le imprese, grandi e
piccole, operanti al dettaglio, salvo appunto che il cliente la richieda.
Il concetto di “dettaglio” non riguarda solo il commercio di beni con modesto prezzo unitario, ma tutte le aziende operanti direttamente verso consumatori finali, anche quelle che trattano beni di apprezzabile valore unitario, come
arredamento, veicoli, elettronica, gioielleria di lusso. La normativa fiscale ricalca la prassi
aziendale, e si spiega non tanto per il ridotto importo dei corrispettivi, ma perché in
queste attività di solito l’acquirente è un consumatore finale.
Il compratore sarebbe teoricamente obbligato a chiedere la fattura ai commercianti
al dettaglio quando è un imprenditore che acquista beni oggetto dell’attività dell’impresa, ma è facilissimo acquistare senza fattura, da commercianti al dettaglio. Si ricordi infatti (par. 3.7/3.8) che il fornitore non ha altra scelta che attenersi, ai fini delle generalità
da indicare in fattura, a quelle comunicate dal cliente (il che rende velleitario l’obbligo
di identificare i consumatori finali che spendono oltre 3000 euro più iva ai fini del c.d.
“spesometro”, di cui al par. 5.14).
Contro la mancata registrazione fiscale della ricchezza, attraverso l’omessa registrazione di parte degli incassi (par. 3.14) sono previste le c.d. «ricevute fiscali» e gli
«scontrini fiscali». Sono strumenti, tutti italiani per contrastare l’evasione da
occultamento dei corrispettivi, ma con un buon rapporto “costi benefici”, ovviamente a patto che il fisco svolga frequenti “piantonamenti di cassa”.
Scontrino e ricevuta sono adempimenti essenzialmente amministrativo-tributari,
dove determinate cautele formali dovrebbero impedire la distruzione del documento. Gli acquisti di ricevute da compilare avvengono secondo formalità da cui
l’Amministrazione finanziaria potrebbe in teoria ricostruirne il numero, mentre il registratore di cassa dovrebbe mantenere traccia indelebile delle relative operazioni, permettendo così il riscontro con quelle indicate nelle dichiarazioni.
Questi documenti sono il risvolto più sensato dell’applicazione della tassazione attraverso le aziende a piccoli commercianti e artigiani, dove manca l’organizzazione, ma
si vede la bottega, col suo afflusso di clientela. Tuttavia si tratta pur sempre di elementi
presuntivi, rilevanti nei modi indicati al par. 5.9; senza sistematici controlli sul tema,
Capitolo 7 – I REDDITI E I CONSUMI...
215
con le dispersioni delle energie amministrative in altre scoordinate contestazioni (studi
di settore, redditometro, indagini finanziarie, reinterpretazioni di ricchezza registrata) è
verosimile che una buona parte degli importi oggetto di regolare scontrino non siano
poi registrati fiscalmente.
La grande distribuzione, affidabile per la propria organizzazione amministrativa,
è stata – come detto in precedenza – esonerata da questi adempimenti fiscali,
anche se ne è stata adottata una definizione troppo estesa, includendovi anche piccole
organizzazioni a gestione familiare, in cui il titolare può dapprima controllare i cassieri,
e poi omettere la registrazione fiscale di una parte delle somme (par. 3.7).
La fattura deve essere invece emessa d’iniziativa del fornitore per le prestazioni non
“al dettaglio”, tipicamente quelle “tra imprese”, oppure anche quelle offerte alla generalità degli acquirenti attraverso cataloghi, dove non ha senso distinguere tra “ingrosso”
e “dettaglio”. In questi casi il prezzo si intende “oltre IVA”, cioè deve essere maggiorato
del tributo; ripetiamo che, invece, nelle prestazioni al dettaglio il prezzo si intende comprensivo dell’imposta, la quale deve essere scorporata da esso.
Le caratteristiche della fattura sono desumibili dagli esempi che si riscontrano nelle
utenze elettriche, telefoniche, etc.: essa deve contenere le generalità delle parti, il
numero di partita IVA dell’emittente, una numerazione progressiva, la (sommaria) descrizione della prestazione, il corrispettivo e l’IVA.
L’acquirente operatore economico, che acquista senza ricevere fattura entro un determinato periodo di tempo (quattro mesi) è obbligato a denunziare all’ufficio tributario il fornitore che non la emette, sotto pena di sanzioni amministrative in proprio.
La fattura è un documento commerciale, che ha ricevuto la sua prima rilevanza
legislativa tributaria per giustificare la detrazione IVA sugli acquisti. È’ stato insomma
ripreso e formalizzato, ai fini fiscali, un documento utilizzato anche come richiesta di
pagamento ai fini commerciali; lo conferma il frequente utilizzo dell’espressione “fattura” anche per i documenti non soggetti ad IVA.
La documentazione sopra indicata è molto informale, come si addice alla ripetitività
dell’organizzazione aziendale: ricordiamo che non si tratta di documenti sottoscritti, ma
semplicemente intestati, in quanto non è un loro fantomatico formalismo a renderli affidabili, ma il loro inserimento nell’organizzazione amministrativa dell’emittente, come
rilevato anche al termine del par. 3.5; ricordiamo che è il contesto amministrativo
a fornire la “prova economica” di credibilità dell’evento registrato, alla luce della
verosimiglianza tra documentazione emessa e tipologia di prestazione (sull’onere della
prova come valutazione di credibilità economica cfr. par. 6.2).
Come anticipato al termine del par. 3.3, occorre passare dalla considerazione isolata
del “documento” ad una considerazione globale del contesto amministrativo in cui esso
si inserisce, della verosimiglianza di quanto esso afferma, in relazione all’organizzazione
aziendale cui si riferisce. È un riflesso dell’oggetto economico della tassazione, la solita
“prova economica”, strutturalmente presuntiva, quand’anche contabile, nel quadro della
determinazione tributaristica della ricchezza.
Quando una operazione viene meno, perché fatturata erroneamente o perché
il corrispettivo pattuito era inferiore a quello erroneamente fatturato, la correzione
216
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
documentale della precedente fatturazione è denominata nella prassi aziendale “nota
di credito” (la fattura comporta infatti, nella contabilità del fornitore, un addebito al
cliente, cui si dà invece “credito” annullando la fattura). Dare rilevanza ai fini IVA a
tale documento è meramente facoltativo, perché non comporta mai aumenti di
gettito per lo stato e può provocarne – al contrario – una riduzione quando il cliente
era un consumatore finale. Il noto meccanismo trilaterale su cui si fonda l’IVA si svolge
infatti in questo caso all’inverso: il venditore restituisce l’importo dell’IVA all’acquirente, recuperandolo dallo Stato mediante una corrispondente riduzione dell’IVA a
debito; il cliente, se consumatore finale, tratterrà l’IVA restituitagli dal fornitore, mentre
il cliente soggetto IVA dovrà riversare tale importo all’Erario, in rettifica della detrazione a suo tempo effettuata. Alla fine di queste correlazioni intersoggettive, tipiche della tassazione attraverso le aziende, solo il consumatore finale sarà avvantaggiato
dall’annullamento dell’operazione, comprensiva dell’imposta, così come era stato inciso
dalla sua fatturazione.
Quanto precede spiega perché l’art. 26 del dpr. IVA circondi di alcuni limiti le variazioni in diminuzione, vietandole, qualora dipendano da un sopravvenuto accordo tra
le parti, dopo un anno dall’operazione cui si riferiscono.
7.8. Segue: dai documenti ai libri contabili (richiami e integrazioni rispetto ai paragrafi 3.3-3.4)
Per la maggior parte dei contribuenti, che non sono operatori economici, la tassazione attraverso le aziende si ferma ai documenti emessi dalle aziende, senza obblighi
di ulteriore loro annotazione contabile; è quanto accade per i lavoratori dipendenti, i
consumatori, i risparmiatori tutti tassati attraverso le aziende, da cui provengono i certificati del sostituto di imposta (par. 3.6), la documentazione degli oneri deducibili, gli estratti conto, la maggior parte dei contratti attivi di locazione etc. utilizzati per
redigere direttamente la dichiarazione fiscale, senza la mediazione di scritture contabili.
Per gli operatori economici abbiamo invece già visto al par. 3.3 che all’emissione dei documenti deve seguire la loro registrazione in appositi libri contabili. È
l’inutile contabilità dei lavoratori indipendenti, che richiede la registrazione anche di
documenti che potrebbero essere conservati comodamente in qualche cartellina, e mostrati all’ufficio in sede di controllo, in una determinazione analitica senza contabilità.
Solo man mano che i documenti diventano numerosi è più pratico organizzarli e
classificarli in supporti chiamati “libri contabili”, su cui sono annotati i dati necessari
a rintracciare il documento.
La registrazione contabile non aggiunge nulla, sul piano probatorio, alla credibilità
dei documenti giustificativi, ma si limita a ordinarli per gruppi omogenei, secondo varie
aggregazioni tipologiche e cronologiche, in elenchi denominati “conti”. Le esigenze
sottostanti sono essenzialmente di praticità nel reperimento della documentazione, e di
suo raggruppamento in categorie omogenee, da esporre nel bilancio, come vedremo
al paragrafo 7.14; ad esempio, le cifre riepilogative esposte in bilancio, come “ricavi”,
Capitolo 7 – I REDDITI E I CONSUMI...
217
“acquisti di materie prime”, “salari e stipendi”, “spese di manutenzione” etc., sono analizzabili nei conti di contabilità generale, dai quali si può risalire ai singoli documenti
giustificativi.
Tutte le scritture sono oggi effettuabili su carta libera, essendo stati aboliti da
alcuni anni i residui obblighi di vidimazione e bollatura iniziale, fino al 2001 previsti
per alcune di esse.
La contabilità è ordinariamente tenuta con l’ausilio di programmi informatici, ed
è anche sufficiente, per un certo arco di tempo (3 mesi), la mera memorizzazione dei
dati, purché stampati contestualmente alla richiesta dei verificatori. Se si adottano alcuni
accorgimenti tecnici per impedire la manipolazione successiva, è consentito omettere, o
distruggere, la copia «cartacea» della documentazione e delle scritture contabili, a favore
di una versione esclusivamente “digitale”.
Un tempo questi libri contabili erano garanzia di affidabilità, anche per il fisco, vista
la loro difficile alterabilità quando erano tenuti a mano; oggi si può invece ristampare
tutta la contabilità in pochi minuti, grazie agli stessi mezzi elettronico-informatici che
hanno fortemente agevolato il passaggio alla tassazione attraverso le aziende.
Anche sotto questo profilo si conferma quindi che la garanzia per il fisco non
è l’inalterabilità del documento, ma la rigidità dell’organizzazione aziendale, come
rilevato ai parr. 3.2, 5.17 etc... Dall’organizzazione deriva l’esigenza di una contabilità, mentre senza organizzazione la contabilità è l’inutile simulacro indicato al
par. 3.13. Se la contabilità è imposta a chi non è organizzato, egli potrà scriverci quello
che vuole (par. 3.13), senza che la sua organizzazione si irrigidisca in modo proporzionale; chi si immedesima con la propria attività, senza organizzazione (i lavoratori indipendenti, par. 3.13), non ha bisogno di “essere organizzato”, e se conserva i documenti
lo fa per memoria nei rapporti con le controparti.
Abbiamo già visto al par. 3.13 che l’obbligo indiscriminato di tenere scritture
contabili, previsto anche per attività senza alcuna organizzazione, è un espediente normativo per “mascherare da aziende” attività immedesimate col titolare. La regolarità
formale di queste inutili contabilità entra a far parte di un rituale dove, in realtà, si
pensa ad altro, cioè ai corrispettivi non registrati; con gli uffici che utilizzano pretese
irregolarità contabili per avvalorare le presunzioni di ricavi non registrati (par. 5.13), e
i contribuenti che enfatizzano la regolarità delle scritture per smentire queste presunzioni. È una gigantesca e inutile sceneggiata, un gioco delle parti dove tutti hanno una
clamorosa riserva mentale.
La contabilità è prevista anche per i lavoratori autonomi tassati attraverso le aziende
loro clienti, organizzazioni, pubbliche o private, amministrativamente rigide. Una determinazione analitica senza contabilità, confrontando semplicemente elementi positivi
e negativi, già prevista nella legislazione tributaria dal 1956 al 1973, è apparsa e scomparsa, a intermittenza, anche negli ultimi anni.
Una prima forma elementare di contabilità è prevista ai fini dell’IVA dove occorre registrare le operazioni attive (fatture o corrispettivi dei dettaglianti, come rilevato
sopra) e gli acquisti, risultanti dalle fatture dei fornitori. Il confronto tra l’IVA a debito
sulle operazioni attive e l’IVA detraibile deve essere effettuato ad intervalli trimestrali
218
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
o mensili, prende il nome di “liquidazione periodica” (art. 27) e deve effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di riferimento. La liquidazione – com
detto al par. 7.3 – consiste nella somma algebrica tra IVA a debito da un lato,
IVA detraibile ed eventuale eccedenza detraibile del periodo precedente (mese
o trimestre) dall’altro. Il debito eventualmente emergente dalla liquidazione deve essere
invece versato entro lo stesso termine.
Sono adempimenti abbastanza elementari, il che spiega perché la contabilità semplificata delle imprese minori vi faccia riferimento anche per le imposte sui redditi, previa
integrazione con le operazioni non soggette a IVA; ad esempio eventuali retribuzioni
per lavoro dipendente o canoni di locazione.
Questa contabilità semplificata per le imprese minori non riporta gli aspetti
patrimoniali dell’attività, cioè il pagamento dei debiti, l’incasso dei crediti, il patrimonio netto, i fondi di ammortamento, etc...; tale contabilità è consentita per le imprese
individuali e società di persone con ricavi inferiori a 309 mila euro se l’oggetto dell’impresa è la prestazione di servizi oppure a 516 mila euro negli altri casi.
Le scritture contabili previste civilisticamente ed espressamente richiamate dalla normativa fiscale, per le imprese in «contabilità ordinaria», sono sostanzialmente
inutili, ai fini non solo del controllo, ma anche della ordinaria pratica aziendale: il libro
giornale e il libro degli inventari sono di scarsissima utilità ai fini dell’analisi delle operazioni, e dell’individuazione degli aggregati patrimoniali e reddituali; si tratta quindi di
adempimenti che si perpetuano per forza di inerzia, e sono “pratici” nel senso più deteriore del termine, perché non servono a nulla, ma la loro mancanza può essere
fonte di insidiose contestazioni del fisco.
Le scritture correntemente utilizzate, nella quotidiana gestione dell’azienda e nella
pratica dei controlli fiscali, sono piuttosto i singoli conti di contabilità generale, e
i registri IVA, da cui passare poi ai documenti giustificativi; nei conti di contabilità
generale troveremo gli elementi patrimoniali e reddituali indispensabili per redigere il
bilancio, come cassa, crediti, debiti, impianti, ricavi, costi, fondi d’ammortamento e accantonamento, rimanenze, etc... A differenza delle inutili annotazioni cronologiche del
libro giornale, qui gli elementi patrimoniali e reddituali sono raggruppati per materia,
offrendo il dettaglio delle voci di bilancio e della dichiarazione fiscale, nonché il punto
di partenza per individuare la documentazione a supporto di singole operazioni; in sintesi, i livelli di aggregazione contabile sono progressivamente “documenti – libri IVA e
conti di contabilità generale – bilancio”.
Una certa affinità tra adempimenti fiscali e scritture tenute dalle imprese di propria
iniziativa sussiste invece per la c.d. contabilità “di magazzino”, diretta a seguire le
entrate e le uscite delle merci, su cui torneremo al par. 7.16.
Ai fini civilistici, l’inadempimento dei suddetti obblighi contabili rileva solo sul
piano fallimentare e dei rapporti tra soci; un imprenditore, anche di dimensioni
consistenti, potrebbe astenersi dalla tenuta delle scritture contabili senza alcuna conseguenza civilistica, ove non avesse rischi di fallimento. Il diritto civile esclude da adempimenti contabili coloro per i quali non è previsto il fallimento, cioè i piccoli imprenditori, organizzati prevalentemente col lavoro proprio o della famiglia, e i professionisti,
Capitolo 7 – I REDDITI E I CONSUMI...
219
entrambi soggetti ad adempimenti contabili ai fini tributari. Ai piccoli imprenditori e
ai professionisti, quali che siano le loro dimensioni, è inutilmente imposta (par. 3.13) la
contabilità fiscale, esclusa invece sul piano civilistico.
Anche l’obbligo contabile civilistico delle società di capitali è comunque
essenzialmente un adempimento di diritto privato, la cui osservanza è sanzionata
solo eventualmente, dall’azione dei creditori o dei soci di minoranza. Il diritto civile e
commerciale non prevedono infatti sanzioni amministrative.
7.9. L’inerenza nelle imposte sui redditi e nell’IVA: 1) la distinzione tra
costi e consumi
Riprendiamo, calandole nei vigenti sistemi di tassazione dei redditi e dei consumi,
le distinzioni già indicate al paragrafo 1.8 tra “consumo”, colpito dall’IVA, e costo,
necessario alla produzione dei ricavi, e rilevante per la determinazione del reddito. Sia
per la tassazione dei consumi, sia per quella dei redditi, devono essere neutralizzate le
operazioni intermedie, cioè gli acquisti non destinati a un consumo, ma alla produzione
di beni e servizi; ciò serve sia a determinare il reddito, al netto dei costi, sia il consumo, anch’esso al netto dei “consumi intermedi”, come chiarito sopra per l’IVA.
Ai fini dei redditi è necessario eliminare tutti i costi, mentre ai fini IVA è necessario
solo evitare le duplicazioni di tributo; voglio dire che i costi non soggetti ad IVA, come
il lavoro dipendente o gli interessi passivi, non pongono problemi di duplicazione, mentre è importante che l’IVA relativa ad altri costi (ad esempio materie prime o energia)
venga detratta nei modi indicati al par. 7.3. Se però non c’è IVA a monte, per qualsiasi
motivo, non sorge il problema delle duplicazioni: si pensi ad esempio a un garagista che
affitta l’autorimessa da un privato, senza IVA, pagando 70 mila euro, ed incassandone
120 mila più IVA dagli automobilisti clienti. Il canone di locazione sarà deducibile ai
fini del reddito, mentre non rileva ai fini IVA in quanto non è soggetto a tributo, poiché
il percettore non è operatore economico IVA. L’IVA, come tutte le imposte sui consumi, deve sterilizzare quindi le sue precedenti eventuali applicazioni, mentre
il reddito deve dedurre tutti i costi, indipendentemente dall’assoggettamento a un
determinato tributo.
Le spese per il consumo personale o familiare del contribuente, di suoi familiari, amici, etc. sono quindi concettualmente estranee ai componenti negativi
della tassazione ragionieristica attraverso le aziende, in quanto consumi e non
“costi”; il concetto di “onnicomprensività” del reddito di impresa, su cui torneremo
al par. 7.11, si riferisce solo alle attività dell’impresa; è quindi conforme a una corretta determinazione tributaristica della ricchezza escludere l’imputazione all’impresa, di
consumi relativi alla sfera personale o familiare del contribuente o di terzi, quindi consumi e non costi.
Non servono indicazioni legislative per distinguere le spese personali da
quelle imprenditoriali, tra cui possono esserci zone grigie composte da spese che
astrattamente potrebbero anche avere una utilità per l’impresa, come spese di vitto e
220
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
alloggio (di cui il contribuente afferma la necessità in relazione a viaggi d’affari), di
trasporto e per autoveicoli, di rappresentanza etc.
Questa mancata definizione legislativa è del tutto normale, in quanto l’inerenza
di una spesa è concetto eminentemente relativo, che dipende dalla specifica
attività svolta, dalle sue dimensioni, dalla sua organizzazione, dalle sue esigenze promozionali etc. Ad esempio una spesa promozionale di notevole importo può essere
inerente per un grande istituto di credito e non per un parrucchiere; l’acquisto di un
fuoristrada sarà senz’altro inerente per un’impresa mineraria, e non lo sarà per un
ristorante di città.
Il controllo dell’inerenza da parte del fisco non può interferire nel merito delle
scelte imprenditoriali. Per negare l’inerenza di un costo non basta che l’impresa potesse
farne a meno, ma deve risultare – in positivo – che il costo stesso rispondeva a una finalità personale o comunque extraimprenditoriale.
Non sempre, in questi casi, il documento di spesa è autosufficiente per stabilire
con certezza l’inerenza, e potrebbe aprirsi una “fase valutativa”, riferibile spesso a una
molteplicità di documenti di trascurabile importo unitario, come ricevute di ristorante,
biglietti aerei, etc... È uno di quei casi in cui la tassazione attraverso le aziende entra
parzialmente in crisi, perché i documenti non consentono di stabilire con sufficiente
probabilità la natura o la concreta utilizzazione del servizio sottostante. In questi casi
emerge la ritrosia delle istituzioni di controllo per le valutazioni probabilistiche caso per
caso (paragrafo 8.11), e la loro tendenza ad evitare analisi, minuziose e congetturali, sui
singoli documenti; è uno dei casi in cui la tassazione attraverso le aziende non consente
di andare a colpo sicuro, esclusivamente in base al documento, e dove gli uffici hanno
spesso caldeggiato criteri forfetari di deduzione.
La tendenza delle autorità fiscali verso criteri forfetari si salda, in un malinteso desiderio di certezza, col desiderio degli stessi contribuenti di avere punti fermi. Il legislatore vi intravede uno strumento di gettito, e nascono così disposizioni limitatrici
della deduzione ai fini delle imposte sui redditi e della detrazione IVA di alcune spese
sospettate di uso personale; si ricordano gli esempi di quelle relative ad autovetture,
telefonia, rappresentanza, ristorazione, alberghi, biglietti di viaggio.
Questi tentativi di forfetizzare, in via legislativa e per semplicità, la misura dell’utilizzo personale, possono peccare di rigidità nei casi concreti, dando luogo ad alcune
censure comunitarie su limitazioni (autoveicoli) ritenute lesive dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Sono stati quindi aboliti (a fine 2008) i limiti specifici alla
detrazione IVA su spese alberghiere e di ristorazione, nonché automobilistiche, limitate
invece forfettariamente ai fini delle imposte sui redditi (tributo meno esposto alle censure della Corte di giustizia europea).
Finalità repressivo-moralizzatrici, anziché possibili deduzioni di costi personali, ispirano invece l’indeducibilità dei c.d. “costi da reato”, di cui al comma 4-bis dell’art.
14 della legge n. 537/1993; visto che i proventi da reato devono essere confiscati, e
non tassati, la norma ha senso solo se riferita alle modalità penalmente illecite per
ottenere un ricavo lecito. Questa indeducibilità, come pure quella affermata per le
sanzioni amministrative, deroga al già citato principio di onnicomprensività del reddito
Capitolo 7 – I REDDITI E I CONSUMI...
221
d’impresa (par. 7.11) per ragioni in un certo senso di ordine pubblico e di correttezza
gestionale.
Le imposte sui redditi sono indeducibili perché logicamente successive alla
determinazione dell’imponibile (le imposte non sono un costo di produzione, ma
una quota del profitto).
La deduzione fiscale di una “remunerazione figurativa” dell’imprenditore individuale contrasta con l’immedesimazione fiscale (oltre che civilistica) tra impresa e imprenditore; la deduzione dei compensi agli amministratori, ancorché soci, ha senso economico
in quanto qui non c’è immedesimazione, e la deduzione in capo alla società erogante è
accompagnata dalla tassazione in capo all’amministratore. Quest’ultima invece non
avviene per l’imprenditore individuale, e questa logica di “indeduciibilità-intassabilità”
è estesa anche alle remunerazioni dei più stretti congiunti dell’imprenditore medesimo.
7.10.Segue: 2) Inerenza e operazioni attive non soggette a tributo – deduzione interessi passivi
Un diverso tipo di limitazioni alla deducibilità discende invece dalle simmetrie della
tassazione attraverso le aziende, cioè dalla correlazione tra costi e ricavi (par. 3.9),
in caso di ricavi che non concorrono, per varie ragioni, a formare il reddito
imponibile. Dedurre i costi relativi a un ricavo escluso da tassazione, ne farebbe gravare l’importo sul resto dei ricavi imponibili, riducendoli ingiustificatamente. Sottrarre
dall’imponibile elementi positivi, lasciandovi gravare i correlati elementi negativi costituisce quindi una asimmetria (paragrafo 3.9-3.12), che il legislatore tende ad evitare,
con correlazioni specifiche tra elementi positivi e negativi, oppure con criteri proporzionali.
Questi correttivi non scattano, per apposita disposizione legislativa, per gli elementi
positivi “esclusi da tassazione”, come i dividendi intersocietari e le plusvalenze su partecipazioni sociali, la cui mancata tassazione non ha finalità agevolative, ma dipende da
tassazioni in capo ad altri soggetti (vedi il coordinamento tra tassazione delle società e
dei soci al paragrafo 7.17). L’esclusione si differenzia dall’esenzione in quanto la prima riguarda la determinazione della ricchezza, mentre l’agevolazione/esenzione (come
pure la penalizzazione) riguarda profili di meritevolezza economico-sociale, derivanti
da una valutazione politica (par. 1.9).
Il problema non si pone invece per le “esenzioni di redditi netti”, o per le determinazioni forfettarie (agricole, par. 8.2) dove costi e ricavi rientrano nello stesso regime, e
quindi non si creano le asimmetrie indicate sopra.
Problemi analoghi sussistono per le operazioni esenti nell’IVA, in cui non
viene applicata l’IVA sulle operazioni attive, ma simmetricamente è indetraibile l’IVA
sugli acquisti.
L’imposizione sui consumi basata sui corrispettivi ha infatti uno spettro molto più
ampio di quella riferita ai passaggi materiali di beni (paragrafo 5.4); alcune tipologie di
servizi, come il prestito di denaro e le vendite in borsa di titoli azionari, sono caratte-
222
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
rizzate da un corrispettivo, ma sono estranee al concetto di consumo finale; alcuni consumi finali, inoltre, sono socialmente meritevoli, come in campo medico (art. 10 n. 18),
abitativo o didattico (n. 20) etc... Tutti questi servizi sono stati esentati da IVA, ma chi
li presta resta un imprenditore, che senza correttivi avrebbe potuto effettuare massicce
detrazioni IVA sugli acquisti, senza avere a valle alcun consumo tassabile.
Per questo la detrazione di IVA su acquisti specificamente relativi a operazioni
esenti è stata vietata, mentre in caso di acquisti promiscui essa è ammessa in misura
proporzionale al rapporto tra operazioni attive imponibili e operazioni attive totali,
comprese le esenti (art. 19-bis). Tale rapporto è correntemente indicato con l’espressione pro rata e la percentuale da esso derivante sarà applicata all’IVA sugli acquisti,
ottenendo così l’ammontare di IVA detraibile.
In un sistema di tassazione analitica “ragionieristico-contabile”, la deduzione degli interessi passivi erogati a terzi è in linea di principio resa necessaria (per una
delle simmetrie di cui al par. 3.9) dalla scelta di tassare gli interessi attivi in capo al
percettore. Tuttavia gli interessi, come i salari ed i profitti, fanno parte del “valore aggiunto”, cioè della ricchezza oggettivamente prodotta dall’azienda, secondo quanto
indicato al par. 7.6, e ripreso al par. 9.6 sull’IRAP. In questo senso gli interessi passivi, come i salari, non sono “costi come tutti gli altri”, cioè come acquisti di materie prime, energia, servizi di impresa, etc., ma sono “ripartizioni di valore aggiunto”.
Mentre però i salari non possono essere “schermati” rispetto agli effettivi dipendenti,
l’imprenditore può attribuire capitale di prestito, anziché capitale proprio, facendosi
remunerare a titolo di percettore di interessi. Ciò non provoca alcun danno al fisco
fino a che l’interesse dedotto dall’erogante concorre a formare il reddito del percettore
e l’imponibile viene semplicemente spostato da un soggetto all’altro, senza alterazioni
del relativo carico tributario. Quando però il percettore finale è estero, la deduzione
dell’interesse passivo avviene in Italia, mentre la tassazione del corrispondente interesse
attivo avviene all’estero. Alla fine sorge il sospetto di deduzioni di costi, per interessi
passivi, su “patrimonio netto” (apporti dei soci mascherati da debiti), perché magari
l’erogante del credito potrebbe essere una banca italiana, garantita da una banca estera,
a sua volta controgarantita da capitali esteri del socio dell’azienda italiana debitrice
finale. Infatti, dietro i limiti alla deduzione degli interessi c’è il sospetto che talvolta il
capitale di debito si nasconda capitale proprio del socio, mascherato da debito, i cui
interessi sono sottratti alla fiscalità italiana. Questo sospetto, difficile da verificare, comporta correttivi sofisticati, che devono però fare i conti anche con le libertà europee di
circolazione dei capitali /par. 2.6), la non discriminazione degli stranieri, la difficoltà
di individuare l’effettivo beneficiario degli interessi, ed altri profili che rendono difficile trovare un soddisfacente equilibrio tra precisione, cautela fiscale, semplicità, etc...
Oggi come oggi, dopo la soppressione della disposizione sulla “capitalizzazione sottile”
(praticamente ingestibile e vigente fino al 2007) la deduzione degli interessi passivi per le società di capitali e assimilate è limitata a una quota percentuale
della differenza tra costi e ricavi (Margine operativo lordo). È una limitazione che non
scatta, già per legge, quando l’indebitamento deriva da una capacità di credito propria
della società debitrice, come nel caso di fabbricati destinati alla locazione. Tuttavia non
Capitolo 7 – I REDDITI E I CONSUMI...
223
è una sistemazione concettuale soddisfacente, e verosimilmente non rimarrà stabile nel
lungo periodo.
7.11.Principali elementi rilevanti ai fini della dell’IVA e principio di onnicomprensività delle imposte sui redditi
Tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi riconducibili all’impresa, siano
esse ordinarie o occasionali rilevano simultaneamente ai fini delle imposte sui redditi e
dell’IVA. Anche la vendita di un bene strumentale, estranea all’oggetto tipico
dell’attività della specifica impresa, o un servizio collaterale, sono rilevanti ai fini IVA
e delle imposte sui redditi. Queste ultime danno rilevanza, per l’impresa, anche a entrate
e spese non riconducibili al concetto di cessioni di beni o prestazioni di servizi, come
risarcimenti danni, contributi pubblici e privati, perdite da furto o danneggiamento,
indennizzi, e varie altre entrate e uscite fortuite, non riconducibili a “cessioni o prestazioni” in senso tecnico.
La sfera applicativa del reddito d’impresa è quindi più vasta di quella IVA, dove
rilevano solo le operazioni riconducibili al concetto di cessioni di beni e prestazioni di
servizi. Sotto questo profilo ha senso introdurre il concetto di “onnicomprensività”
del reddito di impresa, rispetto all’IVA; ad esso faremo riferimento anche al par.
7.7.13 per il regime dei beni di impresa ed il valore fiscalmente riconosciuto. Segnaliamo qui che questa “onnicomprensività” rende imponibili le plusvalenze su beni
intestati a società, soprattutto di mera detenzione immobiliare, che sono indistintamente titolari (in virtù della loro forma giuridica) di una posizione tributaria “di impresa”,
come rilevato al par. 7.5.
Per classificare l’impresa in un determinato settore economico, nonché per
individuarne le dimensioni, rilevanti ai fini di molti regimi contabili nonché ai fini
dei controlli (paragrafo 7.6), rilevano solo le operazioni tipiche, ordinarie,
cioè i corrispettivi delle cessioni di beni o prestazioni di servizi oggetto dell’attività
caratterizzante (c.d. “ricavi”); al contrario, la maggior parte delle operazioni “atipiche” sono però casi limite, questioni di diritto eleganti, ma poco rilevanti in termini
economici.
Il volume d’affari IVA, esclude solo le cessioni dei beni ammortizzabili, cui corrispondono, ai fini del reddito, le plusvalenze e le minusvalenze su beni strumentali. Ai fini del reddito si escludono anche, dal concetto di ricavi, altri corrispettivi di
operazioni “atipiche” rispetto all’oggetto dell’attività, includendo i corrispettivi delle
eventuali cessioni di materie prime e sussidiarie, destinate a essere consumate nelle prestazioni tipiche dell’impresa.
Ai fini del reddito, le plusvalenze da realizzo di beni strumentali e aziende sono
anche soggette a una tassazione diluita nel tempo (in quote costanti sino a un massimo
di 5 periodi di imposta, in base all’art. 86 comma 4 tuir). Sulle plusvalenze “da valutazione”, cioè meramente iscritte in bilancio, vedi il successivo paragrafo 7.13 sui valori
fiscalmente riconosciuti.
224
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
Le «sopravvenienze» rilevano solo ai fini delle imposte sui redditi, modificando
operazioni già contabilizzate in precedenti periodi d’imposta; sono sopravvenienze “attive” se la modifica è «in meglio e «passive» in caso contrario.
7.12.Il momento impositivo nella tassazione attraverso le aziende (cassa,
competenza, irrilevanza delle mere valutazioni: rinvio alle operazioni straordinarie)
Il riferimento delle imposte a manifestazioni di ricchezza non implica che
questa ricchezza sia “liquida”; le somme necessarie al relativo pagamento possono
anche non provenire dalle manifestazioni di ricchezza tassate, potendo benissimo talvolta provenire dal resto del patrimonio del contribuente.
Questo accade per moltissime imposte, da quelle patrimoniali sul valore degli immobili a quelle sugli autoveicoli, a quella di bollo etc... Quando però si tratta di imposte
relative alle note astrazioni di sintesi, indicate al par. 1.8, come il reddito ed anche l’IVA,
l’esigenza di liquidità è maggiore.
La tendenza di tali tributi è quindi di non costringere, per quanto possibile, il
contribuente ad indebitarsi per pagarli. Il pagamento, la monetizzazione, è il
criterio generale, conforme al principio secondo cui le imposte si pagano, salvo eccezioni, quando si dispone delle risorse economiche per farlo. Una tassazione basata sulla
maturazione degli elementi reddituali, anziché sulla loro realizzazione, tasserebbe
redditi potenziali, con continui “alti e bassi” tra redditi potenziali e perdite potenziali,
che occorrerebbe seguire fiscalmente, con incertezze e inutili controversie.
Alla suddetta esigenza di monetizzazione corrisponde il “principio di cassa”, criterio base, elementare, che guarda al pagamento delle spese e all’incasso dei
compensi. Questo principio, abbastanza comune alle imposte sui redditi deve
essere coordinato con esigenze di precisione di vario genere, come il coordinamento
tra tassazione di società e soci (paragrafo 7.17); l’esigenza di evitare vuoti di imposta
giustifica la tassazione sulle plusvalenze d’impresa in caso di perdita della residenza in
Italia, o di perdita dello status di impresa (trasformazione in società semplice). Anche la
possibilità della società beneficiaria di beni conferiti in natura, di valorizzarli fiscalmente
al relativo valore normale, giustifica una plusvalenza o minusvalenza in capo alla conferente, come vedremo al par. 7.20. Sono altrettanti esempi delle correlazioni concettuali
della tassazione attraverso le aziende, indicate al par. 3.11, che qualche volta comportano
una tassazione senza monetizzazione.
Le ipotesi più diffuse in cui, per esigenze di precisione, diventa rilevante fiscalmente ricchezza illiquida sono tuttavia nella determinazione dell’IVA e nel
criterio di competenza per il reddito di impresa. In entrambi i tributi, il semplice principio di cassa porterebbe a una distribuzione troppo imprecisa degli imponibili, anche rispetto agli ordinari criteri di gestione delle attività, ed alla precisione
economico-contabile.
Non è una scelta di cautela fiscale, a vantaggio delle “ragioni del fisco”, tanto è vero
Capitolo 7 – I REDDITI E I CONSUMI...
225
che la deroga al principio di cassa consente anche di dedurre costi e detrarre importi di
IVA non ancora pagati ai fornitori. Il sistema della competenza, insomma, attribuisce
rilevanza anche alla nascita dei crediti e dei debiti, secondo una tempistica che
diremo tra un attimo, a seconda dei tipi di operazioni. Queste ultime possono diventare
infatti rilevanti fiscalmente non solo quando ne avviene la manifestazione monetaria, in
denaro o in natura, ma anche quando si perfezionano i relativi rapporti giuridici, cui in
genere corrisponde la nascita di crediti e debiti rispetto alle relative controparti. Alla nascita del debito o del credito corrisponde infatti la relativa “maturazione” dell’elemento
di ricchezza, individuato però, anche per esigenze di certezza e semplicità applicativa,
coi momenti puntuali che seguono.
Per le cessioni di beni, nelle imposte sui redditi e nell’IVA, si segue, prescindendo
dal pagamento, il criterio della consegna del bene o della stipula dell’atto, se si
tratta di beni immobili. Quando alla consegna non si accompagna il passaggio della proprietà, per condizioni o termini, così come per la necessità di effettuare prove, esprimere
gradimenti, concordare il prezzo “ex post”, l’imputazione a periodo è tendenzialmente
differita al verificarsi dell’evento.
Per le prestazioni di servizi si guarda all’ultimazione nelle imposte sui redditi,
tornando invece al principio di cassa ai fini dell’IVA. Quest’ultima si rende dovuta in
ogni caso qualora la fattura sia emessa prima del momento impositivo; ad esempio nel
settore delle telecomunicazioni, del gas, dell’energia elettrica, si procede comunque, per
snellezza aziendale, alla fatturazione, anche nei confronti di privati consumatori finali
ed anche prima dell’incasso, con notevoli anticipazioni di IVA rispetto al pagamento
(par. 7.12).
Per le prestazioni il cui corrispettivo si distribuisce proporzionalmente al passare del
tempo, come per gli interessi, i canoni di locazione e i premi assicurativi, vanno imputate al periodo d’imposta in proporzione alla quota in esso maturata (ovviamente
anche qui sia dal lato dei costi sia da quello dei ricavi). La normativa fiscale dà qui rilevanza al concetto aziendalistico di ratei e risconti.
I suddetti momenti specifici di competenza, sono dettati solo per le cessioni di beni
o le prestazioni di servizi, coprendo completamente l’area dell’IVA (dove non esistono
operazioni diverse da cessioni e prestazioni). Nel reddito d’impresa restano invece senza
regole precise gli altri elementi reddituali (ad esempio rinunzie, transazioni, risarcimenti
danni, indennizzi assicurativi, controversie giudiziarie, incassi di dividendi). Il criterio
tendenziale è quello della “maturazione” e della certezza giuridica, anche se spesso per
esigenze di sicurezza operativa la normativa fa riferimento al buon vecchio “principio
di cassa”.
Il pagamento può essere anticipato, rispetto alla maturazione economica della prestazione, attraverso acconti, irrilevanti ai fini del principio di competenza nelle imposte
sui redditi. Nell’IVA, che colpisce il consumo, rileva anche questo pagamento di acconti, o persino la fatturazione anticipata rispetto ai momenti impositivi suddetti, beninteso
limitatamente all’importo fatturato o pagato; naturalmente, se poi l’operazione non va
a buon fine, la formalizzazione IVA dell’anticipazione sarà corretta (in gergo contabile
“stornata”) mediante le note di credito descritte al par. 7.7.
226
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
Finora ci siamo posti il problema della rilevanza fiscale dei rapporti con i terzi, acquirenti o fornitori di beni o servizi; è una serie di questioni talvolta chiamate di
“competenza esterna” (cioè verso i terzi) per distinguerle da quelle in cui il reddito
viene influenzato dalle valutazioni di elementi patrimoniali attivi e passivi, senza rapporti giuridici con terzi, come gli accantonamenti, gli ammortamenti, le rimanenze, e
altre questioni di “valutazione del patrimonio aziendale” (o “competenza interna”), che
esporremo al paragrafo 7.15.
La suddetta applicazione dell’IVA “per competenza”, su operazioni non ancora pagate dal cliente, può porre dei problemi di liquidità al fornitore; d’altra parte il cliente
potrà detrarre la relativa imposta anche se non l’ha pagata. Quest’anticipazione all’Erario di IVA che il fornitore deve ancora riscuotere è da sempre oggetto di una deroga
quando i clienti sono enti pubblici e assimilati, notoriamente pagatori “tardivi” (regime
di IVA ad esigibilità differita). Negli ultimi mesi (2012) sono stati introdotti correttivi
tendenti alla cosiddetta “IVA per cassa”, con riflessi anche in capo alla detrazione per il
cliente e varie complesse condizioni per cui è preferibile rinviare ai siti di riferimento
di questo testo (nello specifico www.fondazionestuditributari.com).
La detrazione IVA, a differenza della deduzione dei costi pluriennali nelle imposte sui redditi, spetta immediatamente anche per acquisti con utilizzabilità pluriennale,
come pure per i beni ancora in giacenza (rimanenze finali). È una soluzione conforme
alla natura dell’IVA come imposta sui consumi, dove la detrazione ha semplicemente
lo scopo di “neutralizzare” l’IVA sulle operazioni che non rappresentano consumi, ma
costi; non c’è quindi motivo per distinguere tra detrazione IVA su materie prime e
servizi rispetto a beni strumentali.
Le rettifiche sulla competenza sono un esempio classico di “contestazione interpretativa” (paragrafo 5.17), cui si accompagna al massimo, per il fisco, un danno
meramente finanziario, cioè la percezione del tributo in ritardo (paragrafi 3.9-3.12
sulle “simmetrie fiscali”). Quando arriva l’accertamento, l’imposta è stata in genere
già pagata, sia pure in un momento successivo, e qualche volta era stata addirittura
pagata in un momento precedente. Tuttavia, nel consueto formalismo legalistico, le
rettifiche in esame sono state frequentissime per decenni con una enorme dispersione di tempi amministrativi e professionali. Per alcuni anni le violazioni sull’imputazione a periodo sono state la più frequente contestazione interpretativa, i cui
effetti di duplicazione di imposta sono stati arginati, con un intelligente assestamento
giurisprudenziale, consentendo riliquidazioni del tributo, da richiedere quando la
controversia è divenuta definitiva.
7.13.Il valore fiscalmente riconosciuto e l’esposizione in bilancio dei beni
di impresa, tra criteri patrimoniali e reddituali
La determinazione differenziale dell’IVA è “imposta da imposta” tipica di
un tributo sui consumi (par. 7.3 ss.), senza le valutazioni del patrimonio, di cui diremo
in questo paragrafo e ai successivi 7.14 e seguenti per i tributi sui redditi.
Capitolo 7 – I REDDITI E I CONSUMI...
227
Questi ultimi confrontano ricavi e corrispettivi di periodo, relativi a beni ceduti
o servizi prestati, con i costi di produzione o i valori patrimoniali di tali beni A tal
fine, soprattutto nelle grandi aziende, sono importanti anche valutazioni di elementi
patrimoniali, effettuate facendo riferimento al relativo “valore fiscalmente riconosciuto”; quest’ultimo “costo fiscale” dei beni può essere, a seconda delle tipologie, ammortizzato, oppure consumato per la produzione e contrapposto al prezzo di vendita.
Ai fini delle imposte sui redditi, infatti, l’onnicomprensività del reddito d’impresa
(par. 7.11), e la sua determinazione differenziale richiedono la valorizzazione dei
cespiti aziendali, in vista di quando ne avverrà il “realizzo”, ad esempio per
vendita, per transazione per perdita, nei momenti “di competenza”, indicati al paragrafo
7.12 sull’imputazione a periodo.
Il suddetto valore “fiscalmente riconosciuto” prende le mosse dal costo,
maggiorato da quello di successivi incrementi e miglioramenti, e diminuito di ammortamenti e svalutazioni fiscalmente deducibili, secondo le simmetrie di cui al par. 3.9:
questo valore fiscale si trasmette e si modifica da un periodo d’imposta all’altro,
con i meccanismi delle “valutazioni di bilancio” (7.14 ss.), ad esempio variazioni
di rimanenze, ammortamenti e accantonamenti, secondo l’intuitiva continuità
temporale della tassazione attraverso le aziende e dei collegamenti tra i diversi periodi
di imposta, secondo le sistemazioni concettuali di cui al già citato paragrafo 3.9.
Il valore fiscalmente riconosciuto è molto semplice per i beni esposti, nelle
scritture contabili e nel bilancio, con un criterio patrimoniale, come i beni “strumentali” ad utilità pluriennale, ad esempio gli impianti, i fabbricati, gli automezzi; il
relativo valore sarà diminuito con le quote di ammortamento, che ne esprimono anno
per anno il contributo alla produzione, come vedremo al par. 7.15; lo stesso valore potrà salire per il sostenimento di spese incrementative, migliorie e simili. Al momento
della loro eventuale cessione, la differenza tra corrispettivo conseguito e valore fiscale
come sopra determinato, darà luogo a «plusvalenze o minusvalenze», (par. 7.11,
secondo i criteri di continuità e simmetria contabile esposti al par. 3.9). Lo stesso criterio “patrimoniale” si applica per i crediti e i debiti.
Perché i valori fiscali aumentino occorre quindi sostenere un costo verso terzi,
ricevere un apporto di capitale, o realizzare redditi propri; nella tassazione attraverso le
aziende, ogni costo, o aumento del valore fiscale di riferimento di beni aziendali, corrisponde tendenzialmente a un elemento reddituale di segno opposto di altri soggetti, a
un apporto o a un reddito dello stesso titolare.
Ci dovrebbe essere così continuità di valori fino al momento della vendita
dei beni (o eventi assimilati, accomunati dall’espressione generale di “realizzo”), evitando sia le doppie imposizioni sullo stesso valore sia «i salti d’imposta», cioè l’acquisizione
“in franchigia fiscale” di maggiori valori senza realizzare componenti positive di reddito. Sono punti di riferimento indispensabili per distinguere, come indicato al par. 4.8, la
lecita pianificazione fiscale dall’abuso del diritto.
Ricordiamo che i corrispettivi ed i valori fiscali suddetti non sono oggetto di correttivi a fronte dell’inflazione monetaria (perdita di valore della moneta), introdotti
in alcuni paesi solo quando l’inflazione raggiungeva livelli macroscopici, ad esempio
228
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
in alcuni stati sudamericani. Per questo apposite disposizioni normative di “tassazione
volontaria” consentono di dare rilevanza fiscale a rivalutazioni causate anche dall’inflazione, a fronte del pagamento di una imposta sostitutiva; è una specie di “prestito di
imposta”, uno scambio dove il contribuente “investe” nell’aumento dei valori fiscali;
pagando subito una imposta sostitutiva egli guadagna maggiori costi fiscali di riferimento, da cui giungeranno nei successivi periodi di imposta maggiori costi, deducibili
ad aliquota ordinaria (su questo schema di “rivalutazioni a pagamento” par. 7.20 per le
fusioni, cessioni d’azienda e altre operazioni straordinarie).
Questa esposizione “patrimoniale” (“a patrimonio”) sarebbe troppo complessa
per i beni di magazzino, gestiti in modo “seriale”, ripetitivo, di massa, con continui incrementi per acquisti e prelievi per vendite.
I beni la cui cessione dà luogo a ricavi sono quindi esposti in bilancio “per masse”
col criterio c.d. “costi ricavi e rimanenze” che ritroveremo anche per le rimanenze
finali (par. 7.16). Quando viene acquistata una materia prima, si guarda solo l’aspetto
reddituale, registrando un costo a fronte del debito verso il fornitore, trascurando di
avere in magazzino una merce con un valore reale. In altri termini, l’acquisto di “beni
merce” viene trattato come il pagamento degli operai, o delle utenze di energia, senza
considerare l’aspetto patrimoniale, che emerge invece a fine anno, coi criteri delle rimanenze finali, di cui diremo al paragrafo 7.16, sulle valutazioni del patrimonio aziendale.
I beni in esame sono valorizzati per masse proprio per il loro continuo turnover, con “entrate e uscite” che renderebbero complicatissime valorizzazioni singole;
le entrate e uscite dal magazzino di tali beni sono seguite attraverso la contabilità “di
magazzino” e la loro valorizzazione avviene attraverso la contabilità industriale, come
diremo al par. 7.16.
La ragione è anche qui ragionieristico contabile, legata alla produzione di serie, che
si rinnova continuamente e non può essere analiticamente seguita, per ogni singolo
bene, nelle scritture contabili.
Anche le passività e le voci del patrimonio netto hanno un “valore fiscale”
corrispondente concettualmente a quello indicato per le attività: se un accantonamento, una svalutazione, fiscalmente deducibile, abbatte il valore fiscale dell’attivo, lo stesso
deve accadere se invece viene esposta come posta rettificativa nel passivo: un fondo
dedotto (cioè costituito con accantonamenti deducibili) non è liberamente disponibile
ai fini fiscali, e diventa imponibile, a titolo di sopravvenienza attiva, come vedremo, se
utilizzato per fini diversi da quelli per cui fu costituito. Se invece il fondo nasce con
accantonamenti non dedotti, è liberamente disponibile ai fini fiscali e viene chiamato
“fondo tassato”. La stessa imponibilità dei “fondi dedotti” si verifica, a maggior ragione
quando un debito viene meno in tutto o in parte.
Le voci di patrimonio netto sono fiscalmente franche, in quanto derivano da
apporti, da utili tassati o non tassabili, salvo il caso dei fondi in sospensione d’imposta,
a fronte dei quali è concesso aumentare i valori fiscali dell’attivo, ma che sono tassabili
ove si verifichino determinati eventi (in genere la distribuzione ai soci).
I beni dell’azienda, come l’attività di chi ci lavora, hanno valore in quanto
organizzati e coordinati tra di loro, come rilevato già al paragrafo 3.1 calando
Capitolo 7 – I REDDITI E I CONSUMI...
229
l’azienda in generale nel contesto tributario. Anche i macchinari, gli aerei delle compagnie intercontinentali, le centrali nucleari, i camions, le gru hanno un valore perché
esiste una “organizzazione aziendale in funzionamento”. Se guardiamo alla possibilità
di vendere sul mercato i singoli cespiti aziendali, come tali, i valori espressi nei bilanci aziendali sarebbero spesso inattendibili, ma così non è in quanto l’esposizione al
costo sottintende la possibilità di recuperarlo “attraverso l’attività”. L’insieme
dei costi sostenuti esprime quindi il valore dell’avviamento aziendale, ripartito sulle
singole voci di bilancio, dagli immobili, agli impianti, alle attrezzature. L’avviamento
può anche essere negativo, quando si pensa che l’attività non riuscirà a recuperare i costi
sostenuti per impiantarla.
Una evidenziazione autonoma dell’avviamento si ha quando l’azienda viene
acquistata nel suo complesso da chi paga un prezzo superiore all’insieme dei costi storici
dei beni aziendali (par. 7.20). Questo valore viene definito di solito, nel bilancio dell’acquirente, come «avviamento», perché non ha riscontro nei singoli valori dei beni, già a
loro volta influenzati dalla suddetta componente intrinseca di “avviamento”. Quest’ultimo, più che prospettive di redditività futura, esprime la vitalità dell’azienda, la “possibilità di stare sul mercato”, e di essere acquisita da qualche operatore del settore, anche
se permanentemente in pareggio o perdita. È perciò intuibile la diffidenza civilistica,
sul piano della tenuta patrimoniale della società (e senza riflessi tributari), verso l’iscrizione in bilancio di avviamenti non “misurati dal mercato”, come nel suddetto
pagamento di un prezzo e la richiesta di perizie accurate per gli avviamenti iscritti in
caso di conferimenti di azienda e di fusioni (par. 7.20).
7.14.Valutazioni fiscali di fine esercizio e rapporti col bilancio
Il bilancio civilistico non è un libro contabile, né è destinato alla registrazione
dettagliata di singoli documenti. Il bilancio è piuttosto un prospetto riepilogativo,
dove viene esposta, riassumendola in quattro sezioni (attività, passività e patrimonio,
elementi positivi e negativi del reddito) la situazione patrimoniale e reddituale
dell’azienda. Questa esposizione avviene per motivi civilistici, ma viene riutilizzata
a fini amministrativo-tributari, come avviene –secondo lo schema base rilevato al par.
3.5 – per gran parte della documentazione aziendale.
L’azienda, con il bilancio, “si guarda dentro” e cerca di capire l’andamento degli “affari propri”, cioè quanta ricchezza è stata prodotta e come è stata distribuita tra i vari
soggetti coinvolti nell’attività di questo gruppo sociale (appunto, l’azienda). Per questo
motivo, con l’auspicata “istituzionalizzazione delle aziende” al bilancio guardano anche
i dipendenti, i creditori, gli investitori, i consumatori, gli organi pubblici di vigilanza, ad
esempio dei prezzi, del credito, delle concessioni pubbliche, dei mercati finanziari, della
concorrenza, etc...
Il sistema di documentazione aziendale, e di scritture contabili, è necessariamente uno solo: i rapporti giuridici con i terzi, ed anche i relativi documenti, sono
sempre i medesimi, e non cambiano certo in relazione alle diverse finalità delle varie
230
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
consuntivazioni di fine esercizio. Bilancio e reddito fiscale sono accomunati dall’unicità dei documenti e delle registrazioni contabili sottostanti. Non avrebbe senso che i
corrispettivi di vendita, i versamenti e i prelevamenti bancari, fossero diversi ai fini tributari da come sono ai fini civilistici. È invece del tutto naturale che, in relazione alle
finalità delle rendicontazioni, cambino i criteri di stima e di rappresentazione
delle poste c.d. “valutative”, stimate alla fine dell’esercizio sociale per le operazioni
in corso (ad esempio ammortamenti, accantonamenti, ratei, risconti, rimanenze e altre operazioni in corso a fine anno).
Su questi aspetti valutativi le soluzioni possono essere diverse, tenendo conto di
come il diritto civile contempera le stesse esigenze di precisione, semplicità, certezza dei
rapporti, e altre che caratterizzano la determinazione di ricchezza anche in sede fiscale
(ma con preoccupazioni e priorità diverse, come vedremo).
Le regole civilistiche sul bilancio, infatti, si inseriscono in una regolamentazione
di rapporti interprivati, contratti ed obbligazioni; in questo contesto, il consenso dei
soci o la mancanza di interesse dei creditori, possono superare qualsiasi potenziale
controversia; persino la omessa redazione del bilancio, se si pagano i debiti ed i soci
sono consenzienti, è priva di conseguenze sanzionatorie, salva eventualmente la messa
in liquidazione d’ufficio da parte della camera di commercio, presso cui è tenuto il
registro delle società.
I vantaggi fiscali ottenibili forzando le valutazioni di bilancio sono relativamente
secondari; al massimo un temporaneo differimento delle imposte, o il tentativo,
sostanzialmente legittimo, di bilanciare utili e perdite.
A parte questi lievi vantaggi, la collocazione degli elementi reddituali in un periodo
d’imposta anziché in un altro non produce alcun danno erariale.
Eppure considerando autonomamente il singolo periodo di imposta possono emettersi accertamenti rendicontabili, come risultato di servizio, in termini di “maggiore
imposta accertata”. Non solo sono contestazioni interpretative, ma riguardano solo la
distribuzione della ricchezza tra un periodo di imposta e l’altro, fino al paradosso degli
“accertamenti di imposte già pagate”, quando secondo l’ufficio la competenza dei costi
era anteriore e quella dei ricavi posteriore rispetto ai periodi di imposta utilizzati dal
contribuente (paragrafo 5.18).
Con la riforma tributaria si pensò di ridurre le contestazioni sull’imputazione a
periodo fissando alcune regole fiscali più precise, con margini di valutazione minimi e massimi al cui interno il contribuente può regolarsi senza ulteriori condizioni. Sugli aspetti convenzionali e valutativi possono infatti esserci, tra diritto civile
e tributario, differenti compromessi tra precisione, semplicità, facilità di rilevazione,
coerenza con i bilanci degli anni precedenti, prudenza, etc.; ai fini tributari, invece,
le valutazioni di bilancio riguardano una prestazione di diritto amministrativo, con le
contestazioni giuridico-interpretative indicate al paragrafo 5.18, rispetto alle quali c’è
bisogno di certezza.
Questa possibilità di valutazioni parzialmente divergenti potrebbe giustificare un «bilancio fiscale» autonomo, in cui effettuare le valutazioni ai fini tributari; il
“bilancio fiscale”, come documento autonomo, invece non è previsto, e il reddito
Capitolo 7 – I REDDITI E I CONSUMI...
231
d’impresa parte dall’utile o dalla perdita del conto economico civilistico (art.
83 TUIR). Al bilancio dovranno essere apportate, nella dichiarazione dei redditi, le
variazioni conseguenti all’applicazione dei criteri valutativi fiscali. Ciascuna variazione
potrà tendere ad aumentare il reddito fiscale rispetto al risultato civilistico (nel qual caso
si parla di «variazioni in aumento») ovvero diminuirlo (variazioni in diminuzione).
Alcune variazioni riguardano divergenze strutturali tra bilancio e imponibile fiscale, come costi definitivamente non deducibili (ad esempio le imposte sul reddito o la
retribuzione dell’imprenditore paragrafo 7.9) ovvero proventi non tassabili per ragioni
di tecnica tributaria (ad esempio i dividendi o le plusvalenze, in tutto o in parte non
tassati per evitare duplicazioni tra la tassazione delle società e quella dei soci, vedi infra
par. 7.17) oppure per ragioni agevolative.
Concettualmente, il sistema appena indicato consentirebbe di apportare qualsiasi variazione, derivante dai criteri fiscali di valutazione, al bilancio civile; la suddetta tecnica
delle variazioni in aumento e in diminuzione consentirebbe di usare ai fini civilistici
determinati criteri, e usarne altri ai fini fiscali, in reciproca autonomia dei rispettivi
criteri valutativi.
Nella confusione sociale sull’idea stessa di azienda (paragrafo 3.1) diffidenze e sospetti dilagano, e non è chiara la differenza del patologico falso in bilancio rispetto alla
divergenza tra valutazioni civilistiche e fiscali. Ne è derivato il divieto di dedurre
fiscalmente elementi negativi di reddito non previamente imputati al conto
dei profitti e delle perdite (art. 109 comma 4 TUIR); chi volesse quindi avvalersi di
deduzioni “valutative”, ammesse dalla norma fiscale, dovrebbe imputarle anche al conto
economico, con un «inquinamento» del bilancio civilistico, rischi di impugnativa del
bilancio da parte di altri interessati, etc... Ulteriore implicazione è la rilevanza, anche
fiscale, delle rivalutazioni delle rimanenze di merci e di titoli, effettuate in bilancio.
Sono vincoli facilmente rispettabili per le società non esposte a impugnative di
bilancio da parte di soci di minoranza, mentre le grandi strutture amministrative, soprattutto quotate in borsa, sono costrette a scegliere tra la convenienza fiscale e una
corretta esposizione in bilancio degli elementi valutativi. È un ulteriore inutile stress, a
danno dell’istituzionalizzazione delle aziende, di un ambiente sociale economicamente
arretrato.
Un equilibrio soddisfacente tra i profili appena accennati non sarà certamente
trovato in tempi rapidi, ma da alcuni anni sembrano intravedersi, in un clima di confusione, timide aperture verso una rilevanza fiscale delle valutazioni fatte ai fini
civilistici dalle società quotate in borsa, dalle banche o dalle assicurazioni tenute ad
applicare i cd. principi contabili internazionali (IAS: International Accounting standards); si tratta infatti di strutture affidabili, non solo perché spersonalizzate, ma perché i
dirigenti che le conducono sono valutati dal mercato in base al bilancio, e preferiscono
rinunciare a una convenienza tributaria piuttosto che peggiorare la loro immagine di
bilancio. Per questo è stata data una certa rilevanza anche fiscale ai principi contabili internazionali per le valutazioni di bilancio delle società quotate in borsa e di
quelle bancarie e finanziarie, secondo un intreccio complesso, dove però –in buona
232
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
sostanza – gli uffici tributari reinterpretano i principi contabili per formulare prolisse,
evanescenti ed inutili contestazioni interpretative (par. 5.18).
Ai paragrafi successivi esporremo alcune possibili convergenze e divergenze valutative tra criteri civilistici e tributari, relativamente ad alcune importanti poste di bilancio.
7.15.Le valutazioni del patrimonio di fine esercizio 1) ammortamenti e
accantonamenti
Abbiamo già parlato al paragrafo 7.12 della “competenza esterna”, cioè dell’imputazione a periodo degli elementi reddituali relativi ai rapporti giuridici con terzi,
acquirenti o fornitori di beni o servizi. Per determinare il reddito imponibile bisogna
però anche valutare gli elementi patrimoniali attivi e passivi per i quali, nel periodo
d’imposta di riferimento sono mancati rapporti con terzi, che non riguardano
rapporti giuridici con altri soggetti. Qualcuno definisce correttamente queste valutazioni come “competenza interna” o più propriamente “valutazione del patrimonio aziendale”.
Gli ammortamenti riguardano l’imputazione al periodo di imposta di quote costi
in precedenza coi fornitori esterni, per beni strumentali utilizzabili in una pluralità di
anni. Il costo dei beni patrimoniali “strumentali”, come gli impianti e i macchinari,
viene così dedotto “pro quota” attraverso aliquote percentuali, stabilite con regolamento per settore economico e tipo di bene; il minor ammortamento derivante dall’adozione di un’aliquota inferiore può essere recuperato, conformemente al principio di
continuità dei valori fiscali, alla fine del periodo di ammortamento corrispondente alle
aliquote ordinarie.
Le quote d’ammortamento sono calcolate cespite per cespite per gli immobili o i
mobili iscritti in pubblici registri, mentre gli altri beni sono raggruppati per categorie
omogenee in base all’anno di acquisizione e all’aliquota applicabile.
È un compromesso tra precisione e semplicità, alla quale si viene incontro anche con
la facoltà di dedurre immediatamente, senza ammortamento, le spese per acquistare beni di costo unitario non superiore a 516 euro.
I beni immateriali, come i diritti di brevetto, di marchio, etc., sono invece ammortizzabili in base alla durata di utilizzazione prevista dalla legge (brevetti) o dal contratto
(art. 103 TUIR).
I costi pluriennali si distinguono dai beni immateriali perché a fronte di essi non
esiste alcun bene o diritto provvisto di un proprio valore di mercato e quindi suscettibile di essere alienato a terzi. Basta pensare alle spese di pubblicità, di ricerca e sviluppo, di
formazione del personale, che è consentito non dedurre immediatamente, ma “suddividere” nell’arco di una pluralità di esercizi. Un esempio particolare di costo pluriennale,
che non ha “in sé” valore intrinseco (come gli altri sopra indicati), ma che aumenta il
valore intrinseco di altri beni, sono le spese di manutenzione.
Anche l’avviamento (par. 7.13), sebbene sia regolamentato nell’ambito dei beni immateriali (art. 103 comma 3), costituisce un costo pluriennale secondo i criteri suddetti.
Capitolo 7 – I REDDITI E I CONSUMI...
233
Gli accantonamenti riguardano l’anticipazione al periodo di imposta di costi destinati a manifestarsi in futuro. Il funzionamento contabile degli accantonamenti è il
medesimo già mostrato a proposito dell’ammortamento: la quota di accantonamento
costituisce una componente negativa del reddito e il fondo di accantonamento viene
costituito nella contabilità. Alla base dell’accantonamento c’è un elemento previsionale e fortemente opinabile, perché si riferisce a costi ancora da sostenere, a differenza dell’ammortamento, riferito invece a costi già sostenuti.; c’è quindi una certa
diffidenza del fisco verso gli accantonamenti, fiscalmente deducibili solo in casi tassativi ed in percentuali limitate, come per le perdite su crediti (art. 106), ovvero quando
sostanzialmente dietro di essi c’è un debito già maturato, anche se non esigibile, come
accade per il TFR dei dipendenti (art. 105 TUIR), o una prestazione da svolgere in
futuro, come per le “riserve tecniche” delle imprese di assicurazioni.
7.16.Le valutazioni di fine esercizio: 2) rimanenze di beni e servizi
La valutazione del patrimonio aziendale non riguarda solo gli elementi
esposti “a patrimonio” (trattati al par. precedente), ma anche quelli esposti “a costi
ricavi e rimanenze”, sempre secondo le distinzioni di cui al precedente paragrafo
7.13.
Le rimanenze servono a rettificare, a fine esercizio, le registrazioni dei ricavi e dei
costi relativi a merci, materie prime e prodotti finiti, effettuate senza rilevare nella contabilità generale, per i già indicati motivi di semplicità, i corrispondenti aumenti delle
scorte (per i costi) ovvero le loro diminuzioni, per i ricavi. La determinazione del
reddito ha quindi bisogno di essere aggiustata al termine dell’esercizio, il che avviene
valorizzando le rimanenze finali. Senza questo aggiustamento, il reddito dei periodi
in cui si accumulano le rimanenze verrebbe depresso a favore del reddito dei periodi in
cui i beni vengono venduti: poco male se si tratta di piccoli commercianti o artigiani,
dove il calcolo delle rimanenze è spesso secondario, e finalizzato soprattutto a verificare
la credibilità dei ricavi registrati. Col crescere delle dimensioni aziendali, e quindi delle
rimanenze, la loro valutazione corretta diventa importante ai fini dell’utile di esercizio
e dell’imponibile fiscale.
Proprio per la loro importanza, e continuità, i movimenti di magazzino non
sono registrati nella contabilità generale, ma nella “contabilità di magazzino”; si
tratta di una registrazione cronologica, tenuta a quantità (non a valore), prevista per tutte
le imprese di una certa dimensione e comunque importante ai fini gestionali; questa
contabilità è una forma di “partita semplice” che registra i “carichi” e gli “scarichi” di
merce, ad esempio per vendite o prelievi destinati alla produzione.
Da queste scritture emergono quindi sempre, durante tutto il corso dell’anno, le
“giacenze teoriche di magazzino“, chiamate anche “inventario contabile”; queste risultanze sono oggetto di verifiche a campione attraverso «inventari fisici», cioè
materiali conteggi di tipologie di merci in giacenza. È un monitoraggio che si svolge in
corso d’anno, ma che si concentra a fine esercizio, per la valorizzazione in bilancio delle
234
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
rimanenze. L’“inventario contabile”, potrebbe essere viziato da distruzioni, furti, carichi
o scarichi a magazzino non registrati per dimenticanza.
A tal fine occorre prima di tutto individuare i beni in rimanenza, valorizzati per “categorie omogenee”, gestite in modo ripetitivo, come ad esempio le lavatrici prodotte
da una industria di elettrodomestici saranno distinte dai frigoriferi, dagli scaldabagno e
simili, in distinte categorie omogenee.
Anche per la valutazione fiscale delle rimanenze il punto di riferimento è “il
costo”. Dato che si tratta di beni acquistati o prodotti in serie, in modo continuativo,
con un ricambio continuo e costi variabili, occorre anche decidere “a quale costo”
valorizzarli; per i beni prodotti in serie non avrebbe infatti, senso economico, determinare lo specifico costo effettivo dei beni fisicamente in rimanenza. Si useranno
quindi i costi medi di periodo, calcolati tenendo conto dei costi delle materie prime,
del lavoro, dei macchinari industriali, in genere secondo una apposita contabilità
dei costi (detta anche “contabilità industriale”, elaborata da ogni azienda secondo
le sue particolarità produttive).
Se i prezzi dei fattori produttivi mutano nel tempo, la convenzione più precisa è
valorizzare le merci in rimanenza secondo i costi più recenti, con metodo c.d. FIFO.
Un diverso criterio, più prudenziale in periodi di inflazione, è invece quello di valorizzare le merci ai costi più vecchi (c.d. “LIFO” per cui valgono – mutatis mutandis – le
riflessioni svolte nella nota che precede). Possono così formarsi stratificazioni di valori
per anni di formazione, in quanto queste determinazioni dei costi medi sono svolte per
periodi annuali (art. 92 TUIR).
La svalutazione delle rimanenze è ammessa quando il prezzo di mercato scende
al di sotto del costo; in questo caso l’intera categoria omogenea può essere valutata in
base al prezzo di mercato, comprese le stratificazioni annuali per cui ciò dovesse comportare una rivalutazione, anziché una svalutazione.
Le decisioni di svalutare o meno possono essere effettuate per “categoria omogenea”
di beni in rimanenza, secondo le convenienze gestionali, senza essere tenuti a svalutare
“tutte” le categorie per cui ne sussistano i presupposti. Secondo le regole delle “valutazioni patrimoniali”, anche le rimanenze non devono necessariamente essere svalutate
quando ne ricorrono per la prima volta i presupposti, ma anche successivamente, fino a
che questi presupposti restano.
Non si valutano solo i beni, ma anche i servizi. I servizi in corso di esecuzione al
termine dell’esercizio, benché vi sia un committente e un prezzo contrattuale (si pensi
a servizi di manutenzione, ristrutturazione, etc.) sono valutati in base ai costi sostenuti (art. 92 comma 6). Se invece la prestazione ha un tempo di esecuzione ultrannuale
diventa rilevante il prezzo contrattuale, e deve essere valutata (art. 93 TUIR) in base
alla quota parte di corrispettivi pattuiti proporzionale ai lavori già svolti.
7.17.Coordinamento tra tassazione delle società e dei soci
Mentre l’impresa individuale contiene prevalentemente attività di “lavoro indipendente”, al massimo con alcuni collaboratori, le organizzazioni aziendali si trovano
Capitolo 7 – I REDDITI E I CONSUMI...
235
in genere all’interno di società; solitamente si tratta di società “di capitali”, più raramente “di persone”.
Mentre il reddito delle imprese individuali è tassato immediatamente in capo al
relativo titolare, la diversità soggettiva tra società e soci pone problemi di coordinamento. Lo stesso reddito, infatti, può essere osservato da angolazioni diverse, in momenti
diversi, in capo alla società e in capo al socio. Occorre quindi un coordinamento tra
questi due punti di osservazione di una ricchezza economicamente identica, che
si presenta varie volte, sotto forme giuridiche diverse; dapprima il reddito della società,
poi i dividendi o gli utili o perdite da cessione della partecipazione (plusvalenze o minusvalenze).
In base al principio di neutralità della tassazione rispetto alle forme giuridiche, occorre
un coordinamento per evitare che uno stesso flusso reddituale venga tassato varie
volte, solo perché prodotto in forma societaria e non in forma individuale (si pensi ai
casi di “soci intermedi” prima di quelli finali); la tassazione in base alla ricchezza verrebbe
distorta dando rilevanza a un profilo esclusivamente giuridico-formale, come l’esercizio
dell’attività in forma individuale o societaria (violazione del principio di neutralità).
Anche senza uniformare con precisione ragionieristica la tassazione su queste due
forme giuridiche di esercizio dell’attività, un qualche coordinamento è concettualmente necessario, e di fatto esiste in quasi tutti i paesi del mondo. Alcuni paesi legittimano
un qualche aggravio di tassazione, per le attività esercitate in forma societaria, giustificandolo in base alle maggiori possibilità di raccogliere capitali, accedere al credito, o
persino contrastare la formazione di aziende troppo grandi.
Per le società di persone, il coordinamento avviene tramite l’imputazione diretta in capo ai soci del reddito della società, indipendentemente dalla sua effettiva
distribuzione; i soci di società di persone sono insomma trattati come imprenditori
individuali “saltando” la società. I redditi vengono imputati in base alle quote di partecipazione, indipendentemente dall’effettiva distribuzione e nella stessa proporzione si
imputano le perdite, le ritenute d’acconto, etc. (art. 5 TUIR). Naturalmente poi l’effettiva percezione dei dividendi è fiscalmente irrilevante in quanto la tassazione era già
avvenuta in precedenza.
Lo stesso criterio opera per i redditi attribuiti ai collaboratori familiari di imprese
individuali: la tassazione di tali redditi è quindi trasferita dall’imprenditore al “parente
collaboratore”, circostanza di cui occorre tener conto prima di valutare la congruità dei
redditi di impresa dichiarati da piccoli commercianti e artigiani.
“Saltare la società” è invece più difficile per le società di capitali, dove al massimo
può essere consentito, in via opzionale, qualora i soci siano pochi. In genere il coordinamento si basa su due livelli di tassazione, la cui somma dovrebbe grossomodo
corrispondere alla tassazione della persona fisica, con le aliquote IRPEF più elevate
(par. 9.4). Una prima tassazione avviene in capo alla società, al momento della
produzione del reddito, ed una in capo al “socio finale” (di solito una persona fisica) al
momento della distribuzione.
La ragione di una tendenza, con la somma delle due tassazioni, verso l’aliquota massima dell’imposta personale (IRPEF) è che tale aliquota massima scatta abbastanza
236
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
presto, considerando che i soci sono uomini d’affari abbastanza facoltosi. La tecnica è di tassare l’istituzione societaria alla produzione del reddito, e quindi in caso di
distribuzione anche il socio. L’imposta sulle società (IRES) è del 27 percento, mentre
l’IRPEF in capo ai soci con percentuali elevate di controllo è applicata solo sulla metà
del dividendo, per tener conto della precedente tassazione in capo alla società. Se la
percentuale di partecipazione è piccola, si applica l’imposta sostitutiva del 20 percento
su tutto il dividendo.
Se i soci sono altre società, prima di arrivare alla persona fisica finale, il dividendo
viene escluso da tassazione, salvo un 5 percento, che resta imponibile per compensare
idealmente la deduzione fiscale, da parte della società socia, dei costi relativi alla gestione
della partecipazione.
Le suddette esigenze di coordinamento investono, come già rilevato, anche le
plusvalenze/ minusvalenze su partecipazioni che sono state rese fiscalmente irrilevanti ove realizzate da società. Minusvalenze e plusvalenze sono quindi fiscalmente
indeducibili e intassabili (art. 87 TUIR). In questo modo si impedisce la trasmissione
di costi dai soci (magari persone fisiche o società non residenti, quindi a bassa fiscalità)
alle società, con connessi arbitraggi fiscali (è un caso di corrispondenze intersoggettive
di cui al paragrafo 3.11).
Esiste però l’eccezione di un regime parallelo, per alcune categorie di partecipazioni, costituenti mero investimento finanziario (in genere di borsa), o detenute per
breve periodo, o in società senza impresa, per cui vale la regola opposta, di imponibilità
delle plusvalenze e deducibilità delle minusvalenze; è una sorta di doppio regime di
circolazione delle partecipazioni, concettualmente ambizioso, sulle cui complessità non
ci possiamo dilungare in questa sede.
All’interno dei gruppi societari, una volta rese indeducibili le minusvalenze su
partecipazioni, le perdite delle società controllate possono essere attribuite alle
società capogruppo solo col c.d. “consolidato fiscale”; non è un bilancio consolidato vero e proprio, ma un istituto di diritto amministrativo, basato sulla
«somma algebrica» di redditi e di perdite, risultanti dalle dichiarazioni fiscali delle
società che vi partecipano; ciascuna società continua a determinare i propri redditi
o le proprie perdite per proprio conto, e quindi li trasferisce alla controllante, che
procede al calcolo di un’unica base imponibile di gruppo, e al versamento di un’unica imposta.
Dove manca il controllo, analogo trasferimento delle perdite è possibile attraverso la c.d. “trasparenza fiscale” delle società di capitali, analoga a quella descritta
sopra per le società di persone.
Questi meccanismi per evitare doppie imposizioni dovrebbero funzionare anche in
sede di accertamento di ricchezza non registrata, acquisita direttamente dai soci, e
quindi tassabile prima in capo alla società e poi in capo ai percettori; qui però il criterio
è diverso, e si basa sullo scomputo dell’imposta accertata e pagata dalla società dal reddito accertato ai soci; dall’art. 67 del decreto sull’accertamento delle imposte sui redditi
si desume lo scomputo delle somme pagate dalla società da quelle dovute dai soci (ciò
si verifica nelle società “a ristretta base azionaria”).
Capitolo 7 – I REDDITI E I CONSUMI...
237
7.18.I criteri di collegamento della ricchezza al territorio nazionale
Al paragrafo 3.11 ci siamo già occupati, a proposito della ricchezza non registrata, di rapporti internazionali, cui ora guarderemo come regime di ricchezza palese.
Quest’ultima può rientrare, in base alle norme interne di vari stati, nella sovranità
fiscale (tax jurisdiction) di più di uno di essi. Ne derivano regole di coordinamento,
per evitare la doppia tassazione, di cui qualche volta si può abusare (par. 3.10) per
giungere a sostanziali mancanze di tassazione. Tutte le imposte hanno dei criteri
di collegamento tra territorio statale e manifestazione di ricchezza, che rendono
quest’ultima rilevante ai fini della tassazione. Si pensi al luogo di effettuazione del
consumo, per l’IVA o le imposte di fabbricazione, o all’ubicazione di un immobile
per una imposta fondiaria, o al luogo di redazione di un contratto per una imposta
sugli atti giuridici.
Per le imposte sui redditi, il criterio di collegamento territoriale di partenza sarebbe concettualmente il luogo di produzione del reddito. L’esempio più frequente
per gli operatori economici è il luogo di esercizio di una attività.Tuttavia con questo criterio concorre quello di tassare i residenti per i redditi ovunque prodotti,
denominato correntemente «Worldwide income taxation»; i non residenti sono tassati
solo per i già indicati redditi prodotti nel territorio statale.
Norme interne e trattati internazionali evitano che i produttori di reddito
in un paese, diverso da quello in cui risiedono, subiscano una doppia tassazione;
questi criteri conducono in genere ad un livello complessivo di tassazione pari al più
elevato dei due paesi coinvolti. Questo avviene consentendo di detrarre le imposte pagate nel paese della produzione del reddito da quelle dovute nel paese della residenza
del percettore. Quando, invece del criterio del credito di imposta, viene usato quello
dell’esenzione, l’intreccio tra gli strumenti per evitare la doppia imposizione può sortire
l’effetto contrario della “doppia esenzione”, quando la manifestazione di ricchezza è
considerata in modi diversi nei due stati coinvolti; questo avviene per lo sfasamento tra
i criteri interpretativi utilizzati dai due stati, ciascuno dei quali si astiene da tassazione
nel presupposto erroneo che questa spetti all’altro stato.
I criteri di collegamento per i redditi dei non residenti dipendono dal tipo di
cespite (ad esempio l’ubicazione di un immobile affittato) e saranno indicati nei successivi paragrafi sulle rispettive categorie reddituali. Qui indichiamo, per le imprese,
la regola, tendenzialmente comune a tutti i paesi sviluppati, secondo cui si considera
prodotto nel territorio il reddito facente capo a una sede secondaria, una
c.d. “stabile organizzazione” nel territorio statale, cioè una struttura di fatto,
giuridicamente appartenente allo stesso soggetto estero; la configurabilità di una simile
struttura va esaminata caso per caso in base ai beni materiali, al personale e ai rapporti
giuridici con cui l’impresa non residente esercita l’attività in Italia. Non apriamo enormi, e inutili, parentesi su un concetto da verificare caso per caso, essendo intuitivo che
non configura stabile organizzazione la mera vendita di beni in Italia o la prestazione
di servizi, che non richiedano installazioni durevoli; è invece importante il concetto
secondo cui la stabile organizzazione, pur essendo una parte dell’impresa estera, deve
238
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
determinare separatamente il suo reddito ai fini italiani, come se fosse un terzo rispetto
al resto dell’azienda.
La c.d. esterovestizione è balzata agli onori delle cronache per la tendenza, da parte
di sportivi, attori, cantanti, scrittori e altri percettori di redditi di fonte estera, a prendere la residenza in stati a bassa fiscalità, in modo da evitare la forte tassazione nel
paese di residenza dei redditi di fonte estera. Per le persone fisiche è facile rilevare una
contraddizione tra iscrizioni anagrafiche e situazione reale, mentre per le società, che
comunque sono “entità legali”, senza fisicità né affetti, il discorso è diverso. La società
è una “persona giuridica”, riconosciuta dalle leggi di un determinato stato, in cui si incardina, e da cui sono regolamentati i conflitti tra i soci ed i rapporti con i terzi. Appare
quindi forzato spostare la residenza fiscale delle società come si fa per le persone fisiche;
sarebbe più logico disconoscere i vantaggi fiscali indebiti, collegati all’utilizzazione di società estere; ad esempio considerando la società come un interposto fittizio,
come accade per tante società di paradisi fiscali che praticamente si acquistano su internet; in caso di società “effettive” si può utilizzare la clausola generale dell’abuso
del diritto (elusione), (par. 3.10). Si tratta comunque, anche qui, di un caso classico di
reinterpretazione fiscale di ricchezza palese (evasione interpretativa).
7.19.Segue: simmetrie fiscali e rapporti internazionali, concorrenza fiscale dannosa, transfer price, cfr.
Le correlazioni tra soggetti diversi indicate al paragrafo 3.9 operano in prima battuta
anche rispetto a controparti ubicate all’estero, che altrimenti sarebbero discriminate negativamente. Quindi in linea di principio i costi devono essere riconosciuti anche
se ad essi corrisponde il ricavo di un soggetto estero; una diversa soluzione violerebbe
tra l’altro il principio comunitario di non discriminazione, di cui al paragrafo 2.6, vigente anche in altri rapporti internazionali; le parziali esenzioni dei soci, a fronte di potenziali tassazioni della società (paragrafo 7.17), operano anche se quest’ultima è estera.
Tutti i paesi contengono però cautele contro l’abuso di queste differenze di
regime fiscale, specie in un mondo globalizzato, per delocalizzare gli imponibili ed
evitare ogni tassazione. In un mondo in cui le merci, i capitali, le imprese e le persone
circolano con una facilità molto maggiore di quella con cui possono circolare i controlli, operare con l’estero consente quindi di creare ricavi esteri a fronte di costi italiani, specie per le prestazioni a maggior valore aggiunto e facilmente “delocalizzabili”;
si pensi all’uso di marchi, provvigioni, finanziamenti, etc.; abbiamo già esaminato i casi
in cui la controparte si presenta come apparentemente indipendente, ma in concreto è
complice della controparte nazionale, a danno del fisco secondo il già indicato schema
del “finto cinese” (paragrafo 3.7, anche a proposito dei costi erogati a beneficiari di
paradisi fiscali).
La differenza di regimi e di aliquote fiscali tra i paesi dell’unione, grazie alla libertà
di stabilimento, consente una “concorrenza fiscale”, che può essere legittima se svolta
con provvedimenti generalizzati, relativi anche ai residenti del paese, e quindi tenden-
Capitolo 7 – I REDDITI E I CONSUMI...
239
ti a diminuire indiscriminatamente il prelievo fiscale. La concorrenza fiscale è invece
“dannosa” se finalizzata a distorcere l’allocazione degli investimenti internazionali con
agevolazioni mirate solo agli stranieri. Questo accade soprattutto da parte degli stati
comunitari più piccoli, con minori esigenze di finanza pubblica e maggiore flessibilità
amministrativa nei rapporti tributari. Al riguardo è vietato agli stati membri vanificare le aliquote generali miti, presenti in un paese, imponendo la tassazione degli stessi
redditi nel paese della capogruppo (sentenza Cadbury Schweppes-2006).
Restano aree in cui le simmetrie tipiche della ricchezza registrata e gli arbitraggi
fiscali (paragrafo 3.12) consentono, attraverso società comunitarie, di esternalizzare
ricavi verso altri stati europei, oppure “importare” costi corrispondenti a ricavi realizzati in altri paesi europei. Non si tratta certo delle catene di montaggio o degli stabilimenti industriali, ma di alcune funzioni finanziarie, commerciali, di ricerca,
etc., facilmente delocalizzabili, costruendo i fatti anche in funzione della convenienza
fiscale (cfr. paragrafi 3.10). Non ci dilunghiamo, in quanto troppo tecniche, sulle parità
di trattamento tra soggetti interni, comunitari ed esteri, con cui devono essere conciliate, in base a vari principi di non discriminazione (par. 2.6), le simmetrie interne al medesimo ordinamento tributario (par. 3.9-3.12), dirette ad evitare la doppia imposizione
e le doppie deduzioni.
Al par. 2.6 abbiamo indicato il divieto comunitario di attrarre aziende non residenti concedendo loro regimi fiscali di vantaggio; questo divieto è superabile costruendo regimi generali, cioè applicabili anche all’interno del paese, ma di fatto –per
il settore o la tipologia – prevalentemente applicabili a soggetti non residenti, in quanto
–ad esempio – sul piano effettuale mancano aziende residenti; per Lussemburgo, Malta
o Cipro, la perdita di gettito di una mitigazione generale dell’imposta sulle società è
ben poca cosa rispetto all’attrazione di investimenti esteri, anche se diversi dagli stabilimenti industriali. Per paesi di maggiori dimensioni, con attività industriali (ad esempio
Olanda), la tassazione può essere spostata dalla società ai soci, chiamati a pagare,
se residenti, imposte personali elevate. Il risultato netto sarebbe però quello di attrarre investitori esteri, esclusi dal prelievo al momento della distribuzione dei dividendi,
in quanto residenti all’estero (par. 7.17 sul coordinamento società-soci). L’obiettivo è
comunque attrarre i contribuenti “mobili”, senza perdere gettito da quelli “stanziali”, e viene raggiunto spesso dalle amministrazioni estere in accordi personalizzati
con singoli contribuenti esteri, la cui componente agevolativa, di vantaggio a scapito del
paese in cui il contribuente è radicato, è meno visibile (si pensi ai c.d. “ruling” olandesi
o lussemburghesi).
Le manipolazioni dei corrispettivi per nascondere ricchezza al fisco sono state già
descritte ai paragrafi 3.7 e 3.11; in quella sede abbiamo parlato dell’utilizzazione dei
prezzi tra parti correlate, per canalizzare i flussi di ricchezza nel modo fiscalmente più
conveniente; l’uso di società falsamente indipendenti (par. 3.7) appartiene alla ricchezza non registrata, ma all’interno dei gruppi multinazionali, fortemente spersonalizzati e managerializzati, il corrispettivo palese può essere determinato anche in
funzione di una logica di gruppo, diversamente da quanto accadrebbe tra imprese
indipendenti. Se riflettiamo meglio, quando varie società fanno parte di un gruppo
240
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
multinazionale unico, sono articolazioni diverse di una stessa impresa (economicamente
una azienda unica a livello mondiale), come sarebbe se nei vari paesi esistessero sedi
secondarie, entità materialmente diverse di uno stesso soggetto giuridico. È solo per
praticità operativa che si preferisce operare, in genere, con una o più società per ogni
nazione, ma l’impresa multinazionale considera se stessa come “unica”.
Il corrispettivo tra società appartenenti allo stesso gruppo non esprime un genuino
contrasto di interessi, e la normativa di tutti i paesi sviluppati prevede quindi che i
rapporti con società controllate estere debbano essere valorizzati non già in base
al corrispettivo, ma al valore normale della prestazione sottostante, qualora ne derivi
un aumento del reddito imponibile. Il correttivo non riguarda le società del gruppo
situate all’interno dello stato, perché si presuppone che i relativi elementi reddituali di
segno opposto si compensino. È una disposizione di cautela fiscale, che scatta anche
quando l’adozione di un corrispettivo diverso dal valore normale è dettata da ragioni finanziarie, commerciali o comunque extrafiscali, ed anche quando la controparte
risiede in un paese con aliquote fiscali maggiori delle nostre (e quindi l’operazione,
complessivamente considerata, è priva di qualsiasi convenienza fiscale). Ripetiamo che
nulla è nascosto al fisco, perché si tratta solo di una questione di “fatto valutativo”(par.
5.8), molto simile all’evasione interpretativa”; anzi –se tutti i criteri per la determinazione del prezzo tra aziende appartenenti al gruppo sono descritti “ex ante” – è esclusa
persino l’applicazione di sanzioni amministrative. Qualche volta il calcolo del valore
normale da parte dell’ufficio tributario di una nazione, può risultare eccessivo per l’ufficio tributario dello stato dove ha sede la controparte. Concettualmente quindi nasce
un confitto di sovranità impositiva tra stati, a fronte del quale molte convenzioni
contro le doppie imposizioni prevedono accordi amministrativi tra gli uffici tributari
dei due paesi.
Per eludere le regole appena indicate potrebbero essere interposte società appartenenti a soggetti terzi, occultando il collegamento infragruppo. È uno schema
concettuale (“triangolazione” o operazioni conduit) tendente ad “opacizzare” l’effettiva
controparte, ricorrente anche nelle operazioni verso i soci, verso paesi “a fiscalità privilegiata” o società del gruppo; in tutti questi casi è possibile interporre una società intermedia (denominata “conduit”) che nasconde la reale natura o la reale ubicazione
territoriale del fornitore; ne abbiamo parlato al par. 3.11 per i costi verso paradisi fiscali.
Nei bilanci del destinatario finale, i verificatori fiscali non troveranno alcun riferimento
a paradisi fiscali o a società in qualche modo sospettabili, perché “correlate”, mascherate
dietro un fornitore di tutto rispetto, che presta solo la propria immagine, ignorando (o
potendo sostenere di ignorare) le ragioni del suo intervento.
Sempre sul piano della “ricchezza registrata” si pone l’imputazione “per trasparenza” al socio italiano dei redditi di società da lui controllate, situate in paesi a regime
fiscale privilegiato (paradisi fiscali), infrangendo lo schermo societario (articoli 167 e
168 del TUIR); ciò avviene solo per i redditi “passivi”, cioè facilmente delocalizzabili; ad esempio interessi, dividendi, canoni di licenza commerciale, ed altri facilmente
“mobili”: si tiene conto, in detrazione, dell’imposta eventualmente applicata dallo stato
in cui risiede la società; è il cosiddetto regime CFC, controlled foreign companies, le cui
Capitolo 7 – I REDDITI E I CONSUMI...
241
connessioni coi criteri di coordinamento tributario “società-soci” (par. 7.17) sarebbero
un ottimo approfondimento.
Al par. 3.7 abbiamo già anticipato il rischio di interposizioni fraudolente, rispetto
agli effettivi clienti e fornitori esteri, di società riconducibili alle persone fisiche titolari dell’azienda. Una reazione legislativa (art. 110 tuir) assoggetta quindi a una serie di
limiti e condizioni la deduzione dei costi sostenuti nei confronti di fornitori residenti
in paesi a bassa fiscalità (c.d. black list). La norma fronteggia una possibile parziale retrocessione “in nero” del corrispettivo a terzi, inserendosi nel quadro della “ricchezza non
registrata”; la disposizione è insufficiente prima di tutto quando l’interposizione avviene dal lato dei ricavi, nei modi indicati in nota. Il cliente italiano può essere del tutto
estraneo ad un’interposizione realizzata dal proprio fornitore, per evadere il fisco del
proprio paese. Anche qui, il bilancio della norma è più la creazione di inutili grattacapi
su situazioni innocue, che di contrasto a comportamenti fiscalmente insidiosi.
7.20.Realizzo e neutralità nelle operazioni straordinarie d’impresa
Le cosiddette «operazioni straordinarie» o di riorganizzazione aziendale, come le
cessioni e i conferimenti d’azienda, la cessione di partecipazioni di controllo, le fusioni,
le scissioni, sono profondamente diverse tra loro sul piano della determinazione tributaristica della ricchezza. I punti di riferimento per classificarle sono essenzialmente la
natura “realizzativa” o “neutrale”, dove in entrambi i casi c’è simmetria, ma in modo
diverso, come vedremo iniziando dalle operazioni di realizzo.
Sul piano contabile-ragionierstico, le operazioni che sicuramente comportano un
corrispettivo, come la cessione di azienda contro prezzo, comportano un “realizzo”, un
elemento del reddito imponibile. Invece le operazioni in esame non esprimono economicamente alcun consumo finale, e sono per definizione destinate alla circolazione
tra operatori economici: per questo la cessione d’azienda, ma anche le altre operazioni
straordinarie sono tendenzialmente irrilevanti ai fini IVA, anche quando sono “atti di
realizzo” ai fini delle imposte sui redditi. Ai fini delle imposte sui redditi l’operazione
potrà generare una plusvalenza o una minusvalenza, a seconda della differenza tra prezzo di vendita e valore fiscale dei vari beni costituenti l’azienda. Il corrispettivo della
vendita sarà altresì il punto di partenza cui l’acquirente valorizzerà fiscalmente i beni
dell’azienda acquisita, secondo i principi di continuità e simmetria indicati al par.
3.12 e 7.13.
La cessione di azienda è uno dei casi in cui viene “realizzato” il differenziale tra valori fiscali di acquisto, incrementati da successive eventuali rivalutazioni, e valore attuale,
normalmente misurato dal prezzo di vendita. Emerge così l’“avviamento”(par. 7.13),
inteso come maggior valore dell’organizzazione dell’azienda, come “organismo sociale”
(par. 3.1) rispetto ai singoli beni, che la compongono. L’acquirente dell’azienda, che riconosce al venditore un corrispettivo globale per l’azienda in funzionamento, acquisisce
pochi beni aziendali dotati di valore intrinseco come tali; persino gli immobili industriali, i capannoni, gli impianti, i macchinari, non hanno un vero e proprio mercato
242
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
di riferimento, che si riduce agli immobili civili, e ai terreni edificabili, con un prezzo
di mercato per altre utilizzazioni. Per questo il compratore dell’azienda deve in genere
registrare una parte del prezzo come “valore di avviamento ”, nei termini indicati al
par. 7.13.
Una azienda può essere ceduta anche trasferendo la società che la possiede,
realizzando anche qui un arricchimento, una monetizzazione, e quindi una potenziale
plusvalenza o minusvalenza, a seconda del rapporto tra prezzo di vendita e valore fiscalmente riconosciuto. Queste plusvalenze o minusvalenze possono essere però fiscalmente irrilevanti per via del coordinamento tra tassazione dei soci e delle società, descritto
al paragrafo 7.17; a differenza dell’acquirente di una azienda, l’acquirente di una società
non può dedurre fiscalmente, in modo diretto o indiretto, il costo dell’acquisto;
a parità degli altri fattori, quindi, la cessione della partecipazione, in quanto meno
conveniente per il compratore, avverrà ad un prezzo inferiore a quello che sarebbe
stato pattuito per l’acquisto diretto dell’azienda In caso di trasformazione, fusione o
scissione, invece, considerare realizzate le plusvalenze o le minusvalenze contraddice la
determinazione della ricchezza, in quanto in tali casi la società non ha effettuato vendita di alcunché, né vi sono state modifiche ai valori fiscali dei beni sottostanti. La c.d.
neutralità di fusioni e scissioni è un normalissimo riflesso delle esigenze concettuali,
indicate al paragrafo 3.11, che spingono ad attendere tributariamente il “realizzo” dei
redditi, trascurando la loro mera potenzialità, connessa alla “maturazione economica”
degli avviamenti e dei plusvalori.Trasformazioni, fusioni e scissioni di società non comportano, neppure in senso meramente contabile, una sostituzione tra “beni” e “denaro”
o tra “beni” e “partecipazioni” nei bilanci delle società che vi partecipano; ciò è conforme alla natura delle operazioni in esame, tutte accomunate dal riferimento alla “veste
giuridica” del soggetto, coinvolgendo solo indirettamente i beni e i debiti del soggetto
stesso.
Le varie società si uniscono, nella fusione, o si dividono, nella scissione, ma in base
ai vecchi valori fiscali dei relativi patrimoni: cioè “in neutralità”, come ovviamente
avviene nelle trasformazioni (dove nessuno si unisce o si divide). La società incorporante, o risultante dalla fusione, oppure le società beneficiarie della scissione, unificano
o dividono fiscalmente le proprie voci contabili, utilizzando gli stessi valori che erano
riconosciuti in capo a quest’ultima.
È un riflesso della possibilità degli enti diversi dalle persone fisiche di unirsi o sdoppiarsi, a differenza delle persone fisiche, cui queste prerogative sono precluse per ovvi
motivi biologici (parallelismi eccessivi portano ai soliti equivoci in cui si vedono i gruppi sociali, le aziende o le società in termini antropomorfici, cfr. par. 3.1 ss.).
Alcune voci di bilancio, in genere provenienti dall’incorporata, non possono però –
dopo la fusione – essere mantenute «come se nulla fosse successo». Si pensi al capitale
sociale e alle riserve dell’incorporata, oppure ai crediti e ai debiti reciproci, estinti per
confusione, oppure alla partecipazione che l’incorporante deteneva nell’incorporata.
Ne emergono differenze di fusione, concettualmente di tipo patrimoniale, e quindi
irrilevanti ai fini della tassazione per vari motivi su cui sarebbe qui troppo complesso
dilungarsi.
Capitolo 7 – I REDDITI E I CONSUMI...
243
Nel conferimento in natura, a differenza della cessione di azienda, manca una
contropartita economicamente valutabile, in denaro o altro bene avente valore intrinseco; in cambio dei beni conferiti si ricevono infatti quote della società conferitaria,
che esprimono sotto altra forma gli stessi beni conferiti; questo spinge a dubitare che
il conferimento comporti plusvalenze imponibili in capo al conferente. Non solo il
conferimento è infatti negozio associativo più che di scambio, e tra i due soggetti (almeno al momento dell’operazione di conferimento) sussistono vincoli di controllo o
collegamento (in genere conferente e conferitaria appartengono al medesimo gruppo
di società). Decisiva, ai fini tributari, è sia l’illiquidità della partecipazione ricevuta, sia la
sua consistenza meramente partecipativa (dico sempre che non sono beni reali, ma sono
“figurine”, espressive degli stessi beni conferiti, mancando una sostanziale commutazione). In un’ottica realizzativa, quindi, la conferente dovrebbe pagare le imposte attingendo a proprie diverse risorse, o indebitandosi, perché la partecipazione ricevuta in
cambio del conferimento è in genere “non monetizzabile” né possiede un valore d’uso.
Attualmente, per i conferimenti di azienda è ammessa una “neutralità”, mentre
i conferimenti di beni singoli danno luogo a realizzo (per questo nessuno li effettua!).
Per molti anni, alle operazioni straordinarie si accompagnarono regimi fiscali speciali, come tassazioni sostitutive opzionali, ad aliquota grossomodo pari alla metà di
quella dell’imposizione societaria. Le ragioni sono sia la maturazione pluriennale dei
plusvalori aziendali, sia lo sfasamento tra l’immediatezza della tassazione per il cedente e
la gradualità con cui l’acquirente recupera fiscalmente, attraverso deduzioni, il maggiore
valore fiscale conseguito.
Al pagamento del tributo si accompagna un maggior valore fiscalmente riconosciuto, e quindi un risparmio di imposta negli anni successivi, attraverso maggiori
costi deducibili, secondo le simmetrie fiscali di cui al par. 3.9, applicate ai valori fiscalmente riconosciuti di cui al par. 7.13; lo schema è analogo alle “rivalutazioni volontarie
a pagamento indicate al par. 7.13, e comporta l’anticipazione di un tributo oggi per
fruire poi di maggiori deduzioni domani.
7.21.Determinazione tributaristica della ricchezza e procedure concorsuali
La determinazione tributaristica della ricchezza, dove già si intrecciano spezzoni di materie diverse (par. 4.7), può intrecciarsi col fallimento e le altre procedure concorsuali. Da un punto di vista economico, e di diritto amministrativo, il
fallimento e le altre procedure concorsuali non dovrebbero interferire con la determinazione della ricchezza ai fini tributari: il principale riflesso dovrebbe essere il passaggio
degli adempimenti dal fallito agli organi della procedura, sotto la vigilanza della magistratura fallimentare.
In effetti, nell’IVA accade qualcosa del genere: gli organi della procedura contenziosa
vendono i beni d’impresa del fallimento “con IVA”, al netto delle detrazioni sugli acquisti, secondo gli schemi indicati in generale al par. 7.2 ss..
244
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
Nelle imposte sui redditi, invece, abbiamo un regime conforme alla logica della
determinazione tributaristica della ricchezza solo se il dissesto dell’impresa deriva da
perdite deducibili e riportabili fiscalmente (par. 9.3). Se la crisi di impresa dipende da eventi economici negativi, le perdite precedenti, riportabili in avanti senza limiti,
sarebbero in genere idonee a controbilanciare eventuali redditi prodottisi, ad esempio
vendendo beni con elevato valore intrinseco, oppure la stessa azienda, durante il periodo fallimentare.
Qualora invece la crisi d’impresa derivi da ammanchi, fatture fittizie e appropriazioni indebite, da parte della tipologia imprenditoriale indicata al par. 3.7, la disciplina normativa appare gravemente carente. Il reddito imponibile del periodo fallimentare è dato dalla differenza tra l’eventuale residuo attivo della procedura e il patrimonio
netto risultante dal «bilancio di apertura», trascurando i collegamenti tra bilancio
di apertura e situazione precedente. Se quindi una attività patrimoniale scompare
perché “distratta” dal titolare, essa non figurerà nel bilancio di apertura e sparirà nella
nebbia. Dato che tale residuo attivo in pratica non si verifica quasi mai, il periodo concorsuale non comporta in genere redditi imponibili. Questo meccanismo sembra
perciò attribuire piena rilevanza fiscale alle attività e alle passività emerse nel corso della
procedura, a nulla influendo la corretta registrazione dei costi o dei ricavi a fronte dei
quali i crediti o i debiti erano sorti, ovvero la sorte delle somme a fronte delle quali i
debiti erano stati accesi. Si verifica perciò una totale compensazione tra redditi e debiti,
che esclude solo gli elementi reddituali derivanti da beni personali dell’imprenditore o
dei soci o i pagamenti di debiti personali di tali soggetti. Sul piano della determinazione
tributaristica della ricchezza, la situazione del fallito, in questi casi, è la medesima di
chi – paradossalmente – si arricchisce indebitando la propria impresa, dirottando poi le
relative somme per fini personali, e non restituendo il maltolto ai creditori.
Sul piano delle simmetrie nella determinazione ragionieristica della ricchezza (par.
3.9) costui dovrebbe essere tassato, se non altro per controbilanciare la deduzione delle
perdite su crediti da parte dei creditori; invece le sopravvenienze attive per eliminazione
di debiti, anche da concordato preventivo, non sono imponibili, con una disposizione di
dubbia logicità sul piano della determinazione della ricchezza.
Le simmetrie del reddito d’impresa vengono in questo modo, inevitabilmente, compromesse, perché il creditore deduce la perdita su crediti, mentre il debitore-fallito non
viene tassato sul “venir meno dei debiti”. Una simile disciplina, che sacrifica fortemente la precisione in nome della semplicità, dovrebbe indurre a meditare quantomeno
sull’opportunità di introdurre norme antielusive allo scopo di prevenire operazioni architettate ad arte, dove talvolta creditori e debitore appartengono allo stesso gruppo di
società, allo scopo di beneficiare dei salti d’imposta che la normativa indubbiamente
permette.
Sul piano procedurale viene meno, a partire dalla dichiarazione di fallimento,
l’autonomia degli ordinari periodi d’imposta annuali, consentendo perciò la compensazione tra redditi e perdite di tutta la fase concorsuale, per lunga che sia. Dall’inizio del
periodo d’imposta alla dichiarazione di fallimento si avrà perciò un reddito autonomo,
che andrà determinato dal curatore.
Capitolo 7 – I REDDITI E I CONSUMI...
245
La determinazione della ricchezza in sede fallimentare è problema diverso da quello
di debiti tributari non soddisfatti, relativi a periodi anteriori al fallimento, come
IVA e ritenute non versate, nonché tributi propri del soggetto fallito, per cui rinviamo
al par. 6.11 sull’“evasione da riscossione”, cioè da mancato pagamento di imposte su
ricchezza registrata.
Capitolo 8
ATTIVITÀ “NON AZIENDALI”:
PROFESSIONI LIBERALI, LAVORO DIPENDENTE,
AGRICOLTURA, FABBRICATI, RISPARMIO
E ATTI OCCASIONALI
Sommario: 8.1. Le modeste specificità rispetto all’impresa del lavoro autonomo “professionale” – 8.2. Ricchezza agricola tra catasto e IVA (tracce di forfettizzazione nella tassazione attraverso le aziende?) – 8.3.
Tassazione ragionieristico-documentale del lavoro dipendente – 8.4. Redditi dei fabbricati e fiscalità
immobiliare: l’importanza delle segnalazioni dell’inquilino – 8.5. Tassazione attraverso le aziende di
redditi di capitale e plusvalenze finanziarie – 8.6. Le principali ipotesi residuali (“redditi diversi”)
8.1. Le modeste specificità rispetto all’impresa del lavoro autonomo “professionale”
Il lavoro indipendente, secondo un filo conduttore del testo, è considerato tributariamente “impresa”, quando effettua prestazioni ad elevato contenuto materiale, come
trasporti, riparazioni, vigilanza, etc... I servizi intellettuali vengono invece considerati,
anche fiscalmente, come attività di “lavoro autonomo”, cioè “artistico o professionale”.
I “liberi professionisti” sono quindi fiscalmente considerati “lavoratori autonomi” anche
quando l’attività intellettuale può essere esercitata senza iscrizione in albi, elenchi, etc.,
indipendentemente dall’organizzazione sottostante.
I professionisti e gli artisti hanno in genere una modesta organizzazione, anche se
non mancano i grandi studi legali, d’ingegneria o notarili, con milioni di euro di fatturato, alto valore aggiunto (par. 7.6) e numeroso personale dipendente, non professionale, ma di supporto. Anche questi grandi studi sono tuttavia ben più piccoli delle grandi aziende per la ragione molto semplice secondo cui qui mancano le economie di scala
connesse all’utilizzazione dei macchinari (par. 3.1 sulle aziende); l’attività intellettuale
infatti, anche se fornita da grandi strutture, non si presta alle particolari ottimizzazioni
tecnologiche, sostitutive del lavoro umano.
I compensi erogati ad artisti e professionisti da sostituti di imposta sono soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di acconto (paragrafo 3.6) che li segnala al fisco, inserendoli
in tutto e per tutto nel circuito della tassazione attraverso le aziende. La ritenuta non è prevista invece per i redditi di impresa, sempre per le ragioni indicate nel suddetto paragrafo.
Capitolo 8 – ATTIVITÀ “NON AZIENDALI”
247
Quando il cliente è un individuo consumatore finale, come nel settore medico,
veterinario, edilizio o dei servizi legali a individui o famiglie (avvocati penalisti o matrimonialisti), mancano i presupposti per la ritenuta, cui si tenta di ovviare col c.d “contrasto di interessi” (par. 9.3); in questi casi le possibilità di evasione sono sostanzialmente
analoghe ai piccoli commercianti o artigiani, con forti margini per incassare “in nero” i
relativi compensi, anche se le loro prestazioni lasciano maggiori tracce (si pensi alle deleghe legali o alle risultanze formali delle operazioni chirurgiche). Sul punto rinviamo
a quanto indicato al paragrafo 5.13 sugli studi di settore.
Sul piano economico-sostanziale, le altre differenze di regime tra lavoro autonomo e impresa sono poco significative. Anche la determinazione dei redditi da
lavoro autonomo è differenziale (compensi meno spese) come quella dei redditi di
impresa, che però segue, nell’imputazione a periodo, il principio di cassa (paragrafo
7.12). Anche questi soggetti sono tenuti alle scritture contabili (in genere inutili, par.
3.13), e all’effettuazione di ritenute alla fonte, come sostituti di imposta. Ai fini IVA
le differenze tra queste due tipologie di operatori sono in gran parte venute meno,
e segnaliamo solo che gli esoneri dall’emissione della fattura, per i commercianti al
minuto, non riguardano in linea di principio i professionisti. Il regime dei beni dei
lavoratori autonomi è stato di recente equiparato, nella sostanza, a quello delle imprese,
con i suoi criteri di simmetria e continuità (par. 7.13); in genere sono quindi rilevanti
anche plusvalenze e minusvalenze su beni immobili strumentali, che però sono ben
poca cosa e rappresentano un fenomeno trascurabilerispetto al problema della ricchezza
non registrata.
Sul piano della territorialità (par. 7.18) sono imponibili in Italia i redditi professionali derivanti da attività ivi esercitate, ma la maggior parte delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni richiedono anche una “base fissa”.
8.2. Ricchezza agricola tra catasto e IVA (tracce di forfettizzazione nella
tassazione attraverso le aziende?)
Fino all’avvento della produzione di serie attraverso le aziende tecnologiche (par. 1.4
e 3.1) l’agricoltura era l’attività produttiva più diffusa e anche “più visibile”; la ricchezza
da lei prodotta era tributariamente visibile in modo fisico, attraverso i campi coltivati o le greggi al pascolo; questa visibilità la esponeva alle richieste del potere tributario,
nei termini indicati al par. 1.3.
Anche se il grande latifondo spesso poneva in essere registrazioni contabili della
produzione ottenuta, raramente la ricchezza agricola poteva essere determinata con
i metodi ragionieristico-contabili tipici della tassazione attraverso le aziende. I singoli
“coltivatori diretti”, i mezzadri, etc. producevano poco più del necessario al mantenimento degli addetti (agricoltura di sussistenza basata sul lavoro familiare). Inoltre, nonostante eventuali contabilità agricole delle grandi proprietà, questo tipo di ricchezza può
essere comunque stimata direttamente – con sufficiente approssimazione – secondo la
già indicata valutazione basata sulla tipologia di sfruttamento terriero.
248
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
La ricchezza agricola si prestava bene alla visibilità materiale, basata su nozioni di
esperienza comune sull’andamento dei raccolti (abbondanza di piogge, calamità, etc.);
già nell’antico Egitto la tassazione considerava l’altezza delle piene del Nilo. Questa
stima esteriore della redditività degli immobili venne poi inserita negli elenchi
di proprietà fondiarie (di terreni e fabbricati), espressione di attività amministrativa
denominata “accatastamento” o “catasto”, diretta a rilevare fiscalmente tutti gli
immobili esistenti in un determinato Stato.
Il catasto dei terreni ne contiene la descrizione topografica, con l’indicazione
della loro appartenenza, del tipo di coltivazione e del reddito medio annuo da essa ritraibile, forfettariamente stimato “una tantum” dagli uffici catastali.
La determinazione catastale forfettaria del reddito si sostituisce al reddito effettivo e rende irrilevanti i reali ricavi della coltivazione, come pure le altre componenti
positive del reddito comunque connesse all’attività agricola.
I catasti della società agricola del settecento fronteggiavano validamente le incertezze della stima diretta, caso per caso, della produzione agricola, con le sperequazioni
che possono accompagnarla, anche senza favoritismi e abusi. In un certo senso il catasto
rappresentava una di quelle formalizzazioni con cui da sempre la pubblica opinione
reagisce alle incertezze di una sistematica e valutativa stima della ricchezza. Inoltre, la
tassazione catastale premiava gli agricoltori più produttivi, in quanto l’eccedenza rispetto alla redditività presupposta dal catasto non veniva tassata; inversamente però il catasto
penalizzava eventuali agricoltori meno produttivi rispetto alla media suddetta.
L’evoluzione dell’impresa viene seguita solo comunicando al catasto eventuali variazioni della coltivazione praticata, ad es. da seminativo a frutteto e lo stesso accade per
eventuali perdite per mancata coltivazione ed eventi naturali(come siccità, inondazioni,
incendi, grandinate, etc.), nel qual caso – a seconda del tipo di evento – il reddito fondiario viene eliminato o ridotto.
La pura coltivazione, essendo in rapporto diretto con il terreno, dà luogo comunque a reddito agrario, anche se effettuata con tecniche moderne o sofisticate come
la coltivazione in serra; per le attività accessorie e di allevamento, soglie qualitative e
quantitative, legate alla potenzialità del terreno, limitano i criteri forfettari quando gli
acquisti, manipolazioni e/o rivendite di merci superano una certa proporzione con
quelle ritraibili dal terreno stesso.
I pregi della tassazione catastale hanno però bisogno di un raffinato coordinamento con un contesto di tassazione ragionieristico-contabile attraverso le
aziende; in un contesto ragionieristico-documentale, ispirato all’“effettività” della ricchezza, appare difficile giustificare la tassazione di attività inefficienti su ricchezza “non
effettiva” solo perché attività più efficienti, grazie alle forfetizzazioni, non sono tassate
su ricchezza effettiva.
In questo contesto, quindi, la determinazione catastale dovrebbe rimanere solo per
attività di piccole dimensioni, facili da stimare, dove la contabilità sarebbe inaffidabile e costosa (par. 3.13), mentre l’imprecisione resterebbe poco rilevante, trattandosi di
redditi comunque modesti. Tuttavia la difficoltà di gestire una linea di confine ha condotto a un oggettivo lassismo legislativo, ammettendo le imprese individuali e le società
Capitolo 8 – ATTIVITÀ “NON AZIENDALI”
249
di persone al regime catastale indipendentemente dai limiti dimensionali, comprese le
aziende efficienti e di apprezzabili dimensioni che magari utilizzano sistemi contabili
per propri fini gestionali e pagano poi le imposte su redditi catastali irrisori.
Ciò finiva per distorcere la forma giuridica dell’azienda, e per questo a partire dal
2006 la determinazione catastale è stata concessa anche alle società di capitali, sia pure
in una situazione fluida e altalenante che dovrebbe essere oggetto di approfondimenti.
È un altro caso in cui i compromessi tra semplicità e precisione, indicati al par.
1.8, conducono a una contraddittoria irrilevanza fiscale di scritture contabili tenute da
grandi aziende agricole, mentre i lavoratori indipendenti sono costretti a una superflua
“contabilità fiscale”, come rilevato al par. 3.1.3.
A questa forfetizzazione del reddito si accompagna una forfetizzazione della
detrazione dell’IVA sugli acquisti, stabilita in misura pari all’imposta applicata sulle
vendite (art. 34 d.P.R. 633). Si consente quindi all’agricoltore una rendita IVA qualora
– come in genere accade – l’imposta pagata sugli acquisti effettivi sia inferiore a quella
determinata forfettariamente.
Il “sostegno” all’agricoltura, attraverso forfetizzazioni catastali tarate al ribasso, viene
erogato anche ad aziende che non ne hanno bisogno. Si tratta di uno dei casi classici,
indicati al par. 1.9, in cui la determinazione della ricchezza viene distorta, un po’
ipocritamente, per finalità agevolative.
Inoltre, come indicato al paragrafo 3.7 sulla ricchezza non registrata dalle piccole e
medie organizzazioni, la tassazione catastale del fornitore può innescare la richiesta del
cliente di “gonfiare i corrispettivi” retrocedendogli “in nero” la differenza; come tutte
le forfetizzazioni, insomma, il catasto inceppa le simmetrie della tassazione attraverso le
aziende, indicate al par. 3.9..
8.3. Tassazione ragionieristico-documentale del lavoro dipendente
Il lavoro dipendente, nell’era economica delle aziende tecnologiche, è la categoria
cui appartiene il numero maggiore di contribuenti, cui per questo corrisponde
l’ammontare maggiore di imponibile dichiarato.
L’inquadramento in tale categoria dipende dalla qualificazione formale del lavoro, anche se le mansioni sono di grande complessità e svolte in grande autonomia.
Anche un direttore generale è un lavoratore dipendente, quand’anche le sue mansioni
coincidano in gran parte con quelle di un amministratore delegato.
La forma prevale quindi rispetto agli altri possibili inquadramenti di questo flusso di
ricchezza ai fini tributari. Quando l’inquadramento esplicito manca, perché la ricchezza
è non registrata, torna rilevante la sostanza del rapporto. Anche i lavoratori “non
regolarizzati”, c.d. in nero, sono perciò titolari di reddito di lavoro dipendente ed il
datore di lavoro rischia, in caso di controllo, le sanzioni per omissione delle ritenute alla
fonte (e dei contributi previdenziali). Questa rilevanza della forma sussiste anche per
i rapporti oggettivamente di lavoro dipendente formalmente inquadrati come lavoro
autonomo, o impresa. Negli ultimi anni infatti, anche per via delle rigidità del mercato
250
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
del lavoro, numerosi rapporti sostanzialmente di lavoro dipendente sono stati formalizzati come lavoro professionale o prestazioni d’impresa. A differenza del suddetto “lavoro
nero”, si tratta però di prestazioni fiscalmente “palesi”, diversamente formalizzate, cioè
come remunerazioni di impresa o di lavoro autonomo. Gli unici riflessi fiscali in questi
casi riguardano le particolari modalità di effettuazione della ritenuta d’acconto sui redditi di lavoro dipendente: fiscalmente si tratta tutto sommato di un “peccato veniale” e
questo spiega la rarità di contestazioni di questo tipo da parte degli organi di controllo.
Forti aree di evasione si trovano nel lavoro dipendente domestico, alle dipendenze di piccoli commercianti e artigiani, in quello stagionale per la raccolta di prodotti
agricoli, nell’edilizia (si pensi ai punti di raccolta di manovali, spesso extracomunitari,
che si offrono a giornata la mattina presto, per un pugno di euro).
Il reddito di lavoro dipendente è però, come abbiamo visto in tutto il testo, quello
che per primo viene regolarizzato con il crescere delle dimensioni aziendali
(paragrafo 3.2 e 3.8 sulle retribuzioni “in nero” come forma di “evasione aziendale”).
Con la crescita del numero dei dipendenti è infatti sempre più difficile mantenere quei
rapporti paternalistici, informali, e “in nero”, di quando il padrone e i pochi dipendenti
lavorano fianco a fianco.
Il lavoro dipendente è quindi una delle prime aree ad essere “messa in regola” ai fini
fiscali e previdenziali, come indicato al par. 3.2. Il rapporto con i dipendenti è spesso il
primo in cui l’impresa “diventa grande” e comincia a “lavorare per il fisco”, applicando
le ritenute, i contributi etc., anche se in parallelo continua ad occultare incassi o a
registrare costi fittizi. Da questi può derivare, come rilevato al par. 3.8 sull’evasione
di azienda, l’erogazione occulta (come si dice “fuori busta”) di incentivi, gratifiche o
altre elargizioni paternalistiche, da conciliare in qualche modo col resto della gestione
aziendale. Con la crescita ulteriore delle dimensioni aziendali, anche questi comportamenti gradualmente diventano ingestibili e sono abbandonati.
Di questa collaborazione dell’azienda col fisco fa parte anche la segnalazione
delle retribuzioni al fisco (e agli enti previdenziali) da parte del datore di lavoro, secondo
una procedura indicata al par. 3.4/3.6; lo strumento è la ritenuta alla fonte, che in
questo caso ha la particolarità di essere progressiva, ragguagliando al periodo di paga
le aliquote annue IRPEF, e le detrazioni d’imposta. Lo scopo è rendere la ritenuta pari
all’imposta definitivamente dovuta dal dipendente senza altri redditi, consentendogli di
non presentare alcuna dichiarazione (i suoi dati affluiranno al fisco attraverso la dichiarazione del sostituto d’imposta indicata al par. 3.4).
Costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le pensioni, anche se derivanti da
precedenti attività diverse dal lavoro dipendente; la loro tassazione si giustifica perché
i contributi previdenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro, sono esclusi
dal reddito (è un altro riflesso di quei collegamenti interpersonali e intertemporali
tipici della tassazione attraverso le aziende, indicati al par. 3.9 col nome di “simmetrie
fiscali”).
In via di principio, il reddito di lavoro dipendente ricomprende tutti i compensi,
anche accessori e a titolo di liberalità. Le spese di produzione, pur concepibili (ad es.
per il tragitto casa –ufficio) sono irrilevanti fiscalmente, visti i problemi di docu-
Capitolo 8 – ATTIVITÀ “NON AZIENDALI”
251
mentazione e controllo cui darebbe luogo una loro deduzione, nel tendenziale accollo
della maggior parte dei costi da parte del datore di lavoro.
C’è maggiore larghezza per i servizi erogati attraverso il datore di lavoro, in
quanto più controllabili, come la mensa, il trasporto collettivo “casa lavoro”, ed i “fringe
benefits”, come ad esempio l’auto aziendale, il telefono cellulare, il collegamento a internet, assicurazioni sulla vita, prestiti agevolati etc...
I rimborsi spese per trasferte fuori dall’abituale sede di lavoro non riguardano il dipendente, ma il datore di lavoro, e quindi, in base a documentazione specifica o secondo
parametri forfettari, non costituiscono reddito.
Da quanto precede, appare chiara l’esternalizzazione, sui datori di lavoro, della
gestione tributaria dei dipendenti, riprova della determinazione della ricchezza attraverso le aziende, filo conduttore di questo testo. In particolare si intreccia il “favor” di
fondo verso i dipendenti su tutti i profili demandabili al datore di lavoro con sufficiente
“cautela fiscale” e senza complicazioni eccessive (sono i valori neutri di precisione, certezza, semplicità, cautela erariale indicati al par. 1.9).
8.4. Redditi dei fabbricati e fiscalità immobiliare: l’importanza delle segnalazioni dell’inquilino
Avendo già detto dell’impresa agricola, restano da esaminare gli immobili rappresentati da fabbricati, abitativi o commerciali. Gli immobili sono un settore di investimento tradizionale, tipico rifugio di chi abbandonava precedenti attività commerciali,
più lucrose, ma anche più rischiose, per investirne i frutti in immobili da mettere, come
si dice, “a rendita”; abbiamo visto al paragrafo 7.2 che la rendita fondiaria costituisce
una parte del “valore aggiunto” creato dall’attività di impresa. Oggi, vista la crisi
dell’agricoltura, questa rendita è soprattutto rappresentata da canoni di locazione, per
gli immobili non utilizzati direttamente dal proprietario (peraltro in Italia circa il 75
percento delle famiglie abita in casa di proprietà).
A questo assetto economico-sociale corrisponde un catasto fabbricati strutturato
grossomodo come quello già descritto per l’agricoltura, con una descrizione degli immobili e l’attribuzione di un parametro chiamato “rendita”; le rendite sono ovviamente
molto inferiori ai canoni correnti della locazione, ed è quindi il reddito da locazione a
dover essere dichiarato, mentre il valore catastale rileva per altri tributi, come le imposte
patrimoniali immobiliari (prima l’ICI, poi l’IMU, cfr. par. 10.9), le imposte di registro,
successioni, etc. La tassazione del reddito catastale è rimasta per decenni in IRPEF per
i soli immobili sfitti, diversi dalla abitazione principale (con l’IMU è stata invece eliminata anche per tali immobili).
Quando la locazione avviene da persone fisiche ad altre persone fisiche,
l’occultamento al fisco dei canoni di locazione è molto diffuso, mentre l’evasione
si riduce fortemente quando l’affittuario è un ente pubblico, una società o un altro
soggetto intenzionato a dedurre il canone e in questo caso il relativo contratto di
locazione viene registrato; ciò rileva non solo per il tributo di registro, di cui diremo
252
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
più avanti, ma soprattutto come segnalazione del rapporto principale e viene pretesa
una ricevuta dei canoni pagati. Anche in questo caso, secondo i criteri ordinari della
tassazione attraverso le aziende, la registrazione tributaria della ricchezza, da parte
del fornitore, dipende dall’interesse del cliente a documentare l’esborso ai propri fini
amministrativi.
Le locazioni abitative “in nero” sembrano comunque molto diffuse, anche per la
percezione dello scarso “controllo del territorio” da parte del fisco di fronte all’estrema diffusione e frammentazione della proprietà immobiliare; quando si tratta di piccoli proprietari di uno/due immobili, spesso a basso reddito e per i quali l’evasione ha
una notevole utilità marginale, la propensione al rischio è molto alta: la convergenza
di interessi verso l’evasione si rafforza poi in tutti i casi in cui dall’affitto di immobili
si passa all’affitto di stanze (ad es. a studenti), al bed and breakfast, alle case vacanza, e
ad altre forme di rapporto transitorio, occasionale, flessibile, etc., che ha basse probabilità di dar luogo a controversie tra le parti o di essere individuato dal fisco, vista la
breve durata.
Nel 2011 è stata varata una forma di “contrasto di interessi” tra inquilino e proprietario, per contrastare le locazioni “in nero”, secondo cui in caso di mancata segnalazione
al fisco del contratto (e quindi di denuncia del canone), l’inquilino ha avuto diritto a un
rapporto locatizio a corrispettivo di favore, pari a tre volte la rendita catastale dell’immobile. Questa “bella trovata” (dichiarata illegittima dalla corte costituzionale nel 2014)
non era comunque in grado di rimpiazzare la consueta carenza di intervento degli uffici
tributari sulle locazioni urbane tra privati, estraneo come noto alla tassazione attraverso
le aziende.
Un elemento di affidabilità può invece venire dall’organizzazione amministrativa
del locatore, quando si tratta di proprietari “istituzionali” di immobili, come casse di
previdenza, fondi immobiliari, società assicurative, enti pubblici. Sono tutti casi in cui la
visibilità amministrativocontabile della ricchezza riprende il sopravvento su quella “materiale” dell’immobile e della sua destinazione “di fatto”. Si conferma che la presenza di
una azienda o di una istituzione, in veste di proprietario o di inquilino, rende visibile
la ricchezza per le relative esigenze di documentazione.
Un’altra componente dell’investimento immobiliare, diversa dal reddito consistente
nell’affitto, è l’aumento di valore del bene. Quando l’immobile è posseduto da società,
tale aumento concorre a formare il reddito di impresa, secondo il principio di onnicomprensività indicato al paragrafo 2.10. Quando si tratta di persone fisiche, vedremo i
requisiti di tassabilità delle plusvalenze al successivo par. 8.6.
8.5. Tassazione attraverso le aziende di redditi di capitale e plusvalenze
finanziarie
Tra i redditi del “capitale finanziario” abbiamo già menzionato i dividendi e le plusvalenze su partecipazioni societarie, esaminati al paragrafo 7.17 a proposito dei correttivi contro la doppia imposizione; se percepiti da persone fisiche essi costituiscono
Capitolo 8 – ATTIVITÀ “NON AZIENDALI”
253
reddito di capitale (dividendi) o reddito diverso di natura finanziaria (plusvalenze su
partecipazioni societarie).
Danno luogo a redditi di capitale (art. 44 Tuir) anche tutti gli interessi “su prestiti”, come conti correnti e depositi bancari, e molte altre forme di crediti concessi a
debitori specifici, oppure attraverso titoli obbligazionari, magari quotati sui mercati
finanziari.
Per quanto riguarda gli interessi su prestiti, l’unico elemento segnaletico a vantaggio del fisco è come al solito, la struttura amministrativa dell’erogante-debitore.
Stando alle statistiche dei redditi dichiarati gli interessi verso privati non tenuti a
segnalazioni al fisco non sono praticamente mai dichiarati ai fini della tassazione ordinaria irpef; quando il debitore è un privato, un piccolo commerciante o un artigiano,
il prestito (che spesso sconfina nel reato di usura ovvero si basa sull’amicizia e la fiducia)
è gestito del tutto “in nero”.
Quando il debitore è un ente strutturato, il prestito viene formalizzato in
modo da fruire della tassazione sostitutiva di cui diremo tra un attimo, sfuggendo
all’Irpef.
La tassazione dei frutti del risparmio impiegato in investimenti cartolarizzati (azioni, obbligazioni e titoli similari), nonché depositato presso banche, avviene tramite
una imposizione sostitutiva, applicata “attraverso le aziende” (filo conduttore di
questo libro). Solo attraverso gli intermediari è infatti possibile la tassazione di questi proventi, che non potrebbero né essere inseriti nella base imponibile ordinaria
dell’imposta personale (Irpef), né essere sottoposti a imposte sostitutive “di massa”,
applicate dagli stessi contribuenti. In genere, infatti, il risparmiatore, non può investire
da solo, ma ha necessità di rivolgersi ad un intermediario qualificato che svolge il
solito compito di “ausiliario del fisco”, tipico della nostra tassazione esternalizzata
sulle strutture aziendali, nel caso di specie le banche, per il cui tramite avvengono
investimenti di questo tipo.
Di norma, un risparmiatore piccolo o medio preferisce una banca conosciuta, e non
se la sente di correre i rischi connessi alla gestione dei propri capitali presso intermediari
esteri, che pure gli consentirebbero di evadere le imposte (sono in pochi a profittare
delle opportunità dell’internet banking su questi aspetti); per i grandi patrimoni, il discorso è in parte diverso perché il gioco potrebbe valere la candela.
Solo in via residuale, come ipotesi di chiusura, in modo da non creare vuoti di imposta, è prevista l’autodeterminazione dell’imposta sostitutiva nella dichiarazione del
contribuente.
Per i redditi dei titoli in deposito, e per le plusvalenze su di essi, la banca intermediaria applica una imposta sostitutiva, mentre per gli interessi pagati “in
proprio” su obbligazioni o depositi, agisce direttamente come sostituto di imposta,
secondo i canoni classici di cui al par. 3.6. La banca o la società finanziaria è insomma un mandatario del risparmiatore, e ne amministra gli investimenti: trattandosi
di una organizzazione amministrativa complessa e “vigilata”, il fisco si inserisce
facilmente in questo rapporto e impone all’intermediario le imposte sostitutive in esame.
254
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
Le aliquote di queste imposte sono sempre state relativamente modeste, partendo
da un iniziale 12,5 percento, per salire poi al 20 percento nel 2011, e poi ulteriormente (del 26 percento a inizio 2014). Questa originaria mitezza dell’aliquota non si
spiega né con un “favor” verso i redditi finanziari rispetto ai redditi da lavoro, né con
la preoccupazione di prevenire le tentazioni di evadere “saltando gli intermediari” e
rivolgendosi a intermediari non residenti, grazie alla mobilità dei capitali finanziari.
Questa tentazione non scatta certo per i patrimoni piccoli e medi, stante l’ostacolo di
perdere il capitale investito affidandolo, per motivi fiscali, a intermediari non degni di
fiducia. Queste tentazioni sono ulteriormente ostacolate dal c.d. “monitoraggio fiscale”
dei capitali esteri (par. 3.11).
La mitezza delle aliquote considerava invece in modo forfettario che, sugli
investimenti finanziari, il reddito rappresenta prima di tutto una salvaguardia del capitale investito rispetto alla perdita di valore della moneta. Il capitale investito, infatti,
essendo privo di valore intrinseco, a differenza dei patrimoni immobiliari o aziendali,
perde automaticamente valore effettivo in proporzione all’inflazione. Un riconoscimento generale dell’inflazione, come indicato al par. 1.8 e al par. 7.13 per le aziende, era
però macchinoso, e quindi è stato sostituito da un meccanismo più gestibile. Tendenzialmente infatti, gli interessi sono sempre in linea con l’inflazione, e quindi meritano
forfettariamente una aliquota più modesta, che tenga conto della perdita di valore della
moneta. La modesta aliquota è però fuori luogo quando si tratta di plusvalenze
finanziarie, anche molto più elevate rispetto al tasso di inflazione. Tali plusvalenze
finanziarie, che possono eccedere anche di molto l’inflazione, sono guadagni realizzati
come differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita di titoli azionari, obbligazionari e altre partecipazioni sociali, anche non quotate in borsa, come pure le quote di Srl
e di società di persone etc...
Questi «guadagni di capitale» (capital gains), non sono predeterminabili e dipendono dalla capacità degli operatori di anticipare le tendenze del mercato. I guadagni
di capitale in questione sono inseriti nei «redditi diversi» (si tratta dei c.d. «redditi
diversi di natura finanziaria»), ma soggetti alla stessa tassazione sostitutiva qui in esame. In questo caso, davanti a un reddito “reale” che supera l’inflazione è possibile
un inasprimento di aliquota. Non perché sono redditi “speculativi”, ma nella misura
in cui sono redditi “effettivi”, cioè “reali” e non solo “monetari”, come quelli “da
inflazione”.
Con l’aumento dell’aliquota, inasprita ad inizio 2014, appare quindi sempre più
difficile equiparare il reddito puramente monetario, che salvaguarda il capitale dall’inflazione, e il reddito reale, che supera l’inflazione.
Mentre però i redditi di capitale “da interessi” sono sempre per definizione positivi,
le negoziazioni di titoli (acquisto e successiva rivendita) possono dare luogo a risultati
negativi: possono cioè derivarne non solo plusvalenze, ma anche minusvalenze. L’imposizione sostitutiva sui redditi finanziari ha quindi eliminato pregiudiziali steccati tra
redditi di capitale e «guadagni di capitale», consentendo in alcune ipotesi delle compensazioni delle minusvalenze anche rispetto agli interessi (specialmente in capo ai fondi di
investimento o al c.d. “risparmio gestito”).
Capitolo 8 – ATTIVITÀ “NON AZIENDALI”
255
8.6. Le principali ipotesi residuali (“redditi diversi”)
Nella categoria residuale dei redditi diversi rientrano alcuni arricchimenti concettualmente omogenei a quelli regolati da un’altra categoria di reddito, sprovvisti però
di una particolare caratteristica per esservi inclusi; si pensi ai redditi di lavoro “non
abituali” (cioè definibili –inversamente – “occasionali”), come prestazioni isolate di
lavoro autonomo, insufficienti a far scattare la qualifica di “soggetto IVA”, e quindi di
“professionista” o “imprenditore” ai fini tributari.
Questo lavoro autonomo occasionale rappresenta il grosso dei redditi diversi,
confermando il fondamentale ruolo segnaletico delle ritenute operate dal cliente (vi
rientrano mezzo milione di contribuenti mentre l’impresa occasionale, dove la ritenuta
non è prevista totalizza solo 20.000 contribuenti circa).
Gli altri redditi diversi hanno il già indicato ruolo “di chiusura”, ma non sono frequenti, come i redditi dei beni immobili situati all’estero, inseriti nei redditi diversi in
quanto non iscritti in catasto, per via della loro collocazione territoriale.
Residuali sono anche i proventi conseguiti fuori dall’esercizio d’impresa, per l’affitto
o locazione di veicoli, macchine e altri beni mobili e più in generale per le c.d. “sublocazioni”.
Una ampia portata teorica riguarda l’inserimento nei «redditi diversi» di tutti i proventi ricollegabili ad obblighi di «fare» o «tollerare» (art. 67 lett. l). È una disposizione
con portata molto ampia, che smentisce le affermazioni secondo cui i redditi sarebbero
definiti in modo casistico, in quanto si presta a ricomprendere anche proventi non riconducibili a una prestazione d’opera, compresi quelli per “non fare” (ad esempio non
esercitare una certa attività che farebbe concorrenza ad altri, o utilizzare l’immagine di
un personaggio famoso).
Il concetto in esame richiama quello di “prestazioni di servizi” (paragrafo 7.6), e
quindi lascia fuori dai redditi diversi le “cessioni di beni” e le relative plusvalenze (guadagni in conto capitale tra prezzo di acquisto e di vendita di beni); le plusvalenze non
rientranti tra i redditi diversi, se non già tassate in altre categorie reddituali,
sono quindi escluse da tassazione.
Si pensi ad esempio alle plusvalenze su oggetti d’arte o su immobili destinati, per
la maggior parte del periodo di possesso, ad abitazione principale. Danno luogo a plusvalenze imponibili come redditi diversi, per espressa disposizione, quelle su immobili
non destinati ad abitazione principale, ceduti prima di 5 anni dall’acquisto, quelle su
titoli finanziari (commentate tra i redditi di capitale al paragrafo precedente), quelle su
terreni edificabili, indipendentemente dalla durata del periodo di possesso (in quanto ad
elevato sospetto di speculatività, se non “oggettivamente speculative”). La differenza tra
la tassazione delle plusvalenze su immobili, e la non tassazione di quelle su “beni mobili”
(come gli oggetti d’arte o i metalli preziosi) si spiega anche perché nel secondo caso la
cessione è “informale” senza la visibilità degli “atti solenni” di acquisto e cessione, rilevante ai fini dell’imposta di registro di cui al par. 10.2, che fornisce informazioni anche
per la tassazione sui redditi.
Capitolo 9
REALITÀ E PERSONALITÀ DEI TRIBUTI:
DAL RISULTATO DELLE ATTIVITÀ
ALLE IMPOSTE DOVUTE
Sommario: 9.1. I flussi reddituali nell’IRES, nell’IRPEF e nell’IRAP – 9.2. Realità e personalità dei tributi: concetti generali – 9.3. La personalità dell’IRPEF: riporto perdite, oneri deducibili, detrazioni e
“contrasto di interessi” – 9.4. Segue. Calcolo dell’imposta, progressività delle aliquote e personalità del
tributo – 9.5. Limitata rilevanza della pluriennalità dei redditi ai fini della limitazione della progressività
– 9.6. L’IRAP come esempio di tassazione attraverso le aziende
9.1. I flussi reddituali nell’IRES, nell’IRPEF e nell’IRAP
Dopo la determinazione della ricchezza occorre analizzare gli ultimi passaggi
necessari alla determinazione dei tributi (par. 1.9 sui rapporti tra questi due passaggi
logici). Per la tassazione dei consumi attraverso l’IVA questo passaggio è molto semplice
ed è stato illustrato al paragrafo 7.3.
Passare dalla determinazione della ricchezza reddituale alle imposte sui redditi è invece un po’ più complesso e deve essere distinto per tipologia di contribuente.
Il criterio più semplice è quello degli enti “non societari” (paragrafo 7.5 ultima
postilla), il cui reddito è soggetto all’imposta sul reddito delle società, che a questo
punto“si patrimonializza”, non essendo soggetto ad altri prelievi in quanto può essere
solo consumato e non distribuito a partecipanti che –per definizione – non esistono.
Gli enti non commerciali non sono operatori economici ma titolari di redditi fondiari,
di capitale o di attività marginali di impresa; su tali risultati essi pagheranno l’IRES, con
irrilevanza di vicende successive mentre sulle attività commerciali secondarie, o collaterali, si applicherà anche l’IVA, come indicato al par. 7.5.
Le detrazioni e le deduzioni successive alla determinazione del reddito sono, per
queste entità senza sfera personale o familiare, sostanzialmente insignificanti. Ci
sono solo riduzioni di aliquota, con finalità agevolative per enti preposti a finalità meritevoli, cioè culturali, sociali, assistenziali, etc... Con l’imposta in questo modo determinata dovranno essere confrontate le anticipazioni, cioè le ritenute d’acconto subite,
ed i versamenti d’acconto effettuati, secondo quanto esposto al par. 3.4. Ne deriverà,
secondo le regole generali, un conguaglio di imposta da versare o un credito da chiedere a rimborso.
Capitolo 9 – REALITÀ E PERSONALITÀ DEI TRIBUTI
257
Il reddito delle società, invece, viene tassato in due tempi, una prima volta in capo
alle società, con l’IRES, e un’altra in capo ai soci, con i coordinamenti indicati al paragrafo 7.17.
Per arrivare dalla determinazione della ricchezza a quella dell’imposta servono invece, per le persone fisiche, alcuni passaggi ulteriori che però potranno
essere meglio compresi dopo le riflessioni di cui ai paragrafi successivi.
9.2. Realità e personalità dei tributi: concetti generali
Come anticipato al par. 1.3, la maggior parte delle imposte sono “reali”, cioè si
riferiscono alla manifestazione di ricchezza oggettivamente considerata, senza
considerare altri aspetti della situazione complessiva del soggetto.
L’esempio classico è l’IVA, dove il consumatore di un bene o di un servizio paga una
cifra del tutto indipendente dal resto della sua situazione di consumatore, di proprietario, di lavoratore, di cittadino, di straniero, etc...
Solo pochissime imposte oltre a considerare la ricchezza (ed essendo anch’esse
“reali”) considerano anche alcuni elementi ulteriori, “personali”, del soggetto, e
sono chiamate personali (non perché –ripetiamo – non considerino la ricchezza, ma
perché considerano anche aspetti ulteriori, relativi alla condizione personale o familiare
del contribuente).
Gli antichi tributi “a ripartizione”, descritti al paragrafo 1.3, erano per certi versi i
progenitori delle moderne tassazioni personali, come l’IRPEF, di cui diremo più avanti;
segnaliamo però elementi di personalità che fanno capolino in molti tributi, come
l’IMU, e la precedente ICI (par. 10.9), che tentavano di distinguere tra “prime case”,
seconde case, abitazioni locate a canone sociale, presenza di figli etc. Anche nell’imposta
di registro, come vedremo al paragrafo 10.2, si cerca di distinguere tra “prima casa” e
altri acquisti immobiliari.
Da quanto precede si comprende quindi che elementi di personalità possono esserci
anche in imposte diverse da quelle sui redditi, in cui siamo abituati a trovarli più spesso.
Vedremo al successivo paragrafo che gli elementi di personalità dell’IRPEF, come
gli oneri deducibili, le detrazioni d’imposta per familiari a carico, gli interessi passivi, le
spese sanitarie, le assicurazioni sulla vita sono estranei alla sfera di produzione dei
redditi.
La personalità delle imposte sul patrimonio si potrebbe atteggiare in modo diverso
da quello dell’IRPEF: in questo caso, come abbiamo visto per l’IMU, e l’imposta di
registro, alcune condizioni familiari, come la presenza di figli o la mancanza di altre
“prime case”, attenuano il tributo. Anche le imposte sui consumi, che pure sembrano
a prima vista refrattarie alla personalità, vedono certe volte la rilevanza di condizioni
soggettive dell’acquirente, a partire anche qui dalla “prima casa”.
Le imposte indirette si prestano meno alla personalità, ed è un rovescio della medaglia della loro possibilità di colpire, come consumatore, anche chi evade le imposte sui
redditi (par. 7.1). Per la maggior parte delle spese di consumo è infatti difficile distin-
258
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
guere, a parità di tipologia di beni, cosa tassare normalmente e cosa salvaguardare, in
quanto genere di prima necessità. L’aliquota ridotta per il pane, o per il vino, si
applica sia per i prodotti popolari, sia per quelli raffinati, senza poter distinguere tra
merci di diverso pregio. Inoltre, il fornitore non può discriminare tra gli acquirenti in
base alla quantità acquistata, anche perché sarebbe facile frammentare l’acquisto. Per
salvaguardare i consumi sociali le vie sarebbero abbastanza complicate. Una intricata
salvaguardia qualitativa potrebbe essere la variazione dell’aliquota in base al prezzo;
subordinando ad esempio le aliquote agevolate sui generi alimentari ad un prezzo che
non superi un certo importo per chilo, o per litro. Una salvaguardia per sostenere gli
acquisti “di base” di una famiglia potrebbe essere una specie di “tessera annonaria”
parametrata al consumo personale necessario di generi di prima necessità, con un
contributo all’acquisto sufficiente a sterilizzare l’applicazione ordinaria dell’IVA. Una
macchina pubblica più efficiente della nostra, dove si prendono iniziative di opportunità, senza appiattirsi sulla legislazione, potrebbe anche gestire meccanismi del genere.
Tuttavia gli strumenti più adeguati per conciliare la determinazione dei tributi con
situazioni di disagio sociale consistono, più che nella riduzione dei tributi, nell’erogazione di sussidi.
9.3. La personalità dell’IRPEF: riporto perdite, oneri deducibili, detrazioni e “contrasto di interessi”
Ai paragrafi precedenti sono state poste le premesse per inquadrare l’IRPEF.Anch’essa – come tutte – parte dalla ricchezza oggettivamente considerata, sommando infatti
i vari redditi di categoria. Si ottiene così il reddito complessivo di ciascuna persona
fisica.
Le perdite di impresa o di lavoro autonomo, intese come “redditi negativi”,
sono variamente tenute in considerazione, sia nell’IRES sia nell’IRPEF. Il loro riporto
su altri redditi è ancora molto radicato nella “realità del tributo”, cioè nella determinazione della ricchezza piuttosto che nella situazione personale del contribuente;
il periodo di imposta è una necessità pratica, ma l’attività economica è unitaria, senza
interruzioni nel tempo, e quindi deve rilevare nei due sensi.
Principi di personalità subentrano invece quando le perdite derivanti da attività di
un certo tipo sono scomputabili da redditi derivanti da attività di altro tipo, a conferma
delle solite sfumature intermedie anche tra realità e personalità dei tributi.
Le perdite dei piccoli commercianti e artigiani, operanti in forma individuale, sono
rare, e il fenomeno riguarda soprattutto le organizzazioni societarie, soggette ad IRES,
più rigide e quindi più esposte a perdite; queste ultime sono state per molto tempo riportabili dai redditi dei successivi 5 anni, e dal 2011 sono riportabili senza limiti in
esercizi successivi. Il c.d. “commercio delle perdite” cioè la vendita ad altri gruppi
societari di perdite che si pensa di non poter recuperare in futuro è considerato elusivo, ed è limitato sia con disposizioni ordinarie sia con la norma generale antielusione
(paragrafo 7.5).
Capitolo 9 – REALITÀ E PERSONALITÀ DEI TRIBUTI
259
Ogni individuo soggetto all’irpef è considerato in modo autonomo, senza aggravare l’imposizione quando nello stesso nucleo familiare affluiscono più titolari di
redditi. Casomai si pone il problema politico opposto, degli sgravi alle famiglie “monoreddito”.
In proposito si suggerisce spesso l’introduzione del c.d. “quoziente familiare”, cioè
la divisione del reddito, ai fini delle aliquote progressive, per tutti i membri
della famiglia; si trascurerebbero però così le diseconomie e le spese cui in genere
vanno incontro le famiglie dove entrambi i coniugi esercitano attività lavorativa. È
insomma un problema complesso, dove è preferibile anche qui intervenire con sussidi
alle famiglie monoreddito bisognose, senza mescolare la determinazione dei tributi con l’erogazione di sussidi.. Oggi tuttavia abbiamo le detrazioni d’imposta
per familiari a carico, come coniuge, figli o altri che tendono a diminuire, fino ad
azzerarsi, al crescere del reddito, con un’anticipazione della progressività di cui diremo
al prossimo paragrafo.
La “personalità del tributo” comporta anche la rilevanza, a favore del contribuente, di collegamenti tra tipologie diverse di ricchezza (compensazioni tra redditi e
perdite, e riporto di queste ultime da risultati di altre attività), nonché le spese personali
o familiari estranee alla produzione dei redditi di categoria, di cui ora diremo, come
oneri deducibili e detrazioni d’imposta. Gli oneri deducibili sono estranei alla produzione dei redditi di categoria, e riguardano alcune importanti necessità personali o
familiari (spese educative, sanitarie, etc.) che sono comunque erogazioni di reddito
(consumi) non spese di produzione (si collocano qui anche le spese ipoteticamente
dedotte a seguito del c.d. contrasto di interessi di cui parleremo tra un attimo in questo
paragrafo).
Deducendo gli oneri in esame dall’imponibile, il maggior risparmio d’imposta sarebbe per i contribuenti con aliquote più alte, pertanto la maggior parte degli oneri (tra
cui le spese mediche) rilevano come detrazioni d’imposta calcolate applicando (art. 15
TUIR) all’onere deducibile un’aliquota uguale per tutti, attualmente al 19%.
Solo i contributi assistenziali e previdenziali obbligatori per legge e assimilati, e gli assegni di mantenimento al coniuge, continuano a essere dedotti
dall’imponibile, in quanto ispirati a ragioni di simmetria concettuale tributaria, non di
meritevolezza sociale.
La discrezionalità del legislatore sulla scelta degli oneri deducibili o detraibili è particolarmente ampia e la scelta cade di solito su alcune spese di particolare importanza
per il contribuente (mediche, educative o per la previdenza integrativa), di utilità sociale
(elargizioni ad enti caritatevoli) od altrimenti ritenute meritevoli, come gli interessi
passivi su mutui per l’acquisto della prima casa. Tali oneri devono essere indicati nella
dichiarazione nel loro importo complessivo, mentre la documentazione giustificativa
dovrà solo essere conservata ed esibita nell’eventuale controllo di cui al paragrafo 8.3, il
che impedisce ad oggi di utilizzare queste deduzioni come segnalazioni del percettore,
a fini antievasione.
Questa segnalazione fa invece parte della tendenza ad indurre il consumatore finale
a segnalare fornitori a rischio evasione, nel c.d. “contrasto di interessi”, consenten-
260
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
dogli di “scaricare” una parte della spesa. Mediaticamente è una bella trovata che genera
consenso in quanto unisce “la lotta all’evasione” alla gradita possibilità di “detrarre qualcosa”, per costringere i fornitori a dichiarare.
Per il funzionamento del meccanismo non basterebbe ovviamente “lo scontrino”
(par. 7.7) e neppure la fattura, che, una volta emessa, potrebbe non essere registrata, ma
servirebbe una segnalazione al fisco dell’operazione, con le generalità dei
fornitori, che chiuderebbe il cerchio del “controllo incrociato” da cui deriva il successo della tassazione attraverso le aziende sul lavoro dipendente e autonomo. Questa
segnalazione è realizzabile solo attraverso i professionisti esterni, garanti verso il fisco,
come gli intermediari che redigono le dichiarazioni fiscali (par. 3.12).
Il fornitore saprebbe a questo punto di essere segnalato al fisco dal cliente, ed esposto a controlli di congruità dei ricavi dichiarati anche sotto questo profilo, con classica
utilizzazione presuntiva di informazioni contabili, su cui al par. 5.9.
Il relativo appesantimento procedurale giustificherebbe questo strumento
solo per spese di una certa consistenza e che, in mancanza, avrebbero una notevole
probabilità di non essere registrate dal fornitore; si deve poi trattare di spese di una
certa meritevolezza sociale, in quanto sarebbe politicamente poco presentabile la
detrazione per spese voluttuarie solo perché ad alto rischio di evasione (gioielleria o
alta moda).
L’obiezione secondo cui il fornitore potrà sempre offrire uno sconto maggiore
della detrazione fiscale non considera che l’accordo consumatore-fornitore si trova
facendo risparmiare al primo l’IVA, mentre il secondo risparmia imposte sui redditi
e contributi obbligatori. Alla detrazione si aggiungerebbero il desiderio di documentare l’operazione, i limiti all’uso del contante (par. 5.16) ed eventualmente
una piccola sanzione a suo carico, magari come responsabilità solidale per l’IVA evasa.
È un meccanismo che potrebbe realizzarsi solo con una consapevolezza diffusa della
determinazione tributaristica della ricchezza, e comunque per tipologie di prestazioni
molto limitate.
9.4. Segue. Calcolo dell’imposta, progressività delle aliquote e personalità del tributo
Sottraendo dall’imposta lorda le detrazioni d’imposta si ottiene l’imposta netta che
non è ancora quella da corrispondere, in quanto deve essere confrontata con i crediti
d’imposta, le ritenute d’acconto subìte (par. 3.6) e i versamenti in acconto (par.
3.4).
A differenza delle suddette detrazioni d’imposta queste anticipazioni possono infatti dar luogo a un rimborso a favore del contribuente.
La progressività delle aliquote è ispirata al principio, già anticipato a proposito
dell’art. 53 della costituzione (par. 2.2), secondo cui, all’aumentare della ricchezza il
contribuente può privarsi con eguale sacrificio di una quota proporzionalmente maggiore della medesima.
Capitolo 9 – REALITÀ E PERSONALITÀ DEI TRIBUTI
261
La progressività è un aspetto di quella “personalità” descritta sopra per le detrazioni familiari e gli oneri deducibili. Le imposte personali sui redditi (la nostra
IRPEF) tendono anche ad essere progressive, cioè con aliquote, ripetiamolo,
crescenti più che proporzionalmente all’aumentare dell’imponibile. Le aliquote di un’imposta si dicono infatti progressive quando crescono più che proporzionalmente rispetto alla crescita del reddito imponibile.
La progressività nell’IRPEF è una progressività per scaglioni di reddito, dove le
aliquote più elevate si applicano alla parte di reddito inclusa negli scaglioni successivi,
ferme restando le aliquote applicate sugli scaglioni precedenti. La progressività può
essere raggiunta anche per detrazione, cioè dando agli imponibili più modesti una
“franchigia”, pian piano perduta al crescere del reddito (lo abbiamo visto al par. 9.2 a
proposito delle detrazioni per familiari a carico che svaniscono al crescere del reddito).
Una progressività esasperata rischia di diventare, tenendo conto delle aree di ricchezza non raggiunte dalle aziende; oggettivamente, si tratta di una progressività «di
bandiera»che tartassa i ricchi salvo poi accorgersi che i ricchi – stando alle dichiarazioni – sono pochissimi. Scorrendo la lista delle dichiarazioni con redditi più
elevati, si trovano in prevalenza lavoratori dipendenti e autonomi «di lusso», ma pur
sempre lavoratori, come attori, scrittori, consulenti, avvocati, calciatori, alti dirigenti, i
cui redditi IRPEF sono spesso inferiori a quelli dei titolari delle società per cui i medesimi lavorano, e nel cui patrimonio si trova la vera ricchezza assoggettata in genere alle
imposte sostitutive (par. 3.4), e quindi estranea alla progressività dell’imposta personale.
Naturalmente anche l’evasione, in termini di brutale ricchezza non registrata, è
un ostacolo alla progressività, contribuendo a renderla politicamente meno accettabile, come abbiamo visto al capitolo quarto.
9.5. Limitata rilevanza della pluriennalità dei redditi ai fini della limitazione della progressività
In genere i sistemi fiscali sono incapaci di tener conto dello sforzo, del tempo
e dell’impegno necessari a produrre la ricchezza. Il fisco guarda solo la ricchezza,
in termini di redditi, consumi, patrimonio o investimenti, ed è troppo complicato
considerare la diversa fatica di produrli ed il rischio di non riuscire a “riprodurli in
futuro”. Anche questo è un riflesso della tassazione “oggettiva” e “frammentata” della
ricchezza, rispetto all’illusoria “capacità contributiva globale”, di cui abbiamo parlato
spesso (par. 2.2), e che dovrebbe considerare anche l’aleatorietà della ricchezza, soprattutto reddituale.
Un cantante di successo guadagna, esibendosi anche solo dieci volte l’anno, come
un alto dirigente che lavora tutti i giorni. A parità di reddito, l’imposta è la stessa, a prescindere dal tempo e dallo sforzo profusi. Tuttavia, proprio il confronto, sopra indicato,
del cantante di successo col dirigente industriale mostra un altro profilo che il tributo
non riesce a considerare. Si tratta dell’instabilità dei redditi, che per il cantante di successo può essere molto maggiore rispetto al dirigente industriale, che pure deve impiegare
262
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
più tempo ed energie per la produzione di un reddito analogo. Anche tralasciando la
progressività dei tributi, di cui diremo subito, una ricchezza prospetticamente discontinua meriterebbe forse, a parità di importo, un carico inferiore. In sintesi, anche se
l’impegno del cantante è meno intenso, le sue prospettive di redditività sono meno
stabili.
Ecco perché, nella frammentazione annuale della determinazione tributaristica della
ricchezza, sono aspetti trascurati non per negligenza legislativa, ma per oggettiva difficoltà. Ne deriva un incentivo fiscale a un reddito “sicuro”, non troppo alto, ma ben
distribuito nel tempo, il che non incentiva l’assunzione di rischio, ma in un contesto
restio alle valutazioni, e propenso alle predeterminazioni legislative, è il minimo che
possa accadere.
Inoltre, sempre con riferimento al confronto tra “cantante” e “dirigente”, l’aliquota
progressiva IRPEF comporta una tassazione più onerosa per i redditi concentrati in pochi periodi di imposta, ad esempio quelli di attori o sportivi, che godono di
brevi periodi di alti redditi. Abbiamo già visto le esigenze di semplicità e controllabilità
che ostacolano un temperamento della progressività per tali redditi «straordinari» cioè
difficilmente rinnovabili; la difficile ripetibilità di tali redditi, il loro carattere “isolato”,
e la loro breve durata, sono solo ipotesi proiettate nel futuro, ma tutte da verificare.
Per questo mancano attenuazioni della progressività rispetto all’eventualità che
il reddito non abbia a ripetersi in futuro; anche qui si conferma la considerazione
tendenzialmente isolata della ricchezza, e l’irrilevanza di vicende ulteriori della vita del
contribuente.
L’appena indicata incertezza viene però meno per i redditi «a formazione pluriennale», percepiti dopo un lungo arco di anni in cui i redditi stessi sono maturati; la
maturazione pluriennale guarda al passato, ed è quindi “certa” rispetto ad una aleatorietà che guarda al futuro. Per questo alcuni redditi pluriennali sono sottratti all’ordinaria imposizione progressiva IRPEF, e tassati con una aliquota media (c.d.
“tassazione separata”). Casi da ricordare, in quanto molto frequenti, sono il trattamento
di fine rapporto di lavoro dipendente e le plusvalenze per la cessione e liquidazione di
aziende (art. 17 lett. G TUIR).
9.6. L’IRAP come esempio di tassazione attraverso le aziende
Il concetto di “valore aggiunto” già indicato in molti passaggi di questo testo (par.
7.2) per spiegare l’azienda come organizzazione rispetto al “lavoro indipendente” è
utilissimo per capire l’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive). Il senso economico del tributo è tassare, presso l’impresa in cui si produce, il valore aggiunto economico (il “plusvalore”) rispetto alle materie prime e ai servizi di impresa consumati
nella produzione, che si distribuisce tra salari, interessi e profitti. L’aliquota è bassa,
attorno al 5 percento, secondo scelte della regione in cui ha sede l’impresa.
Si tratta idealmente, della ricchezza prodotta dall’impresa, al netto di quella erogata
ad altre imprese, e che quindi dovrà essere tassata presso di esse, onde evitare duplicazio-
Capitolo 9 – REALITÀ E PERSONALITÀ DEI TRIBUTI
263
ni. L’IRAP è tipica della tassazione ragionieristica attraverso le aziende, perché
fa leva sull’organizzazione aziendale per colpire una molteplicità di percettori di compensi e interessi. L’IRAP colpisce quindi presso l’impresa anche la ricchezza attribuita a
terzi, cioè dipendenti e finanziatori, e questo ha provocato una serie di scoordinamenti,
incomprensioni e polemiche, a cominciare da chi lamentava che l’imposta favorisse la
produzione attraverso macchinari (“i robot), con costo deducibile, rispetto ai lavoratori,
con costo indeducibile. Senza accorgersi del meccanismo sopra indicato, secondo cui il
macchinario è deducibile perché tassato presso il suo produttore, mentre il lavoratore,
percettore di valore aggiunto, dev’essere tassato presso l’azienda. Ciò avviene appunto
attraverso l’indeducibilità, e nei limiti del valore aggiunto prodotto dall’azienda.
Siccome i lavoratori e i finanziatori sono pagati in corso d’anno, ed il valore aggiunto si determina alla fine, potendo anche a posteriori mancare, non si è riusciti ad
immaginare una rivalsa giuridica (par. 3.5) sui finanziatori e sui dipendenti a fronte
dell’IRAP pagata dall’azienda erogante.
Proprio questa tassazione, in capo all’erogante, di ricchezza attribuita ad altri (interessi passivi e costo del lavoro nei limiti del valore aggiunto) senza rivalsa giuridica ha
ingigantito le incertezze e le polemiche sul tributo.
Secondo gli economisti è (giustamente) una imposta sul reddito, mentre i legali formulano evanescenti critiche di incostituzionalità, o immaginano un altrettanto
evanescente riferimento del tributo all’organizzazione produttiva, espressa da un fantomatico “potere sui fattori della produzione”; questo anche a fronte delle esternalità
negative provocate dall’azienda in termini di consumo di servizi e infrastrutture per
l’afflusso di dipendenti, merci, etc... Questa rilevanza dell’organizzazione “fisica” appare
però secondaria rispetto all’organizzazione contabile: ad esempio una miniera, un cementificio, un impianto siderurgico, con fortissimo impatto ambientale, organizzativo e
di traffico, potrebbero pagare ben poco, avendo esternalizzato i costi per materie prime,
trasporto, stoccaggio, servizi etc... Al contrario, società di software, a bassissimo impatto
sociale, ma con maggior valore aggiunto, pagherebbero molto di più.
Questa necessità di un’organizzazione si è radicata nella giurisprudenza, anche a
seguito di un intervento della corte costituzionale. Si sta affermando quindi l’esclusione
da IRAP delle piccole attività di lavoro autonomo “non organizzate in forma di impresa”, cioè non corredate di un nucleo minimo di beni strumentali. Tale soluzione intuisce la suddetta importanza dell’organizzazione amministrativa e quindi l’assurdità di
applicare l’IRAP agli operatori indipendenti, piccoli commercianti e artigiani operanti
verso consumatori finali. Per essi, che organizzano solo beni materiali, non ha senso
parlare di organizzazione, e il valore aggiunto deriva in massima parte dal lavoro
del titolare. In questi casi l’IRAP si trasforma in una imposta aggiuntiva sul reddito del
titolare, e quindi viene meno la sua necessità logica di imposta autonoma. Quando però questi soggetti “non organizzati” vengono pagati da un’organizzazione, la deduzione dei loro corrispettivi, ai fini IRAP, da parte del cliente, crea un salto di imposta,
un “vuoto d’IRAP”. Il fornitore infatti non è tassato, in quanto “non organizzato”, ma
il cliente deduce il corrispettivo ai fini IRAP da cui deriva una detassazione integrale
delle relative somme e una violazione del principio di neutralità delle forme giuridiche
264
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
rispetto alla determinazione della ricchezza: se infatti l’impresa assume i collaboratori
e paga l’IRAP, mentre li utilizza come fornitori indipendenti (in outsourcing di lavoro
non organizzato), né loro né lei pagano l’imposta. La deduzione IRAP in capo al
cliente andrebbe quindi subordinata alla dichiarazione del fornitore, in fattura, di essere
“organizzato”, e quindi soggetto al tributo.
La parte d’imposta relativa al valore aggiunto di pertinenza di terzi (lavoratori dipendenti e percettori d’interessi) è stata inizialmente indeducibile dalle altre imposte sui
redditi, con scelta irrazionale sul piano economico della determinazione della
ricchezza, corretta ad inizio 2012 con la possibilità di deduzione analitica, ai fini del
tributo sui redditi degli eroganti
Il riferimento al “valore aggiunto economico” non ha nulla a che vedere con l’IVA,
il cui valore aggiunto si riferisce alle precedenti applicazioni di tale tributo. Comunque,
di fronte alla “apparente stranezza” dell’IRAP si sospettò persino che essa duplicasse
l’IVA, con un procedimento di infrazione cui la corte di giustizia dell’Unione Europea
sembrava all’inizio dare credito, tra lo sconcerto degli economisti, ma che alla fine ha
respinto (sentenza CGCE 3 ottobre 2006 c475-03).
Capitolo 10
“TRIBUTI MINORI” TRA TASSAZIONE
ATTRAVERSO GLI UFFICI E LE AZIENDE
Sommario: 10.1. Una geografia dei “tributi minori” – 10.2. I tributi sugli atti giuridici solenni o visibili
– 10.3. Istituzioni e organizzazioni nella tassazione dei documenti giuridici (bollo e concessioni pubbliche) – 10.4. “Ricchezza patrimoniale”e difficoltà di una sua gestione “attraverso le aziende” – 10.5.
Successioni e donazioni: una difficile determinazione di ricchezza patrimoniale, senza l’aiuto delle
aziende – 10.6. Altri tributi speciali su consumi di determinati beni e servizi (incluso accise e dogane)
– 10.7. La metamorfosi comunitaria dei tributi doganali – 10.8.Tributi locali tra tassazione attraverso le
aziende e attraverso gli uffici: aspetti tributari del “federalismo fiscale” – 10.9. La tassazione patrimoniale locale sugli immobili (ICI e IMU) – 10.10. Aspetti concettuali di altri “tributi minori”
10.1.Una geografia dei “tributi minori”
In questo paragrafo esamineremo i numerosissimi tributi che, accanto alle poche grandi imposte gestite attraverso le aziende, restano ancorati alle precedenti
logiche della determinazione della ricchezza attraverso gli uffici (par. 1.3). Anche questi
tributi si sono, ovviamente adattati a una società moderna, spesso “esternalizzandosi”
anch’essi su particolari categorie di aziende, organizzazioni e professionisti (banche,
società petrolifere, emittenti o destinatari di documenti in serie, notai e altri pubblici
ufficiali).
Sono tributi in genere semplici le cui complicazioni, anche quando esistono, sono
circoscritte a casi particolari, affrontabili col bagaglio economico giuridico generale degli operatori economico giuridici. Mentre nel sistema delle imposte sui redditi e dell’IVA ci sono tante logiche intrecciate, da coordinare di volta in volta, i tributi tradizionali,
ancorché modernizzati, hanno meccanismi circoscritti, indipendenti l’uno rispetto
all’altro, dove la determinazione della ricchezza è facilmente intuibile.
È uno dei motivi per cui, nella prassi, si parla di “tributi minori”, con una definizione giustificata da ragioni concettuali, non di importanza economica e di gettito (su cui
par. 1.10); alcuni “tributi minori”, come le imposte di fabbricazione, danno anzi
un gettito notevolissimo. Un’altra ragione dell’aggettivo “minori” è che tali tributi
non sono ad ampio spettro, non riguardano, in modo necessario e sistematico, la generalità degli operatori economici, come avviene per il sistema dell’IVA e delle imposte
sui redditi. Spesso, anche quando riguardano la generalità degli individui, lo fanno per
266
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
circostanze che si verificano raramente, come un’eredità o un acquisto immobiliare.
Quando si tratta di eventi ricorrenti, come le imposte immobiliari, le tasse auto o quelle per la raccolta rifiuti, si tratta anche di pagamenti molto elementari, e di solito per
ammontari trascurabili.
Un’ulteriore ragione per cui, tra gli addetti ai lavori, un tributo viene considerato
“minore” è la sua modesta rilevanza professionale, in un contesto oggetto della
decerebrazione professionale di cui al par. 4.4.
Per quest’insieme di motivi alcuni tributi economicamente importanti, come
le già indicate imposte di fabbricazione sugli oli minerali, oppure molto efficienti,
come il bollo, sono inseriti tra i «tributi minori». Sono tributi trascurati dai manuali, dai
corsi di formazione, dagli articoli della pubblicistica, anche perché la loro applicazione
è pressoché proceduralizzata entro alvei ben delimitati, e perché provocano raramente
questioni che giustifichino le spese di un parere professionale o di una controversia
giudiziaria. Sono però tributi frequenti nella vita di tutti i giorni e nel dibattito politico-economico, con un forte radicamento nel passato, e quindi una grande
tradizione storica, di cui sono prive le imposte della “tassazione attraverso le aziende”.
Nei paragrafi successivi collegheremo quindi le caratteristiche di tali tributi con
alcune questioni trattate nella prima parte. Sono interrogativi che, per questa fiscalità
“minore” si pongono spesso in modo più interessante di quanto avvenga per il sistema
della tassazione attraverso le aziende, dove il riferimento economico a redditi e consumi
è molto chiaro. Se invece ci mettiamo a riflettere su tributi come la tassa di possesso
veicoli (c.d. “bollo auto”), le tasse d’imbarco aeroportuali, i diritti per l’iscrizione alla
camera di commercio o il canone Rai-TV di cui neppure parleremo in questo testo,
sorgono interrogativi molto più misteriosi sul senso economico giuridico dei meccanismi sottostanti. Sembra quasi che, più il tributo è “minore”, meno sia facilmente
inquadrabile in termini di ricchezza. I tributi minori stimolano quindi riflessioni
che non sorgono per l’IVA o le imposte sui redditi. È forse un riflesso del gradualismo
dei concetti nelle discipline economico sociali, dove nelle zone grigie, nelle sfumature
intermedie si trovano gli istituti più interessanti. Che però spesso, come già rilevato nel
nostro caso, rilevano poco sul piano professionale e sono quindi trascurati da una pubblicistica di impostazione prevalentemente professionale.
10.2.I tributi sugli atti giuridici solenni o visibili
La ricchezza può essere manifestata anche da atti giuridici “solenni”, che costituiscono una facile occasione di tassazione, come indicato al par. 1.3, quando i contraenti
vogliono vedersi riconosciuto dal pubblico potere il loro diritto; gli archivi
della proprietà immobiliare costituiscono un esempio lampante di come il «servizio di certezza pubblica», diretto alla certificazione dei diritti proprietari, possa
diventare una efficiente occasione per imporre tributi.
Nell’imposta di registro la ricchezza non emerge nella sua visibilità materiale,
come abbiamo visto al par. 1.3 per le movimentazioni di merci o le coltivazioni dei
CAPITOLO 10 – “TRIBUTI MINORI”
267
campi, bensì da rapporti giuridici formalizzati; in questo, la visibilità giuridica della
ricchezza attraverso gli atti solenni ha anticipato, storicamente, la sua attuale visibilità
attraverso la contabilità aziendale; quest’ultima, infatti, è in ultima analisi una documentazione continuativa di rapporti giuridici, affidabile grazie alle esigenze gestionali
delle organizzazioni di cui al capitolo terzo; l’imposta di registro ha quindi anticipato
le questioni, trattate al par. 3.9, sulla qualificazione tributaria di ricchezza emersa per
ragioni gestionali “commerciali”.
Gli atti formali, per cui una simile imposta è oggi “efficiente” sono in prevalenza
quelli aventi ad oggetto la ricchezza immobiliare, anche se il tributo si applica
a tutti quelli che – per motivi di certezza giuridica – si decida di cristallizzare in atti
giuridici “solenni”, in genere redatti da pubblico ufficiale; solo per alcuni atti, come le
cessioni di azienda o le locazioni immobiliari, è prevista l’assoggettabilità all’imposta
anche senza requisiti formali, in quanto il rapporto è visibile in altro modo, per la sua
durata nel tempo (locazioni) o visibilità esteriore (cessione di aziende).
Dopo la solenne enunciazione secondo cui l’imposta colpirebbe tutti gli atti scritti a
contenuto patrimoniale formati nel territorio dello Stato, la sfera applicativa del tributo
si riduce, per l’ovvia esclusione degli atti formati per corrispondenza, nel senso
di “scambio di dichiarazioni”, non altrimenti “visibili”, nonché per quelli relativi ad
operazioni soggette all’IVA; questo sottrae alla sfera applicativa del tributo anche
atti per i quali sussiste una forma giuridica “solenne”, ma che –essendo soggetti ad IVA
– pagano l’imposta di registro in misura fissa (oggi 168 euro), non nella misura proporzionale di cui diremo subito.
I trasferimenti di beni immobili sono soggetti ad aliquote elevate (7% per i fabbricati e 15% per i terreni), più le imposte ipotecarie e catastali, applicate nella misura
complessiva del 3%.
Segnaliamo le riduzioni, per gli immobili da adibire a prima abitazione dell’acquirente, dove l’aliquota è del 3% e le imposte ipotecario-catastali sono applicate in
misura fissa.
L’imposta fa perno sui pubblici ufficiali (ad es. notai), che devono chiedere la
registrazione per gli atti che redigono, ferma restando la responsabilità solidale delle
parti, cui si riferisce la ricchezza.
Quanto precede conferma quindi che l’imposta di registro mantiene, sul settore
immobiliare, una tassazione patrimoniale, che ostacola la circolazione degli immobili, senza riuscire a distinguere gli arricchimenti dagli impoverimenti, come farebbe
invece una fiscalità a carattere maggiormente reddituale, diretta a canoni di locazione
e plusvalenze.
A parte casi particolari, i contraenti hanno interesse solo alla trascrizione dell’atto immobiliare, mentre non hanno interesse all’emersione del prezzo effettivo: sarebbe
quindi troppo pericoloso, sul piano della cautela fiscale, prevedere la tassazione solo in
base ai corrispettivi dichiarati. I valori immobiliari dichiarati in atto sono quindi soggetti ad accertamento da parte degli uffici, in base al valore venale in comune commercio.
Il gran numero di atti riguardanti beni immobili e l’onerosità dell’aliquota applicabile
hanno provocato frequentissime controversie sulla determinazione del valore venale di
268
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
tali beni, stante anche l’opinabilità della relativa valutazione, tanto da far introdurre un
criterio automatico (art. 52) basato sul valore catastale del bene, nonostante le frequenti
sperequazioni rispetto al valore effettivo; nelle compravendite immobiliari tra privati
aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, è infatti consentito pagare il tributo di registro sul suddetto valore catastale, pur evidenziando in atto il maggior prezzo effettivo.
Sono soggette ad imposta, in quanto atti solenni, anche le sentenze, cercando di
riprodurre il regime applicabile ove una manifestazione economica analoga fosse invece
realizzata contrattualmente.
L’applicazione dell’imposta di registro sui principali atti societari, pure redatti
in forma solenne (art. 4 della tariffa) si è fortemente ridotta negli ultimi anni, a seguito di direttive delle comunità europee. La tassazione proporzionale di registro resta
pertanto applicabile, per forza di inerzia e sfasamenti legislativi, solo sui conferimenti di
“beni materiali isolati” (compresi gli immobili ed escluse le aziende) e sulle cessioni di
aziende dietro corrispettivo.
10.3.Istituzioni e organizzazioni nella tassazione dei documenti giuridici
(bollo e concessioni pubbliche)
L’imposta di bollo è tutt’altro che «minore» sul piano della tradizione, e conferma
l’importanza delle strutture amministrative organizzate, sostenuta in tutto il testo; stavolta si tratta delle strutture che ricevono o emettono atti (anagrafici, di pubblica
sicurezza, giudiziari, etc.), controllando anche il pagamento dell’imposta; analoga affidabilità hanno le grandi strutture aziendali (banca, assicurazione, società immobiliare, etc.), che non possono permettersi, per i noti motivi gestionali, di sottrarsi sistematicamente al pagamento. Quando questi uffici non sono coinvolti, l’imposta viene
di solito evasa, come accade nei rapporti tra privati e piccole realtà organizzative come
un condominio, una associazione privata, una piccola azienda, un medico. Del resto,
quando non si tratta di grandi organizzazioni che emettono documenti in serie, ma
di applicazioni polverizzate nel tempo e nello spazio, anche il controllo fiscale si rivela
antieconomico, visto il modesto importo unitario del tributo. Anche qui, insomma, è
importante la ripetitività, la serialità dell’emissione di documenti soggetti al tributo.
Solo in casi eccezionali il tributo è proporzionale al «valore del documento», come
accade per le cambiali.
L’acquisto e l’annullamento delle marche da bollo è la modalità di pagamento per
le applicazioni occasionali del tributo, mentre i “grandi utenti” lo corrispondono in
modo c.d. «virtuale», cioè su dichiarazione periodica che indica il numero complessivo
dei documenti emessi.
La giustificazione dell’imposta di bollo in termini di ricchezza è abbastanza
labile; qualche volta l’atto sottostante esprime un contenuto patrimoniale, ma altre
volte c’è solo un collegamento con una pubblica funzione, e il tributo potrebbe giustificarsi in termini di “tassa”, par. 5.1 (si pensi ad esempio al bollo sui certificati universitari e scolastici).
CAPITOLO 10 – “TRIBUTI MINORI”
269
Lo stesso riferimento a pubbliche funzioni, documenti amministrativi, autorizzazioni, certificati etc., si ritrova nel tributo sulle concessioni governative o di enti locali,
anch’esso più “tassa” che “imposta” (si pensi a passaporti, patenti, autorizzazioni varie,
libri sociali, etc.). Anche qui sono gli uffici amministrativi che si occupano di queste
materie ad assicurare, indirettamente, il gettito del tributo.
10.4.“Ricchezza patrimoniale”e difficoltà di una sua gestione “attraverso
le aziende”
La ricchezza patrimoniale sfugge alla tassazione attraverso le aziende, che proprio
in quanto organizzazioni, riescono a individuare la ricchezza nel suo aspetto dinamico,
nel più volte menzionato circuito “acquisizione di consumi-erogazione di redditi” (ad es. paragrafi 1.8, 7.1). Dal ciclo in cui le aziende incamerano consumi ed erogano redditi resta fuori il patrimonio, inteso come ricchezza nel suo aspetto statico, cioè beni immobili o investimenti finanziari. Anche gli elementi patrimoniali
“tracciabili” presso le aziende (si pensi ai depositi bancari), si pongono fuori dal sopra
indicato circuito tipico “consumi–redditi”, essendo casomai lo strumento di un servizio
di impresa. Per questo la tassazione patrimoniale “attraverso le aziende” è complessa, e
non può essere generalizzata, anche se spesso alcuni elementi patrimoniali “tracciabili”
attraverso le aziende, come i “conti deposito titoli”, sono stati assoggettati a tributi applicati (inutile dirlo) attraverso banche e intermediari finanziari.
Anche la tassazione patrimoniale risponde al criterio secondo cui “tutte le imposte, anche se non colpiscono i redditi”, si pagano coi redditi”, come frutto dell’attività
umana produttiva di beni e di servizi (par. 1.8). Sul piano della precisione nella determinazione della ricchezza e nella sua effettività, è preferibile una tassazione dei redditi di fonte patrimoniale che una tassazione del patrimonio come tale, che scatta
anche quando esso è infruttifero e diminuisce di valore. Per questo, quanto maggiori
sono le informazioni sulla generalità dei redditi, tanto meno è necessaria una imposta
patrimoniale.
Man mano che si perde il controllo dei redditi, soprattutto quelli non determinabili
attraverso le aziende, il patrimonio emerge come soluzione di ripiego. Inoltre, le
condizioni economiche di buona parte delle famiglie sono sempre più influenzate dal
patrimonio, anche a seguito della stagnazione economica, della perdita del valore reale delle retribuzioni a seguito della concorrenza internazionale, del diffuso precariato
giovanile, degli stipendi immobili rispetto all’inflazione, della diffusione di lavoro nero
a basso costo da parte di extracomunitari, dello spostamento delle produzioni in paesi
emergenti. Per questo, il reddito IRPEF è sempre meno indicativo dell’effettiva situazione economica delle persone e delle famiglie. Il suo appiattimento si somma infatti
coi fattori, come l’evasione e la consistenza patrimoniale, che già prima lo rendevano
poco significativo; è insomma inutile discutere se la classe media inizi a 50.000 euro di
reddito Irpef oppure a 70.000, perché ormai la differenza di condizioni economiche
dipende sempre più da altri fattori.
270
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
Tuttavia la risposta a questa situazione sarebbe una considerazione più attenta dei
redditi di fonte patrimoniale, sia in termini di frutti che di plusvalenze. L’inadeguatezza
nel progettare un monitoraggio di questi fenomeni spinge a ripiegare su rozze forme
di “patrimoniale”. Anche quando il patrimonio si concretizza in ricchezza amministrativamente visibile, come depositi bancari, investimenti finanziari, gestioni fiduciarie, le
aziende possono agire da esattori del fisco solo sui cespiti patrimoniali di cui hanno
conoscenza, avendoli ad esempio in deposito.
Le aziende non riescono, a maggior ragione, a coordinare ipotetiche tassazioni patrimoniali con quelle reddituali, dando sfogo alla riflessione, di senso comune, secondo
cui il patrimonio formato con redditi tassati dovrebbe essere esentato, o comunque
tassato con aliquote più miti. Il fatto è che, con gli anni i redditi, dichiarati, fiscalmente
irrilevanti o evasi, si patrimonializzano, si stratificano e danno luogo a uno “stock”, che
passa di mano ormai lontano dalle ricostruzioni del fisco. Non possono essere certo le
aziende a capire se il patrimonio viene da risparmi di una vita di lavoro, propria e dei
propri genitori, evasioni fiscali ormai remote, retaggi familiari di un passato lontano,
speculazioni fortunate, eredità, arricchimenti di dubbia legittimità ormai non più perseguibili, azzeccati investimenti immobiliari fiscalmente irrilevanti o sfuggiti al fisco.
L’imposta sul patrimonio deve quindi essere gestita in primo luogo dalla macchina
fiscale, al massimo con un contributo collaterale delle altre. Oggi il fisco può “vedere”,
in modo sufficientemente sistematico solo la ricchezza risultante dai pubblici registri,
cioè i trasferimenti immobiliari e le eredità; già gli sfuggono però i trasferimenti delle
società intestatarie degli immobili, le rinunzie ai crediti, il titolo giuridico delle cointestazioni dei conti bancari, le intestazioni fiduciarie, i prestanome. Il potere amministrativo tributario fatica quindi ad acquisire e gestire, anche in modo valutativo, informazioni
detenute da terzi, senza poter loro delegare del tutto una imposta patrimoniale.
Il vero ostacolo alla tassazione patrimoniale in Italia si colloca quindi sul versante concettuale della determinazione della ricchezza. A questo proposito è bene
chiudere con alcune riflessioni sulla composizione del patrimonio degli italiani e sul suo
grado di accentramento o frammentazione.
La ricchezza si produce nelle imprese, negli affari, e poi si rifugia nel mattone,
negli immobili o in altri affari, magari più tranquilli: il precedente profitto d’impresa
si trasforma in rendita fondiaria o finanziaria, in speculazione immobiliare, in “affare
occasionale”.. Le rendite finanziarie, come indicato al par. 8.5, possono dare qualche
soddisfazione di breve periodo, ma la storia dimostra che il popolo dei borsini, dei bot,
dei bond argentini e dei fondi comuni è destinato, nella media, a recuperare a stento la
perdita di valore della moneta.
L’unico patrimonio ulteriore è quello costituito “dalle aziende”, cioè il valore
delle aziende nel patrimonio dei rispettivi titolari, soprattutto il capitalismo familiare
italiano; tassare il patrimonio “delle aziende” è controproducente rispetto alla loro esigenza di capitalizzazione, alla facilità di tassarne i redditi ed all’esigenza di renderle più
grandi e più rigide (non dimentichiamo che le aziende saranno sempre il principale
esattore dei tributi; si tratta quindi di chiedersi in quale misura tassare “come persone”,
anche i proprietari delle aziende, utilizzando come parametro la quota parte del rela-
CAPITOLO 10 – “TRIBUTI MINORI”
271
tivo valore. Non in modo punitivo, ed anzi come riconoscimento del loro contributo
all’organizzazione e alla coesione sociale. Sono però riflessioni che travalicano i limiti
di questo testo, e che andrebbero approfondite, prendendo le mosse dalla necessità di
gestire attraverso gli uffici qualsiasi imposta patrimoniale.
I singoli elementi patrimoniali, casualmente visibili attraverso le aziende o pubblici
registri, come conti deposito titoli, immobili o imbarcazioni, possono essere raggiunti
da imposte che non presentano particolari problemi applicativi. Basti pensare alle “tasse
auto” (infra par. 10.9) o alle tasse sui natanti di lusso, o gli aeromobili.
Proprio queste ultime consentono alcune riflessioni, che sviluppano la giustificazione ordinaria del tributo patrimoniale su cespiti produttivi di redditi, presenti o prospettici. Mi riferisco al valore degli immobili, colpito da imposte che si giustificano a fronte
dei redditi presenti (canoni di locazione) e futuri, come le plusvalenze da rivalutazione
dell’immobile. È intuitiva la discussione sulla accettabilità dell’imposta patrimoniale
quando il valore capitale dei beni diminuisce, ma questo può essere giustificato dalle
logiche forfettarie della tassazione sui beni che esprimono un investimento (lo stesso
vale per la tassazione patrimoniale degli investimenti finanziari).
Il senso della tassazione dei patrimoni di lusso, che non danno frutti né si rivalutano, è che essi rendono verosimile una condizione economica florida in generale. È
la conferma dell’impossibilità di esternalizzare la gestione di questi tributi, e la necessità,
per renderli socialmente accettabili, di una loro efficiente gestione valutativa da parte
della macchina pubblica. Altrimenti resteranno solo la maldestra espressione di confusionarie e distruttive invidie sociali.
10.5.Successioni e donazioni: una difficile determinazione di ricchezza patrimoniale, senza l’aiuto delle aziende
L’intervento degli uffici tributari nella tassazione patrimoniale è fondamentale
quando il patrimonio transita per successione ereditaria o per donazione; in
tali casi esso si trova infatti lontanissimo dalle aziende. Tuttavia, in tutti i paesi,
le successioni e le donazioni sono ritenute a una importante manifestazione di
ricchezza, ancorché prive in sé di natura reddituale; già il concetto comune di reddito
chiarisce che gli incrementi patrimoniali gratuiti, derivanti cioè da successioni e donazioni, non ne fanno parte. L’etimologia stessa della parola reddito (dal latino «reditus»)
indica infatti che esso è un qualcosa che ci «ritorna» perché, in cambio, abbiamo dato o
fatto qualcosa. Nelle donazioni o successioni viene invece conseguito un patrimonio che altri hanno abbandonato, per liberalità o per causa di morte, ma comunque
senza alcuna contropartita.
Tuttavia anche queste entrate “non reddituali” idealmente rilevano ai fini della posizione del beneficiario nella società, della ricchezza cui guardare per effettuare la ripartizione delle spese pubbliche. Ricevere ricchezza dalla propria famiglia, o da altri,
migliora la posizione economica nella società, e per questo quasi tutti i paesi assoggettano a tassazione le successioni e donazioni “rilevanti”. È un punto di
272
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
vista particolarmente avvertito in società mature come quella attuale (secondo quanto
rilevato sopra in questo stesso paragrafo), in cui la mobilità sociale è ridotta, le occasioni
di migliorare la propria condizione sono scarse, le prospettive di successo aleatorie e la
posizione familiare è determinante sullo status sociale.
La difficoltà sussiste piuttosto sul piano della determinazione della ricchezza, che qui è lontanissima dalle aziende; i punti forti, per la visibilità della ricchezza,
riguardano solo la registrazione di alcuni beni in pubblici elenchi, dove il beneficiario
(erede o donatario) ha bisogno di sostituirsi al vecchio titolare. Quando la ricchezza era
prevalentemente “immobiliar-fondiaria”, questo tributo era una parte importante della
“tassazione degli atti solenni”. Con la “finanziarizzazione” del patrimonio, e con
l’intestazione a società anche dei patrimoni immobiliari più consistenti, l’imposta si è
svuotata, in quanto inidonea a raggiungere i trasferimenti di ricchezza finanziaria ed
i passaggi di quote societarie; per questi passaggi non servivano più “atti solenni”, ma
bastavano atti “informali” e “donazioni indirette”, realizzate ad esempio senza atto pubblico, ma ugualmente valide, come la rinuncia a crediti, a diritti di opzione, i pagamenti
di debiti altrui etc. Questo “svuotamento” dell’imposta era in parte del tutto naturale, conforme ai modi ordinari di circolazione della ricchezza “mobiliare”; altre volte
strumenti informali di trasferimento, anteriori alla morte, erano pianificati al posto del
testamento, in modo che l’interessato morisse poco più che nullatenente, con notevoli
intralci nel c.d. «passaggio generazionale» delle imprese.
Questa situazione era condivisa dalle classi dirigenti, al termine del ventesimo secolo,
ma le reazioni ebbero sfumature diverse. Il governo di centro sinistra, nel 2000, cercò
di rompere il collegamento all’imposta di registro, abbassando le aliquote (non
superiori all’8%), aumentando le quote esenti e ampliando la base imponibile, tentando
di recuperare anche i trasferimenti mobiliari, non formalizzati in atti soggetti a registrazione.
La difficile qualificabilità dei passaggi informali di ricchezza, soprattutto
all’interno dei nuclei familiari, ne ostacolava un diretto accertamento; si stabilì quindi
di tassare la ricchezza che il contribuente, in sede di accertamento basato sulla spesa
(par. 5.14), spiegasse con le suddette liberalità “informali”. L’accertamento dei tributi sui
redditi diventava quindi uno strumento per accertare il tributo sulle donazioni. Questa
regola, che avrebbe potuto essere perfezionata, non fu tuttavia utilizzata in pratica, ed
anche oggi, dopo essere stata in vigore molti anni, sembra caduta in desuetudine.
L’appiattimento del diritto sulla legislazione, e quindi sulla politica, danneggia anche
la politica, che avverte una certa desiderabilità sociale di simili imposte, intuendone
però anche la scarsa gestibilità, coi soliti problemi di valutazione della ricchezza da parte
degli uffici tributari.
Un tributo successorio, con aliquote ragionevoli, ed autonomo rispetto alla solennità
degli atti, consente di mantenere un certo controllo sulla ricchezza patrimoniale, legittimando le differenze sociali di partenza, e per questo apprezzato proprio nelle ideologie
liberali e liberiste, perplesse di fronte alla formazione di aristocrazie imprenditoriali e
finanziarie, connesse alla nascita e relativamente svincolate dal merito. Nell’impossibilità
di far ripartire da zero, ad ogni passaggio di generazione, la competizione sociale, il tri-
CAPITOLO 10 – “TRIBUTI MINORI”
273
buto successorio diventa una soluzione di ripiego per legittimare politicamente
le differenze sociali agli occhi dei meno fortunati alla nascita. Un ordine di grandezza
del patrimonio complessivo delle persone fisiche è inoltre utilissimo per tenere sotto
controllo i redditi evasi, come indicato al par. 5.13.
Per questo un tributo successorio, o una imposta ordinaria sul patrimonio, è presente
nella maggior parte dei paesi ad economia mista, il che conferma il mantenimento, da
parte di altre amministrazioni fiscali, di una capacità valutativa della ricchezza.
10.6.Altri tributi speciali su consumi di determinati beni e servizi (incluso
accise e dogane)
La tradizione di colpire la ricchezza espressa dalle quantità di merci (paragrafo 7.2)
si è mantenuta per poche imposte, relative a beni con modalità di circolazione
ancora fisicamente controllabili dal fisco; al loro interno troviamo imposte sui prodotti petroliferi, la cui importazione e distribuzione è facile da controllare, imposte
sull’energia elettrica, gas di città (c.d. «accise»), generi di monopolio (tabacchi e
lotterie), nonché assicurazioni.
Si tratta di tributi dalle origini molto antiche, comprensibili in base al tradizionale
schema dei poteri amministrativi applicati a ricchezza facilmente visibile; anche questi
tributi si sono però adeguati alle attuali modalità “analitico aziendali”; anche di questa
tipologia di tributi sono rimasti solo quelli ormai esternalizzati, applicati grazie a pochi
grandi soggetti, caratterizzati dalle note rigidità amministrative, e quindi fiscalmente
affidabili.
Si tratta senz’altro di imposte sui consumi, anche se applicate (per ovvi motivi di
semplicità) in capo al produttore o all’importatore, il quale le riaddebita poi ai propri
clienti, comprendendole nel prezzo, fino ad arrivare sul consumatore. Benché il soggetto passivo delle imposte di fabbricazione sia il produttore, e l’imposta sia dovuta in stadi
anteriori a quello in cui i beni sono immessi al consumo, si tratta di tributi destinati ad
essere economicamente traslati sul consumatore finale, dove la grande organizzazione
amministrativa fa sostanzialmente da esattore (par. 3.5).
Sono quindi imposte che coesistono (e spesso si cumulano) con l’imposizione
generale sui consumi rappresentata dall’IVA, grazie a specifiche autorizzazioni comunitarie. A differenza dell’IVA, queste imposte mantengono l’antica tradizione di
essere applicate alla quantità delle merci, trascurandone il prezzo di vendita.
La valutazione di questi singoli tributi in termini di equità ed efficienza cambia a
seconda delle modalità di produzione e di distribuzione del bene tassato (benzina, sigarette, etc.), come vedremo più avanti. L’elemento comune a tutte queste imposte, per
altri versi eterogenee, è una applicazione accentrata sul fornitore-esattore, che
poi si rivale sui proprio clienti, fino ad arrivare ai consumatori finali. Questa «famiglia»
di tributi funziona tanto più efficacemente quanto più la produzione o la distribuzione
sono concentrate in poche grandi aziende. In questo caso è facile effettuare una vera e
propria vigilanza fisica, da parte degli uffici fiscali, sulle fasi di lavorazione e movimen-
274
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
tazione del prodotto. L’efficienza di questi tributi diminuisce, perché le speciali cautele,
la vigilanza, i controlli fisici e i contrassegni rischiano di dover essere troppo capillari,
diventano antieconomici e insufficienti a contenere l’evasione.
Questo spiega il fallimento di alcune imposte di fabbricazione, come quelle sui sacchetti di plastica, facili da produrre in strutture di fortuna, con macchinari abbastanza
semplici. Insomma, le raffinerie di petrolio clandestine non esistono per il semplice
fatto che sarebbero in perdita, e che è più conveniente pagare l’imposta. Analoghe considerazioni valgono per il contrabbando effettuato trasportando fisicamente le merci
oltrefrontiera: è conveniente per le sigarette e sarebbe antieconomico per gli idrocarburi. Sono altre conferme dell’importanza, ai fini della valutazione di un tributo, delle
modalità di circolazione della ricchezza cui si riferisce.
Sono sostanzialmente imposte di consumo («accise») quelle sull’energia elettrica, il
cui successo dipende anche qui dalla concentrazione dell’offerta presso pochi soggetti
facilmente controllabili (ENEL, Aziende ex municipalizzate, Italgas e simili), che riforniscono un gran numero di consumatori, attraverso apposite condutture, direttamente
nel domicilio degli utenti.
Non c’è perciò un problema di contrabbando e di controllo delle movimentazioni
fisiche dei prodotti; è invece sufficiente imporre al fornitore di applicare, nelle proprie fatture di addebito (ad es. bolletta ENEL), anche il tributo; la gestione di tali imposte è perciò
molto semplice: pochi “grandi fornitori” pagheranno ed effettueranno la rivalsa sui clienti.
Sul piano economico-funzionale, imposte sul «consumo di servizi» sono anche
quella sulle assicurazioni, dove la società di assicurazione addebita il tributo ai propri
assicurati, proporzionalmente al premio pattuito (si ritorna perciò ad una imposta commisurata al corrispettivo) e lo versa al fisco; in modo analogo, cioè facendo leva sulla
struttura amministrativa del fornitore, funziona anche la tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari “in abbonamento”.
Alla categoria dei tributi sul consumo possono essere ricondotte – sotto il profilo
della funzione e della struttura – anche le entrate pubbliche derivanti dal monopolio
(par. 5.1), come la distribuzione dei tabacchi ed il lotto, lotterie e concorsi a premio.
Anche il sistema si basa su una prededuzione dal denaro raccolto vendendo i biglietti: insomma, “gratta gratta” lo Stato vince sempre e il resto possono pure dividerselo i
fortunati vincitori.
10.7. La metamorfosi comunitaria dei tributi doganali
I tributi doganali hanno antichissime origini, rappresentando la più elementare affermazione della sovranità statale sul territorio, con risvolti anche fiscali. La loro applicazione è semplice, in quanto si accompagna a una vigilanza sui confini, svolta
per motivi di ordine pubblico, sanitario, di sicurezza, etc... Un tempo la sorveglianza
doganale, ed i tributi di questo tipo, svolgevano anche una funzione protezionistica
dell’industria nazionale dalla concorrenza straniera.
CAPITOLO 10 – “TRIBUTI MINORI”
275
Con l’integrazione economica mondiale e con la transizione verso una libera circolazione delle merci e dei servizi, le barriere doganali sono entrate in crisi, venendo
abolite tra i paesi comunitari (par. 2.6), come visto già a proposito dell’IVA; le barriere doganali sono rimaste solo ai confini terrestri con gli stati non appartenenti all’UE
(Svizzera), nei porti e negli aeroporti: questi confini sono diventati non solo nazionali,
ma confini dell’unione europea, nel senso che, una volta giunte in un paese dell’unione, le merci potranno circolare in tutti i paesi membri, senza incontrare altre barriere;
accanto alla vigilanza fisica al confine sono diventati perciò importanti i controlli sul
territorio, tendenti ad accertare la provenienza delle merci.
Il gettito dei tributi doganali prelevati su merci di provenienza estranea all’Unione
Europea è acquisito dalle autorità fiscali nazionali (la nostra Agenzia delle Dogane), ma interamente devoluto all’Unione Europea. Quest’ultima emette altresì la
normativa doganale applicabile dalle amministrazioni nazionali.
10.8.Tributi locali tra tassazione attraverso le aziende e attraverso gli uffici: aspetti tributari del “federalismo fiscale”
La tassazione attraverso le aziende ha depotenziato i tributi degli enti locali,
come le regioni e i comuni; questi ultimi, infatti, quando la richiesta dei tributi proveniva da pubblici uffici, erano anche ottimi acquisitori di imposte, visto il loro radicamento sul territorio; quando esistevano relazioni di vicinato solide e coese, gli enti
locali avevano un vantaggio competitivo nell’acquisizione delle entrate, oggi svanito in
aree urbane sempre più spersonalizzate, mentre la tassazione è sempre più esternalizzata
sulle aziende.
La determinazione della ricchezza attraverso le aziende, nuovi corpi sociali (par. 3.1)
ha spiazzato le antiche collettività locali, ben contente, da parte loro, di abbandonare più possibile il ruolo, politicamente non gradito, soprattutto in democrazia,
di esattori dei tributi. Il ruolo degli enti locali nella determinazione della ricchezza
ai fini tributari è stato quindi in buona parte soppiantato, con la riforma tributaria del
1973, da quello delle aziende; queste ultime, dal canto loro, trovavano più semplice
interagire con istituzioni pubbliche a dimensione nazionale, anziché con innumerevoli
enti locali diversi.
Questo declino dei tributi locali ha impedito di utilizzare i comuni per determinare la ricchezza che sfugge alla tassazione attraverso le aziende; mi riferisco a locazioni
immobiliari tra privati, valorizzazione del territorio (in parole povere speculazione edilizia “minuta”), piccolo commercio e servizi, sui quali le strutture locali interferiscono
fortemente. Questa ricchezza può essere “visibile”, sia pure per ordine di grandezza,
solo da parte degli enti locali, che potrebbero supplire alla già indicata perdita di controllo del territorio delle amministrazioni centrali (paragrafo 5.3).
L’opinione pubblica, e le classi dirigenti, pur non avvertendo questo profilo della
determinazione tributaristica della ricchezza, si sono rese conto di altri inconvenienti
della diminuzione dei tributi locali, a cominciare dalla deresponsabilizzazione degli
276
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
enti territoriali, che si sono trovati ad essere erogatori di spesa, finanziata da trasferimenti del governo centrale. È quindi venuto meno l’autogoverno fiscale degli enti
territoriali, con uno sfasamento della spesa rispetto alle entrate. È quindi venuto meno
l’autogoverno fiscale, cioè la possibilità di stabilire le proprie spese e le modalità
con cui coprirle, cercando l’equilibrio migliore con la tassazione dei loro amministrati.
Questo squilibrio tra spese e tributi locali ha provocato non solo deresponsabilizzazione, ma anche lamentele da parte delle regioni più sviluppate; ad avviso di queste ultime,
infatti, i tributi statali raccolti sul loro territorio andavano a finanziare non tanto i servizi
pubblici, quanto gli sprechi, delle aree meno sviluppate.
Ne sono nate, a partire dal 1993, discussioni politico sociali genericamente indicate
con l’espressione “federalismo fiscale“, inteso come esigenza di avvicinare le entrate locali alle spese locali, garantendo i servizi essenziali alle aree territoriali più
deboli, ma stimolandone l’efficienza amministrativa. Si tratta di un problema complessivo di finanza pubblica, che travalica l’aspetto puramente tributario, cui si riferiscono
le discussioni sul c.d. “Federalismo fiscale”; l’aspetto più innovativo della legge delega
42-2009 in proposito è la determinazione dei trasferimenti statali in base a
parametri di “costo standard” validi per tutte le regioni, in modo da fronteggiare
sprechi e inefficienze.
Sul piano più strettamente tributario, anche il federalismo fiscale si è agganciato alla
tassazione attraverso le aziende, soprattutto attraverso le addizionali regionali e comunali ai tributi statali sulle persone fisiche dando così agli enti territoriali margini
di autogoverno su ricchezza determinata ai fini di imposte statali. La scelta è efficiente
in termini di costi di determinazione e riscossione, in quanto si utilizzano informazioni
già presenti nella tassazione attraverso le aziende. Di quest’ultima però si riproducono
anche gli squilibri, in quanto la ricchezza esclusa, di diritto o di fatto, dall’Irpef, non è
soggetta neppure alle relative addizionali.
In questo contesto, la tassazione locale si è rivolta a ricchezza fortemente
legata al territorio, come gli immobili di cui al prossimo paragrafo, o beni mobili
registrati, oppure a varie forme intermedie tra “tasse” e “tariffe” (raccolta rifiuti,
occupazione suolo, servizi idrici e depurazione acque, di alcuni dei quali si è detto
al par. 5.1).
Molti di questi tributi non sono però facilmente gestibili, in quanto altamente frammentati sul territorio, riferiti a un gran numero di contribuenti, ciascuno debitore di
importi modesti, e quindi con notevoli difficoltà gestionali di determinazione della
ricchezza e di riscossione. Il diritto tributario degli enti locali è insomma quello dove
sono minori le possibilità di esternalizzare sulle aziende la determinazione della ricchezza e la riscossione dei tributi. Nella maggior parte dei tributi locali, invece, serve
ancora quel forte intervento sistematico degli uffici pubblici, che conferma la matrice
amministrativa del nostro settore.
Potrebbe essere importante l’utilizzazione degli enti locali per determinare la ricchezza dove la determinazione contabile a cura delle aziende non arriva. Tale ruolo
degli enti locali presuppone però l’acquisizione e la condivisione dei presupposti concettuali indicati in questo testo. I problemi da affrontare sono quelli tipici della tassazio-
CAPITOLO 10 – “TRIBUTI MINORI”
277
ne attraverso gli uffici, e si ritrovano in parte a proposito dei tributi immobiliari, cui è
dedicato il prossimo paragrafo.
10.9.La tassazione patrimoniale locale sugli immobili (ICI e IMU)
La tassazione locale si riferisce, nella maggior parte dei paesi sviluppati, agli immobili, principale forma di ricchezza al tempo stesso facilmente “visibile” e radicata al
territorio. In Italia questo “ritorno” al tributo locale immobiliare annuale avvenne nel
1993, con l’imposta comunale sugli immobili (ICI), che nel 2012, sull’onda della crisi
finanziaria fu sostituita, con la casualità e le contingenze tipiche della comunicazione
“politico mediatica” dall’IMU, specialmente relativa alla c.d. “prima casa”; la proprietà
immobiliare è infatti sia una manifestazione di ricchezza, sia uno strumento per soddisfare consumi personali degli interessati. Di ciò si sarebbe dovuto tener conto attraverso
una franchigia, uguale per tutti, anziché attraverso una indiscriminata esenzione di tutte
le “prime case”, avvantaggiando chi occupa case di proprietà di rilevante valore. La relativa tassazione è stata ripristinata sotto forma di un diverso tributo denominato “TASI”.
L’IMU è un’imposta patrimoniale comunale ordinaria (annuale) sugli immobili
isolatamente considerati. La sua tollerabilità dipende dal reddito, sia ordinario, sia
figurativo, sia derivante dalla prospettiva di future plusvalenze; se l’immobile si apprezza
del 5 percento l’anno, ad esempio, il proprietario pagherà di buon grado un’imposta
patrimoniale dell’1 percento, meno tollerabile quando invece l’immobile si deprezza.
Le imposte in esame sono commisurate al valore degli immobili determinato con i
moltiplicatori della rendita catastale previsti ai fini delle imposte indirette (registro: paragrafo 10.2), con aliquota stabilita annualmente da ciascun comune, e che può variare
fino a un massimo del 11 per mille circa del suddetto valore, a seconda delle tipologie
e della destinazione.
La procedura applicativa è ispirata al ben noto schema dell’autotassazione salvo
controllo (par. 1.5), ed è proprio qui il problema, di fronte alla ricchezza immobiliare
fortemente frammentata tra persone fisiche, spesso propense all’evasione. L’elevato gettito di quest’imposta smentisce ancora una volta l’infedeltà fiscale degli italiani, considerando anche le scarse possibilità reali di controllo degli uffici comunali.
L’individuazione e determinazione della ricchezza sono affidate alla rilevazione del
patrimonio immobiliare, senza l’aiuto di “strutture amministrative intermedie”: come
sopra rilevato gli enti locali sono soli di fronte a una ricchezza frammentata tra migliaia,
spesso milioni, di piccoli proprietari. Nel controllo, i comuni sono soli di fronte a una
massa enorme di contribuenti, ciascuno dei quali deve corrispondere, di solito, importi
trascurabili.
Per questo i costi di riscossione, anche attribuendo l’attività di recupero ad appositi concessionari, rischiano di essere molto alti rispetto alle somme incassate. Anche il semplice incrocio dei dati catastali con le dichiarazioni e i bollettini di pagamento
può essere defatigante visto il numero dei contribuenti coinvolti. Certo, se l’azione
amministrativa fosse meno rigida, meno incardinata in procedure uniformi, omogenee
278
Parte seconda – Il regime della ricchezza registrata
su tutto il territorio, non sarebbe difficile far bussare i vigili urbani periodicamente, per
raccogliere informazioni sul pagamento del tributo.
I controlli del pagamento dell’ICI (IMU) diventano quindi meramente cartolari, basati su lettere raccomandate, spedite a destinatari magari trasferiti da anni, senza
controllare il territorio, proprio come è già avvenuto per il resto della ricchezza non
determinata attraverso le aziende. Gli effetti sul gettito sono ancora sorprendentemente
contenuti, smentendo i luoghi comuni sullo scarso senso civico di cui al par. 4.5. Le
scarse capacità di controllo dei comuni si indirizzano invece proprio a stabilimenti,
ipermercati, capannoni e uffici, anche qui “in rettifica” del dichiarato (confermando
uno dei fili conduttori del testo, secondo cui omettere del tutto la rilevazione fiscale
della ricchezza non è il problema, ma –purtroppo – per molti è la soluzione.
10.10. Aspetti concettuali di altri “tributi minori”
In un testo riferito ai comportamenti tributari delle istituzioni e degli individui
sono opportune anche considerazioni “di sistema”, ispirate da altri “tributi minori”, cui
sarebbe eccessivo dedicare un paragrafo specifico.
Ritroviamo la dialettica tra “tributi e tariffe” (paragrafo 5.1) a proposito dell’occupazione del suolo pubblico, e della pubblicità effettuata attraverso affissioni, insegne pubblicitarie, cartelloni, striscioni etc,; entrambe queste attività dei privati,
soggette a concessione amministrativa, non danno più luogo a tributi, ma a canoni di
concessione; questi ultimi si collocano, nella sfumatura delle entrate pubbliche descritta
al par. 5.1, più verso il principio del “beneficio” ed un criterio “corrispettivo” vista la
“divisibilità” degli spazi pubblici.
La trasformazione in prezzo è difficile quando non si riesce a misurare l’uso effettivo
del servizio, come quello di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; qui l’unica correlazione tra costo del servizio e ammontare del tributo è globale, nel senso che la somma
introitata non può eccedere il costo complessivo del servizio, come è caratteristico dei
c.d. “tributi di scopo”.
La soluzione più facile, e controllabile oggettivamente, è una proporzionalità diretta
tra dimensioni dell’immobile, persone che può ospitare e quindi quantità di rifiuti prodotta; il numero effettivo di occupanti degli immobili è infatti “meno visibile”, anche
se è considerato dall’anagrafe è infatti l’occupazione, a titolo di proprietà o in base a
contratti di locazione, di immobili situati nel comune, tenendo conto delle dimensioni, della destinazione e, tutt’al più, del numero degli occupanti dell’immobile, quali
risultano dall’anagrafe comunale. La personalizzazione del calcolo da parte dei comuni
continua a rendere necessaria la dichiarazione dei contribuenti e la richiesta d’ufficio,
perché l’obbligo di autoliquidazione sarebbe troppo complesso.
Per trasformare il tributo in esame in tariffa occorrerebbe presidiare i cassonetti, e
chiedere un ticket per ogni sacchetto depositato, punendo al tempo stesso chi abbandona rifiuti per strada. È il solito problema di “controllo del territorio” da parte delle
pubbliche autorità, più facile per i rifiuti di grandi dimensioni, più difficili da abbando-
CAPITOLO 10 – “TRIBUTI MINORI”
279
nare in modo anonimo, e dove quindi il deposito in discarica consente al personale di
sorveglianza di richiedere un tributo proporzionale ai rifiuti depositati.
Il difficile inquadramento concettuale dei tributi secondari si ritrova per la tassa di
possesso sui veicoli, che costituisce l’evoluzione della tassa di circolazione; il tributo
si giustifica con le spese pubbliche di costruzione e manutenzione delle strade, che si
cerca di mettere a carico degli utenti; originariamente il controllo era demandato agli
agenti del traffico, in relazione a chi effettivamente circolava, ma nei primi anni ottanta,
usando i registri di proprietà dei veicoli (notoriamente “beni mobili registrati”) il tributo fu collegato alla mera titolarità del veicolo, e attribuito alle regioni. Il tributo va
ormai pagato in “autotassazione” (paragrafo 1.5), ma le regioni utilizzano il gestore dei
registri automobilistici per la richiesta coattiva in caso di inadempimento. Il tributo è
commisurato alla potenza fiscale del veicolo, non al suo valore, amministrativamente ingestibile. Ne deriva quindi, soprattutto per le vecchie auto, un carico tributario annuale
spesso fortissimo rispetto al valore commerciale del veicolo, e al limite può addirittura
eccederlo per qualche vecchio rottame, senza i requisiti per essere agevolato come “auto
d’epoca”.
I problemi concettuali appena indicati si ripresentano per il “canone RAI”, tributo
anacronistico sotto vari profili; sia in relazione alla sua giustificazione economico sostanziale, superata dall’offerta radiotelevisiva, sia in relazione alla gestibilità amministrativa.
È infatti impossibile ed antieconomico gestire una anagrafe specifica dei proprietari di
apparecchi Radiotelevisivi. L’agenzia delle Entrate di Torino, cui fa capo l’applicazione
del tributo, fa il possibile spedendo lettere “random” sul presupposto dell’esistenza di un
apparecchio televisivo in ogni casa. Il tributo si trascina per forza di inerzia, e il sorprendente gettito, ancorché aiutato dal martellamento televisivo, smentisce ulteriormente
lo stereotipo degli italiani evasori fiscali, confermando invece la disorganizzazione nella
progettazione e gestione delle entrate tributarie.