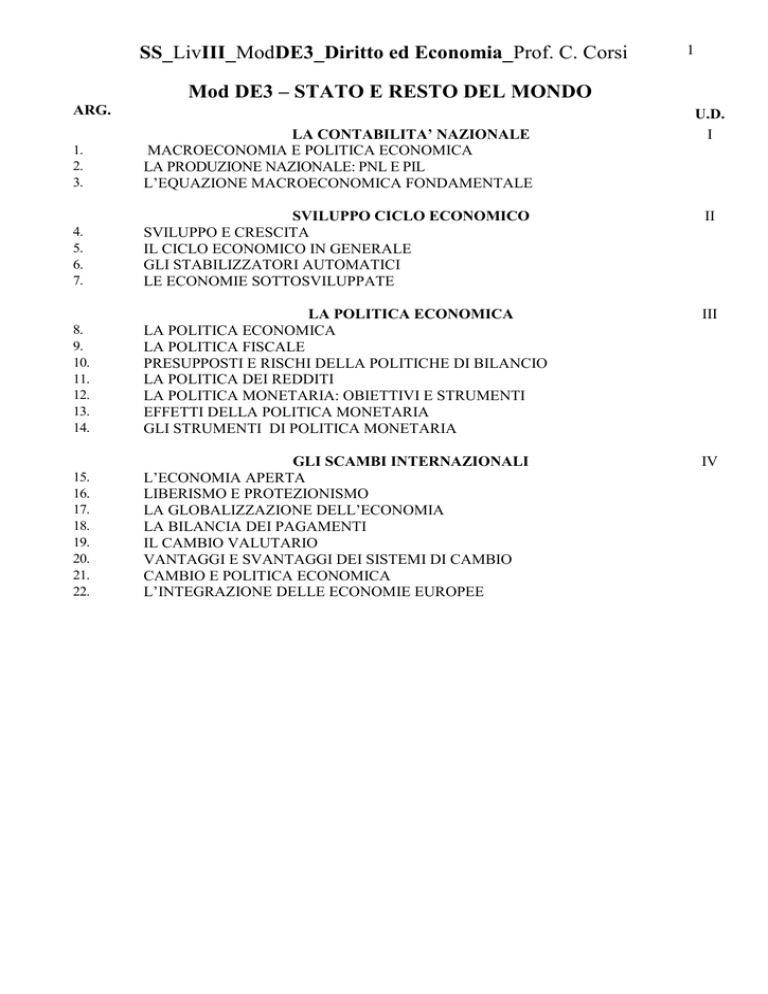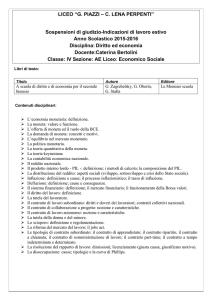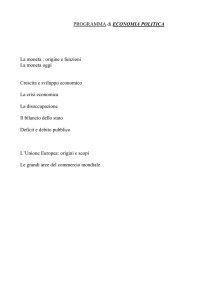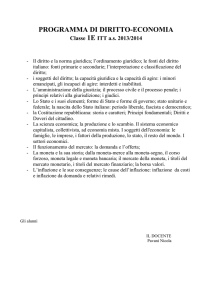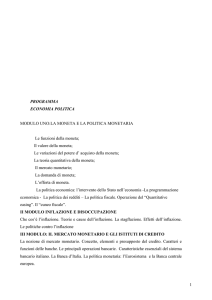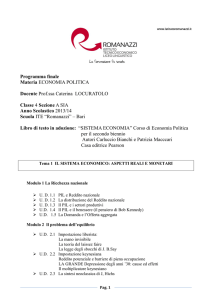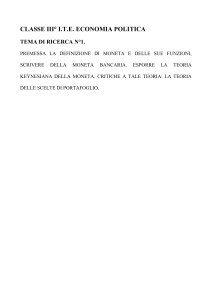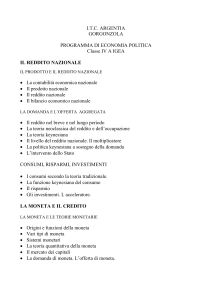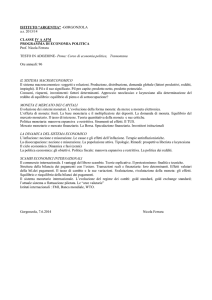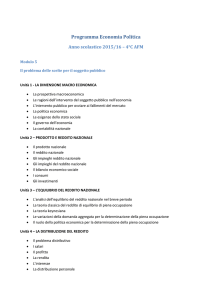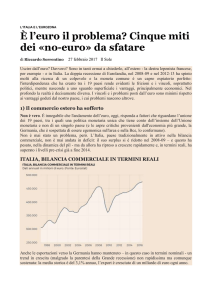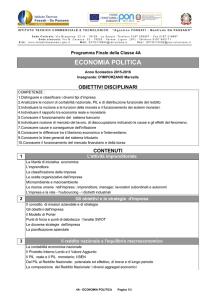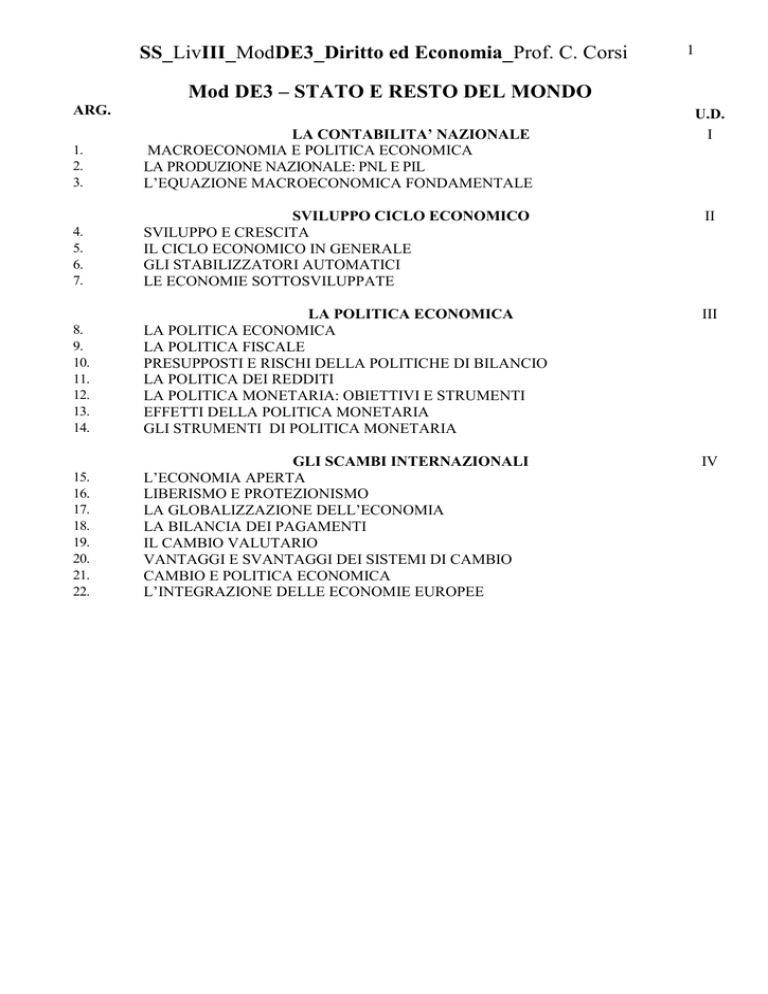
SS_LivIII_ModDE3_Diritto ed Economia_Prof. C. Corsi
1
Mod DE3 – STATO E RESTO DEL MONDO
ARG.
U.D.
I
1.
2.
3.
LA CONTABILITA’ NAZIONALE
MACROECONOMIA E POLITICA ECONOMICA
LA PRODUZIONE NAZIONALE: PNL E PIL
L’EQUAZIONE MACROECONOMICA FONDAMENTALE
SVILUPPO CICLO ECONOMICO
SVILUPPO E CRESCITA
IL CICLO ECONOMICO IN GENERALE
GLI STABILIZZATORI AUTOMATICI
LE ECONOMIE SOTTOSVILUPPATE
II
4.
5.
6.
7.
LA POLITICA ECONOMICA
LA POLITICA ECONOMICA
LA POLITICA FISCALE
PRESUPPOSTI E RISCHI DELLA POLITICHE DI BILANCIO
LA POLITICA DEI REDDITI
LA POLITICA MONETARIA: OBIETTIVI E STRUMENTI
EFFETTI DELLA POLITICA MONETARIA
GLI STRUMENTI DI POLITICA MONETARIA
III
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
GLI SCAMBI INTERNAZIONALI
L’ECONOMIA APERTA
LIBERISMO E PROTEZIONISMO
LA GLOBALIZZAZIONE DELL’ECONOMIA
LA BILANCIA DEI PAGAMENTI
IL CAMBIO VALUTARIO
VANTAGGI E SVANTAGGI DEI SISTEMI DI CAMBIO
CAMBIO E POLITICA ECONOMICA
L’INTEGRAZIONE DELLE ECONOMIE EUROPEE
IV
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
SS_LivIII_ModDE3_Diritto ed Economia_Prof. C. Corsi
UDI
2
LA CONTABILITA’ NAZIONALE
1.
MACROECONOMIA E POLITICA ECONOMICA
Se si pongono sotto analisi le singole unità del sistema (con i loro comportamenti e
le loro relazioni con gli altri soggetti singoli del sistema) l’analisi sarà microeconomica; se
l’oggetto di analisi non è il comportamento della singola unità ma dell’insieme delle unità
del sistema, l’analisi sarà macroeconomica.
La macroeconomia, dunque, studia la situazione economica complessiva del
sistema economico per consentire allo Stato di intervenire con le strategie adeguate per
migliorare il benessere sociale. La misurazione della ricchezza prodotta in un dato periodo
permette di operare confronti e di calcolare rapporti fra i fenomeni economici accaduti
consentendo una valutazione approssimata dei problemi da risolvere da parte della politica
economica, quali, ad esempio: il tasso di disoccupazione, la recessione economica,
l’inflazione ed il livello medio di povertà della popolazione.
2.
LA PRODUZIONE NAZIONALE: PNL E PIL
Il valore complessivo della produzione è chiamato ‘Prodotto Nazionale Lordo’.
Artefici del PNL sono tutti i fattori produttivi italiani (anche se operano all’estero). Tale
valore è costituito dal valore di tutti i beni finali prodotti al netto dei beni intermedi (es. il
valore di un auto contiene già, infatti, il valore delle quattro gomme). Il valore può essere
inteso anche come la somma dei valori aggiunti via via dalle varie imprese nell’intera
produzione (es. valore dell’auto non verniciata + valore della vernice + valore delle
gomme etc = valore complessivo dell’auto).
Se invece si vuole misurare il valore della produzione prodotta all’interno dei
confini italiani occorre sottrarre al PNL il valore della produzione delle imprese italiani
operanti all’estero e aggiungere il valore delle imprese estere operanti in Italia: avremo
allora il PIL (‘Prodotto Interno Lordo’).
Effetti di una variazione del PNL
All’aumentare del PNL aumentano:
- i redditi
- il gettito fiscale (sempre che le aliquote rimangano costanti)
- l’occupazione (ma solo se la produttività rimane costante o aumenta in misura
minore).
- le importazioni, poiché le industrie necessiteranno di maggior materia prima
importata (quindi le importazioni aumentano in misura proporzionale alla dipendenza
dall’estero del sistema relativamente alle materia prime).
Il PNL di piena occupazione
Il PNL di piena occupazione è dato dalla produzione massima che si può ottenere
attraverso la piena occupazione dei fattori produttivi a disposizione.
Per raggiungere la massima produzione potenziale tuttavia non c’è bisogno che tutti
i fattori produttivi siano pienamente occupati: poiché i fattori produttivi cooperano fra loro
nella produzione, è sufficiente infatti che sia interamente utilizzato un solo fattore
produttivo per raggiungere la massima produzione potenziale. In tal caso, gli altri fattori
produttivi considerati non saranno pienamente utilizzati (ovvero potrebbero coesistere
massima produzione possibile e disoccupazione del fattore produttivo lavoro).
Il PNL di piena occupazione è l’obiettivo della politica economica dello Stato,
soprattutto in riferimento al fattore produttivo lavoro.
3.
L’EQUAZIONE MACROECONOMICA FONDAMENTALE
La produzione nazionale dà luogo al reddito nazionale, in quanto il valore della
produzione (Y) viene necessariamente distribuito come compenso dei fattori produttivi che
hanno cooperato per effettuarla (salari, interessi, rendite, tributi e profitti).
SS_LivIII_ModDE3_Diritto ed Economia_Prof. C. Corsi
Il reddito, poi, è necessariamente impiegato in domanda (o spesa) aggregata, le cui
componenti sono: a) spesa per consumi; b) spesa per investimenti. Distinguendo la spesa
privata da quella pubblica si otterrà la funzione: Y(domanda aggregata interna) =
C(consumi privati) + I (Investimenti privati) + G (spesa pubblica divisa in consumi
pubblici e investimenti pubblici). Per tenere conto della domanda estera occorrerà
aggiungere le esportazioni (X) e sottrarre le impostazioni (M).
Equazione macroeconomica fondamentale:
Y (produzione) = Y (reddito = salari+interessi+rendite + tributi + profitti) = Y (domanda o
spesa = C+I+G+X-M)
Consumo, risparmio e investimento
Il risparmio può risolversi in un semplice accantonamento (risparmio non produttivo o
‘tesoreggiamento’), oppure in investimento (risparmio produttivo).
Il consumo è il punto finale dell’attività produttiva e distrugge il valore; il tesoreggiamento
lo lascia inalterato, l’investimento lo accresce.
L’investimento può essere inteso come: a) investimento reale (in capitale fisso, ad es.
macchinari, impianti etc., oppure in scorte); b) investimento finanziario (moneta e titoli di
credito). Categoria a sé stante è l’investimento promosso dallo Stato (investimento pubblico), per dotare o
migliorare le infrastrutture (autostrade, ferrovie, aeroporti, centrali elettriche, reti telematiche etc.). La spesa
per la ricerca scientifica, per l’istruzione, per la sanità, per il riordinamento e l’abbattimento degli sprechi
della PA sono anch’essi investimenti pubblici, ovvero risorse destinate nel medio – lungo periodo a
migliorare strutturalmente il sistema economico.
Effetti di un elevato consumo
Il consumo stimola l’attività produttiva e l’occupazione, ma un livello troppo
elevato di consumo inibisce il risparmio e la carenza di risparmio fa aumentare il saggio di
interesse e diminuire l’investimento, con conseguente diminuzione di attività economica e
di occupazione. Un elevato livello di consumo, inoltre, può generare inflazione e,
conseguentemente, minori esportazioni e squilibrio nella bilancia dei pagamenti.
Effetti di un elevato risparmio
Un elevato risparmio fa diminuire i saggi di interesse e dovrebbe indurre gli
imprenditori all’investimento; ma se all’elevato risparmio fa riscontro una contrazione dei
consumi, gli imprenditori sono indotti a non investire (anche in presenza di saggi di
interesse bassi) poiché temono che la loro produzione futura non sia assorbita dalla
domanda per consumi.
L’obiettivo fondamentale della politica economica è quello di realizzare la
combinazione di consumi e risparmi tale da far coesistere un adeguato livello di consumi
senza che il risparmio non diminuisca a tal punto da far salire i saggi di interesse e gli
investimenti.
Effetto moltiplicatore
Si chiama ‘moltiplicatore’ quel particolare effetto accrescitivo della produzione
determinato da un aumento degli investimenti. L’investimento iniziale, infatti, fa
aumentare l’occupazione, l’aumento di occupazione genera un aumento dei consumi i
quali a loro volta generano aumenti a catena di produzione e di occupazione. Perciò,
Keynes auspicava, in periodi di crisi economica, investimenti pubblici che potessere
produrre l’effetto moltiplicativo.
Esercitazione UD I
1.
2.
3.
4.
Quali nessi sussistono fra ‘macroeconomia’ e ‘ politica economica’?
Distingui il PNL dal PIL
Analizza l’equazione macroeconomica fondamentale
Come opera l’effetto moltiplicatore?
3
SS_LivIII_ModDE3_Diritto ed Economia_Prof. C. Corsi
UDII
SVILUPPO E CICLO ECONOMICO
4.
SVILUPPO E CRESCITA
Per “crescita” si intende quella condizione per cui in un sistema economico i mezzi
per soddisfare i bisogni (le risorse: i beni e i servizi) aumentano in misura maggiore
dei bisogni stessi.
Per “sviluppo” si intende un aumento che sia non solo quantitativo ma anche
qualitativo. Non si bada più soltanto all’aumento nella quantità dei beni prodotti, ma
anche al miglioramento delle condizioni di vita in generale (ad es. riduzione
dell’inquinamento, maggiori opportunità a livello sanitario o culturale etc).
La crescita economica è il presupposto dello sviluppo economico, poiché
aumenta quelle risorse che potranno essere impiegate (ad es. tramite un aumento
della spesa sociale) per migliorare le condizioni di benessere globale dei cittadini.
5.
IL CICLO ECONOMICO IN GENERALE
La crescita economica non si svolge in modo lineare nel tempo, ma è soggetta a periodi di
espansione e a periodi di contrazione. Rappresentata in un grafico, assume l’aspetto di
un’onda: nel punto più basso ha inizio la fase di espansione (ripresa) che prosegue nella
fase più alta di prosperità. Giunta al suo punto più alto ha inizio (con la crisi) la fase
discendente di contrazione, che si manifesta nella prima fase come stagnazione e nella
seconda come recessione e depressione. L’intero sviluppo ha nome di ‘ciclo economico’.
Nel punto più basso della situazione economica (ovvero alla fine della precedente
fase di contrazione), il sistema è al minimo dell’occupazione e della domanda. A questo
punto, basta un lieve miglioramento delle aspettative e una crescita minima degli
investimenti (o anche un aumento delle esportazioni) per innescare il circolo virtuoso,
potenziato dal meccanismo del moltiplicatore, che porta a crescenti livelli di reddito,
occupazione e domanda. La produzione cresce fino ad arrivare al suo punto più alto e così
la domanda. Raggiunta però la piena occupazione si comincia a registrare un disequilibrio:
la domanda aumenta oltre l’offerta e fa salire i prezzi. La piena occupazione della forza
lavoro (aumento di domanda di lavoro da parte delle imprese) spinge i sindacati a chiedere
ed ottenere maggiori aumenti salariali; questo contribuisce a generare inflazione. Per
frenare l’inflazione, il sistema è costretto a ridurre il livello di moneta e ad aumentare i
saggi di interesse. Ciò rende per le imprese più oneroso l’investimento. Da qui vi è la
necessità di ridurre la produzione, e conseguentemente l’occupazione, il reddito e la
domanda. Il meccanismo del moltiplicatore agisce ora in senso inverso e trascina il sistema
alla stagnazione (situazione nella quale il PNL cresce in misura ridotta), alla recessione o
anche alla depressione(situazione nelle quali il PNL addirittura diminuisce rispetto al
periodo precedente).
Effetto generale delle fasi di contrazione è la diminuzione dell’occupazione.
Sintesi schematica
Fase di partenza: recessione
Bassa produzione/occupazione/domanda → crescita minima degli investimenti → crescita
delle aspettative imprenditoriali
Fase di ripresa economica
Crescita consistente investimenti → effetto moltiplicatore→ crescita
produzione/occupazione/reddito dei lavoratori/domanda di prodotti
Fase di crisi
Sistema alla massima offerta (produzione) → la domanda supera l’offerta → crescono i
prezzi e l’inflazione → riduzione dell’offerta di moneta (per ridurre l’inflazione) →
aumento del tasso di interesse → riduzione degli
investimenti/occupazione/reddito/domanda di beni → il moltiplicatore agisce in senso
negativo e trascina alla recessione (fase di ‘arrivo’ e fine ciclo)
4
SS_LivIII_ModDE3_Diritto ed Economia_Prof. C. Corsi
6.
GLI STABILIZZATORI AUTOMATICI
Lo stato dispone di strumenti che possono attenuare i movimenti espansivi e contrattivi:
nelle fasi di espansione si può manovrare lo strumento fiscale; nelle fasi di contrazione si
può sostenere la domanda aumentando i sussidi di disoccupazione.
Una tassazione progressiva può in genere agire come strumento stabilizzatore: nei
periodi di contrazione del reddito la tassazione automaticamente scende; e sale nei periodi
di espansione in proporzione al reddito.
7.
LE ECONOMIE SOTTOSVILUPPATE
Un’economia si dice ‘sottosviluppata’ quando accanto al basso reddito pro-capite si
hanno valori negativi anche per gli altri indicatori dello sviluppo economico: ridotta durata
media della vita, bassi livelli di assistenza, sanità e istruzione, poche o inesistenti
infrastrutture in relazione alle esigenze della popolazione etc.
La condizione dei paesi sottosviluppati deriva la fenomeno economico denominato
“circolo vizioso della povertà”. Tale fenomeno è originato da due presupposti: a) il capitale
è in funzione del risparmio, che è correlato al livello del reddito; b) il livello del reddito
varia al variare del capitale. In altre parole: chi ha basso reddito lo consuma
completamente e non risparmia; chi non risparmia non può investire e dunque non
aumenterà il suo reddito. Nei paesi sottosviluppati il reddito prodotto viene tutto consumato
e il livello del capitale aumenta meno di quanto aumentano i bisogni di una popolazione in
continua crescita. La domanda bassa (dato il basso reddito) non incoraggia investimenti e
non permette accumulazione di capitale; la bassa offerta originata dalla mancanza di
capitale non è capace di creare i presupposti (ad es. tecnologici) perché si possa aumentare
la produttività (e quindi comprimere i costi, elevare i salari, i redditi, la domanda, la
produzione etc.)
Al basso livello del reddito e alla conseguente scarsità di domanda non si può
sopperire con una creazione di moneta tale da abbassare il saggio di interesse e incentivare
gli imprenditori a investire: poiché anche a tassi di interesse bassi gli imprenditori non
hanno incentivo a investire, data la scarsità della domanda di una popolazione troppo
povera. Quindi un aumento dell’offerta di moneta (anche se fosse donata da un paese ricco)
altro non farebbe che generare inflazione.
Esercitazione UD II
1.
2.
3.
4.
UDIII
8.
Distingui fra ‘sviluppo’ e ‘crescita’
Analizza il ciclo economico partendo da una fase di bassa occupazione
Che cosa si intende per ‘stabilizzatore automatico’
Come opera il ‘circolo vizioso della povertà’
LA POLITICA ECONOMICA
LA POLITICA ECONOMICA
Per ‘politica economica’ si intende, in senso lato, l’intervento dello Stato in economia allo
scopo di correggere gli squilibri e determinare una equilibrata crescita.
Le più importanti variabili che lo Stato deve tenere sotto controllo sono:
a) livello di occupazione (soprattutto del fattore produttivo lavoro)
b) controllo sull’aumento dei prezzi (mantenimento della bassa inflazione)
Altri obiettivi:
c) equa distribuzione del reddito fra le classi sociali
d) equilibrio nei conti con l’estero
e) contenimento del debito pubblico.
Le strategia della politica economica sono:
la politica fiscale (o ‘politica di bilancio’): variazione del prelievo fiscale e della
spesa pubblica
5
SS_LivIII_ModDE3_Diritto ed Economia_Prof. C. Corsi
9.
la politica monetaria: variazione della quantità di moneta in circolazione (per
controllare il prezzo della moneta, ovvero il saggio di interesse)
la politica dei redditi: intervento impositivo sul contenimento dei prezzi (per
controllare il prezzo delle merci) oppure opera di mediazione fra le organizzazioni
dei lavoratori e datori di lavoro in sede di definizione dei contratti collettivi (per
controllare il prezzo del lavoro) i salari)
LA POLITICA FISCALE
La politica fiscale ( o di bilancio) mira a influenzare il livello della domanda globale e,
quindi, del reddito e dell’occupazione, attraverso la variazione della spesa pubblica (uscite)
e del prelievo fiscale (entrate).
La spesa pubblica può essere distinto in spesa per investimenti (acquisto di fattori
produttivi) e spesa per trasferimenti (o ‘spesa sociale’: sussidi, pensioni etc.)
Il prelievo fiscale è costituito dalle imposte dirette (che colpiscono il reddito o il
patrimonio dei soggetti) e dalle imposte indirette (che colpiscono i consumi, gli scambi e i
trasferimenti dei beni); e dalle tasse, ovvero dal corrispettivo che un soggetto deve dare a
un ente pubblico che gli fornisce un bene o un servizio.
Politica fiscale espansiva e restrittiva
Una politica di espansione può essere attuata con un aumento della spesa pubblica e/o
diminuendo il prelievo fiscale: ciò produce un aumento del reddito disponibile e dunque
della domanda. All’opposto, con il taglio della spesa pubblica e/o l’inasprimento dei tributi.
Nei periodi di crisi economica, caratterizzata da bassa occupazione dei fattori
produttivi (soprattutto da alta disoccupazione del fattore lavoro), lo Stato:
a) aumenta la spesa pubblica (appaltando ad es. grandi opere pubbliche ed erogando
benefici sociali alle famiglie) al fine di accrescere il reddito disponibile di quelle
famiglie (a reddito medio basso) che hanno maggior propensione al consumo
b) per lo stesso motivo, riduce il prelievo fiscale alle famiglie
c) riduce il prelievo fiscale per le imprese, al fine di rendere più convenienti gli
investimenti
Lo Stato dovrà finanziare l’aumento di spesa pubblica emettendo titoli di debito pubblico
(il cosiddetto ’deficit spending’).
Il conseguente aumento del debito pubblico in questo periodo di crisi non deve
preoccupare in quanto una volta raggiunto l’obiettivo della ripresa il maggior reddito
disponibile delle famiglie permetterà allo Stato stesso di ottenere un più alto prelievo
fiscale con il quale ripianare il disavanzo. Raggiunta la piena occupazione, lo Stato avrà
cura di attuare un’opposta politica restrittiva (ora sopportabile, data la situazione di
ricchezza del sistema) tale da contenere le tendenze inflative che nella fase di ripresa hanno
caratterizzato la crescita della domanda, e da riequilibrare il bilancio pubblico
disequilibrato dal precedente ‘deficit spending’.
10.
PRESUPPOSTI E RISCHI DELLE POLITICHE DI BILANCIO
La politica di bilancio espansiva ‘funziona’ solo:
a) se il sistema è in bassa occupazione: in questo caso soltanto l’aumento della
domanda può essere via via compensato da un corrispondente aumento dell’offerta
e non generare inflazione.
b) poiché l’economia in crescita porta con sé inevitabilmente un aumento delle
importazioni, è necessario che all’inizio del periodo non vi siano preesistenti
squilibri nella bilancia dei pagamenti con l’estero.
Gli effetti negativi della politica espansiva principalmente sono:
a) il surriscaldamento dell’inflazione (soprattutto nel caso lo Stato si trovi in necessità
di finanziare la spesa pubblica con l’emissione di moneta)
b) aumento dei tassi di interesse, in quanto se lo Stato decide di finanziare la spesa
pubblica con i titoli di Stato, è costretto, per attirare i risparmiatori, a offrire
6
SS_LivIII_ModDE3_Diritto ed Economia_Prof. C. Corsi
7
convenienti saggi di interesse. Ciò potrebbe determinare uno ‘spiazzamento’ delle
condizioni di investimento dell’economia privata con aumento dei tassi di interesse
e azzeramento degli effetti benefici indotti dallo Stato.
c) l’aumento del debito pubblico (nel caso non si provveda, nei periodi di benessere a
riordinare i conti pubblici) potrebbe trasferirsi nel tempo alle generazioni future
Una politica di bilancio restrittiva mira alla riduzione della domanda globale che si
può ottenere diminuendo la spesa pubblica e aumentando la pressione fiscale sia sulle
imprese (per disincentivare gli investimenti), sia per le famiglie (per disincentivare i
consumi - tenendo conto che per raggiungere tale obiettivo è efficace soprattutto inasprire i
tributi delle famiglie a reddito basso, che hanno una più elevata propensione al consumo).
Alla politica restrittiva il sistema economico è indotto:
a) per contrastare l’inflazione generata dall’aumento di domanda (non compensata
adeguatamente da un aumento dell’offerta)
b) per riequilibrare i conti con l’estero nel momento in cui l’espansione ha trascinato
l’aumento delle importazioni
Il rischio fondamentale di una politica restrittiva è il calo della produzione e
dell’occupazione.
11.
LA POLITICA DEI REDDITI
Per ‘politica dei redditi’ si intende la mediazione compiuta dallo Stato nella contrattazione
fra sindacati dei lavoratori e imprese volta a contenere da un lato gli aumenti salariali, che
costituiscono aumenti del costo per le imprese e le inducono ad alzare i prezzi; e dall’altro
gli aumenti dei prezzi, che diminuendo il reddito reale dei lavoratori inducono i sindacati a
richiedere aumenti salariali.
La politica dei redditi è usata soprattutto a fini di contenimento dell’inflazione
12.
LA POLITICA MONETARIA: OBIETTIVI E STRUMENTI
La politica monetaria si riferisce alle scelte con le quali lo Stato riesce a controllare
l’offerta di moneta, e per conseguenza il saggio di interesse.
Gli obiettivi principali sono uguali a quella della politica fiscale: promuovere la
crescita economica, controllare l’inflazione, equilibrare i conti con l’estero.
Gli strumenti principali sono:
a) la manovra sul ‘tasso ufficiale di sconto’ (TUS)
b) la manovra della riserva obbligatoria
c) le operazioni di ‘mercato aperto’
13.
EFFETTI DELLA POLITICA MONETARIA
Una politica espansiva mira a aumentare l’offerta di moneta e conseguentemente a ridurre il
tasso di interesse. Effetti di una politica che riduce il tasso di interesse sono:
a) l’incentivazione agli investimenti delle imprese
b) l’incentivazione ai consumi a credito delle famiglie
c) la riduzione del debito pubblico (con conseguente possibile riduzione del prelievo
fiscale), dal momento che lo Stato deve pagare interessi minori per i suoi prestiti
d) l’incentivazione ai risparmiatori nell’acquisto di azioni anziché obbligazioni e titoli
di Stato (favorendo in questo modo il finanziamento ‘interno’ (o ‘a costo zero’)
delle imprese.
Una politica monetaria espansiva produce dunque un aumento della domanda globale, del
reddito e dell’occupazione.
I rischi di tale politica sono quelli di:
a) generare inflazione
b) squilibrare i conti con l’estero (dato l’aumento delle importazioni che ne consegue)
c) fuga dei capitali all’estero (a causa del ridotto tasso di interesse interno).
Una politica monetaria restrittiva, naturalmente, causerà effetti di segno opposto (riduzione
SS_LivIII_ModDE3_Diritto ed Economia_Prof. C. Corsi
8
della produzione, del reddito, dell’occupazione etc.; riduzione dell’inflazione; riequilibrio
delle importazioni; possibilità di attirare capitali finanziari dall’estero etc.)
14.
GLI STRUMENTI DI POLITICA MONETARIA
a) Il tasso ufficiale di sconto
Il tasso ufficiale di sconto (TUS) è il prezzo che le banche ordinarie devono pagare alla
banca centrale ogni volta che richiedono di liquidare cambiali non scadute (mentre il tasso
libero di sconto è il prezzo pagato dagli imprenditori quando intendono liquidare presso le
banche ordinarie cambiali non scadute che hanno in cassa. La banca centrale fissa (aumento
o diminuisce) la percentuale di sconto da praticare alle banche ordinarie (e di conseguenza
queste fissano il tasso libero di sconto).
Variazioni del TUS ed effetti sull’economia
Ovviamente, più è alto il tasso ufficiale di sconto e meno le banche tenderanno a
scontare cambiali presso la Banca Centrale; le banche, del resto, nel fissare il tasso libero di
sconto si baseranno sul tasso ufficiale di sconto, inducendo la clientela a scontare a loro
volta meno cambiali. In sintesi se la Banca Centrale (ovvero l’Autorità Monetaria dello
Stato) intende scoraggiare il credito (manovra restrittiva o antinflazionistica), aumenterà il
tasso ufficiale; viceversa, (manovra espansiva o antideflazionistica) lo diminuirà.
b) Il coefficiente di riserva bancaria obbligatoria
Ogni volta che le banche ricevono una somma di denaro, sono obbligate a
trattenerne in forma liquida un certa percentuale (ad es. il 20%) per far fronte alle richieste
di liquidità quotidiane della clientela. In questo caso, quel 20% è il coefficiente di riserva:
le banche potranno investire il resto, dando luogo a un fenomeno di aumento del credito e
della base monetaria del sistema economico denominato “moltiplicatore dei depositi
bancari”.
Esempio: 1) supponiamo che il coefficiente di riserva sia del 20%; 2) la banca A riceve un deposito di 1000:
ne trattiene 200 e investe i rimanenti 800 alla banca B; 3) la banca B a sua volta tratterrà il 20% (= 160) e
investirà il rimanente (640) presso la banca C; la banca C a sua volta trattiene il 20% (= 128) e ne investirà il
rimanente (= 512) etc. Occorre notare che il deposito iniziale di 1000 ha dato luogo ad un aumento di base
monetaria di 800+640+512 = 1952.
Variazioni del coefficiente di riserva ed effetti sull’economia
Più è alto il coefficiente di riserva e meno il deposito avrà il suo potere
moltiplicativo; dunque: se l’Autorità Monetaria intende accrescere la base monetaria
(manovra espansiva) diminuirà il coefficiente; nel caso contrario, (manovra restrittiva)
dovrà aumentarlo.
c) La compravendita di titoli (operazioni di ‘mercato aperto’)
L’autorità monetaria può decidere di aumentare la liquidità del sistema
semplicemente comprando titoli di credito e dando in cambio moneta liquida (manovra
espansiva); in caso contrario, offrirà titoli di credito e domanderà moneta liquida facendola
in questo modo uscire dal mercato e diminuendo così la base monetaria
Esercitazione UD III
1.
2.
3.
4.
UDIV
15.
Come opera la politica dei redditi?
Come opera la politica fiscale?
Che cosa si intende per ‘tasso ufficiale di sconto’?
Qulai effetti produce una politica monetaria restrittiva?
GLI SCAMBI INTERNAZIONALI
L’ECONOMIA
24.
APERTA
Ogni sistema economico non è chiuso, ma costantemente in rapporto con altri sistemi con i
quali scambia risorse (economia aperta). Il ‘commercio internazionale’ è il complesso degli
scambi di beni e servizi con l’operatore ‘resto del mondo’ (ovvero con uno o più sistemi
economici diversi da quello di riferimento).
SS_LivIII_ModDE3_Diritto ed Economia_Prof. C. Corsi
Importazioni ed esportazioni
I movimenti in uscita dei valori (beni, servizi, moneta) sono chiamate ‘esportazioni’; i
movimenti in entrata sono chiamate ‘importazioni’.
Importazioni
Un sistema importa risorse per vari motivi:
a) perché tali risorse non sono producibili all’interno (perché ad es. manca la materia
prima, o la tecnologia necessaria)
b) perché è mano costoso importare la risorsa piuttosto che produrla all’interno del
sistema.
Tranne qualche eccezione, il movimento di beni o servizi in un senso dà luogo a un
movimento di moneta nell’altro senso. Il sistema che deve importare dovrà dunque
possedere moneta (valuta) del sistema esportatore con la quale pagherà la merce importata,
altrimenti sarà costretto a indebitarsi. Naturalmente il modo meno pericoloso per il sistema
importatore di una certa risorsa è pagare quella risorsa con la valuta che gli deriva
dall’esportazione: in questo caso le casse di moneta estera non si esauriranno.
Le importazioni aumentano nei momenti espansivi del ciclo economico.
Esportazioni
Le esportazioni derivano dalla domanda estera; dunque, quanto più il sistema riesce
ad essere competitivo praticando prezzi bassi quanto più riuscirà ad esportare. Certi beni ad
alto contenuto tecnologico invece non dipendono dai prezzi, ma dalla scarsità. Perciò la
produzione di beni ad alto contenuto di capitale (beni ‘tecnologici’), in virtù del loro
mercato tendente al monopolio, sono beni sicuramente esportabili.
I vantaggi delle esportazioni sono:
a) l’acquisizione di valuta estera (con la quale, eventualmente, compensare le perdite
di valuta causate dalle importazioni)
b) aumento della produzione e dell’occupazione
c) assorbimento di eventuali sovrapproduzioni (scorte di merci) dissuadendo le
imprese dal frenare la produzione
Gli svantaggi possono derivare da una tendenza (nel caso, le esportazioni
sopravanzino di molto le importazioni) a generare inflazione (dal momento che le
esportazioni implicano entrate di moneta con la quale gli altri sistemi pagano le merci).
16.
LIBERISMO E PROTEZIONISMO
Il liberismo
La ‘teoria dei costi comparati’ dell’economista classico Ricardo mostra che per un
sistema è sempre conveniente specializzarsi nella produzione della risorsa che gli costa di
meno e importare da altri sistemi la risorsa più onerosa. Inoltre, il liberismo, allargando la
competizione oltre i confini del sistema, spinge le imprese interne a migliorare sempre più
la produzione (per vincere la concorrenza delle imprese estere). Allargandosi le possibilità
di domanda, le imprese possono aumentare investimenti e produzione, beneficiando in
questo modo delle economie di scala.
Il protezionismo
Il protezionismo è l’orientamento di pensiero opposto al liberismo che afferma la
necessità di difendere la produzione nazionale limitando le importazioni con dazi doganali
o contingentamenti (limiti alle quantità importabili).
Il protezionismo esamina il caso (non preso in esame dalla teoria dei costi
comparati, e tuttavia molto frequente) che i sistemi si trovino in fasi di sviluppo differenti:
in questo caso, una politica protezionista è necessaria per sostenere il Paese in via di
sviluppo, le cui imprese (data una ancora imperfetta organizzazione del lavoro e
l’impossibilità, date le dimensioni ridotte, di usufruire delle economie di scala) sono
costrette a praticare prezzi più alti, aumentando con dazi il prezzo dei beni importati in
modo tale da favorire la domanda interna. Inoltre, un sistema costretto a importare certi
beni essenziali da un altro sistema può correre il rischio di subire il potere politico di tale
sistema (un Paese indebitato è ricattabile). Al contrario, il protezionismo può avere effetti
9
SS_LivIII_ModDE3_Diritto ed Economia_Prof. C. Corsi
10
negativi se usato contro i Paesi in via di sviluppo. Infatti, se applicato dai Paesi
economicamente sviluppati nei confronti delle importazioni dai Paesi poveri, può impedire
per questi ultimi l’aumento della domanda necessaria per avviare lo sviluppo.
17.
LA GLOBALIZZAZIONE DELL’ECONOMIA
Per ‘globalizzazione’ dell’economia si intende quel fenomeno che tende alla formazione di un un
mercato mondiale: una liberalizzazione estesa all’intero pianeta.
Tale fenomeno è frutto della riduzione dei costi e dei tempi del trasporto (che rende
‘vicini’ sistemi anche lontanissimi geograficamente) e della rivoluzione informatica che
permette il trasferimento in tempo reali del capitale finanziario, e l’automatizzazione di
gran parte della produzione.
La globalizzazione permette dunque più facilmente il trasferimento delle imprese al
di là dei sistemi nazionali verso Paesi dove meno costosi sono i fattori produttivi e più
basso è il prelievo fiscale (un’unica impresa, chiamata perciò ‘multinazionale’, può
addirittura decentralizzarsi in più Paesi). La liberalizzazione dei confini crea le condizioni
per una concorrenza ‘totale’ (questo soprattutto per i beni a basso contenuto tecnologico,
poiché i beni ad alto contenuto tecnologico spesso mantengono la loro quota di monopolio
in virtù dei brevetti).
Tale concorrenza allargata impedisce ai sistemi economici di aumentare i prezzi:
dunque li induce a tenere sotto controllo l’inflazione da una parte, e, dall’altra, a controllare
i costi di produzione (ciò comporta: controllare il costo del lavoro, moderare il prelievo
fiscale e adottare investimenti strutturali per migliorare la tecnologia).
Per un sistema economici sarà certo più difficile adottare manovre politiche
espansive, le quali, generando un basso di interesse, possono penalizzare l’investimento
finanziario interno (con promozione della cosiddetta ‘fuga dei capitali’ all’estero).
Rispetto al rapporto fra Paesi ricchi e Paesi poveri, la globalizzazione porta con sé
paradossi e problemi delicati. Normalmente il basso costo dei prodotti di un Paese povero
(ciò che consente lo sbocco internazionale alla sua produzione) è generato dal basso costo
del lavoro, che è un genere ‘sfruttamento’ del lavoro. In questo modo, il Paese ricco,
comprando tali prodotti, da un lato ‘aiuta’ (anche se non certo in modo disinteressato) il
Paese povero; ma nello stesso tempo perpetua lo ‘sfruttamento’ e le condizioni che lo
rendono tale. Del resto, rifiutando di comprare (per opporsi a tale sfruttamento) il Paese
ricco penalizza l’economia del Paese povero. (Una soluzione a questo paradosso potrebbe
essere la cosiddetta ‘clausola sociale’, per la quale si sostiene la lotta allo sfruttamento
impegnandosi nel contempo a comprare a prezzi maggiorati: es. il cosiddetto ‘commercio
equo e solidale’).
18.
LA BILANCIA DEI PAGAMENTI
La bilancia dei pagamenti è il documento contabile che registra le transazioni economiche
intercorse in un determinato periodo di tempo tra il Paese e il resto del mondo.
Strutturata come una partita doppia (dare/avere), la bilancia dei pagamenti può
essere distinta in tre sezioni: a) partite correnti; b) movimenti di capitale; c) movimenti
monetari (o ‘saldo’)
Le ‘partite correnti’ comprendono:
a) la bilancia commerciale: ovvero le esportazioni/importazioni di merci (dette
‘partite visibili’). E’ la voce più indicativa della bilancia di pagamenti, e
talvolta viene usata (impropriamente) come sinonimo dell’intera sezione
‘partite correnti’.
b) le ‘partite invisibili’: ovvero le esportazioni/importazioni di servizi (bancari,
assicurativi, di trasporto, turistici etc.)
c) i ‘trasferimenti unilaterali’: riguardano le donazioni (fatte e ricevute), quali
ad es. gli aiuti ai Paesi poveri.
I ‘movimenti di capitali’ riguardano il movimento in entrata o in uscita di capitali monetari
volti all’acquisizione di risorse reali (di imprese, terreni, abitazioni etc.), o all’acquisizione
SS_LivIII_ModDE3_Diritto ed Economia_Prof. C. Corsi
11
di risorse monetarie (obbligazioni, azioni, moneta). Nel primo caso si parla di investimenti
diretti; nel secondo, di investimenti finanziari (o indiretti).
Gli investimenti diretti trovano ragione in un miglior tasso di profitto (ovvero nelle
‘aspettative di profitto’) nel Paese di destinazione, mentre gli investimenti finanziari sono
influenzati da un miglior tasso di interesse. In ogni caso, questa sezione dipende
interamente dal tasso di cambio della moneta nazionale rispetto alla moneta estera.
I ‘movimenti monetari’ costituiscono il saldo delle due sezioni precedenti: se il saldo è
positivo, la bilancia dei pagamenti è in avanzo (ci sono più esportazioni che importazioni).
E viceversa.
Un persistente disavanzo – o ‘deficit’ estero – frena lo sviluppo del sistema, poiché
lo sviluppo comporta l’aumento delle importazioni e la necessità di contenerle (dal
momento che un’economia poco sviluppata ha difficoltà ad compensare le maggiori
importazioni con un aumento delle esportazioni) con politiche restrittive. Per questa
ragione le economie dei Paesi poveri rimangono impigliate nel ‘circolo vizioso della
povertà’ e non riescono a ‘decollare’ (un rimedio potrebbe venire dai Paesi ricchi attraverso
trasferimenti unilaterali, condono di debiti o, quantomeno, prestiti a tasso di interesse molto
basso).
19.
IL CAMBIO VALUTARIO
Il cambio di una moneta di un certo sistema è il suo prezzo espresso in moneta di un altro
sistema. Essendo un ‘prezzo’, il cambio segue la legge della domanda e dell’offerta, per cui
cresce all’aumentare della domanda e diminuisce (si svaluta) al diminuire dell’offerta.
Se vi è avanzo il cambio si apprezza (o si rivaluta); se vi è deficit, si deprezza (o si
svaluta).
Si parla di ‘apprezzamento’ o di ‘deprezzamento’, quando la variazione di valore è
originata dal mercato; si parla di ‘rivalutazione’ o di ‘svalutazione’ quando la variazione è
imposta dalle autorità monetarie.
Regimi di cambio
I regimi di cambio adottabili sono sostanzialmente due:
a) cambio fisso
b) cambio flessibile
Il regime a cambio fisso prevede che le autorità monetarie dei Paesi decidano
imperativamente il cambio ad un certo valore e si impegnino a scambiare le loro valute a
quel valore (in questo modo, la stabilità è, per così dire, ‘imposta’). Nel caso in cui sul
mercato il cambio sia diverso, essi si impegneranno, comprando o vendendo valuta, a
riportare il valore di cambio di mercato al valore di cambio fisso. Nel caso un Paese non
riesca più a sostenere il cambio fisso a un certo valore (ad es. perché non ha più riserve
valutarie estere da offrire) procederà alla svalutazione della moneta (ovvero stabilirà un
valore di cambio fisso più basso).
Nel regime a cambio flessibile il valore della valuta è determinato semplicemente
dal mercato (ovvero dalla domanda e offerta di moneta necessaria per le importazioni ed
esportazioni di beni) e varia continuamente in ragione dei mutamenti di mercato. Quindi se
vi è domanda della valuta estera (poiché si devono pagare le merci importate, oppure
perché si decide di investire attirati dagli alti tassi di interesse) il suo prezzo aumenta (la
moneta si apprezza); viceversa, diminuisce (la moneta si deprezza). Le autorità monetarie si
astengono dall’intervenire per guidare il cambio, ma lasciano fare al mercato.
Esiste una via di mezzo fra il regime di cambio fisso e il regime di cambio flessibile: il regime di
cambio controllato: in questo caso, le autorità monetarie dei vari sistemi non intervengono solo se il cambio si
mantiene all’interno di certi valori. Se si superano questi valori, le autorità intervengono vendendo o
comprando valuta in modo da riportare i valori entro la fascia di cambio stabilità.
20.
VANTAGGI E SVANTAGGI DEI SISTEMI DI CAMBIO
I sistemi a cambio fisso, bloccando il valore della moneta nel tempo, hanno il vantaggio di
rendere più prevedibile l’economia (e di conseguenza, diminuendo il rischio, di
SS_LivIII_ModDE3_Diritto ed Economia_Prof. C. Corsi
12
incoraggiare gli investimenti, e scoraggiare le speculazioni). Lo svantaggio è quello di
mettere a dura prova, nel caso di crisi, il sistema, in quanto la necessità di intervenire sul
mercato con la vendita di riserve valutarie può favorire l’inflazione.
Al contrario, i sistemi a cambio flessibile non mettono sotto pressione le banche centrali,
ma rendono incerte nel tempo le decisioni di investimento degli imprenditori.
Se il valore reale della moneta nazionale diminuisce sensibilmente, il Paese è costretto alla
svalutazione della propria moneta. Al contrario, si procede a una rivalutazione.
Effetti della svalutazione
Rendendo più convenienti i prezzi per gli operatori esteri, la svalutazione tende ad
aumentare le esportazioni; ma anche fa aumentare i costi di produzione (in misura
dell’aumento delle materie prime importate) e, conseguentemente, tende a far crescere i
prezzi interni. Dunque riduce il benefico effetto sulla domanda indotto dalle esportazioni e
nel lungo periodo causa l’effetto opposto: deprime la domanda, la produzione e
l’occupazione. Inoltre, la svalutazione scoraggia al risparmio e induce l’autorità monetaria
a elevare i tassi di interesse (al fine di incentivare l’offerta di risparmio)
Effetti della rivalutazione
La rivalutazione deprime le esportazioni, e dunque, nel breve periodo, può compromettere
domanda, produzione e occupazione; ma nel lungo periodo consente di contenere
l’inflazione e mantenere bassi i saggi di interesse.
21.
CAMBIO E POLITICA ECONOMICA
Se i Governi intendono promuovere l’occupazione devono intraprendere politiche di
bilancio e monetarie espansive finalizzate al deprezzamento/svalutazione, in modo da
stimolare le esportazioni, e quindi la domanda globale. L’obiettivo è raggiungibile tuttavia
solo nel breve periodo, poiché nel medio lungo periodo si generano tendenze opposte.
Se l’obiettivo di breve periodo è, invece, il contenimento dell’inflazione, le politiche
economiche devono essere restrittive in modo da indurre all’avanzo nella bilancia dei
pagamenti e alla conseguente rivalutazione/apprezzamento del cambio.
22.
L’INTEGRAZIONE DELLE ECONOMIE EUROPEE
Nel mercato interno, i fattori produttivi (capitale, lavoro, materie prime) si trasferiscono
con grande facilità: i lavoratori si rivolgono a quei settori dove più è alta la remunerazione,
e così i capitali sono investiti in quei settori dove si prevede il profitto più elevato. Tale
facilità viene meno in campo internazionale, poiché la diversità delle norme e dei sistemi si
pone come un ostacolo alla mobilità. La Comunità economica europea si è posta da tempo
l’obiettivo di un processo di integrazione di più economie che tende a eliminare tali ostacoli
facendo sì che molti sistemi diventino uno solo. Il processo che nasce nel 1951 ha ricevuto
un grande impulso nel 1993, nel Trattato di Maastricht, e nel 2002, quando si è realizzata
compiutamente l’unione monetaria.
L’integrazione economica (ovvero di “mercato unico”) prevede:
la libertà di circolazione delle merci (ovvero la possibilità delle imprese di un Paese
di vendere o comprare in ciascun altri Paese aderente in condizioni di parità rispetto
alle imprese nazionali, senza variazioni di prezzo dovute a dazi)
la libertà di circolazione delle persone, dei servizi, del lavoro: i cittadini di ciascun
Paese possono essere impiegati in altri Paesi aderenti in condizioni di parità con i
cittadini di questi altri Paesi
la libertà di circolazione dei capitali: per cui ad es. un’impresa italiana può
richiedere prestiti a parità di condizioni ad una banca francese
Gli effetti previsti dell’integrazione
la concorrenza fra le imprese si intensificherà e porterà ad una riduzione generale
dei prezzi
l’espansione dei mercati porta le imprese ad una specializzazione della produzione
la compressione dei costi porta ad una maggiore competitività delle imprese
SS_LivIII_ModDE3_Diritto ed Economia_Prof. C. Corsi
comunitarie rispetto alle altre economie internazionali (soprattutto USA e
Giappone)
restrizioni all’intervento sociale interno dei Paesi aderenti, e per certi aspetti, anche
rinunce a usi e consuetudini nazionali
Esercitazione UD IV
1.
2.
3.
4.
13
Quali sono i vantaggi del libero scambio internazionale?
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un alto livello di esportazioni?
Distingui i regimi di cambio
Quali sono gli effetti di una svalutazione della moneta?