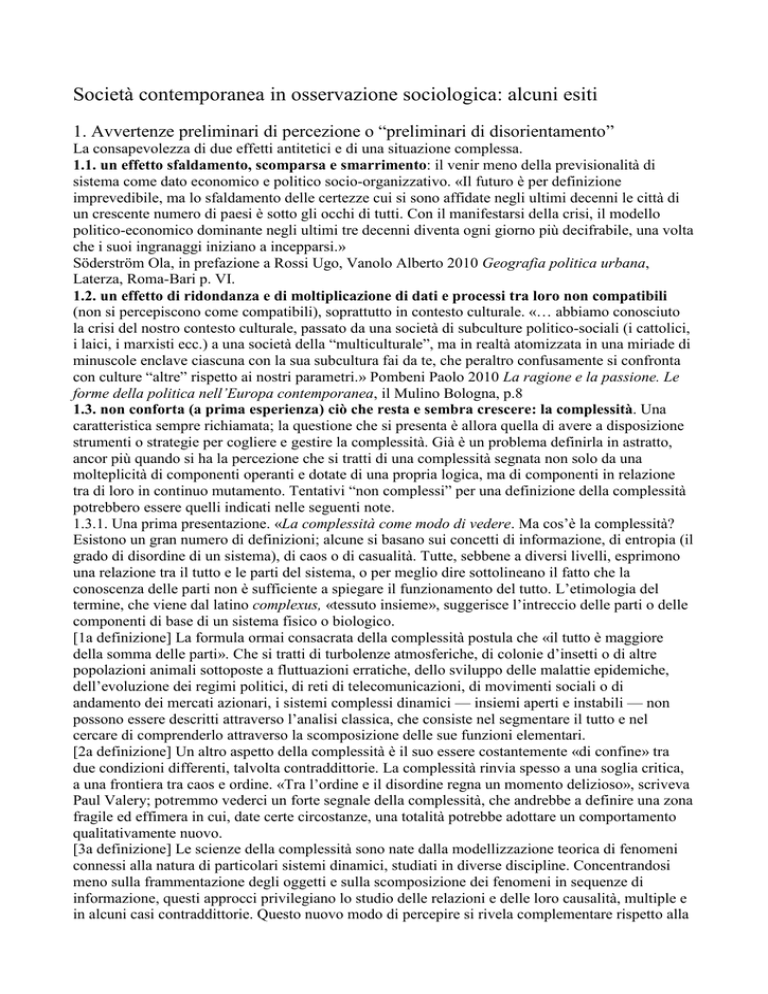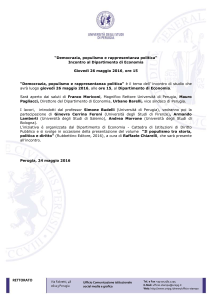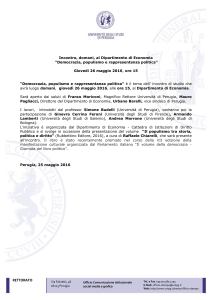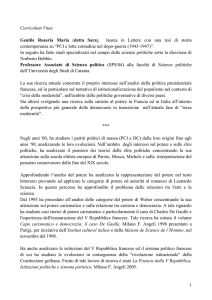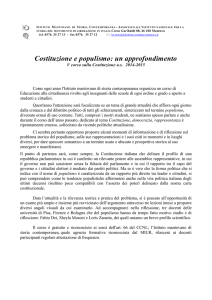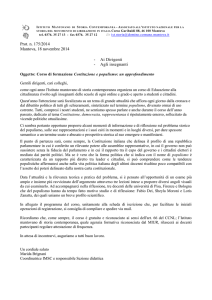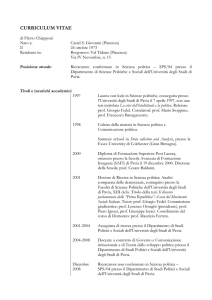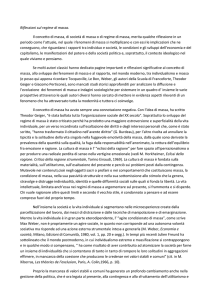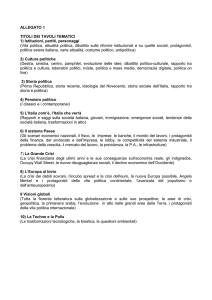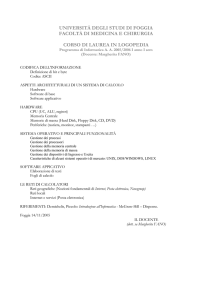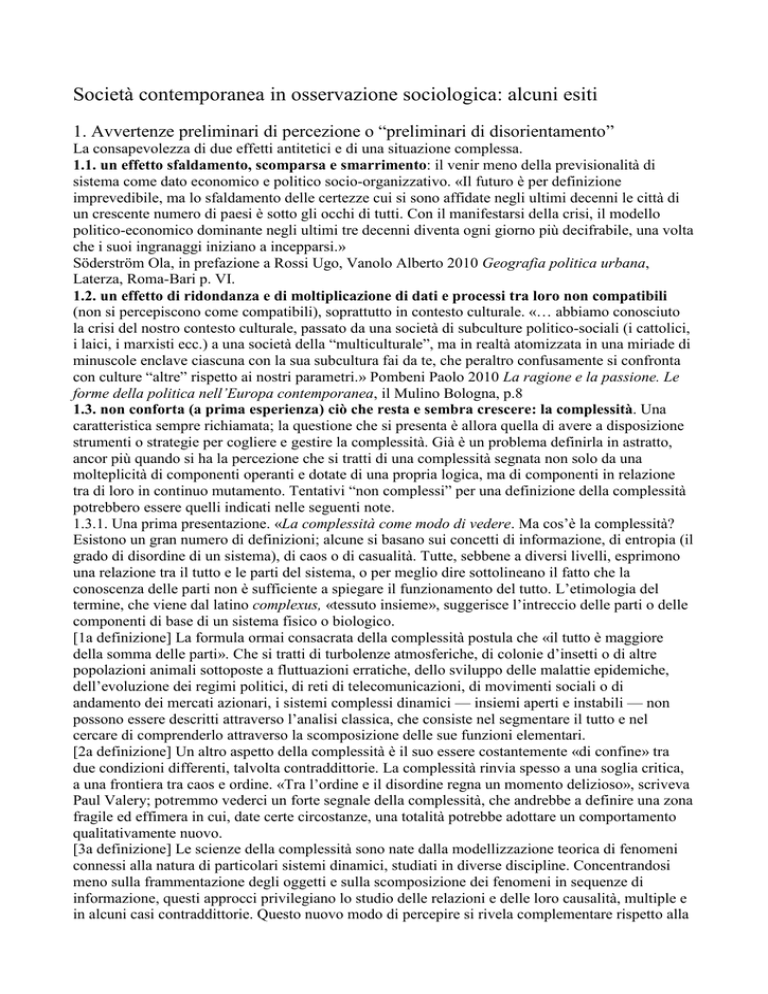
Società contemporanea in osservazione sociologica: alcuni esiti
1. Avvertenze preliminari di percezione o “preliminari di disorientamento”
La consapevolezza di due effetti antitetici e di una situazione complessa.
1.1. un effetto sfaldamento, scomparsa e smarrimento: il venir meno della previsionalità di
sistema come dato economico e politico socio-organizzativo. «Il futuro è per definizione
imprevedibile, ma lo sfaldamento delle certezze cui si sono affidate negli ultimi decenni le città di
un crescente numero di paesi è sotto gli occhi di tutti. Con il manifestarsi della crisi, il modello
politico-economico dominante negli ultimi tre decenni diventa ogni giorno più decifrabile, una volta
che i suoi ingranaggi iniziano a incepparsi.»
Söderström Ola, in prefazione a Rossi Ugo, Vanolo Alberto 2010 Geografia politica urbana,
Laterza, Roma-Bari p. VI.
1.2. un effetto di ridondanza e di moltiplicazione di dati e processi tra loro non compatibili
(non si percepiscono come compatibili), soprattutto in contesto culturale. «… abbiamo conosciuto
la crisi del nostro contesto culturale, passato da una società di subculture politico-sociali (i cattolici,
i laici, i marxisti ecc.) a una società della “multiculturale”, ma in realtà atomizzata in una miriade di
minuscole enclave ciascuna con la sua subcultura fai da te, che peraltro confusamente si confronta
con culture “altre” rispetto ai nostri parametri.» Pombeni Paolo 2010 La ragione e la passione. Le
forme della politica nell’Europa contemporanea, il Mulino Bologna, p.8
1.3. non conforta (a prima esperienza) ciò che resta e sembra crescere: la complessità. Una
caratteristica sempre richiamata; la questione che si presenta è allora quella di avere a disposizione
strumenti o strategie per cogliere e gestire la complessità. Già è un problema definirla in astratto,
ancor più quando si ha la percezione che si tratti di una complessità segnata non solo da una
molteplicità di componenti operanti e dotate di una propria logica, ma di componenti in relazione
tra di loro in continuo mutamento. Tentativi “non complessi” per una definizione della complessità
potrebbero essere quelli indicati nelle seguenti note.
1.3.1. Una prima presentazione. «La complessità come modo di vedere. Ma cos’è la complessità?
Esistono un gran numero di definizioni; alcune si basano sui concetti di informazione, di entropia (il
grado di disordine di un sistema), di caos o di casualità. Tutte, sebbene a diversi livelli, esprimono
una relazione tra il tutto e le parti del sistema, o per meglio dire sottolineano il fatto che la
conoscenza delle parti non è sufficiente a spiegare il funzionamento del tutto. L’etimologia del
termine, che viene dal latino complexus, «tessuto insieme», suggerisce l’intreccio delle parti o delle
componenti di base di un sistema fisico o biologico.
[1a definizione] La formula ormai consacrata della complessità postula che «il tutto è maggiore
della somma delle parti». Che si tratti di turbolenze atmosferiche, di colonie d’insetti o di altre
popolazioni animali sottoposte a fluttuazioni erratiche, dello sviluppo delle malattie epidemiche,
dell’evoluzione dei regimi politici, di reti di telecomunicazioni, di movimenti sociali o di
andamento dei mercati azionari, i sistemi complessi dinamici — insiemi aperti e instabili — non
possono essere descritti attraverso l’analisi classica, che consiste nel segmentare il tutto e nel
cercare di comprenderlo attraverso la scomposizione delle sue funzioni elementari.
[2a definizione] Un altro aspetto della complessità è il suo essere costantemente «di confine» tra
due condizioni differenti, talvolta contraddittorie. La complessità rinvia spesso a una soglia critica,
a una frontiera tra caos e ordine. «Tra l’ordine e il disordine regna un momento delizioso», scriveva
Paul Valery; potremmo vederci un forte segnale della complessità, che andrebbe a definire una zona
fragile ed effimera in cui, date certe circostanze, una totalità potrebbe adottare un comportamento
qualitativamente nuovo.
[3a definizione] Le scienze della complessità sono nate dalla modellizzazione teorica di fenomeni
connessi alla natura di particolari sistemi dinamici, studiati in diverse discipline. Concentrandosi
meno sulla frammentazione degli oggetti e sulla scomposizione dei fenomeni in sequenze di
informazione, questi approcci privilegiano lo studio delle relazioni e delle loro causalità, multiple e
in alcuni casi contraddittorie. Questo nuovo modo di percepire si rivela complementare rispetto alla
modalità «classica» di riflessione, di lavoro e di gestione del cambiamento, incluse le situazioni
imprevedibili e inedite. Ma questi settori emergenti del pensiero scientifico si sono potute
sviluppare solo grazie al progresso degli strumenti informatici. Il computer gioca un ruolo
fondamentale: è il microscopio/telescopio che permette di simulare e visualizzare i sistemi
complessi nell’infinitamente piccolo e nell’infinitamente grande.» Benkirane Réda 2002 La teoria
della complessità, Bollati Boringhieri, Torino 2007, 9-10
1.3.2. applicazione ed uso della complessità in contesto sociologico riferito alla situazione
contemporanea; qui la complessità si presenta a diversi livelli; il ricorso all’antinomia per la loro
presentazione permette di coglierne le forme nell’ampiezza dei problemi e degli aspetti rilevati.
[livello 1] Società nelle quali si è verificata ed è in atto una rapida evoluzione nelle forme di
produzione, delle abitudini e delle regole dei rapporti sociali, ma tale evoluzione si accompagna alla
sopravvivenza di regole e sistemi (economici, sociali, politici, consuetudinari...) vigenti in periodi
anteriori e ancora validi e fedelmente difesi in aree o in settori di vita attuale (economica, politica,
culturale … religiosa, di costume, di lingua…).
[livello 2] Società che appaiono fortemente unificate dalla accentuata centralità della loro
organizzazione statuale e dalla dichiarata volontà di riconoscersi come unità storiche omogenee
(comunità, patria, popolo, grande famiglia, organismo...), contemporaneamente però esse mostrano
nel loro passato e nel presente una serie di differenze "culturali" interne che appaiono più o meno
direttamente connesse con le disuguaglianze associative, politiche, economiche, culturali o che
vengono rivendicate e ripristinate come meccanismi identitari di aggregazione, riconoscimento,
difesa, privilegio … (A.M.Cirese 1997 Dislivelli di cultura ed altri discorsi inattuali, ed. Meltemi,
Roma)
[livello 3] Società nella quali si realizza un forte dinamismo sociale di comunicazioni, addirittura
simultanee, tra centri (politici, economici, culturali) e periferie, tra istituzioni e cittadini, tra persone
note e sconosciute, con irrilevanza di distanze; dinamismo reso possibile dalla disponibilità di mezzi
tecnici prima sconosciuti, dall'innalzamento del livello culturale medio, e tuttavia permangono "salti
culturali" morfologici e storici, qualitativi e quantitativi, ancora tra città e campagna, periferia e
centro, tra ambienti "colti" e ambienti "popolari"; dislivelli forti e resistenti in quanto si presentano
come formazioni storiche e come processi di costruzione di identità sociali mirati alla creazioni di
circoli chiusi e di una ribadita divisione tra attori sociali, comparse, spettatori…
1.4. «le scienze sociali come meccanismi di riduzione della complessità». (Demichelis Lelio 2010
Società o comunità. L’individuo, la libertà, il conflitto, l’empatia, la rete, Carocci editore, Roma p.
125) La sociologia spiegando semplifica. Individua, definisce e cataloga in vista di un discorso che
è composizione e lettura del sociale secondo concetti e secondo un ordine. Semplificazione che non
ha l’effetto di negare il dato della complessità (magari la tecnica delle semplificazioni attuata in
modo strumentale in politica per far trionfare visioni e teorie ideologiche preconfezionate e
sbrigative, costruite per suscitare un rapido consenso, una sudditanza o una assenza di senso
critico), ma ne mette in evidenza le coordinate portando la complessità a lettura e presentandola
come contesto di possibilità, di libertà, di progetto e di realizzazione. Occorre dunque orientarsi nel
sociale con la prassi del classificare. Si tratta di una prassi sociologica (e non solo) generale e quasi
irrinunciabile; resta fedele al proprio ruolo di orientamento e guida solo se si conserva mobile
nell’individuare schemi e classi seguendo la realtà nei suoi mutevoli stati di complessità più che la
coerenza sistematica di una teoria del sociale definita a priori o al servizio di progetti politici.
2. Un sistema classico e finora dominante: la classificazione sociale basata sui ruoli
professionali.
2.1. Il criterio classico e l’evoluzione dei suoi elementi: le classi (evoluzione economico-sociale).
Si può definire classico (in quanto a lungo tradizionalmente condiviso nelle analisi sulle società
industrializzate) il criterio che assume come strumento di orientamento e di classificazione dei dati
sociali il mondo delle professioni economiche, diviso nei tre settori: primario, secondario, terziario,
a loro volta specificate e dettagliate in modo da afferrare con maggior precisione le componenti
operative nella produzione economica e nella vita sociale e politica.
Grafici e tabelle consentono di cogliere l’evoluzione degli investimenti economici, l’alternanza tra i
settori che rivendicano per sé il ruolo della centralità economica (il ruolo di settore punto di
convergenza dei capitali, di realizzazione del massimo profitto, di innovazione tecnologica), la
mobilità sociale professionale nelle diverse aree, le specializzazioni progressive, la scomparsa e
l’emergere di nuove abilità e professioni.
2.1.1. Un simile criterio di classificazione e di orientamento spinge a considerare come
tendenzialmente coincidenti la struttura professionale e la struttura sociale di un gruppo, in
un’epoca data, e ad assumere, almeno come postulato di ricerca, il ruolo fondamentale
dell’economia e delle professioni nella costruzione dei ruoli e degli equilibri sociali.
«La struttura professionale di una popolazione è da mettere in rapporto col tipo di organizzazione
della vita economica. Si possono riconoscere, ad esempio, società rurali a differenziazione
professionale ben poco marcata, visto che quasi tutti i membri vivono del lavoro dei campi, e
società urbane a differenziazione assai accentuata (operai. commercianti, impiegati, professionisti).
Una distinzione di partenza è da fare tra popolazione attiva e popolazione non attiva. Le statistiche
sono spesso viziate dalle diverse definizioni e interpretazioni dei termini. Generalmente per
popolazione attiva s’intende l’insieme delle persone in condizione professionale, ivi compresi anche
i disoccupati. Alcune volte sono pure incluse le persone in cerca di prima occupazione… […] Ma
può influire molto la diffusione dell’“attività” femminile … le donne sono casalinghe, e, in quanto
tali, risultano classificate dalla statistica tra la popolazione non attiva. La percentuale di popolazione
femminile classificata come attiva è irrilevante nei paesi ad economia arcaica: le donne quantunque
fatichino duramente sui campi accanto ai loro uomini, non cessano di restare casalinghe, e cioè
statisticamente inattive. […] Una prima ripartizione della popolazione attiva riguarda i grandi rami
economici. Gli addetti alle attività primarie sono essenzialmente: agricoltori, pescatori, minatori.
Alle attività secondarie, cioè alla trasformazione dei prodotti, attendono gli addetti alle industrie. Si
chiamano attività terziarie i commerci e trasporti, e a che i servizi, le libere professioni, ecc. Più la
società si evolve e più diminuisce la proporzione delle attività primarie a vantaggio delle secondarie
e soprattutto delle terziarie. […] Un aspetto qualificante è lo sviluppo del terziario: col progredire
dell’economia, acquistano ampiezza gli scambi dei prodotti, i compiti amministrativi e
organizzativi, la preparazione dei quadri dirigenti e la ricerca scientifica. Oggi si tende a considerare
in un settore a parte, il quaternario, le attività superiori come quelle della cultura e della scienza,
della direzione politica e della dirigenza d’impresa, della ricerca tecnologica e degli studi di
mercato. […] La struttura sociale è connessa alla diversità della posizione nella scala delle attività
professionali e alla disparità del livello di vita. Nel nostro mondo “occidentale” la gerarchia sociale
ha basi prevalentemente economiche e pertanto le classi sono gruppi differenziati tra loro dalle
diverse possibilità finanziarie.» (Dagradi Piero 1982 Introduzione alla geografia umana, ed. Patron,
Bologna pp. 166-170)
2.1.1.1. Seppur in un mondo di utopia comica e fantascientifica, fa la sua comparsa, sul finire
dell’800 una classificazione geometrica del sociale, attento tuttavia, e paradossalmente, a mettere in
luce più che il destino di ordine l’essenza perennemente mobile (anche in termini di mobilità
sociale) e sovversiva di una società geometricamente composta. Abbott A. Edwin 1884 Flatlandia
(Einaudi, Torino 2011 introduzione di Claudio Bartocci). Gerarchia, classificazione, ipotesi di
ordine e sistema sociale in un contesto turbolento puntellato da tumulti e potenziali rivoluzioni.
«Riguardo agli Abitanti di Flatlandia. La massima lunghezza, o larghezza che dir si voglia, degli
adulti di Flatlandia corrisponde a circa ventotto dei vostri centimetri. Trenta a dir tanto.
Le nostre Donne sono segmenti di Linee rette.
I nostri Soldati e gli Operai delle classi Inferiori sono Triangoli, con due lati uguali lunghi più o
meno ventotto centimetri, e la base, o terzo lato, talmente corta (spesso supera di poco il centimetro)
da formare al vertice un angolo assai appuntito e molto temibile. Invero, quando la base è del tipo
più abietto (non superiore ai tre millimetri), li si distingue a malapena dalle Linee rette, ossia dalle
Donne, tanto sono aguzzi i loro vertici. Da noi, come da voi, tali Triangoli sono chiamati Isosceli,
per differenziarli dagli altri; e con questo nome ne parlerò nelle pagine che seguono.
La classe Media di Flatlandia consiste di Triangoli Equilateri, ovvero con tutti i lati uguali.
I Professionisti e i Gentiluomini sono Quadrati (è questa la classe sociale a cui io stesso appartengo)
e Figure a Cinque Lati o Pentagoni.
Subito al di sopra di costoro c’è l’Aristocrazia, i cui componenti possono raggiungere diversi gradi
di nobiltà, cominciando dalle Figure a Sei Lati, o Esagoni, per passare poi a un numero di lati
sempre maggiore, finché non ricevono il titolo onorifico di Poligonali, o dai molti lati. In ultimo,
allorché il numero di tali lati diventa così copioso, e la lunghezza di ciascuno diminuisce al punto da
rendere il nobile di turno indistinguibile da un cerchio, egli entra a far parte dell’Ordine Circolare o
Sacerdotale, il ceto più elevato di tutti. […]
L’occasionale emergere di un Equilatero da antenati di stirpe servile è gradito non solo ai disgraziati
servi stessi, per i quali rappresenta un raggio di luce e di speranza nel monotono squallore della loro
vita, ma anche all’Aristocrazia nel suo complesso, in quanto tutte le classi Elevate sanno bene come
certi rari fenomeni, lungi dallo svilire i loro privilegi, svolgono il ruolo utilissimo di arginare le
rivoluzioni dal basso.» (Abbott 1884, p.21-22,23)
2.2. la crisi della classificazione sociale per aree di professioni
2.2.1. Le trasformazioni. Il prevalere del settore terziario, del nuovo terziario [avanzato, o settore
quaternario] che impone l’informatizzazione dei processi gestionali e produttivi (informatizzazione
basata sul trattamento matematico di ogni tipo di informazione), avvia la trasformazione delle figure
professionali, si espande imprevedibilmente creando settori nuovi o innovando ambiti tradizionali;
spicca l'emergere di un settore particolare: "la produzione dei beni immateriali" (informazione,
comunicazione, spettacolo, pubblicità, tempo libero, salute...)
Il prevalere del capitale finanziario e dei soggetti che lo gestiscono nei confronti del capitale
industriale produttivo e nei confronti della stessa economia pubblica facente capo alle istituzioni
dello Stato ha profondamente cambiato l’area degli interessi dominanti e dei profitti economici
scalzando l’economia produttiva dal ruolo di decisore delle figure professionali.
Le innovazioni tecnologiche continue, estese e radicali trasformano i modi e i tempi dei processi
produttivi determinando il tramonto non solo di figure professionali, ma anche di interi settori
dell’economia considerati specifici e autonomi (difficile è infatti oggi, ad esempio, continuare a
parlare dell’agricoltura come un settore primario, autonomo, distinto separato dall’economia
industriale vista la meccanizzazione di tutti i suoi processi produttivi e l’informatizzazione della
loro gestione, la sua destinazione al consumo attraverso il commercio e non in forma diretta,
l’ampiezza dei suoi investimenti per aree latifondistiche e capitali; così come è altrettanto difficile,
visti i processi di informatizzazione, distinguere tra settore secondario e settore terziario; restano le
professioni, il loro moltiplicarsi, la loro evoluzione e anche la loro scomparsa).
Il nuovo lavoro (dal fordismo al postfordismo; dalla fabbrica fordista unita e territorialmente
visibile come centro alla fabbrica diffusa, decentrata, invisibile e mobile nella sua rete. Così muta il
lavoro. Il fordismo che ha segnato il '900 era caratterizzato dalla centralità del lavoro salariato che
rimandava alla fabbrica come luogo centrale delle dinamiche spaziali e delle appartenenze, come
sentire fondante il vivere comune; il postfordismo, che caratterizza l'età attuale colloca le forme del
lavoro in una precaria economia e società del competere.
2.2.2. La scomparsa delle professioni classi sociali tradizionali (proprie della prima rivoluzione
industriale), la crisi conseguente del sistema tradizionale di classificazione e la difficoltà a
conservare la coincidenza tra struttura professionale e struttura sociale di un gruppo.
«… al fianco di figure tradizionali nascono figure professionali nuove; con velocità impressionante
si scompongono, si ricompongono, si enucleano nuove professioni che operano con tempi di lavoro
e con caratteristiche assai diverse da quelle con le quali ci si poteva misurare in tempi relativamente
recenti: Proprio questo settore continua ad attraversare una fase di sconvolgimenti e di novità forse
superiore ad altri settori, pur coinvolti in un vorticoso e repentino rinnovamento. Tutto ciò fa
emergere problemi nuovi molto complessi che necessitano analisi precise, per costruire soluzioni e
risposte realistiche. In tutto il mondo del lavoro, si attenuano i tradizionali confini tra industria e
terziario; si attenuano altresì, per molte figure, i confini tra lavoro dipendente e non, mentre si
moltiplicano figure professionali per le quali le tradizionali divisioni non possono che essere lette
con imbarazzante difficoltà.» (Carlo Ghezzi, Mestieri di frontiera, 1988)
2.2.3. una infinita e indistinta "middle class". A parte una ristretta élite al vertice, e coloro che "non
hanno retto il gioco" e sono finiti così ai margini della società, la struttura sociale appare
caratterizzata da una grande middle class, alla quale sembrano approdare insieme, ormai, ceti medi
e operai, resi più simili da capacità di spese in crescita, relativamente più uniformate e stabili,
dunque da livelli e stili di consumo più prossimi; area sociale vasta, non gruppo, non classe.
2.2.3.1. Figlia di diverse classi sociali, la middle class appare piuttosto come una classe di consumo
che come classe produttiva, ed è a partire dai modi del consumo che la sociologia tende a
occuparsene; gli stili di vita e il consumo acquistano maggior importanza nella strutturazione
sociale e raggiunti certi standard di reddito emerge la tendenza generalizzata ad investire nel mondo
e nel tempo del non-lavoro.
2.2.3.2. Si tratta della "società dei due terzi" (o dei quattro quinti): una maggioranza sociale
sostanzialmente compatta e soddisfatta di sé che non si preoccupa delle condizioni di vita del terzo
restante, confinato in condizioni di insignificanza politica, di subalternità o esclusione culturale e di
acuto disagio sociale; o se ne occupa solo in quanto avverte il pericolo e vive l’insopportabile paura
di entrare a farvi parte piombando in fondo, ai margini o all’esterno del sociale, fuori da uno stile di
vita faticosamente costruito e finora fruito.
2.2.3.3. Al binomio uguaglianza/disuguaglianza, finora centrale nel dibattito economico e politico,
viene sostituita dunque la coppia inclusione/esclusione; l'importante per il soggetto sociale non è
essere uguale, ma essere incluso, cioè essere ammesso al processo che permette di accedere alle
opportunità. La sfida è senza esclusione di colpi e crescente: più si amplia l’accesso medio ai
consumi e diventa complesso lo stile di vita considerato normale e necessario, più si dilata la
distanza tra ricchezza e povertà, tra potere e senza potere; si alza sempre più la soglia per restare
inclusi e per competere. In questo margine, gli ultimi non sono più un soggetto storico, protagonisti
di una battaglia di liberazione, classe, divengono, se va bene, "merce" di quella retorica della
solidarietà ove anche la "pietas" diventa area di profitto scambiabile, contrattabile e da esibire.
«… il denaro, la sua distribuzione e il suo utilizzo, è rimasto forse l’ultimo elemento interpretativo
utile per tentare di muoversi tra le «macerie» delle classi sociali ormai totalmente scompaginate e
disomogenee. […] … i contorni della nuova middle-class, quel ceto eterogeneo e complesso che «è
il cuore» [della società] ma non è ancora un blocco sociale. […] Il suo profilo, rispetto anche solo
agli inizi del secolo, è infatti profondamente cambiato: oggi il ceto medio abbraccia categorie
diverse e sempre più “imprendibili” sul piano sociologico. È infatti caduto un discrimine che pure è
stato in voga in passato, tra lavoro dipendente e lavoro autonomo. Oggi si può ben dire che, sia pure
con qualche sfrangiamento al vertice superiore ed inferiore, alla middle-class appartiene tanto
l’impiegato del catasto quanto il commerciante di provincia o l’artigiano della grande città. Il vasto
esercito dei piccoli imprenditori (familiari e non) si è quindi unito alla già folta schiera di impiegati
e dirigenti di imprese private, impiegati e quadri della pubblica amministrazione, maestri e
insegnanti, medici dipendenti e altri appartenenti alle professioni intermedie della sanità, come gli
assistenti sociali. […] Dunque, anche se la si definisce ancora middle-class, questa fatalmente non è
una classe. Non ha al suo interno alcuna identità storica, alcun decalogo di valori comuni cui
ancorarsi, alcuna coscienza del proprio ruolo all’interno della società. Il ceto medio,insomma non
ha virtù proprie. In compenso ha, comuni, alcuni ‘vizi’… […] Il primo tratto unificante … è il
«primato» delle aspirazioni economiche, quelle più ostentative, che generano “un’esasperazione del
confronto e dell’invidia sociale, della gara nella soddisfazione dei bisogni nel più breve tempo
possibile, egoismi che comportano sperpero di risorse e caduta di solidarietà” (Gabriele Calvi). E’
la filosofia del tutto e subito, insomma, che governa le pulsioni consumistiche del ceto medio, e ne
condiziona le scelte e gli stili di vita e perfino bilanci familiari. […] Da questo primo vizio comune
… discendono per logica conseguenza altri due, non meno preoccupanti e altrettanto”visibili” nella
realtà quotidiana. Il primo è la “povertà della coscienza civile”, che fa di queste categorie medie,
sfrangiate e rivali verso l’interno e verso l’esterno, vere e proprie nemiche del contratto sociale e
dello stato in quanto simbolo delle regole (e quindi delle restrizioni e dei divieti, oltre che dei
diritti). “La legge … è per essi una gabbia entro la quale non bisogna finire” (Gabrilele Calvi). […]
…il terzo e ultimo vizio comune del ceto medio [è la] “povertà della coscienza politica” (Gabriele
Calvi). […] I fatti di ogni giorno dicono chiaramente che il danaro e la sua difesa sono e saranno
l’unico, vero elemento che può rendere unitario sia pure con mille frammentazioni, un target sociale
che unitario non è. Sul piano politico questo significa … “la gente vota con il portafoglio”. Sul
piano sociale, invece, questo significa che l’unico punto di riferimento cui sarà possibile ricorrere
per identificare la middle-class saranno i modelli di consumo. […] Vedremo sempre più spesso
impiegati al volante di rombanti fuoristrada nei centri storici e nuove «addette del terziario»
impegnate in rincorse all’abito o persino alla maiolica “griffata”.» E’ così, e non ci possiamo fare
granché. Se è vero che gli ideali di una nazione si capiscono dalla sua pubblicità, l’Italia è
condannata a restare, ancora a lungo, terreno di conquista per Uomini Forti e Grandi Seduttori.»
Massimo Giannini, Una borghesia piccola piccola (La Repubblica 26 aprile 1995)
2.2.3.4. «La crisi delle appartenenze non è però un fenomeno limitato soltanto alla classe dei
lavoratori dell’industria. Nell’ultimo ventennio del Novecento sono messe in discussione anche
tutte quelle certezze di status, di reddito, di socialità che avevano accompagnato la
“cetomedizzazione” della società italiana. Il grande invaso della società di mezzo viene in parte
proletarizzato, scomposto e ricomposto dentro l’emergere dell’economia globalizzata; le classi
medie dotate di istruzione, sapere, conoscenza e capacità di lavorare comunicando, o meglio i figli
di queste classi, negli anni novanta vengono messi al lavoro come General Intellect nelle
professioni della comunicazione, della consulenza, del design e della creatività. Ma senza più
certezze. Perché nel frattempo allo scadere del secolo breve si produce una cesura fondamentale:
passiamo tutti da una società dei mezzi scarsi ma dai fini certi a una società in cui si danno mezzi
abbondanti ma fini incerti.» (Bonomi 2010, 67) «Le appartenenze si sciolgono per lasciare il passo
alle identità intese come riconoscimenti di essere in comunità ma senza più legami. […] Rottura
delle solidarietà di ceto e di classe, crisi del concetto di uguaglianza, competizione molecolare, sono
tutti elementi influenzati anche da un altro grande flusso di trasformazione, che a partire dalla
dimensione della propria vita nuda corporea incarna l’impatto della globalizzazione: le migrazioni.
L’emergere del sindacalismo di territorio come nuova forma di rappresentanza degli interessi e
delle passioni: … sindacalismo di territorio …processo di territorializzazione della
rappresentanza.» (Bonomi Aldo 2010 Sotto la pelle dello Stato. Rancore, cura, operosità,
Feltrinelli, Milano p. 68-69,73)
«Davvero il proletariato è morto, o invece è vero (come ricorda Luciano Gallino) che non è mai
stato così grande e globale (ai 500 milioni di vecchi proletari del ricco Occidente vanno aggiunti
1,5 miliardi di nuovi proletari di India, Cina e di altre nuove potenze economiche)? Se il
proletariato non è mai stato così numeroso come oggi, che cosa lo rende non rivoluzionario, non
conflittuale, addirittura consensuale rispetto al sistema capitalistico (tecnico) egemone? Il conflitto
di classe — morente nel Nord del mondo — nascerà forse nel nuovo Sud capitalistico (tecnico)
dell’India (il conflitto dei contadini contro l’industria automobilistica Tata) o della Cina, dove da
tempo esistono scioperi e richieste di miglioramento economico e salariale…» (Demichelis 2010
p.183)
«Aveva fatto scalpore, in Italia, un sondaggio pubblicato il maggio 2009 su “Il Sole 24 Ore”
secondo il quale i consensi operai al Popolo delle libertà erano il doppio di quelli al Partito
democratico (43,4% contro 22,4%). Dato che subito poneva la domanda base per ogni ulteriore
riflessione: quale rivoluzione culturale ha prodotto questo paradosso, per cui anche in Italia la parte
debole della società (in Italia tradizionalmente a sinistra) decide di votare per la parte forte (la
destra), che fa politiche contro gli operai? 74
«Una delle astuzie della società attuale — almeno in Italia — è di aver convinto i poveri ad amare i
ricchi, a idolatrare la ricchezza e la volgarità», ha scritto Goffredo Fofi (ma in verità questa astuzia
non si è attuata solo in Italia). «In passato i poveri solitamente non amavano i ricchi: li si
convinceva, anche con la forza, a sopportare la loro condizione, si tollerava anche che peccassero di
invidia, al più li si spaventava con la prospettiva delle pene dell’inferno. Negli anni Ottanta […] è
esplosa invece una cosa del tutto nuova: la tendenza a negare le differenze tra i ricchi e i non ricchi,
a far sì che i non ricchi si pensino ricchi, che amino i ricchi come maestri di vita, come modelli
assoluti di cui seguire ogni esempio.» E ancora: «C’è stato un rimescolamento delle classi, e una
piccola borghesia consumistica, manipolata e chiassosamente protagonista ha preso il sopravvento
o, meglio, si è fatta veicolo di una cultura unica, in cui ricchi e poveri, padroni e servi condividono
gli stessi idoli e gli stessi modelli, in questo contesto mutato, le minoranze etiche devono assumersi
oneri maggiori, anche andando incontro a maggiori solitudini.». G. Fofi, La vocazione minoritaria,
Laterza, Roma 2009 p.3, 110»; in Demichelis 2010 74,75-76)
«La lotta di classe l’hanno dunque vinta i ricchi. Sono felici e vorrebbero stravincere. E i poveri non
sognano di rovesciare i ricchi, ma cercano di imitarli e di diventare come loro. […] la classe che
avrebbe dovuto essere sconfitta (la borghesia, gli imprenditori, e i finanzieri) invece ancora più
forte, denominata addirittura superclasse…» (Demichelis 2010, 184, 185)
«Marx (che per altro non ha mai dato una definizione precisa di classe) pensava che la borghesia,
come classe dominante, avrebbe infine prodotto la classe che l’avrebbe rovesciata — il proletariato,
appunto — creando finalmente una società senza più classi e senza più conflitto. In realtà è la
borghesia — o, meglio, il sistema capitalistico, e prima di questo il sistema della tecnica come
apparato — ad avere rovesciato il proletariato, creando una società apparentemente senza classi (se
non la superclasse), senza più conflitto radicale, senza più alternative immaginabili, avendo
l’apparato tecnico espropriato la società di ogni capacità di immaginazione, di speranza, di Utopia,
integrandola a sé.» (Demichelis 2010, 196)
2.3. in conclusione: sulla difficile tenuta di concetti classici: classe, nazione, stato.
« Il passaggio di secolo depotenzia le parole chiave di chi, come me, nato negli anni cinquanta, è
cresciuto a pane e classe con lo stato come companatico. […]… le due categorie del Novecento…
classe e nazione, sono insufficienti entrambe a rapportarsi alla moltitudine migrante. […]
La classe che si fa moltitudine. Il trionfo della moltitudine che altro non è se non la fenomenologia
della massa priva di quel principio ordinatorio ed emancipatorio dato dalle classi sociali, che
produceva coscienza di sé, rappresentanza e rappresentazione. […] Ho ben chiaro che classe e stato
sono parole pesanti, non foss’altro che in loro nome, nel Novecento, si sono vissute guerre e
conflitti epocali, per questo vanno pensate nella loro dissolvenza. Così come mi è altrettanto chiaro
che nella dinamica ipermoderna del conflitto tra flussi e luoghi riappaiono parole pesanti di inizio
secolo come territorio e comunità. All’origine di tragedie, in nome della comunità di sangue e di
suolo eletta a comunità di destino, che vanno pensate e maneggiate con altrettanta, se non maggiore,
cura. Con quel dubbio e con quella diffidenza verso l’eterno ritorno, il dejà-vu, che ci fa apparire
attuale ciò che era inattuale: il territorio e la comunità, ciò che resta sotto la pelle dello stato.»
Bonomi Aldo 2010 Sotto la pelle dello Stato. Rancore, cura, operosità, Feltrinelli, Milano, 10-12
2.3.1. Le parole che ricorrono a registrare una dissolvenza (della classi, dello stato, della nazione…)
e cercano comunque di definirne la natura sono varie e non facilmente conciliabili tra loro: una
infinita e indistinta middle class, la moltitudine, la gente (con parallela soggettivazione del
“gentismo”), il consumatore, l’opinione pubblica … termini che hanno in comune la segnalazione
di una omogeneità crescente tra le persone, omologazione che va di pari passo, paradossalmente,
con un altro termine che ne indica la dissolvenza: individualismo.
2.3.2. «… Marc Augé in un’intervista, laddove definisce la “surmodernità” come la combinazione
di tre fenomeni: “Il restringimento dello spazio, l’accelerazione del tempo e l’individualizzazione
dei destini”. Tre fenomeni che, a ben vedere, rappresentano i capisaldi dell’ideologia del sorvolo.
2.3.2.1. ideologia del sorvolo. Un’ideologia, questa, che si può leggere nelle pratiche quotidiane sia
rivolgendo lo sguardo alla cima della piramide sociale, sia concentrandosi su ciò che avviene alla
sua base.
Lo spazio si restringe, per esempio, per quei manager che lavorano nel primo cerchio della
metropoli milanese — quello di Piazza Affari, delle grandi banche, delle grandi imprese e delle
grandi compagnie assicurative — che, anche nell’arco di una sola giornata lavorativa, si svegliano a
Milano, per poi pranzare a Londra e dormire a New York. Ma il mondo è uno spazio sempre più
stretto anche per le moltitudini dei migranti — sorvolatori di ben più lunga deriva — come per
esempio le badanti rumene e ucraine catapultate in Italia e in Europa, vere e proprie pendolari
transnazionali (o commuters, come va di moda dire ora), che provano a conciliare con difficoltà la
loro vita affettiva e sociale con quella professionale, senza business class o jet privati, carte di
credito e blackberry, ma con i voli low cost, le agenzie di money transfer e i phone center.
Il tempo accelera e si piega per gli ingegneri, i designer e gli altri professionisti al lavoro nelle
fabbriche della creatività mondiali. Come quelli indiani della Cisco Systems che lavorano al
Globalization Centre di Bangalore, copia perfetta dell’originale sede di San José in California
(stesso edificio, stesso numero di dipendenti, stesse figure professionali) che si sono visti cambiare
l’orario di lavoro per armonizzare l’operatività delle due sedi. Invece del classico orario continuato
dalle nove alle cinque, infatti, gli impiegati e i creativi della Cisco lavorano in isole di tempo sparse
nell’arco delle ventiquattro ore, compatibili sia con il fuso orario californiano sia con quello
indiano. Lo stesso, se non peggio, vale per i ben più umili dipendenti dei call center che a centinaia
di migliaia ogni giorno vivono e lavorano in vere e proprie “isole” al di fuori del loro tempo,
agganciate ognuna a un diverso fuso orario, per aiutare i consumatori americani e britannici a
prenotare aerei, a cambiare gestore telefonico, a noleggiare un’auto, ad accendere un mutuo. […]
I destini si individualizzano … […] Dalla massa otto-novecentesca di marxiana memoria, si passa
così a una moltitudine di soggettività che — sempre per citare Augé — “consumano per esistere”,
deprivati della socialità e della coesione di classe. […] Fino alla primavera del 2007, l’ideologia del
sorvolo — o, meglio, le sue pratiche — ha esercitato una forza pressoché egemone sulla vita
quotidiana dei soggetti e sul loro sistema di valori, oltre che sui modi e sulle forme del produrre.
[…] Un senso di onnipotenza che ruota attorno a due soli. La pretesa, fattasi teoria dopo un lungo
percorso di teoremi e modelli economici da Nobel, che i mercati, finanziari e non, possano darsi
autonomamente delle regole e farle rispettare. […] Tuttavia, l’essenza di questa crisi, l’opportunità
di riflessione che offre e da cui dovremo necessariamente ripartire è relativa al crollo dell’illusione
che si possa generare inclusione sociale a partire dall’individualismo e dall’atomizzazione sociale.
Un crollo non ancora del tutto compiutamente percepito, questo. Del quale, tuttavia, è
manifestazione piuttosto evidente la recente riscoperta dei Territori (al plurale e con la T
maiuscola), delle loro peculiarità, delle loro differenti esigenze e delle forme di comunità che si
instaurano su di essi. Anche da parte di alcuni strenui — almeno fino a poco tempo fa —
sorvolatori.» (Bonomi 2010, 129-131)
2.3.2.2. Alla diagnosi che registra in definizione la dissolvenza di antiche realtà sociali, segue il
tentativo di indicare il sorgere di nuovi processi, nuove forme, nuovi soggetti. Contro (in alternativa
o, almeno, accanto) le parole: classe, capitale e in mezzo lo stato, vengono proposte le parole, flussi,
luoghi e in mezzo il territorio e la comunità. (I flussi della globalità interessano e attraversano i
luoghi e si realizzano diventando e facendosi, in modo imprevedibile e tutto da studiare – osservare,
territorio e comunità nella loro impregiudicata natura.) Perciò due percorsi. Viene preso in
considerazione il “populismo”, quasi inesorabile destino politico di un popolo che è diventato
moltitudine e gente per metterne in evidenza potenzialità. Ma, “sotto la pelle dello stato” si
individuano movimenti più o meno autonomi, carsici, precari o durevoli, rancorosi o propositivi,
dotati di autonomia e di iniziativa (quale?).
3. alla ricerca di nuovi classificatori sociali
La società è un sistema funzionale in quanto deve la propria esistenza e continuità all’attivazione di
funzioni considerate, a diverso titolo, essenziali e mutevoli; tra di esse si crea una necessaria
interdipendenza (il sistema sociale è un sistema di interdipendenze). Le funzioni permettono di
individuare e definire ruoli sociali e questi sono assumibili come classificatori sociali. Perciò
restano al centro dell’attenzione i ruoli funzionali degli attori sociali e le loro interrelazioni,
l’emergere di interrelazioni sociali imprevedibili oltre i ruoli professionali.
3.1. La complessità crescente delle funzioni comporta un alto livello di mobilità nella
definizione dei ruoli; essi dunque non possono più venire usati come base per le definizione teorica
e per la gestione pratica rigida delle scelte sociali (come accadeva nella catalogazione classica del
sociale). Solo a livello di mentalità collettiva (caratterizzata da tempi di mutamento propri della
“lunga durata” - Braudel), o in forza dei procedimenti analogici richiesti dalla ragione storica (che si
orienta nel passato assumendo categorie formulate e condivise nel presente), i ruoli funzionali
possono continuare ad esser usati come base per la definizione della società secondo classi; nessuna
programmazione, né economica, né politica, né culturale, può invece investire in modo produttivo
le proprie risorse nel sociale sulla base di un simile criterio di orientamento, in quanto esso non
risulta idoneo a far notare la natura complessa della società contemporanea.
«Se i ruoli fossero sempre definiti in modo così univoco che i comportamenti dei titolari o — come
si dice più frequentemente nel gergo del sociologo — degli attori sociali potessero venirne
immediatamente dedotti, l’attività del sociologo che analizza un sistema di, ruoli sarebbe della
stessa natura di quella dello storico del diritto. Gli sarebbe sufficiente infatti reperire le norme
(scritte e non scritte, esplicite o non esplicite) osservate dagli attori sociali nell‘esecuzione del loro
ruolo. In realtà l’attività del sociologo ha poco in comune con quella dello storico del diritto, E ciò è
dovuto al fatto che nella realtà i ruoli non sono mai definiti in modo così preciso da non lasciare
spazio all’interpretazione. Questo spazio, o, per usare il linguaggio di Parsons, questa varianza dei
ruoli, è una delle fonti primarie di autonomia dell’attore sociale. È sufficiente per assegnare a ogni
sistema di relazioni tra ruoli una dimensione strategica. Se si suppone che ogni attore cerchi di
sfruttare il margine di autonomia che gli viene concesso dal sistema dei ruoli, questo sistema
costituisce un campo d’interazione strategico.» (Raymond Boudon, La logica del sociale, A.
Mondadori, Milano l980, pp 57-76 passim)
Nell’esplicazione dei ruoli, anche di quelli fortemente codificati, ciò che emerge come prioritario
nella attenzione dell’attore (magari poco assecondata dalla dirigenza) non è la pedissequa
ripetizione di formule e procedure preordinate o una continua conferma dell’identico, ma la
gestione personalizzata delle funzioni nel ruolo; sia che tale personalizzazione potenzi o sia che
indebolisca l’efficacia dell’azione. A porre in risalto la complessità dei ruoli in un sistema
funzionale è dunque la loro pluralità, la loro evoluzione, la gestione personalizzata degli stessi e,
come ulteriore elemento, la pluralità dei ruoli che una stessa persona svolge nella propria vita, con
la conseguente interferenza tra essi (e perciò personalizzazione, mutamento, evoluzione…)
«… gli individui giocano generalmente una pluralità di ruoli. Una madre può essere nello stesso
tempo sposa, impiegata di banca, militante sindacale, ed elettrice. È ovvio che tra tutti questi ruoli
possono generarsi fenomeni d’interferenza: la militante sindacale può intralciare l’elettrice; la
madre di famiglia può imbattersi in situazioni che mettono in difficoltà la sposa. Varianza dei ruoli,
ambivalenza delle norme che «definiscono» i ruoli, carattere composito di certi ruoli, e interferenza
tra i ruoli costituiscono quattro fenomeni essenziali per il sociologo. La loro presenza introduce
infatti nei sistemi di ruolo un gioco (nel senso meccanico del termine) sufficiente a garantire sempre
l’esistenza di una dimensione strategica…» (Boudon 1980, ivi)
3.2. L’emergenza delle interrelazioni oltre le interrelazioni professionali: «effetti di
aggregazione» o «emergenti». I ruoli professionali e le loro necessarie interdipendenze non
esauriscono il complesso delle relazioni sociali. Molti nuovi fattori, dagli esiti imprevedibili le
infittiscono: la crescita demografica non più legata prevalentemente, come finora, all’incremento
delle nascite, ma all’allungamento della durata della vita e al conseguente invecchiamento della
popolazione (aumento della vita media), i flussi delle migrazioni dai paesi tenuti in povertà verso i
paesi dello “sviluppo” (disomogeneo), i cicli dell’economia con i momenti ricorrenti di stallo e di
crisi, i mutamenti climatici ambientali e le emergenze degli insediamenti umani, la mobilità delle
professioni e dei ruoli produttivi, la progressiva riduzione del tempo—lavoro (con il doppio effetto
antitetico: aumento del tempo libero, riduzione dell’occupazione e aumento della disoccupazione).
In questi (e altri) contesti, le interdipendenze tra i ruoli professionali, pur continuando a definire
strutturalmente un sistema sociale, ne costituiscono un aspetto progressivamente parziale. Agenti
individuali e in associazione, operando all’esterno dei ruoli funzionali previsti, attivano
comportamenti che apparentemente derivano solo da scelte e criteri del tutto privati, ma sono
all’origine di fenomeni collettivi, gruppi e movimenti più o meni programmati, spesso non
prevedibili, dalla durata e dalla estensione non definibile, ma certamente sono gestori di emergenze
sociali e fonte di emergenze politiche e gestionali. Si tratta di attori e eventi sociali non
programmati sui tempi lunghi, ma capaci di ampia aggregazione e diffusione, spesso ben oltre i
confini tradizionali della politica: sono movimenti transnazionali, globali e si trasformano in
vincolo e controllo critico per ogni tipo di programmazione e scelta: economica, politica, culturale.
3.2.1. un esempio minimo: «Per illustrare meglio questa distinzione, prendiamo un esempio molto
semplice. Osservo il fluire di una coda di persone davanti alla cassa di un cinema. I clienti
compiono tutti la stessa sequenza di azioni: dichiarano il film che vorrebbero vedere e acquistano il
biglietto. Queste azioni si svolgono nel contesto del sistema d’intesa cliente-cassiera. Tale sistema
definisce con grande chiarezza i ruoli dei due protagonisti (la cassiera si stupirebbe se uno
spettatore le domandasse un parere sul film, lo spettatore rimarrebbe altrettanto stupito se la cassiera
intervenisse nella sua scelta). Consideriamo l’insieme degli spettatori potenziali che formano la
coda. Questi spettatori costituiscono un sistema d’interazione: le possibilità che ciascuno di loro
entri nella sala e i tempi di attesa ai quali ognuno è esposto, sono determinati dagli altri. Così, il
fatto che X abbia scelto di vedere lo stesso film di Y e sia arrivato prima di quest’ultimo ha come
conseguenza che X impone ad Y un’attesa supplementare. X e Y sono dunque senz’altro in una
situazione d’interazione, ma la loro non è una relazione di ruoli. Per distinguere questa situazione
parleremo di sistema d’interdipendenza.» (Boudon 1980, p. 79-81 passim)
3.2.2. una conclusione ampia: «I sistemi di interdipendenza sono spesso caratterizzati dal fatto che
le azioni compiute dagli agenti generano dei fenomeni collettivi contrari alla volontà degli agenti
stessi. […] Chiameremo in seguito questo tipo di effetti «effetti di aggregazione» o «emergenti».
Un effetto di aggregazione o effetto emergente è quindi tale quando non è esplicitamente cercato
dagli agenti del sistema, ma risulta dalla loro situazione d’interdipendenza.» (Boudon 1980, ivi)
L’osservazione sociologia ispirata alle linee di una fenomenologia empirico-descrittiva assume
come eventi sociali di lettura e di definizione le interrelazioni, per lo più spontanee e irriflesso, che
si collocano oltre i rapporti definiti e programmati nei ruoli funzionali di un processo produttivo e
comunque gestionale. Il metodo descrittivo fenomenologico evidenzia interdipendenze, coglie attori
aggregati in forma di movimenti e dotati di indubbia consapevolezza del proprio sentire
rivendicativo, civile, politico o, anche solo corporativo, senza la pretesa di mettere a causa dei
fenomeni sociali e politici, tanto meno della “storia”, soggetti collettivi programmati come si diceva
dei soggetti quali la classe, con la necessaria “coscienza di classe”, lo Stato e i suoi programmi di
governo. Questi ultimi (o analoghi) non sono assenti, ma non sono attori necessariamente primari di
una società scoperta, letta e valorizzata nella sua complessità. La società pensata secondo le
categorie dell’ordine e dell’organismo si rivela essere un progetto politico “esterno”; lascito della
concezione della scienza formulata dall’età moderna in termini di ordine sistematico e di dominio –
controllo – potere dell’uomo sulla materia; modello veicolato nelle scienze sociali dalla filosofia del
positivismo. Si tratta di un modello che esprime un progetto, da verificare nella sua fattibilità,
opportunità e da tenere sotto controllo nella sua attuazione. Non può diventare la definizione della
società; se così avviene si mostra incapace di avvertire le dinamiche sociali e di leggere quella realtà
di cui intende e proclama di essere espressione, gestione e progetto.
3.3. il gusto: un nuovo criterio di orientamento sociale
la critica sociale del gusto o proposta di criteri, di carattere fenomenologico per l’orientamento, la
catalogazione, la distinzione sociologica.
3.3.1 Rilevamento fenomenologico sociale del gusto. L’analisi delle scelte e delle preferenze
proprie dei diversi soggetti sociali può ricevere un nuovo impulso dallo studio empirico delle
reazioni che, con costanza, gli individui manifestano di fronte ai prodotti culturali e artistici. Una
simile indagine, presentata analiticamente da Pierre Bourdieu, nell’opera La distinzione. Critica
sociale del gusto, permette di cogliere modalità di comportamento omogenee trasversali ai gruppi
sociali che solitamente vengono individuati, distinti e contrapposti tra loro quando vengono
considerati e definiti sulla base dei ruoli professionali e delle funzioni sociali. La scelta di tale
metodo fenomenologico si basa sulla seguente convinzione: «in un sistema strutturato di gusti,
nell’adozione di uno specifico stile di vita, si ritrova in forma trasfigurata la realtà delle condizioni
materiali di esistenza proprie delle diverse classi sociali.» Vengono dunque menzionate con le
caratteristiche della professione che per tradizione le contraddistingue ma, attraverso l’analisi del
gusto artistico, si trovano ad essere ravvicinati in modo insolito.
«…di tutti gli oggetti offerti alle scelte dei consumatori, non ne esistono di più classificanti delle
opere d’arte legittime; le quali, essendo globalmente distintive, permettono di produrre dei distinguo
all’infinito, grazie al gioco delle divisioni e delle suddivisioni in generi, epoche, maniere, autori,
ecc. Nell’universo dei gusti particolari, che può rigenerarsi attraverso successive ripartizioni, si
possono in tal modo distinguere, attenendosi alle opposizioni principali, tre universi di gusti che,
grosso modo, corrispondono a tre livelli scolastici ed a tre classi sociali: il gusto legittimo, cioè il
gusto per le opere legittime, che in questo caso sono rappresentate dal clavicembalo ben temperato,
dall’Arte della fuga, dal Concerto per la mano sinistra (o, nel campo della pittura, da Bruegel o da
Goya) ed alle quali gli esteti più sicuri possono associare le più legittime delle opere in via di
legittimazione, cinema, jazz o persino canzoni (come, in questo caso, Léo Ferré, Jacques Douai)
aumenta con il livello scolastico e raggiunge la frequenza più alta tra le frazioni della classe
dominane più ricche di capitale scolastico; il gusto «medio», che riunisce le opere minori delle arti
maggiori come in questo caso la Rapsodia in blu, la Rapsodia, ungherese (o, anche, in pittura,
Utrillo, Buffet e persino Renoir) e le opere maggiori delle arti minori, come, nel campo della
canzone, Jacques Brel e Gilbert Bécaud — è più frequente tra le classi medie che non fra le classi
popolari o le frazioni «intellettuali» della classe dominante; infine, il gusto «popolare» —
rappresentato in questo caso dalla cosiddetta musica «leggera», o, dalla musica colta deprezzata
dalla divulgazione come il Danubio blu, la Traviata, l’Arlesiana e soprattutto da canzoni
completamente prive di ambizioni o di pretese artistiche, come quelle di Mariano, di Guétary o di
Petula Clark — raggiunge la sua massima frequenza tra le classi popolari e varia in ragione inversa
il capitale scolastico (il che spiega come mai esso sia un po’ più frequente tra gli industriali ed i
grossi commercianti, e persino tra i quadri superiori, che non tra i maestri elementari e gli operatori
culturali.» (Bourdieu Pierre, La distinzione. Critica sociale del gusto, il Mulino, Bologna 1995, pp.
15-17)
Il livello definito “clavicembalo ben temperato” registra la distanza tra operai, artigiani,
commercianti e i docenti di scuola secondaria e dell’università; ma vede vicini nell’apprezzamento
operai e industriali e grossi commercianti. Il livello definito “rapsodia in blu” mette d’accordo un
po’ tutti (è definito da Bourdieu “il gusto medio”): operai, artigiani, industriali, professori… Il
livello definito “Danubio blu” soddisfa operai, artigiani, commercianti e anche industriali, è distante
da professori specializzati. In conclusione: il gusto sociale accomuna, inaspettatamente, realtà
sociali finora considerate separate e quasi opposte.
3.3.1.1. Processi paralleli e validità di un metodo di lettura orientamento e classificazione. Le tesi di
Bourdieu richiamano studi caratterizzati da analoga impostazione. Va forse menzionata un’origine:
il ruolo della musica nella classificazione dei livelli sociali e della loro educazione nella Repubblica
di Platone. In tempi recenti: l’accostamento tra la struttura di un testo musicale (inteso secondo
genere, partitura, esecuzione e ascolto) con i livelli sociali di partecipazione alla musica (nei suoi
vari aspetti: genere, spartito, esecuzione, fruizione) e la conseguente individuazione (sociologica
descrittiva catalogatoria) di gruppi sociali e del loro sentimento, percezione di appartenenza
collettiva è quanto compare negli studi di Halbwachs sulla “memoria collettiva nei musicisti”
(Halbwachs Maurice 1968 La memoria collettiva, edizione Unicopli, Milano 1987) e in quelli di
Adorno sulla sociologia della musica.
L’analisi fenomenologica della sensibilità estetica si presenta come strumento di classificazione
sociale e, soprattutto, di definizione del gusto e del gusto popolare. Si tratta di un dato che
costituisce la base materiale del comunicare in ogni suo contesto, non solo culturale, ma anche e
soprattutto commerciale (propagandistico), politico (persuasivo / populistico / demagogico)
In particolare si può prendere atto dell’emergere di una nuova trasversalità (come accade nel livello
“Rapsodia in blu”), definito di conseguenza livello “gusto medio”. I tratti salienti del gusto
popolare, debitamente colti e rafforzati dalla produzione di materiale culturale destinato, per
definizione, ad un vasto pubblico, permettono di individuare un nuovo soggetto sociale presente
nelle società informate da diffusi mezzi di comunicazione sociale quotidiana. Il gusto popolare:
individua cioè un soggetto storico omogeneo nella percezione estetico-sensibile, nelle attese
politiche, nelle valutazioni morali. Si tratta di una omogeneità che passa al di sopra delle classiche
divisioni sociali secondo ruoli professionali (operai, impiegati, imprenditori ecc.), e che attesta la
presenza di un nuovo (sensibile, mobile e plasmabile) fruitore e interlocutore dei mezzi di
comunicazione sociale.
3.3.1.2. L’analisi del gusto si candida ad essere un interessante catalogatore sociale in forza della
natura non finalizzata e non pratica, non legata all’utile ma disinteressata, della fruizione estetica.
La sua rilevanza è dovuta alla capacità di misurare quanta parte, in quali occasioni e per quanto
tempo (in una durata definita) la percezione estetica, non pratica o non meramente pratica,
caratterizza l’esperienza soggettiva e, talora, pur in contesto pratico, prende il sopravvento o
costituisce un secondo sguardo nei confronti della percezione funzionale pratica; come può
accadere per esempio quando un oggetto d’uso pratico è costruito e mostrato secondo forme e modi
proprio di un oggetto estetico (una teiera, una cavatappi, un portaombrelli, una suoneria telefonica,
una porta di casa, una cucina … di notevole interesse storico sociologico diventa lo studio del
variare delle forme dell’arredo quotidiano, dei mobili, del quadri, dei lampadari nelle case dette
“popolari” allo scopo non solo di definire il gusto, ma di cogliere le trasformazioni economiche e
culturali della società e l’andamento delle distinzioni e delle distanze sociali).
«Se, come osserva Erwin Panofsky, l’opera d’arte è proprio ciò che esige di venir percepita secondo
una intenzione estetica e se, d’altra parte, qualsiasi oggetto, sia naturale che artificiale, può venir
percepito secondo un’intenzione estetica, come è possibile sottrarsi alla conclusione che è proprio
l’intenzione estetica che «fa» l’opera d’arte o, con una trasposizione della formula di Saussure, che
è il punto di vista estetico che crea l’oggetto estetico? Per uscire da questo circolo, Panofsky deve
conferire all’opera d’arte una «intenzione» nel senso della scolastica; una percezione
esclusivamente «pratica» contraddice questa intenzione oggettiva, esattamente come una percezione
estetica rappresenterebbe in qualche modo una specie di negazione pratica dell’intenzione di un
segnale, per esempio di un semaforo, che esige una risposta «pratica», cioè premere il freno. In tal
modo, all’interno della classe degli oggetti prodotti, anch’essi definiti in contrapposizione agli
oggetti naturali, la classe degli oggetti artistici si dovrebbe definire grazie al fatto di esigere di venir
percepita secondo una intenzione propriamente estetica, cioè nella sua forma, e non nella sua
funzione. Ma come rendere operativa una definizione del genere? Lo stesso Panofsky osserva che è
praticamente impossibile determinare in modo scientifico il momento in cui un oggetto prodotto
diventa un’opera d’arte, cioè qual è il momento in cui la forma prende il sopravvento sulla
funzione: «Quando scrivo ad un amico per invitarlo a cena, la mia lettera è innanzitutto uno
strumento di comunicazione; ma più io presto attenzione alla forma della mia scrittura e più essa
tende a diventare un’opera di calligrafia; più presto attenzione alla forma del mio modo di
esprimermi, e più essa tende a diventare un’opera letteraria o poetica.» (Bourdieu 1995, 29)
3.3.1.3. L’attenzione alla distinzione tra forma e funzione. Una rilevanza notevole viene riservata,
come già notato, alla distinzione tra la forma e la funzione nella definizione dell’atteggiamento
estetico e nella sua catalogazione. Le due componenti storiche di una produzione artistica la forma e
la funzione, stanno alla base di un diverso atteggiamento di fruizione e di produzione dell’opera
d’arte. La priorità data alla forma (che rispetta la natura propriamente estetica dell’opera d’arte, fine
a se stessa) o alla funzione (che valuta la natura e la destinazione sociale dell’opera d’arte:
commerciale, morale, politica, religiosa ecc.), oltre a segnalare il modo specifico con cui un’epoca
si pone di fronte al prodotto artistico, diviene un utile classificatore generale della cultura. Va
sottolineato il peso culturale della distinzione tra mezzi – fini: tra realtà che si giustificano in quanto
mezzi e quindi finalizzate ad altro e realtà che sono fini e si caratterizzano come fine a sé. Una
distinzione che regge la consapevolezza morale che ciò che è fine a sé non può mai essere
considerato mezzo; che spinge ogni cultura a riempire concretamente la categoria di ciò che è fine a
sé e non mezzo (come, nell’universo kantiano, l’umanità, la persona, richiamate nella seconda
enunciazione dell’imperativo categorico, come, nella consapevolezza ecologica recente, l’ambiente,
la natura …).
3.4. L’estetica popolare e la sua logica comportamentale.
«L’«estetica» popolare. È proprio come se l’«estetica popolare» si fondasse sull’affermazione della
continuità tra arte e vita, che implica la subordinazione della forma alla funzione o, se preferiamo,
sul rifiuto di quel rifiuto che costituisce il principio stesso dell’estetica colta, di quel taglio che
separa nettamente le attitudini ordinarie dall’atteggiamento estetico in senso proprio. L’ostilità delle
classi popolari e delle frazioni meno ricche di capitale culturale delle classi medie nei confronti di
qualsiasi tipo di ricerca formale si fa valere tanto in campo teatrale che in materia di pittura o, in
modo ancora più netto perché la loro legittimità è minore, in materia di fotografia o di cinema. A
teatro, come al cinema, il pubblico popolare si appassiona agli intrecci logicamente e
cronologicamente indirizzati verso un happy end e si «riconosce» di più nelle situazioni è nei
personaggi disegnati in modo semplice, che non nelle figure é nelle azioni ambigue e simboliche o
nei problemi enigmatici del teatro secondo Il teatro e il suo doppio; per non parlare dell’inesistente
esistenza dei pietosi «eroi» alla Beckett o delle conversazioni stranamente banali o
imperturbabilmente assurde alla Pinter. All’origine dì queste reticenze e di questi rifiuti non c’è solo
una mancanza di familiarità, ma anche una profonda attesa di partecipazione, che la ricerca formale
sistematicamente delude, soprattutto quando, rifiutando di prestarsi alle seduzioni «volgari» di
un’arte che si basa sull’illusione, la finzione teatrale denuncia se stessa, come accade in tutte le
forme di teatro nel teatro, di cui Pirandello offre il paradigma nei drammi che mettono in scena la
rappresentazione di una rappresentazione impossibile, Sei personaggi in cerca d’autore, Così è (se
vi pare) e Questa sera si recita a soggetto, e di cui Génet svela la formula del prologo dei Nigres:
«Avremo inoltre la gentilezza, appresa appunto da voi, di rendere impossibile ogni comunicazione.
Con i nostri fasti, le nostre affettazioni, la nostra insolenza (perché siamo anche commedianti)
cercheremo di aumentare la distanza che fin dall’origine e ci divide». Il desiderio di entrare nel
gioco, identificandosi nelle gioie o nei dolori dei personaggi, interessandosi al loro destino,
abbracciando le loro speranze e la loro causa, la loro giusta causa, vivendo la loro vita, si basa su
una specie di investimento, su una sorta di partito preso per l’«ingenuità», la spontaneità, la
credulità da pubblico alla buona («si andiamo per divertirci»), che tende ad accettare le ricerche
formali e gli effetti propriamente artistici solo nella misura in cui si fanno dimenticare e non
finiscono invece per ostacolare la percezione di ciò che costituisce la sostanza stessa dell’opera.
[…] La ricerca formale, che in letteratura o nel teatro porta all’oscurità, rappresenta agli occhi del
pubblico popolare un indice in una cosa che a volte viene percepita come volontà di tenere a
distanza il non iniziato o, per usare le parole di un intervistato a proposito di certe trasmissioni
culturali della televisione, di parlare agli iniziati «sopra la testa del pubblico». È proprio come se il
pubblico popolare capisse in modo confuso ciò che è implicitamente sottinteso nel fatto di mettere
in forma, di mettere delle forme, nell’arte come nella vita; vale a dire una specie di censura del
contenuto espressivo, di ciò che irrompe nell’espressività della parlata popolare, insieme ad una
presa di distanza inerente alla stessa freddezza calcolata di ogni ricerca formale, ad un rifiuto di
comunicare che si nasconde nel cuore tesso della comunicazione che nasconde e rifiuta proprio ciò
che sembra offrire; esattamente come accade nelle buone creanze borghesi, il cui impeccabile
formalismo rappresenta una messa in guardia permanente contro la tentazione della familiarità. Al
contrario, lo spettacolo popolare è quello che produce in modo inseparabile la partecipazione
individuale dello spettatore allo spettacolo e la partecipazione collettiva alla festa di cui lo
spettacolo costituisce l’occasione. È per questo che, con le manifestazioni che suscitano e con il
dispiegamento di fasto spettacolare che offrono (si pensi al music-haIl, all’operetta o al film
spettacolare) la fantasmagoria degli scenari l’ardore degli attori, lo sfavillio dei costumi, il trasporto
della musica, la vivacità dell’azione degli spettacoli popolari danno soddisfazione, come tutte le
forme di comico soprattutto quelle che producono i loro effetti con la parodia o con la satira dei
«grandi» (imitatori, chansonniers, ecc.), al gusto ed al senso della festa, del parlare sboccato,
dello scherzo sguaiato, che hanno un potere liberatorio mettendo a testa in giù il mondo sociale,
rovesciando le convenzioni e le convenienze. […] Per questo, non c’è nulla che distingua in modo
altrettanto rigoroso le diverse classi dell’atteggiamento oggettivamente richiesto dal consumo
legittimo delle opere legittime, cioè della capacità di adottare un punto di vista propriamente
estetico su oggetti già costituiti in forma estetica e quindi designati per essere ammirati da coloro
che hanno imparato a riconoscere i segni di ciò che è degno di ammirazione e, cosa ancor più rara,
della capacità di costituire in forma estetica oggetti qualsiasi o addirittura «volgari» (perché
acquisiti, in forma estetica o no, al «volgare») o di applicare i principi di un’estetica «pura» nelle
scelte più ordinarie, per esempio in materia di cucina, di abbigliamento, o di arredamento.»
(Bourdieu 1995, 34-39 passim)
3.4.1. La critica del gusto illustrata e applicata da Bourdieu diventa prassi di indagine diffusa per
individuare aree di comunicazione sociale. La divisione della società in classi sulla base delle
professioni sembra essere vincolata, almeno per vizio di origine, a una visione politica ed
economica della società dominata dalla “lotta di classe” per i diritti e per l’uguaglianza. La
catalogazione del sociale secondo livelli di orientamento e di consumo culturale (musica, pittura,
letteratura, film, libri… e poi il confronto con la professione) fa emergere le disomogeneità interne
alle classi definite per professione, spiega, ad esempio, scelte politiche definite “trasversali”
apparentemente sconcertanti, indica i livelli di comunicazione definiti secondo un utile target per
chi comunica, target destinato a sciogliersi e ricomporsi per aggregazioni diverse in rapporto al
variare del marketing (politico, commerciale, religioso, sportivo…)
3.5. come possibile conclusione applicativa: il ruolo della emozione nell’orientamento, nella
costituzione di nuclei sociali (già classi, forse ora “comunità” più o meno inconsapevoli) e nelle
scelte politiche (del marketing politico) (Cacciotto Marco 2011 Marketing politico. Come vincere le
elezioni e governare, il Mulino, Bologna; Sorice Michele 2011 La comunicazione politica, Carocci
editore, Roma)
«L’emozione e i desideri: nuove parole chiave. Dunque: demotivare da un lato, emozionare per
rimotivare dall’altro; de-socializzare da un lato, ri-socializzare (comunitarizzare) mediante la
moltiplicazione dei desideri dall’altro perché, come ha spiegato Pierre Bourdieu e come ammette
Bauman (e come aveva detto Foucault a proposito delle discipline aperte basate su piacere,
consumo e spettacolo), «la fabbricazione di nuovi desideri sta facendo il lavoro che un tempo
svolgeva la regolamentazione normativa, cosicché la pubblicità e la propaganda commerciale
possono prendere il posto un tempo occupato dal controllo di polizia» Z.Bauman, La solitudine del
cittadino globale, Feltrinelli, Milano 2008, p. 81» (Demichelis 2010, 96)
3.5.1. breve nota sul tema della comunicazione politica: tra il messaggio e la sua ricezione si
collocano più intermediazioni o diaframmi che fungono da selettori, filtri; in particolare i contesti (i
frame) e i leader opinion; si tratta di intermediazioni che decidono del senso del messaggio e della
sua interpretazione comprensiva e operativa.
«Costruire il messaggio. Alla base di una campagna elettorale di successo c’è sempre un messaggio
efficace. Il messaggio non è semplicemente un insieme di poche parole, ripetute frequentemente,
ma molto di più: è l’argomentazione alla base della campagna. Si tratta dell’argomento centrale, la
ragione per la quale gli elettori dovrebbero scegliere un candidato e non uno degli avversari.
Nella preparazione del messaggio va prestata particolare attenzione poiché non sempre il messaggio
diffuso è quello percepito. Il pubblico, infatti, è composto da individui che vivono in contesti di
relazione differenti e il messaggio dovrà passare non solo attraverso i filtri personali (storia, cultura,
convinzioni), ma anche attraverso le reti sociali e, spesso, la mediazione di terze parti (parenti,
conoscenti, amici). L’interpretazione di terze parti può modificare o distorcere quello che per
l’emittente del messaggio doveva essere il significato. Ogni messaggio, quindi, è soggetto a
interpretazioni e reazioni emotive da parte delle persone che lo ricevono.» (Cacciotto 2011, 108)
3.5.2. il marketing politico. «Marketing e politica non sono termini tradizionalmente associati.
Questo non ha impedito negli ultimi due decenni un uso crescente di definizioni derivanti dalla
comunicazione pubblicitaria e dal marketing, che ha portato a paragonare partiti e candidati a veri e
propri prodotti. […] il settore di intervento e di studio del marketing politico va, invece, oltre le
attività di comunicazione, relazioni pubbliche e campagna elettorale: si occupa di come viene creato
il «prodotto» politico, del comportamento di politici e partiti, della loro offerta e di come questa
risponda ai bisogni e ai desideri dei cittadini.» (Cacciotto 2011, 37)
3.5.3. gusto, emotività e gestione della comunicazione politica e del consenso. «Le leve del
consenso: razionalità o emozione? (le note sono tratta da Cacciotto 2011, 138-141)
3.5.3.1. Programma e immagine vengono spesso contrapposti come se la valutazione razionale
dell’operato e delle proposte politiche fosse alternativa a una scelta legata a elementi emotivi. Nelle
ricerche sul comportamento elettorale possono essere individuati tre paradigmi interpretativi
[Campus 2000]: l’approccio sociologico (o Columbia approach), l’approccio psicologico (o
Michigan approach) e l’approccio economico (o Economic approach).
3.5.3.1.1. L’approccio sociologico ha origine con le ricerche di Lazarsfeld, Berelson e Gaudet
[1944; 1954] sulle elezioni presidenziali statunitensi degli anni Quaranta. Le preferenze politiche
vengono ricondotte alle caratteristiche sociodemografiche degli elettori (in modo particolare a status
economico e appartenenza etnica, che include come sottocategoria la fede religiosa). Il consenso è
legato al collegamento dei partiti a una classe sociale piuttosto che al perseguimento sistematico
degli interessi dei gruppi sociali rappresentati [Baldassarri 2005]. La campagna elettorale ha la
funzione di riattivare predisposizioni latenti e preferenze preesistenti, oltre che di risvegliare
l’interesse per la politica.
3.5.3.1.2. L’approccio psicologico, legato al lavoro di Campbell e colleghi [1960], motiva il
comportamento attraverso meccanismi psicologici attivati durante la fase di socializzazione (in
particolare nel nucleo familiare e nei gruppi sociale di appartenenza). Si crea così un legame
affettivo nei confronti di un partito che fa da filtro rispetto a qualsiasi valutazione riguardante
candidati o politiche.
3.5.3.1.3. L’approccio economico applica il modello della scelta razionale al comportamento di
voto [Downs 1957]. Elettori e partiti si muovono nel medesimo spazio ideologico e l’elettore
razionale sceglie il partito più vicino ai suoi interessi quello meglio in grado di garantirgli dei
vantaggi. 138
La difficoltà crescente nel predire con efficacia il comportamento elettorale attraverso indicatori
quali classe sociale d’appartenenza, pratica religiosa e regione di residenza [Itanes 2006] ha spinto a
cercare nuovi approcci che tengano conto del comportamento individuale e non solamente
collettivo: studi psicolinguistici, applicazione delle neuroscienze alla politica, classificazione
individuale degli elettori in base agli stili di vita.
3.5.3.2. Il ruolo delle emozioni è stato recentemente oggetto di diversi studi e convegni [Brader
2006; Westen 2007], che suggeriscono di considerare, nelle scelte di voto, la sfera emozionale come
formidabile scorciatoia cognitiva per gli elettori [Campus 2008].
3.5.3.2.1. Per comprendere come gli elettori «processano» le informazioni e la comunicazione
politica conviene partire, quindi, dal funzionamento del cervello [Westen 2007; trad. it. 2008, 88]:
«la tendenza a vedere solo ciò che vogliamo riflette un effetto secondario accidentale
dell’evoluzione del nostro cervello. Con le idee ci comportiamo come con le cose del mondo che ci
circonda, avvicinandole o evitandole a causa dei sentimenti che provocano, a seconda delle
associazioni emotive a esse collegate. Gli stessi meccanismi che forniscono una bussola per guidare
il nostro comportamento in direzioni adattive funzionano come calamità dell’autoinganno, della
razionalizzazione e di quel genere di «ragionamento» di parte che preclude a circa l’80% della
popolazione, compresi gli elettori più avveduti, qualsiasi discorso razionale intorno a questioni
politiche.»
Dal punto di vista delle neuroscienze, più un messaggio è puramente razionale, meno è probabile
che attivi i circuiti neurali che presiedono al comportamento di voto: per questo motivo Westen
sostiene che difficilmente prestiamo attenzione ad argomenti che non siano in grado di suscitare in
noi interesse, paura, rabbia o disprezzo. Allo stesso modo sia i leader sia i programmi politici
devono avere implicazioni emotive per noi o per le persone che ci sono care.
3.5.3.2.2. La comunicazione e i discorsi più efficaci sono, quindi, quelli che combinano elementi
emotivi ed elementi ed cognitivi. 139
3.5.3.2.3. Secondo Lakoff [2004] le persone ragionano in base a un frame e votano più per
affermare o difendere una propria identità che per interesse e calcolo. Gli elettori votano
principalmente per la propria identità, per i propri valori, per la persona con cui si identificano.
Questo non vuol dire che a volte non possano identificarsi con il proprio interesse. Ma tutti votano
per la propria identità. E solo se identità e interesse coincidono, voteranno per il candidato che li
rappresenta. Per Lakoff «è un grave errore presumere che le persone votino sempre nel proprio
interesse» [2004; trad. it. 2006, 391. Per Westen [2007; trad. it. 2008, 114-115] «le questioni
politiche che dominano le elezioni tendono alla fine a ridursi agli interessi degli elettori e ai loro
valori». Nel primo caso si tratta della risposta a domande come: «questa cosa va a vantaggio mio e
della mia famiglia?», nel secondo a domande come: «per me questa cosa è giusta?». Le campagne
elettorali di successo sono quelle in grado di attivare le emozioni latenti nei due campi degli
interessi e dei valori. Nel seggio elettorale i valori tendono a sopraffare l’interesse e questo avviene
poiché le questioni di valore richiedono pochi passaggi per diventare questioni emotive. I sentimenti
che gli elettori provano nei confronti di un candidato o di un partito possono quindi diventare un
elemento predittivo dell’esito elettorale [ibidem, 27]: «nelle giuste circostanze anche gli elettori che
non si interessano molto di politica — e sono di solito quelli che si cerca di conquistare in periodo
elettorale — rifletteranno su ciò che hanno udito e considereranno le differenze tra due principi o
due posizioni e decideranno anche solo per il tempo necessario a raggiungere una conclusione
emotiva (ad esempio, «quel tipo non mi piace proprio»). Ma le giuste circostanze hanno sempre un
carattere emotivo.
La gestione dei sentimenti positivi e negativi rappresenta l’elemento più importante nella strategia
di una 140 campagna politica che, per essere efficace, deve porsi due obiettivi principali: il primo
riguarda il partito, il secondo il candidato.
Il partito e i suoi principi devono essere presentati modo da risultare emotivamente convincenti. Per
raggiungere questo primo obiettivo è necessario un racconto coerente sul proprio partito e sulle
convinzioni dei suoi membri e, allo stesso tempo, occorre presentare l’altro partito e i suoi valori in
modi che compromettano la sua capacità di suscitare risonanze emotive negli elettori. […]
L’elemento più sorprendente dello studio di Brader è legato alla scoperta che più sensibili ai
messaggi emotivi sono gli elettori più informati e «sofisticati» e non, come spesso viene ritenuto,
gli elettori meno istruiti e meno attenti alla politica.»
4. emergenze sociali dell’età contemporanea tra omologazioni, tempo liberato
4.1. processi economici e sociali di omologazione.
Processi di omologazione (omogeneizzazione) sociale. Poichè il sistema sociale fondato sulla
produzione industriale si mostra capace di trasformare in merce (in bene commerciabile,
“mercificazione”) qualsiasi aspetto della natura e dell’uomo, a partire dai suoi prodotti (non solo
quelli materiale, ma anche culturali), la regola di commercio, che lega il proprio profitto alla
diffusione allargata dei consumi di prodotti seriali, impone di uniformare le abitudini e i “consumi”
culturali della società. L’omologazione dei consumi culturali, delle abitudini di pensiero e degli stili
di vita trasforma il popolo in un’entità indistinta e magmatica indicata, demagogicamente, con il
termine “la gente”. Una simile entità, sociologicamente non definibile, ma considerata e citata come
realtà e soggetto operante, si pone all’origine, di un procedimento sociale circolare (economico,
politico e culturale) ben definito: la società, considerata come pubblico, cioè come soggetto
commerciale, è il destinatario di consumi standardizzati; ma, successivamente, dalle abitudini
indotte del pubblico si ricava (attraverso ricorrenti “sondaggi”) la legittimazione a fornire prodotti
standard in termini di merce e di discorsi.
4.2. tempo liberato (tempo libero, tempo meno occupato, tempo disoccupato… )
Tempo disoccupato e tempo liberato. In fase di decollo industriale e di crescita demografica, la
meccanizzazione dei processi produttivi e l’estendersi dell’area di mercato si traducono in domanda
di manodopera disponibile a fornire lavoro subordinato. La produzione industriale a tecnologia
avanzata tende invece a liberare manodopera e a cambiare il tempo storico, il tempo vissuto, dei
soggetti produttori. L’attuale dinamica di produzione industriale mette dunque in moto un doppio e
antitetico processo di mutamento del tempo-lavoro.
4.2.1. Il primo dato, quello più evidente, è la “liberazione” della manodopera; il sistema economico
non riesce a comporre investimento con occupazioni; anzi i due fattori, in crescita, sembrano
escludersi sempre più. Gli effetti di un simile processo non sono soltanto sociali: socialmente si
creano nuove povertà e si accentua il divario tra ricchezza e povertà, economicamente, per effetto
della disoccupazione, si riduce l’area di mercato e conseguentemente le condizioni di profitto.
In generale . «Le società ricche si stanno muovendo, ciascuna in misura diversa, verso un modello
di società tipico del terzo mondo. Si tratta di società radicalmente divise in due livelli, caratterizzate
cioè da isole di grande privilegio nel mezzo dì un mare di miseria, un enorme surplus di
popolazione che non contribuisce alla creazione del profitto e quindi, secondo il sistema di valori
predominante, non ha alcun diritto. La minaccia che una democrazia realmente funzionante
rappresenta per questo sistema si è ridotta perchè il potere si è concentrato in istituzioni che sono
totalitarie nella loro struttura interna; e sono istituzioni che non rispondono del loro operato, in
quanto agiscono prevalentemente in segreto e sono in larga misura libere dal coinvolgimento del
pubblico, che magari non è neppure consapevole della loro esistenza.» Chomsky Noam, Il potere
dei media, Vallecchi, Firenze 1994, p.7
Amartya Sen: «L’etica del lavoro — ovvero la moralità di avere un posto di lavoro o l’immoralità
di perderlo — è radicata nel nostro patrimonio culturale. Ce ne parla la Bibbia, ce ne parla Adam
Smith e ce ne parlano studiosi e ricercatori contemporanei.» Morti sul lavoro… morti per senza
lavoro: il rapporto tra morte e lavoro: «…la mortalità, fra i non occupati del mondo, da NewYork a
Calcutta, è molto più alta che fra gli occupati. Al convegno abbiamo presentato tabelle che non
lasciano dubbi. Non fa differenza il primo mondo o il terzo mondo. Fa differenza il lavoro. Teniamo
in mente questa regola che ci sembra primitiva, ci sembra di altri secoli, e invece è ancora al centro
di tutto, politica, economia, sviluppo, speranza: perdere il lavoro vuol dire morire. O almeno il
rischio diventa immensamente più grande». […] «Un economista rigoroso dovrebbe dire che non è
possibile [conciliare una grande innovazione delle imprese e un’ondata di assunzione di
manodopera]. Se non altro per la vecchia regola che le buone notizie del mercato dei capitali sono
cattive notizie per i lavoratori e viceversa. Uno dei punti delicati è il rapporto fra pieno impiego e
inflazione. In America è una tale ossessione che al minimo aumento dell’occupazione, la Federal
Reserve corre a ritoccare in alto il costo del denaro per impedire balzi troppo forti della macchina
economica. Diciamo che si tratta di una equazione a molte incognite.» […] Sulle ondate di
immigrazione. Quella paura ha un fondamento? «Gli immigranti in genere sono giovani, soli e
adatti al lavoro. Per questa ragione l’immigrazione, arginata disperatamente, e a volte goffamente,
dai governi, è incoraggiata da una mano invisibile delle imprese che li vede volentieri in moltissimi
posti di lavoro disponibili e non desiderati. Basta vedere le statistiche. Gli immigranti lavorano
presto, lavorano tutti, non cadono quasi mai nella mendicità e — poiché sono giovani e abili —
hanno bisogno di cure mediche in proporzione modesta rispetto alla media della popolazione,
Diciamo in modo esplicito: costano poco e rendono.» Qual è la conclusione? il filosofo morale ne
offre una semplice all’economista: «L’economia è un motore. Se ne possono conoscere tutti i pezzi.
Ma non va da solo. È una questione di responsabilità. È una questione di scelte. È una questione di
guida.» Furio Colombo, Il nostro prossimo mondo (intervista ad Amartya Sen), articolo 30 giugno
1994.
4.2.2. Il secondo dato, evidenziabile in prospettiva, è costituito dall’emergere progressivo del
“tempo libero” (tempo liberato, riduzione del tempo lavoro, libero da lavoro subordinato o coatto).
Si tratta di una liberazione che si configura anche come emergenza e come opportunità.
4.2.2.1. Opportunità di ripensamento del ruolo del lavoro in rapporto alla promozione di iniziative e
scelte individuali tutte ispirate alla creatività, a liberare l’immaginazione al di fuori di ogni logica di
subordinazione e di profitto.
4.2.2.2. Ma si tratta anche di una opportunità che crea spazi (e ne è a sua volta circolarmente
determinata) per il formarsi di una nuova area commerciale (e quindi di produzione e di profitto)
per la gestione del tempo liberato in termini di nuovo stili di vita (hobby, viaggi, salute, cultura …).
4.2.2.3. Sullo sfondo l’antica utopia tecnologia di un mondo liberato dal lavoro inteso come
condanna e fatica; utopia che, pur facilmente predisposta a prevedibili ironie e critiche, ha sempre
avuto lo scopo non tanto di fornire un progetto di società in reale e immediata costruzione ma di
suggerire un ripensamento complessivo del sistema economico attraverso la sua contestualizzazione
sociale ed etica generale e ideale.
«Iniziamo con un famoso enunciato di Marx: «Di fatto, il regno della libertà comincia soltanto là
dove cessa il lavoro determinato dalla necessità e dalla finalità esterna; si trova quindi per sua
natura oltre la sfera della produzione materiale vera e propria». Le parole chiave sono libertà e
lavoro, in quanto la libertà, garantita dal «regno della libertà», è fra l’altro libertà dal lavoro, ovvero
dalla sua necessità, quindi libertà dal lavoro in vista di quelle finalità esterne che sono le sole a
rendere il lavoro necessario; e poi in quanto la liberazione da tale necessità costituisce la prima di
tutte le libertà, a partire dalla quale soltanto hanno inizio le altre libertà del «regno» — e il cui
obiettivo ultimo è a sua volta (secondo un altro enunciato di Marx) «lo sviluppo [in altri passi lo
scatenamento] delle potenzialità della natura umana». Tale sviluppo o scatenamento può aver luogo
soltanto nell’otium: non in quello occasionale, dovuto all’interruzione delle fatiche lavorative, ma
nell’otium quale forma di vita permanente e predominante. […] Si tratterà quindi di un lavoro
senza scopo, libero anche nel senso di privo di finalità, per mezzo del quale dovrà essere soddisfatto
il nuovo bisogno di «lavoro fine a se stesso»; ci si può in effetti immaginare che diventerà per molti
e per i migliori «il bisogno vitale primario», già soltanto per sfuggire alla noia mortale
dell’inattività. Proprio a questo scopo si dovrebbero inventare simili lavori fini a se stessi (oppure li
si dovrebbe riesumare dalle occupazioni manuali del passato pre-industriale). Ha origine così il
paradosso secondo cui il bisogno di lavoro — e non del suo prodotto! — diventa forse il bisogno
più difficile da soddisfare fra tutti quelli di cui si fa carico la nuova società, nella sua aspirazione ad
assicurare «a ciascuno» il soddisfacimento dei «propri » bisogni.» Hans Jonas, Il principio
responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1993, 248-249).
«“Proletari di tutto il mondo divertitevi”. O almeno smettetela di piangere. Il lavoro faticoso,
alienato, sta per finire. È arrivato il tempo del “non lavoro”. Lo gridano a gran voce sociologi,
filosofi, ecologisti. E forniscono dati, elaborano teorie, scatenano fantasie. […] Postmoderni,
postindustriali, postmarxisti, i filosofi del «non lavoro» sostengono alcune idee audaci e
anticonformiste.
Intanto non bisogna avere paura di redistribuire il lavoro, quello che c’è, senza pensare di
aumentarlo. Nel mondo c’è già abbastanza ricchezza. Wolfang Sachs, ecologo radicale, lancia una
provocazione ancora più profonda. Il lavoro non produce più ricchezza anzi la distrugge e crea
degrado. Sotto accusa questa volta non solo Marx o il cristianesimo ma anche Adam Smith secondo
cui il lavoro è l’unica insostituibile fonte di ricchezza, di ricchezza collettiva. E la felicità dipende
da questa. Non è più così, afferma Sachs, perchè la produzione di merci ormai è dannosa per
l’ambiente e per l’uomo e la felicità dipende semmai dal suo ridimensionamento. Ed ecco che dalla
filosofia del non lavoro emerge una società, più sobria, più austera, meno consumista. In cui
l’edonismo non sta nella merce e nel suo possesso, ma all’opposto nel godimento della natura, dei
rapporti con gli altri. Insomma una società in cui regni «l’abbondanza frugale» per usare il termine
degli autori della Revolution du temps choisi. «Una civilizzazione - scriveva qualche tempo fa Groz
su Le monde diplomatique—che garantendo a tutti un’autonomia ed una sicurezza esistenziale
crescenti elimini i consumi pletorici, fonte di mancanza di tempo, di nota, di furti e di frustrazioni».
Fine completa del mondo della produzione e della economia di mercato? Non proprio. Piuttosto
nascita ai una società duale o bipolare in cui il mercato, il tempo della produzione, sia
ridimensionato a favore delle attività dell’individuo, del suo tempo e dei suoi tempi e, perchè no?
dell’ozio.
In questo mondo diverso, il cambiamento più profondo riguarda ovviamente l’individuo. È
possibile pensare ad un uomo per cui il lavoro non sia centrale, non sia fondativo della vita e
dell’identità?» Ritanna Armeni, Proletari di tutto il mondo divertitevi, articolo 16 giugno 1994.
4.3. Tempo a margine e tempo inutile.
La difficoltà del sistema, economico vigente ad assorbire e valorizzare le potenzialità produttive e
progettuali degli individui trova una evidente manifestazione in due fenomeni diffusi delle recenti
società metropolitane: gli “homeless”, gli “sprecati”.
4.3.1. La recente indagine sociologica si sofferma sui fenomeni metropolitani di povertà, e
solitudine degli “homeless”: stile di vita socialmente rilevante dal punto di vista non solo
economico (è infatti rivelatore delle finalità prime del sistema economico dominante), ma anche
etico e politico. Sulla scia dei cinici.
«“StreetWise”, “StreetWise”’, ripete in un angolo della North Michigan, quasi incurante del vento
freddo e tagliente dell’inverno di Chicago, la coraggiosa cantilena di un homeless che vende il
giornale dei senza dimora, comunicazione moderna e orgogliosa di una storia antica e drammatica.
Esperienza particolare, questa, realizzata da una parte di uomini e donne che, esterni ad ogni
processo associativo, trovano elemento di sostanza e presenza nel comunicare le forme, pur
disgregate, della propria esistenza. Essa evidenzia la strutturalità contraddittoria di una condizione
che per sua natura sembrerebbe dover essere temporanea, testimonianza di una dimensione sociale
arretrata, apparentemente in attesa solo di essere cancellata dall’inevitabile progresso e
dall’intervento del resto della società del benessere, ma in effetti stabilmente insediata nella realtà.
Una pubblicistica recente ha riportato l’attenzione sui temi soggettivi della mobilità, sulla scelta
della rottura dei legami e dell’annegare nel viaggio, come nella transitorietà dei rapporti, la propria
individualità. La strada, come il mare, tende a divenire in questo quadro il luogo che nega se stesso
come definizione di insediamento e come identificazione di vita e che viene valorizzato solo come
percorso da attraversare, nel quale dislocare la propria ansia di liberazione da quanto si manifesta
come insoddisfazione, disadattamento, difficoltà di relazione. Si è recuperata a questo proposito la
vicenda degli anni Sessanta, la beat generation, gli hippy, Dylan, Ginzberg e così via, coniugando le
loro pagine ed i loro motivi con la “necessità” di un cammino reso costantemente attuale dal
desiderio/esigenza di rompere ogni processo di formalizzazione esistenziale che tenderebbe a
rendere “normali”, a rafforzare l’idea di un soggetto che, del tutto autonomamente, avverte queste
sensazioni ed altrettanto autonomamente e individualmente sceglie questo percorso nel quale
dissolversi.
L’equivoco che tale operazione può determinare è quello di far pensare che il viaggio, la mobilità
del soggetto, la perdita / lacerazione delle radici e l’attraversamento di molteplici aree di riferimento
siano in quanto tali elemento esclusivo di appartenenza alla modernità. Che facciano parte soltanto
di un ribellarsi individuale alla società organizzata, ai processi di formalizzazione dei rapporti, ai
limiti culturali e comportamentali del gruppo primario così come alla sua disgregazione, che
rispondano insomma alla propria atomizzazione. La reazione a tutto questo sarebbe la fuga
individuale, la vita senza scelte, l’esilio senza ritorno. Ma questa spiegazione sembra insufficiente
rispetto alla molteplicità degli accadimenti che mettono in azione la mobilità, individuale e
collettiva, il vagabondaggio, l’abbandono di legami consolidati, la scelta, a volte inevitabile, della
solitudine. Il discorso sembra più complesso. Non si tratta soltanto di una mobilità moderna
collegata alla vita degli individui che percorrono contesti sociali vari, “altamente disgregati e
profondamente contraddittori”, un attraversamento di mondi sociali tra loro sostanzialmente
divergenti. E in questo percorso non c’è soltanto la possibilità che l’individuo non giunga a trovare
una propria dimora, non c’è solo una minaccia anomica continuamente presente (Berger-BergerKellner 1975, 184). C’è la possibilità che l’idea stessa di dimora non trovi fondamento, si allontani,
almeno nel suo senso tradizionale, dall’individuo, finendo per unificarsi con l’idea di persona,
destrutturando l’universo circostante. La sfera privata, nella quale scompare ogni senso di
autonomia, tenderebbe così ad appartenere a dimensioni pubbliche le quali perdono la propria
funzione di mondo sociale svuotando contemporaneamente la proiezione esterna dell’individuo.
Ogni formalizzazione esistenziale si dilegua così lungo una vita che diviene contemporaneamente
tutta pubblica senza avere più nulla di pubblico; l’individualismo non è più processo di liberazione
determinato dalla modernità, ma piuttosto di atomizzazione del soggetto e separazione pressoché
definitiva dal proprio contesto sociale.
Ora storicamente la mobilità si pone come elemento che può avere una componente soggettiva ma
nasce anche da una coazione oggettiva. Nella mobilità v’è certo un elemento di non integrazione, di
liberazione, ma c’è anche spesso, molto spesso, la necessità di perseguire un obiettivo, un desiderio,
un sogno, in cui magari tendenze individuali e necessità sociali si incontrano, rafforzandone
complessivamente l’attualità e facendo sembrare quasi naturale quel processo. Fu così per il lavoro
negli Stati Uniti tra il XIX: ed il XX secolo: gli hobos ed i tramps furono il cuore di un proletariato
vagante alla ricerca del lavoro, che contribuì in modo determinante alla costruzione della ferrovia
ed all’espansione della frontiera statunitense, e che contemporaneamente manifestò i caratteri di un
forte processo di non integrazione sociale e culturale. […]
L’homeless, nelle forme eterogenee di lavoratore migrante, povero, marginale, avventuriero,
smanioso di viaggiare, malato mentale, socialmente disgregato, vecchio ormai inutile per il lavoro,
giovane assetato di terre e fatti o relazioni nuove, ragazza o donna desiderosa di sfuggire ad un
precoce internamento nell’istituzione familiare o a una esperienza affettiva fallimentare, ha
coesistito con lo sviluppo e l’affermazione della società industriale fin dalla seconda metà del XIX
secolo. Ed egli partecipa a quell’affermazione, come anche alla sua trasformazione in una società
industriale progressivamente matura nella quale ad un certo punto la struttura dei servizi è diventata
predominante rispetto al tradizionale assetto quantitativamente maggioritario delle fabbriche. […]
La sua [homeless] presenza di per sé è anche ribellione, per lo più inconsapevole, ai processi di
segregazione determinati dal normale strutturarsi della città. La sua visibilità, il suo presentarsi
dinanzi a noi, il carattere pubblico della sua mobilità, il suo ‘‘chiedere” rompendo l’idea di una
povertà che, nella sua latenza, potrebbe farci pensare di non esistere, scombussola l’idea di una
società che, arricchendo la comunicazione, crede comunque di poter spostare le miserie del mondo
in una sede altra da noi, dal nostro insediamento, dal nostro essere, dal nostro tempo, dalla nostra
quotidianità. Solidarietà e pietà, diritti dei deboli e asimmetrie sociali possono non essere più parte
del nostro orizzonte se dal medesimo si riesce ad annullare chi di quegli elementi potrebbe essere
testimonianza concreta. […]
Ancora un elemento deve essere preso in considerazione relativamente al tempo degli homeless.
Vedere un homeless dormire sui suoi cartoni mentre noi camminiamo a mattinata inoltrata può
determinare un gesto di insofferenza nei confronti di soggetti che, rispetto al tempo urbano, al
nostro tempo e alle nostre scadenze, sembrano cullarsi nell’indolenza. In effetti quel tempo nostro,
quel tempo della città, sostanzialmente sfibra soltanto gli homeless. Il loro tempo può incrociare
quello organizzato e formalizzato della città forse solo quando qualche struttura assistenziale,
religiosa o no, eroga un pasto; per il resto quel tempo è strettamente personalizzato alla loro
condizione, al contesto di vita, differenziato, che in quel momento vivono. […]
E il problema è stato ritradotto spesso solo in termini di eliminazione della visibilità degli homeless
rispetto alla rappresentazione di sé che le strutture urbane avrebbero dovuto dare.»
Raffaele Rauty, Homeless. Povertà e solitudini contemporanee, Genova 1995 p. 11-27 (passim)
«Fanno colazione nei bar appena aperti, con le macchine ancora in carica che svaporano l’acqua
rimasta ferma dalla sera prima e che puzza di cloro vecchio. Inghiottono insieme il fumo della
seconda sigaretta della giornata e il cappuccino bollente e senza schiuma, ché la schiuma è niente,
una sfumatura di cui non sanno cosa fare. E subito se ne vanno coi loro fagotti e il panino sotto il
braccio, come gli operai nostri degli anni Cinquanta, coi giubbotti consunti, la riga ai pantaloni e il
bordo fissato coi punti metallici.
Un esercito di lavoratori precari, quasi tutti stranieri, arabi o slavi o pakistani, che affolla le prime
corse delle metropolitane e si disintegra nelle tante (sempre meno, per la verità) occupazioni che
offre la città. Sono facchini, muratori, venditori ambulanti, piccoli contrabbandieri, lavavetri,
questuanti. Hanno alle spalle storie di miserie e di avventure, di guerre e di viaggi interminabili,
entrando nei cessi dei treni quando arriva il controllore, cambiando corsa a ogni stazione per non
pagare il biglietto che non possono pagare.
Conoscono ognuno non meno di due lingue, molti di loro portano nel portafogli una laurea che qui
non vale niente, tutta sgualcita e piena di ditate nere: architetti, medici e ingegneri che per
quattordici o sedici ore al giorno ramazzano gli scantinati dei negozi, zappano terreni, e issano in
spalla sacchi di calce o casse di frutta, con la pazienza e la voglia di vivere custodite nelle rughe
profonde di faticatori.
Dormono sui marciapiedi o sulle panchine, oppure affittano in dieci un appartamento per viverci in
quindici, nelle estreme periferie delle città, le Ostia o i Cinisello Balsamo o i Castellammare
d’Europa. Si fermano in un posto, ci lavorano per qualche mese e poi, sia perché stanchi di stare
fermi sia perché licenziati o perché comunque tutto deve a un certo punto avere fine nella vita,
ripartono per un’altra città, o un altro continente, a cercare un nuovo lavoro magari diverso nella
qualità ma uguale, ugualmente precario, nella sostanza.
Gli immigrati, gli extracomunitari appartengono a una stirpe antica, quella dei lavoratori
camminatori, che rincorrendo le varie frontiere aperte nel corso degli ultimi secoli (la Londra
dickensiana, il West di Whitman, pieno di carri, di strade rosse. di pionieri straccioni e di sconfinati
sogni, fino alla Parigi del santo bevitore di Roth) hanno letteralmente costruito le nostre metropoli,
entro le quali non rappresentano dunque un corpo estraneo, ma di cui sono anzi parte ingenita,
fondamentale.
La metropoli, a parte tutto il male che da un punto di vista ecologico se ne può dire, è il libro in cui
tutto il mondo si condensa e si riassume. Visto che non c’è erba a coprire il fango, la città è
incapace di nascondere qualsiasi bruttura, è dunque dalle sue strade affollate e dai suoi uomini
sporchi di storia che bisogna cominciare per conoscere la realtà. »
Sandro Onofri, Uomini fuori luogo, articolo 14 febbraio 1994
4.3.2. La fenomenologia del disoccupato (e del “cassintegrato” del precario, dell’indignato) insiste
con particolare attenzione sul mondo giovanile in attesa di impiego; in tali analisi ricorre
l’ammissione della difficoltà a leggere, decodificare e capire e le attese di chi sembra vivere (e
convivere con) un “tempo inutile”, con un “tempo svuotato”. Analisi nelle quali lo stereotipo
valutativo è sempre in agguato. Nella parvenza sociologica della registrazione “scientifica” o per lo
meno empirica, passano un giudizio e una valutazione attinti inconsapevolmente e in modo
piuttosto sbrigativo nel bagaglio mai vuoto di chi osserva a distanza, da lontano, dall’alto, dal
passato, dai modelli di una società “normale” o, più banalmente, dal come eravamo. Valutazioni a
distanza stranamente accompagnate da prassi mimetiche mirate a far vivere per tutti un perenne
essere giovani, ragazzi… in imitazioni senili di modi e mode che contribuiscono a creare come dato
reale e sociale il volto contraffatto e banale dell’area definita “giovane”, un inesistente oggetto di
studi, seminari,convegni e cure.
4.3.2.1. «E’ proprio quel tempo inutile che Silvia Ballestra (Il compleanno dell’Iguana) racconta
«dal punto di vista di lui», punk casereccio che si ubriaca ma non si droga, parla di donne, insegue
giostraie, si sforza di fare a tutti i costi il diverso, a immaginarsi e fingersi libero e importante,
irresponsabile arbitro del proprio destino. Ma spesso Antò Lu Purk cade nel macchiettistico, come
quando va all’acchiappo alla biblioteca universitaria usando come esca i libri dei minimalisti
americani oppure consuma sesso con una «pocciuta furia» educatasi sugli inserti chiusi dei
settimanali femminili. E fa tenerezza nella sua voglia di fuga: prima al Dams, a Bologna, enorme
delusione per chi sperava in un’università punk, poi cercando di raccattare denaro (rimettendoci
anche una gamba) per realizzare il grande sogno, andare a Berlino, città mitica nell’immaginario
collettivo dei punk, le case occupate di Kreutsberg e tutto il resto, cuore d’Europa eppure già
frontiera.» Mario Celi, Quei ragazzi virili e disperati che sognano Berlino, articolo 4 aprile 1985
4.3.2.2. “il pianeta degli svuotati” «Non abbiamo occhi, non abbiamo schemi di lettura per capire
dei ragazzi degli anni Novanta, quelli compresi tra i 14 e i 24 anni, nonostante questa generazione
sia stata studiata, classificata vivisezionata da Istituti di ricerca come mai era capitato ad altre
generazioni di giovani. Di loro si parla come del «pianeta degli svuotati» dove il progetto ha il
respiro di un giorno, l’interesse la durata di un’emozione, il gesto non diventa stile di vita e l’azione
si esaurisce nel gesto. […] E così a questa tribù del malessere viene «attribuita una valenza di
mercato prima che di identità». Su di essa si buttano le nuove aree di profitto che hanno fatto
proprie le istanze stilistiche, comportamentali ed espressive tipiche della condizione psichica di
questa generazione che la pubblicità, la produzione dell’abbigliamento, le agenzie di viaggio e
l’industria del divertimento hanno decodificato molto meglio di quanto non abbiano fatto le
statistiche sociologiche, le analisi psicologiche del profondo, la cultura devitalizzata della scuola
dove molti insegnanti neppure si accorgono che quei i giovani, che sono ogni giorno sotto i loro
occhi appannati, non avvertono più alcuna corrispondenza tra quanto si apprende in classe e quanto
si intravede dalle finestre dell’aula.
Al di là dei vetri c’è l’America la cui «scoperta è questione di mesi per qualsiasi ragazzino del
pianeta. Il tempo di essere svezzato, di appropriarsi delle categorie del discernimento e l’America
diventa uno stato mentale. A questo punto incomincia quell’emigrazione verso il modello
americano da parte di legioni di adolescenti, teen-agers e ventenni che porta a quell’omologazione
planetaria che Pier Paolo Pasolini denunciava come il rischio maggiore par le generazioni future
che, deprivate delle specificità locali ormai umiliate, sarebbero rapidamente entrate in crisi di
identità. […] E da qui prende avvio quella «morte felice» della propria specificità per imboccare
quella strada a senso unico che compensa la carenza di identità con la sicurezza concessa
dall’appartenenza alla tribù, fuori dalla quale resta solo la solitudine dell’anonimato sociale, dove si
annidano baratri insuperabili in ordine alla comunicazione che il rumore assordante della discoteca
non riesce a colmare. Nascono allora quelle malinconie che hanno abbandonato il tono del tumulto
per frequentare le stanze della rassegnazione. E nei giovani meno autentici, neppure un attimo di
disperazione, perché non si dà disperazione là dove la speranza si è da tempo congedata.
Le parole degli adulti, siano essi educatori, psicologi, insegnanti, esperti, genitori dicono, ordinate,
l’ordine della vita, ma gli adulti ormai, abbandonati dalla memoria della loro adolescenza, peraltro
inutile per capire questa adolescenza, inseguono quella comunicazione impossibile in cui è la loro
ansia di esprimersi e, con essa, la loro ormai pienamente raggiunta incapacità a capire. […] E così
tra i 20 e i 30 anni, quando massima è la forza biologica, emotiva e intellettuale, i nostri giovani
vivono parcheggiati in quella terra di nessuno dove la famiglia non svolge più alcuna funzione e la
società alcun richiamo, dove il tempo è vuoto, l’identità non trova alcun riscontro, il senso di sé si
smarrisce, l’autostima deperisce.
Ma che ne è di una società che fa a meno dei suoi giovani? E’ solo una faccenda di spreco di
energie o il primo sintomo della sua dissoluzione? Forse l’Occidente non sparirà per l’inarrestabilità
dei processi migratori, contro cui tutti urlano, ma per non aver dato senso e identità, e quindi per
aver sprecato le proprie giovani generazioni.» Umberto Galimberti, La generazione degli sprecati,
articolo 17 ottobre 1995.
4.3.2.3. La solitudine aggregata nella comunità virtuale della rete.
«E la rete? Quella rete che è la nuova comunità virtuale, che si presenta e si offre essa stessa come
stormo, sciame, swarm intelligence. […] Che nega dunque la possibilità di poter essere solitari alla
Emerson e impone il dover essere connessi alla comunità della rete, sempre e comunque. […]
Così la rete diventa conformisticamente dispotica, biopoliticamente biopolitica e disciplinare:
rafforza i legami interni divenendo comunità autoreferenziale, escludendo ogni altro sapere diverso
ed esterno a sé, producendo inclusi sempre più inclusi e inclusione/integrazione crescente,
generando esclusi sempre più esclusi e convalidandosi e rappresentandosi appunto nell’esclusione
degli altri (la comunità in rete è cosa buona e giusta, fuori dalla rete non ci sono comunità né
identità, la vita è solo in rete). E poi il modo di stare-essere insieme dei giovani, spesso insieme tra
di loro fisicamente, ma ciascuno impegnato a inviare e a ricevere SMS, soprattutto i più giovani:
incapaci di fare amicizia con chi è vicino, incapaci di essere in comune, ma illudendosi di avere,
grazie alla tecnica, molti amici che, insieme, possano fare comunità. È l’evaporazione dell’amicizia,
per l’incapacità di avere amicizie reali, illudendosi di averle virtuali.» (Demichelis 2010, 140-141)
4.4. un passaggio ai contesti / contenitori sociali
Le trasformazioni e i volti sociali richiamati (da 2. a 4.) sono comprensibili all’interno di
trasformatori storici che definiscono il tempo presente; si possono chiamare “contenitori mobili e
ampi delle dinamiche sociali”. In sequenza: il ritorno della dialettica Comunità e Società, i processi
di globalizzazione e le tentazioni identitarie, il prender forma di un variato ma indifferenziato e
diffuso populismo. Contesti per i quali occorre un doppio esercizio di metodo: prima la
presentazione autonoma della loro dinamica, poi la riflessione sul loro intreccio come di fatto
accade nel sociale ed è elemento costituente della recente complessità.
5. Un contenitore mobile e ampio delle dinamiche sociali: Società - Comunità.
5.1. I concetti formulati dal sociologo e filosofo tedesco Ferdinand Tönnies oggetto continuo di
ripresa e sviluppi nella loro definizione, distinzione e relazione: Comunità e Società.
5.1.1. Il legame di comunità (Gemeinschaft) così definibile: l'insieme dei cittadini pensato come
"gruppo di persone che si trovano ad essere unite in ragione di un vincolo di sangue, di razza o di
nazione, indipendentemente dallo scopo perseguito" (Bobbio); o di un vincolo definito “naturale”.
L’io scompare nel noi (pur in diverse comunità: famiglia, religione, razza...l'intera umanità), un noi
caricato di un significato mistico o magico, primitivo e totale, vero soggetto di rilevanza storica e
nei diritti; «…la logica comunitaria che privilegia l’omogeneità rispetto alla diversità» (Touraine
1997, 151) .
5.1.2. Il legame di società (Gesellschaft) definibile come realtà collettiva in cui "gli individui si
uniscono al fine di perseguire un interesse comune" (Bobbio). Si presenta come gruppo contrattuale,
non come fatto naturale; il vincolo associativo impegna l'individuo parzialmente e in modo
programmato, per quella parte in cui la sua attività è necessaria al raggiungimento del fine comune;
i fini associativi saranno sempre diversi sulla base degli accordi e del modo con cui essi sono
formalmente organizzati (non per un presupposto unanimismo a priori definito di sangue, di
appartenenza, di fedeltà…)
Approfondendo i due termini come strumenti e concetti: «… l’universitas, quel corpo sociale
interpretato come un tutto. Concezione che la modernità trasformerà, traducendo l’universitas in
societas, corpo collettivo che pensa se stesso come associazione di individui e a cui si accede
sostanzialmente nella forma del contratto, ovvero producendo una società intesa come qualcosa di
artificiale, che ha o che dovrebbe avere come proprio scopo quello di accrescere le libertà
individuali. Per cui, «a differenza dell’universitas medioevale, la societas non esprime un’unità
organica, ma un’unità collettiva» U. Galimberti, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica,
Feltrinelli, Milano 1999, p535. […] … Ferdinand Tönnies, considerato fondatore della sociologia
formale (che si occupa di classificare le forme e i processi che accadono nella società, senza una
specifica verifica empirica), con la sua distinzione tra società e comunità. Per cui la comunità
(Gemeinschaft) sarebbe un organismo naturale a forte volontà comune, il prodotto di una volontà
organica, che dà vita in modo spontaneo a rapporti tra le persone, fondati su legami sentimentali, e
su valori profondi quanto inconsapevoli, dalla famiglia alla lealtà tra i membri della comunità, nel
rispetto dell’autorità. La coesione (o meglio, come qui si sostiene, l’integrazione) comunitaria non è
di tipo istituzionale o giuridico, ma si basa su rapporti personali, su una sorta (si potrebbe dire) di
affinità elettiva (di empatia?) con gli altri membri del gruppo/comunità, soggetti poco individui ma
molto legati ai costumi della comunità, nella prevalenza degli interessi collettivi e comuni su quelli
individuali. La società invece — la Gesellschaft — sarebbe il risultato di una volontà arbitraria e di
una riflessione razionalizzante che organizza lo stare insieme degli uomini sulla base di contratti o
di leggi. Per cui la società sarebbe appunto qualcosa di artificiale o comunque di non naturale,
composta da individui separati senza una volontà comune tra loro, se non in rapporto allo scambio,
che stabilisce un valore a ciascun soggetto. In una società prevalenti sono gli interessi dei singoli,
l’azione individuale e sociale è orientata dall’opinione pubblica, la moda ha un ruolo forte. E la
solidarietà si realizza solo in modalità contrattuale. Comunità erano le forme arcaiche dello stare
insieme degli uomini, le forme primitive dove ad esempio i membri di un certo gruppo si ritenevano
discendenti da un animale sacro, un totem, e dove fortissimi erano i legami intergruppo. Società
sarebbero invece quelle moderne, dominate dall’individuo e dalla sua emancipazione dai legami
precostituiti da religione, tradizione e potere. E dall’organismo comunitario si passa al meccanismo
sociale (che in realtà, come detto, è un’altra forma di organismo e di organicità). 126
Anche Max Weber— fondatore con Tönnies e Simmel della Deutsche Gesellschaft für Soziologie
(Società tedesca di sociologia) — distingueva tra comunità e società, in particolare tra
accomunamento e associazione, sostenendo che si avrebbe comunità quando l’agire sociale si fonda
su un comune senso di appartenenza fortemente coinvolgente (affettiva o tradizionale),
«soggettivamente sentita» da parte dei suoi membri, secondo una razionalità rispetto al valore, alla
fede nei valori della comunità; mentre si avrebbe società se questo senso è razionalmente motivato
su «un’identità di interessi, oppure su un legame di interessi motivato razionalmente (rispetto al
valore e rispetto allo scopo).» (Max Weber, Economia e società, Edizioni di Comunità, Torino,
1995, vol.I, p. 38) (Demichelis 2010, 124-126 passim)
5.1.3. utilizzo storico dei concetti: la transizione dalla società tradizionale (feudale, particolaristica)
alla società moderna (amministrativa, universalistica) è presentata come una transizione dalla
comunità alla società
5.1.4. tuttavia le forme comunità/società risultano diversamente essenziali e non si presentano mai
storicamente allo stato puro; il realizzarsi dell'una è accompagnata da momenti di presenza (magari
con moti di nostalgia e rimpianto) per l'altra. Ma solo il concetto di società può sostenere il
principio della comunità in quanto lo subordina al fine della realizzazione dei diritti individuali e
sociali e lo gestisce formalmente come apertura alla complessità del sociale, cioè ad un sistema di
relazioni articolate, in una società complessa e perciò aperta, fondata sulla pluralità storica delle
libere autonomie.
5.1.5. la sorveglianza va applicata a controllare una doppia possibile deriva.
5.1.5.1. Contro una società (Stato) che vuole diventare e si presenta come comunità: a. quando si
trasforma in biopolitica; b. quando si declina come luogo di eticità e come stato etico; c. quando
imposta la propria visione storica e sociale in termini di amici / nemici, noi / loro, fedeli / infedeli,
integrati / extracomunitari …
5.1.5.2. Contro una comunità (ogni gruppo comunitario) che tende a diventare società rivendicando
per sé ruoli politici di governo, di legislazione e di controllo: a. quando libri, tradizioni e valori
definiti sacri vengono posti a fondamento imprescindibile e giudizio inappellabile del fare culturale
politico e sociale (il diffuso fondamentalismo religioso e ideologico); b. quando comunità (gruppi
religiosi o politici) pretendono e ottengono protezione e privilegio, stilano contratti e concordati che
le sostengono nel loro agire sociale.
5.1.6. il passaggio dal principio comunità al principio è passaggio dall'etica della convinzione
all'etica della responsabilità (M.Weber). Non si tratta di etiche tra di loro incompatibili, al contrario
stanno tra loro in rapporto complementare, la seconda, in particolare corregge la natura "emotiva" e
tendenzialmente poco tollerante della prima.
5.2. la comunità e la negazione della società
«La società muore e morendo fa risorgere l’idea di comunità. Risorge la comunità e risorgendo nega
ulteriormente ogni riflessione sull’idea e sul bisogno (oggi già drammaticamente assente) di società
e di socialità, soprattutto sull’idea di una società aperta fatta di dia-logo, di ri-conoscimento delle
soggettività, delle esistenze. Comunità invece come luogo e tempo dell’eccesso di io (l’individuo
egoista, egotista, prometeico, liberista, virtuale, narcisista), e questo eccesso di io si lega
utilitaristicamente ad altri individui altrettanto egoisti, egotisti, liberisti, prometeici, narcisisti, in
una comunità di solitudini ben mascherate dalla e nella stessa comunità. E, insieme, un eccesso del
noi (la comunità immunitaria, immaginaria, identitaria, sempre più chiusa, sempre più
autoreferenziale, spesso solo immaginata ma potente nel cercare disperatamente di difendersi e di
difendere i propri membri, immunizzando e immunizzandosi dal pericolo degli altri), che porta a
un’ossessione per noi e per il noi, ovvero: via tutti gli altri. Tutto questo — secondo Elena Pulcini
— con un eccesso di pathos legato all’io e al noi; e con una parallela assenza di pathos per tutto ciò
che non è io e noi, ovvero per gli altri diversi da noi, per la terra come ambiente comune.»
(Demichelis 2010, 29) «… la comunità come chiusura dell’io in un noi senza libertà e senza
riconoscimento (ancora Remotti) delle esistenze individuali.» (Demichelis 2010, 33)
«Comunità, e non società: le forme semplici ma forti perché chiuse della comunità, non quelle
complesse ma libere della società. Una comunità (e non una società) basata su legami e vincoli di
natura materiale e di mercato (di apparato), legami di integrazione fortissimi anche se fondati sul
denaro, sulle merci, sullo scambio. La comunità dei produttori, dei consumatori. Comunità chiuse,
erette sulla logica chiusa della comunità stessa, una logica autoreferenziale, basata soprattutto
sull’inclusione degli uguali perché produttori/consumatori e sull’esclusione dei diversi perché non
produttori! consumatori, o non connessi. Comunità erette sulla logica chiusa del feticismo delle
merci, della reificazione: per cui ogni uomo diventa soggetto incluso nella comunità solo grazie al
genere della propria attività, un’attività che ha come scopo solo quello della produzione e del
consumo delle merci e dei valori (oggi non solo di scambio: ancora emozioni e divertimento) che
queste merci incorporano.» (Demichelis 2010, 86)
«E se è tutta da discutere la tesi per cui la comunità si baserebbe su legami forti, mentre la società
su legami deboli — in verità, proprio la società con i suoi legami apparentemente deboli permette la
libertà, mentre la comunità, con i suoi legami apparentemente forti, la uccide — certa è oggi la
morte della società, nel trionfo della comunità e del comunitarismo tecnico e di apparato.»
(Demichelis 2010, 236)
5.3. la negazione o la morte dell’utopia (nella comunità) come morte della politica.
5.3.1. è bene che l’utopia sia morta se… «L’Utopia di Thomas More. Che partiva appunto
(premessa necessaria e imprescindibile per ogni progetto, per ogni Utopia, per ogni immaginare) da
una critica radicale dell’esistente (la realtà di allora, e il 1516 è la data di pubblicazione dell’opera).
Sogno o Utopia. Un sogno di molti, anche se spesso (troppo spesso) perseguito e realizzato nel
modo sbagliato. Sbagliato perché l’Utopia e la sua ricerca sono state percepite e vissute come un
obiettivo assoluto e soprattutto realizzabile, l’Utopia come perfezione compiuta e dunque, una volta
realizzata, immodificabile in quanto assolutamente perfetta; e ciò che è perfetto e vero non deve
essere modificato, quasi che anche l’Utopia, in quanto verità assoluta, assolutismo e integralismo
utopistico non ammettesse un proprio ulteriore, continuo perfezionamento. Invece l’Utopia, proprio
perché è ricerca e mai realizzazione (essendo in nessun luogo, non potrà mai essere davvero
raggiunta), non deve portare alla sua realizzazione, se non per approssimazioni, per tentativi.»
(Demichelis 2010, 15)
5.3.2. l’irrinunciabilità politica all’utopia. «È morta l’Utopia. Ed è morta l’idea di società come progetto da realizzare insieme, come essere-in-comune, come convivenza, cooperazione,
collaborazione di soggetti autonomi e diversi, capaci di riconoscere e rispettare le reciproche
diversità e libertà; come con-fronto tra molti per avere dia-logo tra di-versi(tà), dialogo per produrre
non consenso e uniformità, non armonia artificiale indotta dagli apparati e omologazione, ma
relativismo, ambivalenza e laicità (nessuna verità ma molte verità, separazione e bilanciamento dei
poteri, riconoscimento dei diritti personali, politici e sociali); e conflitto (di idee, di progetti, di
diritti da rivendicare e far riconoscere, non certo guerra e violenza) come mezzo per il
cambiamento/miglioramento sociale e per il riconoscimento (non per la loro integrazione nella
normalità indotta) delle diversità; come responsabilità verso gli altri e verso il futuro (i diritti anche
di chi verrà dopo di noi, secondo Hans Jonas); come luogo della profondità e della riflessione e non
del qui e ora, dell’istantaneità, dell’illusione di e dell’allusione a un’infinità di piaceri-merce; come
simpatia (simpatia, più che empatia) o come amicizia verso gli altri e verso l’ambiente.»
(Demichelis 2010, 27)
«Utopia e società, un nesso ormai perduto. La comunità non conosce la parola né l’idea di Utopia, è
anzi una contro-Utopia o una tanato-Utopia (la comunità vive negando, uccidendo ogni idea di
Utopia): perché non cerca isole sconosciute, buoni posti dove vivere pur sapendo che sono in
nessun luogo; ma uccide l’Utopia chiudendosi nell’isola di sé/noi come comunità da cui non si deve
uscire pena la perdita dell’identità, della sicurezza, della protezione; una comunità immunitaria e
insieme panottica come tutte le comunità, dove tutti sanno tutto di tutti, un luogo che si presume di
conoscere, vissuto, pensato, interpretato come il migliore dove vivere.
Thomas More, pensando la sua Utopia, aveva sì immaginato una società razionale, strutturata e
felice ma anche a base elettiva, in cui grande fosse «la partecipazione di tutti al governo, pur se le
supreme funzioni di esso» erano comunque riservate «ai più dotti»; chiamando però tutto il popolo
«alla partecipazione alla cultura, limitando a questo scopo le ore di attività lavorativa». È anche
questa partecipazione alla cultura, come alla cura dell’intera polis e di sé come cittadini, che oggi
drammaticamente manca. Io e noi, invece, trionfano, un io/noi senza cultura, narcisisticamente
felice del proprio rinascente analfabetismo di valori, di scopi, di responsabilità, di autonomia, di
solidarietà, di affetti sociali; ma un noi ristretto, perché più forte è, più è piccolo e chiuso, e
viceversa. Spesso un noi immaginario, però ritenuto sufficientemente consolatorio e protettivo; un
io solipsistico ed egotistico che fa comunità solo con se stesso o con pochi altri (la comunità è
solipsistica ed egoistica per natura); un noi fatto di comunità-nicchia, di tribù dietro e dentro alle
quali si nascondono solo molti io/noi esasperati e in guerra gli uni contro gli altri (uno stato di
natura non più degli individui ma anche delle comunità). Uomini sempre più animali in branco, in
competizione con gli altri branchi, sciami, greggi, comunità. Quegli sciami che, secondo Bauman,
sanno trovare la loro strada senza bisogno di ordini e sarebbero coordinati senza essere integrati,
perché «la nostra è un’epoca di disimpegno; il modello panottico di governo, basato sulla
sorveglianza e su una costante opera di monitoraggio e rettifica comportamentale dei governati, va
rapidamente disgregandosi e cedendo il passo a un sistema di autosorveglianza e automonitoraggio
altrettanto efficace nello stimolare un comportamento idoneo (funzionale al sistema) rispetto al
vecchio metodo di governo, ma molto meno costoso.» (Bauman, Voglia di comunità, cit., p. 123).
[vale forse il ricordo di Aristotele che affermava come fuori della socialità vi fosse la bestialità;
questo si applica anche al principio “comunità”]
Mentre è vero il contrario: perché anche il vecchio modello panottico si basava sulla stimolazione
dell’autosorveglianza per indurre comportamenti funzionali e perché gli uomini sono integrati
senza essere apparentemente coordinati da alcuno, ma integrati (connessi, fatti collaborare tra loro)
dalle stesse modalità di funzionamento degli apparati tecnici (la rete integra e coordina
apparentemente senza coordinare e integrare; ancora, ad es., la wikinomics). (Demichelis 2010, 3031)
5.4. tuttavia, lo spazio per la comunità: «Comunità solide, comunità liquide … il modello della
comunità continuamente si ripropone, si rinnova, non solo nel localismo e nel comunitarismo stretto
e piccolo definito dallo slogan “padroni a casa nostra”, ma anche nel mondo produttivo e soprattutto
del consumo e della rete. Che vivono e si potenziano nel loro funzionamento proprio costruendo
continuamente modelli comunitari di organizzazione dei lavoratori, siano essi di produzione, di
consumo o di rete. Non tanto nel senso di “padroni a casa nostra”, ma di “questa è la nostra casa”
(la fabbrica, il brand, il centro commerciale, la wikinomics).»(Demichelis 2010, 33)
Comunità con le porte aperte, in cui si può entrare e uscire liberamente; luoghi per fornire apporti e
realizzare possibilità morali e civili. Luogo quindi non di rifiuto e negazione del sociale, ma di vita
del sociale segnato da una continua e produttiva dinamica di socializzazione e risocializzazione.
«La socializzazione è comunque un processo che continua nel tempo, anche se la sua fase primaria
è decisamente fondamentale. In ogni caso, la socializzazione, in quanto processo complesso,
delicato e fragile, si gioca nel rapporto tra differenziazione (ricerca di autonomia e relazione con gli
altri senza farsi esattamente come gli altri) e integrazione (entrare in rapporto con gli altri,
integrandosi con loro, facendosi come gli altri)» (Demichelis 2010, 36) Nel mondo del lavoro,
nelle comunità di impresa, di consumo responsabile, di comunicazione e scambio, di cura, di
progetto…
6. Un contenitore economico e politico in avanzata: globalismo e “ossessione
identitaria”
6.1. il legame tra globalizzazione e affermarsi di progetti identitari (per individui e comunità,
ma nell’evidente contraddizione di quest’ultimo collegamento: la comunità tende a ridurre
l’individuo a proprio elemento dipendente e programmato) o «una complementarità tra
globalizzazione e integralismi di varia natura, tra apertura e chiusura, tra edonismo e paura»
(Demichelis 2010, 49). Un concetto più volte ribadito.
«Oggi la comunità è considerata e ricercata come un riparo dalle maree montanti della turbolenza
globale [...] Le radici del presente sentimento di insicurezza affondano nel sempre più ampio
divario tra la condizione di individualità de jure e l’obiettivo di acquisire una individualità de facto.
L’erigere comunità fortificate non aiuta a ricomporre tale divario e al contrario contribuisce
fortemente a rendere più difficile, per non dire impossibile, tale ricomposizione.» (Z. Bauman,
Voglia di comunità, Laterza, Roma-Bari 2001, p.138). (Demichelis 2010, 30)
«… Le società sviluppate appaiono oggi caratterizzate da due tendenze, a prima vista contrapposte:
da un lato, si vanno sempre più affermando processi volti a costituire il mondo come unità globale,
con il diffondersi di strutture e modelli culturali di tipo omologante che dissolvono la diversità dei
contesti sociali tradizionali [cfr. Robertson 1992; Featherstone 1991]; dall’altro, sulla base del
riconoscimento della pari dignità di ogni cultura, si va accentuando la rivendicazione del diritto alla
propria diversità, con il rafforzamento delle spinte di tipo particolaristico. Come cercherò di
mostrare, queste tendenze sono, in realtà, interdipendenti ed è solo tenendo conto della loro
reciproca influenza che si può comprendere il carattere specifico della dinamica attualmente in
corso rispetto al problema dell’identità sia individuale che collettiva.»
Crespi, Franco 2004 Identità e riconoscimento nella sociologia contemporanea, Laterza, RomaBari p. 13
«La rottura operata dai flussi globali ha creato le condizioni per il manifestarsi di un’inflazione
identitaria e di una moltiplicazione degli investimenti simbolici volti a produrre “riconoscimenti”
per opposizione (Cella).» Bonomi Aldo 2010 Sotto la pelle dello Stato. Rancore, cura, operosità,
Feltrinelli, Milano, p. 39
Ancora sul contrasto: globalizzazione e pressioni/volontà/progetti identitari comunitari; o il doppio
contemporaneo in politica:
«Le informazioni, come i capitali e le merci, attraversano le frontiere. Ciò che era distante
s’avvicina e il passato diventa presente. Lo sviluppo non è più la serie delle tappe attraverso le quali
una società esce dal sottosviluppo, e la modernità non é più successiva alla tradizione; tutto si
mescola; lo spazio e il tempo si comprimono. In vaste parti del mondo, i controlli sociali e culturali
stabiliti da stati, chiese, famiglie o scuole s’indeboliscono, e il confine tra normale e patologico,
permesso e proibito diventa indistinto. Non viviamo forse in una società mondializzata e
globalizzata che pervade la vita pubblica e privata della maggior parte di noi? Sembra dunque che
all’interrogativo “Si può vivere insieme?” si possa anzitutto dare una risposta semplice e formulata
al presente: viviamo già insieme. Miliardi di individui guardano gli stessi programmi televisivi,
bevono le stesse bibite, indossano gli stessi abiti e per comunicare da un paese all’altro usano anche
la stessa lingua. Vediamo formarsi un’opinione pubblica mondiale che discute in grandi assemblee
internazionali, a Rio de Janeiro o a Pechino, e si preoccupa in tutti i continenti dell’effetto serra,
delle conseguenze degli esperimenti nucleari o della diffusione dell’AIDS. Basta questo per dire che
apparteniamo alla stessa società o alla stessa cultura? No di certo. La peculiarità degli elementi
globalizzati — siano essi beni di consumo o mezzi di comunicazione, tecnologie o flussi finanziari
— consiste nel fatto che sono svincolati da una particolare organizzazione sociale. Globalizzazione
significa che tecnologie, strumenti e messaggi sono presenti ovunque, cioè da nessuna parte, non
essendo legati ad alcuna società o cultura particolari, come mostrano le immagini, sempre ricercate
dal pubblico, che giustappongono la pompa di benzina e il cammello, la Coca—Cola e il villaggio
andino, i blue-jeans e il castello principesco. Questa separazione fra circuiti e collettività, questa
indifferenza dei segni della modernità rispetto al lento lavoro di socializzazione compiuto dalla
famiglia o dalla scuola, insomma questa desocializzazione della cultura di massa, fa sì che viviamo
insieme solo nella misura in cui compiamo gli stessi gesti e utilizziamo gli stessi oggetti, ma senza
esser capaci di comunicare fra noi, al di là dello scambio dei segni della modernità. La nostra
cultura non influenza più la nostra organizzazione sociale che a sua volta non influenza più l’attività
tecnica ed economica. Cultura ed economia, mondo strumentale e mondo simbolico si stanno
separando.
Mentre le nostre piccole società vanno a poco a poco amalgamandosi in una società mondiale,
assistiamo alla dissoluzione di quei complessi, politici e territoriali, sociali e culturali, che
chiamiamo società, civiltà o più semplicemente paesi. Vediamo separarsi, da un lato, l’universo
oggettivato dei segni della globalizzazione e, dall’altro, insiemi di valori, espressioni culturali e
luoghi della memoria, che non costituiscono più delle società nella misura in cui sono privati della
loro attività strumentale ormai globalizzata, e si chiudono quindi in se stessi dando sempre più la
priorità ai valori piuttosto che alle tecniche, alle tradizioni piuttosto che alle innovazioni. Alla fine
del secolo scorso, in piena industrializzazione del mondo occidentale, i sociologi ci hanno insegnato
che eravamo passati dalla comunità, chiusa nella sua identità globale, alla società, le cui funzioni
erano in via di differenziazione e razionalizzazione. L’evoluzione che stiamo vivendo é quasi
opposta. Dalle rovine delle società moderne e o delle loro istituzioni escono, da un lato, circuiti
globali di produzione, consumo e comunicazione e, dall’altro, un ritorno alla comunità. Avevamo
visto allargarsi lo spazio pubblico e politico; non andrà adesso disgregandosi sotto gli effetti
contrapposti di questa tendenza alla privatizzazione e di questo movimento di globalizzazione?
É vero che viviamo un po’ insieme su tutto il pianeta, ma e altrettanto vero che ovunque si
rafforzano e si moltiplicano i gruppi identitari, le associazioni basate su una comune appartenenza,
le sette, i culti, i nazionalismi; le società ridiventano comunità allorché riuniscono strettamente in un
determinato territorio società, cultura e potere sotto un’autorità religiosa, culturale, etnica o politica
che potremmo definire carismatica, dato che essa trova la sua legittimità non nella sovranità
popolare, nell’efficacia economica oppure nella conquista militate, ma nelle divinità, nei miti o
nelle tradizioni di una comunità. Quando siamo tutti insieme non abbiamo quasi niente in comune,
mentre quando condividiamo delle credenze e una storia rifiutiamo chi è diverso da noi.
Viviamo insieme solo se perdiamo la nostra identità; mentre il ritorno delle comunità comporta un
richiamo all’omogeneità, alla purezza, all’unità, e la comunicazione viene sostituita dalla guerra tra
coloro che offrono sacrifici a divinità diverse, si richiamano a tradizioni estranee ed opposte fra loro
e che talvolta si considerano biologicamente diversi dagli altri e superiori ad essi.» Touraine Alain
1997 Libertà, uguaglianza, diversità. Si può vivere insieme? (Pourrons-nous vivre ensemble?
Egaux et differents, il Saggiatore, Milano 1998, 10-13 e cfr. Touraine Alain 2004 La
globalizzazione e la fine del sociale. Per comprendere il mondo contemporaneo, il Saggiatore,
Milano 2008
6.2. Nell’analisi critica contemporanea una dato sociologico politico: sono in crescita le
comunità e con esse l’“ossessione identitaria”
«È morta la società. Trionfa l’apparato. E sono in crescita (un’autentica resurrezione, dopo i disastri
prodotti nel passato dal trionfo delle logiche comunitarie: nazione, patria, razza, religione,
nazionalismo) le comunità: nelle retoriche del fare comunità quale via facile per avere un’identità e
per superare la paura della non identità; nelle retoriche delle comunità virtuali, diverse dalle
vecchie comunità perché faciliterebbero l’entrata e l’uscita, quindi sarebbero comunità aperte,
virtuose, condivise anche se dominate dalla liquidità e dall’instabilità. Morte le identità di classe
restano, come sottoprodotto della cosiddetta postmodernità (in realtà, nessuna postmodernità, ma
sempre, e sempre più, modernità), le identità di comunità (territoriali, etniche, virtuali, di fantasia,
di spettacolo; forti, potenti, ma ancora, come sempre, socialmente e politicamente pericolose; e poi
identità di marca, di brand, le merci, le cose). Anzi, in queste diverse modalità di ricerca e di
illusione/allusione di comunità si rafforza (viene fatta rafforzare, viene prodotta mediante
un’appropriata biopolitica) quella che Francesco Remotti ha definito come un’ossessione
identitaria. (F. Remotti, L’ossessione identitaria, Laterza, Roma-Bari 2010)» Demichelis Lelio
2010 Società o comunità. L’individuo, la libertà, il conflitto, l’empatia, la rete, Carocci editore,
Roma, p. 28)
6.2.1. «A differenza delle vecchie identità di classe poi, le identità di comunità (avvelenate o
surrogati che siano) non hanno progettualità, illudono di un’identità che non c’è, ma che viene fatta
percepire come esistente o possibile, solida e pesante (l’unica capace di resistere alla liquefazione
della modernità), protettiva quando vengono a mancare tutte le protezioni; mentre negano ogni
riconoscimento delle esistenze (la comunità nega le esistenze individuali e i loro diritti, primo,
quello alla diversità dalla comunità e dalla sua logica autoreferenziale e chiusa) e fanno prevalere
l’identità dell’insieme, del gruppo chiuso, della nicchia, al loro interno non vi sono relazioni e
interazioni ma integrazione, identicità, conformismo/comunanza. Perché progettare significa aprirsi
(le società sono — dovrebbero essere — progettuali e aperte), mentre le comunità si basano sempre
ed essenzialmente su chiusura e autoreferenzialità e quindi sulla negazione di ogni progettualità (a
meno di considerare progetto l’autoreferenzialità, la chiusura e l’identità), di ogni Utopia, di ogni
apertura (il proletariato aveva un progetto, i localismi no e neppure le comunità in rete, quella rete
che è nata da e con un’idea/identità di comunità). La comunità risorge oggi (complice la rete) come
luogo e tempo del privato, dell’egoismo e della fuga dalla paura e dall’insicurezza; come spazio di
integrazione tra simili e come spazio di interdizione rispetto agli altri e a tutto ciò che è altro (idee,
stili, comportamenti) dalla comunità; ma anche come meccanismo di rafforzamento del populismo e
della delega: agli esperti o al populista d’occasione, alla stessa comunità di rete fino agli estremi di
Facebook.» (Demichelis 2010, 28-29)
6.3. l’ “ossessione identitaria” o l’identità avvelenata o identità e violenza. «Perché se per
Bauman l’identità è un «surrogato di comunità», per Remotti l’identità è soprattutto una parola
avvelenata, «perché promette ciò che non c’è, perché ci illude su ciò che non siamo; perché fa
passare per reale ciò che invece è una finzione o, al massimo, un’aspirazione». Non di
riconoscimenti identitari avremmo bisogno (questa la biopolitica dominante), ma (ancora Remotti)
del riconoscimento delle esistenze dei soggetti, dei loro diritti, dei loro obiettivi, dei loro progetti,
delle loro diversità. (Demichelis 2010, 28)
6.3.1. i molti livelli dell’identità avvelenata: l’individuo, la comunità, la società.
6.3.1.1. l’individuo. Sostiene Bauman: «Mentre farsi un’identità è un’esigenza fortemente sentita e
un esercizio incoraggiato da ogni autorevole medium culturale, avere un’identità solidamente
fondata e restarne in possesso ‘per tutta la vita’, si rivela un handicap piuttosto che un vantaggio
poiché limita la possibilità di controllare in modo adeguato il proprio percorso esistenziale.» …
«Questa eccessiva sovraesposizione dell’identità, di una identità, rischia di trasformarci in esseri
unidimensionali, mentre le vicende umane dimostrano che invece siamo degli abilissimi camaleonti
culturali.» (Aime Marco 2004 Eccessi di culture, Einaudi, Torino, p. 68, 56) «L’appello all’identità,
si dice, può sostenere orientamenti liberali o democratici, ma anche un comunitarismo autoritario o
addirittura la ricerca della purezza etnica, razziale o religiosa, che rappresenta una minaccia reale»
(Touraine Alain 2004 La globalizzazione e la fine del sociale. Per comprendere il mondo
contemporaneo, il Saggiatore, Milano 2008, p. 204)
6.3.1.2. la comunità: «Come ignorare il fatto che la difesa dei diritti culturali può ridursi in
ossessione per l’identità, l’omogeneità e la purezza del gruppo, dunque nel rigetto delle minoranze e
delle differenze? In nome dei diritti culturali si costruiscono comunitarismi che impongono le
proprie leggi mascherandole da diritti. In nome di una identità e di una tradizione, dirigenti
autoritari cercano di imporre principi e talora pratiche che negano la libertà di coscienza e le libere
scelte culturali. Touraine Alain 2004 La globalizzazione e la fine del sociale. Per comprendere il
mondo contemporaneo, il Saggiatore, Milano 2008, p.119-120
6.3.1.3. la società: la contraddizione multiculturale. «La società multiculturale, in quanto situazione
di compresenza di gruppi culturali diversi all’interno di uno stesso spazio sociale, chiama in causa il
multiculturalismo quale possibile risposta ai problemi generati dalla loro convivenza. Dalla
considerazione di un dato oggettivo, si passa pertanto all’elaborazione di un progetto di società
all’interno del quale è necessario “stabilire regole per la convivenza di tali gruppi su una base di
assoluta parità e di reciproco riconoscimento” (Crespi 1996, p. 262). Espresso in questi termini, il
concetto di multiculturalismo risulta essere meramente descrittivo nei confronti della realtà, tacendo
sulla natura dei rapporti che intercorrono fra le diverse culture. Il problema legato all’affermazione
della società multiculturale è infatti quello di conciliare la tutela del particolarismo culturale con lo
svolgimento di un graduale processo di contaminazione tra culture diverse, quale garanzia di
mutamento sociale e quale difesa nei confronti di possibili degenerazioni integraliste. Da questo
punto di vista, il multiculturalismo tradisce la sua natura ideologica: incurante della natura
processuale dei fenomeni sociali, i quali non di rado sfuggono a ogni tentativo di razionalizzazione
dell’agire che sia aprioristicamente determinato, esso affonda le sue radici nella cultura moderna e
nella frattura tra cultura e individuo da essa sancita. Le incognite della società multiculturale sono
pertanto riconducibili alle contraddizioni interne al progetto multiculturalista, nonché alla nozione
di cultura su cui esso si fonda.» Maria Cristina Marchetti, La contraddizione multiculturale. Identità
e identificazione (in Pompeo o.c p. 203)
Il mito del multiculturalismo finisce allora per essere una riproposizione, in chiave non conflittuale,
della diversità culturale, e finisce per porre ancora una volta l’accento sulla differenza piuttosto che
sul fatto che ogni cultura è già di per sé multiculturale.
Come afferma Davide Zoletto, il multiculturalismo « è un assunto che si basa quantomeno su un
doppio errore: che un individuo sia per così dire completamente o ampiamente sovradeterminato da
una cultura, e che le nostre società fossero (o che le società in generale possano mai essere)
monoculturali prima dell’arrivo dei migranti. » (Aime p. 23-24)
6.3.1.3.1. «Se i gruppi per la difesa dei diritti degli emarginati hanno certamente un’importante
funzione strategica contro le forme di discriminazione imperanti, tali gruppi rischiano di
dimenticare il loro carattere strumentale diventando, a loro volta, strutture di imposizione autoritaria
sugli individui che intendono difendere. Un autentico riconoscimento dell’autonomia individuale
può essere ottenuto a livello politico e sociale solo se l’individuo non è costretto a organizzare la
sua vita sulla base di criteri prefissati. Quando l’identità individuale viene ricondotta
all’appartenenza di gruppo l’identità di quest’ultimo viene ad assumere un carattere assolutizzato
che compromette non solo la possibilità di sviluppare un’identità personale. ma anche la prospettiva
di integrazione dei diversi soggetti nella società più ampia. Il fatto che l’identità particolaristica
tenda ad essere posta al di sopra dei valori universali dell’essere umano determina un’erosione dei
diritti umani fondamentali [cfr. Rockefeller 1994], con il rischio di accentuare le tensioni sociali, al
limite fino a forme di fanatismo terroristico, che pongono a repentaglio, non solo le forme
democratiche della convivenza, ma anche il mantenimento di un qualunque tipo di ordine sociale.
Come ha rilevato Richard Sennett, il fenomeno del multiculturalismo, nella forma distorta nella
quale è venuto diffondendosi soprattutto negli Stati Uniti, porta in pratica al fatto che «ogni gruppo
si trincera nelle proprie appartenenze identitarie e nei propri stili di vita ed è assolutamente
indifferente alle condizioni di vita degli altri. Così il multiculturalismo decreta la fine del discorso
pubblico» [Sennett 1998, 12].» (Crespi o.c. p. 20-21)
6.3.1.3.2. il carattere costruito, fittizio e strumentale delle identità assolutizzate
«Come ho già accennato, tale assolutizzazione ha portato alla manipolazione strumentale del
bisogno identitario di grandi masse da parte di centri di interesse e di potere economico politico,
con effetti conflittuali devastanti in molte parti del mondo. (Crespi, p. 90)
Il filosofo della politica Jean Franois Bayart ha giustamente osservato che: «Niente minaccia
maggiormente, oggi, la “stabilità dell’ordine sociale” quanto lo scatenamento dell’illusione
identitaria. È diventato urgente oppone un ethos filosofico che distingua le rispettive parti del
contingente e dell’universale, dal momento che alcuni partiti politici, in Europa e altrove, hanno
preso l’iniziativa di ciò che essi chiamano il “conflitto identitario”» [Bayart 1996, 248]. «In quanto
ideologia, il multiculturalismo non è una soluzione che possa esprimere un progetto di società
civile, per il semplice fatto che esclude in linea di principio la possibilità e la necessità di edificare
un mondo comune. Le alternative alle fratture della società possono essere cercate in un programma
di interculturalità in cui l’inter (ciò che sta fra le culture) deve essere letto, interpretato e agito
attraverso un paradigma relazionale. Il senso di tale paradigma è di espandere la ragione dalla
persona umana alle relazioni sociali, in modo tale che la ragione possa giocare il ruolo di
mediazione fra le culture. Chiamerò questa ragione la ‘ragione relazionale’.» (Donati, Pierpaolo
2008 Oltre il multiculturalismo, Laterza, Roma-Bari p.19)
«… il multiculturalismo, laddove riduce la sfera pubblico-politica a neutralità, sia conoscitiva sia
morale, verso le differenze (ciò che è proprio dell’ideologia liberale della laicità, pur se con
differenze fra le diverse versioni del liberalismo), non promuove alcuna composizione fra le diverse
istanze che possa portare alla costruzione di un qualche bene comune: in breve, rinuncia a
perseguire un bene prodotto e fruito insieme, in cui tutti i soggetti multiculturali siano coinvolti, il
che significa che impone uno stato comune di cose che rimane implicito e latente. […] Come ha
osservato Amartya Sen (Sen, Amartya 2006 Identità e violenza, Laterza, Roma-Bari), a distanza di
tre decadi la dottrina politica del multiculturalismo è entrata in crisi quasi ovunque. Appare ormai
evidente che, concepito come ideologia della differenza, il multiculturalismo non è una risposta
adeguata né sul piano etico né sul piano politico al problema della convivenza fra culture diverse.
6.3.2. in sintesi estrema: l’ossessione identitaria entra in contrasto con la società come luogo
dinamico di continua socializzazione e risocializzazione dell’individuo; colpisce dunque nella
società la natura sociale dell’uomo e il ruolo del sociale nel consentire all’individuo lo sviluppo e
l’espressione della propria profonda e produttiva complessità.
7. Un contenitore sociale e politico indifferenziato. Il populismo
7.1. una chiarificazione politica preliminare: «Il populismo: pilastro e tarlo del costituzionalismo
occidentale […] …a ben vedere il riferimento al «popolo» come sorgente di legittimazione è un
riferimento di tipo «simbolico» non meno del riferimento alla «grazia di Dio»: come in questo caso
non vi è (almeno nella maggioranza dei casi) un reale rinvio a una dimensione «religiosa» del
potere (non si ritiene veramente che il re sia un delegato della divinità, ma più semplicemente si
vuole affermare che il suo potere non è vincolato come derivazione ad alcuna componente
«terrena»), così nel primo il «popolo» è la trasfigurazione simbolica di una impossibilità del potere
di svincolarsi dal controllo di coloro sui quali si esercita. Naturalmente questo non significa ancora
tutto: il riferimento alla sovranità che risiede nel popolo è molto meno semplice di quanto non si
supponga. […] …sicché secondo questi interpreti [commentatori della costituzione americana] la
sovranità del popolo si esaurirebbe quasi nel proclamare la sovranità della legge. Resta però il fatto
che la formula di apertura, nella sua solennità non meno che nella sua origine da un atto
rivoluzionario, poneva in concreto il problema del popolo come nuovo soggetto primario della
realtà costituzionale. […] … qui [costituzione del 3 settembre 1791 in Francia] il popolo non viene
riconosciuto se non in quanto trasformato in «nazione»; anzi si mette in guardia sulla inaccettabilità
che «sezioni» del popolo possano richiamarsi alla sovranità.» Pombeni Paolo 2010 La ragione e la
passione. Le forme della politica nell’Europa contemporanea, il Mulino Bologna 577-579
Non c’è la possibilità di fare esistere il popolo come soggetto unitario e reale, tanto meno di farlo
agire come soggetto giuridico unitario capace di decidere oltre e al di sopra delle volontà dei singoli
individui, suoi componenti.
[e vedi anche: Mény Yves – Surel Yves, Populismo e democrazia, il Mulino, Bologna 2001]
7.2. il ricorrere di un soggetto collettivo e di un termine politico: gente e populismo
7.2.1. i termini e la loro varietà / variazione semantica
“la gente” : « Più aggraziata del vocabolo folla, meno impegnativa del termine popolo, più indolore
dell’espressione classe, la parola gente trionfa nei miracolosi anni Novanta. […] La morettiana
battuta: «vado in giro, faccio cose e vedo gente», riesplode in tutta la sua fulminante banalità.
Cambiano i tempi si adeguano le mode linguistiche. La folla degli stadi, il popolo delle piazze, il
pubblico del cinema e del teatro, gli individui tormentati dai sondaggi sono riciclati nella più vaga
delle espressioni: la “gente”.» (Antonio Gnoli, Troppa gente, articolo 9 luglio 1994)
Diversi pareri, diverse impressioni, diverse dinamiche sociali, diversi contesti politici e culturali.
Camilla Cederna: «Confesso di rimpiangere la rude espressione ‘classe’ che mi faceva pensare a un
ordine, anche se tumultuoso a una divisione netta e chiara, anche se difficile da gestire, a una
moralità, a un progetto. Rimpiango perfino il termine “popolo”. Un popolo può insorgere e può
lottare contro le ingiustizie. Ma la gente che cosa può fare?Al più ti penalizza con il telecomando. È
questa la sua sola arma. La gente è la forma sociologica più adeguata all’epoca del trionfo
televisivo; dove tutto è omogeneo, appiattito, ferocemente banale. «La “gente” è figlia di un
pensiero banale, o meglio di un’assenza di pensiero, di un accomodamento linguistico verso il
basso. Non c’è fascino negli individui che sommandosi la compongono.»
Gillo Dorfles: «Mentre si ha paura della folla o delle masse, la gente produce un sentimento
innocuo. Certo l’atmosfera è più indistinta ma l’espressione ferisce meno. Non ingenera più quella
differenza classista che oggi non sarebbe più tollerata. Evita di cadere nel classismo e metta
indiscriminatamente una intera popolazione sullo stesso piano. Risponde a un bisogno plebiscitario
e insieme a un desiderio di sedurre, di piacere a tutti. Chi oggi rimpiange le classi, l’orgoglio di
classe non ha capito che questo orgoglio non esiste più, da tempo è sparito. E non ha molto senso
prendersela con i sondaggi e con il fatto che sarebbero una forma di democrazia deviata. Essi non
sono la democrazia. Semmai sono lo specchio della democrazia nel quale la gente ama riflettersi.»
(Antonio Gnoli, Troppa gente, articolo 9 luglio 1994)
Beniamino Placido «Ci piacciono solo gli eccessi. Prendiamo la “folla”. Constateremo allora che
ogni uomo politico, ogni artista aspira al “Bagno di folla”, rigeneratore e rassicurante…»
(Beniamino Placido, Tutto cominciò con Tina Pica, articolo 9 luglio 1994) (l’analisi può proseguire
con L.Sciolla 1997 Italiani. Stereoptipi di casa nostra, il Mulino, Bologna; E.Berselli 1995 L'Italia
che non muore, il Mulino, Bologna; A.Bagnasco 1996 L'Italia in tempi di cambiamento politico, Il
Mulino, Bologna; A.Bonomi 1996 Il trionfo della moltitudine. Forme e conflitti della società che
viene, Bollati Boringhieri, Torino.)
7.2.2. “gente” e omologazione …
Simonetta Fiori: «Cominciò sul finire degli anni Sessanta con Un borghese piccolo piccolo, epopea
di un Italia rigidamente suddivisa in classi, grandi borghesi, borghesi, microborghesi e borghesi
piccoli piccoli appunto. Una spanna sopra il proletariato, universi separati e non comunicanti,
provvisti di linguaggi., simbologie, culture conchiuse e lunarmente distanti. Poi arrivò Tutti cattivi,
primi anni Ottanta: la modernizzazione aveva portato con sé la società di massa e Cerami affidò il
suo nuovo romanzo all’Uomo Interclassista, personaggio sostanzialmente regressivo perché privo di
riferimenti, ancoraggi, identità. Infine la Gente, uscito lo scorso anno da Einaudi, «trentadue
romanzi brevissimi, che illuminano a tratti «l’esercito rivoltoso nascosto nella folla», «la
maggioranza di quelli che passano per strada», le loro «innocenti nevrosi», come «se avessero
somatizzato la volontà di cambiare il mondo». […] La gente non è un monolito granitico. (Dice
Cerami:) «È instabile come gli ulivi in primavera, che a seconda del vento variano dal verde scuro
all’argento». La gente è oggi usata «in modo ricattatorio, i sondaggi decidono quel che dice e quel
che pensa». Ma quella, aggiunge Cerami, non è la gente (che tiene spenti i televisori). È
qualcos’altro. È la sterminata platea dei telespettatori, nuovo protagonista di un ipotetico racconto.
«Se dovessi scrivere un libro in linea con i precedenti, oggi penserei al telespettatore. Ma la Tv è
troppo impoetica per farne materia di romanzo.» (Simonetta Fiori, Homo televisivus, articolo 9
luglio 1994)
7.3. c’è populismo e populismo (note intorno a una realtà e a uno stereotipo)
7.3.1. Una tesi controcorrente. «Dico subito che, per me, oggi il populismo è espressione
dell’ipermoderno e non del premoderno… […] …è la forma del politico, o meglio della sua
transizione, nell’epoca delle moltitudini. […] Populismo, allora, non è più soltanto l’indicatore di
una famiglia politica o di un gruppo di partiti o leader, ma esprime la trasformazione del politico in
generale. Dentro la crisi della rappresentanza il populismo è forma di una nuova volontà generale
che non è più il monolite rousseauiano, ma un mosaico di soggetti e figure scomposti dalla
modernizzazione, che tali rimangono anche quando ricostruiscano un qualche tipo di connessione
sentimentale e l’imprenditore politico di turno. Come tale, il populismo è fenomeno intrinsecamente
plurale, trasversale alla geometria politica cui eravamo abituati. L’Italia, nel bene e nel male, è oggi
uno dei laboratori più avanzati di questa trasformazione. Sono convinto che siano ormai maturi i
tempi in cui dobbiamo interrogarci sul populismo non come patologia delle democrazie o
sopravvivenza di un passato che non passa, ma come forma generale della politica, adeguata al
dispiegarsi della moltitudine come modalità del vivere sociale e del postfordismo come forma del
produrre.» Bonomi Aldo 2010 Sotto la pelle dello Stato. Rancore, cura, operosità, Feltrinelli,
Milano, 91-92
La tesi sostenuta può essere ulteriormente valorizzata attraverso la sua collocazione all’interno di un
tema classico: quello che indaga sulla dinamica delle rivoluzioni o delle alternanze dei modelli
politici (sull’onda del ragionamento di Platone circa la ciclicità delle formule politiche). Ogni
modello politico precipita nel e parte dal populismo, di cui, in qualche modo, materialmente si nutre
e con cui inesorabilmente si confronta; filosoficamente si tratta di una specie di Lebenswelt della
politica, per quanto già infettato da spezzoni di modelli politici magari da tempo scomparsi ma
rimasti come rottami incomprensibili o senza senso della memoria sociale privata e collettiva (come
il “mare del testo” di Fforde); quindi populismo come “guazzabuglio” (Bonomi 2010, 101),
miscuglio politico indistinto di una pluralità non composta a sistema di elementi per un disegno
possibile, potenzialmente innovativi o comunque protestatari e dalla lettura aperta, soprattutto,
passibili di una conduzione politica plurima secondo formule tra loro in evidente contraddizione:
conservatorismo rancoroso dei luoghi e delle tradizioni intollerante nei confronti del nuovo e dei
“flussi”, apertura spregiudicata e innovativa, magari altrettanto intollerante e sprezzante nei
confronti dell’ottusità insopportata di luoghi e tradizioni ataviche.
7.3.2. Ciò che alimenta il populismo. «Occorre essere chiari: ciò che alimenta i populismi è proprio
il partire, nell’epoca dello spazio globale, da un rinserrarsi nel proprio abitare, luoghi, fabbrichette,
invidie di vicinato e gossip televisivo. Occorre pensare il territorio nella globalizzazione in
dialettica e, perché no, in conflitto con i flussi perversi che lo attraversano, come spazio di una
società aperta, disponibile alla società che viene, e andare verso un altro mondo possibile ai tempi
del globale. […] Per questo, mai come ora, c’è bisogno di una politica che assuma come luoghi del
pensare e dell’agire le parole chiave “territorio” e “comunità” nell’epoca dei flussi globali.
Guardando in basso si troveranno sul territorio, come polvere sotto il tappeto della forma stato,
tracce di una voglia di comunità, tracce di comportamenti collettivi che aiutano a scomporre e
ricomporre la forma indistinta della moltitudine, che titilliamo e mobilitiamo come unica massa di
manovra in epoca di populismi. Il fantasma della comunità che non è più, e la sua allegoria di ciò
che non è ancora, è leggibile nelle tre comunità del rancore, della cura e dell’operosità.
Via Padova, Milano, la città del malessere. Dopo i fatti e gli scontri tra etnie, con un morto, che
hanno messo a soqquadro il quartiere, si sono levate dall’alto, dal cielo della politica, voci di
“guerra”. In nome della comunità del rancore sono state scomodate parole forti come rastrellamento
e coprifuoco. Quelle parole non hanno avuto presa, la comunità rancorosa non è diventata egemone,
perché lì, sul territorio, si sono mobilitate le due polarità altre: la comunità di cura e la comunità
operosa. Le associazioni di quartiere, le scuole, le parrocchie, le associazioni di immigrati, i saperi
metropolitani creativi si sono messi in mezzo. Organizzando una grande festa del quartiere, girando
e rappresentandosi con un film-inchiesta, rapportandosi al melting pot abitativo e pensando il
quartiere che verrà. Assieme alle deboli tracce di comunità operosa fatta dalle reti commerciali e
dalle attività economiche presenti sul territorio, hanno stemperato il rancore e la paura come forma
unica della coesione. Ponendo così anche alla metropoli, alla città infinita, il tema di una Milano
che verrà, se verrà, costruendo o ghetti o la città multietnica. […]» (Bonomi Aldo 2010 Sotto la
pelle dello Stato. Rancore, cura, operosità, Feltrinelli, Milano, p.13-14)
«È come se la comunità possa conservare la propria autenticità solo in condizioni di minaccia
permanente, in un continuo stato di emergenza. […] Qui non stiamo parlando della differenza tra
due visioni, o tra due insiemi di assiomi, ma tra la politica basata su una serie di assiomi universali e
una politica che rinuncia alla dimensione costitutiva stessa di ciò che è politico, affidandosi alla
paura come ultima risorsa di mobilitazione: paura degli immigrati, del crimine, dell’empia
depravazione sessuale, di un eccesso di Stato, con il suo fardello di tasse pesanti, delle catastrofi
ecologiche paura delle molestie. Il politicamente corretto è la forma progressista esemplare della
politica della paura. Una siffatta (post)politica si basa sempre sulla manipolazione di un ochlos, o
moltitudine, paranoide: è la terrorizzante mobilitazione di un popolo terrorizzato.» Žižek Slavoj
2007 La violenza invisibile, Rizzoli, Milano 2007 p. 32, 46
7.4. I quattro populismi Genealogie populiste
«Molto spesso studiamo, teorizziamo, raccontiamo ciò che prende corpo nella società, poi quando
vediamo il racconto sociale quotato al mercato della politica, ci rifiutiamo di riconoscerlo. […]
Un postfordismo che però non va più inteso semplicemente come crisi di ciò che è stato (il
fordismo, la fabbrica, la comunità ecc.), come eterna transizione ma, almeno in parte, come
emersione di ciò che sarà, di istituzioni e di una comunità declinata non più soltanto come assenza
ma come comunità che viene. Dobbiamo sforzarci di cogliere le tracce di un’innovazione che non
ha solo i tratti inquietanti della comunità maledetta. Questo non per un’astratta petizione di
principio, per illuderci prima che l’onda ci travolga. È guardando al legame tra il mutamento della
composizione sociale e i fenomeni politici che sono convinto emergano tracce del nuovo. [valga
come linea di metodo suggerita dalla riflessione sui rapporti tra sociologia (modelli e ricerca della)
e modelli politici (in teoria e in azione governativa)]
Spesso è eccessivo tirare linee rette tra mutamento sociale e politica. Ma preferisco correre questo
rischio piuttosto che assumere posizioni elitarie, spesso adottate da chi parla di una “Italietta”
sempre uguale a se stessa, magari per giustificare la perdita del legame con la composizione sociale
del paese.
Dunque, ciò che sostengo è che se oggi il populismo è forma generale della politica, questo avviene
perché in esso sta lentamente acquisendo rappresentanza non solo la radice neoetnica, ma anche la
radice legata al demos sovrano e ai suoi diritti, oggi della moltitudine e dei suoi bisogni. E che un
pezzo importante della base sociale di questa insorgenza populista sta in quei ceti medi riflessivi, il
cui rapporto con la politica è la grande incognita di questo paese.
Certo, è una cultura populista che oggi si presenta nelle forme del giustizialismo, parte di un
centrosinistra che non coglie nulla del rapporto tra flussi e luoghi nel territorio. Tuttavia, mi sembra
chiaro che questo passaggio segni una differenza di fondo tra un prima e un dopo nello sviluppo di
quello che possiamo definire un populismo postfordista.
In una prima fase, tra gli anni ottanta e i novanta, sono leghismo e berlusconismo a dare voce e
rappresentanza a una composizione sociale fatta di orfani della fabbrica, di stressati del capitalismo
molecolare e spaesati dalla globalizzazione; in questa fase il populismo è in primo luogo voce del
risentimento territoriale.
Oggi si è aperta una nuova fase e dobbiamo prenderne atto. Una fase in cui sono emersi movimenti
e partiti che, pur muovendosi entro una cultura di marca populista, diventano veicolo (provvisorio)
di ceti della società della conoscenza alla ricerca di forme di rappresentazione e rappresentanza.
Dunque, non più soltanto orfani, spaesati e stressati.
Certo, oggi non solo in Italia ma nell’intera Europa sono ancora il rancore e la paura i sentimenti
prevalenti; e l’impasse dell’Europa unita nell’impatto della crisi accrescerà sicuramente la forza del
populismo come forma di rinserramento, se non di xenofobia. Inoltre, la stessa emersione dei
soggetti che esprimono la radice democratica del populismo avviene attraverso il filtro di culture
giustizialiste, localiste, di eruzioni di invidia sociale, verso cui continuo a non provare nessuna
simpatia; ma anche attraverso culture dei diritti e un antielitarismo fatto di radicalità democratica.
Per dirla con le categorie del Novecento, a fianco di un populismo “di destra”, pur con tutte le
contraddizioni del caso, vedo emergere embrioni di un populismo progressista. Per capirlo è forse
utile tracciare una genealogia del fenomeno populista. » (Bonomi 2010, 91-93)
[preliminarmente: forse si può coniugare il populismo con le tre forme di comunità come
potenzialità prepolitiche: del rancore, della cura, operosa]
Ma anche il rancore territoriale, per quanto oggi appaia egemone tanto da cannibalizzare
elettoralmente il campo dell’individualismo proprietario, si è culturalmente frammentato e “alzato
dal suolo”. È un fatto positivo. Se si sposta lo sguardo sul territorio è evidente come il rancore
territoriale non si eserciti più esclusivamente, come all’inizio, attorno al problema dell’identità
territoriale e del perimetrare il proprio spazio come richiamo a una tradizione o a una comunità
originaria. Oggi questa sottocultura ha sviluppato almeno tre anime: a) un nucleo che rimane quello
delle “origini”, ovvero della perimetrazione di uno spazio territoriale per difendere un’identità o una
tradizione (magari reinventata ex novo), oppure per creare comunità omogenee; b) una cultura della
difesa dell’identità territoriale rispetto ai processi di modernizzazione globale centrata sulla qualità
della vita e sull’idea del diritto dei territori a decidere riguardo a installazioni di reti e infrastrutture
identificate come simboli di un potere esterno prevaricatore. Una forma di conflitto tra flussi e
luoghi che ha avuto le sue precipitazioni più rumorose ed evidenti nella rivolta antiTav della Val di
Susa o nell’opposizione all’ampliamento della caserma statunitense Dal Molin di Vicenza; oppure
ancora nel fenomeno del comitatismo metropolitano. Una forma di aggregazione che incrocia
sindrome nimby con coscienza civica e vede protagonisti spesso i nuovi ceti professionali delle aree
urbane. […] c) infine, tutto ciò ci indica il legame fra la trasformazione della sottocultura del
rancore territoriale e l’emergere di un nuovo attore della modernizzazione e di un nuovo segmento
di classi dirigenti, il capitalismo (e i capitalisti) delle reti. Lo abbiamo visto nel la vicenda di
Malpensa o nella richiesta delle varie pedemontane lombarde o venete. C’è un’anima del rancore
territoriale che chiede modernizzazione e reti, e si appassiona per strutture più alte. 98
Per utilizzare la metafora di De Rita, in una società frammentata e ridotta a società dei “coriandoli”,
una volta che si è arrivati all’essenza del proprio individualismo proprietario, del proprio rancore
territoriale e della propria identità di classe, queste sono le ultime cose che ti rimangono, anche se
non sono più sufficienti a dare certezze. Una volta che ci si è fatti coriandolo, si è esposti a ogni
refolo di vento. E i coriandoli diventano stracci che volano. Si può rimanere coriandolo anche
assumendo fino in fondo la propria identità operaia. Ma il giorno che arriva la tragedia della
Thyssen ci si accorge che non si ha più nemmeno la forza contrattuale di porre la questione della
salute. Se non si hanno le reti per andare nel mondo, il rancore territoriale rimane lì, inchiodato al
suolo. Si può esercitare il proprio rancore contro l’ultimo dei rom che arriva. Ma si resta ancora
coriandolo che vola. Anche con l’individualismo proprietario si hanno la casa, le tecnologie, ma
nella società regna comunque l’incertezza. Basta un refolo di vento nelle borse che le proprie
rendite finanziarie svaniscono in un giorno.
La società italiana non è però rimasta a subire l’incertezza che ci pervade. Nei quartieri delle grandi
città, come nella provincia profonda, è cresciuta la percezione di un’assenza di comunità, sentita
come un vuoto da riempire. I “coriandoli” hanno iniziato a chiedersi come fare comunità aperta con
il nostro prossimo.
C’è un desiderio di comunità che trascina la questione più grande del fare società. E non si tratta
della sola questione economica, come spesso si banalizza con il tema della quarta settimana, e oggi
dentro la crisi con il tema della disoccupazione. C’è una dimensione dell’essere, più profonda, che
la politica deve intercettare. Il fatto è che sempre di più si chiede alla politica meno gestione e più
visione del fare società. Cosa che richiama una grande questione all’ordine del giorno: il tema della
governance o delle nuove istituzioni del postfordismo.
Questione che ci richiama ai temi alti di un nuovo processo costituente. Ragionare del fare società
significa infatti ragionare di nuove istituzioni dentro la crisi della rappresentanza, del “chi
rappresenta chi”. Cinque anni fa i sondaggi, soprattutto al Nord, registravano priorità tutte da
individualismo proprietario e da rancore territoriale: le tasse, l’impresa, il risparmio. Oggi la crisi ha
riportato in cima il tema del lavoro; ma dietro ci sono grandi questioni che richiamano il tema del
fare società: immigrazione, sicurezza, welfare, scuola ecc.
Nel chiudere il mio libro dedicato al Rancore, avevo individuato come tema di fondo su cui
continuare la riflessione il “fare società”, o meglio la costruzione di una visione di futuro che
contenesse in sé quegli strumenti culturali necessari a metabolizzare i problemi posti dalla
modernità. Mi chiedevo cioè se nella tenaglia tra rancore e modernizzazione ci fosse qualcosa in
mezzo e rispondevo che la dimensione di ragionamento in cui accettare la sfida era quella della
costruzione di reti lunghe del sociale oltre che dell’economia. Penso che la rottura del prisma
populista, la sua frammentazione e l’emergere di nuove tendenze, o tutte le contraddizioni del caso,
ci offra qualche spunto proposito.
Se le tre sottoculture che hanno formato il brodo di coltura del populismo negli anni novanta sono
oggi in crisi o comunque in trasformazione, ciò che si registra è l’emergere anche in Italia di una
quarta sottocultura, dai tratti indubbiamente populisti quanto a radicalità della critica dei
meccanismi della democrazia rappresentativa, a sentimenti antielitari ecc.
È accaduto che tra la fine degli anni novanta e l’inizio del duemila il panorama del populismo
italiano si è arricchito di nuovi attori, in parte politici, in parte sociali e di movimento, dai girotondi
al movimento dei meet-up di Grillo, da partiti di stampo giustizialista e plebiscitario come l’Italia
dei Valori alla proliferazione locale e nazionale delle elezioni primarie, al recente emergere di una
sinistra territoriale di tipo nuovo come nell’esperienza pugliese. Tutti fondono tratti tipicamente
populisti, come l’opposizione alla politica professionale, all’establishment, l’invocazione di una
democrazia riconsegnata ai cittadini, l’ossessione per le regole e il rispetto della legge come
parametro di uguaglianza nei diritti anche se non nella questione sociale, con la capacità di porsi
come referenti di un ceto medio riflessivo, la cui volontà partecipativa rappresenta a mio parere la
vera novità.
Queste esperienze politiche e di movimento vedono protagonisti come animatori soprattutto
professionisti, comunicatori, partite Iva, insegnanti, giovani precari intellettuali ecc., parte di un
corpo sociale che ha vissuto i processi di terziarizzazione e l’avvento del postfordismo, in parte
erede di quei ceti terziari che avevano composto negli anni ottanta l’immagine della “Milano da
bere” di craxiana memoria e oggi parte di comunità di cura in condizione di difficile operosità.
Sono coloro che percepiscono la postmodernità come occasione di emancipazione rispetto a norme
di condotta tradizionali, per i quali la liquefazione della società è la condizione culturale normale;
magari nel loro segmento d’élite hanno praticato il mondo e le grandi città europee o americane.
Nel loro nucleo più cosmopolita e metropolitano sono quelli che un’evocativa definizione francese
chiama i bobo, bourgeois-bohème, o più prosaicamente all’italiana “cuore a sinistra e portafoglio a
destra”. Più spesso, però, sono parte di un’opinione pubblica cresciuta carsicamente, a volte
impegnata nelle reti del sociale a volte in un comitatismo non solo becero o rinserrato, cresciuta
nella stagione dei movimenti che hanno attraversato l’Italia nei primi anni duemila. Nucleo centrale
di una società civile intesa come espressione della società della conoscenza e di una new economy
che nonostante tutte le mille arretratezze è cresciuta e si è sviluppata anche in Italia, soprattutto
nelle grandi aree metropolitane. E che pare stia imparando a prendere la parola, anche se utilizzando
codici rozzi e populisti nel senso deteriore del termine. Ma lo sta facendo. È questo secondo me il
nocciolo di verità positiva che traspare nell’affermazione di un’egemonia populista divenuta più
complessa e che ormai tende a coprire l’intero asse destra-sinistra.
Importante nella costruzione di un legame tra pezzi di nuova composizione sociale e sfera pubblica;
un legame non egemonizzato dalle sottoculture del rancore leghista o dell’individualismo
proprietario.
Questo nocciolo di positività passa oggi attraverso il lavacro del giustizialismo, del “regolismo”
inteso come trionfo della retorica delle regole, del leaderismo plebiscitario, di una cultura
dell’invidia sociale come forma di conflitto individualizzata, dimidiata e priva di un’idea di
progresso sociale. In cui si riflette spesso un antiglobalismo che mischia tratti di radicalità politicoideologica a un luddismo rivolto contro la modernizzazione delle reti. Un mix in cui la difesa del
proprio ruolo di piccoli produttori artigiani o agricoltori alla José Bové rispetto al potere delle
grandi transnazionali si intreccia all’ecologismo radicale e al fascino di stili di vita improntati a una
naturalità artificialmente costruita come possibilità di esodo a buon mercato dall’alienazione delle
metropoli.
Eppure, a costo di passare per inguaribile ottimista, è un guazzabuglio che esprime anche bisogni di
democratizzazione e di modernizzazione del capitalismo delle reti (di servizi sociali, di mobilità
collettiva nelle grandi aree metropolitane, di diffusione delle reti digitali ecc.) necessario a sostenere
stili di vita e modalità professionali centrati sulla connessione globale. Una composizione sociale
che vive di reti. Dunque, a ben vedere sotto la crosta di giustizialismo e invidia sociale, emerge in
veste postfordista un populismo che si richiama alla democrazia radicale e alla società aperta.
Se questo è vero, allora oggi vedo operanti nel paese al meno tre tipologie di culture populiste più
una, le quali solo in parte e con grande difficoltà possono essere ricondotte schematicamente a uno
specifico partito. Vediamole. (Bonomi 2010, 100-102)
[vedi inoltre Tomelleri Stefano 2009 Identità e gerarchia. Per una sociologia del risentimento,
Carocci, Roma.]
7.4.1. Il populismo del rinserramento 102
«… Oggi comunità e territorio sono le parole chiave per capire la modernità che avanza.
… il populismo del rinserramento, quello dell’“ognuno padrone a casa sua” […]
Non è certo un fenomeno solo italiano. …le fortune elettorali del cosiddetto “populismo alpino”,
prototipo delle nuove destre populiste dell’Europa occidentale (quelle che stanno spaccando il
Belgio, per intenderci), un fronte composto oltre che dalla Lega Nord, dal Fpö di Jòrg Haider in
Austria, dall’Udc di Christoph Blocher in Svizzera, vittoriosa ultimamente nel referendum contro la
costruzione dei minareti, ispirato da leggi analoghe in vigore nei Länder austriaci del Voralberg e
della Carinzia. Un contagio che sembra ormai diffondersi anche nella civilissima Europa del
welfare, dall’Olanda alla Svezia passando per il Belgio, dove il combinarsi di flussi migratori e crisi
ha fatto decollare una destra xenofoba che fa leva sulla grande paura di perdere benessere e
sicurezze che si pensavano incrollabili. Un populismo del rinserramento che non è più confinabile
alle turbolenze delle fragili società dell’Est in una fascia del rancore che ricalca la vecchia Cortina
di ferro, ma è penetrato nel cuore del mito di una civilizzazione europea come società aperta.
In Italia sarebbe errato fermarsi a un’istantanea da anni novanta. È impossibile non accorgersi che il
leghismo attuale è diverso dal leghismo delle origini. Rimane certo quella capacità di fondo, vera
risorsa distintiva del leghismo, di trasformare ciò che di prepolitico anima la dimensione dello
spaesamento antropologico in energia propulsiva per macinare consenso.» (Bonomi 2010, 102-103)
«Una lunga marcia partita anzitutto dalla rappresentanza di tre soggettività che la globalizzazione
emergente al passaggio tra anni ottanta e novanta aveva iniziato a terremotare: gli spaesati delle
vallate alpine, il cui tessuto comunitario proprio in quella fase iniziava a essere eroso dai flussi della
turistizzazione; gli artigiani e i piccoli imprenditori stressati, che nella fabbrica diffusa delle tante
pedemontane lombardo-venete iniziavano a scontrarsi con l’arrivo delle prime merci “cinesi”; gli
orfani del fordismo, che nella chiusura delle grandi fabbriche delle cinture metropolitane non
perdevano soltanto il lavoro, ma anche la coscienza di essere classe.» (Bonomi 2010, 104)
«Oggi come allora il combustibile principale del consenso leghista è la comunità del rancore. Ma
non è più la comunità originaria, quella non esiste più, nemmeno nella reinvenzione
neotradizionalista che ne fa la Lega. La comunità del rancore è anzitutto una comunità del
rinserramento del tutto artificiale, costruita sapientemente attraverso almeno due operazioni: la
prima è lo svuotamento della cittadinanza del suo carattere universalistico e la creazione del
cittadino territorializzato con il territorio come spazio in cui far valere come unica cifra spaziotemporale dell’identità il tempo presente (e quindi l’esigenza di difesa) e la paura del futuro, vero e
proprio caterpillar culturale che riduce al qui e subito ogni progetto per il futuro.
Non è una concezione nata con la crisi: la precede. E la Lega ne ha tentato un’istituzionalizzazione
attraverso quell’ondata di ordinanze con cui i veri quadri locali del partito, i sindaci, hanno stabilito
l’esclusione dai benefici della protezione sociale tutti coloro che erano riferibili alle “classi
pericolose”: nullatenenti, immigrati (spesso, con la crisi, le due categorie nei distretti del Lombardoveneto coincidono), senzatetto ecc. Accade anche nella ricca Brianza, dove i volontari della Caritas
che distribuiscono gli aiuti del fondo Famiglia e lavoro a volte si trovano di fronte al mugugno di
una parte della comunità parrocchiale per gli aiuti “agli stranieri e non agli italiani”.
È uno sfondamento culturale ormai all’opera, su questo non c’è dubbio: basti pensare all’ormai
famigerato “White Christmas” di Coccaglio, ordinanza da rastrellamento, alle ronde nei parchi
cittadini come braccio “sociale” dei partiti del rinserramento, oppure all’ordinanza di Adro,
comunello del Bresciano, il cui sindaco leghista ha pensato di escludere i bimbi delle famiglie
migranti morose dalla mensa scolastica … […] Ma non è una deriva limitata soltanto al contado:
dopo i fatti di via Padova a Milano nel febbraio 2010 il lessico prevalso tra i politici ha contenuto
termini come “rastrellamento” o coprifuoco.
La seconda operazione è l’individuazione del nemico attraverso cui ricostruire l’unità della
comunità perduta come comunità maledetta. Quella che abbiamo ritrovato a Opera nel dicembre
2006, quando il paese si è riunito attorno ai fuochi accesi per espellere i rom. Quella di chi per
ritrovare se stesso è (ri)partito dall’esclusione dell’altro da sé. Con il prevalere di una concezione
del territorio come spazio del rinserramento, sfera di una ideologia localistica che del ritorno alle
reti corte del campanile e della famiglia fa il perno dell’uscita dalla crisi. Un populismo che si
alimenta di ideologia differenzialista che considera incompatibili tra loro culture e religioni. E che
parte dall’abitare originario (o supposto tale) di un luogo per stabilire i confini dell’appartenenza e
dell’inclusione nel luogo stesso.
A un dibattito ebbi in sorte di confrontarmi con un alto rappresentante di questa parte politica, il
quale mi disse: “La comunità c’è, è fatta da quelli che abitano, bianchi, cristiani”. Autodefinendosi
fondamentalista nel senso di assertore dei fondamentali: “Abito qui, sono bianco, vado a messa la
domenica”, caratteristiche in base alle quali per questo tipo di populismo torna tutto.» (Bonomi
2010, 105-106)
[ritrovare se stesso partendo dall’esclusione dell’altro! L’esatto contrario del processo di
riconoscimento di sé che è possibile solo a partire dall’altro ( vedi Ricoeur, Percorsi del
riconoscimento); perché solo così è possibile scoprire se stessi come altro o scoprire la propria
intrinseca e irrinunciabile, anzi sorprendente e creativa alterità, che è il vero essere se stessi oltre
l’indispensabile ma riduttiva omologazione (assoggettamento) contenuta nei processi educativi di
adattamento a ruoli sociali preordinati e necessari]
«È a partire dalla forza di questa ideologia che la Lega ha costruito la sua forza di partito del
sindacalismo di territorio e di rappresentante degli impauriti, utilizzandola come grimaldello per
penetrare dal contado nella metropoli entrando dalla porta di servizio: come a Milano, dove quelle
periferie esterne un tempo bastione della coscienza di classe, e della sinistra che ne rappresentava i
destini, si stanno sempre più velocemente colorando di verde.
Lo dimostra anche l’espansione leghista nei territori della vecchia Emilia rossa, sfondata la “linea
Maginot” del Po … […] La Lega sfonda dove l’impatto dei flussi dell’immigrazione si unisce alla
crisi del vecchio modello distrettuale stressato dalla globalizzazione: come nel caso del distretto
della ceramica di Sassuolo oppure nel Forlivese dove il distretto del tessile viene svuotato
dall’interno dall’arrivo in massa dei subfornitori cinesi, o come nella “valle del pollo” dove la
presenza degli immigrati supera il 30 per cento della popolazione. E dove diventa difficile tenere il
modello di civismo e di welfare virtuosi per tutti (Biorcio, 2008). […] [come ulteriore definizione: ]
…dimensione dei flussi della globalizzazione, da cui difendersi ma con i quali nel contempo ci si
deve connettere … è il modello del “sindacalismo di territorio” (Bonomi 2010, 107-108)
7.4.2. Il populismo dell’individualismo proprietario
Stanno in un’antropologia figlia dell’emergere prepotente del capitalismo molecolare … […]
Basterebbe aver percorso qualche volta l’autostrada Torino-Trieste per cogliere il vero punto di
riferimento del berlusconismo: quel mondo fatto da capannoni attorniati da villette con i nanetti nel
giardino e la Bmw nel garage sotto casa. Fotografia non ancora sbiadita, basti pensare alla Brianza
diffusa. A metà anni novanta andai a Treviolo, paesino della Bergamasca. Quel giorno migliaia di
soggetti erano radunati attorno alla nuova “chiesa”, ovvero un enorme capannone — gigantesco —
in cui avevano riunito ottanta imprese artigiane, il fitness, i negozi, gli architetti, i commercialisti, il
volontariato con la sua ambulanza, e la banca, tutto assieme, ritrovandosi come comunità attorno al
capannone.
Il vero simbolo e la vera base del berlusconismo non è mai stata la televisione, ma quel mondo.
Ecco la sua anima profonda. Non averlo capito significa aver ignorato le radici profonde del
fenomeno nell’attuale composizione sociale del sistema-paese. Pensare di eliminare il problema per
via giudiziaria significa non aver capito nulla: valeva negli anni novanta, vale ancora oggi.
Ma soprattutto Berlusconi si è sempre caratterizzato per il suo tratto, che condivide con Sarkozy o
più recentemente con Obama, di essere “presidente del chiunque della moltitudine”. La forza di
Berlusconi, il suo messaggio, si è sempre basato sul potere del chiunque che dà identità al
molteplice. Partendo dalla figura dell’individuo-proprietario, Berlusconi ha costruito una narrazione
che ha creato il “suo” popolo. Ci ricordiamo quanto si sia sorriso del “sogno” del milione di posti di
lavoro nel 1994 o del Berlusconi-operaio nella primavera del 2001? A ben guardare, dicendo: “Io
sono un operaio, un artigiano, un commerciante, un imprenditore una massaia, una giovane partita
Iva…” , Berlusconi ha fatto scattare un meccanismo di comunicazione diretta, uno spazio di
identificazione possibile tra il suo messaggio politico e la frammentazione delle tante figure
scomposte nella moltitudine sociale ove non è più egemone la categoria delle classi come unico
collante identitario. Con una politica che in tempi di molecole sociali e individualità compiute si è
rivolta ai tanti utenti-clienti possibili con tecnicalità da marketing. Creando una macchina politica
moderna adatta ai tempi in cui la forza della politica sta nel realizzare una connessione tra il
chiunque e la moltitudine dei soggetti spaesati dando loro un riferimento. […]
Anche per l’individualismo proprietario, il nodo da sciogliere riguarda allora il rapporto tra locale e
globale. Con il berlusconismo che riesce a imporsi quando reinventa la connessione tra i due termini
…» (Bonomi 2010, 109-111)
7.4.3. Il populismo dell’invidia sociale (che sostituisce la lotta di classe) (Bonomi 2010, 112)
Nello sconquasso politico degli anni novanta, accanto alla cultura del rinserramento territoriale e
dell’individualismo proprietario cresce progressivamente anche una corrente prima sotterranea e poi
organizzata di populismo che definisco giustizialista. …il giustizialismo emerge nei primi anni
novanta come segmento progressista dell’antipolitica e della mitologia della società civile. … Ma,
soprattutto, è la fase della nascita della “piazza virtuale” nel duplice senso di canale di
rappresentazione immediata della crisi sociale e di processo pubblico-mediatico alle élite. […]
Con la crescita dell’Italia dei Valori di Antonio Di Pietro, che nell’evanescenza della sinistra
radicale si muove per occuparne lo spazio politico, con il girotondismo inaugurato da Nanni Moretti
e la sua critica pubblica alla “indecente” classe dirigente dell’Ulivo e ultimamente con il movimento
di Grillo e la sua feroce polemica antipartito, il giustizialismo è diventato un attore che ha messo
alle corde il Pd.
Alle ultime elezioni regionali si è assistito a una capacità del campo populista, sia nel centrosinistra
sia nel centrodestra, di assorbire consenso ai due grandi partiti con una polarizzazione degli
orientamenti di voto. Lo dimostrano i flussi elettorali con il Pd che perde voti in favore dell’Idv,
quest’ultimo in favore delle liste “grilline” e il Pdl che perde in favore della Lega Nord.
Tipicamente populista è la critica della politica brandita dal giustizialismo; una critica giacobina
con una contrapposizione manichea tra il bene incarnato dai cittadini vittime e i partiti carnefici
guidati dalla “casta” dei loro dirigenti. Inserendo nel lessico della sinistra i temi della democrazia
diretta ma anche dell’antipartitismo e del direttismo plebiscitario, come è evidente nel caso del
movimento di Beppe Grillo.
Un magma in cui più recentemente è confluita anche una corrente che nella crisi del capitalismo dei
flussi ha guadagnato un certo rilievo mediatico, come l’idea della decrescita, trait d’union
ideologico tra protezionismi localisti ed ecologismo radicale.
Ho sempre considerato il giustizialismo una strada senza sbocco soprattutto per la sinistra, perché il
giustizialismo appare come un’ombra svuotata dell’idea di progresso e rappresenta in sostanza la
costola di sinistra di una cultura dell’invidia e del rancore.» (Bonomi 2010, 112-114)
7.4.4. Il populismo dolce (Bonomi 2010, 115)
Nella transizione in senso populista della sinistra non sono cresciuti soltanto giustizialismo o
ideologie della decrescita più o meno felice. Esiste un’altra corrente, o meglio esperienza, politica
che definisco di populismo dolce che credo prefiguri una possibile via d’uscita della sinistra dal
cupio dissolvi in cui sembra essersi infilata ormai da tempo.
Come ebbi modo di discutere in un dialogo di qualche anno addietro con Fausto Bertinotti riguardo
all’opportunità per la sinistra di “ricordare il proprio futuro” guardando alle esperienze
comunitariste e territoriali che l’avevano caratterizzata prima che il modello leninista e il fordismo
ne schiacciassero l’identità sullo stato e sulla grande fabbrica, penso che il futuro per la sinistra stia
in una sua (ri)territorializzazione. Nell’assumere cioè sino in fondo l’avvenuto passaggio dal
paradigma capitale-lavoro al paradigma flussi-luoghi. Il populismo dolce può costituire una strada,
perché fondato su un’idea di territorializzazione dei diritti che tuttavia intende il territorio come
spazio della società aperta, non del rinserramento. È un tipo di ideologia che mi pare fondarsi su tre
capisaldi.
In primo luogo, è un’ideologia che può essere definita come populista dolce in quanto portatrice di
un’idea — e di una prassi, nel caso della Puglia di Nichi Vendola — del codice moltitudine-élite
come presa diretta plebiscitaria tra rappresentante e rappresentato; ma senza la verticalità leaderista
del populismo della destra, creando invece una connessione sentimentale tra popolo e leadership più
orizzontale. Fatte le dovute proporzioni, è in gran parte ciò che è avvenuto nel caso della vittoria di
Obama negli Stati Uniti.
In secondo luogo, al centro di questa ideologia emergente è il ritorno al cuore della comunità e della
“fraternità” come valore primario che precede libertà e uguaglianza. … Una comunità che incorpori
una visione del territorio come spazio dell’apertura rispetto alla globalizzazione. […] Con la
costruzione di reti di cooperazione rispetto al mondo balcanico e alla posizione mediterranea della
regione. Dunque, un processo di riappropriazione del popolare, scippato alla sinistra nel corso
dell’ultimo trentennio dal populismo leghista, ma all’altezza della nuova fase di apertura globale.
In terzo luogo, al centro del populismo dolce sta la ripresa del rapporto tra la sinistra e il mito
culturale della modernità; processo che vede al centro come spazio fondamentale di questa ripresa
di controllo il territorio. […]
La sinistra si è opposta alla mercificazione dei beni comuni ereditati dalla tradizione o dalla natura,
ma non è riuscita a progettare nuovi beni comuni (infrastrutture, diritti ecc.) che parlino di un
progetto di ordine economico e sociale alternativo. […]
Nel populismo dolce mi pare invece di scorgere una prospettiva in cui la sinistra torni ad assumere
la modernizzazione (culturale, delle reti, dell’economia, delle élite, della politica ecc.) come lo
spazio culturale entro cui muoversi a partire però dall’emergere di una nuova coscienza di luogo e
del territorio come piattaforma da cui andare nel globale.» (Bonomi 2010, 115-117)
7.5. una nuova forma di populismo avvolgente: il net-populismo
7.5.1. Il dato generale: «La tesi — l’accusa che qui viene sostenuta — è che il mandante (e insieme
l’assassino) sia la tecnica come apparato, che ha cancellato l’individuo, pur esaltandolo nella sua
illimitatezza desiderante e prometeica ma insieme nichilista; che ha rimosso ogni legame sociale
umano affinché si rafforzasse il solo legame tecnico di apparato e di ciascuno con l’apparato, dalla
catena di montaggio alla rete — confermando la tesi di Richard Sennett per cui il regime flessibile
del lavoro e della società degli ultimi decenni permette «quello che sembra un ossimoro, la
concentrazione del potere senza una sua centralizzazione», dove «il controllo dall’alto non solo è
saldo, ma è anche privo di un volto»—; che ha indebolito ogni relazione dia-logica tra io e noi-altri
e tra noi e noi-altri, perché si sviluppasse solo quella (mono-logante) tra io e l’apparato e tra noi e
l’apparato.» (Demichelis 2010, 12)
7.5.2. La biopolitica e la comunità, alle radici (o componenti essenziali) del populismo
«Egemonia. E biopolitica. Scopo di ogni biopolitica è quello di costruire un’egemonia — culturale,
politica, di senso (stili di vita, valori, sistemi di pensiero) per il biopotere che la produce (perché
esiste un biopotere che la produce, sia esso politico o religioso, nel passato, sia esso tecnico). La
governamentalizzazione della vita delle popolazioni e la disciplina degli individui sono le modalità
con cui si costruisce questa egemonia.
Salute, urbanistica, scuola e istruzione, esercito e guerre: le biopolitiche e le discipline (chiuse) del
passato; oggi, biopolitiche e discipline del lavoro, del consumo e del divertimento (discipline
aperte). Biopolitiche per la creazione di un determinato comunitarismo, un comunitarismo
adattativo, conformativo e insieme confermativo rispetto al biopotere (al pastorato) che le produce,
per tutti quegli individui che si trovano dentro a un modello di organizzazione che chiede loro non
solo subordinazione passiva e flessibilità/precarietà, ma anche, e ora sempre di più, una
partecipazione attiva, persino emotiva e divertita alla subordinazione, chiamata collaborazione o
condivisione.» (Demichelis 2010, 211)
7.5.3. il net-populismo nella forma (nella forza e nella logica) della comunità (virtuale).
«…quella società dell’informazione che limita l’informazione moltiplicandola e semplificandola.
Una prigione senza sbarre, la società di oggi, un panopticon con le porte aperte; con molte belle
ragazze sorridenti, con tanti corpi eroticamente esposti come merci da
acquistare/conquistare/desiderare; con tante telecamere che osservano e altre telecamere o webcam
dalle quali piace farsi guardare: tanto si sono introiettati il controllo e l’autocontrollo (in perfetto
stile panopticon) e il dovere di essere come gli altri. Anche nel guardare e nel farsi guardare. Tutti
hanno imparato a vivere in una sorta di gabbia (lo schermo del computer o del televisore, emblema
di un mondo chiuso in una gabbia di significati offerti, di scopi prodotti, di valori consumati),
persino la gabbia d’acciaio di Weber viene vissuta come libertà, una gabbia sempre più
confortevole, piena di corpi belli e seduttivi, di merci belle e seduttive, di divertimento coinvolgente
e seduttivo. Nessun individuo democratico, dunque. Neppure in rete. Meno che meno in rete.
Nasce—è nata— una comunità tecnica, un fare comunità in modalità nuove ma drammaticamente
simili alla tirannide di Aristotele. Dove la visibilità, o meglio l’essere visti e soprattutto il
lasciarsi/farsi vedere, è meccanismo essenziale (sapere biopolitico) di organizzazione sociale. E
oggi «non c’è gioia nel custodire segreti», ha scritto Zygmunt Bauman, «se questi non possono
essere diffusi su Internet, alla TV, sui tabloid o sulle riviste patinate». È allora una comunità che,
offrendo l’illusione di poter essere se stessi (ancora Facebook, con il proprio profilo che illude di
essere e di essere con gli altri con una propria forte identità, data dal profilo esposto, dalla
spettacolarizzazione di sé), in realtà cancella ogni essere se stessi, perché se tutti si espongono e si
mettono in mostra cessano immediatamente di essere se stessi per divenire (ancor più rispetto a
quanto prodotto dal sistema-moda e dal sistema-pubblicità) come gli altri; e il dialogo (apparente)
diventa un gossip moltiplicato per milioni di persone (un gossip collettivo o, riprendendo Anders,
uno scambio tautologico di gossip) e un far sapere agli altri che cosa si sta facendo o pensando. Una
pratica (una norma e una normalità sociale) e un sapere tipici di ogni comunità, dove importante
non è il singolo nodo (il soggetto), ma la connessione, perché in ogni rete (come in ogni comunità)
non conta il nodo, l’individuo, ma solo la sua connessione con gli altri nodi del TUTTO, senza
interruzioni, senza strappi, senza assenze.» (Demichelis 2010, 144-145) «E se la televisione ha
prodotto e continuamente riproduce da un lato video-crazia e dall’altro video-populismo, la rete —
con Facebook e Twitter e i blog — produce da un lato rete-crazia (il potere assoluto e totalitario
della rete) e dall’altro net-populismo (dire in rete soprattutto cose banali, in un crescendo di
comunicazione solipsistica, tautologica e insieme narcisistica, incapace di fare
connessione/interazione autentica e deliberata con altri). Ancora Bauman: «La celebre “prova
dell’esistenza” di Cartesio —penso, dunque sono — è stata ormai rimpiazzata da un’altra, più
consona a quest’epoca di comunicazioni di massa: sono visto, dunque sono. E maggiore è il numero
di coloro che possono (e decidono) di vedermi, più tale prova risulta convincente» (Z. Bauman,
Cinguetto, dunque sono, in “la Repubblica”, 9maggio 2009). [ il riferimento va alla presenza in e
alla connessione con Twitter (tweet, letteralmente “cinguettio”)].
7.6. Per evitare il peggio
«C’è un rischio che di fronte all’avanzata politico-culturale dei populismi va evitato accuratamente.
È il rischio che dentro la crisi si realizzi una saldatura tra un ceto medio riflessivo che aveva creduto
nell’apertura alla dimensione globale, ma che con il passaggio alla globalizzazione hard potrebbe
scivolare verso il basso reddito e stile di vita, e quella base sociale del rancore territoriale che oggi,
sotto i colpi della crisi, pare estendersi.
Una coalizione tra spaesati, stressati, orfani della fabbrica e nuovi ceti medi a rischio di
declassamento strangolerebbe nella culla il bimbo del populismo virtuoso come possibile
evoluzione di una politica della moltitudine. Su questo piano è l’Europa, la sua tenuta, ma
soprattutto la sua trasformazione, lo spazio vitale in cui giocare la partita. Un’Europa chiusa nella
retorica finanziaria dell’euro e in difficoltà nell’essere motore di nuova coesione sociale non
sarebbe in grado di attenuare le spinte alla chiusura identitaria.» (Bonomi 2010, 117)
7.6.1. un piccolo movimento: tra nimby e pimby:
« PIMBY, la medaglia verde. I Nimby sono dappertutto. Not In My Backyard (non nel mio cortile)
sembra essere la risposta automatica a qualsiasi progetto di nuove infrastrutture: «Si, quella centrale
serve, ma fatela da un’altra parte» è la traduzione italiana. Benvenuti, dunque, ai Pimby, Please In
My Backyard, che potremmo tradurre: «Si può fare, parliamone» I primi premi Pimby sono stati
assegnati ieri, da un’associazione con lo stesso nome, a tre comuni. A Candela (Foggia) che ha
accettato la costruzione di una centrale elettrica a gas da 400 megawatt, quindi tutt’altro che
minuscola. A Torino Gerbido (Torino) che ha accettato un termovalorizzatore. A Stella(Savona) per
un parco eolico, ovvero i mulini a vento per l’elettricità. In nessuno dei tre casi, la comunità locale
ha semplicemente piegato la testa. A Candela, ad esempio, il vapore prodotto dalla centrale Edison
riscalderà il più grande impianto europeo per la coltivazione di fiori recisi in serra, con centinaia di
nuovi occupati. Insomma, Pimby significa semplicemente quello che gli economisti chiamano
l’analisi costi-benefici». Pimby non vuol dire, infatti, accettare in silenzio qualsiasi nuova opera. Il
premio va alla capacità di coinvolgere la comunità e la gente nella discussione del progetto, senza
pretendere di paracadutarlo dall’alto. E anche al coraggio di non dire, sempre e comunque,
pregiudizialmente no. Con l’aria che tira, quasi una medaglia al valor civile.» Maurizio Ricci
7.7. il formarsi di movimenti e le loro specifiche funzioni
[Sul tema i riferimenti ai seguenti studi: il tema della sub-politica o aprire i confini della politica in
Beck Ulrich 1986 La società del rischio. Verso una seconda modernità, Carocci, Roma 2000; la
ricerca “sotto la pelle dello Stato” di Bonomi Aldo 2010 Sotto la pelle dello Stato. Rancore, cura,
operosità, Feltrinelli, Milano; le riflessioni sui movimenti sociali in Touraine Alain Analisi critica
dei movimenti sociali, in AA.VV. Le società complesse, ed. Il Mulino, Bologna 1983 e Touraine
Alain 1997 Libertà, uguaglianza, diversità. Si può vivere insieme? (Pourrons-nous vivre ensemble?
Egaux et differents) il Saggiatore, Milano 1998, oltre alle indagini sociologiche sul campo riservate
al fenomeno storico dei movimenti societari.]
Una definizione preliminare di intesa: «… il movimento sociale è ben più che un gruppo di interessi
o uno strumento di pressione politica; esso rimette in discussione la modalità di utilizzazione sociale
delle risorse e dei modelli culturali. … essi rimettono in discussione taluni orientamenti generali
della società. […] Assistiamo così ovunque alla frammentazione dell’azione collettiva e allo
sviluppo di quella che Ulrich Beck chiama “sottopolitica”. […] Ormai, nei paesi industrializzati, gli
unici movimenti societari che possono esistere sono le azioni collettive rivolte direttamente
all’affermazione e al sostegno dei diritti del Soggetto, della sua libertà e dell’uguaglianza.»
(Touraine 1997, 103, 105, 106)
7.7.1. il contesto storico e sociologico del prender forma dei movimenti
«L’idea di movimento sociale si associa a questo grande rovesciamento del pensiero sociologico
che cessa di porre la società nella storia e inizia a interessarsi al modo in cui le società producono la
loro storia, cioè si producono.» (Touraine 1983, 206)
7.7.2. Il metodo di studio sociologico e politico dei movimenti societari
Il metodo specifico dell’indagine è imposto da una doppia consapevolezza: 1. Occorre distinguere
tra movimenti storico-politici (come rivoluzioni e rivolte), movimenti culturali (nei diversi ambiti
della produzione culturale) movimenti societari (o sociali). 2. Con riferimento, privilegiato
sociologicamente, ai movimenti societari: non si tratta degli attori che la narrazione storico
ricostruisce come coloro a cui si consegnano le direzioni del corso storico. Si tratta di realtà e fatti
espressioni sociali da afferrare con una fenomenologia descrittiva sulla base della consapevolezza
che la società definisce se stessa in forza di se stessa.
«La conseguenza più rilevante di questo è che i movimenti sociali non possono in alcun modo
essere considerati delle «forze». Si tratta sì di attori sociali, cioè, per seguire qui la tradizione
weberiana, di attori orientati normativamente e definiti dai loro rapporti con attori sociali. Lo studio
dei movimenti sociali quindi non è lo studio di una situazione e delle sue contraddizioni, di una
classe a sé, studio che dovrebbe venir completato da quello del passaggio all’azione volontaria e
organizzata. Non c’è movimento sociale che non abbia una certa coscienza di sé, cioè il cui senso
possa essere totalmente separato dalla sua coscienza. Non bisognerebbe però concludere che lo
studio dei movimenti sociali può essere ridotto allo studio degli orientamenti dell’attore. In realtà la
conoscenza di un movimento sociale presuppone che l’analisi passi per almeno quattro fasi
principali. [1.] Bisogna innanzitutto definire gli orientamenti del movimento situandolo in un
rapporto sociale specifico e definendo il gioco comune ai due avversari e di cui si disputano il
controllo. [2.] Bisogna in seguito esaminare le condizioni di formazione e di esistenza effettive di
un movimento, ciò che costituisce quello che si potrebbe chiamare una teoria dell’attore. [3.] In
terzo luogo bisogna esaminare la forma storica assunta da un movimento sociale, cioè la
congiuntura in cui esso si pone e i rapporti che si stabiliscono tra esso, i movimenti di innovazione
culturale, i gruppi di pressione e le rivendicazioni e, dall’altro lato, i meccanismi di mutamento
sociale. [4.] Infine, bisogna studiare la prassi e le forme dell’azione, cioè in particolare i
meccanismi mediante i quali si mobilitano le risorse per l’azione, il ruolo che i simboli e rituali
ricoprono in questa integrazione e il tipo di leadership richiesto da questo o quel tipo di azione
collettiva. Come si può vedere, lo studio dei movimenti sociali non costituisce un capitolo
marginale dell’analisi sociologica. Non deve accadere che alla fine di uno studio sul sistema sociale
e sul suo funzionamento appaia un ultimissimo capitolo sui meccanismi di devianza, di
marginalizzazione, di conflitto e di mutamento.» (Touraine 1983, 206-228 passim)
7.7.3. una collocazione strategica dei movimenti societari. La dinamica tra società / movimenti /
quadri. La società esprime, esplicitamente o implicitamente (anche in interviste, sondaggi, opinioni,
atteggiamenti [gesti, ironie, commenti anche in forma di luoghi comuni [magari banalizzati dalla
ripetizione, assenze clamorose, silenzi pubblici ostentati e ricorrenti…] movimenti; i movimenti
esprimono, prendono forma, ricevono l’attenzione da parte di quadri [partiti o istituzioni] intesi
come soggetti – organizzazione di progetti e programmi.
7.7.3.1. Microstrategie di espressione, come “piccolo” esempio. Citazione (del caso italiano e no).
A partire da “una risata vi seppellirà”: «il peggior nemico dell’autorità è il disprezzo e il modo più
sicuro per scuoterne le basi è il riso» Hannah Arendt Sulla violenza; «il potere può essere spiazzato,
anche nei paesi più cupi, con comportamenti creativi come “la battaglia delle pistole ad acqua” che
si accenna in Iran e l’opposizione a Lukashenko fatta … a scoppi di risate per la strada sono
interpretazioni geniali, minimaliste me micidiali, di questa possibilità» (Ilvo Diamanti, La deriva
del partito personale, la Repubblica 1.08.2011) (così come l’ironia in rete e la contraffazione della
pubblicità politica, degli slogan, delle frasi ad effetto e false, delle sopraffazioni. «Non dobbiamo
pensare, tuttavia, a una deriva inevitabile. La crisi dei partiti personali ha, infatti, sollecitato la
reazione di molte “persone”, che agiscono nella società civile e sul territorio, ma anche alla
periferia dei partiti. Ne abbiamo avuto esempio in occasione delle amministrative e dei referendum.
Da ciò la speranza— e qualcosa di più. Che le persone di buona volontà e i mille segmenti del
movimento invisibile cresciuto in questi mesi non si rassegnino.» (Ilvo Diamanti, La deriva del
partito personale, la Repubblica 1.08.2011)
«Del resto, altri fenomeni collettivi recenti (manifestazioni di movimenti,gruppi,comitati,bande...)
avrebbero dovuto suggerire che queste novità non riguardano solo le polizie, ma più ancora la sfera
politica. Che è del tutto disarmata dinanzi a un mondo in cui per organizzare comportamenti
collettivi basterà un tam tam capillare, istantaneo e magari acefalo, che non lascia traccia che nei
tabulati.» Raffaele Simone, La breve vita dei leader, la Repubblica 12.08.2011)
7.7.3.2. in sintesi: «Anzi, i movimenti sociali sono azioni collettive mediante le quali, attraverso
conflitti sociali e valorizzazione di obiettivi culturali, si creano i quadri di riferimento delle prassi
sociali, quadri che poi sono trasformati dalle istituzioni e dalle organizzazioni in forme e prassi di
funzionamento. Di conseguenza, interrogarsi sull’esistenza di nuovi movimenti sociali è il modo più
diretto per domandarsi se non si stia creando sotto i nostri occhi un tipo sociale nuovo, i cui
orientamenti culturali, i principali attori sociali, i campi e le forme di lotta e di contrattazione
sarebbero profondamente differenti da come furono in un tipo precedente e meglio conosciuto di
società.» (Touraine 1983 ivi)
7.7.4. movimenti societari come fattori di cambiamento.
Fattori di consapevolezza e di cambiamento in cui si esprime il positivo del “populismo”. Sono
infatti anche caratterizzati dalla presenza di molti elementi di giudizio, valutazione e progetti di
azione di carattere populistico (denuncia generalizzata [“sono tutti uguali”, “sono tutti corrotti”,
“pensano ai loro interessi”… quasi a voler fugare il sospetto che si parli per scelta politica di parte e
dunque con prevenzione], giustizialismo sommario [“mandiamoli tutti a casa”, “basta con i
politici”, “perché non vanno in fabbrica”, “via la casta” …]; dati che emergono in forma uguale in
movimenti dallo schieramento molto ampio: dai movimenti sociali per la difesa ambientale, ai
“centri sociali”, ai grillini, a “forza nuova” …).
Movimenti di consapevolezza come risulta da un breve confronto storico tra età industriale e età
post-industriale. «Ho spesso fatto notare ciò che separava questi nuovi movimenti sociali da quelli
che avevano dominato la società industriale. In quest’ultima, gli investimenti principali sono
destinati, alla trasformazione dell’organizzazione del lavoro e alla creazione di fabbriche, come è
stato ottimamente insegnato da parecchi testi ormai divenuti classici. Il posto di lavoro, la bottega e
l’officina sono quindi i luoghi privilegiati dei conflitti sociali e il movimento popolare più
importante, il movimento operaio, è definito dalla difesa del mestiere operaio contro
l’organizzazione autoritaria del lavoro che lo spezza e lo sottopone ad un rendimento e a degli
interessi dagli industriali. È per questo che la coscienza della classe operaia non è mai stata tanto
forte quanto nei luoghi specifici in cui ha avuto luogo questa influenza dell’organizzazione del
lavoro sul mestiere operaio, è in particolare nelle imprese di costruzioni meccaniche nel momento
in cui vengono introdotti metodi orientati al taylorismo e al fordismo. L’elemento caratterizzante di
una società post-industriale è che gli investimenti più importanti non mirano più a trasformare
soltanto l’organizzazione del lavoro, cioè i mezzi di produzione, ma gli scopi della produzione
stessa. Questo si manifesta innanzitutto con la capacità delle imprese di inventare e produrre
prodotti nuovi e anche con, l’importanza crescente assunta dalla gestione dell’impresa in rapporto
all’organizzazione del lavoro. Però lo sviluppo delle strutture tecnologiche non è che un aspetto
limitato di una trasformazione la cui importanza nasce dal fatto che gli apparati produttivi sono
anche apparati che producono bisogni.
La capacità di definire gli obiettivi della produzione non sussiste senza il potere di produrre o di
dare forma alla domanda. La dominazione sociale consiste nel ridurre i bisogni a una domanda,
definita essa stessa sulla base degli obiettivi dell’impresa di produzione. Le nostre società
conoscono l’esistenza di tali apparati, in un numero crescente di settori. L’immagine che ci
formiamo del nostro corpo e della salute non è scindibile dal ruolo determinante della medicina
ospedaliera; la nostra rappresentazione del tempo, dello spazio e del mondo è profondamente
influenzata dalla televisione; il nostro tipo di vita è direttamente e indirettamente costruito, anche in
vista di un lontano futuro, da politiche energetiche.» (Touraine 1983, ivi)
7.7.5. la natura sociale (societaria) del movimento, o nei movimenti societari c’è movimento e
movimento: una necessaria e indispensabile distinzione tra movimenti a natura sociale (che danno
voce e priorità al sociale ed esprimono una istanza specifica, vissuta, avvertita) e movimenti a
natura politica (che danno voce e priorità ad una ideologia, alla lotta politica come assalto diretto
allo Stato e alle istituzioni, come assalto al potere e sua conquista rivoluzionaria)
7.7.5.1. La direzione di movimenti societari. «Gli attuali movimenti societari non sono al servizio di
alcun modello di società perfetta e dunque di alcun partito politico… La debolezza e il fallimento di
quelli che alla metà degli anni settanta avevo chiamato “nuovi movimenti sociali” sono dipesi dal
fatto che essi, portatori di nuovi progetti sociali e culturali, hanno voluto subordinarsi all’autorità di
un’ideologia e di una strategia di carattere politico. E la debolezza di queste ultime, rappresentate
soprattutto in Francia da attive minoranze d’ispirazione marxista, non ha purtroppo impedito che
esse soffocassero l’originalità di quei nuovi movimenti sociali, che ben presto si sono scissi in
un’ala radicale, che sosteneva il primato dell’azione politica, e in un’ala più sensibile
all’innovazione socioculturale, ma che si e poi esaurita nel riformismo o degradata in un rigido
comunitarismo. … la società civile si disgrega quando le istanze sociali sono subordinate a un
programma politico.» (Touraine 1997, 106, 107, 111)
La natura e la destinazione sociale del movimento è posta in risalto da un confronto con
‘autoproclamati’ movimenti che hanno come mezzi violenza e terrorismo. «Il terrorismo è per se
stesso, allo stesso modo della guerriglia in altre circostanze, il contrario dell’azione di classe e di
massa. […] Il terrorismo è quindi l’esatto contrario dei nuovi movimenti sociali che si svilupparono
nel corso degli anni sessanta. Il suo contenuto sociale è opposto al loro e inoltre, mentre questi
proclamarono la priorità dei problemi sociali e culturali rispetto alla lotta propriamente politica,
il terrorismo ridà priorità assoluta a quest’ultima. […] Se si aggiunge poi che, nonostante l’evidente
sviluppo del ruolo dello Stato nell’insieme della vita sociale, le società occidentali industrializzate
rimangono in gran parte società civili, non conviene forse rifiutare l’idea di una scomparsa dei
movimenti sociali e conservare l’idea opposta, quella della nascita, forse per la prima volta, di
movimenti propriamente ed unicamente sociali? […] … i movimenti sociali d’oggi vogliono vivere
fin da ora in modo conforme a ciò che deve diventare, secondo loro, il mondo domani.»
Alain Touraine, Analisi critica dei movimenti sociali, in AA.VV. Le società complesse, ed. Il
Mulino, Bologna 1983, p. 206-228 (passim) (e, a proseguire, M.Ilardi 1995 L'individuo in rivolta.
Una riflessione sulla miseria della cittadinanza, Costa & Nolan, Genova; sul comportamento
violento dei black bloc parassitando in manifestazioni organizzate da movimenti societari, osserva
Niki Vendola: «Il blocco nero è l’esatto capovolgimento politico dell’idea da cui sono partiti i
movimenti in questi tre anni, cioè la tutela dei beni comuni. La città, la piazza, nel significato di
bellezza urbana e di luogo della politica, per il blocco nero non sono beni comuni: sono prede.» [la
Repubblica 23.10.2011 p. 24] prede e trofei da esibire.)
7.7.5.2. Nei movimenti “politici” (a priorità politica di potere) la sede degli “antimovimenti sociali”.
«Il mondo contemporaneo è pervaso da antimovimenti sociali, in particolare quando la difesa
dell’identità si scinde dal controllo della produzione, si ripiega verso se stessa e diviene
affermazione di una differenza culturale o storica. Così come nella società industriale il movimento
operaio era legato a un’ideologia progressista e industrialista, oggigiorno numerosi movimenti si
proclamano antimoderni e difendono valori comunitari o nazionali contro le trasformazioni
economiche e le loro conseguenze sociali. Dal multicomunitarismo estremo degli americani alle
sette di ogni specie fino agli integralismi politico—religiosi, vediamo affiorare ovunque azioni di
difesa contro il predominio dell’universo strumentale, ma che nascono in nome di una tradizione
comunitaria invece di difendere la libertà del Soggetto. Talora questi movimenti comunitari
ripiegano sulla difesa di un’autonomia minacciata; talvolta, al contrario, abbracciano la violenza per
combattere le forze che li minacciano o s’oppongono alla loro indipendenza. Gli antimovimenti
sociali sono sempre dominati da un potere politico, si tratti del guru di una setta o dell’avanguardia
politica che mobilita risorse culturali nella sua lotta per il potere. Quel che li differenzia
radicalmente dai movimenti societari è il loro identificarsi con un’entità storica concreta, un
gruppo, un’etnia, una comunità religiosa e così via, e il non rifarsi mai al concetto di Soggetto e
all’universalismo che esso contiene. […]
7.7.6. movimenti, democrazia e soggetto (soggettività)
Occorre sviluppare una radicale critica intellettuale delle ideologie e delle azioni rivoluzionarie, che
hanno sempre portato a regimi di natura totalitaria, dal Terrore fino al leninismo, nonché, in forma
opposta, al fascismo, cioè ai due principali antimovimenti sociali del nostro secolo. L’idea
principale é che la formazione degli attori sociali, e quindi dei movimenti societari, è inseparabile
dalle mediazioni politiche che sono l’elemento centrale e indispensabile della democrazia. Soggetto,
movimenti sociali, democrazia: tre temi altrettanto inseparabili quanto, sul versante opposto,
necessità storica, azione rivoluzionaria e totalitarismo, i quali portano dritti all’inferno della
violenza invece che al paradiso creativo e liberatorio dei movimenti sociali.
Tutti i movimenti societari, a qualunque tipo appartengano, sono portatori di un’aspirazione
democratica. Essi cercano di dare la parola a chi non ce l’ha, per farlo partecipare alla formazione
delle decisioni politiche ed economiche, mentre le azioni rivoluzionarie vagheggiano sempre una
pulizia sociale, politica, etnica o culturale, una società unitaria e trasparente, la creazione di un
uomo nuovo e l’eliminazione di chiunque si opponga all’unanimismo, la cui unica ragion d’essere
si riduce ben presto a quella di plebiscitare un potere totalitario. Un movimento societario non é né
una lotta all’ultimo sangue, né una mera campagna per le riforme. […]
I dirigenti e gli intellettuali rivoluzionari, populisti o integralisti sono agenti attivi di distruzione dei
movimenti sociali.» (Touraine 1997, 127, 131, 132)
7.7.6.1. le identità plurime (le ontologie regionali [Husserl]) Occorre andare oltre gli stereotipi del
"vuoto", della "crisi di senso" ecc.; ad essi si oppone la proliferazione dei sensi. Le espressioni
stereotipate, se mantenute, vanno ridefinite perchè diventino strumenti di lettura del reale. Se la
"crisi di senso" va intesa come l'incapacità ad elaborare e proporre a tutti i membri della società un
sistema di riferimenti (idee, norme, valori, ideali) che diano un senso stabile all'esistenza, alla
costruzione di una identità unica attraverso la comunicazione, la produzione ecc., allora, così intesa,
la "crisi di senso" non significa assenza radicale di senso; al contrario: proliferazione di senso.
Società globale e mondializzazione sono il contesto in cui l'uomo libero, deterritorializzato,
l'individuo sradicato, assoluto, svincolato dalla appartenenze, viaggia nomade nello sviluppo
dell'economia e della cultura mondiale; in questo viaggio ognuno si può impadronire delle
immagini, dei simboli, dei riti di appartenenza che più gli aggradano. Mondializzazione,
deterritorializzazione inducono la crisi di senso per ciò che già non è più, dunque si tratta di una
"non-crisi", di una sfida, di una ripartenza.
7.7.6.2. centralità dell’idea di Soggetto nei movimenti societari (come conclusione).
«La tematica dei movimenti societari è una sfida sia per il pensiero liberale che per l’ideologia
rivoluzionaria, perché nessuno dei due crede nella capacita dei protagonisti sociali di produrre la
loro storia attraverso i propri orientamenti culturali e i propri conflitti sociali. […]
Certo, i movimenti societari urtano in ogni secolo contro grossi ostacoli, creati non soltanto dalla
miseria ma anche dalla ricerca di soluzioni individuali o da speranze di carriera dentro il sistema, e
però tali ostacoli non sono oggi più insormontabili di quanto non lo fossero ieri. Non esiste infatti
alcuna situazione che sia del tutto favorevole ai movimenti societari, e di certo la società industriale
non lo era più di altre. Quel che cambia è la natura dei comportamenti che s’intrecciano con i
movimenti societari e cercano di servirsene. Il richiamo al popolo, alla nazione o a una chiesa ha
spesso trasformato i movimenti popolari in antimovimenti sociali; e l’ideale rivoluzionario ha
trasformato vari movimenti societari in regimi totalitari. Oggi è l’ossessione identitaria che
attanaglia i movimenti societari, la quale trasforma in straniero l’avversario e sostituisce all’ideale
della liberazione la ricerca fanatica dell’omogeneità e della purezza. […]
Se insisto a collocare l’idea di Soggetto al centro dell’analisi è perché miro a liberare il movimento
societario, qualunque esso sia, dagli strumenti politici e dagli apparati ideologici che,
stravolgendolo, impediscono di scorgere in ogni movimento di questo tipo un richiamo alla libertà
del Soggetto. […]
Da una parte, gli orientamenti culturali, separandosi dai conflitti sociali e politici, si
“moralizzano”, diventando principi di appartenenza o di esclusione, meccanismi di controllo
culturale o norme di conformità sociale. D’altra parte, i conflitti politici, separati dai movimenti
societari, si riducono a una lotta per il potere, favorendo una dissociazione fra Stato e società che
diviene sempre più patologica per effetto della produzione, del consumo e delle comunicazioni di
massa. Infine, le rivendicazioni lasciate a se stesse tendono ad aumentare le disuguaglianze, poiché
sono le categorie più forti e influenti quelle che hanno maggiori interessi acquisiti da difendere e la
maggiore capacità di pressione rivendicativa. Vediamo così sovrapporsi ristretti gruppi di pressione,
movimenti che rifiutano categorie considerate come minoranze, devianti o allogeni sociali e
culturali, e un populismo comunitario che si richiama in maniera indeterminata al popolo contro i
dirigenti politici o gli intellettuali. A prima vista, sembra che ognuno di questi aspetti della vita
sociale o politica possa essere analizzato indipendentemente, ma ciò si rivela ben presto impossibile
in quanto nessuna azione collettiva è una mera difesa razionale di determinati interessi o
un’affermazione di valori comunitari, poiché tutte recano in sé tracce di un movimento sociale
assente o disgregato. Non sempre il movimento esiste, ma ne va ipotizzata l’esistenza per
comprendere i comportamenti collettivi che se ne allontanano e quelli che già la preannunciano o
l’alimentano. Abbiamo assolutamente bisogno di una simile ipotesi, perché viviamo in una società
sconvolta e priva di autocoscienza, in cui restano oscuri gli obiettivi e i protagonisti del
cambiamento storico, e dove i discorsi e le ideologie sono in ritardo rispetto alle pratiche (o, al
contrario, conferiscono loro un’artificiosa radicalità).»
Touraine Alain 1997 Libertà, uguaglianza, diversità. Si può vivere insieme? (Pourrons-nous vivre
ensemble? Egaux et differents, il Saggiatore, Milano 1998 (135-137)
Sono in ritardo rispetto alla società che produce la propria storia e alla sociologia che «che cessa di
porre la società nella storia e inizia a interessarsi al modo in cui e società producono la loro storia,
cioè si producono.» (Touraine 1983, 206); si è tornati alla priorità della sociologia come fine e
contesto dell’agire… o forse a Socrate che vede nel confronto dialogico l’unica sede per costruire
secondo giustizia e verità.
«Anche se una società pluricomunitaria è impossibile, la società può rendere possibile la
comunicazione interculturale, riconoscendo e tutelando lo sforzo di ogni individuo per costituirsi in
Soggetto e incoraggiando ciascuno a riconoscere e amare lo sforzo che gli altri compiono per
realizzare, ogni volta in maniera diversa, una coniugazione di strumentalità e identità. Ciò implica
che la società rinunci sia a identificarsi con l’universalismo, cancellando qualsiasi appartenenza
sociale e culturale a vantaggio della cittadinanza, sia a definirsi in quanto comunità d’origine o di
destino. » (Touraine 1997, 151; concetto più volte ribadito… esempio p. 181 e 259)
«… è diventato impossibile confondere lo Stato con il sistema politico. […]
… oggigiorno l’attività democratica tende ad essere rivolta, più che verso lo Stato, verso gli attori
sociali stessi. […]
Ma non si tratta soltanto di una rottura con il giacobinismo e il centralismo democratico (di cui ben
conosciamo il significato attribuitogli dai partiti comunisti); si tratta, più in profondità, di sostituirli,
in quanto principi d’integrazione della società, con la libertà del Soggetto. Oggi, infatti, occorre
conciliare la partecipazione di ciascuno al mondo degli scambi e delle tecniche con la difesa della
sua identità culturale. Questa sintesi realizzarsi solo attribuendo un valore centrale alla capacità e
alla volontà d’iniziativa di ciascun attore, individuale o collettivo, di costruire un’azione personale,
la cui forma più alta è una storia di vita, ossia la capacità di trasformare situazioni in elementi di un
progetto personale. La democrazia slitta verso il basso: si sposta dal rapporto fra Stato e sistema
politico verso il rapporto fra sistema politico e attori sociali. Se un tempo essa aveva creato la
cittadinanza al di sopra di una società civile frammentata e gerarchizzata, oggi sostiene la diversità
dei soggetti, delle culture, delle associazioni e delle minoranze e, soprattutto, la libertà che, in una
società diversificata e in cambiamento, si basa sul riconoscimento dell’Altro in quanto Soggetto.
L’universalismo dei diritti dell’uomo l’aveva collocata al di sopra di ogni interesse e di ogni potere,
anche di quelli che pretendevano di parlare in nome della maggioranza. Ma più gli stati si sono
caratterizzati come sostenitori di una maggioranza, di una classe o di una nazione, più questa
concezione universalista e individualista è stata travolta dalle mobilitazioni di massa. Questo ci
impone, dopo un secolo dominato dai regimi autoritari o totalitari e dalle sedicenti democrazie
popolari, rivoluzionarie o nazionali che fossero, di dare un’espressione diversa all’idea dei diritti
umani, che devono trasformarsi in diritto all’individuazione concreta, e non più consistere soltanto
in quello di appartenere a umanità astratta.
É esattamente su questo punto che si contrappongono la liberta degli Antichi e quella dei Moderni,
per riprendere l’idea cara a Benjamin Constant. Finché la democrazia cerca il proprio fondamento
vuoi nell’interesse della polis, vuoi nel movimento della storia, predomina la libertà degli Antichi,
legata a un’etica del dovere e a una politica del progresso. Ma quando le divinità della polis o della
Storia invecchiano e muoiono, allora la libertà diventa interiore e, di conseguenza, l’idea
democratica, che non può più rifarsi contro i poteri a un principio superiore a essi, deve fare appello
alla resistenza del Soggetto personale, al suo desiderio di essere attore, artefice della propria
esistenza contro una logica civile o storica che gli appare sempre più distruttiva della propria liberta
e, ancor più, della propria identità. Da questo momento in poi, l’idea democratica si volta contro
ogni filosofia della storia. » (Touraine 1997, 258, 259)