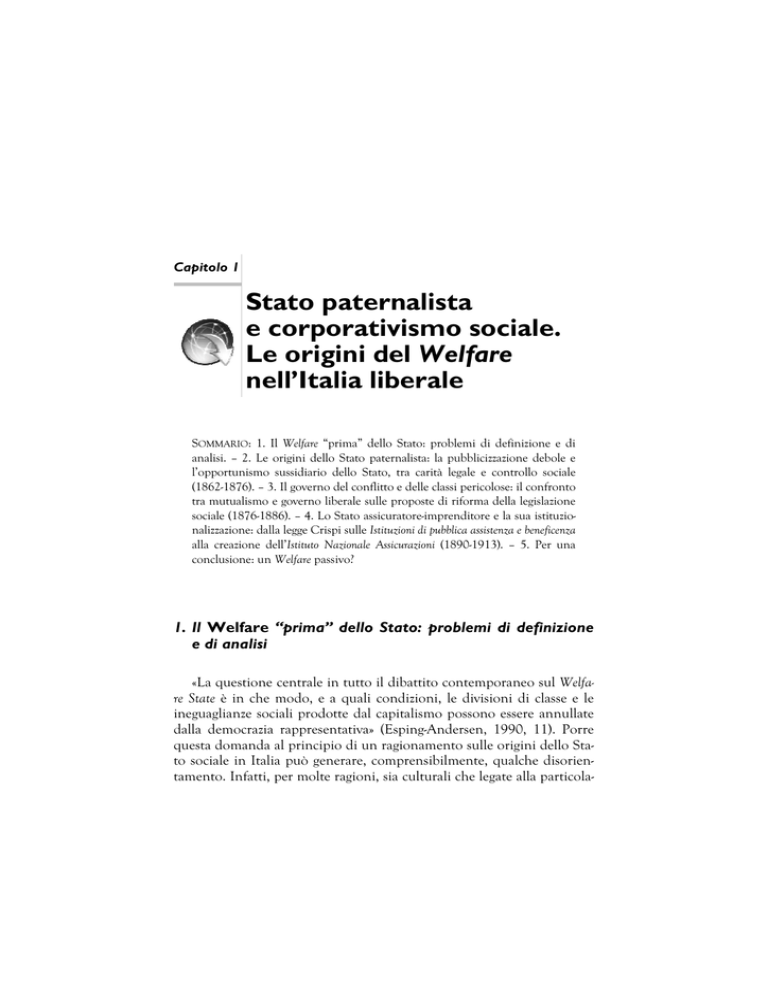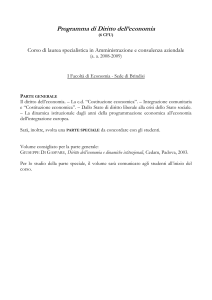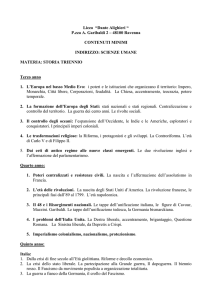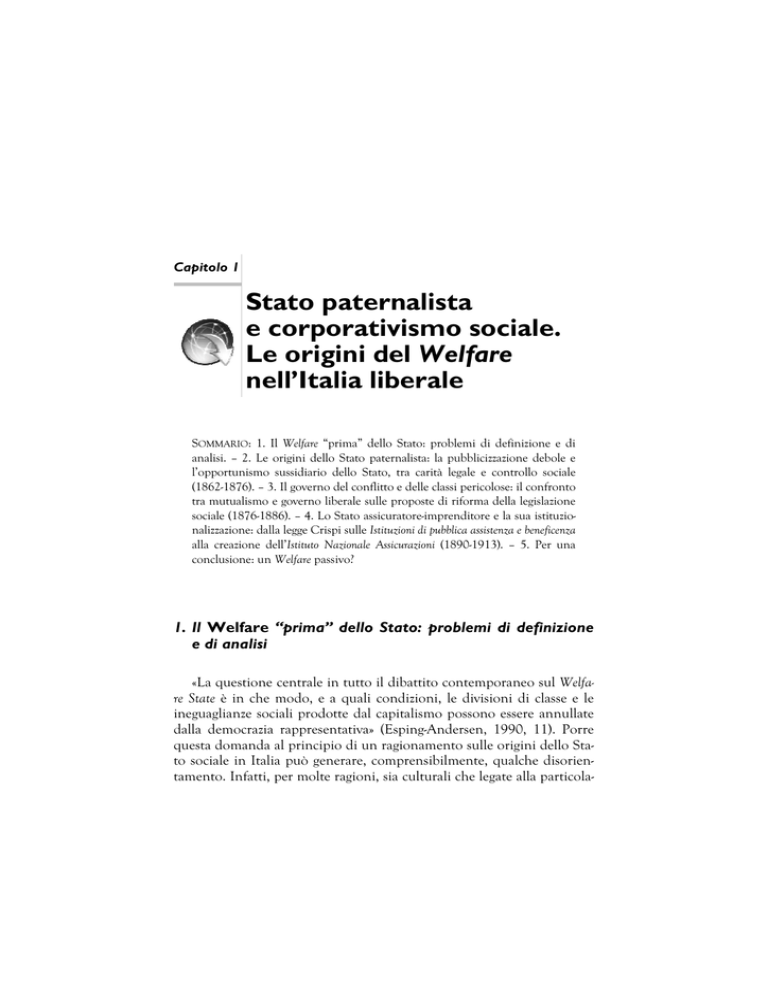
Capitolo 1
Stato paternalista
e corporativismo sociale.
Le origini del Welfare
nell’Italia liberale
SOMMARIO: 1. Il Welfare “prima” dello Stato: problemi di definizione e di
analisi. – 2. Le origini dello Stato paternalista: la pubblicizzazione debole e
l’opportunismo sussidiario dello Stato, tra carità legale e controllo sociale
(1862-1876). – 3. Il governo del conflitto e delle classi pericolose: il confronto
tra mutualismo e governo liberale sulle proposte di riforma della legislazione
sociale (1876-1886). – 4. Lo Stato assicuratore-imprenditore e la sua istituzionalizzazione: dalla legge Crispi sulle Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza
alla creazione dell’Istituto Nazionale Assicurazioni (1890-1913). – 5. Per una
conclusione: un Welfare passivo?
1. Il Welfare “prima” dello Stato: problemi di definizione
e di analisi
«La questione centrale in tutto il dibattito contemporaneo sul Welfare State è in che modo, e a quali condizioni, le divisioni di classe e le
ineguaglianze sociali prodotte dal capitalismo possono essere annullate
dalla democrazia rappresentativa» (Esping-Andersen, 1990, 11). Porre
questa domanda al principio di un ragionamento sulle origini dello Stato sociale in Italia può generare, comprensibilmente, qualche disorientamento. Infatti, per molte ragioni, sia culturali che legate alla particola-
2
Capitolo 1
re tradizione scientifica italiana, gli studi storici organici sul fenomeno 1,
a parte i molti che ne hanno analizzato a fondo aspetti più specifici o
contemporanei, non sono numerosi. Questo per molto tempo ha segnalato, anche, la poca attrazione esercitata dal tema sotto il suo aspetto
complessivo, e non soltanto inteso nelle sue ricadute per l’economia
pubblica e le istituzionali previdenziali, assistenziali, o quant’altro.
È vero, insomma – com’è stato notato – che «l’Italia non è certo annoverata tra i modelli» di Welfare, e che a ciò è connessa la «scarsa rilevanza complessiva che [essa] ha rivestito nell’elaborazione e nello sviluppo di teorie e modelli originali di Stato sociale» (Gaeta, Viscomi,
2003, 227). Ma questo dato, per molti aspetti incontestabile, non
esclude affatto ma forse accresce l’interesse per uno studio organico sulle origini e sullo sviluppo delle istituzioni del Welfare in Italia; se con
questo si intende non certamente una indagine esaustiva sul tema – ci
mancherebbe altro – bensì l’obiettivo di costruire, come avvenuto per
altri paesi (Heclo, 1974; Alber, 1987; Baldwin, 1990; Flora-Heideneheimer, 1993; Ritter, 2003), un modello di analisi storica e politicoistituzionale di tipo organico, ovvero che intenda la questione del Welfare in Italia nel senso che il fenomeno, tra la fine dell’Ottocento e gli
anni ’70 del Novecento, ha assunto nei principali paesi europei:
l’ultima forma di modernità occidentale attraverso lo Stato, ovvero un
modello complesso di organizzazione economica, politico-istituzionale e
sociale espresso attraverso la democrazia.
Cosa, chi, come e perché. Sono queste, in fondo, le domande a cui rispondere se si intende ricostruire ed interpretare l’origine del modello
italiano di Welfare nell’Italia liberale, negli anni che vanno dall’unificazione politica, amministrativa ed economico-sociale del paese a quelli immediatamente precedenti il primo conflitto mondiale, e che da
molti sono considerati l’età di affermazione di quello Stato “assicuratore” che contraddistinguerebbe il caso italiano.
La prima questione è più insidiosa di quanto appaia. È noto come in
Italia, comunemente ad altri paesi europei, inizi dagli anni che coincidono con il primo decollo industriale – gli anni novanta e l’inizio del
ventesimo secolo – l’espansione dell’intervento economico e sociale del1
Cherubini (1977), Ferrera (1984), Conti (2005).
Stato paternalista e corporativismo sociale
3
lo Stato, che assume i due volti del protezionismo e della legislazione
sociale. Più difficile è il giudizio su come la scelta maturi, e se questa sia
anche solo parzialmente collocata dalla classe dirigente liberale in un
coerente modello di sviluppo in senso sociale ed economico dell’azione
pubblica.
Questo si collega alla questione del tipo di intervento economico e
sociale dello Stato, che, dal principio, caratterizza l’esperienza italiana
sotto molti aspetti (cioè, il “cosa”). Il collegamento molto spesso citato
con la coeva esperienza bismarckiana è, da questo punto di vista, opportuno ma non esaustivo. Sia le politiche industriali che quelle sociali espresse dai governi liberali nei due decenni della repressione (18931899) e della riforma (1901-1913) attingono certamente all’esperienza
tedesca sotto alcuni aspetti (modello assicurativo-previdenziale, concezione corporatista, uso della protezione sociale anche per fini di controlo politico). E tuttavia sembrano mancare nel caso italiano sia un preciso
disegno legislativo ed istituzionale che una visione complessiva della progettazione politica, economica e sociale di medio periodo sottese al nuovo ruolo assunto dallo Stato. Fin dal principio, le politiche di riforma appaiono di ispirazione “residualista”, l’impegno finanziario pubblico è generalmente esiguo o mal congegnato, e nel complesso il modello di intervento economico e sociale dello Stato (la politica di pubblicizzazione) avanza “a
pezzi e bocconi” e senza un chiaro orizzonte, dalla legge sulle IPAB del
1890 fino alla creazione dell’INA nel 1912.
Molto rilevante è anche la questione del “chi”, ovvero di quali soggetti emergono in età liberale a farsi carico, con differenti ruoli, delle
politiche sociali. Da questo punto di vista, l’esperienza italiana – pur tra
mille ambiguità – segnala una sua identità precisa, caratterizzandosi ab
initio prima di tutto per la forte componente privata del Welfare, grazie
non solo alle reti di protezione sociale di tipo caritatevole costituite dagli istituti e dalle opere benefiche ecclesiastiche, sottoposte a pubblicizzazione già dal 1862, ma anche grazie alla vivacità rappresentata dal sistema del mutualismo, precedente in qualche caso l’unificazione stessa
del paese. Le realtà del movimento cooperativo, delle società di mutuo
soccorso, della fratellanza, costituiscono già dagli anni ’60 dell’Ottocento un pilastro effettivo del solidarismo economico e sociale indipendente dall’intervento dello Stato, ma anche una soggettività politica
molto ingombrante per le classi dirigenti liberali. Ogni qual volta, infat-
4
Capitolo 1
ti, il governo o il parlamento tentano di allargare l’iniziativa dello Stato
in materia sociale, dai conflitti nel lavoro, all’assicurazione o alla previdenza, alla regolamentazione dei fondi di beneficenza e degli istituti caritatevoli, incontreranno spesso la diffidenza se non la resistenza di questi corpi intermedi all’azione invadente dello Stato in materia sociale,
non tanto in nome della difesa di una visione liberista dell’economia –
che né il movimento operaio, né buona parte del solidarismo “bianco”
interpretano – quanto, piuttosto, a vantaggio di un modello di politica
sociale fondato sull’azione e il primato dei corpi intermedi, che rappresenta, se si vuole, il gene sussidiario del modello italiano di Welfare, ma
ne caratterizza anche lo sviluppo in senso assicurativo-corporativo.
In ultimo, il “come” e il “perché” spiegano molto sulle origini del
Welfare italiano. Ad un primo approccio, infatti, il caso italiano si segnala, soprattutto negli anni fondativi, ovvero in quelli a cavallo tra i
due secoli, per un difetto di progettazione politica e di modello di sviluppo istituzionale, cioè per l’assenza di una visione comune, diffusa e
sostenuta tra le classi dirigenti sul come fare politica economica e intervento sociale attraverso lo Stato.
Sotto quest’ultimo aspetto, la questione investe il problema delle
forme strutturali dell’intervento pubblico, i rapporti con il sistema delle
istituzioni e dell’amministrazione, il ruolo della costituzione economica
nell’Italia postunitaria.
In assenza di una chiara progettazione, almeno in età liberale,
l’impressione è che tra le variabili maggiormente determinanti nello sviluppo del modello di Welfare quella istituzionale-amministrativa abbia
rivestito – coerentemente con il modello “statualista” che ha guidato la
formazione e lo sviluppo nazionale – un certo peso. L’influenza del modello istituzionale e amministrativo sullo sviluppo del cd. Stato sociale è stata
alta, soprattutto perché negli anni in cui l’intervento economico dello
Stato liberale e la legislazione sociale si dilatano, si assiste, comprensibilmente, al “decollo amministrativo” dello Stato. Un decollo che si
esprime attraverso processi interni all’amministrazione – espansione e
meridionalizzazione del personale pubblico, “fuga dallo Stato” e nascita
delle amministrazioni parallele – in parte indipendenti dalla nascita dello Stato assicuratore, e che si legavano alla forte crisi politica attraversata dal sistema liberale in quegli anni.
Stato paternalista e corporativismo sociale
5
2. Le origini dello Stato paternalista: la pubblicizzazione
debole e l’opportunismo sussidiario dello Stato, tra carità legale e controllo sociale (1862-1876)
Centralismo e liberismo possono essere considerati, da un certo
punto di vista, i caratteri culturali prevalenti del progetto attraverso cui
la classe dirigente unitaria perviene alla fondazione dello Stato nazionale tra il 1859 ed il 1865. Ed è infatti nel complesso di leggi approvate in
quegli anni, che presiedono al consolidamento dell’accentramento istituzionale e a disciplinare l’assetto amministrativo del nuovo Stato, da
un lato, e a riaffermare un modello di sviluppo economico-sociale fondato sul dominio della proprietà agraria per la costituzione di un mercato interno, dall’altro, che bisogna guardare per rintracciare il profilo
originario dei rapporti tra Stato ed economia e Stato e società nel nuovo regno.
L’estensione del Codice Civile, l’approvazione delle fondamentali
leggi di unificazione amministrativa del 20 marzo 1865, ma anche la
prima ondata di privatizzazioni e, nel 1866, l’incameramento dei beni
dell’asse ecclesiastico, disegnano un ruolo dello Stato ispirato all’accentramento amministrativo e al disimpegno economico e sociale pubblico,
e dunque caratterizzato «dall’assenza di una macchina statale di governo
dell’economia» (Cassese, 2012, 11).
Le prima tracce della legislazione sociale unitaria, che emergono in
questo humus culturale e dentro il disegno istituzionale e amministrativo appena descritto, risalgono all’agosto del 1862, e precisamente alla
legge Rattazzi n. 753 sull’amministrazione delle opere pie e degli enti
caritatevoli.
La legge affermava la volontà non di sottoporre le opere pie alla catena di comando del nuovo Stato, ma a quella di controllo, attraverso
oneri di regolamentazione della vita amministrativa, patrimoniale e
contabile di tutti quegli «istituti di carità e beneficenza» che avessero «in
tutto» (art. 1) o anche solo «in parte» (art. 2) l’obiettivo di «soccorrere
alle classi meno agiate», escludendo dal novero, in sostanza, solo le opere costituti da lasciti temporanei e le società di mutuo soccorso.
Va considerato, preliminarmente, che si trattava di una realtà che,
secondo le statistiche del Ministero dell’Interno, contava al 1861 circa
6
Capitolo 1
18.000 enti e alla fine del secolo ne avrebbe fatti contare circa 27.000
(Sepe, 1995, 70). La legge affidava l’amministrazione di queste opere a
«corpi morali, consigli, direzioni collegiali o private», disciplinandone la
vita interna secondo un principio di autonomia statutaria, con il solo
obbligo di deposito e comunicazione di statuti e regolamenti presso il
prefetto (artt. 4 e 5), al quale era affidato il controllo sugli stessi per tutti i casi di incompatibilità di questi con l’ordinamento e di conflitto di
interesse palese (artt. 6 e 7) ravvisabile tra gli amministratori delle opere.
Importante era anche l’obbligo di archivio e inventario patrimoniale
imposto a queste amministrazioni sociali regolamentate pubblicamente
(artt. 8-13), imponendo un tesoriere per alcune di esse, l’obbligo di asta
pubblica per molti movimenti patrimoniali, regole di bilancio omogenee.
A conferma di questo nuovo regime di controllo statale sul regime
economico-finanziario e sull’attività amministrativa delle opere, esse venivano espressamente poste sotto «la tutela della rispettiva Deputazione
provinciale» (art. 14), che ne approvava i regolamenti di amministrazione (art. 15), i conti consuntivi e i bilanci, se cofinanziati dalla provincia
(art. 16), i movimenti patrimoniali immobiliari e le deliberazioni a questi connesse (artt. 17-18). Inoltre, al termine della catena gerarchica del
controllo, vi erano i poteri concessi al ministro dell’interno, significativamente inclusi nel titolo sull’«ingerenza governativa nell’amministrazione delle opere pie». Secondo la legge (artt. 19-25) il ministro sorvegliava («inviglia») il regolare andamento delle opere pie, iniziava il
procedimento che avrebbe condotto – nei casi di inadempienza alla legge – al decreto reale di scioglimento delle opere, poteva sospendere o
riformare l’amministrazione di un opera, istigare alla fondazione di una
nuova amministrazione caritatevole ove necessaria.
In ultimo, la legge provvedeva all’istituzione di un organo amministrativo di livello comunale, le congregazioni di carità (art. 26). Presieduto e composto, a seconda della grandezza del comune, da quattro o
otto membri più il presidente, tutti nominati dal consiglio comunale, il
nuovo organo aveva il compito di amministrare nel comune «tutti i beni destinati genericamente a pro dei poveri … quando nell’atto della
fondazione non venga determinata l’Amministrazione, Opera pia o
pubblico stabilimento in cui favore sia disposto» (art. 29).
Proprio quest’ultimo articolo era significativo di una idea dell’assi-
Stato paternalista e corporativismo sociale
7
stenza pubblica e della sua istituzionalizzazione nutrita dalla classe dirigente liberale, che potrebbe sintetizzarsi nel rifiuto di esplicito finanziamento ma nella volontà di controllo, regolamentazione e patrimonializzazione da parte dello Stato di una realtà – che oggi definiremo di
privato sociale – fatta di enti di beneficenza, istituti caritatevoli, donativi e lasciti privati rivolti all’assistenza di poveri, malati e mendicanti secondo uno schema di azione essenzialmente non-organico e caritatevole. Insomma, regolamentare e pubblicizzare debolmente le azioni assistenziali sociali esistenti, ovvero aumentandone il controllo Statale ma
non l’impegno finanziario e “politico” pubblico, può essere il modo di
sintetizzare l’esordio della legislazione sociale unitaria. Una sorta di legalizzazione della carità.
E proprio dal generale intento di legalizzare la carità, bisogna in
qualche modo partire per comprendere il senso del provvedimento del
1862 sulle opere pie. La legge, come si è notato, non contraddiceva affatto il principio liberista, ma anzi ribadiva l’aspirazione al controllo sociale ed alla regolamentazione del conflitto, in tutti i suoi aspetti, da
parte della borghesia liberale, attraverso quello schema ispirato al «paternalismo amministrativo» che trovava nell’amministrazione prefettizia
non solo l’articolazione del potere dello Stato sul territorio, ma anche
lo strumento di compensazione degli interessi locali con quelli nascenti
dal nuovo centro politico (Sepe, 1995, 26).
Il progetto di debole pubblicizzazione delle istituzioni di assistenza
sociale contenuto nel provvedimento faceva emergere due caratteri originari che risulteranno costanti nella legislazione sociale di età liberale.
Il primo è rappresentato dalla concezione residuale dell’intervento economico e sociale dello Stato, che si pone come autorità regolatrice e di
controllo rispetto alla politica sociale “preesistente lo Stato”, il cui corollario è il disegno non omogeneo delle prestazioni (in senso orizzontale) e non universale, dunque non fondato su un’idea dei diritti sociali,
ma essenzialmente pietistico-caritatevole e rivolto a segmenti sociali
marginali e ristretti, e sostanzialmente agli inabili, agli orfani, all’assistenza ospedaliera e caritatevole.
Le origini di questi aspetti vanno ricercate, tuttavia, non solo nella
cultura liberista e centralista espressa dai governi liberali, ma anche nella resistenza all’invadenza statale in campo sociale espressa da parte di
tutte quelle realtà, ecclesiali ma anche del movimento dei lavoratori,
8
Capitolo 1
che già prima dell’unificazione e in misura certamente differente tra le
varie zone del paese garantivano una rete di solidarismo e mutualismo
sociale minima ma diffusa, se si vuole il gene sussidiario del Welfare italiano alle sue origini. Anche se, di fatto, nel primo quarantennio di vita
dello Stato, «alle classi dirigenti era funzionale l’esistenza di un sistema
caritativo-assistenziale, gestito da istituzioni autonome, che esimeva il
potere pubblico dall’intervenire direttamente» (Sepe, 1995, 69).
Il secondo aspetto, invece, riguarda più il fronte degli obiettivi. Già
con la legge del 1862 – lo denota anche il dibattito politico – emerge la
volontà della classe dirigente liberale di intervenire sul sistema della
protezione sociale e dell’assistenza (se così allora la si poteva definire)
certo con l’obiettivo di regolamentarne in senso pubblicistico i bilanci,
le pratiche, l’azione senza invaderne l’autonomia, ma anche con il fine
neanche tanto celato di governare seppur mediatamente l’assistenza con
fini di controllo politico-sociale e, soprattutto, sottoponendo – nel caso
delle Opere pie – al controllo economico e fiscale del prefetto una dinamica da cui nasceva una partita politica importante, «che aveva come
posta in gioco gli oneri per l’assistenza ai poveri» e il controllo del territorio, giacché «specialmente nei grandi centri urbani le opere pie erano
in grado di condizionare la vita politico/amministrativa» (Sepe, 1995,
26 e 70).
3. Il governo del conflitto e delle classi pericolose: il confronto tra mutualismo e governo liberale sulle proposte
di riforma della legislazione sociale (1876-1886)
La legge del 1862 escludeva dalla pubblicizzazione le società di mutuo soccorso. Ciò non era casuale. Bisogna considerare che la tradizione
del mutualismo artigiano, contadino e poi operaio, sotto le forme dell’assistenza familiare, sanitaria, ma anche negli aspetti connessi ad azioni di sostegno economico attivo, come nel settore del credito e del sostegno agli infortunati sul lavoro, era in Italia, già prima dell’unificazione, forte e diffusa in alcune zone del paese. Già negli ’50 le società operaie italiane, soprattutto in Piemonte, Toscana e in Lombardia,
contavano diversi iscritti e disponevano di una importante rete associa-
Stato paternalista e corporativismo sociale
9
tiva, poi rafforzata dalle fratellanze mazziniane (Manacorda, 1992, 3 ss.),
che negli anni ’60, appunto, spinsero le società verso un Patto di coordinamento generale.
Nei due decenni aurei del mutualismo italiano, gli anni ’60 e ’70
dell’Ottocento, una parte della classe dirigente liberale, quella che intuisce gli effetti sull’ordine sociale della industrializzazione, inizia a coltivare l’idea di regolamentarne legislativamente le attività con un duplice obiettivo: governare in senso pubblico – com’era avvenuto per gli
istituti di beneficenza – una rete di protezione sociale, il germe dello
Stato assicuratore, deresponsabilizzando in senso fiscale e politico lo
Stato rispetto alla questione sociale; controllare il potenziale politico del
mutualismo, concependo la regolamentazione statale come un «terreno
privilegiato della borghesia, nel tentativo di riaffermare la propria egemonia sulla società italiana» (Degl’Innocenti, 1981, 5).
Non a caso la «questione del riconoscimento giuridico delle società
di mutuo soccorso era antica quanto le società stesse» (Manacorda,
1992, 93). Per la classe dirigente liberale si trattava, come per la regolamentazione statale delle opere pie, di trovare una soluzione tale da coniugare nel ruolo dello Stato un controllo politico forte e un impegno
fiscale debole; un’opzione paternalistica, coerentemente con la cultura
prevalentemente liberistica ed agraria dei liberali, che intendevano separare la questione sociale da quella dell’industrializzazione, per la paura che la «formazione di vaste concentrazioni operaie» minacciasse
l’ordine sociale fondato sulla grande proprietà terriera (Castronovo,
2005, 90-92), e dunque indebolisse il predominio di un determinato ceto dirigente.
Come con la legge Rattazzi del 1862, la vicenda della legislazione e
delle istituzioni sociali in Italia prosegue, dunque, sui binari del sostanziale disimpegno fiscale e politico del pubblico, attraverso il tentativo di
includere i segmenti della solidarietà sociale preesistenti allo Stato – la
beneficenza, ed ora l’assicurazione sociale e i germi della previdenza –
dentro un regime di controllo e regolazione pubblicistica, secondo un
uso opportunistico della sussidiarietà sociale.
La vicenda della legislazione sociale postunitaria avanza, dunque, negli anni ’70, affiancando al tema della beneficenza quello dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e poi della previdenza.
È la Sinistra storica al potere a proporre la questione, con l’obiettivo
10
Capitolo 1
– anche – di raccordarsi con un crescente segmento del consenso sociale, più di tipo industriale-urbano, che il gruppo di Depretis cercherà di
cooptare anche con l’allargamento del suffragio operato nel 1882. Il primo progetto di riforma, presentato il 9 giugno del 1877 dal ministro
Maiorana-Calatabiano, propone il riconoscimento giuridico e la regolamentazione delle attività delle società di mutuo soccorso, secondo uno
schema simile alla legge sulle opere pie. Il doppio obiettivo del riconoscimento e della regolazione della vita finanziaria-amministrativa delle
società, divise le componenti del Congresso nazionale delle società di
mutuo soccorso, la cui assemblea nell’ottobre del 1877, si dichiarò favorevole al principio del riconoscimento, ma «respinse il principio dell’autorizzazione, della tutela e del controllo governativo» (Manacorda, 1992,
95). Lo stesso avvenne, tre anni dopo, per i progetti presentati dal ministro del governo Cairoli, Miceli, che dovette scontrarsi con la gelosa autonomia e la resistenza alla «rigida regolamentazione di Stato» delle società (ivi, 103).
Così nel 1882, furono alcuni ambienti ministeriali – Luzzatti su tutti
– a promuovere un Congresso nazionale delle società di mutuo soccorso, tenutosi a Roma il 19 marzo, nel tentativo di fornire un sostegno
pubblico ai nuovi progetti di legge del governo Depretis, contando
sull’appoggio dell’ala conservatrice dei moderati, rappresentata in quella sede dalle pochissime società che aderirono al congresso. I tre distinti
progetti insistevano non solo sulla regolamentazione delle società, ma
sulla disciplina pubblica della cassa-pensioni volontaria, e sugli infortuni sul lavoro. Si aggiungeva insomma ai due precedenti temi di legislazione sociale (assistenza ai poveri e assicurazioni sul lavoro), quello della
previdenza. L’avversione delle componenti radicali e operaieste delle
società ai progetti di legge fu forte, ed espressa dal quindicesimo Congresso delle società affratellate di Genova, nel giugno del 1882 (Manacorda, 1992, 126-127).
Negli anni successivi, la rete delle fratellanze e delle società ingaggiò
contro i progetti del ministro Berti una dura battaglia. Sebbene divise
sui tre progetti al loro interno, con posizioni che variavano tra i radicali,
i repubblicani, gli operaisti, la questione di fondo restava il dilemma tra
accettazione del paternalismo borghese e difesa dell’autonomia sociale
dei lavoratori, che in effetti rispecchiava la doppia anima del movimento cooperativo italiano in generale, nato da un lato sugli obiettivi di tu-
Stato paternalista e corporativismo sociale
11
tela e assistenza della classe lavoratrice, dall’altro sulla promozione «dello sviluppo economico, integrata o alternativa rispetto a quello in atto»
(Degl’Innocenti, 1981, 4).
Dal punto di vista dello Stato, e dunque della classe dirigente liberale, si trattava di approcciare alla legislazione ed alla questione sociale
riducendone la portata in uno schema paternalistico-passivo e soprattutto orientato al governo delle cd. classi socialmente pericolose. Ma la
linea perseguita di costruzione di uno Stato assicuratore, non sostenuto
fiscalmente e politicamente, e di una debole pubblicizzazione dell’intervento sociale, si rivelò chiaramente inefficace nella sua emulazione
del modello bismarckiano, in realtà da pochi sostenuto tra i liberali, e
stimato esclusivamente per la sue funzioni di controllo politico e sociale.
A parte gli effetti poco significativi della legge di regolamentazione
delle società di mutuo soccorso (legge 15 aprile 1886, n. 3818), fu sul
fronte assistenziale e pensionistico che la politica della Sinistra liberale
dimostrò il suo difetto di fondo, ovvero l’impegno debole dello Stato.
La verità era che la classe dirigente liberale giudicava onerosa e impegnativa, anche politicamente, la scelta delle assicurazioni e delle casse
obbligatorie (Girotti, 1998, 172-173), nonostante si comprendesse il
crescere di una ragione wagneriana nell’intervento dello Stato (De Cecco, 1995, 257). Così la Cassa nazionale delle assicurazioni facoltative
creata nel 1883 si rivelò assolutamente inefficace, oltre che contrastata
dalle società operaie stesse.
Gli anni ’80, in definitiva, segnalano una risposta debole ed inefficiente in materia di legislazione sociale, sul duplice fronte assicurativo
e previdenziale, in cui prevalgono quei caratteri «umanitario-filantropici
o pietistico-confessionali» che già avevano caratterizzato la legge Rattazzi
del 1862 e che si dimostrano coerenti con una visione liberistica dell’economia e paternalistica della questione sociale.
Non bisogna, tuttavia, dimenticare che la fine degli anni ’70 fa emergere nel paese la questione dei conflitti economico-industrali. E c’è, infatti, un altro fronte della discussione sulla questione sociale che caratterizza il dibattito di quegli anni e che riguarda lo sciopero e i conflitti
tra capitale e lavoro.
Il primo segnale era provenuto dalla discussione parlamentare sul
fenomeno degli scioperi, che dalla fine degli anni ’70 sembravano atterrire l’opinione pubblica moderata.