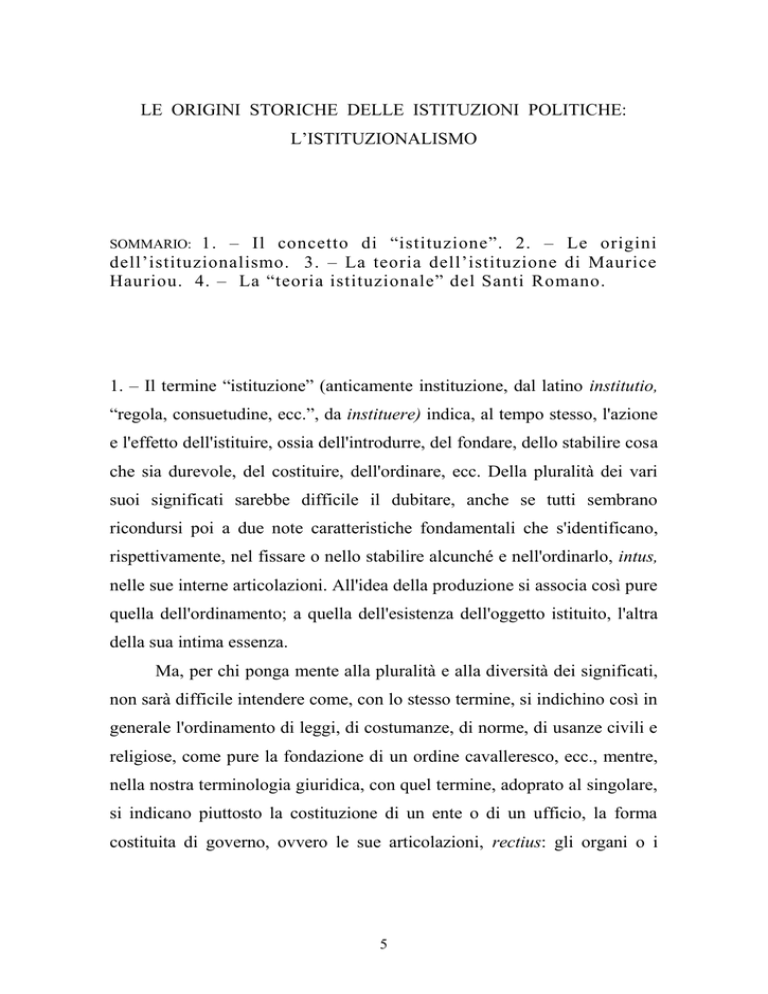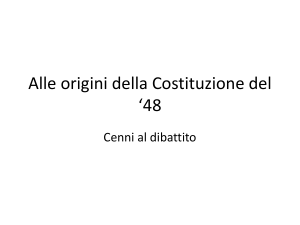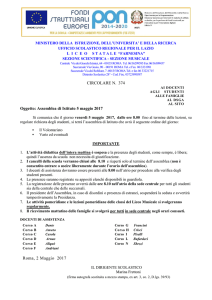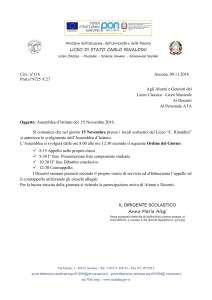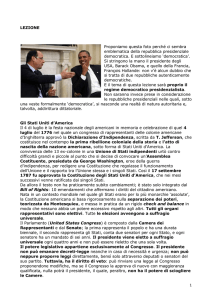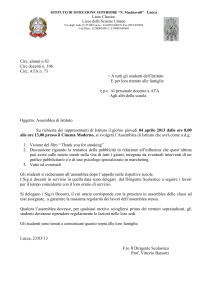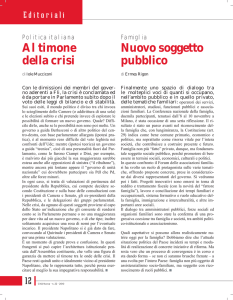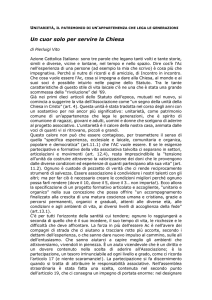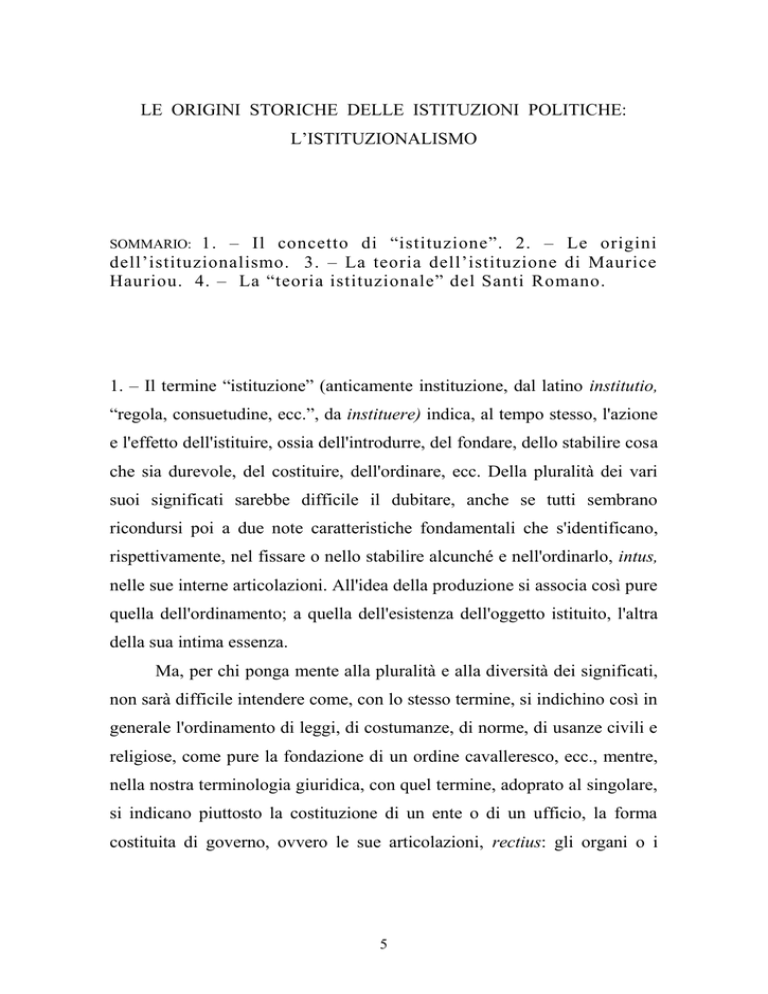
LE ORIGINI STORICHE DELLE ISTITUZIONI POLITICHE:
L’ISTITUZIONALISMO
1. – Il concetto di “istituzione”. 2. – Le origini
dell’istituzionalismo. 3. – La teoria dell’istituzione di Maurice
Hauriou. 4. – La “teoria istituzionale” del Santi Romano.
SOMMARIO:
1. – Il termine “istituzione” (anticamente instituzione, dal latino institutio,
“regola, consuetudine, ecc.”, da instituere) indica, al tempo stesso, l'azione
e l'effetto dell'istituire, ossia dell'introdurre, del fondare, dello stabilire cosa
che sia durevole, del costituire, dell'ordinare, ecc. Della pluralità dei vari
suoi significati sarebbe difficile il dubitare, anche se tutti sembrano
ricondursi poi a due note caratteristiche fondamentali che s'identificano,
rispettivamente, nel fissare o nello stabilire alcunché e nell'ordinarlo, intus,
nelle sue interne articolazioni. All'idea della produzione si associa così pure
quella dell'ordinamento; a quella dell'esistenza dell'oggetto istituito, l'altra
della sua intima essenza.
Ma, per chi ponga mente alla pluralità e alla diversità dei significati,
non sarà difficile intendere come, con lo stesso termine, si indichino così in
generale l'ordinamento di leggi, di costumanze, di norme, di usanze civili e
religiose, come pure la fondazione di un ordine cavalleresco, ecc., mentre,
nella nostra terminologia giuridica, con quel termine, adoprato al singolare,
si indicano piuttosto la costituzione di un ente o di un ufficio, la forma
costituita di governo, ovvero le sue articolazioni, rectius: gli organi o i
5
complessi organici, complessivamente considerati, che costituiscono la
struttura dello Stato (cosiddette istituzioni costituzionali).
Con quest’ultimo significato s’intende ripercorrere e precisare il
significato che nella scienza giuridica il termine “istituzione” ha ricevuto,
con la migliore consapevolezza dell’impiego e il maggiore svolgimento
delle implicazioni, massime per il fatto, per nulla trascurabile, che con esso
si è voluto indicare niente di meno che lo stesso fenomeno giuridico nella
sua integralità e nella sua essenza e che quindi da esso e per esso è stato
tratto il termine derivato di “istituzionalismo” o “istituzionismo”, per
designare la teoria o le teorie che hanno tentato di identificare appunto il
“diritto” o “l’ordinamento” tout court con l’ “istituzione”.
Secondo l'ultimo dei significati passati in rassegna, il termine
riappare dunque, adoprato al singolare, proprio per indicare l'unità,
l'unificazione di elementi diversi, il quid commune di una molteplicità. Alle
istituzioni costituzionali di uno Stato, ad esempio, si contrappone
l'istituzione complessiva dello Stato stesso alla quale esse si assimilano;
agli organi, la persona dello Stato della quale essi sono considerati
strumenti. È evidente che il significato di una tale contrapposizione –
assimilazione risulta dall'esigenza di unificare una molteplicità, di
ricondurre ad unità la differenza, di precostituire una “forma”, un
“modello”, una “classe” di elementi rispetto ai quali, e fra di loro, questi
ultimi risultino relativamente identici.
Come criterio unificatore, come forma o tratto relativamente comune
di tutti questi elementi può assumersi la nozione di “istituzione”, che si
riferisce sia alle parti, agli elementi dell'insieme, sia all'intiero, al tutto del
quale
essi
partecipano.
Di
là
quindi
6
dalla
contrapposizione
–
differenziazione, per rimanere nell'esempio, di Stato – persona e istituzioni
– organi costituzionali, incentrata sulla diversa natura e sul rapporto
strumentale di “ente” ed “organo”, vi ha un tratto comune che unifica
invece tanto l'ente, quanto l'organo e, fuori dell'esempio, sia la persona ut
sic, sia un complesso di persone, un determinato fatto, come un complesso
di determinati fatti, una cosa, come pure un insieme di certe cose. Da
questo punto di vista è facile mostrare come non repugni la qualifica di
“istituzione” o di “istituzionale” non solo all'ufficio – organo costituzionale
dello Stato, o allo Stato – persona, ma neppure all'ordinamento
complessivo dello Stato, allo Stato – ordinamento, o, perfino, dal lato
opposto, agli elementi che, a loro volta, compongono l’ufficio – organo
dello Stato.
Lasciando naturalmente da parte l’uso del termine nelle altre scienze
ed esperienze, è chiaro però che, nel diritto, dire “istituzione” val dire
innanzi tutto produzione o, meglio, posizione del diritto stesso e quindi
ordinamento di esso. Ma è qui pure la radice della particolare fortuna che il
termine ha avuto nella scienza giuridica. Se il diritto è sinonimo di ordine,
di ordinamento e se l’ “istituzione” esprime la produzione e la posizione di
un ordine, “istituzione” vale, innanzi tutto, propriamente, “posizione del
diritto”, e denota, ad una, l’origine stessa del fenomeno giuridico,
comunque e dovunque lo si voglia concepire. Indagare sulla “istituzione”
equivale ad indagare sul “diritto” e, per meglio dire, sui modi nei quali esso
sorge e sulle forme nelle quali esso si manifesta.
Questa
indagine
costituisce quindi
propriamente
la
“teoria
dell’istituzione”, che è per definitionem, un capitolo della teoria del diritto
7
o, se si vuole, della teoria generale del diritto, nonché della storia stessa del
diritto.
Ma l’indagine sull’origine e sul modo di produzione del diritto
implica la nozione del diritto stesso e si risolve anzi nella ricerca di che
cosa sia il diritto, dal momento che l’ “ordinamento” è un aspetto dell’
“istituzione” o è questa stessa, tout court.
Per ordinamento giuridico s'intende quel complesso di norme che lo
compongono, ovvero quell’ordinamento del quale quelle norme giuridiche
fanno parte.
Tale affermazione risulta indiscussa ed in effetti non controvertibile.
Più controverso e diversamente risolto è il problema se siano soltanto le
norme a costituire l'ordinamento o se questo consti di qualcosa di più, cioè
dell'organizzazione sociale alla quale le norme si ricollegano.
L'interrogativo in esame postula una riflessione di base sul concetto
di diritto: "ubi ius, ibi societas" oppure "ubi societas, ibi ius". La risposta al
petitum è data nel secondo senso. Per completezza, è d'uopo sottolineare
che il ragionamento logico – giuridico sviluppato ab initio risulta essere:
"ubi homo, ibi societas; ubi societas, ibi ius; ergo ubi homo, ibi ius".
L'uomo considerato non al suo stato selvaggio ed isolato, ma come un
essere sociale (per Aristotele l'uomo non era altro che un animale politico –
nel senso sociale –), vivente, cioè, in una determinata società ed in continuì
rapporti con i suoi simili. Quella dell'uomo completamente libero ed arbitro
di sé, isolato dalla società, è una concezione meramente astratta e fuori
della realtà. Pertanto il diritto si deve considerare un prodotto della vita
sociale, creato dagli uomini e da loro stessi utilizzato.
8
Altresì, poiché ogni gruppo sociale risultante dalla comunanza degli
interessi e dalla concordanza sul modo di soddisfarli costituisce
ordinamento, appare esatta 1'identificazione che si suol fare fra gruppo
ordinato e diritto, quale si esprime con la formula "ubi societas, ibi ius".
Invece l'equivalenza a questa dell'altra formula che ne inverte i termini, e
che suona "ubi ius, ibi societas" sarebbe da accogliere solo quando si
aderisse all'opinione, che invece è stata respinta, della inestensibilità della
categoria del giuridico alla vita degli individui, singolarmente considerati.
La società umana, per conservarsi e progredire abbisogna,
necessariamente, di un complesso dì norme. Tali norme, riunite in sistema,
costituiscono l'ordinamento giuridico, che è insopprimibile premessa alla
vita associativa, in quanto supremo regolatore della condotta e dei rapporti
tra i consociati (ubi societas, ibi ius).
2. – Il termine di «società» al quale l’istituzionalismo si riferisce può e
deve essere inteso sostanzialmente in due modi diversi che caratterizzano
un'altra fondamentale ambiguità della teoria istituzionale. Vi è la società
intesa come aspetto o momento dialettico del processo costitutivo del
«diritto», oggetto ma, al tempo stesso, condizione di ogni «diritto» e, per
meglio dire, oggetto del «diritto» inteso come «ordinamento» e condizione
o scaturigine del «diritto» stricto sensu; vi è poi la società come corpo o
ente chiuso, in sé perfetto – si ponga mente alla «suità» dell'istituzione di
cui ci parla Santi Romano – organismo singolo, esteriormente rilevabile,
visibile, «per quanto immateriale», e quindi suscettibile di rapporti con altri
9
organismi della stessa specie, che è compito della scienza giuridica studiare
e classificare.
Si potrebbe parlare allora più propriamente non già della società,
concettualmente e unitariamente intesa, sebbene delle molteplici, diverse e
irriducibili, società, rilevabili all'osservazione empirica. La società, da un
lato, e le società, dall'altro.
E tuttavia la stessa giuridica ipotizzabilità di queste ultime, in tanto è
resa possibile, in quanto si tenga ben presente il concetto di societas e la
relazione dialettica identità - distinzione intercorrente tra di essa e il diritto
di cui si è prima discorso. Non si potrebbe, diversamente opinando, che
fermarsi alla pura rilevazione del dato empirico costituito dall'esistenza di
molteplici aggregazioni umane, ora dotate di reciproche relazioni, ora
invece assolutamente prive, e non già costruire su di essa un sistema dì
relazioni che presuppone evidentemente la loro fondamentale omogeneità.
Ora, la sostanziale riconducibilità delle molteplici società –
istituzioni alla societas intesa come un tutto, logicamente inoppugnabile,
sembra comprovata, sul piano storico, dallo stesso enuclearsi della figura o
della nozione di «istituzione».
La storia del concetto equivale, com'è evidente, alla storia della
teoria. E una teoria è innanzi tutto consapevolezza della storicità del
proprio oggetto. Ma l'indagine rivolta a studiare, per esempio, il «concetto
dell'ordinamento giuridico alla luce dell'esperienza romana» non può
condurre, come invece ha condotto – sul rilievo che la nozione di
«ordinamento giuridico» era ignoto al pensiero giuridico romano (e in
genere antico) – ad escludere la possibilità di applicare la nozione stessa
allo studio dell'esperienza giuridica romana, se è vero che l'indagine storica
10
deve e non può non avvalersi dei concetti che storicamente vengono
enucleandosi e che insomma le res gestae (la storia) sono concepibili e
intelligibili solo alla luce della historia rerum gestarum (la storiografia).
Pertanto, appare nel giusto chi, capovolgendo 1'impostatura qui criticata, ha
affermato che 1'«esperienza romana» vada studiata «alla luce del concetto
di ordinamento giuridico», pur nella consapevolezza che il concetto di
ordinamento giuridico e quindi di «istituzione» è stato foggiato ed
enucleato in ragione e in funzione dello Stato moderno.
La storia del concetto di «istituzione» risale al Medioevo e
precisamente alla tradizione giuridica canonistica classica, su fino al
pensiero di Sinibaldo de' Fieschi (Innocenzo IV – P.M.), allorché egli, nella
tradizionale classificazione delle persone giuridiche, introdusse una figura
nuova, l’institutio, distinta e nettamente diversa «dai due tipi antichi e
tradizionali della corporazione – persona giuridica che ha il suo substrato
nell'elemento personale del collegium ... – e della fondazione semplice
massa patrimoniale destinata ad un fine proprio, esclusivo», in ragione
della presenza di «un elemento autoritario imposto dal di fuori che sottrae
l'ente alla libera disposizione delle parti».
Ma è la precisa individuazione di un tale elemento autoritario che è
più significativa. Esso, non soltanto presente nel momento della creazione
della institutio, continua per tutta la vita di questa, reggendola e
indirizzandola e contraddistinguendola quindi ancor meglio dalla
corporazione, la quale «agisce secondo la volontà dei propri soci», mentre
l'altra «agisce conforme alla 'voluntas superioris' che ha presieduto al suo
nascere e della quale gli organi di essa istituzione continuano ad essere gli
esecutori». Questa ‘voluntas superioris’ è, da un lato, semplicemente la
11
volontà del fondatore, la volontà e, si direbbe, la radice istituzionale, ma,
dall'altro, è chiaramente ricollegata, come elemento di un insieme, all'intera
organizzazione piramidale e gerarchica della Chiesa, raffigurata quale
corpus mysticum o corpus Christi, nella terminologia paolina, del quale le
singole persone, fisiche e giuridiche, aventi potestà giurisdizionale
ecclesiastica, sono gli «organi». È perciò che può ben dirsi che l'elemento
autoritario proceda «dall'esterno e dall'alto» e che «anche quando semplici
masse patrimoniali sono destinate ad uno scopo religioso o caritativo,
questo è nel più dei casi coordinato alla organizzazione gerarchica della
Chiesa e collegato con i numerosi uffici suoi, che il fine pubblico diventa
quasi di regola soverchiante».
Di qui la più tarda concezione di Maurice Hauriou del «potere di
governo organizzato» come «secondo elemento di ogni istituzione
corporativa» e, in ogni caso, necessario nell'ambiente sociale, anche se
esterno alla «istituzione – cosa».
Ora è proprio un siffatto elemento autoritario che rese possibile a
Sinibaldo de' Fieschi (Papa Innocenzo IV) di innestare sulla nozione di
persona ficta et repraesentata, che pure egli aveva ereditato dai glossatori
– intendendola però non già nel senso della negazione, propria del diritto
romano, della qualità di soggetto reale di diritto alle universitates
(personarum o bonorum) (universi consentire non possunt), ma in quello
diverso e più limitato di incapacità della persona giuridica ad agire se non
per mezzo di rappresentanti – l'idea della «istituzione», «intesa come ente
che vive ed agisce in virtù d'una volontà autoritativa che la guida
dall'esterno e dall'alto: idea affatto estranea al diritto romano e che si
presenta, per contro, come una peculiare creazione del diritto della Chiesa».
12
Sul terreno dell'esperienza, «istituzioni» furono così i singoli benefici
parrocchiali rurali primitivi eretti dal Superior competens, la praebenda e
la dignitas canonicale staccatesi dalla mensa capituli, e pertanto legate «ad
un'ideale unità, fondata dall'esterno e dall'alto». Questa unità – dipendenza
dell'istituzione «dall'esterno e dall'alto» è in particolare individuata nella
unità - dipendenza della personalità giuridica (della praebenda, della
dignitas, dei beneficia) dalla persona giuridica suprema della Chiesa e, per
analogia (un'analogia che potrebbe dirsi affinità o addirittura convergenza),
per quanto riguarda gli enti civili, dalla persona giuridica suprema
dell'Impero. Anzi sono stati gli stessi canonisti a procedere a tale applicazione analogica dell'istituto agli enti civili. Che poi, su tale strada, si sia
giunti alla personificazione dell'elemento autoritativo come base per
sostenere la tesi del conferimento della personalità giuridica agli enti
minori esclusivamente ad opera dello Stato, il cui atto è costitutivo e non
dichiarativo, nonostante la natura di realtà sociale della persona giuridica, è
una questione che qui interessa soltanto marginalmente, dal momento che
l'istituzione, come si vedrà, non sembra presupporre necessariamente e neppure comportare la personalità dell'ente. Piuttosto giova osservare, ancora
una volta, come il tratto caratteristico della institutio è qui ravvisato nella
dipendenza dell'ente da un elemento superiore ed estraneo, o, se si vuole,
da una auctoritas superioris, la quale, tuttavia, si immanentizza, rendendo
possibile all'ente di perdurare nonostante il mutamento delle persone fisiche
investite dell'ufficio, per cui, «licet moriatur praelatus, et omnes clerici in
ecclesia, dominium illorum non vacat: quia Christus non moritur, nec
potest Ecclesia deficere».
13
È questo, del collegamento e della derivazione da un elemento
superiore, che, in definitiva, è la radice e il principium di ogni institutio e
che si pone come un tutto supremo di cui le singole institutiones
rappresentano semplicemente le derivazioni e, quasi, le propaggini, il
motivo di maggiore interesse, il quale sta a dimostrare, anche sul piano
della storia della teoria, quel che si diceva precedentemente a proposito dei
due modi diversi d'intendere l'istituzione, che essi cioè non si
contrappongono ma si accordano fra di loro e che non è dato concepire le
istituzioni singole quasi «monadi» chiuse in sé medesime, indipendenti
dall'istituzione più comprensiva e suprema dalla quale tutte derivano.
Da questo punto di vista si può tentare di rispondere alla domanda,
già posta in precedenza
relativa al modo di intendere la società,
affermando che questa rappresenta il terreno e per così dire la dimensione
nella quale si muovono le singole istituzioni nella loro realtà storica: una
dimensione che, per il fatto di essere comprensiva di più entità, implica
necessariamente la molteplicità (di esse), ma, per il fatto di essere poi come
il tessuto connettivo che le tiene insieme e l'ordine che le rende possibili, le
spinge verso l'unificazione e l'unità. In tal senso, l’ordo ordinatus è
piuttosto la singola istituzione, in quanto tratta ad oggetto di osservazione,
ritagliata, per così dire, dal divenire storico, l’ordo ordinans è invece la
societas come totalità, che è poi la storia delle molteplici istituzioni, ossia
la dimensione nella quale le varie societates si succedono e si
condizionano.
Ma una siffatta reductio ad unum non è un dato, è piuttosto un
processo continuo, per il quale è sempre necessaria la molteplicità degli
elementi da unificare. Così che la teoria istituzionale non può, al tempo
14
stesso, non presentarsi come una concezione pluralistica e societaria degli
ordinamenti giuridici, ripudiando al tempo stesso il mito della unicità e
unità data dell'ordinamento, sia sotto il profilo cioè della pretesa
qualificazione statualistica ad esso attribuita, sia sotto l'altro, non meno
importante, della pretesa «purezza» e unilateralità dell'ordinamento, il
quale, lungi dall'essere un'unità ferma e per così dire conchiusa in se stessa,
si scinde, continuamente presentandosi, a volta a volta, come norma e come
fatto, come «diritto» e come «società».
Una reazione ante litteram al mito statualistico e normativistico è
quella segnata dall'opera sulle teorie politiche del Medioevo di Otto von
Gierke, al quale va il merito di avere delineato una concezione pluralistica
e societaria del diritto, sul fondamento dell'indagine storica relativa alle
comunità e corporazioni medioevali.
Sembra perfino superfluo avvertire come proprio il Medioevo, in cui
è apparsa la prima presa di coscienza dell'institutio, nel quadro di una
concezione unitaria della società, di un'unica res publica christiana retta da
papa e imperatore, presenti il fenomeno della pluralità delle istituzioni al
massimo grado storicamente riscontrabile di sviluppo. Ma una siffatta
molteplicità di istituzioni non è per nulla incompatibile con la sostanziale
omogeneità della societas della quale anzi codesti enti sono la puntuale e,
nella società feudale, gerarchica espressione. La sostanziale omogeneità è
data, infatti, secondo Otto von Gierke, proprio dalla capacità, che hanno
tutti gli organismi sociali, di creare diritto. È ovvio, però, che, mentre con
riferimento al sistema giuridico – sociale del Medioevo, una tale affermazione risulta immediatamente comprensibile e, per così dire, naturale,
15
essa acquista invece un significato che può ben dirsi rivoluzionario, quando
la si riferisca al sistema giuridico – sociale dello Stato moderno.
L’oscillazione fra la concezione sociologica e quella storicistica della
società è presente anche e soprattutto nel pensiero dei due maggiori
esponenti della “teoria istituzionale”, ossia di Maurice Hauriou e di Santi
Romano, nei quali pure – e in specie in Santi Romano – si rinviene il
tentativo più valido di costruire una teoria giuridica dell’istituzione.
3. – La teoria di Maurice Hauriou è intesa a concepire la realtà sociale
come – direttamente ed intrinsecamente – realtà giuridica.
L'Hauriou
infatti
è
uno
dei
primi
assertori
del
concetto
d’"istituzione",in base al quale sarebbe superabile quella dicotomia tra
realtà sociale e ordine giuridico che tante difficoltà crea al giurista. Per tale
Autore l'"istituzione" rappresenta l’"elemento ontologico del diritto", in
quanto in essa si realizza la piena trasformazione dello "stato di fatto" (cioè
i fenomeni sociali sociologicamente intesi) in "diritto": in particolare
l'"istituzione" si differenzierebbe dal piano dei meri fatti in quanto sarebbe
realtà di fatto; però basata su un elemento autoritario (non sulla pura forza)
e di conseguenza sarebbe realtà intrinsecamente giuridica. L’Hauriou però
non si preoccupa eccessivamente di precisare se il suddetto elemento
autoritario sia personificato (non si preoccupa cioè di identificare il soggetto di tale autorità) o comunque di precisare meglio i caratteri ed il modo
di essere di tale elemento.
Si preoccupa invece essenzialmente di analizzare la realtà giuridica,
differenziando i vari piani di profondità in cui essa si distribuisce per
16
individuare quale posizione occupi l'istituzione nell'ambito di tale realtà. In
particolare ritiene che il piano più superficiale sia quello delle regole rigide
e astratte, emanate secondo procedimenti formali (il piano cioè della
"legge" nel senso tecnico del termine); il secondo piano, sottostante al
precedente, sarebbe quello costituito dalle regole singolari, emanate per i
casi concreti: di quelle regole cioè che sono prodotto ed espressione della
discrezionalità; il piano più profondo sarebbe invece quello dell’ "istituzione", cioè di quell'autorità impersonale e spontanea dalla quale ogni
manifestazione giuridica in ultima analisi viene dall’Hauriou fatta derivare.
Lo studioso si preoccupa anche di distinguere due diversi tipi di
istituzione: l' "istituzione – gruppo" e la "istituzione – rapporto"; solo il
primo tipo (qualificabile anche come quello delle 'istituzioni – corporative"
cioè costitutive di un "corpo" sociale) interessa il problema considerato (il
fondamento dell'ordine statuale): non il secondo, che riferisce il concetto di
istituzione alla sfera delle cose inerti (sì tratta cioè di istituzioni che non
sorgono ad opera di un potere a loro interno, come invece avviene nel
primo caso). Per quanto riguarda l'ambito dei gruppi sociali, anche in esso secondo l'Hauriou - è possibile distinguere l'esistenza di diversi piani di
profondità in modo da potersi riallacciare a quello accennato a proposito
della realtà giuridica. Bisognerebbe perciò distinguere, iniziando dal piano
più profondo per giungere a quello più superficiale: la "comunione di
fondazione", che rappresenta il fenomeno istituzionale più spontaneo
(risultante cioè dall'equilibrio spontaneo, di forze e di interessi, derivante
dalla stessa natura delle cose) e non esprimentesi in vera e propria
organizzazione; l'"incorporazione", caratterizzata invece dal formarsi di
un'organizzazione che permette e realizza una distribuzione di competenze
17
nell'ambito del gruppo; l’"inter-organizzazione dell’incorporazione", in cui
la distribuzione delle competenze avviene in modo da garantire a tutti i
membri del gruppo sociale la partecipazione attiva alla vita dell’istituzione
e quindi si fonda sul consenso generale di tali membri (in sostanza cioè si
tratta
di
istituzioni
caratterizzate
dal
principio
democratico
e
rappresentativo); infine il piano più superficiale si ha quando si verifica il
conferimento al gruppo della personalità giuridica, il che può verificarsi
specie in considerazione dei suoi rapporti con gli altri gruppi. E' da notare
inoltre che, poiché negli strati meno profondi l'istituzione si esprime in
un'organizzazione e poiché l'esistenza di questa implica il formarsi di un
potere di comando, l'Hauriou cerca di risolvere il problema del
conferimento di tale potere (problema che - visto in relazione all'istituzione
statuale – si identifica in quello dell'attribuzione della sovranità)
distinguendo tra la "sovranità politica" e la "sovranità giuridica", ed
attribuisce la prima allo Stato (intendendola specificamente come potere
d'imperio) e la seconda, invece, alla nazione.
In relazione a quanto evidenziato,
la teoria dell’Hauriou appare
molto complessa, tanto complessa anzi da diventare complicata. Appunto a
causa di questa eccessiva complicazione non è facile intendere che cosa in
sostanza lo studioso intenda per "istituzione", cioè quali siano i suoi
caratteri veramente essenziali. Ciò perché non si riesce a rintracciare nella
suddetta teoria un criterio che sia insieme univoco e sufficientemente
preciso; le oscillazioni del pensiero dell'Hauriou nell'individuazione di
simile criterio non sono né poche né irrilevanti: ad esempio, secondo
quanto risulta implicito dall'esposizione prima accennata non è del tutto
18
chiaro se aspetto essenziale dell’"istituzione"sia quello organizzativo, e se
tipico di essa sia l'esistenza di un potere di comando.
Secondo quanto innanzi rilevato, la risposta dovrebbe essere
negativa, ma il dubbio sorge perché l'Autore ad un certo momento definisce
l'istituzione come "tout arrangement permanent per lequel, à l'interieur
d'un groupement social determiné, des organes disposant d'un pouvoir de
domination sont mis au service des buts interessants le groupe, par une
activité coordonneè a celle de l'ensemble du groupe”. In conclusione
perciò nell’interpretare il pensiero dell''Hauriou, ci si trova di fronte a due
alternative: o, intendere il concetto di istituzione con riferimento alle
particolari specificazioni relative alla sua struttura organizzativa ed al
potere di comando, ma in tal caso esso risulterebbe troppo restrittivo, incapace di valere per ogni forma di realtà giuridica; o, invece intenderlo con
esclusivo riferimento al principio essenziale, che secondo l’Hauriou sta al
fondo di ogni istituzione e che egli identifica in un’ "idea forza". in un'idea
attiva che plasma di sé la realtà, rendendola giuridica e per cui l'istituzione
si pone come "fonte" del diritto. La seconda alternativa, che sembra tutto
sommato la più esatta pur contenendo un indubbio aspetto di verità, si
risolve in un concetto troppo generico, del quale è anche legittimo dubitare
se appartenga veramente al mondo giuridico od invece si arresti alla soglia
di questo ed in particolare sembra incapace di spiegare scientificamente
come e perché la realtà sociale sia da considerarsi intrinsecamente
giuridica, come e perché essa si ponga a fondamento dell'ordinamento
statuale.
19
4. – La teoria dell'istituzione trova però la sua più approfondita ed organica
definizione nel pensiero del Santi Romano. Può dirsi anzi che tale Autore
realizzi un superamento qualitativo rispetto al pensiero degli istituzionisti
francesi (anche dell’Hauriou, che di questi è il maggiore esponente), sia per
il metodo (rigoramente giuridico) col quale la sua indagine è condotta, sia
per l'esatta individuazione dei problemi essenziali, sia per le conclusioni
sufficientemente specifiche ed articolate alle quali giunge.
E’ la “teoria istituzionale” sviluppata in Italia dal Santi Romano, per
il quale un ordinamento non si risolve solo in norme. Il diritto è anche
norma; ma oltre che norma, e spesso prima di essere norma, è
organizzazione e corpo sociale, e quindi si collega alla istituzione, intesa
appunto come qualunque ente o corpo sociale fornito di una struttura e di
un’organizzazione più o meno stabile e permanente.
Il Santi Romano ha giuridicizzato il concetto di istituzione, già
elaborato in Francia da Hauriou su un fondamento prevalentemente
sociologico, ed ha sostituito questo concetto, che egli considera più largo e
più completo oltre che più intrinsecamente giuridico, a quello di comunità.
Merito indiscusso della teoria istituzionale del Santo Romano è
quello di aver sottolineato che il fenomeno giuridico non si esaurisce nel
fenomeno normativo e che, al contrario, non solo le norme traggono la loro
giuridicità dal fatto di essere espressione della struttura associativa del
gruppo o corpo sociale ma anche che il fatto stesso dell’organizzazione
imprime ad un gruppo o corpo sociale il carattere della giuridicità (ogni
istituzione è un ordinamento giuridico).
Il Romano parte dall’esigenza, che sottolinea con particolare forza,di
individuare l'entità sottostante alle norme, perché, ove ci si arrestasse a far
20
riferimento esclusivamente a queste ultime, riuscirebbe impossibile trovare
il fondamento e la natura del diritto. Ispirandosi al pensiero greco, il quale
– relativamente allo Stato – concepiva tale entità come assetto complessivo
di una realtà unitaria, permanente, oggettiva e concreta (il riferimento del
Romano al pensiero greco è deducibile, oltreché dal contenuto del suo
pensiero, anche da sue espresse dichiarazioni a riguardo), egli ricerca
un'entità che non sia puro sostrato sociale, mero presupposto dell'ordine
giuridico, ma che sia essa stessa di natura giuridica ed anzi rappresenti
l'essenza primaria e necessaria del fenomeno giuridico.
Tale entità per il Romano è appunto l’ “istituzione”, col che si indica
un ente o corpo sociale (che, in quanto tale, deve avere "un'esistenza
obiettiva e concreta" ed un'individualità "esteriore e visibile") dotato di vita
autonoma, anche se tale autonomia può essere assoluta o soltanto
relativa,che rappresenta un "'unità ferma e permanente" pur nel mutare dei
suoi particolari elementi.
L'essenza dell’"istituzione" è l’“organizzazione sociale”, dovendosi
ritenere che essa non ha, ma e' organizzazione sociale. Né potrebbe dirsi
che con ciò ci si riferisca a concetto non giuridico perché il Romano
sottolinea che "scopo caratteristico del diritto è per l’appunto quello
dell'organizzazione sociale". Inoltre il riferimento all’organizzazione mette
in rilievo come si tenga conto dell'esigenza di una struttura basata sul
principio del collegamento tra autorità e forza.
Da ciò risulta abbastanza chiaramente che per il Romano l'istituzione
non è né entità indifferenziata, né si risolve mai in un singolo rapporto
giuridico od in una somma di rapporti (infatti, egli precisa, l'istituzione
implica dei rapporti, ma non si risolve in essi" perché costituisce
21
l'organizzazione necessaria a fornire ai rapporti medesimi il sostrato che
consente di poterli qualificare come giuridici). Ciò spiegherebbe e
confermerebbe definitivamente la perfetta identità tra istituzione e diritto:
"questo - afferma esplicitamente il Romano - non può estrinsecarsi se non
in un'istituzione e l'istituzione esiste in quanto è creata e mantenuta in vita
dal diritto".
Da un simile concetto di istituzione, specie dal suo carattere di unità
permanente dotata di vita autonoma, sorge l'esigenza dì riferirsi a un
principio capace di conferire all'istituzione appunto tali caratteri; particolare
interesse perciò riveste l'accenno che il Romano fa al “principio vitale di
ogni istituzione”, come “ciò che anima e tiene riuniti i vari elementi di cui
questa risulta, che determina, fissa e conserva la struttura degli enti
immateriali”; ma si tratta solo di un cenno, del quale non è possibile trovare
una più specifica esplicazione; cosicché resta il dubbio se il Romano
intenda questo principio identico in ogni istituzione (nel qual caso si
tratterebbe di qualcosa di troppo generico perché possa valere quale
essenziale criterio d'identificazione), oppure lo intenda in senso specifico,
cioè diverso a seconda dei vari tipi di ordine nei quali agisce (ed allora le
sue affermazioni a riguardo avrebbero uno straordinario interesse per
risolvere definitivamente il problema del fondamento e dell'essenza della
costituzione, cioè come il Romano intenda il concetto di costituzione).
Comunque può dirsi che la teoria del Romano, considerata nel suo
nocciolo essenziale, equivale a un rovesciamento della concezione di Hans
Kelsen. Questi vede l’ordinamento soltanto come un sistema di norme “teoria normativa” - (e considera giuridico soltanto ciò che in norme si
esprime) mentre il primo afferma che diritto - in senso proprio - è solo
22
“l’entità che pone la norma”, cosicché "le norme non ne sono che una
manifestazione, una delle sue varie manifestazioni .... uno dei modi con cui
esso opera e raggiunge il suo fine" (a conferma il Romano nota "che non
solo si possono astrattamente immaginare, ma storicamente si danno....
esempi di ordinamenti giuridici in cui non si rinvengono norme scritte o
anche non scritte nel senso proprio della parola", quale ad esempio
l'ordinamento in cui esista solo "la figura del giudice").
Il pensiero del Romano si presenta anche in netta antitesi con coloro
che ritengono di poter costruire il sistema dalle norme, desumendolo cioè
dall'esame delle medesime e dai loro rapporti reciproci. In particolare come il Romano sottolinea - non è possibile individuare la giuridicità
attraverso una simile operazione: se infatti ogni singola norma di per sé non
è giuridica, la giuridicità non può essere trovata sommando più norme in
sistema; perché dunque un sistema di norme sia giuridico è necessario
trovare il quid che conferisce unità al gruppo di norme, che le forma in
sistema ma che, non identificandosi con esse, ha vita propria e forza
espansiva tale da garantire ad un tempo lo sviluppo e la continuità
dell’ordinamento. Il Romano conclude anche che tale quid non può essere
ricercato nel principio gerarchico che, secondo il Kelsen, caratterizza il
sistema di norme come ordinamento (infatti detta tesi è stata portata avanti
con molto vigore logico dalla Scuola viennese e segnatamente da Hans
Kelsen che, partendo dal presupposto della necessaria “purezza” del diritto,
intesa come incontaminazione della norma nei confronti dei fatti sociali, è
giunta appunto a concludere che l’ordinamento giuridico si compone
soltanto di norma – “teoria normativa” – disposte in una scala gerarchica
che partendo dalla norma fondamentale “grundnorm” giunge fino al
23
comando concreto in una disposizione gradualistica di rigorosa
correlazione fra norme sovraordinate e sottordinate ed osserva (a riprova
dell'impossibilità che tale principio possa promuovere la espansione
dell'ordinamento mantenendone insieme l’unità) come sulla base di esso
l'ordinamento potrebbe mutare radicalmente, anche nella sua norma
fondamentale, così che in ultima analisi risulterebbe annullata la sua unità.
Passando ad una più particolare valutazione critica del pensiero del
Romano sono preliminarmente da precisare alcuni punti, che appaiono
basilari per l’esatta sua interpretazione.
Si deve notare anzitutto, per ciò che riguarda l’uso del termine
"istituzione", che il Romano dichiara di distaccarsi dagli altri istituzionisti,
in particolare dall'Hauriou: a differenza di quanto sostiene tale Autore,
infatti afferma di non credere che “l'istituzione sia fonte del diritto, e che
quindi questo sia un effetto, un prodotto della prima”, e di ritenere invece
che “fra il concetto di istituzione e quello di ordinamento giuridico....ci sia
perfetta identità".
In secondo luogo bisogna ricordare che l'ordinamento non può non
essere concepito come entità ferma e permanente, che non muta pur nel
mutare dei diversi interessi che ad esso fanno capo. Inoltre che
l'ordinamento non è da considerarsi soltanto come sistema di norme
perché non si risolve esclusivamente in esse.
La suddetta entità non può essere concepita che per riferimento
all'organizzazione sociale (poiché tale organizzazione è scopo specifico del
diritto); l'aspetto organizzativo è dunque tipico del fenomeno giuridico ed
intrinseco ad esso, sicché l'ordinamento va identificato con il “corpo
sociale” organizzato, costitutivo dell’“istituzione”. L'istituzione è quindi
24
diritto obiettivo (nel senso di ordine giuridico, di "status") e, poiché
l'obiettività è caratteristica del diritto, vi è perfetta identità tra istituzione e
diritto; il diritto non si estrinseca se non in un'istituzione e l'istituzione è
tale in quanto creata e mantenuta in vita dal diritto. Sono dunque da
respingere radicalmente tutte quelle opinioni che considerano il fatto
dell'ordinamento sociale come antecedente al diritto o comunque non
giuridico.
Non è però sempre secondo il Romano - errato dire che il diritto è
“forma”; tale affermazione, se esattamente intesa, significa infatti che la
identificazione di ciò che è diritto si ha in considerazione del suo inserirsi
nell'istituzione (una data norma, o regola, o precetto dunque non è giuridico
per il suo contenuto, ma per il suo riconnettersi ad un istituzione, perché è
propria di un'istituzione).
L'istituzione si costituisce ed esiste in forza di un "principio vitale"
(che la anima, la tiene unita nei suoi elementi, ne promuove e assicura
l'espansione); tale principio può dunque essere inteso come la normatività
intrinseca dell'istituzione.
In particolare, per quanto riguarda l’istituzione dell'ordinamento
statuale, il Romano afferma che lo Stato sorge col fatto del suo costituirsi,
senza che ciò si esprima necessariamente in una norma, perché questa può
anche sorgere solamente in seguito. E' questo un punto specifico, di
notevole rilievo, nel quale il Romano ribadisce la sua differenziazione tra
"ordine sociale" e “norma”: ed offre quindi la migliore occasione per chiedersi se tale differenziazione (analoga a quell’altra vista prima, tra "fonte" e
25
"diritto"
(1)
, sia veramente esatta. Quando a proposito del sorgere dello
Stato, si fa riferimento al fatto del suo costituirsi, si ammette implicitamente che questo non sia mero fatto perché esso si pone come ordine;
ma questo ordine, per esser tale, deve potersi concretare ed esprimere con
qualche "legge" (nel suo senso più proprio di "regola") cioè non può esprimersi altrimenti che con norme o con gruppi di norme. Se si tiene presente
quanto si è detto, dovrebbe venire a cadere la contrapposizione tra norma e
istituzione: d’altra parte lo stesso Romano, ad un certo momento, non può
non riconoscere che "l'esistenza di una istituzione non si scompagna mai da
una serie di norme, che possono essere e, in parte, sono sempre implicite
nella sua struttura e nei suoi caratteri essenziali". Ma, a parte le incertezze
dimostrate dal Romano al riguardo, è da riaffermare il concetto che la
differenziazione tra istituzione e norme non può essere intesa che come
differenziazione tra la norma immanente all'istituzione (il principio normativo intrinseco ad essa) e le norme derivate. In tal modo risulta
superabile l'antitesi che da più parti si prospetta. E’ facile infatti il rilievo
che anche la norma base, presupposta dal Kelsen, si richiama ad una realtà
sociale in se ordinata, perché capace di esprimere la norma stessa, ad una
realtà che perciò si può chiamare “istituzionale”.
(1)
Si e' notato come il Romano, criticando l'Hauriou fa rilevare come l'istituzione non sia fonte di diritto,
ma diritto essa stessa, e si e' osservato che ogni fonte di diritto non può non essere essa stessa espressione
di diritto, di ordine giuridico: sicché non e' giustificato porre una contrapposizione nella natura dell'una e
dell'altro.
26
STORIA DEL PARLAMENTO ITALIANO
1. – Gli antichi parlamenti italiani. 2. – Dalle Repubbliche
giacobine ai Regni napoleonici. 3. – Il periodo risorgimentale. 4. – Il
Parlamento italiano.
SOMMARIO:
1. – La parola “parlamento” si fa risalire più addietro del tardo secolo XI.
Esso nasce nei Paesi dell’Occidente come parlamentum o parliamentum e,
alla francese, parlement. In quest’ultima forma esso si presenta, forse per
la prima volta in senso assoluto, nella celebre Chanson de Roland, della
fine dell’XI o principio del XII secolo. In latino lo si trova in un documento
pontificio, del 1089, del papa Urbano II che richiamava gli abitanti di
Velletri al loro obbligo di exhibere parlamentum, cioè di presentare alla
rassegna il loro contingente militare; nel 1101, negli Annali genovesi di
Caffaro, con l’ordine impartito in senso, egualmente, militare; nel 1113, in
un documento lucchese dove si ricorda un publicum parlamentum, o
pubblica riunione locale; in un altro documento pontificio degli anni 1107 –
1110, accennante agli obblighi militari degli abitanti di Ninfa. Lo si ritrova
ancora, in questo senso o in quello di grande assemblea, nei documenti
italiani di Federico Barbarossa e di suo nipote Federico II, in un documento
trevigiano del 1189, ecc.
Che cosa siano stati i parlamenti - o le assemblee di stati - durante il
Medio Evo è cosa non certo semplice dire in poche righe.
In Italia gli antichi parlamenti o, secondo altra terminologia,
“preparlamenti”, si ricollegano a quelle stesse formule istituzionali tardo –
27
medievali europee da cui nasce il Parlamento inglese. Non solo perché a
fine Settecento l’istituto appare quasi in ogni parte d’Italia estinto, non
resistendo alla pressione livellatrice dell’assolutismo, così come del resto
dagli inizi del Seicento non si adunavano più gli Stati Generali di Francia.
E neppure tanto perché si trattasse di “assemblee di Stati” – fondate sulla
rigida divisione di ordini sociali di “ancien régime” nobiltà feudale o
braccio militare, clero, borghesia privilegiata delle città regie o demaniali –
e non già di forme di rappresentanza politica generale. Quanto e
soprattutto, perché non appaiono organi della sovranità, investiti di una
autonoma potestà legislativa e di indirizzo politico, ma parti di un rapporto
contrattuale improprio con il Principe (“leggi pazionate”) o più spesso
organi di rimostranza, di consultazione e di petizione posti in certo modo al
di fuori della struttura essenziale dello Stato. Nulla che in essi anche
lontanamente arieggi il principio che contemporaneamente si afferma
invece in Inghilterra della responsabilità dell’esecutivo nei confronti delle
assemblee, tanto meno quello americano del Parlamento titolare del potere
legislativo nel quadro di una “higher Law” irremovibile. Mancano,
soprattutto, del potere di autoconvocarsi: anche quando per le loro
adunanze è prevista una periodicità annuale, più spesso triennale o
decennale, non esiste mezzo legale per riparare al difetto di convocazione.
La certificazione dei loro atti e deliberazioni è spesso affidata a un
funzionario del principe, il Regno Protonotaro in Sicilia, il Reggente la
Reale Cancelleria in Sardegna. “Nessun nostalgico o romantico amore del
passato può farci dimenticare che nella concezione e funzione istituzionale,
nella loro struttura, ‘in toto’ insomma, essi fossero ormai, al termine del
periodo considerato, poco meno che un’anticaglia, anzi avanzi davvero,
28
come aveva detto il marchese Domenico Caracciolo, di medio evo”
(Marongiu).
Se l’Italia di fine Settecento appare un cimitero di Parlamenti, un
primato in materia spetta certamente alla casa di Savoja, posta di fronte a
più gravi problemi di amalgama e unificazione interna di domini acquistati
in tempi e a titoli diversi. Già nel Cinquecento, Emanuele Filiberto aveva
spento quelli delle due “patrie” di Savoja e di Piemonte e alla fine del
Seicento risalivano ormai le ultime tornate del Parlamento di Saluzzo e
degli “Stamenti” sardi; finalmente, nel 1766, cessano di adunarsi anche gli
“Stati” della Val d’Aosta. Che in circostanze eccezionali e dopo aver
respinto un tentativo di invasione francese, lo “Stamento” militare sardo
presieduto dalla sua “prima voce”, il marchese di Laconi, si autoconvochi e
reclami da Vittorio Amedeo III nel 1793 il ristabilimento delle forme
parlamentari e che per circa due anni una “deputazione” stamentaria
assuma di fatto la direzione dell’amministrazione dell’isola, è vicenda
effimera e presto chiusa. Nel 1799, riparando in Sardegna, i Savoja
accantonano le promesse sessioni parlamentari, come avrebbero voluto fare
anche i Borboni riparati in Sicilia se non lo avesse impedito la volontà
dell’onnipotente alleato inglese.
Dovunque
le
monarchie
acquistassero
forza,
i
Parlamenti
scomparivano. Dopo l’ultima sessione del 1642 e dopo la rivolta di
Masaniello, non si era più adunato quello del Regno di Napoli. Con il 1754
finivano, per volontà di Maria Teresa d’Austria, quelli di Gorizia e di
Gradisca. Solo Venezia, mantenendo immobile la sua struttura oligarchica
di patriziato cittadino contro ogni tentativo di riforme (come quella,
proposta nel suo “Consiglio politico” da Scipione Maffei, di ammettere una
29
limitata rappresentanza delle città di Terraferma avviandosi alla lontana
verso forme all’inglese), consentiva però che si adunasse ogni anno il
secolare Parlamento della “Patria friulana” in Udine, nel quale aveva il
maggior peso l’elemento feudale. Ma quanto alla sostanza ancora racchiusa
in queste forme, ha valore di giudizio storico un passo assai noto delle
“Confessioni” del Nievo: “Tutto adunque concorda a stabilire che quando il
magnifico General Parlamento della Patria supplicava da sua serenità il
Doge la licenza di giudicare intorno a una data materia, il tenor della legge
fosse già concertaro minutamente fra sua eccellenza il Luogotenente e
l’eccellentissimo Consiglio dei Dieci (…). Il magnifico General Parlamento
invocava poi dalla Serenissima dominante la conferma di quanto aveva
discusso, deciso ed approvato; e giunta conferma, il trombetta nel giorno
festivo gridava ad universale notizia e per inviolabile esecuzione la Parte
presa dal magnifico General Parlamento”.
In questo quadro generale, anche particolarità interessanti di
procedura, come ad esempio il fatto che gli “Stamenti” sardi si reggessero
secondo lo stile delle “Cortes” di Catalogna e derivassero poi da quelle
d’Aragona l’istituto di una speciale commissione per i gravami o “greuges”
per
giudicare
sugli
abusi
e
illegalità
degli
organi
e
agenti
dell’amministrazione; o che in vari Parlamenti le tre “prime voci” di
ciascun ramo o braccio, o un’apposita deputazione, fossero sentiti
dall’esecutivo nei lunghi intervalli fra due convocazioni – perdono
nettamente importanza. Nulla di ciò passerà nell’esperienza parlamentare
del nuovo ciclo napoleonico e risorgimentale. Né le Restaurazioni del 1814
– 1815 restituiranno in vita queste forme esauste, tanto più in quanto la
chiusura di quella pagina ha segnato nuovi passi avanti sulla via del
30
rafforzamento strutturale delle amministrazioni centrali, recando a
compimento il vecchio sogno livellatore dell’assolutismo. L’affermazione
di un sistema tributario più moderno era un altro acquisto importante e
toglieva ogni residuo significato alla sola competenza di vero rilievo
politico delle vecchie assemblee dello “Stato a ceti” fondato su ordini
sociali privilegiati (Standen-Staat): quello di consentire i “donativi” della
nazione al principe e le imposizioni straordinarie.
Il solo caso che meriti considerazione a parte, rappresentando un
anello di congiunzione fra i preparlamenti “ancien règime” e l’esperienza
del Risorgimento, è quello della Sicilia, che sotto l’unico scettro dei
Borboni di Napoli costituiva però da secoli e restò fino al 1816 un Regno
separato, con distinta amministrazione e proprie rappresentanze risalenti
fino al Regno normanno - svevo di Federico II. La nobiltà, il clero, le città
isolane avevano tenacemente difeso in ogni tempo i privilegi e prerogative
parlamentari e ancora per tutto il Settecento le convocazioni avvenivano
ogni tre anni. Quando i Borboni ripararono nell’isola si ha una crescente
tensione fra il Parlamento e la monarchia, finché per la determinante
pressione
del
rappresentante
inglese,
lord
Bentinck,
si
passa
all’elaborazione di una nuova Costituzione, quella del 1812. Benché posta
nel nulla solo quattro anni dopo, con il recupero del Regno di Napoli e la
fusione nell’unico regno delle Due Sicilie che pone termine alla secolare
corona isolana, questa Costituzione assume eccezionale rilievo e significato
sia perché codifica adattandoli alla realtà siciliana diritti e consuetudini del
Parlamento inglese (del quale, retoricamente, si ricordava la matrice
normanna comune a quello dell’isola); sia, in un secondo tempo, come mito
del movimento costituzionalistico in Sicilia e anche fuori di questa come
31
modello costituzionale che si propone alle classi dirigenti risorgimentali in
alternativa a quelli della “Charte” francese e delle “Cortes” spagnole. Essa
dà vita ad una struttura bicamerale all’inglese, con commissioni miste dei
due rami per comporre le divergenze sui temi legislativi; vieta al re, sulla
linea di precedenti inglesi e spagnoli, di recarsi fuori dell’isola senza il
consenso del Parlamento; accorda alla Camera dei Comuni l’iniziativa
esclusiva in materia di imposizioni, e a quella dei Pari spirituali e temporali
(ecclesiastici e baroni) quella di leggi che incidano sul regime della Paria,
l’altro ramo potendo nell’uno o nell’altro caso solo accettare o respingere
in blocco. Per ogni legge, il re deve articolo per articolo concedere il suo
“placet”, od opporre il “veto” (e già in sede di sanzione della Costituzione,
tra molti articoli respinti, figura quello che accordava ad ogni siciliano il
diritto di petizione, rimostranza o presentazione di progetti di legge al
Parlamento). La disciplina delle prerogative e procedura della Camere, e
persino del loro personale, è minutissima e ispirata a diffidente e gelosa
garanzia nei confronti dell’esecutivo: il Parlamento giudica i suoi membri
anche per reati comuni; la stamperia è posta all’interno del suo edificio, e il
suo direttore dipende esclusivamente dai due presidenti; la convocazione
deve avvenire ogni anno, anziché ogni tre, e ciascuna Camera può
illimitatamente aggiornare le proprie discussioni e deliberazioni; nessuna
ingerenza regia in tema di potestà disciplinare, e ai presidenti sono concessi
energici poteri per il buon andamento dei lavori; nessuna truppa può essere
levata, introdotta o mantenuta dal re nell’isola, senza il consenso del
Parlamento. I ministri sono responsabili di fronte al Parlamento, che ha
anche il potere di processarli e punirli nella forma britannica
dell’“impeachment”. Soluzioni di estremo interesse, ma che durano
32
nell’isola tanto quanto il protettorato di fatto inglese, la guerra europea
contro Napoleone e lo stato di necessità dei Borboni. Con la Restaurazione,
ogni forma di rappresentanza, vecchia o riformata, verrà travolta anche qui.
Poco resta da dire sull’Italia prerivoluzionaria. Aspirazioni
costituzionali che pure circolano nel pensiero dell’illuminismo italiano non
ne costituiscono certo il tema e la rivendicazione dominante. La linea di
governo dell’assolutismo illuminato solo in casi eccezionali, mentre spezza
o cancella i privilegi dei vecchi Parlamenti, può orientarsi verso forme
rappresentative nuove. Così Leopoldo, Granduca di Toscana, che prima di
essere chiamato al trono di Vienna fa elaborare dai suoi funzionari un
progetto di costituzione sulla base di rappresentanti eletti a livello
provinciale dalle comunità locali, con poteri consultivi e solo limitatamente
deliberativi (i funzionari, del resto, propendono per attribuzioni meramente
consultive, se non per la vecchia forma di assemblee separate di ceti o
“Stati”). Solo in una sua ultima fase, per lo più successiva alla rivoluzione
francese, il pensiero dell’illuminismo italiano si orienta nettamente verso
forme di rappresentanza politica e diviene più acutamente consapevole dei
pericoli di arbitrio dell’assolutismo illuminato. Così Pietro Verri nei
“Pensieri sullo stato politico del milanese” (1790): “Una Costituzione
finalmente convien cercare, cioè una legge inviolabile anche nei tempi
avvenire (che) assicuri ai nostri cittadini un’inviolabile proprietà, essendo
questo il fine di ogni Governo. Conviene che tale Costituzione venga
garantita e difesa da un corpo permanentemente interessato a custodirla e di
cui le voci possono liberamente e in ogni tempo avvisare il monarca degli
attentati che il ministero con l’andare del tempo potesse promuovere per
invaderla”: corpo eletto da tutti i censiti in catasto, che dia il suo parere su
33
tutte le leggi. La sussistenza intatta delle leggi fondamentali, e fra queste
dei principi-cardine del diritto privato, richiede ormai in questa visione un
corpo politico costituito sulla nuova base dell’universalità dei cittadini: ma
è facile vedere come, quanto alla struttura dei suoi poteri e al suo ruolo
nell’organismo statale, si sia ancora lontani dalle nuove formule di diritto
pubblico che con l’arrivo delle armate rivoluzionarie francesi si faranno
strada nella penisola.
2. – Le prime manifestazioni di un moderno parlamento in Italia si hanno
nel quadro dei nuovi ordinamenti repubblicani del triennio rivoluzionario
1796 – 1799, sorti sul cammino dell’armata d’Italia del generale Bonaparte
e fissate nelle Costituzioni delle repubbliche di Bologna (1796), Cispadana,
Cisalpina e Ligure (1797), seconda Cisalpina e Romana (1798), di Lucca e
Napoletana (1799).
Benché in ragione di certi caratteri, che appartengono piuttosto alla
storia politica o all’ideologia, si sia mantenuto l’uso di parlare (magari tra
virgolette) di Repubbliche e di costituzioni “giacobine”, non è però dubbio
che essi si modellino piuttosto sulla costituzione direttoriale francese
dell’anno III, dettata da un preciso spirito di reazione antigiacobina. Questa
faceva ritorno ad un suffragio largo sì, ma censitario, e soprattutto
introduceva il nuovo principio strutturale del bicameralismo, attribuendo al
ramo più numeroso del Corpo legislativo, il Consiglio dei Cinquecento,
l’iniziativa esclusiva delle leggi e all’altro, il Consiglio degli Anziani, il
potere di accettarle o respingerle in blocco sia per motivi di merito, sia per
averne ritenuto l’incostituzionalità. Poco meno di cento articoli, a parte
quelli dedicati al procedimento elettorale, disciplinavano il Legislativo, sui
34
377 di cui constava l’intera Costituzione. Alle regole di procedura da valere
per entrambi i suoi rami fissate a questo livello, si aggiungevano le altre,
del pari comuni, fissate in via legislativa il 3 Fruttidoro dello stesso anno
(1795) nell’intento di assicurare una sostanziale stabilità del parlamento col
porlo al riparo dai colpi di maggioranza che a questo riguardo avevano
punteggiato la vita della Convenzione giacobina.
Le Repubbliche italiane fecero proprio le linee essenziali di questa
disciplina con pochi adattamenti, ora derivati da spirito di combinazione
con qualche raro e sparso precedente degli ordinamenti patrizi cittadini
(Bologna, Genova, Lucca, Municipalità provvisoria di Venezia); ora in
ragione del fatto stesso che, toltane l’eccezione di Bologna che pur aveva
trecentosessanta rappresentanti in confronto ai settecentocinquanta del
Corpo legislativo francese, si tendeva in Italia ad assemblee molto più
ristrette: da quarantotto a centoventi rappresentanti in un ramo e da
ventiquattro a sessanta nell’altro. Ciò non andava senza riflessi sulla
disciplina normativa e, più ancora, sulla prassi. Come in Francia, si tornava
in parte allo spirito di Mirabeau, che invano alla Costituente aveva difeso
contro Sieyès, in sede di elaborazione del regolamento 27 luglio 1789, un
sistema di tipo inglese con maggiori poteri al Presidente dell’Assemblea,
minori concessioni all’individualismo e salvaguardie contro le prassi
tumultuarie, le pressioni psicologiche del pubblico, le petizioni esposte
direttamente in forme intimidatorie in faccia all’Assemblea: le sanzioni
contro i membri indisciplinati potevano spingersi fino al carcere. Come in
Francia, il metodo di deliberazione sulle leggi era quello inglese delle tre
letture, salva la procedura d’urgenza. Come in Francia, la persistenza
ideologica del mito della “volontà generale”, della quale i pubblici
35
funzionari sedenti nelle assemblee erano considerati gli organi e gli
annunciatori, faceva ricondurre ogni manifestazione legislativa o
d’indirizzo politico al momento generale assembleare, escludendo ogni
delegazione legislativa ad ogni formazione di commissioni permanenti,
anche prive di poteri di decisione, che potessero arieggiare ai comitati della
Convenzione giacobina. L’ostilità ad ogni cristallizzazione di posizioni
dirigenti all’interno delle assemblee politiche era spinta al punto, che anche
presidenti e segretari erano assoggettati ad una rapida rotazione. Come in
Francia, infine, erano garantite l’inviolabilità dei membri del Corpo
legislativo e, quasi sempre, la sua sicurezza riposante su un proprio corpo
armato e sulla clausola che ne richiedeva l’autorizzazione per far transitare
o mantenere truppe entro un certo raggio dalla sua sede (nelle piccole
Repubbliche italiane, varranno gli stessi confini del territorio, confluendovi
differenti motivazioni). Altre disposizioni assicuravano la pubblicità e la
stampa dei processi verbali e le comunicazioni fra i due rami dei Corpi
legislativi e con l’esecutivo, affidati di norma a “messaggeri di Stato” posti
alla dipendenza diretta delle Assemblee.
Accanto alle affinità – o meglio, e più spesso, alle riprese testuali di
disposizioni – vanno registrate le differenze. Meno importanti, forse, quelle
che rappresentavano residui o ricordi di istituti della tradizione comunale
italiane, come il sindacato sugli eletti allo scadere della carica sancita, ad
esempio, dalla Costituzione bolognese, per la quale (art.59) “Ciascun
membro del Corpo legislativo è responsabile di ciò che ha operato nel
tempo della sua carica per un anno intero dal giorno in cui uscì d’ufficio.
Non può in tale anno partirsi dallo Stato della Repubblica senza permesso
del Corpo legislativo”. Meno importante, certamente, la terminologia
36
diversa dalla francese che tratto tratto affiora e si rifà ancora alla tradizione
comunale, o a Roma, o alla Grecia. Ma assumono un sicuro significato certi
svolgimenti che riflettono esperienze, o mancate esperienze italiane, a
partire dal fatto stesso che molte di queste assemblee si dessero propri
regolamenti, con una manifestazione di autonomia normativa che
corrispondeva alla meno sentita necessità di prevenire eccessi assembleari.
Anche questa, naturalmente, è una pura generalità, perché la Repubblica
romana si diede a sua volta invece, sull’esempio francese, una “legge sopra
l’organizzazione dei consigli legislativi e sopra l’ordine delle loro
deliberazioni”. Che, poi, la giustificazione teorica di tali regolamenti si
trovasse nella teoria già enunciata nell’89 da Mirabeau del “pouvoir
constituant” – nell’esercizio del quale ogni Assemblea stipulava il proprio
“patto sociale” su un piano ben distinto da quello dell’attività legislativa
ordinaria, che era esercizio di potere costituito, non costituente – e fosse in
tutto e per tutto congruente con il sistema di diritto pubblico desumibile dal
complesso delle Costituzioni “giacobine”, è altra e diversa questione. Qui è
solo il caso di registrare la conclusione della storiografia, ormai stabilita nel
senso che essi, precisando e svolgendo la disciplina delle Assemblee già
largamente enunciata a livello costituzionale; da un alto si presentavano
come un felice corollario della concezione illuministica delle fonti del
diritto tuttora prevalente, ispirata a netta diffidenza verso la consuetudine e
la prassi non scritta, dall’altro, contribuirono a consentire un ordinato e
proficuo esplicarsi dell’attività legislativa in un paese, come l’Italia, che
non poteva rifarsi a una propria esperienza parlamentare in senso moderno.
Va anche detto che il regime di semiprotettorato francese nel quale ebbero
vita questi esperimenti era ben più efficace delle stesse salvaguardie
37
costituzionali e regolamentari nel senso di prevenire i temuti sviluppi verso
il “regime di assemblea”.
Alcune specifiche novità italiane meritano, in ogni caso, attenzione.
Nella Costituzione della repubblica napoletana, per merito soprattutto di
Mario Pagano, che su questo e su altri temi faceva valere una sua originale
visione costituzionale, l’iniziativa delle leggi è attribuita al corpo più
ristretto e di età più adulta, il Senato, considerando “oltre l’esempio delle
antiche repubbliche, nelle quali un ristretto senato proponeva le leggi, e
numerosa assemblea popolare le rigettava o approvava”, che “proporre le
leggi è più l’effetto della fredda analisi che dell’ardito genio, richiede più
estensione di lumi che voli di spirito. Ritrovare la propria, esatta e chiara
forma di legge, è più l’opera del riserbato giudizio che dell’audace
invenzione. Ond’è che pochi, ed uomini maturi, vi riescono meglio che
audace moltitudine di giovani”, guardando essi più all’organicità e
coerenza del sistema giuridico che ai pregi o agli incomodi della legge
singola, che un’assemblea di molteplici voci è invece meglio in grado di
apprezzare. Ancora a Pagano si deve l’assai notevole istituzione
dell’Eforato, che nella sua Costituzione doveva assicurare nello stesso
tempo quel controllo di costituzionalità formale delle leggi che nel testo
francese dell’anno III era attribuito agli Anziani ed uno, duplice, di
costituzionalità sostanziale, consistente da un lato nel cassare e annullare
gli atti emanati da ciascun potere “ultra vires” (ad esempio, atti
materialmente amministrativi o giudiziari emessi dal legislativo, come le
odierne “leggi provvedimento”), dall’altro nel “rappresentare al Corpo
legislativo l’abrogazione di quelle leggi che sono opposte ai principi della
Costituzione” nel loro contenuto (art. 368, n. 5). Un’altra novità tecnica di
38
rilievo fu introdotta nella Repubblica romana, nell’intento di accelerare il
lavoro legislativo e prevenire insabbiamenti di riforme: il c.d. silenzio –
approvazione degli atti legislativi approvati dal Tribunato, che un mese
dopo aver trasmesso una risoluzione al Senato poteva richiamarlo al suo
dovere di pronunciarsi: decorso inutilmente un secondo mese “senza che il
Senato abbia decretato definitivamente, il Tribunato può dichiarare che il
Senato col suo silenzio ha approvato la risoluzione. Egli può in
conseguenza mandarla al Consolato per farla eseguire come una legge: ed è
tenuto di avvisarne il Senato con un messaggio” (art. 99). Lo stesso accade
nella seconda Costituzione Cisalpina (artt. 98-101). Il Governo, che in
omaggio alla divisione dei poteri manca in tutti questi testi l’iniziativa delle
leggi, alla cui promulgazione è chiamato a provvedere, deve però esso
“invitare” o “proporre” quando si tratti di abrogazione a norma di questo
due Costituzioni e per l’abrogazione in nessun caso è ammessa la
procedura d’urgenza. L’ “invito” a legiferare era del resto nella
Costituzione dell’anno III: “Il direttorio può in ogni tempo invitare in
iscritto il consiglio de’ juniori e quello degli anziani a prendere un oggetto
in considerazione: può loro proporre misure, ma non dei progetti stessi in
forma di leggi” (art.166: cfr. gli artt. con lo stesso numero delle
Costituzioni della seconda Cisalpina e Romana, e il 162 della Napoletana).
Se le Costituzioni “giacobine” rispecchiano, con le modificazioni
accennate, il sistema di quella francese dell’anno III, dopo l’invasione degli
austro – russi in Italia e la nuova conquista o liberazione francese il
paesaggio istituzionale italiano viene ad essere dominato da un nuovo
modello autorevole: la Costituzione francese dell’anno VIII (13 dicembre
1799), quella cioè del Consolato che succede al Direttorio dopo il colpo di
39
Stato del 18 Brumaio, elaborata da Sieyès. Carattere essenziale del nuovo
regime per quanto riguarda le Assemblee parlamentari è che l’iniziativa
delle leggi passa al Governo . “Non saranno promulgate nuove leggi salvo
il caso in cui il progetto sarà stato proposto dal Governo, comunicato al
Tribunato e decretato dal Corpo legislativo” (art. 25). Tribunato e Governo,
mediante i loro oratori, sostengono e contrastano i vari progetti di fronte a
tale corpo sovrano (rimarrà famosa l’apposizione del Tribunato, e alla sua
testa di
Benjamin Constant, al Codice civile: per averne ragione,
Napoleone si induce a un ulteriore colpo di Stato); l’uno o l’altro, rimasto
soccombente, può ancora adire il Senato conservatore per il giudizio di
costituzionalità. Va notato che a breve distanza dal 18 Brumaio la legge del
5 Nevoso dell’anno VIII riconosce tanto al Corpo legislativo quanto al
Tribunato una autonoma potestà regolarmente nella materia che sotto il
Direttorio era stata invece definita con la legge già rammentata, che aveva
valore di legge costituzionale complementare. Dopo il “giro di vite”, un
Senato – consulto organico dell’anno XII (20 dicembre 1803), esteso
l’anno dopo al Tribunato, toglie però al Corpo legislativo una delle più
gelose attribuzioni della legge del ’95, la nomina della commissione
amministrativa interna, alla quale subentrano i Questori, nominati dal
Primo Console su liste formate dall’Assemblea. Lo stesso avviene per i
“Pretori”, il Cancelliere e il Tesoriere del Senato conservatore, al cui
consiglio di amministrazione annuale, che pianifica ogni genere di spese,
partecipano i tre consoli, cioè l’intero vertice dell’esecutivo.
Si possono collocare sulla linea francese dell’anno VIII le nuove
costituzioni delle Repubbliche di Lucca (1801) e Ligure (1802), nonché
quella della Repubblica italiana discussa ai Comizi di Lione (1802), che
40
prende il posto della Cisalpina con Napoleone presidente. Se non si è più di
fronte a calchi in senso tecnico del modello francese, con più o meno
estese modificazioni, è anche perché Napoleone ha ora maggiore libertà di
iniziativa in Italia, teatro e campo sperimentale dei suoi effettivi
orientamenti costituzionali. In tutte e tre le Repubbliche, intanto, si ha una
nuova base della rappresentanza: “possidenti” (fondiari), “dotti” e
“mercanti” (negozianti e fabbricanti), ora designati a vita dall’esecutivo,
ora cooptati dai colleghi, ora eletti da speciali assemblee territoriali. I loro
“collegi”, dichiara la Costituzione della repubblica italiana, “sono l’organo
primitivo della sovranità nazionale” (art.10), e come tali procedono alla
nomina di tutta una serie di cariche statali, inclusi i membri del Corpo
legislativo. Sempre riferendosi all’ordinamento di questa Repubblica, che
“mutatis mutandis” trova riscontro nelle due minori, “Il Presidente ha
l’iniziativa di tutte le leggi” (art.45), sia pure con la premessa di una certa
disciplina della fase pre-legislativa del procedimento. Altri strumenti, già
previsti
nella Costituzione
francese dell’anno
VIII, o
introdotti
successivamente ad essa, fanno la loro apparizione: esame congiunto dei
progetti da parte di una commissione del Corpo legislativo e di consiglieri
del Governo (Repubblica italiana, art.87; Lucca, art.16); successivo
dibattito in contraddittorio davanti al Corpo legislativo fra oratori del
Governo e della commissione (rispettivamente artt. 88 e 19); forme di
Senato – consulto improprio, come quella dell’art.4 della Costituzione
Ligure: ”Ne’
casi urgenti e impensati, e soprattutto se la tranquillità
pubblica è compromessa, il Senato con due terzi de’ voti può
provvisoriamente ordinare l’esecuzione dei progetti di legge”. Le sole
imposte sono eccettuate da questo tipo di disposizione (Lucca, art. 21).
41
Ancora nella Costituzione Ligure è attribuita al Senato l’emanazione dei
regolamenti esecutivi, nella sua doppia veste di organo di governo e
legislativo (artt. 4 e 7).
Gli ordinamenti dei Regni napoleonici della fase successiva (Statuti
costituzionali del Regno d’Italia degli anni 1805 – 1810; del Regno di
Napoli e Sicilia del 1808, del Principato di Lucca del 1805; Costituzione
murattiana di Napoli del 1815) si discostano ancor più, nonostante alcune
precise analogie, dall’ordinamento imperiale francese che prendeva le
mosse dal Senato – consulto organico dell’anno XII, e incontrò maggiori
opposizioni in Consiglio di Stato che nello stesso Senato. E’ mantenuta,
rispetto alla fase precedente, la formazione della rappresentanza sulla base
di notabilità, se il Regno Italico conserva i tre collegi dei possidenti, dei
dotti e dei mercanti, che ancora nel 1832, nella sua critica del “Reformbill”
inglese, formeranno l’ammirazione di Hegel, il Regno di Napoli e Sicilia
prevedeva un Parlamento nazionale formato da cinque “sedili” come nella
Napoli “ancien régime”, ma ora sorgenti rispettivamente dal clero, dalla
nobiltà, dai possidenti, dai dotti e dai commercianti; la Costituzione
murattiana del 1815, infine, affiancava al Senato vitalizio un “consiglio dei
notabili” formato da deputati espressi dai sindaci delle province, dai
contribuenti delle città maggiori, da un collegio vitalizio di commercianti
napoletani, dalle università e dalle corti di appello del Regno. Egualmente
mantenuta l’iniziativa delle leggi nelle mani dell’esecutivo, generalizzando
il metodo delle “conferenze” fra consiglieri di Stato e commissioni dei due
rami del Corpo legislativo nella formazione delle leggi, metodo già
sperimentato sia nella Repubblica di Lucca, sia nell’elaborazione del
42
Codice Napoleone in Francia, che lo aveva poi consacrato nel Senatoconsulto organico del 19 agosto 1807 (art. 4).
Nuove, invece, le disposizioni che configurano quello che
modernamente si chiamerebbe un “domaine de la loi” ristretto ad alcune
materie enumerate, attribuendo le rimanenti al “domain du réglement”. A
parte il Codice Napoleone, richiamato da norme costituzionali sia nel
Regno Italico sia in quello di Napoli e Sicilia, nel Regno Italico erano di
competenza del potere legislativo il bilancio dello Stato, la coscrizione
militare, l’alienazione dei beni nazionali, il sistema monetario, le nuove
imposte o tariffe d’imposta e le leggi civili, di “alto criminale” e
commerciali: “Tutt’altro oggetto è di competenza della pubblica
amministrazione” (art. 47). Nel Regno di Napoli e Sicilia la materia coperta
da riserva di legge appare ancora più ridotta: oltre al bilancio, vi figurano
“la ripartizione delle contribuzioni fra le province, i cambiamenti notabili
da farsi al codice civile e al codice penale, al sistema delle imposizioni o al
sistema monetario” (art. 27); ma competeva al Consiglio di Stato
“compilare” i regolamenti
generali di pubblica amministrazione e i
progetti di leggi civili e criminali (art. 5). Spettava al Re, svincolato da
questo limite di procedimento, la normazione minore, e di fatto egli
provvide anche a quella coperta da riserva di legge sulla base di una
specifica autorizzazione costituzionale valida fino alla prima riunione del
Parlamento, che non ebbe luogo mai. Nel Principato di Lucca il Senato,
formato anch’esso da possidenti, commercianti e “lettori”, è competente
per il bilancio, la vendita delle proprietà nazionali, il sistema tributario, la
legislazione civile, commerciale e penale: “Ogni altro oggetto è di
competenza
dell’Amministrazione
interna”
43
(art.
12).
Solo
nella
Costituzione murattiana la legiferazione torna in ogni caso di competenza
parlamentare, sulla base dell’iniziativa del Re e dell’esame previo da parte
delle commissioni in cui si divide ciascuna Camera: “Insorgendo obiezioni
al Parlamento sui progetti presentati per ordine del Re, o proponendosi
delle modificazioni, le commissioni (reali), se ve ne sono, o i consiglieri (di
Stato) che hanno presentato i progetti, possono sull’autorizzazione del Re
concertarsi con le commissioni di ambo le Camere, al fine di appianare le
difficoltà, e di concorrere ad una redazione, che secondi le vedute del
Parlamento” (art. 150). Con che non tanto si riprende una linea precedente
di collegamenti e organi misti fra due rami del Parlamento, quanto si mira
ad una limitazione sostanziale del diritto di emendamento.
Si accentua ulteriormente in tutta questa fase, la tendenza
dell’esecutivo a uno stretto controllo della vita delle assemblee,
sull’esempio dei precedenti francesi già richiamati. Nel Regno Italico,
Napoleone si riserva il diritto di nomina del presidente del Corpo
legislativo e dei due Questori di due in due anni, sia pure sulla base di un
bilancio fisso ripartito ogni due anni dall’Assemblea in comitato segreto.
Nel Regno di Napoli e Sicilia il Re nomina il presidente del Parlamento
sulla base di una terna elettiva (artt. 22-23), mentre l’autonomia di
quest’ultimo di fronte alla Corona è limitata dall’abbandono del sistema
delle sedute pubbliche: anzi “Le opinioni e le deliberazione non debbono
essere né palesate né impresse. Qualunque pubblicazione per via di stampa
o di affissi, che si faccia dal Parlamento nazionale o da uno dei suoi
membri, è considerata un atto di ribellione (art. 26). Ancora nella
Costituzione murattiana del 1815 il Re nomina presidente e vicepresidente
44
del Senato e del Consiglio dei notabili, in quest’ultimo caso tra cinque
nomi a lui sottoposti (artt. 97 e 121).
Va, infine, tenuto presente che il Corpo legislativo del Regno Italico
poteva soltanto accettare o respingere in blocco i progetti di legge
dell’esecutivo, ciò che non era previsto nel Reno di Napoli e Sicilia perché
l’ottanta per cento dei membri del Parlamento era di nomina regia, mentre
nella Costituzione murattiana fu contemplato un Senato egualmente di
nomina regia, oltre al ricordato dispositivo a limitazione del diritto di
emendamento. Ma soprattutto occorre ricordare che nessuno dei Parlamenti
napoletani poté aver vita, il primo per volontà della Corona, il seconda per
la fine della dinastia. Quanto al Corpo legislativo del Regno Italico, due
mesi dopo l’incoronazione Napoleone, contrariato dalle critiche e dalle
resistenze su un progetto di legge in tema di atti di registro, lo sospendeva e
poi ne paralizzava la vita col semplice espediente di cancellare lo
stanziamento necessario a farlo funzionare dal bilancio dello Stato,
nonostante che il suo ammontare fosse fissato dalla Costituzione. Nel
marzo 1808 Napoleone attribuiva al “Senato consulente” alcune
prerogative legislative: deliberare a maggioranza di due terzi sugli statuti
costituzionali e a maggioranza semplice sui progetti di aumenti di imposte:
“Sopra qualunque altro progetto di legge il Senato può presentare al Re le
sue deliberazioni dieci giorni dopo la comunicazione che gliene viene
fatta” (art. 13). Aveva poi attribuzioni consultive in materia di trattati
internazionali, altre deliberative (eventuali) sull’incostituzionalità degli atti
dei collegi elettorali, sui ricorsi per eccesso o abuso della giurisdizione
ecclesiastica, sulla rimozione dei giudici, e poteva annualmente presentare
al Re le sue osservazioni sul conto dei ministri e rappresentargli i bisogni e
45
i voti delle popolazioni. Se è forse improprio un accostamento con le
prerogative di “interinazione” e di rimostranza dei Parlamenti francesi o dei
Senati italiani “ancien regimé”, che erano corpi giudicanti e per altro verso
amministrativi, resta in ogni caso che si trattava di una assemblea parte
composta di membri di diritto e di altri nominati dal Re, parte scelta sopra
liste formate dai soliti collegi dei possidenti, dei dotti e dei mercanti.
Ovunque, del resto, nei Regni napoleonici italiani come in Francia, le
attribuzioni del Consiglio di Stato in ordine all’elaborazione e a tutta la fase
che precede la vera e propria deliberazione legislativa ebbero, in concreto,
assai maggiori importanza; non appena si consideri “un poco più da vicino
anche lo intero dei solenni e pomposi edifizi costituzionali, d’architettura
napoleonica, fin qui specificati” (Marongiu).
3. – Mentre la Restaurazione francese trova il suo assetto istituzionale
nella Charte del 6 aprile 1814, con Senato di Pari ereditari e Camera
censitaria, i principi italiani restaurati né accedono all'idea di nuove carte
costituzionali,
né
fanno
poi
rivivere
gli
antichi
Parlamenti
prerivoluzionari. La Costituzione siciliana del 1812 non venne abrogata
espressamente, ma Ferdinando II rientrando in possesso del Regno di
Napoli cancellò addirittura il Regno separato di Sicilia con atto del
1816, concedendo all'isola solo alcuni particolari diritti e privilegi
amministrativi, completati formalmente nel 1824 dalla «Legge organica
della Consulta generale del Regno». Di fronte all'assolutismo ristabilito,
e in molti domini italiani reso più completo dall'acquisizione dei risultati
dell'accentramento e livellamento napoleonici, si delinea il nuovo
46
movimento costituzionale, che si fa forte della discrasia (e della
conseguente necessità di riconciliazione) fra ordine politico ancien
régime e moderni ordini civili e amministrativi. Nella rappresentanza
parlamentare esso avrà una delle sue grandi idee-forza.
Tre sono i modelli costituzionali che tengono il campo dalla
Restaurazione fino all'età delle riforme e al
'48-'49.
Quello
anglosiciliano, bandiera dei movimenti isolani fino al 1848 - allora però
anche la seconda Camera viene resa elettiva, come la prima, fra
determinate categorie - che per il suo spirito più che moderato raccoglie
simpatie anche in altre regioni e ad esempio in Piemonte (Santorre di
Santarosa). Quello delle Cortes spagnole del 1812, la cui Costituzione
viene proclamata nel 1820 nel Regno delle Due Sicilie e nel 1821 in
Piemonte, salve le modificazioni da apportare dal Parlamento che
seguirono, ma minime, solo nel primo caso. Per quanto riguarda la
rappresentanza, in luogo del bicameralismo all'inglese si ritorna qui al
monocameralismo roussoviano della Convenzione, sulla base però di un
suffragio universale dei capofamiglia, alfabeti e no, mediato in due gradi, a
livello parrocchiale e provinciale. L'iniziativa della legislazione, o della
deroga straordinaria alle leggi vigenti, spetta al Parlamento, che procede
con il metodo delle tre letture: il silenzio del Re si ha per sanzione; la
sanzione può essere rifiutata, ma dopo la terza approvazione parlamentare
in tre anni distinti il progetto ha ugualmente forza di legge (artt. 135-145
Due Sicilie e 132-142 Piemonte). Una «deputazione permanente del
Parlamento» siede negli intervalli tra le sessioni annuali, può convocare un
Parlamento straordinario, e deve fra l'altro «invigilare sulla osservanza
della Costituzione e delle leggi, onde dar conto al prossimo Parlamento
47
delle infrazioni che avessero osservate» (artt. 153 Due Sicilie e 160
Piemonte). Il Re abbisogna del consenso delle Cortes per varcare i confini
del Regno, come effettivamente avvenne da parte di Ferdinando I, che ne
approfittò però per recarsi al congresso di Lubiana e ottenere dalla Santa
Alleanza i mezzi per schiacciare le forze liberali e annullare la
Costituzione; deve farvi approvare annualmente il contingente militare
consentito, il cui ordinamento è competenza delle Cortes; queste scelgono
il successore al Trono, nel caso di estinzione della linea maschile principale
dei successibili, e hanno poi tutta una serie di altre attribuzioni, ad esempio
in materia di controllo. Il fatto che questi due testi abbiano avuto limitata o
nessuna applicazione, nulla toglie al valore di punto di riferimento che la
Costituzione di Cadice ebbe nei dibattiti della Restaurazione, quale
modello fra tutti gli altri più avanzato in senso democratico.
Il modello che avrà però decisiva influenza è quello franco-belga. La
Charte borbonica del 1814 era stata modificata nel 1830 all'avvento della
Casa di Orléans, fra l'altro, nel senso di rendere da segrete pubbliche le
adunanze e deliberazioni della Camera dei Pari e di attribuire alla Camera
dei deputati la nomina del proprio presidente in apertura di ogni sessione,
in luogo dell'indicazione di cinque suoi membri per la nomina da parte del
Re. Rimaneva ferma la priorità della Camera dei deputati per l'esame dei
progetti d'imposta, così come la clausola che l'imposta fondiaria, a
differenza di quelle indirette, non poteva essere consentita in via
pluriennale, ma solo di anno in anno (artt. 47 e 49). Facendo alcuni passi
più in là, la Costituzione belga del 1831 rendeva elettivo anche il Senato,
con durata di otto anni e diritto di nominare il proprio presidente,
vicepresidente e bureau; sanciva espressamente il diritto d'inchiesta
48
parlamentare e quello di votare per divisione articoli e emendamenti agli
articoli di legge (artt. 40 e 42); escludeva o sospendeva dal mandato
parlamentare gli impiegati pubblici (art. 36) e, con le modificazioni della
Costituente del 1848, introduceva nel testo costituzionale l’indennità
parlamentare per i membri delle due Camere e stabiliva che ogni
funzione pubblica retribuita è incompatibile con il mandato di
rappresentante del popolo.
Il secondo Impero annullerà la potestà legislativa delle Camere,
attribuendola con il 1852 a decreti del Capo dello Stato e tornando al
Senato nominato dall’alto e sedente in segreto, al mandato parlamentare
senza indennità, alla nomina presidenziale del presidente e dei
vicepresidenti del Corpo legislativo, a limitazioni - in forma nuova - del
diritto di emendamento. Una correzione «liberale» si avrà già con i
Senato-consulti organici del 1869, promossi da Napoleone III, che regola
fra l'altro gli «uffici»: ma più ampiamente, ormai sotto la Terza
Repubblica, con i nuovi regolamenti della Camera e del Senato nel 1876,
a seguito delle prime elezioni indette sulla base delle leggi costituzionali
del 1875.
Ma per tornare al modello 1814-1830-1839 e alla sua avanzata
versione belga, occorre appena ricordare che sotto i Borboni restaurati
manca, e del resto neppure è prevista dalla Charte, la responsabilità
politica dei ministri di fronte alle Camere. Soprattutto la Camera dei
Deputati cercò via via di sfruttare in questo senso gli strumenti legali di
cui disponeva - indirizzo al Re, esame di petizioni, messa in stato di
accusa dei ministri, voto dei bilanci, lo stesso esame delle leggi -,
49
nonché di azionare strumenti di controllo non previsti in Costituzione,
come le interrogazioni (questions) e le inchieste parlamentari.
Dopo la rivoluzione di luglio si forma invece una vera e propria
tradizione parlamentare, sulla base dell'iniziativa legislativa che la
Charte riformata riconosce alle Camere e l'avvio ad una effettiva
responsabilità politica dei ministri quale si delinea con il diritto di
interpellanza e con la stessa nuova importanza e funzione dell'indirizzo di
risposta al discorso della Corona, che viene quasi a configurare un'annua
interpellanza globale sul complesso dell'azione di governo. Nonostante vari
inconvenienti, come il numero dei deputati impiegati, la macchina legislativa
funzionava sotto la Monarchia di luglio in modo quasi perfetto. Quasi
contemporaneo è il Reformbill inglese del 1832, premessa a un rinnovamento
profondo del lavoro parlamentare. In Francia, nel 1842 si propone di
distribuire i comptes-rendus delle sedute a tutti gli elettori, sia pure nel
quadro di un elettorato strettamente censitario; altre interessanti proposte
regolamentari non hanno sèguito. Ma nella Repubblica del 1848, sulla base di
una migliore organizzazione dei resoconti e della stenografia, si cerca di
risolvere in modo organico il problema dei rapporti fra stampa e Parlamento.
La Costituzione poi, a parte le norme già ricordate, conferisce ad un apposito
organo dell'Assemblea sedente nell’intervallo delle sessioni il potere di
convocarla in caso di urgenza e fa obbligo al Presidente della Repubblica, in
un quadro di netta divisione dei poteri, di presentare ogni anno, sull'esempio
americano, «con un messaggio all'Assemblea nazionale, l'esposizione
generale degli affari della Repubblica» (art. 52).
Su questo sfondo europeo vengono a proiettarsi (prescindendo
dall’ordinamento provvisorio della «Costituzione delle province unite
50
italiane» sorta dai moti del '31 a Bologna e nelle Romagne, con la sua
Consulta legislativa) gli statuti e costituzioni del 1848-49. Non va
dimenticata, anche a questo riguardo, una certa differenza fra statuti octroyés
dai Principi e testi elaborati da Assemblee, come la Costituzione della
Repubblica romana e lo Statuto del Regno autonomo di Sicilia, la cui Corona
venne offerta al primogenito di Carlo Alberto, Alberto Amedeo duca di
Genova. Ma qui, «mentre si può e si deve parlare di un movimento
costituzionale, soltanto con molte riserve è possibile parlare anche di un
movimento «costituente» del '48 italiano: e comunque di un movimento
costituente strozzato quasi sul nascere, che non è riuscito cioè, per le sue
vicende esterne e per le sue interne contraddizioni, ad essere veramente e
pienamente tale». In ogni caso, è possibile discernere alcuni tratti comuni alla
maggior parte di questi documenti, quale che ne sia l'origine: la Costituzione
del Regno delle Due Sicilie, e gli statuti del Regno di Sicilia, dello Stato della
Chiesa, del Granducato di Toscana e del Regno di Sardegna (1848) nonché il
progetto dello stesso anno per uno statuto del ducato di Modena; l'atto
costituzionale di Gaeta per la Sicilia e la Costituzione della Repubblica
romana (1849). Altro carattere hanno le «basi costituzionali» per il
Ducato di Parma (1848), mentre rimasero sulla carta il progetto di una
Costituzione italiana a base confederale elaborato dal congresso
giobertiano di Torino (1848) e quello democratico toscano per una
Costituente italiana (1849): in Toscana, peraltro, come subito dopo nella
Repubblica romana, si passò a un sistema monocamerale, sulla base del
suffragio universale.
Limitando l'analisi ai testi costituzionali, quasi in tutti ricorre una
seconda Camera vitalizia sul modello francese (con le due eccezioni in
51
Toscana e nella Repubblica romana), dove presidente e vicepresidente
sono di nomina della Corona, mentre quelli della Camera bassa sono
elettivi; le sedute sono pubbliche, salvo il diritto per un certo numero di
rappresentanti di chiedere il comitato segreto; le garanzie dei
parlamentari e il procedimento di accusa nei confronti dei ministri da
parte della Camera bassa, con giudizio della Camera alta, sono
egualmente comuni, più o meno sulla linea della Charte. Un ventaglio
più largo di soluzioni si ha per quanto riguarda l'eleggibilità dei pubblici
funzionari, ora preclusa in ogni caso, ora esclusa solo nel territorio in cui
si esercitasse la loro giurisdizione, ora assoggettata all'onere di una
rielezione, mentre qualche testo ne tace. L'indennità parlamentare, gran
novità belga del 1831 e francese del 1848, viene introdotta in via
generale solo nella Repubblica romana, mentre in Sicilia e nel
Granducato di Toscana la si accorda, a carico dei comuni, solo ai
rappresentanti residenti fuori delle capitali e in misura modesta, e altrove
ci si attiene al sistema francese della gratuità del mandato, denunciata
dai democratici come un «censo elettorale larvato». Dove poi la
divergenza è massima è nella disciplina dell'iniziativa legislativa, per la
quale alcuni testi (Due Sicilie, Granducato di Toscana, Stato della
Chiesa) tornano alla Charte del 1814 che la riserva all'esecutivo, o
accordano ai suoi progetti una priorità procedurale. Altrove, essa spetta
tanto alle Camere quanto all'esecutivo, mentre dove esiste una Camera
alta vitalizia è logico, e viene spesso sancito, che alla Camera bassa
spetti la priorità nell'esame dei bilanci e delle leggi di spesa, e dunque un
ruolo preminente nel sindacato parlamentare sull’azione di governo.
Nello statuto siciliano, in quello pontificio e nell'Atto addizionale di
52
Gaeta la Corona si riserva un potere di veto, che per gli Stati della
Chiesa si esercita udito il Concistoro, e non è superabile da una seconda
o terza deliberazione.
Fra le disposizioni singolari, che si discostano dai modelli francobelgi o britannici (il costituzionalismo « giacobino » o direttoriale, e
quello spagnolo di Cadice, quasi non hanno più udienza in questo tornante del secolo), almeno due vanno ricordate. Lo Statuto del Regno
autonomo di Sicilia, elaborato sotto la direzione di Ruggero Settimo, non
solo prevede una seconda Camera elettiva; non solo per quanto riguarda
le leggi finanziarie o militari accorda al Senato il semplice diritto di
accettare o respingere in blocco; non solo mira a tutelare 1'autonomia
delle assemblee statuendo che i deputati e i senatori, se eletti ministri,
sono sospesi per la durata della carica dalle loro funzioni parlamentari;
ma ipotizza organi misti dei due rami del Parlamento: «Nel caso che le
due Camere siano d'accordo in alcuni punti, e discordi in altri dello
stesso progetto di legge, potranno deputare un numero uguale dei
rispettivi membri perché sedendo insieme procurino di conciliare le
differenze e ridurre le Camere alla conformità dei voti. Il nuovo progetto
sarà recato alla discussione delle Camere. Una proposta definitivamente
rigettata non può riprodursi che alla nuova sessione» (art. 27).
Altra disposizione notevole, questa volta in tema di controllo, è
quella per cui «Appartiene a ciascuna Camera il diritto di fare
rimostranze e indirizzi per qualunque atto del potere esecutivo» (art. 31).
Nello statuto di Pio IX, isolato fra gli altri, è limitata in certe materie
1'iniziativa legislativa: i due consigli «non possono mai proporre alcuna
legge: 1) che riguardi affari ecclesiastici o misti; 2) che sia contraria ai
53
canoni o disciplina della Chiesa; 3) che tenda a variare o modificare il
presente Statuto» (art. 36). Negli affari misti potevano essere sentiti in
via consultiva: ma era poi vietata, in ogni caso, «ogni discussione che
riguardi le relazioni diplomatiche-religiose della Santa Sede all'estero»
(art. 38). L'imposta diretta, come in altri testi, poteva essere consentita
solo per un anno, le indirette per più, con evidenti riflessi sui rapporti fra
esecutivo e legislativo.
La clausola che quasi sempre ricorre, a tenore della quale «i ministri sono responsabili» non implica (come non implicherà nella lettera
dello Statuto albertino) il principio del governo di Gabinetto o
parlamentare, ma solo la possibilità di messa in stato di accusa dei ministri stessi o la predisposizione di strumenti di sindacato parlamentare.
Solo nella Repubblica romana del 1849 l'assemblea unica elegge essa a
maggioranza di due terzi tre Consoli, ai quali spettano la nomina e
revoca dei ministri (i quali poi, a differenza da altri ordinamenti del
1848-49, formano un consiglio), l'esecuzione delle leggi e la condotta
della politica estera. Un supergoverno, insomma, con mandato triennale,
sostituzione annuale di un membro, precostituzione di responsabilità, e
di mezzi legali per vincerne l'eventuale inerzia: «Le leggi adottate
dall'Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome
di Dio e del popolo. Se il Consolato indugia, il presidente dell'Assemblea
fa la promulgazione» (art. 32). È questo, nel segno mazziniano di «Dio e
popolo», il momento di massima affermazione, configurabile peraltro
solo nel quadro di un sistema monocamerale, dei poteri del Presidente di
Assemblea.
54
4. – Lo Statuto albertino, concesso dal re di Sardegna Carlo Alberto di
Savoia per il suo Regno di Sardegna, considerava solo quattro organi
costituzionali: la corona, ereditaria con esclusiva a favore dei discendenti
maschi da maschi (cosiddetta legge salica), il senato, la camera dei
deputati, i ministri, in altre parole “il governo del re”. Con l'adozione
della forma parlamentare, il governo, organo essenziale del potere
esecutivo, diventava anch'esso una longa manus delle Camere, soprattutto
di quella elettiva. Il governo, nasceva dai voti della Camera: spesso non
c'era nessuna interpretazione da compiere da parte del governo, tanto
erano chiari. I ministri, salvo una piccola rappresentanza del Senato, erano
tutti deputati; si compiva la carriera a Montecitorio, deputato, membro di
alcune commissioni autorevoli o della giunta del bilancio, sottosegretario
di Stato, ministro.
La Camera dei deputati era il centro, il fulcro, di tutta la vita
politica.
Le norme statutarie attribuivano (art. 3) il potere legislativo “collettivamente” al re ed alle due Camere (l'art. 56 parlava, addirittura, di “tre
poteri legislativi”) ed il potere esecutivo al re, con obbligo (art. 4)
d'informare le Camere dei trattati internazionali da lui firmati e di
chiederne il consenso quando essi importassero oneri finanziari e
variazioni di territorio dello Stato. Il re convocava (art. 9) ogni anno le
due Camere, poteva prorogarne le sessioni e sciogliere quella dei deputati
(la sola elettiva) ogni cinque anni e prima, se l'avesse ritenuto necessario,
ma, in quest'ultimo caso, ne convocava un'altra nel termine (in verità assai
largo) di quattro mesi. Il re, salendo al trono, prestava giuramento di
osservare lo Statuto in presenza delle due Camere riunite. Nessun tributo
55
(art. 30) poteva essere imposto senza il consenso delle Camere. Quella che ad imitazione di quella dei Lords si chiamava anche Camera alta - del
Senato era composta di membri nominati a vita dal re su ventuno
categorie di persone, tra le quali gli ex deputati con almeno tre legislature,
oppure sei anni di esercizio, ministri, alti magistrati, coloro che, con
servizi o meriti eminenti avessero illustrato la patria, i contribuenti per
almeno tremila lire di imposte dirette. Presidente e vicepresidente del
senato (il quale, costituito in Alta Corte di giustizia per giudicare dei più
gravi crimini contro la sicurezza dello Stato e dei ministri accusati dalla
Camera dei deputati, cessava - doveva cessare! - di essere “un corpo
politico”) erano di nomina regia. La Camera elettiva era composta dei
deputati scelti dai collegi elettorali, rappresentanti, con
divieto di
mandato imperativo, non i rispettivi elettori ma «la nazione in generale »
(art, 41); essi erano eletti per cinque anni e la cessazione di un deputato,
per qualunque motivo, dalle sue funzioni dava luogo ad una
riconvocazione, per nuova elezione, del collegio di appartenenza. Come i
senatori, anche i deputati godevano delle consuete immunità, persino
(art. 46) dall'arresto per debiti, allora in vigore. Le due Camere dovevano
funzionare di conserva («cominciano e finiscono nello stesso tempo»:
art. 48); senatori e deputati, prima di entrare in funzione, dovevano
prestare giuramento di fedeltà al re, allo Statuto ed alle leggi dello Stato;
le loro funzioni non dovevano dar luogo ad alcuna indennità; godevano
di piena libertà di parola e di voto nelle rispettive Camere; nessuno
poteva essere allo stesso tempo senatore e deputato. Ognuna delle
Camere era competente a valutare la validità dei titoli di ammissione di
ciascun membro. Particolari norme regolavano 1'iter del procedimento
56
legislativo e sancivano, senza precisazioni ulteriori, la “responsabilità
dei ministri”.
Nessun articolo dello Statuto prescriveva che i ministri dovessero
venire scelti su designazione delle Camere ed essere, eventualmente,
revocati se queste avessero negato la loro fiducia. Come per un tacito
accordo tra i poteri dello Stato, l'espressione statutaria (art. 2) «governo
monarchico rappresentativo» fu tuttavia sin dal principio intesa in
questo senso e col loro comportamento dettero un contenuto immediato
e preciso all'anzidetta affermazione (art. 63) della responsabilità dei
ministri. Lo Statuto non parlava né di “parlamento” come unità, né di
Consiglio, o presidente del Consiglio, dei ministri, ma la prassi
statutaria rimediò alla lacuna: si videro, pertanto, piuttosto che i singoli
ministri, il loro insieme, e si vide e si rispettò nel Governo sia l'organo
dell'indirizzo politico dello Stato sia l'organo e l'espressione della
maggioranza parlamentare.
Pur senza che lo Statuto l'avesse affermato, il sistema elettorale
coevo e coerente ad esso era quello uninominale. Il “proclama
costituzionale” albertino dell'8 febbraio 1848 prevedeva che le elezioni
dovessero svolgersi «sulla base del censo da determinarsi» e la legge
elettorale (1egge 17 marzo 1848, n. 680) ne aveva precisato i particolari.
L'adozione del criterio censitario, allora comune, partiva dall'idea,
tradizionale, che le imposte dovessero essere consentite da coloro che
avrebbero dovuto sostenerne il peso. In pratica, però, tale criterio veniva
in parte temperato, sin da tale prima legge, da quello delle “capacità”. Il
legislatore del 1859 (1egge 20 novembre 1859, n. 3778), che operava in
virtù di pieni poteri datigli dal Parlamento, apriva nuovi, opportuni,
57
spiragli sia quanto al censo sia quanto alle “capacità”, allargando la
massa elettorale e aumentando il numero dei collegi elettorali (e, quindi,
dei deputati) da duecento a duecentosessanta: furono per la prima volta,
allora, ammessi a votare senza limite di censo, quei cittadini che, per
“indizi legali”, cioè per titolo di studio, erano «reputati possedere la
capacità necessaria all'esercizio dei diritti politici». All'aumento,
effettuato per gradi sino a raggiungere il numero di cinquecentootto, del
numero
dei
deputati,
corrispose,
via
via,
anche
una
nuova
organizzazione interna della Camera (e, per simmetria, anche del
Senato). Agli “uffici”, o raggruppamenti casuali, per sorteggio, dei
parlamentari
si
sostituirono,
gradualmente
più
numerose,
le
Commissioni, costituite sulla base, talvolta malsicura, delle competenze
o vocazioni settoriali e, più tardi, anche i “gruppi” corrispondenti ai
partiti politici di appartenenza.
Importanti novità furono, lentamente realizzate, che nel giudizio
di convalida dei nuovi senatori l'Assemblea deliberasse non più a voto
palese, ma segreto, e che il presidente della Camera alta venisse sì nominato dal Re, ma su rispettosa richiesta degli stessi senatori. Più lunga, e
risolta positivamente soltanto nel 1912, la lotta contro il divieto,
contenuto nell'art. 50 dello Statuto, di retribuzioni o indennità
parlamentari. Tra i
fautori della soppressione del divieto, il
costituzionalista e deputato Pietro Chimienti sosteneva, tra l'altro, che
l'eventuale indennità avrebbe dato la possibilità di entrare in Parlamento
anche a degli autentici operai e consentito ai deputati di trattenersi più a
lungo nella capitale e di meglio svolgervi il proprio mandato: tra gli
avversari, Gaetano Mosca replicava che l'indennità avrebbe giovato
58
assai poco e che almeno quattrocentonovanta dei cinquecentootto
deputati sarebbero rimasti o ritornati alla Camera, anche senza
indennità. Peraltro, la legge 30 giugno 1912, n. 665 (lo Statuto albertino,
costituzione flessibile, poteva essere mutato anche da una legge
ordinaria) introduceva un “rimborso spese”, eguale per tutti, e poi la
normativa elettorale, di cui al Testo Unico 26 gennaio 1913, n. 821,
introduceva un rimborso spese di corrispondenza di lire duecento annue
più un compenso annuo di quattromila lire da corrispondere ai
parlamentari non godenti stipendi o pensioni, oppure la differenza da tale
cifra degli eventuali stipendi o pensioni. Questione lungamente, a varie
riprese, dibattuta ma non risolta restò invece quella della trasformazione
del Senato in organo più concretamente “rappresentativo”, cioè elettivo.
Sebbene di estrazione parlamentare, i governi (in nome del re) più
volte esercitarono sul Parlamento pressioni e rappresaglie mediante la
chiusura o le anche lunghe proroghe e con la minaccia, tutt'altro che
campata in aria, di scioglimento ed elezioni. Salvo un'effimera,
brevissima, parentesi il Paese è stato sempre governato da deputati e i
governi hanno tutti riscosso, sino al momento di rassegnare le dimissioni,
la fiducia delle Camere. La tradizione inglese del capo della maggioranza
che diventa capo del governo è stata quasi sempre puntualmente
rispettata. Ciò spiega la scarsa volontà delle Camere di promuovere un
effettivo controllo sul Governo. In circostanze eccezionali la prassi
parlamentare è andata invece, al di là delle comuni regole procedurali,
opponendo alle iniziative governative ostacoli tecnici di varia indole,
lungaggini, proteste, interventi irrituali di vario genere (clamoroso, per
esempio, l'ostruzionismo opposto al presidente del consiglio Pelloux nel
59
giugno 1899). A ragione, pertanto, la vita politica veniva intesa da tutti
come «regime parlamentare» anche quando governo e parlamento
venivano ai ferri corti.
Le elezioni del 1913, malgrado l'adozione del “suffragio
universale”e l'abbandono, dopo il “patto Gentiloni” da parte della Chiesa
della politica del «Non expedit», cioè del divieto ai cattolici di partecipare
alle elezioni, aprivano queste ultime a nuove ed ingenti masse di elettori,
ma furono ben lontane dal portare alla Camera una maggioranza
omogenea o almeno coerente: sui cinquecentootto deputati, ben duecento
erano estranei ad ogni preciso schieramento politico e l'estrema sinistra
era molto aumentata ed ancor più aggressiva. La Camera, perciò, era
come l'opinione pubblica agitata da contrasti: un ulteriore sconvolgimento
fu provocato dallo schieramento a favore o contro l'intervento nella prima
guerra mondiale, attuato faticosamente nel maggio 1915, In un'atmosfera
quanto mai turbolenta e piena di contraddizioni, le Camere conferivano, il
20 maggio, al Governo presieduto da Antonio Salandra, i pieni poteri,
ossia la «facoltà, in caso di guerra e durante la medesima, di emanare
disposizioni aventi vigore di legge, per quanto sia richiesto dalla difesa
dello Stato, della tutela dell'ordine pubblico e da urgenti e straordinari
bisogni dell’economia nazionale», come pure quella di «esercitare
provvisoriamente i bilanci». Sembrò la fine del regime parlamentare. I
governi fecero, nel corso della guerra, uso indiscriminato dei decretilegge, persino in materia fiscale (sebbene l'art. 30 dello Statuto albertino
stabilisse che nessun tributo poteva essere imposto o riscosso se non fosse
stato consentito dalle Camere).
60
La perdita di credito, e di peso, elettorale, dell'antica classe
dirigente, di destra e di sinistra, l'epidemia inarrestabile degli scioperi e
delle agitazioni operaie, la debolezza dei Governi e l'adozione, nelle
elezioni del 1919, del sistema proporzionale e il dilagare della violenza
politica resero, o fecero ritenere, 1'Italia ingovernabile. La lotta politica,
ormai esplosiva, trovò forse nuovo alimento nell’agosto del 1920, nella
riforma del regolamento della Camera dei deputati, con la trasformazione
dei raggruppamenti, o “uffici” sino ad allora esistenti in altri, composti dei
rappresentanti, anch'essi proporzionalmente eletti, dei vari partiti: ciò mise
in atto, per la prima volta, un diretto ed efficace controllo dell'attività del
Parlamento da parte, appunto, di questi. Il Parlamento sembrava diventato,
ormai, né più né meno di un comitato politico avente per unico fine di
creare e rovesciare i governi.
Iniziato e salutato da molti come restauratore dell'ordinamento
costituzionale e, poi, perpetuato e consolidato in ordinamento, o regime,
totalitario, il governo fascista sembrò, nei primi anni della sua attività,
rimettere tutto in sesto e realizzò, tra l'altro, varie riforme da tempo
domandate. Sdegnoso dei «ludi cartacei», e cioè del suffragio elettorale,
esso non mancò, tuttavia, di occuparsi anche di essi, introducendo, sul
finire del 1923, a proprio uso e consumo, la norma (1egge 18 novembre
1923, n. 2444) per cui alla lista che avesse ottenuto il maggior numero dei
voti - non meno, però, del venticinque per cento - nel collegio unico
nazionale sarebbero spettati i due terzi del numero dei deputati.
Conseguentemente, e successivamente, le due Camere furono, con una
serie di artifici, inquadrate tra le istituzioni “fasciste” e subordinate non
solo al “capo del governo-capo del fascismo” ma anche al “Gran Consiglio
61
del Fascismo”. La legge 24 dicembre 1925, n. 2263 stabiliva che «nessun
oggetto può esser messo all'ordine del giorno delle Camere, senza
l'adesione del capo del Governo». La stessa legge, dicendo, all'art. 2, che il
Capo del Governo era nominato e revocato dal Re e rispondeva verso di lui
dell'indirizzo generale politico del Governo, estrometteva implicitamente
dal sistema la sanzione del voto di fiducia delle Camere. A coronamento di
tale politica, la legge 17 maggio 1928, n. 1019 ribadiva il collegio elettorale
unico nazionale e riduceva il numero dei deputati a quattrocento; attribuiva
la scelta dei candidati da votare alle organizzazioni di categoria e
l'approvazione di tale lista al Gran Consiglio; limitava la pronuncia degli
elettori ad un, plebiscitario, «sì» oppure «no». La riforma toccava anche il
Senato, togliendogli la facoltà (della quale del resto aveva cessato di fare
uso) di designare al Re la persona del suo presidente.
Con la 1egge 19 gennaio 1938, n. 129, approvata per acclamazione,
cioè senza discussione, dai due rami del Parlamento, la Camera dei deputati
veniva sostituita da una «Camera dei fasci e delle corporazioni», di membri
non più eletti ma proclamati dall’alto. Per l’art. 16 di essa, salvo i disegni di
legge di carattere costituzionale, di deleghe legislative, di esame e
approvazione di bilanci, tutti gli altri provvedimenti dovevano essere
sottoposti alla decisione delle commissioni legislative delle due Camere.
A pochi giorni di distanza dal 25 luglio, con regio decreto 2 agosto
1943, n. 705, la Camera dei fasci e delle corporazioni era sciolta. È
notevole però la formula: «La XXX legislatura è chiusa», che inseriva quel
ciclo di vita parlamentare affatto atipico nella serie ordinaria delle
legislature del Regno. Relativamente al Senato, si ebbe a lungo una
situazione di incertezza giuridica per quanto riguarda la permanenza se non
62
delle sue attribuzioni (il decreto del '43 prevedeva la convocazione di una
nuova Camera entro quattro mesi dalla cessazione dello stato di guerra e
implicitamente confermava il pieno diritto della seconda Camera), di una
cittadinanza nell'ordinamento che, specialmente dopo il decreto legislativo
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, che abrogava la statuizione
relativa alla nuova Camera per prevedere l'elezione di un'Assemblea
Costituente «per deliberare la nuova Costituzione dello Stato» diede luogo
a curiose controversie politiche e poi anche giudiziarie.
Tuttavia a poche settimane di distanza il Governo Bonomi, nato dal
compromesso fra 1a Corona e i partiti del Comitato di Liberazione
Nazionale (C.L.N.), provvedeva a invitare uno dei Presidenti della Camera
prefascista, Vittorio Emanuele Orlando, ad assumere i poteri presidenziali a
norma dell'art. 16 del suo Regolamento interno considerato, dunque,
vigente. Era posto così il primo pilone del ponte di continuità che si voleva
ricollegasse le nuove all'antica Assemblea.
Con successivo decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n.
146, veniva istituita la «Consulta nazionale» con compiti di affiancamento
consultivo del Governo. Le nomine a consultore avvennero fra tre
categorie: designati dai maggiori partiti politici antifascisti; esponenti di
categorie e organizzazioni sindacali, culturali e di reduci; ex parlamentari
antifascisti, ai quali poi si aggiunsero antichi ministri, sottosegretari ed alti
commissari di governo dell'età prefascista. Specialmente quest'ultima
categoria è da considerare, perché la sua autorità ed esperienza risultò per
più punti, decisiva nel configurare la nuova tradizione politicoparlamentare democratica. Molti fra questi consultori vennero rieletti alla
Costituente e nelle prime Camere repubblicane, altri entrarono a far parte,
63
quali membri di diritto, del Senato della Repubblica per gli anni 19481953. Si attuò per questa via un’ulteriore saldatura di generazioni, che
dava un contenuto concreto alla riaffermata continuità parlamentare.
È ancora notevole il fatto che la Consulta, nonostante contrasti e
rimostranze in ordine all'esame consultivo in sede di Commissione (e cioè,
nuovamente, in sede non pubblica) dei progetti per i quali il suo parere era
obbligatorio, avesse dieci Commissioni permanenti. La esperienza di
queste Commissioni forma un importantissimo precedente sia rispetto alle
Commissioni dell'Assemblea Costituente che, restando riservati per quasi
tutte le materie i poteri legislativi al Governo, diedero però vita ad una
forma di legislazione sostanzialmente concertata fra Commissioni e
Governo; sia, soprattutto, alle ristabilite Commissioni permanenti del
Parlamento repubblicano, che non ebbero, come nel 1922, attribuzioni
puramente consultive ma, come nel 1939, attribuzioni legislative. Per il
momento, la Consulta si limitò a porre in essere forme sperimentali ed
empiriche di attività: furono riservate all’Aula, ad esempio, le leggi
elettorali mentre restava affidata alle Commissioni la più minuta
legislazione finanziaria; per i bilanci dello Stato si fece ricorso all'esame
consultivo congiunto da parte della Commissione competente per lo
specifico Ministero e di quella Finanze e Tesoro. Le Commissioni potevano
in ogni caso chiedere al Governo di deferire all'Assemblea plenaria la
discussione in ordine a dati pareri, ma di fatto non si avvalsero mai di tale
facoltà.
Per quanto riguarda i servizi, il decreto legislativo luogotenenziale 31
agosto 1945, n. 539, stabilì che «La Consulta, per il suo funzionamento, si
avvale dei locali e dei servizi della Camera dei deputati. Agli eventuali
64
servizi che non possono essere prestati dalla Camera, provvede il Ministero
per la Consulta nazionale» (art. 13), fermi restando i poteri del Presidente
della Camera dei deputati, V.E.Orlando. In relazione a tale disposizione, un
apposito stanziamento doveva figurare nel bilancio del Ministero per la
Consulta nazionale, appena istituito con il compito di elaborare e
promuovere l'emanazione delle norme giuridiche regolanti la Consulta
nazionale, e di «predisporre ed attuare le misure necessarie per la
costituzione
e
il
funzionamento
della
Consulta,
provvedendo
all'organizzazione dei relativi servizi tecnici ed amministrativi» (art. 2
decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 443). Di fatto, il
ministro per la Consulta venne ad assumere un ruolo sotto più aspetti simile
a quello del ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento
fiorito poi in periodo repubblicano, seppure per il brevissimo periodo fino
al dicembre dello stesso anno, quando venne costituito presso la Presidenza
del Consiglio un apposito «Ufficio per le relazioni con la Consulta
nazionale».
Va da ultimo ricordato che in periodo repubblicano si sono avute
varie proposte tendenti a riconoscere la Consulta, per il contributo da essa
dato all'opera legislativa del primissimo dopoguerra, quale prima
legislatura della Repubblica. Fra l'altro, su relazione di V. E. Orlando, essa
approvò con 172 voti contro 50 lo schema di decreto legislativo De Gasperi
sul referendum istituzionale e l'attribuzione dei poteri normativi al Governo
per la durata dell'Assemblea costituente e la disciplina di quest’ultima.
La relazione alla proposta di legge presentata a riguardo nel
ventennale della Consulta, il 20 aprile 1965, da esponenti dei principali
gruppi politici della Camera, così motiva conclusivamente: «È giusto e
65
degno che in quest’anno, ventesimo dalla Liberazione, il Parlamento
repubblicano dia atto della natura e delle funzioni di quella prima
assemblea popolare, ricollegandola formalmente, come idealmente e
storicamente essa è collegata, alle successive Assemblee parlamentari della
Repubblica».
66
INTRODUZIONE STORICA
ALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
NEI LAVORI PREPARATORI
SOMMARIO:
1. L’istituzione dell’Assemblea Costituente. – 2.
L’organizzazione interna dei lavori. – 3. Il progetto di Costituzione nei
lavori preparatori. – 4. La relazione al progetto di Costituzione della
Repubblica italiana.
1. - L'articolo 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151, stabilì: «Dopo la liberazione del territorio nazionale, le
forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano, che a tale fine
eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, un'Assemblea
Costituente per determinare la nuova Costituzione dello Stato».
Nell'autunno del 1945 furono istituiti, in correlazione con questa
disposizione, la Consulta Nazionale e il Ministero della Costituente. La
prima fu un organo consultivo per la legislazione ed elaborò le norme
per la elezione dell'Assemblea Costituente che il Governo poi emanò con
il Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74
(1)
; mentre
i1 secondo ebbe il compito specifico di predisporre un ampio materiale
di consultazione per i deputati alla Costituente. Il 2 giugno 1946 furono
Prolusione tenuta, in occasione dei “Quarant’anni della Costituzione della Repubblica italiana”
1948 – 1988, ai Corsi per gli Ufficiali dell’Aeronautica Militare presso la Scuola di Guerra Aerea –
Scuola di Applicazione A.M. – Firenze, Anno Accademico 1987 – 1988.
(1)
Fu emanato anche il D. L. L 16 marzo 1946; n. 98, che affidò ad un referendum popolare ogni
decisione sulla forma istituzionale dello Stato e dettò norme sulla delegazione al Governo, durante
il periodo della Costituente e .fino alla convocazione del Parlamento, del potere legislativo
ordinario.
67
convocati i comizi per deliberare, mediante referendum, sulla forma
istituzionale dello Stato e per eleggere i deputati alla Costituente.
L'Assemblea Costituente si riunì per 1a prima volta il 25 giugno
1946. Il Governo non presentò all'Assemblea un vero e proprio progetto
di Costituzione, ma si limitò a dar conto degli studi eseguiti dal
Ministero della Costituente con una serie di pubblicazioni nelle quali
tuttavia non di rado furono elaborati schemi di norme costituzionali.
2. - Apparve subito necessario che l'Assemblea fosse chiamata a
discutere, nelle sue riunioni pubbliche, sopra un progetto di Costituzione
organico e articolato. Fu nominata pertanto una Commissione per la
Costituzione, per la redazione di uno schema, che l'Assemblea avrebbe
poi esaminato con discussione generale, con discussioni generali parziali
sui vari titoli e con discussioni articolo per articolo. La Commissione per
la Costituzione, composta di 75 deputati scelti su designazione dei vari
Gruppi parlamentari in modo da rispecchiarne la proporzione, fu nominata
dal Presidente dell'Assemblea, on. Giuseppe Saragat, e
la sua
composizione, approvata dall'Assemblea, fu la seguente: Ruini, Tupini,
Ghidini, Terracini, Perassi, Grassi, Marinaro, Amadei, Ambrosini, Basso,
Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Ganevari, Cannizzo, Cappi,
Castiglia, Cevolotto, Codacci Pisanelli, Colitto, Conti, Corsanego, De
Michele, De Vita, Di Giovanni, Di Vittorio, Dominedò, Dossetti, Einaudi,
Fabbri, Fanfani, Fa- rini, Maria Federici, Finocchiaro Aprile, Froggio,
Fuschini, Giua, Angela Gotelli, Grieco, Leonilde Iotti, Laconi, Lami
Starnuti, La Pira, La Rocca, Giovanni Leone, Lombardo, Lucifero, Lussu,
68
Mancini, Mannironi, Marchesi, Mastrojanni, Lina Mer1in, Umberto
Merlin, Molè, Moro, Mortati, Nobile, Teresa Noce, Paratore, Pesenti,
Piccioni, Porzio, Rapelli, Ravagnan, Paolo Rossi, Targetti, Taviani,
Togliatti, Togni, Tosato, Uberti e Zuccarini. Fecero pure parte pro tempore
della Commissione dei 75 i deputati: Amendola, Assennato, Caristia,
Corbi, Giovanni Lombardi, Maffi, Patricolo, Vanoni, Micheli, Caronia,
D'Onofrio, Bettiol, Giolitti, Molinelli, Vito Reale, Cortese, Storchi e
Condorelli.
Nella sua prima riunione (20 luglio 1946) la Commissione elesse suo
presidente l’on. Meuccio Ruini, allora presidente del Consiglio di Stato;
vicepresidenti gli on. Tupini, Ghidini e Terracini; segretari gli on. Perassi,
Grassi e Marinaro. La Commissione procedette nei suoi lavori suddividendosi nel modo seguente:
PRIMA SOTTOCOMMISSIONE: Diritti e doveri dei cittadini: Tupini,
presidente; Grassi, segretario; Amadei, Basso, Cevolotto, Corsanego, De
Vita, Dossetti, Angela Gotelli, Leonilde Iotti, La Pira, Lucifero, Mancini,
Marchesi, Mastrojanni, Umberto Merlin, Moro e Togliatti;
SECONDA SOTTOCOMMISSIONE: Ordinamento costituzionale della
Repubblica:
Terracini,
presidente;
Perassi,
segretario;
Ambrosini,
Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cannizzo, Cappi, Castiglia,
Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Di Giovanni, Einaudi, Fabbri, Farini,
Finocchiaro Aprile, Froggio, Fuschini, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La
Rocca, Giovanni Leone, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Piccioni,
Porzio, Ravagnan, Paolo Rossi, Targetti, Tosato, Uberti e Zuccarini.
69
Prima Sezione: Potere esecutivo: Terracini, presidente; Perassi,
Bordon, Castiglia, Codacci Pisanelli, De Michele, Einaudi, Fabbri,
Finocchiaro Aprile, Fuschini, Grieco, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu,
Mortati, Nobile, Piccioni, Paolo Rossi, Tosato e Zuccarini.
Seconda Sezione: Potere giudiziario: Conti, presidente; Ambrosini,
Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cannizzo, Cappi, Di Giovanni,
Farini, Laconi, Giovanni Leone, Mannironi, Porzio, Ravagnan, Targetti e
Uberti.
TERZA SOTTOCOMMISSIONE: Diritti e doveri economico-sociali:
Ghidini, presidente; Marinaro, segretario; Canevari, Colitto, Di Vittorio,
Dominedò, Fanfani, Maria Federici, Giua, Lombardo, Lina Merlin, Molè,
Teresa Noce, Paratore, Pesenti, Rapelli, Taviani e Togni.
L'autonomia regionale, prima di essere discussa e deliberata dalla
seconda Sottocommissione, fu esaminata e redatta in articoli da un Comitato
di dieci deputati, facenti parte della Sottocommissione stessa, presieduto
dall'onorevole Gaspare Ambrosini.
Le Sottocommissioni e le Sezioni lavorarono separatamente, con l'intesa di sottoporre poi le norme rispettivamente formulate alla Commissione
dei 75 in adunanza plenaria. Durante i lavori, tuttavia, sorse un conflitto di
competenza fra la prima e la terza Sottocommissione, che vollero entrambe
occuparsi della parte economico-sociale; se ne occuparono infatti e a un
certo punto si ebbero due progetti, non troppo contrastanti. Fu allora
nominato un Comitato di coordinamento, per unificare i due testi.
Allorché la materia fu portata all'esame della Commissione dei 75,
parve necessario evitare che tutto fosse rimesso in discussione. Risultò anche
70
che non poche erano le discordanze sostanziali e formali fra i vari testi e
difficilmente eliminabili con la richiesta rapidità in una Commissione troppo
numerosa. La Commissione dei 75 affidò allora l'incarico di coordinare le
formulazioni approvate dalle Sottocommissioni e dalle Sezioni e di redigere
un progetto organico e unitario a un Comitato di diciotto suoi membri.
Questo Comitato, che fu detto Comitato di redazione o anche
Comitato dei 18, approntò il progetto, suddividendo tutta la materia in
modo organico, in parti, in titoli, in sezioni; coordinando tutti gli articoli,
approvati in sede di Sottocommissione e di Sezione, che furono ridotti da
199 a 131, più nove disposizioni finali e transitorie, con numerazione
separata.
Il Comitato di redazione ebbe poi l'incarico di rappresentare tutta
la Commissione dei 75 di fronte all'Assemblea Costituente durante gli
otto mesi di discussione pubblica. Esso fu inizialmente così composto:
Ruini,
presidente;
Tupini,
Terracini,
Ghidini;
presidenti
delle
Sottocommissioni; Perassi; segretario; Grassi, Marinaro, Ambrosini,
Calamandrei, Canevari, Cevolotto, Dossetti, Fanfani, Fuochini, Grieco,
Moro, Paolo Rossi e Togliatti. Alcuni di questi deputati divennero
successivamente ministri e cedettero il posto ad altri; altri si dimisero.
Sicché fra i deputati che hanno fatto parte, prima o poi, del Comitato dei
18 vi furono anche: Mortati, Laconi, Vito Reale, Targetti, Lucifero,
Condorelli, Giovanni .Leone, Colitto, Fausto Gullo, Tosato, Conti e
Giolitti.
Allorché il progetto di Costituzione fu approntato dal Comitato di
redazione, ne fu investita la Commissione dei 75, che vi apportò lievi
modificazioni, approvando la grandissima parte dell'operato dei 18.
71
Quindi il progetto, il 31 gennaio 1947, fu presentato all'Assemblea
Costituente, accompagnato da una relazione dell'on. Ruini.
3. - Il progetto di Costituzione rimase all'ordine del giorno dell'Assemblea
dal 4 marzo al 22 dicembre 1947. Diresse le discussioni il presidente on.
Umberto Terracini. Le norme furono votate dall'Assemblea con la riserva
(talvolta esplicita, talvolta sottintesa) del coordinamento finale, il quale
fu affidato al Comitato di redazione, che vi attese nelle ultime settimane.
Nella seduta antimeridiana del 22 dicembre l'Assemblea prese in esame i1
testo finale coordinato e risolse con votazione gli ultimi punti controversi.
La Costituzione fu approvata con votazione complessiva e finale
nella seduta pomeridiana dello stesso 22 dicembre; fu promulgata il 27
dicembre e, per la XVIII disposizione finale, entrò in vigore il l° gennaio
1948.
La formula per la promulgazione fu la seguente: « Il Capo
provvisorio
dello
Stato,
vista
la
deliberazione
dell'Assemblea
Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la
Costituzione della Repubblica Italiana; vista la XVIII disposizione
finale della Costituzione; promulga la Costituzione della Repubblica
Italiana nel seguente testo: (segue il testo). La Costituzione, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti della Repubblica. La Costituzione dovrà essere fedelmente
osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e
dagli organi dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1947. Firmato
ENRICO DE NICOLA. Controfirmano: il presidente dell'Assemblea
72
Costituente UMBERTO TERRACINI; il presidente del Consiglio dei
ministri ALCIDE DE GASPERI ».
L'Assemblea tenne 347 sedute: 128 antimeridiane e 219
pomeridiane, delle quali ultime 22 con prolungamento serale e notturno.
Alla Costituzione furono dedicate 170 sedute e le rimanenti 177 ad altre
materie: il periodo di diretta elaborazione della Costituzione cominciò il 4
marzo 1947 e si protrasse sino al 22 dicembre con complessive 272
giornate lavorative.
Sui 140 articoli del progetto furono presentati 1663 emendamenti,
dei quali 292 approvati, 314 respinti e 1057 ritirati o assorbiti; gli
emendamenti furono inegualmente ripartiti fra le singole parti del
progetto, talché su tre articoli soltanto non si ebbero emendamenti; su 18
se ne ebbe uno solo, mentre il massimo di 102 emendamenti si ebbe
sull'articolo 109 del progetto (potestà legislativa della Regione).
Durante la discussione parlarono 275 oratori, con un complesso di
1090 interventi; furono approvati 15 ordini del giorno e si ebbero, sulle
questioni più controverse, 23 votazioni per appello nominale, 43 a
scrutinio segreto, mentre 3 votazioni furono rimandate per mancanza del
numero legale.
Di tutte le discussioni in aula furono redatti un resoconto
stenografico e un resoconto sommario; di quelle nelle Sottocommissioni,
Sezioni e Commissione dei 75 ampi resoconti sommari.
Il Comitato di redazione (dei 18) e i1 Comitato speciale per le
autonomie locali (dei 10) non fecero alcun verbale o resoconto delle
sedute.
73
4. - La Costituzione comincia con dodici articoli posti sotto l'intitolazione
«Principi fondamentali». Non si tratta di un preambolo, in quanto
l'Assemblea non volle accedere al concetto del preambolo, poiché temette
che esso avrebbe potuto dar luogo a una graduatoria di valori fra le norme
relegatevi e quelle contenute nel vero e proprio testo costituzionale.
Nei Principi fondamentali sono state raccolte dal Comitato di
redazione alcune norme che per il loro carattere «generalissimo», secondo il
termine usato dal presidente on. Ruini, non avrebbero potuto trovare sede
adeguata in uno dei titoli in cui 1a Carta costituzionale si suddivide e d'altra
parte, appunto per questo loro carattere, valgono a delineare - come fu ripetutamente detto in Assemblea - il «volto della Repubblica ».
La Costituzione si divide poi in due parti. La Parte prima, intitolata
«Diritti e doveri del cittadino», è così suddivisa: Titolo I: Rapporti civili;
Titolo II: Rapporti etico-sociali; Titolo III: Rapporti economici; Titolo IV:
Rapporti politici.
La Parte seconda si intitola «Ordinamento della Repubblica» ed é così
suddivisa: Titolo I: Il Parlamento; Titolo II: II Presidente della Repubblica;
Titolo- III: Il Governo; Titolo IV: La Magistratura; Titolo V : Le Regioni,
le Province, i Comuni; Titolo VI: Garanzie costituzionali.
Seguono, quindi, diciotto disposizioni transitorie e finali.
Nella ripartizione della materia della Parte prima il Comitato di
redazione ha seguito un determinato sviluppo concettuale, che può dirsi
ispirato a1 criterio della socialità progressiva. Nel primo Titolo infatti il
cittadino è visto nella sua individualità, pur nel quadro della società della
quale fa parte; nel secondo Titolo si considerano i primi e più elementari
rapporti del cittadino con la comunità (diritti e doveri in rapporto alla famiglia
74
e alla scuola); nel terzo Titolo si considera la sfera, già più ampia, del mondo
economico; nel quarto Titolo quella, più estesa, del mondo politico. Quivi
termina la Parte prima e, con perfetta sutura ideologica, comincia la Parte
seconda, che disciplina l'organizzazione statale unitaria della società.
Il problema base che il costituente fu chiamato a risolvere fu quella
della titolarità della sovranità, che si presentò naturalmente connesso con
quello della suddivisione dei poteri (nella Costituzione si è preferito parlare di
funzioni) e del loro equilibrio in modo da rendere effettiva l’affermazione
contenuta nel primo articolo, per cui l'Italia è una «Repubblica democratica».
L'impostazione e la risoluzione che a questi problemi furono date, dopo
elaboratissimi dibattiti, dalla Commissione dei 75, e particolarmente dalla
seconda Sottocommissione, nel progetto di Costituzione, rimasero pressoché
immutate anche nel corso della maggior discussione fattane in Assemblea.
Giova quindi cedere la parola al presidente della Commissione per la
Costituzione, o n . R u i n i , i l q u a l e n e l l a relazione a1 progetto così si
espresse:
«I problemi dell'ordinamento costituzionale sono così complessi, che
non è dato risolverli con qualche formula breve. Deve bensì rimanere
fermissimo il principio della sovranità popolare. Cadute le combinazioni
ottocentesche con la sovranità regia, la sovranità spetta tutta al popolo, che è
l'organo essenziale della nuova Costituzione. Anche se non ha la continuità di
funzionamento e la personalizzazione più concreta degli altri organi, è la forza
viva cui si riconduce ogni loro potere; l'elemento decisivo, che dice sempre la
prima e l'ultima parola. Per la sua struttura universale e fluente, non può
direttamente legiferare e governare; ormai neppure nella minuscola ed arcaica
Landesgemeinde cara a Rousseau.
75
La sovranità del popolo si esplica, mediante il voto, nell'elezione del
Parlamento e nel referendum. E poiché anche il referendum si inserisce
nell'attività legislativa del Parlamento, il fulcro concreto dell'organizzazione
costituzionale è qui, nel Parlamento, che non è sovrano di per se stesso, ma è
l'organo di più immediata derivazione dal popolo e come tale riassume in sé la
funzione di fare le leggi e di determinare e dirigere la formazione e l'attività
del governo.
I1 Parlamento non può, neppur esso, governare direttamente e la sua
prerogativa di legislazione dà luogo, oggi, a difficoltà pratiche; per la
dilatazione dei compiti statali, che richiede moltissime leggi, non a torto si è
osservato che il Parlamento rischia di non poter neanche legiferare, se non
attua, per così dire, un decentramento legislativo, che - stabiliti i principi base
con « leggi cornici » - ne deleghi le norme di integrazione e attuazione anche
ad organi nuovi quali i Consigli regionali ed il Consiglio economico
nazionale.
La posizione preminente del Parlamento non toglie che gli altri organi
costituzionali abbiano funzioni e, quindi, poteri propri. Il Capo dello Stato è
regolatore ed equilibratore fra tutti i poteri ed organi dello Stato, compreso il
Parlamento. Né il «potere esecutivo», che spetta al Governo, è di mera
esecuzione; è piuttosto il «potere attivo», che, pur svolgendosi nei limiti
tracciati dalla legge, deve avere iniziative ed autonomia, per provvedere, come
è suo compito, ai bisogni che sono condizione preliminare ed originaria della
vita dello Stato. A tal fine il Governo si vale dell'apparato amministrativo e
lo dirige; ma non sono una sola ed identica cosa; e anche
democraticamente giova che l'amministrazione
abbia funzioni
e
responsabilità proprie e definite. Non occorre aggiungere quale
76
importanza abbia, per una sana democrazia, l'indipendenza della
magistratura, che, come l'amministrazione, ha alla sua radice non il voto
popolare, ma il concorso, né deve essere aperta all'influenza dei partiti. Se
si tiene presente tutto ciò, si ha l'impressione della varietà e complessità
dei problemi che vanno affrontati.
Vi è un punto che non si deve mai perdere di vista in nessun
momento, in nessun articolo della Costituzione: i1 pericolo di aprire
l'adito a regimi autoritari e antidemocratici. Si sono a tale scopo evitati
due opposti sistemi.
Anzitutto: il primato dell'esecutivo, che ebbe nel fascismo
1'espressione più spinta. Non si può dire che appartenga a questo tipo il
sistema presidenziale, che fa buona prova negli Stati Uniti d'America con
un capo dello Stato che è anche capo del Governo e ha ampi poteri ma
non sembra poter essere trasferito da noi, che non abbiamo la forma
federale né altri elementi - d'equilibrio col Congresso, d'avvicendamento
di due grandi partiti - che accompagnano quel sistema nella Repubblica
della bandiera stellata. Vi è in Europa una resistenza irriducibile al
governo presidenziale, per il temuto spettro del cesarismo, e anche per il
convincimento (e noi non dobbiamo abbandonarlo, ma valorizzarlo) che il
Governo di gabinetto abbia diretta radice nella fiducia parlamentare.
Si è d'altra parte evitato il pericolo di mettersi nel piano inclinato
del Governo d'assemblea. Ha l'apparenza d'un sillogismo la tesi che,
poiché la sorgente di sovranità è unica, nel popolo, ed unica deve esserne
la delegazione, ogni potere si concentra nel Parlamento e gli altri organi,
il Governo, il capo dello Stato, la magistratura, ne sono il comitato o i
commessi e agenti d'esecuzione. Si nega con ciò la possibilità di forme
77
molteplici e diverse di espressione della sovranità popolare; e si lascia
cadere quel tessuto costituzionale di ripartizione ed equilibrio dei poteri,
che - anche se la formula di Montesquieu è in parte superata - ha costituito
una conquista ed un presidio di libertà. Il Governo d'assemblea - lo dice
Robespierre - non può essere che di momenti eccezionali e rivoluzionari;
bisogna, quando è possibile, e noi aneliamo alla normalità, instaurare un
«regime costituzionale», a cui Robespierre aspirava, al di là della
Convenzione. « Un Governo d'assemblea - dice Proudhon - è non meno
temibile del Governo d'un despota; vi è, dippiù, che manca la
responsabilità».
Il progetto italiano, allacciandosi alla realtà europea, mantiene il
sistema parlamentare o di gabinetto; ed eliminando residui e riflessi di
eredità monarchica, lo svolge in un quadro di più piena democrazia».
Sul Titolo V della Parte seconda l'on. Ruini scrisse nella sua relazione al progetto:
«L'innovazione più profonda introdotta dalla Costituzione è
nell'ordinamento strutturale dello Stato, su basi di autonomia; e può aver
portata decisiva per la storia del Paese.
Il Comune: unità primordiale; la Regione: zona intermedia ed
indispensabile tra la Nazione e i Comuni. Mazzini, il più grande unitario
del Risorgimento, era per la Regione; e si incontrava con la proposta di
più caute forme di decentramento in Cavour e nei politici della sua scuola.
Sarebbe stato naturale e logico che all'atto dell'unificazione nazionale, si
mantenesse qualcosa delle preesistenti autonomie; ma prevalsero il timore
e lo «spettro dei vecchi Stati»; e si svolse irresistibilmente i1 processo
accentratore. È oggetto di dispute quali ne furono gli inconvenienti e
78
anche
i
vantaggi;
molti
dei
malanni
d'Italia
si
attribuiscono
all'accentramento, in ispecie pel Mezzogiorno; se anche tutti gli studiosi
meridionalisti non sono fautori di autonomia.
Certo si è che oggi assistiamo - e per alcune zone ci troviamo col
fatto compiuto - ad un fenomeno inverso a quello del Risorgimento, e
sembra anch'esso irresistibile, verso le autonomie locali. Non si tratta
soltanto, come si diceva allora, di «portare il Governo alla porta degli
amministrati», con un decentramento burocratico ed amministrativo, sulla
cui necessità tutti oggi concordano; si tratta di «porre gli amministrati nel
governo di se medesimi».
La tendenza si collega alle rivendicazioni di libertà, che sono la
grande nota di questo momento storico: di tutte le libertà, anche degli enti
locali come «società naturali». Riecheggia più viva, in questa atmosfera,
l'affermazione di Stuart Mill che nelle autonomie locali si ha un
«ingrandimento della persona umana» e che «senza istituzioni locali una
nazione può darsi un governo libero, ma non lo spirito della libertà». Vi è
bensì, nel momento attuale, un'altra tendenza all'ampliarsi, più che al
rimpicciolirsi, delle formazioni statali; e ai loro collegamenti in complessi
internazionali; si sostiene che a ciò deve accompagnarsi, per l'equilibrio,
il decentramento interno; e anche gli autonomisti riconoscono la necessità
di non intaccare l'unità politica di un Paese, che fu, come il nostro,
lacerato e indebolito. Altra tendenza ancora, alla quale assistiamo, dopo
aver visto l'influenza e la miseria di chiuse economie locali, è la
ricostruzione di ampi mercati; si sostiene che ad essi potrà meglio
riallacciarsi l'iniziativa regionale; e il desiderio d'autonomia, più vivo nel
Mezzogiorno, si basa sulla convinzione di danni e sfruttamenti da parte di
79
altre regioni; né senza l'esperimento autonomistico si potranno conoscere
le realtà e le possibilità effettive.
La Commissione è stata unanime per l'istituzione della Regione.
Questa non sorge federalisticamente. Anche quando adotta con sua legge
lo statuto di una Regione, lo Stato fa atto di propria sovranità.
L'autonomia accordata eccede quella meramente amministrativa, ma si
arresta prima della soglia federale e si attiene a1 tipo di Stato regionale
formulato dal nostro Ambrosini.
Nell'atto di dare i1 via a così rilevante riforma strutturale della vita
italiana, la Commissione non si è celate le complessità e le difficoltà di
pratica attuazione. Basta pensare all'autonomia finanziaria, non agevole a
congegnarsi, e che non potrà fare a meno d'un riparto delle imposte che
implichi un contributo di solidarietà delle Regioni provviste di maggiori
mezzi a quelle che con le proprie risorse non sarebbero in grado di
adempiere i loro servizi essenziali. Pericolo da evitare è che, mentre si
tende
ad
un
alleggerimento
della
macchina
amministrativa, i1
decentramento non dia origine ad una nuova moltiplicazione di burocrazia
nelle Regioni, senza toccare quella centrale».
Sempre nella relazione Ruini leggesi, sul Titolo VI della Parte
seconda:
«Carattere comune delle costituzioni moderne è di essere rigide. La
modificabilità continuata, e quasi inavvertita, poté sembrare un giorno
vantaggio e conquista della democrazia; ma ha dato disastrosi risultati nel
tempo fascista; e oggi la coscienza politica, vigile e sospettosa, reclama la
difesa delle libertà sancite nella Costituzione e vuole che, nella gerarchia
delle norme, quelle costituzionali abbiano valore preminente, ed istituti e
80
procedimenti particolari siano di salvaguardia contro le violazioni da parte
dello stesso Parlamento.
Istituto nuovo è la Corte costituzionale; e scarsi ne sono i precedenti e
le prove, così che non è facile risolvere i suoi problemi. Non è stata accolta
l'idea di affidare un controllo di costituzionalità, che è giurisdizionale, ma su
materie anche politiche, alla magistratura ordinaria. E’ sembrato opportuno un
organo speciale e più alto, come custode della Costituzione.
E anche per i1 procedimento di revisione costituzionale si sono adottati
i criteri più semplici, senza ricorrere ai sistemi dell'approvazione in due
legislature successive o dello scioglimento automatico delle Camere dopo che
abbiano approvato la revisione in prima lettura. Vi dovranno essere due
letture, e con un sensibile intervallo («pensarci su»), nella stessa legislatura.
Potrà il popolo promuovere il referendum; ma, quando la proposta di
revisione abbia ottenuto il voto di due terzi dei deputati e di due terzi dei
senatori, sarà senz'altro definitiva.
Se la Costituzione deve essere rigida, una troppo macchinosa e
complicata procedura di revisione ostacolerebbe il cammino a un
completamento dell'edificio costituzionale, che vogliamo sia nelle sue grandi
mura definitivo e abbia vita di secoli; ma potrà essere necessario rimettervi le
mani, negli sviluppi, non ancora esattamente prevedibili, dei sistemi
costituzionali».
Seguono quindi, con numerazione separata, diciotto disposizioni
transitorie e finali, delle quali la XII (divieto di riorganizzazione del disciolto
partito fascista), la XIII (Casa Savoia), la XIV (titoli nobiliari), la XV
(conversione in legge del Decreto Legislativo Luogotenenziale 25 giugno
1944,
n.151,
sull'ordinamento
provvisorio
81
dello
Stato)
e
XVIII
(promulgazione ed entrata in vigore della Costituzione) sono finali, le altre
transitorie.
Particolarmente le disposizioni transitorie VII e XVI sono dirette ad
evitare fratture e contrasti nel sistema giuridico: la VII proroga le vigenti
norme dell'ordinamento giudiziario fino alla emanazione (per la quale non si
pone alcun termine) della nuova legge conforme con la Costituzione e
stabilisce inoltre che fino all'entrata in funzione della Corte costituzionale la
decisione delle controversie attribuite dalla Costituzione alla competenza di
questo argano ha luogo nelle forme e nei limiti dell’ordinamento
giurisdizionale in atto; la XVI stabilisce che nel termine di un anno dall'entrata
in vigore della Costituzione si deve procedere alla revisione e al
coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano
finora esplicitamente o implicitamente abrogate. In queste due
disposizioni transitorie, mentre si fissa al potere legislativo il termine di
un anno per l'adattamento alla Costituzione delle leggi costituzionali e
preesistenti
e
nessun
termine
per
l'adattamento
della
legge
sull'ordinamento giudiziario, si tace per l'adattamento delle altre leggi
preesistenti, non costituzionali e non giurisdizionali, per quelle
disposizioni in esse contenute che siano in contrasto con norme della
Costituzione. Durante la discussione delle disposizioni transitorie non
furono fatte proposte in merito.
Il problema affiorò tuttavia nel corso delle discussioni generali su
alcuni Titoli o su singole norme della Costituzione, fornendo anche
occasione ai rappresentanti della Commissione e ad altri deputati di
riflettere, più o meno esplicitamente, le teorie più correnti sul valore
giuridico (applicabilità immediata o mediata, distinzione fra norme
82
imperative e norme costruttive, ecc.) delle disposizioni costituzionali in
raffronto a quelle della legislazione ordinaria: problema d'altronde
inerente a quella chiarificazione delle attribuzioni fra i vari organi costituzionali il cui processo è caratteristico dei periodi di transizione fra un
vecchio e un nuovo ordinamento giuridico.
Seppure sarebbe arduo ritenere totalmente raggiunta questa
chiarificazione, sta di fatto che molti dubbi sono ormai caduti, sia perché
accanto alle norme scritte si è venuta formando una valida prassi
esplicativa ed integrativa, sia soprattutto per la giurisprudenza della Corte
costituzionale, la quale ha, tra l'altro, risposto positivamente al quesito
della dichiarabile incostituzionalità di norme giuridiche anteriori alla
Costituzione.
Infatti, l’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica
italiana (in vigore dal 1° gennaio 1948 ed il cui testo è stato depositato
nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi
esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino potesse
prenderne cognizione – XVIII disposizione finale – ) non ha comportato
l’abrogazione di tutte le norme costituenti il precedente ordinamento,
essendo prevalsa nel dibattito politico, dottrinario e giurisprudenziale, la
tesi della continuità dello Stato così come formatosi nel periodo
risorgimentale (il regime fascista, infatti, si è formalmente sovrapposto
all’ordinamento statutario senza abrogarlo esplicitamente).
Pertanto agli organi legislativi, come – per altri versi e più tardi –
alla Corte Costituzionale, si pose il problema di adeguare l’intero
ordinamento ai nuovi principi affermati dalla Costituzione. In questo
senso, e impropriamente,
si può individuare un’ attuazione della
83
Costituzione come compito precipuo del legislatore e, in genere, di tutti
gli organi costituzionali. Tale opera di adeguamento è stata lunga,
complessa e non è ancora esaurita.
84
LE ORIGINI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Da qualche anno l’Italia sembra prepararsi a un cambiamento
fondamentale del suo assetto istituzionale e della sua vita civile: quello
legato alla revisione della Carta costituzionale. Per comprendere
l’importanza di un simile cambiamento, per vedere al di là di un dibattito
spesso approssimativo e strumentale, è necessario però recuperare appieno
il significato e la storia della nostra Costituzione.
Nel racconto di Umberto Terracini, che fu presidente dell’Assemblea
costituente, rivivono il travaglio e le discussioni che portarono
all’elaborazione del dettato costituzionale, le passioni e le preoccupazioni
di quell’epoca, l’impeto di rinnovamento che trovò nella Costituzione
espressione e sostegno. Ed emerge, soprattutto, una rilettura lucida e
autorevole del testo fondamentale della nostra Repubblica e del suo
rapporto con la vita del paese.
Non basta fare una buona Costituzione scritta se poi manca la
volontà politica di applicarla. Secondo Terracini, è il popolo che deve
imporre la volontà di applicazione della Costituzione. Ma spesso il popolo
non la conosce, come accade, ad esempio, per la grande maggioranza dei
giovani del nostro tempo.
Forse qualcuno di loro leggerà questa lunga intervista(1) e noterà
quello che fu chiamato allora lo spirito dell’Assemblea costituente: spirito
che si rispecchia nella stessa Costituzione formale che, nonostante i
(1)
Si riporta uno stralcio della lunga intervista di Pasquale Balsamo ad Umberto Terracini nel 1977,
in “Come nacque la Costituzione”, Roma 1997.
85
compromessi che qua e là appaiono con evidenza, nacque dal cervello di
Giove tutta intera. I costituenti vollero una democrazia-partecipazione,
vollero che il lavoro assumesse una rilevanza costituzionale da grande
principio, anche in rapporto all’altro grande principio di eguaglianza,
formale e sostanziale; vollero che protagonista della Costituzione – e
questo si deve soprattutto a Giuseppe Dossetti – fosse la persona umana (il
cittadino), garantita dalla più ampia sfera possibile delle libertà
costituzionali.
Enrico De Nicola, capo provvisorio dello Stato, per quanto fosse
napoletano, non concedeva nulla all’esteriorità. Per questo i suoi giudizi
sull’Assemblea e sull’operato di essa furono prevalentemente positivi e non
era raro il suo compiacimento per le prove di equilibrio e di concretezza
che il primo parlamento della Repubblica forniva di giorno in giorno a
onore del popolo italiano. In quel periodo, contemporaneamente, sedeva a
Parigi l’Assemblea costituente francese. Le due assemblee hanno avuto
vicende diverse e diversissimi furono i risultati dei loro valori. Il testo di
quella costituzione, tanto per fare un esempio, non fu neanche ratificato
tento era lontano dalle aspettative del popolo francese. La Costituzione
italiana, al contrario conteneva in sé tutte quelle “chiavi” che avrebbero
aperto ai lavoratori (ai cittadini) più d’una porta. L’apprezzamento di De
Nicola su questo punto era completo, senza riserve.
Di questa atmosfera è permeata l’intera intervista.
Umberto Terracini - severa figura morale che si imponeva a prima
vista - parla a lungo dei lavori dell’Assemblea costituente e mostra
sostanzialmente un’adesione ai principi fondamentali che alla fine
emersero nelle votazioni a grandissima maggioranza. Penetranti restano
86
peraltro alcune delle sue critiche: ad esempio in punto di referendum
popolare egli avrebbe voluto (e parlava nel 1978) una garanzia
costituzionale in modo che quell’istituto non potesse diventare “oggetto di
speculazioni politiche da parte di minoranze irresponsabili”. Per Terracini,
giustissimamente, “democrazia è solo rispetto delle minoranze, non
prevaricazione delle minoranze sulla maggioranza. Questa è dittatura”.
All’ultima domanda dell’interlocutore Terracini risponde senza
incertezza e le sue parole assumono un grande significato politico: “Solo se
la Costituzione è attuata nella sua interezza la sovranità del popolo può
integralmente affermarsi”.
Questa lunga intervista con il senatore Umberto Terracini avvenne a
più riprese, fra la fine della primavera e l’inizio dell’autunno 1977, mentre
la situazione del paese, pur fra ostacoli e difficoltà, subiva una delle svolte
più importanti della sua storia repubblicana. Una storia repubblicana che
era cominciata, legalmente, il 1° gennaio 1948, con l’entrata in vigore della
Costituzione, ma le cui radici erano già profonde e tenaci nella volontà del
popolo sin dalla lotta antifascista, e quindi antimonarchica, e dalla
resistenza. Si può dire che, di giorno in giorno, mentre l’intervista prendeva
corpo, la stessa Costituzione ci appariva sempre più presente nel paese.
Due dei dettami costituzionali più importanti rimasti fino a quei giorni
completamente ignorati dai governi – quello della delega di poteri alle
regioni e quello della democratizzazione delle forze armate – venivano
affrontati e avviati a soluzione sulla base di un accordo: il primo dopo
ventidue anni, fra Dc, Ppc, Psi, Psdi, Pri e Pli, i cui esponenti maggiori
avevano ragionato e discusso tutti insieme intorno ad un tavolo per offrire
all’Italia una via d’uscita dalla crisi economica e istituzionale; il secondo
87
dopo trent’anni con l’entrata in vigore della legge n. 382 del 1978 “Norme
di principio sulla disciplina militare”.
La
lunga
intervista
con
Umberto
Terracini,
presidente
dell’Assemblea costituente e confirmatario della Costituzione insieme con
Enrico De Nicola, primo capo dello Stato repubblicano, e Alcide De
Gasperi, presidente del consiglio dell’ultimo governo regio e del primo
governo della repubblica, è spesso influenzata da domande provocatorie.
Ecco, il punto è questo: individuare e approfondire i “perché no” e i
“perché
si”
della
nostra
Costituzione.
Il
motivo
conduttore
dell’argomentazione di Terracini era, infatti, molto chiaro e semplice: non
basta fare, sulla carta, la migliore Costituzione di questo mondo se poi
manca la volontà politica di applicarla. Ebbene, questa volontà politica non
la si può invocare come regalo da chi detiene i poteri economico e politico.
La Costituzione fornisce un indirizzo, una guida e anche una garanzia.
La Repubblica nasce dalla lotta antifascista e dalla guerra di
liberazione. Il 25 luglio 1943, il successivo 8 settembre e il 25 aprile 1945
sono le tre date decisive che portano il popolo italiano al 2 giugno 1946.
È quasi una somma aritmetica: caduta del fascismo più armistizio con gli
anglo-americani e fuga della famiglia reale più insurrezione nazionale
uguale Repubblica. La Repubblica matura il suo divenire nella rapida
successione dei quattro eventi, ciascuno dei quali provoca il susseguente
per trovare il naturale sbocco nel definitivo e radicale mutamento
istituzionale. Chiedo a Terracini: tu credi che uno solo dei quattro eventi
sarebbe stato sufficiente a convincere la maggioranza del popolo italiano
ad abbattere quella monarchia sabauda che, storicamente, era pur
88
sempre stata considerata la fautrice dell'unità d'Italia?
Il 25 luglio, da solo, non sarebbe servito a nulla. Anzi, avrebbe
potuto contribuire a ridare alla monarchia un fulgore e un merito dei
quali era, certamente, non degna. Ma il modo col quale il fascismo fu
congedato, attraverso l'arresto di Mussolini e il passaggio alla creazione
di un governo che accoglieva in sé solo parzialmente uomini o
tradizioni mediate del fascismo, fece credere agli italiani che, in realtà,
il merito della liquidazione del fascismo spettasse alla monarchia. In
definitiva si conchiudeva un ciclo che era cominciato con una grande
colpa della monarchia quando, nel novembre 1922, il re aveva incaricato
Mussolini di formare il nuovo governo, rifiutandosi di firmare il decreto
di stato d'assedio che persino Facta, l'uomo bonario e indulgente che si
trovava allora a capo del governo, gli aveva portato da firmare al
Quirinale. Comunque il fatto che il re aveva rifiutato lo stato d'assedio,
spalancando così le porte di Roma e affidando a Mussolini la guida del
governo, presentò automaticamente lo stesso re di fronte all'opinione
pubblica come il primo e maggiore responsabile dell'avvento del regime
fascista. Ma la gente semplice è portata a presto dimenticare. E il re,
ancora una volta per un freddo e cinico calcolo, nel luglio 1943 compì il
gesto di cacciare Mussolini, con lo scopo di riacquistare credito di fronte
alle grandi masse popolari e anche per scuotere definitivamente il
traballante ma non ancora caduto regime fascista. Di ciò le grandi masse
popolari non potevano non tenere conto in quei primi giorni di «non
fascismo». Le considerazioni della gente umile, incolta politicamente,
erano tali da dimostrare verso il re una simpatia da riscattarlo dalla colpa
del 1922. Ma la fuga dell'8 settembre verso Pescara con il governo
89
Badoglio e lo stato maggiore, e l'abbandono di Roma nelle mani
tedesche fecero dissolvere di colpo l'aureola di gloria che aveva
circonfuso la corona reale. Questo gesto deve essere considerato senza
dubbio come il primo, timido avviamento verso l'instaurazione della repubblica.
Una piccola digressione: mi accorgo che la data del 4 marzo
ricorre per ben due volte nella vita costituzionale italiana: la prima è
del 1848, quando il re Carlo Alberto elargì il suo Statuto; la seconda è
di 99 anni dopo, quando l'Assemblea costituente da te presieduta
cominciò in sedute plenarie l'esame del progetto repubblicano. Le
coincidenze qui non c'entrano, ma questa data mi fornisce l'occasione
per chiederti se il legislatore repubblicano non si sia lasciato
influenzare, nella stesura della Costituzione, dal vecchio Statuto
monarchico.
A nessuno dei deputati costituenti è mai venuto in mente il
benché più lontano richiamo allo Statuto, che restò lì, negli archivi,
come remoto fantasma. Persino i deputati del gruppo liberale, del quale
facevano parte molti vecchi nostalgici della monarchia, si sarebbero
vergognati di richiamarsi a quello Statuto.
Siamo così arrivati, dopo una lenta marcia di avvicinamento, del resto
necessaria per inquadrare la Costituzione in un contesto realistico del
momento storico, agli atti pratici che dovevano presiedere alla formulazione
vera e propria della Carta repubblicana. Vuoi parlarci brevemente degli
strumenti legislativi che resero possibili l'elezione e il funzionamento
90
dell'Assemblea costituente?
La convocazione di un'Assemblea costituente fu immediatamente
nella mente e nelle dichiarazioni ufficiali sia dei governanti, sia delle
personalità politiche dopo la formazione del governo di Salerno,
presieduto ancora dal maresciallo Badoglio. Fu lì che si cominciò a
parlare concretamente dell'opera di creazione del nuovo Stato e della
necessaria fase di passaggio. Il problema era decidere sulle competenze
che sarebbero state di un'Assemblea costituente, perché si ponevano due
questioni: la prima era quella di decidere sulla forma istituzionale.
Nessuno pensò mai di poter evadere da questa necessità, dato che
nessuno pensava di poter considerare, dopo quanto era successo, la
monarchia come forma consacrata e indiscussa. La seconda era quella di
porre le basi, e come, della nuova Carta costituzionale. Inizialmente si
era pensato, in realtà, che si doveva eleggere l'Assemblea costituente
che, come primo compito, avrebbe avuto quello della scelta istituzionale.
Solo dopo questa scelta, l'Assemblea sarebbe passata all'elaborazione
della legge fondamentale. Fu in un momento successivo, commisurando
più a fondo la situazione e le prospettive, che i partiti arrivarono alla
conclusione di scindere i due momenti: 1) dare al popolo la possibilità di
scelta istituzionale con il referendum; 2) deferire all'Assemblea eletta dal
popolo il compito di redigere la Costituzione.
A tanti anni di distanza non afferro più la differenza fra il metodo
adottato e quello proposto inizialmente.
Un conto era eleggere un'Assemblea che avrebbe poi deciso a
maggioranza la forma istituzionale dello Stato, un conto era riconoscere
91
solennemente al popolo la sua concreta sovranità nel decidere da se stesso,
senza delegare questa decisione a terze persone per quanto da esso stesso
designate o elette. Nel contempo, le nuove istituzioni sarebbero state così
investite di una maggiore autorità proprio perché promananti direttamente
dalla volontà espressa dal popolo.
Prima di addentrarci oltre, vorrei ricapitolare i tempi di questo
lavoro preparatorio. Il 4 giugno, la V Armata americana del generale
Clark libera Roma. Automaticamente, secondo gli accordi presi a Salerno,
il maresciallo Badoglio si dimette da capo del governo e Vittorio Emanuele
III delega i propri poteri di capo dello Stato a suo figlio Umberto, che
assume la qualifica di luogotenente generale del Regno. È Ivanoe Bonomi
a formare il nuovo governo. Tra i suoi primi atti, diretti a rendere possibili
le iniziative da te già illustrate, vi è il decreto legislativo luogotenenziale n.
151 del 25 giugno 1944, il cui articolo 1 disponeva: «Dopo la liberazione
del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo
italiano, che a tale fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto,
un'Assemblea costituente per determinare la nuova Costituzione dello
Stato». A guerra finita, infatti, siamo nel maggio 1945, si cominciano a
gettare le basi degli strumenti pratici per l'attuazione del D.L.L. n. 151 del
1944. Nell'autunno, il governo dà vita al ministero della Costituente,
affidato al socialista Pietro Nenni, per la preparazione di documenti-base e
di materiale di consultazione per i futuri deputati, e alla Consulta
nazionale, che, in mancanza di un parlamento eletto, è un organo
rappresentativo di tutte quelle formazioni politiche che avevano
praticamente
partecipato
alla
Resistenza:
92
comunisti,
socialisti,
democristiani, azionisti, liberali e demolaburisti: 430 in tutto. È la
Consulta, presieduta dal conte Carlo Sforza, a elaborare fra il 25
novembre 1945 e il 9 marzo 1946 tutte quelle proposte che saranno poi
trasformate
in
decreti
legislativi
luogotenenziali
per
l'elezione
dell’Assemblea costituente (D.L.L. n. 74 del 10 marzo 1946) e per il
referendum popolare (D.L.L. n. 98 del 16 marzo 1946).
Le votazioni furono fissate dal governo De Gasperi per il 2 e il 3 di
giugno.
In quella prima domenica di giugno, casa Savoia avrebbe dovuto
celebrare, come tutti gli anni, lo Statuto. Ma da quelle votazioni casa
Savoia uscì licenziata nonostante il tentativo in extremis di salvarla messo
in atto da Vittorio Emanuele III con la sua abdicazione del 9 maggio a
favore del figlio Umberto. Umberto, anch'egli fra i fuggiaschi di Ortona
(Pescara) sulla torpediniera «Baionetta», passò così alla storia come il «re
di maggio».
Arriviamo così all'8 giugno, quando la suprema Corte di cassazione
tira le somme del referendum: 12.718.641 voti (54,3%) per la repubblica e
10. 718.502 voti (45,7%) per la monarchia. Il 25 giugno 1946, quando il
parlamentare più anziano dell'Assemblea, Vittorio Emanuele Orlando,
dichiara aperta la seduta, sui banchi di Montecitorio siedono 207
costituenti democristiani (37,3%), 115 socialisti (20,7%), 104 comunisti
(18,7%), 41 dell’Unione nazionale democratica (7,4%), 30 del Fronte
dell'Uomo qualunque (5,4%), 23 del partito repubblicano (4,1 %), 16 del
Blocco nazionale della libertà (2,9 %), 7 del Partito d'azione (1,3%), 4
indipendentisti siciliani, 2 della Concentrazione democratica repubblicana,
93
2 del Partito sardo d'azione, e 1 ciascuno per il movimento unionista, i
cristiano-sociali, i «contadini» e i demolaburisti. Sono 555 in tutto. Appare
subito evidente che se la Repubblica avrà una Costituzione non potrà
averla che con l'accordo dei tre maggiori partiti: Dc, Psi e Pci. Il 26
giugno l'Assemblea elegge, intanto, il suo presidente effettivo nella
persona del socialista Giuseppe Saragat. Due giorni dopo, con una
maggioranza di 396 voti su 501, Enrico De Nicola viene eletto capo
provvisorio dello Stato repubblicano, succedendo a De Gasperi, che
aveva momentaneamente assunto quei poteri il 9 giugno, all’atto della
partenza per l'esilio di Umberto II. Lo stesso giorno viene presentata e
(caso rimasto unico in tutta la storia parlamentare) immediatamente
discussa la prima interrogazione al governo: è firmata dagli esponenti
di tutti i partiti democratici, da Brusasca a Secchia, da Rapelli a
Moscatelli, Villabruna, Jacometti, Einaudi, Roveda e Chiaramello, sulla
ventilata cessione alla Francia di Briga, Tenda e Moncenisio. De
Gasperi, che è ancora presidente del governo elettorale, risponde subito.
È sempre De Gasperi a presentarsi il 15 luglio dinanzi all'assemblea
con il suo primo governo della Repubblica, formato 12 giorni prima. Lo
Stato repubblicano poteva, dunque, funzionare. Quali furono gli
strumenti che l'Assemblea creò nel suo seno per dare all'Italia la sua
prima Costituzione democratica?
Allo scopo specifico di redigere il testo del progetto di
Costituzione fu deciso di formare una commissione rappresentativa di
tutte le forze presenti in assemblea. Era infatti impensabile che un'opera
così vasta e impegnativa potesse esser compiuta sin dall'inizio in seduta
plenaria. Da questa esigenza nacque così la commissione dei 75 che,
94
presieduta da Meuccio Ruini allora presidente del consiglio di Stato, si
suddivise in tre sottocomissioni.
Tu
presiedesti
la
seconda
sottocommissione,
quella
per
l'ordinamento costituzionale della Repubblica.
La mia sottocommissione, in particolare, fu a sua volta suddivisa
in due sezioni. La prima, presieduta sempre da me, doveva occuparsi
particolarmente del potere esecutivo; la seconda, presieduta dal
repubblicano Conti, del potere giudiziario. La prima sottocommissione,
presieduta dal democristiano Tupini, doveva fissare i diritti e i doveri dei
cittadini. La terza, infine, dei diritti e doveri economico-sociali, era
presieduta dal democristiano Ghidini.
La commissione dei 75 diede vita, se non ricordo male, a un
organismo ancor più ristretto che fu chiamato inizialmente comitato di
coordinamento, che si occupò in particolare del conflitto insorto fra la
prima e la terza sottocommissione sulla parte economico-sociale; e, in
un secondo momento, assunse il nome di comitato di redazione, o
comitato dei 18.
Il comitato dei 18 ricevette infatti le conclusioni delle tre
sottocommissioni, le coordinò, le sottopose alla commissione dei 75 e le
sostenne, infine, dinanzi all'assemblea. Solo per il capitolo delle regioni
tutto il lavoro riepilogativo fu affidato a Gaspare Ambrosini, che sarà poi
anche presidente della Corte costituzionale.
Quindi, tutto il lavoro preparatorio intorno al testo da presentare
95
in assemblea plenaria fu compiuto dalla commissione nei sette mesi
compresi fra il 20 luglio 1946 e la fine del febbraio 1947. Un vero
record, a giudicare da certi ritmi lavorativi che le assemblee legislative
avrebbero assunto negli anni successivi! Che cosa ricordi della tua
esperienza di presidente della seconda sottocommissione? Con quali
intenti, in quale atmosfera, si svolsero i lavori?
Di piena collaborazione e di affiatamento completo. Non ricordo
che si siano mai create situazioni tese e le discussioni furono vivaci, sì,
ma mai acrimoniose, né si verificarono contrapposizioni irriducibili.
L'unico elemento che poteva portare qualche turbamento in sede di lavori
preparatori era la presenza in commissione dei qualunquisti, che
rappresentavano l'unica forza valida di dissidenza. Il Fronte dell'Uq, infatti,
era costituito in gran parte da monarchici, che avevano ovviamente il dente
avvelenato per dover operare in una struttura repubblicana. Tutta la loro
azione era improntata ad astio e a disfattismo, frutto dell'esasperazione di
una situazione obiettivamente difficile che esisteva nel paese appena uscito
da una guerra disastrosa. La carenza dei generi alimentari, la borsa nera,
l'inefficienza dei trasporti pubblici, l'incapacità della burocrazia ad
affrontare una situazione nuova esacerbavano gli animi soprattutto di una
classe borghese battuta e scoraggiata. Discorso diverso, ovviamente, per le
classi lavoratrici e le masse popolari che, dopo aver subito il maggior peso
della guerra, vedevano nell'Assemblea costituente un punto di riferimento
per la rinascita e la ricostruzione. Sì, Guglielmo Giannini sfruttava molto
bene l'insoddisfazione generica, appunto qualunquista, per la situazione del
paese, e ricordo ancor oggi le frequenti manifestazioni di protesta che, in
tutto l'arco del 1947, si svolgevano a piazza Colonna e nelle strade
96
adiacenti Montecitorio all'insegna del qualunquismo più becero e
irresponsabile. Ecco, volevo ricordare questa nota musicale, rumorosa, dei
qualunquisti che stonava con la generale concordia con cui si svolgevano i
lavori preparatori.
Fra i partiti democratici a prevalenza repubblicana esisteva,
quindi, un'atmosfera costruttiva di piena collaborazione. Adesso, però,
devi spiegarmi come si venivano a formare materialmente, una parola
dietro l'altra, i vari articoli della Costituzione. Rileggendo gli atti, non
sempre risulta la paternità dell'articolo, dell'emendamento, del punto e
virgola. È possibile che, a volte, si discutesse su di un testo già
approntato in precedenza da qualche altro, non so, dal governo?
Assolutamente no. Posso e debbo dire che il governo è rimasto
completamente estraneo alla redazione del testo della Costituzione.
Nell'aula di Montecitorio i banchi dei ministri erano occupati dai
membri del comitato dei 18. Tuttavia, a quell'epoca il governo era
costituito dai maggiori partiti che sedevano in aula.
Fino al 13 maggio 1947, quando De Gasperi, mettendo in pratica
i postulati della guerra fredda scatenata da Churchill col suo discorso
di Fulton, cacciò i comunisti dal governo. Non dimentichiamo che
l'Assemblea lavorò intorno alla Costituzione sino alla fine di dicembre
di quell'anno e il governo mai si pronunciò come tale sui singoli
articoli e mai tentò di esercitare la sua influenza in sede di votazione.
Certo, se fosse stata scritta direttamente dal governo De Gasperi, la
Costituzione avrebbe avuto un carattere molto più arretrato di quello
97
che le fu dato dall'Assemblea. Ma, per fortuna, il governo non aveva
titoli per interferire, né l'Assemblea gli lasciò mai spazio per farlo.
Parliamo ora della tua elezione a presidente dell'Assemblea. Il
partito socialista (Psiup) si scinde in due tronconi: uno, il Psi, rimane
con Nenni; l'altro, meno consistente, segue Saragat, e dà vita al Psli, al
partito cioè «dei piselli», come tutti lo chiamavano comunemente a
quel tempo. Non sentendosi più rappresentante del secondo partito
italiano, Saragat si dimette da presidente dell'Assemblea. È il 6
febbraio 1947. L'Assemblea respinge le dimissioni, ma il giorno
successivo Saragat insiste. Il repubblicano Conti propone di respingere
ancora le dimissioni. De Gasperi è d'accordo, ma il socialista Lussu è
assolutamente contrario. Togliatti non esprime alcuna posizione
pregiudiziale e si rimette alla sensibilità dell'interessato. L'8 febbraio
vieni così eletto tu. La domanda è ovvia, ma voglio chiederti egualmente
che cosa avvertisti in quel momento solenne. Che cosa provasti
nell'insediarti sul seggio più alto e prestigioso della prima assemblea
parlamentare della Repubblica, tu che per 17 anni eri stato
perseguitato, imprigionato e vilipeso come sovversivo e comunista, e
cioè come nemico non solo del fascismo, ma anche della democrazia
parlamentare?
Ti dirò che non ci fu un balzo improvviso dalla mia veste di
prigioniero, di detenuto e, quindi, di uomo apparentemente umiliato dal
potere, all'alto scanno di Montecitorio. C'è stata tutta una fase di
transizione,
una
fase
abbastanza
lunga
durante
la
quale,
progressivamente, avevo assunto compiti e funzioni che mi avevano
98
dato fiducia e anche una certa posizione di rispetto e di autorità nei
confronti del mondo politico italiano. Per me la cosa più importante e
che mi aveva profondamente commosso era stato il mio reingresso
ufficiale e solenne nel partito. Quello era stato per me l'elemento
decisivo che mi aveva, anche di fronte a me stesso, riabilitato. Il partito
mi dimostrò immediatamente grande fiducia e grande stima, sì da
attribuirmi sempre più spesso incarichi nuovi e più importanti.
All'atto
della
costituzione
dell'ufficio
di
presidenza
dell'Assemblea, il partito mi designò infatti alla vicepresidenza di
spettanza comunista. Quindi, già come vicepresidente, avevo acquisito
molta pratica dell'assemblea plenaria. Saragat non era uomo da
presiedere un’assemblea, non ne ha le attitudini, non le ha mai avute,
egli porta in sé il disordine anche laddove già esisté un po' d'ordine.
D'altra parte non è colpa sua. Saragat è l'uomo del mondo della poesia,
della letteratura, della filosofia trascendentale, e quindi incaricava
frequentemente uno dei suoi vice di sostituirlo alla presidenza. Fra il
socialista Targetti, il repubblicano Conti e il democristiano Tupini, egli
preferiva me, forse per la mia preparazione, sicuramente per il mio
passato.
Posso tuttavia escludere che la tua successione a Saragat sia stata
una naturale eredità di seggio e di funzioni. In che modo si arrivò alla tua
designazione? Fosti contestato da qualcuno?
Guarda, queste son tutte cose che si decidevano in separata sede.
Ma la mia non fu una successione ereditaria, automatica, tanto vero che
anche per me fu una sorpresa, né avevo mai avuto la più lontana
99
premonizione di questa promozione massima. Per quel che ne so, la mia
candidatura fu avanzata da Togliatti ai segretari degli altri partiti anche in
base al fatto che, con la scissione socialista, il partito comunista era
finalmente divenuto il secondo partito italiano. Siccome la Dc, come
primo partito, deteneva la presidenza del consiglio, era logico che la
presidenza dell'Assemblea dovesse spettare al Pci, che faceva parte dello
stesso governo De Gasperi. Venni a sapere della mia designazione la sera
precedente la votazione. Incontrai per caso Togliatti, che usciva proprio
allora da una riunione della direzione del partito, e fra tante altre cose, alla
fine, al momento di accomiatarci, mi disse: «A proposito di domani, è
stato deciso che il presidente dell'Assemblea sarai tu».
E vorresti farmi credere che l'annuncio non ti provocò emozione?
Anche se, come vice, avevi presieduto più volte, diventavi comunque il
secondo cittadino della Repubblica!
Sì, certo, sotto questo aspetto ero evidentemente emozionato. Ma,
vedi, io sono di carattere non dico freddo, ché anzi molte volte sono sin
troppo caldo intimamente, ma sono sempre molto padrone di me stesso.
Sì, accettai l'incarico con enorme contentezza e fui particolarmente lieto
dell'enorme rivincita che mi prendevo nei confronti di tutto il passato. La
sola ambizione che mi solleticava in quel momento era in ogni modo
quella di assolvere bene anche a questo mio compito, come d'altra parte
credevo di aver ben assolto anche agli altri compiti che il partito mi aveva
assegnato dal 1945 in poi.
Arrivi dunque alla presidenza di Montecitorio con un'esperienza e
100
una conoscenza molto approfondite della materia che ti accingevi a
dirigere. Ma alla direzione del Pci discutevate di volta in volta sulle
singole parti della Costituzione che stavate formando? C'erano delle
riunioni per concordare fra i vari compagni deputati l'atteggiamento da
prendere sui diversi articoli, i singoli commi, ecc.
Non c'erano collegamenti specifici fra noi deputati e il partito come
tale. Sugli argomenti più spinosi e delicati c'era invece un'ampia e
profonda consultazione in seno al gruppo parlamentare. È chiaro che i
consigli più sentiti erano quelli di Togliatti, dato che a quell'epoca la
segreteria e la stessa direzione del partito non disponevano di compagni
molto competenti nella materia in discussione.
All'interno del gruppo comunista della Costituente, ci fu una
discussione sul tipo di Costituzione, sul tipo di Repubblica per cui
bisognava battersi? Cioè Togliatti voleva una democrazia senza
aggettivi, oppure una democrazia socialista, progressista, avanzata?
La situazione era piuttosto difficile perché il partito, nel suo
complesso, e specialmente in quelle leve che si ricollegavano al
passato
per
aver
vissuto
il
lungo
periodo
dell'illegalità,
dell'emigrazione, del carcere, della lotta partigiana - tutte esperienze
molto diverse - pensava concorde a un tipo di Repubblica se non già
socialista, comunque molto avanzato. Era l'epoca in cui la demo crazia
popolare trionfava, quanto meno verbalmente, in taluni paesi dell'est
europeo. Non sa quanto di democratico vi fosse; gli esempi erano
comunque incerti. Quindi tutto lo slancio, l'attesa, la propensione era
per uno Stato che avesse largamente in sé il segno di una direzione di
101
classe, della classe operaia, e che quindi non avesse molto a che fare
con la democrazia tradizionale. Quanto al termine di democrazia
avanzata, Togliatti sapeva bene quel che poteva esser fatto o no; e se
pure, sul piano puramente verbale, concedeva molto al partito,
Togliatti sapeva esattamente che l'unica democrazia che si poteva
creare era la democrazia borghese. Il fascismo era stato preceduto da
un regime liberal-democratico, ma lo Statuto era liberale, e quanto di
democratico si era via via potuto realizzare era il risultato delle lotte delle
masse operaie. Ripeto: operaie, e non popolari, perché fino al 1920-21 le
grandi masse contadine erano state il ventre greve della conservazione.
Quando in Italia si conquista, ad esempio, il diritto di sciopero (1904), il
merito è delle lotte degli operai e dei braccianti agricoli; lo stesso
suffragio universale, il cosiddetto suffragio universale, è conseguenza
delle lotte operaie e bracciantili. E quindi, in definitiva, la democrazia che
era venuta lentamente creandosi in Italia prima della guerra mondiale e
nei due anni successivi era stata non tanto qualche cosa che si aggiungeva
a un preesistente regime democratico, ma qualcosa che veniva finalmente
a integrarlo, a completarlo. E questo era il massimo cui si potesse
giungere a quel tempo. Va naturalmente tenuto sempre presente che la
democrazia borghese, in quanto a libertà di carattere sociale, non le aveva
mai ammesse, né volute. Quindi, tutte le norme che regolano la vita del
lavoro, i rapporti sociali fra i vari gruppi sono una innovazione
fondamentale della nostra Costituzione. Ma ciò non era sufficiente per
fare sì che la Costituzione, da democratico-borghese, diventasse socialista
o soltanto democratico-avanzata: semmai, una democrazia pienamente
dispiegata nella sua logica connaturata con il progresso dei tempi.
102
Abbiamo così portato il discorso direttamente sull'articolo 1 della
Costituzione, il cui primo paragrafo è il più famoso, forse l'unico
conosciuto da tutti i cittadini: «L'Italia è una Repubblica democratica
fondata sul lavoro». Per arrivare all'ultimo articolo, l'Assemblea
impiegò poco più di nove mesi, dal 4 marzo al 22 dicembre 1947: 272
giornate lavorative con 170 sedute esclusivamente dedicate alla
discussione e alla votazione dei 131 articoli e delle 9 disposizioni
transitorie trasmessele dalla commissione dei 75. Il tuo lavoro di
direzione, mi sembra superfluo sottolinearlo, dovette essere abbastanza
duro perché non doveva essere agevole star dietro, a volte anche in
sedute notturne, ai 275 oratori che svilupparono 1.090 interventi,
presentarono 1.663 emendamenti, approvandone 292, respingendone 314
e ritirandone o fondendone con altri 1.057, discutendo 15 ordini del
giorno e votando 23 volte per appello nominale e 43 a scrutinio segreto.
Ma l'aspetto indubbiamente più interessante di quest'orgia di parole e di
numeri è la sostanza del lavoro compiuto. Al progetto propostole,
l'Assemblea apportò poco meno di una quarantina di modifiche dando
vita al testo definitivo, che risulta composto di 139 articoli e di 18
disposizioni transitorie. La votazione finale fu pressocchè plebiscitaria:
453 sí e 62 no. Uno degli articoli più dibattuti e modificati fu, appunto, il
primo. Prendendo spunto dal modo come si arrivò all'attuale formulazione, vuoi spiegarci il meccanismo, e non soltanto tecnico,
attraverso il quale la Costituzione è infine risultata quella che è, con le
sue caratterizzazioni qualificanti, e non è stata invece un'altra cosa, non
importa se migliore o peggiore? Che cosa puoi dirci, per esempio, sul
fatto che, pur non essendoci stata nessuna obiezione sull'aggettivazione
103
«democratica» della Repubblica vi fu, invece, discussione se questa
Repubblica democratica dovrebbe essere «fondata sul lavoro» o, più
drasticamente, «di lavoratori»?
In realtà, i costituenti hanno appuntato sin dall'inizio la loro
attenzione sulle parti sostanziali della Costituzione che sarebbero state
discusse in seguito. La commissione dei 75 aveva proposto una formula più
narrativa e cioè: «L'Italia è una Repubblica democratica. La Repubblica
italiana ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese». L'importante, in questa formula, era di richiamare tutti gli elementi che,
integrandosi reciprocamente, avrebbero determinato il carattere della nostra
Repubblica. Essendo una Repubblica di popolo, la sovranità emana dal
popolo e il popolo è costituito nella sua enorme maggioranza da gente che
lavora e non certamente da coloro che lo sfruttano o che lo evitano. Ora,
l'intenzione dei proponenti delle altre formule era nutrita evidentemente da
un momento ideale: non a caso, come potrai documentare, ciascuno di essi
ebbe a negare che intendesse attribuire un carattere di classe alla nostra
Repubblica. Al contrario, se ci fosse stata una consequenzialità, sarebbe
stato necessario dichiarare che, con quelle formule, si intendeva dare un
carattere di classe. Il pluralismo, di cui oggi tanto si parla, era una realtà
già allora non solo incombente e immanente, ma operante e presente.
Infatti, Fanfani, dicendo che la «Repubblica è fondata sul lavoro»,
voleva escludere che essa potesse fondarsi «sul privilegio, sulla nobiltà
ereditaria e sulla fatica altrui». Amendola e Basso, come proponenti, e
Pacciardi e Bruni, come sostenitori, erano invece dell'opinione che
104
l'Italia dovesse essere una «Repubblica di lavoratori», e non di parassiti.
Ma Gronchi appoggiò e fece prevalere la formula di Fanfani sostenendo
proprio che era «illogico negare che la parola "lavoratori" avesse, anche
contro la volontà dei proponenti, un significato classista».
Prevalse così la formula più generica e siccome era assurdo pensare
di poter modificare in qualsiasi modo, magari anche con la violenza, la
realtà della vita italiana, la sottolineatura del momento del lavoro non
poteva poi tradursi conseguentemente in una differenziazione dei cittadini
a seconda della classe cui appartenevano, cioè della loro collocazione
specifica nell'ambito più generale del fenomeno-lavoro.
Un’ultima domanda, prima di concludere. Secondo te, basterà la
Costituzione, questa Costituzione, a fornire alle classi lavoratrici gli
strumenti, tutti gli strumenti necessari per realizzare anche il secondo
capoverso del suo articolo 1, che ancor oggi, pur fra i tanti progressi già
visti, rimane pressochè ignorato? Mi riferisco alla frase programmatica:
“La sovranità appartiene al popolo”.
Per concludere: solo se la Costituzione è attuata nella sua interezza,
la sovranità del popolo può integralmente affermarsi. Quando a ciò si
giungesse – e ne siamo ben lontani – ogni mutamento eventuale della
vigente Costituzione non potrà non tradursi che nel consolidamento di tale
sovranità.
105