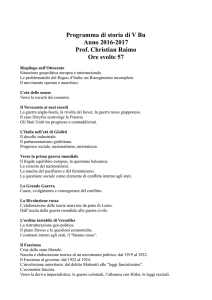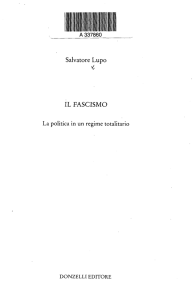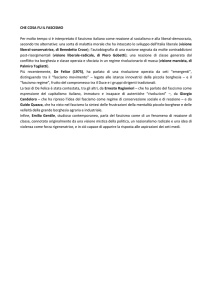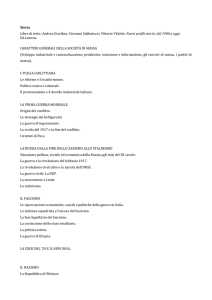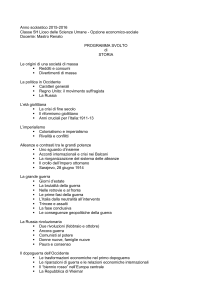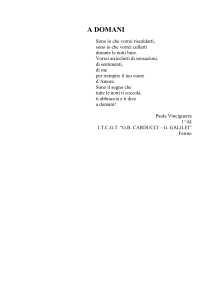CONVERSAZIONE IN SICILIA. INCIPIT.
Io ero, quell’inverno, in preda ad astratti furori. Non dirò quali, non di questo mi son messo a
raccontare. Ma bisogna dica ch’erano astratti, non eroici, non vivi; furori, in qualche modo, per il
genere umano perduto. Da molto tempo questo, ed ero col capo chino. Vedevo manifesti di giornali
squillanti e chinavo il capo; vedevo amici, per un’ora, due ore, e stavo con loro senza dire una
parola, chinavo il capo; e avevo una ragazza o moglie che mi aspettava ma neanche con lei dicevo
una parola, anche con lei chinavo il capo. Pioveva intanto e passavano i giorni, i mesi, e io avevo le
scarpe rotte, l’acqua che mi entrava nelle scarpe, e non vi era più altro che questo: pioggia, massacri
sui manifesti dei giornali, e acqua nelle mie scarpe rotte, muti amici, la vita in me come un sordo
sogno, e non speranza, quiete.
Questo era il terribile: la quiete nella non speranza. Credere il genere umano perduto e non aver
febbre di fare qualcosa in contrario, voglia di perdermi, ad esempio, con lui. Ero agitato da astratti
furori, non nel sangue, ed ero quieto, non avevo voglia di nulla. Non mi importava che la mia
ragazza mi aspettasse; raggiungerla o no, o sfogliare un dizionario era per me lo stesso; e uscire e
vedere gli amici, gli altri, o restare in casa era per me lo stesso. Ero quieto; ero come se non avessi
mai avuto un giorno di vita, né mai saputo che cosa significa esser felici, come se non avessi nulla
da dire, da affermare, negare, nulla di mio da mettere in gioco, e nulla da ascoltare, da dare e
nessuna disposizione a ricevere, e come se mai in tutti i miei anni di esistenza avessi mangiato pane,
bevuto vino, o bevuto caffè, mai stato a letto con una ragazza, mai avuto dei figli, mai preso a pugni
qualcuno, o non credessi tutto questo possibile, come se mai avessi avuto un’infanzia in Sicilia tra i
fichidindia e lo zolfo, nelle montagne; ma mi agitavo entro di me per astratti furori, e pensavo il
genere umano perduto, chinavo il capo, e pioveva, non dicevo una parola agli amici, e l’acqua mi
entrava nelle scarpe.
UNA NUOVA CULTURA
Non più una cultura che consoli nelle sofferenze ma una cultura che protegga dalle sofferenze, che
le combatta e le elimini.
Per un pezzo sarà difficile dire se qualcuno o qualcosa abbia vinto in questa guerra. Ma certo vi è
tanto che ha perduto, e che si vede come abbia perduto. I morti, se li contiamo, sono più di bambini
che di soldati; le macerie sono di città che avevano venticinque secoli di vita; di case e di
biblioteche, di monumenti, di cattedrali, di tutte le forme per le quali è passato il progresso civile
dell'uomo; e i campi su cui si è sparso più sangue si chiamano Mauthausen, Maidanek,
Buchenwald, Dakau.
Di chi è la sconfitta più grave in tutto questo che è accaduto? Vi era bene qualcosa che, attraverso i
secoli, ci aveva insegnato a considerare sacra l'esistenza dei bambini. Anche di ogni conquista civile
dell'uomo ci aveva insegnato ch'era sacra; lo stesso del pane; lo stesso del lavoro. E se ora milioni di
bambini sono stati uccisi, se tanto che era sacro è stato lo stesso colpito e distrutto, la sconfitta è
anzitutto di questa «cosa» che c'insegnava la inviolabilità loro. Non è anzitutto di questa «cosa» che
c'insegnava l'inviolabilità loro?
Questa «cosa», voglio subito dirlo, non è altro che la cultura: lei che è stata pensiero greco,
ellenismo, romanesimo, cristianesimo latino, cristianesimo medioevale,. umanesimo, riforma,
illuminismo, liberalismo, ecc., e che oggi fa massa intorno ai nomi di Thomas Mann e Benedetto
Croce, Benda, Huitzinga, Dewey, Maritain, Bernanos e Unamuno, Lin Yutang e Santayana, Valéry,
Gide e Berdiaev.
Non vi è delitto commesso dal fascismo che questa cultura non avesse insegnato ad esecrare già da
tempo. E se il fascismo ha avuto modo di commettere tutti i delitti che questa cultura aveva
insegnato ad esecrare già da tempo, non dobbiamo chiedere proprio a questa cultura come e perché
il fascismo ha potuto commetterli?
Dubito che un paladino di questa cultura, alla quale anche noi apparteniamo, possa darci una
risposta diversa da quella che possiamo darci noi stessi: e non riconoscere con noi che
l'insegnamento di questa cultura non ha avuto che scarsa, forse nessuna, influenza civile sugli
uomini.
Pure, ripetiamo, c’è Platone in questa cultura. E c’è Cristo. Dico: c’è Cristo. Non ha avuto che
scarsa influenza Gesù Cristo? Tutt’altro. Egli molta ne ha avuta. Ma è stata influenza, la sua, e di
tutta la cultura fino ad oggi, che ha generato mutamenti quasi solo nell'intelletto degli uomini, che
ha generato e rigenerato dunque se stessa, e mai, o quasi mai, rigenerato, dentro alle possibilità di
fare anche l'uomo. Pensiero greco, pensiero latino, pensiero cristiano di ogni tempo, sembra non
abbiano dato agli uomini che il modo di travestire e giustificare, o addirittura di render tecnica, la
barbarie dei fatti loro. È qualità naturale della cultura di non poter influire sui fatti degli uomini?
Io lo nego. Se quasi mai (salvo in periodi isolati e oggi nell'U.R.S.S. a cultura ha potuto influire sui
fatti degli uomini dipende solo dal modo in cui la cultura si è manifestata. Essa ha predicato, ha
insegnato, ha elaborato princìpi e valori, ha scoperto continenti e costruito macchine, ma non si è
identificata con la società, non ha governato con la società, non ha condotto eserciti per la società.
Da che cosa la cultura trae motivo per elaborare i suoi principi e i suoi valori? Dallo spettacolo di
ciò che l'uomo soffre nella società. L'uomo ha sofferto nella società, l'uomo soffre. E che cosa fa la
cultura per l'uomo che soffre? Cerca di consolarlo.
Per questo suo modo di consolatrice in cui si è manifestata fino ad oggi, la cultura non ha potuto
impedire gli orrori del fascismo. Nessuna forza sociale era «sua» in Italia o in Germania per
impedire l'avvento al potere del fascismo, né erano «suoi» i cannoni, gli aeroplani, i carri armati che
avrebbero potuto impedire l'avventura d'Etiopia, l'intervento fascista in Spagna, 1'«Anschluss» o il
patto di Monaco. Ma di chi se non di lei stessa è la colpa che le forze sociali non siano forze della
cultura, e i cannoni, gli aeroplani, i carri armati non siano «suoi» ?
La società non è cultura perché la cultura non è società. E la cultura non è società perché ha
in sé l'eterna rinuncia del «dare a Cesare» e perché i suoi princìpi sono soltanto consolatori,
perché non sono tempestivamente rinnovatori ed efficacemente attuali, viventi con la società
stessa come la società stessa vive. Potremo mai avere una cultura che sappia proteggere
l'uomo dalle sofferenze invece di limitarsi a consolarlo? Una cultura che le impedisca, che le
scongiuri, che aiuti a eliminare lo sfruttamento e la schiavitù, e a vincere il bisogno, questa è la
cultura in cui occorre che si trasformi tutta la vecchia cultura.
La cultura italiana è stata particolarmente provata nelle sue illusioni. Non vi è forse nessuno in Italia
che ignori che cosa significhi la mortificazione dell'impotenza o un astratto furore. Continueremo,
ciò malgrado, a seguire la strada che ancora oggi ci indicano i Thomas Mann e i Benedetto Croce?
Io mi rivolgo a tutti gli intellettuali italiani che hanno conosciuto il fascismo. Non ai marxisti
soltanto, ma anche agli idealisti anche ai cattolici, anche ai mistici. Vi sono ragioni dell'idealismo o
del cattolicesimo che si oppongono alla trasformazione della cultura in una cultura capace di lottare
contro la fame e le sofferenze?
Occuparsi del pane e del lavoro è ancora occuparsi dell’«anima». Mentre non volere occuparsi che
dell’«anima» lasciando a «Cesare» di occuparsi come gli fa comodo del pane e del lavoro, è
limitarsi ad avere una funzione intellettuale e dar modo a «Cesare» (o a Donegani, a Pirelli, a
Valletta di avere una funzione di dominio «sull'anima» dell'uomo. Può il tentativo di far sorgere una
nuova cultura che sia di difesa e non più di consolazione dell'uomo, interessare gli idealisti e i
cattolici, meno di quanto interessi noi?
ESTRATTI UOMINI E NO.
«Non possiamo desiderare che un uomo sia felice? Noi lavoriamo perché gli uomini siano felici.
Non è per questo che lavoriamo?»
«È per questo,» disse Enne 2.
«Non è per questo?» Selva disse.
E sempre guardava uomo e donna.
«Perdio!» disse. «Bisogna che gli uomini siano felici. Che senso avrebbe il nostro lavoro se gli
uomini non potessero essere felici? Parla tu,ragazza. Avrebbe un senso il nostro lavoro?»
«Non so,» rispose Berta. [...]
«No.No. Bisogna che gli uomini possano esser felici. Ogni cosa ha un senso solo perché gli uomini
siano felici. Non è solo per questo che le cose hanno un senso?»
«È per questo.»
«Dillo anche tu, ragazza. Non è per questo?»[...]
«Presuntuosi siete voi. Volete lavorare per la felicità della gente, e non sapete che cosa occorre alla
gente per essere felici. Potete lavorare per essere felici?»
Enne 2 si alzò dal divano dov'era seduto con Berta, e si avvicinò alla bella vecchia.
«Selva,» le disse, «io oggi sono felice.»
(Pagine 16-18)
Perché, ora, lottavano? Perché vivevano come animali inseguiti e ogni giorno esponevano la loro
vita? Perché dormivano con una pistola sotto il cuscino? Perché lanciavano bombe? Perché
uccidevano?
Gracco era curioso degli uomini: voleva conoscere il perché delle loro cose. [...]
Questi uomini non avevano dietro niente che li costringesse, niente che prendese su di sé quello che
loro facevano.
Come accadeva che fossero semplici e pacifici anche loro?
Che non fossero terribili?
Il Gracco era curioso, e se lo domandava.
Perché, se non erano terribili, uccidevano? Perché, se erano semplici, se erano pacifici, lottavano?
Perché, senza aver niente che li costringesse, erano entrati in quel duello a morte e lo sostenevano?
«è anche perché vorrei sposarmi presto» disse Orazio[...]
«vorrei che finisse presto, e sposarla.»
(Pagine 50-55)
(Il vecchio riferendosi ai morti) «Non bisogna,» il vecchio disse, «piangere per loro»
«No?» disse Berta.
«Non bisogna piangere per nessuna delle cose che oggi accadono.»
«Non bisogna piangere?»
«Se piangiamo accettiamo. Non bisogna accettare.»
«Gli uomini sono uccisi e non bisogna piangere?»
«Se li piangiamo li perdiamo. Non bisogna perderli.»[...]
«Dobbiamo imparare»
«Imparare che cosa?» disse Berta. «Cos'è che insegnano?»
«Quello per cui,» il vecchio disse, «sono morti.»[...]
«La liberazione?» disse Berta.
Il vecchio sembrava cercasse la risposta migliore davanti a sé con occhi lieti. «Di ognuno di noi,»
rispose. [...]
(Pagine 100-101)
Questo è il punto in cui sbagliamo.
Noi presumiamo che sia nell'uomo soltanto quello che è sofferto, e che in noi è scontato. Aver fame.
Questo diciamo che è nell'uomo. Aver freddo. E uscire dalla fame, lasciare indietro il freddo,
resoirere l'aria della terra, e averla, avere la terra, gli alberi, i fiumi, il grano, le città, vincere il lupo
e guardare in faccia il mondo. Questo diciamo che p nell'uomo.
Avere Iddio disperato dentro, in noi uno spettro, e un vestito appeso dietro la porta. Anche avere
Iddio felice. Essere uomo e donna. Essere madre e figli. Tutto questo lo sappiamo, e possiamo dire
che è in noi. Ogni cosa che è piangere la sappiamo: diciamo che è in noi. Lo stesso ogni cosa che è
ridere: diciamo che è in noi. E ogni cosa che è il furore, dopo il capo chino e il piangere. Diciamo
che è il gigante che è in noi.
Ma l'uomo può anche fare senza che vi sia nulla in lui, né patito, né scontato, né fame, né freddo, e
noi diciamo che è non è l'uomo.
Noi lo vediamo. È lo stesso del lupo. Egli attacca e offende. E noi diciamo: questo non è l'uomo.
Egli fa con freddezza come fa il lupo. Ma toglie questo che sia uomo?
Noi non pensiamo che agli offessi. O uomini! O uomo!
Appena vi sia l'offesa, subito noi siamo con chi è offesso, e diciamo che è l'uomo. Sangue? Ecco
l'uomo. Lagrime? Ecco l'uomo.
E chi ha offeso che cos'è?
Mai pensiamo che anche lui sia l'uomo. Che cosa può essere d'altro? Davvero il lupo?
Diciamo oggi: è il fascismo. Anzi: il nazifascismo. Ma che cosa significa che sia il fascismo? Vorrei
vederlo fuori dell'uomo, il fascismo. Che cosa sarebbe? Che cosa farebbe? Potrebbe fare quello che
fa se non fosse nell'uomo di poterlo fare? Vorrei vedere Hitler e i tedeschi suoi se quello che fanno
non fosse nell'uomo di poterlo fare. Vorrei vederli a cercare di farlo. Togliere loro l'umana
possibilità di farlo e poi dire loro: Avanti, fate. Che cosa farebbero?
Un corno, dice mia nonna.
Può darsi che Hitler scriverebbe lo stesso quello che ha scritto, e Rosenberg lui pure; o che
scriverebbero cretinerie dieci volte peggio. Ma io vorrei vedere, se gli uomini non avessero la
possibilità di fare quello che fa Clemm, prendere e spogliare un uomo, darlo in pasto ai cani, io
vorrei vedere che cosa accadrebbe nel mondo con le cretinerie di loro.
(Pagine 167-168)
E perché lottare? Per resistere. Come se mai la perdizione ch'era sugli uomini potesse finire, e mai
potesse venire una liberazione. Allora resistere poteva essere semplice. Resistere? Era per resistere.
Era molto semplice.
(Pagina 175)
Non c'era che resistere per resistere, o non c'era che perdersi. Non c'era sempre stata sugli uomini la
perdizione? I nostri padri erano perduti. Sempre il capo chino, le scarpe rotte. O erano perduti dal
principio; o resistevano per resistere, e poi lo stesso si perdevano. Perché ora sarebbe finita? Perché
vi sarebbe stata una liberazione? Ora molti resistevano per una liberazione, che doveva esserci.
Anche lui aveva resistito per questo, ancora questo resisteva, era sicuro che vi sarebbe stata, ma
ecco, proprio per questo, che resistere non era semplice.
(Pagina 177)
Sedeva, le gambe larghe, la schiena appoggiata alla spalliera della sedia, la testa un po' indietro, e la
faccia triste, persa, una stanca faccia da operaio.
Dio di Dio! O non aveva conquistato? Non era in terra conquistata? Che cosa aveva da essere così
triste, un tedesco che aveva conquistato?
Tornò a guardarlo, e vide che quello non lo guardava. Aveva gli occhi più in basso, come umiliato.
Un momento si osservò le mani; da una parte, dall'altra, entrambe insieme, e fu un gesto lungo
come ne fanno solo gli operai.
Dio di Dio! Egli pensò di nuovo.
Lo vide non nell'uniforme, ma come poteva essere stato: indosso panni di lavoro umano, sul capo
un berretto da miniera.
(Pagina 201)
Non perché sono, come tutti sanno, un militante comunista si deve credere che questo sia un libro
comunista... Cercare in arte il progresso dell'umanità è tutt'altro che lottare per tale progresso sul
terreno politico sociale... la mia appartenenza al Partito Comunista indica quello che io voglio
essere, mentre il mio libro può indicare soltanto quello che in effetti sono io. C'è nel mio libro un
personaggio che mette al servizio la forza della propria disperazione d'uomo. Si può considerarlo un
comunista? Lo stesso interrogativo è sospeso sul mio risultato di scrittore. E il lettore giudichi
tenendo conto che solo ogni merito, per questo libro, è di me come comunista. Il resto viene dalle
mie debolezze d'uomo. Né in proposito posso promettere nulla, come scrittore. 'Impareò meglio' è
tutto quello che posso aggiungere, come il mio operaio dell'epilogo.
(Postfazione di Elio Vittorini).