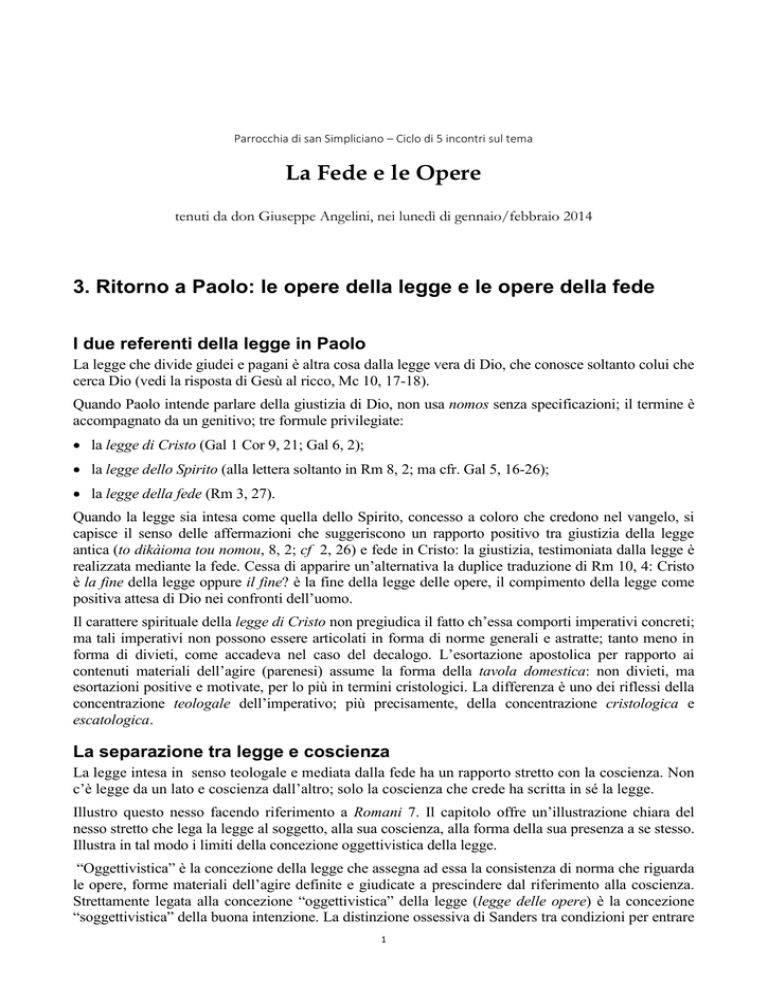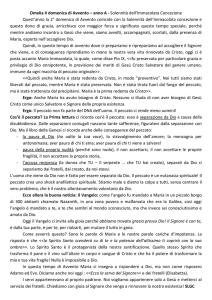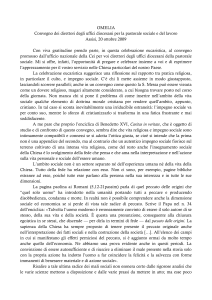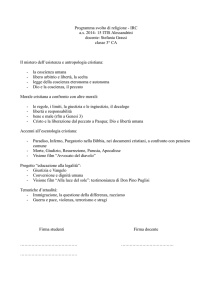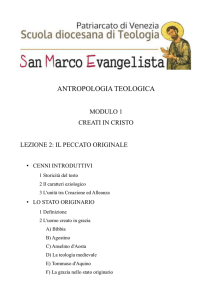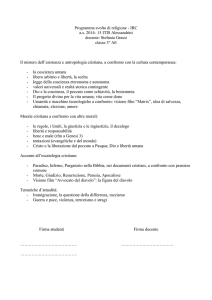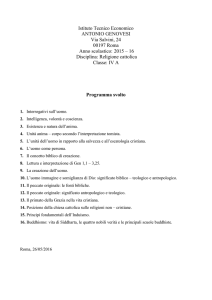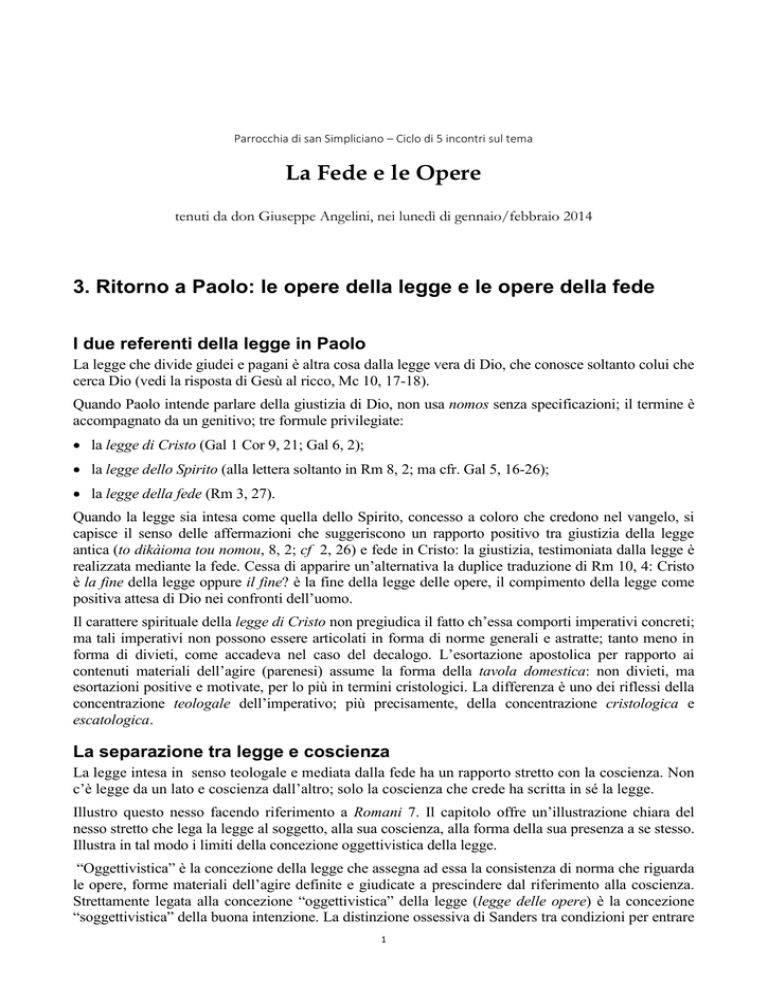
Parrocchia di san Simpliciano – Ciclo di 5 incontri sul tema
La Fede e le Opere
tenuti da don Giuseppe Angelini, nei lunedì di gennaio/febbraio 2014
3. Ritorno a Paolo: le opere della legge e le opere della fede
I due referenti della legge in Paolo
La legge che divide giudei e pagani è altra cosa dalla legge vera di Dio, che conosce soltanto colui che
cerca Dio (vedi la risposta di Gesù al ricco, Mc 10, 17-18).
Quando Paolo intende parlare della giustizia di Dio, non usa nomos senza specificazioni; il termine è
accompagnato da un genitivo; tre formule privilegiate:
la legge di Cristo (Gal 1 Cor 9, 21; Gal 6, 2);
la legge dello Spirito (alla lettera soltanto in Rm 8, 2; ma cfr. Gal 5, 16-26);
la legge della fede (Rm 3, 27).
Quando la legge sia intesa come quella dello Spirito, concesso a coloro che credono nel vangelo, si
capisce il senso delle affermazioni che suggeriscono un rapporto positivo tra giustizia della legge
antica (to dikàioma tou nomou, 8, 2; cf 2, 26) e fede in Cristo: la giustizia, testimoniata dalla legge è
realizzata mediante la fede. Cessa di apparire un’alternativa la duplice traduzione di Rm 10, 4: Cristo
è la fine della legge oppure il fine? è la fine della legge delle opere, il compimento della legge come
positiva attesa di Dio nei confronti dell’uomo.
Il carattere spirituale della legge di Cristo non pregiudica il fatto ch’essa comporti imperativi concreti;
ma tali imperativi non possono essere articolati in forma di norme generali e astratte; tanto meno in
forma di divieti, come accadeva nel caso del decalogo. L’esortazione apostolica per rapporto ai
contenuti materiali dell’agire (parenesi) assume la forma della tavola domestica: non divieti, ma
esortazioni positive e motivate, per lo più in termini cristologici. La differenza è uno dei riflessi della
concentrazione teologale dell’imperativo; più precisamente, della concentrazione cristologica e
escatologica.
La separazione tra legge e coscienza
La legge intesa in senso teologale e mediata dalla fede ha un rapporto stretto con la coscienza. Non
c’è legge da un lato e coscienza dall’altro; solo la coscienza che crede ha scritta in sé la legge.
Illustro questo nesso facendo riferimento a Romani 7. Il capitolo offre un’illustrazione chiara del
nesso stretto che lega la legge al soggetto, alla sua coscienza, alla forma della sua presenza a se stesso.
Illustra in tal modo i limiti della concezione oggettivistica della legge.
“Oggettivistica” è la concezione della legge che assegna ad essa la consistenza di norma che riguarda
le opere, forme materiali dell’agire definite e giudicate a prescindere dal riferimento alla coscienza.
Strettamente legata alla concezione “oggettivistica” della legge (legge delle opere) è la concezione
“soggettivistica” della buona intenzione. La distinzione ossessiva di Sanders tra condizioni per entrare
1
nell’alleanza (l’elezione) e condizioni per rimanere in essa (la legge) sancisce lo scorporo tra fede e
agire; la legge può soltanto vietare, non può assumere la forma di norma che dia forma all’agire.
L’immagine della legge come serie di divieti trova riscontro nelle formulazioni più antiche: il decalogo e in genere i codici orali antichi. Ma la tôrāh della predicazione profetica non cita mai i codici;
ricorre invece alle risorse della descrizione valutante. È impossibile intendere il pensiero di Paolo, e il
vangelo di Gesù. a procedere dall’idea che vede nella legge una siepe di separazione tra giudei e
gentili.
Legge e coscienza in Romani 7, 7-13
Il nesso tra l’immagine della legge e la qualità morale dell’intenzione libera del soggetto è illustrato
con particolare evidenza da Rm 7, che interpreta la condizione umana universale a procedere dal
paradigma di Adamo.
Che diremo dunque? Che la legge è peccato? No certamente! Però io non ho conosciuto il peccato
se non per la legge, né avrei conosciuto la concupiscenza, se la legge non avesse detto: Non desiderare. Prendendo pertanto occasione da questo comandamento, il peccato scatenò in me ogni sorta
di desideri. Senza la legge infatti il peccato è morto e io un tempo vivevo senza la legge. Ma,
sopraggiunto quel comandamento, il peccato ha preso vita e io sono morto; la legge, che doveva
servire per la vita, è divenuta per me motivo di morte. Il peccato infatti, prendendo occasione dal
comandamento, mi ha sedotto e per mezzo di esso mi ha dato la morte. Così la legge è santa e
santo e giusto e buono è il comandamento. Ciò che è bene è allora diventato morte per me? No
davvero! E` invece il peccato: esso per rivelarsi peccato mi ha dato la morte servendosi di ciò che è
bene, perché il peccato apparisse oltre misura peccaminoso per mezzo del comandamento. (7, 713)
Che diremo dunque? la legge è peccato? No certamente! però io… L’io di cui si parla è l’uomo prima
di Cristo, in ogni caso al di fuori di Cristo; l’ottica nella quale si parla di quell’uomo è quella
dischiusa dalla fede nel vangelo, rispettivamente dalla tradizione biblica tutta letta nella luce del
compimento. Tale ottica riprende una tesi già proposta dalla predicazione profetica, il tratto incorreggibile del cuore di questo popolo; presume d’essere popolo di Dio; in realtà non si distingue dagli
altri popoli della terra. La legge soltanto condanna, non salva. L’affermazione si riferisce alla legge
mosaica. Non intende suggerire la tesi che Dio stesso avrebbe assegnato alla legge il compito di
rendere il popolo peccatore; per questo popolo, che onora Dio con le labbra soltanto, la legge di fatto
è però divenuta questo.
Lo schema storico-salvifico distingue tre epoche della storia umana: prima della legge, sotto la legge,
oltre la legge. La distinzione tra prima e seconda epoca non deve essere intesa per riferimento al Sinai,
ma al comandamento di non mangiare dell’albero. Non che esso sia dato soltanto in un secondo
tempo, ma diventa evidente soltanto dopo la suggestione del serpente. Gn 3 offre la trama segreta di
Rom 7, 7-13.
- l’unico uomo Adamo corrisponde a quell’unico di cui in Rm 7 si dice attraverso il pronome io;
- l’unico precetto, non mangiare dell’albero, corrisponde all’unico precetto (entolè) di cui si dice in
Rm 7, 8;
- il peccato personificato scatena ogni genere di desideri (cfr. Rm 7, 8), esattamente come la
suggestione del serpente scatena nella della il triplice desiderio, della bocca, degli occhi e della vita
(cfr. Gn 3, 6);
- il peccato mi sedusse, qui si dice (Rm 7, 11), mimando le parole di Eva: il serpente mi ha sedotto;
è impiegato il verbo exapapàn (decipiendo a recta via avertere, interpreta Zerwik); esso ricorre
anche negli altri due passi nei quali Paolo cita Genesi 3 (2 Cor 11,3; 1 Tm 2,14);
2
- il precetto di non mangiare è dato perché l’uomo eviti la morte (cfr. Gn 2, 17); tale
caratterizzazione corrisponde a che Paolo dà della legge, doveva servire alla vita (cfr, Rm 7, 10),
ma di fatto produce morte.
La consapevolezza del precetto interviene soltanto dopo l’iniziale consenso della donna alla
suggestione del serpente; esso rende evidente il limite che il precetto oppone al desiderio umano.
L’ascolto della suggestione del serpente muta gli occhi: il significato della legge, e la sua attitudine a
giustificare muta con il mutare della disposizione interiore del soggetto. La legge pensata come fonte
di vita diventa fonte di morte:
«Il Signore Dio prese l’uomo e lo fece abitare nel giardino dell’Eden per osservare la legge e
seguirne i comandamenti»; qui la legge non dà vita al peccato, ma all’uomo; espressamente infatti
è precisato che «la legge è l’albero della vita per chiunque la osserva e ne segue i precetti; egli
vivrà e resterà come l’albero della vita nel mondo futuro. La legge è buona da osservare in questa
vita come il frutto dell’albero della vita». (Targum a Gn 2, 15 del Codice dei neofiti)
Quando Paolo scrive che la legge è santa e santo e giusto e buono è il comandamento (Rm 7, 12), le
sue parole fanno eco a simili tradizioni del giudaismo.
Il contenuto essenziale della legge è Non desiderare (7, 7). Il decimo precetto del decalogo è una
sintesi della legge; equivale al divieto del giardino: dell’albero della conoscenza del bene e del male
non devi mangiare (Gn 2, 17). Non fare del tuo desiderio la misura del bene e del male, come fecero i
tuoi padri:
Ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete
fatti uscire dall’Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c’è né pane né acqua e
siamo nauseati di questo cibo così leggero». Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti
velenosi i quali mordevano la gente e un gran numero d’Israeliti morì. (Nm 21, 4b-6)
Appare qui esplicito il nesso tra progetto di misurare con la bocca il valore di tutte le cose e destino di
morire; per non morire l’uomo deve affidarsi ad altro che a ciò che riempie la bocca; ha bisogno di
una parola che esca dalla bocca di Dio e divenga oggetto di fede; se l’uomo, emancipato da ogni
obbedienza, cerca solo con la bocca quel che gli dà vita, di necessità muore.
In favore della lettura del peccato di Adamo quale peccato di desiderio depone la descrizione di quel
che la donna vide dopo l’insinuazione del serpente:
Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per
acquistare saggezza... (Gn 3, 6)
Nel Nuovo Testamento è dato di trovare un sorprendente parallelo di questo testo, in 1 Gv 2,16 (tutto
quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia
della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo).
La legge, in se stessa santa giusta e buona, non produce giustizia, ma soltanto conoscenza del peccato.
Ch’essa possa solo questo, non è da imputare alla legge o a Dio che l’ha data, ma al peccato. Di esso
Paolo parla come di realtà che sussiste a monte rispetto al momento in cui io sono confrontato con la
legge.
Il peccato ipostatizzato
Il massimo interrogativo suscitato dalla tesi proposta da Paolo è la figura del peccato ipostatizzato: a
quale tratto dell’esperienza umana corrisponde tale figura? La rappresentazione non è del tutto nuova;
l’idea di un peccato ineluttabile è proposta già dai profeti: il cuore di pietra di Ezechiele (cfr. Ez 11,
19; 26, 36); oppure le molte metafore di Geremia (la pelle dell’etiope; il piombo la cui impurità è
senza rimedio). Paolo stesso offre spunti utili per pensare la figura del peccato che pesa sull’uomo
come un destino inevitabile. Pensiamo alla rappresentazione dei pagani come abbandonati
all’impurità secondo i desideri del loro cuore, sì da disonorare fra di loro i propri corpi. Il loro
3
peccato è letto per altro come esito di scelta: essi hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna e
hanno venerato e adorato la creatura al posto del creatore (Rm 1, 24s).
Il pensiero di Paolo sulla giustificazione non può essere compreso al di fuori del riferimento al
sistema del male. Appunto per rapporto al tratto nascosto del peccato la legge adempie a una funzione
di giudizio, e non di edificazione: porta alla luce, e insieme realizza, il destino che il peccato comporta
per se stesso da sempre.
Legge e coscienza in Romani 7, 14-25
La successiva sezione riprende il tema del peccato ineluttabile e della sterilità della legge. La tesi è
però svolta in altro registro linguistico; rilievo determinante assumono categorie greche (bene e male,
quel che voglio o non voglio, uomo interiore/esteriore, legge della mente e legge delle membra), di
valore umano universale e senza riferimenti alla storia della salvezza.
4