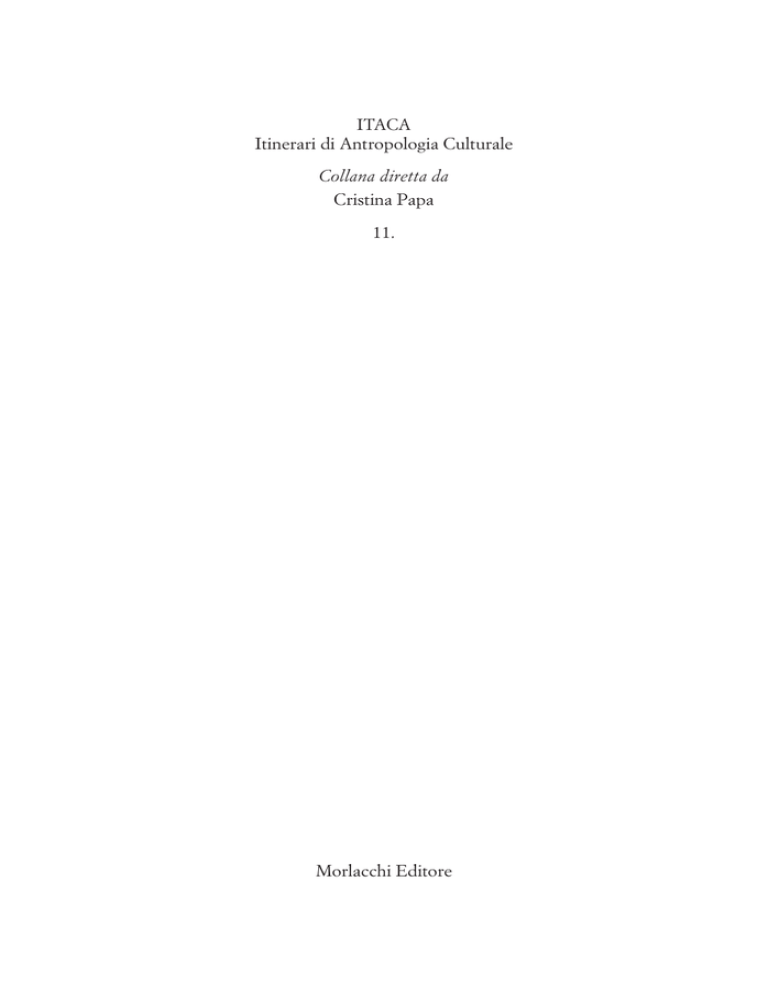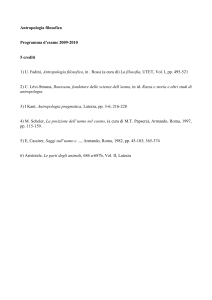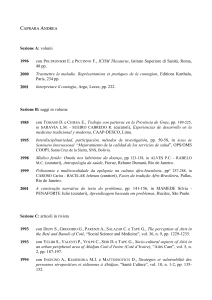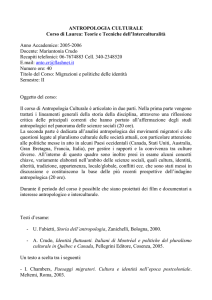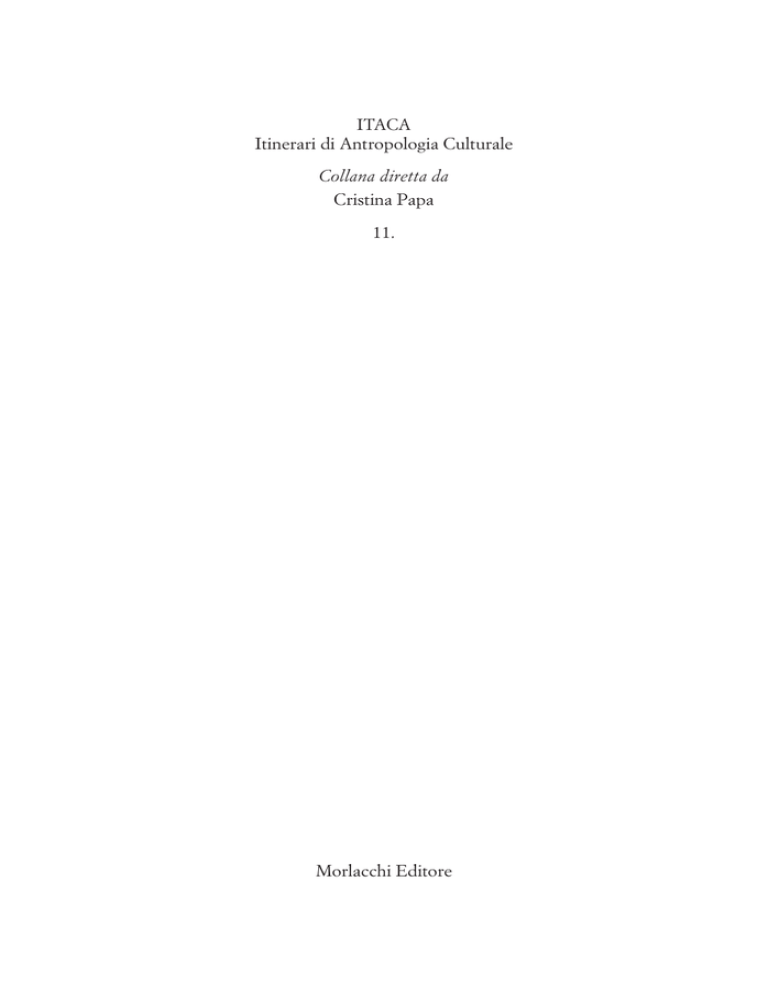
itaca
Itinerari di Antropologia Culturale
Collana diretta da
Cristina Papa
11.
Morlacchi Editore
ITACA
Itinerari di Antropologia Culturale
La collana ITACA accoglie studi e ricerche di antropologia
culturale intesa in una accezione larga, che oltrepassa le
tradizionali partizioni areali, tematiche e temporali. Si rivolge ad
un pubblico universitario e specialistico.
Comitato scientifico
Fabio Dei (Università di Pisa) - Alessandro Lupo (Università di Roma
La Sapienza) - Roberto Malighetti (Università Milano Bicocca) - Chris
Shore (Università di Auckland) - Valeria Siniscalchi (EHSS Marsiglia Centre Norbert Eliàs) - Filippo Zerilli (Università di Cagliari)
Direzione
Cristina Papa (Università di Perugia)
Comitato di Redazione
Giancarlo Baronti - Giancarlo Palombini
Daniele Parbuono - Sandro Piermattei - Georgeta Stoica
Tutti i volumi sono sottoposti a duplice referaggio anonimo.
a cura di Donatella Cozzi
Le parole dell’antropologia medica
Piccolo dizionario
Morlacchi Editore
in omaggio a Tullio Seppilli
Prima edizione: isbn/ean:
2012
978-88-6074-526-2
copyright © 2012 by Morlacchi Editore, Perugia.
Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi
mezzo effettuata, compresa la copia fotostatica, non autorizzata.
[email protected] – www.morlacchilibri.com
Finito di stampare nel mese di novembre da Digital print-Service, Segrate.
Indice
Donatella Cozzi
Introduzione9
Massimiliano Minelli
1. Capitale sociale e salute
13
Andrea Caprara
2. Contagio
53
Gianfranca Ranisio
3. Corpo femminile e medicalizzazione 67
Donatella Cozzi
4. Dolore
85
Giovanni Pizza e Helle Johannessen
5. Incorporazione e Stato
113
Alessandro Lupo
6. Malattia ed efficacia terapeutica
127
Fabio Dei 7. Medicine non convenzionali: una prospettiva
antropologica 157
Giovanni Pizza
8. Medicina popolare: una riflessione
181
Donatella Cozzi
9. Narrazione della malattia
205
Sergio Zorzetto e Giuseppe Cardamone
10. Salute mentale di comunità.
Osservazioni etnopsichiatriche
225
Giuseppe Cardamone e Michela Da Prato
11. Salute mentale e migrazioni.
Ipotesi esplicative per il binomio
239
Salvatore Inglese
12. Sindromi culturalmente caratterizzate (Culture-Bound Sindromes)
253
Pino Schirripa
13. Sistema Medico. Campo politico, istituzioni
sanitarie e processi di medicalizzazione
tra egemonia e resistenza
269
Ivo Quaranta
14. Sofferenza sociale e violenza strutturale
285
Bibliografia301
Indice degli autori
343
Indice analitico
349
Gli autori
353
Donatella Cozzi
Introduzione
Nel 1995 iniziavano le riunioni di redazione della rivista “AM.
Rivista della Società Italiana di antropologia medica”, il cui primo numero uscì nel 1996. Esse erano state precedute da un lungo lavoro di contatti e sensibilizzazione accademica condotto
da Tullio Seppilli, che aveva avuto molteplici tappe importanti,
prima tra tutte la costituzione, nel 1988, della Società italiana
di antropologia medica (SIAM). Tra le iniziative che seguirono, nel 1994 ebbero luogo le giornate di studio Per una attività
formativa della Società italiana di antropologia medica (Perugia,
24-25 novembre 1994)1, alla quale parteciparono molti degli
allora giovani antropologi, psichiatri ed etnopsichiatri che poi
furono chiamati a collaborare alla redazione di AM e che qui
compaiono con un loro testo. Tullio, conoscendo quello che già
avevamo iniziato a pubblicare, le nostre aree tematiche di ricerca, i nostri progetti e il nostro lavoro, ci aveva chiamato, attribuendo valore alle nostre potenzialità ed esordi lavorativi ed accademici, permettendoci di incontrare ricercatori più esperti ed
affermati, come Paola Falteri e Paolo Bartoli, tutti riuniti presso
l’Istituto di etnologia e antropologia culturale della Università
di Perugia. Soprattutto, ci ha fatto partecipi del grande progetto associativo della SIAM, strumento di confronto scientifico e
promozione organizzativa per quell’ampio campo di indagini,
riflessioni teoriche ed elaborazioni operative conosciuto con
il termine “antropologia medica”, che ha nella rivista AM la
principale iniziativa editoriale. Per chi partecipò a quelle riu1. Altre dense iniziative della SIAM riguardanti incontri scientifici per
la costituzionee il consolidamento della Società sono segnalati in Seppilli T.,
1996: 364-365.
10
Donatella Cozzi
nioni esse furono un momento impareggiabile di discussione
e confronto, punteggiato da incontri conviviali e lunghe serate passate a vagliare, spesso animatamente, gli articoli proposti
alla rivista per la pubblicazione, illuminate dalla guida esigente
di Tullio, dalla sua inesauribile precisione e curiosità e dal suo
amore per la sistematicità. Il vento della vita, non solo accademica, poi ci ha in parte disperso: alcuni hanno continuato con
maggiore assiduità e grande dedizione l’impegnativo lavoro di
redazione della rivista, che ha incorporato nuovi collaboratori,
con altri i rapporti si sono più rarefatti, seguendo il solco della loro vita professionale, ma non è meno vivo il ricordo della
stagione che ha visto avviarsi la pubblicazione dei primi numeri
di AM.
Oggi, una parte di coloro che parteciparono a quelle riunioni di redazione e al Consiglio direttivo della rivista, desiderano rendere omaggio a Tullio Seppilli con questa raccolta di
testi, che ha preso la forma di un catalogo di voci, ciascuna delle quali recupera gli approfondimenti disciplinari nell’ambito
dell’antropologia medica maturati dai singoli autori nel corso
degli anni. Senza l’esaustività di vere e proprie ‘voci’ enciclopediche, quali quelle che hanno iniziato a comparire sulla rivista a
partire dal 20002, i contributi qui raccolti desiderano offrire una
panoramica ragionata per quanto concisa dello stato dell’arte,
dei punti che animano la discussione entro questo ambito disciplinare e che ne manifestano la vitalità critica e la fervida attenzione alla ricerca empirica, mantenendo la libertà di ciascun
autore di dare angolature parziali e selettive, di costruire la forma dell’argomentazione più congeniale. Compaiono quindi in
questo lavoro14 argomenti disposti alfabeticamente: “Capitale
sociale e salute” (Massimiliano Minelli), “Contagio” (Andrea
Caprara), “Corpo femminile e medicalizzazione” (Gianfranca
Ranisio), “Dolore” (Donatella Cozzi), “Incorporazione e Stato”
(Giovanni Pizza e Helle Johannessen), “Malattia ed efficacia
ripa
2. Al momento sono state pubblicate le voci: “Sistema medico” di SchirP., 2000 e “Dolore” di Cozzi D., 2002.
Introduzione
11
terapeutica” (Alessandro Lupo), “Medicine non convenzionali” (Fabio Dei), “Medicina popolare” (Giovanni Pizza),
“Narrazione della malattia” (Donatella Cozzi), “Salute mentale
di comunità” (Giuseppe Cardamone e Sergio Zorzetto), “Salute
mentale e migrazioni” (Giuseppe Cardamone e Michela Da
Prato), “Sindromi culturalmente ordinate” (Salvatore Inglese),
“Sistema medico” (Pino Schirripa), “Sofferenza sociale e violenza strutturale” (Ivo Quaranta). Insieme racchiudono il ventaglio degli approfondimenti personali degli autori e richiamano la vasta area di interessi attraversata da Tullio Seppilli nella
sua vita di ricerca3.
L’occasione iniziale di questo volume è stata l’omaggio
deferente e affettuoso in occasione del suo ottantesimo compleanno. Ma la gestazione di queste pagine è stata più lunga
e ha oltrepassato quella ricorrenza: ce ne scusiamo con lui.
L’omaggio che abbiamo voluto consegnargli con questo volume
è al Maestro che ci ha stimolato e guidato in questi anni con
passione e rigore scientifico.
Ringrazio tutti coloro che per vari motivi non hanno potuto essere presenti in queste pagine, pur manifestando solidale
volontà a festeggiare l’occasione che ci vede riuniti. Un ringraziamento vivissimo a Cristina Papa, che ospita nella collana di
studi antropologici Itaca da lei diretta questo volume e a Paola
Falteri, che ha concesso la riproduzione della litografia che
compare in copertina.
3. Cfr. i due volumi che raccolgono gli scritti di T. Seppilli, curati da Papa
C. e Minelli M., 2008.
Massimiliano Minelli
1. Capitale sociale e salute1
L’espressione “capitale sociale” è oggi adoperata diffusamente
soprattutto per indicare le risorse che provengono da partecipazione civica, relazioni di fiducia e norme di reciprocità caratterizzanti le reti sociali. Risorse che potrebbero favorire anche
l’accesso ai servizi sociosanitari e migliorare i livelli di salute
delle popolazioni.
Con riferimento alle iniziative politiche riguardanti la salute,
vorrei qui esaminare alcuni problemi che fanno la loro comparsa proprio quando si usano i termini ‘capitale’ e ‘sociale’ in
rapporto alle interpretazioni e alle risposte collettive a sofferenza e malattia. Il mio obiettivo è mostrare come l’ampio successo avuto dalla nozione di capitale sociale sia ascrivibile ai suoi
flessibili usi in campi politico-amministrativi distinti e pur in
costante rapporto di reciprocità. Il percorso analitico che suggerirò attraversa rispettivamente il linguaggio burocratico dei
soggetti pubblici responsabili della salute collettiva (in senso
stretto le amministrazioni regionali in Italia), il cosiddetto terzo
settore, in una fase di profonda trasformazione del welfare verso un modello misto di gestione, con un considerevole impegno
di privato sociale (organizzazioni non governative, cooperative
sociali, volontariato), la medicina territoriale e la salute mentale
1. Questo testo è stato scritto nell’ambito del programma di ricerca che la
Sezione antropologica del Dipartimento Uomo e Territorio della Università
degli studi di Perugia conduce da alcuni anni su “Capitale sociale, salute e
diritti in Umbria”. Si tratta di un lavoro che è parte della convenzione tra il
Dipartimento e la Direzione salute, coesione sociale e società della conoscenza della Regione Umbria. Le considerazioni qui contenute sono state discusse
più volte con Paolo Bartoli che vorrei ringraziare per il costante scambio di
idee e di riflessioni nel corso della nostra attività di ricerca.
14
Massimiliano Minelli
di comunità, le scienze sociali applicate alla salute pubblica. In
tutti i casi ci si trova di fronte a soggetti con peculiari caratteristiche organizzative e istituzionali, i quali nelle loro interazioni
tendono a utilizzare oggi termini preformati da strutture sovranazionali impegnate in ricerca, indirizzo politico, finanziamento a iniziative riguardanti i bisogni socio-assistenziali dei gruppi
umani.
Viene qui prospettato anche un itinerario attraverso le differenti forme di capitale e le sue possibili trasformazioni. Ritengo
infatti che la maniera più proficua di riflettere sulla dimensione
sociale delle risorse umane sia di considerare i modi in cui, in
vari contesti e con varie strategie, sono considerate le possibilità
di accumulare risorse economiche, culturali, biologiche connesse alle vita umana e come queste vengono ricombinate all’interno di una particolare nozione di ‘capitale umano’. Questa
necessità di comprensione porta alla fine a esaminare le attuali
politiche di accumulazione e scambio che investono i bio-capitali e in senso ampio la bio-economia.
Come si vedrà, in questo modo, si può meglio comprendere
come il capitale sociale venga efficacemente usato per inscrivere il sociale in particolari panorami istituzionali e amministrativi. Sono gli impieghi di questa espressione in scene concrete,
dove si produce conoscenza sulla società e dove si sviluppano
interventi in campo bio-medico, a mostrare come la metafora
del capitale non sia solo strumento di conoscenza, ma anche
atto performativo che costituisce soggettività politiche e aree
d’intervento. In definitiva, chi impiega l’espressione capitale sociale mette in atto poetiche e narrative che letteralmente danno
forma alla “questione sociale”. Seguire le tracce di tali strategie
retoriche permette di ricostruire alcuni aspetti della governance
neoliberale e i suoi rapporti con l’economia sanitaria e i mercati
di servizi alla persona.
1. Capitale sociale e salute
15
1. Battezzare il denaro
«Guillermo! Te vas o te quedas? Te vas o te quedas? Te vas o
te quedas?» A causa di questa formula, bisbigliata vicino a un
registratore di cassa di un affollato supermarket di una città della Colombia, una cliente venne accusata di tentato furto da un
addetto alla sicurezza. L’episodio, risalente agli anni Settanta, è
riportato da Michael Taussig, nel suo saggio The devil and commodity fetishism in South America, come un folgorante esempio
di cosa può accadere nel punto di congiunzione fra arti magiche
e feticismo delle merci (Taussig M., 2010 [1980]). In quel testo,
dedicato all’impatto socio-economico del mercato capitalista
sulle vite e le relazioni quotidiane di agricoltori colombiani e
minatori boliviani, nella sua analisi della circolazione della moneta e del nuovo assetto economico fondato sul lavoro salariato, Taussig ha attribuito particolare importanza al modo in cui
una banconota può catturare ricchezza attraverso il cosiddetto
“bautizo del billete”.
Nel bautizo del billete, se durante il “battesimo cattolico” il
padrino tiene nascosta nel palmo della mano una banconota da
un peso e recita sottovoce una formula magica associando il nome
del bambino alla moneta, la benedizione divina può essere deviata verso il denaro. La banconota verrebbe così sottomessa al
sacramento del battesimo al posto del bambino, il proprietario
della banconota diverrebbe il padrino del denaro, il bambino rimarrebbe non battezzato. Nella costituzione di questo peculiare
legame di parentela spirituale il denaro, una volta battezzato col
nome del neonato, è destinato a tornare nelle mani del padrino,
portando con sé i soldi con cui è entrato in contatto, semplicemente recitando la formula magica «Te vas o te quedas? Te vas o
te quedas? Te vas o te quedas?» Nel racconto di Taussig, la donna
alla cassa del supermercato sorpresa a evocare Guillermo venne
accusata di furto probabilmente perché sospettata di stregoneria:
dopo aver pagato la merce acquistata con una banconota battezzata, tornandone in possesso, avrebbe potuto magicamente
appropriarsi dell’intero incasso della giornata.
16
Massimiliano Minelli
Con il rito illegale del battesimo del billete i contadini della
Valle Cauca, in Colombia, s’impegnano in una raffinata operazione analogica che permette di entrare nell’arcano della nascita del “capitale” e delle metamorfosi del valore in denaro.
È la capacità di riprodursi, in precedenza esclusiva solo degli
animali allevati, a essere ora riconosciuta al denaro, la cui specifica caratteristica di essere sterile è invece così sovvertita. Nella
commistione di fertilità e denaro, a essere investiti alla radice
sono il principio stesso della riproduzione della vita e la logica intrinseca dei legami sociali. Il segreto della nascita, della
crescita e dell’abbondanza entra nella sfera di pertinenza del
denaro e «un mezzo di scambio inerte diventa una quantità che
si auto-alimenta e si trasforma così in feticcio – una cosa con
poteri quasi vitali – » (Taussig M., 2010 [1980]: 128). Questa
metamorfosi, per così dire, retroagisce sul complesso delle relazioni pensabili e attivabili fra esseri viventi, umani e animali,
e beni da vendere e comprare.2 Il feticismo assume perciò una
peculiare configurazione, combinando la magia dello scambio
reciproco e quella dello scambio delle merci.
Sebbene non ci si trovi qui propriamente di fronte al feticismo della merce in forma compiuta, ovvero alla proprietà
intrinseca nel denaro di riprodursi come capitale, el bautizo
del billete rappresenta una efficace “descrizione esotica” della formula marxiana della valorizzazione nella circolazione del
capitale. La formula Denaro-Merce-Più Denaro (D-M-D’ comprare per vendere) che si sviluppa in opposizione alla formula
Merce-Denaro-Merce (M-D-M vendere per comprare) esprime
la qualità più feticizzata del capitale: il lavoro morto oggettivato
sorge davanti al lavoro vivo e lo domina come una presenza
esterna autonoma e potente (Marx K., 1994 [1867]).
Il destino del concetto di capitale sociale ha evidenti analogie
2. Quella di Taussig è una esplorazione dei congegni di cattura della forza, scatenata nelle relazioni di violenza e dominio coloniale, che gli consente
di ricostruire all’interno dei rituali sciamanici le trasformazioni e le pratiche
terapeutiche efficaci (Taussig M. 1987).
1. Capitale sociale e salute
17
con le dinamiche di sfruttamento e valorizzazione della vita
umana cui si riferisce lo sketch etnografico ripreso da Taussig.
L’uso del termine “capitale” sembra promettere di rigenerare
quanto è contemporaneamente sterilizzato per altre vie: la produzione del legame sociale e la costituzione della solidarietà che
dovrebbero provenire da “atti disinteressati”. Nonostante gli
inviti provenienti da più parti a considerare la natura evocativa
e metaforica dell’espressione capitale sociale, è utile ricordare
come il sostantivo al centro di molte iniziative politiche ed economiche sia un “capitale” – “sociale” è l’attributo apposto per
qualificare il suo ambito di applicazione – che promette risparmio d’investimenti in una fase storica in cui lo stato diminuisce
la sua presenza come erogatore di servizi alla persona e come
garante dei diritti fondamentali di cittadinanza. Una premessa
comune, nella nutrita congerie di ricerche prodotte negli anni
recenti, è che il capitale sociale rappresenti un’alternativa locale
alla drastica crisi delle politiche redistributive di scala nazionale. Va peraltro ricordato come, nel caso della salute, la definizione sia il risultato di una preliminare lunga manovra di reificazione e alienazione della produzione sociale della realtà medica. È
dunque necessario seguire da vicino la “produzione del sociale”
e le contraddizioni emergenti negli scambi materiali e simbolici
attorno alla vita umana, per analizzare «una cosa imbrogliatissima e piena di sottigliezza metafisica» e possibilmente svelare
l’arcano di quanto appare ovvio e naturale, ma nasconde i più
complicati atti di magia (Marx K., 1994 [1867]: 103).
2. Tradizioni civiche
Impianto teorico e strumenti analitici attraverso i quali inquadrare il capitale sociale sono stati proposti da Robert Putnam
(docente di scienze della politica a Harvard) in una ricerca sulle cosiddette tradizioni civiche delle regioni italiane (Putnam
R.D., 1993). Il testo, pubblicato nel 1993, intendeva studiare
le cause del diverso rendimento delle istituzioni regionali, in
18
Massimiliano Minelli
rapporto alla formazione e allo sviluppo di un’attiva società civile. Secondo l’ipotesi interpretativa di Putnam, esisterebbe un
rapporto circolare fra i modi in cui le istituzioni danno forma
alla politica e i meccanismi attraverso i quali la storia influisce
sull’architettura istituzionale di un paese. In questa circolarità, i
contesti sociali avrebbero la capacità di modellare il rendimento delle istituzioni: un contesto sociale favorevole, rappresentato in primo luogo da una comunità (termine ricorrente nella
sua connotazione genericamente positiva) fornita di un bagaglio adeguato di norme e impegno civico, rappresenterebbe la
principale fonte di sviluppo locale.
Già in questa prima formulazione, il sociale è avvicinato al
termine capitale declinando in toni morali le attese derivanti da
un investimento economico, in previsione di profitti da ottenere
con un’oculata allocazione di risorse. In effetti, Putnam riprende il concetto dai Fondamenti della teoria sociale del sociologo
Coleman (Coleman J.S., 2005 [1990]), quadro di riferimento
teorico-metodologico pubblicato nel 1990 in cui il capitale sociale compariva come una funzione della struttura sociale ed
era costituito da dimensioni organizzative che possono facilitare l’azione degli individui. L’affermazione di questa proposta è perlopiù dovuta all’aspettativa di circoscrivere il capitale
sociale come una risorsa-macro, statisticamente rilevabile con
adeguati indicatori e misurabile su scala regionale e nazionale.
Come tutte le forme di capitale, anche il capitale sociale indicherebbe un valore produttivo misurabile, finalizzato a ottenere
risultati altrimenti irraggiungibili. Le reti comunitarie proliferate ai margini dello stato, spesso in condizioni di povertà e di carenze infrastrutturali, potrebbero alla fine entrare ufficialmente
dentro la statistica, la “scienza dello stato”, portando in dote i
legami e le solidarietà.
Il libro di Putnam ha incontrato un certo successo: in primo
luogo per la visione ottimista e “volontarista” di cui si faceva
portavoce, in secondo luogo per l’efficace combinazione del
piano economico-imprenditoriale (il miracolo dei distretti in-
1. Capitale sociale e salute
19
dustriali nel centro-nord e nel nord-est), della performance delle
amministrazioni locali e della cosiddetta virtù civica3, infine per
la capacità di presentare come plausibili misurazioni quantitative di fenomeni talvolta identificabili con scambi e reciprocità
in sfere d’appartenenza investite di valore relazionale e affettivo. Una rilettura del testo del 1993 oggi mostra tuttavia che
a rivelarsi particolarmente debole è l’idea di contesto su cui
Putnam ha fatto affidamento, soprattutto perché ritagliata su
macro-parametri poco sensibili alla specifica storia delle regioni
italiane. Nel libro infatti è presentato un percorso tipologico ed
evolutivo delle regioni, secondo cui i differenti rendimenti delle
istituzioni sarebbero eredità di tradizioni civiche, retrodatabili
nel centro-nord a modalità associative e di divisione in ceti d’epoca comunale, al contrario, le connessioni fra i piani analitici
utili a delineare una realtà complessa appaiono sganciate dalle
pratiche sociali4.
La mancanza di descrizioni culturalmente sensibili delle differenziazioni sociali e politiche in Putnam è una grave lacuna,
soprattutto se si nota il numero elevato di riferimenti a opere di
antropologi (M. Douglas, M. Sahlins, C. Geertz, S. Silverman)
di cui egli si è servito per evocare principi di reciprocità generalizzata ed esperienze di mutuo aiuto. Tali riferimenti – in
cui le relazioni sociali si traducono in vantaggi collettivi che
supererebbero le eventuali perdite in cui possono incorrere
temporaneamente gli attori delle transazioni – introducono la
logica della reciprocità, ma proiettando per così dire una specie
di “esotismo” o di “orientalismo” su vari ambiti dell’agire economico. Vengono così caratterizzate in termini atemporali, non
considerandone le contraddizioni e i conflitti, rispettivamente
le economie del dono e dei mercati ristretti, le reti e gli obbli3. Si veda in proposito Bagnasco A.,1999.
4. Recentemente questa lacuna è stata evidenziata ad esempio da Michael Herzfeld in uno studio sui processi di gentrification nel centro storico di
Roma, nel punto in cui egli rilegge storicamente la combinazione fra qualità segmentaria e sussidiarietà in vari ambiti della vita urbana (Herzfeld M.,
2009: 77 e segg.).
20
Massimiliano Minelli
ghi di parentela, le organizzazioni del lavoro e dello scambio
nella società mezzadrile, e recuperato un concetto discutibile
come quello di familismo amorale, coniato da Banfield, per
spiegare l’arretratezza di alcune realtà del Mezzogiorno d’Italia
(Banfield E.C., 1961[1958]) 5.
3. Solidarietà mancanti
Una più ampia diffusione della nozione di capitale sociale si
è avuta in seguito, nei primi anni Duemila, con l’applicazione
del modello della virtù civica agli Stati Uniti dell’era Clinton.
Nel libro Bowling alone (Putnam R.D., 2004 [2000]), Putnam
è tornato sul concetto già impiegato nello studio delle tradizioni civiche italiane, proponendone l’adozione per contrastare la
minaccia della individualizzazione dei destini e la perdita dei
valori di riferimento nella società statunitense. Minaccia efficacemente rappresentata con l’immagine di un numero crescente
di americani che si recano al bowling per giocare da soli. Gli
illustri precursori richiamati da Putnam – oltre alle osservazioni di Toqueville sulla società americana, egli cita l’articolo del
1916 del riformatore Hanifan ove l’espressione capitale sociale
indica spirito di collaborazione fra le parti, aiuto e amicizia –
sono serviti a richiamare un’idea piuttosto nostalgica e di fatto
indefinita di legame comunitario (Putnam R.D., 2004 [2000]:
5. Le critiche qui richiamate fanno parte di un lungo e interessante dibattitto sullo sviluppo economico che sembra la naturale prosecuzione delle
obiezioni mosse da diversi intellettuali italiani agli studi di comunità e alla monografia di Banfield (Mutti A., 1994, 1998, cfr. Bagnasco A., 2006). Nel caso
specifico, Putnam sembrava soprattutto fornire strumenti amministrativi per
lo sviluppo programmato in aree caratterizzate da basso capitale economico
e da mancanze strutturali. Emblematica in proposito è la parabola dello sviluppo dei distretti industriali, che Putnam riconduceva alla presenza o meno
di scambi sociali virtuosi, per certi versi ribaltando precedenti letture economiche deterministe. Nella sua visione sarebbe «l’impegno civico contemporaneo, non lo sviluppo socio-economico a condizionare in modo diretto il
rendimento del governo regionale» (Putnam R., 1993: 183).
1. Capitale sociale e salute
21
15). In tale quadro, le cause dell’erosione del capitale sociale
sarebbero riconducibili a fattori concomitanti che impediscono
lo sviluppo di legami inclusivi (famiglie con doppia carriera,
cambiamento generazionale dei valori, espansione e dispersione suburbana, tempi e modi del consumo televisivo), ma poco
è detto del contenuto materiale e simbolico degli scambi in cui
s’impegnano gli attori sociali in differenti situazioni di cooperazione e di conflitto. Il testo di Putnam esamina una cospicua
mole di dati statistici passando dal consumo culturale all’associazionismo, dall’affiliazione a gruppi religiosi alle appartenenze che si sviluppano tramite internet e nuove tecnologie, ipotizzando anche una diretta correlazione fra numero di adesioni
associative e livello di salute della persona. Il problema tuttavia
in questo caso è cogliere nel capitale sociale una risorsa di cui si
postula l’esistenza proprio mentre se ne denuncia la scomparsa:
la ricerca della solidarietà mancante porta a guardare nostalgicamente al passato per trovare quanto sarebbe sparito dalla vita
associata contemporanea6.
Questo genere di capitale, infatti, quando è collocato in
un’astratta zona intermedia fra lo stato e il mercato, e sistematicamente identificato con caratteristiche comunitarie “incapsulate”, porta a una problematica riduzione di complessità sia
delle forme culturalmente specifiche di riproduzione sociale,
sia delle interazioni fra macro-aree nazionali e sovranazionali.
Nel primo caso, la separazione degli ambiti impedisce di vedere
le reciproche implicazioni e sovrapposizioni tra dono e scambio
di mercato, con la conseguente sottovalutazione di vaste aree
della prassi sociale nello studio delle transazioni economiche.
Tendono così a passare in secondo piano le attività di riproduzione sociale, svolte nella sfera domestica ed entro i rapporti di
parentela, in cui gli attori definiscono le appartenenze attraver6. Per una critica sostanziale ai teorici della solidarietà basata sulla fiducia,
in una lettura che pone l’accento sulla base razionale dell’azione collettiva e
sul ruolo dei processi cognitivi nella formazione del legame sociale («perché
fare sacrifici a vantaggio del gruppo?»), si veda Douglas M., 1990 [1986].
22
Massimiliano Minelli
so relazioni familiari e trasmissione di beni inalienabili (Papa C.,
1999: 82)7. Diviene perciò difficile cogliere soprattutto le forme
di socialità, costruite attraverso pratiche di cura e di mutuo aiuto, che in modi irregolari si configurano quasi per opposizione rispetto alla parte visibile e legittimata dell’agire economico
(Dei F., 2008)8. L’esame etnografico delle sfere di reciprocità nel
campo della salute permette invece di inquadrare in una prospettiva culturale complessa da un lato comportamenti altruistici come la donazione di sangue e di organi, dall’altro scambi di
prestazioni, continuamente frequentati sebbene caratterizzati
da un basso livello di visibilità sociale. Si tratta infatti di scambi
dotati di una costitutiva ambivalenza, connessa al margine di
7. Lo scambio di mercato dovrebbe essere invece considerato nel quadro
delle moleplici combinazioni disgiuntive tra differenti categorie economiche,
considerando il rapporto che la merce instaura con il dono, il baratto, i beni
inalienabili (ciò che non viene scambiato ed è conservato per passare da una
generazione all’altra) (Papa C., 1999: 82 e segg.). In particolare, la definizione
degli stock e delle rendite ottenibili dai legami sociali porta con sé un’ipoteca
riconducibile alla dicotomia tra dono e merce formatasi storicamente negli
studi economici. Nella genealogia dell’opposizione dono-merce (Pavanello
M., 2008), l’uso combinato delle due categorie segue effettivamente un processo di sovradeterminazione, in cui l’una si definisce per negazione dell’altra.
Nella realtà delle politiche di sviluppo invece dono e credito non sono inseriti
in separate realtà relazionali, ma interagiscono in uno stesso ambito di negoziazioni e scambi.
8. Nei contesti socio-sanitari si combinano variamente le tre tipologie di
dono che Godbout e Caillé classificano in base al diverso rapporto esistente
fra il bene circolante e il legame sociale: il “dono rituale” in cui il bene nega
anche la propria funzione d’uso esprimendo il puro legame, la “prestazione
fondata sulla utilità” ove sono in gioco transazioni in presenza di un legame
già esistente, ma considerate libere, i “doni unilaterali” a sconosciuti, nei quali, in assenza di legami espliciti e visibili con il destinatario, i beni circolano
secondo un principio di solidarietà anche senza una eventuale restituzione
(Godbout J.T., 1994 [1992]: 30-31). D’altra parte in quest’area, vasta e poco
definita, fuori dalle pertinenze astrattamente ripartite fra stato e mercato, si
sviluppano quotidianamente interazioni dalle quali esce ridefinito il “quadro astratto di assegnazioni di competenze” di alcuni modelli di scambio e
reciprocità. Per esempio quei modelli in cui il dono è contrapposto sia alla
circolazione delle merci nel mercato sia alla redistribuzione del cosiddetto
Stato-provvidenza.
1. Capitale sociale e salute
23
rischio implicato nel debito e, in definitiva, alla centralità della
fiducia risposta nella restituzione differita.
Nel secondo caso, un deficit di prospettiva analitica genera
l’immagine stereotipata e attrattiva di realtà locali, descritte in
termini morali come solidali, ma sganciate dai flussi di merci e
denaro di un capitalismo storico senza memoria dei rapporti di
forza coloniali e post-coloniali (Wolf E., 1990 [1982], Wallerstein I., 1985 [1983]). Si tratta di analisi che uniformano dall’alto i rapporti differenziali delle politiche economiche, evocando
soprattutto fattori coesivi all’interno degli agglomerati umani.
La chiusura all’interno delle comunità è così in genere affiancata da una “etnicizzazione” delle divisioni e dei confini e, come
accade per un ampio filone di studi sociali statunitensi, contrassegnata da una sottovalutazione dei rapporti di classe.
4. Campi e trasformazioni
Nella formulazione proposta da Robert Putnam e dopo l’impiego da parte della Banca mondiale, il capitale sociale è stato
adottato con un certo entusiasmo nelle direttive sull’integrazione socio-sanitaria anche in Italia. Questo effetto di ritorno è
parte di un più ampio processo di acquisizione di termini che
appaiono come ovvi e indiscutibili perché ritraggono come naturale la realtà dei rapporti di forza internazionali, un processo
che seguendo Pierre Bourdieu chiameremmo di “imposizione simbolica”. In effetti, la politica economica applicata dalle
grandi organizzazioni internazionali (ad esempio il Fondo monetario internazionale o la Banca mondiale) afferma e naturalizza tre presupposti taciti delle politiche neoliberali su larga
scala: l’esistenza di una netta separazione fra dinamiche sociali
e sfera economica, promuovendo le leggi economiche a regole
dell’intera organizzazione sociale, l’inevitabilità, come fatto storicamente incontrovertibile, del mercato quale unico regolatore
degli scambi e della produzione a livello globale, in particolare
all’interno delle cosiddette democrazie avanzate, la necessità
24
Massimiliano Minelli
d’ineluttabili tagli della spesa per la sicurezza sociale, sotto la
pressione del debito pubblico e della concorrenza internazionale (Bourdieu P., 2001: 31).
Ironicamente, a fronte della oggi prevalente declinazione
tecnocratica dei lessici riferiti al lavoro sociale, il modo in cui
Pierre Bourdieu ha definito e usato il concetto di capitale sociale nella sua opera avrebbe consentito di cogliere e demistificare
le contraddizioni implicate nel processo, sopra richiamato, di
“valorizzazione” dello scambio sociale. Un processo che, come
si è detto, procede parallelamente all’arretramento dell’azione
pubblica degli stati dalla difesa della salute come bene comune.
La premessa del ragionamento del sociologo francese è che
il mondo sociale è “storia accumulata” e, in questo senso, un
capitale inteso come lavoro sociale accumulato. Ma il lavoro
sociale accumulato, cui Bourdieu si riferisce, va inquadrato
nell’ambito di un’economia generale delle pratiche (Bourdieu
P., 2003 [1972]), che ben oltre la sola accumulazione di diversi
capitali presuppone capacità di agire in un intreccio storico di
rapporti di forza, scambi e trasformazioni.
«Secondo il campo nel quale agisce, e al prezzo di più o
meno costose trasformazioni che sono le pre-condizioni per la
sua efficacia nel campo in questione, il capitale può presentarsi in tre forme fondamentali: come capitale economico, che è
immediatamente e direttamente convertibile in denaro e può
essere istituzionalizzato nella forma di diritti di proprietà, come
capitale culturale, convertibile a certe condizioni in capitale economico e istituzionalizzabile nel riconoscimento di qualifiche
educative, come capitale sociale, fatto di obbligazioni e relazioni
sociali, che è convertibile a certe condizioni in capitale economico e può essere istituzionalizzato nella forma di un titolo nobiliare» (Bourdieu P., 1986: 243).
Nella definizione dei diversi capitali la convertibilità e l’istituzionalizzazione sono caratteristiche fondamentali del lavoro
sociale diversamente accumulato. Si comprende come il capitale sociale debba essere pensato in rapporto continuo con gli
altri tipi di capitale (culturale, economico) nei quali può a certe
1. Capitale sociale e salute
25
condizioni essere convertito e istituzionalizzato, e come il capitale economico svolga una funzione cruciale, senza però essere
il fulcro di una sovradeterminazione sugli altri capitali. Le differenti forme di capitale, infatti, possono essere derivate dal capitale economico quando specifici attori attivano il tipo di potere
efficace ed effettivo nel campo sociale in cui avvengono contese
e transazioni (Bourdieu P., 1986: 252, vedi anche Siisiäinen M.,
2000). D’altro canto, il capitale culturale, come lavoro sociale
accumulato nel processo di costruzione della persona, attraversa le capacità di agire e i saperi corporei degli attori, prendendo differenti forme: “incorporato” (embodied) e naturalizzato
nelle disposizioni mentali e corporee, “oggettivato” (objectified)
nei beni culturali (dipinti, libri, macchine, strumenti), e “istituzionalizzato” attraverso l’attribuzione di originali qualifiche
garantite al soggetto dal sistema educativo. Investimento personale di tempo in ricchezza esterna convertita in persona, il
“capitale culturale incorporato” tende in alcune circostanze a
trasformarsi in capitale simbolico – vale a dire un capitale su
base cognitiva fondato su conoscenza e riconoscimento e per
questo percepibile attraverso categorie risultanti dall’incorporazione delle strutture oggettive del campo considerato –9. Anche a causa della natura mascherata delle condizioni della sua
trasmissione e acquisizione, il capitale culturale agisce così nei
processi di naturalizzazione e di controllo sociale.
Nell’articolata economia delle pratiche di Bourdieu, com’è
noto, la definizione dei contesti dipende dal rapporto storicamente determinato fra “campo” e “habitus”. Dove il campo è
costituito dai modi in cui specifici agenti si riconoscono e interagiscono attraverso “posizioni” e “prese di posizione”, mentre
l’habitus è storia incorporata, disposizione ad agire – con una
9. Il caso di alcuni terapeuti tradizionali è particolarmente interessante al
riguardo: il dono che caratterizza un mediatore di guarigione è legato a indole
e vocazione, ma spesso è acquisito fuori dalla linea genealogica, sviluppandosi
in modo idiosincratico (Friedmann D., 1993 [1987]). In tal senso può essere contemporaneamente oggetto di appropriazione materiale (come capitale
economico) e di appropriazione simbolica (come capitale culturale).
26
Massimiliano Minelli
peculiare duplice dimensione, strutturata e strutturante – sulla
quale gli agenti sociali possono fare affidamento. In tal modo il
campo mantiene un rapporto attivo con le pratiche e la corporeità degli agenti, i quali, mentre agiscono, accumulano diverse
forme di capitale, ne deriva che «la struttura e la distribuzione
di differenti tipi e sottotipi di capitale in un dato momento rappresentano la struttura immanente del mondo sociale» (Bourdieu P., 1986: 243).
Nella definizione data da Bourdieu, il capitale sociale appare
quindi come una realtà con precise caratteristiche relazionali e
contestuali, il suo essere moltiplicatore di risorse dipenderebbe
inoltre dal potenziale suo riconoscimento come credenziale da
giocare in rapporto ai partner degli scambi in cui si è coinvolti:
«Il capitale sociale è l’insieme di risorse attuali o potenziali, legate al possesso di una rete durevole di più o meno istituzionalizzate relazioni di reciproca conoscenza e riconoscimento – o
in altre parole alla appartenenza a un gruppo –, che forniscono
a ciascuno dei suoi membri il sostegno del capitale posseduto
collettivamente, una credenziale che riconosce loro il diritto al
credito, nei diversi significati del termine» (Bourdieu P., 1986:
248-249).
Il volume complessivo di capitale sociale, in questo senso,
è dato dall’ampiezza delle connessioni realizzabili da un attore e riconoscibili in specifici campi. La sua capacità di intervenire nel contesto è dovuta inoltre all’essere un moltiplicatore
di risorse per l’azione sociale. Ecco perché la prospettiva di
Bourdieu implica un inquadramento strutturale, un’analisi delle differenze di classe e richiede una ricostruzione processuale e
storica dei processi di incorporazione.
Lungo le direttrici delineate da Pierre Bourdieu, Gilles
Bibeau ha sviluppato una puntuale critica degli usi recenti del
costrutto “capitale sociale” in epidemiologia. Egli ha in primo
luogo evidenziato come il deficit teorico principale, nell’impiego
da parte degli epidemiologi di questa nozione, sia riconducibile
soprattutto all’assenza di una articolazione concettuale necessaria a pensare la società nel suo complesso (Bibeau G., 2005). Più
1. Capitale sociale e salute
27
in generale, nel “comunitarismo alla Putnam” – sostiene Bibeau
– la solidarietà e la coesione sociale sono richiamate senza chiedersi quali altri fattori (di ordine economico, politico, culturale, etico) perpetuano le ineguaglianze nelle società neoliberali
e come tali ineguaglianze incidano profondamente sui livelli
di salute collettiva di un paese. È inoltre discutibile l’idea che
ciascuna persona sia in grado di controllare il suo capitale, senza subire limiti o costrizioni. Il capitale sociale, infatti, proprio
perché è indissociabile dai capitali economico e culturale di cui
dispongono rispettivamente l’individuo, la famiglia e il gruppo,
tende ad essere difeso e perpetuato tramite le reti di parentela
e i legami genealogici (Bibeau G., 2005: 158). È dunque necessario avvalersi di una teoria critica della società, che riconosca
nello spazio sociale il ruolo giocato dalle posizioni (relativamente stabili) ascrivibili a soggetti depositari di differenti capitali
(sociale, economico, culturale), per ricostruire adeguatamente
la storia specifica dei meccanismi di trasmissione degli status da
una generazione all’altra. Per questi motivi Bibeau ha suggerito
di studiare il rapporto tra reti sociali e determinanti di salute
seguendo due principi: (a) considerare il capitale sociale come
in costante rapporto con i capitali economico e culturale, (b)
individuare e misurare il capitale sociale in relazione alle storie
di individui, famiglie e gruppi sociali, tenendo conto di ineguaglianze economiche e differenze di classe (Ibidem).
5. Scenari
I programmi di aggiustamento strutturale, promossi dalla Banca mondiale e dal Fondo monetario internazionale a cominciare
dagli anni Ottanta, hanno avuto un impatto negativo di scala
continentale su vaste aree geopolitiche. Come mostrano recenti
rassegne sugli effetti delle politiche neoliberiste sulle economie
sanitarie in vari stati (Pfeiffer J. - Nichter M. 2008, Pfeiffer
J. - Chapman R., 2010), privatizzazioni, riduzioni della spesa
pubblica e deflazione delle valute imposte ai paesi in via di svi-
28
Massimiliano Minelli
luppo hanno portato, nei rapporti internazionali, a un sensibile
allargamento della forbice fra i paesi ricchi e quelli più poveri.
Nonostante i differenti livelli di crescita dello stato sociale nei
paesi con economie emergenti (si pensi all’attuale differente organizzazione ed efficienza dei sistemi di salute in Brasile, India
e Cina), è stato notato come insufficienti finanziamenti in servizi pubblici di base, prevenzione primaria e accesso alle risorse
fondamentali, abbiano acuito entro i singoli confini nazionali la
distanza tra grandi ricchezze e povertà estreme.
Negli ultimi due decenni, nondimeno, la direzione economica delle campagne di prevenzione e d’intervento sanitario
è entrata fra le prerogative della Banca mondiale e del Fondo
monetario internazionale, mentre alla redistribuzione di varie
iniziative dell’Organizzazione mondiale della sanità fra diverse agenzie delle Nazioni Unite non è seguita una complessiva
pianificazione strategica. La ridefinizione delle competenze in
materia sanitaria è stata accompagnata da consistenti tagli agli
investimenti che hanno avuto un effetto sfavorevole, dolorosamente noto, sulle popolazioni più povere delle macro-aree economiche dell’economia-mondo. Conseguenze negative massicce si sono avute in primo luogo, ad esempio, sulla vulnerabilità
rispetto alle malattie infettive delle popolazioni di paesi asiatici
e africani. Peraltro lo squilibrio fra finanziamenti, sempre più
ridotti, e azioni politiche necessarie per ridurre l’ineguaglianza
sociale rappresenta un’emergenza anche negli stati con sistemi
sanitari avanzati e più equamente distribuiti.
Più in generale, si è assistito da un lato all’accentramento
delle strategie d’azione in un ristretto numero di centri sovranazionali e privati di finanziamento economico, dall’altro a sistematici attacchi alle politiche di welfare negli stati nazionali.
Tale doppia operazione ha come protagonisti appunto gli stessi
organismi sovranazionali che, in linea di principio, si auto-rappresentano come a-politici e neutrali. Si tratta di una condotta ben conosciuta dai cittadini di quei paesi europei nei quali
sono stati ridefiniti i rapporti fra pubblico e privato, a favore di
quest’ultimo, in settori nevralgici: salute, educazione, formazio-
1. Capitale sociale e salute
29
ne, ricerca. L’Italia dei governi di centro-destra nel quindicennio trascorso è un esempio. Ma la linea è in atto da anni in molti
paesi dell’Unione Europea e sembra aver attraversato indenne
diverse fasi politiche ed economiche caratterizzate da spinte inflattive e da crisi recessive.
In Italia, per quel che concerne la salute, alla distinzione
tra welfare state, per così dire classico (ad esempio secondo il
modello delle socialdemocrazie del nord-Europa), e mercato
neoliberista, è andata progressivamente sostituendosi una realtà mista, fatta d’intervento statale e interessi privati attraverso appalti ed esternalizzazioni. Nella nuova ratio dei mercati
interni alla pubblica amministrazione, l’erogazione dei servizi
socio-sanitari è stata fatta prevalentemente da un gestore pubblico soggetto a forti pressioni e a conflitti d’interesse. Nella
maggioranza dei casi, con investimenti variabili nelle regioni,
si è cercato di produrre un sistema competitivo tra profit e non
profit, tenendo in vita un mercato privato dentro il pubblico.
La tendenza prevalente a proporre risposte predefinite, rispondenti soprattutto a esigenze dell’erogatore e in parte al presunto
gradimento dei consumatori (utenti e famiglie), riduce drasticamente lo spazio riservato alla costruzione di soluzioni originali
locali. Evidenti sono i limiti di questo modello di gestione, in
cui la concorrenza del mercato dovrebbe fornire migliori servizi
sociali, soprattutto quando l’obiettivo prioritario di ridurre il
costo delle prestazioni si scontra inevitabilmente con la iperregolamentazione centralizzata, frenante il miglioramento della
qualità, e con un sistema degli appalti che aumenta il potere di
enti esterni di certificazione economico-finanziaria-organizzativa (Folgheraiter F., 2006: 25).
In questa situazione, ipotizzare prestazioni in cui sia attiva un’astratta “virtù civica”, lasciando che beni e servizi siano distribuiti e accumulati secondo le regole del mercato e
l’intervento dello stato, significa ridimensionare il ruolo della
partecipazione attiva nelle politiche democratiche della salute.
Nel caso italiano, ad esempio, le indicazioni affinché le aziende
sanitarie provino a beneficiare di un buon capitale sociale ali-
30
Massimiliano Minelli
mentato dagli scambi informali, nonostante i generici richiami
alla cosiddetta utenza consapevole, non sembrano incidere sui
reali assetti economici e funzionali della sanità. D’altra parte i
membri di alcune associazioni di utenti, spesso i soggetti più
attivi della società civile, sembrano consapevoli del modo in cui
economia, cultura e sociale si mescolano nel gioco politico e
possono essere fra loro convertibili. A fronte di operatori sociosanitari costretti a lavorare in organici ridotti (senza turnover) e che vedono accrescersi il carico di lavoro burocratico,
i destinatari delle cure sono invece costantemente impegnati
a intervenire come attivi produttori di relazioni e reciproche
forme di protezione. In questo processo di produzione e riproduzione, possono emergere nuovi scambi e reciprocità, insieme ad aperte critiche alle forme di riduzione del “sociale” (cfr.
Minelli M., 2011: 99-132). Per questi motivi, è da seguire con
attenzione la costruzione di relazioni cooperative dal basso,
non solo quindi la protezione da alcune patologie e la risposta
alle difficoltà di accesso ai servizi, ma anche modi innovativi
di produrre salute. L’associazionismo, la partecipazione civica,
l’organizzazione comunitaria nella gestione di risorse e servizi
sono infatti caratteristiche connesse con buoni livelli di salute,
soprattutto quando la partecipazione diretta apporta trasformazioni microscopiche e profonde, di natura molecolare, alla
vita di individui e famiglie (cfr. Ginsborg P., 2004).
Con questa pluralità deve confrontarsi ogni volta il complesso di reti informali e organizzazioni che costituisce il supporto
ineludibile per azioni sistemiche sulla salute. In modi diversi,
il problema è costruire strategie avanzate, in cui la efficacia terapeutica sia fatta interagire con la questione della produttività dei sistemi medici. Seguendo Allan Young (Young A., 2006
[1982]), con l’espressione produttività medica è possibile riferirsi all’impatto sulla popolazione generale, nei termini di morbilità e mortalità, delle pratiche mediche caratterizzate da una
efficacia clinica riconosciuta nel trattamento individuale di ciascun paziente. La distinzione tra efficacia di un’azione specifica
e produttività dell’insieme delle operazioni in cui essa è inserita
1. Capitale sociale e salute
31
è rilevante per valutare ogni progetto di sviluppo della rete sanitaria in un contesto dato. Vi sono, difatti, varie situazioni in cui
i miglioramenti di efficacia di un trattamento non hanno effetti positivi sulla popolazione generale, in cui dunque l’efficacia
delle cure disponibili non ha effetto sulla produttività medica.
Allan Young descrive tre casi esemplari: (a) quando l’efficacia
caratterizza solo interventi destinati a gruppi ristretti, spesso per
pochi utenti legati alle realtà urbane, sottraendo risorse al resto
della popolazione in condizioni di povertà e bisogno (Young
A., 2006 [1982]: 135), (b) quando farmaci o presidi medici sono
messi a disposizione di ampie fasce della popolazione, senza
però creare le effettive condizioni per un loro impiego adeguato (come accade quando la somministrazione estesa di un
farmaco ha, nel lungo periodo, imprevisti effetti iatrogeni), (c)
quando la cura di casi isolati non procede di concerto con la
ricerca sulle cause sociali di una malattia, amplificandone anzi
la naturalizzazione e la desocializzazione. Il fatto che il modello
biomedico sia strutturato su una logica ospedaliera e farmacologica ha come potenziale conseguenza la naturalizzazione di
vaste aree della sofferenza sociale e la de-socializzazione della
malattia, ecco perché la stessa logica biomedica alla base delle
economie sanitarie può in certe circostanze diventare il principale responsabile della diminuzione della produttività di un
sistema di salute.
Si comprende come il rapporto squilibrato tra medicina
ospedaliera e salute comunitaria sia un punto nevralgico per le
strategie sanitarie pubbliche, che meriterebbe un ampio e costante confronto politico. In generale, se i livelli essenziali di
salute fossero ridotti alle procedure e tecnicalità biomediche,
tagliando fuori le azioni di cura della sfera informale e non istituzionalizzata (volontariato e ambiente familiare), si potrebbe
arrivare a parlare di efficacia solo per interventi medici preventivamente separati dal sociale, con evidenti contraccolpi sulle
politiche di welfare più complesse che dovrebbero invece investire su competenze, partecipazione e reciprocità nelle realtà della cura. In tutti i casi, l’imporsi di una bio-medicina ad
32
Massimiliano Minelli
alta tecnologia, centrata sulla razionalità del costo-prestazione,
oltre che sulla diagnostica strumentale e sulla cura farmacologica, rischia di occultare la fondamentale natura sociale degli
interventi complessi, plurali, prolungati nel tempo e microfisicamente diffusi nelle comunità locali10. Si pensi, per esempio,
alla difficoltà incontrata, in vari settori biomedici, a proiettare
l’azione di cura fuori dai dispositivi ospedalieri, per impostare invece azioni territoriali socialmente orientate sui problemi
più rilevanti. In termini complessivi, il problema di come far
interagire approcci clinici e sociali grava sugli interventi terapeutici e riabilitativi con un supporto specifico alla persona. Si
tratta, com’è noto, dell’emergere di nuove complesse situazioni,
a fronte del prolungarsi dell’attesa di vita, del progressivo invecchiamento delle popolazioni, con il crescente numero di anziani non autosufficienti, più in generale, con un largo impatto
sociale delle malattie croniche o degenerative. Sono prestazioni
in cui devono essere coinvolti diversi soggetti istituzionali, reti
comunitarie, datori di cura e, insieme, strategie di mutuo aiuto
negli ambiti domestici. Tali interventi “labour intensive” non si
vedono oggi riconosciuta una rilevanza nelle economie sanitarie paragonabile ai cosiddetti interventi “technology intensive”,
considerati invece più importanti nell’assetto organizzativo di
tipo ospedaliero (Vineis P. - Dirindin N., 2004: 74-75).ù
La definizione di uno spazio autonomo per i legami sociali
e gli scambi altruistici, tra il pubblico e il privato, sembra destinata allo scacco soprattutto se non sono ricercate nuove possibilità di confronto politico rispetto alle reali forme di sperimentazione e produzione della salute come diritto fondamentale e
bene comune. Sono le lotte per la salute nei territori a ridefinire,
di volta in volta e in situazioni plurali e contestative, il difficile
10. Le scelte di politica economica, l’equità delle risposte e i dilemmi etici,
come ricorda Paul Farmer, non vanno considerati separatamente dallo sviluppo tecnologico e dagli assetti istituzionali della biomedicina: «con tutto
il nostro potere tecnologico, le nostre scansioni a risonanza magnetica, e i
nostri protease inibitor, non solo si consente la riproduzione ma si favorisce il
combinarsi delle ineguaglianze» (Farmer P., 2006: 173).
1. Capitale sociale e salute
33
rapporto fra gestione della salute come bene comune ed efficienza dei sistemi medici (Smith-Nonini S., 2006). Tali processi
assumono importanza proprio perché si attivano dalle relazioni
storicamente mutevoli e dalle conoscenze situate di agenti specifici, in arene conflittuali dove sono prodotte la partecipazione
attiva e la coesione sociale. In alcuni incontri pubblici, con vari
soggetti attivi in difesa dei diritti di cittadinanza, Tullio Seppilli è recentemente intervenuto su questi problemi e sulla salute
come bene comune, proponendo di definire gli strumenti di
analisi e i modi di confronto politico per il riconoscimento dei
diritti e dei commons (Seppilli T., 2010, 2012). Il suo è un vero
e proprio esercizio d’immaginazione antropologica cui è importante richiamarsi a questo punto, per riflettere sul rapporto tra
forme condivise di presa in carico e partecipazione democratica
alle decisioni strategiche. Come egli ha ricordato, l’obiettivo è
«comprendere quali siano le radici e i fattori che pesano a sostegno dell’attuale assetto economico-politico (e dei suoi successi),
quali le dinamiche attualmente in gioco e quali le contraddizioni che ne risultano, con quali forze sociali e con quali forme
organizzative sia realisticamente pensabile in termini strategici
e tattici, aprire spazi per una società diversa» (Seppilli T., 2012:
116). In questa prospettiva è indispensabile riflettere su mutamenti sistemici di larga scala e nello stesso tempo puntare sulla
soggettività sociale e sulle forme di organizzazione collettiva.
Nella direzione indicata da Seppilli, è necessario «che alcuni
beni essenziali per la vita dell’uomo debbano sfuggire alla logica della proprietà privata, del mercato e del profitto e vadano
comunque tutelati dalla legge come beni collettivamente controllati e potenzialmente disponibili ‘per tutti’, di interesse di
tutti, siano cioè beni comuni» (Seppilli T., 2010: 370). Inserire
la salute in tal quadro politico ha conseguenze importanti. Se il
potenziamento delle risorse comunitarie locali corrispondesse
effettivamente alla partecipazione politica dei cittadini/fruitori/
abitanti, la tutela, la delega e la rappresentanza potrebbero essere rimesse in discussione. Nuovi modi del confronto democratico potrebbero aprirsi a differenti livelli: locali, coinvolgendo
34
Massimiliano Minelli
nelle politiche economiche le istituzioni regionali e nazionali, e
internazionali, investendo le agenzie sovranazionali responsabili delle politiche di sviluppo.
6. Politiche, ineguaglianze, reti
Nel passaggio dalla sociologia all’epidemiologia, come ha notato Didier Fassin, il capitale sociale ha generato problemi rispettivamente di ordine: teorico, giacché il capitale sociale è definito
in base ai suoi effetti (giudicati di solito in termini positivi dai
ricercatori) piuttosto che in base alle cause, metodologico, in
merito a come si decide di distinguere il livello individuale da
quello sociale, politico, per lo spostamento dell’attenzione verso la responsabilità individuale, a scapito dei fattori strutturali
condizionanti i livelli di salute e le trasformazioni delle politiche
internazionali (Fassin D., 2003).
In tale complicato scenario, per orientarsi in una letteratura scientifica su capitale sociale e salute 11, diventata in pochi
anni vastissima, è possibile distinguere tre strategie di ricerca e
cornici teoriche corrispondenti ai principali indirizzi di politica
socio-sanitaria (Muntaner C. - Lynch J.W. - Davey Smith G.,
2000): (a) quella di taglio psicologico-sociale che si concentra
sulla “coesione sociale”, riconducibile alla nozione elaborata da
Robert Putnam, (b) quella che, nel quadro degli approcci politico-sociologici alle dinamiche istituzionali fra stato e comunità
locali, spesso riferibili alla teoria economica formalista, colloca
11. Un’ampia panoramica sullo stato della ricerca si trova in Baron S. Field J. - Schuller T. curatori, 2000. Fra i testi di orientamento generale si
può vedere anche Lin N., 2001, Field J., 2004 [2003] e Bagnasco A. - Piselli
F. - Pizzorno A., - Trigilia C., 2001. Va segnalato inoltre il testo in cui Farr J.,
2003 ha ricostruito una storia concettuale del capitale sociale. Utili rassegne,
anche critiche, sul concetto sono apparse alla fine degli anni Novanta (Portes
A., 1998, Woolcock M., 1998, Foley M. - Edwards B. 1999, Fine B., 2000).
Per un quadro complessivo e un’esplorazione della letteratura riguardante la
salute mi permetto di rinviare a Minelli M., 2007.
1. Capitale sociale e salute
35
le priorità di salute entro le teorie del comportamento fondate
sulla “scelta razionale”, (c) quella riconducibile alla analisi dei
“reticoli sociali”, un filone di studi che ha avuto un significativo
e autonomo sviluppo in diversi ambiti delle scienze umane, ben
prima che capitale sociale divenisse una espressione chiave usata
per indicare i vantaggi derivanti dalle relazioni comunitarie.
(a) Coesione sociale. Per quanto riguarda il rapporto fra determinanti di salute e livelli di coesione, è da ricordare che il capitale sociale è stato adottato sulla scia di un’importante ricerca di
Wilkinson sulla correlazione fra salute, relazioni sociali e livelli
di reddito nelle società industrializzate (Wilkinson R. 1996). In
quella ricerca, il capitale sociale – definito, seguendo Putnam,
come «partecipazione, responsabilità civica, coinvolgimento
nella vita pubblica» – è stato considerato come elemento di mediazione psicosociale fra caratteristiche ambientali e insorgenza
di patologie (Wilkinson R., 1999, 2001, Wilkinson R. - Marmot
M. curatori, 2003, cfr. anche Elstad J.I., 1998). Parallelamente,
i riferimenti al capitale sociale sono aumentati soprattutto negli
articoli pubblicati in “Social Science and Medicine”, rivista che
ha alimentato un importante confronto fra scienze mediche e
scienze sociali a proposito del rapporto fra determinanti di salute, politiche pubbliche e gestione collettiva dei sistemi medici. In questo quadro, va collocata anche l’attività di ricercatori
della Harvard school of public health (Boston) impegnati nella
indagine sulle correlazioni epidemiologiche fra capitale sociale,
salute e differenze di reddito (Kawachi I. - Kennedy B.P., 1997,
Kawachi I. - Kennedy B.P. - Lochner K. - Prothrow-Stith D.,
1997, Lochner K. - Kawachi I. - Kennedy B.P., 1999, Kawachi
I. - Kennedy B.P., 2002). In generale, già in una prima fase, da
più direzioni è stato suggerito di congiungere reti sociali e azioni comunitarie di prevenzione primaria. La costatazione che le
risorse riconducibili ai legami sociali dipendono da processi
ecologici, storici e politici ha sostenuto diverse ricerche comparative sull’ineguale distribuzione internazionale delle ricchezze
e dei servizi di salute. Un orientamento implicito in tali studi è
36
Massimiliano Minelli
che le società più ricche non producono necessariamente migliori livelli di salute per la totalità della popolazione e che vi
sia una chiara sinergia fra livello biologico, psicologico e sociale
nel determinare l’insorgenza di malattie in persone variamente
collocate sulla scala sociale. Le ricerche appartenenti a questo
filone di studi hanno riscontrato una relazione positiva tra livelli
di capitale sociale, inteso come fiducia e reciprocità, e stato di
salute. Hanno inoltre proposto di rafforzare il capitale sociale per ridurre l’impatto delle ineguaglianze socio-economiche
(Kawachi I., 1999).
Negli studi che si muovono lungo questo cammino, tuttavia,
le differenze strutturali (fondate su classificazioni di “genere”,
“etnia”, “reddito”) raramente sono inserite in analisi complessive di come possano funzionare e riprodursi i rapporti di potere
e le differenze di “classe”. Un’accurata lettura della vasta letteratura scientifica disponibile mostra inoltre che l’aumento dei
riferimenti alle caratteristiche strutturali degli aggregati sociali
è coinciso con un’enfasi accordata alla quantificazione a scapito
di ricerche intensive con dettagliate analisi d’interazioni in situazioni specifiche.
I più critici verso l’adozione del concetto di capitale sociale
hanno ritenuto soprattutto discutibile il rapporto tra i principali indicatori di salute della popolazione e i tratti psico-culturali definiti in termini di fiducia e di numero di affiliazioni
ad associazioni. Studi sulla diseguaglianza socioeconomica e
sui dislivelli di classe (Lynch J.W. - Kaplan G.A. - Salonen
J.T., 1997, Muntaner C. - Lynch J.W. - Hillemeier M. - Lee
J.H. - David R. - Benach J. - Borrell C., 2002) mostrano che
se da un lato è statisticamente evidenziata una correlazione
strutturale fra reddito pro-capite, spesa pubblica e condizioni
socio-sanitarie di gruppi di popolazione, dall’altro lato non vi è
altrettanta evidenza statistica dell’impatto sulla salute di alcuni
indicatori standard del capitale sociale (ad esempio, fiducia negli altri e appartenenza ad associazioni volontarie) (Kennelly
B. - O’Shea E. - Garvey E., 2003). In proposito, le critiche più
incisive all’uso della nozione di capitale sociale in epidemiolo-
1. Capitale sociale e salute
37
gia provengono da epidemiologi che invitano a ricostruire con
strumenti adeguati gli effetti strutturali delle specifiche politiche economiche dalle quali dipendono la produzione e l’organizzazione del sapere medico (Navarro V., 2002, 2004, Muntaner C. - Lynch J.W., 2002, Muntaner C. - Lynch J.W. - Oates
G.L., 2002, Navarro V. - Muntaner C. curatori,. 2004). Quando tali trasformazioni strutturali sono lasciate sullo sfondo, accade che, con un ribaltamento delle responsabilità, le cause di
vulnerabilità siano imputate alla scarsa coesione sociale dei più
poveri e dei più deboli (Pearce N. - Davey Smith G., 2003).
(b) Stato e politiche locali. Il capitale sociale ha cominciato a
“circolare” nel dibattito internazionale in particolari congiunture storiche (nel passaggio dalla governance neoliberale dell’era
Thatcher e Reagan a quella neo-laburista e democratica della
cosiddetta terza via di Blair e Clinton), ma è un concetto che
è riuscito ad avere accoglienza in differenti stagioni politiche
(Muntaner C. - Lynch J.W. - Davey Smith G., 2001). Gli inviti
a rifugiarsi nella piccola comunità con forti toni identitari sono
propri anche dei governi conservatori, nelle fasi storiche in cui
le differenze di reddito fra i cittadini sono più marcate. Nel prevalere di una politica di alleggerimento degli investimenti pubblici, di deregolamentazione e privatizzazione di beni e risorse
collettive è riconoscibile un chiaro piano di tagli agli investimenti di indirizzo neoliberale. Un progetto che include anche
una complementare strategia d’intervento nelle policies locali,
con frequenti richiami alla valorizzazione della solidarietà e della partecipazione civica.
La ricerca epidemiologica sul capitale sociale, in merito alle
strategie di politica socio-sanitaria, si è sviluppata lungo tre linee di indirizzo: sulle reti come fattori di protezione della salute, sulla disuguaglianza economica, che mette in crisi i diritti
di cittadinanza e la giustizia sociale, sulla disparità di accesso
alle risorse materiali sia a livello nazionale che internazionale
(Szreter R. - Woolcock M., 2004, con replica ai commenti:
Szreter R., 2004). Riguardo alle prospettive di ricerca, sono
38
Massimiliano Minelli
intervenuti sia i fautori del capitale sociale come elemento di
mediazione psico-sociale nei determinanti di salute (Putnam
R.D., 2004, Ellaway A., 2004, Kawachi I. - Kim D. - Coutts
A. - Subramanian S.V., 2004) sia i “neo-materialisti” focalizzati
sulle ineguaglianze strutturali (Navarro V., 2004, Muntaner C.,
2004, Muntaner C. - Lynch J. W., 2002) 12. Condivisibile è la
posizione di Vicente Navarro, il quale sostiene ad esempio che
la rilevanza del capitale sociale come determinante di salute sia
stata sovrastimata, tralasciando i fattori politico-economici correlati alla classe sociale e confondendo all’interno di una sola
definizione tradizioni politiche e modelli di assistenza sanitaria fra loro molto differenti (Navarro V., 2002). Solo apparenti
sono le somiglianze fra il comunitarismo, così come si configura
negli Stati Uniti, e le politiche di stampo cristiano-democratico
diffusesi in Europa nel Secondo Dopoguerra, con la loro particolare enfasi attribuita alla famiglia – secondo un modello naturalizzato e conforme alla morale cattolica – quale asse portante
della coesione sociale e garante formale di diritti di cittadinanza. Una tale visione, secondo cui lo stato dovrebbe favorire la
coesione e l’inclusione sociale, eliminando i conflitti tra diversi
settori della società, non considera infine la più avanzata versione socialdemocratica del welfare dei paesi scandinavi, in cui lo
stato è visto come il principale agente di redistribuzione della
ricchezza.
(c) Social networks. L’analisi di configurazioni e scambi relativi
12. Le ipotesi materialiste sono interessanti quando riflettono criticamente sulle principali direttrici di economia politica della salute, vale a dire quando mostrano che la produzione delle disuguaglianze economiche e di classe
sono incorporate in differenti modi nella malattia (Navarro V. curatore, 2004,
Kaplan G. A. - Pamuk E. R. - Lynch J. W. - Cohen R. D. - Balfour J. L., 1996,
Lynch J.W. - Due P. - Muntaner C. - Davey Smith G., 2000, Lynch J. W.,
2000, Lynch J.W. - Davey Smith G. - Kaplan G.A. – House E., 2000, Lynch
J.W. - Davey Smith G. - Hillemeier M. - Shaw M. - Raghunathan T. - Kaplan
G. A., 2001). Il loro limite è dato talvolta dalla mancanza di adeguati strumenti interpretativi per i livelli specifici della esperienza del corpo e della malattia.
Proprio su questi aspetti il contributo della antropologia medica contemporanea è determinante (Nguyen V.K. - Peschard K., 2003).
1. Capitale sociale e salute
39
alla salute e alle prestazioni di cura è stata affinata in ricostruzioni dei legami fra individui, famiglie, reti amicali e di vicinato,
luoghi di lavoro, e stili di vita. Varie ricerche sui social networks hanno evidenziato come le informazioni per affrontare problemi sanitari siano accessibili in base alla posizione occupata
dagli attori nei reticoli e siano perciò strettamente dipendenti
dai contesti e dalle loro trasformazioni storiche (Campbell C.,
2000, Campbell C. - Gillies P., 2001, Campbell C. - McLean
C., 2003). In particolare, questi approcci alla dinamica strutturale dei reticoli fanno spesso riferimento a progetti di promozione della salute affidati alle “comunità” (termine ricorrente
nelle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità per indicare le popolazioni locali), con politiche di coesione e d’assistenza sociale volte a potenziare specifici networks.
La costruzione di legami interni ed esterni alle “comunità”, insieme all’opportunità di unire differenti agenti servendosi di diverse fonti d’informazione, sono aspetti sottolineati nello studio
del collegamento fra coesione sociale e ineguaglianze di salute.
In proposito, una distinzione fondamentale riguarda le dimensioni riferibili a legami interni (bonding) e a quelli fra (bridging)
gruppi sociali (Adams J. - White M., 2003). In questa direzione,
studi recenti sulla salute hanno rilevato un modesto ruolo di
protezione da parte del capitale sociale sia bonding che bridging
(Kim D. - Subramanian S.V. - Kawachi I., 2006). Soprattutto
hanno evidenziato che i processi in questione sono dipendenti dalla struttura sociale e dalla natura degli scambi materiali
e simbolici, quindi non deducibili da misurazioni statistiche
applicate a grandi aggregati. L’analisi dei reticoli ha messo in
evienza inoltre possibili conseguenze negative del capitale sociale: ad esempio, il fatto che la stessa forza dei legami di gruppo tenderebbe ad escludere l’accesso di attori considerati estranei, un forte in group che si chiude rispetto all’out group. Tra le
caratteristiche dei gruppi vi è inoltre la richiesta di conformità:
un controllo sociale esercitato sui membri e, dunque, una limitazione dell’autonomia e della libertà individuale (uno dei costi
di una organizzazione sociale centrata sui legami forti) può in-
40
Massimiliano Minelli
cidere negativamente sui progetti di prevenzione e promozione
sanitaria (Portes A., 1998).
Lo studio puntuale delle differenti configurazioni delle reti
mostra che il capitale sociale sarebbe prevalentemente da identificare con i vantaggi, nei termini d’informazione e di controllo,
derivanti dall’essere in relazione con persone altrimenti disconnesse nella struttura sociale. In proposito, la teoria dei “buchi
strutturali” di Ronald S. Burt permette di dare un significato
operativo al concetto di capitale sociale. Nella sua più concreta
applicazione, essa evidenzia chiaramente le opportunità derivanti dalla posizione occupata e dall’attività di brokerage in un
network con estensione e caratteristiche particolari (Burt R.S.,
1997: 340, Burt R.S., 2001). Seguire la gestione delle relazioni
e delle informazioni, da parte di specifici attori situati in una
rete, permette di rappresentare nel dettaglio le irregolarità dei
mercati reali fatti di gruppi di interesse, di reticoli variamente
interconnessi, di intervento pubblico e privato. Qui le disconnessioni e i cambiamenti di posizione incidono su formazione,
accumulazione e circolazione di capitali. Il problema quindi, da
questo punto di vista, non è dato solo dagli eventuali vantaggi
economici e sociali derivabili da un certo capitale sociale, ma
da come il capitale sociale scaturisca da relazioni di potere attivate attraverso specifiche posizioni e configurazioni dei gruppi.
Andando a curiosare fra queste descrizioni molto tecniche si
scopre l’utilità dell’analisi dei network nell’etnografia dei gruppi d’interesse, dei membri dei consigli di amministrazione di
società concorrenti in borsa, impegnati a scambiare informazioni con denaro e potere. La fama raggiunta da alcune lobbies
e gruppi di potere sulle pagine di cronaca giudiziaria dedicate
agli scandali che hanno investito la sanità in varie regioni italiane ce ne offrirebbero numerosi esempi.
1. Capitale sociale e salute
41
7. Competenza – macchina - flusso
In questa ultima parte dell’itinerario sulle modalità di valorizzazione della vita umana, in particolare nella sua peculiare dimensione relazionale, vorrei indicare una ulteriore linea di indagine.
Si tratta più che altro di un invito a riflettere sul ruolo strategico
svolto dalla teoria del capitale umano nelle economie contemporanee e il modo in cui in essa il capitale sociale è stabilmente
inserito.
In genere, le risorse derivanti da reti sociali, norme di reciprocità e virtù civica vengono prevalentemente descritte come
un capitale collocato nella “terra di mezzo” fra capitale fisico e
capitale umano. Per certi versi, il capitale sociale acquisirebbe
valore solo se considerato, analogamente al capitale fisico e al
capitale umano, come un ingrediente della produttività individuale e collettiva. L’immagine costruita da Putnam per evocare
questi “ferri del mestiere” è particolarmente efficace: «come un
cacciavite (capitale fisico) o l’istruzione universitaria (capitale
umano) possono aumentare la produttività (sia individuale sia
collettiva), allo stesso modo agiscono pure i contatti sociali»
(Putnam R., 2004 [2000]: 14).
Nel riprendere criticamente questo punto, in previsione di
possibili scenari futuri, dovrebbero essere considerati i campi
storico-sociali in cui si definiscono e circolano diverse forme di
capitale. Il quadro di riferimento è costituito dalle ricerche sul
capitale umano e sulle sue componenti innate e acquisite. In tale
ambito la ricerca antropologica contemporanea sui processi di
capitalizzazione della vita umana incrocia la questione delle reti
con quella del bio-capitale, qui vanno esplorati meccanismi di
funzionamento, genealogie e trasformazioni di differenti tipologie di capitale.
Una pista in tale direzione è stata indicata da Michel Foucault
nelle sue lezioni al Collège de France, del 1978-1979, dedicate
a una disamina delle teorie neoliberali relative al cosiddetto
“capitale umano”. In proposito, va ricordato che l’interesse
di Foucault per le teorie neoliberali è parte del suo più am-
42
Massimiliano Minelli
pio tentativo di ricostruire attraverso quali procedure la Natura
divenga «l’ipoderma indispensabile all’esercizio della governamentalità» (ibidem). Con l’esame delle varie forme di capitale e
delle sue parti costitutive è possibile infatti scoprire «una certa
naturalità propria della stessa pratica di governo» (Foucault
M., 2005 [2004]: 27).
Nell’analisi di Foucault, la pratica di governo implicita nel
progetto neoliberale ribalta il rapporto tra sovranità e fondamento naturale delle relazioni sociali, inserendo i principi
dello stato di diritto nell’ordine economico. Per questo motivo il nodo strategico del neoliberalismo diviene la teoria del
“capitale umano”, nella quale l’attore principale è il soggetto
produttore di sé e dei propri redditi e non solo il socius degli
scambi economici ad alto contenuto d’interessi. Nella visione
neoliberale, le ripartizioni economiche e politiche dell’eredità
della persona (trasmissione, educazione, formazione, gerarchia)
sono ricondotte a pochi principi uniformabili della formazione
di ciascun individuo. Le caratteristiche individuali possono essere così progressivamente considerate alienabili ed entrare in
flussi di scambi materiali e immateriali, in una gestione imprenditoriale di beni e servizi. Il potenziale della vita individuale
diventa alla fine un capitale umano di rischio incorporato. Allo
stesso tempo, la competenza del lavoratore si configura come
una macchina produttrice di flussi di reddito, con diverse intensità nel corso della sua vita.
La prima conseguenza di tale scomposizione del lavoro in
capitale e reddito è che il capitale viene vincolato strettamente
alla persona del lavoratore e alle sue trasformazioni, al sostrato
materiale e vitale della sua stessa esistenza. Si viene così a creare
una peculiare relazione biunivoca tra reddito e capitale, questa
volta inteso come «ciò che rende possibile un reddito futuro».
Ne consegue che, se da una parte il salario del lavoratore è un
reddito prodotto dal rendimento di un capitale, dall’altra, «inversamente, si chiamerà capitale tutto ciò che può essere, in
un modo o nell’altro, fonte di redditi futuri» (Foucault M.,
2005 [2004]: 184). In modo quasi paradossale, nella genealogia
1. Capitale sociale e salute
43
foucaltiana, il capitale umano diviene “una specie di reddito”
che accompagna le trasformazioni della persona, essendo sostanzialmente indissociabile dall’individuo considerato come
portatore di una competenza-macchina-flusso.
I meccanismi di formazione, incorporazione e distribuzione della competenza-macchina-flusso possono essere affrontati
distinguendo i processi costituitivi del capitale umano relativamente (a) alle sue parti acquisite, in primo luogo la formazione
e la competenza culturale, e (b) alle sue parti innate, cioè dipendenti da caratteristiche biologiche e da eredità genetiche.
(a) Sulle parti acquisite del capitale umano. Per quanto concerne
i caratteri acquisiti, un ambito strategico è costituito dai percorsi educativi volti a formare quella competenza-macchina-flusso, di cui parlava Foucault, necessaria a produrre un reddito.
In questo campo la nozione di capitale sociale, mostratasi di
particolare interesse per i sociologi dei sistemi educativi come
Bourdieu e Coleman, ha la peculiare caratteristica di concentrarsi su quella qualità creata fra le persone (il capitale sociale
inteso come conoscere le persone giuste nel posto giusto), che
completa i tratti culturali incorporati nelle persone attraverso
l’educazione e lo sviluppo di attitudini individuali. Il capitale
sociale diventa, in altre parole, uno degli caratteri costitutivi del
capitale culturale incorporato nel corso della vita.
È possibile oggi ricostruire gli usi variabili di questo “capitale culturale incorporato” nelle attuali trasformazioni del capitalismo cognitivo. Jean e John Comaroff sono recentemente
tornati a riflettere sull’argomento, in un libro dove evidenziano
le conseguenze della cessione di sovranità alle corporations da
parte degli stati nazionali, nei processi di patrimonializzazione culturale e di rivendicazione identitaria (Comaroff J.L. Comaroff J., 2009). Con l’instabilità dei mercati finanziari, la
crisi del debito sovrano degli stati-nazione e il rischio generalizzato d’insolvenza, la cessione di sovranità si è configurata concretamente non solo attraverso la deregolamentazione finan-
44
Massimiliano Minelli
ziaria e ma anche attraverso inviti alla “responsabilità sociale”
rivolti a soggetti economici privati, in primo luogo le imprese.
Nello specifico, la subalternità degli stati rispetto al mercato ha
assunto una conformazione peculiare attraverso la combinazione di legislazione leggera (soft law) e di responsabilità sociale dell’impresa (corporate social responsibility). Il “sociale”
è divenuto così un campo economico ove può trovare spazio
l’investimento privato, mentre le principali funzioni pubbliche
sono soggette a rinegoziazioni fra gli stati e i più grandi settori
imprenditoriali multinazionali. In questa dinamica strutturale
trans-nazionale, secondo i Comaroff, le competenze specifiche
dell’impresa sociale entrerebbero in contatto con il volontarismo neoliberale inscritto negli «agenti umani che possiedono e
commercializzano le loro abilità, le loro eredità, il loro capitale
incorporato» (Comaroff J.L. - Comaroff J., 2009: 130). Nel
quadro internazionale, il lavoro sociale e l’intervento umanitario tenderebbero così a combinarsi, attingendo alla dimensione incorporata del capitale umano, soprattutto nella gestione
delle emergenze delegata a organizzazioni non governative.
Nell’amministrazione ordinaria della questione sociale, d’altro
canto, il pubblico, chiamato localmente a governare il meno
possibile, si appoggerebbe piuttosto a un diffuso auto-controllo professionale e a una “sorveglianza caritatevole” incorporate
nelle relazioni di cura. Questo è quanto ha cercato di mostrare Andrea Muehlebach in una ricerca etnografica sul welfare
di Regione Lombardia, evidenziando come utopie di destra e
solidarietà della vecchia sinistra si combinano in un “unico ordine morale” (Muehlebach A., 2011). Nella sua analisi, il lavoro del privato sociale tenderebbe e a svilupparsi dentro le
negoziazioni in atto fra stato e mercato dei servizi, accompagnando almeno formalmente lo spostamento di responsabilità
del lavoro di cura: dalle donne, viste riduttivamente come le
tradizionali responsabili dello spazio domestico e familiare, ai
pensionati e ai giovani disoccupati (la cosiddetta popolazione
1. Capitale sociale e salute
45
passiva) da impiegare nel terzo settore13. La tesi di Muehlebach
è che un’anomala sfera pubblica – basata sulla condivisione
della sofferenza e dei doveri – si sostituisce così a quella dei
diritti universali, mentre le ineguaglianze, anziché essere superate, diventano strumento per far funzionare lo scambio sociale.
Il lavoro, a basso costo o non retribuito, fondato sui “buoni
sentimenti” (fiducia, reciprocità, generosità) diviene essenziale
garante di un contratto sociale per una società sostanzialmente
disarticolata. In modo pervasivo e quasi impercettibile, il lavoro
di cura non salariato, insieme al capitale culturale incorporato
su cui si fonda, diviene «atto esemplare di cittadinanza» ed «è la
partecipazione non retribuita dei cittadini in azioni volontarie
affettive a essere considerata la chiave per la stabilità sociale»
(Muehlebach A., 2011: 67). Robert Castel ha offerto il quadro
di riferimento generale in cui collocare questi nuovi modi di
contrattazione e di trattamento localizzato dei problemi, che
hanno operato una complessiva “metamorfosi della questione
sociale” (Castel R., 1995). In un processo di frammentazione
dei rapporti sociali, che investe massicciamente l’articolazione
dei collettivi, il consumo di prestazioni e servizi individualizza i
percorsi dei cittadini, anche se ne unifica i destini proprio perché è condizione di socialità diffusa e standardizzante (Castel
R., 1995: 757).
(b) Sulle parti innate del capitale umano. Come si è detto, il capitale umano è il risultato di una combinazione di abilità acquisite
e caratteri biologici innati. Ne consegue che se, per certi versi,
il capitale sociale può essere considerato come una delle parti
acquisite del capitale umano, per altri esso non dovrebbe essere separato dal resto delle componenti innate, giacché – come
aveva intuito Foucault – con lo sviluppo della ricerca e della
13. Sulla situazione del terzo settore in Italia si può vedere Cartocci R.
- Maconi F. curatori, 2006. Questo settore del lavoro immateriale, con alto
contenuto cognitivo e affettivo, è caratterizzato da specifici usi del capitale
umano nella sfera pubblica.
46
Massimiliano Minelli
industria biomedica il materiale biologico è destinato a divenire uno dei principali oggetti di contesa e di sviluppo di nuove
forme di socialità.
Oggi è sempre più evidente il modo in cui la capitalizzazione
del bios nelle reti tecno-scientifiche e finanziare transnazionali
definisce un’area intermedia fra vita umana, bioscienze e socialità. In questo ambito problematico, si profilano gli scenari
contemporanei in cui i ricercatori sociali studiano le contese
attorno al bio-capitale e alle forme emergenti del sociale. Qui
Paul Rabinow ha individuato la biosocialità che si sviluppa, ad
esempio, quando un gruppo di utenti e familiari definiti attraverso lo screening genetico come portatori di una malattia, si
riuniscono per scambiare esperienze, fare lobby, programmare
l’educazione dei figli, trasformare gli spazi abitativi e le scelte di
vita (Rabinow P., 1996: 102). Si tratta di relazioni e attività di
persone concrete che spesso oltrepassano confini e violano interdetti, soprattutto quando sono personalmente impegnate ad
affrontare la malattia e la sofferenza. È infatti negli itinerari terapeutici dei pazienti che si possono scorgere da un lato i punti
di accesso alle contraddizioni celate nella prassi burocratizzata
dei servizi, dall’altro i canali di comunicazione (spesso custoditi
da relazioni informali caratterizzate da una certa “riservatezza”)
tra sfere mantenute normativamente separate e distinte nella
biomedicina. In tale direzione, gli antropologi che si occupano
di malattia sono chiamati a interrogare oggetti, pratiche e discorsi, nella loro sfaccettata conformazione relazionale, lungo
una linea di “contaminazione” quotidiana tra biologico e sociale.
9. Bioeconomia e biocapitali
Nell’aumento degli investimenti alla ricerca sulle biotecnologie
e la genomica, è oggi possibile scorgere un nuovo terreno di
contese e di affermazioni politiche costituito dalla bio-economia, da intendere come un dispositivo di “capitalizzazione della
1. Capitale sociale e salute
47
vitalità” (Sunder R.K., 2006). Tale processo si lega ad una nuova concentrazione di risorse nella ricerca sulla vita. Com’è noto
la medicina e la biologia, in particolare nella fase dello sviluppo
della ricerca molecolare, richiedono alti investimenti di capitale
di rischio privato, affinché la riconfigurazione complessiva delle
attività economiche possa catturare «il valore latente nei processi biologici e nelle bio-risorse rinnovabili» (Rose N., 2008
[2007]: 47). Gli esseri umani, come mostra nelle sue indagini
Nicolas Rose, sono così soggetti a un rimodellamento della loro
più intima natura, all’interno di una “economia politica della
vita” basata sul valore estratto dalle proprietà dei processi viventi (Rose N., 2008 [2007]: 46). In questi casi si parla prevalentemente di bio-capitali.
Negli ultimi due decenni, si è potuto vedere come il riconoscimento e la manipolazione del corredo genetico costituiscano
un ambito cruciale dell’intervento sulla parte innata del capitale
umano. Gli studi sociali e storici delle bio-scienze hanno evidenziato, nel settore della procreazione assistita, nuove costanti
interazioni fra componenti genetiche della valorizzazione nello
scambio di mercato e proliferazione di network tecno-politici
(Franklin S., 2006). Nell’ambito degli science studies, molteplici ricerche hanno reso disponibili nuove descrizioni e interpretazioni che mettono in gioco oggetti di natura mista (ibridi
e cyborgs), fabbricati in reti operative, collettive e discorsive
attraverso la circolazione di materiali genetici e biologici (Ong
A. - Collier S.J., 2005). La tecnologia necessaria a gestire e
a far circolare informazione proveniente dagli esseri viventi è
molto costosa e occupa un posto strategico nella realtà politicoeconomica costruita sulla genetica.
I processi storici co-implicati e le interazioni fra assetti istituzionali e produzione di conoscenza biomedica sono particolarmente complessi. Un esempio di tale complessità è offerto
dal dettagliato resoconto che Andrew Lakoff ha fatto della
collaborazione, iniziata nel 1997, fra la Genset-genomics e il
Dipartimento di psicopatologia di un ospedale pubblico di
Buenos Aires, finalizzata alla raccolta e alla mappatura del Dna
48
Massimiliano Minelli
proveniente da pazienti affetti da disturbo bipolare (Lakoff
A., 2005). L’ipotesi della Genset era che markers di variazione
genetica potessero essere statisticamente correlabili con un’alta
vulnerabilità al disturbo bipolare. La ricostruzione di Lakoff
su quanto è avvenuto negli anni seguenti mostra che sono indispensabili tecnologie, classificazioni e istituzioni per stabilizzare
gli elementi circolanti nella rete fatta di sperimentazione, brevetti e commercializzazione di sequenze genetiche. La sua analisi evidenzia inoltre come tutto il circuito di interazioni poggi
sulla ridefinizione di alcune dinamiche sociali – di cui svaniscono le tracce ai livelli più astratti degli scambi –, in particolare sulla comunicazione e sulla plasmazione dell’esperienza del
malato, nell’incontro clinico fra psichiatra e paziente. Queste
interazioni – nel vivo della pratica quotidiana delle bioscienze, tra esami diagnostici, prelievi e ricerche epidemiologiche –
sono sempre irriducibilmente locali. Ciò accade anche se, alla
fine di un processo di produzione medica e clinica, le risorse
in gioco sono rese fluide, marcate e scambiabili in un mercato
globalizzato, nel quale circolano informazioni sul Dna di intere
popolazioni stoccate e gestite per mezzo di archivi informatici.
Un mercato dove «la validità apparentemente universale della
conoscenza biomedica deve essere forgiata, materialmente e discorsivamente, per mezzo della standardizzazione della pratica,
attraverso molteplici domini» (Lakoff A., 2005: 20).
“Liquidità” è il termine che Lakoff riprende dal lessico della
finanza per analizzare la costruzione delle “illness populations”
al fine di far circolare informazioni e valore monetario sul Dna
dei pazienti. Scrive Lakoff: «per essere trasferibile – liquido –
un asset deve perdere la sua specificità e località. Il processo di
astrazione del valore di scambio avviene attraverso una classificazione tecnica in cui la diagnosi produce equivalenza appoggiandosi su convezioni in grado di inserire nel medesimo spazio
di misurazione le storie di vita e le esperienze biografiche dei
pazienti» (Lakoff A., 2005: 21). Nel processo di reificazione
del dato statistico i partecipanti alla sperimentazione mutano
la propria presenza, al cambiare delle categorie in cui vengono
1. Capitale sociale e salute
49
di volta in volta inseriti: «il gruppo emergente diviene alternativamente una popolazione epidemiologica, un segmento di
mercato e una comunità di identità auto-attribuite» (Lakoff
A., 2005: 22).
Lo sviluppo, la gestione e l’investimento del bio-capitale
sono possibili quando aumenta la possibilità di processare cellule, tessuti e organi umani, come strumenti terapeutici e farmacologici. Perché questo accada, ovvero perché un bio-valore
venga inserito nel processo di reificazione e mercificazione, la
parte del corpo oggetto di transazioni deve perdere i tratti di
individualità, indivisibilità e riconoscibilità, negando «il continuo lavoro necessario per tenere in vita i corpi tecno-scientifici
materiali e semiotici» (Haraway D.J., 2000 [1997]: 200). Ne
discende che, entro lo scambio di mercato, il processo di valorizzazione del materiale biologico (quale parte costitutiva del
cosiddetto capitale umano) procede nella direzione opposta a
quella della valorizzazione del legame sociale (la rete relazionale riconducibile al cosiddetto capitale sociale) e «potenzialmente distrugge la possibilità umana di affiliazione quale risultato
dello scambio» (Lock M. - Nguyen V.K., 2011: 211). Esso tende inoltre a occultare il processo di produzione delle relazioni
biosociali con tutte le sue articolazioni socio-naturali fra i diversi agenti umani e non-umani co-implicati (ricercatori, pazienti,
dispositivi, macchine, embrioni, cellule vegetali…) (Latour
B., 1995 [1991]). In questa direzione, piuttosto che separare le
reti sociali da quelle delle bio-scienze e della bio-economia, è
urgente concentrare l’attenzione sulle loro attuali interconnessioni, provando a evidenziare i processi di naturalizzazione del
corpo e di reificazione dei legami umani.
10. Conclusioni
Alla fine del percorso qui proposto, si vede come il capitale
sociale circoli non come un oggetto che abbia un’autonomia
derivante da specifiche caratteristiche, ma perché si presta a es-
50
Massimiliano Minelli
sere spostato rapidamente all’interno delle tecnologie gestionali
e, ricombinato in vario modo, nella governance degli apparati
tecno-scientifici e amministrativi. Si tratta di risorse, definite
come locali e contestuali, ma fatte circolare, nell’epoca dei tagli
drastici al welfare, in reti nazionali e transnazionali di dati e
d’informazioni in cui il confine fra biologico e sociale è rinegoziato e ridefinito.
Le situazioni reali sono peraltro più complicate e interessanti di quanto generici riferimenti alla virtù civica lascino immaginare. L’osservazione diretta e intensiva porta spesso a scoprire come nella prassi quotidiana i cittadini-utenti combinino
sapientemente il piano biomedico con quello politico, mobilitando di volta in volta capitali biologici, economici, culturali e
sociali. Nelle scene concrete della pratica sociale i protagonisti
della costruzione, stabilizzazione, circolazione del capitale sociale sono “broker culturali” spesso abili nell’intervenire, oltre
che in quelli che chiameremmo, con Burt, buchi strutturali delle comunità di appartenenza, anche nello scambio istituzionale e nel dibattito pubblico. Si capisce perciò come il capitale
sociale possa essere stato rapidamente incluso nel vocabolario
dei rappresentanti di gruppi di interesse i quali hanno ben compreso come lo scambio economico e politico in cui è coinvolto
il terzo settore fosse collegato a risorse non direttamente monetizzabili ma politicamente vantaggiose14. A questo andamento
va affiancato il riconoscimento dell’autonomia degli agenti nel
campo biomedico e della loro capacità di auto-organizzazione
e partecipazione politica. La combinazione oculata di cultural
brokerage e di gestione di competenze incorporate, acquisite e
innate, del capitale umano, rappresenta un tratto caratterizzan14. Se il termine per indicare tali risorse comunitarie con un corrispettivo
economico è “capitale”, allora diviene utile inserire tale termine nei progetti
da presentare alle amministrazioni pubbliche integrando i previsti tagli alla
spesa, ne scaturisce una tessitura fine di rapporti sociali e al contempo una
concreta traduzione di reti e di forme di cooperazione in un linguaggio amministrativo. In questo modo, le organizzazioni più radicate nei territori diventano poi attori nel mercato interno delle amministrazioni pubbliche.
1. Capitale sociale e salute
51
te le strategie anche molto complesse di soggetti che investono
nel capitale sociale. Proprio in questa direzione un’etnografia
della prassi amministrativa e delle policies locali potrebbe occuparsi con un rinnovato interesse di quelle azioni che gli attori
adottano in campi di scelta limitati con differenti profili di razionalità strategica15.
Se si vuole, per così dire, prendere sul serio la metafora del
capitale si può allora provare a collocare le definizioni dei legami sociali entro networks di pratiche e strategie di valorizzazione centrate su tre aspetti: le componenti della persona umana, i
processi di scambio finanziario, la ricerca in campo biomedico.
È infatti particolarmente importante fare attenzione ai meccanismi di scambio e circolazione dei differenti capitali, per evitare l’illusione prospettica di un capitale sociale visto come risorsa indissolubilmente legata ai territori e alle cosiddette identità
locali16. A tale scopo, si dovrebbero rispettivamente: (a) distinguere i vari piani e i processi di accumulazione e distribuzione
delle risorse indissociabili dalla vita umana, (b) capire come, nei
termini di Bourdieu, un capitale si trasforma in un altro nello
specifico campo della medicina e della salute, (c) vedere infine
come il capitale sociale venga istituzionalizzato e come i vari
soggetti si riconoscano con azioni di accreditamento un titolo di
nobiltà per agire nella solidarietà e nella sussidiarietà.
Il capitale sociale appare in definitiva come un Giano bifronte (Narotzky S., 2007) e agisce come un dispositivo di governance che unifica in alto quello che spera di riconoscere nella
parte bassa della scala sociale. Il suo carattere ambivalente è
però l’esito di un peculiare processo di alienazione e feticismo,
analogo a quello subito dalla merce nell’analisi marxiana (e ripreso da Taussig all’inizio di questo testo). L’effetto del feticcio,
potere emanato dalla cosa, è infatti ottenuto attraverso la circolazione delle componenti dei capitali e le loro trasformazioni
15. Si veda Piselli F. curatore, 2001, Gribaudi M., 1996.
16. Una direzione percorsa in una curiosa “caccia la tesoro” del capitale
sociale (Cartocci R., 2007).
52
Massimiliano Minelli
continue, mostrando così un aspetto interessante del potere incantatorio che la merce esprime attraverso il suo movimento. Il
capitale sociale, alla fine di questo percorso, svela la sua natura
reificata e mostra come una parte acquisita del capitale umano
possa contenere l’arcano dei processi di produzione e accumulazione delle forme emergenti di umanità e di socialità.
Andrea Caprara
2. Contagio
1. Simpatia e analogia
Nel 1546 Girolamo Fracastoro pubblica il trattato De contagionibus et contagionis morbis et eorum curatione nel quale distingue tre forme di contagio: quella che agisce per semplice contatto, quella che opera per contatto indiretto attraverso sostanze
infettive e quella che agisce per trasmissione a distanza. Si tratta
della prima grande opera sul contagio, le cui basi concettuali
lo stesso Fracastoro spiegherà in un altro libro, De sympathia
et antipathia rerum (G. Fracastoro, 1968 [1546]). Durante il
Rinascimento, quattro elementi fondamentali costituivano l’episteme che forniva la chiave di lettura delle relazioni che si
instaurano tra elementi apparentemente diversi tra loro: convenientia, aemulatio, analogia e simpatia. Fino alla fine del XVI
secolo, avevano un ruolo chiave nell’esegesi dei testi, nell’interpretazione e nella rappresentazione del mondo (Foucault
M., 1966 [1967]). Queste quattro forme di pensiero permettevano una interpretazione dei segni dell’universo mettendo in
relazione elementi apparentemente diversi tra loro, in base a
somiglianze di colore, forma o posizione, stabilendo relazioni
tra il corpo umano, l’universo, le piante, gli animali e le cose.
Secondo Foucault, il potere della simpatia consiste nel rendere
la persona o la cosa simile a quello da cui viene colpito: «essa
può nascere da un solo contatto come ‘quelle rose di lutto di cui
ci si sarà serviti durante il funerale’, che, con la semplice vicinanza della morte, renderanno chiunque ne respiri il profumo
‘triste e moribondo’ (...) Essa altera ma nella direzione dell’i-
54
Andrea Caprara
dentico (...)»1 (cit. in Foucault M., 1966 [1967]: 38-39). La
simpatia genera movimento e, a causa dell’attrazione delle cose
tra loro, rende possibile l’esistenza del suo contrario - l’antipatia
-, che permette alle cose, agli animali e alle piante di rimanere
separati e di mantenere, opponendosi, la loro individualità.
Frazer, nel suo famoso libro Il ramo d’oro, presenta un insieme interessante di dati etnografici sulla trasmissione delle malattie tra gli esseri umani, gli animali e le piante (Frazer J., 1973
[1911-15]). Gli esempi che l’Autore considera, sia nel contesto
europeo che in altre aree culturali, indicano la presenza di simboli, segni ed elementi naturali che sono direttamente legati alla
trasmissione della malattia e che mutano secondo il contesto
culturale preso in considerazione.
Frazer segnala, ad esempio, l’esistenza di una pratica, diffusa
nello Cheshire, e riguardante la maniera di curare le verruche:
bisognava sfregare le verruche con un pezzetto di lardo, fare
una piccola incisione nella scorza di un frassino ed inserirvi il
pezzetto di lardo. Le verruche sarebbero scomparse mentre
l’albero si sarebbe coperto via via di nodosità. Il passaggio della
malattia si compiva tra gli esseri umani e il mondo vegetale attraverso l’analogia, la somiglianza tra la forma delle verruche e
le nodosità dell’albero.
Sono numerosi gli esempi che si riferiscono a forme di collegamento tra elementi naturali e simbolici. In particolare, in
caso di malattia, il suo passaggio da un individuo malato ad un
individuo sano può produrre la guarigione dell’individuo malato portando alla rovina dell’altro. Il meccanismo non funziona
soltanto tra persone ma anche tra gli esseri umani e gli animali,
le piante ed alcune figure simboliche.
Il contatto tra due realtà, pianta, animale o essere umano,
si stabilisce intorno ad un elemento mediatore. Questo schema presenta anche un’altra particolarità: il meccanismo di trasmissione si realizza soltanto nel contesto ove esista una precisa
1. Tutte le citazioni in lingua straniera sono state tradotte dall’autore, ove
non altrimenti indicato.
2. Contagio
55
relazione tra colui che trasmette la malattia e quello che ne è
colpito.
Uno dei più importanti contributi di Frazer è costituito dal
fatto che egli ha definito i due principi associativi che spiegherebbero il pensiero magico: il principio di analogia o di rassomiglianza e il principio di contagio o di contiguità (Tambiah
S. J., 1990 [1993]). Frazer ha suddiviso i principi sui quali si
fondano i sistemi magici in due principali categorie: la magia
simpatica e la magia contagiosa anche se, secondo Tambiah, era
cosciente che, in pratica, c’era un parziale accavallamento dei
due (Tambiah S.J., 1990 [1993]). Questi due principi sono stati
considerati da Frazer come le caratteristiche fondamentali del
pensiero magico. Frazer ha cercato anche di identificare gli elementi di base del pensiero magico e del pensiero razionale e di
porli in una prospettiva storica. In maniera tipica degli schemi
evoluzionisti e lineari, egli considera che il pensiero magico preceda il pensiero religioso che, a sua volta, è spodestato dall’affermazione del pensiero scientifico. Sul piano storico, queste
tre forme di pensiero si susseguirebbero una dopo l’altra.
Il tentativo di Frazer di definire e separare gli elementi del
pensiero magico da quelli del pensiero razionale ha subito gli
attacchi di numerose critiche, una delle più dure tra queste è
stata quella di Wittgenstein. All’opposto di Frazer, Wittgenstein
cerca di mostrare come, in realtà, elementi del pensiero magico
appartengano a tutte le società umane e come degli esseri detti
“civilizzati” siano, nella loro costituzione logica e culturale, simili ai popoli “selvaggi” (Wittgenstein L., 1975 [1967]).
Nelle sue note critiche al Ramo d’oro, Wittgenstein si richiama ad una forma di pensiero comune a tutti gli esseri umani
e che associa continuamente la ragione e l’immaginario. Una
tale forma di pensiero è caratterizzata da strutture di simbolizzazione che erano familiari a Saussure e agli Strutturalisti, la
metafora e la metonimia, e che Wittgenstein considerava come
arbitrarie e convenzionali ma anche cariche di senso e razionali.
Nel pensiero umano qualunque cosa può essere scelta e mantenuta per rappresentarne un’altra, anche entità diverse possono
56
Andrea Caprara
essere utilizzate per rappresentare una unica e medesima cosa
(Tambiah S.J., 1990 [1993]). Per Wittgenstein quindi, l’uomo
“civilizzato” ha la stessa tendenza a simbolizzare e ritualizzare
dell’uomo primitivo. Questo sforzo per identificare certe forme
universali di pensiero è tuttavia accompagnato dalla consapevolezza della diversità di culture complesse che si sono formate
storicamente. In particolare, Wittgenstein sottolinea l’impossibilità di paragonare quello che non è paragonabile, come fanno,
ad esempio, coloro che traducono le rappresentazioni di certi
popoli nelle categorie del pensiero occidentale.
Il pensiero analogico rimane in ogni caso il modello esplicativo fondamentale che permette di comprendere e di interpretare la trasmissione della malattia in numerose società. È
questa una delle più importanti conclusioni di un articolo di
Perrin sulla nozione di contagio presso i Guajiro (Perrin M.,
1985). Questo autore introduce un altro concetto analitico che
mi sembra importante per spiegare la trasmissione della malattia: si tratta del concetto di contaminazione. Due particolari caratteristiche la differenziano dal contagio: per prima cosa
il suo stretto legame con il concetto di impurità e, in seguito,
la sua diffusione generalizzata a partire da un agente infettivo che può essere un animale o un oggetto. L’Autore ricorda
che i Guajiro distinguono principalmente tre tipi di malattie
trasmesse per contaminazione: quelle che provengono da un
animale, quelle provocate dal contatto con le ossa di un uomo
morto e, infine, quelle provocate dal corpo di un uomo morto
assassinato. Nel caso degli animali bisogna notare che soltanto
alcuni di essi hanno il potere di contaminare gli uomini, in particolare i bambini. Una parte di «questi animali contaminano
perché mangiano i raccolti oppure resti di cibo» (ibidem: 105).
Per curare un bambino contaminato è quindi necessario uccidere l’animale ed incorporarlo simbolicamente nel corpo del
bambino per bocca o per inalazione. L’animale vivo provoca
la malattia, morto permette la cura del bambino malato. Altri
animali possono provocare la malattia semplicemente perché
la forma o il colore dell’animale è simile ad uno o all’altro dei
2. Contagio
57
sintomi della malattia medesima. Le differenze interpretative
che variano secondo i contesti culturali specifici (contesti diversi prendono in considerazione animali diversi) testimoniano
tuttavia la presenza di una matrice globale comune che si basa
soprattutto sull’associazione analogica.
2. Empirismo e associazioni metaforiche
Sarebbe un errore però ritenere che il pensiero ed i comportamenti riguardanti il contagio in diverse culture, sia basato sul
solo pensiero analogico (Caprara A., 2001). Questo costituisce
incontestabilmente una componente importante del pensiero
umano presso tutti i popoli, ma l’osservazione dei fatti e l’empirismo giocano ovunque un ruolo senza dubbio altrettanto fondamentale. Talvolta le associazioni metaforiche svolgono una
funzione puramente convenzionale, mentre invece è l’osservazione minuziosa della realtà che permette di dare un senso agli
avvenimenti. Osservazione ed empirismo permettono, in molti
casi, di precisare le cause di malattia. La presenza di due persone con la stessa sintomatologia, dopo che vi sia stato contatto
tra di loro, porta a considerare contagiosa la malattia poiché si
è trasmessa dall’una all’altra. Le epidemie hanno sicuramente
costituito un terreno di osservazione capitale per stabilire certe
interpretazioni relativamente alle cause delle malattie, ma il fatto che una parte soltanto e non tutte le persone siano colpite da
una malattia durante il contagio ha creato dovunque un limite
all’utilizzazione del concetto di trasmissione. Per quanto riguarda, ad esempio, la storia europea e più particolarmente italiana
del XVII secolo, Cipolla ha studiato il caso di un medico di
Prato durante una epidemia di tifo, il quale affermava che non
c’erano prove evidenti del contagio perché nessuno, tra gli altri malati e gli infermieri dell’ospedale, aveva mostrato sintomi
della malattia nonostante frequenti contatti coi malati che soffrivano di tifo (Cipolla C. M., 1989). La questione dell’osservazione diretta e dell’esperienza concreta porta ad interrogarci
58
Andrea Caprara
sulla funzione del sapere empirico nella costruzione dei sistemi
di sapere e di significato.
Gilles Bibeau, nel suo saggio Entre sens et sens commun, ci
invita a riflettere sulle componenti metaforiche e sperimentaliste
del pensiero umano (Bibeau G., 1992). Egli sottolinea che si tratta di articolare il sapere e il significato: «La ricerca del significato
e l’attribuzione di senso costituiscono il percorso fondamentale
che caratterizza le culture umane, percorso che inscrive il senso
fino nel cuore delle classificazioni e della messa in ordine empirica del mondo operata dal senso comune» (Bibeau G., 1992:
89). Bibeau riafferma il ruolo chiave che l’esperienza comune
svolge nella costruzione di ogni sapere: il senso comune presenta
un carattere pratico e coincide largamente con quel che si traduce generalmente nei termini di saggezza popolare. Una prima
esperienza del mondo permette a tutti gli esseri umani che sono
dotati degli stessi organi di percezione2 di concepire ad un livello
elementare il reale, ad esempio sulla base dei tratti esteriori delle
piante e degli animali, ad un secondo livello essi costruiscono le
categorie e le classificazioni in riferimento ai loro valori e sistemi
di rappresentazione. Bibeau riassume così la sua prospettiva: «La
costruzione culturale della realtà nei gruppi umani ed anche la
loro teoria del significato possono essere comprese appieno soltanto se l’antropologo procede, nelle sue analisi, ad una doppia
lettura complementare dei codici culturali: da un lato quella che
è più vicina ad una interpretazione centrata sulle produzioni del
“senso comune” e delle “percezioni sensoriali”, dall’altro quella
ispirata dall’antropologia interpretativa alla maniera di Geertz,
Tambiah o dei semiologi post-saussuriani che tendono a scoprire
il senso dei codici di secondo livello. Ogni lavoro antropologico
implica dunque il ricorso ad una doppia ermeneutica capace di
rendere al tempo stesso il senso comune e il sistema di segni la
cui congiunzione genera la struttura del senso originale di ogni
cultura» (Bibeau G., 1988: 26).
3. Contagio, trasgressione ed esclusione sociale
2. A questo riguardo vedi i lavori di Atran (Atran S., 1986).
2. Contagio
59
Una componente che si potrebbe definire universale nell’interpretazione della malattia considera quest’ultima come il
prodotto di una trasgressione, come una infrazione a certe regole o leggi precise stabilite dalla società (Héritier-Augé F.,
1992). La trasgressione può essere di tipo religioso e provoca
una malattia considerata come una punizione divina, oppure
di tipo sociale attraverso l’infrazione di regole comuni, come,
ad esempio, la rottura del legame con gli antenati. All’inizio vi
è una trasgressione, un errore dell’individuo o del gruppo nei
confronti di una norma collettiva. Perfino oggi, nella società
occidentale, che sempre più è retta dalle scoperte scientifiche,
spesso la malattia è ancora considerata il risultato della infrazione a certe regole sociali, che variano da una comunità all’altra e
secondo epoca e luogo (Ruffié J. - Sournia J.C., 1985 [1984]).
Il consumo di alcool, di tabacco, vengono appunto considerati
come inosservanze alle regole definite di prevenzione e possono
indurre l’apparizione di diverse patologie. Nella nostra società
si sarebbe colpiti dall’Aids perché alcune persone andrebbero
contro regole sociali e morali. È tuttavia necessario aggiungere
che all’interno di questo paradigma il caso e la probabilità svolgono un ruolo molto importante, perché inscrivono il futuro
del malato nell’imprevedibile.
Ogni malattia trasmissibile si comprende soltanto se inserita in un tessuto sociale, poiché essa mette in causa i rapporti
dinamici esistenti tra gli individui di un gruppo. Il rischio di
contagio e i meccanismi attraverso i quali si effettua la trasmissione contribuiscono alla costruzione sociale della malattia e
provocano, inevitabilmente, comportamenti che tendono a separare il malato dalla società attraverso il rifiuto o l’isolamento3.
Alcune malattie, ad esempio, come la lebbra, la tubercolosi o
l’Aids conferiscono subito al malato uno stigma che influenza
i suoi rapporti con la società: generalmente è la percezione del
rischio che genera accettazione o rifiuto, anche nel caso in cui
3. Vedi a questo proposito il volume curato in Francia da un gruppo di
storici della medicina (Bardet J.P. et al., (curatori), 1988).
60
Andrea Caprara
l’esatta identificazione del rischio, come per la lebbra, rimanga
relativamente imprecisa (Volinn I.J., 1989). L’indeterminatezza
o l’ambiguità che contribuiscono alla definizione dello stigma associato alla malattia sono state descritte molto bene da
Erwin Goffman (Goffman E., 1983 [1963]). Prendiamo, a titolo d’esempio, il caso descritto da Dennis Mull che tratta della
verifica di un programma di controllo della lebbra in Pakistan
(Mull D., 1989): il trenta per cento dei pazienti in cura aveva
abbandonato il programma, la motivazione principale di questo
abbandono era il fatto che essi negavano la malattia. La ricerca
ha rivelato che la paura di essere esclusi dalla società o di perdere il loro lavoro o ancora l’impossibilità di sposarsi li aveva
spinti a negare la loro malattia.
I numerosi casi di esclusione dei lebbrosi costituiscono altrettanti esempi probanti in diversi contesti culturali.
Effettivamente le interpretazioni religiose di questa malattia,
che è tipicamente identificata come una punizione divina, ne
fanno ancor più delle altre una vera malattia-stigma. Questi
esempi mostrano quanto sia importante lo studio della percezione che i malati hanno della propria malattia, come vi si adattino o cerchino forme di “destigmatizzazione”.
Le rappresentazioni sociali delle malattie incorporano i valori ed i giudizi di una collettività e traducono i rapporti degli individui tra loro e al tempo stesso di questi con la società.
L’analisi culturale e storica di significati, immagini, metafore
costruite a partire dalle malattie, in particolare la tubercolosi
o il cancro, ci permetterà di risalire ai valori, ai simboli e alle
regole della società.
Susan Sontag ha reso popolare negli anni Settanta una prospettiva importante nell’analisi della malattia, quella che la considera come una metafora (Sontag S., 1979 [1977]). Il malato
e la malattia permettono di leggere indirettamente la società e
il posto che vi occupa l’individuo: così, ad esempio, la reazione
di una popolazione di fronte ad una malattia può essere vista
come un atto di difesa che si esprime attraverso l’esclusione
della persona malata. Questo rifiuto, questa esclusione manife-
2. Contagio
61
stano pubblicamente una più fondamentale interruzione della
comunicazione per mezzo della distanza fisica, visiva, spaziale
e verbale. Tali reazioni, secondo Sontag, sarebbero il risultato
di interpretazioni multiple della malattia che sono cariche di
contenuti e significati morali.
Sontag si è opposta a queste interpretazioni cercando di
smascherarne il senso nascosto e invitando gli individui a liberarsene. Soltanto la scienza medica, più chiara e precisa, potrebbe, secondo lei, aiutarci a liberarci di queste strutture simboliche che si sono messe in atto intorno alla malattia. Ma ci si
può realmente liberare di questo immaginario collettivo che si
è storicamente costruito? È vero poi che la medicina potrebbe liberarcene? Non ha invece contribuito anch’essa alla loro
elaborazione? Se alcune scoperte scientifiche hanno indubbiamente contribuito a chiarire alcuni aspetti del campo eziologico
e nosografico, resta pur vero che una parte consistente della
medicina continua ad essere rituale e “religiosa” e mantiene
vive numerose metafore.
È necessario includere l’esperienza della malattia intesa
come illness4 nel processo di diagnosi e nella presa di decisioni.
Parallelamente, tuttavia, è necessario combattere, come sottolinea Sontag, l’aspetto più pernicioso della malattia, quello legato
alla sua trasmissione nella misura in cui quest’ultima genera la
tendenza ad escludere il malato dalla società, processo che è
stato ritualizzato con la comparsa dell’Aids.
In effetti, le società “tradizionali” definiscono le malattie
contagiose in opposizione alle malattie non contagiose per mezzo di criteri eziologici molto diversi da quelli individuati nel
paradigma occidentale. Tali criteri rinviano non soltanto ad un
asse causale, ma anche ad altri codici, simbolico, corporeo e
sintomatologico che formano modelli di tipo multi-assiale (G.
4. Mi riferisco in particolare ai concetti di disease e illness e elaborati
da Eisenberg (Eisenberg L., 1977) e al modello esplicativo di A. Kleinman
(Kleinman A., 1980). In questa prospettiva per illness si intende la malattia
percepita e vissuta dal malato.
62
Andrea Caprara
Bibeau, 1981). Un esempio fornito da Morton Beiser fa un po’
di luce su questa questione. I Sérère del Senegal distinguono
due forme di crisi epilettica: la prima è chiamata Dof e non è
considerata contagiosa mentre l’altra, M-Befedin, anche se presenta la stessa sintomatologia, è invece considerata contagiosa.
La differenza è dovuta alla presenza, nel secondo caso, di saliva
nella bocca del malato durante la crisi (Beiser M., 1985). La saliva nella bocca acquista in questo caso un valore simbolico che
permette di definire la contagiosità della malattia e di cambiare
il quadro concettuale di riferimento. Questo esempio mostra
bene come un approccio interpretativo permetta di comprendere i codici che differenziano una malattia trasmissibile da
quelle che non lo sono: sarà infatti un’analisi del ruolo simbolico della saliva, del suo valore in quanto segno e del suo rapporto
con altri codici culturali (concezioni del corpo, dell’ambiente,
rapporto tra i sessi, esistenza di regole sociali ecc.) che aiuterà
a capire come una malattia assuma tutto il suo significato sul
piano concettuale e pratico.
Lo studio delle concezioni e delle pratiche relative alla trasmissione costringe il ricercatore a compiere, in una prospettiva
sociologica, una analisi dei processi di interazione tra gli individui. Questa attenzione al sociale permette di cogliere le vie di
passaggio di “qualcosa” da un individuo ad un altro o, eventualmente, molti altri. La configurazione dello spazio abitato
(il villaggio, la disposizione delle case, le vie di comunicazione,
eccetera) e l’organizzazione sociale (la vita familiare e comunitaria, la gerarchia sociale, le regole) delimitano un primo campo
d’analisi. Inoltre è necessario considerare, sul piano cognitivo
questa volta, le concezioni del corpo, della vita e della morte e il
loro ruolo in relazione all’interazione tra gli individui.
4. Ordine e disordine, puro e impuro
Il tema centrale intorno a cui si organizza l’insieme di regole e di
proibizioni fa riferimento al rapporto tra puro e impuro. Mary
2. Contagio
63
Douglas ha mostrato che le nozioni di contaminazione e di ordine acquistano realmente significato soltanto se le si considera
nel loro rapporto con una specifica organizzazione della realtà
sociale umana (Douglas M., 1981 [1966]). È possibile parlare
di proibizioni soltanto situandole in una classificazione fondamentale, primaria, più o meno esplicita e sempre legata all’ordine sociale. Ponendosi nella linea di pensiero di Durkheim
e dell’antropologia funzionalista inglese - Radcliffe-Brown e
Evans-Pritchard soprattutto - Douglas ha corretto e completato
le tesi di Frazer e di Tylor: «la sporcizia - scrive l’Autrice - è essenzialmente disordine (...) e i riti di purezza e impurità danno
una certa unità alla nostra esperienza» (1981: 24).
Douglas ha potuto dimostrare perché la cultura occidentale
e quelle tradizionali hanno ognuna una loro concezione della
sporcizia: nella cultura occidentale, le nozioni di igiene si basano sulla teoria dei germi, nelle società tradizionali invece «la
sporcizia non è mai un fenomeno unico ed isolato: dove vi è
sporcizia vi è un sistema. La sporcizia è il sottoprodotto di una
organizzazione e di una classificazione della materia [...] di una
sistemazione dell’universo» (1981: 55).
In un’altra opera che dialoga soprattutto con i lavori di
Durkheim e Mauss, Douglas indica come i sistemi simbolici
si strutturino a partire dalle concezioni del corpo, che sono a
loro volta in stretto rapporto con le regole sociali (Douglas M.,
1979 [1970]), cosa che la porta a identificare delle corrispondenze tra il sistema simbolico ed il sistema sociale. In questo
modo trasforma l’organismo umano in un sistema analogo al
sistema sociale, come in un gioco di specchi che si ritroverebbe
in numerose società del mondo. Effettivamente il corpo umano
fornisce, secondo Douglas, un sistema naturale di simboli che
si inscrivono nell’organizzazione sociale e fanno del corpo una
specie di codificatore primordiale ed universale. Poiché ogni
simbolo acquista il suo significato soltanto attraverso la relazione che si stabilisce con altri simboli, il senso non può essere ricavato che prendendo gli elementi uno ad uno, indipendentemente dalla struttura d’insieme. Ogni sistema simbolico
64
Andrea Caprara
è prigioniero del suo contesto, delle regole autonome che lo
controllano ed è quindi necessariamente specifico di ogni gruppo umano. Douglas tuttavia non rinuncia ad enucleare alcune
generalità ed alcuni modelli che sarebbero comuni a molte società e, in questo contesto, distingue quattro sistemi di simboli
naturali: nel primo, il corpo è concepito come un organo di
comunicazione, nel secondo, il corpo è visto come un veicolo
della vita che mantiene la sua efficacia attraverso la qualità degli
alimenti che gli sono forniti. Nel terzo, il corpo è considerato
sul piano pragmatico, concentrandosi principalmente sugli orifizi, i fenomeni di eliminazione e le escrezioni. Nel quarto, la
vita è considerata nella sua forma spirituale e il corpo assume
significati negativi perché legato alla vita sociale (Douglas M.,
1979 [1970]).
Quel che interessa Douglas nella questione delle categorie
delle malattie contagiose e nel loro rapporto con la nozione di
contaminazione, è il fatto che quest’ultima sia retta da regole
che sono inerenti alla struttura delle idee e non a forme di potere (Douglas M., 1981 [1966]). Ci si trova nell’ordine della
trasgressione di regole sancite dalla comunità e non a livello di
pratiche di stregoneria. Così se si esaminano, in una prospettiva
strutturalista, le categorie di pensiero di un determinato gruppo, si scopre che la sporcizia coincide spesso con il disordine e
la pulizia con l’ordine.
5. Prospettive recenti sul contagio
Negli ultimi decenni, sul piano medico, sociale e culturale, il
problema del contagio5 è stato al centro di interesse di numerosi studi in ambito antropologico essendo al centro di tutta una
serie di attività di prevenzione e di controllo della malattia sia
5. Utilizzo i concetti di contagio e di trasmissibilità della malattia come
sinonimi, anche se, in una parte della letteratura biomedica e socio-antropologica, vengono presentati in forma distinta tra loro.
2. Contagio
65
nella società occidentale che in quelle tradizionali.
La maggior parte degli studi pubblicati sulle malattie contagiose nelle società altre hanno affrontato questo tema a partire da diverse prospettive: la storia sociale (Dawson M., 1979,
Janzen J., 1978, Ford J., 1979, Turshen M., 1977, M’Bokolo
E., 1986 [1984], Feierman S.- Janzen J. M. (curatore), 1992,
Swanson M., 1977, Lyons M., 1985, Darmon P., 1986), l’ecologia medica (Wiesenfeld S., 1967, Hughes C.- Hunter J., 1970),
la storia delle malattie e delle pratiche di igiene (Ackerknecht
E.H, 1965, Patterson D.K., 1984, Vigarello G., 1985, Sigerist
H., 1933, Salomon-Bayet C., 1986). Per quanto riguarda gli
studi di natura antropologica, questi hanno soprattutto cercato di riflettere sul problema del contagio all’interno di una
comunità, focalizzando l’attenzione principalmente sulle interpretazioni e pratiche collettive, sia di natura preventiva che terapeutica adottate all’interno del gruppo. Ricordiamo al riguardo i lavori di Michel Perrin (Perrin M., 1985), di Marguerite
Dupire (Dupire M., 1985), di Gilles Bibeau (Bibeau G.,1996),
di Roberto Lionetti (Lionetti R., 1994), di Doris Bonnet e
Yannick Jaffré (Bonnet D.- Jaffré Y. (curatori), 2003). Va inoltre sottolineato un capitolo del libro di Marc Nichter (Nichter
M., 1989), un volume di Dina Czeresnia (Czeresnia D., 1997)
e due lavori di Sylvie Fainzang (Fainzang S., 1986, 1996). Altri
lavori in campo antropologico riguardano lo studio di singole
malattie controllabili con le immunizzazioni (Heggenhoughen
H.K. - Clements J., 1987, Nichter M., 1990), le diarree (Coreil
J. - Mull J.D. (curatori), 1988, Kendall C., 1989), le malattie
respiratorie acute (Pelto G.H., 1997), la tubercolosi (Nichter
M., 1994, Liefooghe R. et al., 1995), l’Aids (innumerevoli sono
gli studi di carattere antropologico che riguardano l’Aids e sarebbe impossibile menzionarli in modo esaustivo in questo lavoro), la malaria (Brown P.J., 1983, Manderson L., 1997), la
lebbra (Volinn I.J., 1989, Justice J., 1997). La maggior parte
di questi studi possono essere inseriti in quel filone di ricerca di
antropologia medica applicata a programmi di sanità internazionale (Coreil J.- Mull J.D. (curatori), 1990).
66
Andrea Caprara
Se i modelli epidemiologici di diffusione delle malattie contagiose sono abbastanza ben conosciuti, sono gli aspetti socioculturali che rimangono in gran parte oscuri. Un approccio orientato
etnograficamente deve porsi l’obiettivo di studiare le conoscenze
e le pratiche relative alle malattie trasmissibili a partire da interpretazioni elaborate da ogni singola comunità a proposito della
trasmissione della malattia. Questa prospettiva permette di superare il semplice adattamento dei programmi sanitari in un determinato contesto culturale a profitto di una reale calibrazione
nei processi cognitivi e nel tessuto comunitario della popolazione
(Seppilli T., 1996). Se, ad esempio, si prendono in considerazione i programmi di medicina di base, il problema che si pone è il
seguente: come si può pretendere di modificare i comportamenti
di una popolazione riguardo alla prevenzione oppure all’igiene
quando ci si confronta con la coesistenza di diversi paradigmi
di pensiero? Questa domanda non porta a sottovalutare i determinanti sociali, ci spinge invece ad allargare il quadro di analisi e ad introdurvi una maggior complessità. Posta in termine
di intervento, la domanda iniziale potrebbe essere formulata in
questo modo: qual è, ad esempio, il significato di un programma
di costruzione di servizi igienici se, per la popolazione coinvolta,
il concetto di trasmissione oro-fecale di una malattia non esiste?
Diversi autori hanno centrato la loro riflessione sui rapporti tra la medicina occidentale e quella tradizionale all’interno di
società caratterizzate dalla presenza di una pluralità di sistemi
(Bibeau G., 1982, Janzen J.M., 1978, Kleinman A., 1978, Leslie
C., 1980, Perrin M., 1980, Young A., 1976). L’esistenza di un
pluralismo concettuale ci costringe, senza dubbio, a mettere in
evidenza non solo le regole e le permanenze, ma anche e soprattutto le contraddizioni, le incoerenze, le debolezze, che esistono
all’interno di un dato contesto culturale e sociale.
Gianfranca Ranisio
3. Corpo femminile e medicalizzazione
1. Definizione
Il processo di medicalizzazione può essere definito come l’applicazione delle conoscenze e delle tecnologie mediche ad aspetti
della vita che storicamente non erano considerati di pertinenza
medica, o meglio come un processo di sconfinamento della medicina al di là dei suoi limiti, per cui problemi non medici sono
definiti e trattati come problemi medici (Conrad P., 1992, 2007,
Colucci M., 2006). La medicalizzazione è stata analizzata sin
dagli anni Sessanta del XX secolo, dando luogo allo sviluppo di
un’ampia letteratura, che ha coinvolto vari ambiti disciplinari.
In particolare nelle scienze sociali essa è stata associata con il
processo di modernizzazione, che si è verificato nelle società
occidentali. Come è stato più volte sottolineato, perché questo
insieme di circostanze si potesse realizzare è stato necessario
che prima si determinassero le condizioni necessarie e che cioè
si imponesse a livello culturale l’accettazione della separazione
tra soma e psiche, così come si è andata affermando nel pensiero scientifico occidentale.
In una prima fase molti studiosi - tra questi forse il più noto
è Ivan Illich (1977 [1976]) - hanno sostenuto la tesi dell’imperialismo medico, considerando alla base del processo di medicalizzazione l’imposizione di un potere unilaterale, che si realizza con l’affermarsi nella società dell’egemonia delle professioni
mediche. E’ Irving Zola, all’inizio degli anni Settanta, a sostenere la tesi secondo cui la medicina stava diventando un’istituzione del controllo sociale, in parte soppiantando istituzioni come
la religione e la legge e a denunciare che molti aspetti della vita
68
Gianfranca Ranisio
quotidiana erano stati medicalizzati. Tuttavia, secondo Zola, si
trattava di un processo che non era tanto dovuto ad un conquista professionale, quanto ad una trasformazione culturale che
cercava soluzioni tecniche a problemi essenzialmente sociali
(Zola I., 1972).
Allo stato attuale l’analisi si presenta più complessa, poiché
è opinione ormai condivisa che a tale processo hanno contribuito più soggetti, tra i quali i movimenti sociali, le organizzazioni
dei pazienti, gli stessi pazienti a livello individuale e negli ultimi
decenni, in misura massiccia, l’industria farmaceutica, che ha
operato in modo da trasformare i pazienti in consumatori di
farmaci (Conrad P., 2007: 4-5). Medicalizzare significa, infatti,
creare consenso intorno alla natura oggettiva del corpo malato
e questo presuppone, a livello pragmatico, il coinvolgimento
del singolo soggetto, il quale, per lo più, accetta la medicalizzazione in quanto la considera parte e forma del diritto alla salute.
E’ stato così che bisogni di tipo sociale sono stati riconosciuti
come malattie individuali da curare.
Il corpo femminile è stato particolarmente esposto ai processi di medicalizzazione, sia per la complessità e per le caratteristiche del ciclo fisiologico e dell’apparato riproduttivo, che
fanno sì che le donne si sottopongano a più regolari controlli ed
esami nel corso della loro vita rispetto agli uomini, sia per il ruolo sociale che le donne ricoprono nelle famiglie, come tramite
con i medici e con i sistemi sanitari, ruolo che le rende più condizionate, se non più subordinate al potere medico (Riessman
C. K., 1998, Long M., 2008). Tra i processi di vita che sono stati
medicalizzati rientrano il parto, le mestruazioni, la menopausa,
il controllo delle nascite e allo stesso tempo l’infertilità. Nelle
società occidentali contemporanee la medicalizzazione tende a
condizionare momenti importanti del vissuto e a distinguere ciò
che è definito “normale”, da ciò che è invece considerato “patologico”. Le implicazioni di questo sulle donne sono notevoli, poiché riguardano soprattutto la perdita di un “sapere” che
non viene più riconosciuto, la svalorizzazione della capacità di
3. Corpo femminile e medicalizzazione
69
comprendere e intervenire, completamente delegata ai medici,
alla farmacologia e alla tecnologia, il rischio che il corpo femminile si trasformi in un luogo per interventi tecnologici e nuove
sperimentazioni. Sulla medicalizzazione del corpo femminile
esistono oggi numerosi studi, in particolare la medicalizzazione
della riproduzione è emersa come un tema centrale in antropologia medica, sia per l’attenzione che a questo hanno rivolto le
femministe, che hanno considerato la medicina come un’istituzione patriarcale, fonte di oppressione sulle donne1, sia per il
profondo impatto che la biomedicina ha avuto sulle medicine
“indigene” nelle società extraoccidentali (Ginzburg F. - Rapp
R., 1991). Molti sono stati gli studi che hanno sottolineato come
alla base della medicalizzazione della gravidanza, dell’infertilità e della procreazione vi sia innanzitutto la rappresentazione
del corpo femminile come corpo “naturalizzato” e oggettivato.
Privilegiando la riproduzione, come oggetto di analisi, si rischia
di avvalorare la naturalizzazione del corpo femminile e con essa
lo stereotipo che riduce il femminile alla riproduzione, perpetuando ed approfondendo le differenze di genere. Il processo
di medicalizzazione interessa, infatti, l’intero ciclo fisiologico
delle donne e per questo è importante analizzare il modo in cui
si è esteso alle tappe fisiologiche che contraddistinguono la loro
vita, dal menarca alla menopausa.
Alcune sociologhe recentemente hanno proposto il termine
di biomedicalizzazione, che ritengono specifichi ulteriormente i
processi complessi e multidirezionali che riguardano le trasformazioni dell’umano e del non umano. Esse sostengono che intorno al 1985 la medicalizzazione ha iniziato a cambiare nelle sue
caratteristiche, in seguito alle innovazioni tecnico-scientifiche,
che, associate a nuove forme di organizzazione sociale, hanno
1. Nel 1971 il libro Our Bodies, Ourselves [tradotto in italiano con il titolo
Noi e il nostro corpo, scritto dalle donne per le donne, Feltrinelli, Milano
1974, I ediz.], ad opera del Boston Women’s Health Book Collective, ebbe
un ruolo importante nell’invitare le donne a prendere coscienza del controllo
sociale che veniva esercitato sul loro corpo e a prendersi cura della loro salute,
essendo informate sulle scelte.
70
Gianfranca Ranisio
trasformato gradualmente la medicina dal suo interno (Clarke
A. et aliae, 2010: 47). Secondo Clarke la medicalizzazione era
co-costitutiva della modernità, mentre la biomedicalizzazione è
propria della postmodernità. Queste trasformazioni sono state
rese possibili dallo sviluppo di nuovi campi del sapere, come la
biologia molecolare, le biotecnologie, la medicina dei trapianti,
la scoperta del genoma e delle nanotecnologie. Infatti i fattori
che sono considerati alla base della biomedicalizzazione sono:
l’informatizzazione e l’avvento del digitale, la medicalizzazione della salute e dei fattori di rischio, gli interventi della tecno
scienza e della ricerca farmacologica (Clarke A. E. – Shim J.
K., 2009). Secondo questa prospettiva teorica, la biomedicina è sempre più orientata dalla tecnologia che utilizza, ovvero sempre più dipendente da apparecchiature di complessità
crescente e questo comporta una trasformazione organizzativa
non solo delle infrastrutture, ma anche delle conoscenze e dei
nuovi trattamenti clinici, come in un processo di ibridazione tra
scienza medica e tecnologia (Maturo A., 2010).
A questi progressi si è accompagnata una visione della vita
basata sul messaggio neoliberista, secondo il quale i cittadini
sono responsabili delle loro condizioni di salute e devono ottemperare all’imperativo morale di essere e sentirsi sani e in
forma, così ad esempio è la vecchiaia a essere medicalizzata,
non solo le sue malattie, mentre la ricerca studia come produrre
terapie anti-invecchiamento (Maturo A. – Conrad P., 2009).
L’accento che viene posto sui fattori di rischio collegati alle ricerche sulla genetica comporta un nuovo approccio alla salute, di impronta bio-riduzionista, che riconducendo sempre più
l’origine dei problemi alla sola dimensione individuale, non fa
altro che opacizzare il peso dei fattori sociali contribuendo ad
una sostanziale depoliticizzazione dei fenomeni.
Rispetto alle problematiche di genere affrontate negli studi
sulla medicalizzazione, questa prospettiva di studi intende considerare il genere come una categoria analitica, utile per analizzare non tanto il corpo femminile, quanto le molteplici relazioni
tra il maschile e il femminile, in opposizione alla tendenza della
3. Corpo femminile e medicalizzazione
71
biomedicina di costruire un corpo “naturale” (Riska E. , 2010:
149).
2. Profilo storico
Il percorso storico del processo di medicalizzazione del corpo
femminile è strettamente intrecciato con la costruzione della
medicina come sapere scientifico. In questo percorso rientrano
l’istituzione degli ospedali, la lotta tra i professionisti della salute e le ostetriche, l’emergere della ginecologia come disciplina
e del ruolo sociale del ginecologo. Secondo l’impostazione di
Foucault, il controllo della società sugli individui non si effettua
solo con l’ideologia ma anche attraverso il corpo e nel corpo, è
tra il XVII e XVIII secolo che si sviluppa quello che egli indica
come il biopotere, cioè la gestione e il controllo del corpo umano da parte del potere politico (Foucault M., 1978 [1976]).
Possiamo perciò considerare la medicalizzazione attuale come
l’esito di un processo lungo che ha inizio a partire dai secoli
XVIII e XIX, quando la medicina si assume l’obiettivo della
salvaguardia e del miglioramento della salute della popolazione
e arriva a incidere in modo molto elevato nella seconda metà
del XX secolo.
Nel passaggio della medicina da arte a scienza l’uomo - e nel
nostro caso la donna - diviene un oggetto da analizzare, un caso
clinico. Infatti, le rappresentazioni del corpo femminile si sviluppano e si modificano nel corso della storia della tradizione
medica occidentale, a partire da quella ippocratica. Aristotele
sancisce come naturale l’inferiorità biologica femminile e rappresenta il corpo femminile come imperfetto e impuro, freddo
poiché con le mestruazioni le donne perdono il sangue portatore di vita (Héritier F., 2004: 16 [2002]). Galeno successivamente lo caratterizza per avere gli organi riproduttivi simili a quelli
maschili, ma posizionati all’interno del corpo, con un’immagine speculare ma inversa, riproponendo nel fisico il dualismo
simbolico interno/esterno (Duden B., 2006: 37-38 [2002]). In
72
Gianfranca Ranisio
tale rappresentazione i due sessi non sono considerati eguali, in
quanto il corpo maschile è ritenuto più perfetto. Questa concezione - con alcune eccezioni come Trotula de Ruggiero nella Scuola Medica Salernitana e altre donne che si impegnano
come empiriche nell’esercitare una pratica femminile separata,
che sfugge al controllo maschile - è diffusa fino al XVII-XVIII
secolo.
Solo con l’apparire del discorso scientifico cartesiano inizia
a farsi strada la differenza tra i due sessi, quando, a partire dal
dualismo mente/corpo, nel XVIII secolo si impone la concezione del corpo anatomico, composto di organi (Busoni M., 2002
: 52-53). La visione del corpo femminile considerato nella sua
differenziazione dal corpo maschile, e analizzato come macchina riproduttiva sottoposta a regolarità funzionale, si impone a
livello istituzionale, mentre nella cultura popolare europea permane per un lungo periodo la visione precedente e con essa
la credenza nell’utero separato e dotato di vita autonoma, in
grado di muoversi (Charuty G., 1997, Guggino E., 2006: 29,
Pizza G., 2005). Se il corpo è considerato una macchina e può
essere scomposto nelle sue varie parti, ne consegue che la riproduzione è rappresentata come un processo lineare e la nascita come un processo industriale, sottoposto a controllo, così
come è esemplificato dalle pratiche ospedaliere (Davis Floyd
R., 1987, Anderson R. 1996). Emily Martin (2001) si sofferma
su quest’immagine, attraverso l’analisi dei testi di medicina del
Novecento, per rilevare come alla donna sia attribuita una ridotta capacità di produzione, per la ciclicità delle mestruazioni
e per la loro scomparsa con la menopausa, mentre all’uomo viene ascritta una produzione continua. La conoscenza del corpo
femminile e del suo apparato riproduttivo si intreccia con la
rappresentazione del sangue mestruale.
La teoria di Galeno che vede nelle mestruazioni un salasso
naturale dovuto ad un eccesso di sangue (pletora), prevale per
lungo tempo. Infatti prima del XVIII secolo questo flusso, in
quanto considerato sangue in eccesso e pertanto da eliminare,
3. Corpo femminile e medicalizzazione
73
è considerato “naturale” e non patologico2. Tuttavia, pur essendo “naturale”, il sangue mestruale è ugualmente considerato
sporco e contaminante, nelle descrizioni medievali, influenzate
dalla tradizione giudaico-cristiana, esso appare come “impuro”
(Camporesi P., 1997).
Per tutto un lungo periodo della storia dell’umanità, vi è una
svalorizzazione dei fluidi del corpo femminile e la discussione
anatomica del mestruo è tutta incentrata sulla provenienza di
esso. Il sangue mestruale non è ancora collegato alle fasi della riproduzione, nonostante la teoria di un “seme femminile”
sia piuttosto condivisa. Solo nel 1827 la scoperta dell’ovulo
permette di collegare la funzione delle ovaie alle mestruazioni. Tuttavia il processo stesso viene visto come patologico e si
accentua la convinzione che le mestruazioni siano debilitanti,
sottolineando l’impatto negativo che queste hanno sulla vita e
sul lavoro delle donne.
Agli inizi del Novecento si inizia a sviluppare il concetto di
ormoni e soltanto tra gli anni Trenta e Quaranta del XX secolo
sono individuati e isolati quelli femminili e si comincia a parlare
di “ciclo” mestruale (Malaguti R., 2005: 56). La prospettiva
meccanicistica insita nella biomedicina del periodo fa sì che il
flusso mestruale sia descritto come segno di un mancato concepimento, insinuando progressivamente la concezione delle
mestruazioni come “fallimento produttivo”. Nei testi di ginecologia analizzati da Emily Martin il sistema riproduttivo è rappresentato metaforicamente come «un sistema di informazionetrasmissione con una struttura gerarchica», per cui a determinati segnali corrispondono determinate risposte endocrine. In
questi testi è sottolineata la “funzione” che ha la produzione ormonale di preparare la fecondazione dell’ovulo, per cui quando
2. Allo stesso modo si ritiene che gli uomini eliminino il sangue in eccesso,
ma per altre vie (dal naso o anale). Pomata (1992) definisce questi uomini
“mestruanti”, sottolineando che per secoli la “base corporea” della differenza
di genere non è legata ad aspetti fisiologici qualitativi ma solo “quantitativi”
e di “posizione”.
74
Gianfranca Ranisio
un ovulo non si impianta, questo processo è descritto in termini
negativi, come appare da questa metafora molto suggestiva, ma
anche indicativa a livello ideologico del tipo di modello su cui
si basa, che si trova in un testo di ginecologia molto diffuso tra
gli studenti americani: «quando la fecondazione non si verifica,
l’endometrio si disfa e un nuovo ciclo ha inizio. Questo è il motivo per cui si usa insegnare che la mestruazione è l’utero che
piange per la mancanza di un bambino» (Martin E., 2001: 45).
L’individuazione degli ormoni femminili segna il momento decisivo per il passaggio dall’interpretazione dei “segni” delle mestruazioni ai “sintomi” e per la trasformazione di ciò che prima
era considerato fisiologico in patologico. Il legame tra natura e
donna mestruata, presente sia nella concezione della contaminazione che in quella “magica” (si pensi al rapporto con la luna
e le sue fasi), è profondamente modificato da questa visione,
che impone alla donna di intervenire per vie “scientifiche” rispetto agli effetti “invalidanti” delle mestruazioni, pena l’esclusione dal mondo del lavoro. Negli anni Trenta si riteneva che
le donne con le mestruazioni dovessero ridurre le loro attività
per conservare le loro energie, perché il corpo non può fare
bene due cose allo stesso tempo e ancora alla fine degli anni
Quaranta nei testi medici si consigliava alle donne di non affaticarsi durante il ciclo, di evitare esercizi fisici e estremi sbalzi di
temperatura, perché potevano arrecare maggiori dolori e traumi emozionali, convinzioni che sono poi rimaste a lungo nelle
credenze comuni (Ranisio G., 2006). Questo tipo di approccio
ha comportato l’estendersi di una tendenza sempre più diffusa:
il ricorso generalizzato al trattamento farmacologico, chiamato
ad annullare disagi e sofferenze.
Emily Martin analizza attentamente come, parallelamente
alla visione di mestruazioni come “fallimento produttivo”, si
sia imposta nella comunità scientifica la concezione “debilitante” della donna mestruata e la “costruzione” della cosiddetta
“Sindrome Premestruale” (PMS).
La sindrome premestruale è introdotta per la prima volta da
un medico, Robert T. Frank, in un articolo del 1931, nel quale
3. Corpo femminile e medicalizzazione
75
egli descrive e mette insieme vari sintomi, distinguendoli in psicologici, quali la depressione e l’ansietà, fisici quali la nausea,
problemi epidermici e dolori alla pancia e al seno e problemi di
concentrazione, quali la stanchezza e l’insonnia. La costruzione
della sindrome premestruale ha avuto risvolti sociali e culturali
rilevanti, infatti, ha consentito che si diffondesse, anche a livello
comune, l’opinione secondo la quale le donne sarebbero inabili
a lavorare durante il ciclo. A questo proposito Emily Martin ha
istituito una correlazione tra questa costruzione culturale e il
periodo della Grande Depressione. Infatti, il processo di medicalizzazione delle mestruazioni, con la creazione della PMS
quale categoria diagnostica, si è sviluppato in questo specifico
contesto economico e sociale, quando vi era l’esigenza di escludere le donne dal mercato del lavoro. Si sono diffuse e sviluppate in questo contesto quelle pratiche mediche che controllavano il corpo delle donne, in una prima fase attraverso l’uso di
sedativi e calmanti e poi successivamente di trattamenti ormonali. Tuttavia, queste pratiche hanno ricevuto il supporto dalle
donne, che chiedevano un trattamento per i loro sintomi e che
sono state indotte maggiormente a controllare il loro comportamento in quei giorni del ciclo. Questa tendenza a patologizzare
le mestruazioni ha, infatti, determinato nelle donne la convinzione che sia i loro comportamenti che i loro disturbi fisici e
psichici - prima e durante il ciclo - siano dovuti alle variazioni
ormonali. Questa costruzione culturale della PMS ha permesso
e permette tuttora alle donne di utilizzare le mestruazioni come
una scusa legittima per il loro comportamento prima e durante
il ciclo, quando i sintomi mestruali sono spesso usati per manipolare delle situazioni a proprio vantaggio e per ricevere maggiore attenzione (Martin E., 2001: 135).
È singolare come la più recente forma di medicalizzazione
del corpo femminile riguardi le mestruazioni e rappresenti l‘ultimo dei molti tentativi di medicalizzare ciò che è fisiologico
nella vita femminile. L’introduzione della pillola che elimina
le mestruazioni, la cui vendita negli USA è stata approvata recentemente, pone degli interrogativi sul significato che questo
76
Gianfranca Ranisio
evento potrà avere sulla vita delle donne e sul modo in cui possono cambiare le stesse rappresentazioni simboliche del femminile. E’ significativo che nella pubblicità di questo tipo di
pillole si faccia riferimento più alla liberazione dal ciclo che alla
contraccezione. La premessa scientifica su cui si basa questo
intervento sulla fisiologia femminile è che le donne del passato
avevano molti meno cicli di quelle contemporanee, a causa delle numerose gravidanze e dei lunghi periodi di allattamento. La
soppressione delle mestruazioni può essere vissuta come una
conquista o una liberazione3, può intrecciarsi con aspetti del
vissuto soggettivo, ma può anche essere utilizzata in contesti
in cui le mestruazioni connotano ancora l’inferiorità femminile.
È questo il caso della società iraniana, studiata da Byron
Good, nella quale le donne usano la pillola durante il mese del
Ramadan o durante il pellegrinaggio, per prevenire con le mestruazioni la contaminazione che ne deriverebbe in entrambe
le circostanze (Good B.J., 2006: 54). La pillola, quindi, in questi casi “libera” sul piano pratico ma non a livello ideologico,
poiché rafforza sul piano simbolico l’immagine tradizionale del
sangue “sporco” e contaminante e la concezione della debolezza e dell’inferiorità delle donne.
In tutt’altro contesto, l’uso della pillola contraccettiva tende
a imporsi tra le giovanissime, al di là di specifiche patologie e
di reali esigenze sessuali. Infatti, una ricerca svolta in Olanda
ha posto in evidenza che quest’uso, se ha comportato la riduzione della fecondità e del numero di aborti tra le adolescenti,
si è tuttavia generalizzato. Le ragazze hanno una grande fiducia
nelle pillole, perché ritengono in questo modo di poter pianificare le mestruazioni, di poter agire sulle irregolarità mestruali e
sull’acne, di poter programmare il week-end, insomma il controllo sulle mestruazioni appare come la più importante funzione della pillola, che viene considerata come una “tecnologia di
3. Il sito del mum.org (Museum of Menstruation) contiene la rubrica:
Would you stop menstruating if you could?, nella quale si invitano le donne a
intervenire e ad esprimere la loro opinione.
3. Corpo femminile e medicalizzazione
77
liberazione”, consentendo la pianificazione della propria vita.
I medici, dal canto loro, aderiscono a tale ideologia, prescrivendo la pillola di routine, senza fornire informazioni adeguate
sugli effetti collaterali (Hardon A. - Harries J., 2001: 214-215).
Anche Laura Fingerson, in una ricerca effettuata negli USA,
pone in evidenza come le adolescenti (13-19 anni) comprese
nel suo campione, accettino la medicalizzazione sia adeguandosi nel comportamento, che facendo proprie le conoscenze
scientifiche elaborate in campo medico. Le ragazze intervistate
si riferiscono a ciò che hanno appreso durante le lezioni e pertanto, invece che parlare di sangue, di flusso, e dell’impatto che
esso ha sulle loro esperienze, parlano di ovuli, ovulazione e utero, collegando il ciclo al processo riproduttivo. Le ragazze tendono a descrivere le mestruazioni come una malattia cronica,
una condizione definita da sintomi che richiedono trattamenti.
Come nota la studiosa, non avvertono le mestruazioni come
qualcosa che accade dentro il loro corpo, ma le percepiscono
come qualcosa che accade a loro, non in loro. Inoltre dimostrano di utilizzare le mestruazioni a proprio vantaggio, non sempre come una scusa, ma piuttosto come un disturbo legittimo
e fisiologico (Fingerson L., 2005). Si può ritenere perciò che
la medicalizzazione non sia di per sé avvertita come limitante e
che le donne in certo modo partecipino al processo di medicalizzazione del loro corpo e lo sostengano, accettando la tesi che
le mestruazioni possono arrecare disturbi fisici e psicologici.
La cessazione delle mestruazioni per effetto della menopausa, segna importanti cambiamenti nel corpo e nel destino
femminile, ma anche per questo passaggio l’interesse medico è
recente. E’ infatti solo tra il Settecento e la prima metà dell’Ottocento che la manualistica medica costruisce la menopausa
come oggetto scientifico, iniziando a descrivere i disturbi che
caratterizzano questa fase e soprattutto a individuare un nesso
tra l’utero e il sistema nervoso centrale4. L’origine dello stesso
4. Il termine menopausa viene introdotto in Europa da De Gardanne nel
De la Ménopause, ou de l’age critique des femmes, nella prima metà del XIX
78
Gianfranca Ranisio
termine menopausa si intreccia con l’emergere della professione
ginecologica ed è a partire dal XIX secolo che la menopausa è
considerata come un problema medico e si cerca di individuarne la sindrome (Pizzini F., 1999). In seguito alla scoperta fatta
da Edward John Tilt dell’importanza della rete nervosa delle
ovaie per l’origine dei disturbi della menopausa, nella scienza
medica viene abbandonata la teoria dell’accumulo di tossine,
che si riteneva causato dalla scomparsa dei flussi. Tilt esprime
chiaramente la convinzione che molti problemi associati con
tale fase di cambiamento non siano patologici di per sé e che la
menopausa in alcuni casi possa anche apportare effetti salutari
(Lock M., 1993: 311). Egli ritiene inoltre che il sangue che rimane nel corpo, sia la causa delle vampate e successivamente,
dopo la menopausa, dell’accumulo di grasso, senza che ciò implichi una patologia. Soltanto nel Novecento, con lo sviluppo
dell’endocrinologia e quindi con l’individuazione degli estrogeni e del progesterone, la medicina attribuisce ai cambiamenti
ormonali il potere di agire in modo globale sulla salute femminile, ne consegue che, dopo questa scoperta, le donne in menopausa iniziano a essere curate con terapie ormonali. L’uso della
terapia ormonale sostitutiva, largamente prescritta alle donne
in menopausa dai ginecologi statunitensi, che ha prodotto un
incremento di tumori al seno, rappresenta un esempio drammatico dei rischi della medicalizzazione sul corpo della donna
(Lock M. –Nguyen V.K. , 2010: 53). Nei testi di antropologia
medica si pone in evidenza che queste conoscenze mediche sulla menopausa e sui disturbi ad essa correlati si sono sviluppate
a partire dai sintomi di donne europee o nordamericane, naturalizzati e biologizzati come universali, senza alcun confronto
con l’esperienza di vita della maggioranza delle donne del mondo (Lock M., 2001: 485). Pertanto, la storia della costruzione
secolo, ma soltanto successivamente la menopausa sarà poi definita a partire
dal concetto di carenza ormonale. Nella seconda metà del XX secolo la medicalizzazione è generalizzata ed è negli anni Ottanta e Novanta che la menopausa diviene oggetto di analisi storiche e socio-antropologiche.
3. Corpo femminile e medicalizzazione
79
della menopausa come patologia è una storia tutta interna alla
medicina occidentale, a riprova di ciò, per porre in discussione
la teoria dell’universalità di tali fenomeni, è importante analizzare la menopausa all’interno di una prospettiva transculturale
(Alfieri C., 2002, Héritier F., 2004 [2002], Diasio N.- Vinel
V., 2007, Vincent J. F., 2003, Lock M.– Nguyen V.K., 2010).
Margaret Lock in un testo che può essere considerato fondamentale per le prospettive teoriche che ha aperto, Encounters
with Aging: Mythologies of Menopause in Japan and North
America (1993), opera un paragone tra la situazione americana e quella giapponese, ponendo in evidenza come le donne
di queste due società non vivano questo periodo nello stesso
modo. Partendo dall’analisi dei comportamenti e delle affermazioni delle donne giapponesi durante quello che viene definito
con il termine konenki, che compare in Giappone verso la fine
dell’Ottocento e non appare come la trasposizione meccanica
del termine occidentale menopausa, l’autrice rileva che le donne giapponesi, quando descrivono i sintomi della menopausa,
non ne parlano e non li affrontano nello stesso modo in cui
lo fanno le donne occidentali. La visione che ne forniscono è
legata alla concezione che hanno elaborato del corpo e del rapporto tra corpo individuale e corpo sociale, che è differente da
quella delle donne occidentali. In altro contesto, Dona Davis
(1997) ha analizzato i cambiamenti intervenuti rispetto alla
menopausa tra le donne di un villaggio dell’isola di Terranova,
originariamente un paese di pescatori, dove si è recata in due
periodi differenti, la prima volta negli anni Settanta, la seconda
nel 1989-90. Durante il secondo soggiorno, ha avuto modo di
rilevare l’impatto e l’estensione della medicalizzazione. Infatti,
a differenza degli anni Settanta, quando le conoscenze sulla
menopausa erano ancora basate sulle esperienze di vita ed erano condivise, le donne hanno descritto la menopausa come un
periodo in cui stare sotto controllo medico e che è da gestire a
livello privato, facendo ricorso alle spiegazioni mediche e psicologiche, che hanno soppiantato i discorsi popolari. La studiosa
ritrova un cambiamento profondo nella natura dei rapporti in-
80
Gianfranca Ranisio
terpersonali e nel modo di percepire il corpo e ciò che avviene
nel corpo, considerati ora come fatti privati. Le donne da lei
intervistate si sentono o troppo grasse, o troppo vecchie, o incapaci di controllare le emozioni, mentre quelle che erano le
metafore condivise, e con esse la forza delle reti femminili, molto presenti negli anni Settanta, hanno perduto ogni rilevanza
nel paese. Questi cambiamenti non possono essere considerati
soltanto conseguenza delle più ampie forze globali e dell’effetto
dei mass-media, poiché su di essi hanno inciso anche le trasformazioni socioeconomiche, che hanno profondamente modificato la vita del villaggio, in corrispondenza con il venir meno dei
legami comunitari. Anche dalle ricerche etnologiche traspaiono
immagini complesse, non univoche, che pongono in evidenza,
più che aspetti medici, problematiche legate ai cambiamenti di
status e alla posizione delle donne in quelle società.
Ne emerge una ridefinizione della menopausa, che la sottrae
all’esclusiva gestione medica: la menopausa è un evento che
implica un intreccio tra gli aspetti biologici e quelli sociali e
culturali, è un evento biologico, ma, al tempo stesso, una costruzione culturale che determina un cambiamento dello status
sociale della donna, un evento difficile da definire, che deve essere contestualizzato e storicizzato, perché non è un fenomeno
universale, ma un fenomeno legato alla storia e alla cultura di
un popolo e alle donne che la vivono (Lock M., 1993, Pizzini F.,
1999, Ranisio G., 2006, Diasio N. - Vinel V., 2007).
3. Problemi aperti
Il processo di medicalizzazione può essere considerato in relazione da un lato con l’esasperazione della medicina difensiva e
della medicina predittiva, dall’altro con l’espropriazione del
controllo del corpo femminile. Tale processo di espropriazione ha come conseguenza che le donne stesse si affidino a tutte
le tecniche possibili, a tutte le pratiche che consentano loro di
prevenire eventuali complicazioni, anche a costo di sottoporsi a
3. Corpo femminile e medicalizzazione
81
esami invasivi e di andare incontro a rischi iatrogeni.
Le donne si percepiscono e sono percepite come soggetti
dalla fisiologia debole, che hanno bisogno dell’apporto della
scienza medica, per non dire della tutela. Le critiche che sono
state mosse all’interpretazione medica del corpo femminile e
della sua fisiologia pongono in discussione, innanzitutto, il presupposto su cui si basa: il corpo che è considerato “normale” è
quello della donna in età riproduttiva e tutto il processo fisiologico è considerato finalizzato alla produzione di altri esseri
umani. Questo corpo viene poi preso come termine di paragone
anche quando si considerano le condizioni della donna nelle
varie fasi della vita, sia che abbia le mestruazioni, sia che sia
già in menopausa. Per questo un insieme di fattori, che sono
fisiologici, sono collegati tra loro per delineare una particolare
patologia.
Gli eventi che avvengono nel corpo e attraverso il corpo delle donne, dalla procreazione al ciclo mestruale, appaiono legati
a pratiche e saperi attraverso i quali il dato biologico interagisce
con il sociale e il culturale. Anche gli studi su altre società ci
dimostrano che isolare il dato biologico e medicalizzarlo, senza
tenere conto delle implicazioni sociali e culturali che lo caratterizzano, come sta avvenendo oggi, significa operare un’interpretazione riduttiva della complessità umana.
Antropologhe e femministe hanno denunciato l’eccessiva
medicalizzazione del corpo femminile, ponendo in evidenza come questo modello, elaborato nell’Europa occidentale e
nell’America settentrionale durante il XX secolo, rischi di essere esteso anche ad altre parti del mondo e di diventare globale.
Tuttavia le ricerche antropologiche hanno posto in evidenza
anche come il processo di medicalizzazione si presenti in modo
contraddittorio e ambiguo, poiché le donne, per sottrarsi al
dominio che i processi biologici esercitavano sulla loro vita,
hanno poi accettato il controllo sul loro corpo da parte della biomedicina (Riessman C. K., 1998: 59, Long M., 2008).
Significativo è quanto è avvenuto con la pillola contraccettiva,
che ha rappresentato una svolta epocale e che doveva garantire
82
Gianfranca Ranisio
alla donna l’autodeterminazione e la liberazione dai vincoli biologici, eppure la stessa autodeterminazione è divenuta ambigua,
poiché attraverso l’accettazione della pillola è stata veicolata anche l’accettazione di «una concezione del corpo che non può
essere vissuto a livello sensibile», e con questa la consegna della
propria corporeità a una tecnica che promette di esaudire i desideri femminili5 (Duden B., 2006: 141 [2002]).
Se le scienze mediche hanno sviluppato approfondite conoscenze sul corpo femminile e sui processi fisiologici che lo governano, tuttavia è necessario riconcettualizzare l’intero modo
di pensare il dato biologico e considerare che fenomeni definiti
“naturali” sono di fatto la conseguenza delle circostanze sociali
della vita delle donne (Riessman C. K., 1998: 60, Martin E.,
2001, Lock M., 2001). Queste conoscenze andrebbero utilizzate per il benessere delle donne e non distorte per vantaggi economici, come nel caso delle industrie farmaceutiche. Esempi
significativi di questo, come abbiamo visto, possono essere considerati l’utilizzo della pillola per il controllo e l’eliminazione
delle mestruazioni, o la terapia ormonale sostitutiva per la menopausa, prescritte in modo indiscriminato.
Ricerche puntuali sottolineano che la prospettiva di genere
non può essere applicata in modo astratto, ma che si deve intersecare con altre categorie quali la classe sociale, la lingua, l’etnicità, la religione. Le donne non sono soltanto vittime di questo
processo ma oppongono forme e modalità di resistenza, che
dimostrano un approccio pragmatico, piuttosto che ideologico,
rispetto alle tecnologie e ai servizi medici, così come ad altri
settori dell’esperienza (Signorelli A., 1996). L’attitudine verso
la medicalizzazione può essere positiva, negativa o ambivalente,
può mutare nel corso del tempo. La risposta è spesso legata alle
5. Su questa posizione, ma con implicazioni di tipo psicologico, è Chatel, la quale sostiene che i mezzi che hanno permesso alle donne di liberarsi
dell’arrivo intempestivo di un figlio hanno modificato l’impulso profondo
della fecondità e hanno introdotto anche l’idea che sia possibile fare un figlio
quando lo si desidera (1995: 31-58 [1993]).
3. Corpo femminile e medicalizzazione
83
percezioni di come la tecnologia o le cure del corpo possono
migliorare o peggiorare le condizioni di vita. Si vede così che,
in certe situazioni, la maggioranza delle donne ritiene che sia
nel proprio interesse accettare la medicalizzazione (Lock M.Kaufert P. A., 1998: 1-27, Lock M., 2003, Lock M., 2001: 481).
Per questo, al di là delle rivendicazioni generali, è importante
affrontare queste tematiche in modo problematico a partire da
situazioni specifiche, poiché molti studi sottolineano ormai che
le donne non sono solo vittime passive, ma ricercano le tecniche
biomediche per acquisire l’autonomia dalle condizioni biologiche, o per soddisfare dei desideri personali. Tuttavia, analizzare
le scelte individuali, anche tenendo conto delle differenze economiche e di potere tra le donne, non significa voler escludere
il ruolo della microfisica del potere e delle ideologie dominanti, ma considerare come queste si articolino, si incontrino e si
scontrino con quelle che sono le possibilità di scelta e le capacità di riflettere criticamente sulle situazioni proprie e dei propri
familiari da parte dei soggetti interessati.
Donatella Cozzi
4. Dolore
«In uno dei suoi diari, in una pagina scritta nel periodo in cui si stava
sottoponendo alla chemioterapia
per il cancro al seno, mia madre
[Susan Sontag] intimava a se stessa
di essere «allegra, stoica, tranquilla». E poi aggiungeva: «Nella valle
del dolore, spalanca le ali».
Non fu quella la morte che morì.
Ma alla fine, credo che le sue parole – che ci credesse davvero o no,
che chiunque di noi possa arrivare
a crederci davvero o no – siano la
cosa migliore che si possa dire del
nostro vecchio essere mortali.
«Nella valle del dolore, spalanca le
ali»
David Rieff, Senza consolazione,
2009, p. 120
L’oncologa a Cinzia: «A noi del suo
dolore non importa un bel nulla».
In questo momento è sempre più diffusa nell’ambito delle cure
la consapevolezza dell’importanza di fornire una assistenza e
cure di eccellenza in caso di dolore acuto o cronico, ai malati
terminali o ai morenti. Questa attenzione è il prodotto di un atteggiamento che unisce relazione a cura, con sempre maggiore
sensibilità verso la qualità percepita da chi è malato. Inoltre,
l’istituzione dell’Ospedale senza dolore, secondo il dettato delle
Linee Guida pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel 2001, ha costituito una vera e propria rivo-
86
Donatella Cozzi
luzione copernicana intorno alla persona sofferente. E, ancora
più importante, la torsione verso una nuova concettualizzazione del dolore è possibile restituendo a chi soffre il primato di
esprimere ciò di cui sta facendo esperienza, senza che alla sua
voce si sovrapponga la voce degli esperti della cura: «il dolore
è tutto ciò che il malato afferma che sia, reale o immaginario, e
per quanto insignificante possa sembrare all’osservatore esterno, il malato non ha dubbi della sua esistenza e importanza»
(McCaffery M., 1983: 21).
Tuttavia, un dato sconcertante che emerge dalla letteratura
in ambito medico è che il dolore negli spazi di cura viene ancora
troppo spesso sottostimato, poco ascoltato, preso scarsamente
in considerazione e quindi, soprattutto in alcuni ambiti sanitari,
non viene trattato convenientemente. Oppure, il dolore e la sua
valutazione e gestione vengono demandati esclusivamente alle
nuove équipes di terapia antalgica, collegati al riconoscimento
di ‘Ospedale senza dolore’ come un compito da demandare agli
specialisti del settore. In quanto ambito specialistico, la diffusione di formazione e informazione a medici e infermieri rimane scarsa, quindi non patrimonio comune della cura ma sapere
elitario.
A questa constatazione, si unisce una ulteriore considerazione, ovvero che alla opacità del dolore entro il nostro universo culturale si associa spesso la dichiarata incomprensibilità,
da parte delle figure della cura, del dolore dell’Altro culturale,
dei suoi codici, delle sue espressioni e del significato ad esso
attribuito. L’insieme di questi atteggiamenti interroga le nostre
pre-comprensioni culturali sul dolore, e sollecita l’antropologia medica ad immergersi nella comprensione del dolore fisico
rivolgendo la propria lettura critica alle epistemologie e ontologie, alle cosmologie e pratiche invocate per trattarlo, teoricamente e materialmente. In altri termini: da un lato il dolore
viene naturalizzato sino a disperderne l’importanza come esperienza, individuale e umana, e può essere trattato tecnicamente
con opportuni farmaci come qualsiasi altro elemento oggettivo
di disease, dall’altro, a turbare la sicumera della naturalizzazio-
4. Dolore
87
ne biologica, autentico prodotto culturale e storico, interviene
la pluralità delle forme di vita e di significato che si iscrivono
in esso. Il dolore, in ogni società, ‘significa’ molto di più dell’identificazione del danno tissutale o del funzionamento neurobiologico. L’enigma del dolore si condensa attorno a ciascuna
delle vie esclusive che possiamo intraprendere nel cercare di
interpretarlo: se leggiamo il dolore solo come risposta soggettiva, rischiamo di precluderci ogni comprensione sociale (come
il dolore viene comunicato utilizzando codici che sono sociali e
condivisi, e quali le radici della sofferenza sociale), se mi limito
all’analisi del racconto, posso perdere di vista i condizionamenti politici e sociali ai quali è collegato, se leggiamo il dolore solo
nelle sue qualità espressive e culturali, ci impediamo di affrontare cosa esso significhi per la singola persona, nella peculiarità
della sua vicenda individuale, se lo guardiamo da una prospettiva filosofica, sul piano ontico, rischiamo di annullare la visione
delle differenze ontologiche, secondo le quali non è indifferente
né universale come individui, gruppi e società modellano comprensione ed espressione del dolore, organizzano saperi e tecniche, concretizzano istituzioni e campi del sapere, se guardo
solamente alla molteplicità ontologica, è il dramma umano del
dolore e la sua carica etica a perdersi tra i rivoli della differenza.
1. La complessità di una definizione biomedica
Consapevole di non poter accettare come ugualmente valide
le innumerevoli definizioni esistenti, nel 1979 la International
Association for the Study of Pain (I.A.S.P.) richiese ad un gruppo di studiosi presieduto dallo psichiatra Merksey di fornire
una nuova definizione: «il dolore è una esperienza sensoriale ed
emozionale spiacevole, associata ad un danno tessutale reale o
potenziale e descritta in termini di tale danno, segnalata da una
qualche forma di comportamento rilevabile». Inoltre «il dolore è sempre soggettivo» e anche quando una persona riferisce
di provarlo in assenza di evidenza organica o funzionale «deve
88
Donatella Cozzi
essere accettato in quanto dolore» (International Association
for the Study of Pain 1979: 249).
Si tratta di una definizione che sottolinea la complessità
dell’argomento: esperienza sensoriale e psicologica, strutturata
ad un livello percettivo elevato che implica la sfera emozionale e
affettiva, profondamente collegata alla dimensione soggettiva e
quindi inserita nel prisma delle condizioni storiche e delle relazioni sociali. Tuttavia, in grado di cogliere più gli eventi puntuali che i processi, nella pratica clinica buona parte di questa complessità si perde e si riduce, e l’inadeguata gestione del dolore,
acuto e cronico, resta un problema a livello mondiale. Questo
benché una pluralità di studi abbia ampiamente dimostrato che
il dolore non trattato inneschi una cascata di risposte ormonali,
metaboliche, funzionali, psicologiche tali da ritardare ed anche
compromettere un pronto ristabilimento psicofisico.
Dietro al dolore del corpo si annidano sicuramente ostacoli
comunicativi, ma soprattutto i problemi relativi a come vengono strutturate le relazioni tra curanti e curati, nella progressione
storica che va dal paternalismo medico all’approccio tecnico.
Nella misura in cui questa relazione porta ad una progressiva
oggettivazione del paziente, tanto più la soggettività che esprime il dolore diventa un fattore di disturbo da rimuovere perché
non oggettivabile, gli strumenti di valutazione del dolore sostituiscono l’esperienza che di esso fa il soggetto (vedi infra), e il
tema del dolore diviene opaco alle dinamiche di potere che si
sviluppano entro gli spazi relazionali della cura.
2. Un approccio antropologico al dolore: breve storia degli
studi
Il tentativo più noto di collegare l’esperienza del dolore ad una
dimensione sociale è stato quello di Mark Zborowski nel 1952
(Zborowski M., 1977 [1952], Zborowski M., 1969). Non fu il
primo, ma l’impatto del suo studio fu di gran lunga maggiore,
valicando l’ambito degli specialisti del rapporto tra cultura e
4. Dolore
89
sistemi medici. L’autore si rivolse alla differenza di comportamento e di reazione al dolore in quattro gruppi ‘etnici’ (quelli
più rappresentati nella città di New York agli inizi degli anni
Cinquanta: italiani, irlandesi, ebrei e Old Americans, ovvero cittadini americani da più di due generazioni) in un grande ospedale specializzato nella cura e nella riabilitazione dei reduci di
guerra. Lo studio prende dunque in esame solo la popolazione
maschile appartenente a diverse classi di età. L’obiettivo pratico, che per noi rimane oggi l’autentico valore pioneristico di
questo studio, era contribuire a chiarire da dove emergevano le
difficoltà nel rapporto tra infermiere, medico e paziente: l’atteggiamento nei confronti del dolore fisico da parte dei curanti ha,
infatti, grande importanza, soprattutto quando l’infermiere o il
medico ritengono che il paziente esageri la sensazione di dolore,
mentre il paziente pensa che il medico o l’infermiere minimizzino la sua sofferenza. Questo aspetto ha importanti conseguenze
sulla decisione di somministrare analgesici e sul tipo di risposte assistenziali fornite al paziente. Al nostro sguardo appaiono
invece superati i criteri analitici impiegati, e soprattutto la sopravvalutazione del ruolo dell’etnicità nella stilizzazione dell’espressione del dolore. Le categorie analitiche impiegate sono:
i modelli educativi, ovvero come ciascuno di noi apprende fin
dalla più tenera età in quali occasioni lamentarsi, come esprimere dolore e sofferenza, quando cercare aiuto se non si sta bene,
seguono le aspettative concernenti il comportamento secondo
il genere sessuale, altre variabili prese in considerazione sono
di tipo più propriamente sociologico, come il grado di istruzione e l’attività lavorativa. L’autore dichiara esplicitamente che si
tratta di uno studio a carattere descrittivo, ma la scelta delle categorie analitiche alle quali far risalire le differenze significative
tra i gruppi, e l’impiego acritico, come nello spirito del periodo,
del termine “etnia” sortisce un effetto generalizzante e atemporale. Inoltre, l’atteggiamento in risposta al dolore coagula tutte
queste componenti in uno stile espressivo, verbale e non verbale, il quale però è subordinato alla comunicazione di diverse
esigenze psicologiche: ad esempio, provocare preoccupazione e
90
Donatella Cozzi
interessamento, o suscitare comprensione per la propria sofferenza. In altre parole, le componenti culturali identificate servono più a spiegare l’atteggiamento psicologico soggiacente che
ad avere importanza in quanto tali. La maggiore critica rivolta
a Zborowski è quella che il suo studio, nel tratteggiare le differenze tra “etnie”, fuori dalla storia e dal cambiamento, esemplifica il paradigma discontinuista, ovvero l’idea secondo la quale
il mondo è composto da un mosaico di ’etnie’, ciascuna delle
quali è insediata su un territorio delimitato, con una lingua,
tradizioni, modi di vivere che le sono particolari. Una accanto
all’altra forniscono l’effetto di tessere di un mosaico, ciascuna
singolarmente conchiusa e autonoma, immagine che non tiene
conto delle dinamiche identitarie e di ibridazione, omogeneizzazione ed anche sovrapposizione territoriale dei gruppi. Il paradigma discontinuista è stato da almeno 20 anni abbandonato
dalle discipline antropologiche, ma resiste tenace nel senso comune, che continua a pensare a un mondo fatto di etnie, ognuna delle quali descrivibile come una entità autonoma, distinta
da quella accanto, portatrice di interessi, con un profilo caratteriale, usi, costumi e comportamenti ‘diversi’ da quelle intorno.
Nell’universo sanitario, il rischio che un paradigma discontinuista profila è quello di generare negli operatori sanitari aspettative di comportamento dei pazienti standardizzate: quando
l’italiano, il ghanese o il cinese sembrano comportarsi in modo
diverso dalle pre-comprensioni, rappresentano una deviazione
dalla norma, che acquista una coloritura morale: allora si tratta
di una incapacità della persona ad esprimersi in modo comprensibile, oppure essa è dotata di scarsa autonomia e pretende di
‘avere tutto’, di ottenere risposte per qualsiasi esigenza. L’alone
di notorietà del saggio di Zborowski meglio è più comprensibile
se concentriamo la nostra attenzione su alcuni elementi periferici della sua analisi. Tra di essi, oltre al già citato problema della
possibile sottovalutazione del dolore del paziente da parte dello
staff medico-infermieristico, che diventerà il tema dominante
nella letteratura clinica degli ultimi anni, lo spunto legato alla
dimensione biografica, concernente le conseguenze che una pa-
4. Dolore
91
tologia dolorosa può avere sulla globalità di vita di una persona
quando interseca la dimensione lavorativa e le risorse attingibili
dai vari sistemi di welfare, e la riflessione sulla differenza tra
“dolore previsto” e “dolore accettato”. Scrive Zborowski: «la
previsione del dolore nasce da una sofferenza considerata inevitabile in determinate situazioni... L’accettazione presuppone
anche la disponibilità a sperimentare il dolore» (Zborowski M.,
1977 [1952]:110) L’esempio fornito dall’autore per capire la
differenza tra previsione ed accettazione del dolore riguarda il
parto: il dolore delle doglie è previsto in quanto connesso fisiologicamente al parto, ma mentre ad esempio negli Stati Uniti,
già negli anni Cinquanta, non era accettato e si usavano vari
mezzi per alleviarlo, in altre nazioni esso era previsto e anche
accettato, e di conseguenza si faceva poco o nulla per mitigarne
la sofferenza. Questo spunto ci permette di aprire una riflessione contemporanea sulla lentezza della diffusione delle terapie
antalgiche, segnatamente in Italia sino al 1999, che caratterizza una cultura dell’accettazione sociale del dolore, soprattutto
nel caso dei malati terminali. È stato un percorso segnato da
pastoie burocratiche - il peso delegato ai medici di medicina
generale nella somministrazione di oppiacei, quindi di sostanze
la cui prescrizione era materia soggetta a particolari controlli -,
dal timore dei pazienti e dei loro familiari legato all’assunzione
di sostanze lette come comportanti dipendenza, da una cultura
del dolore, non possiamo dire quanto influenzata da ideologie
religiose, per la quale il dolore mal trattato e necessariamente
sopportato diventava inevitabile.
A proposito della “disponibilità a sperimentare il dolore”
si segnala uno degli aspetti meno indagati dalla letteratura, ma
che appare particolarmente pertinente all’ambito delle cure riabilitative: la mobilizzazione di un arto, il ri-apprendere a camminare utilizzando presidi o supporti per il recupero funzionale
di lesioni muscolo-scheletriche, e gli esercizi ad esso legati, così
come molti altri trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi, implicano la disponibilità a sperimentare dolore da parte
del soggetto. Un dolore che, soprattutto in ambito riabilitativo,
92
Donatella Cozzi
non può essere sedato, perché fornisce al curante e al paziente
la percezione del limite di motilità e di controllo e di percezione
del corpo, se si eccettua l’applicazione preventiva di ghiaccio
sintetico o della Tens (Transcutaneous electrical nerve stimulation, stimolazione cutanea mediante elettricità a basso voltaggio applicata per mezzo di elettrodi nella zona da cui si irradia
il dolore). Rispetto a questa cooperazione tra curanti e curati
intessuta dall’esperienza del dolore, è stato esaminato principalmente il versante della cooperazione interpretativa, nella
costruzione del “therapeutic emplotment” (“costruzione della
trama terapeutica”) esaminata da Cheryl Mattingly (Mattingly
C., 1994): la narrazione mette in forma l’esperienza della malattia e ne consente la valutazione dei progressi da parte dei
pazienti e dello staff.
Studi successivi a quello di Zborowski sino alla fine degli
anni ottanta del Novecento hanno approfondito il rapporto
tra dolore e cultura in senso descrittivo, allargandolo ad altri
gruppi culturali (Migliore S. 1989, Lipton J. - Marbach J.
1984, Craig K. - Wyckoff M. 1987). Il merito di tali ricerche è
senz’altro quello di evidenziare la relatività di quanto consideriamo scontato nell’esprimere qualcosa che ci appare immediato e “naturale” come il dolore fisico. Tuttavia, studi di questo
genere, orientati ancora su singole popolazioni, ripetono alcuni
dei limiti già evidenziati: tendono a costruire una immagine stereotipata, rischiano di farci perdere di vista l’individuo, e ciò
che per la sua esperienza viene a significare “provare dolore”.
Inoltre, collaborano a costruire immagini dell’Altro come forme di appropriazione, inglobamento, annichilimento della diversità. Ogni cultura crea le forme entro le quali versare e concettualizzare la sofferenza, ma che cosa il dolore significhi per
la vita di ciascuno di noi può essere chiarito solo attraverso la
relazione complessa tra la nostra esperienza e storia individuali,
e l’arena politica formata dalle figure e dalle strutture sanitarie.
Meno generalizzante è la serie di studi che tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta concentra l’attenzione sui modi culturali
di esperienza del dolore, le categorie descrittive e cognitive, la
4. Dolore
93
semantica del dolore che traduce l’esperienza in significati condivisi: dalla descrittività si procede verso i linguaggi e i significati del dolore, avvicinando l’approccio fenomenologico. E’ il
periodo in cui si approfondiscono gli ‘idiomi della sofferenza’,
ovvero i codici espressivi utilizzati per esprimere malessere e
dolore fisico.
Ad esempio, nella vasta letteratura sui “nervios”, quale particolare idioma del malessere, troviamo lo studio di Abad e Boyce (Abad V. - Boyce E., 1979) concernente due diverse concettualizzazioni del mal di testa (dolor de cabeza e dolor de cerebro),
che si distinguono per sede, intensità dello stimolo doloroso e
qualità dell’esperienza. Ohnuki-Tierney (Ohnuki-Tierney E.,
1981), descrivendo la salute/malattia presso gli Ainu giapponesi, elenca le metafore animali impiegate nella descrizione dei
sintomi, come pure Ots (Ots T., 1990) si sofferma sulle forme
di disagio che segnano l’incorporamento delle categorie mediche tradizionali cinesi di equilibrio/squilibrio quale causa della
malattia. Ebigbo (Ebigbo P.O., 1982) elenca le forme di malessere e dolore fisico e le espressioni relative che appaiono come
predittive di disagio mentale in una popolazione nigeriana. Va
ricordato inoltre uno studio la cui complessità anticipa le linee
attuali di riflessione sul dolore: Fabrega e Tyma (Fabrega H.
- Tyma S., 1976a, Fabrega H. - Tyma S., 1976b) individuano
la relazione tra dolore e cultura come interrelazione di stupefacente complessità tra elementi neurobiologici, modulati da processi ormonali, emozionali e percettivi, a loro volta influenzati
da categorie culturali e relazioni sociali. Uno studio così denso
e multifattoriale da rendere improponibile ogni tentativo settoriale (delle scienze sociali o di quelle mediche) di cogliere i
processi che trasformano la fatica in mal di testa, o uno stigma
sociale in crampi addominali. In effetti, la rete delle variabili da
prendere in considerazione nell’esperienza del dolore è talmente ampia, e la metodologia ancora così inadeguata, da spiegare
come il dolore sia, per le scienze mediche, uno dei pochi stati
definiti come “soggettivi”, da un lato, mentre per le scienze sociali ci si concentra maggiormente sulla espressione del dolore
94
Donatella Cozzi
ed i codici condivisi.
David Le Breton (Le Breton D. 1995) aggiunge una nuova
tessera alla costruzione della sua “antropologia del corpo” intrapresa sin dalla metà degli anni Ottanta con un testo che affronta
il dolore su un piano antropologico, interrogandosi su come la
trama sociale e culturale in cui esso è immerso influisce sui comportamenti e sui valori. Le tre polarità del dolore – universalità,
individualità, socialità – costituiscono lo sfondo di un percorso
complesso di riflessione. Il dolore, assolutamente irriducibile
alla nudità di un semplice fatto biologico, propone l’eterno problema del significato del male. Per questo motivo il dolore viene
integrato da tutte le società in una visione del mondo, che attribuisce significati, elabora misure simboliche e pratiche per limitarne la distruttività, o trasformarlo in prova creativa e vitale.
Esemplare è il cristianesimo, il quale, come altri sistemi religiosi, colloca la sofferenza umana all’interno di un disegno divino
al quale l’uomo non può che sottostare. La sofferenza estrema,
la tribolazione della carne in questo disegno divengono segno
di elezione, trasformandosi, come testimoniano le vite dei santi,
in godimento ed estasi. Sulla valenza positiva e vitale del dolore
si fondano anche i riti di iniziazione: il dolore imposto e ritualizzato, insieme alla dimensione del segreto, diventano matrici
generatrici di inclusione e costruzione di umanità, di risorse
morali e fisiche per affrontare l’esistenza, individuale e sociale.
Le Breton si sofferma su alcuni “usi sociali” del dolore, come il
“dolore educativo” somministrato attraverso le punizioni corporali, o la tortura quale materializzazione di una logica del dominio, o, seguendo lo spunto di Zborowski, il dolore ammesso
e previsto in alcune pratiche sportive, come il pugilato. L’analisi
di Le Breton è senz’altro calzante, quando constata che l’appropriazione del dolore da parte della medicina come oggetto
di sua esclusiva competenza ha contribuito a mutare il rapporto
degli individui con la sofferenza fisica. Il dolore sta perdendo
ogni significato morale, così come si perde progressivamente il
valore un tempo attribuito alla capacità di sopportazione personale, mentre la domanda crescente di analgesici consegna alla
95
4. Dolore
medicina un potere crescente sui corpi, nonostante le attese di
onnipotenza si infrangano contro l’incapacità di trattare molte
forme di dolore grave, cronico e invalidante. La gestione monopolistica del dolore da parte della biomedicina lo trasforma
in problema tecnico di pertinenza specialistica. Viene quindi
sottratto alla competenza culturale degli attori sociali, avviandosi a diventare un non senso, incomprensibile, intollerabile.
L’Autore conclude ribadendo che in ogni dolore c’è in potenza
una dimensione iniziatica, una sollecitazione a vivere più intensamente la coscienza di esistere. Sradicando il sentimento della
propria identità, il dolore è antropologicamente un principio
radicale di metamorfosi, di accesso ad una identità rinnovata,
di conoscenza dei propri limiti. Ma sembra che Le Breton si
stia riferendo unicamente al dolore acuto, non a quello cronico,
sembra ignorare quella parte dell’umanità per cui non è possibile risollevarsi dal proprio male, ed il dolore rimanda ad una
mortificazione della propria umanità, all’impellente e non risolvibile necessità di allontanarsi da esso. Questo tipo di analisi,
alla fine disancorato dalle situazioni concrete, sortisce un effetto disumanizzante.
3. Dare
Scarry
voce al dolore: da
Margo McCaffery
a
Elaine
Il dolore è “reale” nel senso che è provato da una persona: non
esiste quindi disancorato da innumerevoli specifiche esperienze. Il poter essere definito, nella sua intensità e nelle conseguenze che si oppongono alla qualità della vita, unicamente da chi lo
prova, è una acquisizione recente per le scienze mediche e per
il campo applicato della terapia e dell’assistenza. Si tratta infatti
di un ambito che si sottrae alle istanze di modelli oggettivanti
e di validità generale, in quanto la specifica qualità percettivocognitiva dell’esperienza del dolore la sottrae ai paradigmi conoscitivi consolidati. Questa riflessione fu ripresa dall’ostetrica
inglese Margo McCaffery, una tra le professioniste più impe-
96
Donatella Cozzi
gnate nel campo dell’applicazione della gestione del dolore e
nella divulgazione scientifica rivolta agli infermieri (McCaffery
M., 1983: 21): «il dolore è tutto ciò che il malato afferma che
sia, reale o immaginario, e per quanto insignificante possa sembrare all’osservatore esterno, il malato non ha dubbi della sua
esistenza e importanza».
Elaine Scarry (Scarry E., 1990 [1985]) si colloca entro questo nuovo ambito di consapevolezza, e in un poderoso testo
conduce una complessa riflessione sulla violenza, in cui si coglie
la meditazione di Simone Weil, alla luce del concetto di alienazione marxiana. Muovendo da osservazioni sulla difficoltà di
esprimere il dolore (avverte l’autrice che lavorare per dare voce
al dolore è lavorare contro la sua persistente, autoisolante intensità, e perciò contro il dolore stesso), Elaine Scarry esamina due
casi di pratiche il cui carattere distruttivo viene socialmente negato, opacizzato: la tortura e la guerra. La sequenza fondamentale dell’analisi è dedicata al nesso produzione-violenza: sofferenza, immaginazione, lavoro, oggetto prodotto, differenziando
tra il produrre come civiltà e il produrre come estraneazione.
Analogamente il corpo si inscrive in questa produzione: può
essere colto come espansione, attraverso oggetti e strumenti,
come creazione, “proiezione della vitalità”, mentre simmetricamente, la “decivilizzazione” distrugge il corpo, attraverso la
tortura e la guerra, o meglio il corpo si contrae a significare una
ideologia estranea vincente. L’Autrice analizza come il dolore
fisico occupi una posizione eccezionale nell’intero tessuto degli
stati psichici, somatici e percettivi, perché è l’unico stato privo
di un oggetto:
sebbene la capacità di esperire dolore fisico sia per gli esseri umani
un fatto altrettanto importante quanto la capacità di udire, toccare, desiderare, temere, aver fame, il dolore si distingue da questi
eventi e da ogni altro evento somatico e psichico, poiché non ha un
proprio oggetto nel mondo esterno. Si odono e si toccano oggetti
posti al di fuori dei confini del corpo, un desiderio è un desiderio
di x, la paura è paura di y, la fame è fame di z: ma il dolore non
4. Dolore
97
è «di» o «per» qualcosa – è soltanto se stesso. Questa mancanza
di oggetto, la totale assenza di un referente, impedisce di solito la
sua espressione linguistica: privo di oggetto, non può essere facilmente oggettivato in alcuna forma, materiale o verbale. Ma questa
mancanza di oggetto può anche dare origine all’immaginazione,
mettendo innanzitutto in moto il processo che alla fine porta alla
luce la marea di artefatti e di simboli che produciamo e fra cui ci
muoviamo (Scarry E., 1990 [1985]: 278).
La prima qualità che caratterizza il dolore, secondo Scarry, è
la sua refrattarietà al linguaggio. Questo è ancora più vero per
il dolore intenso e prolungato che può accompagnare un cancro, le ustioni, un’amputazione, così come il dolore intenso e
prolungato che si può provare senza che si manifesti una malattia definibile. Il dolore fisico non resiste solo al linguaggio,
ma lo distrugge attivamente, porta ad uno stato anteriore ad
esso, ai suoni e ai gemiti che un essere umano emette prima di
apprenderlo. Inoltre, l’esperienza dell’intensità del dolore non
può essere condivisa. Quando una persona ci parla del proprio
dolore, ciò che accade all’interno del suo corpo può assumere il carattere remoto di un evento sotterraneo e profondo. A
meno che la superficie del corpo non ne mostri le tracce che
lo giustificano e che lo rendono reale per noi – una ferita, una
piaga, un ascesso, un gonfiore – il dolore per chi non lo vive non
è reale: appartiene ad una geografia invisibile, perché non si è
ancora manifestato sulla superficie visibile del corpo. Il dolore
si trova nei corpi di persone che vivono nel mondo in cui si
svolge la nostra vita quotidiana, e che ad ogni istante possono
trovarsi soltanto a qualche centimetro di distanza da noi. Il segno del trionfo del dolore è che il suo carattere ripugnante è in
parte determinato dalla separazione completa tra il senso della
propria realtà e la realtà delle altre persone. Quando si parla
del proprio dolore fisico e del dolore fisico di un’altra persona,
può quasi sembrare che si stia parlando di due eventi completamente diversi. Chi soffre coglie il dolore naturalmente (cioè non
può non coglierlo, neppure con uno sforzo eroico), mentre per
98
Donatella Cozzi
chi è estraneo al corpo sofferente, viene naturale non cogliere
il dolore. È facile rimanere nella totale inconsapevolezza della
sua esistenza, anche facendo uno sforzo, se ne può dubitare, o
si può mantenere la straordinaria libertà di negarla. Alla fine,
anche se si riesce a coglierla con il massimo dell’empatia e un
prolungato sforzo dell’attenzione, quel qualcosa che si osserva
non sarà che una parte minuscola e vaga di quello che chiamiamo il vero dolore.
Così, per la persona che soffre, il proprio dolore è un fatto talmente incontestabile e indiscutibile che «provare dolore» può
essere pensato come l’esempio più convincente dell’«essere certi», per l’altra persona, invece, ciò è così difficile da afferrare
che «sentir parlare del dolore» può costituire il modello principale dell’«essere in dubbio». Così il dolore si insinua tra di noi,
senza che noi possiamo condividerlo, come ciò che non può
essere negato e non può essere provato al tempo stesso (Scarry
E., 1990 [1985]: 18-19).
Quindi il problema del dolore è il problema della relazione tra
colui che lo prova e gli altri, è il problema della sua comunicabilità e delle complicazioni percettive che ne derivano, dell’accogliere come veridica l’espressione altrui, è il problema della
sua esprimibilità sia corporea che verbale, è il problema di rappresentare fenomenologicamente il corpo nell’esperienza vissuta del sé. È la declinazione delle rappresentazioni che hanno il
corpo per oggetto e insieme il rendere conto della conoscenza
incorporata del mondo. È porre attenzione ai dispositivi di regolazione, di controllo, di sorveglianza, di dominio dei corpi.
4. Dolore
e comunicabilità: il dilemma del paziente manipo-
lativo e del dolore cronico
Il primo problema è quindi quello della comunicabilità: poiché la persona che soffre esprime con difficoltà quanto prova,
4. Dolore
99
il linguaggio adatto al dolore viene talvolta creato da coloro che
non soffrono, ma parlano per conto di chi soffre. Il confronto
tra gli studi culturalisti degli anni Settanta e Ottanta e gli studi
degli ultimi 15 anni evidenza la svolta dalla leggibilità dei codici
e delle espressioni del dolore, quali repertori di segni ed espressioni che la comparazione culturale costruisce come evidenti, al
dibattito sulla loro opacità. Due sono le forme di questo dibattito: la prima è interna all’antropologia medica, e si verticalizza
nella riflessione fenomenologica e interpretativa sulla comunicabilità del dolore. La seconda matura nella pratica clinica
e assistenziale, e si sostanzia nella necessità di comprendere il
dolore per l’interpretazione clinica e il darne sollievo.
Quando il dolore diventa cronico, si viene a complicare la
possibilità di una rappresentazione culturale. Atipico e difficilmente diagnosticabile, il dolore cronico sfida le forme convenzionali di significato. Soprattutto quando viene a mancare
una causa facilmente rintracciabile (come nel caso di emicranie persistenti, alcune forme di mal di schiena, della sindrome
temporo-mandibolare, eccetera), si avanza il dubbio che il dolore manifestato non sia reale, “stia tutto nella testa”, o che sia
espressione di mala fede. Molti tra coloro che soffrono di sindromi di dolore cronico, dal canto loro dicono “dopo un po’
nessuno ti crede”. Dalla malattia, intesa come disease, ovvero
quale viene definita all’interno del modello biomedico, si passa
spesso alla valutazione morale: è una incapacità della volontà,
è un lasciarsi andare al lamento senza sapersi controllare, è la
cattiva abitudine appresa a casa propria, dove tutti «corrono
dietro al paziente». Arthur Kleinman (DelVecchio Good M.J. - Brodwin P.E. - Good B.J. - Kleinman A., 1992), dedica
pagine di severa critica al “modello del paziente manipolativo”,
che si ritiene tragga “vantaggi” dalla sua “vera” o “falsa” condizione di malattia. Un modello che poggia sulla radicalizzazione dell’opposizione tra psiche e soma, all’interno della quale si
suppone l’almeno parziale influenza di un controllo volontario
sui propri sintomi, della cui sincerità si diffida. Questo modello
interpretativo si basa sull’assunzione che il soggetto conoscen-
100
Donatella Cozzi
te sia un agente individuale razionale, in grado di utilizzare la
ragione strumentale per raggiungere determinati scopi nel suo
mondo quotidiano. La sofferenza è una risposta privata del soggetto, e fintantoché questo soggetto è socialmente competente,
può controllare il fatto che la malattia incida sulla sua vita di
relazione, esterna al suo corpo sofferente. La psicologia ha ridimensionato il riduzionismo biologico: invece di affondare il dolore nelle condizioni oggettive del corpo, essa guarda al dolore
come prodotto o mantenuto in base ad alcuni principi. Tuttavia
spesso all’interno di questa interpretazione vengono mantenute
le stesse categorie che sottostanno all’approccio medico. Se la
letteratura medica sottolinea i processi somatici, qui si focalizza la mente soggettiva (come soggetta a specifiche contingenze comportamentali e dinamiche familiari). Entrambe queste
tradizioni tendono ad ignorare che l’esperienza immediata del
dolore unifica le sue origini corporee, psicologiche e sociali. Il
concetto di “vantaggi” (primari o secondari) che deriverebbero al paziente dalla sua condizione di malattia, esamina come,
ad esempio, le risposte comportamentali della famiglia possano
rafforzare un vissuto di malattia, e come attraverso sintomi e
dolore fisico si possano controllare gli altri, giustificare la propria dipendenza, essere lasciati in pace, evitare i rapporti sessuali, punire gli altri, controllare la propria rabbia, evitare le
relazioni troppo intime. Sono facilmente comprensibili gli effetti negativi di questi comportamenti, che descrivono i giochi manipolativi dei pazienti che usano i propri sintomi per dominare
la propria famiglia o sfuggire alle proprie responsabilità. Ora,
se da un lato è vero che sintomi e dolore ristrutturano la vita
dell’individuo e quella di chi gli sta intorno, se è vero che esistono famiglie che si impadroniscono dei sintomi di un familiare
o di un figlio per distogliere l’attenzione dai conflitti esistenti e
mantenere un precario equilibrio che le metta al riparo dall’affrontare crisi e cambiamenti, è anche vero che non è facile dire
dove finisce la sofferenza del corpo e inizia la manipolazione,
quanto si è coscienti e si è in grado di controllare i sintomi e il
dolore, e, soprattutto, se questo dolore fisico è “vero” o “falso”.
4. Dolore
101
Il medesimo interrogativo viene sollevato da medici e operatori
sanitari che incontrano, per le visite obbligatorie o su richiesta,
molti rifugiati e richiedenti asilo dei Centri di accoglienza: quel
dolore allo stomaco, o alla testa, quel malessere diffuso e opaco
che resiste ad ogni diagnosi puntuale, parla attraverso un corpo sofferente in cui è inscritta la «temporalità sotto assedio»
(Beneduce R., 1998) di coloro che sono in attesa di definire il
loro status.
La dicotomia tra mente e corpo sostenuta sia dalla ricerca
medica che da una parte di quella psicologica, mortifica e indigna molti pazienti quando la loro esperienza viene screditata e
messa in dubbio come “non reale”, o come dolore “funzionale”, quando il dolore fisico che comunque provano viene considerato “un problema psicologico, non un problema medico”.
Attribuire questo dolore ad una disfunzione della mente piuttosto che del corpo implica che è colui che soffre che deve essere
biasimato sia per il dolore sia per il fallimento del medico a
trovare una cura.
A partire dal dolore cronico, la prospettiva antropologica sostenuta dagli estensori di Pain as human experience (DelVecchio
Good M.J. - Brodwin P.E. - Good B.J. - Kleinman A., 1992)
ribadisce che l’esperienza del dolore richiede sempre un riorientamento cognitivo da parte della persona. Qualsiasi evento di malattia e in modo particolare quelle gravi o croniche,
costituiscono un assalto ontologico che sfida la relazione tra il
corpo, il self e mondo circostante. Diventa a questo punto importante concentrarsi su come viene riferita, narrata, proposta
l’esperienza del soggetto, rivelando la dialettica tra i generi, le
modalità di “resistenza”, le condizioni socio-economiche che
contribuiscono a mantenere subordinazione, miseria, malattia,
disabilità, dispiegate come embodiment, incorporazione.
È ancora il testo di Elaine Scarry ed il problema della comunicabilità del dolore ad essere motore di riflessioni critiche:
Vincent Crapanzano (Crapanzano V., 1996), muove la sua critica a Elaine Scarry alla luce della visione di Lacan, pur condividendo che il dolore del corpo è una percezione costituti-
102
Donatella Cozzi
vamente priva di oggetto. Oltre al dolore, vi sono anche altri
stati privi di un oggetto, come l’angoscia, o il godimento, e la
mancanza oggettuale di uno stato non ne impedisce la figurazione, come nella poesia o nelle arti figurative. Al contrario,
Crapanzano pone il dolore a fondamento della significazione, e
i suoni e grida che Scarry considera anteriori al linguaggio vengono letti come istanza comunicativa, richiamo all’empatia, non
più espressione di un sé isolato, di un corpo isolato. Il dolore ha
quindi una dimensione interpersonale, interlocutoria. L’Autore
ribadisce l’impossibilità di raggiungere una definizione univoca
del corpo, e ricorda che il corpo non può mai essere considerato al di fuori dell’esperienza della sofferenza, nella misura in
cui parlare il/del corpo equivale ad agirlo. In questa azione si
basa fenomenologicamente l’esigenza di una intersoggettività.
Questo deve valere come monito alle scienze sociali in generale,
di fronte al pericolo di mimare quel silenzio che collude a perpetuare le forme di sofferenza.
5. Il genere del dolore
Le donne provano la temperatura del ferro da stiro toccandolo.
Brucia ma non si bruciano. Respirano forte quando l’ostetrica dice
«non urli, non è mica la prima». Imparano a cantare piangendo, a
suonare con un braccio che pesa come un macigno per la malattia, a sciare con le ossa rotte. Portano i figli in braccio per giorni
in certe traversate del deserto, dei mari sui barconi, della città a
piedi su e giù per gli autobus. Le donne hanno più confidenza
col dolore. Del corpo, dell’anima. È un compagno di vita, è un
nemico tanto familiare da esser quasi amico, è una cosa che c’è e
non c’è molto da discutere. Ci si vive, è normale. Strillare disperde
le energie, lamentarsi non serve. Trasformarlo, invece: ecco cosa
serve. Trasformare il dolore in forza. Ignorarlo, domarlo, metterlo
da qualche parte perché lasci fiorire qualcosa. È una lezione antica, una sapienza muta e segreta: ciascuna lo sa (De Gregorio C.,
2008: 3).
Se il dolore è una dimensione umana universale, è legittimo
4. Dolore
103
leggervi una dimensione di genere? Nel caso di una risposta
positiva, cosa di questa lettura arricchisce il tema generale di cui
stiamo trattando? Più che a inverare la differenza, le peculiarità di genere, ci permettono di approfondire il tema delle precomprensioni cognitive e culturali in gioco quando si affrontano i problemi posti dal dolore. Abbiamo notato come i primi
studi sull’espressione del dolore siano sorti all’interno di uno
spazio decisionale e terapeutico connotato al maschile, come
l’ospedale per veterani in cui si svolge lo studio pioneristico di
Zborowski degli anni Cinquanta del Novecento. Nel solco di
quella lettura generalizzante l’esito è stato duplice: spesso si è
espunta una prospettiva di genere, considerando l’espressione
del dolore come esito di eventuali differenze culturali, ma non
di differenze di genere. Altre volte, del dolore delle donne si
è accentuato il carattere di “eccessività” espressiva, cresciuto
entro lo stereotipo di matrice ottocentesca della donna come
sregolata detentrice del primato emotivo tra i sessi. Il dolore
espresso dalle donne sarebbe quindi due volte soggetto a fraintendimento: perché le donne sono spesso considerate testimoni inaffidabili, e perché, soprattutto in caso di dolore cronico,
“dopo un po’ nessuno ti crede”.
Emma Whelan (2003) mette a confronto due strumenti di
valutazione costruiti per le donne che soffrono di endometriosi.
Quest’ultima è una malattia cronica frequentemente descritta
come ‘enigmatica’ da parte dei professionisti medici, a causa della quale alcuni tessuti collocati nella cavità perineale, in
siti esterni all’utero, durante il periodo mestruale si dilatano e
sanguinano, ma non possono essere espulsi dal corpo con le
mestruazioni. Oltre a dismenorrea, l’endometriosi è associata
a dolore pelvico cronico, infertilità ed una ampia gamma di
disturbi. Whelan mette a confronto lo strumento elaborato
dall’American Fertility Association, associazione professionale
costituita da ginecologi, ostetrici ed endocrinologi con quello
sviluppato da Andrea Mankoski, una donna affetta da endometriosi. Il punto di partenza del confronto è originale: nel
caso dell’endometriosi – ma si può allargarlo ad altre patolo-
104
Donatella Cozzi
gie - l’autrice contrappone quanto condiviso da una ‘comunità
epistemologica’, in questo caso le donne che collettivamente, e
non solo individualmente fanno esperienza della malattia, con
quanto prodotto da una comunità esperta, quella dei professionisti medici. Ad essere comparati sono i saperi elaborati da
due comunità, quindi, diversamente ‘esperte’: «suggerisco che
questo concetto di comunità epistemologiche di pazienti potrebbe essere particolarmente utile nel contesto presente, considerata la proliferazione dei gruppi di supporto su Internet,
che sono i riti di interazione di queste comunità di pazienti»
(Whelan E., 2003: 465). Le frontiere che separano le comunità
epistemologiche non sono date o autoevidenti, piuttosto sono
il prodotto di quanto un sociologo della scienza come Thomas
Gieryn (1983, 1999) chiama boundary work: una frontiera flessibile, nella pratica spesso violata. Nel caso dell’endometriosi,
ogni comunità prende in prestito risorse epistemiche dall’altra,
per affermare qualcosa ed apparire credibile, di fatto superando il confine tra esperti e profani. La co-dipendenza e, insieme,
il conflitto tra le due comunità è illustrata dagli strumenti che
ciascuna di esse sviluppa per accertare, e forse costruire, l’oggetto “dolore da endometriosi”. Per oltre ottant’anni, i ginecologi hanno sviluppato classificazioni dell’endometriosi, che
potessero rendere questa patologia più affrontabile. La classificazione dell’American Fertility Society prende soprattutto in
considerazione l’infertilità, sottostimando il sintomo principale, ovvero il dolore pelvico. Dipende, come molte altre scale di
valutazione del dolore, dalla percezione di una scala visiva, in
grado di stimare quanto la malattia sia estesa, ma non di determinarne l’attività. Infatti, pare esservi una correlazione inversa
tra l’attività endometriotica e lo stadio di classificazione: una
minima endometriosi anatomica produce una infiammazione
maggiore rispetto ad una endometriosi anatomicamente estesa. Paradossalmente, una endometriosi grave anatomicamente
produce meno sintomi, e meno dolore, di una endometriosi
allo stato iniziale o poco estesa. Come appare evidente, questo strumento di accertamento non è in grado di tracciare una
4. Dolore
105
qualche conclusione sulla relazione tra dolore ed endometriosi.
Lo strumento di accertamento dell’American Fertility Society
unisce infine indicatori fisici – riscontrabili dai medici – alla valutazione soggettiva della paziente, che è invitata ad esprimere
con alcuni aggettivi la qualità del proprio dolore. Quando ciò
che viene riferito dalle donne coincide con quanto rilevato dai
medici, quando la mappatura fisica della malattia combacia con
la geografia fisica del dolore, la narrazione della malata viene solidificata, resa oggetto. Talvolta, però, resoconto della paziente
e indagine fisica non trovano coincidenza, e quanto narrato dalla donna viene screditato, messo in dubbio. Seguendo Emma
Whelan, è lunga la traiettoria storica che stringe un legame
causale tra la salute riproduttiva e quella mentale della donna
e nella ginecologia contemporanea l’endometriosi continua ad
essere considerata come un fenomeno la cui eziologia è tanto
fisica quanto psicologica.
Il dolore e le sue rappresentazioni possono allora esprimere
forme di resistenza alla vulgata dominante, rivendicando margini di contrattazione, attraverso l’elaborazione di strumenti
alternativi e di visibilità. Il tema del dolore, attraverso il prisma della sofferenza di genere, permette quindi di sviluppare
le dinamiche di potere implicite negli spazi di cura evidenti
nelle diverse “comunità esperte”, le forme di negoziazione e di
costruzione di soggettività, le implicazioni relazionali e quelle
epistemologiche alla base della interpretazione delle evidenze
cliniche, della loro definizione e di quella degli strumenti atti a
valutare il dolore vissuto.
6. Strumenti di valutazione, assistenza sanitaria ed espressione del dolore
«Quando faccio esperienza del dolore, la sua realtà è insistente
ed autoevidente per me. Ma solo per me. Per gli altri, il mio dolore può non essere nulla di più che il resoconto del mio dolore»
(Whelan E. 2003: 463).
106
Donatella Cozzi
Provare dolore sfida il linguaggio e la capacità di comunicarlo all’esterno del corpo. Sapere quanto dolore prova una
persona è insieme il primo atto di sollecitudine di chi cura ed
assiste e la pietra d’inciampo per ogni pretesa di oggettivazione.
Indubitabile per chi ne fa esperienza, il dolore aggiunge alla
sofferenza che imprime quella di alimentare il dubbio di chi
si volge a coglierlo dall’esterno, in assenza di strumenti che
permettano di darne una misurazione oggettiva. In un ambito
come quello clinico in cui prevale la pretesa di riuscire a tradurre ogni esperienza del corpo in dato oggettivo, l’esperienza del
dolore per la sua stessa specificità si sottrae a questo universalismo misuratore. Cerchiamo di sfidare la dimensione privata e
individuale del dolore definendolo, misurandolo, teorizzandolo
ed analizzando la narrazione di qualcuno che lo prova. Ma le
rappresentazioni del dolore non sono equivalenti al dolore in
sé. Come esperienza è privata e soggettiva e crea una separazione
tra chi soffre e chi osserva. Isabelle Baszanger, nel suo studio sull’”invenzione” della medicina del dolore, nota come gli strumenti
di accertamento e classificazione del dolore siano stati essenziali
per farne un oggetto ‘malleabile’, affrontabile oltrepassando la
sfida soggettiva che propone. Intorno a questo oggetto la comunità professionale può organizzarsi: «la classificazione gioca un
ruolo essenziale nel creare una comunità di pratiche e può diventare una base comune attraverso la quale i medici comunicano tra
loro e con gli altri» (Baszanger I., 1995: 34).
Lo studio di Whelan, citato nel paragrafo precedente, riporta come, quando si chieda - ad esempio nel caso dell’endometriosi - di esprimere la qualità del dolore scegliendo cinque
aggettivi, questi possono essere usati in modo diverso da persone diverse, ed anche impiegati differentemente dalla stessa
persona in momenti diversi.
Oltre alla complessità che il tema della comunicazione del
dolore schiude per la riflessione antropologica, riposa un grande quesito di fondo, pertinente la possibilità della sua ‘rappresentazione’ (e rappresentabilità). Comunicare e prestare ascolto al dolore ha comportato e comporta sviluppare strumenti in
4. Dolore
107
grado di affrontare la difficoltà di rendere accessibile qualcosa
che è incarnato in chi ne fa esperienza, quindi in una soggettività irriducibile, e rendere tali ‘traduzioni’ congruenti allo scopo di curare, lenire il dolore, renderlo significativo per comprendere cosa succede nel corpo della persona sofferente. Gli
strumenti di assessment del dolore rispondono all’esigenza di
generalizzazione e comparazione delle esperienze individuali,
ma presentano il rischio di ridurre l’esperienza di chi soffre o di
sovrapporre il dato tecnico - di norma espresso numericamente - al vissuto. Questa esigenza si è diffusa particolarmente in
Italia dopo l’emissione delle Linee guida per la realizzazione dell’”ospedale senza dolore” (Gazzetta della Repubblica Italiana,
2001), che, con un ritardo storico non indifferente rispetto ad
altre nazioni europee, ha dato impulso ad un nuovo atteggiamento verso questo problema. L’argomento di quali strumenti
utilizzare per la valutazione del dolore dei pazienti e di come
affrontare la comunicazione del dolore in persone con difficoltà
espressive o cognitivamente svantaggiate è stato variamente affrontato nei protocolli delle aziende sanitarie che si conformano alle Linee guida, dando luogo sia a ricerche e discussioni che
permettono una critica culturale degli strumenti adottati, e che
si pongono con attenzione il problema della comunicazione del
dolore, sia a pratiche che inficiano la portata delle Linee guida,
vanificandone gli scopi. Mancano dati concreti su quanto siano
effettivamente diffusi negli ospedali italiani il rilevamento del
dolore e le équipes antalgiche, alle quali esso viene demandato
soprattutto nel periodo post-operatorio, e su quale sia la loro
composizione (che vedrebbe l’obbligo della presenza di un medico anestesista). Nel divario sempre possibile tra la teoria della
pratica corretta e la sua applicazione nelle singole realtà, si raccolgono notizie sconfortanti: molti medici ospedalieri continuano a considerare la presenza di dolore post-operatorio ‘utile’ per
comprendere il decorso dopo l’operazione, alla rilevazione del
dolore talvolta vengono delegati gli studenti infermieri, indice
che il compito non viene stimato come proprio di una professionalità matura, e quanto essi raccolgono viene poi re-interpre-
108
Donatella Cozzi
tato dall’infermiere dirigente – segno che occorre ‘correggere’
la traduzione che del dolore dei ricoverati essi fanno, portando
ad una approssimazione di secondo grado rispetto alla enunciazione di chi sta provando dolore, si tende a delegare in toto
all’équipe antalgica rilevazione e trattamento del dolore, come
se fosse un ambito di specializzazione e non un atteggiamento
del prendersi cura della persona che deve essere ubiquitario in
ogni ambito sanitario. Soprattutto, come vedremo nelle righe
che seguono, ci si affida spesso acriticamente agli strumenti di
assessment: invece di considerarli una traduzione formalizzata e
una trasformazione dell’esperienza dell’altro, quindi come una
‘finzione’ in senso etimologico utile per fondare un linguaggio
comune che permetta ai vari professionisti che collaborano alla
gestione del sintomo di interagire in modo affidabile, questi
strumenti possono essere considerati come validi, oggettivi ed
affidabili in sé e per sé, in grado di sostituire ‘naturalmente’
l’esperienza, la parola, i bisogni, il vissuto della persona che soffre. L’equivoco nasce dalla ipoteca di misurazione che grava su
questi strumenti. Misura che, per definizione, si pone sempre
come invariante ed oggettiva. Per nulla diffusi sono invece altri
strumenti – ad esempio il McCaffery Questionnaire – che non
misurano l’intensità del dolore, piuttosto chiedono alle persone
come esso interferisce nella loro quotidianità (nel ritmo sonnoveglia, nell’appetito, nel movimento, nelle attività di lavoro e
svago, nel desiderio di incontrare e stare con gli altri) e come
questo cambia dopo la somministrazione di analgesici. Infatti,
cogliere solo l’intensità del dolore è un approccio limitato ad
una unica dimensione, che trascura la fenomenologia della qualità di vita percepita dalle persone.
Esaminiamo rapidamente alcuni tra gli strumenti più diffusi,
per passare in rassegna le critiche ad essi rivolte, che mettono in
luce la loro natura culturalmente orientata e come essi riposino
su particolari pre-comprensioni culturali.
- NRS (Numerical Rating Scale) si presenta come una linea di dieci centimetri, ancorata a descrittori verbali, tra due
4. Dolore
109
estremi, in cui 0 corrisponde a ‘nessun dolore’ e 10 a ‘dolore
insopportabile’. Al paziente viene richiesto di posizionarsi,
verbalmente o graficamente (ad esempio con un tratto di
penna) su questa linea. È molto diffusa per la facilità di impiego, ma sconsigliata nel caso di persone che presentano
problemi cognitivi, e inoltre perché in due momenti anche
di poco successivi l’intensità segnalata può variare. Le persone che non sono in grado di rispondere a questa scala –
come i sordi, molti anziani, i bambini - vengono escluse dalle
ricerche che hanno lo scopo di testare l’affidabilità di questo
strumento. Può essere fraintesa, ad esempio in Italia, perché
a questa scala si sovrappongono altre tipologie di valutazione, come quella scolastica, secondo la quale l’indice numerico più basso corrisponde alla performance peggiore e quello
più alto a quella migliore. Così, in perfetta buona fede, si
può dare alla sensazione di dolore l’indice numerico ‘7’ – volendo esprimere una sensazione di dolore lieve – quando per
gli operatori ‘7’ comporta una verifica clinica delle condizioni del paziente e/o la somministrazione rapida di analgesici,
in quanto vicina al limite di dolore non sopportabile. Questa
scala inoltre, è poco atta a descrivere l’intensità del dolore
in quegli ambiti culturali in cui scrittura e lettura non si dispongono su un asse orizzontale da sinistra a destra.
- VAS (Visual Analogue Scale), simile alla precedente,
si presenta come una linea di dieci centimetri, ancorata a
descrittori verbali, tra due estremi, in cui 0 corrisponde a
‘nessun dolore’ e 10 a ‘dolore insopportabile’. In questo
caso la linea presenta, come un righello, segni disposti ad un
centimetro l’uno dall’altro per sottolineare la progressione
numerica. Gli errori ed i fraintendimenti più frequenti sono
simili alla NRS.
- FPS (Faces Pain Scale), studiata per la misurazione del
dolore in ambito pediatrico, presenta una serie di ‘faccine’
(in numero di 6 o 7) ciascuna delle quali esprime una espressione da sorridente (‘nessun dolore’) a piangente (‘dolore
insopportabile’). Facilmente comprensibile, non richiede
110
Donatella Cozzi
competenze di lettura o scrittura (si chiede al bambino di indicare quale ‘faccina’ esprima meglio come ci si sente), e viene anche utilizzata nel caso di adulti, come anziani o persone
con difficoltà di espressione, in questo caso stilizzando con
tratti meno infantili ogni singola espressione. In quest’ultimo caso però, essendo le stilizzazioni legate ad emozioni culturalmente formalizzate e a percezioni di genere – piangere
non ha lo stesso significato ovunque -, è alta la possibilità di
incomprensioni.
- IPT (Iowa Pain Thermometer) consiste in sette descrittori della diversa intensità di dolore (da ‘nessun dolore’ a
‘dolore insopportabile’) disposti verticalmente, simulando
graficamente un termometro, in cui più si sale, più intensa è
la sensazione di dolore.
Una ricerca recente, condotta tra persone sorde, è in grado di
mostrare i limiti di questi strumenti (Palese A.- Salvador L. –
Cozzi D., 2011) evidenziandone le pre-comprensioni culturali
implicite. Oltre a quelle già segnalate per la NRS e la VAS, è
privilegiata l’espressione verbale e l’udito, che mette in difficoltà chi non abbia una competenza linguistica adeguata o chi
abbia lesi questi canali sensoriali. Se l’ambiente non è adeguatamente illuminato, le persone sorde non sono in grado di leggere
l’espressione labiale dell’operatore che sta somministrando lo
strumento, e questo rinvia ad una variabile spesso trascurata,
ovvero le condizioni ambientali nelle quali avviene sovente la
comunicazione tra operatori e pazienti. Inoltre, molti adulti
possono sentirsi offesi dell’essere trattati come bambini a cui
vengono mostrate ‘faccine’, considerate consone all’infanzia
o a persone con problemi mentali. ‘Faccine’ che non tengono
conto di come, nella LIS (Lingua Italiana dei Sordi) le espressioni facciali sono quasi sempre in relazione con sentimenti ed
emozioni – essere allegri, tristi.. - e non hanno una correlazione
diretta con il dolore. Anche in questo caso non si riflette sulla
natura convenzionale della sovrapposizione tra espressione ed
emozione, considerandole culturalmente neutre.
4. Dolore
111
Nel periodo immediatamente successivo all’emissione delle
Linee guida, chi scrive è stata coinvolta in numerose attività di
formazione concernenti il dolore rivolte agli infermieri, e una
delle domande ricorrenti riguardava “come rendere oggettiva
la risposta soggettiva del paziente”. È una domanda significativa: allo stesso tempo rivela le implicazioni epistemologiche di
una assistenza che inevitabilmente si confronta con il paradigma biomedico e l’implicita depersonalizzazione di tale modello
e insieme mostra una professionalità che talvolta si dibatte tra
personalizzazione e standardizzazione dell’assistenza. Infine
produce riflessione e consapevolezza sugli aspetti che circondano la valutazione del dolore attraverso gli strumenti che abbiamo brevemente presentato: dare ascolto al dolore, renderne la
densità di esperienza vissuta, che è culturalmente produttrice di
senso e di pratiche sociali. A questa domanda, talvolta ne seguiva una seconda: come gli stranieri (ovvero ‘come le altre culture’) esprimono il dolore. Quando la “differenza” è tutto ciò che
notiamo nell’Altro (e gli strumenti che richiediamo all’esperto
devono sedare la nostra ansia non tanto di comprendere quanto
di normalizzare l’Alterità, la malattia, la vecchiaia, riconducendola a quanto ci è noto), le attribuiamo una concretezza che si
fa ostacolo all’incontro. A questa opera di trinceramento dietro
alle nostre pre-comprensioni culturali, che schiaccia in dimensioni univoche le varie forme di umanità e non tiene conto della
plurivocalità dell’accoglienza, può contribuire anche la riflessione filosofica, quando non tiene conto della singolarità delle
esperienze, del loro trovare espressione in linguaggi comuni. Si
rischia uno slittamento verso una concezione univoca, rocciosa,
imperiosa dell’essere uomini o donne. Di questo costruire la
differenza, se non è presente una vigile capacità di ascolto, che
trasforma le pratiche e la relazione terapeutica, si nutre anche
una parte della teoria del nursing transculturale, quando esalta
le modalità attraverso le quali i membri di ciascuna “cultura”
mantengono e difendono la propria salute in modi peculiari,
senza rilevare la complessità del nostro mondo attuale o senza considerare che quanto viene considerato come “cultura” è
112
Donatella Cozzi
molto più questione di quello che ciascuno di noi “fa” che una
essenza che ci compenetra.
Giovanni Pizza e Helle Johannessen
5. Incorporazione e Stato1
Obiettivo di queste pagine non è quello di passare in rassegna i
dibattiti accademici sull’incorporazione da un lato e sullo Stato
dall’altro. Cercheremo soltanto di discutere alcuni significati e
implicazioni dei due concetti, per poi provare a focalizzarne la
relazione, cioè a delineare qualche tratto del rapporto fra l’incorporazione e lo Stato.
1. Sull’incorporazione
L’incorporazione è un concetto ingannevole, apparentemente
facile da comprendere perché presente in maniera irriflessa
nel contesto dei discorsi ordinari, oggetto di contese piuttosto
1. Questo testo è la versione italiana – leggermente modificata e arricchita – della prefazione inglese dal titolo originale Editorial. Two or three things
about Embodiment and the State, al numero monografico di “AM. Rivista della Società italiana di antropologia medica”, n. 27-28, ottobre 2009, a cura di
Giovanni Pizza e Helle Johannessen, dedicato a Embodiment and the State.
Health, biopolitics and the intimate life of State powers. Gli articoli in esso
contenuti sono di Seppilli T., Pizza G. - Johannessen H., Young A., Palumbo
B., Zempléni A., Pandolfi M. - McFalls L., Ravenda A.F., Johannessen H.,
Minelli M., Brogård Kristensen D., Middelthon A.L., Rostgård L., Pizza
G., Lock M (2009). Tali lavori possono essere considerati come contributi a
una discussione che incroci medicina e politica. Desideriamo manifestare qui
la nostra profonda e affettuosa gratitudine a Tullio Seppilli, per avere egli incoraggiato e favorito questa discussione, accogliendone i risultati nella Rivista
da lui diretta. Immaginato ed elaborato in comune, il testo è stato materialmente scritto: da H. Johannessen, il primo paragrafo (Sull’incorporazione), da
G. Pizza, il secondo (Sullo Stato), da entrambi, il terzo (Statualità della vita
quotidiana). La traduzione dall’inglese è di G. Pizza.
114
Giovanni Pizza e Helle Johannessen
complesse nei dibattiti scientifici internazionali. In antropologia
esso indica i modi corporei di abitudine al mondo, designando
al tempo stesso l’iscrizione dei processi sociali nel corpo e l’iscrizione del corpo nei processi sociali. La parola italiana traduce l’originale termine inglese embodiment, la cui apparente leggerezza deriva dal suo significato ovvio nell’inglese ordinario.
Secondo il Dizionario Oxford della lingua inglese, embodiment
è il nome riferito al verbo to embody, che significa: «Rendere
([una] idea, ecc.) reale o discernibile, (di cose), essere espressione
di, includere, comprendere». Il verbo inglese to embody accomuna significati che in italiano sono distribuiti a due verbi: incorporare e incarnare. Secondo il Dizionario Zanichelli della lingua
italiana, infatti, incarnare vuol dire appunto «Dare corpo e figura,
rappresentare concretamente e con efficacia: i. un concetto, un’idea, un’immagine, un tipo (…)», mentre il significato aggiuntivo
di includere, comprendere, assorbire è connesso a incorporare,
anche se nel parlare comune i due verbi tendono ad essere in
gran parte sinonimi. Stando a tali significati ordinari, potremmo
dire, ad esempio, che una multinazionale è l’incorporazione del
capitalismo, un anello nuziale è l’incorporazione del legame tra
un marito e una moglie, o che questo scritto incorpora idee che
si sono manifestate nella nostra mente alcuni anni fa.
Come accade a molti altri concetti quotidiani, anche l’incorporazione è stata inclusa nel discorso accademico e qui discussa
e ridefinita nel corso del tempo. Pertanto questo nostro contributo è una riflessione personale che si basa sui nostri punti di
vista di antropologi, e quindi esprime una chiara inclinazione a
usare il termine nel senso antropologico.
Una importante messa a punto nell’uso antropologico
del concetto di incorporazione è costituita da un articolo di
Thomas Csordas pubblicato nel 1990, nel quale l’antropologo
statunitense propose di considerare l’embodiment come paradigma per l’antropologia (Csordas T., 1990). Csordas cercò di
mostrare come lo studio della cultura e del sé potesse giovarsi
del paradigma antropologico dell’incorporazione (ibidem: 5).
Egli sosteneva che «il corpo non è un oggetto da studiare in
5. Incorporazione e Stato
115
rapporto alla cultura, ma deve essere considerato come il soggetto, oppure in altri termini come la base esistenziale della
cultura» (ibidem, corsivo originale). Csordas si rifaceva a tre
autori in particolare: Alfred Irving Hallowell (1892-1974), per i
suoi lavori sulla costituzione culturale del sé, Maurice Merleau
Ponty (1908-1961), sul problematico rapporto tra il corpo e la
percezione, e Pierre Bourdieu (1930-2002), per i suoi studi sui
processi di incorporazione come pratica sociale (ibidem: 5-8).
Riflettendo sulle concettualizzazioni del sé, della cultura, del
corpo, della percezione, dell’habitus e della pratica, che nei
dibattiti appaiono talora contraddirsi l’una con l’altra, fino al
paradosso, Csordas identifica l’incorporazione come un concetto sovraordinato che comprende e rende compatibili la visione
fenomenologica con quello che egli denomina “strutturalismo
dialettico” (ibidem: 12).
In queste prime proposte di Csordas riscontriamo due questioni di interesse tuttora fondamentale. La prima è che, nella
interpretazione dell’antropologo statunitense, l’incorporazione
si conferma come una caratteristica intimamente connessa al
corpo umano. Muovendosi così agilmente da un concetto all’altro, dal corpo al sé, dalla cultura all’incorporazione, Csordas
sembra evidenziare un percorso personale che punta a coniugare una antropologia culturale del sé con una esplorazione
filosofica dei fondamenti corporei della percezione e con una
teoria sociale dei rapporti fra pratiche sociali e corporee. In una
pubblicazione successiva, Csordas definisce l’incorporazione
retoricamente attraverso un paragone: il rapporto fra corpo e
incorporazione è equiparato al rapporto fra testo e testualità.
Questa figura retorica gli consente di definire «“il corpo” come
l’entità biologica, materiale, e l’“incorporazione” come un campo metodologico indeterminato, definito dalla esperienza percettiva e dalle forme della presenza e dell’essere impegnati nel
mondo» (Csordas T., 1994: 12). In questa lettura, l’incorporazione diventa un concetto riferito alla percezione corporea e
all’esperienza dell’essere-nel-mondo, in una stretta connessione
con il corpo umano individuale destinata a consolidarsi nel di-
116
Giovanni Pizza e Helle Johannessen
battito successivo senza mai essere messa in discussione. Per
gli studiosi impegnati nelle scienze sociali della medicina è certamente molto rilevante riferirsi al corpo umano, dato che tale
entità è il soggetto/oggetto della malattia, della terapia e della
cura. Eppure – ripensando al suo significato ordinario – noi
vorremmo guardare alla possibilità di considerare l’incorporazione come un concetto più ampio e comprensivo, che non si
riferisca soltanto alla fenomenologia della percezione e all’esperienza corporea umana, ma che piuttosto possa essere ricondotto alla pratica che rende le idee, le ideologie o i rapporti di
potere, reali e discernibili, concreti ed efficaci nella vita sociale
e personale degli esseri umani.
Il secondo punto di interesse ancora attuale nella proposta
di Csordas dell’incorporazione come paradigma, è il tentativo
di coniugare prospettive intellettuali diverse, dell’antropologia culturale, della fenomenologia e della sociologia strutturale, in una comune cornice teorica. Perseguendo tale obiettivo
egli illumina la questione del rapporto tra l’agente e il contesto
dell’agire. Un argomento discusso fin dai primi passi dell’antropologia, e che può essere considerato come il cardine di questa
disciplina. Il dibattito antropologico si è trasformato nel corso
del tempo, poiché nuovi sviluppi teorici sono stati introdotti,
ma sembra che – sotto diverse spoglie – queste due prospettive generali dell’antropologia ancora continuino a contrastarsi.
Pensiamo qui a quello che nell’antropologia internazionale si
andò configurando ora come contesa fra struttura e agentività ora come polemica tra fenomenologia e costruttivismo. La
costante di queste discussioni era stabilire la direzione dell’influenza: è la capacità di agire umana a produrre la società o è la
società a determinare l’esperienza umana? La percezione è una
caratteristica preoggettiva, fenomenologica e soggettiva o essa
si costruisce entro specifici rapporti sociali e di potere?
Il dibattito sull’incorporazione sembra portare ancora
i segni di queste antiche discussioni (Pizza G., 2005: 37-43).
L’isolamento dell’incorporazione all’interno di un approccio
fenomenologico al corpo umano pare essere diventato paradig-
5. Incorporazione e Stato
117
matico, poiché gli studi sull’incorporazione per lungo tempo
hanno ampiamente privilegiato l’esperienza soggettiva del corpo e dell’essere nel mondo. Ad ogni modo, in questi studi l’incorporazione è stata spesso intesa come uno strumento concettuale per estendere l’idea del corpo: da una materialità corporale di muscoli e ossa, tipica della biomedicina, a una concezione
comprensiva dell’esperienza corporea soggettiva e dei modi di
esistenza in un mondo sociale. Noi sosteniamo decisamente la
ridefinizione concettuale del corpo introdotta dalla nozione di
incorporazione e la riteniamo estremamente importante per la
comprensione delle vite umane.
Csordas, come altri studiosi, ci ricorda comunque la necessità di analizzare e intendere l’incorporazione come un processo un modo di essere nel mondo, e non come entità separata
dai più ampi contesti sociali, politico-economici e strutturali.
Molti studiosi hanno anche considerato i corpi come costruzioni politiche, economiche e strutturali, prevalentemente in
una prospettiva foucaultiana. Eppure sono stati rari i tentativi
di conciliare le prospettive fenomenologiche e quelle costruttiviste attraverso esplorazioni etnografiche di specifici contesti
empirici. Ci sono state proposte teoriche e studi che hanno
esaminato l’intreccio fra le caratteristiche fenomenologiche e
quelle strutturali in termini generali, come ad esempio nei lavori sul rapporto tra scienza e corpi femminili. Ci pare, tuttavia,
che molti studi si siano concentrati sull’incorporazione come
costruzione sociale dei corpi in modi che hanno spesso ridotto
l’esperienza e l’agentività delle persone in carne e ossa a funzioni meccaniche che li trasformavano in burattini della struttura,
oppure, al contrario, hanno focalizzato l’incorporazione come
un essere-nel-mondo esistenziale, in forme che hanno in definitiva ridotto il sociale a un livello astratto, lasciandolo confuso,
defocalizzato, avvolto nella nebbia.
Come ha affermato Bruce Kapferer «La grande svolta individualista e soggettivista in antropologia […] ha contribuito a
far sì che il sociale e la società diventassero poco più che gusci
vuoti, dal valore analitico scarso, se non nullo» (Kapferer B.,
118
Giovanni Pizza e Helle Johannessen
2005: 2-3). Riteniamo che, a questo punto, sia urgente impegnarsi ancora in metodologie e analisi che incorporino le due
prospettive, che in un certo senso le comprendano e le superino, programmando ricerche che indaghino i processi e le relazioni che le legano. Ma prima di proseguire in ulteriori discussioni, dobbiamo volgere uno sguardo più ravvicinato all’altro
polo, al secondo concetto del titolo: lo Stato.
2. Sullo Stato
Il termine “Stato” ha una storia antica e complessa, discussa in
una ampia serie di scienze. Non vogliamo né possiamo ricostruirne qui la lunga vicenda, ma alcuni brevi tratti possono essere utili. Dopo le rappresentazioni medievali del sovrano come
governo e potere incarnato, i filosofi italiani del Rinascimento
hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo della
parola Stato. Il termine deriva dal latino status e fin dal medioevo si riferisce alla stabilità dei governanti, alle condizioni della
repubblica, status publicus o status rei publicae, e indicava al
tempo stesso la stabilità dei governanti (il Principe, nei termini
di Niccolò Machiavelli), la terra (la difesa del territorio era essenziale), e le strutture amministrative del potere del Principe.
È con Max Weber che viene formulata una idea razionale di
Stato moderno, caratterizzato da una specifica prerogativa: solo
lo Stato ha il monopolio legale della coercizione fisica. Lo Stato
moderno è l’entità che ha il monopolio del politico, messo in
atto da procedure e mezzi razionali: la legge, la burocrazia, che
consente la legalità e l’oggettività dei processi politico-amministrativi (Matteucci N., 2005).
Il concetto weberiano di Stato è molto diverso dall’idea di
Stato che ritroviamo nella ricerca antropologica, alla quale torneremo tra breve. Anche se la nozione weberiana dello Stato
può essere sottoposta a una critica antropologica, è tuttavia utile soffermarsi su alcuni aspetti interessanti che emergono dalla
tradizione filosofico-politica europea. Per esempio, come ha
5. Incorporazione e Stato
119
mostrato il filosofo Gianluca Briguglia in un suo recente studio,
la scienza politica dello Stato occidentale ha usato per secoli la
metafora dello Stato come corpo vivente (Briguglia G., 2006).
Poiché stiamo esplorando insieme l’incorporazione e lo Stato,
non possiamo trascurare una tale intrigante tradizione metaforica usata per descrivere la natura e la funzione dello Stato.
Per approfondire questo punto, troviamo nei lavori di Niccolò
Machiavelli (nel 1515) e di Thomas Hobbes (nel 1651) tratti
di un discorso sulla vita corporea dello Stato espressi non soltanto in termini metaforici. Machiavelli infatti descrive lo Stato
come corpo regolato dall’equilibrio e dalla stabilità dei suoi
“umori” (Briguglia G., 2006: 77-110), ma questa metafora non
è solo un frammento di una retorica naturalistica, piuttosto è
connessa alla pratica medica del tempo, che aiuta Machiavelli
a sviluppare una filosofia dinamica del conflitto e dei processi
di trasformazione rappresentati nei termini di salute, malattia
ed efficacia delle cure. Machiavelli ci invita a studiare lo Stato
come una forma di vita (attraverso la metafora corporea), nelle
guerre, nelle battaglie, nella instabilità, ed elabora una complessa arte dell’efficacia, basata sull’abilità di manipolare e trasformare i rapporti di forza. In tal senso la metafora corporea non
è usata come dispositivo cognitivo o suggestione retorica per
descrivere la fisiologia o la patologia della politica, ma come
una cornice per ragionare su specifiche e concrete situazioni di
conflitto in cui i poteri sovrani dello Stato sono incarnati e messi
in opera. Analogamente, secondo Hobbes, nel suo Leviatano, la
metafora dello Stato-corpo è concepita anche in termini teologici: la naturalizzazione dello Stato è un processo rappresentato
nei termini di una incorporazione della autorità divina identificata con lo Stato. La direzione che Hobbes imbocca è chiara,
se solo citiamo i titoli relativi alle diverse parti del suo trattato:
De Corpore, De Homine, De Cive: corpo, uomo, cittadino. Vale
a dire che gli esseri umani condividono un corpo biologico, ma
anche un corpo statale che costituisce la loro seconda natura
(sudditi/cittadini).
Attraverso questi brevi frammenti di storia del termine Stato
120
Giovanni Pizza e Helle Johannessen
e della tradizione metaforica dello Stato incorporato, vorremmo
sottolineare come sia possibile disarticolare l’idea weberiana
dello Stato come unità monolitica fissa e razionale attraverso un
esercizio di rilettura critica della filosofia politica. Le etnografie
della complessa evidenza dello Stato nella vita quotidiana hanno posto molta attenzione sulla frammentazione e la presenza
microfisica dello Stato (Aretxaga B., 2003). In molti commenti
scientifici a carattere filosofico-politico, tale frammentazione è
stata reificata e descritta nei termini di una dissoluzione dello
Stato, ci riferiamo alle letterature sulla presunta “crisi” dello
Stato. Nel nostro contesto, invece, preferiamo concepire la microfisica disseminazione dello Stato nelle pratiche che lo costruiscono quotidianamente. Quello antropologico è piuttosto un
tentativo di vedere come lo Stato viva nelle pratiche della vita
quotidiana, cioè nei processi di incorporazione. Questa prospettiva presuppone la disposizione a non separare lo Stato dalla “società civile”, ovvero a guardare oltre una simile dicotomia.
In quello che ci appare come il primo tentativo di superare tale
dicotomia il marxista italiano Antonio Gramsci suggerì di studiare la statualità nella vita quotidiana. Gramsci ha cercato di
andare oltre la separazione tra lo Stato e la società civile e nella sua teoria pratica dell’egemonia troviamo inclusa un’ampia
gamma di attività statali fra le quali è considerata anche la pratica intellettuale e scientifica:
Se scienza politica significa scienza dello Stato e Stato è tutto il
complesso di attività pratiche e teoriche con cui la classe dirigente
giustifica e mantiene il suo dominio non solo ma riesce a ottenere
il consenso attivo dei governati, è evidente che tutte le quistioni essenziali della sociologia non sono altro che le quistioni della
scienza politica (Gramsci A., 1975: 1765).
Nella teoria della egemonia come concepita da Gramsci, una
specifica ideologia non è semplicemente una serie di regole e
sanzioni, né l’affermazione istituzionalizzata di una visione dominante del mondo, basata sul potere di coercizione, piuttosto
5. Incorporazione e Stato
121
una ideologia lavora costantemente, culturalmente e sentimentalmente, a una costruzione della realtà, essa, cioè, descrive autorevolmente come il mondo e la realtà sono (Mageo J. - Knauft
B. M. 2002: 5, Pizza G. 2003, 2012). È pertanto sulle forme di
costruzione della realtà che una prassi critica deve esercitarsi.
In primo luogo criticando e riarticolando la nozioni filosofiche
di “natura umana”, “seconda natura”, “naturale”:
Argomenti di coltura. Contro natura, naturale ecc. Cosa significa
dire che una certa azione è “naturale”, o che essa è invece “contro natura”? Ognuno, nel suo intimo, crede di sapere esattamente
cosa ciò significa, ma se si domanda una risposta esplicita, si vede
che la cosa non è poi così facile. Intanto occorre fissare che non
si può parlare di “natura” come qualcosa di fisso e oggettivo, in
questo caso “naturale” significa giusto e normale secondo la nostra
attuale coscienza storica, che è poi la nostra “natura”. Molte azioni
che alla nostra coscienza appaiono contro natura, per altri sono
naturali perché gli animali le compiono e non sono forse gli animali gli “esseri più naturali del mondo”? Queste forme di ragionamento si sentono talvolta fare a proposito di problemi connessi
ai rapporti sessuali. Perché l’incesto sarebbe “contro natura” se
esso è comune nella “natura” Intanto anche queste affermazioni
sugli animali non sempre sono esatte, perché le osservazioni sono
fatte su animali addomesticati dall’ uomo per il suo utile e costretti
a una forma di vita che per loro non è naturale, ma è secondo la
volontà umana. Ma se anche ciò fosse vero, che valore avrebbe ciò
per l’uomo? La natura dell’uomo è l’insieme dei rapporti sociali
che determina una coscienza storicamente definita, e questa coscienza indica ciò che è “naturale” o no [ed esiste così una natura
umana contraddittoria perché è l’insieme dei rapporti sociali].
Si parla di “seconda natura”, una certa abitudine è diventata una
seconda natura, ma la “prima natura” sarà stata proprio “prima”?
Non c’è in questo modo di esprimersi del senso comune l’accenno
alla storicità della natura umana? (Gramsci A., 1975: 1032).
Per Gramsci lo Stato ha il compito di elaborare un «nuovo tipo
umano» (Gramsci A., 1975: 2146), trasformando il corpo e producendo l’idea della soggettività. Lo Stato agisce, pertanto, in
un dialogo intimo con i suoi cittadini. Gramsci suggerisce che
122
se
Giovanni Pizza e Helle Johannessen
“Stato” significa specialmente direzione consapevole delle grandi
moltitudini nazionali, è quindi necessario un “contatto” sentimentale e ideologico con tali moltitudini e, in una certa misura, simpatia e comprensione dei loro bisogni e delle loro esigenze (ibidem:
2197).
Nei Quaderni del carcere Gramsci riflette anche sulle performance concrete e le azioni fisiche degli intellettuali e dei burocrati statali, che sono considerati i riproduttori dello Stato attraverso i loro gesti (come nella scrittura, ad esempio). In sostanza
egli si interroga sulla unità di azione fisica e intellettuale di questi specifici “funzionari” e sul loro “addestramento” formativo:
Sulla burocrazia. 1) Il fatto che nello svolgimento storico delle
forme politiche ed economiche si sia venuto formando il tipo del
funzionario “di carriera”, tecnicamente addestrato al lavoro burocratico (civile e militare) ha un significato primordiale nella scienza
politica e nella storia delle forme statali. Si è trattato di una necessità o di una degenerazione in confronto dell’autogoverno (selfgovernment) come pretendono i liberisti «puri»? È certo che ogni
forma sociale e statale ha avuto un suo problema dei funzionari, un
suo modo di impostarlo e risolverlo, un suo sistema di selezione,
un suo tipo di funzionario da educare. Ricostruire lo svolgimento
di tutti questi elementi è di importanza capitale. Il problema dei
funzionari coincide in parte col problema degli intellettuali. Ma
se è vero che ogni nuova forma sociale e statale ha avuto bisogno
di un nuovo tipo di funzionario, è vero anche che i nuovi gruppi
dirigenti non hanno mai potuto prescindere, almeno per un certo
tempo, dalla tradizione e dagli interessi costituiti, cioè dalle formazioni di funzionari già esistenti e precostituiti al loro avvento (ciò
specialmente nella sfera ecclesiastica e in quella militare). L’unità
del lavoro manuale e intellettuale e un legame più stretto tra il potere legislativo e quello esecutivo (per cui i funzionari eletti, oltre che del controllo, si interessino dell’esecuzione degli affari di
Stato) possono essere motivi ispiratori sia per un indirizzo nuovo
nella soluzione del problema degli intellettuali che di quello dei
funzionari (Gramsci A., 1975: 1632, corsivo mio).
Alla luce di queste notazioni gramsciane possiamo considerare
5. Incorporazione e Stato
123
lo Stato nel senso più ampio e allargato. Esso è presente nella
estensione della vita quotidiana, che è la cornice di quella unità
del lavoro manuale e intellettuale, da esplorare minutamente.
Occorrerà interrogarsi su come lo Stato viva nelle mani, nelle braccia, nelle gambe, negli elementi del corpo. Percezioni,
azioni, gesti, devono essere scoperti nella vita quotidiana e una
antropologia gramsciana dello Stato dovrebbe essere anche una
etnografia delle tecniche del corpo e dei processi di incorporazione dei burocrati, intesi come agenti di Stato, e dei cittadini.
Tecniche del corpo (incluso il lavoro intellettuale), attraverso le
quali lo Stato è fatto, disfatto e rifatto in una incessante dialettica quotidiana.
Ci troviamo in effetti di fronte a una delle principali suggestioni che risultano dalla più recente antropologia contemporanea dello Stato (Herzfeld M., 1997, Das V. - Poole D.,
curatori, 2004, Sharma A. - Gupta A., 2006, Palumbo B., 2009).
Oggi lo Stato è fatto oggetto di ricerche etnografiche che lo osservano come un insieme di rapporti di potere, una serie di pratiche, processi ed esperienze (Aretxaga B., 2003), i cui effetti si
disperdono in molti campi di pratiche istituzionali – scuola, famiglia, medicina, patrimonio, ecc. Oppure si identifica con istituzioni simili a esso, che concepiscono la loro sovranità come
potere di stabilire cosa sia la vita e cosa sia la morte, se non chi
debba vivere e chi debba morire, come è accaduto storicamente
in forme diverse con la Chiesa, la biomedicina, il terrorismo o la
mafia (Palumbo B., 2009b).
Lo Stato vive anche oltre i suoi confini e i suoi governi, e
anche nelle sue battaglie interne per le identità locali, che pure
sembrano ergersi, ironicamente e apparentemente, contro
lo Stato. In definitiva possiamo aderire pienamente a quanto scrivono Veena Das e Deborah Poole introducendo il loro
Anthropology in the Margins of the State:
La nostra strategia analitica e descrittiva è stata quella di distanziarci dalla consolidata immagine dello Stato come forma amministrativa razionalizzata di organizzazione politica, che si indebolisce
124
Giovanni Pizza e Helle Johannessen
o diventa meno articolata lungo i suoi margini territoriali o sociali.
Al contrario, abbiamo chiesto ai partecipanti al seminario di riflettere su come le pratiche e le politiche della vita in queste aree
abbiano modellato le pratiche politiche, normative e disciplinari
che costituiscono in qualche modo quella cosa che noi chiamiamo
“lo Stato” (Das V. - Poole D., curatrici, 2004: 3).
3. Statualità della vita quotidiana
In quale quadro analitico possiamo cogliere le interrelazioni tra
i processi di incorporazione e lo Stato, e quali strategie possiamo delineare per la ricerca delle reti relazionali? Noi crediamo che una combinazione delle due prospettive possa favorire una posizione più forte degli studi sociali della medicina.
Vorremmo che negli studi sociali della medicina si superasse il
posizionamento pregiudiziale sia quando è animato dalle buone
intenzioni di dar voce alle inascoltate esperienze dei pazienti –
come se tali esperienze esistessero unicamente nel corpo-mente
del paziente –, sia quando si prefigura come una critica sociale
aprioristicamente ossessionata da discussioni astratte su “potere”, “discorso” e “corpi docili” sui quali la voce autoritaria
della medicina, della legge e della disciplina agisce vincendone
sempre la resistenza. Tali visioni dicotomiche e simmetricamente riduzioniste rischiano di mettere in ombra il gioco reale dei
rapporti di forza che orientano i processi di incorporazione e
le capacità di agire. Osservare tutti gli agenti nella dimensione
ordinaria della vita quotidiana è un programma utile a superare
tali rischi.
In riferimento all’originale significato inglese del termine
embodiment, così come alle prospettive innovative aperte da un
settore recente degli studi antropologici che si qualifica come
antropologia dello Stato, riteniamo che l’idea di osservare la
statualità delle pratiche quotidiane sia un buon punto di partenza per l’identificazione dei rapporti fra l’incorporazione e lo
Stato: «La sfera delle pratiche quotidiane è l’arena primaria nel-
5. Incorporazione e Stato
125
la quale le persone apprendono qualcosa dello Stato» (Sharma
A. - Gupta A., 2006: 11). Auspichiamo dunque ulteriori studi
che pongano l’attenzione alle pratiche corporee di persone e
istituzioni varie dello Stato e su come le pratiche concrete delle
persone reali possano influenzare le concrete pratiche statali.
Un approccio su questa linea ci porterebbe a esplorare i modi
in cui lo Stato penetra nei nostri corpi così come ai modi attraverso i quali i corpi creano e ricreano lo Stato: nel corso della
pratica quotidiana, nelle istituzioni centrali della burocrazia statale e nei siti che sono marginali e solo apparentemente rimossi
o esclusi dalle procedure burocratiche dello Stato. Seguendo
una linea di studio avviata dai lavori di Talal Asad, potremmo
chiederci: «in che modo le attitudini del corpo umano (al dolore, al decadimento fisico, all’invecchiamento, alla morte, alla
integrità fisica, alla crescita corporea, al piacere sessuale) differiscono nelle varie forme di vita? Su quale struttura dei sensi
– ascoltare, vedere, toccare – tali attitudini poggiano? In quali
modi la legge definisce e regola pratiche e dottrine in base al
fatto che esse siano “veramente umane”?» (Asad T., 2003: 17)
La complessità degli aspetti politici concernenti l’incorporazione richiede l’incontro ravvicinato di diversi campi di studio,
indirizzati ai processi di salute-malattia e a quelli politici, un incontro che implica un ripensamento di concetti quali agentività,
intimità, potere/poteri, incorporazione e Stato.
Un simile confronto di studi fra antropologia medica, medicina e teoria politica implica anche una analisi dell’intimità dei
poteri statali su forme diverse di esperienza corporea, come la
nazionalità, la cittadinanza, la scienza, la violenza, la malattia,
la danza o la possessione. Riteniamo che sia molto importante stimolare ulteriori ripensamenti lungo queste linee. C’è da
augurarsi che fruttuosi dibattiti possano sorgere a partire da
nuove etnografie rivolte a osservare la ricchezza delle pratiche
corporee e la complessità della vita statale nella dimensione
quotidiana.
Alessandro Lupo
6. Malattia ed efficacia terapeutica
1. Introduzione
Affrontare in prospettiva antropologica la questione dell’efficacia degli atti terapeutici è impresa non facile, in quanto implica
una riflessione critica ad ampio raggio su cosa si debba intendere per salute e malattia, su chi sia il malato cui la cura è rivolta
e a quale “oggetto” essa si applichi, su quali siano (e per chi)
gli obiettivi che con essa ci si prefiggono, su chi abbia la capacità e l’autorità di dichiarare (e quando) il loro conseguimento.
Tutto ciò, nella consapevolezza che non è possibile applicare a
un fenomeno complesso come la guarigione dei diversissimi tipi
di mali che affliggono gli esseri umani criteri di valutazione oggettivi e universalmente validi1. Una volta di più, lo strumentario analitico dell’antropologia si presta a cogliere la sfaccettata
complessità dei fenomeni bio-psico-sociali, a de-naturalizzare
i concetti con i quali si è soliti trattarli e a evitare i rischi di
approcci riduzionistici, cui inevitabilmente sfuggirebbero molti
dei fattori che concorrono a determinare la realtà che si osserva.
1. La maggior parte degli antropologi che si sono occupati del tema (cfr.
Young A., 1976, 1983, Foster G.M. – Anderson B.G., 1978: 124, Kleinman
A. – Sung L.H., 1979, Moerman D.E., 1979, 2004 [2002], Kleinman A., 1980,
Etkin N.L., 1991, Waldram J.B., 2000) hanno rilevato come qualsiasi tentativo di definire l’efficacia terapeutica debba fare i conti col fatto che «è essa
stessa un costrutto culturale» (Kleinman A., 1973: 210) e pertanto non possa
ignorare la variabilità dei contesti, delle concezioni, dei sistemi di significato e
di valori sulla base dei quali i diversi gruppi umani orientano le proprie pratiche curative. Tra le più citate, la definizione di Young (Young A., 1983: 1208),
che recita: «L’efficacia è la capacità percepita di una determinata pratica di
contrastare la malattia in una qualche maniera auspicabile».
128
Alessandro Lupo
È infatti palese sin da un primo sguardo che salute e malattia,
così come anche cura e guarigione, sono concetti il cui significato varia enormemente nel tempo e nello spazio, a seconda
dei modelli culturali, assiologici e normativi di volta in volta
vigenti, e che si riferiscono a fenomeni impossibili da circoscrivere alla sola dimensione biologica. Un loro approfondito esame non può non prendere in considerazione anche (e, in casi
particolari, soprattutto) i risvolti psicologici ed emozionali, le
valenze simboliche e il significato, le relazioni sociali, i rapporti
di forza, le implicazioni economiche che sempre riguardano le
diversissime esperienze umane che siamo soliti etichettare come
“malattia” (o “salute”). In altri termini, è necessario superare le
limitazioni conoscitive ed esplicative derivanti dal paradigma
cartesiano cui negli ultimi secoli si è ispirata la medicina occidentale (e che peraltro è alla radice di gran parte della sua poderosa capacità di agire risolutivamente su tante patologie che ci
affliggono), in base al quale non solo vi sarebbe una sostanziale
autonomia tra le funzioni corporee e le attività mentali, ma –
per lo meno nell’orientamento materialistico dell’epistemologia
che ispira buona parte degli attori del campo biomedico – i fenomeni riguardanti le distinte componenti del dualismo corpo/
mente avrebbero anche un diverso grado di “realtà”: quelli appartenenti alla dimensione corporea, in quanto suscettibili di
una conoscenza sperimentale sistematica e quantificabile (pensata come “oggettiva” e dunque “vera”) nonché di un intervento razionale efficace, sarebbero avvertiti come assolutamente
“reali”, per contro quelli mentali, appartenenti alla sfera della
psiche e delle emozioni, allorché non siano immediatamente riconducibili a un sostrato organico capace di determinarli in maniera diretta e di renderli così conoscibili nella stessa maniera
dei primi, sarebbero pensati come assai meno “reali” (cfr. Lock
M. - Scheper-Hughes N., 2006 [1990]: 155 ss.).
Questa stessa prospettiva empirista ispira la ben nota distinzione biomedica tra le tipologie delle evidenze della malattia,
conferendo ai “segni” (intesi come le prove oggettive di un’infermità suscettibili di osservazione diretta o indiretta) uno sta-
6. Malattia ed efficacia terapeutica
129
tuto di attendibilità e “verità” assai maggiore dei “sintomi” (le
manifestazioni soggettive di una malattia come sono percepite
ed espresse dal paziente), che sarebbero invece viziati dal fatto
di non esser radicati in dimostrabili e misurabili risultanze corporee, ma invece prodotto dell’idiosincratica interpretazione e
narrazione del proprio stato da parte del soggetto malato (cfr.
Martínez Hernáez A., 1998: 9-10). Le malattie, in quest’ottica,
sono concepite essenzialmente come appartenenti a un’unica
tassonomia di «entità biologiche o psicofisiologiche universali, imputabili a lesioni o a disfunzioni somatiche» (Good B.J.,
1999 [1994]: 14). Il che lascerebbe ben poco spazio per il riconoscimento del fatto che la malattia, anziché un mero fenomeno naturale, è anche – sempre – un fatto sociale che modifica
radicalmente le relazioni, gli status e le attività di quanti ne sono
più o meno direttamente coinvolti, e che costoro inevitabilmente la investono di profondi significati, culturalmente plasmati
a seconda dei contesti. La riflessione antropologica permette
infatti di comprendere che:
la malattia non è un’entità, ma un modello esplicativo. La malattia
appartiene alla cultura [...]. E la cultura non è solo un mezzo per
rappresentare la malattia: è essenziale nella sua stessa costituzione
in quanto realtà umana. [...] Fenomeni umani complessi entrano a
far parte della categoria “malattia”, diventando così oggetto delle
pratiche mediche [...]. Allora, la malattia trova il proprio fondamento ontologico nell’ordine del significato e [d]ella interpretazione umana (Good B.J., 1999 [1994]: 83, corsivo dell’A.).
Da simili premesse, risulta evidentemente fallace la pretesa di
stabilire parametri universali per la definizione di cosa siano la
normalità (dunque la “salute”) e l’anomalia (la “malattia”), specie se ci si propone di farlo secondo valutazioni di ordine quantitativo: «È proprio dell’essenza della salute [...] non lasciarsi
imporre dei valori standard, non conformi ad essa, i quali vengono accostati al caso singolo secondo una media statistica. [...]
In verità non è possibile misurare la salute» (Gadamer H.G.,
130
Alessandro Lupo
1994 [1993]:117). L’unico criterio normativo che sia possibile
individuare, in quest’ambito, è quello basato sull’esperienza dei
soggetti coinvolti e sui criteri (culturalmente e individualmente variabili) da questi applicati nel valutare il proprio stato, ne
aveva piena consapevolezza Georges Canguilhem, allorché nel
suo celebre saggio su Il normale e il patologico sosteneva che «la
norma, in materia di patologia, [è] innanzitutto norma individuale» (Canguilhem G., 1998 [1966]: 90), e citava la seguente
affermazione di Jaspers: «è la considerazione dei pazienti e delle idee dominanti l’ambiente sociale che, più del giudizio dei
medici, determina ciò che si chiama ‘malattia’»2. Accantonata
dunque la pretesa di definire in termini “oggettivi” e basandosi
su criteri empirici di portata universale che cosa sia la malattia,
sarà fondamentale tener conto dell’esperienza e delle valutazioni degli attori sociali che ne sono toccati, oltre che del contesto
storico-sociale in cui essi sono immersi: un’operazione che porta in primo piano i significati che essi conferiscono alla malattia,
le diverse e talora contrastanti istanze che essa mette in gioco, i
rapporti di forza e le negoziazioni che intercorrono tra di loro,
i valori che ne orientano le scelte e le condotte.
Proprio per render conto della pluralità delle dimensioni in
cui è possibile scomporre il fenomeno malattia, alcuni antropologi nordamericani3 hanno avanzato anni fa una distinzione
terminologica tra alcuni vocaboli originariamente sinonimi: con
disease (che in italiano potremmo rendere con “infermità” o
“patologia”4) si propone di designare la malattia intesa in termini fisiologici, sulla base delle evidenze cliniche “oggettive”
solitamente considerate dai medici, illness (traducibile come
2. Karl Jaspers (1933), Psychopathologie générale, Alcan, Paris, p. 5, cit. in
Canguilhem (Canguilhem G. 1998 [1966]: 93).
3. Al riguardo si vedano Eisenberg (Eisenberg L. 1977), Kleinman, Eisenberg e Good (Kleinman A. - Eisenberg L. - Good B.J., 1989 [1978]) e Young
(Young A., 2006 [1982]).
4. Per la restituzione in italiano dei tre termini inglesi disease, illness e
sickness, si vedano le soluzioni adottate da Signorini (Signorini I., 1988: 45) e
Quaranta (Quaranta I., 2006: 117), cui mi attengo.
6. Malattia ed efficacia terapeutica
131
“malessere” o “esperienza di malattia”) indica la «percezione
ed esperienza individuale di determinati stati ritenuti socialmente sfavorevoli», cioè l’esperienza soggettiva della malattia,
così come essa viene vissuta dai singoli pazienti (Eisenberg L.,
1977: 11, Young A., 2006 [1982]: 117), infine sickness (traducibile come “stato di malattia” o “relazioni sociali di malattia”)
indica «il processo attraverso il quale i segni comportamentali e biologici preoccupanti [...] vengono investiti di significati
socialmente riconoscibili» (Young A., 2006 [1982]: 124) o, in
altri termini, il processo di «socializzazione della patologia (disease) e dell’esperienza di malattia (illness)».
Connessa a questa distinzione – cui non sono mancati i rilievi critici5, ma che per quanto riguarda disease e illness ha
avuto ampia accoglienza, anche in ambito biomedico –, ne è
stata proposta un’altra, relativamente all’azione terapeutica, tra
curing e healing6. Il primo termine, solitamente tradotto con
“curare”, è riservato all’intervento tecnico sulla dimensione organica dell’infermità (il disease), che costituisce il fulcro principale dell’agire terapeutico della biomedicina, il secondo, reso
con “guarire” o “risanare”, indica invece la presa in carico (così
peculiarmente centrale nelle medicine cosiddette tradizionali e
in quelle non convenzionali) delle afflizioni che riguardano il
vissuto individuale dei malati e gli sforzi per consentire loro
di rielaborare l’esperienza di malattia (l’illness)7. Per quanto
utile a sottolineare la natura complessa dell’azione terapeutica,
evitando i rischi del riduzionismo organicista ed evidenziando
5. Si vedano al riguardo le utili sintesi di Pizza (Pizza G., 2005: 83-92) e
Quaranta (Quaranta I., 2006: xii-xvi).
6. Per alcuni esempi dell’applicazione di questa distinzione, si vedano
Kleinman (Kleinman A., 1980) e Strathern e Stewart (Strathern A. - Stewart
P.J., 1999).
7. Per molti versi analoga è una seconda distinzione lessicale, sempre formulata in contesti anglofoni e assai diffusa in ambito biomedico, tra cure e
care, ove il primo termine continua ad indicare l’azione tecnica sulle disfunzioni organiche dei corpi e il secondo la capacità di fare ciò assistendo e confortando attraverso una efficace relazione terapeutica le persone.
132
Alessandro Lupo
le molteplici vie attraverso cui si può perseguire e ottenere il
contrasto della malattia e il ripristino della salute, una simile
contrapposizione lessicale rischia di risultare schematica e di
riproporre, sia pure sotto altre vesti, la discussa dicotomia cartesiana tra corpo e mente. Al contrario, i più recenti studi antropologici sull’azione terapeutica hanno insistito sulla necessità di
optare per una prospettiva compiutamente olistica, capace di
render conto di tutti i diversi fattori che operano in quegli intrecci complessi di fenomeni fisiologici, processi psichici, condizionamenti e innovazioni culturali, relazioni sociali e rapporti
di potere che sono gli esseri umani, in quanto “corpi pensanti”
(mindful bodies), al contempo soggetti e oggetti di esperienza e
di rappresentazione, inseriti in campi di forze che agiscono in
misura determinante sulla loro condizione e sui quali essi stessi
esercitano la propria agentività (agency)8.
Sta di fatto che – per quanto ampia sia la gamma degli elementi che si intendono tenere in considerazione nella disamina
dell’efficacia terapeutica – questa non potrà mai esimersi dal
considerare innanzitutto le esperienze, le rappresentazioni e
le valutazioni dei soggetti, le quali variano enormemente a seconda dei modelli culturali che questi avranno incorporato e
che li indurranno a classificare e rispondere in maniere radicalmente diverse a problemi di salute per molti versi simili (talora
attribuendo cause e nomi distinti a casi di malattia analoghi,
talaltra arrivando a considerare “normale”, e dunque “sana”,
una condizione che altri giudicano “patologica”, e viceversa9).
8. Su queste tematiche, si rinvia a Bourdieu (Bourdieu P. 2003 [1972]),
Lock e Scheper-Hughes (Lock M. - Scheper-Hughes N., 2006 [1990]), Csordas (Csordas T., 1990, 1994, 2003 [1999]), Pandolfi (Pandolfi M., 1996), Pizza (Pizza G., 1998a), Mattalucci (Mattalucci-Yılmaz C., 2003).
9. Emblematici al riguardo sono alcuni casi riportati dalla letteratura etnografica, in cui la stessa vasta diffusione endemica di condizioni che la biomedicina considera patologiche può far sì che la popolazione che ne è affetta
le consideri del tutto normali e invece bolli come patologico lo stato dei pochi
che ne sono esenti: valga per tutti quello riportato nel 1945 da Ettore Biocca
riguardo agli indigeni dell’Amazzonia settentrionale, tra i quali il “mal del
pinto” (o Spirochetosi discromica, causata dal Treponema careatum) era dif-
6. Malattia ed efficacia terapeutica
133
È infatti evidente che i diversi processi di plasmazione culturale degli individui (dei loro “corpi pensanti”, degli habitus10
che li caratterizzano, dei modelli valutativi che ne orientano le
scelte) faranno sì che le esperienze di malattia vissute da questi e dal loro gruppo sociale siano qualcosa di loro peculiare, e
profondamente dissimili da quelle di soggetti formatisi seguendo altre modalità antropo-poietiche11. Se dunque esseri umani
plasmatisi diversamente patiranno mali diversi (e non di rado
discorderanno nello stesso riconoscimento che una determinata
condizione sia o meno “patologica”), altrettanto difformi saranno i loro modi di gestire la malattia sul piano terapeutico, nonché le loro reazioni alla terapia e i criteri in base ai quali considereranno “guarito” chi era ammalato. Queste considerazioni
indubbiamente complicano la possibilità di valutare secondo
modalità uniformi e comparabili l’efficacia terapeutica, nondimeno consentono di sfuggire all’illusione che ciò sia possibile
in maniera “oggettiva” mediante l’uso di parametri universali
(come quelli usati dalla biomedicina). Troppe sono le variabili e
gli aspetti del complesso fenomeno della cura e della guarigione
che un simile approccio trascurerebbe. Vediamo invece di esaminarli e di coglierne la rilevanza.
2. Il paziente
Una prima questione che è indispensabile chiarire ogniqualvolfuso a tal punto che chi ne era immune veniva considerato “malato” ed era
conseguentemente escluso dal matrimonio (cit. in Ackerknecht E.H., 1971).
10. Sul concetto di habitus, originariamente introdotto da Mauss (Mauss
M., 1965b [1935]) e successivamente riformulato da Bourdieu (Bourdieu P.,
2003 [1972]), si vedano Csordas (Csordas T., 1990, 1994) e Pizza (Pizza G.,
2005: 39 ss.).
11. Circa il processo di plasmazione culturale degli esseri umani – chiamato antropo-poiesi – quale elemento caratterizzante la specie umana, si vedano Remotti (Remotti F., 2000) ed Affergan et al. (Affergan F. et. al., 2005
[2003]).
134
Alessandro Lupo
ta si intenda affrontare il tema dell’efficacia di un atto terapeutico è chi sia il malato da curare (Waldram J.B., 2000: 612).
Non sempre, infatti, a venir curato è il singolo individuo (il
“corpo individuale” dello schema tripartito proposto da Lock e
Scheper-Hughes12). L’approccio individualizzante alla malattia,
che trascura la sua natura di fatto sociale, isolando il paziente
dalla sua rete relazionale, è logica conseguenza di una prospettiva tutta incentrata sul corpo, quando non addirittura sugli organi e i tessuti. Non a caso tra le accuse che più di frequente
vengono rivolte alla biomedicina vi è quella di limitarsi a curare
i corpi, trascurando le persone, ma non di rado le si imputa
di spingere ancor oltre il suo approccio iperspecialistico, ragionando per “sineddoche”, come quando, con scelte lessicali rivelatrici, gli operatori sanitari parlano fra loro dei propri pazienti
chiamandoli «un omero» o «un triplo by-pass», anziché con il
loro nome. Laddove invece esistano concezioni della persona
meno individualistiche e autonome che nel mondo occidentale
(Augé M., 1980, Geertz C., 1988 [1974]: 75), è possibile ed
anzi frequente che a venir curati non siano la singola donna o il
singolo uomo, quasi fossero degli atomi sociali irrelati, ma che
invece l’azione terapeutica sia diretta alle più ampie molecole
sociali che si ritiene la malattia colpisca, sovvertendone i legami
e l’armonia. Nelle società ove la presenza di gruppi corporati
– come clan e lignaggi – induce a concepire gli individui come
parti inscindibili e interconnesse di un insieme più ampio, pensato alla stregua di un organismo, sarà l’intero “corpo sociale”
a venir curato, non diversamente da come, in ambito biomedico, si somministrano i farmaci al corpo nel suo complesso (ad
esempio con un’iniezione endovenosa) anche quando si desidera che agiscano in particolare su una sua singola parte. In simili
casi, l’idea dell’esistenza di una “persona diffusa”, che travalica
i confini corporei individuali e coinvolge i congiunti più pros12. Nel loro saggio (Lock M. - Scheper-Hughes N., 2006 [1990]), le autrici
propongono di distinguere fra “corpo individuale”, “corpo sociale” e “corpo
politico”, la mediazione tra i quali avverrebbe per tramite delle emozioni.
6. Malattia ed efficacia terapeutica
135
simi, giustifica il fatto che l’intervento terapeutico sia esteso a
più soggetti, fino a coinvolgere l’intero lignaggio (cfr. Augé M.,
1986 [1983]: 94).
Il fatto che con frequenza le terapie tradizionali (in specie
quelle di carattere rituale) si configurino come delle socioterapie, che hanno come destinatari una pluralità di attori, denota
la consapevolezza, da parte delle società che vi fanno ricorso,
del fatto che la malattia, anche ove si manifesti in un singolo
individuo, comporta sempre una qualche lacerazione del tessuto sociale, pertanto la sua cura non può non prevedere la ricucitura dei rapporti strappati, coinvolgendo la collettività. La
malattia individuale, anzi, più che l’origine di tali lacerazioni,
è spesso interpretata come un epifenomeno della lesione del
“corpo sociale”, quasi ne fosse la spia, sicché le azioni terapeutiche includono spesso l’esplicitazione e la ricomposizione
controllata delle tensioni interne al gruppo, come nel rito ihamba esaminato da Turner, nel quale «sembra che il “dottore”
Ndembu identifichi il proprio compito più con la riparazione
dei mali di una collettività che con la cura di un singolo paziente. [...] Il paziente non migliorerà finché tutte le tensioni e le
aggressività nei rapporti del gruppo non saranno state portate
alla luce e sottoposte al trattamento rituale» (Turner V., 1970
[1964]: 454). L’attenzione spesso prestata alle cause profonde
(di ordine morale e sociale) che si pensa possano stare dietro la
malattia del singolo individuo fa sì che questi sia coinvolto, assieme agli altri membri della comunità, in pratiche collettive di
ricostruzione e risoluzione delle ferite nei loro rapporti, simili a
una vera e propria “confessione”13.
Questo comporta altresì che, analogamente ai casi estremi
in cui per salvare la vita di un paziente si decide di sacrificarne
13. È quanto ad esempio avviene tra i Huave del Messico meridionale, ove
la cura dell’ampia categoria di mali che si credono provocati da una volontà aggressiva (e che per questo vengono genericamente chiamati narangüch
‘fatto’) prevede quasi sempre la confesión da parte del paziente degli eventi
che hanno causato le forti emozioni (spavento, vergogna, ira, rimpianto di un
defunto) all’origine della malattia (cfr. Signorini I. - Tranfo L., 1979).
136
Alessandro Lupo
un organo o una parte (come l’appendice, un rene o un arto),
le terapie possano privilegiare la “salute” (in senso ampio) di
quel “paziente collettivo” che è il gruppo sociale a discapito di
quella dell’individuo che ne fa parte, non necessariamente giungendo fino ad accettarne la morte14, ma anche solo privilegiando il benessere dei più su quello del singolo. Sono frequenti gli
esempi etnografici in cui l’esame dei molti ed eterogenei effetti
delle terapie mostra come queste non sempre abbiano al vertice delle priorità la guarigione del paziente, ma mirino prima
ancora ad alleviare i malesseri (illnesses) e le altre difficoltà dei
suoi congiunti (cfr. Kleinman A., 1980: 354 ss.), quando non a
risolvere problemi di ordine extra-medico, ad esempio fomentando il consenso della collettività verso il terapeuta e favorendo la compliance e la partecipazione alle sue attività, mediante il
rafforzamento della sua autorità e del suo prestigio (Atkinson
J.M., 1987).
3. L’oggetto dell’azione terapeutica
Un secondo aspetto su cui vale la pena soffermarsi è quale sia
l’“oggetto” dell’intervento terapeutico, ovvero su quale elemento che si pensa abbia perturbato la condizione di normalità/salute sia diretta l’azione curativa. Il che mette in gioco i
“modelli esplicativi” (Kleinman A.,1980: 104 ss.), le nozioni
utilizzate dai diversi attori coinvolti nella gestione della malattia
per spiegarne «eziologia, sintomi iniziali, patofisiologia, decorso [...] (gravità e tipo di ruolo del malato), terapia» (Kleinman
A., 2006 [1978]: 13, 1980: 105). La grande variabilità di questi
modelli esplicativi – che non dipende soltanto dalla cultura di
14. Osserva al riguardo Bibeau (Bibeau G., 1998 [1983]: 158) che a volte
può succedere «che il malato muoia, senza che ciò significhi che la terapia ha
fallito, i sintomi possono anche permanere, ma si dirà che vi è stata guarigione
se le relazioni sociali nel gruppo d’appartenenza del malato sono migliorate.
La guarigione negli Angbandi non concerne solo il paziente: anche se il prezzo da pagare è caro, questa medicina è più olistica della nostra».
6. Malattia ed efficacia terapeutica
137
appartenenza degli attori, ma anche dai loro ruoli e dalle finalità
che perseguono – può far sì che costoro dirigano il proprio intervento (o interpretino quello di chi cura) verso bersagli assai
eterogenei, che varieranno a seconda delle concezioni intorno
all’eziologia del male e della natura che gli viene attribuita. In
ambito biomedico si va dai germi e i parassiti che possono attaccare l’organismo, alle sostanze tossiche e agli agenti esterni
che ne possono alterare il funzionamento, ai tessuti, agli organi
e ai sistemi che possono accusare traumi, anomalie, degenerazioni e malfunzionamenti. Ma nelle altre tradizioni mediche la
lista può comprendere una congerie ancor più vasta, fatta di
organi o parti corporee che si pensa siano andati “fuori posto”
(come l’utero, lo stomaco, le ossa o anche organi immaginari15)
o che abbiano subìto guasti di tipo meccanico (come quando
si crede che un pelo ostruisca il dotto galattoforo causando la
mastite16), equilibri alterati (tra fluidi corporei, come nella teoria degli umori ippocratico-galenica, o in termini di freddo/
calore17), forme diverse di “contagio” e di influssi esterni al corpo (non di rado collegati a relazioni sociali e all’infrazione di
norme18), oggetti introdotti magicamente nel corpo19, sostanze
15. Per gli spostamenti dell’utero e dello stomaco si vedano Zanetti (ZaZ., 1978 [1892]), Guggino (Guggino E., 1986) e Pizza (Pizza G. 1998b),
per le ossa si vedano Lis Quibén (Lis Quibén V., 1980 [1949]: 166 ss.) e Quattrocchi (Quattrocchi P., 2006), per organi o parti immaginari, come il ti’pté e
la “fontanella” tra gli indigeni messicani, si vedano Quattrocchi (Quattrocchi
P., 2011) e Lupo (Lupo A., 1998).
16. Al riguardo, si vedano Rivera (Rivera A., 1989), Ranisio (Ranisio G.,
1996) e Baronti (Baronti G., 1998).
17. In gran parte dell’America Latina, è diffusissima l’idea che buona
parte delle malattie derivino da alterazioni dell’equilibrio “termico” dell’organismo, inteso in termini simbolici e in relazione a sostanze variamente connotate in tal senso (cfr. Signorini I. - Tranfo L., 1979, Signorini I., 1989, Lupo
A., 1998).
18. Si veda al riguardo quanto illustrato da Caprara (Caprara A., 2001),
Schirripa (Schirripa P., 2005: 54-68) e Hersch (Hersch Martínez P., 1997).
19. L’introduzione magica di oggetti è così universalmente diffusa che cito
a titolo esemplificativo il solo testo di Lévi-Strauss (Lévi-Strauss C., 1975a
[1949]).
netti
138
Alessandro Lupo
o essenze impalpabili (spiriti) che vi penetrano alterando la salute e il comportamento20, componenti spirituali che si pensa lo
abbandonino (spontaneamente, o per traumi, forti emozioni o
attacchi esterni21).
In tutti questi casi, è frequente l’idea che la malattia si manifesti su di una pluralità di piani, richiedendo così un’azione
combinata su più fronti. Ciò vale ovviamente tanto in ambito
biomedico quanto nelle altre tradizioni mediche, e se ne dovrà
tener conto nel considerare l’efficacia della cura, con la differenza che, mentre nel primo caso la terapia, per quanto complessa, ha sempre luogo sul solo piano delle cosiddette “cause
empiriche”22, senza che ci si curi delle eventuali cause “ulteriori” che potrebbero soggiacervi (dèi, spiriti, maghi e altri aggressori, variamente sollecitati dalle condotte del paziente o dei suoi
congiunti), per quanti ricercano nella risposta agli universali
quesiti di “perché a me?”, “perché ora?” il significato del male
che li affligge, proprio nell’individuazione e nella rimozione di
quelle cause ulteriori può risiedere il nocciolo fondamentale
della cura (nonché la fonte di un’ultima speranza di guarigione,
allorché manchino o si siano dimostrati vani gli strumenti per
combattere le “cause empiriche”). Non è solo tra i popoli ove
20. Qui si va dal “veleno” che si credeva inoculato dalla tarantola (de
Martino E. 1961) alle innumerevoli forme di possessione spiritica (Ong A.,
1988, Pizza G., 1996, Pennacini C., 2001, Talamonti A., 2005).
21. Anche questa tipologia è così onnipresente che mi limito a citare
le opere di Hamayon (Hamayon R., 1990) per l’Asia, Lewis (Lewis I., 1972
[1971], 1993 [1986]) per l’Africa, Signorini e Lupo (Signorini I. - Lupo A.,
1989) e Severi (Severi C., 1993) per l’America.
22. Mi riferisco qui alla distinzione tra livelli diversi dell’“asse eziologico”
proposto da Bibeau (Bibeau G., 1982) e sostanzialmente coincidente con la
proposta analitica di Sindzingre e Zempléni (Sindzingre N. - Zempléni A.,
1981), in cui al piano verificabile della “causa empirica” (il come ci si è ammalati) possono sommarsi – per quanti lo ritengono fattibile – cause ulteriori
appartenenti a un livello “socio-psicologico”: la “causa agente” (il chi, con
la propria intenzionalità, avrebbe scatenato la “causa empirica”) e la “causa
iniziale” (il perché tale iniziativa avrebbe avuto luogo, in base a considerazioni
di ordine morale che investono la condotta degli attori sociali, in primis il
malato).
6. Malattia ed efficacia terapeutica
139
la biomedicina ha un minor radicamento rispetto all’Occidente
e i saperi autoctoni conservano la propria “forza funzionale”
(Lee R.P.L., 1982: 630) che l’azione terapeutica può dispiegarsi combinando pragmaticamente molteplici strategie d’azione
(ad esempio ricorrendo ai farmaci di sintesi e alla chirurgia,
ma affiancando ad essi le sostanze e i preparati della tradizione locale, nonché le più diverse pratiche rituali). , lo dimostra
il proliferare delle medicine alternative anche nelle società più
prospere e “moderne”, ove la sanità pubblica vanta la massima
diffusione ed efficienza, ma nelle quali la domanda di senso non
per questo viene meno, cercando comunque chi sia in grado di
farsene carico ed evaderla (Dei F., 1996).
4. Gli obiettivi
Da quanto appena osservato discende che per determinare
l’efficacia di una terapia è indispensabile tenere ben presenti
gli obiettivi che si prefiggono tutti i diversi attori presenti sulla
scena, che non sempre coincidono. Vi sarà chi mira innanzitutto alla eliminazione del dolore, al recupero della funzionalità
compromessa, al ritorno alla “normalità” (ove ciò sia possibile, qualora il danno fisiologico sia irreversibile, si punterà alla
massima approssimazione alla possibilità di condurre la vita di
sempre, o alla miglior accettazione della nuova condizione). Ma
vi sarà anche chi punta prioritariamente all’eliminazione delle
cause della malattia, indipendentemente dalla scomparsa dei
suoi sintomi (analogamente al dentista che, più che sopprimere il mal di denti con un analgesico, si premura di combattere
l’ascesso con gli antibiotici), e qui entrano in gioco i modelli
esplicativi, a seconda dei quali si potrà tendere all’eliminazione
delle “cause empiriche” (come i batteri che causano l’ascesso, il
plasmodio che provoca gli attacchi di febbre malarica, il “pelo”
che ostacola il flusso del latte, lo squilibrio termico cui si imputa il mal di fegato, l’“apertura” delle ossa del bacino che causa
140
Alessandro Lupo
l’irregolarità del flusso mestruale23), o si privilegerà la rimozione
– più laboriosa, ma spesso ritenuta assai più urgente e risolutiva
– delle cause “ulteriori”. Se si pensa che la malattia (quale che
ne sia la manifestazione fisiologica) sia imputabile al volere di
entità (vicini invidiosi, stregoni prezzolati, antenati offesi, divinità vindici...) capaci di attivare e controllare gli agenti patogeni
“empirici”, si cercherà di contrastare o placare tale intenzionalità negativa, quando non di ribaltarne il segno, attraverso scongiuri, controfatture, suppliche, voti, promesse, negoziazioni rituali, offerte, sacrifici eccetera: solo così si potrà sperare di aver
cancellato la “causa agente” del male (il “chi” lo ha scatenato).
Per ottenere questo fondamentale mutamento relazionale, tuttavia, è spesso necessario rimediare alle eventuali responsabilità
morali di chi, pur ritenendosi innocente, è colpito dalla sventura (la “causa iniziale”, ovvero il “perché” del male)24: l’invidia e
l’avversione del prossimo, così come la collera degli avi e delle
entità extraumane, difficilmente scaturiscono dal nulla, ed anche quando chi ne è vittima non abbia commesso alcunché per
innescarle, non è escluso che altri membri del suo alveo sociale
(che con lui possono formare la “persona diffusa” di cui s’è detto prima) l’abbiano fatto, o che egli abbia disatteso le norme di
prudenza, discrezione, devozione e autoprotezione che si pensa
garantiscano dagli incerti della vita associata (la quale naturalmente si estende oltre la cerchia degli umani, in una concezione
delle forze extraumane che spesso proietta su di esse sentimenti e condotte affatto antropomorfi). A questo fine, nelle molte
circostanze in cui la malattia è pensata come il riflesso di un disordine sociale (Augé M., 1986 [1983]), uno dei primi obiettivi
della terapia consiste nel ripristinare l’ordine, facendo emergere
e risolvendo secondo modalità consolidate di mediazione e ne23. Per gli ultimi due esempi citati, rinvio a Lupo (Lupo A., 2007) e Quattrocchi (Quattrocchi P., 2006, 2011).
24. Circa la logica che, nei sistemi medici tradizionali africani, tende ad
attribuire all’individuo la responsabilità del male che lo affligge, rinvio a Zempléni (Zempléni A., 1975) e Augé (Augé M., 1975).
6. Malattia ed efficacia terapeutica
141
goziazione le tensioni e le mancanze dei membri del gruppo che
si immaginano all’origine del processo patogenetico25.
Quanto appena ricordato evidenzia l’importanza di considerare quale tipo di salute venga perseguito dai protagonisti
dell’azione terapeutica: se quella del singolo ammalato – e in
tal caso se si privilegerà la piena funzionalità dell’organismo
o il benessere e la serenità della persona nel suo complesso –,
oppure quella della collettività, che avrà verosimilmente a cuore l’integrità e la capacità del suo membro di svolgere i ruoli
che gli competono, ma che si preoccuperà sempre anche delle
ripercussioni che la sua malattia ha sulla vita associata e sul benessere comune, degli oneri e del costo che la cura comporta,
della sostenibilità di tale impegno nell’eventuale protrarsi della malattia. In questa prospettiva, è evidente la possibilità che
gli obiettivi dei diversi soggetti coinvolti divergano e possano
confliggere, e che il prevalere di una strategia a svantaggio di
un’altra dipenderà dai valori che orienteranno le scelte e dai
rapporti di forza esistenti fra di essi. A chiunque abbia svolto
ricerche etnografiche in ambito medico sarà capitato di osservare tali controversie e di assistere all’eventualità che la salute del
singolo individuo venga sacrificata a quella del gruppo.
Nuovamente, però, occorre interrogarsi su quale tipo di
salute sia in gioco. Non solo, infatti, società meno incentrate
della nostra sull’assoluta autonomia dell’individuo e sulla sua
salvaguardia possono anteporre la funzionalità, il benessere e
la continuità del gruppo a quelli dei suoi singoli membri (cfr.
Waldram J.B., 2000: 618). Può succedere che sia l’individuo
stesso a cercare una salus che, più ancora che con l’integrità
fisica del corpo nella sua transitoria parabola terrena, egli identifica con la salvezza dell’anima nel suo destino ultraterreno.
Ed anche se per gli aderenti a tanti movimenti religiosi la salute
spirituale viene spesso a coincidere con (ed è condizione per)
quella del corpo, che in tal modo ne diviene esplicita testimo25. S’è già menzionata la frequenza delle pratiche di confessione e di condivisione delle presunte responsabilità dei malati e dei loro interlocutori.
142
Alessandro Lupo
nianza nel mondo26, non mancano neppure quanti accettano di
buon grado la malattia, la menomazione e finanche la morte,
ritenendole il necessario strumento per ottenere l’unica salute
durevole e “vera”, quella dell’anima, che meglio si raggiunge
attraverso la mortificazione della carne. Per quanto i medici
cerchino con ogni mezzo possibile di preservare la vita e l’integrità fisica dei propri pazienti, non di rado capita che debbano
piegarsi al loro volere, quando quelli rifiutano cure o interventi
che ne assicurerebbero sì la sopravvivenza, ma alla condizione
di contravvenire ai propri valori o ai dettami della propria fede
(come nei casi ben noti delle trasfusioni di sangue o emoderivati, dell’impianto di organi o tessuti altrui o dell’amputazione
di un arto per scongiurare cancrena e setticemia). A chi spetta,
in casi del genere, di stabilire verso quali obiettivi – verso quale
modello di “salute” – debba tendere la terapia?
5. L’autorità di chi decreta la guarigione
La condizione di “ammalato” – come d’altronde quella di
“persona sana” – non è uno stato oggettivo, né una percezione
soggettiva, ma uno status, cioè una posizione sociale che viene
riconosciuta all’individuo dalla società di cui fa parte sulla base
di evidenze culturalmente definite (Lupo A., 1999). Così come
non basta che una persona “si senta male”, né che presenti dei
segni espliciti di alterazione, perché sia malata, ma è necessaria
la sanzione sociale che gli attribuisce tale status (il processo di
socializzazione del sickness, cfr. Young A., 2006 [1982]), analogamente perché sia guarita occorre che abbia luogo il processo inverso, culminante nel riconoscimento collettivo della
“guarigione”. Un processo, dunque, nel quale le condizioni, le
esperienze, l’opinione e il volere del soggetto in questione sono
26. Sui movimenti carismatici si vedano, tra gli altri, Charuty (Charuty
G., 1998 [1990]), Csordas (Csordas T.J., 1997 [1994]), Finkler (Finkler K.,
1998), Schirripa (Schirripa P., 2005).
6. Malattia ed efficacia terapeutica
143
certo assai rilevanti, ma mai di per sé sufficienti, ciò che conta è
la deliberazione di colui o coloro che – sulla base delle convenzioni vigenti – sono investiti dell’autorità di stabilire l’esistenza
o meno di una condizione morbosa. Com’è facile comprendere,
si tratta di una questione dagli evidenti risvolti politici, nella misura in cui le scelte di chi detiene questo potere interferiranno
con la libertà d’azione del paziente e degli altri attori sociali che
interagiscono con lui, concedendo esenzioni o privilegi, imponendo certe condotte e inibendone altre, attribuendo o negando status e ruoli.
Abbiamo a più riprese osservato che assai spesso i punti di
vista su quale sia la condizione di salute di un individuo variano considerevolmente, così come possono divergere le concezioni, i criteri valutativi, gli obiettivi e gli interessi dei diversi
protagonisti del processo terapeutico. Potrà dunque succedere
che il paziente si senta guarito senza che chi ha l’autorità per
dichiararlo tale riscontri gli elementi per farlo, negandogli così
il reintegro nelle normali attività quotidiane da cui la malattia
l’aveva esonerato, per converso, egli può esser dichiarato guarito – e spinto a svolgere i propri ruoli abituali – senza che abbia
superato la propria condizione di malessere, per non dire delle ulteriori discrepanze di opinione che possono sorgere con
le altre figure sulla scena. In casi come questi, è praticamente
impossibile per un osservatore esterno non pregiudizialmente
orientato stabilire se la cura sia stata efficace, in quanto il giudizio varierà a seconda dei punti di vista presi in considerazione,
nessuno dei quali esaurisce la complessità della realtà studiata.
Così come non è possibile trascurare l’esperienza e le valutazioni del soggetto che vive in prima persona la malattia e la sua
eventuale risoluzione, altrettanto improprio sarebbe non tener
conto di quelle di coloro che standogli accanto esperiscono i
risvolti sociali della vicenda, o delle valutazioni di chi è investito
dalla collettività della facoltà di decretare lo status di sano/malato, o infine delle evidenze empiriche eventualmente rilevabili
delle trasformazioni subite dal suo organismo. Come accortamente fa rilevare Waldram (Waldram J.B., 2000: 615 ss.), la
144
Alessandro Lupo
capacità di stabilire se la guarigione abbia avuto o meno luogo
riflette assai più la gerarchia dei saperi in campo e il potere di
chi emette il giudizio che non l’elusiva (e prospetticamente mutevole) verità di tale enunciato.
6. Tipi di efficacia
Vista l’estrema varietà di fenomeni che vanno sotto il nome di
“malattia”, sarà bene tener presente che anche con l’espressione “efficacia terapeutica” si designano una molteplicità assai
multiforme di processi (Etkin N.L., 1991: 301), che riguardano trasformazioni complesse, in cui si combinano in variabile
misura le dimensioni fisiologica, psichica, affettiva, sociale e
politica di quanti le vivono. Se per un verso l’artificiale scomposizione analitica appena accennata facilita la disamina delle
diverse dinamiche in cui si dispiega il processo di guarigione,
per un altro essa rischia di offuscarne la natura unitaria, così
caratteristica di quegli animali simbolici e sociali che sono gli
umani, assoggettati come tutti i viventi a leggi naturali, ma al
contempo costitutivamente destinati ad esser foggiati in modi
culturalmente e storicamente mutevoli (Leroi-Gourhan A.,
1977 [1974], Geertz C., 1987 [1973]: 73-133, Remotti F.,
2000, 2008), e dunque dotati come specie della capacità/necessità di rispondere secondo modelli appresi e incorporati «irriducibilmente molteplici» (Remotti F., 2008: 7) ai bisogni e alle
difficoltà che li assillano.
Questa tensione tra l’utilità di riconoscere la specificità dei
diversi processi di contrasto alla malattia e l’esigenza di preservare l’unitarietà dello sguardo (l’olismo proprio dell’approccio
antropologico) è stata una caratteristica di molti degli studi dedicati al tema dell’efficacia degli atti terapeutici. Fin dal forse
più celebre di essi – quello di Claude Lévi-Strauss (Lévi-Strauss
C., 1975b [1949]) sull’efficacia simbolica –, gli antropologi si
sono sforzati di esaminare contrastivamente le diverse dinamiche curative perseguite dai saperi medici dell’Occidente e dalle
6. Malattia ed efficacia terapeutica
145
altre medicine, evidenziandone le peculiarità e al tempo stesso
cercando gli elementi di convergenza. Tuttavia, pur applicando
una prospettiva intrinsecamente relativista e contestualizzante,
non si è inizialmente sfuggiti alla involontaria riproposizione
del paradigma cartesiano proprio della medicina scientifica,
ad esempio creando una dicotomia tra la “cura dell’infermità”
organicamente intesa (curing disease, ove la biomedicina esplicherebbe la sua massima capacità d’azione) e la “guarigione
del malessere” soggettivamente esperito (healing illness, ove
le medicine tradizionali mieterebbero i maggiori successi) (cfr.
Kleinman A., 1980, Young A., 1983, 2006 [1982], Strathern
A. - Stewart P.J., 1999). Col passare del tempo, tuttavia, ha preso vigore l’orientamento critico che, guardando alla stessa biomedicina come a uno dei tanti saperi sulla realtà culturalmente
plasmati, non le riconosce la proprietà singolare di essere «un
linguaggio scientifico [...] trasparente verso il mondo naturale,
[quasi fosse uno] “specchio della natura”» (Good B.J., 1999
[1994]: 8) e per ciò stesso da assumere quale metro con cui misurare tutti gli altri, sicché anche la valutazione dell’adeguatezza dei saperi medici nel rispondere ai problemi di salute delle
diverse società va commisurata alle loro particolarità locali:
in ciascun contesto sociale il banco di prova di un sistema medico,
o di un singolo procedimento preventivo o terapeutico, è costituito non già dalla “verità” della concezione della patologia in base
alla quale esso viene localmente legittimato ma dalla sua capacità
di dare efficaci risposte ai problemi che è chiamato ad affrontare: efficaci, comunque, in riferimento agli obiettivi che nei singoli
contesti culturali volta a volta “contano” (Seppilli T., 1996: 21).
Tullio Seppilli non è certo il solo studioso a sottolineare la necessità di sgombrare il campo dall’equivoca identificazione tra
“verità” ed “efficacia”, che essendo profondamente radicata
nel paradigma biomedico ha a lungo costituito un ostacolo alla
comprensione del funzionamento e al riconoscimento del successo delle pratiche di altre tradizioni terapeutiche. Scriveva
146
Alessandro Lupo
anni or sono Roberto Lionetti:
Verità ed efficacia non si equivalgono, né vanno sempre di pari
passo. I saperi sociali hanno infatti come scopo l’efficacia [...].
Perciò, a condizione di sortire l’effetto desiderato, e non importa
per quale via, i saperi tradizionali hanno anche il diritto di essere
falsi dal punto di vista scientifico (Lionetti R., 1988: 4).
Tanto più che, come ha acutamente osservato Lévi-Strauss
(Lévi-Strauss C., 1975b [1949]), la ragione del successo di tante terapie (e specialmente di quelle che danno particolare enfasi
alla manipolazione del significato, come le rituali) nel risolvere
i problemi di salute di coloro cui sono dirette sta nella loro capacità di sollecitare i meccanismi di guarigione presenti all’interno dell’individuo. Il che non avviene in ragione della “verità”
dei modelli cosmologici cui si ispirano e della verificabile realtà
empirica degli agenti che esse chiamano in causa (sovente forze
ed entità extraumane, anche “mostruose” [v. oltre]), ma della
facoltà che i simboli di volta in volta evocati hanno di suscitare
nel paziente emozioni in grado di influire sui processi endogeni
dell’organismo nel suo complesso. Se è vero che una parte consistente dell’efficacia delle terapie dipende sempre dalle aspettative che la relazione col terapeuta e l’azione curativa in quanto
tali producono nel paziente, il fatto che entrambi condividano
un orizzonte di significati non solo ne favorisce il dialogo tra
loro e la complicità nella comune lotta contro il male27, ma consente l’attivazione di importanti risposte di guarigione, spesso
una delle principali risorse delle medicine tradizionali: non è
un caso, osserva provocatoriamente Lévi-Strauss, che gli stessi
meccanismi endogeni spesso osservati nelle terapie sciamaniche
non si inneschino con «i malati delle nostre società, quando si è
27. Una condizione che già Ippocrate (nel cap. 5 del I libro delle Epidemie) aveva individuato come essenziale per il fecondo costituirsi del “triangolo” che porta il suo nome: «L’arte si compone di tre termini: la malattia, il
malato e il medico. Il medico è il servitore dell’arte, il malato deve opporsi alla
malattia con il medico» (cit. in Jouanna J., 1994 [1992]: 137).
6. Malattia ed efficacia terapeutica
147
ben spiegato loro la causa delle loro disfunzioni, invocando secrezioni, microbi o virus. Ci accuseranno forse di paradosso se
rispondiamo che la ragione di ciò sta nel fatto che i microbi esistono, mentre i mostri non esistono» (Lévi-Strauss C., 1975b
[1949]: 222). Sarebbe il potenziale evocativo dei “mostri”, derivante proprio dalla loro natura fantastica (proteiforme e potenzialmente inesauribile) e inversamente proporzionale a quello
dei germi freddamente studiati dalla biomedicina, a costituire la fonte dell’efficacia delle terapie rituali: «la relazione fra
microbo e malattia è esterna alla mentalità del paziente, è una
relazione di causa ed effetto, mentre la relazione fra mostro e
malattia è interna a quella stessa mentalità, ne sia essa consapevole o meno: è una relazione fra simbolo e cosa simbolizzata»
(ibidem).
In altri termini, una parte consistente dell’efficacia di ogni
terapia (e non solo di quelle rituali) deriverebbe dalla capacità
di rendere pensabile la malattia, di darle un nome e permetterne
la rappresentazione28. Per questo la fase diagnostica sarebbe a
pieno titolo parte essenziale del processo terapeutico (Csordas
T.J. - Kleinman A. 1998 [1990], Lupo A., 1999), consentendo di
compiere il primo passo verso quella risignificazione dell’esperienza di malattia che costituisce un elemento ricorrente di gran
parte dei percorsi di guarigione (Kleinman A., 1980, 1988a,
Csordas T.J., 1994, Finkler K., 1998, Good B.J., 1999 [1994],
Gallini C., 1998a, 1998b). Un conferimento di senso che assai
spesso – nei contesti tradizionali – si richiama alla forza rassi28. Ritengo significativo che, pochi anni prima che Lévi-Strauss enunciasse le sue provocatorie teorie sulla potenza terapeutica dei mostri rispetto ai
microbi, nel 1943 Georges Canguilhem formulasse considerazioni per certi
versi analoghe circa la maggior rappresentabilità dei batteri rispetto ai virus:
«la teoria microbica delle malattie contagiose deve sicuramente una parte del
suo successo a quel poco di rappresentazione ontologica del male che essa
contiene. Un microbo, per quanto necessiti della complicata mediazione del
microscopio, dei coloranti e delle colture, è qualcosa di visibile, mentre non è
possibile vedere un virus [miasme] o un’influenza. Vedere un essere significa
già prevedere un atto» (Canguilhem G., 1998 [1966]: 15-16).
148
Alessandro Lupo
curante dei modelli atemporali del mito, esplicitamente evocati
nelle pratiche rituali, cui si attinge per disporre di un «orizzonte
rappresentativo stabile [...] nel quale la varietà rischiosa delle
possibili crisi individuali trova il suo momento di arresto, di
configurazione, di unificazione e di reintegrazione culturali»,
riconducendola «alla iterazione di uno stesso ordine risolutore,
nel quale il negativo è “per natura” sempre sospeso e annientato» (de Martino E., (1987 [1959]: 96-97). Questo percorso
passa attraverso il tentativo – che accomuna le terapie rituali e
quelle psicologiche, come la psicanalisi – di «rendere coscienti
conflitti e resistenze rimaste sino allora inconsce» (Lévi-Strauss
C., 1975b [1949]: 222) e consisterebbe – secondo un’ormai celebre formula – «nel rendere pensabile una situazione che in
partenza si presenta in termini affettivi: e nel rendere accettabili alla mente dolori che il corpo si rifiuta di tollerare» (LéviStrauss C., 1975b [1949]: 221). Il riorientamento cognitivo che
sempre accompagna il percorso terapeutico – e che a seconda
dei contesti culturali si declina in forme assai mutevoli – viene
qui a soddisfare l’«avidità di comprensione dell’universo» (ibidem: 204) che caratterizza tutte le attività umane, ma che nella
crisi rappresentata dalla malattia si fa particolarmente acuta.
Fin qui non si è ritenuto di differenziare quest’ultimo tipo di
efficacia, basata sulla sollecitazione per mezzo di stimoli psichici dei meccanismi endogeni di guarigione (e non certo agevole
da verificare), da quella di altri strumenti assai più facilmente
sottoponibili a forme di misurazione empirica, come i farmaci, gli interventi chirurgici e i dispositivi meccanici. In effetti
può risultare proficuo distinguere – come ad esempio fa Daniel
Moerman in un recente volume (Moerman D.E., 2004 [2002])
– tra le diverse tipologie di risposte attraverso cui gli esseri
umani reagiscono alle lesioni della loro salute29. Ma non vorrei
29. La distinzione di Moerman (Moerman D.E., 2004 [2002]: 33) è fra:
risposte autonome, «tutti i processi che l’organismo ha a disposizione per riparare i danni e ristabilire il suo equilibrio, compresa la mobilitazione del
sistema immunitario» (dunque reazioni endogene e per lo più automatiche),
6. Malattia ed efficacia terapeutica
149
qui riproporre la troppo schematica distinzione tra terapie che
perseguono un’efficacia “empirica” e terapie che si basano su
una diversa efficacia, appunto “simbolica”30. Oltre a ricalcare la
schematica ed etnocentrica contrapposizione tra Occidente (razionale, moderno, scientifico) e Resto del mondo (irrazionale,
arcaico, simbolico), tale dicotomia ostacolerebbe la considerazione unitaria dei processi di guarigione, occultando il fatto che
tra esseri umani la dimensione del significato permea comunque qualsiasi atto terapeutico, rituale o tecnico che sia, e che
tutte le terapie hanno risvolti “simbolici”31.
Una delle (involontarie) conseguenze della fortunata ma discutibile denominazione coniata da Lévi-Strauss, infatti, è stata
quella di prestarsi a far ritenere l’“efficacia simbolica” degli atti
di cura rituali meno “reale” di quella dei farmaci o del bisturi
(mentre egli era interessato proprio al fatto che l’azione rituale non si limitasse a far “sentire meglio” la donna cuna dell’erisposte specifiche, «quelle dell’organismo al contenuto di una terapia medica» (che può andare dalla somministrazione di sostanze attive, vaccini e
antibiotici, alla chirurgia e agli ausili meccanici, reazioni a interventi dall’esterno), infine quelle che egli battezza risposte al significato, che «dipendono
dall’interazione col contesto del processo di guarigione», ovvero «l’insieme
degli effetti psicologici e fisiologici del significato nell’ambito della terapia»
(ibidem: 31), una formulazione abbastanza generica che indica le reazioni (endogene) innescate dal significato che i malati attribuiscono ai più diversi elementi dell’intervento terapeutico: dalla maggior “potenza” attribuita al laser
rispetto al bisturi in chirurgia, al colore e alla forma delle pillole, alla “forza”
riconosciuta alle formule verbali di un rito, alla capacità di un sacrificio di
sostituire con la vita di un animale quella in pericolo del paziente.
30. Si vedano a questo riguardo le osservazioni critiche formulate da Le
Breton (Le Breton D., 1991), che per superare l’eredità dualista dell’approccio “psico-somatico” propone di passare a una più unitaria prospettiva “fisiosemantica”.
31. Come giustamente osserva Moerman (Moerman D.E., 2004 [2002]:
208) rispetto alla “placebofobia” di coloro che mostrano una particolare
avversione per la sperimentazione sulla “risposta al significato”: «mentre in
una ricerca si può decidere di includere o escludere un gruppo di controllo
trattato con placebo, decidere di includere o escludere il ‘significato’ è semplicemente impossibile. Il significato ci sarà sempre, e sempre avrà effetti,
indipendentemente dalla nostra volontà».
150
Alessandro Lupo
sempio etnografico preso in esame, senza agire sul suo stato
fisico, ma potesse risolvere concretamente il suo parto difficile,
portando all’espulsione del feto). Un pregiudizio strettamente connesso all’«epistemologia fondamentalista» (Good B.J.,
1999 [1994]: 12 ss.) su cui si basa la biomedicina, che arroga a
sé la “verità” della conoscenza scientifica di contro alla “illusorietà” delle credenze su cui s’imperniano gli altri saperi medici.
Lo stesso pregiudizio che ritroviamo – in contesti meno esotici – nei confronti del cosiddetto “effetto placebo”32, spesso
inteso come un «procedimento terapeutico [che] abbia effetto
su un sintomo, una sindrome, una malattia o un paziente essendo obiettivamente privo di attività specifica sulla condizione
trattata» (Shapiro A.K., 1964: 136, cit. in Moerman D.E., 2004
[2002]: 30), quasi che la sua (pur perfettamente misurabile) efficacia, oltre ad essere in qualche misura immorale perché basata sull’“inganno” (Cozzi D., 2003: 494, Moerman D.E., 2004
[2002]: 243), fosse anche meno “reale” di quella delle sostanze
contenenti principi dimostrabilmente attivi.
Ciò che invece emerge dagli studi dedicati a questo peculiare aspetto dell’“efficacia” è la capacità che le pratiche terapeutiche hanno di coinvolgere in termini cognitivi ed emozionali i pazienti, producendo così concrete trasformazioni nella
loro condizione, verificabili anche sul piano fisiologico. Il che
ha sollevato due ordini di interrogativi. Il primo sulla natura
non specifica delle reazioni endogene innescate dal significato
degli atti e degli strumenti di cura. Il secondo su quali siano
gli esatti meccanismi attraverso cui l’attività psichica e le emozioni producono miglioramenti percettibili nella condizione
dei pazienti (e cioè la relazione tra processi psichici, sistema
nervoso centrale, azione delle ghiandole endocrine e risposta
32. «Viene definito “effetto placebo” l’esito terapeutico prodotto da una
sostanza inerte che il paziente – nel momento in cui gli viene somministrata
– ritiene essere efficace: talché la conseguente attesa psichica di un miglioramento – e non già un’azione specifica del farmaco, che non c’è – risulta la sola
possibile causa del miglioramento avvenuto» (Seppilli T., 2004: 83, cfr. Brody
H., 1998 [1980]).
6. Malattia ed efficacia terapeutica
151
del sistema immunitario). Per quel che riguarda il tipo di trasformazioni che le terapie rituali producono nell’organismo, fin
dagli studi illustrati da Prince (Prince R., 1982) è emerso come
esse comportino la produzione di endorfine, con effetti sostanzialmente generici, soprattutto analgesici, euforici e amnesici,
effetti nient’affatto trascurabili e senz’altro utili a contrastare lo
stato di malattia nel suo complesso, ma non sempre sufficienti
a spiegare l’azione di contrasto verso specifiche manifestazioni
patologiche:
non si comprende bene come un processo generale, comune a tutti
i pazienti, possa produrre qualcosa di specifico adatto alla patologia di ciascuno [...] Non è possibile limitarsi ad affermare che
il sistema nervoso autonomo ha la possibilità di raggiungere tutti gli organi: occorre assolutamente comprendere meglio perché
guarisca tal parte del corpo in luogo di tal altra, in una situazione
patologica particolare (Bibeau G., 1998 [1983]: 138-139).
Proprio per fornire soluzioni a questo tipo di interrogativi, negli ultimi decenni si è registrato un avvicinamento tra branche
disciplinari diverse, alla ricerca di studi e analisi che sappiano
integrare una pluralità di informazioni relative alle diverse funzioni dell’organismo (come fra l’altro attesta la nascita in seno
alla biomedicina di una disciplina innovativa quale la psiconeuroendocrinoimmunologia33).
Quanto agli esatti meccanismi attraverso cui le attività
psichiche sarebbero in grado di produrre la loro “efficacia”
(curando la malattia, ma a volte causandola o contribuendo
33. A questa disciplina si deve lo sforzo di «delineare le complesse e articolate mediazioni anatomo-fisiologiche e chimico-fisiche – le precise catene
molecolari, ad esempio – attraverso le quali si determina effettivamente il condizionamento del sistema nervoso centrale sul sistema immunitario e dunque
sulla sua attività modulatoria sui livelli di difesa organica dalle malattie: un
momento essenziale del funzionamento sistemico unitario del corpo umano
e dei suoi meccanismi di attivo adattamento al contesto ambientale (sociale e
naturale)» (Seppilli T., 2003: 83, cfr. anche Seppilli T., 1996: 13).
152
Alessandro Lupo
ad aggravarla34), svariate teorie si sono succedute dai tempi
del già menzionato saggio sull’“efficacia simbolica” di LéviStrauss (Lévi-Strauss C., 1975b [1949]) e, prima ancora,
dei lavori anticipatori di Mauss (Mauss M., 1965a [1926]) e
Cannon (Cannon W.B., 1942) sulla “morte vodu” o “morte per
suggestione”35. Alla loro base troviamo l’ipotesi36 che attraverso
l’impiego di parole e gesti rituali si stabilisca una connessione
tra la condizione di sofferenza del singolo paziente e i modelli
culturali attraverso cui è possibile rappresentarla, dimodoché
“manipolando” ritualmente tali simboli il terapeuta riesce ad
agire sulla psiche del paziente, trasformandone l’esperienza e
attivando processi cognitivi ed emozioni in grado di suscitare
reazioni fisiologiche. Questo tipo di spiegazione dell’efficacia
delle terapie rituali – che sostanzialmente riprende e rielabora la proposta di Lévi-Strauss – presuppone che da parte del
paziente vi sia una effettiva comprensione del significato degli
enunciati verbali (canti, formule, preghiere, narrazioni mitiche,
performance sciamaniche) e degli atti rituali di chi interviene in
suo favore e ai quali si pensa egli assista. Tuttavia – almeno in
alcuni casi, tra cui proprio l’esempio cuna da cui parte la riflessione dell’antropologo francese –, l’evidenza etnografica sembra smentire tale eventualità, in quanto spesso i pazienti non
sono in grado di ascoltare o vedere ciò che viene detto e fatto a
loro beneficio, oppure non possono comprendere quelle parole, in quanto formulate in un linguaggio esoterico inaccessibile
ai profani37, o infine non sono neppure fisicamente presenti al
34. Speculare all’effetto placebo vi è infatti l’effetto “nocebo”, capace di
«causare la malattia (o la morte) attraverso le aspettative di malattia (o di
morte) e gli stati emotivi a ciò associati» (Hahn R.A., 1998: 139).
35. Sul tema della “morte vodu” vi è una copiosa letteratura, di cui qui
mi limito a segnalare i contributi di Lex (Lex B.W., 1974), Lewis (Lewis G.,
1997 [1977]), Hahn e Kleinman (Hahn R.A. - Kleinman A., 1983), Eastwell
(Eastwell H.D., 1982), Reid e Williams (Reid J. - Williams N., 1984).
36. Mi rifaccio qui soprattutto ai lavori di Dow (Dow J., 1986) e Kleinman
(Kleinman A., 1988b: 131 ss.), cfr. anche Beneduce (Beneduce R., 1997: 21).
37. Si vedano al riguardo le obiezioni sollevate da Sherzer (Sherzer, 1983:
134, 1989 [1974]: 271-272), Squillacciotti (Squillacciotti M., 1998) e Severi
6. Malattia ed efficacia terapeutica
153
rituale terapeutico (cfr. Sherzer, J. 1989 [1974]: 272, Lupo A.,
1999: 79).
Se non è nella comprensione cosciente da parte del paziente dei “significati” della terapia rituale a lui dedicata, dove va
dunque cercata la fonte di questo tipo di efficacia? Come ha
pertinentemente osservato Laurence Kirmayer, «qualunque sia
il lavoro metaforico eseguito dal [paziente] sofferente, non lo si
potrà rinvenire nella struttura formale degli incantesimi dello
sciamano ma nelle aspettative ingenerate dal più ampio contesto sociale della guarigione e nelle sensazioni corporee e nelle
immagini evocate dagli aspetti non verbali e paralinguistici del
processo rituale» (Kirmayer L.J., 1993: 169). Un punto di vista
che permette di cogliere la centralità del ruolo che – nel processo di guarigione – svolge la capacità “creativa”, sollecitata nel
paziente dall’intervento del terapeuta, di ridefinire in termini
cognitivi e affettivi la sua esperienza di malattia, elaborandone rappresentazioni aperte a soluzioni positive e molteplici. Mi
sembra che molte delle più recenti e interessanti proposte analitiche dell’antropologia in tema di efficacia38 convergano nel riconoscere la fondamentale funzione degli spazi che, nell’ambito
del percorso di cura, vengono lasciati alla creatività del malato
e che consentono di sottrarlo almeno in parte alla passività cui
la malattia per definizione lo condanna. Ciò vale sia per quanto
riguarda la possibilità di elaborare del proprio vissuto di malattia rappresentazioni narrative “aperte” (gli «elementi congiuntivi» di Byron Good, 1999 [1994]: 234) e suscettibili di «risvegliare dalla convenzionalità e dalla finitudine [della malattia],
generando una risposta creativa e rivitalizzando il linguaggio e
l’esperienza» (Good B.J., 1999 [1994]: 252), sia per quella di
contrastare con l’immaginazione la soffocante “determinatezza
del passato” e costruire una nuova soggettività (un self) capace
(Severi C., 1993: 242, 2004: 215, 230-238) per il caso cuna.
38. Mi riferisco soprattutto ai saggi di Contreras e Favret-Saada (Contreras J. - Favret-Saada J., 1985), Csordas (Csordas T. J., 1994), Good (Good
B.J., 1999 [1994]), Severi (Severi C., 2004), Beneduce (Beneduce R., 2005).
154
Alessandro Lupo
di contrapporsi alla malattia in un contesto di completo rinnovamento esistenziale (Csordas T.J., 1994: 3, 109, 161-164),
sia infine per la capacità “proiettiva” mediante la quale il paziente risponderebbe non tanto al contenuto proposizionale (il
significato linguistico) della terapia sciamanica, quanto alle sue
“parti incomprese”, che verrebbero «decifrate iconicamente»
quasi fossero «una sorta di immagine sonora» (Severi C., 2004:
232), dimodoché non sarebbe tanto il terapeuta rituale, ma «il
paziente stesso a costruire per sé la sua efficacia simbolica, a
prestare la propria parte al canto enunciato dal terapeuta [...
attribuendo] senso agli aspetti latenti di quanto il terapeuta
enuncia. Prima di credere, la paziente dello sciamano proietta»
(ibidem: 236-237). Secondo quest’ultima ipotesi analitica, l’efficacia terapeutica degli atti rituali risiederebbe nella possibilità
che essi offrono al paziente di effettuare una elaborazione inconscia di rappresentazioni non codificate (ibidem: 220), in cui
collegare le proprie esperienze concretamente vissute a quegli
spazi ancora indefiniti del proprio immaginario – che Severi designa come «punti neutri» (ibidem: 223, 235) o «vuoti», «spazi
mancanti» (ibidem: 235), “scarsamente connotati” – che possono essere creativamente riempiti dal soggetto, rendendogli
possibile immaginare interpretazioni e soluzioni nuove e potenzialmente salvifiche39.
Quest’ultimo accenno al “credere” (nei modelli cognitivi e
simbolici del proprio orizzonte culturale, così come nella capacità risolutiva dell’azione terapeutica) ci permette di rimarcare
– in conclusione – l’irrinunciabile ruolo che il terapeuta svolge
nel rendere sempre in qualche modo “efficace”, con la sua presenza, con le sue capacità di ascolto, di dialogo e di persuasione,
con il semplice suo agire, la terapia. Un’efficacia che, come s’è
più volte ribadito, si dispiega su piani molteplici e può variare
a seconda delle circostanze, delle persone, dei contesti sociali e
39. Nella prospettiva di Severi, dunque, la stessa “credenza” è «un tipo
particolare di proiezione, scatenata dall’interpretazione di particolari indizi»
(Severi C., 2004: 226).
6. Malattia ed efficacia terapeutica
155
culturali, ma che ben difficilmente può prescindere dalla qualità della relazione terapeutica e dalla capacità del paziente di
aderire e partecipare al processo terapeutico e farsene in qualche misura protagonista. Ben lo sanno pazienti e terapeuti, in
qualsiasi latitudine essi si trovino e a qualunque tipo di risorsa
facciano ricorso, come attestano le testimonianze che cito qui di
seguito e che due giovani antropologhe romane hanno raccolto
dalla viva voce di un paziente del più grande ospedale della
capitale, affetto da un carcinoma al polmone, e di un guaritore nahua della comunità messicana di Cuetzalan del Progreso
(Puebla):
La terapia agisce meglio se lo spirito è sollevato, almeno credo. Se
tu vuoi che una cosa ti faccia bene, quella cosa ti fa bene. L’umore
predispone il fisico ad accettare i farmaci, ecco. Se invece si ritiene la terapia un suicidio, quella non funziona. Vale come per
il vino: se mi piace, digerisco meglio. Ma se sa di tappo, non digerisco» (Intervista realizzata da Arianna Drudi presso il reparto di Pneumoncologia 1 dell’Ospedale San Camillo Forlanini, il
2/2/2007).
Se tu lo credi, sì funziona, ma se non lo credi, non funziona. [...]
Se vai [dai medici] con la miglior disposizione [con todo corazón]
e ti danno la medicina... Per questo c’è il Niño Santo Doctor40, se
credi al Niño Santo Doctor, così anche devi credere se ti dà la medicina il dottore. Sì: credere alla persona che ti farà il lavoro! [Un
curandero] ti farà la “pulizia”, ti farà le “chiamate”41, ti dirà le preghiere. Ma [funziona solo] se io credo, come dice la preghiera. Se
io credo! Allora sì, ti fa effetto la medicina, ti tornerà utile quello
che fa» (Scippa S., 2011: 60).
40. Si tratta di un’immagine di Gesù bambino con il camice e gli strumenti
del medico (stetoscopio, valigetta, ecc.), assai venerata a livello popolare e
presente in molte chiese messicane.
41. La “pulitura” (tachipahualiz) è un’azione lustrale volta a rimuovere
entità patogene eventualmente penetrate nel corpo, la “chiamata” (tanotzaliz)
serve invece a recuperare una delle entità spirituali che si pensa sia “caduta”
per via di una forte emozione, causando così la malattia (cfr. Signorini I. Lupo A., 1989).
Fabio Dei
7. Medicine non convenzionali: una prospettiva
antropologica
1. Cosa sono le MNC?
Medicine non convenzionali (MNC) è il termine che si è affermato negli ultimi anni per definire un’ampia e assai eterogenea gamma di saperi e pratiche diagnostiche e terapeutiche
che si differenziano in modo sostanziale dalla biomedicina e
che, usualmente (anche se non sempre), non sono praticate
e insegnate nelle istituzioni mediche ufficiali. Le si denomina
talvolta anche attraverso etichette come medicina alternativa,
complementare, dolce, naturale, olistica: l’espressione “MNC”
è stata però adottata nelle discussioni istituzionali (ad esempio
dal Parlamento Europeo) ed è oggi divenuta la denominazione
standard in Europa (in ambito anglosassone è più diffusa la sigla
CAM – Complementary and Alternative Medicine). Omeopatia,
agopuntura, pranoterapia, iridologia, naturopatia, fiori di Bach,
chiropratica, medicina ayurvedica, medicina antroposofica,
shiatsu sono alcuni fra i possibili e più noti esempi di MNC. In
realtà le discipline che rientrano in questo campo sono centinaia, con una tendenza alla proliferazione e alla produzione di
varianti. Si tratta di dottrine e pratiche che in Europa e nei paesi
occidentali hanno goduto di una certa diffusione a partire più o
meno dall’ultimo quarto del Novecento, giungendo a far presa
su segmenti significativi della domanda e del mercato sanitario,
in particolare fra i gruppi sociali medio alti, più giovani e con
un più alto livello di istruzione. Le ricerche quantitative in proposito sono varie e difformi: si afferma di solito che almeno il
158
Fabio Dei
50% dei cittadini dei paesi occidentali ha almeno una volta fatto ricorso a MNC, e una più bassa ma importante percentuale,
superiore al 10%, vi fa ricorso in modo sistematico come conseguenza di scelte precise e di una vera e propria filosofia di vita.
L’European Forum for Complementary and Alternative Medicine
parla oggi di 100 milioni di utenti in Europa (http:/www.efcam.
eu/content/view/27/45). Dopo alcuni decenni di sviluppo costante, oggi cominciano ad avvertirsi segnali di cedimento – è
un punto su cui tornerò in conclusione.
Da dove vengono le MNC? E che cos’hanno in comune oltre al loro attributo negativo, cioè al fatto di non coincidere con
la medicina ufficiale, “convenzionale”, scientifica? Potremmo
pensarle come un campo che riprende e mischia in nuove configurazioni una serie di ambiti culturali precedentemente separati. Fra questi:
a) la medicina popolare tradizionale (la continuità con essa
è particolarmente evidente in forme quali pranoterapia e fitoterapia),
b) le medicine orientali,
c) alcune tradizioni minoritarie della storia medica occidentale,
d) nuove forme di spiritualità, in particolare quelle usualmente etichettate come new age,
e) alcuni aspetti del pensiero ecologista e dei movimenti di
“ritorno alla natura”.
Questi ingredienti non sono presenti in tutte le MNC, ma nel
complesso ne costituiscono il campo. Li si può vedere uno accanto all’altro sfogliando le riviste del settore o partecipando
alle rassegne o ai festival di settore – il cui successo è tra l’altro
uno degli indici del progressivo radicamento delle MNC nel
mercato e nel senso comune. Percorrendo simili vetrine, non
è inconsueto trovare una accanto all’altra omeopatia, medicina
tradizionale cinese, forme di massaggio e manipolazione corporea come nella chiropratica, gli approcci “magici” della prano-
7. Medicine non convenzionali: una prospettiva antropologica
159
terapia, quelli misticheggianti della cristalloterapia e così via.
Si deve anche pensare che ciascuna disciplina, pur possedendo
una sua visione esclusiva e spesso non logicamente compatibile
con quella delle altre, tende a combinarsi con almeno alcune di
esse. Sia gli operatori che gli utenti praticano molto spesso più
di una disciplina: il che significa che la varietà è in sé un valore
che viene perseguito (laddove, dal punto di vista biomedico, è
proprio la tendenza alla proliferazione degli approcci a dimostrarne l’inconsistenza).
C’è qualcosa in comune in questa eterogenea varietà? Può
esser utile, sul piano descrittivo, individuare alcuni tratti ricorrenti o somiglianze di famiglia: caratteristiche che fanno parte o
sono desumibili dalla visione delle MNC, dall’autorappresentazione che danno di se stesse.
a) in primo luogo, una concezione del corpo e dell’intero cosmo basata sul concetto di energia più che su quello di materia. È il tema teorizzato nel Tao della fisica, e che le MNC
contrappongono alla visione “meccanicistica” della biomedicina. La salute è un corretto equilibrio di flussi energetici,
la malattia è il sintomo di squilibri, la cura deve consistere di
conseguenza in interventi volti a riattivare l’ “equilibrio”. Il
fatto che non si tratti di materia (o meglio che la materia rappresenti una sorta di effetto secondario o di epifenomeno rispetto alla fondamentale realtà dei campi energetici) spiega
il fenomeno dell’efficacia simbolica e delle cure spirituali. È
interessante osservare come il concetto di energia che circola
nel discorso delle MNC, per quanto pretenda di agganciarsi al significato attribuito al termine dalla fisica, finisca per
distaccarsene del tutto e per funzionare come termine-ombrello, vago e indeterminato e con una connotazione spesso
decisamente religiosa.
b) il carattere olistico. L’insistenza sull’inscindibilità di corpo e mente, della dimensione fisica e di quella spirituale,
caratterizza l’intero campo delle MNC, le quali dichiarano
invariabilmente di voler curare l’individuo come un tutto.
160
Fabio Dei
Questo è uno dei principali argomenti di polemica nei confronti della biomedicina, accusata non solo di separare corpo e mente ma di parcellizzare lo stesso corpo, curandone
singole parti o organi piuttosto che la totalità funzionale. Nel
discorso delle MNC, il cosiddetto “dualismo cartesiano” è il
grande scoglio da superare per una nuova concezione della
salute e della malattia,
c) La naturalità. Il secondo grande argomento critico verso
la biomedicina riguarda il suo approccio intrusivo, che tenderebbe a violare il naturale equilibrio della salute attraverso
l’uso smodato di farmaci sintetici e di tecniche chirurgiche.
Insieme alle cattive abitudini alimentari, ciò introduce nel
corpo un principio inquinante, si muove dunque in una logica patogena. Al contrario, nel campo delle MNC è diffusa
l’idea che la cura debba rappresentare semplicemente un
aiuto alla fondamentale vis medicatrix naturae.
d) il metodo individuante. Alla biomedicina viene imputata
anche la tendenza a spersonalizzare i pazienti, considerandoli solo come portatori intercambiabili di malattie a prescindere dagli aspetti peculiari della loro personalità. Le
MNC sostengono di curare la persona e non la malattia – anche se questa individualizzazione si esprime, come nel caso
dell’omeopatia, in un approccio classificatorio a “tipi” caratteriali, attribuiscono inoltre grande importanza al rapporto
umano tra medico e paziente, rapporto che nella medicina
ufficiale sarebbe oggettivato e burocratizzato. Occorre notare che l’individualizzazione della cura implica l’impossibilità
di standardizzare le procedure diagnostiche e terapeutiche:
non è detto che si possa formulare la stessa diagnosi per due
persone che presentano gli stessi sintomi, né che gli stessi
rimedi risultino ugualmente efficaci per persone affette in
apparenza dalla stessa malattia. Ciò rende incommensurabili le MNC rispetto ai metodi di test di efficacia (come il
doppio cieco) utilizzati dalla medicina ufficiale.
e) il lessico morale. Per quanto solo raramente in modo
esplicito, il discorso delle MNC attribuisce spesso connota-
7. Medicine non convenzionali: una prospettiva antropologica
161
zioni morali alla salute e alla malattia. La prima è frutto di
uno stile di vita “buono”, equilibrato e naturale, la seconda
scaturisce da disordini nel comportamento, da alimentazione squilibrata, da una vita quotidiana troppo stressante – in
definitiva da scelte sbagliate. Se la medicina moderna, come
nella memorabile analisi di Foucault, si è evoluta separando in modo netto il peccato dalla malattia e la salute dalla
salvezza, le MNC sembrano riavvicinare queste coppie di
concetti, facendo sì che la morale torni ad agire a ridosso del
corpo e delle sue manifestazioni.
f) il carattere alternativo. La denominazione di “alternative”,
che ha a lungo identificato le MNC, è stata lasciata cadere perché sembrava escludere la possibilità di una funzione
“complementare” rispetto alla biomedicina. Il termine coglieva tuttavia una caratteristica importante del fenomeno:
il suo presentarsi cioè in modo oppositivo rispetto alle istituzioni sanitarie ufficiali. Per quanto alcune MNC abbiano
cercato legittimazione nella mimesi del linguaggio e dell’atteggiamento biomedico, il campo si è piuttosto nutrito della
diversificazione – nel linguaggio, negli atteggiamenti e nel
modo di porsi degli operatori, nell’apparato simbolico e
rituale che circonda la cura, oltre che nelle vere e proprie
pratiche terapeutiche. Questo carattere alternativo è stato e
continua almeno in parte ad essere determinante nell’appeal
delle MNC per un certo tipo di pubblico: anche se questo
entra in tensione con la contrapposta tendenza al riconoscimento e alla normalizzazione. Questa tensione definisce
lo spazio sia morale che giuridico in cui si collocano oggi
le MNC, come vedremo oltre a proposito dei problemi del
loro riconoscimento legale.
2. Perché lo studio delle MNC è importante per l’antropologia medica
Malgrado la loro grande visibilità, le MNC sono state poco stu-
162
Fabio Dei
diate dall’antropologia culturale e da quella medica. Sul piano
internazionale, poche sono le monografie di taglio specificamente antropologico (Cant S. - Sharma U., 2001, Sharma U.
1991, Frohock M., 1992, Goldstein M.S., 1999, Lee-Treweek
G. et al. (curatori), 2005) e sembrano mancare ricerche di respiro ampio e comparativo. In Italia, i lavori più rilevanti sono stati
prodotti in ambito sociologico (Lalli P., 1988, Losi N., 1990,
Colombo E. – Rebughini P., 2003), e risentono della difficoltà
di individuare metodologie etnografiche adeguate alla natura
del fenomeno. In generale, rispetto ai grandi temi dell’antropologia medica, il fenomeno è decisamente sottovalutato (basta
sfogliare gli indici delle principali riviste del settore per rendersene conto). Eppure si tratta di un fenomeno cruciale per
gli orizzonti teorici della disciplina. Si potrebbe pensare che la
scarsità degli studi dipenda dal suo controverso statuto teorico. Dal fatto, in altre parole, che focalizzare la questione delle
MNC costringe a scardinare alcuni assunti basilari del discorso
medico-antropologico: in particolare, il modo di pensare il rapporto tra la medicina ufficiale e quella popolare o tradizionale.
Nella sua impostazione classica, la disciplina assume come dato
di partenza la netta separazione tra una biomedicina caratterizzata come ufficiale o egemonica, sostenuta istituzionalmente e
scientificamente fondata, e una serie di saperi e pratiche folkloriche, tradizionali, subalterne, fondate su semplici evidenze
empiriche o su atteggiamenti magici e religiosi. È questa la situazione che gli antropologi si trovano di fronte nelle società
coloniali o ex-coloniali, e i folkloristi nello studio della medicina
popolare. Anzi, in entrambi i casi – dislivelli esterni o interni di
cultura – l’antropologo entra sul campo in un contesto di drammatica contrapposizione pratica tra i due ambiti: la medicina
ufficiale lotta per affermarsi universalmente e capillarmente
contro le resistenze e gli ostacoli delle “superstizioni” arcaiche.
L’antropologia, è vero, si muove (sia pur progressivamente)
nella direzione dell’annullamento della dicotomia. Da un lato,
essa rivendica la razionalità della medicina tradizionale: lontano dal risolversi in una congerie di superstizioni o “credenze”,
7. Medicine non convenzionali: una prospettiva antropologica
163
quest’ultima si rivela come una importante istituzione culturale,
radicata nelle strutture della socialità e dotata di una propria
efficacia simbolica. Dall’altro lato, gli strumenti dell’etnografia
possono mostrare come la stessa medicina scientifica sia legata
a “credenze” (ad esempio assunti metafisici e non solo evidenze
empiriche), operi nel quadro di modelli simbolici e rituali e abbia a che fare molto più di quanto pretenderebbe con significati
sociali. Dunque, la biomedicina è molto più significativa e la
medicina tradizionale è molto più razionale di quanto il senso
comune etnocentrico tende a pensare.
Tuttavia, il campo su cui le interpretazioni medico-antropologiche si esercitano resta strutturato dalle coppie concettuali
tradizione-modernità, magia-scienza e simili. La consapevolezza dell’opposizione tra la moderna biomedicina e tutto ciò che
essa si lascia alle spalle è ancora il fondamento epistemologico
della disciplina. Rispetto a questo quadro, le MNC rappresentano un oggetto ibrido e non definibile. Pur essendo un fenomeno decisamente moderno, riprendono e inglobano aspetti
caratteristici delle medicine tradizionali e non scientifiche – incluso, come abbiamo visto, dimensioni esplicitamente magiche
e significative. Quale razionalità o sapere le fonda? L’assunto
antropologico secondo il quale dietro certe pratiche e concezioni del corpo, della malattia e della salute debba esservi un
sistema cognitivo compatto e coerente sembra qui non potersi
applicare. Nel caleidoscopio delle MNC di razionalità e di filosofie ve ne sono molte, intrecciate, fluide e mutevoli. La ricerca di coerenza e compattezza non è semplicemente perseguita.
Neppure i concetti di sincretismo e di pluralismo medico si
applicano facilmente, legati come sono al classico schema dicotomico (una modernità che si combina variamente con una
resistente tradizione). In cosa consiste allora la “cultura” che
nutre le MNC? La loro proliferazione ci costringe a considerare
criticamente proprio il concetto centrale dell’intera intelligenza
antropologica.
E ancora: come è possibile classificarle sull’asse colto-popolare, o egemonico-subalterno? È evidente come queste nozioni,
164
Fabio Dei
usate per dar conto del divario tra medicina ufficiale e folklorica, non riescono a dir molto sulla natura delle MNC. Queste
non sono prodotte e sostenute dalle istituzioni ufficiali, ma non
sono neppure patrimonio distintivo di ceti sociali esclusi dal
potere e dai circuiti della comunicazione culturale. Si collocano
semmai sul piano intermedio della cultura di massa – un terreno che l’antropologia medica non è molto abituata a studiare.
Certo, sul piano mondiale le MNC restano un fenomeno minoritario rispetto sia alla biomedicina che alle forme tradizionali e
folkloriche di diagnosi e terapia. Tuttavia, la loro stessa presenza obbliga a mutare la percezione anche degli altri due campi,
ai quali è irriducibile, e del loro reciproco rapporto. Così come
obbliga a mettere a fuoco alcune caratteristiche peculiari della
cultura contemporanea, che la distinguono dai più classici contesti di studio dell’antropologia.
3. MNC e biomedicina.
Come detto, la diffusione delle MNC ha riguardato in particolare (anche se non esclusivamente) i paesi occidentali più ricchi
a partire dall’ultimo quarto del ventesimo secolo – nella fase
che è stata variamente definita come tardo-capitalistica, post-industriale o post-moderna. È possibile individuare alcune caratteristiche di questo contesto storico-sociale che possano, se non
spiegare, almeno chiarire aspetti e modalità del loro successo?
Cercherò di sintetizzare di seguito alcuni dei punti di maggior
rilievo. Alcuni di questi hanno a che fare con gli sviluppi dei
problemi sanitari e della stessa biomedicina, altri riguardano
le culture del corpo, del benessere, dell’ambiente e della spiritualità, infine, vi sono condizioni riguardanti il più generale
contesto politico e comunicativo in cui le MNC si radicano,
in particolare quella che potremmo chiamare crisi dei saperi
esperti.
In primo luogo, si è soliti porre in relazione la diffusione
delle MNC con alcuni punti deboli o insuccessi della biome-
7. Medicine non convenzionali: una prospettiva antropologica
165
dicina. Quest’ultima, dopo i clamorosi successi ottenuti nella
lotta alle malattie infettive nella prima metà del Novecento, non
ha ottenuto uguali risultati nei confronti delle malattie croniche
e degenerative nella seconda metà del secolo. Nonostante gli
indubbi progressi delle tecniche terapeutiche, la scienza medica
non ha trovato risposte certe a malattie come il cancro, i disturbi cardiaci, l’asma, l’AIDS. In questi casi continua ad esistere
grande incertezza sul piano dell’eziologia come su quello della
cura, inoltre, sembra prevalere un aspetto idiosincratico (decorsi della malattia e reazioni alle cure molto diversi da persona
a persona) che la biomedicina non riesce a controllare e a inglobare nel suo sapere generalizzante e nomotetico. Perché la
stessa causa può produrre malattia in un caso e non in un altro,
o produrla in tempi molto diversi (come ad esempio accade con
l’HIV)? Perché la stessa terapia può avere o non avere effetto
sullo stesso tipo di sindrome? In mancanza di risposte, la biomedicina non riesce a dare un chiaro significato a questi disturbi. Si può pensare allora che le MNC rappresentino una duplice
promessa: trovare soluzioni più efficaci e attribuire a queste malattie un più chiaro e coerente significato, che le renda pensabili
e non le sottometta all’angoscioso dominio del caso.
A questo argomento se ne affianca spesso un altro, che insiste su diversi punti deboli della pratica biomedica: il suo carattere eccessivamente tecnico e spersonalizzante, la concezione
meccanicistica e parcellizzata del corpo, un rapporto medicopaziente poco umano. E ancora, la tendenza a medicalizzare
ogni tipo di problema e a intervenire in modo invasivo e localizzato, senza porre attenzione all’equilibrio complessivo dei
soggetti del processo di cura. A ciò le MNC possono opporre
il loro approccio ecologico e olistico, l’attenzione agli aspetti
umani e una (presunta) centralità della relazione tra medico e
paziente (tanto che entrambi questi termini divengono inadeguati a definire i rispettivi ruoli).
Simili argomenti sono plausibili, ma solo fino a un certo
punto. Intanto, non funziona l’idea che gli attori sociali, di
fronte al fallimento o all’incertezza delle cure biomediche, ten-
166
Fabio Dei
dano a rivolgersi a qualsiasi altra soluzione venga prospettata
dal mercato: occorre che esistano le condizioni culturali che
fanno apparire autorevoli, credibili e sensate queste alternative. A maggior ragione, non è certo la disperazione provata di
fronte al male incurabile che fa scattare l’affidamento a risorse
alternative. Qualcosa di simile è stato sostenuto per il ricorso
ai guaritori e alle terapie magiche e miracolistiche. La tesi non
funziona per i guaritori e, a maggior ragione, per le MNC. Non
sono certo persone disperate quelle che vi si rivolgono, o spinte
dall’impulso irrazionale dell’ultima speranza: sono al contrario
soggetti lucidi e razionali, che compiono scelte motivate nel
quadro di condizioni culturali che occorre comprendere.
Inoltre, la maggior parte delle MNC non offre una risposta
alle più gravi malattie. Magari viene promosso uno stile di vita
che si ritiene possa prevenire i disturbi cronici e degenerativi:
ma quasi mai vi è la pretesa di possedere terapie miracolose,
in grado di salvare la vita delle persone là dove la biomedicina
ha fallito. Piuttosto, le MNC offrono una risposta a tutta una
serie di malesseri che le maglie troppo ampie della biomedicina
non riescono ad affrontare e qualche volta neppure a riconoscere e a nominare. Il loro terreno è quello di una domanda di
salute raffinata e consapevole, che presuppone un’alta qualità
della vita e l’esistenza della rete di protezione di un’assistenza
sanitaria (la possibilità di rivolgersi in ogni momento a strutture di pronto soccorso, ospedali, laboratori diagnostici, medici
specialisti, eccetera) che viene assunta come scontata, anche se
considerata non più sufficiente. Per certi versi, si può dire allora che le MNC si innestano sui successi della biomedicina, più
che sui suoi insuccessi: vale a dire, su una domanda di salute
e di benessere che è divenuta possibile in seguito al miglioramento delle condizioni di vita (alimentazione, riscaldamento,
sicurezza e igiene sul lavoro e così via) e alla capillare diffusione
dell’assistenza sanitaria e delle risorse biomediche.
Se è così, si può dubitare del fatto che le MNC costituiscano
una reazione alla progressiva medicalizzazione della società cui
tende la biomedicina (come sostenuto fra gli altri da Schneirov
7. Medicine non convenzionali: una prospettiva antropologica
167
M. – Geezik J.P., 2003: 24): ne rappresentano semmai un aspetto. Per il loro tramite, l’influenza dei saperi, delle pratiche e
degli esperti medici si estende in aree della vita quotidiana e
della gestione del proprio corpo e delle relazioni sociali cui la
biomedicina non ha accesso. Questa è l’altra faccia della medaglia dell’approccio olistico: rifiutando di isolare la medicina
dalla vita, da un lato ne “umanizza” le pratiche, dall’altro porta
a concepire l’intera esistenza in termini di preoccupazioni in
senso lato mediche, riferite cioè allo stato di salute e di benessere, all’equilibrio tra mente e corpo e così via.
Le interpretazioni centrate sulla contrapposizione delle
MNC alla medicina “ufficiale” colgono solo un aspetto del loro
discorso o della loro ideologia: nella pratica, esse sono in larga
parte dipendenti dalle forme ufficiali della medicina e da quelle
che potremmo chiamare le concezioni egemoniche del corpo,
della salute e della malattia. L’idea di leggerle come forme di
“resistenza” antiegemonica, come pure è stato suggerito da alcuni frettolosi lettori di Michel De Certeau, sembra alquanto
forzata. Del resto, una parte almeno delle MNC cerca legittimazione proprio nell’adesione a quelli che potremmo chiamare
i presupposti politici della biomedicina: ad esempio un modello forte di autorità (talvolta carismatica) del medico rispetto
al paziente, l’uso di un linguaggio tecnico e specialistico che
ri-descrive il mondo del senso comune, la pretesa di imporre
ai pazienti regole di buona vita. Naturalmente, questi punti andrebbero dimostrati empiricamente caso per caso. Non è facile
farlo sulla base della letteratura, perché la gran parte degli studi
sulle MNC si basano sulla interpretazione della loro esplicita
filosofia più che sull’analisi etnografica delle pratiche che esse
fondano.
4. Il personale è politico
Dunque, è improbabile spiegare il successo delle MNC semplicemente come conseguenza dei fallimenti della biomedicina, o
168
Fabio Dei
come reazione antiegemonica al “biopotere” che su di essa si
fonda. Non solo le MNC presentano ampie e rilevanti continuità con la pratica biomedica, soprattutto, esse si innestano
su una serie di tratti socio-culturali che appartengono decisamente alla sfera dell’“egemonico” nelle società occidentali contemporanee. Prima di tutto, non è difficile ipotizzare un nesso forte con alcuni dei grandi mutamenti culturali che hanno
caratterizzato gli anni Sessanta e Settanta del Novecento. Tra
questi, una rinnovata attenzione al corpo, alla sua forma fisica,
al suo rapporto con il mondo naturale, lo sviluppo di nuove
forme di spiritualità orientate verso l’immanenza, l’attenzione
alle religioni e alle filosofie orientali e alle relative tecniche di
coordinamento mente-corpo. Questi ingredienti sono cruciali
nella costruzione dell’universo delle MNC, così come è cruciale la tendenza sempre più accentuata a cercare la realizzazione
personale nel perseguimento individuale del benessere fisico e
spirituale – piuttosto che, come nella fase classica o “solida”
della modernità, nell’adesione a grandi ideali o a grandi sfere
dello spazio pubblico. “Il personale è politico”, lo slogan che
era sembrato tanto rivoluzionario ai movimenti femministi, è
diventato il motto più distintivo delle società occidentali di fine
XX secolo. Anche i più importanti legami sociali sono subordinati all’imperativo del benessere. Quelli familiari sono sempre
più percepiti come vincoli insopportabili rispetto alle esigenze di realizzazione personale, quelli religiosi sono mantenuti al
prezzo della dismissione dei valori e delle regole di condotta
che possono apparire “antimoderne”, riguardanti la sfera del
comportamento affettivo e sessuale, quella del consumo e delle
gratificazioni (basti pensare alla scomparsa o almeno alla impopolarità, nelle religioni “moderne”, di ogni pratica penitenziale, di digiuno o mortificazione del corpo, e della proibizione
di ogni forma di soddisfacimento immanente). Infine i legami
politici, sia nei confronti delle istituzioni (lo stato, la patria) sia
degli ideali (il liberalismo, il socialismo), sono decisamente indeboliti e non più in grado di produrre identificazioni forti e di
orientare progetti di vita.
7. Medicine non convenzionali: una prospettiva antropologica
169
La sociologia ha descritto largamente questi fenomeni sotto etichette come cultura dell’edonismo o del narcisismo, sottolineando la loro connessione con la sfera del consumo e con fenomeni quali il fitness, lo sport e varie forme di estetiche del corpo
(per una connessione forte tra fitness e MNC si veda Glassner
B., 1990, Goldstein M. S., 2003). La centralità del corpo assume aspetti forse contrapposti ma correlati. Da un lato, c’è
l’idea di un corpo da costruire per conformarsi ai modelli commerciali di bellezza, attrattiva e realizzazione, attraverso mezzi
“artificiali” quali la cosmesi, il body-building, trattamenti estetici come depilazione, abbronzatura eccetera, varie forme e livelli di chirurgia plastica. Dall’altro, c’è invece il perseguimento
dell’ideale di un corpo “naturale”, che occorre sottrarre ai condizionamenti della tecnologia e agli squilibri della vita urbana.
Si tratta di due orizzonti di rappresentazioni e strategie molto
diversi. Il primo rimanda a scenari di aggressivo consumismo,
a idee di successo personale nel quadro di una piena accettazione dei valori del consumismo, il secondo è apparentemente antimodernista, rinvia a una cultura ecologista e alternativa
che rifugge il consumismo e sottolinea i valori della purezza,
dell’autenticità, della spiritualità.
Apparentemente opposti, questi due atteggiamenti possono
però apparire come facce di una stessa medaglia secondo una
certa visione sociologica della contemporaneità. Fra i più autorevoli studiosi che hanno sottolineato questo punto si deve citare Zygmunt Bauman, che nel successo del fitness e nelle diffuse
preoccupazioni per l’immagine corporea vede una conseguenza
della crisi della sfera pubblica e della privatizzazione radicale
dell’esistenza in quella che chiama modernità liquida. In una
società in cui i legami, le istituzioni e le identità si fanno sempre più deboli e fluide, le attenzioni e le preoccupazioni per il
corpo occupano una sfera dell’esistenza quotidiana e della consapevolezza molto più ampia che in passato. Sono attenzioni,
per Bauman, di tipo ossessivo, dominate dal senso di ansia e di
insicurezza per una quantità di pericoli, noti o sconosciuti. Nel
tentativo disperato di negare la mortalità, ci concentriamo sulla
170
Fabio Dei
difesa dalle minacce esterne (le impurità che possono entrare
nel corpo contaminandolo, dai cattivi alimenti all’aria inquinata), oppure sul tentativo di evitare attraverso pratiche sempre
più scientifiche l’invecchiamento e il deterioramento del corpo,
mantenendolo almeno esteriormente prossimo ai modelli pubblicitari. Il tratto comune delle due strategie è la «sostituzione del valore della salute con il valore del fitness» (Bauman Z.,
1999: 82 e 50-55, in direzione analoga, anche se non necessariamente così critica, vanno le analisi del rapporto tra MNC e
consumismo contenute in Tovey P. – Easthope G. – Adams J.
(curatori), 2003, Lee-Treweek G., 2005a).
5. Il corpo sociale nelle società a griglia debole.
Lo scenario che Bauman e altri autori delineano (v. in particolare Coward R., 1989 per una brillante analisi del tema del corpo
naturale) coglie importanti elementi di trasformazione culturale
sui quali il successo delle MNC si innesta. Queste tesi hanno
anche il merito di collegare i mutamenti nelle percezioni del
corpo e nelle relative pratiche a una più ampia prospettiva socio-politica. Bauman vede nel rilievo dell’estetica corporea, del
fitness e del “salutismo” il frutto dell’ansia causata dalla liquefazione delle istituzioni moderne, da un lato, dall’altro, di una
privatizzazione radicale della vita sociale, di una fuga dai valori
relazionali della sfera pubblica, di un vuoto edonismo che trasforma gli individui in passivi imitatori di modelli consumistici.
Ma questa prospettiva, oltre che apocalittica, sembra anche un
po’ troppo semplicistica, o meglio, rimanda a un discorso di
critica al consumismo e di rivalutazione dell’ “essere” rispetto
all’ “avere” o all’ “apparire” che nella cultura contemporanea
è tanto diffuso quanto il discorso consumista stesso (il che, per
inciso, spiega la grande fortuna editoriale di Bauman). Dunque,
fa parte del fenomeno da comprendere più che rappresentarne
una spiegazione.
Nella tradizione antropologica, il corpo non rappresenta
7. Medicine non convenzionali: una prospettiva antropologica
171
una sfera puramente individuale in contrapposizione a quella
pubblica: è anzi il terreno d’incontro privilegiato fra individualità e società. Com’è noto, questo punto sta al centro della riflessione di Mary Douglas, che è qui importante ricordare
proprio perché ha esplicitamente collocato i temi della culture
alternative e delle MNC nel quadro di una teoria sociale del
corpo e della percezione del rischio (Douglas M., 1994). Il
rapporto tra sistemi simbolici e struttura sociale è impostato
da Douglas in modo assai più complesso rispetto a Bauman:
dove quest’ultimo ricorre a nozioni vaghe e ambigue come ansia e insicurezza, la prima fa riferimento a sistemi cognitivi e di
classificazione categoriale che sono legati, sia pure in modo non
deterministico, a caratteristiche dei sistemi sociali definite dai
valori differenziali del “gruppo” e della “griglia”. Queste due
nozioni fanno riferimento rispettivamente alla forza del controllo dei gruppi sugli individui (al gruppo debole corrisponde
un alto livello di individualismo) e al grado di compattezza e
obbligatorietà dei sistemi di classificazione (alla griglia debole
corrisponde un’ampia gamma di variabilità di rappresentazioni,
“mitologie”, norme e valori). Ora, per Douglas «il controllo
del corpo è un’espressione del controllo sociale»: c‘è un corpo
fisico che “contrae o espande le sue esigenze” in modo proporzionale alle esigenze del corpo sociale, vale a dire con il tendersi
o il rilassarsi delle pressioni sociali (Douglas M., 1970: 101,
109). Dunque, la gamma di significati che può assumere l’uso
del corpo – il modo di presentarlo esteticamente, la percezione
della sua purezza e impurità, del rischio e della sicurezza e così
via – è legata all’esperienza sociale.
La società contemporanea è del tipo gruppo debole-griglia
debole: fortemente individualistica, lascia ai suoi membri una
libertà relativamente ampia di scelta di norme, valori, cosmologie. In essa il rapporto delle persone col proprio corpo non
è né più né meno rilevante che in altre epoche o formazioni
sociali, la differenza sta semmai nella diffusione di molti e diversi modelli, orientamenti, rappresesentazioni fra cui è possibile scegliere. La gestione del corpo si svincola sempre più dalle
172
Fabio Dei
forme dell’autorità (da qui l’orrore tutto contemporaneo per la
violenza, la costrizione fisica e la disciplina corporale), dai dettami del rito e dai dogmi cosmologici, per ricadere nella sfera
delle strategie distintive individuali e di gruppo. È la libertà di
scelta, assieme alla diffusione di una molteplicità di modelli e risorse sia conoscitive sia pratiche (con l’aumento dell’istruzione
e dell’accesso alle informazioni), che pone la gestione del corpo
al centro dell’attenzione. In contesti caratterizzati da una griglia
più forte (non solo le società “tradizionali”, ma anche la modernità solida), le questioni riguardanti il modo di presentare
il corpo, di modellarlo, vestirlo, nutrirlo, curarlo eccetera, sono
regolate da schemi culturali relativamente stabili e obbligatori,
accompagnati da forti sanzioni per la devianza e, soprattutto,
da una scarsa disponibilità di risorse alternative. Nella tarda
modernità, le risorse e le possibilità di accedervi aumentano in
modo esponenziale, e tutto ciò diviene arena per le stategie distintive di agenti individuali e collettivi.
Sulla base di un simile modello, possiamo forse individuare
con maggior precisione i fattori socio-culturali che negli ultimi
decenni hanno trasformato la percezione del corpo, della salute
e della malattia, ponendo le condizioni anche per la fortuna delle MNC. L’espansione delle risorse conoscitive, in particolare
attraverso la modalità “democratica” dei mezzi di comunicazione di massa, ha proceduto parallelamente all’indebolimento
del principio di autorità. Quest’ultimo ha investito anche l’ambito del sapere scientifico e medico, che non ha perduto nulla
del suo prestigio ma è stato affiancato da altre visioni e voci, le
quali hanno avuto la possibilità di prendere la parola in modo
simmetrico e di non esser presentate come pure bizzarrie devianti. Nella modernità “solida”, come già osservato, la diversità in questo campo si presentava sotto forma di residuo di
arretratezza, e nei termini di nette dicotomie quali egemonicosubalterno, scientifico-magico, ufficiale-folklorico. Nei sistemi
a griglia debole assistiamo alla proliferazione di una pluralità
di prospettive che, nell’immaginario pubblico, competono ponendosi, in linea di principio, sullo stesso piano. È il fenomeno
7. Medicine non convenzionali: una prospettiva antropologica
173
che è stato anche definito come indebolimento dei saperi esperti. L’autorevolezza dei ceti intellettuali e delle loro istituzioni
(l’università, le comunità scientifiche) nel costruire ed imporre
“cosmologie” non è più così solida: molte crepe si aprono nel
loro rapporto con la società civile, con quella politica e con la
comunicazione mediale. I cittadini rivendicano il loro diritto di
scelta attiva in campi che in precedenza erano regolati da rigide
norme dettate dall’alto di un’autorità indiscutibile, che poteva
esser rifiutata solo ponendosi al di fuori della razionalità e della
normalità. La rappresentazione e la gestione del corpo, della
salute e della malattia non fanno eccezione.
Come in altri campi del consumo culturale, la scelta di modalità di presentazione del corpo, di alimentazione, di forme
di attività fisica e di pratiche terapeutiche diviene parte della
strategia di costruzione identitaria e di distinzione sociale. Nella
cornice sociologica proposta da Mary Douglas o – con le dovute differenze – da Pierre Bourdieu l’opzione per le medicine non convenzionali appare in primo luogo come una scelta
di ordine estetico e morale, parte di un “gusto” che identifica
segmenti sociali tracciando linee di separazione da ciò che sta
“in basso”, nell’ambito della volgarità e del cattivo gusto. Ciò
spiega anche il dato di fatto della diffusione delle MNC, e delle
relative estetiche del corpo, tra i gruppi sociali che più hanno
bisogno di investire in capitale simbolico: i ceti medi con buon
livello d’istruzione, i giovani e in particolare gli studenti e altri
gruppi caratterizzati da mobilità verso l’alto. Questo sembra
valere decisamente per l’Europa, la situazione degli Stati Uniti così come descritta ad esempio in Schneirov M. – Geezik J.D.,
2003, Frohock M. 1992 - corrisponde meno a questo modello
in ragione del diverso tessuto sociale sul quale si colloca e della
tendenza delle culture mediche “alternative e complementari”
a combinarsi con movimenti religiosi e con forme di associazionismo che veicolano tutt’altro tipo di significati sociali.
È in un simile quadro che devono essere intese fra l’altro le
rivendicazioni dei cittadini (in qualità di potenziali “pazienti”
o di “consumatori” della salute) nei confronti delle istituzioni
174
Fabio Dei
mediche, e i movimenti diretti alla cosiddetta “democratizzazione” della medicina e all’affermazione dei diritti del malato.
È in questo quadro, inoltre, che possiamo meglio comprendere
la diffusa rivendicazione del diritto alla libertà di scelta terapeutica – il principio che sta alla base delle proposte di riconoscimento giuridico delle MNC, che discuterò nel prossimo
paragrafo.
6. Il problema del riconoscimento giuridico delle MNC.
La diffusione delle MNC ha posto alle autorità sanitarie e politiche il problema del loro riconoscimento e della loro regolamentazione. È un problema dai molteplici e interrelati aspetti
(per una prospettiva generale si vedano Stone J. – Matthews J.
1996, Lee-Treweek J., 2005a). Dal punto di vista dei praticanti,
riconoscimento significa legittimità dell’impiego di terapie non
convenzionali per coloro che sono comunque abilitati all’esercizio della professione medica, da un lato, dall’altro, la possibilità di svolgere una professione sanitaria per gli esperti in MNC
che non siano in possesso del titolo di medico. Per i pazienti,
il riconoscimento può significare libertà di scelta terapeutica
ed inclusione delle MNC nel quadro dell’assistenza pubblica
e delle prestazioni fornite dal sistema sanitario nazionale, ma
anche garanzia di trovarsi di fronte un’offerta sicura, praticanti non improvvisati e formati in modo rigoroso e controllato.
Nell’ottica della gestione pubblica della sanità, il problema è
principalmente quello di tenere sotto controllo un settore che,
come abbiamo visto, tende alla costante proliferazione e rischia
in molti punti di sconfinare verso forme di esercizio abusivo
della professione medica. Tutto questo non è affatto semplice: il
pluralismo che contrassegna l’universo delle MNC entra in una
essenziale tensione con il principio monopolistico che ha guidato le politiche sanitarie moderne, basato su una stretta alleanza
tra stato e biomedicina. Se il sapere medico non è più unitario,
garantito cioè da una comunità scientifica, da un sistema forma-
7. Medicine non convenzionali: una prospettiva antropologica
175
tivo e da un relativo ordine professionale, su quale base lo stato
può impiegare criteri di rigore scientifico nel sostegno alla ricerca, di efficacia terapeutica nella spesa farmaceutica, di competenza nel riconoscimento al diritto di esercitare la professione?
La spinta a forme di riconoscimento giuridico delle MNC è stata forte in Europa soprattutto verso la fine degli anni Novanta,
oltre che dalle organizzazioni dei praticanti, essa è venuta dalle
forze politiche più legate alla cultura ecologista, in primo luogo
i Verdi. A livello di Parlamento Europeo, una intensa discussione ha portato nel 1997 all’approvazione di una risoluzione che i
promotori (in primo luogo il parlamentare belga Paul Lannoye)
hanno trovato deludente ed eccessivamente cauta, finendo per
disconoscerla: ma la relazione che l’ha accompagnata e la discussione che essa ha aperto hanno rappresentato il momento
di più ampia emergenza pubblica della questione delle MNC.
Tornerò fra un attimo su alcuni punti qualificanti che ne emergono. In Italia, gli echi di questo dibattito si sono manifestati
in un disegno di legge presentato nel corso della XIII legislatura, 1997, (anche qui per iniziativa di un deputato verde, Paolo
Galletti), che dà unità a una serie di eterogenee proposte del
decennio precedente (raccolte in Crocella C., 1991), non ne è
tuttavia risultato nulla di concreto. Andrebbero analizzate anche le iniziative di alcune Regioni, che come il Piemonte hanno
adottato leggi specifiche, o come la Toscana hanno inserito le
MNC nel Piano Sanitario Regionale. Un quadro complesso e
articolato, in cui tuttavia le difficoltà e le contraddizioni inerenti alla materia hanno impedito il raggiungimento di soluzioni
chiare e ben definite.
Possiamo capire il perché analizzando alcuni dei punti cruciali che emergono dalla discussione del Parlamento europeo.
a) il principio della libera scelta terapeutica. La necessità di
legalizzare le MNC è sostenuta in base a un “doppio principio di libertà: libertà per i pazienti di scegliere la terapia
preferita e libertà per i terapeuti di esercitare la loro professione”). Si tratta di un principio liberista, mutuato dal
176
Fabio Dei
campo dei diritti dei produttori e dei consumatori (Kelner
M. - Wellman B., 2000, Tovey P. – Easthope G. – Adams J.,
2003). Lo stato non dovrebbe intromettersi nelle decisioni
dei cittadini su cosa produrre, cosa consumare e, allo stesso
modo, come e con chi curarsi, limitandosi a garantire condizioni di sicurezza, di informazione e di relativa equità. La
scelta resta affidata alla responsabilità individuale e alla legge
della domanda e dell’offerta. Si tratta di un principio che presenta notevoli ambiguità, impostando in modo superficiale il
rapporto tra costruzione dei movimenti d’opinione, ricerca
scientifica e pratiche amministrative. Proprio il campo del
consumo dimostra quanto sia in sé problematico il concetto
di “libera scelta”. In ambito sanitario, inoltre, si rischia di
dimenticare che lo stato da un lato eroga servizi ai cittadini,
dall’altro promuove la ricerca scientifica e il perseguimento
di ideali di conoscenza e di efficacia cui quei servizi devono
conformarsi. Ma le logiche delle conoscenza scientifica, ovvero di scelta e formazione del consenso all’interno di una
comunità scientifica, sono molto diverse e spesso inconciliabili con quelle che plasmano la pubblica opinione e i comportamenti di mercato. Confondere i due livelli implica forti
rischi, di cui abbiamo visto un nitido esempio qualche anno
fa con il caso della terapia antitumorale del prof. Di Bella –
una situazione nella quale la pressione politica e mediatica è
riuscita, sia pure provvisoriamente, a sostituirsi al consenso
scientifico come guida del governo sanitario.
b) il pluralismo scientifico e medico è un principio ricorrente nei documenti e nelle proposte di legge sulle MNC (Cant
S. – Sharma U., 2001). C’è qui l’idea di una scienza non monolitica, che possa procedere secondo paradigmi diversi e
paralleli, tutti ugualmente legittimati dallo stato, secondo
una certa idea della “medicina integrata”, questi paradigmi
– per quanto incompatibili sul piano epistemologico – potrebbero fondersi nelle pratiche di cura. In antropologia, il
concetto di pluralismo medico è stato applicato a contesti di
acculturazione (coloniali o post-coloniali) nei quali la medi-
7. Medicine non convenzionali: una prospettiva antropologica
177
cina occidentale moderna si è trovata a convivere con sistemi diagnostici e terapeutici radicati nella tradizione locale.
Il caso delle MNC è evidentemente molto diverso. La loro
base non è né la tradizione né, in senso stretto, ciò che i
filosofi chiamano paradigma o “tradizione di ricerca” scientifica, è piuttosto un approccio in senso lato culturale che
sfrutta le possibilità della rete comunicativa e i circuiti del
consumo di massa. Non è dunque corretto presentare la medicina “convenzionale” e le MNC come paradigmi scientifici
paralleli che, nella loro diversità, si pongono tuttavia su uno
stesso piano. Non c’è simmetria tra i due: basta confrontare le rispettive letterature specialistiche, i sistemi formativi,
l’organizzazione della ricerca e così via. Nella pubblicistica
di sostegno alle MNC la biomedicina viene spesso presentata come un campo di chiusura dogmatica stretto attorno alla
difesa dei propri privilegi (nonché degli interessi dell’industria farmaceutica). Dovrebbe essere tuttavia evidente che
le garanzie di apertura e criticità vengono proprio dall’organizzazione sociale della conoscenza su cui poggia la scienza
biomedica, laddove i rischi di chiusura dogmatica sono legati all’alone ideologico e talvolta quasi fideistico che circonda
le MNC (almeno una loro parte). Di fronte a un quadro così
disuguale di fenomeni, è dunque assai problematico parlare
di pluralismo scientifico.
c) Il controllo dell’efficacia. La risoluzione del Parlamento
europeo, così come quasi tutte le proposte legislative in materia, rimandano all’incremento della ricerca e della sperimentazione per valutare l’efficacia delle MNC. L’idea è che
l’atto politico del riconoscimento necessiti dell’appoggio di
una valutazione tecnica e neutrale. Solo che una simile neutralità non è possibile, dal momento che i diversi sistemi non
concordano sui criteri di valutazione. In particolare le prove
cliniche a doppio cieco, che per la biomedicina rappresentano la principale metodologia di sperimentazione dell’efficacia dei farmaci, non sono ritenute probanti nell’ambito delle
MNC – sulla base dell’assunzione, già discussa sopra, del
178
Fabio Dei
carattere individuante della terapia. Quest’ultima si adatta
al paziente più che alla malattia: non è dunque possibile valutarla sulla base di considerazioni quantitative. Il doppio
cieco tende a testare l’efficacia di un farmaco eliminando
l’influenza del fattore soggettivo – proprio quanto le MNC
non ritengono possibile. È vero che esiste un piccolo corpus
di ricerche che applica anche alle MNC, in specie agopuntura ed omeopatia, un metodo di valutazione statistica, con
risultati peraltro contrastanti. Ma in generale è chiaro che il
problema “politico” del riconoscimento non può essere risolto dal ricorso a metodi oggettivi e reciprocamente riconosciuti di validazione. Il “pluralismo scientifico” rischierebbe
allora per risolversi nella irrelata compresenza di universi
incommensurabili, ciascuno con proprie regole del gioco, e
la legittimazione pubblica in pura funzione della forza dei
rispettivi gruppi di pressione. Una situazione, dunque, che
con la “scienza” non avrebbe più nulla in comune.
7. Ascesa e declino delle MNC?
Infine, la difficoltà forse maggiore sulla strada del riconoscimento delle MNC viene dal loro grande numero e dalla loro
eterogeneità. È possibile riconoscerle tutte? E altrimenti, quali
criteri selettivi adottare? La proposta di legge europea sceglieva
di privilegiare quelle discipline che godessero già di una qualche legittimazione legale in alcuni stati dell’Unione, che fossero
dotate di una struttura organizzativa internazionale e di un codice interno di autoregolamentazione e formazione. Da questi
criteri esce il seguente elenco: chiropratica, omeopatia, medicina antroposofica, medicina tradizionale cinese (denominazione
sotto la quale è ricompresa l’agopuntura), shiatsu, naturopatia,
osteopatia, fitoterapia. Difficilmente il quadro potrebbe essere
più composito, dal punto di vista dell’origine delle discipline,
della loro impostazione filosofica, delle pretese terapeutiche,
delle modalità di esercizio. È tanto difficile tenere insieme que-
7. Medicine non convenzionali: una prospettiva antropologica
179
ste MNC quanto giustificare l’esclusione di altre. Se le ragioni
del loro successo sono in qualche misura quelle sopra ipotizzate, allora è difficile estirpare dall’universo delle MNC la tendenza ad una eterogenea varietà e a un processo di costante proliferazione. Questi aspetti rappresentano la loro forza. Lasciate a
se stesse e isolate dalle altre, le singole discipline perdono molto del loro appeal e mettono a nudo la scarsità dello spessore
scientifico, finendo magari per riprodurre gli aspetti peggiori
della biomedicina (fanno eccezione, per il loro più profondo
radicamento storico-culturale, la medicina tradizionale cinese e
per certi versi la fitoterapia).
Dunque, le MNC si rivelano un oggetto particolarmente
ostico da assimilare nel quadro giuridico e amministrativo che
ha accompagnato l’ufficializzazione della biomedicina moderna. Lo sforzo verso il loro riconoscimento produce contraddizioni e difficoltà, e forse ne indebolisce il fronte, introducendo
divisioni al loro interno e spezzando il pur tenue filo che stabilisce tra di loro delle continuità. Del resto, la stagione più intensa
delle “lotte” per il riconoscimento sembra trascorsa. Certo non
occupa un ruolo di primo piano nell’agenda della politica europea ed italiana, indaffarata in altri problemi, pochi sembrano
disposti – come accadeva invece negli anni a cavallo del secolo
– a farne la bandiera di una concezione d’avanguardia della salute, della coscienza ecologica e delle libertà individuali dei cittadini. Se andiamo a sondare l’interesse dei media per le MNC,
ci imbattiamo soprattutto in menzioni negative. Nella stampa
recente (anno 2008) hanno avuto grande risalto i casi di due
giovani morti per la sospensione dei farmaci convenzionali suggerita da medici alternativi, con una certa frequenza compaiono
i risultati di ricerche sulla inefficacia delle MNC, il cui effetto
è considerato equivalente a quello del placebo. L’accostamento
tra MNC e la figura ambigua del medico-stregone e del ciarlatano comincia (o ricomincia) a farsi largo nell’immaginario
comune.
Insomma, il clima sembra cambiato. Dati chiari non ce ne
sono. Può darsi che l’infatuazione di una certa cultura critica,
180
Fabio Dei
antiautoritaria, ecologica, antimaterialista e romantica per le
MNC stia declinando, che la fioritura di cento e cento medicine
naturali, umane e colorate sia stato il sogno di un’epoca che si
sta ormai chiudendo. Tuttavia, se gli argomenti sopra proposti
sono almeno in parte corretti, le condizioni socio-culturali del
loro sviluppo continuano a sussistere: la centralità “politica”
del corpo e delle preoccupazioni sulla sua purezza, sulla sua
estetica e sulla sua buona forma, la moltiplicazione delle risorse
culturali e dei canali comunicativi, l’erosione dell’autorità dei
saperi esperti e così via. Lo spazio d’azione delle MNC resta
aperto – anche se esse lo occupano oggi con minore facilità,
finendo per apparire un prodotto ormai un po’ logoro e scontato, non più così nuovo e attraente. D’altra parte, esse hanno
dimostrato fino a oggi una straordinaria capacità di mutare volto, di trasformare la propria immagine, di rinnovarsi e moltiplicarsi. Si può immaginare che continueranno a farlo.
Giovanni Pizza
8. Medicina popolare: una riflessione1
Le seguenti riflessioni vertono sulle trasformazioni della categoria di “medicina popolare”, una nozione che ha avuto grande
importanza nella storia dell’antropologia internazionale, europea in particolare, e ancor di più nella vicenda antropologica
italiana. In Italia, infatti, essa ha conosciuto la sua genesi e uno
sviluppo che ha attraversato gli ultimi due secoli, segnando una
lunga fortuna ottonovecentesca, conclusasi con un vertiginoso
declino a fine Novecento. In questo arco di tempo l’espressione
“medicina popolare” designò non soltanto un settore di studi, ma anche una categoria analitica e interpretativa, che talora
ambì a configurarsi come disciplina autonoma, prima di cedere
a una definitiva disarticolazione critico-culturale.
Questo lavoro evoca un rethinking e pertanto può essere
1. Il presente testo costituisce la resa verbale del mio intervento di apertura alla seconda giornata del convegno Vicende e protagonisti della ricerca
antropologica in Umbria. Etnografia umbra tra ‘800 e ‘900. Contributi per
una storia degli studi, tenuto a Perugia il 17-18 dicembre 2008, curato scientificamente da Paolo Bartoli e Paola Falteri, in occasione delle iniziative di
studio e dibattito svoltesi in onore di Tullio Seppilli, nel cinquantesimo anniversario della costituzione dell’Istituto di etnologia e antropologia culturale
(oggi Sezione antropologica del dipartimento Uomo & territorio), nel quadro
delle celebrazioni del 7° centenario della Università degli studi di Perugia.
Lo scritto conserva i toni dell’oralità, se non per la divisione in paragrafi, le
correzioni e alcune integrazioni. La bibliografia di riferimento è aggiornata
alla data del convegno, tranne l’aggiunta di alcuni studi pertinenti apparsi
negli anni successivi. Alla medesima occasione appartiene un ulteriore esito,
cui è utile rimandare il lettore (Pizza G., 2008), pubblicato come Postfazione
a uno dei gruppi di saggi di Seppilli raccolti in capitoli nella festschrift in due
volumi a lui dedicata (Seppilli T., 2008a). Ringrazio Fabio Dei, Paola Falteri
e Cristina Papa per aver discusso il presente testo, Alessia Fiorillo per aver
curato e messo a mia disposizione la videoregistrazione dell’evento.
182
Giovanni Pizza
letto in due modi: come indicazione di un punto di svolta rispetto a una tradizione precedente, o invece come un ritorno,
un omaggio a un pensiero già pensato e che tuttavia appare ineludibile, necessario da rimeditare per andare avanti. È in questa
seconda chiave che auspico sia interpretata l’esigenza di ripensare la medicina popolare.
Una strategia endotica
Non è frequente nei “manuali” di antropologia medica internazionali, se si escludono alcuni casi europei, che l’effetto del differenzialismo culturale sia cercato e ottenuto attraverso il confronto fra la biomedicina e le medicine cosiddette domestiche
o endotiche, quelle per le quali il differenziale culturale è dato
dai rapporti di forza (e di “classe”, se si vuole usare una nozione frequentemente adottata nelle discussioni di fine Novecento
intorno a questo argomento) all’interno del campo sociale. Si
preferisce in altri casi effettuare questa operazione differenzialista con l’approccio classico dell’etnologia, e cioè evidenziando la differenza nella distanza dello spazio geografico, e quindi
privilegiando il contrasto fra biomedicina e medicine esotiche.
Inserendo in un testo a carattere generale di antropologia medica un intero capitolo sulla genesi, lo sviluppo, e il declino della
categoria di medicina popolare in Europa (Pizza G., 2005: cap.
V), ho voluto sottolineare un tratto saliente che ha segnato la
mia formazione nell’antropologia italiana. Cioè l’esigenza metodologica di considerare le diversità culturali nel quadro dei
rapporti di forza che definiscono l’eterogeneità delle disuguaglianze nel corpo sociale. Questo dato politico è a mio avviso
molto importante perché costituisce il punto di partenza per
una rilettura del concetto di medicina popolare. Anche perché,
se usciamo dall’Europa, la dialettica del confronto endotico sulla questione del “popolare” (con tutta la pregnanza gramsciana
del termine), emerge con evidenza in tutte quelle aree mondiali
8. Medicina popolare: una riflessione
183
in cui le medicine indigene entrano in una competizione complessa, dialettica e dialogica, con le egemonie delle medicine
ufficiali, sollevando problemi geo-politico-culturali analoghi
(Signorini I. - Lupo A., 1989, Schirripa P. - Vulpiani P. curatori, 2000, Johannessen H. - Lázár I. curatori 2006, Seppilli T.,
2008b).
In verità, negli ultimi trent’anni, una rilettura della medicina
popolare è stata in gran parte già svolta, da parte di importanti
studiosi europei, operanti sia in rapporto fra loro sia in totale
autonomia, nella prospettiva di una progressiva disarticolazione della categoria. Quindi il declino della nozione è stato positivo, foriero di letture critiche nuove, svolte nei quadri contemporanei dell’antropologia simbolica, medica, religiosa e della
corporeità, capaci di attivare inattese visioni in controluce del
rapporto fra il corpo e i poteri governamentali dello stato, ovvero sulle forme storicamente profonde della biopolitica.
A proposito di disarticolazione della categoria, è utile fare
una precisazione metodologica. Immagino una certa differenza
fra la procedura critica che possiamo definire disarticolazione e
quella invece detta decostruzione. Attribuisco a questi due termini una diversa valenza, anche in ragione dei significati che
nella storia degli studi e nei dibattiti metodologici sono stati
loro conferiti. Per disarticolazione intendo uno studio di scomposizione critica dei modi di fabbricazione di una categoria,
che implichi una sua apertura in rapporto agli intellettuali che
materialmente e simbolicamente l’hanno prodotta. La parola
decostruzione, invece, mi pare che abbia finito per evocare soprattutto lo smascheramento di una sorta di mistificazione ideologica immanente all’oggetto da decostruire. Denuncia spesso
fondata, ma che ha il limite di non andare oltre il testo scritto, di
non ricostruirne, cioè, la genesi fisica e sociale. Pertanto essa si
rivela talora incapace di risalire alla sua sorgente, cioè agli intellettuali in tutta la loro complessità, considerati non unicamente dal punto di vista mentale-cognitivo-ideologico, ma anche
come corpi che agiscono in uno specifico campo sociale.
184
Giovanni Pizza
Intellettuali e organizzazione della “medicina popolare”
La dimensione dell’intellettuale come agente sociale e produttore culturale è stata particolarmente importante per ripensare
la medicina popolare. Soprattutto in rapporto alla specificità
di quelle figure di intellettuali, al tempo stesso medici ed etnografi, che furono autori dei trattati sulle medicine popolari
regionali italiane. È stata proprio l’attenzione agli intellettuali la
più efficace prospettiva di studio sulla medicina popolare che
abbiamo avuto in Europa, e in particolare in Italia, nella scuola
di antropologia medica di Perugia e in altri luoghi di elaborazione critica.
In Italia, l’inizio degli anni Ottanta del Novecento coincide
con il punto più alto della efficacia analitica ed esplicativa della
categoria di medicina popolare, e insieme segna l’avvio di una
sua rapida e definitiva disarticolazione critica.
Nell’ottobre del 1983 fu pubblicato il numero 8 della rivista
La Ricerca Folklorica, uno strumento a quel tempo senz’altro innovativo nell’antropologia italiana. Il volume monografico, curato da Tullio Seppilli, dal titolo La medicina popolare in Italia,
rappresentava un raro caso di Atti che escono prima del convegno. Esso infatti anticipava un incontro scientifico di notevole
importanza (Seppilli T., 1983). Il convegno Salute e malattie
nella medicina tradizionale delle classi popolari italiane, di cui
Seppilli fu ideatore e organizzatore, fu dedicato alla memoria di
Ernesto de Martino e si svolse a Pesaro dal 15 al 18 dicembre
1983. Si trattò del primo evento italiano specificamente dedicato alla medicina popolare e riguardante l’intero territorio nazionale. Obiettivo di quell’incontro era un coordinamento e un
rilancio della ricerca cosiddetta “demoiatrica” italiana in un’ottica di dialogo fra discipline differenti: il convegno era centrato
sulla linea antropologica ma integrava (secondo una metodologia che è anche un progetto politico-culturale costante nell’azione intellettuale di Seppilli) scienze biomediche, psicologiche,
storiche e sociologiche. Come scriveva Seppilli nell’opuscolo di
presentazione, si voleva «avviare un primo bilancio critico dello
8. Medicina popolare: una riflessione
185
stato della ricerca sul passato e il presente della medicina popolare italiana, saggiare in questo campo più aggiornati e multidisciplinari modelli interpretativi, indicare nuove prospettive
per ulteriori indagini».2 Si trattò di un evento importante per
quelle antropologie europee accomunate da una attenzione alla
profondità storica dei processi culturali che investono il corpo,
la salute e la malattia, e caratterizzate da una sensibilità politica
capace di cogliere le differenze culturali in rapporto alle disuguaglianze sociali, e non solamente nelle forme della lontananza
esotica e dello scarto cognitivo.
Nel 1983 era apparso anche il libro di Alfonso Maria Di
Nola L’arco di rovo, contenente il suo saggio sulla terapia sacrale dell’ernia infantile. Si trattava di un lavoro che riconfigurava
l’efficacia del metodo comparativo in campo europeista, e rileggeva i repertori medico-popolari in un dialogo nuovo fra storia
e antropologia, per certi versi vicino agli sviluppi della ricerca
antropologica europea di quegli anni che assumeva a oggetto di
studio privilegiato il “simbolico” senza peraltro separarlo dal
“materiale” (Charuty G. curatore, 1995). In quel lavoro, le
questioni di medicina popolare costituivano un passaggio per
lo studio della costruzione sociale del corpo, in quel caso, del
corpo infantile osservato nelle pratiche rituali destinate contemporaneamente a scongiurare l’ernia e a garantire l’accesso
alla mascolinità. Due anni prima, il lavoro di Di Nola (1981) sul
tema dei processi di salute-malattia si era imposto con un altro
importante contributo: il suo scritto introduttivo al volume collettivo Mal di luna. Anche in quel caso Di Nola aveva posto il
problema del tutto specifico di una tradizione “endotica” della
ricerca antropologica sulle rappresentazioni e le pratiche della
malattia, e sulla salute mentale, con una attenzione particolare
al contesto storico-culturale e politico italiano.
Ancora alla fine del 1983, usciva l’importante monografia
2. La citazione è relativa all’opuscolo programmatico del Convegno, conservato a Perugia nell’archivio di Tullio Seppilli, presso la sede della Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute (Perugia).
186
Giovanni Pizza
storico-antropologica La sonnambula meravigliosa, di Clara
Gallini, in cui erano ricostruite e svelate con chiarezza le astuzie
intellettuali e amministrative nella colonizzazione delle diversità culturali interne al territorio dello stato nazionale italiano
(Gallini C., 1983ab).
Si coglieva in quegli studi una critica rispetto al differenzialismo esotico, e una volontà di esplorare il campo statale e
nazionale italiano senza per questo riprodurre la distanza in un
esotismo interno di stampo endo-orientalista. Piuttosto si gettavano le basi di reinterpretazione di quadri classici della storia delle tradizioni popolari italiane, che non erano ancora stati
interrogati sul piano della significanza antropologico-critica e,
quindi, politico-culturale.
Le conseguenze di tali lavori sono state molto proficue. Dopo
il convegno di Pesaro, ad esempio, fu più difficile usare quei
repertori prodotti dai medici-etnografi in maniera riduttiva,
soltanto per collezionare occorrenze etnografiche comparative
estratte come da un’enciclopedia. È stata progressivamente privilegiata una sempre più attenta lettura critica. Indubbiamente
anche qui occorre distinguere i termini del metodo: a volte per
lettura critica si intende, in modo riduzionistico, la totale destituzione di fondamento o di autorevolezza dell’oggetto criticato. Niente di più lontano da una idea antropologica, per la
quale la critica vuol dire al contrario individuare la complessità dell’oggetto da criticare, situarne la conoscenza, estendere
all’organismo autoriale la pertinenza testuale, valutarne le intime contraddizioni, gli elementi dialogici e generativi, i costitutivi antidoti interni che possono rendere profonda una apparente
superficialità. Per esempio, ogni critica all’opera di Giuseppe
Pitrè che segnali un eccesso di positivismo, o una oggettivazione riduzionistica del dato, apparirebbe anacronistica, non soltanto perché fatta dopo tanti anni, ma in quanto rischierebbe di
occultare la ricchezza delle sue opere che vanno invece etnografate a loro volta nel profondo, come prodotti politico-culturali
complessi. Al contrario occorre elaborare un riconoscimento
del lavoro quotidiano dei medici etnografi dell’Ottocento e del
8. Medicina popolare: una riflessione
187
Novecento, impegnati nella raccolta e documentazione di una
enorme quantità di materiali. Il richiamo al rispetto del valore
di queste opere presente nei saggi di Tullio Seppilli, e ribadito in un recente scritto di Clara Gallini sulla Medicina popolare siciliana di Pitrè (2006), caratterizzava come una costante
l’apertura delle lezioni di Alfonso Maria Di Nola all’Istituto
Universitario Orientale di Napoli sulla medicina popolare, nei
primi anni Ottanta.
Di Nola proseguiva in un percorso autonomo nel quale era
già avviata da tempo una rilettura critica dei repertori classici
della demoantropologia medico-popolare ottonovecentesca (Di
Nola A.M., 1981, 1983ab, 1987, 1989), vicina a quella che si
conduceva a Perugia, nei lavori di Seppilli e della sua scuola
(Bartoli P. - Falteri P., 1983, 1987, Seppilli T. curatore, 1989).
Parallelamente, da punti diversi dell’antropologia italiana, si
aprivano dunque, a partire dalla medicina popolare, questioni
e problemi talmente nuovi da spingere a una rivisitazione della
categoria. I repertori classici della medicina popolare, quello di
Giuseppe Pitrè, del 1896, e quello di Zeno Zanetti, del 1892,
venivano sottoposti a una lettura critica di tipo etnografico, a caratterizzare quasi una specifica estensione del termine etnografico, che non è solo designazione professionale di un metodo di
ricerca empirica, ma è una più complessa postura dello sguardo
conoscitivo fondata sullo straniamento e sulla capacità di cogliere nei testi le spie di un sapere pratico, di una conoscenza
corporea (Ginzburg C., 1986). In questo senso si può ulteriormente ripensare una tradizione italiana che ha talora valorizzato
questa lettura aperta e ampia dell’etnografico.
Di Nola mostrava come rimuovendo opportunamente le
griglie positivistiche che Pitrè aveva imposto a materiali assolutamente eterogenei, si ottenessero imprevedibili effetti di rivitalizzazione antropologica di quei dati. Certo ciò era possibile per
chi fosse predisposto o avesse gli strumenti critici per cogliere il
contrasto tra i due sguardi: da un lato quello di Pitrè, rigoroso
sul dato ma animato dal positivismo della sua formazione medica, dall’altro, invece, un etnografico “sguardo da lontano”,
188
Giovanni Pizza
che provava a incrociare l’occhio ribelle dei dati stessi, i quali,
resistenti nel tempo alle rigide gabbie in cui erano stati reclusi,
cercavano di proiettarsi oltre le maglie tassonomiche, in attesa
di essere definitivamente liberati e riconosciuti come forme di
vita culturale.
Questo vivido contrasto attraversa in effetti il testo di Pitrè
e lo sovrasta di senso. Pitrè cerca di catturare un dato sensibile,
un dato corporeo. Maneggiando i simboli che servono a descrivere i corpi, attraverso una imponente e rigorosa impresa etnografica (Gallini C., 2006), ottiene un effetto di manipolazione
dei corpi stessi, le cui conseguenze politiche erano immediate,
sia nel senso comune siciliano3, sia nella conoscenza sociale e
culturale italiana ed europea, nonché nel campo intellettuale
medico-folklorico-accademico ottonovecentesco e in uno spazio pubblico dove le questioni della popolarizzazione della medicina, e quindi anche della medicalizzazione, erano in quel momento al punto più alto del cosiddetto incontro-scontro4. Alla
luce degli studi successivi, le opere di Pitrè avrebbero progressivamente svelato la sua costitutiva ambiguità di intellettuale
organico sia alla sfera politico-culturale siciliana, sia all’appena
compiuto progetto nazionale italiano. Costruendo tassonomie
3. A proposito della funzione intellettuale organica di Pitrè nella storia
dei rapporti fra contesto siciliano e nazionale disponiamo ora di uno studio
antropologico illuminante, mi riferisco ad ampie parti del recente lavoro di
Berardino Palumbo (2009: 242-249, 284-288, 391-393, soprattutto p. 244).
Sulla struttura dell’opera Medicina popolare siciliana, in particolare per
quanto riguarda il rapporto fra i materiali della ricerca etnografica (conservati nell’Archivio Pitrè di Palermo) e le strategie di composizione del testo,
si veda il recente saggio di Clara Gallini (2006). Alcuni interessanti spunti di
riflessione sulla ripresa della nozione di “medicina popolare” in Italia negli
anni trenta del Novecento sono già in Vidossi G., 1935, per comprendere il
carattere organico di tale rilancio nel campo politico-intellettuale del positivismo italiano risultano utili le note di Bronzini G. B., 1983.
4. Un conflitto, una lotta, talora una guerra se si pensa ai drammatici esiti
di forte tensione nell’ordine pubblico, con l’impiego del neo-esercito italiano, nel 1867, per imporre le vaccinazioni in Sicilia contro il colera: cfr. § 5
di questo articolo (Genealogie del biopolitico), cfr. inoltre Seppilli T., 2000
[2004].
8. Medicina popolare: una riflessione
189
bivalenti e ambigue nelle quali ingabbiare le figure della corporeità siciliana, egli in fondo ci sollecitava a spostare l’attenzione
sul rapporto fra intellettuali, medicina popolare, popolarizzazione della biomedicina e populismo medico nella costruzione
corporea della (bio)cittadinanza e dello stato-nazione5.
Pluralità corporee
Fin dall’inizio degli anni Ottanta del Novecento, dunque, fu
condotta un’attenta disamina critica del vasto repertorio di testi
e materiali di medicina popolare, e si avviò un processo irreversibile di disarticolazione della categoria, capace di liberare
i corpi reclusi nelle tassonomie medico-etnografiche. Nella mia
memoria, quel numero 8 della Ricerca Folklorica, dalla copertina verde chiaro, resta l’emblema di questa operazione, e del
dialogo fra Seppilli e Di Nola. Perché si apriva con una introduzione di Seppilli, seguita poi da una seconda introduzione
metodologica di Di Nola. Raramente uno studioso che cura un
lavoro collettivo affianca una seconda introduzione alla sua. Ciò
accadde, e quell’effetto di raddoppiamento conserva nel tempo il senso profondo di un sodalizio umano e intellettuale. È
interessante seguire alcune attuali riflessioni tratte da quei due
contributi generali.
Secondo Seppilli:
Lo stesso significato attribuito all’espressione “medicina popolare” non sembra univoco e si presta comunque a parecchie ambiguità di lettura [...]. Non esiste dunque una medicina popolare,
cioè un assetto specifico di forme di difesa della salute e dell’equilibrio psichico comune a tutte le classi subalterne. A rigore,
in effetti, l’espressione “medicina popolare” rinvia esclusivamente
all’esistenza, in talune classi subalterne, di forme mediche e oriz5. Su questi aspetti si colgono interessanti analogie nella monografia
storico-antropologica dedicata alla vicenda ottonovecentesca della medicina
popolare in America Centrale (Costa Rica) (Palmer S., 2003).
190
Giovanni Pizza
zonti ideologici di riferimento che si presentano come oppositivi o
comunque “altri” rispetto alla medicina ufficiale (Seppilli T., 1983:
5).
Così veniva sottolineata la difficoltà di considerare la “medicina
popolare” come il sistema medico delle classi popolari. Il significato di medicina popolare andava «volta a volta concretamente
individuato facendo riferimento a singoli strati subalterni, in un
preciso territorio e in una precisa collocazione rispetto ai centri
propulsori del cambiamento sociale, entro il quadro di specifiche
correlazioni città-campagna, di specifici processi di circolazione
culturale e di specifici rapporti di classe, di egemonia e di potere» (ibid.). Tenendo poi conto anche dell’aspetto dell’efficacia
delle pratiche terapeutiche, il dibattito sulla medicina popolare
negli anni Ottanta del secolo scorso poneva una questione politica, offrendosi come: «un preciso punto di riferimento per
l’intera problematica della programmazione sanitaria» (ivi: 6), e
la ricerca su questa categoria, analogamente alle ricerche di antropologia medica sulle medicine non occidentali, finiva quindi
«per assumere un valore emblematico in vista del ripensamento
e del superamento, ormai maturi, dei ritardi “eurocentrici” e
delle contraddizioni storiche che frenano un ulteriore sviluppo
della medicina scientifica» (ibid.).
Anche la critica proposta da Di Nola (1983b) fu rivolta soprattutto alla definizione e all’indiscriminato carattere catalogante dei trattati europei di medicina popolare. Egli esaminava
l’intera costellazione terminologica internazionale: dal tedesco
Volksmedizin, ai paralleli italiani demoiatria, demopsichiatria.
Secondo Di Nola, nei saperi e nelle pratiche della medicina popolare si poteva individuare una differenziazione di tipo cognitivo ed epistemologico rispetto alla biomedicina, relativa alle
forme stesse di organizzazione della conoscenza sul corpo, la
salute e la malattia. Il riduzionismo dei medici etnografi operava infatti un taglio netto rispetto a sistemi di conoscenza diversi
da quello occidentale cartesiano e galileiano basato su un’idea
di separazione del corpo dalla mente e sul metodo scientifico
8. Medicina popolare: una riflessione
191
della verifica empirica. La dimensione del simbolismo religioso,
come prodotto culturale elaborato per trascendere la natura e la
storia, non era presa in considerazione nei campi di pensiero e
di pratica della biomedicina, così come veniva escluso il dispositivo del rituale e la sua efficacia simbolica (anche se tale esclusione valeva più sul piano retorico, teorico e ideologico, e meno
su quello delle pratiche mediche quotidiane). Di Nola riteneva che questo taglio di spessori significanti che non rientrano
nell’orizzonte empirico della medicina scientifica non fosse soltanto il prodotto della classificazione, ma anche il segno di una
differenza gnoseologica ed epistemica profonda fra le pratiche
corporee della biomedicina e le esperienze culturali del corpo
classificate come medicina popolare. A partire da un’esigenza
di rispetto per la pluralità delle forme di vita culturale, Di Nola
affermava allora l’urgenza di un’educazione politica del personale medico-sanitario, improntata a una maggiore attenzione
verso figure e pratiche della corporeità “diverse” ma interne
allo stato italiano. Perché a suo avviso ciò poteva risultare in
una definitiva apertura politica, e in definitiva democratica, del
progetto medico-scientifico. In tal modo, formati all’uso di tali
conoscenze critiche, gli agenti del campo biomedico avrebbero
potuto tenere conto della pluralità di rappresentazioni del corpo e del carattere sociopolitico dei processi di salute e malattia,
non riducibili alla sola dimensione naturale e biologica.
Per esempio, la disarticolazione alla quale Di Nola lavorava mostrava come Pitrè applicasse un rigido schema di separazione mente/corpo. Schema evidentemente all’opera quando
il medico-etnografo siciliano classificava lo stesso malessere sia
nei mali dell’“apparecchio” nervoso, sia in quelli dell’ “apparecchio” del corpo. Oggettivando, in particolare, una malattia
particolarmente significativa: la matrazza. Una fenomenologia
di sentimenti e comportamenti che interessava il corpo femminile in una casistica europea estremamente complessa, relativa
alle figure corporee della posseduta e alle rappresentazioni di
spiriti femminili e stregonici siciliani, le celebri donni di fora,
protagoniste invisibili nei processi dell’inquisizione antistrego-
192
Giovanni Pizza
nica spagnola in Sicilia, e al tempo stesso connesse, quali esseri
fantastici, alle dimensioni corporee che caratterizzano l’esperienza culturale, pre-freudiana, del sogno in Europa. Liberare
le pluralità corporee femminili dalle gabbie tassonomiche di
Pitrè significava recuperare la complessità della matrazza a una
interpretazione antropologica, culturale e politica, molto più
vasta e articolata. Questo argomento non a caso sarebbe stato
trattato da studiosi che avevano a cuore il ripensamento delle
questioni storiche e antropologico-critiche connesse alla categoria di medicina popolare: Elsa Guggino (1986), Giordana
Charuty (1987, 1997), Gustav Henningsen (1990)6.
Vi è dunque una intera filiera di studi storico-antropologici
che hanno contribuito a ricostruire la genealogia storica della categoria di medicina popolare. Ricordo i lavori di allievi
e collaboratori diretti di Seppilli, come Alessandro Alimenti,
Giancarlo Baronti, Paolo Bartoli, Paola Falteri e Cristina Papa,
sugli esseri fantastici e le figure metaforiche dell’immaginario
medico-popolare, su intellettuali collezionisti di amuleti, sulla formazione dei guaritori e il loro rapporto con i medici, rivolti a quella fase cruciale di “scontro-incontro” fra medicina
“ufficiale” e “popolare” collocata fra Ottocento e Novecento
(Alimenti A., 1989, Baronti G., 2008, Bartoli P. - Falteri P.,
1987, Bartoli P., 1989, Papa C., 1989). In Francia, penso agli
importanti studi condotti dall’antropologa francese, italianista,
Giordana Charuty sulla “invenzione della medicina popolare”
e sulla nozione della persona cristiana (Charuty G., 1997ab).
In diretto rapporto con la scuola seppilliana, l’antropologo spagnolo Josep M. Comelles (e in generale la scuola di antropologia
medica di Tarragona, in Spagna), ha riflettuto sull’invenzione
del concetto di medicina popolare da parte dei medici etnografi, evidenziando in particolare il «problema della costruzione
del ruolo dei medici nella configurazione dei valori dominanti
relativi alla comprensione, interpretazione e gestione delle credenze e delle pratiche popolari» (Comelles J. M., 1996). Studi
6. Cfr. anche, per il “mal di matre” in Campania, Pizza G. 1988, 1996, 1998.
8. Medicina popolare: una riflessione
193
che possiamo rileggere oggi anche dal versante dei rapporti fra
antropologia e storiografia in Italia.
Fra antropologia e storia
Sui repertori della medicina popolare si è giocato anche un
dialogo difficile, quello fra antropologi e storici. Emergevano,
da quei repertori, i tratti di una possibile lettura, insieme storica e antropologica, delle questioni che vi erano imbricate: il
corpo, il sé, la persona, il genere, la sessualità, l’intreccio fra il
campo religioso, il campo medico, il campo politico. Nonché
i tentativi e le capacità di questi diversi campi istituzionali di
influenzare i processi di incorporazione, di fabbricare soggetti
docili, di appropriarsi della capacità di agire delle persone, di
fare cioè egemonia, per esempio attraverso la medicalizzazione
(Cosmacini G., 1987), da un lato, l’evangelizzazione dall’altro
(De Rosa G., 1983). Eppure il dialogo fra storici e antropologi
faticava a riconoscersi in concetti comuni. Anche la cosiddetta
“microstoria”, che pure è stata molto importante nella formazione degli antropologi italiani della mia generazione, ha avuto
difficoltà nel confronto aggiornato con le antropologie internazionali. Una incomprensione dovuta a uno scarto cronologico
nell’aggiornamento delle letture reciproche, oppure a un non
riconoscimento di teorie, linguaggi e campi comuni7.
7. Per una riflessione antropologica attenta e aggiornata sulle difficoltà
del dialogo fra antropologia e (micro)storia in Italia, cfr. Palumbo B., 2006. In
generale si può dire che nel campo delle “medicine popolari” una differenza
fondamentale è nella opportunità dell’antropologia di osservare e studiare,
attraverso l’etnografia, i processi stessi della incorporazione nel loro divenire,
collocandosi al punto più vicino all’esperienza, laddove gli studi storiografici
si centralizzano su fonti che catturano in origine le esperienze corporee nel
dispositivo della scrittura e del testo. Eppure l’importanza di una analisi storica della dialettica “colto-popolare” e della natura corporeo-indiziaria (che va
ben oltre la dicotomia orale/scritto) dei saperi “medico-popolari” fu avvertita
in tutta la sua complessità e urgenza (quale programma scientifico da avviare)
dallo storico Carlo Ginzburg fin dal 1986, a margine di una sua riflessione sul
194
Giovanni Pizza
Nel 1980, gli antropologi della scuola di Toulouse Giordana
Charuty e Daniel Fabre, avevano cominciato ad applicare le riflessioni teoriche sul concetto di “persona”, maturate e dibattute nell’etnologia africanista8, a una interpretazione delle fenomenologie corporee europee, emergenti dai dati raccolti nei
trattati demologici sulla “medicina popolare”. Essi lanciavano
così un progetto di confronto fra etnografie europee ed extraeuropee, una comparazione in grado di porre nuove domande
alla ricerca antropologica europeista. Per esempio: in quale misura era possibile rinvenire nei narrati raccolti e cristallizzati
nella prosa medica di Pitrè, e in opere folkloriche analoghe, i
tratti di una idea “selvaggia” della persona, fluttuante all’ombra
della nozione giuridica e di quella cristiana?
Su questa comparazione fra “esotico” e “endotico” - in particolare per quanto riguarda la nozione antropologica di “persona plurale” -, si saggiavano insieme difficoltà e possibilità di
un dialogo più ravvicinato fra antropologi e storici.
Osserviamo, ad esempio, una domanda e una risposta tratta
dall’intervista a Carlo Ginzburg realizzata da Charuty e Fabre
per l’edizione francese dei Benandanti, tradotto con il titolo Les
metodo: «In ogni caso queste forme di sapere erano più ricche di qualsiasi codificazione scritta, non venivano apprese dai libri ma dalla viva voce, dai gesti,
dalle occhiate, si fondavano su sottigliezze certo non formalizzabili, spesso
addirittura non traducibili verbalmente, costituivano il patrimonio in parte
unitario, in parte diversificato, di uomini e di donne appartenenti a tutte le
classi sociali. […]. Forse solo nel caso della medicina la codificazione scritta
di un sapere indiziario aveva dato luogo a un reale arricchimento (ma la storia
dei rapporti tra medicina colta e medicina popolare è ancora da scrivere) »
(Ginzburg C., 1986: 181). Recenti considerazioni storiografiche di notevole
interesse antropologico sui rapporti fra «medicina colta e popolare» in diversi
momenti storici in Italia sono negli studi coordinati da Giovanna Fiume (Fiume G. curatore, 2003).
8. Si pensi all’importanza che aveva avuto in Francia il convegno internazionale di etnologia africanista, La notion de personne en Afrique noir, svoltosi
a Parigi nei giorni 11-17 ottobre del 1971. Il volume omonimo che ne raccoglieva gli atti fu pubblicato per la cura dell’antropologa africanista, Germaine
Dieterlen, allieva di Marcel Mauss (Dieterlen G. curatore, 1973).
8. Medicina popolare: una riflessione
195
Batailles Nocturnes9:
Domanda di G. Charuty-D.Fabre: - Mais est-ce que qui arrête les
inquisiteurs et suscite leur interprétation démonologique ce n’est
pas d’abord une conception différente de la “personne”? Au fond
peu import de leur propre point de vue que les “Benandanti”
se déplacent et se retrouvent réellement ou en esprit, l’essentiel
n’est-il pas dans la possibilité conceptuelle d’une personne plurielle comprenant des parties autonomes et mobiles qui vivent les
batailles nocturnes comme des rêves incarnés ou des épreuves oniriques? Ne trouve-t-on pas en Europe les éléments – systématisés
différemment dans certaines ethnies africaines et sibériennes –
d’une théorie de la personne qui ne correspond pas à la représentation chrétienne (corps + âme) et qui suppose une multiplicité
de pièces relativement indépendantes? Songeons par exemple au
mythe de l’esprit séparable sous forme animale que les cathares
ariégeois utilisaient dans leur sermons et que l’on retrouve dans les
traditions orales contemporaines.
Risposta di C. Ginzburg: - Sans doute… (Charuty G. - Fabre D.,
1980: 237-238)
La risposta di Ginzburg, affermativa quanto lapidaria, lasciava al lettore antropologo l’impressione che non si riconoscesse
pienamente nella nozione di “persona plurale” una categoria
concettuale comune.
Nella dimensione contemporanea storici e antropologi si
sono incontrati più agevolmente. Recentemente, in un saggio
apparso nel 2004 sulla rivista britannica Folklore, lo storico inglese David Gentilcore, che ha condotto ricerche sul territorio
italiano, ha posto una domanda provocatoria: è mai esistita una
medicina popolare in Europa? Facendo propria la prospettiva
già indicata da Seppilli nel 1989 per una lettura dei processi
politico-culturali attuali nel campo medico, Gentilcore osserva:
9. La medesima questione, ripensata alla luce della nozione di credenza
(nel quadro di nuove riflessioni sulla nozione lévistraussiana di “efficacia simbolica”) e in un nuovo dialogo critico con Ginzburg, sarà ripresa venti anni
dopo da Carlo Severi (2000). Sul confronto fra storia e antropologia intorno
ai temi del corpo e della possessione cfr. Pizza G., 1995, 1996, 1998, 2003bc.
196
Giovanni Pizza
In un’epoca di crescenti tensioni e di pluralismi nell’ambito medico, c’è ancora molto da apprendere dal “popolare”. Tullio Seppilli
suggerisce che per esplorare le strutture mediche di ogni singolo
gruppo subalterno nel contesto sociale, occorre guardare al grado
di specificità, autonomia e dinamismo culturali in relazione ad altri gruppi. La sua enfasi sulle differenze può apparire ovvia, ma difendendo lo studio dei processi di generazione culturale egli sta di
fatto parlando un linguaggio che gli storici possono ben capire. In
ogni caso, forse esplorare le differenze è l’unico modo attraverso
il quale possiamo individuare influenze e spiegazioni alternative.
Come afferma Seppilli, queste sono ormai tali da disturbare l’autocompiacimento che ha a lungo caratterizzato la biomedicina moderna. Ciò appare evidente in rapporto alla troppo lenta risposta
alla sempre crescente domanda di forme di medicina alternativa o
complementare. Queste spesso appaiono nella forma di frammenti
decontestualizzati di altre tradizioni: occidentali (come l’omeopatia) o non occidentali (come la medicina erboristica cinese). Quel
che soggiace a tali bisogni, suggerisce Seppilli, sono specifiche
concezioni del corpo, della salute e della malattia, nella cultura
tradizionale delle classi popolari. Il modello offerto dal mercato
biomedico, infatti, non sempre appare adeguato a soddisfare motivazioni e bisogni latenti (Gentilcore D., 2004: 160-161)10.
Gentilcore rilancia in effetti il problema posto da Seppilli della complessità della categoria, ma la sua risposta alla domanda
sulla esistenza della medicina popolare più che puntare a una
disarticolazione della categoria, sembra centrata su un tentativo
di attualizzazione e rivalorizzazione del concetto di “popolare”,
nei termini di una attenzione urgente ai processi di differenziazione plurale e di adattamento culturale nelle società europee
contemporanee. Uno studio la cui motivazione è vicina a quella
esigenza di uso sociale della ricerca antropologica e di valorizzazione critica dei repertori etnografici della medicina popolare
nella formazione medica, costantemente perseguiti da Di Nola
e Seppilli.
In effetti proprio il lavoro svolto sulla medicina popolare
10. La traduzione dall’inglese è mia.
8. Medicina popolare: una riflessione
197
da tempo ha condotto Seppilli sul terreno contemporaneo di
una analisi politico-culturale del pluralismo medico e delle rivendicazioni di legittimità delle medicine cosiddette “non convenzionali”, spingendolo recentemente all’organizzazione di un
laboratorio permanente di studi e dialoghi transdisciplinari sulla salute e la sanità italiana come beni comuni. A testimonianza
che le linee guida emerse fin dal convegno di Pesaro del 1983,
riuscirono effettivamente a far confluire i repertori folkloricomedici con i lavori condotti a partire da altre prospettive di
ricerca sui processi di salute/malattia e sulle diverse forme di
medicina, in un nuovo campo generale di studi: quello di un’antropologia medica sensibile alla dimensione storico-politica della salute, intesa come diritto umano fondamentale (Seppilli T.,
1996).
Genealogie del biopolitico
La lettura antropologica ha quindi gettato le basi per una operazione di disarticolazione dei repertori medico-popolari. Negli
esiti più felici, poi, non ci si è accontentati della valorizzazione culturalistica, ma si è preferito, come dicevo, esercitare una
consapevolezza critica che vede nell’intellettuale che ha fabbricato queste categorie un organismo strategico, da oggettivare
nell’analisi, per giungere a cogliere il suo ruolo di funzionario,
agente di una burocrazia legata al progetto di fabbricazione della località e dei suoi abitanti, da parte del nascente stato italiano.
L’apertura della categoria di medicina popolare riserva dunque
esiti inattesi, anche alla luce, gramsciana, della funzione politico-organica, statalista e nazionale-popolare, degli intellettuali
che la produssero. In effetti se una categoria intellettuale è fabbricata da specifici funzionari, questa produzione culturale avrà
pure un suo obiettivo. Oltre al fine primario di costruire una
categoria omogenea di “saperi errati” a danno dei quali alimentare l’identità scientifica e “razionale” della biomedicina nella
fase del suo radicamento territoriale nazionale (Pizza G., 2005:
198
Giovanni Pizza
155-168), certamente uno degli scopi ulteriori era intervenire
massicciamente sulle figure della corporeità: in primo luogo,
avvantaggiandosi della straordinaria diffusione capillare della
medicina a cavallo tra Otto e Novecento, quando gli “assistiti” diventano informatori per il medico-etnografo, in secondo
luogo perché agire nel senso di una manipolazione dei simboli
della conoscenza corporea popolare, consentiva un immediato
riscontro dell’attività di raccolta, documentazione e narrazione:
l’ordine del discorso sulla medicina popolare poteva avere immediati effetti pratici, trattandosi di manipolare le parole per
controllare i corpi.
La classificazione dei corpi nelle descrizioni medico-etnografiche deborda dunque il campo specifico delle curiosità popolari tradizionali, lo sovrasta, acquisisce una efficacia governamentale che permea la costruzione della stessa cittadinanza
italiana, peraltro in una fase liminale (e perciò strategica dal
punto di vista dell’assestamento contraddittorio delle forze in
campo), che è quella dei primi anni dell’unità d’Italia. Questo è
l’elemento interessante che emerge, direi quasi in una genealogia storica del biopolitico, da uno studio di Seppilli su un testo
di Edmondo De Amicis (Seppilli T., 2000), in cui lo scrittore
ricorda e descrive la sua partecipazione da giovane soldato alle
incursioni dell’esercito italiano in Sicilia per imporre la vaccinazione contro il colera, nel 1867. Seppilli incrocia i commenti
che Gramsci aveva prodotto nei Quaderni del carcere su questo
importante episodio, con le retoriche di stigmatizzazione che
Giuseppe Pitrè attivava nella Medicina popolare siciliana, stigmatizzando con toni più forti del solito la paura popolare nei
confronti della vaccinazione anti-colera:
Il colera è un veleno. Esso è sempre mandato dal Governo, il quale
è personificato nel re. Questi, e con lui i principi reali e i capi dello
stato, lo fanno gettare o lo gettano essi impunemente, ed hanno il
contra, ossia il contravveleno, che dispensano alle persone di loro
fiducia e simpatia. […] I medici sono quelli che meglio si prestano
alla diffusione del colera. Essi non meno che i preti son pagati per
8. Medicina popolare: una riflessione
199
far morire la povera gente. […] La origine di questa superstiziosa
credenza è storica. I patrioti siciliani per gettare sempre più il discredito sul governo borbonico vennero spargendo la notizia che il
colera fosse mandato da esso governo per isbarazzarsi del popolo:
e la notizia si diffuse così rapidamente ed ebbe tanta presa che mai
più. L’animo dell’uomo diventa crudele fino alla superstizione nelle sventure che lo colpiscono […] (Pitrè G., 1978 [1896]).
Rimeditando alla luce delle fonti pitreane e gramsciane il testo di De Amicis sulla credenza popolare relativa al rapporto
fra stato e colera, Seppilli coglie quello che a me pare un dato
biopolitico, legato, cioè, al rapporto fra produzione della conoscenza corporea popolare e governo delle popolazioni. In verità biopolitico è dire poco, perché peculiare della biopolitica è
il suo carattere silente: essa, cioè, agisce in maniera silenziosa
attraverso microfisici processi quotidiani di costruzione dell’abitudine, rispetto ai quali indubbiamente la violenza diretta
dell’esercito appare più tumultuosa. Eppure, anche su questo
aspetto clamorosamente biopolitico, Seppilli offre una lettura
complessa, critica ma non anacronistica né ideologica: se l’esercito agisce per imporre la vaccinazione, anche all’interno di tale
campo di azione, al di là del meccanismo violento che si espone
alla condanna morale, è pur sempre riscontrabile un tentativo
di fabbricare la cittadinanza sanitaria attraverso la salvaguardia
dell’unità della Nazione. Secondo Seppilli questo è un dato interpretativo da valutare applicando, per l’appunto, una lettura
dialettica di questi processi. In effetti sarebbe un errore frammentare l’egemonia in un dominante e un dominato, quando
invece occorre indagare una dialettica egemonica che, di volta
in volta, può essere giocata dall’interno con un’estrema complessità, vanificando ogni polarizzazione egemone/subalterno.
L’egemonia si rivela come un complesso meccanismo di unificazione delle forze disperse, che si attua attraverso processi di
incorporazione e naturalizzazione del consenso all’interno dei
quali è possibile agire in almeno due direzioni: per conservare
e rafforzare lo stato delle cose, o invece per disarticolare l’azio-
200
Giovanni Pizza
ne naturalizzante, attivando, per esempio, iniziative di volontà
collettiva nella direzione del cambiamento, del capovolgimento dei rapporti di forza vigenti. Oggi le numerosissime letture
gramsciane ci fanno capire che in Gramsci la coppia egemonico/subalterno è inesistente come dicotomia. I due termini
sono presi in una visione processuale, di lotta: una dialettica
egemonica che si connette alla minuta valutazione dei rapporti
di forza dentro un campo di azione condiviso, come peraltro
Ernesto de Martino aveva insegnato opponendosi a ogni tentativo, metodologico o analitico, di separare la storia “popolare”
dalla storia delle élites (de Martino E., 1959, 1961)11.
La rilettura della categoria di medicina popolare, quindi,
consente anche di fare un passo oltre i materiali da essa descritti, per comprendere, cioè, gli obiettivi di questi intellettuali, e
aprire la strada a nuove ricerche in grado di cogliere le strategie
politiche e governamentali oltre le tattiche narrative. Ancora
una volta vorrei sottolineare che questo tipo di lettura critica e
di apertura teorica non può fondarsi solo sul testo, in una prospettiva da cultural studies. Quand’anche si basi sul testo, deve
piuttosto considerarlo un terreno in cui cogliere all’opera le
spie di azioni concrete. Le biografie reali, quindi, sono importanti, come le reti relazionali. Si può approfondire lavorando a
una biografia di Pitrè, che forse è meno difficile da ricostruire
di quella di Zanetti (Cirese A. M., 1978), seguendo le reti so11. Non prendo in esame in questa sede l’approccio di Ernesto de Martino alla “visione magica della malattia” in Italia meridionale, quale fu messo a punto fin dalle sue etnografie lucane. Ricordo soltanto che il fondatore
dell’antropologia italiana non accolse la nozione di “medicina popolare”, ma
anzi ne propose una precoce – spesso implicita – disarticolazione critica, rifiutando la semplicistica distinzione “colto/popolare” e ricontestualizzando
le questioni corporee del malessere e delle cure simboliche in un più vasto
campo magico-religioso, politicamente sensibile e storicamente profondo,
con una attenzione particolare alle condizioni della efficacia rituale. Ho prodotto alcuni elementi di analisi dell’approccio antropologico demartiniano ai
processi di salute/malattia in Pizza G. 2005: passim (con particolare riguardo
alle opere: Il mondo magico [1948], Sud e magia [1959] e La terra del rimorso
[1961]).
8. Medicina popolare: una riflessione
201
ciali di questi intellettuali. Ricordo, ad esempio, le domande già
sollevate da Antonino Buttitta con le sue note su Pitrè e la mafia
(Buttitta A., 1968), che riecheggiano più tardi in un articolo
di Nancy Triolo sul medesimo argomento (Triolo N., 1993),
per trovare infine importanti risposte in un saggio recente di
Berardino Palumbo (Palumbo B., 2009: 242-249). Sono studi
molto importanti, infatti, quelli che ricostruiscono, a partire
dal testo, anche gli elementi di una memoria dell’azione sociale
reale degli intellettuali, talora veri e propri funzionari politici, agenti nello spazio pubblico locale. Tenendo costantemente
sullo sfondo – che poi tanto sfondo non è – la questione dell’unificazione dell’Italia, e quindi la questione dello stato.
La fase storica successiva all’unità d’Italia corrisponde a una
dinamica che Paolo Bartoli e Paola Falteri hanno ricostruito
nella sua complessità definendola «dinamica storica dell’incontro/scontro tra medicina ufficiale e medicina popolare»
(Bartoli P. - Falteri P., 1987: 168, Bartoli P., 1989, Pizza G.,
2005: 155-168). L’osservazione di questa dinamica consente di
andare oltre lo sguardo dei medici etnografi. Al tempo stesso,
può evidenziare le trasformazioni della corporeità e dei saperi e
pratiche a essa connessi, che l’intervento dello stato nelle campagne determinava, in vista della creazione di «un nuovo tipo
umano»12. Nuove risorse venivano elargite, vecchie malattie venivano debellate, ma attraverso forme di controllo, repressione
e dissuasione da pratiche che, fino ad allora, appartenevano alla
vita quotidiana. Lo stato avviò una capillare medicalizzazione
del territorio, con una forma di egemonia e di controllo nuova
e più incisiva. La politica sanitaria era concepita come un capitolo di “ordine pubblico”, gestita cioè interamente dalla burocrazia dei comuni, delle province, e direttamente dallo stato
12. È l’espressione che Gramsci usa nel quaderno 22 dedicato ad Americanismo e fordismo (Gramsci A., 1975: 2146) L’attenzione ai termini del rapporto fra il corpo e lo stato in Gramsci è notevole. Su questi aspetti biopolitici
dell’opera gramsciana cfr. Pizza G., 2003a, 2005: 146, 262 n. 17, Pizza G.
- Johannessen H., 2009, Pizza G., 2012.
202
Giovanni Pizza
attraverso il ministero dell’Interno e le prefetture (Cosmacini
G., 1987: 405, Bartoli P., 1989).
Connivenze e conflitti, scambi e ineguaglianze, si attivarono
tra le forze storiche che governarono il processo di medicalizzazione e i soggetti concreti che a quelle forze furono docili o
resistenti: cioè i cittadini del nascente stato unitario. L’intreccio
fra storia della biomedicina e processi di egemonia e di controllo sociale è ormai un dato acquisito nello studio delle forme
attraverso le quali l’organizzazione sanitaria si è diffusa e insediata sul territorio nazionale. La capillare diffusione dell’istituzione sanitaria e delle forme dell’assistenza pubblica produceva
il miglioramento delle condizioni e delle aspettative di vita, ma
favoriva anche una colonizzazione delle esperienze e dei corpi,
un tentativo di espropriazione della capacità di agire.
Tutto avveniva attraverso la diffusione egemonica di un
modello statuale della conoscenza che si presentava come un
complesso e contraddittorio dispositivo ora riduzionistico e naturalistico, ora più magico e stregonesco della stessa stregoneria
che intendeva eradicare, in quanto capace effettivamente di catturare e ridurre la complessità dell’esperienza corporea, e della
vita stessa, attivando le forme proprie della governamentalità
biomedica, mediata, nel rapporto con le popolazioni, sia dalle
politiche sanitarie, sia dalle procedure dei medici-etnografi sia
dalle pratiche degli stessi guaritori, veri e propri mediatori di
guarigione esperti nella gestione intima dei poteri pubblici13. In
questa prospettiva, la ricchezza di dati delle medicine popolari
offre altrettante occasioni per approfondire la complessa dinamica storica che investe i rapporti fra i corpi e lo stato.
13. Per un confronto fra diversi approcci antropologici allo studio degli operatori terapeutici “tradizionali” cfr. fra gli altri Renzetti E. -Taiani
R. 1988, Papa C., 1989, Friedmann D., 1993, Lanternari V., 1994, Pizza G.,
1995, 2005, Di Vito A. 2006, Minelli M. 2008. Cfr. inoltre Di Rosa M. curatore, 1987, “Annali di San Michele”, 16, Museo degli Usi e Costumi della Gente
Trentina, dedicato a Saperi terapeutici tradizionali nell’arco alpino, a cura di
Kezich G. e Seppilli T., San Michele All’Adige, 2003, Renzetti E., 2007.
8. Medicina popolare: una riflessione
203
Ritorno a Gramsci
Lo stato, dunque. Allora il Gramsci necessario non è più quello
del folklore, delle presunte dicotomie colto/popolare o subalterno/egemone, ma è il Gramsci di una teoria antropologica
dello stato e di una storia critica delle pratiche intellettuali e
della organizzazione della cultura italiana. Per ripensare la medicina popolare è importante recuperare pienamente lo spirito
gramsciano, nell’egida del quale mi pare che il convegno di
Pesaro del 1983 volesse operare.
In questo senso è utile tornare a Gramsci, per rileggere un
suo paragrafo tratto dai Quaderni del carcere. Un passo in cui
la questione degli intellettuali incrocia il campo medico e quello religioso, nella ricerca delle modalità attraverso le quali gli
intellettuali-istituzione costruiscono la “seconda natura” dei
cittadini inverando, proprio in questa fabbrica biopolitica, il
progetto egemonico (Pizza G., 2003a, 2012).
Si tratta di un paragrafo che testimonia di una parte dei
Quaderni del carcere che Gramsci programmò ma non scrisse
mai. Nella sua idea, avrebbe dovuto studiare genesi, ruolo e
funzione organica di una specifica categoria di “intellettuali tradizionali”, quella dei medici, riservando ad essa una attenzione
pari e analoga a quella poi effettivamente profusa al campo religioso, al quale sono infatti dedicate note e pagine molto importanti.
A rileggerli ora, questi appunti stesi da Gramsci nel carcere
di Turi, così densi di forza progettuale, mi appaiono come un
manifesto programmatico attuale, in cui è ancora possibile discernere chiaramente ciò che è stato fatto da quello che ancora
resta da fare:
Intellettuali. Intellettuali tradizionali. Per una categoria di questi
intellettuali, la più importante forse, dopo quella «ecclesiastica»,
per il prestigio e la funzione sociale che ha svolto nelle società primitive – la categoria dei medici in senso largo, cioè di tutti quelli
che «lottano» o appaiono lottare contro la morte e le malattie – oc-
204
Giovanni Pizza
correrà confrontare la Storia della medicina di Arturo Castiglioni.
Ricordare che c’è stata connessione tra la religione e la medicina
e ancora in certe zone, continua ad esserci: ospedali in mano a
religiosi per certe funzioni organizzative, oltre al fatto che dove
appare il medico appare il prete (esorcismi, assistenze varie, ecc.).
Molte grandi figure religiose erano anche o furono concepite come
grandi «terapeuti»: l’idea del miracolo fino alla resurrezione dei
morti. Anche per i re continuò a lungo ad esservi la credenza che
guarissero con l’imposizione delle mani ecc. (Gramsci A., 1975:
846).
Donatella Cozzi
9. Narrazione della malattia
1. Definizione, contingenze storiche e di ricerca
Le illness narratives, le narrazioni di malattia, sono le pratiche
discorsive con cui le persone raccontano la propria illness, ovvero la declinazione soggettiva, esperienziale e al contempo sociale, del loro malessere o della loro malattia. Mike Bury ci offre
questa definizione:
Illness narratives [è una locuzione che] designa le pratiche di narrazione e resoconto che insorgono di fronte alla malattia. L’analisi
narrativa cerca di comprendere la “trama” del resoconto fornito,
e le sue dimensioni sociali e motivazionali (Bury M., 2004: 82)1.
Le narrazioni di malattia:
mostrano come le persone riescono ad affrontare momenti di crisi eccezionali, difficili, che trasformano le loro vite interpersonali,
come esse inventano nuovi modi di discorso quando quelli vecchi
diventano insufficienti, come rendono l’incomprensibile concepibile e il disastro affrontabile, come sono capaci di mutare l’evento
tragico in dono (Bochner A.P., 2002: 82).
Le pratiche narrative consentono di iscrivere l’evento malattia in una temporalità biografica, mantenendo le connessioni
di significato tra il proprio passato, il presente e il futuro, di
rinegoziare la propria identità e di trovare un senso pur entro
le fratture biografiche che sottolineano la nostra vulnerabilità
1. La traduzione è di Daniele Nigris (2008: 82). Ove non altrimenti specificato, altre traduzioni sono mie.
206
Donatella Cozzi
in quanto esseri umani. Raccontare una storia organizza, struttura e dà senso all’esperienza e conduce chi ascolta entro «un
viaggio immaginario in un mondo di storie» (Mattingly C.
– Garro M.C., 2000: 13), dispiegandosi sul piano della soggettività esperita da un lato, e dell’intersoggettività dall’altro,
attraverso il linguaggio, i segni, il riconoscimento dei sintomi,
i significati condivisi, le sovrapposizioni nosografiche. Infatti,
il vissuto soggettivo della malattia è pensato e descritto sempre
anche a partire dalle categorie della scienza medica esistente in
quel determinato sistema medico e in un particolare periodo
storico e declinato sempre anche secondo le categorie sociali
culturalmente disponibili. Arthur Kleinman nota che la sofferenza ci costringe a riconsiderare le nostre vite, e questo conduce alla possibilità di trasformarle (1988a: 3). Vite sempre situate
all’incrocio di traiettorie storiche e sociali, arena di confronto
ed esercizio di saperi e poteri.
Due sono le contingenze storico-epistemologiche che accompagnano l’attenzione per le narrazioni di malattia: la prima è interna all’ambito dell’antropologia e particolarmente
dell’antropologia medica, e riguarda la riflessione sullo statuto
del soggetto, la seconda è esterna all’ambito disciplinare, e si
riferisce alla crescente insoddisfazione verso il riduzionismo oggettivante della clinica. Vieda Skultans (2007) ci ricorda quanto
a lungo la nozione di soggetto sia stata considerata spuria per
l’antropologia culturale. Gli antropologi tendevano a vedere i
propri informatori in quanto veicoli di valori e pratiche sociali,
piuttosto che come soggetti e agenti morali a pieno titolo. A tale
proposito, Anthony Cohen (1994) scrive:
Gli antropologi non attribuivano alcuna importanza al problema
di che cosa significassero quelle strutture per coloro che le popolavano. In questo tipo di schema teorico, la gente e gli individui erano importanti solo in quanto strutture in sé, o in quanto collegati
alla struttura in qualche modo identificabile (1994: 98).
Questa apertura verso la soggettività va a collocarsi nel solco
9. Narrazione della malattia
207
della riflessione fenomenologica già presente con Schultz nelle
scienze sociali, si sostanzia della nozione di esperienza – incorporata e situata socialmente -, porta a interrogarsi sulle forme
che prende la cognizione di sé, sulle strategie narrative, sulle
peculiarità di una vita in cui la malattia interviene con una frattura biografica (Bury M., 1982). È all’interno della scuola antropologica e psichiatrica di Harvard, ad esempio con le opere
di Arthur Kleinman (1988a) e Byron Good (1994) che prende
corpo il campo di studi sulle illness narratives, con una pluralità di importanti contributi, tra i quali va segnalato almeno
Cheryl Mattingly (1994). Contemporaneamente, si sviluppa
una scuola sociologica relativa alle narrazioni di malattia in
Gran Bretagna, con gli studi di Mike Bury sulla malattia cronica
(1982, 1991, 2001, 2005). Particolare menzione meritano i lavori di Catherine Kohler-Riessman (1990, 1993), Cathy Charmaz
(1983, 1987), Arthur Frank (1995), Michael Kelly (1992), Alan
Radley (1989), Gareth Williams (1984), autori che dai più diversi orientamenti teorici, e da posizioni epistemologiche anche
contrapposte, hanno riflettuto con le loro ricerche empiriche,
sulla natura dell’esperienza di malattia. Tra gli studi editi in
Italia, va ricordato quello dedicato alle cure palliative e al fine
vita nei malati di cancro realizzato da Debora Gordon e Carlo
Peruselli (2001).
Illness Narratives di Arthur Kleinman (1988a) promuove
nel panorama dell’antropologia medica una nuova attenzione nei confronti delle narrazioni dei soggetti colpiti dalle più
varie forme di malattia, soprattutto cronica. Il testo appare in
un momento in cui più voci, sia provenienti dal campo medico
che da quello antropologico e sociologico, lamentano come la
progressiva separazione del modello biomedico di malattia (disease) dalla sua esperienza individuale (illness) e l’espansione
di tecnologie diagnostiche, terapeutiche e chirurgiche avvenuta
dopo gli anni quaranta del Novecento, hanno congiurato nel
far scomparire il malato dalla cosmologia medica (Jewson N.,
1976). Non ascoltare l’esperienza del paziente – e quindi la sua
208
Donatella Cozzi
narrazione dei sintomi e insieme di quei lacerti di vita che li
tessono nella trama di una quotidianità vissuta – si configura
come un atto di potere che nega l’esistenza di un corporeità
vissuta, del mindful body della persona che si propone nella
relazione duale con il curante, o in quella molteplice con le
varie figure che popolano lo spazio ospedaliero. Nega il fatto
che del sintomo, o di quella costellazione di sintomi, qualcuno
stia facendo ‘esperienza’, e quindi che questo soggetto sia sotto
qualche aspetto ‘esperto’ di quanto accade al proprio corpo e
alla propria vita. Nega inoltre che tale esperienza venga interpretata culturalmente, quindi che esistano altre semiologie oltre
a quella universalista e naturalista proposta dalla biomedicina,
e che la malattia sia da «situare […] nella storia, nelle relazioni sociali, ricostituendo un ordine temporale dotato di senso»
(Good B.J., 1999[1994]: 180). Infine, ma più importante, nega
l’Altro attraverso l’opacizzazione della sua soggettività. Ancora
Kleinman aveva individuato nell’interpretazione delle narrazioni dei pazienti uno dei compiti fondamentali del lavoro del
medico:
[…] la malattia ha un significato, e capire come acquisisce significato significa comprendere qualcosa di fondamentale sulla malattia, la cura e, forse, la vita in generale. Inoltre, l’interpretazione
della malattia è qualcosa che i pazienti, i familiari e gli operatori
debbono intraprendere insieme. Ciò in quanto vi è una dialettica al cuore della guarigione, che porta l’operatore sanitario nel
mondo incerto e pieno di paure del dolore e della disabilità e che
reciprocamente introduce il paziente e la sua famiglia entro l’altrettanto incerto mondo delle azioni terapeutiche (Kleinman A.,
1988a: xiv).
Tuttavia, non mancano ambiguità quando le narrazioni di malattia entrano nell’ambito della bio-medicina, dei suoi spazi di
azione e delle sue finalità. Spesso i termini illness narrative e
narrative-based medicine sono utilizzati in modo intercambiabile, e le medical humanities utilizzano il materiale narrativo
in una pluralità di modi spesso molto diversi da quelli dell’an-
9. Narrazione della malattia
209
tropologia medica o della sociologia della salute. Ad esempio,
sollecitano creazioni discorsive da parte dei pazienti (racconti,
affabulazioni, messe in scena, giochi di ruolo, fiabe) o utilizzano favole ed altri materiali con funzioni terapeutiche, oppure
selezionano brani dall’ampio repertorio di scrittori che hanno
raccontato il loro malessere. O ancora, le illness narratives permettono agli operatori in formazione di conoscere l’esperienza
di malattia e il suo trattamento dal punto di vista del paziente.
L’intento è in quest’ultimo caso quello pedagogico di «progettare e attuare una formazione nella quale i sentimenti dei futuri
operatori possano trovare diritto di cittadinanza» (Zanini L.,
2008: xviii). Non entrano, quindi, nell’esplorazione dell’esperienza di vita delle persone che vivono con una determinata malattia, disfunzione, menomazione o disabilità e di come in essa si
iscrivano elementi sociali e politici. Come scrive Daniele Nigris
«in questo modo certe chiavi di lettura – scientifiche ancorché
non mediche – della malattia non riescono a diventare fattori
sociali operanti per una modifica virtuosa dei rapporti esistenti
tra cittadino e sistema sanitario al livello macrosociale, e tra paziente e operatori della cura al livello micro» (2008: 130).
Eccezione al processo di progressiva perdita di rilevanza
della narrazione del paziente in medicina è stata la psicanalisi
(Giarelli G., 2005, Skultans V., 2007) e quella parte della psichiatria più attenta alle modalità di conferimento di senso alla
situazione di crisi del soggetto e a fornire un orientamento per
il processo di cambiamento terapeutico.
Mike Bury (2001) indica quattro fattori che hanno giocato
un ruolo chiave nell’emergere della narrazione e che ne segnano
la crescente importanza. Il primo è di natura epidemiologica e
demografica: il declino delle patologie infettive, sulle quali era
fondato il modello medico, e il prevalere delle patologie cronico-degenerative prodotta dal processo di invecchiamento della
popolazione, sottolinea l’importanza dei mondi di vita quotidiana, rendendo inadeguato il trattamento biomedico classico e
le sue modalità di ascolto e relazionali. La cura diventa polifonica: il malato, i suoi familiari, chi lo accudisce quotidianamente
210
Donatella Cozzi
diventano parte della qualità della vita del paziente cronico. Il
secondo fattore è di natura organizzativa a livello di politiche
sanitarie: l’ospedale perde la sua centralità nell’ambito dei sistemi sanitari contemporanei e il territorio, il domicilio del paziente e l’assistenza sanitaria di base acquisiscono sempre maggiore
importanza. Anche questa ridefinizione aumenta l’attenzione
per il mondo del paziente. Il terzo fattore riguarda la messa
in discussione dell’efficacia della biomedicina (come nel caso
dell’AIDS, del cancro e di diverse patologie cronico-degenerative). La persona malata ritrova il diritto all’espressione della
propria sofferenza, a lungo negato dal paternalismo medico.
Connesso a questo è il quarto fattore: l’espansione dell’informazione sulle malattie attraverso i mass media, la stampa medica e
divulgativa, internet, le medicine non convenzionali e i gruppi
di self-help. Questa crescente possibilità di accesso ha ridotto
l’autorevolezza del medico come esclusiva fonte di conoscenza,
ampliando la gamma delle opzioni conoscitive disponibili per
il malato.
Se quelle elencate da Bury sono le contingenze favorevoli che
inclinano verso una attenzione alle illness narratives, non vanno taciuti i problemi metodologici ed epistemologici che esse
pongono. Nigris (2008), per quanto riguarda la teoria sociologica, li sottopone ad una serrata analisi, utile in un approccio
etnografico critico e consapevole del posizionamento reciproco
del ricercatore e del narratore. Lavorare per “tracce” e punti
tematici invece che seguendo una serie strutturata di domande,
attribuisce all’intervistato un «enorme potere di dirsi, il difetto
è il converso: all’intervistato sono richieste una capacità e una
volontà di parola che, per varie ragioni, egli può non possedere» (Nigris D., 2008: 133). Inoltre, considerato che la caratteristica del racconto è dispiegarsi nel tempo, oltre che impiegare
i modi della temporalità, «può esserci poco tempo – prima o
dopo un colloquio clinico, o un trattamento chemioterapico –
[…] Il tempo può essere poco anche perché, a volte, siamo costretti a intervistare in setting ospedalieri caotici, e non sempre
gli spazi sono a nostra disposizione riservata, l’intervistato, poi,
9. Narrazione della malattia
211
può trovarsi in una situazione in cui i sintomi della patologia
– o, al contrario, i trattamenti – gli concedano limitati ambiti
di mobilità, o tempi di concentrazione, o di libertà dal dolore,
oppure può avere una età in cui la presenza di più malattie contemporaneamente in atto e il declino fisico rendono complicata
la concentrazione e il lavoro di rammemorazione» (ibid.: 133).
In breve, quanto ingenuamente, e con notevole etnocentrismo,
possiamo dare per scontato, ovvero quanto sia semplice ‘narrare di sé’, può incontrare ostacoli e restrizioni delle condizioni di
effabilità da non sottovalutare. Inoltre, Nigris affronta un altro
problema da non dare per ovvio: entro una narrazione di malattia, tutte le asserzioni si collocano sullo stesso piano, quanto
a statuto epistemico? In altre parole, chi sta parlando? E poi,
di chi sta parlando? Questo secondo interrogativo prelude alla
terza dimensione da esplorare, ovvero chi sta facendo esperienza, e di che cosa? Procedere in questo modo consente di distinguere tra esperienza diretta, mediata e rappresentata, quindi tra
la pluralità di illnesses a seconda che il locutore sia la persona
malata, un suo familiare, il suo medico curante, le figure che lo
seguono nella cura. Ognuna delle narrazioni prodotte riguarda
la illness, ma con statuti di mediazione e fedeltà all’esperienza
differenti. Tuttavia, quando non è la parola della persona malata ad «innescare il flusso di senso» (Nigris D., 2008: 148) e
siamo di fronte alla sola rappresentazione altrui, il soggetto che
fa esperienza viene puramente evocato: viene oggettivato, gli/le
vengono attribuite sensazioni e vissuti senza che abbia una presenza autonoma nel discorso che lo/la riguarda. Distinguere,
quindi, tra esperienze e rappresentazioni diventa criterio discriminante per situare la illness anche in relazione alla questione
dell’agentività – il soggetto presente nelle istituzioni sanitarie è
anche soggetto politico -, della relazione con i curanti e della
sofferenza sociale.
212
Donatella Cozzi
2. Intermittenze dialogiche, sofferenza, ethos compassionevole
Il percorso di assestamento nel panorama disciplinare delle
illness narratives non è stato lineare: ci sono state oscillazioni
iniziali che riconducevano l’ascolto al miglioramento della relazione medico-paziente o delle capacità di diagnosi clinica,
elaborazioni centrate sul significato e la rete semantica (Good
B.J. 1977), ma che opacizzavano la dimensione politica e sociale
che forma l’ordito della trama della malattia, altre interessate
ad approfondire l’analisi narratologica, il dispositivo di costruzione sintattica delle storie (Mattingly C., 1994, 2000), infine
analisi empiriche volte a comprendere in che modo la malattia
de-costruisce e costruisce forme e mondi di vita, cambia la socialità delle persone, le trasforma socialmente (come le ricerche
dedicate all’artrite reumatoide, Charmaz K., 1983, 1987).
Dalla seconda metà degli anni Novanta, sempre più numerosi sono stati i riferimenti alla letteratura filosofica - Ricoeur,
Gadamer, Levinas. Un bisogno di radicamento, quello filosofico, che mostra anche quanta fatica abbia fatto l’antropologia
contemporanea a confrontarsi con il tema della testimonianza
individuale e delle molteplici verità che ritrae, con i temi della
memoria e dell’oblio e della loro costruzione, infine a fare proprio il tema di un corpo vissuto, oltre che agente negli habitus,
che incorpora le coordinate sempre mobili e da ridefinire della
sua collocazione storica. A guardare ora la sfaccettata letteratura sulle narrazioni di malattia, emerge un quadro magmatico e
vitale, a volte contraddittorio e organizzato da paradigmi diversi, con diversi gradienti di contestualizzazione storico-sociale, e
diversa accessibilità alle narrazioni da parte di chi legge (ampie
citazioni dirette VS estrapolazioni e riassunti). Talvolta, resta
un senso di incompiutezza dopo la lettura di alcune illness narratives. Verso il lettore si muovono profili dolenti di persone,
immagini sfumate, biografie imperfette, echi di lamenti, di sopportazione, di resistenze: intermittenze dialogiche. Viene da
chiedersi: e poi? Il fine lavoro di accogliere voci, di restituire il
9. Narrazione della malattia
213
punto di vista degli attori sociali coinvolti ha consentito anche
di ridisegnare le forme di cittadinanza entro la malattia? Che
forme di soggettività ha contribuito a creare? Quale aggancio
ha suggerito con le cause sociali della malattia e le disuguaglianze sociali di accesso alle risorse di cura? Viene da chiedersi, con
Vieda Skultans (2007) quanto dell’intento di dare spessore di
presenza all’esperienza di malattia non finisca per essere un
conato illuministico, che fa rientrare nella pensabilità e nella
dicibilità – ed entro riposanti e assestati orizzonti accademici
- situazioni ai limiti delle consuete capacità di rispecchiamento
etnografico. Viene da chiedersi quanto un ethos compassionevole (Fassin D., 2010) possa interferire nell’attutire la potenzialità corrosiva delle narrazioni di malattia, corrosività verso
i saperi e i sistemi di cura, verso le relazioni proposte, se non
imposte, entro l’ospedale e le istituzioni sanitarie (Cappelletto
F., 2009). Prendo come esempio il primo lavoro dedicato da
Arthur Kleinman (1982, poi ripreso in Kleinman A., 1986) alla
somatizzazione, alla neurastenia e alla depressione in Cina, che
delinea le conseguenze devastanti della rivoluzione culturale
su coloro che ne patirono l’assalto al proprio senso di identità, lo sradicamento dal proprio contesto di vita e relazionale,
l’intrusione violenta nei significati della propria vita attraverso
l’incertezza e la minaccia fisica. Ma di questa esperienza in questo saggio c’è a malapena traccia. L’approccio dell’autore alla
neurastenia utilizza categorie classificatorie quasi cliniche del
dolore e della sofferenza, rendendo difficile rendere il senso dei
significati soggettivi. Nel centinaio di persone raggiunte dalla
sua ricerca del 1982, sono riuscita a trovare un solo esempio
di narrazione in grado di rendere l’esperienza soggettiva della
sofferenza e della memoria storica della rivoluzione culturale. Si
tratta del ‘Caso 4’, una donna di 52 anni soggetta con il marito
e i figli all’oppressione e violenza politica. Ecco la parafrasi di
Kleinman (1982: 169):
Fai conto, essa disse, di guardare giù mentre stai arrampicandoti
su una montagna e la montagna è molto scoscesa e dura da ar-
214
Donatella Cozzi
rampicare. Alla tua destra e sinistra vedi gente che precipita giù.
Attaccati dietro di te ci sono alcuni dei tuoi familiari, così se cadi
potresti trascinarli giù con te. Hai arrampicato questa montagna
per venti anni con gli occhi fissi a un appiglio per le mani, a un appoggio per i piedi. Senza guardare avanti o indietro. Finalmente,
raggiungi la cima. Forse è la prima volta che guardi indietro, e vedi
tutto quello che hai sopportato, quanto difficile è stata la tua vita e
quella della tua famiglia, quanto appassite sono le tue speranze…
Ha concluso chiedendomi se queste non erano ragioni sufficienti
per diventare depressa
Ho citato il passo per intero perché illustra quanto si rischia
di perdere in una analisi narrativa che si concentri solo sugli
aspetti di confronto diagnostico transculturale, o ermeneutici, o
narratologici. Il tema del saggio era l’incapacità di questi Cinesi
a riconoscere e manifestare emozioni dolorose e a tradurle e
percepirle come disagio psicologico e sintomi somatici, posizione dalla quale il lavoro di Kleinman durante la seconda metà
degli anni Novanta si allontana, concentrandosi sugli effetti della violenza statale sulla vulnerabilità individuale. Non è qui mio
intento far diventare Arthur Kleinman (uno degli autori a cui
addebito il sorgere della mia attenzione verso le illness narratives e l’antropologia medica in generale) il capro espiatorio delle
omissioni dell’approccio narrativo alla illness. Il mio scopo è
ricordare come guardare con occhi diversi ad una esperienza,
darle un nome diverso, si ripercuote sul modo in cui rivalutiamo
il resto della nostra esperienza. Come ricorda Cheryl Mattingly
(2005), l’incontro con coloro che sono colpiti da una malattia
grave, i loro sintomi e il loro vissuto collocano il ricercatore
ai limiti della facoltà di partecipare all’esperienza dell’Altro. Il
resoconto di Mattingly della sua relazione con Shanelle, madre
di una bambina colpita da un tumore cerebrale, mostra come
coloro che a vario titolo partecipano a questo tipo di ricerche,
che siano pazienti o i loro familiari, manifestano il desiderio che
il proprio racconto raggiunga un auditorio più ampio, che consenta loro di diventare protagonisti/attori e non solo testimoni
o interlocutori privilegiati, uscendo da quella invisibilità che li
9. Narrazione della malattia
215
tutela attraverso l’anonimato garantito di consueto durante le
ricerche in ambiente sanitario. Mattingly riferisce di cartelle
cliniche o altri documenti che Shanelle sottrae clandestinamente all’ospedale per fornire materiali all’antropologa, metterla
in grado di testimoniare le vicissitudini della figlia nell’universo nosocomiale, perché quella storia possa servire ad altri.
Lavorare con i malati e con la loro malattia – non sui malati e
sulla loro malattia – conclude Mattingly, è una esperienza che
pone al ricercatore molteplici interrogativi etici, ma soprattutto
è una esperienza ‘trasformativa’: la narrazione trasforma l’esperienza di chi soffre tanto quanto quella di chi ascolta, se l’ascolto è uno strumento per esplorare il mondo dell’altro.
3. Emozioni, comprensione relazionale e rappresentazionale
L’esperienza è necessariamente soggettiva, e si dischiude attraverso linguaggio e discorso. Osserviamo gli altri e ascoltiamo
quello che ci dicono: questo tipo di comprensione non dispiega
un qualche processo misterioso di identificazione ma piuttosto
la comprensione etnografica dell’Altro. «Interpretare significa mettere in gioco le proprie precomprensioni in modo che
i significati del testo possano realmente essere in grado di parlarci» (Gadamer H.G., 1983: 94). Questo tipo di antropologia
trasforma il self autobiografico in self etnografico (Ryang F.,
2000). La consapevolezza di un self etnografico rende più difficile dissimulare l’esperienza e la storia altrui quanto la propria. Questa considerazione implica considerare il posto che le
emozioni occupano nel dialogo con i nostri interlocutori e nella
ricerca. Ovvero, questione che riguarda il ricercatore quanto
il professionista coinvolto in relazioni di aiuto e di cura, come
trovare un equilibrio tra empatia ed eccesso di coinvolgimento.
Skultans (2007: 14-15) sottolinea la differenza tra una comprensione relazionale ed una comprensione rappresentazionale: «Se
un mio informatore mi sta chiedendo una comprensione emozionale, non posso dirgli “Mi spiace, non provo nulla, ma cono-
216
Donatella Cozzi
sco qualcuno che può sentire al posto mio”». Molti ricercatori/
trici, nel ricordare vividamente l’impatto emotivo dell’incontro
etnografico, potranno capire questa distinzione. Frank (1995,
2001) l’ha identificata nella differenza tra ‘thinking with stories’
e ‘thinking about stories’: ‘pensare con’ le storie che ci vengono
narrate è un processo esperienziale e trasformativo, che lascia
spazio all’empatia (per quanto questo termine vada sottoposto
ad attento vaglio, onde non scadere in superficiale riconoscimento emotivo, cfr. Piasere L., 2002) con il narratore, che a
sua volta fa appello alla nostra immaginazione morale. Quando
ci confrontiamo con il dolore e la sofferenza degli altri, le loro
narrazioni esercitano una sorta di obbligo morale nei confronti
dell’ascoltatore a non distogliere il nostro sguardo e il nostro
ascolto, ma a riconoscere e condividere (Morris D.B., 2002).
«Quello che le voci degli altri possono fare per noi che noi non
possiamo fare per noi stessi, è che la loro alterità che ci invade
ci rende altri. Essi possono destare una risposta dialogicamente strutturata in noi, essi possono creare possibilità di cambiamento entro di noi che non siamo in grado da soli di creare»
(Skultans V., 2007 p. 15). Le etnografie mediche e psichiatriche
spesso concernono storie di dolore ed esperienze di afflizione,
e il processo del raccontare suscita emozioni in chi racconta. E
l’atto del rispecchiamento etnografico dell’esperienza narrativa
dal campo suscita ulteriori emozioni.
Nella sua eloquente monografia, The Wounded Storyteller
(1995), Arthur Frank descrive le illness narratives come tentativi di prendere la parola: raccontare una storia è parte del
processo di cura quando la persona malata chiede alla medicina la ‘restituzione’ del proprio corpo e costruisce il senso della
malattia nella propria vita. Secondo Frank, è l’esperienza postmoderna della malattia che genera questo bisogno di narrare,
in quanto veicolo per la riflessione e l’espressione in relazione
al self e agli altri. Una narrazione di malattia è quindi sia uno
strumento che un risultato del processo di rendere densa di
significato la malattia.
Da un punto di vista concettuale (Kangas I., 2001), il proces-
9. Narrazione della malattia
217
so di costruzione di senso della malattia comprende tre aspetti:
a) contestualizzazione individuale, che riguarda il tentativo di
trovare e dare un significato ed una spiegazione all’origine della
malattia entro il perimetro biografico della vita individuale, b)
contestualizzazione sociale, che abbraccia le considerazioni sugli effetti e i significati della malattia per la posizione sociale e
le relazioni sociali dell’individuo, con ripercussioni pratiche e
morali, c) contestualizzazione culturale che informa e interagisce
con gli altri aspetti della contestualizzazione. Essa comprende
aspetti e saperi condivisi: metafore e immagini che attingono
all’orizzonte rappresentazionale, aspettative culturali, atteggiamenti e norme, quindi modelli di condotta e incondotta, teorie
disciplinari. Credenze, conoscenze comuni ed esperte si sovrappongono, così come possono intersecarsi ad esse ambiti di
non conoscenza o di cui non ci si cura di conoscere, nel senso
che una costellazione di sintomi, una certa forma di malessere
non vengono concettualizzati e nominati da un certo gruppo
(Littlewood R., 2007).
Storie e narrazioni, una volta dette o scritte, sembrano vivere
una vita indipendente da quella del locutore. Infatti Bauman e
Briggs sottolineano la preoccupazione degli antropologi verso la
contestualizzazione delle narrazioni, proprio perché esse rischiano di essere facilmente staccate dal loro contesto: «quali sono i
fattori che portano a perdere i legami tra il discorso performato e
il suo contesto?» (1990: 73). La scelta di un modello interpretativo finisce col lasciare in ombra ciò che potrebbe essere illuminato
da un altro paradigma. Ma molta della ricerca e scrittura antropologica comprende la scelta difficile di cosa lasciar fuori. La domanda da porsi è piuttosto: di quanto contesto abbiamo bisogno
per non distorcere o privare le narrazioni del loro significato?
Il processo di costruzione di senso è una ricerca attiva di significato, che tenta di trovare una risposta al quesito ‘Perché a
me?’. Questo processo è stato denominato ricostruzione narrativa
(Williams G., 1984) nella quale la frattura biografica (Bury M.,
1982) provocata dalla malattia è tessuta nella trama della vita individuale. Raccontare la propria malattia disponendola in forma
218
Donatella Cozzi
narrativa è anche parte del processo di coping attraverso il quale
si costruisce un adattamento attivo alla malattia e alle sue conseguenze (Radley A., 1989). Si tratta di un processo fluido e continuo, in cui nuovi significati sostituiscono o si sovrappongono ai
precedenti, facendo della illness un racconto senza fine manipolato e interpolato. La malattia viene reinterpretata ed il processo continua, ed è quindi difficile comprenderlo unicamente da
una singola prospettiva (Giarelli G. - Good B.J. – DelVecchio
Good et al., 1995).
Una illness narrative può anche essere il tentativo di costruire
legittimazione sociale per chi soffre: soprattutto chi soffre di un
disagio mentale, spesso avverte la minaccia di essere considerato incompetente o incapace, e il sospetto che la illness sia una
auto-rappresentazione o che la persona stia mentendo permane
(Radley A. - Billig C., 1996: 228). Byron Good (1995: 134) ci
ricorda che una narrazione di malattia comprende sempre lo
sforzo di raccontare la storia ‘giusta’, tamponando la frattura morale che la malattia presenta. Riuscire a giustificare moralmente
quello che si è fatto o non fatto, diventa una questione cruciale
per i narratori.
Ilka Kangas (2001) e Donatella Cozzi (2007) hanno raccolto
rispettivamente in Finlandia e in Carnia illness narratives di persone che si dichiaravano ‘depresse’. In entrambi gli studi emerge
quella prospettiva emic che spesso abbraccia la lunghezza di una
vita intera, per quanto giovane possa essere l’età biografica del
narratore. Mescolano costruzioni imperfette della propria identità, brani di intimità, eventi di vita, quotidianità, elementi sociali come lavoro, emigrazione, genere, significato dei sintomi. La
narrativa della depressione è essenzialmente contestuale, malgrado la cultura dei servizi la riduca ad una prospettiva individuale
per sofferenza e duale nella relazione con il medico psichiatra, e
mette a fuoco la relazione cangiante tra self e mondo. Come le
altre illness narratives, quella riguardante la depressione descrive
la relazione complessa tra individuo e cultura, relazioni sociali
e malattia (Giarelli G. - Good B.J. – DelVecchio Good et al.,
1995: 157).
9. Narrazione della malattia
219
4. Analizzare le narrative: prospettive a confronto
Per l’analisi delle forme che strutturano e organizzano le narrazioni, possiamo seguire tre linee di pensiero: a) narratologica,
b) ermeneutica, centrata sul significato (rete semantica della
malattia, Good B.J., 1977), c) che ricostruisce la co-occorrenza
di modelli esplicativi, prototipi e complessi a catena (MINI
Questionnaire di Groleau D. – Young A. – Kirmayer L., 2006).
a) La rappresentazione narrativa dell’esperienza diventa un
modo di pensiero, il pensiero narrativo (Bruner J., 1988,
1992): noi utilizziamo la narrazione ogniqualvolta vogliamo
comprendere eventi concreti e le azioni che li hanno prodotti. Questa concatenazione di eventi è strettamente connessa
al tempo, il tempo concreto dell’esperienza, «il mondo rivelato da ogni opera narrativa è sempre un mondo temporale»
(Ricoeur P., 1986: 3). Cosa è avvenuto prima e dopo, come
le nostre azioni si sono incontrate con quelle degli altri, costruisce quell’intreccio che chiamiamo trama. Tempo e trama sono quindi strettamente connessi, «ogni evento particolare acquisisce il suo significato grazie alla sua collocazione
nella configurazione narrativa, come contributo alla trama»
(Mattingly C., 1994: 813)2.
Una storia richiede un narratore e un ascoltatore/let2. Secondo Cheryl Mattingly che si ispira all’approccio ermeneutico di
Ricoeur, le sei caratteristiche fondamentali del tempo narrativo sono le seguenti: 1) il tempo narrativo è configurato, gli eventi si configurano in un
movimento evolutivo verso un telos, che emerge dall’insieme della storia e dei
soggetti coinvolti, 2) azione e movente sono meccanismi strutturanti, che concatenano gli eventi e nei quali interagiscono le persone, 3) il tempo narrativo
si costruisce tra il divario tra ciò che un attore è e ciò che vorrebbe essere, 4) la
narrazione mostra come le cose cambiano nel tempo, non in modo lineare, ma
attraverso sovrapposizioni, imprevisti, capovolgimenti, 5) il tempo narrativo
è drammatico: vanno superati ostacoli, composti conflitti, nemici affrontati, ci
sono rischi da correre e situazioni difficili devono essere affrontate. È in questo clima che si svolgono i dialoghi tra gli attori coinvolti, o quello interiore
del protagonista, 6) il finale è incerto, e non può essere previsto.
220
Donatella Cozzi
tore che la decodifica. Questo sposta la nostra attenzione al
contesto nel quale essa viene costruita e agli effetti che essa
produce, ai processi sociali che innesca, alle dinamiche istituzionali. Sulla base di una ricerca durata cinque anni con i
terapisti occupazionali in un ospedale per acuti, Mattingly
sposta l’attenzione dalla narrazione come ‘testo’ raccontato
o scritto alla narrazione come struttura dell’azione clinica,
legata all’incontro clinico in cui avviene l’emplotment, ovvero la costruzione delle trame terapeutiche in un processo
di creazione e negoziazione di significati. Utile all’analisi è
identificare le storylines (tracce, linee narrative): una storyline guida la narrazione e deriva spesso da simboli, metafore,
scene o temi drammatici, che costruiscono una trama riconoscibile (Schaefer R., 1992: 29-31). Nelle storie di depressione di Kangas, ad esempio, l’autrice rileva tre diverse
storylines: una legata alle ferite e ai traumi infantili e dell’adolescenza, la seconda focalizzata sulle richieste considerate eccessive del contesto familiare e sociale e sui conflitti di
ruolo (burn-out lavorativo), che si sviluppano o contengono
già tratti depressivi. La terza storyline riguarda il precipitare
dei fattori provocanti i sintomi in età adulta, che sottolineano una storia intrisa di perdite e drammatici eventi di vita, ai
quali si reagisce con la depressione. Tutte queste storylines,
che possono sovrapporsi, esprimono il legame tra contesto
e depressione: la illness è descritta attraverso una causalità
molteplice che collega particolari circostanze e casi della vita
individuale. Le storylines non si concentrano particolarmente sulla spiegazione delle cause della malattia, ma comprendono elementi indispensabili per chiarirla.
b) Il modello ermeneutico culturale (Good B.J. 1977, 1994)
ruota intorno al concetto di rete semantica della malattia, per
definire «una rete di parole, situazioni, sintomi e sensazioni
associati a una malattia, e che a essa conferiscono un significato per chi ne soffre». Le reti sono organizzate intorno a
elementi simbolici fondamentali (come nel caso del cuore e
del mal di cuore in Iran, Good B.J., 1977). L’idea di sim-
9. Narrazione della malattia
221
boli fondamentali ricalca quella di Turner di simboli dominanti, che organizzano i significati dei rituali delle società
pre-industriali. Essi sono polisemici, collegano differenti
domini simbolici, e questo spiega perché le reti semantiche
comprendano elementi eterogenei. Nel caso iraniano, il mal
di cuore collega in modo complesso gli eventi della fisiologia
femminile: nascita, gravidanza, aborto, contraccezione, sterilità, vecchiaia, dispiacere, tristezza. Secondo Byron Good,
quanto afferma un informatore deve essere interpretato nel
contesto della sua esperienza di malattia, e può variare nel
tempo, in relazione con le circostanze vissute.
c) Il McGill Illness Narrative Interview (MINI) (Groleau
D. – Young A. – Kirmayer L., 2006) è un modello di intervista semistrutturata che raccoglie i risultati delle ricerche di Laurence Kirmayer e di Allan Young soprattutto nel
campo della salute mentale. Nella redazione di questo strumento qualitativo, viene concretizzata la critica che Young
aveva rivolto alla antropologia della illness e alla scuola di
Harvard in generale, ovvero di non considerare gli aspetti
di sickness e le traiettorie che la persona malata compie nei
servizi sanitari. Il MINI considera i modelli esplicativi del
soggetto (il pensiero causale riguardante i processi o i meccanismi all’opera nella malattia), i prototipi (il ragionamento
che concatena episodi salienti della propria esperienza o di
un familiare, che consente l’elaborazione di un significato
per analogia), i complessi a catena (le esperienze passate collegate metonomicamente ai sintomi presenti attraverso una
sequenza di eventi che circondano i sintomi, senza nesso
causale con questi). Il MINI può essere utilizzato per esplorare i legami tra significati e percorsi di recupero della salute,
compresi l’autocura, le medicine convenzionali o tradizionali, l’aderenza terapeutica, l’adozione di comportamenti
promuoventi la salute, il livello di soddisfazione dei servizi
sanitari, i cambiamenti identitari.
222
Donatella Cozzi
5. Testimoniare la sofferenza sociale
Le narrazioni di malattia infine, permettono di arricchire di senso e situare entro il contesto storico sociale la ricerca sulla varie
forme di sofferenza sociale, laddove essa coniuga malattia e violenza macrosociale. Qui mi limito a menzionare i vari saggi editi
tra il 2000 e il 2005 da Vieda Skultans (ora raccolti in Skultans
V., 2007) sulle conseguenze delle trasformazioni economiche e
politiche attraversate dalla Lettonia, paese dal quale nel 1941 la
famiglia dell’Autrice fuggì trovando rifugio in Inghilterra. La
più diffusa diagnosi psichiatrica durante tutto il periodo della
dominazione sovietica in Lettonia (1939-1941 e, dopo l’occupazione nazista durante il secondo conflitto mondiale, dal 1944 al
1991) fu quella di “neurastenia”, derivata dal modello tripartito
pavloviano del sistema nervoso in auge presso la psichiatria sovietica. Ma il discorso profano non adottò mai questa diagnosi
nello stesso modo con cui la diagnosi di depressione è diventata
parte del discorso quotidiano in altri paesi europei. Le narrazioni e gli scritti autobiografici raccolti dall’autrice lasciano
sullo sfondo la “neurastenia”, e descrivono piuttosto come gli
eventi violenti vissuti abbiano fatto “ammalare” le persone. Tra
i narratori, molti i medici che hanno visto, come i loro pazienti,
le circostanze brutali e oppressive prima dell’occupazione nazista, poi di quella sovietica, con la collettivizzazione forzata delle
proprietà agricole e la deportazione in massa in Siberia, reputate aver inferto un colpo diretto e brutale ai danni del sistema
nervoso. Nervi lesi, menti danneggiate, cuori malati diventano
un modo per descrivere il corpo collettivo e irrimediabilmente
ferito della patria, costruiscono memoria contro l’oblio imposto
dai dominanti: la neurastenia diventa il discorso che articola la
critica contro la dominazione sovietica, con una intensa identificazione tra le narrazioni personali e la più vasta narrazione della
storia. La storia della neurastenia in Lettonia è un esempio del
fallimento del sapere medico che riflette la capacità di resistenza a cinquanta anni di dominazione. Con qualche riserva ironica, Vieda Skultans utilizza il concetto di événement créatrice
9. Narrazione della malattia
223
di Emmanuel Le Roy Ladurie (1979: 130), per mostrare come
queste illness narratives sono strutturate. Per Ladurie alcuni
eventi storici sono creativi nel senso che spezzano le vecchie
strutture sociali introducendone di nuove. E la storia della Lettonia sovietica presenta numerosi eventi di questo tipo che forniscono il materiale di costruzione sia della macro storia sia di
una intima storia clinica. Ciò di cui si soffre non rende incapaci
di vivere – e soffrire – la propria vita. Piuttosto i loro racconti
ci riportano a quanto Veena Das ed altri sottolineano in merito
all’importanza di non «essenzializzare, naturalizzare o rendere
sentimentale la sofferenza. Non c’è un unico modo di soffrire»
(Das V. - Kleinman A. - Lock M. - Ramphele M. - Reynolds
P., 2001: 2). La disgiunzione tra narrazioni e vite riporta anche
ad uno dei compiti più importanti dell’antropologia, ovvero costruire la mappa delle complesse relazioni tra parole e azioni, tra
simboli e significati, tra individualità e società. Una complessità
riflessa nelle ricerche condotte a partire dal 2002 da Skultans:
se nel 1992 i suoi interlocutori lamentavano il malessere causato da una società e da una storia che li aveva fatti ammalare,
nel 2002 essi parlavano di “depressione”, di un disagio interno,
installato nel self, e dell’incapacità di riprendere il controllo di
se stessi. Un cambiamento correlato ai mutamenti strutturali
legati al nuovo ordine del liberismo economico e alla ricezione del nuovo linguaggio medico della depressione, incentivato
da corsi di aggiornamento per il personale medico promossi da
grandi case farmaceutiche europee. Il tema qui suggerito, così
importante per l’antropologia medica e per il quale le illness
narratives possono fornire elementi di analisi insostituibili, è:
quali circostanze portano le persone ad accettare con facilità
e a fare propria la versione della realtà profferita dagli esperti?
Nel caso lettone, l’autrice concorda con l’ipotesi di Rose sulle
“tecnologie psy” (1988:16) e il peculiare potere pervasivo del
loro linguaggio, che pone particolare enfasi sulla libertà personale: «Le forme di libertà che abitiamo oggi sono intrinsecamente legate ad un regime di soggettivazione in cui i soggetti
non sono solo ‘liberi di scegliere’ ma piuttosto di comprendere
224
Donatella Cozzi
e mettere in atto le proprie vite in termini di scelta sotto condizioni che sistematicamente limitano le capacità di tanti a dare
forma al proprio destino» (ibid.: 17). Mills ci rammenta la complessità interna al concetto di libertà: non solo è la possibilità di
fare quel che ci piace, né l’opportunità di scegliere tra alternative differenti, ma «libertà è, anzitutto, opportunità di formulare le scelte disponibili, di discuterle, e finalmente di scegliere»
(1995 [1959]:185). I nuovi linguaggi psichiatrici creano nuove
forme della persona e della personalità, ma non tutti i linguaggi creano senso e aprono nuove possibilità: possono anche mistificare. Nel caso lettone, la superiorità economica del resto
dell’Occidente, l’idea stessa di Europa quale sinonimo di civiltà
e sapere e, non ultimo, la diffusione di psicofarmaci, insieme
colludono a rendere il nuovo linguaggio della psichiatria occidentale difficile da sfidare, nella riduzione che opera ad una individualità sofferente e chiusa in se stessa. La libertà che si offre
alle persone è illusoria: «In questo processo gli individui sono
stati trasformati da commentatori attivi e critici delle circostanze della propria vita a passivi ricevitori di diagnosi» (Skultans
V., 2007: 9) e, una volta ancora, questa patologizzazione aiuta
a mascherare le fonti politiche e sociali della sofferenza, «e in
che modo la metafora della vittimizzazione come patologia di
un individuo altera l’esperienza – collettiva quanto individuale
– così che il suo significato vissuto come memoria morale e politica, forse persino come resistenza, viene perduto e sostituito
da “colpa”, “paranoia”» (Das et al., 2001:10).
Sergio Zorzetto e Giuseppe Cardamone
10. Salute mentale di comunità. Osservazioni
etnopsichiatriche
La riforma dei servizi psichiatrici italiani ha dato l’avvio ad un
peculiare percorso multidisciplinare e territoriale di presa in carico delle evenienze psicopatologiche. Progressivamente, negli
oltre trent’anni trascorsi, tale percorso ha reso possibile il configurarsi di una modalità comunitaria di cura nel campo della
salute mentale (Cardamone G. e Zorzetto S., 2000), che mantiene intatta la sua forza culturale propositiva e la sua originale
metodologia di lavoro (sia sul piano organizzativo che su quello
clinico-operativo).
Si tratta di una prospettiva che richiede il ripensamento continuo dei luoghi e delle prassi delle discipline psicologico-psichiatriche, il coinvolgimento degli utenti e dei loro familiari in
quanto soggetti titolari di diritti, l’apertura verso l’interazione
intersettoriale con soggettività individuali e collettive operanti
nel territorio e una visione complessiva delle dimensioni istituzionali attive nei sistemi di cura.
1. Ripensare l’operatività dei servizi
È necessario osservare, oggi, che le mutazioni sociali e culturali di tali soggettività individuali e collettive, prodotte dalle
migrazioni internazionali di massa, esigono sempre più un ripensamento dell’operatività dei servizi, in ragione del carattere
strutturale della presenza immigrata e del suo peso ormai anche
quantitativamente rilevante (Zorzetto S. et al., 2001).
Negli ultimi anni si è progressivamente diffusa negli ope-
226
Sergio Zorzetto e Giuseppe Cardamone
ratori una consapevolezza riguardo all’impatto della variabile
culturale sull’operatività quotidiana, e le difficoltà incontrate
hanno spinto anche i livelli organizzativi – almeno in alcuni
casi – a promuovere puntuali iniziative che permettessero l’articolazione di risposte adeguate (Harrag, 2007). Parallelamente
all’implementazione di competenze transculturali relativamente al momento clinico, risulta necessario immaginare prospettive di sviluppo anche per il lavoro territoriale.
Tanto più necessarie in quanto ad una tendenza al ripiegamento ambulatoriale dei servizi si somma il rischio di un vissuto xenopatico negli operatori, con la conseguenza per l’utenza
straniera di divenire uno dei capri espiatori di carenze organizzative e conoscitive.
Questo attivo ripensamento del lavoro comunitario si rende
auspicabile, in prima battuta, per evitare che i servizi di salute
mentale si ritrovino a dover rispondere alla domanda emergenziale delle agenzie sociali deputate all’intervento assistenziale
nei confronti di alcune categorie specifiche di migranti (minori
stranieri non accompagnati, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria, donne fuoriuscite dalla tratta).
In questi casi, i dispositivi legislativi esistenti assicurano la
protezione statuale attraverso la predisposizione di una serie di
misure, fra cui l’ospitalità in strutture di accoglienza. Si creano
in tal modo comunità eterogenee dal punto di vista culturale,
artificiali nella loro costituzione ed a tempo determinato, che
sopportano l’eventuale carico traumatico dei singoli ospiti (passato), la quota di conflittualità interpersonale e/o interculturale
che si crea al loro interno nei confronti degli altri ospiti o degli
operatori che gestiscono le strutture (presente) e la pressione di
una scadenza che – amministrativamente – dovrebbe proiettare
le persone verso un inserimento nel contesto sociale allargato di
cui tuttavia rimangono aleatorie le condizioni di realizzabilità
(futuro).
È l’intera struttura della temporalità ad essere foriera di fattori di rischio capaci di incrementare la vulnerabilità di questa
quota di popolazione, essendo ciascun migrante chiamato a
10. Salute mentale di comunità. Osservazioni etnopsichiatriche
227
farvi fronte più o meno autonomamente, nell’alienazione dalle
risorse relazionali, valoriali e tecniche dei rispettivi mondi di
provenienza.
Le soluzioni problematiche trovate possono ricadere nell’autoesclusione sociale oppure nella costituzione di sottogruppi,
ad esempio su base nazionale o linguistica (acculturazione antagonistica), sostanzialmente fittizi, con comportamenti antisociali, soprattutto là dove la tendenziale desocializzazione dalle
formazioni originarie e la carente risocializzazione nel contesto
adottivo provochino l’inveramento di un’individuazione anonima e astenica (deculturazione).
In queste condizioni, l’assenza di collaborazione, anche in
senso preventivo, fra agenzie sociali e servizi di salute mentale
operanti nella comunità può facilmente produrre una domanda
di psichiatrizzazione da parte delle prime ed una risposta meramente reattiva da parte dei secondi.
2. Etnopsichiatria comunitaria
È possibile sottolineare come, almeno per quanto riguarda la
popolazione profuga e rifugiata, l’etnopsichiatria comunitaria ha
dato prova di efficacia preventiva attraverso l’attuazione di una
metodologia di intervento macro- e microgruppale, vedi l’esperienza di Badolato in Calabria descritta da Inglese (1999, 2002).
Negli interventi di accoglienza diretti a profughi e rifugiati è
richiesta una costante opera di diplomazia fra mondi eterogenei, sempre sottoposti al rischio del sospetto reciproco o della
collisione imminente.
L’esperienza in precedenza richiamata, che ha visto la partecipazione del servizio pubblico di salute mentale, mostra come
gli interventi di accoglienza possano assumere valenze preventive, oltre che terapeutiche, tali da ridurre gli effetti traumatici
della violenza collettiva e dei suoi aspetti emergenziali.
È necessario che simili operazioni vengano svolte secondo
modalità culturalmente sensibili e utilizzando tutte le risorse
228
Sergio Zorzetto e Giuseppe Cardamone
locali disponibili (istituzionali e non).
Tali interventi promuovono all’interno di uno scambio sociale allargato – anticoncentrazionario – una ricostruzione collettiva e comunitaria, a partire dalla valorizzazione dei sistemi
culturali costitutivi dei gruppi ospitati.
L’obiettivo strategico diventa quello di collocare in una posizione attiva ed autonoma coloro che vi partecipano come beneficiari e ciò è possibile cominciando dal riconoscimento delle
competenze linguistiche, personali e culturali di tutte le persone coinvolte. Parallelamente gli operatori dell’accoglienza sono
chiamati ad una pratica di mediazione verso i contesti ospitanti,
al fine di evitare il rigetto xenofobico dell’estraneo.
3. Dilatare il territorio: risorse relazionali e tecniche
Le riflessioni appena esposte muovono da specifiche categorie
giuridiche di migranti. È necessario, in seconda battuta, allargare la prospettiva e riflettere sull’inclusione del fenomeno migratorio generale all’interno delle strategie di lavoro comunitario
dei servizi.
È interessante iniziare a riflettere almeno su alcuni modi
attraverso cui la migrazione può incidere sulla salute mentale
dei migranti e sui processi sociali e culturali cui i gruppi umani
ricorrono per far fronte al male ed alla malattia.
Si tratta, in ultima analisi, di ragionare intorno al binomio
deculturazione/acculturazione come elemento dinamico ma
ambivalente dei processi culturali in corso di migrazione. Si
può così osservare come, benché distali, le reti di relazioni con
la famiglia di origine possano conservare la loro rilevanza ed
efficienza, ritrovandosi in tal modo capaci di attivarsi in caso di
evenienze critiche di uno o più dei loro componenti espatriati,
fino al ricorso alle figure terapeutiche autorizzate e riconosciute
della comunità allargata.
Si assiste, pertanto, ad una dilatazione del territorio coinvolto nel dramma psicopatologico e ad una moltiplicazione delle
10. Salute mentale di comunità. Osservazioni etnopsichiatriche
229
figure coinvolte nella cura, con ruoli che possono essere, a seconda delle situazioni, complementari o antagonisti rispetto a
quelli esercitati dagli operatori.
Tale territorio dilatato ed esteso diventa un piano su cui
scorrono comunicazioni e attraverso il quale transitano oggetti
(ad es., di protezione) e persone.
In altri casi, invece, le risorse parentali o culturali vengono
rifiutate o al contrario risultano interdette o comunque inattingibili, in relazione a processi identitari aperti ad una molteplicità di esiti.
Al riguardo, l’esperienza clinica mostra situazioni molto variegate e differenziate.
Quelle in cui si registra un’interruzione solo superficiale
della possibilità di ricorso alle risorse relazionali e tecniche del
mondo di origine in connessione a momenti di difficoltà – anche di ordine psicopatologico – della vicenda migratoria, con
ampie possibilità di lavoro nel senso di una loro riattivazione
con effetti trasformativi degli esiti clinici e sociali. Quelle, al
contrario, dove è il mondo di origine (o porzioni di esso) che si
presenta come espulsivo, minaccioso e persecutorio. Il rischio
in questi casi è che alla desolidarizzazione dai legami culturali di
provenienza si saldi una deriva sociale nei contesti di adozione.
4. Migrare di persone, migrare di forme di socialità
Non è solo il sistema familiare che tende a ricostituirsi nei luoghi di arrivo della traiettoria migratoria, benché più o meno
trasformato per via di scomposizioni e ricomposizioni a carico
delle linee di filiazione e dei processi di trasmissione provocate
dai vincoli che tale traiettoria comporta.
Anche altre forme di socialità – laica e religiosa – tendono a
migrare insieme alle persone, parallelamente alla costituzione
di forme associative almeno formalmente inspirate a modelli
autoctoni (associazioni di migranti su base nazionale/etnica o
multiculturali). Attraverso la migrazione di forme associative
230
Sergio Zorzetto e Giuseppe Cardamone
si dislocano modelli di comportamento, visioni del mondo e
risorse tecniche.
Si struttura in tal modo nel paese di adozione un panorama
sociale e culturale composito e dalle molteplici valenze.
Alcuni modelli di comportamento, ad esempio, possono risultare disfunzionali nel nuovo contesto o comunque generatori di
conflittualità sociale con l’ambiente circostante, come nel caso
dei comportamenti di uso di sostanze alcoliche da parte di alcune comunità immigrate (Mani E. - Zorzetto S. - Cardamone
G., 2009).
D’altra parte, si rendono disponibili risorse di cura di tipo
magico-religioso, popolari o sapienti, cui le persone ricorrono
in maniera parallela o alternativa rispetto a quelle offerte dai
presidi pubblici.
Queste tipologie di risorse, del resto, non sono a loro volta
esenti da processi di adattamento e scambio rispetto al contesto
in cui si inseriscono, confrontate con i nuovi problemi che questo pone: si può segnalare, in questo senso, almeno un caso in
cui all’interno di un centro religioso islamico è stato adottato il
modello dei gruppi alcolisti in trattamento (adozione di un item
culturale allogeno) al fine di rispondere a problemi di uso alcolico da parte della popolazione musulmana, rimanendo tuttavia
disconnesso dalla rete locale di tali gruppi.
5. Alterità culturale e alienità psicopatologica
La disamina dei processi di preservazione, perdita e mutazione culturale appena svolta, sebbene sintetica in considerazione della natura di questo saggio, permette di porre in risalto la
complessificazione del panorama socioculturale che i processi
migratori innescano.
Ne discende la necessità di una riflessione, argomentata e
con precisi riferimenti storico-antropologici, sul lavoro culturale intorno ai temi della salute e della malattia.
Il contributo delle discipline psicologico-psichiatriche a tale
10. Salute mentale di comunità. Osservazioni etnopsichiatriche
231
lavoro è certo rilevante, sia nel momento della costruzione di
saperi scientifici, sia nel momento applicativo, per gli effetti
complessivi che tali saperi producono sugli individui e sui gruppi (modificazioni della situazione soggettiva, interventi sulle reti
di relazioni delle persone, instaurazione di determinati regimi
discorsivi, ecc.).
Da questo punto di vista, le discipline psicologico-psichiatriche si costituiscono come produttrici di eterotopie (Foucault
M., 2006) che a loro volta ingenerano, dentro ed attorno a sé, la
costituzione di gruppi sociali variamente composti.
La riforma psichiatrica ha rappresentato, e tutt’ora rappresenta, un tentativo di rimessa in discussione di simili eterotopie:
delle dimensioni di potere che in esse vigono e dei saperi che al
loro interno si producono e riproducono.
D’altra parte, si è cercato di sostenere come esistano e continuamente si riproducano altri luoghi ed altri attori che partecipano al suddetto lavoro culturale ed una complessiva strategia
di salute mentale di comunità deve poter immaginare e intraprendere un’interazione ed un dialogo con simili luoghi e attori,
o quanto meno iniziare a considerare seriamente che, insieme
alla scienza e ai suoi rappresentanti, anche loro sono ospitati nel
medesimo spazio condiviso, pur producendo e riproducendo al
suo interno mondi alternativi, con ripercussioni sulle concezioni del male, della malattia e della sua cura.
La mancata presa d’atto di questo dato antropologico empirico e l’evitamento di una sua valutazione a livello epistemologico ha condotto e conduce le discipline psicologico-psichiatriche
a produrre effetti iatrogeni a carico di quelle persone che quei
mondi alternativi abitano (Risso M. - Böker W., 2000 [1964],
Favret-Saada J., 1977) ed effetti negativi rispetto alla possibilità di innovazioni nei loro saperi e nelle loro pratiche (Stengers
I., 1997 e 1996, Devereux G., 1984).
Il mondo magico di de Martino (1973 [1948]) rappresenta
un modo per pensare l’esistenza di simili mondi alternativi, al
cui interno le persone sperimentano specifiche modalità critiche della presenza e corrispondenti strumenti di reintegrazione
232
Sergio Zorzetto e Giuseppe Cardamone
culturale.
Il mondo magico non costituisce semplicemente una vestigia del passato italiano ed europeo, ormai interessante soltanto
dal punto di vista folklorico. Al contrario, presenta una sua capacità di vivere la storia, adeguandosi e mutando in relazione
ai cambiamenti che questa produce e continuando a costituire
una risorsa esplicativa per dare senso all’esperienza, così come
una possibilità di cura per mezzo della quale si strutturano, anche se sotterraneamente, reti di relazioni sociali intorno alle
figure terapeutiche (Favret-Saada J., 2009).
Quello che questa autrice mette in evidenza è la riproposizione in ambito antropologico-culturale ed anche negli studi
folklorici di un atteggiamento che lei stessa ha incontrato come
posizione (difensiva e di mascheramento in quel caso) nelle
persone presso cui andava strutturando la propria indagine di
campo sulla stregoneria nel Bocage: e cioè che il mondo magico
“è sempre un po’ più in là”. Nel caso della scienza questo “là”
è l’altrove geografico (i paesi extra-occidentali) oppure anche il
qui, ma in un tempo passato ormai superato e lontano.
Ma ciò che la sua ricerca mostra è, propriamente, la persistenza di tali mondi nel panorama contemporaneo così come il
loro inserimento nei processi sociali attuali, con ampie capacità
di aggiornamento dei propri costrutti e delle proprie logiche di
funzionamento. D’altra parte, come si è cercato in precedenza
di evidenziare, i flussi umani globalizzati conducono l’altrove –
e dunque anche i mondi culturali che “là” sono fabbricati e che
a loro volta fabbricano gli umani che li abitano – nel panorama
sociale occidentale, contribuendo ad una ulteriore complessificazione del paesaggio di visioni della salute e della malattia,
di pratiche ad esse connesse e di reti di relazioni attraverso cui
queste ultime vengono attuate.
Progressivamente i servizi di salute mentale stanno prendendo atto di quanto i flussi migratori internazionali influenzino il
lavoro clinico ed extra-clinico non solo, o non tanto, in quanto
fattore di rischio psicosociale, ma anche, e forse soprattutto, in
quanto fattore culturale di perturbazione degli assetti conosci-
10. Salute mentale di comunità. Osservazioni etnopsichiatriche
233
tivi ed operativi consueti in dotazione agli operatori.
La perturbazione, di certo, investe le stesse categorie di giudizio adoperate e, in ultima analisi, il concetto stesso di realtà (de Martino E., 1973 [1948]), esattamente nel momento in
cui mondi eterogenei – incarnati dai rispettivi rappresentanti
seppure collocati in ruoli diversi della scena clinica (quello di
paziente e quello di terapeuta) – vengono in contatto.
Quando questi mondi eterogenei e le rispettive realtà vengono in contatto, ciò che rischia sempre di prodursi è che «un
difetto di umanità della coscienza storica, un suo limite interno,
viene ipostatizzato nel magico: invece di scoprire il lato negativo di un pensiero che non riesce a comprendere, si considera
come negativo, come non dotato di vera realtà storiografica,
l’oggetto incompreso» (de Martino E., 1973 [1948], p. 164).
La mancata assegnazione di un dato fenomeno (sensazione,
percezione, spiegazione, ecc.) ad una specifica modalità dell’esserci radicata in uno specifico mondo culturale, e secondo le logiche di questo fabbricata, produce “boria culturale” o astenia
scientifica, da una parte, e in ogni caso degradazione dell’alterità a follia o mera superstizione e creduloneria dall’altra (controtransfert culturale).
La lezione demartiniana, pur lasciando tracce che saranno
riprese parzialmente in seguito nell’etnopsichiatria italiana, non
è riuscita ad innervare la psichiatria riformatrice nel momento
in cui il modello manicomiale veniva messo radicalmente in crisi e, con il suo superamento, si dava avvio alla nascita dei servizi
su base territoriale, nonostante la possibilità di confrontarsi con
la molteplicità dei modelli culturali autoctoni riguardo alla malattia ed alla cura, seppure popolari e subalterni. Va ricordata,
in questo contesto discorsivo, la singola esperienza descritta nel
volume di Corino, Tavolaccini e Verrua (1976), rimasta unica
nel panorama italiano sia nei suoi aspetti epistemologici che
di programmazione e gestione dei servizi sanitari operanti sul
territorio. Semplicemente si può sostenere che la cultura popolare italiana fu guardata con distacco, se non proprio ignorata,
nell’ambito dello sviluppo di modelli di presa in carico alterna-
234
Sergio Zorzetto e Giuseppe Cardamone
tivi a quello asilare (Cardamone G. - Inglese S. 1996).
L’ostracismo cui andò incontro de Martino rispecchia, a
livello del dibattito culturale e politico, un atteggiamento generale rispetto alle logiche dei mondi culturali subalterni ed
alle prassi e vissuti ad esse sintonici, che ha avuto ed ha ampia
diffusione nei servizi pre- e post-riforma, anche se ovviamente
esistono significative eccezioni (tra queste ricordiamo Harrag,
2007, Taliani S. - Vacchiano F., 2006).
L’errore potrebbe non essere considerato tale, o al più semplicemente veniale, se alla postura ideologica non conseguisse
una prassi che corre sempre il rischio di tramutare un’alterità
culturale in un’alienità psicopatologica o, comunque, di misinterpretare il senso psicopatologico di un comportamento o di
un insieme sintomatico (Risso M. – Böker W., 2000 [1964],
Zorzetto S. et al., 2002). E se, inoltre, non ne discendesse l’elisione di prospettive possibili nell’ambito del lavoro territoriale
e comunitario in salute mentale.
La presa in considerazione della dimensione antropologica della salute mentale, richiede una riflessione sui processi di
scambio o, viceversa, di chiusura conseguenti al contatto fra le
discipline psicologico-psichiatriche ed i saperi non-scientifici
(religiosi, tradizionali, ecc.) a cui sono connesse pratiche di
cura.
6. Le strategie di delimitazione del campo di lavoro: il caso
delle CBS
Uno di noi ha già osservato come esistano, da parte degli operatori della salute mentale, delle strategie attive – benché implicite – di delimitazione del proprio campo di lavoro (Cardamone
G. – Schirripa P., 1994 e 1997).
Osservando l’azione di cura dei servizi si possono individuare azioni di demarcazione che segnalano e riproducono una
frontiera al cui interno vigono determinate conoscenze e modi
di espressione della soggettività che vi si confanno.
10. Salute mentale di comunità. Osservazioni etnopsichiatriche
235
Si tratta, cioè, di un’azione disciplinare che stabilisce quali siano i vissuti, le pratiche ed i saperi ammessi e quali gli esclusi.
Sebbene si verifichino di continuo delle infrazioni alla disciplina, attraverso l’azione di spoletta fra mondi esercitata dagli
utenti (attraverso i loro sintomi, le loro parole ed i loro comportamenti), le demarcazioni mirano a mantenere l’ordine a scapito
della conoscenza e dell’innovazione disciplinare.
Le azioni di demarcazione hanno come conseguenza non
solo la tendenziale esclusione dei sistemi di cura religiosi o “tradizionali” dalla gamma degli interlocutori nel lavoro territoriale
dei servizi di salute mentale, ma il loro effetto si esercita anche
sulle modalità e forme della sofferenza dei pazienti allorquando
inscritte all’interno di regimi discorsivi alternativi a quelli ammessi (Inglese S. – Cardamone G. - Da Prato M., 2008).
Ciò che si produce è l’esposizione delle pratiche scientifiche
della cura al rischio della battaglia ideologica rispetto ad altri
ricorsi terapeutici esistenti e la moralizzazione del rapporto con
gli utenti e la società nel suo complesso (Stengers I., 1997).
D’altra parte, l’isolamento fra culture e fra gruppi è una pratica
difficile da realizzare, anche quando effettivamente perseguita
o semplicemente dichiarata.
Senza soffermarsi su come vengono gestite le conoscenze
provenienti dalle farmacopee tradizionali, si pensi al lento percorso che ha condotto dalle prime descrizioni di forme morbose
esotiche all’inserimento delle Culture Bound Syndromes (CBS),
all’interno della quarta edizione rivista del manuale diagnostico
dell’Associazione Psichiatrica Americana (DSM-IV TR).
Quello che si è verificato è un adattamento tecnico a fini
diagnostici, terapeutici e di ricerca prodotto – ed in qualche
modo obbligato – dall’incontro della psichiatria con altri mondi
culturali.
Ciò non significa, per altro, che l’adattamento tecnico non
possegga parallelamente anche finalità politiche: ad esempio,
quella di massimizzare la diffusione di un simile strumento conoscitivo, aumentandone la pertinenza per altri contesti geoculturali (per i clinici che in esso operano e per i pazienti che da
236
Sergio Zorzetto e Giuseppe Cardamone
essi provengono).
L’adattamento tecnico si configura come un affinamento degli strumenti conoscitivi e di intervento al fine di rispondere ad
un problema nuovo, ma è anche un sottoporre a lavorazione
l’oggetto che attraversa i confini della disciplina per giungere
infine ad essere accolto al suo interno.
Le CBS, infatti, non sono solo fenomenologie morbose riscontrabili in determinate popolazioni e passibili di assimilazione a diagnosi descrittive.
Sono, soprattutto, costrutti complessi, conosciuti e riconosciuti da quelle stesse popolazioni che ad essi assegnano uno o
più nomi.
Tali nomi rinviano a saperi (eziologici ad esempio), modi di
fare, pratiche diagnostiche, interventi terapeutici e mitologie.
A ben vedere, si è assai lontani dalla modalità di costruzione
dell’edificio nosografico psichiatrico, caratterizzata da una lenta
opera di distinzione e di battesimo degli insiemi sindromici individuati con nomi che ne esprimessero il senso fenomenologico, eziopatogenetico e/o prognostico1 o che semplicemente ne
riconoscessero la paternità. In questo caso, sono interi oggetti
– ad un tempo empirici e teorici, incarnati nel singolo e rappresentati collettivamente – che vengono assimilati all’interno
della nosografia psichiatrica, seppure relegati in una posizione
marginale.
La modalità di assimilazione delle sindromi culturalmente
caratterizzate in quanto semplici fenomenologie morbose, d’altra parte rischia di far dimenticare che si tratta di realtà empiriche inserite in una cultura vissuta e agita da una pluralità
di attori e da essi costruita: non solo le persone sofferenti che
a tali fenomenologie danno corpo, ma anche i loro familiari e
vicini che condividono con loro ethos e visioni del mondo e
della malattia, insieme alle figure tecniche deputate alla cura ed
1. L’andamento ciclico della psicosi maniaco-depressiva, il senso psicopatologico della Spaltung nella schizofrenia o il destino degenerativo della
demenza precoce.
10. Salute mentale di comunità. Osservazioni etnopsichiatriche
237
all’interazione con le forze invisibili.
Rischia di far dimenticare quell’insieme di relazioni definibili, almeno descrittivamente, come comunità e quelle potenzialità di elaborazione culturale che tutti i gruppi umani esprimono.
Le migrazioni internazionali offrono, pertanto, ai servizi
pubblici di salute mentale operanti nella comunità la possibilità
di pensare la dimensione culturale della cura e di aprirsi ad un
territorio riscoperto nella sua dimensione antropologico-culturale, oltre che nei suoi aspetti sociologici, politici o urbanistici.
Giuseppe Cardamone e Michela Da Prato
11. Salute mentale e migrazioni.
Ipotesi esplicative per il binomio
Metalogo 1: fallacia dei principi esplicativi
METALOGO
Che cos’è un istinto (parte 1)
Figlia: Papà, che cos’è un istinto?
Padre: Un istinto, tesoro, è un
principio esplicativo.
Figlia: Ma che cosa spiega?
Padre: Ogni cosa… quasi ogni
cosa. Ogni cosa che si voglia spiegare con esso.
Figlia: Non dire sciocchezze. Non
spiega la forza di gravità.
Padre: No. Ma è così perché nessuno vuole che l’istinto spieghi la
forza di gravità. Se qualcuno volesse, la spiegherebbe. Si potrebbe
semplicemente dire che la luna ha
un istinto la cui forza varia in maniera inversamente proporzionale
al quadrato della distanza.
Figlia: Ma non ha senso, papà.
Padre: Si, d’accordo. Ma sei tu che
hai tirato fuori l’istinto, non io.
Figlia: D’accordo… ma allora che
cos’è che spiega la forza di gravità?
Padre: Niente, tesoro, perché la
forza di gravità è un principio esplicativo.
Figlia: Ah.
240
Giuseppe Cardamone e Michela Da Prato
Questa prima parte di uno dei più conosciuti metaloghi di
Gregory Bateson (2007 [1976]: 70) ben ci introduce ad una
versione critica delle spiegazioni che, in tempi remoti e non
solo, sono state prodotte intorno al binomio “salute mentale” e
“migrazione”.
Nello specifico, la presenza di disturbi di tipo psicologicopsichiatrico è stata considerata alla stregua di un principio
esplicativo che poteva giustificare la migrazione stessa di un
individuo. Così come la migrazione, in un secondo posizionamento, poteva essere individuata come principio causale e primario rispetto all’insorgenza di problemi di salute mentale. Per
lungo tempo gli studi intorno a questo oggetto hanno oscillato
tra queste due polarità causali, pensate e articolate in maniera
pressoché lineare e diretta per cui, in sintesi, “la migrazione è la
causa di un disturbo psichico” verso “la migrazione è l’espressione di un disturbo psichico”1.
Gli studi che interessano la prima posizione sono alquanto
eterogenei ed accompagnano, tuttora, la mole di lavori che cercano di far luce sulla relazione esistente tra questi due termini
appartenenti ad ordini discorsivi diversi, quello clinico della
“salute mentale” e quello che potremmo condensare all’interno
dell’etichetta “sociale” della “migrazione” (presentandosi, in
realtà, come un oggetto di lavoro polimorfo e multiplo che assume in sé le coordinate relazionali personali e familiari, comunitarie e gruppali, sociali e culturali, geopolitiche). Dettaglieremo
in un secondo momento questo tipo di relazione che, più che
causale, oggi potremmo definire di co-occorrenza (modificando
sostanzialmente il tipo di associazione e legame che può connettere i termini del discorso): quando la migrazione si installa
violentemente nella vita di un individuo e di un gruppo familiare come momento di rottura o interrogazione, anche positiva e
fruttuosa, dell’assetto pre-esistente.
Per quanto riguarda la seconda posizione, ne sono un’espres1. Ad esempio il contributo di Johannes Hofer, Dissertatio medica de Nostalgia, in Hernst F. 1949.
11. Salute mentale e migrazioni. Ipotesi esplicative per il binomio 241
sione conosciuta, ad esempio, gli studi e i resoconti di Achille
Foville2 figlio, direttore del manicomio “Quattro mari” di Le
Havre, che descrisse nel 1875 quattordici casi di individui migranti da lui definiti ‘lipemaniaci’ (‘affetti’ da follia melanconica, allucinazioni croniche, delirio con idee di persecuzione
ecc.), individuando nel viaggio e nella migrazione l’espressione
diretta di un disturbo mentale. La figura del ‘migrante alienato’
diventa con il tempo il principio esplicativo più accreditato per
spiegare i fenomeni migratori, esiti e risultanti di tare o difetti
genetici. Alcuni autori si orientarono verso questa ipotesi, come
lo psichiatra norvegese Ørnulv Ødegard3 che ipotizzò negli anni
Trenta del secolo scorso una personalità schizoide di base che
avrebbe innescato la spinta al migrare. Questa posizione rimase
forte e generativa anche da un punto di vista clinico nonostante
le discordanze e contraddizioni dei risultati delle indagini sperimentali e le successive critiche metodologiche (ad esempio, sui
campioni di studio individuati e indagati).
È soprattutto nella seconda metà del Novecento che compaiono in maniera più determinante i tentativi di ribaltare i termini del discorso, non più l’effetto psicopatologico racchiuso
nell’immagine del “migrante alienato”4 ma l’ipotesi di un effetto contrario, del tipo “migrante sano”, secondo il quale sarebbe
proprio la migrazione ad intervenire in termini distruttivi e patogeni in individui partiti dal paese di origine in buona condizione di salute psico-fisica.
È all’interno di questa impostazione che prendono forma
altri principi esplicativi come quelli conosciuti e diffusi dello
shock culturale, del goal striving stress e dell’acculturazione5.
L’ipotesi parziale dello shock culturale evidenzia il carattere
dirompente e brutale dell’impatto della migrazione (in termini
2. Foville A., 1875.
3. In Häfner H., 1987.
4. Si vedano i contributi di Frigessi Castelnuovo D. - Risso M., 1982,
Frigessi D., 1993.
5. Per un approfondimento si veda Zorzetto S. – Inglese S. – Da Prato
M. – Cardamone G., 2002a, Cardamone G. – Inglese S. – Zorzetto S., 1999.
242
Giuseppe Cardamone e Michela Da Prato
di sradicamento, spaesamento, fragilizzazione e vulnerabilità),
l’ipotesi parziale del goal striving stress narra degli effetti più
dilatati nel tempo dell’impossibilità nel realizzare gli obiettivi
del progetto migratorio, quando l’individuo è posto di fronte
alle difficoltà materiali sul piano lavorativo, relazionale e sociale
(così come quando l’individuo riesce effettivamente a realizzare
gli obiettivi prefissati e si apre un mondo di tensioni e distanze
“pericolose” con il gruppo dell’origine). Le evidenze cliniche
mostrano quanto il disturbo psichico del migrante sia connesso
ad un’esperienza di rottura, avendo a che fare con un’identità
spesso fratturata dalla migrazione in contesti culturali diversi da
quelli d’origine. Si tratta di una frattura insanabile ed impensabile, nucleo dell’esperienza che deve poter diventare anche un
punto decisivo nella clinica, quando ci aspettiamo di svolgere
un intervento psicoterapeutico in senso stretto che presuppone
la “pensabilità” dei propri conflitti. La domanda di aiuto del
migrante si presenta con i caratteri della provvisorietà, perché
provvisorio nel tempo è percepito il progetto migratorio, come
instabile e precaria è spesso la sua condizione lavorativa e la
possibilità concreta e fattiva di raggiungere gli obiettivi sperati.
Ed anche precaria diventa la sopravvivenza della sua identità,
in perdurante conflitto tra il contesto di appartenenza e quello
adottivo: questa particolare “situazione” di provvisorietà spesso finisce per diventare permanente.
La terza ipotesi esplicativa, complessa sul piano della discussione teorica e delle implicazioni cliniche, definisce l’acculturazione come un potente motore disarticolante l’identità dell’individuo migrante, nel suo lento ma inesorabile movimento di
apparentamento problematico con il luogo di nuova residenza.
Non è questa la cornice esaustiva nella quale collocare il dettaglio di questi spunti, richiamati in particolare per la loro funzione di “ipotesi esplicative”, come suggerito dal metalogo citato
da Bateson: spiegazioni, ipotesi, per definizione parziali e modellizzazioni spurie che hanno tentato di dire qualcosa intorno
all’impatto di un fenomeno-esperienza sulla vita di qualcuno,
o viceversa, sull’impatto della componente personologica nel
11. Salute mentale e migrazioni. Ipotesi esplicative per il binomio 243
verificarsi ed attuarsi del fenomeno-esperienza del migrare.
Ciò che lega entrambe queste posizioni, chiaramente ben
distinte tra loro, è la necessità riscontrata di mettere in correlazione stretta due termini di un discorso che appartengono, in
verità, a domini altrettanto distinti. È la necessità di trovare il
punto di partenza, di stabilire un vettore, che possa collegare
insieme due proposizioni che la storia del pensiero psicologico
e, soprattutto, psichiatrico ha voluto giustapporre.
Su questo punto avremo modo di ritornare, dopo aver ricevuto una ulteriore suggestione dal già citato metalogo batesoniano.
Metalogo 2: complessità epistemologica della salute mentale in migrazione
Che cos’è un istinto (parte 2)
Figlia: Vuoi dire che non si può
usare un principio esplicativo per
spiegarne un altro? Mai?
Padre: Uhm… quasi mai. Questo è
ciò che Newton intendeva quando
diceva “hypotheses non fingo”.
Figlia: E che cosa vuol dire?
Padre: Bè, sai che cosa sono le ipotesi. Ogni proposizione che colleghi
tra loro due proposizioni descrittive
è un’ipotesi. Se dici che il 1° febbraio c’era la luna piena e che il 1°
marzo c’era di nuovo, e poi colleghi
queste due proposizioni in qualche
modo, la proposizione che le collega è un’ipotesi.
Figlia: Si, e so anche che cosa vuol
dire non. Ma fingo che cosa vuol
dire?
Padre: Bè… fingo è un termine
244
Giuseppe Cardamone e Michela Da Prato
della tarda latinità che significa
‘fabbrico’. Da esso si forma un sostantivo, fictio, da cui proviene la
parola ‘finzione’, che oggi è spesso
intesa come ‘fabbricazione non
vera’.
Figlia: Papà, vuoi dire che il signor
Isaac Newton pensava che tutte le
ipotesi fossero solo fabbricate come
le storie?
Padre: Si… proprio così.
Figlia: Ma non è stato lui a scoprire
la gravità? Con la mela?
Padre: No, tesoro, l’ha inventata.
L’ipotesi di una correlazione tra “problemi di salute mentale”
e “l’essere migranti” trova chiaramente una sua collocazione
legittima nelle pieghe dei racconti delle persone che, come clinici o operatori impegnati nell’ambito di cui stiamo discutendo, ascoltiamo e lavoriamo come materiale prezioso e denso,
abitato da una pluralità di oggetti e esseri, non sempre umani,
come negare la “presenza” dell’esperienza di migrazione, e la
conseguente delocalizzazione geografica e culturale, nelle storie
di disagio o di agio di chi la sta vivendo o l’ha vissuta?
La questione più radicale che, in questo contributo, vorremmo mettere in evidenza è, fondamentalmente e squisitamente,
una questione di posizionamenti, ovvero, in che termini e con
quale intenzione di fondo si intenda studiare e lavorare questa
“presenza” di senso e di nesso.
Mentre in passato il senso e il nesso si erano installati come
principi causalistici, è ormai da tempo che la maggior parte dei
punti di vista sulla questione è attenta alla pluralità e molteplicità dei discorsi che intorno a quel famoso binomio si agitano e
manifestano.
Si sono inventate altre e altrettanto complesse ipotesi esplicative.
11. Salute mentale e migrazioni. Ipotesi esplicative per il binomio 245
E allora, come è stato giocato - in questo ambito di interesse - il
confine tra “invenzione/fabbricazione di ipotesi” e “scoperta di
una realtà oggettiva”?
Per procedere nel nostro ragionamento abbiamo bisogno di
articolare la formulazione di tre passaggi fondamentali, che potremmo così definire e condensare:
1. la necessità di far emergere gli ordini discorsivi ai quali i
nostri termini appartengono,
2. la necessità di controbilanciare il peso dell’oggetto studiato con il peso del soggetto che studia (la dinamica ricorsiva
tra sistema osservato e sistema osservante),
3. la necessità di alleanze epistemologiche (tra discipline e
saperi, tra persone “supposte sapere”).
Abbiamo già introdotto la criticità di connettere e “vedere insieme” due nuclei operazionabili provenienti e sostanziati da
ordini discorsivi differenti. Quando parliamo di ‘ordine discorsivo’ ci riferiamo al contributo di Michel Foucault intorno a
due aspetti per noi cogenti (Foucault M., 1966, 1971): la questione dei codici fondamentali di una cultura che impongono
un ordine all’esperienza umana, le strutture dei discorsi delle
varie discipline che hanno costruito teorie e detto qualcosa sulla
società, sugli individui e sul linguaggio, andando così a fondare
attraverso regolarità discorsive i principi costitutivi di un sapere
diffuso e condiviso da una comunità (anche scientifica).
Relativamente al primo aspetto, si fa allora interessante l’indagine sull’esperienza nuda dell’ordine e dei suoi modi d’essere e come questa si intrecci (inscindibilmente) con le pratiche
discorsive e ricorsivamente organizzate di una comunità, o del
singolo pensato comunque come parte di una comunità. Questa
prima riflessione ci permette di collegare l’attenzione posta dal
clinico su un “individuo-in-(più di una) comunità” all’interno
di un approccio alla salute mentale su base comunitaria, a partire da una data metodologia, da peculiari aspetti tecnici, da
un’intenzione che sia anche politica. Non si potrà lavorare nelle
246
Giuseppe Cardamone e Michela Da Prato
società multiculturali esimendosi dal considerare le “forze” e
“pressioni” comunitarie, sempre presenti anche laddove esse
fossero latenti o retrostanti ai fenomeni osservati. Parliamo così
di un lavoro che mette insieme i territori, le zone di frontiera,
gli oggetti reali delle comunità di appartenenza dei migranti e di
quelle adottive. D’altra parte, si può ritenere che la malattia - o
il benessere - non sia mai un affaire privato ma un problema di
interesse sociale e comunitario.
Relativamente al secondo aspetto, declinato nell’ambito del
nostro intervento, è cruciale poter pensare e analizzare criticamente le discipline psicologico-psichiatriche come discipline/
discorsi e saperi forti che si sono collocati nella posizione di
esercitare un potere consensuale sull’uomo, stabilendo un confine tra il modo del sano e dell’insano, stabilendo categorie di
riferimento e tassonomie accreditate da una parte di mondo
(una comunità scientifica che ha fabbricato teorie ed ipotesi
esplicative oltre che descrittive, entrate a far parte anche di un
sentire comune e non specialistico). Una forza e un potere che
non sono sostanzialmente modificate dall’introduzione della
rubrica delle Culture-bound Syndromes (Inglese S. – Peccarisi
C., 1997, Cardamone G. – Inglese S. – Zorzetto S., 1999).
A questo punto del nostro ragionamento è indispensabile
rivedere i termini in oggetto, passando alla seguente ulteriore
giustapposizione: “discipline-istituzioni psi” e “migranti”. Si è
compiuto così un primo aggiustamento, sostituendo il termine
diffuso di “salute mentale” con quello della disciplina che, presso di noi, è deputata ad interagire e intervenire. Solo apparentemente si può mostrare come un cambiamento vezzoso, diventa
evidentemente sostanziale, quando pensiamo che si è sostituito
un oggetto di studio che si presume risiedere nella persona (lo
stato di salute o malattia) con il soggetto che solitamente è deputato a studiarlo (la teoria e la lente che orienta lo sguardo).
Siamo così al secondo passaggio che fa dialogare il sistema
osservato (il migrante, la migrazione, il contatto tra culture, lo
stato di salute ecc.) con il sistema osservante (le discipline psicologico-psichiatriche e, per estensione, il punto di vista teorico
11. Salute mentale e migrazioni. Ipotesi esplicative per il binomio 247
e metodologico di turno).
Si tratta, quindi, di passare da una netta distinzione tra un
Io e Tu, un Noi e Voi, un Soggetto e un Oggetto ad una scomoda ma più adeguata riflessione sulla relazione che si installa
tra più sistemi che si incontrano e interfacciano. E la relazione
che si dispiega ha il carattere della perturbazione reciproca tra
osservatore ed osservato, accadimento - la perturbazione - che
diventa il perno dell’interesse.
In questo gioco al rialzo e rispettoso della complessità epistemologica esistente, una disciplina come la psichiatria non
può essere da sola a condurre l’operazione.
Dal nostro punto di vista questo passaggio fondamentale è
inaugurato con rigore e coerenza da Georges Devereux (1967,
1970), padre dell’etnopsichiatria teorica, che già nella sua formazione personale e professionale ha portato in sé il senso incarnato di una profonda molteplicità: fisico, etnologo, psicoanalista, pianista, grecista, Gheorghe, Georg, György, Gyuri,
George e infine Georges, i nomi usati per presentarsi e farsi
conoscere, a seconda dei paesi attraversati.
L’idea della necessità di una molteplicità di punti di vista su un oggetto osservato o studiato trae spunto dalle leggi
della Fisica Quantistica e il Principio di Indeterminazione di
Heisenberg, secondo questo ultimo Principio, due grandezze
come la velocità/movimento e la massa/posizione (relative, ad
esempio, a particelle luminose) non sono osservabili e misurabili contemporaneamente, e la misura dell’una genera incertezza
nell’altra. Le due misurazioni, che si accoppiano, daranno una
descrizione/spiegazione esauriente di porzioni del problema
posto alla base dell’analisi, e saranno valide entrambe.
Affiancando questo modo di procedere al comportamento
umano (e alle scienze che lo studiano e pretendono di dirne
qualcosa) ciò ha significato iniziare a pensare alla possibilità di
spiegare in termini esaustivi un fenomeno o un comportamento
umano almeno in due modi, ognuna delle funzioni conoscitive e
delle risultanti sarà ugualmente valida all’interno di un dominio
parziale e ben delineato. È il complementarismo che si andrà
248
Giuseppe Cardamone e Michela Da Prato
a collocare come generalizzazione metodologica, e l’apertura
necessaria delle discipline psicologico-psichiatriche alla collaborazione e al coordinamento con discipline come l’etnologia.
Abbracciare questo principio metodologico ha significato in
prima battuta muoversi pensando ai comportamenti umani (e,
in clinica, alle problematiche “psi”) come ordinati a partire da
una molteplicità di principi organizzatori, e per questo, ‘descrivibili’ e ‘spiegabili’ a partire da una molteplicità di categorie
esplicative (ipotesi esplicative pertinenti non tanto - o non solo
- rispetto all’oggetto quanto rispetto alla disciplina di riferimento). In seconda battuta, ciò ha significato introdurre una riflessione intorno alla dimensione del potere e dell’egemonia della
psichiatria occidentale nella sua affermata capacità di cogliere i
segreti dell’animo umano come se l’umano fosse universalmente declinato in un’unica forma, struttura e sostanza.
Altri autori, come lo stesso Gregory Bateson percorrendo
altre strade, hanno parlato della mente (il presunto oggetto
del contenzioso, quando parliamo di problematiche di salute
mentale) come un processo interattivo in cui il complesso del
sistema evolutivo che interessa non è più l’organismo in senso
stretto ma esso nel suo ambiente, nel suo contesto, la stessa nozione di mente o di psiche come qualcosa che appartiene all’individuo e che “sta nella sua testa” non regge di fronte, invece,
all’idea che essa sia il prodotto di interazioni tra elementi ed
unità ricorsivamente connessi tra loro.
In questa produzione, dobbiamo aggiungere come protagonista partecipante il sistema di pensiero stesso che “dice qualcosa” e “sa”, sia esso il pensiero delle scienze occidentali che
si è auto-eletto come sistema razionale e scientifico, siano esse
i sistemi molteplici e le visioni dell’uomo, della malattia e della
cura.
È attraverso la via regia del complementarismo e dell’indeterminazione che arriviamo al terzo passaggio postulato, ovvero la
necessità di creare alleanze epistemologiche prima ed operative
poi, tra discipline e saperi, tra persone “supposte sapere”.
Riferendosi nello specifico al tema del nostro contributo,
11. Salute mentale e migrazioni. Ipotesi esplicative per il binomio 249
ne consegue che una buona prospettiva orientata al luogo che
si apre avvicinando i termini “salute mentale” e “migrazione”
debba poter agire ed osservare tenendo fermi i seguenti vincoli
conoscitivi:
- il filo sottile ma sostanziale che lega insieme chi/cosa è
osservato e chi osserva (sia esso un clinico, un ricercatore,
uno sperimentatore delle cosiddette hard sciences),
- la parzialità, la non neutralità, la non esaustività di ciascuna teoria, modello, strumento o prospettiva adottata,
- la necessità di aprire un dialogo e un dibattimento aperto, nel caso degli umani, con i sistemi di idee e di oggetti che
li hanno fabbricati.
Si afferma così una conoscenza localmente situata e posizionata
in coordinate ben definite, una fabbricazione di ipotesi esplicative che hanno necessità di accoppiarsi con quelle prodotte da
altri saperi, e questo si struttura come un procedimento interessante anche, e soprattutto, in campo clinico.
Nell’ambito dei saperi intorno alla psicopatologia, così come
è intesa dalla psichiatria globalizzata e accreditata da un punto di vista accademico, questa démarche implica la necessità di
dialogare non tanto con un uomo universale o statisticamente
inquadrabile, ma con i gruppi e i collettivi, oltre ai singoli individui, all’interno dei quali quello specifico uomo possa mantenere un posto (utilizzando questa sua appartenenza ad una
storia e ad un luogo come punto di riferimento per orientare la
pratica clinica). È implicato, pertanto, un modo di procedere
che non esclude dal suo interesse tutte le forme di intervento
sull’umano (le terapeutiche tradizionali) che si collocano a lato
del territorio globalmente accreditato (da una comunità ristretta, quella accademica e scientifica), e che possa così rinunciare al concetto di ‘psiche’ così come comunemente la intende
(Nathan T. 1998).
Questo ribaltamento, che è prima di tutto epistemologico e
di concerto metodologico, pone grossi interrogativi alle nostre
250
Giuseppe Cardamone e Michela Da Prato
discipline cliniche, ne forza i confini e i saperi, le tecniche e le
teorie di riferimento, i sistemi esplicativi e le ipotesi eziologiche. Spesso vuol dire forzare e mettere in uno spazio pubblico
di commento ciò che generalmente è considerata una “realtà
di fatto” mentre, dal nostro punto di vista, può essere meglio
ridefinita nei termini di “principio esplicativo”, fabbricato da
qualcuno (anche un gruppo), parte di un ordine discorsivo ben
situato e storicamente consolidato. Ne sono un esempio l’uso
di nozioni-strumento come “intrapsichico”, “psiche” oppure lo
stesso “inconscio”. Riformulando la suggestione apportata dal
metalogo di Gregory Bateson, alla stregua della “gravità”, anche l’intrapsichico, la psiche oppure l’inconscio sono invenzioni
piuttosto che scoperte o realtà di fatto.
Su questa linea, è chiaro che le pratiche, gli oggetti, le idee,
le prospettive portate dai migranti nei racconti che fanno al
mondo ospitante non potranno essere considerate in termini
di “credenza”, piuttosto in termini di altre ipotesi esplicative
fabbricate e inventate, altrettanto parziali ma pertinenti, alla
stregua di quelle prodotte da chi ascolta.
È il passaggio stesso che l’antropologia medica evoluzionista
e funzionalista ha dovuto compiere per affrancarsi dall’utilizzo di concetti quali “credenza”, “superstizione”, “pre-logico”,
“selvaggio”. Contributi successivi sono stati ridefiniti a partire
da una prospettiva interpretativa che tenesse conto della narratività e modalità discorsive. Ma questa battaglia non si è giocata
(e non si gioca tuttora) sul piano delle discipline, ma inesorabilmente sul piano del confronto tra consorzi umani: storicamente, almeno nella parte di mondo alla quale apparteniamo, la
credenza è entrata nella matrice collettiva come stato inferiore
e incompatibile con la conoscenza, è ciò che differenzia “chi
crede” da “chi sa”, il “non vero e mitico” dal “vero e certo”.
L’esperienza di Tobie Nathan nell’ambito dell’etnopsichiatria clinica ben ha evidenziato questo scarto, questo ribaltamento di prospettiva e metodologia di lavoro, non agendo all’interno di una dualità pensiero-credenza.
E questo è il presupposto per promuovere e praticare alleanze
11. Salute mentale e migrazioni. Ipotesi esplicative per il binomio 251
epistemologiche e collaborazioni che possano effettivamente
dire qualcosa di pertinente anche intorno a ciò che accade a
un individuo, alla sua famiglia e al suo collettivo posti di fronte
all’esperienza della migrazione, nel punto-momento dell’incontro con il sistema istituzionale e disciplinare del paese che abita.
A partire dalla nostra prospettiva, si tratta anche di decidere
per una collocazione etica, e in qualche sorta politica, intorno
alle questioni che riguardano il posto che i paesi di origine dei
migranti hanno in seno alle società cosiddette di accoglienza.
Il movimento che un orientamento etnopsichiatrico propone,
infatti, è coerente con un principio di distribuzione dei poteri,
delle forze e delle capacità/competenze dei gruppi umani, in
clinica, ciò corrisponde ad un progressivo interessamento per
i dispositivi tecnici di intervento da questi costruiti ed utilizzati (Nathan T. 1996). Così anche Devereux, ribaltando il focus
di interesse clinico sul transfert, ha postulato il controtransfert
come terreno di studio più proficuo (Devereux G., 1984).
Nel nostro paese non è per niente nuovo il richiamo ai sistemi terapeutici tradizionali, basti pensare ai contributi di de
Martino (1959, 1975, 1977) o di Risso e Böker nei rispettivi ambiti di interesse: etnologia e clinica (dei migranti) si intrecciano
in una affascinante esperienza che possiamo spingere oltre le
categorie di credenza, superstizione, irrazionale. Laddove i fatti e i feticci, secondo Latour (2001 e 2005), combinati insieme
nel neologismo fatticci mostrano l’atto di fabbricazione comune
che li rende entrambi veri e attivi, la verità dei cosiddetti fatti
come la verità dei cosiddetti spiriti.
Riteniamo che tutto il fervente movimento di idee, spesso
anche conflittuali e dissonanti, che si è mosso intorno alla clinica di ispirazione etnopsichiatrica ben rappresenti e interpreti
quel posizionamento epistemologico che è necessario e fondamentale per costruire e condurre interventi adeguati e efficaci
nell’ambito della clinica con i migranti. Non è questa la sede
per discutere nel dettaglio le potenti implicazioni metodologiche che questo posizionamento richiede e si rinvia in particolare ai contributi di base di Tobie Nathan (ad esempio, Nathan
252
Giuseppe Cardamone e Michela Da Prato
T., 1990, 1994, 1996, 2001, 2005) e ad alcuni testi introduttivi
scritti sull’argomento (Coppo P., 1996 e 2003, Cardamone G.,
2006).
Una implicazione importante, contenuta nel ragionamento
che in questa sede abbiamo voluto punteggiare, riguarda la declinazione di una data prospettiva interpretativa e metodologica in forme istituzionali di presa in carico, tra l’intenzione psicoterapeutica e un approccio cosiddetto ‘di comunità’ (Bracci
F. – Cardamone G., 2005, Cardamone G. - Bracci F. – Da
Prato M. - Zorzetto S., 2005, Cardamone G. - Da Prato M. Zorzetto S., 2005, Cardamone G. - Da Prato M. - Zorzetto
S., 2007, Harrag, 2007, Zorzetto S. - Da Prato M. - Inglese
S. - Cardamone G., 2001 e 2002a, Inglese S. - Cardamone G.,
1996).
Le alleanze epistemologiche, in definitiva, devono potersi
tradurre in prassi adeguate e predisposte all’emersione delle
collettività coinvolte (quelle dei clinici, quelle dei pazienti migranti e dei loro consorzi di umani e non umani). L’incontro
che si genera impone un ripensamento continuo del proprio
modo di lavorare, che sembra non poter più contare né su un
linguaggio condiviso, né su modi codificati di gestire la relazione terapeutica: esiste un modo culturalmente determinato di
impostare la relazione terapeuta-paziente, esistono costruzioni
sociali ed attese implicite pertinenti la malattia, il terapeuta, la
guarigione e queste sono condivise all’interno di specifici gruppi umani.
Salvatore Inglese
12. Sindromi culturalmente caratterizzate
(Culture-Bound Sindromes)
1. Costellazioni sintomatiche particolari
Le classificazioni descrittive della psichiatria contemporanea
hanno sempre patito la difficoltà di posizionare per mezzo di
algoritmi decisionali costellazioni sintomatiche particolari, ricorrenti in alcune società ma infrequenti o inesistenti nelle altre (Leff J., 1988, Littlewood R. e Lipsedge M., 1987). Tali
configurazioni psicopatologiche, denominate Culture-Bound
Syndromes (CBS ovvero Sindromi culturalmente caratterizzate,
Hughes C.C., 1998, Pfeiffer W.M., 1982, Prince R. - TchengLaroche F., 1987, Yap P.-M., 1974), sono accolte nel sistema
diagnostico più diffuso al mondo in un contenitore supplementare (DSM-IV-TR. Appendice I) dove vengono considerate
come «categorie diagnostiche popolari locali che conferiscono
significati coerenti a certi complessi di esperienze ripetitive,
strutturate e disturbanti» (American Psychiatric Association
2001: 958). Tale formulazione oscura il fatto che esse si fondano
su concezioni eziologiche popolari, ma spesso provengono dai
costrutti nosologici delle tradizioni mediche elaborate dalle più
diverse popolazioni. Il contenitore suddetto è stato predisposto
nell’attesa che il problema generale dei disturbi mentali correlati
o determinati dall’influenza della dimensione culturale su quella psicopatologica (Alarcon R.D., 1995, Devereux G., 2007,
Kirmayer L.J., 1998) venga infine risolto su vari piani proposizionali, epistemologico: sono realtà patologiche che scaturiscono dall’interazione tra mente e culture (Coppo P., 2003) oppure
sono narrazioni clinicamente illegittime (Ciminelli M.L., 1998,
254
Salvatore Inglese
Merli C., 1999)?, epidemiologico: quanto, dove e in quali condizioni socioambientali sono diffuse (Murphy H.B.M., 1961,
1982)?, diagnostico: cosa sono in se stesse e come si distinguono
dagli altri disturbi mentali (Inglese S., 2005)? clinico: cosa le
genera, come evolvono, ne esiste una cura attraverso dispositivi
terapeutici, tradizionali o moderni, comunque culturalmente
orientati (Nathan T., 1996, 2001)?, antropologico: la cultura esercita davvero qualche effetto nei loro confronti oppure
bisogna disconoscerle ogni funzione pragmatica sull’accadere
psichico (la “cultura” stessa, in quanto categoria euristica, sembrerebbe aver perduto di consistenza finanche all’interno del
suo dominio disciplinare, Appadurai A., 2001, Bhabha H.K.,
2001, Bibeau G. - Corin E., 1994)?
Le CBS sono ancora oggi un autentico rompicapo che ha
interdetto la psichiatria occidentale fin dai tempi dell’impresa
sistematica di Emil Kraepelin, finalizzata ad aggregare i sintomi psicopatologici elementari in complessi sindromici distinti
per imporre la sovranità della tassonomia naturalistica (rigidamente universalistica e biomedica (Jaspers K., 1965, Kraepelin
E., [1904], 1996). Il problema affrontato dall’antenato tedesco
costituisce il fondamento stesso della psichiatria scientifica alla
continua ricerca delle corrispondenze necessarie tra fatto psicopatologico e lesione o disfunzione cerebrale. Il metodo kraepeliniano ha instaurato un ordine logico-formale ma non è
ancora riuscito a decretare l’annessione dei disturbi mentali dal
regime delle sindromi (a forma nota) a quello delle malattie (a
causa nota). L’ordinamento categoriale non riesce a dispiegarsi compiutamente perché ai suoi margini pullulano singolarità
cliniche che non si lasciano sistemare entro l’una o l’altra definizione diagnostica. Tali entità sono particolarmente diffuse e
in via di moltiplicazione anche a causa di una sintomatologia
ricombinante in grado di generare forme ibridate (Hinton D.
et al., 2002, Suryani L.K. - Jensen G.D., 1993). Dal secolo di
Kraepelin al Terzo millennio, la situazione è diventata ancora
più complicata poiché gli eventi clinici una volta collocati “oltre
frontiera” superano con facilità irrisoria i confini ormai virtuali
12. Sindromi culturalmente caratterizzate
255
dell’Occidente, importandovi problemi che, un tempo, erano
relegati in un altrove remoto ed “esotico” (Adouane S., 20012002, Littlewood R., 1990, Murphy H.B.M., 1977). La comunicazione velocizzata tra gli spazi geopolitici e la progressione
inarrestabile del movimento di massa delle popolazioni propongono questi stessi dilemmi anche nelle società non occidentali dove operano i princìpi generali della psichiatria scientifica
(Ebigbo P.O. - Ihezue U.H., 1992, Gaw A.C. 1993, Ilechukwu
T.C., 1991). Piuttosto che venir superato dai mutamenti sociologici planetari (da cui si attende un’improbabile omogeneizzazione epidemiologica), l’ostacolo delle CBS si mette di traverso
praticamente ovunque (Inglese S.- Peccarisi C. - Casadei F.,
2002, Peccarisi C. - Inglese S., 1999). In effetti, le CBS devono
adesso sopportare un processo trasformativo in ragione dello
scambio generalizzato indotto dalla globalizzazione dei mercati, delle culture e delle malattie (rarefazione di quadri clinici,
acquisizione di nuove caratteristiche, nascita di forme morbose
prima impensabili, Bibeau G., 1997, Littlewood R., 1997).
La difficoltà principale della psichiatria biologica è di non
sapere giustificare le anomalie cliniche delle CBS nel momento
in cui postula l’esistenza di nuclei biologici invarianti e universali, agenti come causa naturale dei disturbi mentali. Per conciliare il determinismo biologico con la variabilità fenomenica, la
psichiatria ammette che l’endogenicità (genotipi) lasci comunque emergere manifestazioni multiformi (fenotipi) dei disturbi
mentali a causa dell’azione patoplastica dell’ambiente sociale.
In effetti, questa concessione contraddice un assunto della psicopatologia biomedica secondo cui i disturbi mentali devono
dimostrare un core sufficientemente invariante anche sul piano
clinico-empirico - sia trasversale (osservazione di stato: presentazione) che longitudinale (osservazione diacronica: esito) – da
cui poter inferire l’esistenza di un nucleo biologico altrettanto
invariante (Inglese S. 2000, Jenkins J. 1998, Nathan T. et al.
2000). Tale nucleo, che irradia la propria potenza dalla profondità silenziosa del codice genetico verso la superficie dell’evidenza comportamentale, può concedere alla singolarità espres-
256
Salvatore Inglese
siva del disturbo solo una ristretta banda di oscillazione (es., una
concezione delirante è influenzabile dai fattori esterni solo nei
suoi contenuti tematici, ma, in quanto disordine del pensiero,
sarebbe provocata da una disfunzione della neurotrasmissione
molecolare). A causa di ciò l’incidenza epidemiologica e il core
psicopatologico resterebbero indifferenti alla variazione ambientale e alla pressione del contesto socioculturale. Kraepelin
inaugura questa impostazione e risolve l’equazione nosografica
sostenendo che le malattie mentali sono “ovunque le stesse”,
per cui sono organizzabili in una classe finita di entità patologiche distinguibili. Tale posizione scientifica enfatizza i costrutti
morbosi come altrettanti tipi clinici ideali (puri) e contempla la
possibilità di recuperare nell’ordinamento nosografico anche i
tipi ibridi (forme di transizione, miste e atipiche). Essa rimane
piuttosto frigida alla seduzione di riscontrare nuove malattie
mentali in altre realtà geoculturali poiché ritiene di essere riuscita a concludere la catalogazione di tutte le entità cliniche
esistenti nel mondo, avendone già compiuto il censimento
all’interno dell’esteso campione costituito dalla variegata popolazione europea. La stagione della ricerca kraepeliniana ha fatto
maturare il suo frutto (tassonomia) e ai clinici delle generazioni
successive lascia il compito di estendere il nomos dell’ordinamento classificatorio alle varianti eccezionali (a bassa frequenza:
esistono in alcune società ma non in altre), bizzarre (gravide di
sintomi inusuali: sussulti emozionali e motori, corse omicidesuicide, retrazioni di organi e perdita di sostanze biologiche,
intervento di entità invisibili sulla soggettività umana), recalcitranti alla diagnostica formalizzata (amok, dhat, koro, latah: le
denominazioni delle varie lingue locali illustrano il senso dei
rispettivi eventi morbosi meglio di quanto riesca a fare la loro
traduzione nel codice della psichiatria classificatoria).
La psichiatria transculturale continua a cimentarsi su queste sindromi per riscattarne l’esistenza come entità autonome
o, più spesso, per assoggettarle ai disturbi mentali già esistenti e universali. Essa evidenzia l’impatto degli ambienti reali di
vita sull’incidenza dei vari disturbi, misurando la frequenza
12. Sindromi culturalmente caratterizzate
257
statistica delle varie forme cliniche in correlazione sia al tipo,
sia alla natura dei fattori che permettono l’espressione di certi caratteri patologici e la recessione o la soppressione di altri.
Accoppiando la conoscenza clinica a quella antropologica, si
impegna in un esercizio comparativo tra le categorie cliniche
universali e quelle locali, reso possibile dall’ipotesi di un’equivalenza transcontestuale dei sintomi più importanti. Sente di
poter condurre a buon fine una siffatta operazione dirimente tradurre accuratamente nelle categorie diagnostiche scientifiche
le forme del disordine riscontrate nelle diverse culture – grazie
alla leva culturale che permette di spostare verso il campo della
comprensibilità l’entità clinica ignota (secondo questa istanza,
la matrice culturale serve come codice di decifrazione del senso
criptico di un quadro clinico culturalmente caratterizzato).
2. Psichiatria transculturale e teoria della cultura
La peculiarità del sintomo psicopatologico è di emergere da
uno sfondo generativo dominato dall’interazione tra forze biologiche e culturali. L’assegnazione di un valore determinativo
maggiore alle une o alle altre dipende da un osservatore interagente con un proprio sistema di osservazione (gnoseologico:
teoria, pragmatico: tecnica, Stengers I., 1997). Se, in quanto
specializzazione della clinica medica, la psichiatria generale assegna un rango superiore alla teoria del determinismo biologico, la psichiatria transculturale deve accoppiarvi una teoria
della cultura, riconoscendo in quest’ultima una facoltà elettiva e
un fattore determinativo indipendente dell’essere umano socializzato. Proponiamo qui di considerare la categoria antropologica di cultura come un insieme di modelli trasmissibili di comportamento (es., costumi, usi, tradizioni, abitudini…) e come
una serie di meccanismi di controllo (progetti, prescrizioni, regole, istruzioni, programmi) che orientano le condotte umane
in tutte le contingenze vitali. L’invenzione della cultura da parte
della nostra specie denota quanto la vita di quest’ultima dipen-
258
Salvatore Inglese
da da dispositivi “extragenetici ed extracorporei” (programmi culturali) selezionati storicamente per dare un ordine e un
senso all’esistenza dei suoi membri (Geertz C., 1987). L’uomo
è pertanto un soggetto essenzialmente culturale: crea e viene
creato dalla cultura con cui interpreta e influenza il caos del
mondo, trasformato dai gruppi umani per mezzo di strumenti
culturali fino a diventare mondo domestico e socialmente condiviso (Devereux G., 2007). Il mondo (nel suo essere di fronte
all’uomo - per o contro di esso) e il comportamento dell’uomo
(nel suo esser-ci nel mondo – per o contro di esso, de Martino
E., 1977) sarebbero praticamente ingovernabili e, soprattutto,
incomprensibili in assenza di schemi culturali trasmessi lungo
le generazioni. Questa interpretazione attraversa il DSM IV-TR
dove la cultura viene definita come:
una serie di significati, norme comportamentali e valori adottati
dai membri di una particolare società nella costruzione della loro
originale visione del mondo. Questi valori o punti di riferimento
coinvolgono aspetti come le relazioni sociali, la lingua, l’espressione non verbale dei pensieri e delle emozioni, le credenze religiose,
la morale, la tecnologia e l’economia. Inoltre, la cultura non è una
nozione statica ma cambia nella sua trasmissione da una generazione all’altra (American Psychiatric Association, 2004: 6).
Da questa formulazione si ricava che la cultura è una proprietà
generale dei gruppi umani organizzati in società specifiche, capace di produrre un’azione profilattica ma anche psicopatogena, essa emerge dal sistema di pensiero dei gruppi umani come
una forza-invenzione che ispira i sistemi nosologici e ne fabbrica le leve terapeutiche (Coppo P., 1993, Devereux G., 1996,
Zempléni A., 1966).
Il riconoscimento del ruolo della cultura negli accadimenti
vitali degli esseri umani prescrive una focalizzazione dell’analisi
psicopatologica al di fuori del suo ristretto recinto naturalistico (Kleinman A., 1987, 1988a). Esso preconizza l’estensione
dell’orizzonte disegnato dal principio culturalista ben oltre la
petizione di principio o la raccomandazione di un metodo su
12. Sindromi culturalmente caratterizzate
259
cui sintonizzare l’esercizio della psichiatria: invita la ricerca e la
pratica professionale a sciogliere il groviglio di problemi insoluti della psichiatria biologica, psicologica e culturale nel momento in cui questi diversi circoli interpretativi si sono sviluppati in
modo indipendente, ignorandosi o in conflitto reciproco.
La psichiatria transculturale deve ritornare su tutti gli oggetti psicopatologici per rintracciarvi la nervatura delle influenze
culturali anche nel modo in cui queste stimolano le risposte al
disordine mentale. Non si tratta di offrire una diversa spiegazione alle sole CBS ma all’intero ventaglio delle sindromi psichiatriche che vanno riposizionate rispetto agli assi culturali,
esistenti in tutti i mondi umani (Carr J.E., 1985, Kleinman A.,
1988b). Per realizzare un simile progetto si dovrebbero elevare le CBS a punti cardinali di un nuovo ordine clinico: questa
categoria altrimenti marginale, proposta ancora come riserva
naturale di creature cliniche chimeriche, diventerebbe centrale
poiché vi si accumula la massa critica delle anomalie dovute al
ruolo decisivo dei fattori culturali specifici di un gruppo dato.
Essa potrebbe provocare un cambiamento progressivo del paradigma psichiatrico dominante (biologico e, simmetricamente,
psicologico, Kuhn T.S., 1969, Nathan T., 1994). Per avviarsi
verso una nuova direzione bisogna valorizzare scientificamente
le nosologie originali che i gruppi umani utilizzano per classificare i disordini mentali, individuarne l’eziologia e praticarne
la conversione terapeutica (Bastide R., 1965, Nathan T. et al.,
2000).
Questo richiamo metodologico si giova della tipizzazione
dei disturbi mentali insorgenti nei diversi gruppi umani costruita da Devereux (cfr. disturbi etnici, 2007). La sua teoria prevede
che: ogni area culturale possiede almeno uno o diversi disturbi del genere, strutturati e coordinati culturalmente, identificati da un nome specifico e interpretati localmente sulla base
di teorie esplicite riguardo alla loro causa e natura, i sintomi
hanno un’evoluzione e una prognosi prevedibili, sono trattati
per mezzo di terapeutiche e procedimenti tecnici in grado di
controllarne a profitto del gruppo gli effetti più disturbanti, la
260
Salvatore Inglese
sindrome prevalente viene scatenata da molti stimoli differenti
e fornisce un modello ideale di “cattiva condotta” soggettiva
dove appare deformata una serie di norme e comportamenti
culturali caratteristici del gruppo (Linton R., 1956). Secondo
Devereux la cultura definisce la natura e il grado di intensità
dello stress o del trauma capaci di imporre il modello patologico culturalmente caratteristico che costituisce un marcatore
dell’intero processo di fabbricazione culturale di ciascun membro del gruppo considerato.
Egli evidenzia altri aspetti importanti di questa classe: a)
alla presentazione dei disturbi etnici possono concorrere processi eziopatogenetici diversi (sindromi organiche a causa nota
o ignota, stress e reazioni di disadattamento, stati traumatici e
post-traumatici, processi psicopatologici endogeni inizialmente
dissimulati dietro entità nosografiche locali) indirizzati verso
una sorta di via finale comune e che costringono a constatare
l’impatto trasformativo dei fattori culturali su esordio, forma,
esito e terapia di un qualunque epifenomeno clinico anche a
patogenesi biologica (Carr J.E., 1985, Carr J.E. - Vitaliano
P.P., 1985), b) se si opera una dissezione e una riaggregazione
dei sintomi costitutivi di un disturbo etnico, esso perde la sua
coesione sindromica culturalmente determinata e fluttua con
un inarrestabile nomadismo transnosografico (Inglese S., 1999)
che lo fa riapparire contemporaneamente in varie categorie
psichiatriche (apparentate o estranee tra loro), fino a rendere
contraddittorio il processo clinico eterodiretto (esterno alla cultura del gruppo considerato, il Koro potrebbe essere classificato
come disturbo ipocondriaco, dismorfofobico o psicosessuale,
di panico o di depersonalizzazione, l’Amok potrebbe essere un
disturbo dissociativo ma anche uno dominato dal discontrollo
di impulsi aggressivi…).
Non bisogna limitarsi a riconoscere in astratto la cultura
come dimensione correlata al disturbo ma ci si deve applicare alla ponderazione dell’effetto puntuale e verificabile che la
cultura esercita su di esso. Vanno costruiti gli assi decisionali
per stabilire non solo quale ruolo gioca la dimensione culturale
12. Sindromi culturalmente caratterizzate
261
nella categoria generale delle CBS ma anche per ricostruire le
modalità con cui la cultura condiziona il singolo caso.
Per effettuare questo passaggio conviene sapere quale sia
l’insieme sintomatico necessario a classificare il disturbo come
CBS appropriata oltre che conoscere i dettagli psicopatologici
e culturali del caso in questione. Dopo aver fatto convergere
questa doppia serie complementare di dati clinici e antropologici si può ripercorrere la catena patogenetica a cui il caso è
verosimilmente legato. Bisogna ruotare intorno al tipo ideale
di CBS conosciuto nella sua maggiore o minore precisione descrittiva (Inglese S. - Peccarisi C., 1997, Simons R.C. - Hughes
C.C., 1985) per poter affrontare le contingenze cliniche dove il
ruolo della cultura appare verosimile ma che sono ancora prive
di nome o non assegnate a uno specifico dominio esplicativo
(religione, clinica, costume culturale, Kiev A., 1974).
Il modello teoretico e operazionale di Tseng (2003) sembra
soddisfare queste istanze e conferisce una precisione più accurata alla comprensione dei rapporti tra cultura e psicopatologia,
individuando le reti culturali che condizionano ciascuna CBS.
Egli preferisce ricategorizzarle come Sindromi specifiche correlate alla cultura per spiegare che alcune di loro non sono confinate in un’area culturale ma si presentano anche in altre società,
manifestando aggregati sintomali affini.
Questo modello contempla che la cultura possa agire come:
a) fattore patogenetico: le sindromi sono il risultato diretto di
concezioni culturali che, al contempo, possiedono gli strumenti
per curarle. Il sistema noetico del gruppo è il motore patogenetico del disturbo perché crea il circuito di stress che produce i
sintomi caratteristici della sindrome (es., Koro, Dhat, Malgri), b)
fattore patoselettivo: la cultura seleziona e modella determinate
reazioni comportamentali a vari tipi di stress, guidando l’individuo ad adottare schemi preformati (favoriti) di risposta alle
perturbazioni esterne (es., per riscattare un sentimento intollerabile di vergogna, viene socialmente prescritta una scarica
violenta contro bersagli casuali e impersonali – estremo Amok,
o individuati e personali (suicidio allargato alla famiglia) – estre-
262
Salvatore Inglese
mo Ikkashinju), c) fattore patoplastico: la cultura modifica la forma dei sintomi fino a lasciar emergere una sindrome apparentemente unica e caratteristica del contesto sociale considerato.
L’effetto patoplastico traveste un disturbo ubiquitario, a nucleo
psicopatologico invariante, facendogli assumere l’aspetto di
un fenotipo sintomatologico singolare e culturalmente caratterizzato (presentazione “atipica”, ma caratteristica, di un disturbo “tipico”, es., Ataques de nervios, Brain fag, Pibloktoq,
Taijinkyofusho), d) fattore patoelaborativo: la cultura elabora reazioni comportamentali elementari universalmente osservabili
(es., risposte motorie improvvise e stereotipate innescate da un
riflesso neurofisiologico automatico), le articola e struttura in un
comportamento più complesso, culturalmente convenzionale.
In alcuni casi il fenomeno non è necessariamente patologico e
spesso appaga bisogni individuali o sociali (es. Latah), e) fattore
patofacilitante: la cultura favorisce un incremento della frequenza con cui un particolare disturbo, potenzialmente universale,
si manifesta in certi contesti sociali e in determinati frangenti
storici. In questi casi, l’influenzamento della cultura agirebbe su
un piano epidemiologico quantitativo (es., alcolismo dei nativi,
isteria di massa), f) fattore patoreattivo: la cultura offre un’elaborazione interpretativa del disturbo a cui il soggetto reagisce con
una particolare espressione sintomatologica congruente all’interpretazione culturale (es., Hwabyung, Susto). Questa induzione socioculturale condiziona anche il processo evolutivo di
altre malattie (es., interferenza sociale sull’esito variabile delle
Schizofrenie, del Disturbo da Stress Post-traumatico).
Il modello di Tseng è disposto a riconoscere l’esistenza di
manifestazioni comportamentali di natura incerta e non facilmente assimilabili a sindromi cliniche (es., Stati di trance/possessione: praticamente ubiquitari, in cui si attivano circuiti neurofisiologici e manifestazioni comportamentali tra loro comparabili oltre che riproducibili attraverso tecniche di induzione
operanti soprattutto in contesti rituali, Windigo: la sua esistenza
reale viene ancora discussa dagli studiosi pur conoscendo che la
tensione verso atti cannibaleschi (prescritti ritualmente da alcu-
12. Sindromi culturalmente caratterizzate
263
ne società iniziatiche, segrete o nella zona d’ombra della stregoneria) potrebbe convertirsi in sintomatologia soggettiva. Sono
documentati passaggi all’atto cannibalesco in quelle forme di
efferatezza comportamentale innestate su condizioni psicotiche
estreme nonché rare. Non si può comunque escludere la possibile esistenza di una categoria sindromica a un solo membro,
Arens W.E., 2001, Cooper J.M., 1933, Parker S., 1960).
3. Le
retroazioni continue tra epifenomeno e costruzioni
sociali
Alcuni anni fa abbiamo definito le CBS come Sindromi
Culturalmente Ordinate (Inglese C. - Peccarisi C., 1997) per
rimarcare che ogni gruppo culturale elabora un ordinamento
nosologico tributario della propria visione del mondo, del male
e della malattia. Il sistema classificatorio adottato (“povero” di
elementi interpretativi o di figure cliniche: polo Sedang, “ricco”
di ambedue: polo Mohave, Devereux G., 1996) può essere realmente compreso solo conoscendo i valori generali e lo statuto
assegnato da quel mondo culturale alla persona, al corpo, alle
emozioni e alla dimensione dell’invisibile non umano (spiriti,
antenati, forze naturali), insieme alle sue concezioni sull’anatomia, fisiologia e patologia degli esseri umani. Ordinato significa
anche che le culture selezionano e prescrivono modi altamente
specifici di ammalarsi, corrispondenti al processo di costruzione dell’identità culturale di una collettività. La cultura, inoltre,
ordina modalità elettive di terapia e trasformazione corrispondenti alle fenomenologie patologiche selezionate da essa. In
sintesi, il fattore culturale si dispiega come una rete di dispositivi di protezione psicologica, fisica e relazionale, al contempo rappresenta un sistema perturbativo capace di predisporre,
precipitare e causare l’insorgenza di tali disturbi. La cultura,
quindi, garantisce un ordine di senso al comportamento o assegna un ordine particolare alle forme del disordine mentale.
Si può sintetizzare una formula operativa generale della clini-
264
Salvatore Inglese
ca transculturale: il grado di comprensibilità di una sindrome
culturalmente ordinata dipende dalla contestualizzazione della
sua fenomenologia all’interno dei mondi culturali in cui viene
riscontrata, ciò richiede una conoscenza delle leggi costitutive
e delle dinamiche socioculturali esistenti in mondi siffatti. Solo
questo sapere animerebbe un saper fare rispettoso di concezioni, valori, descrizioni e spiegazioni dei pazienti iscritti in una
propria matrice culturale.
Ogni forma di disordine mentale non è definibile solo in
base alla sua natura o alla causa ma al suo divenire globale che
implica retroazioni continue tra l’epifenomeno e le codificazioni realizzate dagli attori sociali coinvolti (medici, guaritori, famiglie, organizzazioni politiche, sistemi religiosi). Un approccio
dinamico alle trasformazioni dei più diversi tipi psicopatologici
lungo l’asse della storia sociale - dagli anormali alle personalità
multiple – si scopre tanto più pertinente rispetto alle CBS, una
volta stabilito che esse sono esposte alla mutazione incessante delle società e delle rispettive culture (Foucault M., 2000,
Hacking I., 1996).
Ciò richiede di provvedere a un aggiornamento continuo di
queste sindromi per disegnarne la deriva epidemiologica (movimento nella spazialità e temporalità culturale), registrare il
grado di stabilizzazione delle loro sintomatologie (quanto dei
loro caratteri si conserva, si riproduce, si perde e si deforma),
analizzarne le condizioni di salienza nel contesto della storia di
un gruppo umano (chiusura e apertura massiva o selettiva delle
frontiere culturali). Le culture umane, insieme alle sindromi che
le caratterizzano, sono tali proprio perché si adattano al divenire storico. Le CBS vanno considerate in quanto entità peculiari
a spiccato dinamismo (plastiche e variabili) ma esse non sono
volatili o effimere (possiedono radici robuste con cui si attaccano al sostrato culturale e se ne nutrono), semmai diventano
recessive (talvolta si eclissano fino ad evaporare nel mito o nella
leggenda dove continuano ad agire come deposito di comportamenti disponibili) o si nascondono in nicchie sociali non apprezzabili da un osservatorio esclusivamente clinico (passaggio
12. Sindromi culturalmente caratterizzate
265
silenzioso dal dominio clinico a quello religioso e viceversa). La
maggioranza delle CBS conserva una vitalità a prova di tempo
e segue un ciclo vitale che le difende dall’estinzione finanche
nell’epoca della mondializzazione e delle migrazioni internazionali su scala di massa (ormai quasi un esodo e una diaspora di
popoli). Questa realtà prepara alcuni scenari clinici altrettanto
mobili e sorprendenti, comprensibili solo rivolgendosi all’individuazione dei destini che i processi di metamorfosi culturale
riservano ai collettivi umani (acculturazione, deculturazione,
Devereux G., 1985).
Nelle situazioni di contatto sociale squilibrato, conseguenti
a uno sradicamento degli individui e a una disgregazione del
loro modello culturale, le CBS non sono immediatamente e
necessariamente sostituite dai disturbi tipici di un’altra realtà
culturale (es. disturbi schizofrenici al posto di perturbazioni
isteriformi). Esse possono riprodursi su se stesse quando la mutazione del contesto materiale di vita non riesce a determinare
la trasformazione delle matrici mentali culturalmente condizionate. Soprattutto nelle prime fasi della dislocazione migratoria,
i soggetti ripropongono i sintomi delle CBS prevalenti nel mondo di provenienza. In modo più sorprendente, questi disturbi
mantengono la loro tipicità anche dopo un lungo intervallo dalla migrazione degli individui nei luoghi più lontani ed estranei.
Si può parlare di una migrazione delle CBS rinvenibile nella
conservazione tenace e inalterata delle loro caratteristiche al di
fuori delle aree culturali di pertinenza. Nell’incapacità di individuare la sindrome culturalmente ordinata, a causa di un’inclinazione negazionista delle differenze cliniche e culturali, gli psichiatri si applicano a tradurre la lingua sintomatica ad impronta
culturale nel codice artificiale di una diagnosi “forte” e standardizzata (categorie universali). Questo impegno è gravato da un
notevole rischio di equivocità: il senso originario della lingua
sintomatica viene tradotto in due o più categorie diagnostiche
percepite come equivalenti, ovvero sostanzialmente indecidibili
in mancanza di una bussola di orientamento culturale. Quando
persiste tale incertezza – nel caso in cui un sintomo inusuale fa
266
Salvatore Inglese
deragliare l’appropriatezza della diagnosi - si scelgono qualificazioni del disturbo che vorrebbero impedirne l’evasione dalla cella categoriale predisposta (quadro “atipico” perché non
altrimenti specificabile). Quando la configurazione morbosa
subisce un’oscillazione più brusca o più ampia - ad esempio,
quando si assiste al transito dalla lamentela corporea soggettiva,
inizialmente stimata come disturbo umorale “mascherato”, alla
percezione o alla convinzione delirante a tema somatico – anche
la diagnosi tenta un salto categoriale azzardato (si polarizza in
favore di una forma “tipica” stigmatizzando l’estraneità della
sindrome e del paziente che, da semplicemente Altro - “atipico” - diventa radicalmente alieno, ovvero incomprensibile sia
sul piano antropologico che psicopatologico).
In relazione ai processi distopici indotti da cambiamenti socioculturali rapidi e massivi, si profila una dinamica progressiva
a causa della quale i sintomi della CBS incominciano a disgregarsi dalla loro originaria struttura come frammenti non più
compattati dalla forza di legame del sistema culturale originario.
Senza questo centro di attrazione coesiva i sintomi elementari si ricombinano tra loro come se fossero preda di un vortice
clinico centrifugo. In questa fase predomina un polimorfismo
dinamico della sintomatologia che si proietta attraverso campi nosografici eterogenei. Questo è dovuto all’esplosione della coerenza sindromica del disturbo determinata dalla perdita
della coesione del nucleo culturale originario dove sono ormai
rintracciabili elementi della cultura originaria e di quella acquisita. La sovrapposizione disordinata genera situazioni cliniche
ibride e instabili in cui, ad esempio, condotte di abuso alcolico
(tipiche del contesto adottivo) sono innescate dall’induzione
persecutoria di un sortilegio (tipica del modello culturale d’origine), o sono talvolta il punto di partenza per una conversione
religiosa che si renderà virtuosa fino al fanatismo.
In tali situazioni, dove sintomi appartenenti a diverse matrici
culturali si condensano in un solo disturbo a caratteri molteplici, è necessario spingere la conoscenza sulla componente culturale originaria che resterebbe altrimenti inattaccabile dall’azio-
12. Sindromi culturalmente caratterizzate
267
ne clinica perché scotomizzata.
La cura dei migranti stranieri conferma l’esistenza di situazioni sature di CBS ricalcate sul loro ideal-tipo convenzionale
che, in assenza di dispositivi transculturali, non si espongono
all’attenzione psichiatrica. Quando poi riescono a sollecitarla
non sono percepite come tali (a causa della barriera linguisticoculturale o della distorsione etnocentrica che separa il clinico
da questi pazienti) né concepite come entità autonome provenienti da altre filiere generative. Esse diventano “invisibili”
(salvo rare eccezioni non superano alcuna soglia di rilevamento
statistico) o vengono “travisate” dietro la maschera diagnostica
di una declinazione “atipica”.
Esiste anche la possibilità che la lesione irreparabile del
modello culturale originario provochi la separazione definitiva
del paziente dalla propria matrice sociale. In questo caso viene
inibita la capacità del paziente di far ricorso alla CBS specifica
utilizzabile per rispondere allo stress a cui si trova esposto e non
previsto, peraltro, dalla cultura d’origine. Tale vuoto sindromico viene infine riempito da un disturbo mentale tipico della società ospitante ed esso rappresenta il segnale di un’affiliazione
individuale alla cultura adottiva (iniziazione e naturalizzazione
culturale per via morbosa e/o iatrogena). Una simile deviazione psicopatologica può avvenire anche all’interno della società
originaria del paziente laddove riesca a manifestarsi un disturbo
etnico provvisorio sovrapposto a una forma totalmente idiosincrasica (deviazione individuale dal modello nosologico idealtipico esistente nel contesto culturale del soggetto).
Infine, non si deve escludere che in aree sociali dove impera uno scambio incessante tra molti modelli culturali estranei
e competitivi si possa instaurare una ricombinazione imprevedibile di sintomi e sindromi. Da quest’ultima può insorgere un nuovo caos psicopatologico che dovrà attendere il suo
Kraepelin, forse, per molto tempo ancora…
Pino Schirripa
13. Sistema Medico.
Campo politico, istituzioni sanitarie e processi di
medicalizzazione tra egemonia e resistenza
1. Definizione
In un testo di qualche anno fa avevo proposto, assieme a César
Zúniga Valle, una definizione di sistema medico. Per quanto
non sia in genere cosa auspicabile porre all’esordio di un intervento una autocitazione, riprendo quella definizione perché,
almeno a mio avviso, è tutto sommato chiara e sintetica. In quel
caso scrivevamo che in prima approssimazione si può definire il
sistema medico come:
l’insieme delle rappresentazioni, dei saperi, delle pratiche e delle
risorse, nonché le relazioni sociali, gli assetti organizzativi e normativi, le professionalità e le forme di trasmissione delle competenze, che in un determinato contesto storico-sociale sono finalizzate a individuare, interpretare, prevenire e fronteggiare ciò che
viene considerato come “malattia” o comunque compromissione
di un “normale” stato di salute (Schirripa P. - Zúniga Valle C.,
2000: 210).
Tale definizione, nella sua ampiezza, ci permette di definire
come sistema medico, qualunque insieme di concettualizzazioni e di pratiche, comunque sia esso organizzato, attraverso cui
un dato gruppo umano pensa, previene e fronteggia gli eventi
che considera come patologici.
Su questa definizione, e ripercorrendo la complessa e a volte contraddittoria costruzione di questo concetto nella storia
270
Pino Schirripa
delle nostre discipline, notavamo come il concetto di sistema
medico abbia, nelle differenti tradizioni di studi, consentito di
guardare, e ancor più di analizzare, le pratiche e gli orizzonti
culturali riferibili a forme di terapie “altre”, non tanto e non
come a un brogliaccio di pratiche empiriche, più o meno efficaci, di carattere erboristico e manipolativo cui si sommano un
insieme di teorie della causazione del male e della sua risoluzione, non sempre intimamente coerenti, e interventi di carattere magico, considerati invece di dubbia efficacia. Attraverso
questo concetto, infatti, emerge dall’analisi l’intima coerenza di
tali sistemi di cura, e ancor di più la stretta correlazione tra i
vari ambiti: quindi le pratiche empiriche sono viste come diretta conseguenza di un insieme, teoricamente ordinato, di ordine simbolico e cognitivo. Sottolineavamo inoltre come, specie
nell’antropologia britannica, diversi autori1 sottolineassero non
solo come tali sistemi manifestassero un buon grado di coerenza, ma come essi non operassero solo al livello della eziologia e
della cura di ciò che, in quel contesto, è considerato come stato
patologico. Essi invece rispondono a una più generale esigenza
di mantenimento di ciò che viene, in ogni determinato contesto,
considerato come uno stato di salute, attraverso norme e pratiche volte alla prevenzione.
Ripercorrendo la storia del concetto notavamo inoltre due
cose, che in questo contributo, è bene ribadire. Da una parte
come negli ultimi decenni diversi autori, spesso sulla scorta di
ricerche empiriche, abbiamo messo fortemente in discussione il
carattere di coerenza interna dei sistemi medici. Ciò non certo
per riproporre, sia pur mascherata, una concezione dei sistemi
altri come giustapposizione disorganizzata di pratiche empiriche e teorie, quanto invece per proporre modelli più sfumati e
complessi2.
Tali riflessioni scaturiscono anche da uno sguardo differen1. Cfr. ad esempio J. Janzen (1978, 1979),
2. Si vedano a questo proposito M. Last (1981), R. Pool (1994), R. Massé
(1997)
13. Sistema Medico. Campo politico, istituzioni sanitarie
e processi di medicalizzazione tra egemonia e resistenza
271
te in cui le tradizioni terapeutiche non erano viste nella loro
unicità, o purezza potremmo dire, ma invece sottolineando il
carattere “impuro”, il continuo scambio di pratiche e teorie
della malattia tra tradizioni differenti. Ciò ci porta al secondo
problema che notavamo con Zúniga Valle, cioè quello della indagine dei sistemi medici plurali. Su questo tema, tornerò più
diffusamente nel prossimo paragrafo. Vorrei invece qui notare,
anche per una completezza di dati sulla storia di questo concetto, come l’indagine dei sincretismi, delle situazioni creole per
meglio dire, sia diventato uno dei punti salienti del dibattito degli ultimi tre decenni. Una pluralità di pratiche che si ritrova ad
esempio negli studi incentrati sui percorsi terapeutici che sottolineano come un individuo che cerchi la guarigione si muova
all’interno del ventaglio di risorse che un determinato sistema
medico offra. A creare un percorso terapeutico concorrono le
sue interpretazioni del male e quelle dei suoi familiari, la disponibilità delle diverse risorse terapeutiche e, non ultima la possibilità di accesso a queste, possibilità da intendersi sia sul piano
cognitivo sia, e soprattutto, su quello economico e strutturale.
Non è facile formalizzare i differenti percorsi terapeutici, perché tante sono le variabili sulle quali poggiano. Inoltre non sempre vi è coerenza tra un ordine cognitivo e simbolico dell’individuo e le scelte terapeutiche che egli stesso opera, questo perché
a guidare la scelta delle risorse è quella che potremmo definire
come una “logica pratica” il cui fine è la guarigione e per il peso
che le diverse variabili sopra ricordate possono assumere un
una specifica situazione. È il muoversi incessante dei pazienti
tra le diverse risorse a disposizione che è la cifra dell’immagine
complessa dei percorsi terapeutici. Come sintetizza Didier Fassin, un percorso terapeutico:
appare come il risultato di logiche multiple, di cause strutturali
(sistemi di rappresentazione della malattia, posto del soggetto nella società) e di cause congiunturali (modificazioni della situazione
finanziaria, consigli di un vicino) che rendono vani tutti i tentativi
di formalizzazioni precise (Fassin D., 1992: 118).
272
Pino Schirripa
Non sono solo gli attori sociali ad attraversare il crocicchio delle terapie, per riprendere una nota metafora di Benoist (vedi
oltre), ma sono anche i terapeuti che si pongono all’incrocio
di differenti tradizioni, utilizzando nel corso del processo terapeutico pratiche e teorie di differente provenienza, coniugando
in tal modo pratiche, teorie e simboli in insiemi nuovi. Tutto
ciò ha consentito un ampliamento, nonché una maggiore complessità, del quadro teorico e analitico. Ribadivamo comunque
come proprio una tale complessità induca a non eludere problemi stringenti legati al costituirsi delle realtà creole come esiti
di processi storici lunghi e complessi, quindi ribadendo la necessità di indagare le dinamiche storiche e sociali, i processi di
egemonia e le pratiche di resistenza e, soprattutto, i rapporti di
forza ineguali tra i gruppi sociali coinvolti in questi processi.
2. Sistemi medici plurali
La pluralità di pratiche e di logiche, insomma ciò che si è convenuto chiamare sistemi medici plurali, rappresenta sicuramente
uno dei campi problematici di indagine lasciati tuttora aperti.
Del resto i sistemi medici tendono sempre più a essere plurali,
tanto nell’occidente euro-americano che negli altri continenti.
Sicuramente i due autori che vengono più spesso citati quando si discute del concetto di sistemi medici plurali sono Irwin
Press e Arthur Kleinman. Per molti versi le loro posizioni – e
spesso anche la stessa prospettiva di indagine − sono opposte,
e ciò ha favorito una certa polarizzazione del dibattito intorno
alle loro posizioni.
Irwin Press propone una definizione precisa, e molto ristretta di sistema medico: «un corpo integrato e interrelato di valori e pratiche intenzionali governato da un unico paradigma di
significazione, identificazione, prevenzione e trattamento della
malattia» (Press I., 1980: 47). La prospettiva di Press è quella
della tassonomia. Per identificare un sistema medico occorre
che sia chiaro il paradigma unitario cui ricondurre non solo l’in-
13. Sistema Medico. Campo politico, istituzioni sanitarie
e processi di medicalizzazione tra egemonia e resistenza
273
sieme delle pratiche e dei valori che governano l’azione degli
attori sociali, ma anche il modo di interpretare la malattia e di
intervenire su di essa. è una prospettiva condivisa da diversi
studiosi di lingua anglosassone, tra questi Yoder che, commentandola, scrive:
Questa concezione del sistema medico contiene sia aspetti sociali
sia culturali. Gli aspetti culturali sono quelli concernenti l’ascrizione di un significato agli episodi di malattia (illness). Cioè, i sistemi
medici servono a ordinare, classificare e spiegare la malattia. Sono
comunque parte di una più larga realtà simbolica che è costruita
culturalmente. Nella nostra società l’importanza degli aspetti culturali della malattia (illness) è stata oscurata dall’assunzione che
tutti noi accettiamo il modello biomedico di malattia (disease) per
come è definito dai medici. Gli aspetti sociali del sistema medico
sono quelli che riguardano i ruoli e gli status dei partecipanti. I sistemi medici contengono assunti su chi siano le persone o i gruppi
qualificati a fornire informazioni, prendere decisioni o prescrivere
terapie [Yoder P.S., 1982: 9]
È evidente in questo commento come l’attenzione di questi autori sia concentrata sulla tassonomia dei sistemi medici. Questi
sono definiti principalmente attraverso i loro aspetti sociali e
culturali, ponendo l’attenzione soprattutto sulla loro coerenza
interna, e principalmente su come i vari elementi (per esempio
le eziologie e le pratiche terapeutiche) siano tra loro interrelati
e derivino da comuni assunzioni di carattere più generale. Non
è dunque strano che Press rifiuti il concetto di sistema medico
plurale in favore di quello di configurazioni sanitarie plurali.
Press sostiene che non si possa parlare di un sistema medico
che contiene al suo interno dei sottosistemi (cioè ad esempio la
biomedicina e una medicina tradizionale africana, o piuttosto
l’omeopatia) e che funzioni su differenti paradigmi culturali,
poiché ciò contraddirebbe quella coerenza interna che è ascritta al concetto stesso di sistema. Al contrario, l’idea di configurazioni sanitarie plurali manterrebbe tale coerenza, poiché starebbe a significare la coesistenza di diversi sistemi medici (cioè
di diversi paradigmi coerenti) all’interno di una data situazione
274
Pino Schirripa
sociale. Quel che rimane ai margini degli interessi tassonomici
di Press sono le pratiche di intervento dei terapeuti − che purtroppo per lui sono spesso impure, sincretiche e poco coerenti
−, e i comportamenti di ricerca della salute, cioè le concrete
azioni che i pazienti compiono per guarire e che li portano a
muoversi incessantemente tra le diverse risorse terapeutiche a
loro disposizione.
Sicuramente più attenta ai comportamenti dei pazienti è
la posizione di Kleinman (Kleinman A., 1978, 1980). Partendo dalla sua ricerca sul campo a Taiwan, l’antropologo e psichiatra statunitense propone un modello tripartito che, a suo
avviso, può essere utile anche come base per la comparazione
transculturale dei sistemi medici intesi come sistemi culturali.
Tale tripartizione prevede un settore popolare, che comprende
l’insieme delle pratiche e delle credenze della comunità di cui
un dato individuo fa parte, comprese le forme di autocura, uno
professionale, che comprende le pratiche di quanti svolgano un
lavoro terapeutico in quanto rappresentanti di una medicina
istituzionalizzata, sia essa la biomedicina o qualche altra forma
terapeutica, uno folk, in cui vengono comprese le pratiche di
quanti svolgono un’attività terapeutica – a partire da un sapere
che non è diffuso –, ma che non godono di riconoscimenti istituzionali (Kleinman A.,1980). La proposta di Kleinman è ben
lontana da quella di Press, individuando proprio nella pluralità
di risorse una caratteristica dei sistemi medici. I tre settori individuati dall’antropologo nordamericano, infatti, vanno visti
come delle arene sociali, ma anche come un luogo in cui i saperi
medici si rimescolano e in cui hanno origine sintesi nuove.
Una simile attenzione alla pluralità di risorse terapeutiche si
ritrova anche in Benoist (Benoist J., 1993, Benoist J. curatore,
1996). Nella sua pratica etnografica Benoist predilige i contesti
creoli, cioè quelle società in cui diverse tradizioni – non solo
terapeutiche – convivono una a fianco all’altra trovando momenti di sintesi creativa. In questi contesti egli insiste sull’unità
strutturale del sistema medico che è visto come:
[…] uno spazio dove le piante si fanno simboli, gli dèi medicine,
13. Sistema Medico. Campo politico, istituzioni sanitarie
e processi di medicalizzazione tra egemonia e resistenza
275
i rituali trattamenti e le promesse vaccini […] [uno] spazio dove
anche la medicina moderna, l’assistenza sociale, la TAC e gli antibiotici hanno il loro luogo incontestato [...] ma dove queste si
adeguano a quelle venute dalla tradizione completandole (Benoist
J., 1993: 148)
Un sistema medico plurale perché prodotto storico di storie
particolari, ma soprattutto figlio di specifici rapporti sociali.
Studiando le società creole, Benoist vuole interrogarsi direttamente sulle dinamiche sociali e culturali attraverso cui “il
plurale prende forma”, in cui le stesse tradizioni terapeutiche
diventano sia strumenti di definizione dell’identità che luogo
di scambio fra tradizioni differenti (Benoist J. curatore, 1996).
Qui diventa centrale la metafora dell’incrocio, del crocicchio,
del luogo in cui tradizioni differenti si incontrano. Questi incroci sono continuamente attraversati da pazienti che scelgono
anche modelli di cura differenti dal proprio per arrivare alla
guarigione, dando così vita a un incessante movimento da una
tradizione all’altra. La pluralità di regole, di logiche e di pratiche
curative disponibili, è attraversata dai singoli individui che nel
loro percorso di recupero della salute si rivolgono a più risorse
per la risoluzione dei propri problemi, ma anche dai terapeuti, diventando così campi in cui diverse tradizioni terapeutiche
(tra cui va compresa anche la biomedicina) si incontrano. Ciò
dà luogo interessanti “incroci” di pratiche che rendono sempre
più impure le singole tradizioni.
La dimensione del potere, nell’indagine sui sistemi medici,
diventa centrale in Fassin, tanto da rimettere in discussione la
stessa nozione di sistema medico (almeno nell’accezione tassonomica di Press):
[…] la nozione di sistema medico non può, da un punto di vista
euristico, dar conto di realtà complesse in cui convivono diverse
tradizioni di cura. Partendo dalla sua ricerca sul campo in una
banlieue di Dakar, Fassin (D. Fassin, 1992) mette in discussione un
tentativo di classificazione dei sistemi medici basati sull’asse tradizionale/moderno, così come anche rende più sfumate le differenze
tra i diversi sistemi medici, mettendo in luce come vi siano zone di
276
Pino Schirripa
convergenza e sincretismi. Partendo dal punto di vista degli attori
sociali, in particolar modo dei terapeuti, egli sottolinea come in
situazioni di pluralismo medico − marcate anche dai processi di
legittimazione della medicina tradizionale − si assista ad una continua rinegoziazione del ruolo sociale dei terapeuti che li riposiziona
continuamente su diversi livelli del campo complessivo dell’offerta
terapeutica (Schirripa P. - Zúniga Valle C., 2000: 217-218)
Gli autori appena presi in considerazione accettano la sfida
dell’analisi di un sistema medico plurale, sottolineando come
il suo “farsi plurale” ci costringa a rendere conto delle dimensioni dei rapporti sociali e di potere. In questa prospettiva, ad
esempio, Rance Lee, discutendo del sistema medico cinese,
sottolinea i rapporti ineguali, ancorché complessi, che esistono all’interno di un sistema medico plurale, sostenendo che si
debba parlare – nel suo caso particolare per il contesto cinese,
ma naturalmente è un discorso che può essere applicato anche
altrove – di una “superiorità strutturale” della biomedicina, dovuta al suo maggior potere economico e politico e al conseguente prestigio sociale. Di contro, e complementare a ciò, troviamo
il “potere funzionale” delle medicine tradizionali, cioè la loro
grande diffusione sul territorio e il loro utilizzo da parte di ampie fasce delle popolazioni (Lee R.P.L., 1982).
Il sistema medico plurale quindi non è un insieme armonico:
in esso trovano espressione i conflitti che attraversano le società, così come al suo interno i differenti attori sociali competono
per le risorse e rinegoziano le loro posizioni.
Pur se da prospettive teoriche differenti, molti degli autori
citati sottolineano come un sistema medico plurale sia una arena gerarchizzata di competizione tra attori sociali che stanno in
posizione asimmetrica. Competizione che dà luogo, se seguiamo Fassin, a una continua rinegoziazione dei ruoli sociali.
Credo che in questa prospettiva possa risultare utile il concetto di “campo” di Bourdieu. In diversi saggi il sociologo
francese (ad es. Bourdieu P., 1971a, 1971b, 1995 [1994]) ha
definito il “campo” come un sistema di relazioni che dipende
ad ogni momento dai rapporti di forza esistenti al proprio in-
13. Sistema Medico. Campo politico, istituzioni sanitarie
e processi di medicalizzazione tra egemonia e resistenza
277
terno, creati dalla relazione tra i diversi agenti. Inoltre, secondo
Bourdieu, ogni campo si presenta come dotato di una struttura
gerarchizzata che si articola sulla base di posizioni dominanti e
subalterne, legate alla ineguale distribuzione di capitale (simbolico, sociale, culturale, eccetera). Il campo non è una struttura
statica, ma è un luogo di lotte per conservare e trasformare le
posizioni e le relazioni al suo interno.
Utilizzare la nozione di campo nel caso dell’analisi dei sistemi medici ci permette di abbandonare definitivamente il
terreno della tassonomia, e le conseguenti questioni legate alla
minore o maggiore coerenza degli stessi sistemi – coerenza comunque oramai messa largamente in questione anche come
problema euristico – per spostare il nostro discorso nell’ambito
politico. Arena sociale, spazio in cui si articolano posizioni sociali, la cui gerarchia è continuamente definita da relazioni mai
date come statiche, il campo delle terapie è dunque un ambito
in cui rapporti sociali e di potere si determinano e si significano
mutuamente. Essi sono il frutto di particolari processi storici,
nei quali rapporti di forza, di potere e dinamiche di resistenza
assumono caratteristiche distintive.
È proprio su questo che vorrei concentrarmi nella seconda
parte del mio contributo. Più precisamente vorrei interrogarmi sulla natura politica dei sistemi medici, cosa che in parte
ho già fatto nella monografia dedicata alle politiche della cura
nel Ghana contemporaneo (Schirripa P., 2005). Vorrei partire
da una prospettiva specifica: quella dei processi di estensione
dell’egemonia della medicina occidentale nel mondo e quindi
di un determinato modellamento e di una peculiare diffusione
di particolari istituzioni sanitarie. In breve, vorrei guardare ai
sistemi sanitari a partire dalla prospettiva storica della diffusione egemonica della biomedicina (mettendo dunque al centro le
relazioni di potere e le conseguenti dinamiche di resistenza), e
di quel processo correlato, presente tanto nell’Occidente che
nel resto del mondo, chiamato medicalizzazione.
278
Pino Schirripa
3. Istituzioni sanitarie e processi di medicalizzazione
Entrambi, istituzioni sanitarie e processi di medicalizzazione,
possono essere interpretati in diversi modi, quel che è certo è
che il loro significato non può essere dato per scontato. Utilizzare il termine “istituzioni sanitarie” vuol dire operare una precisa distinzione all’interno di una realtà sociale, cioè riferirsi al
fatto che esistono delle organizzazioni che hanno come compito
principale, precipuo e riconosciuto come tale dalla società (o,
se si vuole, dal gruppo sociale, dalla realtà in cui un individuo
agisce), di fronteggiare i processi di salute e malattia.
Spesso, inoltre, parlare di istituzioni sanitarie significa, sia
pur implicitamente, riferirsi alle istituzioni della biomedicina.
Per fare un esempio banale, il bagaglio di ogni viaggiatore comprende solo alcuni farmaci, perché gli altri sono reperibili nel
posto in cui ci si reca (qualunque esso sia), pressoché ovunque,
infatti, è ormai possibile fare affidamento ad istituzioni di riferimento a noi note, che sono quelle della biomedicina. Questo
altro non è che il segno di un particolare processo storico che
segue pari passo il predominio occidentale nel pianeta. In questo senso, quando ci si riferisce alle “istituzioni sanitarie”, identificando tali istituzioni con quelle specifiche della biomedicina,
bisogna essere consapevoli che si sta richiamando – implicitamente o esplicitamente – il processo storico dell’egemonia occidentale nel resto del pianeta.
Ovviamente si possono rintracciare in diversi contesti istituzioni sanitarie che non sono quelle della biomedicina, e che
si propongono programmaticamente e coscientemente come
istituzioni sanitarie. Esse sono frutto ogni volta di una peculiare
storia, che rispecchia le modalità dell’incontro avvenuto attraverso la colonizzazione e la diffusione dei processi di dominio
dell’Occidente nel resto del mondo. Un processo che ha fatto
sì che specifiche istituzioni si trasformassero in sanitarie, pur
essendo prima qualcosa di probabilmente più complesso. Mi
riferisco a quell’insieme variegato, multiforme e sfumato che
noi definiamo medicina tradizionale – termine quanto mai am-
13. Sistema Medico. Campo politico, istituzioni sanitarie
e processi di medicalizzazione tra egemonia e resistenza
279
biguo e che qui uso solo per comodità –. Questo significa che
anche altrove i processi egemonici hanno fatto sì che istituzioni
e figure che potevano riferirsi al contempo ad un ambito terapeutico, a uno religioso, nonché ad altri (penso ad esempio alla
figura del sacerdote-guaritore in Africa occidentale), si siano
declinati principalmente come sanitari perché figli della storia
complessa della colonizzazione e dell’imposizione del dominio
occidentale.
Che si voglia studiare il presente o si intenda procedere a
una analisi cronologicamente più profonda, occorre comunque
mantenere la consapevolezza di essere di fronte al risultato di
processi storici complessi e di relazioni ineguali tra parti del
mondo.
Il termine medicalizzazione ci pone qualche problema in
più. Vorrei partire da una riflessione di Franca Ongaro Basaglia:
Alla fine del diciottesimo secolo si era assistito ad una trasformazione del concetto di assistenza che implicava una contemporanea
trasformazione dell’atteggiamento nei confronti della morte. Non
più intesa come un destino cui l’uomo non può sottrarsi, la morte
viene gradualmente riconosciuta come il risultato di processi patologici per la maggior parte ancora sconosciuti che possono cadere
sotto il controllo e il dominio dell’uomo. Il problema del contatto
delle malattie e quello delle misure igienico-alimentari che avrebbero potuto prevenirle spostano l’asse di una generica assistenza fondata sulla carità e sul soccorso all’indigenza e alla miseria,
dall’accettazione religiosa della morte ad un concetto di lotta contro ciò che può prematuramente produrla. L’individuazione o la
collocazione della malattia che sarà oggetto di ricerca della clinica
dalla seconda metà del diciottesimo alla metà del diciannovesimo
secolo è ciò che libera l’uomo da un destino ineluttabile accettato
come naturale, ponendolo in condizione di lottare contro la malattia che non viene più identificata con la morte. (Ongaro Basaglia
F., 1982: 178-179)
Partendo da tale riflessione, si potrebbe definire la medicalizzazione come il processo attraverso cui tutta una serie di pratiche
e atteggiamenti della vita quotidiana, e non solo, sono ricom-
280
Pino Schirripa
presi entro un ambito che è quello del sapere medico. Potremmo fare a questo proposito numerosi esempi che riguardano
la vita quotidiana dei nostri giorni. Fumare, per chi lo fa, è un
piacere ma oggi viene visto principalmente come una controindicazione alla salute. E quello che era un atteggiamento privato
diviene un comportamento regolamentato a livello pubblico.
Esempio banale, forse, ma che serve a mostrare come una serie
di comportamenti della vita quotidiana sia continuamente disciplinata, facendola in tal modo rientrare nel quadro di una
normatività/normalizzazione implicita in un sapere medico che
si erge a disciplina del corpo e del comportamento3. Quanto
qui detto si richiama chiaramente alla prospettiva biopolitica
inaugurata da Foucault.
Se utilizziamo tale prospettiva dobbiamo dunque, parlando di medicalizzazione, fare riferimento al campo del potere e
quindi del politico. Come giustificare il riferimento al politico?
La medicina nel suo costituirsi ha a che fare con una costruzione di regole che è costruzione di soggetti: dunque abbiamo a
che fare col potere. Questa è una dimensione che nell’ambito
delle analisi dei processi di salute e malattia si è affermata prepotentemente nell’antropologia medica a partire dagli anni ‘90
e che ancora oggi produce fertili analisi.
Vorrei ritornare brevemente al testo di Ongaro Basaglia:
La trasformazione avvenuta nell’atteggiamento nei confronti della
morte attraverso l’individuazione di una malattia contro cui lottare, coincide con la modificazione dell’identità tra vita e destino. Se
la morte non è più “naturale” non è più “naturale” neanche la vita.
La vita può essere modificata dall’uomo, la miseria e la malattia
possono essere debellate, la salute può essere conquistata nel momento in cui il ruolo di chi comanda non è più espressione di un
diritto divino, così come la sua subordinazione non è più condizione “naturale”. Scoperte scientifiche, lotta contro le malattie, lotte
3. Si veda ad esempio D. Fassin - D. Memmi curatori, (2004), dove i
diversi contributi, utilizzando una prospettiva biopolitica, si concentrano su
come la medicina governi i corpi analizzando i dibattiti e la costruzione di
regole riguardo la fine della vita, l’utilizzo del tabacco, la gravidanza.
13. Sistema Medico. Campo politico, istituzioni sanitarie
e processi di medicalizzazione tra egemonia e resistenza
281
per la salute e per una maggiore possibilità di vita sono aspetti di
uno stesso fenomeno storicamente riferibile alla nuova filosofia del
mondo sorta dall’illuminismo e dalla rivoluzione francese. (Ongaro Basaglia F., 1982: 184)
Questa citazione, che è tratta da un paragrafo che si intitola
in maniera significativa “Nascita della salute”, ci permette di
meglio definire il processo di medicalizzazione della società
come qualcosa non immediatamente riferibile al contrasto della
malattia, quanto invece ad un dominio che si determina storicamente come ambito di riflessione e di intervento, costellazione
di teorie ma anche insieme di pratiche: la salute. La possibilità
di intervenire medicalizzando, di dare regole e comportamenti
di vita, di costruire un soggetto attraverso tali regole, avviene
non quando insorge la patologia ma nel momento in cui l’obiettivo è il mantenimento degli organismi in quel certo stato che
viene definito come “salute”.
4. Sistemi medici e dimensione politica
Nella parte conclusiva vorrei tentare di riassumere in breve
quali possano essere i punti di riferimento di una analisi dei
sistemi medici che tenga in conto principalmente la loro dimensione politica.
È a questo proposito utile rifarsi a quanto scrive Didier Fassin in un noto saggio sulla genesi dello spazio politico della salute:
In tutte le società la malattia mette in gioco dei rapporti di potere.
Essa si esprime nei corpi attraverso le differenze tra gli individui
di fronte al rischio dell’esistenza o alla possibilità di curarsi, che
sono altrettanti modi di iscrivere fisicamente l’ordine sociale. Essa
si rivela nell’intervento di quelli che sono accreditati della capacità
di guarire, che siano sciamani, marabutti o medici, ma anche nelle
relazioni che si instaurano tra professionisti della salute e poteri
pubblici. Infine si svela nella ricerca di risposte collettive, ad esempio i rituali di purificazione, o programmi di prevenzione, la cui
282
Pino Schirripa
efficacia rappresenta sempre un test dell’autorità tanto tradizionale quanto statale. Iscrizione dell’ordine sociale nei corpi, legittimazione dell’azione dei terapeuti, gestione collettiva della malattia,
tre figure nelle quali il potere si manifesta. (Fassin D., 1996: 3)
Il brano qui riportato ci consente di meglio definire il senso
della natura politica dei sistemi sanitari e dei processi che in tal
modo si possono individuare. Per comodità e brevità, procedo
schematicamente:
a) Non abbiamo tutti le stesse possibilità di curarci, poiché
queste sono immediatamente riconducibili a condizioni
strutturali (la prossimità o la distanza delle risorse terapeutiche) ma ancor di più al nostro status economico e sociale,
e alla rete di relazioni sociali che possiamo mettere in atto.
Al nostro capitale economico quindi, ma anche al capitale
sociale e questo in tutte le società, non solo in Occidente,
perché ovunque le relazioni sociali sono ineguali. Va sottolineato che ciò rende evidente quale sia il rischio insito nel
processo di medicalizzazione, ovvero la mistificazione: rendere esclusivamente naturale e iscritto nei processi biologici
e fisiologici del singolo individuo, quanto invece si presenta anche come l’iscrizione fisica di relazioni sociali. I rischi
dell’esistenza non sono uguali per tutti. L’ineguaglianza si
segna fortemente nella storia individuale attraverso il corpo
e quindi attraverso l’iscrizione dell’ordine sociale nel corpo.
b) Legittimazione dell’azione dei terapeuti. Chi cura è investito di questo ruolo dal gruppo, riceve una legittimazione
all’azione terapeutica. Nel momento in cui a un individuo,
sia esso uno sciamano o un medico, è riconosciuta la capacità di intervenire positivamente per risolvere una situazione che si considera di malattia, e quindi le sue azioni sono
investite di un’aura di efficacia, viene a lui riconosciuto un
potere che non è solo quello della cura. Chi cura, attraverso le eziologie proposte, le pratiche di disciplina del corpo,
le norme di comportamento e così via, si pone attivamente
nell’arena sociale contribuendo alla costruzione dei sogget-
13. Sistema Medico. Campo politico, istituzioni sanitarie
e processi di medicalizzazione tra egemonia e resistenza
283
ti, sciogliendo o istituendo relazioni sociali, risolvendo o
creando conflitti. Allo stesso modo, è lo stesso gioco delle
eziologie, nella sua trama intersoggettiva, ad avere non solo
una dimensione individuale (la spiegazione di quella singola
malattia), ma anche una più latamente politica, investendo la
costruzione di relazioni sociali4.
c) Gestione collettiva della malattia. La malattia, da Marc
Augé in poi (Augé M., 1986 [1983]), è vista in antropologia
medica come ad un tempo la più individuale e contemporaneamente la più sociale delle dimensioni esistenziali. La
malattia, infatti, può mettere in causa l’esistenza del sé –
dunque ha una dimensione fortemente individuale connessa
al rischio di non esserci – e allo stesso tempo necessita di
una spiegazione, e quindi si declina socialmente. Diventa,
quindi, un problema per la comunità che deve far fronte al
rischio della morte da tre punti di vista: cercando di evitarla
(la prevenzione e la cura), dandosi un sistema di spiegazione
rispetto al processo in atto (le eziologie e le nosologie), infine
dando un senso a quell’evento, qualunque sia il suo esito (il
significato dell’evento morte e dell’evento malattia in quella
società). Allora la gestione collettiva della malattia mobilita sempre risposte sociali che, va ribadito, sono il frutto di
storie complesse di violenze e di relazioni ineguali iscritte
nell’evento malattia e nell’atto della cura. Scrive Fassin: «L’
4. Qui intendo principalmente fare riferimento a Zempléni (Zempléni A.,
1988) quando insiste sul fatto che le eziologie e i discorsi sulla malattia non
possono essere compresi se non come parte di una trama intersoggettiva che
interessa, e ad un tempo investe, un più ampio tessuto sociale. Tale trama
intersoggettiva ha una doppia posta: un gioco manifesto, la cura, e uno latente, la messa in forma ed eventualmente la risoluzione di problemi sociali,
ideologici e politici. Zempléni nel saggio qui citato, discutendo di alcuni casi
etnografici e facendo appello a categorie analitiche antropologiche e psicoanalitiche, insiste sul gioco progressivo delle interpretazioni del fatto patologico e delle sue eziologie che permettono all’individuo, al suo gruppo parentale
e a più estese categorie sociali di riflettere sulle proprie relazioni, e soprattutto
sulle trasformazioni in atto nel campo sociale. I discorsi sulla malattia e sulle
sue cause riflettono non solo specifici orientamenti culturali, ma anche precise
relazioni e pratiche sociali.
284
Pino Schirripa
iscrizione dell’ordine sociale passa per un marchio sui corpi
della violenza e attraverso l’incorporazione dell’ineguaglianza sotto la forma della diseguaglianza di fronte alla malattia
e alla morte» (Fassin D., 1996: 3).
Ivo Quaranta
14. Sofferenza sociale e violenza strutturale
1. Sofferenza sociale: un riposizionamento critico
Il concetto di sofferenza sociale si è imposto negli ultimi anni
come tentativo di ridefinizione dell’oggetto di analisi di quell’anima critica dell’antropologia medica che oggi va sotto i diversi
titoli di Critical Anthropology of Health (Farmer P., 1996, 1999,
2003) o di Antropologie Politique de la Santé (Fassin D., 1996,
2000, 2006). Già nel 1984 Robert Hahn aveva proposto di individuare nel concetto di suffering il campo di indagine della
disciplina nel tentativo di affrancarla dai presupposti epistemologici e ontologici della biomedicina, che l’autore identificava
come pervasivi nell’incapacità delle precedenti proposte di
problematizzare adeguatamente il disease, e dunque il corpo.
Da allora tuttavia molte cose sono cambiate: il radicale ripensamento della corporeità in termini storico-culturali e fenomenologici (Scheper-Hughes N. –Lock M., 1987, Csordas T.J.
1990) parallelamente ad una nuova cittadinanza accademicoistituzionale delle prospettive critiche. Le attuali prospettive
critiche, infatti, cercano di cogliere i meccanismi attraverso cui
forze sociali di ampia portata fanno registrare i loro effetti nella
carne, arrivando così a concepire la malattia come una – e non
la sola, dunque – delle possibili forme di sofferenza sociale. Nel
primo di un trittico di volumi dedicati a questo tema il concetto
viene così definito dai curatori:
La sofferenza sociale […] accomuna una serie di problemi umani
la cui origine e le cui conseguenze affondano le loro radici nelle
devastanti fratture che le forze sociali possono esercitare sull’esperienza umana. La sofferenza sociale risulta da ciò che il potere po-
286
Ivo Quaranta
litico, economico e istituzionale fa alla gente e, reciprocamente,
da come tali forme di potere possono esse stesse influenzare le
risposte ai problemi sociali. Ad essere incluse nella categoria di
sofferenza sociale sono condizioni che generalmente rimandano
a campi differenti, condizioni che simultaneamente coinvolgono
questioni di salute, di welfare, ma anche legali, morali e religiose
(Kleinman A. – Das V. – Lock M., 1997).
Fatto sociale, dunque, che rinvia a condizioni e campi assai
differenti fra loro, il cui elemento comune sembrerebbe essere costituito dall’essere conseguenza del disagiato rapporto fra
soggetto e ordine sociale, nonché delle modalità in cui tale malessere viene affrontato.
Se il rischio del concetto di suffering (Hahn R., 1984) era
quello di fare appello a un generico e universale fenomeno - la
sofferenza umana -, con l’aggettivo “sociale” si specifica chiaramente che la sofferenza è sempre organizzata culturalmente,
e che con tale concetto ci si intende riferire espressamente alle
dimensione della sua produzione sociale.
La questione fondamentale è, tuttavia, come indagare tale
rapporto. Come sottolinea Veena Das, infatti:
Come rendere la sofferenza significativa rimane un compito formidabile per l’antropologia sociale e la sociologia. Questo deriva in
parte dal fatto che una società deve, in qualche misura, nascondere
a se stessa quanta sofferenza è imposta agli individui come prezzo
della loro appartenenza ad essa, e le scienze sociali possono correre il pericolo di mimare il silenzio della società nei confronti di tale
sofferenza (Das V., 1997: 563).
Fondamentale in questo dibattito è stato il contributo dell’antropologia critica della salute di Paul Farmer (1992, 1996) e la
sua ridefinizione del concetto di violenza strutturale
Ripreso dal lavoro di J. Galtung, il concetto di violenza
strutturale è stato posto dall’antropologo e infettivologo nordamericano Paul Farmer al centro delle sue analisi. Con tale concetto egli intende riferirsi a quelle forme indirette di violenza
14. Sofferenza sociale e violenza strutturale
287
che non derivano dall’azione diretta di un individuo, ma piuttosto la loro natura processuale proviene dall’essere esercitate
dalle forme stesse dell’organizzazione sociale, meglio ancora da
quelle forme di organizzazione sociale pervase da profonde disuguaglianze. La violenza strutturale agirebbe dunque tanto a
livello locale quanto a quello globale sulla vita di chi occupa i
segmenti più marginali di ordinamenti sociali segnati da profonde disuguaglianze.
L’impatto del lavoro di Farmer è stato senza dubbio rivoluzionario. La sua proposta infatti non si pone come ulteriore
variante paradigmatica nel variegato campo dell’antropologia
medica, nella misura in cui egli arriva a mettere sotto accusa
l’antropologia culturale tutta su due fronti, intrecciati fra loro:
da un lato egli rinfaccia alla tradizione nord-americana di aver
limitato lo scopo dell’impresa analitica della disciplina al solo
studio delle rappresentazioni culturali della malattia, del corpo,
della persona, eccetera ignorando così l’analisi di quei processi
economico-politici che contribuiscono alla distribuzione delle
patologie e della sofferenza in modo ineguale nella realtà sociale, dall’altro lato egli sottolinea come questa impostazione teorico-metodologica, derivante da una problematica interpretazione dell’atteggiamento relativista, abbia portato gli antropologi
a non indagare i processi geograficamente ampi e storicamente
profondi che fanno sì che alcuni siano maggiormente esposti
a processi patogenetici. In questo modo gli antropologi si sarebbero fatti complici inconsapevoli della violenza strutturale
stessa, arrivando a rappresentare certi fenomeni come prodotti
di processi culturali locali, occultando la loro matrice generativa sociale. Farmer mette in luce come spesso l’antropologia
medica abbia rappresentato gli effetti della violenza strutturale
in termini di differenza culturale:
Siamo stati mandati sul campo in cerca di culture differenti dalla
nostra. Abbiamo visto oppressione, tutto sommato ci è apparsa
differente dalla nostra vita confortevole all’università, così l’abbiamo chiamata “cultura” (Farmer P., 1999: 7).
288
Ivo Quaranta
Per contrastare questo atteggiamento egli propone un’analisi economico-politica della sofferenza attraverso un approccio
che colloca il locale all’interno di triangolazioni storico-politiche capaci di mettere in luce i meccanismi sociali dell’oppressione. Celebri sono ormai le sue analisi dell’AIDS e della tubercolosi farmaco-resistente, patologie la cui capillare diffusione
in contesti del sud del mondo è stata spesso ricondotta dalle
agenzie internazionali a valori culturali locali.
2. Aids e individualizzazione dei processi sociali
Per quanto riguarda l’HIV-AIDS, infatti, fin dai primi anni della
presa di consapevolezza dell’epidemia la ricerca biomedica, nel
caso dell’Africa sub-sahariana, si è concentrata principalmente
su particolari gruppi “a rischio”, quali militari, prostitute e camionisti, identificati attraverso il trinomio prostituzione – vagabondaggio sessuale - avversione al preservativo. Al fine di comprendere i meccanismi della diffusione dell’epidemia, l’OMS
invitò ad indagare le pratiche sessuali di questi gruppi. Tuttavia
l’attenzione esclusiva sulle pratiche sessuali ha prodotto l’idea
che il modo migliore di procedere alla prevenzione dell’AIDS
fosse quello di fornire una corretta informazione circa la sua natura e trasmissione, in modo da generare un mutamento comportamentale. È evidente come questo protocollo di ricerca,
che andava sotto l’acronimo di K.A.P. (Knowledge, Attitudes,
Practices), poggiasse su un modello razionalistico dell’azione
umana che privilegia il livello individuale: il comportamento
non sarebbe altro che il risultato di un calcolo costi/benefici
che, una volta fornita la corretta informazione, porterà i soggetti interessati ad agire in modo adeguato. L’illusione dell’approccio cognitivo-comportamentale, alla base del K.A.P., consisteva
nel considerare il problema dell’AIDS in Africa una questione
radicata nella locale cultura sessuale: obiettivo del K.A.P. era,
infatti, quello di giungere ad una comprensione dei saperi, atteggiamenti e pratiche relative alla sessualità, sì da mettere a
14. Sofferenza sociale e violenza strutturale
289
punto strategie di prevenzione che tenessero conto dei codici
locali.
In primo luogo bisogna mettere in luce come il concetto di
persona alla base del KAP è affatto particolare, radicato com’è
nella cultura occidentale, in secondo luogo questo approccio
non solo tende ad individualizzare i processi sociali della malattia e della sua trasmissione (depoliticizzandoli), ma offusca
anche quelle dinamiche (non solo individuali ma anche collettive, non solo culturali ma anche economiche, sociali e politiche)
che producono contesti di rischio. Ascrivendo quest’ultimo alle
scorrette informazioni degli attori sociali, questo protocollo da
un lato ha prodotto una visione della cultura locale come essa
stessa fattore di rischio, dall’altro era strutturalmente destinato
a non cogliere le decisive forze socio-economiche e politiche,
tanto locali quanto globali, che fanno da contesto all’azione individuale.
I lavori di Farmer, come di altri, hanno invece preso le mosse
dall’esigenza di elaborare una comprensione differente del fenomeno AIDS, capace di cogliere il ruolo dell’azione umana nel
plasmarne non solo la comprensione, ma anche la diffusione e
il suo eventuale controllo. Secondo Farmer, infatti, il problema
della diffusione dell’HIV, come di altre patologie, non andrebbe ricercato nelle locali concezioni culturali, quanto piuttosto
nelle costrizioni che le forze sociali esercitano sulla capacità di
scelta dei soggetti, spingendoli ad esempio verso forme di scambio sessuo-economico o limitando la loro capacità di negoziare
i termini dei propri rapporti sessuali. In altre parole, sostiene
Farmer, sono le limitazioni economiche e sociali all’agire individuale che esporrebbero le persone a specifici rischi e forme
di vulnerabilità. È in questo senso che egli giunge a parlare
di patologie del potere (Farmer P., 2003) e di incorporazione
biologica della violenza strutturale. Durante la mia personale
esperienza di ricerca nel Nord-Ovest del Camerun (Quaranta
I., 2006), il ricorso a forme di scambio sessuo-economico rappresentava una modalità residuale di azione, volta ad accedere
a risorse materiali altrimenti precluse. Quello della sessualità
290
Ivo Quaranta
emerge allora come un terreno non riducibile ai meri comportamenti individuali, configurandosi piuttosto come un terreno in
cui si materializzano ineguali rapporti di potere ancorati a disuguaglianze socio-economiche , differenze di genere, rapporti tra
generazioni, che insieme concorrono a strutturare la vita sociale
dell’agente virale.
Attraverso tale prospettiva la malattia viene a configurarsi
come un processo sociale: non più mera realtà biologica, frutto
di un beffardo destino o di rischio statistico, ma realtà attivamente prodotta da particolari assetti sociali informati da profonde disuguaglianze.
Se dunque la violenza strutturale agisce limitando la capacità di azione dei soggetti, è proprio sul fronte della promozione
di quest’ultima che la lotta per la salute pubblica deve essere
combattuta, mettendo al centro l’azione politica per la promozione dei diritti sociali ed economici.
Lo stesso tipo di analisi Farmer dedica al tema della tubercolosi farmaco-resistente: le agenzie internazionali hanno infatti
ricondotto l’emergere di ceppi resistenti alla cattiva compliance dei pazienti che nell’assumere scorrettamente i farmaci (seguendo le loro concezioni culturali non allineate con i principi
biomedici) sarebbero i primi responsabili da biasimare. Nel
contesto haitiano, ma non solo, Farmer e i suoi collaboratori
hanno chiaramente dimostrato che la compliance è direttamente legata alle condizioni materiali di esistenza: raffrontando il
comportamento di pazienti a cui venivano dati solo farmaci per
la TBC con quello di chi riceveva oltre ai farmaci anche un contributo economico, che seppur minimo li affrancava dall’obbligo di dedicarsi alla produzione della immediata sussistenza,
è stato messo in luce quanto la compliance fosse direttamente
legata a fattori non esclusivamente culturali, ma principalmente
economico-sociali.
Il lavoro di Farmer è stato estremamente pervasivo nel produrre un riallineamento degli approcci critici in antropologia
medica, mettendo chiaramente in luce quanto salute e malattia debbano essere considerati nei termini di processi sociali: le
14. Sofferenza sociale e violenza strutturale
291
patologie possono, in altre parole, essere intese come prodotti
finali di più ampi processi tutti da indagare e non solo attraverso prospettive bio-psicologiche. In modo evocativo Farmer
sostiene che certamente si potrà sostenere che i mattoni della
nostra esistenza sono (culturalmente concepibili in termini, aggiungerei io) biologici, ma certamente il progetto di edificazione è squisitamente sociale.
3. Etnicizzazione dei processi eziopatogenetici
In linea con questa prospettiva Nancy Krieger (2005), parimenti, mette in luce quanto le istituzioni nord-americane, ad esempio, utilizzino concetti come quelli di etnia e razza nella compilazione delle statistiche epidemiologiche da cui emerge che le
minoranze definite in termini “etnico-razziali” presentano una
performance estremamente minore dei loro indicatori sanitari
rispetto alla popolazione “bianca”. Questi dati hanno spesso
portato istituzioni come i Centres for Disease Control di Atlanta
a finanziare ricerche volte ad indagare quali valori culturali possano essere alla base di comportamenti lesivi della salute nelle
comunità in questione, riproponendo quell’atteggiamento culturalista (Fassin D., 2001a) secondo cui la cattiva salute sia da
imputare a scelte comportamentali di carattere esclusivamente
individuale. Nancy Krieger propone di eliminare concetti equivoci e assai problematici come quelli di etnia e razza a favore di
quello di classe socio-economica: in modo assai poco sorprendente emerge la lapalissiana verità che ad ammalarsi di più e a
morire prima sono i poveri. Se concetti come quelli di razza, ma
ormai anche quello di etnia, emergono come scientificamente
infondati, è parimenti vero che la discriminazione su base etnica e razziale invece esista, eccome. Dove rintracciare a questo punto le ragioni di un tale quadro epidemiologico emerge
quanto mai evidente: certamente non sul piano esclusivamente culturale e del comportamento individuale, ma nei processi che strutturano e limitano la capacità di azione dei soggetti,
292
Ivo Quaranta
socialmente esclusi in virtù di discriminazioni etnico-razziali.
Sulla stessa linea si collocano anche le analisi che Didier Fassin
(2001b) dedica ai temi dell’immigrazione in Francia.
Il concetto di sofferenza sociale allora permette di ripensare profondamente l’oggetto stesso dell’antropologia medica, in
virtù del fatto che ci consente di cogliere come differenti esisti
bio-psicologici individuali (disagio, malattie infettive, violenza politica, abusi sessuali e di genere, malnutrizione, mortalità
infantile, eccetera) possano essere ricondotti a processi simili,
tutti da indagare alla luce dei particolari risultati prodotti dalla triangolazione fra indagine etnografica, analisi storicamente
profonda e contestualizzazione geograficamente ampia.
Non si intende con ciò delegittimare le categorie biomediche di malattia, quanto piuttosto mettere in luce quanto ciò che
culturalmente chiamiamo malattia possa essere conseguenza
della sofferenza sociale.
A caratterizzare l’Anthropologie Politique de la Santé, proposta in contesto francese da Didier Fassin (1996), è tuttavia
un più marcato accento sull’iscrizione dei processi storici nella
carne. Non fermandosi ai soli determinanti sociali delle condizioni biologiche, le sue indagini permettono di recuperare efficacemente l’analisi anche dell’esperienza soggettiva e della voce
degli attori sociali, temi questi fortemente assenti nei resoconti
della Critical Anthropology of Health nord-americana. Nel lavoro di Fassin (2007a) le storie di vita fanno da terreno per l’analisi della costruzione storico-sociale dell’esperienza vissuta che,
lungi dall’essere deterministicamente schiacciata, viene piuttosto apprezzata come flusso emergente in cui il destino sociale e
la capacità di azione individuale danno vita a forme di azione
che certamente non possono essere meccanicamente ricondotte
da approcci culturalismi a mera articolazione personale di dettami simbolici collettivi.
Ad accomunare queste differenti anime della sofferenza sociale è la volontà di cogliere i meccanismi dell’oppressione e
parimenti di destare l’antropologia alle sue responsabilità politiche di denuncia e di azione pubblica.
14. Sofferenza sociale e violenza strutturale
293
Coerentemente con questa posizione Farmer fondò Partners
In Health e l’Institute for Health and Social Justice (braccio di ricerca di Partners In Health). Sfruttando consapevolmente la sua
posizione di professore ad Harvard, Farmer si è fatto vettore di
fondi nel Sud del mondo per combattere le patologie del potere
creando accesso alle risorse sanitarie dove queste sono assenti.
In molti hanno messo in luce le contraddizioni più o meno latenti di questo impianto. Nguyen (2006), ad esempio, sottolinea
come questo approccio, sebbene prenda le mosse da una critica
del riduzionismo biomedico alle sole dimensioni biologiche individuali, a favore di una visione sociale e politica della sofferenza, si traduca in definitiva in una estensione dell’accesso ai
servizi biomedici.
Farmer in più occasioni ha ribattuto a questo tipo di critiche
segnalando che a suo modo di vedere ci sarebbe più violenza
strutturale nella mancanza di servizi sanitari che nel promuovere la capacità di accesso ai benefici della ricerca farmacologia.
Difficilmente gli si potrebbe dare torto, anche se rimangono valide alcune cautele: in primo luogo se le disuguaglianze minassero la salute solo attraverso le difficoltà di accesso, allora certamente la promozione di quest’ultimo sarebbe la via maestra, ma
esse – come lo stesso Farmer mette in luce – sono chiamate in
causa anche a livello eziopatogenetico e dunque a monte, in secondo luogo, seguendo sempre Nguyen, non bisogna tralasciare l’analisi dei processi che sono generati dalla presenza delle
tecnologie biomediche in contesti in cui i diritti umani, associati
a quelli di cittadinanza, rimangono lettera morta in virtù del
fatto che gli stati del Sud del mondo sono spesso impossibilitati
ad assolvere le loro funzioni di promozione del benessere della
popolazione. In un contesto in cui, ad esempio, la cooperazione sanitaria mobilita risorse enormemente superiori a quelle
disponibili alle locali istituzioni sanitarie, ecco che la possibilità di sperimentare la tutela e la promozione dei propri diritti,
ovvero l’esperienza della moderna cittadinanza, si realizza nei
contesti dell’industria umanitaria e dunque in riferimento alla
propria eleggibilità a tale tutela. Nelle sue ricerche sull’impatto
294
Ivo Quaranta
delle terapie antiretrovirali in Africa Occidentale, lo studioso
mette in luce, infatti, come quanto più le disuguaglianze sociali fanno registrare il loro impatto nei corpi degli svantaggiati,
tanto più il loro destino è legato alla biologia e alle politiche di
intervento su di essa (Nguyen V.-K., 2006). Basti pensare alle
campagne per invitare le popolazioni a sottoporsi al test per
l’HIV, nei contesti del Burkina Faso e della Costa d’Avorio da
lui esaminati: chi risulta sieropositivo viene inserito in programmi di qualificazione professionale, di assistenza domiciliare e di
trattamento sanitario, mentre chi risulta siero-negativo non avrà
accesso a quelle forme di tutela che noi sperimentiamo come
associate allo status di cittadini. In questo senso si può parlare
tanto di cittadinanza terapeutica, quanto di forme di modernità
derivata.
4. Biopolitica e biosocialità
Adottando una prospettiva biopolitica, ispirata direttamente
dai lavori di Foucault e di Agamben, Nguyen indica come la
condizione di sieropositività abbia rappresentato, dunque, per
molte persone l’unico modo di avere accesso a una serie di diritti che normalmente ascriviamo al concetto di cittadinanza. È in
questo senso che possiamo parlare, seguendo Rabinow (1992),
di “biosocialità”, termine con cui si rimanda all’emergere di
relazioni sociali e di movimenti organizzati intorno a una condizione biologica condivisa. Risulta chiaro, nel caso presentato
da Nguyen, come la presa in carico della sofferenza dia vita ad
ulteriori dispositivi di potere, che oggi vedono la loro chiave
di volta in quello che Didier Fassin definisce un ethos compassionevole (2006): è, infatti, in quanto nuda vita, mera esistenza
biologica, che si possono vedere riconosciuti diritti e la partecipazione a quella che Nguyen definisce una modernità derivata,
come abbiamo appena discusso.
Il caso dei programmi per l’accesso agli ARV viene così
iscritto in seno al più ampio ambito dell’industria umanitaria
14. Sofferenza sociale e violenza strutturale
295
che oggi, sempre più, interviene (parallelamente ad azioni militari) a sopperire le mancanze degli stati nazionali nell’assolvere
le proprie funzioni biopolitiche (Fassin D., 2007b, Pandolfi
M. 2005). Tuttavia, come questi autori sottolineano, sempre più
spesso il complesso umanitario-militare è ben lontano dall’essere una forma transitoria che entra in scena in casi di emergenza,
per ergersi invece a forma di bio-sovranità che corre insieme
alla globalizzazione delle tecnologie biomediche.
In questa direzione Leslie Butt (2002) sviluppa ulteriori riflessioni critiche mettendo in luce come le iniziative sanitarie
perorate da organizzazioni come Partners In Health si iscrivano nella promozione di una nuova agenda politica che finisce
con il legittimare nuove forme di intervento improntate a un
problematico universalismo che tradirebbe la specificità stessa
della riflessione antropologica: la sua imprescindibile considerazione del punto di vista degli attori sociali circa la propria
realtà. L’autrice, in modo assai poco caritatevole, mette in luce
come l’utilizzo delle biografie nei resoconti antropologici per
cogliere l’azione della violenza strutturale ci offra narrazioni
decontestualizzate di esperienze il cui fine è quello di convalidare più ampi assunti teorici circa i diritti umani e la giustizia
sociale: così facendo tuttavia si maschera l’assenza di una sfera
pubblica internazionale in cui le voci di queste persone possano trovare legittimità ed essere udite (se non ascoltate). Leslie
Butt sostiene quanto un serio attivismo dovrebbe non solo esaminare le distruttive relazioni di disuguaglianza, ma dovrebbe
anche mettere in discussione gli assunti, culturalmente orientati
e politicamente implicati in strutture economiche globali, su cui
si fonda oggi un’industria umanitaria e filantropica sempre più
universalista che si arroga il diritto di sapere cosa sia meglio
per gli altri, per i poveri e gli svantaggiati, ulteriormente privati
della propria voce.
Ci troviamo qui di fronte ad una profonda tensione fra
un’etica della nuda vita e un’etica della giustizia sociale, che
certamente non possono e non devono essere pensate in termini mutuamente esclusivi (Fassin D., 2000). Quello che va però
296
Ivo Quaranta
certamente evitato è lo schiacciamento dei temi della giustizia
sociale su quelli della promozione e salvaguardia della vita in
termini meramente biologici.
Se la sofferenza è direttamente legata all’incorporazione individuale e collettiva di più ampi processi socio-politici, al punto che la stessa possibilità di pensare individuo e società, biologia e storia come ontologicamente distinti emerge nei termini
di una finzione culturale, allora è ovvio che ciò che riteniamo
essere il più intimo e personale degli eventi è inevitabilmente
implicato in trame storico-sociali. In questo senso la sofferenza è sempre e comunque una questione politica, nella misura
in cui chiama direttamente in causa il rapporto fra soggetto e
ordine sociale. Eppure oggi a dispetto di quanto sembra sostenere la Das (1997), il silenzio è stato rotto, e la sofferenza
sembra onnipresente: dai media alle scienze umane, alle azioni umanitarie e filantropiche, dai centri di ascolto all’industria
degli aiuti umanitari, dalle guerre preventive alle politiche dei
flussi migratori, dal conflitto sociale al disagio del lavoratore,
ci troviamo di fronte ad uno stesso dispositivo che traduce un
problema sociale e politico nel linguaggio della malattia e della
salute mentale. Siamo di fronte a una politica che si impegna ad
alleviare la sofferenza, allontanando al tempo stesso lo sguardo
dalle sue cause. Il rischio è quello di rinunciare a pensare la
disuguaglianza e la violenza sociali per quello che sono, preoccupandoci solamente di quello che fanno.
La sfida allora emerge nei termini non di una contrapposizione fra etica della nuda vita ed etica della giustizia sociale,
quanto nell’incessante sforzo di non ridurre le questioni etiche
alle sole dimensioni della mera esistenza biologica, ma di concepirle all’interno di una più robusta pratica e politica della cittadinanza (Comaroff J., 2006) in cui le dimensioni biologiche
dell’esistenza non siano svincolate dalle dimensioni politiche
che le informano e che sollevano.
14. Sofferenza sociale e violenza strutturale
297
5. La revisione critica del concetto di cultura e i processi di
costruzione della realtà sociale
Un’ultima considerazione merita tuttavia attenzione nel volgere
alla conclusione. Certamente tradizioni critiche in antropologia
medica non sono una novità dei nostri tempi: lo stesso contesto
italiano, da Ernesto De Martino a Franco Basaglia, è sempre
stato caratterizzato da una profonda attenzione per le dimensioni politiche (oltre che fenomenologiche e storico-culturali)
della salute, così come Rudolf Virchow, Frederich Engels e
Salvador Allende hanno rappresentato i padri fondatori di una
antropologia critica della public health (Singer M. – Baer H.,
1995). È un dato di fatto tuttavia che solo oggi questi approcci
critici abbiano guadagnato una cittadinanza senza precedenti
in ambito tanto accademico quanto politico-istituzionale (basti pensare alla offerta del Presidente nord-americano Barack
Obama a Farmer di assumere il coordinamento delle iniziative
statunitensi in materia di salute internazionale, alla recente nomina del co-fondatore di Partners in Health, Jim Yong Kim, a
presidente della Banca Mondiale, eccetera). Certamente questa
legittimità è da ricondurre anche alle complesse implicazioni di
questi approcci con quelle nuove forme di diplomazia sanitaria che oggi fondano le nuove forme globali di sovranità su cui
Mariella Pandolfi e altri dirigono la nostra attenzione.
Ciononostante questa virata critica ha prodotto non poco
disagio per un’antropologia che sempre più si è andata sentendo orfana del suo elettivo terreno di riflessione: il concetto di
cultura, progressivamente sottoposto a profonde revisioni critiche. Non è un caso che il tema del meeting annuale dell’American Anthropological Association del 2009 sia stato “The End(s)
of Anthropology”, titolo che gioca sul doppio senso di fine e di
finalità, in cui ci si interroga proprio su quale spazio di praticabilità abbia oggi la nostra disciplina.
Come le contemporanee correnti critiche segnalano infatti,
molto problematico è ricondurre la sofferenza a quadri analitici meramente simbolico-culturali, laddove essa affonda spesso
298
Ivo Quaranta
le sue radici in privazioni socio-economiche e dinamiche politiche. Detto schiettamente: se il punto sono le disuguaglianze
socio-economiche, noi antropologi che c’entriamo?
Una domanda di tal fatta avrebbe senso all’insegna di una
visione dell’antropologia come studio delle differenze culturali.
Ma se nostro compito diviene quello di indagare i processi generativi della datità, allora le cose cambiamo profondamente,
in virtù del fatto che i processi di costruzione della realtà non
sono certamente solo simbolici. Nuovamente però in che termini questo ci distinguerebbe da altri ambiti disciplinari, se non
la nostra imprescindibile dipendenza dalle prospettive degli attori locali circa la realtà che vivono? In questi termini allora la
nostra vocazione etnografica emerge come partner dialogico di
un’economia-politica dell’afflizione, all’insegna di un concetto
di cultura fortemente processuale e anti-essenzialista, in cui essa
viene concepita come
in continua creazione - […] fluida, interconnessa, diffusa, interpenetrata, compatta, resistente, riformulabile, creolizzabile, più
aperta che chiusa, più parziale che totale, [che] supera i propri
stessi confini, si conserva immutata dove non ce lo aspettiamo, e si
trasforma dove ce lo aspettiamo (Sanjek R., 1991: 622).
In altre parole: una visione della cultura non tanto e non solo
come qualcosa che “abbiamo” in quanto membri di un gruppo,
ma anche come quel processo intersoggettivo di produzione di
senso socialmente posizionato all’interno di specifici configurazioni storiche di potere, in cui i soggetti mantengono la loro
capacità di rapportarsi criticamente ai processi della propria costrizione/costruzione proprio in virtù dell’essere in essi partecipi (attraverso le forme della loro plasmazione storico-culturale).
In questi termini possiamo pensare di superare quelle aporie che tanto disagio creano nell’accademia antropologica nordamericana, ricomponendo quella arbitraria e assai problematica
frattura fra dinamiche sociali e processi simbolici. Sulla scia del
concetto di sofferenza sociale possiamo così ripensare la malat-
14. Sofferenza sociale e violenza strutturale
299
tia come uno (certamente non il solo) degli ambiti dell’esistenza
umana in cui cogliere analiticamente in che modo l’esperienza sociale viene culturalmente elaborata nell’esperienza vissuta, sfidando le nostre traduzioni culturalmente legittimate sul
piano professionale secondo il linguaggio della sintomatologia
bio-psicologica.
Ma affinché questo atteggiamento analitico possa creare uno
spazio in cui i temi della salute vengono posti in termini vicini
all’esperienza degli attori sociali, dobbiamo innanzitutto impegnarci nel creare una sfera in cui quelle voci siano udibili.
Nuovamente la tradizione italiana si impone come contesto da cui imparare molto, se non altro a livello delle cornici
teoriche per formulare buone intenzioni. Chi oggi si impegna
sul fronte dell’antropologia medica difficilmente può sottrarsi
all’impegno e all’implicazione rispetto ai contesti istituzionali in
cui le dinamiche, micro- o macro-, (bio-)politiche si dipanano.
Recuperando una dimensione etnografica che non è più mera
descrizione densa di un contesto di significati ma pratica di coproduzione di scenari di senso a partire dalla partecipazione
degli attori, si possono evitare anche quelle derive universaliste
che oggi caratterizzano alcuni approcci nel campo della sofferenza sociale.
Interessante sottolineare come queste riflessioni siano
centrali anche nel recente rapporto della Commissione sui
Determinanti Sociali di Salute della OMS (CSDH 2008), in
cui si parla della necessità di colmare il divario fra ciò che sappiamo (le dimensioni eziopatogenetiche delle disuguaglianze
socio-economiche) e ciò che facciamo, partendo da analisi quali-quantitative, in cui le prospettive degli attori sociali circa la
propria realtà e la definizione dei propri bisogni abbiano piena
cittadinanza al fine di garantirne la diretta partecipazione nelle
politiche che li riguardano.
Bibliografia
Abad V. - Boyce E. (1979), Issues in psychiatric evaluation of Puerto Ricans. A
sociocultural perspective, “Journal of Operational Psychiatry”, n. 10, pp.
28-39.
Ackerknecht E. H. (1965), History and geography of the most important
diseases, New York, Hafner Publishing Co.
Ackerknecht Erwin H. (1971), Medicine and ethnology. Selected essays,
Baltimore, The Johns Hopkins Press.
Adams J. - White M. (2003), Evidence concerning social capital and health
inequalities is still lacking, “Journal of Public Health Medicine”, vol. 25,
n. 2, 2003, pp. 184-185.
Adouane S. (2001-2002), La pratique du voudou haïtien à Paris,
”Psychopathologie africaine”, vol. 1, pp. 69-91.
Affergan F. - Borutti S. - Calame C. - Fabietti U. - Kilani M. - Remotti F.
(2005 [2003]), Figure dell’umano. Le rappresentazioni dell’antropologia,
traduzione di C. Mattalucci e I. Maffi, Roma, Meltemi [ediz. orig.:
Figures de l’humain. Les représentations de l’anthropologie, Editions de
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris].
Alarcon R.D.(1995), Culture and Psychiatric Diagnosis: Impact on DSM-IV
and ICD-10, “Psychiatric Clinic of North America”, vol. 18, pp. 449-466.
Alfieri C. (2002), Mutazione di ruoli nel ciclo di vita femminile post-riproduttivo:
il caso della donna Bobo, pp. 370-379. in Guerci A. - Consigliere S.
(curatori), Il vecchio allo specchio. Percezioni e rappresentazioni della
vecchiaia, Genova, Erga (serie Vivere e “curare” la vecchiaia nel mondo,
vol. 4).
Alimenti A. (1989), Folletti, streghe, vampiri e altri esseri fantastici: il sonno e
la notte disturbati, pp. 37-42, in Seppilli T. (curatore) 1989.
American Psychiatric Association – Group for the Advancement of
Psychiatry (2004), Psichiatria culturale: un’introduzione, Milano,
Raffaello Cortina.
American Psychiatric Association (2001), Manuale Statistico e Diagnostico
dei Disturbi mentali – DSM IV-TR, Masson, Milano.
Anderson R. (1996), Magic, Science and Health. The Aims and Achievements
of Medical Anthropology, New York, Harcourt Brace College Publishers.
Appadurai A. (2001), Roma, Modernità in polvere, Meltemi.
Arens W.E. (2001), Il mito del cannibale. Antropologia e antropofagia, Bollati
Boringhieri, Torino.
Aretxaga B. (2003), Maddening states, “Annual Review of Anthropology”, n.
32, 2003, pp. 393-410.
Asad T. (2003), Formations of the Secular. Christianity, Islam, Modernity,
302
Bibliografia
Stanford, Stanford University Press, California.
Atkinson Jane Monnig (1987), The effectiveness of shamans in an Indonesian
ritual, “American Anthropologist”, vol. 89, n. 2, pp. 342-355.
Atran S. (1986), Fondements de l’histoire naturelle. Pour une anthropologie de
la science, Bruxelles, Complexe.
Augé M. (1986 [1983]), Ordine biologico, ordine sociale. La malattia come
forma elementare dell’avvenimento, pp. 33-85, in Augé M. - Herzlich C.
(curatori), Il senso del male. Antropologia, storia e sociologia della malattia,
traduzione dal francese di A. Wouters e L. Ferri, Il Saggiatore, Milano
[ed. orig.: Le sens du mal. Anthropologie, histoire, sociologie de la maladie,
Luxembourg, Éditions des Archives Contemporaines, 1983].
Augé M. (1975), Logique lignagère et logique de Bregbo, pp. 219-236, in
C. Piault (curatrice), Prophétisme et thérapeutique. Albert Atcho et la
communauté de Bregbo, Paris, Hermann.
Augé M. (1980), voce Persona, in Enciclopedia Einaudi, vol. 10, pp. 651-672,
Torino, Einaudi.
Bagnasco A. - Piselli F. - Pizzorno A. - Trigilia C. (2001), Il capitale sociale,
Bologna, il Mulino.
Bagnasco A. (1999), Tracce di comunità, Bologna, il Mulino.
Bagnasco A. (2006), Ritorno a Montegrano, pp. 7-34, in Banfield E.C., Le
basi morali di una società arretrata, Bologna, il Mulino, 2006.
Banfield E.C. (1961 [1958]), Le basi morali di una comunità arretrata,
Il Mulino, Bologna [ediz. orig.: The moral basis of a backward society,
Glencoe, Ill., The Free Press, 1958].
Bardet J.P. - Bourdelais P. - Guillaume P. - Lebrun F. - Quétél C. (curatori)
(1988), Peurs et Terreurs face à la Contagion. Choléra, tuberculose, syphilis
XIXe - XXe siècles, Paris, Fayard.
Baron S. - Field J. - Schuller T. (curatori) (2000), Social capital: critical
perspectives, Oxford, Oxford University Press.
Baronti G. (1998), Le ardue vie del latte. Note su alcuni amuleti e strumenti
terapeutici popolari connessi al “mal del pelo” (mastite puerperale), “AM.
Rivista della Società italiana di antropologia medica”, vol. 5-6, pp. 105169.
Baronti G. (2008), Tra bambini e acque sporche. Immersioni nella collezione di
amuleti di Giuseppe Bellucci, Perugia, Morlacchi Editore [Itaca. Itinerari
di Antropologia Culturale, Collana diretta da Cristina Papa].
Bartoli P. - Falteri P. (1983), Il corpo conteso. Medicina “popolare” e medicina
“ufficiale” a Magione, “La Ricerca Folklorica”, n. 8., La medicina popolare
in Italia, pp. 57-66.
Bartoli P. - Falteri P. (1987), La medicina popolare in Umbria dalla fine
dell’800 ad oggi: permanenze e trasformazioni, pp. 167-208, in A. Pastore
- P. Sorcinelli (curatori), Sanità e Società. Emilia-Romagna, Toscana,
Marche, Umbria, Udine, Casamassima.
Bartoli P. (1989), La medicina popolare e la costruzione del sistema sanitario
Bibliografia
303
pubblico nello Stato unitario italiano, pp. 23-30, in Seppilli T. (curatore),
Le tradizioni popolari in Italia. Medicine e magie, Electa, Perugia.
Bastide R. (1965), Sociologie des maladies mentales, Paris, Flammarion.
Baszanger I. (1995), Inventing pain medicine. From the laboratory to the
clinic, (N.Y.), New Brunswick, Rutgers University Press.
Bateson G. (2007 [1976]), Verso un’ecologia della mente, Milano, Adelphi
Edizioni [ed. orig.: Step to an Ecology of Mind, Chandler Publishing
Company, trad. it. di G. Longo e G. Trautteur, 1976].
Bauman R. - Briggs C. (1990), Poetics and Performance as Critical Perspectives
on Language and Social Life, “American Review of Anthropology”, vol.
19, pp. 59-88.
Bauman Z. (2000 [1999]), La solitudine del cittadino globale, Milano,
Feltrinelli [ed. orig.: In search of politics, Cambridge, Polity Press, 1999].
Beiser M. (1985), The grieving witch: a framework for applying principles of
cultural psychiatry to clinical practice, “Canadian Journal of Psychiatry”,
n. 30, pp. 130-141.
Beneduce R. (1998), Frontiere dell’identità e della memoria, Milano, Franco
Angeli.
Beneduce R. (1997), Dimensioni antropologiche della cura, pp. 9-41, in
Beneduce R. (curatore), Saperi, linguaggi e tecniche nei sistemi di cura
tradizionali, Torino, L’Harmattan Italia,.
Beneduce R. (2005), Dall’efficacia simbolica alle politiche del sé, pp. 7-27, in
Beneduce R. - Roudinesco E. (curatori), Antropologia della cura, Torino,
Bollati Boringhieri.
Benoist J. (1993), Antropologie médicale en société créole, Presses
Universitaires de France, Paris.
Benoist J. (curatore) (1996), Soigner au pluriel. Essais sur le pluralisme
médical, Karthala, Paris.
Bhabha H.K. (2001), I luoghi della cultura, Meltemi, Roma.
Bibeau G. (1981), The circular semantic network in Ngbandi disease nosology,
“Social Science & Medicine”, vol. 15B, pp. 295-307.
Bibeau G. (1982), A systems approach to Ngbandi medicine, pp. 43-84, in
Yoder P. S. (curatore), African health and healing systems: proceedings of
a symposium, Los Angeles, Crossroads.
Bibeau G. (1988), Entre sens commun et sens: éléments d’une théorie
de la signification chez les Angbandi, versione preliminare non
pubblicata.
Bibeau G. (1992), Entre sens et sens commun. Exposé de présentation à
l’Académie des lettres et des sciences humaines de la Société Royale du
Canada, dattiloscritto.
Bibeau G. (1996), Promenades ethnographiques autour du concept de «contact»,
Deuxième Colloque du Département d’Anthropologie de l’Université de
Montréal, pp. 7-25.
Bibeau G. (1997), Psichiatria transculturale in un mondo in via di
304
Bibliografia
globalizzazione, “I Fogli di Oriss”, n. 7/8, pp. 21-63.
Bibeau G. (1998 [1983]), L’attivazione dei meccanismi endogeni di
autoguarigione nei trattamenti rituali degli Angbandi, pp. 131-158, in
Lanternari V. - Ciminelli M. L. (curatori), Medicina, magia, religione,
valori. II. Dall’antropologia all’etnopsichiatria, traduz. dal francese di M.
L. Ciminelli, Napoli, Liguori [ediz. orig.: L’activation des mécanismes
endogènes d’auto-guérison dans les traitements rituels des Angbandi,
“Culture”, vol. 3, n. 1, pp. 33-49].
Bibeau G. (2005), Le «capital social»: vicissitudes d’un concept, “Ruptures.
Revue transdisciplinaire en santé”, vol. 10, n. 2, 2005, pp. 134-168.
Bibeau G., Corin E. (1994), Beyond Textuality. Asceticism and Violence in
Anthropological Interpretation, Berlin, Mouton de Gruyter.
Bochner A. P. (2002), Perspectives on Inquiry III: The moral of Histories, pagg.
73-101, in M.L. Knapp - J. A. Daly (curatori), Handbook of interpersonal
communication, Thousand Oaks, Sage.
Bonnet D. - Jaffré Y. (curatori) (2003), Les maladies de passage. La
construction sociale des notions de transmission, Paris, Karthala.
Boston Womens’s Health Book Collective (1971), Our Bodies, Ourselves,
Boston, South End, [trad. it.: Noi e il nostro corpo, scritto dale donne per
le donne, Feltrinelli, Milano, 1974, Ia ed.].
Bourdieu P. (1971a), Genèse et structure du champ religieux, “Revue Française
de Sociologie”, vol. 12, n. 3, 1971, pp. 295-334.
Bourdieu P. (1971b), Champ du pouvoir, champ intellectuel et habitus de
classe, “Scolies. Cahiers de recherches de l’École normale superieure”, n.
1, 1971, pp. 7-26.
Bourdieu P. (1986), The forms of capital, pp. 241-258, in Richardson J. G.
(curatore), Handbook of theory and research for the sociology of education,
Greenwood Press, New York, 1986.
Bourdieu P. (1995 [1994]), Ragioni pratiche, traduz. dal francese di R.
Ferrara, Il Mulino, Bologna [ediz. orig. Raisons pratiques. Sur la théorie
de l’action, Édition du Seuil, Paris, 1994].
Bourdieu P. (2001), Controfuochi 2. Per un nuovo movimento europeo, Roma,
Manifestolibri, [ediz. orig.: Contrefeux 2, pour un mouvement social
européen, Paris, Éditions Raison d’Agir, 2001].
Bourdieu Pierre (2003 [1972]), Per una teoria della pratica. Con tre studi di
etnologia cabila, traduz. dal francese di I. Maffi, Milano, Raffaello Cortina
[ediz. orig.: Esquisse d’une théorie de la pratique précédé de trois études
d’ethnographie kabyle, Genève, Droz, 1972].
Bracci F. - Cardamone G. (curatori) (2005), Presenze. Migranti e accesso ai
servizi socio-sanitari, Franco Angeli, Milano.
Briguglia G. (2006), Il corpo vivente dello Stato. Una metafora politica,
Milano, Bruno Mondadori.
Brody H. (1999 [1980]), Per una filosofia della guarigione. Scienza ed etica
dell’effetto placebo, prefazione di F. Mondella, traduz. dall’inglese di A.
Bibliografia
305
Parodi, Milano, FrancoAngeli [ediz. orig.: Placebo and the philosophy of
medicine, Chicago, University of Chicago Press, 1980].
Brogård Kristensen D. (2009), The shaman or the doctor? Disease categories,
medical discourses and social positions, “AM. Rivista della Società
italiana di antropologia medica”, Pizza G. - Johannessen H. (curatori),
Embodiment and the State. Health, Biopolitics and the Intimate Life of
State Powers, n. 27-28 / ottobre 2009, pp. 183-207.
Bronzini G. B. (1983), Antropologia e medicina popolare. Note sugli studi dei
positivisti italiani, “La Ricerca Folklorica”, n. 8, La medicina popolare in
Italia, pp. 13-16.
Brown P. J. (1983), Demographic and socioeconomic effects of disease control.
The case of malaria eradication in Sardinia, “Medical Anthropology”, vol.
7, n. 2, pp. 63-87.
Bruner J. (1992 [1990]) La ricerca del significato, Bollati Boringhieri, Torino.
[ediz. orig.: Acts of meanings, Harvard University Press, 1990].
Bruner J. (1988 [1986]), La mente a più dimensioni, Laterza, Roma – Bari
[ediz. orig.: Actual minds, possible worlds, Harvard University Press,
Cambridge, 1986].
Budd S. - Sharma U. (curatori) (2004), The healing bond. The patientpratictioner relationship and therapeutic responsibility, London, Routledge.
Burt R. S. (1997), The contingent value of social capital, “Administrative
Science Quarterly”, vol. 41, 1997, pp. 339-365.
Burt R. S. (2001), Structural holes versus network closure as social capital, pp.
31-56, in Lin N. - Cook K. - Burt R. S. (curatori), Social Capital. Theory
and Research, NewYork, Walter de Gruyter, 2001.
Bury M. (1982), Chronic illness as biografical disruption, “Sociology of Health
and Illness”, vol. 4, n. 2, pp. 167-182.
Bury M. (1991), The sociology of chronic illness: a review of research and
prospects, “Sociology of Health and Illness”, vol. 13, n. 4, pp. 451-468.
Bury M. (2001), Illness narratives: fact or fiction?, “Sociology of Health and
Illness”, vol. 23, n. 3, pagg. 263-285.
Bury M. (2004), Voce “Illness narratives”, pp. 82-86, in Gabe J. - Bury M. Elston M., A key concepts in medical sociology, London - Thousand Oaks
- New Delhi, Sage.
Bury M. (2005), Health and Illness, Cambridge, Polity.
Busoni M. (2002), Genere, sesso, cultura. Uno sguardo antropologico, Carocci,
Roma.
Butt L. (2002), The Suffering Stranger: Medical Anthropology and International
Morality, “Medical Anthropology”, 21, pp. 1-24.
Buttitta A. (1968), Pitrè e la mafia, pp. 121-129, in AA.VV., Pitrè e Salomone
Marino, Flaccovio, Palermo.
Campbell C. - Gillies P. (2001), Conceptualizing ‘social capital’ for health promotion in small local communities: a micro-qualitative study, “Journal of
Community & Applied Social Psychology”, vol. 11, n. 5, 2001, pp. 329-
306
Bibliografia
346.
Campbell C. - McLean C. (2003), Social capital, local community participation
and the construction of Pakistani identities in England: implications for
health inequalities policies, “Journal of Health Psychology”, vol. 8, n. 2,
2003, pp. 247-262.
Campbell C. (2000), Social capital and health: contextualizing health promotion
with local community networks, pp. 182-196, in Baron S. - Field J. Schuller T. (curatori), Social capital: critical perspectives, Oxford, Oxford
University Press, 2000.
Camporesi P. (1997), Il sugo della vita. Simbolismo e magia del sangue, Milano,
Garzanti.
Canguilhem Georges (1998 [1966]), Il normale e il patologico, introduzione
di M. Porro, postfazione di M. Foucault, traduz. dal francese di D.
Buzzolan, Torino, Einaudi [ediz. orig.: Le normal et le pathologique,
Paris, Presses Universitaires de France, 1966].
Cannon Walter B. (1942), ‘Voodoo’ death, “American Anthropologist”, vol.
44, n. 2, pp. 169-181.
Cant S. - Sharma U. (2001), A new medical pluralism? Alternative medicine,
doctors, and the state, New York, UCL Press.
Cappelletto F. (2009), Vivere l’etnografia. Osservazioni sul rapport medicopaziente, pp. 199-224, in Id. (curatore), Vivere l’etnografia, Firenze, SEID.
Caprara A. (2001), Interpretare il contagio. Un’indagine storico-etnografica
sulle pratiche mediche presso gli Alladian della Costa d’Avorio, Argo
Editore, Lecce.
Caprara Andrea (2001), Interpretare il contagio. Una indagine storicoetnografica sulle pratiche mediche presso gli Alladian della Costa d’Avorio,
Lecce, Argo.
Cardamone G. (2006), Lineamenti di storia dell’etnopsichiatria, “Quaderni del
Centro di Ricerca sull’antropologia e l’epistemologia della complessità”,
Università degli Studi di Bergamo, n. 1, pp. 209-224.
Cardamone G. - Bracci F. – Da Prato M. - Zorzetto S. (2005), L’alterità
culturale nei servizi di salute mentale. L’esperienza pratese fra clinica e
ricerca, pp. 248-258, in Bracci F. - Cardamone G. (curatori), Presenze.
Migranti e accesso ai servizi socio-sanitari, Milano, Franco Angeli.
Cardamone G. - Da Prato M. - Zorzetto S. (2005), Servizi di salute mentale e
alterità culturale: quali rapporti e in quali contesti, pp. 69-79, in Cardamone
G. - Affettuoso P. - Romano N. (curatori), Etnie, arti e terapie. Strade per
incontrarsi, Genova, Edizioni il Vaso di Pandora.
Cardamone G. - Da Prato M. - Zorzetto S. (2007), Sulla costruzione di
dispositivi clinici transculturali nei servizi pubblici di salute mentale,
“Gruppi (nella clinica, nelle istituzioni, nella società)”, giornale della
Coirag Confederazione di organizzazioni per la ricerca analitica sui
gruppi, vol. IX, fasc. 3, Settembre-Dicembre 2007, pp. 57-73.
Cardamone G. – Inglese s. - Zorzetto S. (curatori) (1999), Djon djongonon.
Bibliografia
307
Psicopatologia e salute mentale nelle società multiculturali, Paderno
Dugnano, Colibrì.
Cardamone G. - Schirripa P. (1994), Esperienze della malattia e linguaggio
del corpo nella terapeutica carismatica, “Religioni e Società”, vol.9, n. 19,
pp. 39-47.
Cardamone G. - Schirripa P. (1997), Retorica della terapia, corpo e narrazione
della malattia. La terapeutica carismatica nel meridione d’Italia, pp. 157182, in Beneduce R. (curatore), Saperi, linguaggi e tecniche nei sistemi di
cura tradizionali, Torino, L’Harmattan Italia.
Cardamone G. - Zorzetto S. (2000), Salute mentale di comunità. Elementi di
teoria e pratica, Milano, Franco Angeli,.
Carr J.E. (1985), Ethno-Behaviorism and the Culture-Bound Syndromes. The
Case of Amok, pp. 199-224, in Simons R.C., Hughes C.C. (curatori), The
Culture-Bound Syndromes. Folk Illnesses of Psychiatric and Anthropological
Interest, Dordrecht, Reidel Publishing Company.
Carr J.E., Vitaliano P.P. (1985), The Theoretical Implications of Converging
Research on Depression and the Culture-Bound Syndromes, pp. 244-266,
in Kleinman A., Good B. (curatori), Culture and Depression, Berkeley,
University of California Press.
Cartocci R. - Maconi F. (curatori) (2006), Libro bianco sul Terzo settore,
Bologna, il Mulino.
Cartocci R. (2007), Mappe del tesoro. Atlante del capitale sociale in Italia,
Bologna, il Mulino.
Castel R. (1995), Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du
salariat, Gallimard, Paris.
Charmaz K. (1983), Loss of self: a fundamental form of suffering in the
chronically ill, “Sociology of Health and Illness”, vol. 5, n. 2, pp. 168-195.
Charmaz K. (1987), Struggling for a self. Identity levels of the chronically ill,
“Research in the sociology of health care”, vol. 6, pp. 283-321.
Charuty G. - Fabre D. (1980), Dialogue avec Carlo Ginzburg, pp. 225-238,
in Ginzburg C., Les Batailles Nocturnes. Sorcellerie et rituels agraires en
Frioul XVI-XVII siècle, Verdier, Lagrasse.
Charuty G. (1987), Le mal d’amour, “L’Homme. Revue française
d’d’anthropologie”, a. XXVII, vol. 3, n. 103, pp. 45-72.
Charuty G. (curatrice) (1995), Nel paese del tempo. Antropologia dell’Europa
cristiana, traduz. dal francese di A. Talamonti, Liguori, Napoli.
Charuty G. (1997a), Folie, mariage et mort. Pratiques chrétiennes de la folie
en Europe occidentale, Paris, Seuil.
Charuty G. (1997b), L’invention de la médecine populaire, “Gradhiva”, n. 22,
1997, pp. 45-57.
Charuty Giordana (1998 [1990]), Liturgie della sventura: le cure dei cristiani
carismatici, pp. 209-237, in Lanternari V. - Ciminelli M. L. (curatori),
Medicina, magia, religione, valori. II. Dall’antropologia all’etnopsichiatria,
traduz. dal francese di M. L. Ciminelli, Napoli, Liguori, [ediz. orig.
308
Bibliografia
del saggio: Les liturgies du malheur. Le souci thérapeutique des chrétiens
charismatiques, “Le débat”, vol. 59, 1990, pp. 68-89].
Chatel M. M. (1995 [1993]), Il disagio della procreazione, Il Saggiatore,
Milano. [ediz. orig.: Malaise dans la procreation. Les femmes et la médicine
de l’enfantement, Paris, Albin Michel].
Ciminelli M.C. (1998), La decostruzione del concetto di “Culture-Bound
Syndrome, pp. 85-108, in Lanternari V., Ciminelli M.C. (curatori),
Medicina, magia, religione, valori, Vol. II, Liguori, Napoli.
Cipolla C. M. (1989), Miasmi ed umori, Bologna, il Mulino.
Cirese A. M. (1978), Zanetti e la medicina popolare: questioni di ieri e di oggi,
pp. 13-35, in Zanetti Z. (1978 [1892]), La medicina delle nostre donne,
nuova ed. a cura di M.R. Trabalza, con un saggio di A. M. Cirese, Ediclio,
Foligno, 1978 [ediz. orig.: S. Lapi Tipografo Editore, Città di Castello,
1892].
Clarke A. E. – Mamo L. – Fosket J. R. – Fishman J. R. – Shim J. K. (2010),
Biomedicalization. Technoscience, Health, and Illness in the U. S., Durham
& London, Duke University Press.
Cohen A. (1994), Self Consciousness. An Alternative Anthropology of Identity,
London, Routledge.
Coleman J. S. (2005 [1990]), Fondamenti di teoria sociale, Bologna, il Mulino,
[ediz. orig.: Foundations of social theory, Cambridge, Mass., Harvard
University Press, 1990].
Colombo E. - Rebughini P. (2003), La medicina che cambia. Le medicine non
convenzionali in Italia, Bologna, il Mulino.
Colucci M. (2006), Medicalizzazione, “SISSA, International School for
Advanced Studies, Journal of Science Communication” , vol. V, n.1, pp.16.
Comaroff J. (2006), Oltre la politica della nuda vita. L’AIDS e l’ordine
neoliberista, “Annuario di Antropologia”, vol. 8, Sofferenza Sociale, Roma,
Meltemi.
Comaroff J.L. - Comaroff J. (2009), Ethnicity, Inc., Chicago – London, The
University of Chicago Press.
Comelles J. M. (1996), Da superstizione a medicina popolare. La transizione
da un concetto religioso a un concetto medico, “AM. Rivista della Società
italiana di antropologia medica”, n. 1-2, ottobre 1996, pp. 57-88.
Conrad P. (1992), Medicalization and Social Control, “Annual Review of
Sociology”, vol. 18, pp. 209-32.
Conrad P. (2007), The Medicalization of Society, Baltimore, John Hopkins
University Press.
Contreras J. - Favret-Saada J. (1985), La thérapie sans le savoir, “Nouvelle
Revue de Psychanalyse”, vol. 31, pp. 223-238.
Cooper J.M. (1933), The Cree Witiko Psychosis, “Primitive Man”, vol. VI,
n.1, pp. 20-24.
Coppo P. (curatore) (1993), Essai de psychopathologie dogon, Bandiagara-
Bibliografia
309
Perugia, Éditions CRMT/PSMTM.
Coppo P. (1996), con la collaborazione di Cardamone G. e Inglese S.,
Etnopsichiatria, Milano, Il Saggiatore.
Coppo P. (2003), Tra psiche e culture. Elementi di etnopsichiatria, Torino,
Bollati Boringhieri.
Coreil J. - Mull J.D. (curatori) (1988), Anthropological studies of diarrheal
illness, “Social Science & Medicine”, vol. 27, n. 1, (special issue).
Coreil J. - Mull J.D. (curatori) (1990), Anthropology and primary health care,
Boulder, Westview Press.
Corino U. - Tavolaccini L. - Verrua G. (1976), Modelli di malattia mentale:
psichiatria e territorio. Elementi per una programmazione sanitaria
partecipata, Firenze, Le Monnier.
Cosmacini G. (1987), Storia della medicina e della sanità in Italia, Roma-Bari,
Laterza.
Coward R. (1989), The whole truth. The myth of alternative health, London,
Faber & Faber.
Cozzi D. (2003), Dolore, “AM. Rivista della Società Italiana di Antropologia
Medica”, vol. 15-16, pp. 474-503.
Cozzi D. (2007), Le imperfezioni del silenzio. Riflessioni antropologiche sulla
depressione femminile in un’area alpina, Acireale – Roma, Bonanno.
Craig K. - Wyckoff M. (1987), Cultural factors in chronic pain management,
pp. 99-108, in Burrows G. (curatore), Handbook of chronic pain
management, Amsterdam, Elsevier Scientific Publishers,.
Crapanzano V. (1996) Riflessioni frammentarie sul corpo, il dolore, la memoria,
pp. 156-180, in M. Pandolfi (curatrice), Perché il corpo. Utopia, sofferenza,
desiderio, Roma, Meltemi.
Crocella C. (curatore) (1991), Le medicine non convenzionali. Ricerca
scientifica, problemi normativi, disegni di legge, Camera dei deputati,
Roma (Quaderni di documentazione, 11).
CSDH (WHO Commission on the Social Determinants of Health) (2008),
Closing the gap in a generation. Health equity through action on the social
determinants of health.
Csordas T.J. (1990), Embodiment as a Paradigm for Anthropology, “Ethos.
Journal of the Society for Psychological Anthropology”, vol. 18, n. 1,
1990, pp. 5-47.
Csordas T.J. (curatore) (1994), Embodiment and Experience. The Existential
Ground of Culture and Self, Cambridge University Press, Cambridge.
Csordas Thomas J. (1997 [1994]), The sacred self, University of California
Press, Berkeley.
Csordas Thomas J. (2003 [1999]), Incorporazione e fenomenologia culturale,
“Antropologia”, vol. 3, n. 3, pp. 19-42.
Csordas T. J. - Kleinman A. (1998 [1990]), Il processo terapeutico, pp. 109-129,
in Lanternari V. - Ciminelli M. L. (curatori), Medicina, magia, religione,
valori. II. Dall’antropologia all’etnopsichiatria, traduz. dall’inglese di M.
310
Bibliografia
L. Ciminelli, Liguori, Napoli [ediz. orig. del saggio: The therapeutic
process, pp. 11-25, in Johnson T. J. - Sargent C. F. (curatori), Medical
anthropology. Contemporary theory and method, Praeger, New York,
1990].
Czereznia D. (1997), Do contágio à transmissão. Ciência e cultura na gênese do
conhecimento epidemiológico, Rio de Janeiro, Editora Fiocruz.
Da Prato M. - Cardamone G. - Zorzetto S. (2005), Genitorialità e filiazione
in corso di migrazione, pp. 103-110, in Martinetti M., Stefanini M.
(curatori), Approccio evolutivo alla neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza, SEID, Firenze.
Darmon P. (1986), La longue traque de la variole, Paris, Librairie Perrin.
Das V. (1997), Suffering, theodicies, disciplinary practices, appropriations,
“International Social Science Journal”, vol. 154, pp. 563–572.
Das V. - Kleinman A. - Lock M. - Ramphele M. - Reynolds P. (2001),
Remaking a World: Violence, Social suffering and Recovery, University of
California Press, Berkeley.
Das V. - Poole D. (curatori) (2004), Anthropology in the Margins of the State,
Santa Fe-Oxford, School of American Research Press - James Currey.
Davis D.L. (1997), Blood and Nerves Revisited: Menopause and the
Privatisation of the Body in a Newfoundland Postindustrial Fishery,
“Medical Anthropological Quarterly”, vol. 11, n. 1, pp. 3-20.
Davis Floyd R. (1987), The Technological Model of Birth, “Journal of
American Folklore”, pp. 479-495.
Dawson M. H. (1979), Smallpox in Kenya, 1880-1920, “Social Science &
Medicine”, vol. 13B, pp. 245-250.
De Gregorio C. (2008), Malamore. Esercizi di resistenza al dolore, Mondadori,
Milano.
de Martino E. (1959), Sud e Magia, Feltrinelli, Milano.
de Martino E. (1961), La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa
del Sud, Il Saggiatore, Milano.
de Martino E. (1973 [1948]), Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del
magismo, Torino, Bollati Boringhieri, [I ediz.: Torino, Einaudi, 1948]
de Martino E. (1975 [1958]), Morte e pianto rituale. Dal lamento funebre
antico al pianto di Maria, Torino, Bollati Boringhieri, [I ediz.: Torino,
Bollati Borignhieri 1958].
de Martino E. (1977), La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi
culturali, Torino, Einaudi.
de Martino Ernesto (1987 [1959]), Sud e magia, Feltrinelli, Milano [I ediz.:
Milano, Feltrinelli, 1959].
De Rosa G. (1983), Vescovi, popolo e magia nel Sud, Napoli, Guida.
Dei F. (2008), Tra le maglie della rete: il dono come pratica di cultura popolare,
pp. 11-41, in Aria M. - Dei F. (curatori), Culture del dono, Roma, Meltemi.
Dei Fabio (1996), Medicine alternative: il senso del male nella post-modernità,
“I Fogli di ORISS”, vol. 5, pp. 29-56.
Bibliografia
311
DelVecchio Good M.-J. - Brodwin P. E. - Good B. J. - Kleinman A. (curatori)
(1992), Pain as human experience. An anthropological perspective, Berkeley
- Los Angeles – London, University of California Press.
Devereux G. (1984 [1967]), Dall’angoscia al metodo nelle scienze del
comportamento, a cura di C. Severi, Roma, Istituto dell’Enciclopedia
italiana [ediz. orig.: From anxiety to method in the behavioral sciences, The
Hague-Paris, Mouton, 1967].
Devereux G. (1985), Ethnopsychanalyse complémentariste, Flammarion,
Paris.
Devereux G. (1996), Ethnopsychiatrie des Indiens Mohaves, Paris, Les
Empêcheurs de penser en ronde.
Devereux G. (2007 [1973]), Saggi di etnopsichiatria generale, nuova edizione
italiana a cura di Inglese S., Armando, Roma [ediz. orig.: Essais
d’ethnopsychiatrie générale, Gallimard, Paris, 1973]
Di Nola A. M. (1981), Introduzione metodologica, pp. 9-27, in Lützenkirchen
G. - Chiari G. - Troncarelli F. - Saci M. P. - Albano L., Mal di luna.
Folli, indemoniati, lupi mannari: malattie nervose e mentali nella tradizione
popolare, Roma, Newton Compton.
Di Nola A. M. (1983a), L’arco di rovo. Impotenza e aggressività in due rituali
del Sud, Torino, Boringhieri.
Di Nola A. M. (1983b), La medicina popolare: questioni di metodo, “La Ricerca Folklorica”, n. 8, La medicina popolare in Italia, pp. 7-12.
Di Nola A. M. (1987), Salute mentale e malattia nelle culture popolari: il
problema metodologico, pp. 229-245, in Di Rosa M. (curatore), Salute
e malattia nella cultura delle classi subalterne del Mezzogiorno, Napoli,
Guida Editori.
Di Nola Alfonso M. (1989), Le terapie magico-religiose, pp. 91-100, in Seppilli T. (curatore), Medicine e magie, Perugia, Electa.
Di Rosa Massimo (curatore) (1987), Salute e malattia nella cultura delle classi
subalterne del Mezzogiorno, Napoli, Guida Editori.
Di Vito A. (2006), Ulisse e lo sciamano, Roma, Cisu.
Diasio N. - Vinel V. (2007) (curatrici), Il tempo incerto. Antropologia della
menopausa, Milano, Franco Angeli.
Dieterlen G. (curatore) (1973), La notion de personne en Afrique Noir, Paris
11-17 octobre 1971, Paris, Éditions du Centre national de la recherche
scientifique [nuova edizione: Paris, L’Harmattan, 1993].
Douglas M. (1975 [1966]), Purezza e pericolo. Un’analisi dei concetti di
contaminazione e tabù, traduz. dall’inglese di A. Vatta, introduzione
all’ediz. italiana di G. Ferraro, Bologna, il Mulino, [ediz. orig.: Purity and
danger. An analysis of concepts of pollution and taboo, Harmondsworth
(Middlesex), Penguin Books, 1966].
Douglas M. (1979 [1970], I simboli naturali. Esplorazioni in cosmologia,
traduz. dall’inglese di P. Levi, Einaudi, Torino [ediz. orig.: Natural
symbols. Explorations on Cosmology, Harmondsworth (Middlesex),
312
Bibliografia
Penguin Books, 1970].
Douglas M. (1979 [1970], I simboli naturali. Esplorazioni in cosmologia,
traduz. dall’inglese di P. Levi, Einaudi, Torino [ediz. orig.: Natural
symbols. Explorations on Cosmology, Harmondsworth (Middlesex),
Penguin Books, 1970].
Douglas M. (1990 [1986]), Come pensano le istituzioni, Il Mulino, Bologna
[ediz. orig.: How institutions think, Syracuse, NY, Syracuse University
Press, 1986].
Douglas M. (2004 [1994]), The construction of the physician: A cultural
approach to medical fashions, pp. 23-40, in Budd S. - Sharma U. (curatori),
The healing bond. The patient-pratictioner relationship and therapeutic
responsibility, Routledge, London, [trad.it.: Come si costruisce il medico:
un approccio culturale alle mode in medicina, pp. 179-205, in M. Douglas,
Credere e pensare, Il Mulino, Bologna, 1994].
Dow James (1988), Universal aspects of symbolic healing: a theoretical
synthesis, “American Anthropologist”, vol. 88, n. 1, pp. 56-69.
Duden B. (1994 [1991]), Il corpo della donna come luogo pubblico, Bollati
Boringhieri, Torino [ediz. orig.: Der Frauenlieb als offentlicher Ort,
Hamburg-Zurich, Luchterhand Literaturverlag, 1991].
Duden B. (2006 [2002]), I geni in testa e il feto nel grembo. Sguardo storico
sul corpo della donna, Bollati Boringhieri, Torino [ediz. orig. Die Gene
im Kopf. Der Fotus im Bauch. Historisches zum Frauenkorper, Hannover,
Offizin-Verlag, 2002].
Dupire M. (1985), Contagion, contamination, atavisme: trois concepts serer
ndut (Sénégal), «L’Ethnographie», n. 96-97, pp. 123-139.
Eastwell Harry D. (1982), Voodoo Death and the mechanism for dispatch of
the dying in East Arnhem, Australia, “American Anthropologist”, vol. 84,
n. 1, pp. 5-18.
Ebigbo P. O. (1982), Development of a culture specific (Nigerian) screening
scale of somatic complaints, “Culture, Medicine and Psychiatry”, n. 6, pp.
29-44.
Ebigbo P.O., Ihezue U.H. (1982), Uncertainty in the Use of Western
Diagnostic Illness Categories for Labelling Mental Illness in Nigeria,
“Psychopathologie africaine”, n. 1, pp. 59-74.
Eisenberg Leon (1977), Disease and illness. Distinctions between professional
and popular ideas of sickness, “Culture, Medicine and Psychiatry”, vol. 1,
n. 1, pp. 9-23.
Ellaway A. (2004), Health by association? social capital, social theory, and the
political economy of public health - commentary: can subtle refinements
of popular concepts be put into practice?, “International Journal of
Epidemiology”, vol. 33, n. 4, 2004, pp. 681-682.
Elstad J. I. (1998), The psycho-social perspective on social inequalities in
health, “Sociology of Health and Illness”, vol. 20, n. 5, 1998, pp. 598-618.
Etkin N. L. (1991 [1988]), Cultural constructions of efficacy, pp. 299-
Bibliografia
313
326, in van der Geest Sjaak - Reynolds White Susan (curatori), The
Context of Medicines in Developing Countries. Studies in Pharmaceutical
Anthropology, Amsterdam, Het Spinhuis Publ.
Fabrega H. - Tyma S. (1976a), Language and cultural influence in the
description of pain, “British Journal of Medical Psychology”, vol. 49, pp.
349-371.
Fabrega H. - Tyma S. (1976b), Culture, language, and the shaping of illness:
an illustration based on pain, “Journal of Psychosomatic Research”, vol.
20, n. 4, pp. 323-337.
Fainzang S. (1986), L’intérieur des choses. Maladie, divination et reproduction
sociale chez les Bisa du Burkina, Paris, L’Harmattan.
Fainzang S. (1996), Alcoholism, a contagious disease. A contribution towards
an anthropological definition of contagion, “Culture Medicine and
Psychiatry”, vol. 20, pp. 473-487.
Falteri P. (1989), Medicina popolare / Umbria, pp. 160-165, in Seppilli T.
(curatore), Medicine e magie, Perugia, Electa.
Farmer P. (1992), AIDS and accusation: Haiti and the geography of blame,
Berkeley, University of California Press.
Farmer P. (1996), On suffering and structural violence: a view from below,
“Daedalus”, vol. 125, n. 1, pp. 261–83.
Farmer P. (1999), Infections and inequalities. The modern plagues, Berkeley,
University of California Press.
Farmer P. (2003), Pathologies of power. Health, human rights, and the new war
on the poor, Berkeley - Los Angeles – Oxford, University of California
Press.
Farr J. (2003), Social capital: a conceptual history, “Political Theory”, vol. 31,
n. 10, 2003, pp. 1-28.
Fassin D. – Memmi D. (curatori) (2004), Le gouvernement des corps, Editions
de l’École en Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.
Fassin D. (1992), Pouvoir et maladie en Afrique. Anthropologie sociale dans la
banlieue de Dakar, Paris, Presses Universitaires de France.
Fassin D. (1996), L’espace politique de la santé. Essai de généalogie, Paris,
Presses Universitaires de France.
Fassin D. (2000), Entre politiques du vivant et politiques de la vie. Pour une
anthropologie de la santé, “Anthropologie et sociétés”, vol. 24, n. 1, pp.
95-116.
Fassin D. (2001a), Culturalism as ideology, pp. 300-317, in Obermeyer C.M.
(curatore), Cultural perspectives on reproductive health, Oxford, Oxford
University Press.
Fassin D. (2006 [2001b]), La biopolitica dell’alterità, pp. 303-322, in Quaranta
I. (curatore), Antropologia medica. I testi fondamentali, Milano, Raffaello
Cortina, [ediz. orig.: The biopolitics of otherness, “Anthropology Today”,
Vol. 17, n.1, p. 3-7, 2001b].
Fassin D. (2003), Social capital, from sociology to epidemiology: critical analysis
314
Bibliografia
of a transfer across disciplines, “Revue d’Epidémiologie et de Santé
Publique”, vol. 51, n. 4, 2003, pp. 403-413.
Fassin D. (2006), Un ethos compassionevole. La sofferenza come linguaggio,
l’ascolto come politica, “Annuario di Antropologia”, vol. 8, Sofferenza
Sociale, Roma, Meltemi.
Fassin D. (2007a), When bodies remember. Experiences and politics of AIDS in
South Africa, Berkeley, University of California Press.
Fassin D. (2007b), Humanitarism as a politics of life, “Public Culture”, vol.
19, n. 3, pp. 499-520.
Fassin D. (2010), La raison umanitarie. Une histoire morale du temps présent,
Paris, Gallimard – Seuil.
Favret-Saada J. (1977), Les mots, la mort, les sorts, Paris, Gallimard.
Favret-Saada J. (2009), Désorceler, Paris, Edition de l’Olivier.
Feierman S. - Janzen J. M. (curatori) (1992), The social basis of health and
healing in Africa, Berkeley, University of California Press.
Field J. (2004 [2003]), Il capitale sociale: un’introduzione, Trento, Erickson
[ediz. orig.: Social capital, London, Routledge, 2003].
Fine B. (2000), Social capital versus social theory: political economy and social
science at the turn of the Millennium, London, Routledge.
Fingerson L. (2005), Adolescent’s Medicalization of Menstruation, University
of Wisconsin, Milwaukee, pp.1-11 (paper presented to the Annual
Meeting of the American Sociological Association 2005).
Finkler Kaja (1998), Sacred healing and biomedicine compared, pp. 1019, in Brown Peter J. (curatore), Understanding and applying medical
anthropology, Mountain View, CA, Mayfield Publishing Company.
Fiume G. (curatore) (2003), Guarigioni mirabili. Medicina e teologia tra XIV
e XIX secolo, “Quaderni Storici”, vol. 112, n. 1.
Foley M. - Edwards B. (1999), Is it time to disinvest in social capital?, “Journal
of Public Policy”, vol. 19, 1999, pp. 141-173.
Folgheraiter F. (2006), La cura delle reti, Trento, Erickson.
Ford J. (1979), Ideas which have influenced attempts to solve the problems of
African trypanosomiasis, “Social Science & Medicine”, vol. 13B, pp. 269275.
Foster G. M. - Anderson B. G. (1978), Medical anthropology, New York,
John Wiley & Sons.
Foucault M. (1967 [1966]), Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze
umane, con un saggio critico di G. Canguilhem, traduz. dal francese di
E. Panaitescu, Milano, Rizzoli, [ediz. orig.: Les mots et les choses. Une
archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1966].
Foucault M. (1978 [1976]), Storia della sessualità. La volontà di sapere,
Feltrinelli, Milano [ediz. orig.: Histoire de la sexualité. La volonté de
savoir, Paris, Gallimard, 1976].
Foucault M. (2000 [2004]), Gli anormali. Corso al Collège de France (19741975), Milano, Feltrinelli, 2000[ediz. orig.: Les anormaux. Cours au
Bibliografia
315
Collège de France 1974-1975, Paris, Seuil - Gallimard, 2004].
Foucault M. (2005 [2004]), Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France
(1978-1979), Feltrinelli, Milano [ediz. orig.: Naissance de la biopolitique.
Cours au Collège de France 1978-1979, Paris, Seuil - Gallimard, 2004].
Foucault M. (2006), Utopie Eterotopie, Napoli, Edizioni Cronopio.
Foucault M. (2004 [1971]), L’ordine del discorso e altri interventi, Torino,
Einaudi.
Foville A. (1875), Les aliénés voyageurs ou migrateurs. Étude clinique sur
certains cas de lypémanie, “Annales Médico-Psychologiques”, vol. 2, pp.
5-45.
Fracastoro G. (1950 [1546]), Il contagio, le malattie contagiose e la loro cura,
traduzione, introduzione e note di V. Busacchi, Leo S. Olschki Editore,
Firenze [ediz. orig.: De contagionibus et contagiosis morbis et eorum
curatione, 1546] .
Fracastoro G. (1968 [1546]), La simpatia e l’antipatia delle cose, introduzione,
traduzione e note a cura di P. Gelmetti, Università degli Studi di Bologna
[ediz. orig.: De sympathia et antipathia rerum, 1546].
Frank A. (1995), The Wounded Storyteller: Body, Illness and Ethics, Chicago,
University of Chicago Press.
Frank A. (2001), Can we research suffering?, “Qualitative Health Research”,
vol. 11, n. 3, pp. 353-62.
Franklin S. (2006), Dolly mixtures: the remaking of genealogy, Durham, NC,
Duke University Press.
Frazer J. G. (1973 [1911-15]), Il Ramo d’oro, Boringhieri, Torino [ediz.
orig.: The Golden Bough. A study in magic and religion, 3ª ed. 12 voll.
MacMillan, London, 1911-15].
Friedmann D. (1993 [1987]), I guaritori, Flaccovio, Palermo [ediz. orig.: Les
guérisseurs, Editions Métailié, Paris, 1987].
Frigessi Castelnuovo D. - Risso M. (1982), A mezza parete. Emigrazione,
nostalgia, malattia mentale, Torino, Einaudi.
Frigessi D. (1993), Il modello patologico dell’immigrazione, pp. 43-52, in De
Micco V. - Martelli P. (curatori), Passaggi di confine. Etnopsichiatria e
migrazioni, Napoli, Liguori.
Frohock M. (1992), Healing powers: Alternative medicine, spiritual
communities, and the State, Chicago University Press, Chicago.
Gadamer H.-G. (1983 [1960]), Verità e metodo, trad. it. di G. Vattimo,
Milano, Bompiani [ediz. orig.: Wahrheit und Methode, Tübingen, 1960].
Gadamer H.-G. (1994 [1993]), Dove si nasconde la salute, traduz. dal tedesco
di M. Donati e M. E. Ponzo, Milano, Raffaello Cortina, [ediz. orig.: Über
die Verborgenheit der Gesundheit, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main,
1993].
Gallini C. (1983), La sonnambula meravigliosa. Magnetismo e ipnotismo
nell’Ottocento italiano, Milano, Feltrinelli.
Gallini C. (2006), Giuseppe Pitrè, la Medicina popolare siciliana. Etnografia
316
Bibliografia
e scrittura, “Lares. Quadrimestrale di studi demoetnoantropologici”, a.
LXXII, n. 3, Settembre-Dicembre 2006, Leo S. Olschki, Firenze, pp. 769784.
Gallini Clara (1998a), Il miracolo e la sua prova. Un etnologo a Lourdes,
Napoli, Liguori.
Gallini Clara (1998b), Lourdes e il discorso medico, pp. 191-208, in
Lanternari V. - Ciminelli M. L. (curatori), Medicina, magia, religione,
valori. II. Dall’antropologia all’etnopsichiatria, Napoli, Liguori.
Gardanne C.P.L. de (1821), De la menopause, ou de l’âge critique des femmes,
Paris, Mequignon Marvis.
Garro L. C. - Mattingly C. (2000), Narrative as construct and costruction, pp.
1-49, in Mattingly C. e Garro L. C. (curatrici), Narrative and the cultural
constructions of illness and healing, Berkeley, University of California
Press.
Gaw A.C. (1993), Culture, Ethnicity and Mental Illness, Washington,
American Psychiatric Press.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (2001), Linee guida per la
realizzazione dell’ “ospedale senza dolore”, documento presentato alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, Maggio 2001.
Geertz C. (1987 [1973]), Interpretazione di culture, introduzione all’edizione
italiana di F. Remotti, traduz. dall’inglese di E. Bona, Bologna, il Mulino
[ediz. orig.: The interpretation of cultures, New York, Basic Books, 1973].
Geertz C. (1988 [1974]), “Dal punto di vista dei nativi”: sulla natura della
comprensione antropologica, pp. 71-90, in Geertz C., Antropologia
interpretativa, traduz. dall’inglese di L. Leonini, Bologna, il Mulino
[ediz. orig. del saggio: From the native’s point of view: on the nature of
anthropological understanding, “Bulletin of the American Academy of
Arts and Sciences”, vol. 28, n. 1, 1974, pp. 26-45]
Gentilcore D. (2004), Was there a “popular medicine” in early modern
Europe?, “Folklore”, n. 115, pp. 151-166.
Gergen K. (1994), Realities and Relationship: Sounding in Social Construction,
Cambridge, Cambridge University Press.
Giarelli G. (2005), La svolta narrativa: l’incontro clinico come negoziazione
di significati, pp. 35-50, in Giarelli G. - Good B. J. - Del Vecchio Good
M.-J. - Martini M. - Ruozi C. (curatori), Storie di cura. Medicina narrativa
e medicina delle evidenze: l’integrazione possibile, Milano, Franco Angeli.
Gieryn T. F. (1983), Boundary work and the demarcation of science from
non-science. Strain and interests in professional ideologies of scientists,
“American Sociological Review”, n. 48, pp. 781-795.
Gieryn T. F. (1999), Cultural boundaries of science. Credibility on the line,
Chicago, University of Chicago Press.
Ginsborg P. (2004), Il tempo di cambiare. Politica e potere nella vita quotidiana,
Torino, Einaudi.
Bibliografia
317
Ginzburg F. - Rapp R. (1991), The Politics of Reproduction, “Annual Review
of Anthropology”, vol. 20, pp. 311-343.
Ginzburg C. (1986), Miti emblemi spie. Morfologia e storia, Torino, Einaudi.
Glassner B. (1990), Fit for modern selfhood, in H.S. Becker - McCall M.M.,
Symbolic Interaction and Cultural Studies, Chicago, Chicago University
Press.
Godbout J.T. (1994 [1992]), La circolazione mediante il dono, pp. 25-42, in
Berthoud G. - Godbout J.T. - Nicolas G. - Salsano A., Il dono perduto
e ritrovato, Roma, Manifestolibri [ediz. orig.: La circulation par le don,
“Revue du Mauss”, n. 15.16, 1992, pp. 215-231].
Goffman E. (1983 [1963]), Stigma. L’identità negata, traduzione di R.
Gianmanco, Giuffré Editore, Milano [ediz. orig.: Stigma, New Yersey,
Prentice-Hall, 1963].
Goldner M. (2004), The dynamic interplay between Western medicine and the
complementary and alternative medicine movement: how activists perceive
a range of responses from physicians and hospitals, “Sociology of Health
and Illness”, vol. 26, n. 6, pp. 710-36.
Goldstein M.S. (1999), Alternative health care: Medicine, miracle, or mirage?,
Philadelphia, Temple University Press.
Goldstein M.S. (2000), The culture of fitness and the growth of CAM, pp.
27-38, in Kelner M. - Wellman B. (curatori) (2000), Complementary
and alternative medicine. Challenge and Change, Amsterdam, Harwood
Academic Publisher.
Good B. J. (1999 [1994]), Narrare la malattia. Lo sguardo antropologico sul
rapporto medico-paziente, traduz. dall’inglese di S. Ferraresi, Torino,
Edizioni di Comunità, [ediz. orig.: Medicine, rationality, and experience.
An anthropological perspective, Cambridge, Cambridge University Press,
1994].
Good B. J. (2006 [1977]), Il cuore del problema. La semantica della malattia in
Iran, pp. 31-74, in I. Quaranta, Antropologia medica. I testi fondamentali,
Milano, Raffaello Cortina, [ediz. orig.: The heart of what’s the matter. The
semantic of illness in Iran, “Culture, Medicine and Psychiatry”, vol. 1, n.1,
pp. 25-58, 1977].
Gordon D. - C. Peruselli (2001), Narrazione e fine della vita. Nuove possibilità
per valutare la qualità della vita e della morte, Milano, Franco Angeli.
Gramsci A. (1975), Quaderni del carcere, a cura di V. Gerratana, Torino,
Einaudi.
Gribaudi M. (1996), L’analisi di rete tra struttura e configurazione, “Rassegna
Italiana di Sociologia”, vol. XXXVII, n. 1, 1996, pp. 31-55.
Groleau D. – Young A. – Kirmayer L. (2006), The McGill Illness Narrative
Interview (MINI): an Interview Schedule to elicit meanings and modes of
reasoning related to illness experience, “Transcultural Psychiatry”, vol. 43,
pp. 671-691.
Guerci A. - Consigliere S. (curatori) (2002), Il vecchio allo specchio.
318
Bibliografia
Percezioni e rappresentazioni della vecchiaia, Genova, Erga (serie Vivere e
“curare” la vecchiaia nel mondo, vol. 4)
Guggino E. (1986), Un pezzo di terra di cielo. L’esperienza magica della
malattia in Sicilia, Palermo, Sellerio.
Guggino E. (2006), Fate, sibille e altre strane donne, Palermo, Sellerio.
Hacking I., La riscoperta dell’anima. Personalità multipla e scienze della
memoria, Feltrinelli, Milano, 1996.
Häfner H. (1987), Ørnulv Ødegard, “Social Psychiatry”, vol. 22, n. 3, pp.
177-178.
Hahn R. (1984), Rethinking ‘Illness’ and ‘Disease’, “Contributions to Asian
Studies”, vol. XVIII, p. 1-23.
Hahn R. A. - Kleinman A. (1983), Belief as pathogen, belief as medicine:
‘voodoo death’ and the ‘placebo phenomenon’ in anthropological perspective,
“Medical Anthropology Quarterly”, vol. 14, n. 3, pp. 16-19.
Hahn R. A. (1998), The nocebo phenomenon: concept, evidence, and
implications for public health” , pp. 138-143, in P. J. Brown (curatore),
Understanding and applying medical anthropology, Mountain View (CA),
Mayfield Publishing Company.
Hamayon R. (1990), La chasse à l’âme. Esquisse d’une théorie du chamanisme
sibérien, Nanterre, Société d’Ethnologie.
Haraway D. J. (2000 [1997]), Testimone_modesta@FemaleMan©_incontra_
OncoTopoTM. Femminismo e tecnoscienza, Milano, Feltrinelli, [ediz.orig.:
New York, Routledge, 1997].
Hardon A. - Harries J. (2001), Toward an Anthropology of Contraception:
on the Pill, Control and Embodiment, “AM. Antropologia medica”, vol.
11-12, pp. 211-226.
Harrag - Gruppo di Ricerca per la Salute Mentale Multiculturale (2007), Di
clinica in lingue. Migrazioni, psicopatologia, dispositivi di cura, Paderno
Dugnano, Ediz. Colibrì.
Heggenhoughen H.K. - Clements J. (1987), Acceptability of childhood
immunization: social science perspectives, Evaluation and Planning Centre
for Health Care - London London, School of Hygiene and Tropical
Medicine, (Epc Publication n. 14).
Henningsen G. (1990), The “Ladies from Outside”: an archaic pattern of the
witches Sabbath, pp. 191-217, in Henningsen G. - Ankarloo B. (curatori),
Early Modern European Witchcraft. Centres and peripheries, Clarendon
Press, Oxford [trad. it.: Le “donne di fuori”: un modello arcaico del sabba,
con una nota di E. Guggino, “Archivio Antropologico Mediterraneo.
Semestrale di studi e ricerche”, a. I, n. 0, 1998, pp. 35-60].
Héritier-Augé F. (1992), Ce mal invisible et sournois, pp. 148-157, in
L’homme contaminé. La tourmente du sida, Paris, Editions Autrement,
(Série Mutations n. 130).
Héritier F. (1997 [1996]), Maschile e femminile. Il pensiero della differenza,
Laterza, Roma-Bari [ediz. orig.: Masculin/Feminin. La Pensèe de la
difference, Paris, Odile Jacob, 1996].
Bibliografia
319
Héritier F. (2004 [2002], Maschile e femminile, II. Dissolvere la gerarchia,
Raffaello Cortina, Milano [ediz. orig.: Masculin/Feminin II. Dissoudre la
hiérarchie, Paris, Odile Jacob, 2002].
Hernst F. (1949), Vom Heimweh, Zurich, Fretz & Wesmuth.
Hersch Martínez P. (1997), Tlazol e Ixtlazol: persistenza degli “aires de
basura” (Estado de Puebla, México), “AM. Rivista della Società Italiana di
Antropologia Medica”, vol. 3-4, pp. 41-67.
Herzfeld M. (1997), Cultural Intimacy. Social Poetics in the Nation-State,
New York-London, Routledge.
Herzfeld M. (2009), Evicted from eternity. The restructuring of modern Rome,
Chicago – London, The University of Chicago Press.
Hinton D., Hinton S., Um K., Chea A., Sak S. (2002), The Khmer Weak Heart
Syndrome: Fear of Death from Palpitations, “Transcultural Psychiatry”,
vol. 39, n. 3, pp. 323-344.
Hollenberg D. (2006) Uncharted ground. Patterns of professional interaction
among complementary/alternative and biomedical practitioners in
integrative health care settings, “Social Science and Medicine”, vol. 62, n.
3, pp. 731-744.
Hughes C. - Hunter J. M. (1970), Disease and development in Africa, “Social
Science & Medicine”, vol. 3, n. 4, pp. 443-493.
Hughes C.C. (1998), The Glossary of “Culture-Bound Syndromes” in DSM IV:
a Critique, “Transcultural Psychiatry”, vol. 35, n. 3, pp. 413-421.
Ilechukwu T.C. (1990-1991), Ogbanje/Abiku: a Culture-Bound Construct of
Childhood and Family Psychopathology in West Africa, Psychopathologie
africaine, n. 1, pp. 19-63.
Illich I. (1977 [1976]) , Nemesi medica. L’espropriazione della salute,
Mondadori, Milano [ediz. orig.: Limits to Medicine, Medical Nemesis: the
expropriation of Health, New York, Pantheon Books, 1976].
Inglese S. (1999a), Radici strappate e malattie migranti. Intorno al costrutto
nosologico di Culture-Bound Syndrome, pp. 109-133, in Cardamone G.
- Inglese S. - Zorzetto S. (curatori), Djon djongonon. Psicopatologia e
salute mentale nelle società multiculturali, Edizioni Colibrì, Paderno
Dugnano.
Inglese S. (1999b), Un passo avanti e due indietro: claudicanze intermittenti
e senza meta intorno alle condizioni psicotraumatiche in tempo di guerra
asintotica, “I Fogli di Oriss”, n. 11/12, pp. 73-99.
Inglese S. (2000), La follia perfetta: sulla schizofrenia come psicosi etnica,
pp. 169-201, in Tagliavini G. - Cardamone G. (curatori), Ripensare le
schizofrenie. Un dibattito italiano, Paderno Dugnano, Edizioni Colibrì.
Inglese S. (2002), Etnopsichiatria comunitaria: profughi e rifugiati in Calabria,
“Psichiatria e Territorio”, vol. XX, supplemento al n. 2, pp. 41-44.
Inglese S. (2005), A sud della mente. Etnopsichiatria e psicopatologia delle
migrazioni in sei movimenti, pp. 61-163, in Attenasio L. - Casadei
F. - Inglese S. - Ugolini O. (curatori), La cura degli altri. Seminari di
320
Bibliografia
etnopsichiatria, Roma, Armando.
Inglese S. - Cardamone G. (1996), Psichiatria e alterità culturale. La questione
dell’immigrazione, “I Fogli di Informazione”, vol. XXIV, n. 168, pp. 1527.
Inglese S. - Cardamone G. - Da Prato M. (2008), Proposta di un confronto
etnopsichiatrico tra fattura e paranoia, pp. 133-148, in Cardamone G.
- Dalle Luche R. (curatori), La paranoia. Psichiatria e antropologia,
Edizioni ETS, Pisa.
Inglese S. - peccarisi C. (1997), Psichiatria oltre frontiera. Viaggio intorno alle
sindromi culturalmente ordinate, Milano, UTET.
Inglese S. - Peccarisi C. - Casadei F. (2002), Ethnical Sexuality Disorders
and Migration: the Koro Case, in IIIrd European Conference on Travel
Medicine, Book of Astracts, Florence.
International Association for the Study of Pain (1979), Pain terms: a list
with definitions and notes on usage, “Pain”, vol. 6, n. 1, 1979, pp. 249-252.
Janzen J. M. (1978), The quest for therapy in lower Zaire, Berkeley, University
of California Press.
Janzen J. M. (1979), Pluralistic legitimation of therapy systems in contemporary
Zaire, pp. 208-216, in Ademuwagun Z. – Ayoade J.A.A. – Harrison I.E. Warren D.M. (curatori), African therapeutic systems, London, Crossroad
Press.
Janzen J. M. (1981), The need for a taxonomy of health in the study of African
therapeutics, “Social Science and Medicine”, vol. 15B, pp. 185-194.
Jaspers K. (1965), Psicopatologia generale, Roma, Il Pensiero Scientifico
Editore.
Jenkins J. (1998), Diagnostic Criteria for Schizophrenia and Related Psychotic
Disorders: Integration and Suppression of Cultural Evidence in DSM-IV,
“Transcultural Psychiatry”, vol. 35, n. 3, pp. 357-376.
Jewson N. (1976), The disappearance of the sick man from medical cosmology,
“Sociology”, vol. 10, pp. 225-244.
Johannessen H. (2009), Exclusive inclusions: cancer practices in Toscana and
Southern Denmark, “AM. Rivista della Società italiana di antropologia
medica”, Embodiment and the State. Health, Biopolitics and the Intimate
Life of State Powers, Pizza G. - Johannessen H. (curator), n. 27-28 /
ottobre 2009, pp. 137-160.
Jouanna J. (1994 [1992]), Ippocrate, traduz. dal francese di L. Rebaudo,
Torino, SEI, [ediz. orig.: Hippocrate, Paris, Librairie Arthème Fayard,
1992].
Justice J. (1997), The medical anthropology of leprosy and its control, in
The Role of Medical Anthropology in Infectious Disease Control. An
International Symposium, Heidelberg University, 23-26 aprile 1997.
Kangas I. (2001), Making sense of Depression: perception of melancholia in lay
narratives, “Health”, vol. 5, n.1, pp. 76-92.
Kapferer B. (curatore) (2005), The Retreat of the Social: The Rise and Rise of
Bibliografia
321
Reductionism, New York – Oxford, Berghahn Books.
Kaplan G. A. - Pamuk E. R. - Lynch J. W. - Cohen R. D. - Balfour J. L.
(1996), Inequality in income and mortality in the United States: analysis of
mortality and potential pathways, “British Medical Journal”, vol. 312, n.
7037, 1996, pp. 999-1003.
Kawachi I. (1999), Social capital and community effects on population and
individual health, “Annals of the New York Academy of Sciences”, vol.
896, 1999, pp. 120-130.
Kawachi I. - Kennedy B. P. - Lochner K. - Prothrow-Stith D. (1997), Social
capital, income inequality, and mortality, “American Journal of Public
Health”, vol. 87, n. 9, 1997, pp. 1491-1498.
Kawachi I. - Kennedy B. P. (1997), Socioeconomic determinants of health:
health and social cohesion: why care about income inequality?, “British
Medical Journal”, n. 314, 1997, pp. 1037-1040.
Kawachi, I. - Kennedy B. P. (2002), The health of nations: why inequality is
harmful to your health, New York, New York Press.
Kawachi I. - Kim D. - Coutts A. - Subramanian S. V. (2004), Health by
association? Social capital, social theory, and the political economy of
public health - commentary: reconciling the three accounts of social capital,
“International Journal of Epidemiology”, vol. 33, n. 4, 2004, pp. 682-690.
Kelly M. (1992), Self, identity and radical surgery, “Sociology of Health and
Illness”, vol. 14, n.3, pp. 390-415.
Kelner M. - Wellman B. (curatori) (2000), Complementary and alternative
medicine. Challenge and Change, Amsterdam, Harwood Academic
Publisher.
Kendall C. (1989), The use and non-use of anthropology: the diarrheal
disease control program in Honduras, in Van Willigen J. - Rylko-Bauer
B. - McElroy A. (curatori), Making our research useful, San Francisco,
Westview Press.
Kennelly B. - O’Shea E. - Garvey E. (2003), Social capital, life expectancy and
mortality: a cross-national examination, “Social Science and Medicine”,
vol. 56, n. 12, 2003, pp. 2367-2377.
Kezich G. - Seppilli T. (curatori) (2003), Saperi terapeutici tradizionali
nell’arco alpino, “Annali di San Michele”, vol. 16, San Michele all’Adige,
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina.
Kiev A. (curatore) (1974), Magic, Faith and Healing. Studies in Primitive
Psychiatry Today, New York, Free Press.
Kim D. - Subramanian S. V. - Kawachi I. (2006), Bonding versus bridging social
capital and their associations with self related health: a multilevel analysis of
40 US communities, “Journal of Epidemiology and Community Health”,
vol. 60, n. 2, 2006, pp. 116-122.
Kirmayer L. J. (1998), Editorial: The Fate of Culture in DSM-IV, “Transcultural
Psychiatry”, vol. 35, n. 3, pp. 339-342.
Kirmayer L. J. (1993), Healing and the invention of metaphor: the effectiveness
322
Bibliografia
of symbols revisited, “Culture, Medicine and Psychiatry, vol. 17, n. 2, pp.
161-195.
Kleinman A. (1973), Medicine’s symbolic reality. On a central problem in the
philosophy of medicine. “Inquiry”, vol. 16, pp. 206-213.
Kleinman A. (1978), Concepts and a model for the comparison of medical
systems as cultural systems, “Social Science & Medicine”, vol. 12, pp. 8593.
Kleinman A. (1980), Patients and healers in the context of culture. An
exploration of the borderland between anthropology, medicine, and
psychiatry, Berkeley, University of California Press.
Kleinman A. (1982), Neurasthenia and depression. A study of somatization and
cultura in China, “Culture, Medicine and Psychiatry”, vol. 6, pp. 117-190.
Kleinman A. (1986), Social Origins of Distress and Disease. Depression,
Neurasthenia and Pain in Modern China, New Haven, Yale University
Press.
Kleinman A. (1987), Anthropology and Psychiatry. The Role of Culture in
Cross-Cultural Research on Illness, “British Journal of Psychiatry”, vol.
151, pp. 447-454.
Kleinman A. (1988a), The illness narratives. Suffering, healing and the human
condition, New York, Basic Books.
Kleinman A. (1988b), Rethinking Psychiatry. From Cultural Category to
Personal Experience, New York, The Free Press.
Kleinman A. (1995), Writing at the margin. Discourse between anthropology
and medicine, Berkeley, University of California Press.
Kleinman A. (2006 [1978]), Alcuni concetti e un modello per la comparazione
dei sistemi medici intesi come sistemi culturali, pp. 5-29, in Quaranta I.
(curatore), Antropologia medica. I testi fondamentali, Milano, Raffaello
Cortina [ediz. orig. del saggio: Concepts and a model for the comparison
of medical systems as cultural systems, “Social Science and Medicine”, vol.
12, pp. 85-93].
Kleinman A. - Eisenberg L. - Good B. J. (1989 [1978]), Cultura, stato di
sofferenza e cure. Lezioni cliniche dalla ricerca antropologica e transculturale,
“Sanità Scienza e Storia”, vol. 1, pp. 3-26 [ediz. orig.: Culture, illness
and care: clinical lessons from anthropological and cross-cultural research,
“Annals of Internal Medicine”, vol. 88, 1978, pp. 251-258].
Kleinman A. - Sung L. H. (1979), Why do indigenous practitioners successfully
heal?, “Social Science and Medicine”, vol. 13B, pp. 7-26.
Kleinman A. - Das V. - Lock M. (curatori), (1997), Social suffering, University
of California Press, Berkeley.
Kraepelin E. (1996 [1904]), Psichiatria comparativa (1904), “I Fogli di Oriss”,
n. 6, pp. 193-198.
Krieger N. (curatrice) (2005), Embodying Inequality. Epidemiologic
Perspectives, Amityville, NY, Baywood Publishing Company.
Kuhn T.S. (1969), La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino.
Bibliografia
323
Lakoff A. (2006), Pharmaceutical reason: knowledge and value in global
Psychiatry, Cambridge, Cambridge University Press.
Lalli P. (1988), L’altra medicina e i suoi malati. Un’indagine nel sociale delle
pratiche di cura alternative, Bologna, Clueb.
Lanternari V. (1994), Medicina, magia, religione, valori, vol. I, Napoli,
Liguori.
Last M. (1981), The importance of knowing about not knowing, “Social
Science and Medicine”, vol. 15B, pp. 387-392.
Latour B. (1995 [1991]), Non siamo mai stati moderni. Saggio di antropologia
simmetrica, Milano, Elèuthera [ediz. orig.: Nous n’avons jamais été
modernes, Paris, Éditions La Découverte, 1991].
Latour B. (2001), Factures/fractures: de la notion de réseau à celle
d’attachement, “Ethnopsy”, n. 2, pp. 43-66.
Latour B. (2005 [1996]), Il culto moderno dei fatticci, Roma, Meltemi
Le Breton D. (1991), Corps et anthropologie. De l’efficacité symbolique,
“Diogène”, vol. 153, pp. 92-107.
Le Breton D. (1995), Anthropologie de la douleur, Paris, Éditions Métailié.
Le Roy Ladurie E. (1979), The Territory of the Historian, Hassocks, Harvester.
Lee R. P. L. (1982), Comparative studies of health care systems, “Social Science
and Medicine”, vol. 16, n. 6, pp. 629-642.
Lee-Treweek G. (curatore) (2005a), Complementary and alternative medicines:
Structures and Safeguards, London, Routledge.
Lee-Treweek G. (curatore) (2005b), Perspectives on complementary and
alternative medicine. A reader, London, Routledge.
Leff J. (1988), Psychiatry around the Globe. A Transcultural View, London,
Gaskell.
Leroi-Gourhan A. (1977 [1964]), Il gesto e la parola, traduz. dal francese di F.
Zannino, Torino, Einaudi [ediz. orig.: Le geste et la parole, Editions Albin
Michel, Paris, 1964].
Leslie C. (1980), Medical pluralism in world perspective, “Social Science &
Medicine”, vol. 14 B, pp. 191-195.
Lévi-Strauss C. (1975a [1949]), Lo stregone e la sua magia, pp. 189-209,
in Lévi-Strauss C., Antropologia strutturale, traduz. dal francese di P.
Caruso, Milano, Il Saggiatore, [ediz. orig. del saggio: Le sorcier et sa
magie, “Les temps modernes”, vol. 4, n. 41, 1949, pp. 3-24].
Lévi-Strauss C. (1975b [1949]), L’efficacia simbolica, pp. 210-230, in LéviStrauss C., Antropologia strutturale, traduz. dal francese di P. Caruso,
Milano, Il Saggiatore, [ediz. orig. del saggio: L’efficacité symbolique,
“Revue de l’Histoire des Religions”, vol. 135, n. 1, 1949, pp. 5-27].
Lewis G. A. (1997 [1977]), La paura della stregoneria e il problema della
morte per suggestione, “AM. Rivista della Società italiana di antropologia
medica”, vol. 3-4, 1997, pp. 281-312 [ediz. orig.: Fear of sorcery and the
problem of death by suggestion, pp. 111-143, in Blacking John (curatore),
The anthriopology of the body, London, Academic Press, 1977].
324
Bibliografia
Lewis I. M. (1972 [1971]), Le religioni estatiche. Studio antropologico sulla
possessione spiritica e sullo sciamanismo, traduz. dall’inglese di F. Cardelli,
Roma, Ubaldini [ediz. orig.: Ecstatic religion. An anthropological study of
spirit possession and shamanism, Harmondsworth, Penguin, 1971].
Lewis Ioan M. (1993 [1986]), Possessione, stregoneria, sciamanismo. Contesti
religiosi nelle società tradizionali, a cura di V. Lanternari, traduzione
dall’inglese di A. Di Nola, Napoli, Liguori, [ediz. orig.: Religion in
context. Cults and charisma, 1986, Cambridge, Cambridge University
Press, 1986].
Lex Barbara W. (1974), Voodoo death: new thoughts on an old explanation,
“American Anthropologist”, vol. 76, vol. 4, pp. 818-823.
Liefooghe R. - Michiels N. - Habib S. - Moran M.B. - De Muynk A. (1995),
Perception and social consequences of tuberculosis patients in Sialkot,
Pakistan, “Social Science & Medicine”, vol. 41, pp. 1685-1692.
Lin N. (2001), Social capital: a theory of social structure and action, New York,
Cambridge University Press.
Linton R. (1956), Culture and Mental Disorders, Springfield, Charles C.
Thomas Publisher.
Lionetti R. (1994), “Bana Jugu”: la malattia cattiva. Rappresentazioni del
contagio e percezione di una malattia nuova fra i guaritori tradizionali
del Mali, relazione al convegno “Ripensare l’Aids”, Bologna, 29 aprile-1
maggio 1994.
Lionetti R. (1988), L’efficacia terapeutica: un problema antropologico, “La
ricerca folklorica”, vol. 17, pp. 3-6.
Lipton J. A. - Marbach J. J. (1984), Ethnicity and the pain experience, “Social
Science and Medicine”, vol. 19, pp. 1279-1298.
Lis Quibén Víctor (1980 [1949]), La medicina popular en Galicia, prologo di
F. Bouza Brey, Madrid, Akal [ediz. orig.: Gráficas Torres, Pontevedra,
1949].
Littlewood R. (1990), From Categories to Context. A Decade of New CrossCultural Psychiatry, “British Journal of Psychiatry”, n. 156, pp. 308-327.
Littlewood R. (1997), L’identità e le sue vicissitudini: patologie del futuro, “I
Fogli di Oriss”, n. 7/8, pp. 85-101.
Littlewood R. (curatore) (2007), On knowing and not knowing in the
anthropology of medicine, Walnut Creek, Left Coast Press.
Littlewood R., Lipsedge M. (1987), The Butterfly and the Serpent: Culture,
Psychopathology and Biomedicine, “Culture, Medicine and Psychiatry”,
vol. 11, pp. 289-335.
Lochner K. - Kawachi I. - Kennedy B. P. (1999), Social capital: a guide to its
measurement, “Health & Place”, vol. 5, n. 4, 1999, pp. 259-270.
Lock M. (1993), Encounters with Aging: Mythologies of Menopause in Japan
and North America, Berkeley, University of California Press.
Lock M. (2001) The Tempering of Medical Anthropology: Troubling Natural
Categories, “Medical Anthropology Quarterly”, vol. 15, n. 4, pp.478-492.
Bibliografia
325
Lock M. (2003), Medicalization and the Naturalization of Social Control, pp.
116- 125, in C. Ember - M. Ember (curatore), Encyclopedia of Medical
Anthropology, New York, Springer.
Lock M. (2009), Globalization and the State: is an era of neoeugenis in the
offing?, “AM. Rivista della Società italiana di antropologia medica”, n.
27-28 / ottobre 2009, pp. 261-295, Embodiment and the State. Health,
Biopolitics and the Intimate Life of State Powers, Pizza G. - Johannessen
H. (curatori).
Lock M. - Kaufert P. A. (1998), Introduction to Pragmatic Women and Body
Politics, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 1-27.
Lock M. - Nguyen V. K. (2010), An Anthropology of Biomedicine, Oxford,
Wiley - Blackwell, London.
Lock M. - Scheper-Hughes N. (2006 [1990]), Un approccio criticointerpretativo in antropologia medica. Rituali e pratiche disciplinari e di
protesta, pp. 149-194, in Quaranta I. (curatore), Antropologia medica. I
testi fondamentali, traduz. dall’inglese di E. Fabietti, Milano, Raffaello
Cortina, [ediz. orig. del saggio: A critical-interpretive approach in medical
anthropology: ritual and routines of discipline and dissent, pp. 47-72,
in Johnson T. M. - Sargent C. F. (curatori), Medical anthropology.
Contemporary theory and method, Westport (CT), Praeger, 1990].
Long M. (2008), The Impact of Medicalization on the Authority of Women
Healers, University Honors College, Honors (thesys of Baccalaureate of
Science in Psychology).
Losi N. (1990), Gli amici dell’acqua. Medici, pazienti e medicine alternative,
Milano, Franco Angeli.
Lupo A. (1998), Postille sulle trasformazioni della medicina tradizionale in
Messico, pp. 185-214, in Lupo A. (curatore), La cultura plurale. Riflessioni
su dialoghi e silenzi in Mesoamerica. Omaggio a Italo Signorini, “Quaderni
de L’Uomo”, n. 2, Roma, CISU.
Lupo A. (1999), Capire è un po’ guarire: il rapporto paziente-terapeuta tra
dialogo e azione, “AM. Rivista della Società Italiana di Antropologia
Medica”, vol. 7-8, pp. 53-92.
Lupo A. (2007), Incontro, fusione e conflitto tra saperi medici nel Messico
indigeno, pp. 77-94, in Giannelli L. (curatore), Mesoamérica como área
de intercambio lingüístico y cultural, Siena, Centro Interdipartimentale di
Studi sull’America Indigena - Università degli Studi di Siena.
Lynch J. W. (2000), Income inequality and health: expanding the debate,
“Social Science and Medicine”, vol. 51, n. 7, 2000, pp. 1001-1005.
Lynch J.W. - Davey Smith G. - Hillemeier M. - Shaw M. - Raghunathan T.
- Kaplan G. A. (2001), Income inequality, the psychosocial environment,
and health: comparisons of wealthy nations, “Lancet”, vol. 358, n. 9277,
2001, pp. 194-200.
Lynch J.W. - Davey Smith G. - Kaplan G. A. - House J. (2000), Income,
inequality and mortality: importance to health of individual income,
326
Bibliografia
psychosocial environment, or material conditions, “British Medical
Journal”, vol. 320, n. 7243, 2000, pp. 1200-1204.
Lynch J.W. - Due P. - Muntaner C. - Davey Smith G. (2000), Social capital: is
it a good investment strategy for public health?, “Journal of Epidemiology
and Community Health”, vol. 54, n. 6, 2000, 404-408.
Lynch J.W. - Kaplan G. A. - Salonen J. T. (1997), Why do poor people behave
poorly? Variation in adult health behaviours and psychosocial characteristics
by stages of the socioeconomic lifecourse, “Social Science and Medicine”,
vol. 44, n. 6, 1997, pp. 809-819.
Lyons M. (1985), From ‘Death Camps’ to ‘Cordon Sanitaire’: the development
of sleeping sickness policy in the Uele District of the Belgian Congo 19031914, “Journal of African History”, 26, 1985, pp. 69-91.
M’Bokolo E. (1986 [1984]), Storia delle malattie, storia e malattia: l’Africa,
pp. 145-174, in Augé M. - Herzlich C. (curatori), Il senso del male.
Antropologia, storia e sociologia della malattia, ediz. italiana a cura di
F. Maiello, traduz. dal francese di A. Wouters – L. Ferri, Milano, Il
Saggiatore [ediz. orig.: Histoire des maladies, histoire et maladie: l’Afrique,
in Augé M. - Herzlich C. (curatori), Le sens du mal. Anthropologie, histoire,
sociologie de la maladie, Paris, Éditions des Archives Contemporaines,
1984].
Mageo J.M. - Knauft B.M. (2002), Introduction: theorizing power and the
self, pp. 1-25, in Mageo J.M. (curatore) (2002), Power and the Self,
Cambridge, Cambridge University Press.
Malaguti R. (2006), Le mie cose, Milano, Bruno Mondadori.
Manderson L. (1997), Community and context, belief and behaviour: social
interventions for the prevention and control of Malaria, in The Role of
Medical Anthropology in Infectious Disease Control, An International
Symposium, Heidelberg University, 23-26 aprile 1997.
Mani E. - Zorzetto S. - Cardamone G. (2009), Pensare l’alcol nelle culture
dei migranti. Riflessioni su una ricerca etnografica a Bergamo, “Animazione
Sociale”, n. 233, maggio, pp. 79-86.
Martin E. (2001), The woman in the Body. A Cultural Analysis of Reproduction,
Boston, Beacon Press.
Martínez Hernáez Ángel (1998), L’antropologia del sintomo. Fra ermeneutica
e teoria critica, “AM. Rivista della Società italiana di antropologia medica”,
vol. 5-6, pp. 7-37.
Marx K. (1994 [1867]), Il capitale. Critica dell’economia politica. Libro Primo,
Roma, Editori riuniti, [ediz. orig.: Das Kapital, 1867].
Massé R. (1997), Les mirages de la rationalité des savoirs ethnomédicaux,
«Anthropologie et Société», vol. 21, n. 1, 1997, pp. 53-72.
Mattalucci-Yılmaz C. (2003), Introduzione, “Antropologia”, vol. 3, n. 3, pp.
5-17, n. monografico a cura di C. Mattalucci-Yilmaz, Corpi.
Matteucci N. (2005 [1984]), Lo Stato, Bologna, il Mulino.
Mattingly C. (1994), The concept of therapeutic ‘emplotment’, “Social Science
Bibliografia
327
and Medicine”, vol. 38, n. 6, pp. 811-822.
Mattingly C. (2005), Toward a vulnerable Ethics of research practice, “Health”,
vol.9, n. 4, pp. 453-471.
Maturo A. (2010), La medicalizzazione della normalità nella società bionica,
quali rischi?, pp. 83-95, in Bontempi M. – Maturo A. (curatori), Salute e
salvezza. I confini mobili tra sfere della vita, Milano, Franco Angeli
Maturo A. – Conrad P. (curatori), La medicalizzazione della vita, “Salute e
Società”, a. VIII, n. 2.
Mauss M. (1965a [1926]), Effetto fisico nell’individuo dell’idea di morte
suggerita dalla collettività (Australia, Nuova Zelanda), pp. 327-347, in
Mauss M., Teoria generale della magia e altri saggi, traduz. dal francese
di F. Zannino, Torino, Einaudi [ediz. orig. del saggio: Effet physique chez
l’individu de l’idée de mort suggérée par la collectivité (Australie, Nouvelle
Zelande), “Journal de Psychologie Normale et Pathologique”, vol. 23,
1926, pp. 652-669]
Mauss M. (1965b [1935]), Le tecniche del corpo, pp. 383-409, in Mauss M.,
Teoria generale della magia e altri saggi, traduz. dal francese di F. Zannino,
Torino, Einaudi [ediz. orig. del saggio: Les techniques du corps, “Journal
de Psychologie”, vol. 32, nn. 3-4, pp. 271-293, 1935].
McCaffery M. (1983), Nursing: the patient in pain, London, Harper Row.
McCaffery M. (1994), Nursing management of the patient in pain,
Philadelphia, Lippincott.
Merli C. (1999), Il corridore di Amok: dall’eroico guerriero al folle internato.
Mutamenti della visione di un fenomeno culturale malese trasformato in
sindrome psichiatrica, “AM. Rivista della Società Italiana di Antropologia
Medica”, n. 7-8, pp. 209-250.
Middelthon A.L. (2009), The duty to feed and eat right, “AM. Rivista della
Società italiana di antropologia medica”, n. 27-28 / ottobre 2009, pp. 209225, n. monografico Pizza G. - Johannessen H. (curatori), Embodiment
and the State. Health, Biopolitics and the Intimate Life of State Powers.
Migliore S. (1989), Punctuality, pain and time-orientation among SicilianCanadians, “Social Science and Medicine”, vol. 28, n. 8, pp. 851-860.
Mills C. W. (1995 [1959]), L’immaginazione sociologica, Milano, Il Saggiatore
[ediz. orig. The sociological imagination, Oxford, Oxford University
Press, 1959].
Minelli M. (2007), Capitale sociale e salute. Una bibliografia ragionata,
Perugia, Morlacchi Editore.
Minelli M. (2008), Scambi e devozioni nella ricerca di guarigione, “Umbria
Contemporanea. Rivista di studi storico-sociali”, n. 10-11, dicembre
2008, pp. 289-307.
Minelli M. (2009), Self-control and administrative grotesque in psychiatric
practice, “AM. Rivista della Società italiana di antropologia medica”, n.
27-28 / ottobre 2009, pp. 161-182, Pizza G. - Johannessen H. (curatori),
Embodiment and the State. Health, Biopolitics and the Intimate Life of
328
Bibliografia
State Power..
Minelli M. (2011), Santi, demoni, giocatori. Una etnografia delle pratiche di
salute mentale, Lecce, Argo.
Moerman D. E. (1979), Anthropology of symbolic healing, “Current
Anthropology”, vol. 20, n. 1, pp. 59-80.
Moerman D. E. (2004 [2002]), Placebo. Medicina, biologia, significato, traduz.
dall’inglese di S. Galli, Vita e Pensiero, Milano [ediz. orig.: Meaning,
medicine and the ‘placebo effect’, Cambridge, Cambridge University Press,
2002].
Morris D. B. (2002), Narrative, Ethics and Pain: Thinking with Stories, pp.
123-145, in Charon R. - Montello M. (curatori) Stories Matter: the Role
of Narrative in Medical Ethics, London and New York, Routledge.
Muehlebach A. (2011), On affective labor in post-fordist Italy, “Cultural
Anthropology”, vol. 26, n.1, 2011, pp. 59-82.
Mull D. (1989), Culture and compliance among leprosy patients in Pakistan,
“Social Science & Medicine”, vol. 29, pp. 799-811.
Muntaner C. - Lynch J. W. - Davey Smith G. (2000), Social capital and the
third way in public health, “Critical Public Health”, vol. 10, n. 2, 2000,
pp. 107-124.
Muntaner C. - Lynch J. W. - Davey Smith G. (2001), Social capital, disorganized
communities, and the third way: understanding the retreat from structural
inequalities in epidemiology and public health, “International Journal of
Health Services”, vol. 31, n. 2, 2001, pp. 213-237.
Muntaner C. - Lynch J. W. - Hillemeier M. - Lee J. H. - David R. - Benach
J. - Borrell C. (2002), Economic inequality, working-class power, social
capital, and cause-specific mortality in wealthy countries, “International
Journal of Health Services”, vol. 32, n. 4, 2002, pp. 629-656.
Muntaner C. - Lynch J. W. - Oates G.L. (2002), The social class determinants
of income inequality and social cohesion, pp. 367-399, in Navarro V.
(curatore), The political economy of social inequalities. Consequences for
health and quality of life, Amityville, NY, Bay-Wood.
Muntaner C. - Lynch J. W. (2002), Social capital, class gender and race conflict,
and population health: an essay review of Bowling alone’s implications for
social epidemiology, “International Journal of Epidemiology”, vol. 31, n.
1, 2002, pp. 261-267.
Muntaner C. (2004), Commentary: social capital, social class, and the
slow progress of psychosocial epidemiology, “International Journal of
Epidemiology, vol. 33, n. 4, 2004, pp. 674-680.
Murphy H. B. M. (1961), Social Change and Mental Health, “The Milbank
Memorial Fund Quarterly”, vol. 39.
Murphy H. B. M. (1977), Transcultural Psychiatry Should Begin at Home,
“Psychological Medicine”, vol. 7, pp. 369-371.
Murphy H. B. M. (1982), Comparative Psychiatry: The International and
Intercultural Distribution of Mental Illness, Berlin-New York, Springer.
Bibliografia
329
Mutti A. (1994), I sentieri dello sviluppo, “Rassegna Italiana di Sociologia”,
anno XXXV, n. 1, 1994, pp. 109-119.
Mutti A. (1998), Capitale sociale e sviluppo, Bologna, il Mulino.
Narotzky S. (2007), The project in the model: reciprocity, social capital and
the politics of ethnographic realism, “Current Anthropology”, vol. 44, n.
3, 2007, pp. 413-414.
Nathan T. (1990 [1986], La follia degli altri. Saggi di etnopsichiatria, traduz.
dal francese di M. Pandolfi, Ponte alle Grazie, s.l. [ediz. orig.: La folie
des autres. Traité d’ethnopsychiatrie clinique, Dunod, Paris, 1986].
Nathan T. (1994), L’influence qui guérit, Paris, Éditions Odile Jacob.
Nathan T. (1996), Princìpi di etnopsicoanalisi, Torino, Bollati Boringhieri.
Nathan T. (1998), Quale avvenire per la psicoterapia, in Pichot P. - Nathan
T., Quale avvenire per la psichiatria e la psicoterapia?, Paderno Dugnano,
Colibrì.
Nathan T. (2000), Actualité de la schizophrénie, “Ethnopsy. Les mondes
contemporaines de la guérison”, n. 1.
Nathan T. (2001), Nous ne sommes pas seuls au monde, Paris, Les Empêcheurs
de penser en rond/Le Seuil.
Nathan T. (2005), Etnopsichiatria, complementarismo, possessione, pp. 164178, in Attenasio L. - Casadei F. - Inglese S. - Ugolini O. (curatori), La
cura degli altri. Seminari di etnopsichiatria, Roma, Armando.
Nathan T., Stengers I. (1996 [1995]), Medici e stregoni, trad. dal francese di
S. Inglese e A. Salsano, Torino, Bollati Boringhieri [ediz. orig.: Médecins
et sorciers. Manifeste pour une psychopatologie scientifique. Le médicin et le
charlatan, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 1995].
Navarro V. (2002a), A critique of social capital, “International Journal of
Health Services”, vol. 32, n. 3, 2002, pp. 423-432.
Navarro V. (curatore) (2002b), The political economy of social inequalities:
consequences for health and quality of life, Baywood, Amityville, NY.
Navarro V. (2004), Health by association? Social capital, social theory, and
the political economy of public health - commentary: is capital the solution
or the problem?, “International Journal of Epidemiology”, vol. 33, n. 4,
2004, pp. 672-674.
Navarro V. - Muntaner C. (curatori) (2004), Political and economic
determinants of population health and well-being: controversies and
developments, Amityville, NY, Baywood.
Nguyen V.-K. (2006), Attivismo, farmaci anti-retrovirali e riplasmazione del sé
come forme di cittadinanza biopolitica, “Annuario di Antropologia”, vol.
8, Sofferenza Sociale, Meltemi, Roma.
Nguyen V. K. - Peschard K. (2003), Anthropology, inequality, and disease: a
review, “Annual Review of Anthropology”, vol. 32, 2003, 447-474.
Nichter M. (1989), Anthropology and international health. South Asian case
studies, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers.
Nichter M. (1994), Illness semantics and international health: the weak lungs/
330
Bibliografia
TB complex in the Philippines, “Social Science & Medicine”, vol. 38, n. 5,
pp. 649-663.
Nigris D. (2008), Epistemologia delle narrazioni di malattia: un frame
concettuale per l’analisi della illness, pp. 130-153, in Lanzetti C. - Lombi
L. - Marzulli M. (curatori), Metodi qualitativi e quantitativi per la ricerca
sociale in sanità, Milano, Franco Angeli.
O’Connor B.B. (1995), Healing traditions. Alternative medicine and the
health professions, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
Ohnuki-Tierney E. (1981), Illness and healing among the Sakhalin Ainu,
Cambridge, Cambridge University Press.
Ong A. (1988), The production of possession: spirits and the multinational
corporation in Malaysia, “American Ethnologist”, vol. 15, n. 1, pp. 28-42.
Ong A. - Collier S.J. (2005), Global assemblages: technology, politics, and
ethics as anthropological problems, Oxford, Blackwell.
Ongaro Basaglia F. 1982, Salute/Malattia. Le parole della medicina, Torino,
Einaudi.
Ots T. (1990), The angry liver, the anxious heart, and the melancholy spleen.
The phenomenology of perceptions in Chinese culture, “Culture, Medicine
and Psychiatry”, n. 4, pp. 21-58.
Palese A. – Salvador L. – Cozzi D. (2011), One-dimensional Scales for pain
evaluation adopted in Italian nursing practice: giving preference to Deaf
patients, “Journal of Nursing Measurement”, vol.19, n. 2, pp. 91-104.
Palmer S. (2003), From Popular Medicine to Medical Populism: Doctors,
Healers, and Public Power in Costa Rica 1800-1949, Durham, NC, Duke
University Press.
Palumbo B. (2006), Scuola, scala, appartenenza. Problemi di identità tra storia
e antropologia, pp. 251-300, in Revel J. (curatore), Giochi di scala. La
microstoria alla prova dell’esperienza, Roma, Viella.
Palumbo B. (2009a), Politiche dell’inquietudine. Passioni, feste e poteri in
Sicilia, Firenze, Le Lettere.
Palumbo B. (2009b), Biopolitics the Sicilian way, “AM. Rivista della Società
italiana di antropologia medica”, n. 27-28 / ottobre 2009, pp. 37-71,
Pizza G. - Johannessen H. (curatori), Embodiment and the State. Health,
Biopolitics and the Intimate Life of State Powers.
Pandolfi M. (curatore) (1996), Perché il corpo. Utopia, sofferenza, desiderio,
Roma, Meltemi.
Pandolfi M. (2005), Sovranità mobile e derive umanitarie: emergenza, urgenza,
ingerenza, pp. 151-185, in Malighetti, R. (curatore), Oltre lo sviluppo. Le
prospettive dell’antropologia, Roma, Meltemi.
Pandolfi M. - McFalls L. (2009), Intervention as therapeutic order, “AM.
Rivista della Società italiana di antropologia medica”, n. 27-28 / ottobre
2009, pp. 91-111, n. monografico Pizza G. - Johannessen H. (curatori),
Embodiment and the State. Health, Biopolitics and the Intimate Life of
State Powers.
Bibliografia
331
Papa C. (1989), I guaritori, pp. 77-84, in Seppilli T. (curatore), Medicine e
magie, Perugia, Electa.
Papa C. (1999), Antropologia dell’impresa, Milano, Guerini.
Parker S. (1960), The Wiitiko Psychosis in the Context of Ojibwa Personality
and Culture, “American Anthropologist”, n. 62, pp. 603-623.
Patterson D. K. (1984), Cerebrospinal meningitis in West Africa and Sudan
in the twentieth century, Los Angeles, University of California Crossroads
Press.
Pavanello M. (2008), Dono e merce: riflessione su due categorie
sovradeterminate, pp. 43-63, in Aria M. - Dei F. (curatori), Culture del
dono, Roma, Meltemi.
Pearce N. - Davey Smith G. (2003), Is social capital the key to inequalities
in health?, “American Journal of Public Health”, vol. 93, n. 1, 2003, pp.
122-129.
Peccarisi C. - Inglese S. (1999), Tre voci da un catalogo delle sindromi
culturalmente ordinate (CBS), pp. 134-145, in Cardamone G. - Inglese S.
- Zorzetto S. (curatori), Djon djongonon. Psicopatologia e salute mentale
nelle società multiculturali, Paderno Dugnano, Edizioni Colibrì.
Pelto G. H. (1997), Socio-cultural dimensions of Ari from the household
perspective, in The Role of Medical Anthropology in Infectious Disease
Control, An International Symposium, Heidelberg University, 23-26 aprile
1997.
Pennacini C. (2001), Introduzione, “Antropologia”, vol. 1, n. 1, pp. 7-14, La
possessione, n. monografico curato da C. Pennacini.
Perrin M. (1980), Un succès bien relatif: la médecine occidentale chez les
indiens Guajiro, «Social Science & Medicine», vol. 14B, pp. 279-287.
Perrin M. (1985), Les fondements d’une catégorie étiologique (la notion de
contamination chez les Guajiro, «L’Ethnographie», n. 96-97, pp. 103-122.
Pfeiffer J. - Chapman R. (2010), Anthropological perspectives on structural
adjustment and public health, “Annual Review of Anthropology”, vol. 39,
2010, pp. 149-165.
Pfeiffer J. - Nichter M. (2008), What can critical medical anthropology
contribute to global health? A health systems perspective, “Medical
Anthropology Quarterly”, vol. 22, n. 4, 2008, pp. 410-415.
Pfeiffer W. M. (1982), Culture-Bound Syndromes, in Al-Issa I., Culture and
Psychopathology, University Park Press, Baltimore, 1982.
Piselli F. (curatore) (2001), Reti. L’analisi di network nelle scienze sociali,
Roma, Donzelli Editore.
Pitrè G. (1978 [1896]), Medicina popolare siciliana, ristampa anastatica a
cura di A. Rigoli, con una prefazione di G. Resta, Palermo, Il Vespro,
[dell’ediz. Carlo Clauser, Torino-Palermo, 1896].
Pizza G. (1988), Il “mal di matre” “Summana”, anno IV, n. 14, dicembre
1988, pp. 27-30.
Pizza G. (1995), Il medico, la mammana e il “basso popolo”. Operatori, pratiche
332
Bibliografia
e rappresentazioni della “medicina popolare” in Campania, nelle Statistiche
Murattiane del 1811 e nella memoria culturale contemporanea, in “Annali
della Facoltà di Lettere e Filosofia”, 2, studi storico-antropologici, vol.
XXXI-XXXII, pp. 489-521.
Pizza G. (1996), Sulla “possessione europea”, “AM. Rivista della Società
Italiana di Antropologia Medica”, n. 1-2, pp. 261-286.
Pizza G. (1998b), “Così siamo composte noi...”. Figure della corporeità
femminile in un’area appenninica della Campania, “Etnosistemi”, vol. 5, n.
5, pp. 73-93, n. monografico Figure della corporeità in Europa.
Pizza G. (2003a), Antonio Gramsci e l’antropologia medica ora. Egemonia,
agentività e traformazioni della persona, “AM. Rivista della Società italiana
di antropologia medica”, n. 15-16, ottobre 2003, pp. 33-51.
Pizza G. (2003b), Il motivo del rospo utero. Stregoneria, possessione e metafore
del corpo femminile nelle opere dei folkloristi dall’Alsazia alle Alpi orientali,
pp. 75-84, in Kezich G. - Seppilli T. (curatori) (2003), Saperi terapeutici
tradizionali nell’arco alpino, “Annali di San Michele”, vol. 16, San Michele
all’Adige, Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina.
Pizza G. (2003c), Sciamanismo, stregoneria, possessione. Una prospettiva
comparativa a partire dal caso romeno, in C. Papa - G. Pizza - F. M. Zerilli
(curatori), La ricerca antropologica in Romania. Prospettive storiche ed
etnografiche, Napoli, Esi.
Pizza G. (2005), Antropologia medica. Saperi, pratiche e politiche del corpo,
Roma, Carocci.
Pizza G. (2009), Dancing on the margins of the state. Fragments for an
ethnography of sovereign bodies in Southeastern Italy, “AM. Rivista della
Società italiana di antropologia medica”, n. 27-28 / ottobre 2009, pp. 245260, n. monografico Pizza G. - Johannessen H. (curatori), Embodiment
and the State. Health, Biopolitics and the Intimate Life of State Powers.
Pizza G. (2012), Second nature: on Gramsci’s anthropology, “Anthropology &
Medicine”, vol. 19, n. 1, aprile 2012, pp. 95-106.
Pizza Giovanni (2008), Postfazione, pp. 667-677, in Seppilli T. (2008b), Scritti
di antropologia culturale, M. Minelli - C. Papa (curatori), Firenze, Leo S.
Olschki Editore, 2 volumi 2008a.
Pizza G. - Johannessen H. (2009), Editorial. Two or three things about
Embodiment and the State, “AM. Rivista della Società italiana di
antropologia medica”, n. 27-28 / ottobre 2009, pp. 13-20, n. monografico
Pizza G. - Johannessen H. (curatori), Embodiment and the State. Health,
Biopolitics and the Intimate Life of State Powers.
Pizzini F. (1999), Corpo medico e corpo femminile. Parto, riproduzione
artificiale, menopausa, (in collaborazione con L. Lombardi), Milano,
Franco Angeli.
Pomata G. (1992), Uomini mestruanti. Somiglianza e differenza fra i sessi in
Europa in età moderna, “Quaderni Storici”, a. XXVIII, vol. 79, n. 1, pp.
51-91.
Bibliografia
333
Pool R. (1994), On the creation and dissolution of ethnomedical systems in
the medical ethnography of Africa, “Africa. Journal of the International
African Institute”, vol. 64, n. 1, 1994, pp. 1-19.
Portes A. (1998), Social capital: its origins and applications in modern sociology,
“Annual Review of Sociology”, vol. 24, 1998, pp. 1-2.
Press I. (1980), Problems in the definition and classification of medical systems,
“Social Science and Medicine”, vol. 14B, 1980, pp.45-57.
Prince R., Tcheng-Laroche F. (1987), Culture-bound syndromes and
International Disease Classifications, “Culture, Medicine and Psychiatry”,
vol. 11, n. 1, pp. 3-19.
Prince Raymond (1982b), Shamans and endorphins. Hypothesis for a synthesis,
“Ethos”, vol. 10, n. 4, pp. 409-423.
Putnam R. D. (1993), La tradizione civica nelle regioni italiane, Milano,
Mondadori [ediz. orig.: Making democracy work. Civic traditions in
modern Italy, Princeton, Princeton University Press, 1993].
Putnam R. D. (2004 [2000]), Capitale sociale e individualismo. Crisi e rinascita
della cultura civica in America, il Mulino, Bologna [ediz. orig.: Bowling
alone. The collapse and revival of American community, New York, Simon
and Schuster, 2000].
Putnam R. D. (2004), Health by association? Social capital, social theory, and
the political economy of public health - commentary: ‘health by association’:
some comments, “International Journal of Epidemiology”, vol. 33, n. 4,
2004, pp. 667-671.
Quaranta I. (curatore) (2006), Antropologia medica. I testi fondamentali,
Milano, Raffaello Cortina.
Quaranta I. (2006), Corpo, potere e malattia. Antropologia e AIDS nei
Grassfields del Camerun, Roma, Meltemi.
Quattrocchi P. - Barbiani E. - Tomasin E. (2006), Sobada: il dono delle
levatrici maya, Trieste, Videomante scs Onlus.
Quattrocchi P. (2011), Corpo, riproduzione e salute tra le donne maya dello
Yucatán (Messico), Pisa, Pacini Editore.
Rabinow P. (1992), Artificiality and enlightenment: from sociobiology
to biosociality, pp. 234-252, in J. Crary - S. Kwinter (curatori),
Incorporations, New York, Zone Books.
Rabinow P. (1996), Essays on the anthropology of reason, Princeton, Mass.,
Princeton University press.
Radley A. (1989), Style, discourse and constraint in adjustment to chronic
illness, “Sociology of Health and Illness”, vol.11, n. 3, pp. 230-252.
Ranisio G. (1996), Venire al mondo. Credenze, pratiche, rituali del parto,
Roma, Meltemi.
Ranisio G. (2006), Quando le donne hanno la luna, Milano, Baldini Castoldi
Dalai.
Ravenda A. F. (2009), Embodying Temporary Stay Centers. An ethnography of
immigrants and institutions in the south-eastern border of Italy (Apulia),
334
Bibliografia
“AM. Rivista della Società italiana di antropologia medica”, n. 2728 / ottobre 2009, pp. 113-135, Pizza G. - Johannessen H. (curatori),
Embodiment and the State. Health, Biopolitics and the Intimate Life of
State Powers.
Reid J. - Williams N. (1984), ‘Voodoo death’ in Arnhem Land: whose reality?,
“American Anthropologist”, vol. 86, n. 1, pp. 121-133.
Remotti F. (2000), Prima lezione di antropologia, Roma-Bari, Laterza.
Remotti F. (2008), Contro natura. Una lettera al Papa, Roma-Bari, Laterza.
Renzetti E. - Taiani R. (1988), Sulla pelle del villano. Profili di terapeuti e
metodi di cura empirica nella tradizione trentina, S. Michele all’Adige,
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina.
Renzetti E. (2007), La grammatica della salvezza. Ritualità popolare tra
protezione e morte nel mondo alpino, Torino, Priuli & Verlucca,.
Ricoeur P. (1986-88 [1983-85], Tempo e racconto I –II – III, Jaka Book,
Milano [ediz. orig.: Temps et récit I –II - III, Paris, Seuil, 1983-85]).
Rieff D. (2009), Senza consolazione. Gli ultimi giorni di Susan Sontag, Milano,
Mondadori.
Riessman C. K. (1990), Strategic use of narrative in the presentation of self and
illness: a research note, “Social Science and Medicine”, vol. 30, n.11, pp.
1995-2000.
Riessman C. K. (1993), Narrative analysis, Newbury Park and London, Sage.
Riessman C. K. (1998), Women and Medicalization: A New Perspective, pp.
46-63, in Weitz R. (curatore), The Politics of Women’s Bodies, New York
and Oxford, Oxford University Press.
Riska E. (2010), Gender and Medicalization and Biomedicalization Theories,
pp. 147- 170, in Clarke A. E. – Mamo L. – Fosket J. R. – Fishman J. R. –
Shim J. K. (2010), Biomedicalization. Technoscience, Health, and Illness in
the U. S., Durham & London, Duke University Press.
Risso M., Böker W. (2000 [1964]), Sortilegio e delirio, Lanternari V. - De
Micco V. - Cardamone G. (curatori), Liguori Editore, Napoli [ed. orig.:
Verhexungswahn, Karger, Basel – New York, 1964].
Rivera A. (1989), Gravidanza, parto, allattamento, malattie infantili: pratiche
empiriche e protezione simbolica, pp. 63-70, in Seppilli T. (curatore),
Medicine e magie, Perugia, Electa.
Rose N. (1988), Inventing our Selves: Psychology, Power and Personhood,
Cambridge, Cambridge University Press.
Rose N. (2008 [2007]), La politica della vita. Biomedicina, potere e
soggettività nel XXI secolo, Torino, Einaudi [ediz. orig.: The politics of
life itself. Biomedicine, power, and subjectivity in the Twenty-First Century,
Princeton, Princeton University Press, 2007].
Rostgård L. (2009), Body and health in women’s everyday lives: an
ethnographic fieldwork in Southern Denmark, “AM. Rivista della Società
italiana di antropologia medica”, n. 27-28 / ottobre 2009, pp. 227-244,
Pizza G. - Johannessen H. (curatori), Embodiment and the State. Health,
Bibliografia
335
Biopolitics and the Intimate Life of State Powers.
Ruffié J. - Sournia J.-C. (1985 [1984]), Le epidemie nella storia, traduz. dal
francese di A. Foa, Editori Riuniti, Roma [ediz. orig.: Les épidémies dans
l’histoire de l’homme, 1984].
Ryang S. (2000), Ethnography or self-cultural Anthropology? Reflections on
Writing about Ourselves, “Dialectical Anthropology”, vol. 25, pp. 297320.
Sacks O. (1996), Biologia e identità, pp. 145-157, in Donghi P. (curatore), Il
sapere della guarigione, Roma-Bari, Laterza.
Salomon-Bayet C. (1986), Pasteur et la révolution pastorienne, Paris, Payot.
Sanjek R. (1991), The Ethnographic Present, “Man”, vol. 26, num. 4, p. 607628.
Scarry E. (1990 [1985]), La sofferenza del corpo. La distruzione e la costruzione
del mondo, traduz. dall’inglese di G. Bettini, Bologna, il Mulino [ediz.
orig.: The body in pain. The making and unmaking of the world, New
York, Oxford University Press].
Schaefer R. (1992), Retelling a life: narration and dialogue in psychoanalysis,
New York, Basic Books.
Scheper-Hughes N. - M. Lock (2006 [1987]), Un approccio critic interpretative
in antropologia medica: rituali e pratiche disciplinary e di protesta, pp. 149194, in Quaranta I. Antropologia medica. I testi fondamentali, Milano,
Raffaello Cortina [ediz. orig.: The Mindful Body. A Prolegomenon
to Future Work in Medical Anthropology, “Medical Anthropology
Quarterly”, n. 1, p. 6-41, 1987].
Schirripa P. (2005), Le politiche della cura. Terapie, potere e tradizione nel
Ghana contemporaneo, Lecce, Argo.
Schirripa P. - Vulpiani P. (curatori) (2000), L’ambulatorio del guaritore. Forme
e pratiche del confronto tra biomedicina e medicine tradizionali in Africa e
nelle Americhe, Fondazione Angelo Celli per una Cultura della Salute,
Lecce, Argo (Biblioteca di Antropologia Medica 1, collana diretta da
Tullio Seppilli).
Schirripa P. – Zúniga Valle C. (2000), Sistema medico, “AM. Rivista della
società italiana di antropologia medica”, n. 9-10, Ottobre 2000, pp. 210222.
Schneirov M. - Geezik J.D. (2003), A diagnosis for our times. Alternative
health, from lifeworld to politics, Albany, State University of New York.
Scippa S. (2011), Dal susto alla tubercolosi. Pluralismo medico a Santiago
Yancuictlalpan (Sierra Norte de Puebla, Messico), tesi di Laurea specialistica
in Discipline etnoantropologiche, Sapienza Università di Roma.
Seppilli T. (1983), La medicina popolare in Italia: avvio ad una nuova fase della
ricerca e del dibattito, “La Ricerca Folklorica”, n. 8, pp. 3-6.
Seppilli T. (curatore) (1989), Medicine e magie, Milano, Electa.
Seppilli T. (1996), Antropologia Medica: fondamenti per una strategia, “AM.
Rivista della Società Italiana di Antropologia Medica”, n. 1-2, pp. 7-22.
336
Bibliografia
Seppilli T. (1996), La Società italiana di antropologia medica, “AM. Rivista
della Società Italiana di Antropologia Medica”, pp. 361-366.
Seppilli T. (2000 [2004]), Presentazione. Il colera, Il Mezzogiorno e il nuovo
Stato italiano: una testimonianza di Edmondo De Amicis, “AM. Rivista della
Società italiana di antropologia medica”, n. 9-10 / ottobre 2000 [2004],
pp. 151-207, ora in Seppilli T. (2008a), Scritti di antropologia culturale, M.
Minelli - C. Papa (curatori), Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2 volumi
pp. 653-665.
Seppilli T. (2004), La questione dell’efficacia delle terapie sacrali e lo stato della
ricerca nelle scienze umane. Dialogo a cura di Pino Schirripa, “Religioni e
Società”, n. 48, pp. 75-85.
Seppilli T. (2008a), Scritti di antropologia culturale, M. Minelli - C. Papa
(curatori), Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2 volumi.
Seppilli Tullio (2008b), Etnomedicina e Antropologia medica: un approccio
storico-critico, “AM. Rivista della Società italiana di antropologia medica”,
nn. 21-26, ottobre 2006- ottobre 2008, pp. 53-80.
Seppilli T. (2009), To our readers - Ai nostri lettori, “AM. Rivista della Società
italiana di antropologia medica”, n. 27-28 / ottobre 2009, pp. 9-12, Pizza
G. - Johannessen H. (curatori), Embodiment and the State. Health,
Biopolitics and the Intimate Life of State Powers.
Seppilli T. (curatore) (2010), Salute e sanità come beni comuni: per un nuovo
sistema sanitario, “Educazione Sanitaria e Promozione della Salute”, vol.
33, n. 4, ottobre-dicembre 2010, pp. 369-381.
Seppilli T. (2012), Sulla questione dei beni comuni: un contributo antropologico
per la costruzione di una strategia politica, pp. 110-125, in Marella M.R.
(curatore), Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni,
Verona, Ombre Corte, 2012.
Severi C. (1993), La memoria rituale. Follia e immagine del Bianco in una
tradizione sciamanica amerindiana, La Nuova Italia, Firenze.
Severi C. (2000), Proiezione e credenza. Nuove riflessioni sull’efficacia
simbolica, “Etnosistemi. Processi e dinamiche culturali”, anno VII, n. 7,
pp. 75-85, n. monogr. Antropologia e psicologia. Interazioni complesse e
rappresentazioni mentali.
Severi Carlo (2004), Il percorso e la voce. Un’antropologia della memoria,
Torino, Einaudi.
Shapiro A. K. (1964), Etiological factors in placebo effect, “Journal of the
American Medical Association”, vol. 187, n. 10, pp. 712-714.
Sharma A. - Gupta A. (2006), Introduction: Rethinking Theories of the State
in an Age of Globalization, pp. 1-41, in Sharma A. - Gupta A. (curatori)
The Anthropology of the State. A Reader, Malden - Oxford – Carlton,
Blackwell Publishing.
Sharma U. (1991), Complementary Medicine Today. Pratictioners and patients,
London, Routledge.
Sherzer J. (1983), Kuna ways of speaking. An ethnographic perspective, Austin,
Bibliografia
337
University of Texas Press.
Sherzer J. (1989 [1974]), Namakke, sunmakke, kormakke: three types of
Cuna speech events, pp. 263-282, in Bauman R. - Sherzer J. (curatori),
Explorations in the ethnography of speaking, Cambridge, Cambridge
University Press.
Sigerist H. E. (1933), The philosophy of hygiene, “Bulletin of the Institute of
the History of Medicine”, vol. I, pp. 323-331.
Signorelli A. (1996), Il pragmatismo delle donne. La condizione femminile
nella trasformazione delle campagne, pp. 223-251, in Piccone Stella S. Saraceno C. (curatrici), Genere. La costruzione sociale del femminile e del
maschile, Bologna, il Mulino.
Signorini I. (1988), Spavento e sindromi culture-bound. Sindrome?,
“L’Uomo”, vol. 1 n.s., n. 1-2, pp. 25-49.
Signorini I. (1989), Sobre algunos aspectos sincréticos de la medicina popular
mexicana, “L’Uomo”, vol. 2 n.s., n. 1, pp. 125-147.
Signorini I. - Tranfo L. (1979), Le infermità: classificazione e terapie, pp.
164-197, in Signorini I. (curatore), Gente di laguna. Ideologia e istituzioni
sociali dei Huave di San Mateo del Mar, Milano, FrancoAngeli.
Signorini I. - Lupo A. (1989), I tre cardini della vita. Anime, corpo, infermità
tra i Nahua della Sierra di Puebla, Palermo, Sellerio.
Siisiäinen M. (2000), Two concepts of social capital: Bourdieu vs. Putnam,
Paper presented at ISTR Fourth International Conference “The Third
Sector: For What and for Whom?”, Dublin, Trinity College.
Simons R. C. - Hughes C. C. (curatori) (1985), The Culture-Bound Syndromes.
Folk Illnesses of Psychiatric and Anthropological Interest, Dordrecht,
Reidel.
Sindzingre N. - Zempléni A. (1981), Modèles et pragmatique, activation et
repétition: reflexions sur la causalité de la maladie chez les Senoufo de Côte
d’Ivoire, “Social Science and Medicine”, vol. 15b, pp. 279-293.
Singer M. - H. Baer (1995) Critical Medical Anthropology, Amityville,
Baywood Press.
Skultans V. (2007), Empathy and Healing. Essays in Medical and Narrative
Anthropology, New York – Oxford, Berghahn Books.
Smith-Nonini S. (2006), Conceiving the health commons. Operationalizing a
‘Right’ to Health, “Social Analysis”, vol. 50, n. 3, 2006, pp. 233-245.
Sontag S. (1979 [1977]), Malattia come metafora, traduz. dall’inglese di E.
Capriolo, Giulio Einaudi Editore, Torino [ediz. orig.: Illness as metaphor,
New York, Farrar, Straus and Giroux, 1977].
Squillacciotti M. (1998), Il linguaggio dei segni nel canto del Muu igala, pp.
123-147, in Squillacciotti M., I Cuna di Panamá. Identità di popolo tra
storia ed antropologia, Torino, L’Harmattan Italia.
Stengers I. (1996), Il medico e il ciarlatano, pp. 103-144, in Nathan T.
- Stengers I., Medici e stregoni, trad. dal francese di S. Inglese e A.
Salsano, Torino, Bollati Boringhieri [ediz. orig.: Médecins et sorciers.
338
Bibliografia
Manifeste pour une psychopatologie scientifique. Le médicin et le charlatan,
Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 1995].
Stengers I. (1997a), Pour en finir avec la tolérance. Cosmopolitiques VII, La
Découverte/Les Empêcheurs de penser en ronde, Paris.
Stengers I. (1997b), Sciences et pouvoirs. La démocratie face à la technoscience,
Editions la Découverte, Paris.
Stone J. - Matthews J. (1996), Complementary medicine and the law, New
York, Oxford University Press.
Strathern A. - Stewart P. J. (1999), Curing and healing. Medical anthropology
in global perspective, Durham, NC, Carolina Academic Press.
Sunder R.K. (2006), Biocapital: the constitution of postgenomic life, Durham,
NC, Duke University Press.
Suryani L.K. - Jensen G.D. (1993), Transe and Possession in Bali. A Window
on Western Multiple Personality, Possession, Disorder, and Suicide, Kuala
Lumpur, Oxford University Press.
Swanson M. W. (1977), The sanitation syndrome: bubonic plague and urban
native policy in the Cape Colony, 1900-1909, “Journal of African History”,
vol.18, n. 3, 1977, pp. 387-410.
Szreter S. - Woolcock M. (2004), Health by association? Social capital, social
theory and the political economy of public health, “International Journal of
Epidemiology”, vol. 33, n. 4, 2004, pp. 650-667.
Szreter S. (2004), Health by association? Social capital, social theory, and
the political economy of public health - commentary - author response:
debating mortality trends in 19th Century Britain, “International Journal
of Epidemiology”, vol. 33, n. 4, 2004, pp. 705-709.
Talamonti A. (2005), La carne convulsiva. Etnografia dell’esorcismo, Napoli,
Liguori.
Taliani S. - Vacchiano F. (2006), Altri corpi. Antropologia ed etnopsicologia
della migrazione, Milano, Edizioni Unicopli.
Tambiah S. J. (1993 [1990]), Magia Scienza Religione, traduz. dall’inglese di
F. de Giovanni, Napoli, Guida Editori [ediz. orig.: Magic, science, religion
and the scope of rationality, Cambridge, Cambridge University Press,
1990].
Taussig M. (1987), Shamanism, colonialism and the wild man. A study in
terror and healing, Chicago,University of Chicago Press.
Taussig M. (2010 [1980]), The devil and commodity fetishism in South
America, Chapel Hill, The University of North Carolina Press [ediz. orig.:
1980].
Tovey P. - Easthope G. - Adams J. (curatori) (2003), The mainstreaming of
complementary and alternative medicine. Studies in social context, London,
Routledge.
Triolo N. (1993), Mediterranean Exotica and the Mafia “Other” or Problems
of Representation in Pitrè’s Texts, “Cultural Anthropology”, vol. 8, n. 3,
pp. 306-313.
Bibliografia
339
Tseng W.-S. (2003), Sindromi specifiche correlate alla cultura, pp. 365-454,
in Manuale di psichiatria culturale, Milano, CIC Edizioni Internazionali.
Turner V. (1976 [1967]), Un medico ndembu all’opera, pp. 417-455, in Turner
V., La foresta dei simboli. Aspetti del rituale ndembu, traduz. dall’inglese di
N. Greppi Collu, Brescia, Morcelliana [ediz. orig. del saggio: An Ndembu
doctor in practice, pp. 230-263, in Ari Kiev (curatore), Magic, faith, and
healing, Glencoe, The Free Press, 1967].
Turshen M. (1977), The impact of colonialism on health and health services
in Tanzania, “International Journal of Health Services”, vol. 7, n. 1, pp.
7-35.
Vidossi G. (1935), Per lo studio della medicina popolare, “Lares. Organo
del Comitato Nazionale Italiano per le Arti Popolari”, anno VI, n. 4,
dicembre 1935, pp. 245-249.
Vigarello G. (1985), Le propre et le sale. L’hygiène du corps depuis le Moyen
Age, Paris, Seuil.
Vincent J. F. (2003), La Ménopause, chemin de la liberté selon le femmes Beti
du Sud Camerun, “Journal de la Société des Africanistes”, vol. 72, n. 2,
pp. 121-136.
Vineis P. - Dirindin N. (2004), In buona salute. Dieci argomenti per difendere
la sanità pubblica, Torino, Einaudi.
Volinn I. J. (1989), Issues of definitions and their implications: Aids and
leprosy, “Social Science & Medicine”, vol. 29, pp. 1157-1162.
Waldram J. B. (2000), The efficacy of traditional medicine: current theoretical
and methodological issues, “Medical Anthropology Quarterly”, vol. 14, n.
4, pp. 603-625.
Wallerstein I. (1985 [1983]), Il capitalismo storico, Torino, Einaudi [ediz.
orig.: Historical capitalism, 1983].
Whelan E. (2003), Putting pain to paper: endometriosis and the documentation
of suffering, “Health”, n. 7, pp. 463-482.
Wiesenfeld S. L. (1967), Sickle-cell trait in human biological and cultural
evolution, “Science”, n. 157, pp. 1134-1140.
Wilkinson R. (1996), Unhealthy societies: the afflictions of inequality, London,
Routledge.
Wilkinson R. (1999), Income inequality, social cohesion and health: clarifying
the theory. A reply to Muntaner and Lynch, “International Journal of
Health Services”, vol. 29, n. 3, 1999, pp. 525-543.
Wilkinson R. (2001), Mind the gap: hierarchies, health, and human evolution,
Yale University Press, New Haven.
Wilkinson R. - Marmot M. (curatori) (2003), Social determinants of health:
the solid facts, Copenhagen, World Health Organization.
Williams G. (1984), The genesis of chronic illness: narrative re-construction,
“Sociology of Health and Illness”, vol. 6, n.2, pp. 175-201.
Williams S. J. (2000), Chronic illness as biographical disruption or biographical
as chronic illness? Reflection on a core concept, “Sociology of Health and
340
Bibliografia
Illness”, vol. 22, n.1, pp. 40-67.
Wittgenstein L. (1975 [1967]), Note sul “Ramo d’oro” di Frazer, traduz. dal
tedesco di Sabina de Waal, Adelphi, Milano [ediz. orig.: Bemerkungen
über Frazers “The Golden Bough”, Wittgensteins Nachlass Verwalter,
1967].
Wolf E. (1990 [1982]), L’Europa e i popoli senza storia, Bologna, il Mulino
[ediz. orig.: Europe and the People without history, Berkeley, University of
California Press, 1982].
Woolcock M. (1998), Social capital and economic development: towards a
theoretical synthesis and policy framework, “Theory and Society”, vol. 27,
n. 2, 1998, pp. 151-208.
Yap P.-M. (1974), Comparative Psychiatry: a Theoretical Framework, Toronto,
University of Toronto Press.
Yoder P. S. (1982), Introduction, pp. 1-20 in Yoder P. Stanley (curatore),
African health and healing systems: proceedings of a symposium, Crossroads
Press, Los Angeles.
Young A. (1976), Some implications of medical beliefs and practices for social
anthropology, “American Anthropologist”, vol. 78, n. 1, pp. 5-24.
Young A. (1983), The relevance of traditional medical cultures to modern
primary health care, “Social Science and Medicine”, vol. 17, n. 16, pp.
1205-1211.
Young A. (2006 [1982]), Antropologie della “illness” e della “sickness”, pp. 107147, in Quaranta I. (curatore), Antropologia medica. I testi fondamentali,
traduz. dall’inglese di E. Fabietti, Milano, Raffaello Cortina, [ediz. orig.
del saggio: The anthropologies of illness and sickness, “Annual Review of
Anthropology”, vol. 11, pp. 257-285].
Young A. (2009), The history of a virtual epidemic, “AM. Rivista della Società
italiana di antropologia medica”, n. 27-28 / ottobre 2009, pp. 21-35, n.
monogr. Pizza G. - Johannessen H. (curatori), Embodiment and the State.
Health, Biopolitics and the Intimate Life of State Powers.
Zanetti Z. (1978 [1892]), La medicina delle nostre donne (1892), a cura di M.
R. Trabalza, con un saggio di A. M. Cirese, Ediclio, Foligno [ediz. orig.:
S. Lapi Tipografo Editore, Città di Castello, 1892].
Zborowski M. (1969), People in pain, San Francisco, Jossey-Bass Inc.
Zborowski M. (1977 [1952]), Componenti culturali nella risposta al dolore,
pp. 108-126, in Maccacaro G. A. - Martinelli A. (curatori), Sociologia
della medicina, Milano, Feltrinelli [ediz. orig.: Cultural components in
response to pain, “Journal of Social Issues”, vol. 8, pp. 16-30].
Zempléni A. (1966), La dimension thérapeutique du culte des Rab. Ndöp, Tuuru
et Samp: Rites de possession chez les Lebou et les Wolof, “Psychopathologie
africaine”, vol. II, n. 3, pp. 259-439.
Zempléni A. (1975), De la persécution à la culpabilité, pp. 153-218, in Colette
Piault (curatrice), Prophétisme et thérapeutique. Albert Atcho et la
communauté de Bregbo, Paris, Hermann.
Bibliografia
341
Zempléni A. (1988), Entre ‘sickness’ et ‘illness’: de la socialisation à
l’individualisation de la ‘maladie’, “Social Sciences and Medicine”, vol.
27, n. 11, 1988, pp. 1171-1182.
Zempléni A. (2009), Embodiment by the dead and the state: postcommunist
reburials in Hungary, “AM. Rivista della Società italiana di antropologia
medica”, n. 27-28 / ottobre 2009, pp. 73-89, Pizza G. - Johannessen H.
(curatori), Embodiment and the State. Health, Biopolitics and the Intimate
Life of State Powers.
Zola I. K. (1972), Medicine as an institution of social control, “The Sociological
Review”, vol. 20, n. 4, pp. 487-504.
Zorzetto S. - Cardamone G. - Da Prato M. - Inglese S. (2002), Schizofrenie
e contesto sociale: dai fattori culturali agli studi di follow-up, pp. 157-168,
in Tagliavini G. - Cardamone G. (curatori), Ripensare le schizofrenie. Un
dibattito italiano, Paderno Dugnano, Colibrì.
Zorzetto S. - Da Prato M. - Inglese S. - cardamone G. (2001), Declinazioni
plurali della società e strategie di inclusione, “Gruppi (nella clinica, nelle
istituzioni, nella società)”, giornale della Coirag Confederazione di organizzazioni per la ricerca analitica sui gruppi”, vol. 3, n. 2, pp. 53-63.
Zorzetto S. - Inglese S. - Da Prato M. - Cardamone G. (2002), Disturbi
psichiatrici maggiori. Esperienze cliniche in corso di migrazione, pp. 184204, in Rizzi R. - Iossa Fasano A., Ospitare e curare. Dialogo interculturale
ed esperienze cliniche con immigrati, Milano, Franco Angeli.
Indice degli autori
Abad V., 93
Ackerknecht E. H., 65, 133
Adams J., 39, 170, 176
Adouane S., 255, 301
Alimenti A., 192
Anderson R., 72
Appadurai A., 254
Aretxaga B., 120, 123
Asad T., 125
Atkinson J. M., 136
Augé M., 134-135, 139-140, 283
Bagnasco A., 19-20, 34
Banfield E. C., 20
Baron S., 34
Baronti G., 137, 192
Bartoli P., 9, 13, 181, 187, 192,
201- 202
Basaglia F., 279-281, 297
Bastide R., 259
Bateson G., 240, 242-243, 248,
250
Bauman Z., 169-171, 217
Beneduce R., 101, 152-153
Benoist J., 272, 274-275
Bhabha H. K., 254
Bibeau G., 26-27, 58, 62, 65,
136, 138, 151, 254-255
Bochner A. P., 205
Böker W., 231, 234, 251
Bonnet D., 65
Bourdieu P., 23-26 , 46, 51, 115,
132-133, 173, 276-277
Boyce E., 96
Briguglia G., 149
Brodwin P. E., 99, 101
Brody H., 150
Bury M., 205, 207, 209-210, 217
Butt L., 295
Buttitta A., 201
Campbell C., 39
Canguilhem G., 130, 147
Cannon W. B., 152
Cant S., 162, 176
Cappelletto F., 213
Caprara A., 10, 57, 137
Cardamone G., 11, 225, 230,
234-235, 241, 242, 252
Carr J. E., 259-260
Casadei F., 255
Castel R., 45
Chapman R., 27
Charmaz C., 207, 212
Charuty G., 72, 142, 185, 192,
194-195
Cipolla C. M., 57
Cirese A. M., 200
Cohen A., 206
Cohen R. D., 38
Coleman J. S., 18, 43
Collier S. J., 47
Colombo E., 162
Comaroff J. e J., 43- 44, 296
Comelles J. M., 192
Conrad P., 67-68, 70
Contreras J., 153
Coppo P., 252-253, 258
Corin E., 254
Cosmacini G., 193, 202
344
Indice degli autori
Coward R., 170
Cozzi D., 10, 110, 150, 218
Crapanzano V., 101-102
Crocella C., 175
Csordas T. J., 114-117, 132-133,
142-147, 153-154, 285
Da Prato M., 11, 235, 252
Das V., 123-124, 223-224, 286,
296
Davey Smith G., 34, 37-38
Davis D., 79
Davis Floyd R., 72
Dawson M., 65
de Martino E., 138, 148, 184,
200, 231, 233-234, 251, 258, 297
De Rosa G., 193
Dei F., 11, 22, 139, 181
DelVecchio Good M.-J., 99, 101,
218
Devereux G., 231, 247, 251, 253,
258-260, 263, 265
Di Nola A. M., 185, 187, 189191, 196
Di Vito A., 202
Diasio N., 79, 80
Dirindin N., 32
Douglas M., 19, 21, 63-64, 171,
173
Duden B., 71, 82
Dupire M., 65
Easthope G., 170, 176
Ebigbo P. O., 93, 255
Eisenberg L., 61, 130-131
Elstad J. I., 35
Etkin N. L., 127, 144
Fabrega H., 93
Fainzang S., 65
Falteri P., 9, 11, 181, 187, 192,
201
Farmer P., 32, 285-287, 289-290,
293, 297
Farr J., 34
Fassin D., 34, 213, 271, 275-277,
282-285, 291-292, 294-295
Favret-Saada J., 153, 231-232
Field J., 34
Fingerson L., 77
Folgheraiter F., 29
Ford J., 65
Foucault M., 41-43, 45, 53-54,
71, 161, 231,
245, 265, 280, 294
Fracastoro G., 53
Frank A., 207, 216
Frazer J., 54-55, 63
Friedmann D., 25, 202
Frigessi Castelnuovo D., 241
Frohock M., 162, 173
Gadamer H. G., 129, 212, 215
Galeno, 71-72
Gallini C., 147, 186-188
Geertz C., 19, 58, 134, 144, 258
Gentilcore D., 195-196
Giarelli G., 209, 218
Ginsborg P., 30
Ginzburg C., 69, 187, 192, 194195
Glassner B., 169
Godbout J.T., 22
Goffman E., 60
Goldstein M. S., 162, 169
Good B. J., 76, 99, 101, 129-130,
145, 147, 150, 153, 208, 212,
218-220
Gordon D., 207
Gramsci A., 120-122, 198, 201,
203
Groleau D., 21, 221
Indice degli autori
Guggino E., 72, 137, 194
Gupta A., 123 , 125
Hacking I., 264
Hallowell A. I., 115
Hamayon R., 138
Haraway D.J., 49
Hardon A., 77
Harrag, 226, 234, 252
Harries J., 77
Henningsen G., 192
Héritier F., 71, 79
Héritier-Augé F., 59
Hersch Martínez P., 137
Herzfeld M., 19, 123
Hobbes T., 119
Hofer J., 240
Hughes C. C., 65, 253, 261
Illich I., 67
Inglese S., 227, 234-235, 252,
254-255, 260-261, 263
Jaffré Y., 65
Janzen J., 65, 270
Janzen J. M., 65-66
Jaspers K., 130, 254
Jensen G.D., 259
Johannessen H., 113, 183, 201
Jouanna J., 146
Kangas I., 216, 218, 220
Kapferer B., 117-118
Kawachi I., 35-36, 38-39
Kelner M., 176
Kennedy B. P., 35
Kiev A., 261
Kim D., 38-39
Kirmayer L. J., 153, 253
Kleinman A., 61, 66, 99, 101,
127, 130-131, 136, 145, 147, 152,
206-208, 213-214, 223, 258-259,
272, 274, 286
345
Knauft B. M., 121
Kohler-Riessman C., 207
Kraepelin E., 254, 256, 267
Krieger N., 291
Martínez Hernáez A., 129
Marx K., 16-17
Mattalucci-Yılmaz C., 132
Matteucci N., 118
Mattingly C., 92, 206-207, 212,
214-215, 219-220
Mauss M., 63, 133, 152, 194
McCaffery M., 86, 95-96, 108
Merleau Ponty M., 115
Migliore S., 92
Minelli M., 10-11, 30, 34, 113,
202
Muehlebach A., 44-45
Muntaner C., 34, 36-38
Murphy H. B. M., 254-255
Mutti A., 20
Narotzky S., 51
Nathan T., 248, 250-251, 254255, 259
Navarro V., 37-38
Nguyen V. K., 38, 49, 78-79,
293-294
Nichter M., 27 , 65
Nigris D., 205, 209-211
Ohnuki-Tierney E., 93
Ong A., 47, 138
Ongaro Basaglia F., 279-281
Ots T., 93
Palumbo B., 113, 123, 188, 193,
201
Pandolfi M., 113, 132, 295, 297
Papa C., 11, 22, 181, 192, 202
Pavanello M., 22
Peccarisi C., 246, 255, 261, 263
Pelto G. H., 65
346
Indice degli autori
Perrin M., 56, 65-66
Peruselli C., 207
Pfeiffer J., 27
Pfeiffer W. M., 253
Piasere L., 216
Piselli F., 34, 51
Pitrè G., 186-188, 191-192, 194,
198-199, 200
Pizza G., 10, 11, 72, 113, 116,
121, 131-133, 137-138, 181-182,
192, 195, 197, 200-203
Pizzorno A., 34
Poole D., 123-124
Press I., 272-275
Prince R., 151, 253
Putnam R. D., 17-21, 23, 27, 34,
38, 41
Quaranta I., 11, 130-131, 289
Quattrocchi P., 137, 140
Rabinow P., 46, 294
Radley A., 207, 218
Ranisio G., 10, 74, 80, 137
Rebughini P., 162
Remotti F., 133, 144
Renzetti E., 202
Riessman C. K., 68, 81, 82, 205
Riska E., 71
Risso M., 231, 234, 241, 251
Rivera A., 137
Rose N., 47
Ruffié J., 59
Sahlins M., 19
Sanjek R., 298
Scheper-Hughes N., 128, 132,
134, 285
Schirripa P., 10-11, 137, 142,
183, 234, 269, 276-277
Schneirov M., 166, 173
Schuller T., 34
Seppilli T., 9-11, 33, 66,
113, 145, 150-152, 181, 183-185,
187-190, 192, 195-199, 202
Sharma A., 123, 125
Sharma U., 162, 176
Sigerist H., 65
Signorini I., 130, 135, 137-138,
155, 183
Silverman S., 19
Singer M., 297
Skultans V., 206, 209, 213, 215216, 222-224
Smith-Nonini S., 33
Sontag S., 60-61, 85
Sournia J. C., 59
Squillacciotti M., 152
Stengers I., 231, 235, 257
Stewart P. J., 131, 145
Stone J., 174
Strathern A., 131, 145
Subramanian S.V., 38-39
Suryani L.K., 254
Szreter R., 37
Tambiah S. J., 55-56, 58
Taussig M., 15-17 , 51
Tcheng-Laroche F., 253
Tovey P., 170, 176
Trigilia C., 34
Turner V., 135, 221
Tyma S., 93
Vidossi G., 188
Vigarello G., 65
Vineis P., 32
Vinel V., 79-80
Vitaliano P. P., 260
Vulpiani P., 183
Waldram J. B., 127, 134, 141,
143
Whelan E., 103-106
Indice degli autori
Wiesenfeld S., 65
Wilkinson R., 35
Wittgenstein L., 55-56
Yap P. M., 253
Yoder P. S., 273
Young A., 30-31, 66, 113, 127,
130-131, 142, 145, 219, 221
Zanetti Z., 137, 187, 200
Zanini L., 209
Zborowski M., 88, 90-92, 94,
103
Zempléni A., 113, 138, 140, 258,
283
Zola I., 67-68,
Zorzetto S., 11, 225, 230, 234,
241, 246, 252
Zúniga Valle C., 269, 271, 276
347
Indice analitico
adolescenti e medicalizzazione,
76-77
agentività, 116-117, 125, 132,
211
agopuntura, 157, 178
AIDS, 59, 61, 65, 165, 210, 288289,
amok, 256, 260, 261
arene sociali, 274
asse eziologico, 138
bio-economia, 14, 46, 49
biopolitica, 183, 199, 203, 280,
294
- e medicina popolare, 199
bios, 46
- capitalizzazione del, 46
biosocialità, 46, 294
brain fag, 262
capitale sociale, 13-52, 277
- come valore misurabile, 18
- e analisi dei reticoli, 35, 39
- e disuguaglianze socioeconomiche, 27, 37
- e ricerca epidemiologica, 37
- e solidarietà, 17-18, 20-21,
27, 37, 44, 51
care, 131
CBS, 234-236, 253-267
Vedi sindromi culturalmente
caratterizzate
chiropratica, 157-158, 178
ciclo mestruale, 73, 81
complementarismo, 247-248
compliance, 136, 290
comunità epistemologiche, 104
configurazioni sanitarie plurali,
273
contagio, 53-66, 137, 147,
- e associazioni metaforiche,
57
- e pensiero analogico, 56, 57
- per contiguità, 55
- contaminazione, 46, 56, 63,
64, 74, 76
corpo
- come macchina, 72
- come simbolo naturale, 63,
64
- concezioni del, 62, 63, 163,
167, 196
- controllo del, 68, 71, 80, 82,
92, 98, 171
- naturalizzazione del, 49, 69
- e medicine non
convenzionali, 159
- e percezione, 83, 92, 115,
170, 172
- femminile, 67-83, 191
corredo genetico, 47
- manipolazione del, 47
credenza, 72, 154, 195, 199, 204,
250-251
Culture Bound Syndromes Vedi
CBS
cure, 131
deculturazione/acculturazione,
227-228, 265
depressione, 75, 213, 218, 220223
determinismo biologico in
350
Indice analitico
psichiatria, 255, 257
dhat, 256, 261
disease, 61, 86, 99, 130, 131,
145, 207, 273, 285
disturbi etnici, 260
disturbo da stress posttraumatico, 262
Dna, 47-48
- mappatura del, 47
- dolore, 85-112
- acuto, 85, 88
- cronico, 85, 88, 95, 98, 99,
101, 103
- definizione, 87
- e comunicazione, 106, 107,
110
- e cultura, 91-93
- e genere, 102-103
- ed esperienza, 86, 88, 9293, 95, 97, 100, 105, 106
- interpretazione del, 99-100
- strumenti di accertamento
del, 104-106
donazione di sangue e di organi,
22
dono, 22
- economie del, 19
- e credito, 22
- e merce, 22
- e scambio, 21
DSM-IV, 235, 253
dualismo corpo/mente, 72, 128
effetto nocebo, 152
effetto placebo, 150
efficacia, 127-155
- clinica, 30
- simbolica, 144, 149, 152,
154, 159, 163, 191, 195
- e lavoro metaforico, 153
embodiment. Vedi
incorporazione
empatia, 98, 102, 215-216
endocrinologia, 78
endometriosi, 103-106
ethos compassionevole, 212,
213, 294
etnopsichiatria, 233, 247, 250
etnopsichiatria comunitaria, 227
eziologia, 105, 136-137, 165,
259-260, 270
fenomenologia della percezione,
116
fenotipi, 255
fiori di Bach, 157
fitness, 169-170
fitoterapia, 158, 178-179
follia melanconica, 241
frattura biografica, 207, 217
genotipi, 255
gentrification, 19
goal striving stress, 241, 242
Guajiro, 56
guaritori, 166, 192, 202, 264
habitus, 25, 115, 133, 212
- e imposizione simbolica, 23
healing, 131, 145
hwabyung, 262
illness narratives, 205, 207, 209210, 212, 214, 216, 218, 223
- definizione, 205
incorporazione, 25-26, 43, 101,
113-125, 193, 199, 284, 289, 296
iridologia, 157
istituzioni sanitarie, 161, 211,
213, 269-284, 293
knowledge, attitudes, practices,
288
koro, 256, 260, 261
matrazza, 191, 192
medical humanities, 208
Indice analitico
medicalizzazione,
- definizione, 67, 279
- della procreazione, 69
- e fisiologia femminile, 69,
75
- processi di, 278
- processo storico di, 278
medicina alternativa.
Vedi medicine non convenzionali
medicina antroposofica, 157, 178
medicina ayurvedica, 157
medicina complementare.
Vedi medicine non convenzionali
medicina naturale. Vedi
medicine non convenzionali
medicina popolare
- definizione, 181, 189
- e fenomenologie corporee,
194
- e intellettuali, 184
- genesi della categoria
analitica di, 182
- incontro/scontro con
medicina ufficiale, 188, 192,
201
medicina tradizionale cinese,
158, 178, 179
medicine non convenzionali,
157-180
- concezione del corpo nelle,
159
- definizione, 159
- e corpo, 159
- e razionalità, 161-163, 173
- ed estetica del corpo, 170
olismo, 144
menopausa, 68-68, 72, 77-82
mestruazioni, 68, 71-77, 81-82,
103
metalogo, 239, 242, 243, 250
351
migrazioni, 225, 237
- e forme di socialità, 229
- e salute mentale, 239-252
mindful bodies, 132, 208
MNC. Vedi medicine non
convenzionali
modelli esplicativi, 136, 139,
219, 221
morte per suggestione, 152
narrative-based medicine, 208
narrazioni di malattia, 105-107,
111, 205- 208, 212-213, 222
- problemi metodologici, 210
naturopatia, 157, 178
Ndembu, 135
neurastenia, 213, 222
omeopatia, 157-158, 160, 178,
196, 273
OMS, 288, 299
paziente manipolativo, 98-99
percorso terapeutico, 148, 271
pibloktoq, 262
pluralismo medico, 163, 176,
197, 276
pranoterapia, 157, 158
pratiche rituali, 139, 148, 185
psichiatria, 209, 222, 224, 233,
235, 247-249, 253-254
- biologica, 255, 259
- transculturale 256-259
- principio esplicativo in,
239, 240, 250
- tipi clinici ideali in, 256
- tipi ibridi in, 256
psiconeuroendocrinoimmunologia, 151
rete semantica della malattia,
212, 219-220
rifugiati, 101, 226, 227
salute
352
-
-
Indice analitico
determinanti di, 27, 35, 38
determinanti sociali della,
299
- e bene comune, 24, 32-33,
197
- e gestione di servizi, 233
- e livelli di reddito, 35
- e reciprocità, 22, 36
- e welfare state, 29
salute mentale, 13, 185, 221,
226-227, 234-237, 246, 248
- di comunità, 225-237
- e migrazioni, 239-252
salute riproduttiva, 105
sangue mestruale, 72, 73
sciamano, 153, 154, 282
Sérère, 62
servizi di salute mentale, 226227, 232, 235
- e flussi migratori, 232
shiatsu, 157, 178
shock culturale, 241
sickness, 130, 131, 142, 221
simboli naturali, 64
simbolizzazione, 55
sindrome premestruale, 74-75
sindromi culturalmente
caratterizzate, 236, 253-267
- definizione, 253
sistema medico, 145, 190, 206,
269-284
- definizione, 269
sistemi medici plurali, 271-272
sofferenza sociale, 31, 87, 211,
222, 285, 299
- definizione, 285
somatizzazione, 213
stato
- come colonizzazione delle
diversità
culturali, 186
- come corpo vivente, 119
- e incorporazione, 113-125
- e tecniche del corpo, 123
stregoneria, 15, 64, 202, 232, 263
strutture di accoglienza, 226
susto, 262
taijinkyofusho, 262
therapeutic emplotment, 92, 220
tubercolosi, 59, 60, 65, 288, 290
vaccinazione, 198-199
- e paura popolare, 198
violenza strutturale, 285-299
- definizione, 286
- incorporazione biologica
della, 289
windigo, 262
Gli autori
Andrea Caprara, medico e antropologo, è attualmente visiting
professor presso l’Instituto de Saúde Colectiva, Universidade
Federal da Bahia e presso la Escola de Saúde Pública do Ceará,
Fortaleza, Brasile. In queste istituzioni insegna antropologia
medica, antropologia dei sistemi sanitari, metodologia di ricerca e si interessa di metodi educativi come l’apprendimento per
problemi (problem based learning). Tra le numerose pubblicazioni, il volume Interpretare il contagio. Una indagine storicoetnografica sulle pratiche mediche presso gli Alladian della Costa
d’Avorio (2001).
Giuseppe Cardamone, medico psichiatra e psicoterapeuta. Attualmente lavora presso l’Azienda USL 9 di Grosseto nel ruolo
di Direttore Dipartimento di Salute Mentale e continua ad occuparsi di salute mentale dei migranti, in particolare rifugiati e
richiedenti asilo.
Donatella Cozzi, insegna antropologia medica presso l’Università di Milano Bicocca e presso l’Università di Ca’ Foscari Venezia, e da oltre venti anni nei corsi di laurea in Infermieristica
di diversi Atenei. Si interessa della relazione tra antropologia e
professioni sanitarie e di illness narratives. Attualmente è membro associato alla UMR 7236 «Culture et Société en Europe»,
Université de Strasbourg nel quadro del programma ANR “Expériences du corps et passages d’âge: le cas des 9-13 ans (France
et Italie)”, coordinato da Nicoletta Diasio.
Michela Da Prato, psicologa e psicoterapeuta specializzata
presso l’Istituto di Psicoterapia Relazionale di Pisa, presidente
dell’Associazione culturale S.I.P.R. “Società Italiana di Psicote-
354
Gli autori
rapia Relazionale”, vice-Presidente Ce.R.I.S.C. “Centro Ricerche e Interventi nei Sistemi Complessi” onlus, Prato. Nell’ambito della clinica e interventi con i migranti svolge attività di
consulenza, supervisione e formazione, nonché attività clinica
con utenti dei Dipartimenti di Salute Mentale, profughi, richiedenti asilo e rifugiati.
Fabio Dei, insegna Antropologia culturale presso l’Università
di Pisa. Si interessa di epistemologia delle scienze sociali, antropologia della violenza, forme della cultura popolare e di massa
nell’Italia contemporanea. Fra i suoi più recenti scritti: Antropologia della violenza (2005), Culture del dono (con M. Aria,
2008), La donazione del sangue. per un’antropologia dell’altruismo (con M. Aria, G.L. Mancini, 2008), La materia del quotidiano. Per un’antropologia degli oggetti ordinari (con S. Bernardi,
P. Meloni, 2011), Antropologia culturale (2012). Salvatore Inglese, medico e psichiatra. Da molti anni cura la
salute mentale delle popolazioni straniere all’interno dei sistemi
di salute pubblica. La sua attività di ricerca e formazione si concentra sullo sviluppo della metodologia clinica dell’etnopsichiatria. Nell’intento di costruire e perfezionare dispositivi operatori sensibili alle nosologie degli altri mondi culturali, lavora sulle
modalità teorico-pratiche con cui utilizzare le lingue d’origine
nella clinica transculturale.
Helle Johannessen, è professore ordinario presso l’Institute of
Public Health, University of Southern Denmark. Esperta in antropologia del pluralismo medico, ha svolto ricerche etnografiche in Danimarca, Canada e Italia. Dal 2005 è direttrice di una
équipe multidisciplinare presso la Facoltà di Health Sciences
del medesimo ateneo. Dirige progetti europei sulla integrazione fra metodologie qualitative e quantitative nella ricerca interdisciplinare sull’efficacia delle terapie. Fra i suoi lavori più
recenti, Multiple Medical Realities: Reflections from medical
anthropology (con Imre Lázár 2006), Embodiment and the Sta-
Gli autori
355
te (con G. Pizza, 2009), Citizens’ needs and attitudes towards
CAM (European Commission, 2012).
Alessandro Lupo, insegna Etnologia presso l’ Università di
Roma La Sapienza, dove coordina il Dottorato in Etnologia ed
etnoantropologia. Dirige la Missione Etnologica Italiana in Messico, di cui fa parte dal 1979, svolgendo ricerche tra i Huave
dell’Istmo di Tehuantepec e i Nahua della Sierra di Puebla, su
temi quali la residenza, l’etnoastronomia, la cosmologia, la tradizione orale, i saperi medici e le pratiche rituali, nonché le dinamiche culturali in generale. Coordina inoltre diversi progetti
di ricerca etnografica su temi di sanità pubblica, in Italia e in
Messico. Tra i suoi lavori: I tre cardini della vita. Anime, corpo,
infermità tra i Nahua della Sierra di Puebla (con I. Signorini,
1989), La Tierra nos escucha. La cosmología de los nahuas de la
Sierra a través de las súplicas rituales (1995), Antropologia della
salute indigena: popolazione nativa e istituzioni sanitarie in Messico (a cura di, in stampa).
Massimiliano Minelli, insegna Antropologia medica ed etnopsichiatria e Metodologia della ricerca etnografica nella Facoltà
di lettere e filosofia della Università degli studi di Perugia (Corso di laurea magistrale in Antropologia culturale ed etnologia).
I suoi principali interessi riguardano il rapporto fra dinamiche
culturali, forme di disturbo psichico e azioni comunitarie nel
campo della salute mentale. Da alcuni anni su questi temi coordina diversi progetti di ricerca etnografica in Italia e in Brasile.
Tra i suoi recenti lavori: Memorie e possessione (2008), Santi,
demoni, giocatori. Una etnografia delle pratiche di salute mentale
(2011).
Giovanni Pizza, insegna Antropologia medica e culturale nelle
Facoltà di Lettere e Filosofia e di Medicina e Chirurgia nell’Università degli Studi di Perugia. È stato visiting professor in
diverse università europee. Si interessa di medicina popolare,
antropologia del corpo, processi di incorporazione, posses-
356
Gli autori
sione, patrimonializzazione del tarantismo, migrazioni, studi
gramsciani. Attualmente coordina un gruppo di ricerca sulla
diagnosi precoce della malattia di Alzheimer. Fra le sue pubblicazioni Antropologia medica. Saperi, pratiche e politiche del
corpo (2005), Embodiment and the State. Health, biopolitics and
the intimate life of state powers (con H. Johannessen, 2009).
Ivo Quaranta, insegna Antropologia Culturale e Antropologia
del corpo e della malattia presso l’Università di Bologna. I suoi
principali interessi di ricerca lo vedono impegnato sul fronte
dell’analisi del rapporto fra disuguaglianze socio-economiche e
salute, delle politiche e dei servizi socio-sanitari e dell’esperienza vissuta di sofferenza. Tra le sue pubblicazioni, ha curato il
volume antropologia medica. I testi fondamentali (2006).
Gianfranca Ranisio, insegna Antropologia Culturale presso la
Facoltà di Sociologia dell’Università di Napoli Federico II. Si
occupa da anni di tematiche di antropologia medica e di gender
studies. In particolare si è soffermata sui processi di medicalizzazione che interessano le tappe biologiche femminili ponendo
in evidenza come queste si intreccino con le rappresentazioni
simboliche e culturali di genere. Su questo ha pubblicato: Venire al mondo. Pratiche, credenze e rituali del parto (1998), Quando le donne hanno la luna. Credenze e tabù (2006) e numerosi
articoli.
Pino Schirripa, insegna Antropologia Religiosa ed Etnopsichiatria presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni della
Sapienza, Università di Roma. Si è occupato di migrazioni, terapie religiose e processi di professionalizzazione della medicina tradizionale svolgendo ricerche in Italia, Ghana ed Etiopia. Attualmente dirige una missione di ricerca di antropologia
medica in Etiopia. Tra i volumi recenti pubblicati: Le politiche
della cura. Terapie potere e tradizione nel Ghana contemporaneo
(2005), Materiali di ricerca sulla medicina tradizionale in area
nzema (Ghana) (con M. Pavanello, 2008), Health system, sikness
Gli autori
357
and social suffering in Mekelle (Tigray – Ethiopia) (2010), Terapie religiose. Neoliberismo, cura, cittadinanza nel pentecostalismo contemporaneo (2012).
Sergio Zorzetto, psicologo e psicoterapeuta. Dottore di ricerca
in Antropologia ed Epistemologia della Complessità – Università di Bergamo. Presidente di Ce.R.I.S.C – Centro Ricerche e
Interventi nei Sistemi Complessi onlus, Prato. Con G. Cardamone ha pubblicato Salute mentale di comunità. Elementi di
teoria e pratica (2000).