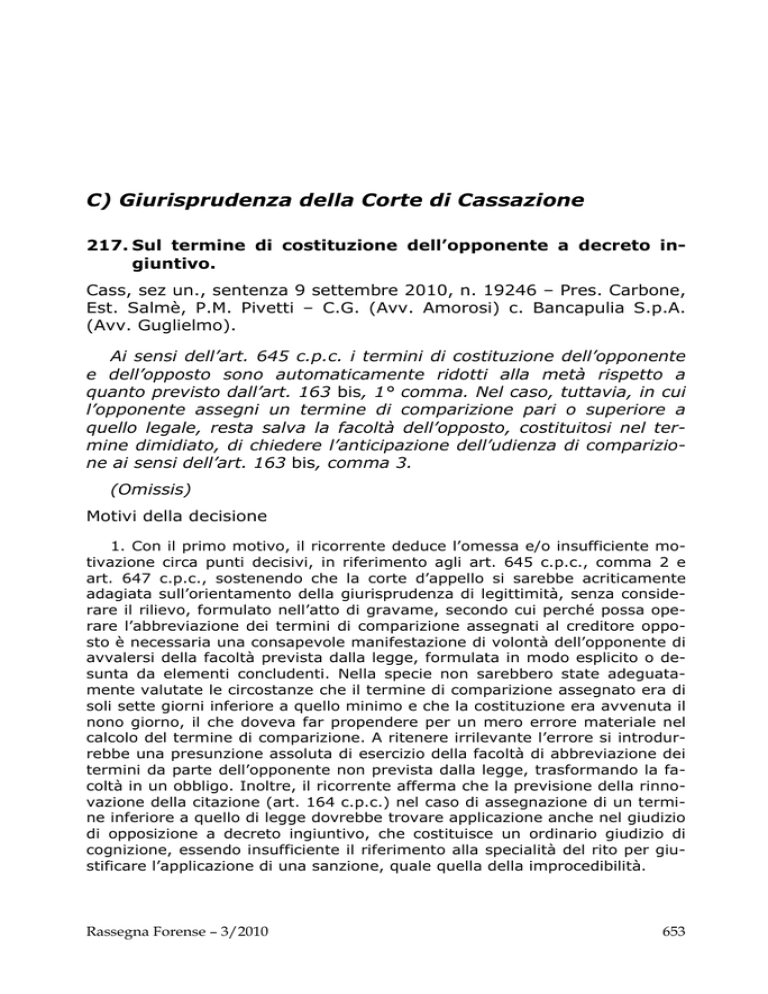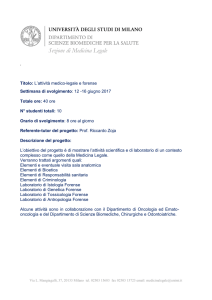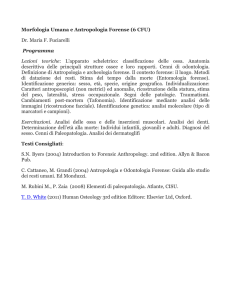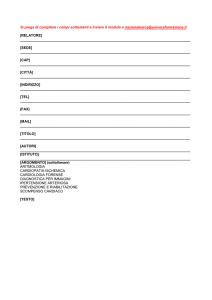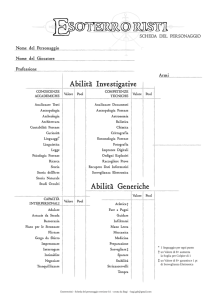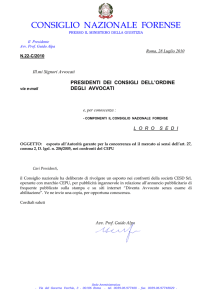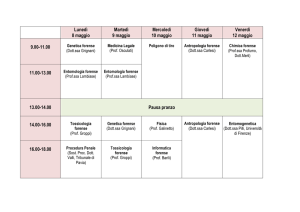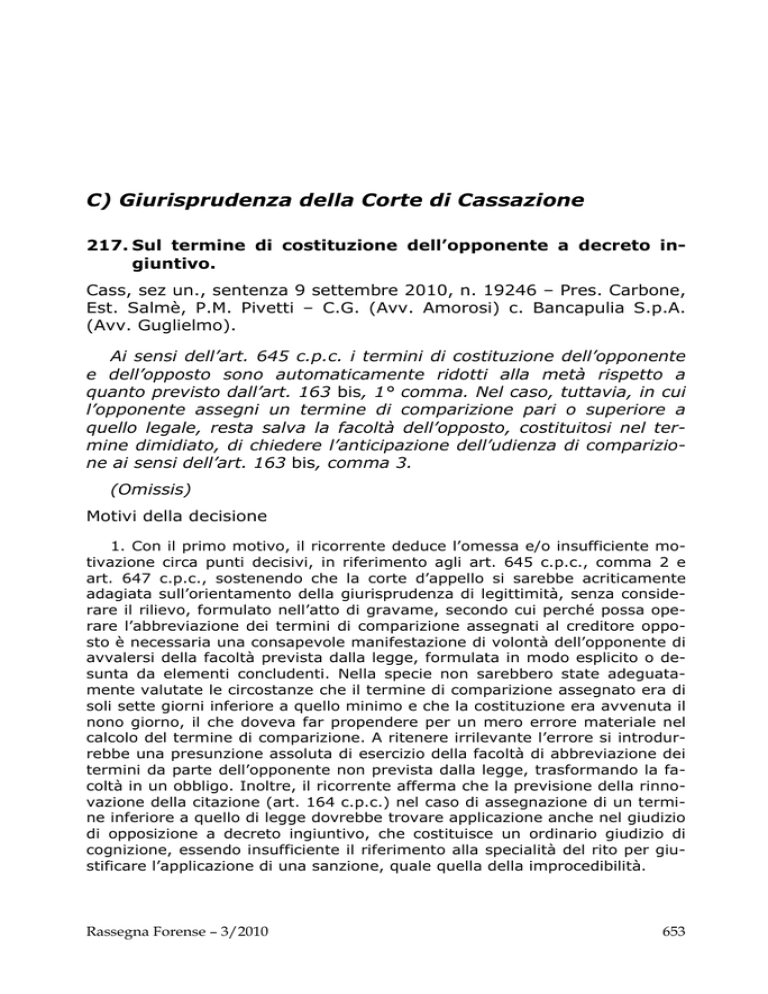
C) Giurisprudenza della Corte di Cassazione
217. Sul termine di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo.
Cass, sez un., sentenza 9 settembre 2010, n. 19246 – Pres. Carbone,
Est. Salmè, P.M. Pivetti – C.G. (Avv. Amorosi) c. Bancapulia S.p.A.
(Avv. Guglielmo).
Ai sensi dell’art. 645 c.p.c. i termini di costituzione dell’opponente
e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà rispetto a
quanto previsto dall’art. 163 bis, 1° comma. Nel caso, tuttavia, in cui
l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a
quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, comma 3.
(Omissis)
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’omessa e/o insufficiente motivazione circa punti decisivi, in riferimento agli art. 645 c.p.c., comma 2 e
art. 647 c.p.c., sostenendo che la corte d’appello si sarebbe acriticamente
adagiata sull’orientamento della giurisprudenza di legittimità, senza considerare il rilievo, formulato nell’atto di gravame, secondo cui perché possa operare l’abbreviazione dei termini di comparizione assegnati al creditore opposto è necessaria una consapevole manifestazione di volontà dell’opponente di
avvalersi della facoltà prevista dalla legge, formulata in modo esplicito o desunta da elementi concludenti. Nella specie non sarebbero state adeguatamente valutate le circostanze che il termine di comparizione assegnato era di
soli sette giorni inferiore a quello minimo e che la costituzione era avvenuta il
nono giorno, il che doveva far propendere per un mero errore materiale nel
calcolo del termine di comparizione. A ritenere irrilevante l’errore si introdurrebbe una presunzione assoluta di esercizio della facoltà di abbreviazione dei
termini da parte dell’opponente non prevista dalla legge, trasformando la facoltà in un obbligo. Inoltre, il ricorrente afferma che la previsione della rinnovazione della citazione (art. 164 c.p.c.) nel caso di assegnazione di un termine inferiore a quello di legge dovrebbe trovare applicazione anche nel giudizio
di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce un ordinario giudizio di
cognizione, essendo insufficiente il riferimento alla specialità del rito per giustificare l’applicazione di una sanzione, quale quella della improcedibilità.
Rassegna Forense – 3/2010
653
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sul termine di costituzione dell’opponente a d.i.
Con il secondo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 645 c.p.c., comma 2, con riferimento all’art. 647 c.p.c., si sostiene che
al giudizio di opposizione, come previsto dall’art. 645 c.p.c., deve applicarsi la
disciplina del procedimento ordinario e pertanto in caso di costituzione in giudizio, non omessa, ma semplicemente ritardata, non sarebbe giustificata la
sanzione processuale dell’improcedibilità, prevista soltanto per il giudizio di
appello dall’art. 348 c.p.c., come modificato dalla l. n. 353 del 1990. Viene
anche denunciata l’incoerenza consistente nel ritenere inapplicabile, per la
specialità del rito, l’art. 164 c.p.c. facendo allo stesso tempo applicazione del
disposto degli artt. 165 e 163 bis c.p.c.
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce errata o falsa applicazione dell’art.
645 c.p.c., comma 2, in quanto non sarebbe corretta l’estensione della riduzione del termine di costituzione previsto dall’art. 165, per il caso in cui il
giudice abbia autorizzato la riduzione del termine minimo a comparire, all’ipotesi in cui la riduzione del termine di comparizione sia conseguenza di una
mera scelta di parte.
2. Le ragioni addotte dal ricorrente, in parte recepite e sviluppate nell’ordinanza interlocutoria della prima sezione civile, non sono idonee a giustificare un mutamento del costante orientamento della corte, anche se, come sarà
in seguito precisato, è opportuno procedere a una puntualizzazione. A parte
un unico risalente precedente contrario, rimasto assolutamente isolato (Cass.
10 gennaio 1955 n. 8), la giurisprudenza della corte è stata costante nell’affermare che quando l’opponente si sia avvalso della facoltà di indicare un
termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine per la sua costituzione è automaticamente ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell’atto di citazione in opposizione, pari alla metà del termine di costituzione
ordinario (principio affermato, nel vigore dell’art. 645, come modificato con il
d.P.R.n. 597 del 1950, art. 13 a cominciare da Cass. 12 ottobre 1955, n.
3053 e poi costantemente seguito; da ultimo, v. Cass. n. 3355/1987,
2460/1995, 3316 e 12044/1998, 18942/2006).
Più recentemente, nell’ambito di tale orientamento, si è ulteriormente precisato che l’abbreviazione del termine di costituzione per l’opponente consegue
automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine
di comparizione inferiore a quello ordinario, essendo irrilevante che la fissazione di tale termine sia dipesa da una scelta consapevole ovvero da errore di calcolo (Cass. n. 3752/2001, 14017/2002, 17915/2004, 11436/2009).
Contrariamente a quanto ritenuto da una parte della dottrina l’orientamento ora richiamato non è privo della necessaria base normativa.
Se, infatti, è vero che nella formulazione originaria del codice del ‘42, l’art.
645, comma 2 prevedeva la riduzione a metà dei termini di “costituzione”,
mentre nell’attuale formulazione della disposizione la riduzione a metà si riferisce solo ai termini di “comparizione”, dai lavori preparatori non emerge tuttavia che la modifica testuale sia stata introdotta per ridimensionare la funzione acceleratoria della riduzione a metà dei termini di costituzione prevista
dalla disciplina previgente, ma solo che la norma era stata imposta come necessaria conseguenza dalla introduzione del sistema della citazione ad udienza fissa.
654
Rassegna Forense – 3/2010
Parte Seconda – Giurisprudenza
Non esiste, peraltro, nessuna ragione oggettiva che giustifichi l’opposta
opinione che reputa che il silenzio del legislatore in ordine alla disciplina dei
termini di costituzione, a fronte della espressa previsione contenuta nella disciplina previgente, sia significativo della volontà di cambiare la regola, espressamente affermata dall’art. 165 c.p.c., comma 1, che stabilisce un legame tra termini di comparizione e termini di costituzione, al fine di rendere
coerente il sistema nei procedimenti che esigono pronta trattazione.
Ne deriva che tale regola, non può certo ritenersi di natura eccezionale o
derogatoria, ma espressione di un principio generale di razionalità e coerenza
con la conseguenza che l’espresso richiamo nell’art. 645 di tale principio sarebbe stato del tutto superfluo.
Né appare decisivo il rilievo, indubbiamente corretto, della differenza esistente tra la fattispecie di cui all’art. 163 bis c.p.c., comma 2, nella quale
l’abbreviazione dei termini è conseguenza dell’accertamento da parte del giudice della sussistenza delle ragioni di pronta trattazione della causa prospettate dall’attore, e di quella di cui all’art. 645 c.p.c., nella quale tale apprezzamento è compiuto (non dalla parte, come sostiene l’ordinanza di rimessione, ma direttamente) dal legislatore una volta per tutte, essendo in entrambe
le fattispecie identica la funzione del dimezzamento dei termini di comparizione, consistente, da un lato, nel soddisfare le esigenze di accelerazione della trattazione e dall’altro, nell’opportunità di bilanciare la compressione dei
termini a disposizione del convenuto con la riduzione dei termini di costituzione dell’attore.
Essendo pacifica la sussistenza dell’esigenza di sollecita trattazione dell’opposizione, diretta a consentire la verifica della fondatezza del provvedimento sommario ottenuto dal creditore inaudita altera parte, deve osservarsi
che sussiste anche l’esigenza di bilanciamento delle posizioni delle parti, pur
tenendo conto della peculiarità del giudizio di opposizione che, come è noto,
ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame de rapporto giuridico controverso, e non il semplice
controllo della legittimità della pronuncia del decreto d’ingiunzione. È anche
pacifico che, a differenza dalle qualità formali, le posizioni dell’opponente e
dell’opposto sono quelle, rispettivamente, di convenuto e di attore in senso
sostanziale. Ora, se è vero che l’opposto ha avuto tutto il tempo di impostare
la propria posizione processuale prima di chiedere il decreto ingiuntivo, resta
anche vero che, di fronte alle allegazioni e alle prove, prodotte o richieste,
dall’opponente, l’opposto ha necessità di valutarle per apprestare le sue difese e a tal fine sussiste l’esigenza di avere a disposizione i documenti sui quali
si fonda l’opposizione nel più breve tempo possibile, per riequilibrare il sacrificio del termine a sua disposizione per valutare tali prove e articolare le difese prima della propria costituzione in giudizio.
Ciò che è indubbio è che certamente la necessità di sollecita trattazione dei
procedimenti di opposizione meglio sarebbe stata soddisfatta se oltre alla riduzione a metà dei termini di costituzione dell’opponente il legislatore avesse anche ridotto in misura congrua i termini di costituzione dell’opposto, che invece
restano abbastanza ampi (trentacinque giorni dalla notifica dell’opposizione e
cioè dieci giorni prima dell’udienza che deve essere fissata a non meno di qua-
Rassegna Forense – 3/2010
655
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sul termine di costituzione dell’opponente a d.i.
rantacinque giorni dalla notifica stessa, ai sensi dell’art. 166 c.p.c.), ma tale
opportunità di assecondare “l’euritmia del sistema” (corte cost. n. 18/2008),
non incide sulla fondatezza del rilievo che il dimezzamento dei termini di costituzione dell’opponente, comunque rappresenta una, sia pur parziale e, forse,
insoddisfacente, misura di accelerazione del procedimento.
3. Una parte della dottrina, ripresa anche dall’ordinanza della prima sezione
civile, ha osservato che la lettera dell’art. 645 c.p.c. induce a ritenere che il dimezzamento dei termini di comparizione sia un effetto legale della proposizione
dell’opposizione e non dipenda invece dalla volontà dell’opponente che intenda
assegnare un termine inferiore a quello previsto dall’art. 163 bis c.p.c.
In effetti esigenze di certezza e quindi di garanzia delle parti, di fronte alla
previsione di termini previsti a pena di procedibilità dell’opposizione, ha già
portato a introdurre nell’orientamento tradizionale, basato sulla facoltatività
della concessione da parte dell’opponente di un termine a comparire inferiore
a quello legale, il temperamento costituito dall’affermazione dell’irrilevanza
della volontà dell’opponente che potrebbe avere assegnato un termine inferiore anche solo per errore.
Ritengono le sezioni unite che esigenze di coerenza sistematica, oltre che
pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello
legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia sfata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni
caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore
a quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, comma 3.
D’altra parte, se effettivamente il dimezzamento dei termini di costituzione
dipendesse dalla volontà dell’opponente di assegnare un termine di comparizione inferiore a quello legale, non si capirebbe la ragione per la quale, secondo
la giurisprudenza di questa Corte, sono cumulabili il dimezzamento che deriva
dalla astratta previsione legale di cui all’art. 645 c.p.c. con quello che può discendere da un apposito provvedimento di dimezzamento di tali termini richiesto ai sensi dell’art. 163 bis, comma 3 (Cass. n. 4719/1995, 18203/2008).
Né potrebbe indurre a diverse conclusioni l’osservazione che, se si ritiene
irrilevante la volontà dell’opponente di assegnare un termine di comparizione
inferiore a quello legale, potrebbe sorgere il dubbio che il sacrificio del suo
termine di costituzione possa essere ingiustificato, alla luce dell’art. 24 Cost.,
come potrebbe desumersi da corte cost. n. 38/2008. Infatti, l’effetto legale
del dimezzamento dei termini di costituzione dell’opponente, dipendente sia
solo fatto della proposizione dell’opposizione, è pur sempre un effetto che discende dalla scelta del debitore che non può non conoscere quali sono le conseguenze processuali che la legge ricollega alla sua iniziativa.
Infine, la diversa ampiezza dei termini di costituzione dell’opponente rispetto a quelli dell’opposto non appare irragionevole posto che la costituzione
del primo è successiva alla elaborazione della linea difensiva che si è già tra-
656
Rassegna Forense – 3/2010
Parte Seconda – Giurisprudenza
dotta nell’atto di opposizione rispetto al quale la costituzione in giudizio non
richiede che il compimento di una semplice attività materiale, mentre nel
termine per la sua costituzione l’opposto non è chiamato semplicemente a ribadire le ragioni della sua domanda di condanna, oggetto di elaborazione nella fase anteriore alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, ma ha la
necessità di valutare le allegazioni e le prove prodotte dall’opponente per
formulare la propria risposta.
4. È consolidato orientamento di questa Corte che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell’opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione (Cass.
n. 9684/1992, 2707/1990, 1375/1980; 652/1978, 3286/1971, 3030/1969,
3231/1963, 3417/1962, 2636/1962, 761/1960, 2862/1958, 2488/1957,
3128/1956). È innegabile infatti, da una parte, che la specialità della norma di
cui all’art. 647 c.p.c. impedisce l’applicazione della ordinaria disciplina del processo di cognizione, e dall’altra, che la costituzione tardiva altro non è che una
mancata costituzione nel termine indicato dalla legge. Il ricorrente non ha prospettato ragioni decisive che possano indurre la Corte a discostarsi da tale orientamento. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi, in relazione al dibattito esistente sulle questioni
oggetto del presente giudizio, per compensare le spese.
(Omissis)
Rassegna Forense – 3/2010
657
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Maestro elementare e professione forense
218. Sulla compatibilità tra l’impiego pubblico di maestro elementare e professione forense.
Cass., sez. un., 8 novembre 2010, n. 22623 – Pres. Vittoria – Rel.
Botta – Ricorrente F.B., c. C.O.A. Lecce e Consiglio nazionale forense.
La lettura costituzionalmente orientata della norma di cui all’art. 3,
comma 4, lettera a), r.d.l. n. 1578 del 1933 non esclude la compatibilità dell’attività di docente della scuola elementare statale con
l’esercizio della professione forense e consente l’iscrizione all’albo degli avvocati del soggetto che abbia i requisiti richiesti.
(Omissis)
La controversia concerne l’impugnazione innanzi al Consiglio nazionale forense del provvedimento con il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Siena deliberava negativamente sulla domanda di iscrizione all’albo presentata dalla dott.ssa F.B., dopo aver compiuto il periodo della prescritta pratica
forense e dopo aver superato la prova orale degli esami di avvocato. La ragione del rigetto della domanda di iscrizione era indicata nella circostanza che
«l’attività di insegnante elementare (svolta dalla richiedente), retribuita con
stipendio a carico del bilancio dello Stato, non è compresa tra le eccezioni di
cui alla lettera a) dell’art. 3 del r.d.l. n. 1578/1933».
Il Consiglio nazionale forense rigettava il ricorso, con la decisione in epigrafe, avverso la quale, la dott.ssa B. propone ricorso per cassazione con tre
motivi. Il C.O.A. di Siena non si è costituito.
Motivazione
1. Con il primo motivo si censura, sotto il profilo della violazione di legge,
la decisione impugnata, laddove ha ritenuto la inequivoca capacità ostativa
della norma espressa dall’art. 3, comma 4, lettera a), r.d.l. n. 1578 del 1933,
con la quale il legislatore avrebbe «indicato in dettaglio le situazioni soggettive che si pongono in termini di eccezione al generale ed inderogabile regime
di incompatibilità» prescritto dai commi precedenti della medesima disposizione, limitando tali situazioni solo a quelle dei docenti universitari e degli insegnanti degli istituti secondari dello Stato.
2. La ricorrente sostanzialmente contesta la ragionevolezza della limitazione, rilevando l’assenza di una distinzione, quanto alla funzione esercitata,
tra insegnante della scuola elementare e insegnante di istituto secondario, ed
evidenziando la possibilità della interpretazione estensiva di una “norma eccezionale”: in subordine, con il secondo motivo, per l’ipotesi che non venisse
ritenuta possibile una diversa ricostruzione del contenuto normativo denunciato, la ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale della norma
per contrasto con gli artt. 3, 4. 33, 35 e 41 Cost.
3. Il motivo è fondato. Secondo quanto afferma la Corte costituzionale
nella sentenza n. 390 del 2006, l’eccezione al regime di incompatibilità stabi-
658
Rassegna Forense – 3/2010
Parte Seconda – Giurisprudenza
lita dall’art. 3, comma 4, lettera a), r.d.l. n. 1578 del 1933, deve essere considerata «alla luce del principio costituzionale della libertà dall’insegnamento
(art. 33 Cost.), dal quale discende che il rapporto di impiego (ed il vincolo di
subordinazione da esso derivante), come non può incidere sull’insegnamento
(che costituisce la prestazione lavorativa), cosi, ed a fortiori, non può incidere
sulla libertà richiesta dall’esercizio della professione forense». Se questa è la
ratio della norma in esame, allora appare piuttosto evidente la irragionevolezza di circoscrivere l’eccezione ai soli docenti universitari e agli insegnanti
degli istituti secondari, escludendo gli insegnanti elementari.
4. Quest’ultimi, infatti, godono della medesima “libertà di insegnamento”
ed esercitano una identica funzione, come emerge immediatamente dal
D.Lgs. n. 295 del 1994, che tratta unitariamente, nel quadro dell’istruzione
obbligatoria, scuola elementare e scuola media. La prima, «nell’ambito dell’istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione
delle diversità individuali, sociali e culturali ... e si propone lo sviluppo della
personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale»
(art. 118); la seconda, «concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del
cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva» (art. 161).
5. La funzione docente è, anch’essa, espressione di una scelta legislativa
che non distingue scuola elementare e scuola media, affermando che «la funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla
partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica
della loro personalità».
6. Unitariamente, infine, è trattato il reclutamento del personale docente,
che, per essere impiegato nella scuola elementare, deve essere in possesso
di un diploma di laurea (v. art. 3, l. n. 341 del 1990; v. anche art. 1, l. n. 270
del 1982).
7. Il problema è se la rilevata irragionevolezza, stante l’unitarietà della funzione docente, dell’esclusione degli insegnanti elementari dall’area di eccezione
alla incompatibilità generale con la professione forense, abbia un possibile rimedio per via interpretativa a fronte dell’indiscutibile carattere eccezionale della norma di cui all’art. 3. comma 4, lettera a), r.d.l. n. 1578 del 1933.
7.1. Riguardo alle norme eccezionali, questa Corte se ha sempre escluso
la possibilità di un’interpretazione analogica, ha, tuttavia, ammesso la possibilità di una interpretazione estensiva (Cass. nn. 5297 del 2009; 17396 del
2005; 9205 del 1999), come quella cui dovrebbe farsi ricorso nell’ipotesi in
esame.
7.2. Si tratta, nel caso di specie, non di stabilire una nuova eccezione alla
“regola”, bensì di esplicitare quanto è già individuabile nel contenuto della
norma in coerenza con l’identità di ratio di quanto espressamente previsto (v.
in particolare Cass. n. 9205 del 1999): e tanto più ciò sembra ammissibile, in
quanto nella fattispecie, mediante l’interpretazione estensiva, è possibile dare
una lettura costituzionalmente orientata della norma stessa, che, altrimenti,
Rassegna Forense – 3/2010
659
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Maestro elementare e professione forense
sembrerebbe disporre una discriminazione “irragionevole” e per questo in
contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza.
8. In tal modo deve ritenersi superata l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 3, comma 4, lettera a), r.d.l. n. 1578 del
1933, con l’assorbimento di qualsiasi altro motivo di impugnazione.
9. Pertanto si deve affermare il seguente principio di diritto: «l’art. 3,
comma 4, lettera a), r.d.l. n. 1578 del 1933, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, non esclude la compatibilità dell’attività di
docente della scuola elementare statale con l’esercizio della professione forense e ne consente l’iscrivibilità all’albo degli avvocati ove il soggetto ne abbia i requisiti richiesti».
10. Tali requisiti, nel caso di specie sussistono, visto che la ricorrente ha
sia compiuto la prescritta pratica forense, sia superato l’esame di Avvocato
(sul punto non sussistono in causa specifiche contestazioni).
11. Il ricorso deve essere, quindi, accolto e la decisione impugnata deve
essere cassata. Non essendo necessario alcun altro accertamento di fatto, la
causa può essere decisa nel merito, dichiarando il diritto della ricorrente
all’iscrizione all’Albo degli avvocati.
12. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese
dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto della ricorrente all’iscrizione
all’Albo degli avvocati. Compensa le spese.
660
Rassegna Forense – 3/2010
Parte Seconda – Giurisprudenza
219. Sui motivi di impugnazione della delibera di avvio del
procedimento disciplinare.
Cass., sez. un., sentenza 8 novembre 2010, n. 22624 – Pres. Vittoria
– Rel. Botta – Ricorrente C.N., P.L., L.L.
In relazione all’ammissibilità dei motivi di impugnazione di una delibera di avvio del procedimento disciplinare deve essere verificato caso
per caso secondo la prudenza del giudice, nella specie il Consiglio nazionale forense, se l’eccezione sollevata dal ricorrente sia o meno attinente in via esclusiva alla legittimità della delibera contestata.
Quanto alla competenza territoriale dell’organo deliberante, non
può esservi dubbio che essa costituisce un necessario presupposto
della legittimità della delibera adottata per l’avvio del procedimento
disciplinare.
Quanto alla genericità degli addebiti contestati, deve affermarsi
che costituisce presupposto di legittimità della delibera di avvio del
procedimento disciplinare una chiara e specifica contestazione dei fatti addebitati, tale da escludere il sospetto di un arbitrario esercizio
dell’azione disciplinare e da assicurare la possibilità dell’irrinunciabile
diritto di difesa dell’incolpato. Spetterà al giudizio di merito, poi, la
valutazione dell’eventuale fondatezza degli addebiti.
(Omissis)
La controversia concerne l’impugnazione innanzi al Consiglio nazionale forense del provvedimento con il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
presso il Tribunale di Bari deliberava di promuovere procedimento disciplinare
nei confronti degli avv.ti C.N., P.L. e L.L. per la contestazione di una serie di
addebiti relativamente a fatti avvenuti in Foggia.
Il Consiglio nazionale forense dichiarava inammissibile il ricorso, quanto
agli avv.ti P.L. e L.L., per intempestività della relativa proposizione, e quanto
all’avv. C.N., per inconferenza dell’impugnazione in relazione al mero controllo di legittimità dell’avvio del procedimento.
Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione l’avv. C.N. con tre
motivi, chiedendo altresì la sospensiva della deliberazione di avvio del procedimento disciplinare.
Motivazione
1. Con i motivi di ricorso, si lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’erroneità della decisione impugnata, laddove
ha ritenuto che l’eccepita incompetenza territoriale del Consiglio dell’Ordine
che aveva deliberato l’avvio del procedimento disciplinare e l’altrettanto ec-
Rassegna Forense – 3/2010
661
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sulla delibera di avvio del procedimento disciplinare
cepita genericità degli addebiti contestati, non costituissero motivi ammissibili
ai fini della censura della legittimità della delibera del C.O.A.
2. La decisione impugnata afferma, infatti, che, anche a voler aderire a siffatta prospettazione, nessuna delle censure esposte nell’impugnazione può ritenersi attinente agli stretti profili di legittimità dell’avvio del procedimento, né
funzionale a metterne in discussione gli astratti necessari presupposti: anche
l’eccezione di incompetenza territoriale «non può essere risolta se non attraverso la preventiva disamina della fondatezza delle allegazioni sviluppate in linea di fatto nel ricorso postulando essa un giudizio di merito sulle ragioni che
hanno indotto i consiglieri dell’Ordine di Foggia ad astenersi, così radicando la
competenza funzionale del C.O.A. di Bari a procedere disciplinarmente».
3. Il motivo è fondato. Queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 29294 del
2008, hanno affermato che: «In tema di procedimento disciplinare a carico di
un avvocato, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata
dell’art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, onde consentire, nella prospettiva del giusto processo (art. 111, primo e secondo comma, Cost.), un
più rapido intervento di un giudice terzo e imparziale sulla legittimità dell’avvio dell’anzidetto procedimento, deve ritenersi ammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione con la quale il locale Consiglio
dell’ordine stabilisce d’iniziare il procedimento medesimo».
4. Tale riconoscimento è strettamente funzionale ai principi della ragionevole durata del processo e all’effettività della tutela, essendo inteso ad evitare una dispersione di energie processuali derivanti dall’avvio di un procedimento illegittimo. Proprio per questa sua, in definitiva limitata, funzione, le
ragioni che possono sorreggere l’impugnazione della deliberazione di avvio
del procedimento disciplinare debbono essere strettamente attinenti ai profili
(o, se si vuole, alle condizioni) di legittimità della delibera medesima.
5. Poiché, tuttavia, è rispetto alla specifica realtà delle diverse situazioni,
che deve essere verificata l’ammissibilità dei motivi di impugnazione di una
delibera di avvio del procedimento disciplinare, non è possibile stendere un
completo catalogo delle ragioni opponibili, ma dovrà necessariamente essere
la prudenza del giudice, nella specie il Consiglio nazionale forense, a valutare,
caso per caso, se l’eccezione sollevata dal ricorrente sia o meno attinente in
via esclusiva alla legittimità della delibera contestata.
6. Nel caso di specie, i motivi addotti dal ricorrente concernono l’incompetenza territoriale del C.O.A. deliberante e la genericità degli addebiti contestati.
6.1. Quanto alla competenza territoriale dell’organo deliberante, non può
esservi dubbio che essa costituisce un necessario presupposto della legittimità della delibera adottata per l’avvio del procedimento disciplinare. Ed, invero, solo un organo che ne abbia la competenza può legittimamente disporre
l’avvio di un procedimento disciplinare.
6.2. Quanto alla genericità degli addebiti contestati, deve affermarsi che costituisce presupposto di legittimità della delibera di avvio del procedimento disciplinare una chiara e specifica contestazione dei fatti addebitati, tale da escludere il sospetto di un arbitrario esercizio dell’azione disciplinare e da assicu-
662
Rassegna Forense – 3/2010
Parte Seconda – Giurisprudenza
rare la possibilità dell’irrinunciabile diritto di difesa dell’incolpato. Spetterà al
giudizio di merito, poi, la valutazione dell’eventuale fondatezza degli addebiti.
7. Alla luce di siffatte considerazioni non poteva essere dichiarata inammissibile l’impugnazione per inconferenza dei motivi addotti, e, conseguentemente il ricorso deve essere accolto, e la decisione impugnata deve essere
cassata con rinvio della causa al Consiglio nazionale forense perché valuti la
fondatezza o meno delle eccezioni sollevate dal ricorrente.
8. Nell’accoglimento del ricorso resta assorbita la domanda di sospensione
della deliberazione di avvio del procedimento disciplinare.
9. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese della
presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Consiglio nazionale forense. Compensa le spese.
Rassegna Forense – 3/2010
663
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
La pubblicità informativa dell’attività professionale
220. Sui limiti della pubblicità informativa dell’attività professionale.
Cass, sez. un., 18 novembre 2010, n. 23287, Pres. Vittoria – Rel. Segreto – P.S. (Avv.ti Principi, Pensa) c. C.O.A. Brescia (Avv.ti Scognamiglio, Libertini) e Consiglio nazionale forense∗.
È illegittimo e sanzionabile disciplinarmente l’utilizzo da parte degli
avvocati di forme di pubblicità comparative attuate con messaggi di
suggestione che inducono a ritenere, in modo emotivo e riflessivo,
che valga la pena di visitare quello che appare uno studio legale aperto e accessibile, senza le formalità tipiche dello studio legale.
(Omissis)
L’avv. A.L. trasmetteva al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 2
articoli di giornali nei quali si riferiva dell’iniziativa degli avvocati C.C. e F.P.,
che avevano aperto uno studio legale in Milano “simile a qualsiasi attività
commerciale” sotto la insegna “A.L.T. ovvero Assistenza legale per tutti”. Il
Consiglio dell’Ordine di Milano trasmetteva gli atti per competenza a quello di
Brescia, poiché l’avv. F.P. era consigliere dell’Ordine di Milano.
Il Consiglio dell’ordine di Brescia iniziava procedimento disciplinare nei
confronti dei due avvocati per avere gli stessi, al fine di acquisire rapporti di
clientela, posto in essere una condotta non conforme a correttezza, e decoro,
consistita nell’avere aperto in Milano, sotto la suggestiva insegna “A.L.T. Assistenza legale per tutti”, un ufficio direttamente affacciato sulla pubblica via,
alla cui porta di ingresso era applicata una scritta a caratteri vistosi, recante
l’indicazione “Prima consulenza gratuita”.
Il Consiglio, esclusa ogni responsabilità per l’uso di ambienti diversi da
quelli tradizionali, riteneva l’illecito disciplinare nell’uso dell’acronimo ALT,
suggestivo come invito a fermarsi, nonché per l’utilizzo dello slogan “assistenza per tutti” e per quello “prima consulenza gratuita”; quindi irrogava la
sanzione della censura.
Il Consiglio nazionale forense, adito dagli avv.ti C.C. e F.P., con decisione
del 10.12.2009, rigettava i ricorsi.
Riteneva il C.N.F. che gli slogans usati avevano solo funzione di pubblicità
suggestiva ed emozionale e non informativa dei possibili clienti, finalizzata a
realizzare un vantaggio competitivo dei due incolpati nell’acquisizione della
clientela e non informativa della professionalità e dei settori di esercizio dello
studio legale, per cui sussisteva la lesione del decoro e della dignità della professione.
∗
Rigetta il ricorso proposto contro Cons. naz. forense, 21-12-2009, n. 183 – Pres. f.f. PERFETTI –
Rel. BIANCHI – P.M. IANNELLI (conf.) – avv. C.C. ed F.P., la cui massima è pubblicata con il n. 36, in
questa Rivista, 1/2010.
664
Rassegna Forense – 3/2010
Parte Seconda – Giurisprudenza
Avverso questa decisione hanno proposto separati ricorsi per Cassazione
gli incolpati.
Resiste con separati controricorsi il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Brescia.
Tutte le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi. Va, quindi, esaminato il ricorso
proposto dall’avv. C.C.
Questi con il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 38 l.
prof., e, quindi, l’incompetenza territoriale del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia (eccezione tempestivamente proposta), assumendo che erroneamente la decisione impugnata abbia ritenuto sussistente tale competenza per effetto della connessione del procedimento a carico del C. con quello a
carico della P., non operando tale figura nel procedimento disciplinare.
A tal fine il ricorrente si riporta ad una decisione del 1996 del C.N.F., in
contrasto con quella del 2001 richiamata nel provvedimento impugnato.
2. Il motivo è fondato.
Osserva preliminarmente questa Corte che nella giurisprudenza del Consiglio nazionale forense vi è contrasto sull’applicabilità della connessione da
cumulo soggettivo (nell’ipotesi che si proceda contro due o più iscritti all’ordine) ai fini della determinazione della competenza territoriale.
Secondo un orientamento più risalente, fatto proprio dal ricorrente, la
competenza territoriale disciplinare è determinata dal luogo dell’iscrizione
dell’incolpato ovvero dal luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di incolpazione. Non sono invece applicabili ai procedimenti disciplinari né il principio
della connessione oggettiva proprio del processo penale (perché non richiamato dalla normativa disciplinare), né le regole sulla competenza per ragioni
di connessione previste nel processo civile, in quanto ogni procedimento disciplinare deve ritenersi autonomo rispetto a quello contro altri incolpati
(Cons. Naz. Forense 6 novembre 1996, n. 151).
Secondo altro orientamento, fatto proprio dalla decisione impugnata, la
competenza territoriale disciplinare è determinata dal luogo dell’iscrizione
dell’incolpato, ovvero dal luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di incolpazione, secondo il principio della prevenzione, e la competenza è attribuita
al C.d.O. che per primo abbia dato inizio al procedimento. Tale competenza
può essere derogata, in caso di connessione di illeciti disciplinari consumati
da più iscritti, sulla base dei principi in tema di cumulo soggettivo fissati dal
codice di procedura civile (Cons. Naz. Forense 13 luglio 2001, n. 159).
3.1. Osserva preliminarmente questa Corte (riportandosi ad un principio
già espresso, per quanto risalente, di queste S.U. – sent. 13/04/1981, n.
2176) che, data anche la natura amministrativa della fase procedimentale
davanti al Consiglio dell’Ordine Locale, nei procedimenti disciplinari a carico di
avvocati e procuratori, si devono seguire, quanto alla procedura, le norme
particolari che sono dettate dalla legge professionale per ogni singolo istituto
ovvero, qualora manchino disposizioni specifiche si deve far ricorso alle norme del codice di procedura civile. Trovano applicazione le norme del codice di
Rassegna Forense – 3/2010
665
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
La pubblicità informativa dell’attività professionale
procedura penale invece, quando la legge professionale ne faccia espresso
rinvio ovvero quando siano da applicare istituti, quali l’amnistia e l’indulto,
che trovano la loro regolamentazione solo in detto codice.
3.2. L’art. 38 del r.d.l. n. 1578/1933 statuisce, per quanto qui interessa,
che: “Salvo quanto è stabilito negli artt. 130, 131 e 132 del codice di procedura penale e salve le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati ed i procuratori che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al
decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare.
La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio
dell’ordine che ha la custodia dell’albo in cui il professionista è iscritto, quanto
al Consiglio nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede:
ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione. Il Consiglio dell’ordine
che ha la custodia dell’albo nel quale il professionista è iscritto è tenuto a dare esecuzione alla deliberazione dell’altro Consiglio”.
L’art. 1 del d.lgtcps. n. 597/1947 statuisce che “La competenza a procedere disciplinarmente in confronto dell’avvocato o del procuratore che è componente del Consiglio dell’ordine, appartiene al Consiglio costituito nella sede
della Corte d’appello. Se egli appartiene a quest’ultimo, è giudicato dal Consiglio costituito nella sede della Corte d’appello più vicina”.
3.3. Ne consegue che la materia della competenza territoriale è delineata
completamente da disposizioni specifiche interne al procedimento disciplinare
nei confronti degli avvocati.
Pertanto non è possibile procedere all’applicazione a questo procedimento
di norme relative al processo civile, in tema di modifica della competenza per
ragioni di connessione, ed a maggior ragione di norme del procedimento penale, in assenza di un qualunque rinvio operato dalle norme specifiche che
trattano della competenza nel procedimento disciplinare contro un avvocato.
3.4. In ogni caso, a parte il suddetto principio dell’inapplicabilità nel procedimento disciplinare delle deroghe alla competenza territoriale per ragioni
di connessione, va rilevato che nella fattispecie l’unica ipotesi di connessione,
che potrebbe essere operante tra quelle previste dagli artt. 31 e segg. c.p.c.
è quella di cui all’art. 33 attinente al cumulo soggettivo. Sennonché anche
per la struttura interna alla stessa norma di cui all’art. 33 c.p.c. sulla competenza in caso di cumulo soggettivo, non si sarebbe mai potuta affermare la
competenza del Consiglio dell’ordine di Brescia anche in relazione al procedimento instaurato contro l’avv. C.C., essendo tale competenza affermata nei
confronti dell’avv. P., in quanto consigliere dell’Ordine degli avvocati di Milano, e quindi a norma dell’art. 1 del d.lgtcps. n. 597/1947.
Infatti la modificazione della competenza per territorio, nel caso di cumulo
soggettivo di cause connesse per l’oggetto o per il titolo, incide, per espressa
previsione normativa (art. 33 c.p.c.), non suscettiva di interpretazione estensiva, soltanto sul foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche (rispettivamente, art. 18 c.p.c. e art. 19 c.p.c.), nel senso che consente
l’attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a
favore di altri fori, come i fori facoltativi operanti nei riguardi di una delle parti convenute (Cass. 11 gennaio 2001, n. 313; Cass. 1 marzo 2007, n. 4862),
666
Rassegna Forense – 3/2010
Parte Seconda – Giurisprudenza
ovvero, a maggior ragione, a favore di fori speciali operanti nei riguardi di
una delle parti convenute, per ragioni soggettive (Cass. 13 luglio 2004, n.
12974; Cass. 17 giugno 2004, n. 11387).
3.5. Nella fattispecie la competenza territoriale disciplinare del Consiglio di
Brescia era individuata nei confronti di uno degli incolpati (avv. P.), quale foro speciale dello stesso, perché consigliere presso l’ordine di Milano, con la
conseguenza che, già a norma dell’art. 33 c.p.c. non si sarebbe potuta avere
alcuna vis actractiva di questo foro speciale nei confronti di quelli propri
dell’avv. C. (dei quali peraltro solo quello relativo all’albo di iscrizione potrebbe ritenersi come foro generale, sia pure con interpretazione estensiva, tendenzialmente da evitare in sede di determinazione di competenza).
3.6. Ovviamente, per le ragioni già esposte, neppure possono applicarsi i
principi di cui agli artt. 12, lett. a) e 16 c.p.p. in tema di competenza per
connessione in materia penale “allorché il reato per cui si procede è stato
commesso da più persone in concorso”.
A parte il rilievo che, come già detto, la norma procedurale penale è invocabile in siffatto procedimento disciplinare solo quando espressamente prevista e che nella fattispecie non lo è, va in ogni caso osservato che in siffatta
ipotesi di connessione l’art. 16 c.p.p., coordinato con l’art. 8 c.p.p., statuisce
che la competenza territoriale si appartiene al giudice del luogo ove si è verificato l’evento.
Sennonché tanto coincide anche con uno dei due fori alternativi previsti
dall’art. 38 del r.d.l. n. 1578/1933, per cui competente al procedimento disciplinare è, oltre al Consiglio dell’ordine di iscrizione del professionista, quello
nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto.
Al di fuori di tale ipotesi di determinazione della competenza per unicità
del fatto, non sono ravvisabili altre competenze territoriali da connessione,
fondate sulla vis actractiva di un foro speciale di un incolpato.
Peraltro, l’eventuale accertamento in modo difforme del fatto storico non
dà luogo ad un contrasto pratico di giudicati, ma soltanto ad un contrasto logico. (cfr. Cass. civ. n. 13514/2007).
3.7. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento
degli altri motivi di censura mossi dall’avv. C.
4. Con l’unico motivo di ricorso l’avv. F.P. lamenta la nullità della decisione
per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.l. n. 223/2006, conv. con l. n.
248/2006 (c.d. legge Bersani). Nullità della decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 38, c. 1, d.d.l. n. 1578/1933, con riferimento al codice deontologico forense conseguente controllo di ragionevolezza in sede di legittimità
della concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso
decisivo per il giudizio (concreta antigiuridicità della condotta ascritta).
Assume la ricorrente che con l’art. 2 della l. n. 248/2006 sono state abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disponevano divieti, anche
parziali, di pubblicità informativa relativa ad attività libero-professionale; che
l’art. 17, modificato a seguito di questa norme, del codice deontologico forense prevede che l’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale, che l’art. 17 bis cod. deontologico statuisce le modalità dell’informa-
Rassegna Forense – 3/2010
667
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
La pubblicità informativa dell’attività professionale
zione; che l’art. 19 vieta l’acquisizione di clientela con modi non conformi a
correttezza ed al decoro.
Lamenta la ricorrente che la censura sia stata irrogata su tre circostanze:
a) l’utilizzo dell’acronimo ALT; b) l’utilizzo dello slogan “Assistenza Legale per
tutti”; c) l’utilizzo dello slogan “prima consulenza gratuita”.
Ritiene la ricorrente che nel valutare tali comportamenti la decisione impugnata è caduta in evidente errore interpretativo e sistematico, in quanto
l’acronimo non compariva mai da solo, essendo accompagnato dalla scritta
“Assistenza legale per tutti”, per cui non rappresentava uno slogan suggestivo
contrario alla dignità ed al decoro professionale. Secondo la ricorrente né il
nome dello studio (A.L.T.) né l’indicazione “prima consulenza gratuita” possono
essere considerati mezzi illeciti per un’attività accaparratoria di clientela.
5.1. Il motivo è infondato.
L’esame di tale motivo rende necessaria l’esposizione di alcuni principi regolatori della responsabilità disciplinare degli esercenti la professione forense
e del controllo delle Sezioni Unite sulla motivazione delle decisioni rese dal
Consiglio nazionale forense in tale materia.
Vi è da premettere che, come affermato dalla costante giurisprudenza della Sezioni Unite (ex multis 16/11/2004, n. 21633) l’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, il quale prevede che siano sottoposti a procedimento
disciplinare gli avvocati “che si rendano colpevoli di abusi o di mancanze
nell’esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale”, non contiene una specifica tipizzazione di ipotesi d’illecito.
La ragione di tale scelta di formulazione normativa, al pari di quanto avviene per altre categorie, viene generalmente ravvisata nel fine di evitare che
violazioni dei doveri anche gravi possano sfuggire alla sanzione disciplinare.
Pertanto, per un’esatta ricostruzione del controllo di legittimità sull’interpretazione ed applicazione di tale norma, occorre prendere le mosse dalla premessa che la stessa descrive fattispecie d’illecito disciplinare, non mediante
un catalogo di ipotesi tipiche, ma mediante clausole generali o concetti giuridici indeterminati.
Ciò comporta anzitutto che tale norma non si presta ad una definitiva ed
esaustiva individuazione di ipotesi tipiche sul piano astratto, sia pure da parte
dell’organo deputato alla sussunzione del fatto nella norma generale. Il che,
sotto il profilo attuativo, significa che il perimetro di tale norma generale,
preposta alla tutela del decoro e della dignità professionale, non è esaurito
dalle fattispecie tipiche lesive che possano rinvenirsi nel codice deontologico
professionale.
5.2. L’applicazione di norme di tale specie può dar luogo a valutazioni che
– pur rimanendo distinte dal campo della discrezionalità, intesa come ponderazione comparativa d’interessi – finiscono con l’attribuire all’organo decidente un margine di apprezzamento non controllabile in cassazione.
Il sindacato del giudice di legittimità sull’applicazione di un concetto giuridico indeterminato deve essere, quindi, rispettoso dei limiti che il legislatore
gli ha posto, utilizzando una simile tecnica di formulazione normativa, che attribuisce al giudice del merito uno spazio di libera valutazione ed apprezza-
668
Rassegna Forense – 3/2010
Parte Seconda – Giurisprudenza
mento. Il controllo della Corte di Cassazione sulla corretta interpretazione ed
applicazione del citato art. 38 non può prescindere dal fatto che detta norma
contiene, per la definizione delle condotte sanzionabili, concetti giuridici indeterminati.
5.3. Non fornendo la norma, per sua intrinseca natura, elementi tassativi
per la definizione delle condotte disciplinarmente illecite, il sindacato di legittimità deve tener conto del fatto che la categoria normativa impiegata finisce
con l’attribuire agli organi disciplinari forensi un compito di individuazione
delle condotte sanzionabili, nel quale non può ammettersi una sostituzione da
parte dal giudice di legittimità, consistente nella riformulazione o ridefinizione
di tali condotte.
Il dibattito sul controllo di legittimità dell’applicazione di concetti giuridici
indeterminati effettuata dal giudice di merito non è certo recente, né esclusivo della tradizione giuridica italiana, ma risale ad oltre un secolo e mezzo fa.
Limitando l’esame all’esperienza applicativa della Corte, è certo che, almeno nella sua teorica enunciazione, quando il giudice del merito è chiamato
ad applicare concetti giuridici indeterminati, il compito del controllo di legittimità può essere soltanto quello di verificare la ragionevolezza della sussunzione del fatto.
La Corte non può, pertanto, sostituirsi al giudice di merito nell’attività di
riempimento dei concetti indeterminati contenuti nel citato art. 38.
Tale è la linea che si ricava dalla costante giurisprudenza della Corte e, in
particolare, dalle pronunce delle Sezioni Unite in tema di sindacato di legittimità sulle decisioni del Consiglio nazionale forense.
Pertanto, anche nell’individuazione di condotte costituenti illecito disciplinare degli esercenti la professione forense, essendo le stesse definite dalla
legge mediante una clausola generale, il controllo di legittimità sull’applicazione di tale norma non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi agli
organi forensi nell’enunciazione di ipotesi d’illecito, se non nei limiti di una
valutazione di ragionevolezza (Cass. S.U. 27.1.2004, n. 1414).
5.4. Ciò che va posto in risalto è che in questa attività di individuazione
dell’ipotesi concreta di illecito disciplinare, quale modo di porsi della norma
generale per il caso concreto, l’organo professionale (prima ancora di effettuare una valutazione dei fatti storici) concretizza la norma al caso specifico,
individuando un precetto per esso.
Il precetto della norma generale di cui all’art. 38 del d.d.l. n. 1578/1933, è:
“non commettere fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionale”.
Da tale precetto generale, il Consiglio dell’ordine è giunto alla tipizzazione
di un precetto per il caso specifico, sia pure – come ogni precetto – ancora in
astratto: “non effettuare alcuna forma di pubblicità con slogans evocativi e
suggestivi, privi di contenuto informativo professionale, e quindi lesivi del decoro ed alla dignità professionale”.
Ne consegue che in questa fase la ragionevolezza cui deve attenersi l’organo professionale disciplinare non è quella relativa alla motivazione sulla ricostruzione dei fatti (che è un momento successivo ed attiene all’accertamento degli avvenimenti fattuali), ma quella relativa alla “concretizzazione”
Rassegna Forense – 3/2010
669
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
La pubblicità informativa dell’attività professionale
della norma generale nella fattispecie in esame, come ipotesi di illecito disciplinare ascritto all’incolpato.
Per l’effetto l’attività di sindacato della Corte di legittimità sulla ragionevolezza in questo tipo di attività dell’organo disciplinare, quale risulta dal provvedimento impugnato, non attiene ad un giudizio di congruità logica della
motivazione adottata, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Non si versa in ipotesi
di dubbio sulla ragionevolezza della motivazione sulla ricostruzione fattuale.
Qui la ragionevolezza attiene all’individuazione del precetto formulato per
l’ipotesi specifica considerata, come concretizzazione del più ampio precetto
della norma generale (nella fattispecie l’art. 38 l.f.).
Il sindacato sulla ragionevolezza è quindi non relativo alla motivazione del
fatto storico, ma alla sussunzione dell’ipotesi specifica (sia pure in questa fase ancora in astratto) nella norma generale, quale sua concretizzazione.
Il sindacato da parte della Corte di legittimità sulla ragionevolezza di tale
concretizzazione della norma generale è quindi un sindacato su vizio di violazione di norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c., ben lontano da quello di cui
all’art. 360 n. 5 c.p.c.
6.1. Il secondo aspetto concerne i limiti del sindacato sulla motivazione
propri dello speciale giudizio di legittimità previsto in materia disciplinare per
gli esercenti la professione forense.
Si deve premettere che le decisioni del Consiglio nazionale forense sono
impugnabili soltanto per i motivi previsti dagli articoli 56, terzo comma, del
r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e 68, primo comma, del r.d. 22 gennaio
1934, n. 37 (incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge).
Fino all’entrata in vigore dell’art. 2 del d.lgs. n. 40/2006, secondo quanto
previsto dall’art. 27 dello stesso d.l., doveva, quindi, escludersi un sindacato
della Corte di Cassazione secondo il canone di cui all’art. 360, comma primo,
n. 5, c.p.c., e cioè esteso alla sufficienza della motivazione, limitandosi il controllo di legittimità ai casi in cui il vizio si traduca in violazione di legge (art.
111 Cost.).
6.2. Per effetto della sostituzione dell’art. 360 c.p.c., disposta dall’art. 2
del d.lgs. n. 40/2006, a norma dell’ultimo comma dell’art. 360 c.p.c. la decisione del C.N.F., essendo impugnabile per violazione di legge, lo può essere
anche per vizio di motivazione a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
Va solo ribadito, in generale e secondo il costante orientamento, che il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del
proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire
l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non
possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove
dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte.
7. Nella fattispecie non sussistono le lamentate violazioni di legge.
670
Rassegna Forense – 3/2010
Parte Seconda – Giurisprudenza
9. Pertanto va accolto il primo motivo di ricorso proposto dall’avv. C.C.,
assorbiti i restanti. Va cassata l’impugnata sentenza e dichiarata la competenza territoriale del Consiglio dell’Ordine di Milano.
Va, invece, rigettato il ricorso dell’avv. F.P.
Vanno compensate tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione,
per l’esistenza di giusti motivi. Essi sono costituiti, quanto al ricorso del C.,
per il contrasto esistente tra le decisioni del C.N.F., in tema di deroga della
competenza per connessione, e, quanto al ricorso della P., per la mancanza di
precedenti arresti giurisprudenziali in tema di pubblicità da parte di studi legali che potessero costituire un precedente orientativo, in presenza della novità normativa sia a livello legislativo che di codice deontologico.
(Omissis)
Rassegna Forense – 3/2010
671
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sui limiti di tariffa forense
221. Sulla conformità al diritto della concorrenza dei minimi di
tariffa forense.
Cass., sez. lavoro, sentenza 27 settembre 2010, n. 20269 – Pres. Vidiri – Rel. Stile – Conpass Cfn Spa e altro; M.L.O.
Sono conformi al principio comunitario della libera concorrenza le
norme che prevedono l’inderogabilità dei minimi di tariffa forense,
giacché può consentirsi a una limitazione della libera prestazione dei
servizi professionali in presenza di ragioni imperative di interesse
pubblico quali la garanzia della qualità della prestazione professionale
a tutela degli utenti consumatori e la buona amministrazione della
giustizia. Nel contesto italiano, caratterizzato da una elevata presenza
di avvocati, le tariffe che fissano onorari minimi consentono di evitare
una concorrenza che si traduce nell’offerta di prestazioni “al ribasso”,
tali da poter determinare un peggioramento della qualità del servizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 16 settembre 1994, l’avv.to M.L.O., in proprio e quale titolare dell’Associazione Professionale “Studio legale Associato
degli Avv. Murolo Lancia & Verde”, esponeva al Giudice del lavoro di Napoli di
avere stipulato una convenzione con la Spa Compass e, poi, anche con la soc.
Cofactor per l’espletamento di attività stragiudiziale e giudiziale concernente
il recupero dei crediti contenziosi vantati dalle società nei confronti di propri
clienti inadempienti.
Aggiungeva che, in seguito all’interruzione del rapporto, unitamente all’Associazione professionale, faceva presente di avere ricevuto, in base alla
convenzione, compensi inferiori ai minimi tariffati, inderogabili. Soggiungeva
che, mentre erano in corso trattative per una bonaria definizione della vertenza insorta, le due società notificavano un atto di citazione a comparire innanzi al Tribunale di Milano per sentire accertare che nulla era dovuto all’Avv.
M.L. ed allo Studio Associato Murolo Landi; – che esso convenuto si costituiva
ritualmente e, nella comparsa depositata, eccepiva l’incompetenza per materia e per territorio del giudice adito, chiedeva il rigetto delle domande e spiegava, infine, domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento delle competenze dovute; che, con sentenza n. 32/94 del 16.12.93, pubblicata il
10.1.94, il Tribunale di Milano dichiarava la propria incompetenza per essere
competente il Pretore di Napoli in funzione di giudice del lavoro; che successivamente, con racc.te del 21.7.93, comunicava alle due società che, in seguito a più attento esame delle parcelle emesse per quelle pratiche ove era
stata svolta attività processuale avente ad oggetto la proposizione di pignoramenti presso terzi, gli erano dovuti ulteriori compensi, rispetto a quanto già
richiesto, per la somma di L. 27.366.600 da parte della Spa Cofactor e di L.
15.920.100 da parte della Spa Conpass. Tanto esposto, l’avv.to M.L.O., in
proprio e nella qualità, chiedeva emettersi i seguenti provvedimenti:
672
Rassegna Forense – 3/2010
Parte Seconda – Giurisprudenza
1) dichiarare la nullità l. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 24, modificata
dalla l. 19 dicembre 1949, n. 957, recepito dall’art. 4, delle vigenti tariffe forensi, delle convenzioni intercorse tra le parti per la determinazione dei compensi forfettari relativi agli incarichi professionali espletati;
2) determinare in L. 263.284.450 (meno L. 5.001.000 per la pratica P.) gli
importi dovuti dalla Spa Compass ed in L. 228.974.908 quelli dovuti dalla Spa
Cofactor e relativi ai compensi professionali per l’attività svolta in relazione
alle causali dedotte in ricorso;
3) condannare conseguentemente la Spa Compass e la Spa Cofactor al
pagamento in favore dei ricorrenti della somme segnatamente determinate in
L. 263.284.450 e in L. 28.974.908 ovvero di quelle che sarebbero risultate
dovute;
4) condannare le convenute società al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla data di espletamento dei singoli incarichi;
5) in subordine, condannare le convenute al risarcimento dei danni pari all’ammontare degli interessi passivi corrisposti alle banche di cui al capo 47
che precede in L. 33.287.506;
6) rigettare le domande avanzate da Compass e Cofactor innanzi all’A.G.O. Tribunale di Milano con il loro atto introduttivo del 10/3/92.
Le società convenute resistevano alle avverse domande, in rito e nel merito, insistendo nell’accoglimento delle domande in precedenza proposte. Con
sentenza del 25.5.99, il Giudice adito accoglieva parzialmente la domanda e
condannava la Cofactor s.p.a. al pagamento, nei confronti dei ricorrenti, della
somma di L. 40.206.723 (L. 23.611.186 + 5.913.085 + 10.682.452), oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza, quanto agli importi
di L. 23.611.186 e L. 10.682.452, dal 3 dicembre 1991 sino al soddisfo, nonché, quanto all’importo L. 5.913.085, con decorrenza dall’8 maggio 1992 sino
al soddisfo; condannava Società Compass spa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, nei confronti dei ricorrenti, della somma di L.
9.016.514, oltre rivalutazione monetaria interessi legali dall’8 maggio 1992
sino al soddisfo; dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale.
Con ricorso depositato il 20.7.00, l’avv.to M.L.O., sempre in proprio snella
sopra indicata qualità, proponeva appello avverso detta decisione, censurandola sotto vari profili, cui resistevano entrambe le società, proponendo appello incidentale, relativamente a somme pretese dalla controparte Rinnovata
l’indagine peritale, con sentenza del 13 giugno – 15 settembre 2006, l’adita
Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello principale,
condannava la società Compass al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di Euro 60.160, 5575 (pari a L. 116.487,.082) e la spa Cofactor al
pagamento, in favore degli stessi, della somma di Euro 33.226,5402 (pari a
L. 64.335.553) oltre svalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi
legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione dei crediti al saldo; rigettava l’appello incidentale.
A sostegno della decisione, osservava che l’accordo – convenzione, intervenuto tra le parti in causa alla fine del 1988, doveva ritenersi nullo perché in
violazione del divieto sancito dalla l. n. 794 del 1942, art. 24, essendo l’ammontare del compensi consensualmente predeterminato, inferiore ai minimi ta-
Rassegna Forense – 3/2010
673
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sui limiti di tariffa forense
riffari; che non era applicabile la riduzione al di sotto dei minimi – consentita
dall’art. 4 della stessa legge “quando la causa risulti di facile trattazione”, solo
nei confronti della parte soccombente e non anche nei confronti del cliente –,
mancando il parere del Consiglio dell’Ordine in tal senso; che inammissibile era
la richiesta di ulteriori somme scaturenti dalla rielaborazione delle parcelle, già
ritenuta inammissibile dal primo Giudice in quanto domanda nuova; che inammissibile era la domanda riconvenzionale azionata in primo grado dalle società
appellate per mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto, come ritenuto in primo grado; che la rinuncia al principio di inderogabilità delle tariffe –
dedotta dalle società – non aveva fondamento mancando la necessaria consapevolezza del rinunciante; che da respingersi erano l’eccezione di prescrizione
presuntiva e la richiesta degli interessi bancari.
Le società propongono ricorso per cassazione con otto motivi; ricorso che
poi viene riprodotto con l’aggiunta dei quesiti.
Resiste al primo ricorso l’avv. O.L. in proprio ed anche come titolare
dell’Associazione Professionale “Studio legale Associato degli avv.ti Murolo
Landi & Verde” con controricorso.
Le società hanno anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Sono state depositate note di udienza.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi proposti dalle Società Compass e Cofactor, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima
sentenza (art. 335 c.p.c.).
Va poi, ancora, preliminarmente rilevato che deve essere dichiarato inammissibile il primo ricorso in quanto privo dei quesiti, così come richiesti
dall’art. 366 bis c.p.c., mentre – contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente – va ritenuta l’ammissibilità del secondo ricorso, in quanto munito del suddetto requisito. A norma dell’art. 366 c.p.c., infatti, il ricorso per
cassazione deve essere proposto, a pena d’inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di forma e di contenuto indicati in detta disposizione, con la
conseguenza che è inammissibile un nuovo atto successivamente notificato a
modifica o ad integrazione del primo, sia se concerna l’indicazione dei motivi,
ostandovi il principio della consumazione dell’impugnazione, sia se tendente a
colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti, essendo possibile, invece, la proposizione di un nuovo ricorso, ove -come nella specie – non siano
decorsi i termini dell’impugnazione, ed esso sia predisposto in sostituzione –
non ad integrazione, né a correzione – di un ricorso viziato ma non ancora dichiarato inammissibile (ex plurimis, Cass. n. 2704/2005; Cass. n.
13817/2002; Cass. n. 10701/1993).
Tanto chiarito, va subito osservato che, con il primo motivo, le società ricorrenti affrontano il tema centrale della controversia, denunciando violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 15 preleggi, della l. 13 giugno 1942, n. 794,
art. 24, della l. n. 1051 del 1957, art. unico, e dell’art. 2233 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
674
Rassegna Forense – 3/2010
Parte Seconda – Giurisprudenza
In particolare, sostengono che erroneamente il Giudice di appello avrebbe
ritenuto la sopravvivenza della l. n. 794 del 1942, art. 24, poiché l’abrogazione ad opera della disciplina dettata dalla l. n. 1051 del 1957, art. unico, ex
art. 15 preleggi, avrebbe riguardato soltanto gli artt. da 1 a 23.
Viceversa, detto art. unico avrebbe delegificato il procedimento di approvazione delle tariffe, rendendo i regolamenti tariffali inidonei a derogare efficacemente all’art. 2233 c.c., fonte principale per la determinazione del compenso spettante ai liberi professionisti. Ma, anche a voler ritenere, sotto l’indicato profilo, ancora vigente l’art. 24 citato, il confronto dell’assetto normativo nazionale con il quadro Europeo avrebbe dovuto condurre alla conclusione di incompatibilità del divieto con il Trattato, dato che la liceità di una tariffa non comporterebbe di per sé la liceità della ben diversa disposizione che
fissi la inderogabilità della sua misura minima.
Il motivo è infondato.
Va anzitutto chiarito che, con riferimento alla professione di avvocato,
questa Corte, con orientamento pressoché costante, ha ritenuto, ora esplicitamente, ora per implicito, che la l. n. 794 del 1942, se pur deve ritenersi abrogata nei suoi artt. da 1 a 23, ai sensi dell’art. 15 disp. gen., – essendo
stata la materia interamente regolamentata per effetto della l. 3 agosto
1957, n. 1051, che ha attribuito al Consiglio nazionale forense la competenza
di stabilire, con le modalità ivi previste, i criteri per la determinazione degli
onorari, dei diritti e delle indennità spettanti per le prestazioni giudiziali in
materia civile – ha lasciato in vita l’art. 24 (v. Cass. n. 12840/2003; Cass. n.
7094/2006; Cass. 28718/2008).
Tale articolo, dopo la significativa dicitura, “Inderogabilità convenzionali
degli onorari e dei diritti”, statuisce che “Gli onorari e i diritti stabiliti per le
prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli
avvocati sono inderogabili”.
Sulla base di tale disposizione la giurisprudenza di legittimità ha sancito la
nullità dell’accordo con il quale l’avvocato ed il cliente pattuiscono l’onorario
spettante al professionista in deroga ai minimi della tariffa forense (v. Cass.
n. 3432/2003). In tal modo si è inteso superare la gerarchia di carattere preferenziale, fissata dall’art. 2233 c.c., tra i vari criteri previsti per la determinazione del compenso dovuto per le attività intellettuali, laddove si stabilisce
che “il compenso, che non è convenuto tra le parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice”.
La vigenza nel nostro ordinamento di una normativa che vieti di derogare
convenzionalmente agli onorari minimi determinati da una tariffa forense,
trova, del resto, riscontro nelle pronunce della Corte di giustizia, che, in tema
di tariffe professionali degli avvocati, ha affermato, con la sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, che “gli artt. 5 e 85 del trattato CEE (divenuti art.
10 Ce e 81 Ce) non ostano all’adozione, da parte di uno Stato membro, di
una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto
stabilito da un ordine professionale, una tariffa che fissa dei minimi e dei
massimi per gli onorari dei membri dell’ordine, qualora tale misura statale sia
dettata nell’ambito di un procedimento come quello previsto dal r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato.
Rassegna Forense – 3/2010
675
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sui limiti di tariffa forense
La conformità al principio comunitario della libera concorrenza di quelle
norme del diritto interno in virtù delle quali è imposta la inderogabilità dei
minimi di tariffa forense, costituisce orientamento confermato dalla più recente sentenza della Corte di giustizia del 5 dicembre 2006, cause riunite C94/04 e C-202/04, ove, tra l’altro, si sottolinea che una limitazione al principio di libera prestazione dei servizi professionali può essere consentita allorché “ragioni imperative di interesse pubblico” la giustifichino; ragioni che con
riferimento alla inderogabilità dei minimi della tariffa degli avvocati vengono
individuate nell’esigenza di garantire la qualità della prestazione professionale
a tutela degli utenti consumatori e la buona amministrazione della giustizia.
Sussistendo questi obiettivi, l’obbligatorietà dei minimi può essere giustificata, dunque, allorché sussista il rischio che, per le caratteristiche del mercato,
la concorrenza al ribasso sull’offerta economica tra gli operatori possa prgiudicare la qualità della prestazione. A proposito dei servizi legali, la Corte individua come fattore di rischio il “numero estremamente elevato” di professionisti iscritti ed in attività e riconosce al giudice nazionale il compito di determinare se la restrizione della libera prestazione creata dal divieto di derogare
convenzionalmente ai minimi tariffari per i servizi legali, previsto dalla legislazione italiana, risponde a ragioni imperative di interesse pubblico ed è
strettamente idoneo a garantire da un lato che vi sia corrispondenza tra il livello degli onorari e la qualità delle prestazioni fornite dagli avvocati, dall’altro che la determinazione di tali onorari minimi costituisca un provvedimento
adeguato alla tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia.
Pur non essendo una garanzia della qualità dei servizi, non si può di certo
escludere – ed anzi deve affermarsi – che nel contesto italiano, caratterizzato
da una elevata presenza di avvocati, le tariffe che fissano onorari minimi consentano di evitare una concorrenza che si traduce nell’offerta di prestazioni
“al ribasso”, tali da poter determinare un peggioramento della qualità del
servizio. È appena il caso di osservare che il D.L. n. 223 del 2006, art. 2,
comma 1, convertito in l. n. 248 del 2006, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano la fissazione di tariffe obbligatorie fisse
o minime per le attività professionali e intellettuali “dalla data di entrata in
vigore” della legge stessa; ne consegue che quelle disposizioni conservano
piena efficacia in relazione a fatti – come quelli in oggetto – verificatisi prima.
(Cass. n. 9878/2008). Con il secondo motivo le ricorrenti, denunciando vizio
di motivazione e violazione dell’art. 1362 c.c. e ss., e art. 1418 c.c., lamentano che – anche a voler sostenere la esistenza di minimi inderogabili tariffari
– il Giudice di appello abbia ritenuta la invalidità della rinuncia ai minimi tariffari, operata dalla parte controricorrente, a fronte di una continuità di incarichi da parte delle società.
Il motivo è privo di fondamento, avendo il Giudice a quo correttamente
argomentato sul punto.
Giova rammentare che – secondo l’orientamento di questa Corte – il principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari, stabilito dalla l. 13 giugno 1942,
n. 794, art. 24, sugli onorari di avvocato e procuratore, non trova applicazione nel caso di rinuncia, totale o parziale, alle competenze professionali, allor-
676
Rassegna Forense – 3/2010
Parte Seconda – Giurisprudenza
ché quest’ultima non risulti posta in essere strumentalmente per violare la
norma imperativa sui minimi di tariffa. La prestazione d’opera del difensore
può, infatti, pure essere gratuita – in tutto o in parte – per ragioni varie, oltre
che di amicizia e parentela, anche di semplice convenienza. Sotto questo riflesso la retribuzione costituisce un diritto patrimoniale disponibile e la convenienza relativa può concretarsi, sul piano sostanziale, anche in un accordo
transattivo, in quanto tale, pienamente lecito, rientrando esso nella libera autonomia dispositiva delle parti contraenti, alle quali è soltanto inibito di infrangere il divieto legale sancito dal citato art. 24, e cioè quello di predeterminare consensualmente l’ammontare dei compensi professionali in misura
inferiore ai minimi tariffari (Cass. n. 7144/1998).
Orbene, la Corte partenopea, nel rigettare l’assunto delle società, dopo
avere richiamato la contraria giurisprudenza, ha tenuto ad aggiungere che, in
ogni caso, perché potesse ritenersi intervenuta una rinuncia occorreva, pur
sempre, che vi fosse piena consapevolezza da parte del rinunciante dello specifico oggetto della rinuncia medesima, “condizione questa che, nel caso di
specie, non può certamente essere ravvisabile nelle lettere dell’avv.to M.L.
con le quali lo stesso si limitava a dare atto della definizione della pratica in
base al forfait illegittimamente concordato”.
Trattasi, dunque, di una valutazione di merito, incensurabile in questa sede, che si innesta su di un corretto principio di diritto, collegato alla natura
“parasubordinata” del dedotto rapporto di lavoro, oggetto di più specifica
considerazione con l’esame del sesto motivo.
Con il terzo motivo le ricorrenti, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 47, 48, 50, 416 e 426 c.p.c., nonché omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), contestano quanto
asserito dalla Corte di appello, e cioè che, in seguito a riassunzione ex art. 50
c.p.c., con il disposto mutamento di rito si sarebbe dovuto precisare quanto
non già dedotto nell’atto di citazione. Osserva il Collegio che sulla questione
correttamente il Giudice di appello ha osservato che, pur essendo esatto
quanto sostenuto dalle società appellate, che ex art. 50 c.p.c., con la riassunzione si continua lo stesso giudizio riassunto, tuttavia stante il cambiamento
di rito (da quello ordinario a quello del lavoro, come nel caso de quo) era necessario che le società regolarizzassero, in virtù del principio della immediatezza, oralità e concentrazione che caratterizza il processo del lavoro, nella
memoria difensiva di costituzione – primo atto difensivo successivo al cambiamento del rito – e deducessero tutto quanto non già dedotto nell’atto di citazione di cui al giudizio presso il Tribunale di Milano. Lo stesso Giudice ha
rimarcato che, in tale atto, infatti le appellate avevano parlato di gravi fatti
addebitati al legale, senza tuttavia in concreto precisare in cosa sarebbero
consistiti, ed avevano chiesto la restituzione di somme incassate e non dovute con il solo riferimento ad un elenco n. 2 ed ai documenti allegati. Pertanto,
non risultando nulla di specifico sulle azionate richieste dalla citazione di cui
al pregresso giudizio in Milano, le società avrebbero dovuto, in relazione al
cambiamento del rito, regolarizzare ogni deduzione irritualmente e tardivamente proposta inserendola nella memoria di costituzione; adempimento,
questo,non avvenuto “neppure venendo articolati mezzi istruttori che d’al-
Rassegna Forense – 3/2010
677
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sui limiti di tariffa forense
tronde mancavano anche nell’atto di citazione”. Solo con la memoria del 155-96, successiva alla sentenza della Cassazione pronunciatasi sulla competenza– e quindi tardivamente erano stati articoli specifici capitoli di prova ma
quando ormai si erano già verificate le preclusioni di cui all’art. 416 c.p.c..
Conseguentemente, – prosegue il Giudice a quo – “ogni richiesta istruttoria
formulata tardivamente nel presente grado di giudizio non può trovare accoglimento alcuno e deve concordarsi perciò con la inammissibilità della relativa
richiesta già dichiarata dal primo giudice”. Non ravvisandosi nell’iter argomentativo della Corte di merito i lamentati vizi motivazionali e le dedotte violazioni di legge, la censura va disattesa. Va disatteso anche il quarto motivo,
con cui si denuncia violazione e/o falsa applicazione della l. 13 giugno 1942,
n. 794, art. 4, e r.d. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 60, nonché omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censurandosi la impugnata pronuncia, laddove ha escluso la riducibilità degli onorari quando la causa risulti di facile trattazione.
Sul punto, correttamente la Corte di merito ha osservato che, ai sensi del
d.m. 5 ottobre 1994, art. 4, ai fini della diminuzione dei minimi di tariffa indicati nelle tabelle, nella ricorrenza della ipotesi specificamente prevista dalla
norma – qualora fra la prestazione dell’avvocato e l’onorario previsto dalle
tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione – occorre che la parte interessata (e quindi anche il cliente, regolando tale
norma proprio il rapporto ira cliente ed avvocato, con esclusione, perciò, di
ogni paventato sospetto di illegittimità costituzionale della previsione normativa) esibisca il parere del competente Consiglio dell’Ordine.
Nel caso de quo – prosegue la Corte territoriale – non risultava provato
che, in osservanza della citata disposizione, per ogni pratica, ritenuta riferibile alla previsione medesima, fosse stata fatta richiesta da parte delle società
– clienti interessate – del parere al competente Consiglio dell’Ordine. A ciò
era da aggiungere che il principio dell’inderogabilità delle relative tariffe minime non era suscettibile di soffrire eccezioni in considerazione della natura
semplice o ripetitiva di alcuni affari, poiché la cosiddetta standardizzazione
delle pratiche, così come il carattere “routinario” delle medesime, avrebbero
potuto, se mai, incidere sulla determinazione dei compensi tra il minimo e
massimo delle tariffe.
Così argomentando, il Giudice a quo si è adeguato all’orientamento di
questa Corte, secondo cui, in materia di onorari e diritti di avvocato e procuratore, la disposizione della l. n. 794 del 1942, art. 24, – che sancisce il principio dell’inderogabilità delle relative tariffe minime, con testuale riferimento
alle “prestazioni giudiziali” – va interpretata nel senso dell’estensione di detto
principio anche alle “prestazioni stragiudiziali”, alla stregua sia della “ratio legis” (collegata ad esigenze di tutela del decoro della professione forense che
si prospettano con identico rilievo nei riguardi di entrambi i tipi di prestazione), sia del criterio di adeguamento al precetto costituzionale di uguaglianza,
sia, infine, di ragioni sistematiche volte a tutelare il lavoro e il lavoratore anche nelle prestazioni d’opera intellettuale, con analoghe prescrizioni di inderogabilità. Né la suddetta inderogabilità – cui, quando ne ricorrano i presupposti, si collega automaticamente il doveroso riconoscimento del rimborso
678
Rassegna Forense – 3/2010
Parte Seconda – Giurisprudenza
forfettario delle spese generali di studio, introdotto dall’art. 15 della tariffa
professionale approvata con d.m. 22 giugno 1982 – può soffrire eccezioni in
considerazione della natura semplice o ripetitiva di alcuni affari, poiché la cosiddetta standardizzazione delle pratiche, così come il carattere “routinario”
delle medesime possono, se mai, incidere sulla determinazione dei compensi
tra il minimo e il massimo delle tariffe, ma non anche giustificarne la totale
disapplicazione (Cass. n. 1912/1999). Con il quinto motivo le ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2956 c.c. in rapporto all’art.
4, comma 2, e art. 5, comma 3, della tariffa forense, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamentano
una erronea valutazione della sollevata eccezione di prescrizione presuntiva
sull’altrettanto erroneo presupposto che, essendo contestata la “debenza”, si
ammetteva implicitamente il mancato pagamento, dovendosi, invece, distinguere le ipotesi, in cui le contestazioni del debito contraddicono in punto di
fatto l’avvenuto suo soddisfacimento, dalle contestazioni in punto di diritto,
dove non si verifica alcuna contraddizione né ammissione. Sul punto la Corte
di Napoli ha correttamente osservato che le società appellate, a fronte della
richiesta di differenze (in relazione ai minimi tariffari) azionata dall’avv. M.L.,
si sono difese affermando che tali ulteriori importi non competevano sia per
l’intervenuto accordo di forfetizzazione sia, soprattutto, per la semplicità e ripetitività delle cause curate dall’appellante.
Tale comportamento processuale, a parere della Corte di merito, è apparso del tutto incompatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata,
riproposta in sede di gravame, che, presupponendo l’intervenuto pagamento,
non consente contestazione alcuna in ordine all’esistenza del credito azionato
neppure in relazione a parte degli importi richiesti.
Così argomentando, il Giudice a quo si è adeguato al condivisibile orientamento di questa Corte (Cfr. sent Cass. n. 3105/01) secondo il quale, in tema di prescrizioni presuntive, l’ammissione di non aver estinto il debito da
parte del debitore (che comporta il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva) può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione,
da parte del debitore stesso, dell’entità della somma richiesta (cfr in senso
conforme Cass. 2004/5563; 2001/15132; 2001/10998; 2000/231 l;
1999/2257; 1999/13921; 1995/01160).
Con il sesto motivo le ricorrenti denunciando violazione e lo falsa applicazione degli artt. 409 e 429 c.p.c., e del principio dispositivo per la concessione “automatica” della rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5),
lamentano che il Giudice di appello abbia applicato in modo assolutamente
automatico la rivalutazione monetaria, nonostante, nel caso di specie, sia
configurabile un rapporto che, ancorché ricompreso tra quelli di cui all’art.
409 c.p.c., dalla sentenza 9.1.1996 n. 96 (in sede di regolamento di competenza) si differenzia qualitativamente da quelli “di lavoro dipendente” per non
essere assoggettato alla speciale tutela di cui all’art. 36 Cost.
Tale tesi, che, almeno sotto certi aspetti, ha trovato riscontro favorevole
in tempi meno recenti sia in dottrina che in giurisprudenza (v. Cass. 23 marzo 1983 n. 2036), ha finito con l’essere successivamente soppiantata da altra
Rassegna Forense – 3/2010
679
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sui limiti di tariffa forense
ricostruzione della normativa di riferimento, alla quale il Collegio intende aderire. Ed invero – ed a voler trattare più diffusamente la questione in considerazione della ampie argomentazioni svolte dalle ricorrenti sul punto – va osservato che secondo quest’ultima ricostruzione, pur non negandosi che la rado della estensione del “nuovo rito” ai rapporti c.d. parasubordinati sia riposta in una esigenza di protezione, richiesta anche in questi casi dalla attività
lavorativa, benché non nelle penetranti forme previste dall’art. 36 Cost., una
volta accertata la presenza dei requisiti espressamente richiesti dalla ipotesi
normativa (art. 409 c.p.c., n. 3: continuatività, coordinazione, prevalenza
personale della prestazione), devono poi operare tutte le garanzie sia di ordine processuale che sostanziale, contemplate dalla legge per detti rapporti.
Deve, infatti, escludersi, già in linea teorica, una scissione degli aspetti garantistici, che il mero rito assicura al lavoratore, da quelli di natura più propriamente sostanziale, previsti dalla legge medesima, essendovi tra gli stessi
una stretta e reciproca connessione, in forza di una valutazione operata, una
volta per tutte, dal legislatore.
È noto che i criteri informatori della speciale disciplina processuale sono
espressione di una chiara scelta del legislatore, il quale – come non ha mancato di rilevare la dottrina – ha abbandonato la posizione tradizionale, che
vorrebbe limitare il suo intervento ad assicurare il rispetto delle regole del
gioco individuale, ed ha preso decisamente posizione a favore della parte socialmente più debole, considerando la tutela che ne consegue un momento
necessario dei suoi fini politici generali.
Il processo, tuttavia, come è stato in più occasioni affermato, non è un
bene in se stesso, ma è uno strumento per l’attuazione del diritto, e quindi
per il raggiungimento degli scopi che un dato ordinamento giuridico si propone; onde il potenziamento dei poteri processuali a favore di una parte costituisce il mezzo per l’attuazione dei diritti sostanziali che a quella parte l’ordinamento attribuisce. Una riprova sul terreno concreto della validità di tale assunto la si ricava dalle argomentazioni adottate dalla Corte Costituzionale
proprio in relazione alla disposizione prevista dall’art. 429 c.p.c., comma 3,
laddove ha dovuto esaminare l’asserita incostituzionalità in rapporto agli artt.
3 e 35 Cost., in quanto non applicabile ai crediti di lavoro autonomo.
La Corte, con ordinanza 10 maggio 1978, n. 65 (17), ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione nel senso che “la norma denunciata è applicabile anche ai rapporti di lavoro autonomo, la cui prestazione si concreti in
una attività continuativa e coordinata, prevalentemente personale, e la sua
mancata applicazione nei residuali rapporti di lavoro, non è priva di razionale
giustificazione poiché in questa ipotesi non sussiste la posizione di debolezza
del lavoratore rispetto al datore di lavoro, che rappresenta la ratio del particolare strumento di tutela”. Una ratio questa, che – come accennato – è posta alla base dell’intero complesso normativo introdotto dalla l. n. 533 del
1973, diretto a favorire il lavoratore in vario modo, garantendo, ad esempio,
l’immediata e concreta percezione delle somme che gli sono dovute, attraverso la previsione sia dell’ordinanza di pagamento, sia della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado in base finanche alla sola copia del dispositivo. La rilevata stretta compenetrazione tra i profili di rito e quelli di diritto
680
Rassegna Forense – 3/2010
Parte Seconda – Giurisprudenza
sostanziale e l’altrettanto evidenziata esigenza di uniformità dalla disciplina
garantistica per tutti i rapporti previsti dalla l. n. 533, lasciano, dunque, agevolmente comprendere come, nel momento stesso in cui si afferma la sottoposizione della fattispecie in esame a detta legge debba applicarsi altresì la
disposizione contenuta nell’art. 429 c.p.c., comma 3.
Deve, dunque, ribadirsi che alla natura parasubordinata del rapporto consegue l’applicazione del disposto dell’art. 429 c.p.c., comma 3, circa la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, tenuto conto che tale norma – come
sottolineato nelle decisioni della Corte costituzionale n. 65 del 1978 e 76 del
1981 – riguarda tutti i rapporti elencati nel precedente art. 409 c.p.c., e quindi anche quelli dei lavoratori autonomi quando siano caratterizzati dalla continuità e dalla coordinazione delle prestazioni eseguite (Cass. S.U. n.
1912/1999; Cass. n. 19206/1999; Cass. n. 7602/1986; Cass. n. 6298/1988;
Cass. n. 8838/1992).
Con il settimo motivo le ricorrenti osservano le ricorrenti che nel ricorso
introduttivo l’avv. L. aveva richiesto rivalutazione ed interessi sul proprio credito”dalla data di espletamento dei singoli incarichi” ed in via subordinata la
domanda di “pagamento degli interessi bancari” ed il giudice di primo grado
aveva accolto parzialmente la domanda accordando la rivalutazione e gli interessi “dalle date di messa in mora”.
Nel proprio atto di appello l’avv. L. aveva invertito le domande, chiedendo
in principalità il “pagamento degli interessi bancari” – senza indicazione di
decorrenza ed in subordine limitandosi al pagamento di interessi e rivalutazione senza indicare una diversa decorrenza rispetto alla decisione di primo
grado.
Il Giudice di appello ha ritenuto che l’accoglimento della domanda – posta in
via principale in primo grado – di rivalutazione ed interessi privasse l’appellante
di interesse all’impugnazione e che non fosse consentito in appello “invertire”
l’ordine delle domande, accogliendo peraltro la domanda di rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei crediti anziché dalla messa in mora.
Secondo i ricorrenti ai sensi dell’art. 346 c.p.c., la proposizione subordinata della domanda principale equivale a rinunzia.
Inoltre la domanda subordinata (in appello) non poteva essere accolta con
una decorrenza diversa, in difetto di apposito gravame.
Il motivo è fondato quanto a quest’ultimo profilo.
Ed invero, in ordine al primo profilo, del tutto correttamente il Giudice a
quo ha ritenuto che l’accoglimento della richiesta principale di corresponsione
di interessi e rivalutazione monetaria non giustificasse una doglianza volta ad
ottenere il riconoscimento degli interessi bancari, la cui richiesta era stata
formulata in primo grado solo in via subordinata.
Quanto al secondo profilo va invece ritenuto che, in difetto di gravame, da
effettuarsi in maniera specifica (art. 434 c.p.c.) non poteva il giudice di appello fissare una decorrenza diversa da quella accordata dal primo giudice e
quindi dalle “date di messa in mora”.
Il motivo va, pertanto, accolto, con assorbimento del successivo, con cui,
denunciandosi violazione degli artt. 1219, 1224 e 1227 c.c., e dell’art. 429
c.p.c., nonché vizio di motivazione, si censura la decisione della Corte parte-
Rassegna Forense – 3/2010
681
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sui limiti di tariffa forense
nopea, in punto decorrenza della rivalutazione ed interessi legali, sotto altro
aspetto.
Per quanto precede l’impugnata sentenza va annullata in relazione al motivo accolto e non essendo necessari accertamenti di fatto la causa va decisa
nel merito con condanna, sulle somme determinate nella sentenza di appello,
degli interessi e rivalutazione dalle date di messa in mora, come specificato
nella sentenza di primo grado.
La complessità delle questioni oggetto di controversia ed i contrasti giurisprudenziali su talune di esse, induce a compensare tra le parti le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso, dichiara assorbito l’ottavo e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,
decidendo nel merito, condanna le ricorrenti al pagamento, sulle somme determinate nella sentenza di appello, degli interessi e rivalutazione dalle date
di messa in mora, come specificato nella sentenza di primo grado. Compensa
le spese dell’intero processo.
GIUSEPPE COLAVITTI
Le tariffe forensi tra diritto interno e diritto comunitario: parole chiare
dalla Corte suprema di Cassazione
1. Pochi giorni prima che il tema delle tariffe tornasse ad animare le cronache politiche nel quadro dei lavori del Senato per l’approvazione della riforma dell’ordinamento forense, la Corte suprema di cassazione ha, con la
sentenza oggi in commento, depositato una decisione che non potrà non influire nel dibattito in corso, considerata la nettezza delle affermazioni rese, e
l’autorevolezza di chi appunto le rende. Ed invero la decisione della sezione
lavoro n. 20269 del 2010 pare quasi avere l’ambizione di fare il punto sul
quadro di riferimento giuridico di diritto interno e di diritto comunitario che
vige su di un tema da molti considerato cruciale rispetto al più generale problema della compatibilità del modello ordinistico con la disciplina della libertà
di concorrenza.
Ambizione rilevabile dalla completezza dei richiami alla giurisprudenza
comunitaria in materia, ma più in generale dalla disamina di tutte le fonti rilevanti, la cui corretta applicazione non è stata negli anni certamente facilitata da un quadro assai complesso, sia in relazione alla successione nel tempo
di diversi interventi normativi, sia in relazione all’afferenza delle norme in
questione a tipologie differenti per rango e valore. Con la conseguenza di non
poche incertezze e passi falsi nella giurisprudenza di merito.
2. Il caso di specie verte sulla nullità o meno di una convenzione intercorsa
tra alcune società commerciali e taluni legali avente ad oggetto attività stragiudiziali e giudiziali per il recupero di crediti rimasti insoddisfatti, convenzione che
682
Rassegna Forense – 3/2010
Parte Seconda – Giurisprudenza
prevedeva compensi inferiori ai minimi di tariffa. Dalla nullità di siffatte convenzioni deriva il diritto dell’avvocato a percepire la differenza tra quanto effettivamente corrisposto e quanto invece dovuto in forza dei minimi tariffari.
Si tratta di un caso esemplare. Chi conosce l’argomento sa che il problema
non si pone mai o quasi mai nelle relazioni tra il cittadino consumatore ed il suo
avvocato. È difficile che un cittadino colpito magari in un fondamentale bene
della vita (il lavoro, o la casa, ad esempio) compia una vera e propria “trattativa” sui costi con il suo legale: in questi casi, anche in virtù della stretta relazione fiduciaria che si instaura tra assistito e legale, in genere il cliente corrisponderà all’avvocato quanto gli viene richiesto, salvo magari richiedere in via preventiva una stima di massima. Sono invece le convenzioni stipulate con la media o la grande impresa (in ispecie quella bancaria o assicurativa) che molto
spesso, anche in relazione alla serialità vera o presunta delle prestazioni professionali richieste, presuppongono una negoziazione dove la parte debole è
certamente l’avvocato, sia per l’ormai altissimo numero di legali disponibili sul
mercato, sia per lo squilibrio oggettivo tra la forza della banca e quella del professionista, che quasi sempre è tenuto (o è costretto) ad accettare compensi
inferiori appunto alle soglie minime. Non è un caso che, all’indomani, nel 2006,
dell’approvazione del decreto Bersani (d.l. n. 223/2006, conv. in legge n. 248
del 2006), furono proprio l’ABI e l’ANIA a sostenere entusiasticamente la linea
del Governo di allora. Di questo genere di rapporti economici in realtà si discute, quando si ragiona sulle tariffe forensi. Da qui la esemplarità della pronunzia
in commento.
3. Scorrendo la disamina in diritto dei motivi di ricorso, e le relative soluzioni indicate dai giudici di legittimità, è possibile tracciare un efficace ed in
gran parte convincente quadro ricostruttivo dell’esatta portata della problematica tariffaria, almeno sotto il profilo giuridico, e ferma restando la ovvia
opinabilità, in senso politico, di talune opzioni piuttosto che di altre.
Seguiamo l’ordine logico della pronunzia.
4. In primo luogo è investita la vigenza o meno della fonte primaria che
determina (rectius: ha determinato, fino al Decreto Bersani) la regola della
inderogabilità dei minimi, e cioè l’art. 24 della legge n. 794/1942. La analoga
disposizione delle tariffe vigenti, che – giova ricordarlo – sono adottate con
decreto ministeriale, e cioè con una fonte regolamentare ovviamente subordinata alla legge, non fa altro che ripetere la regola in questione, ma non avrebbe certamente la forza di derogare al principio consensuale di cui all’art.
2233 c.c., se non fosse sorretta da una norma avente rango di legge (cfr. art.
4, comma 1, d.m. 8 aprile 2004, n. 127). Più volte, infatti, si è revocato in
dubbio (e lo fanno anche le società parti del procedimento in esame) che
l’art. 24 fosse ancora vigente, considerato che la successiva legge n.
1051/1957 aveva abrogato la legge del 1942, delegificandone i contenuti sostanziali che sono rimessi da quel momento in poi alla fonte regolamentare.
Avendo regolato ex novo la materia – si diceva – la legge del 1957 avrebbe
abrogato tutta la legge del 1942, compreso l’art. 24 dedicato alla inderogabilità dei minimi. Così non è stato, dice invece la Corte, richiamando al riguardo
la propria pregressa consolidata giurisprudenza. Assunto del tutto condivisibile. Secondo il meccanismo di cui all’art. 15 preleggi, l’abrogazione si è avuta
Rassegna Forense – 3/2010
683
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sui limiti di tariffa forense
solo per gli articoli dall’1 al 23, giacché la fonte successiva ha sì ridisciplinato
la materia, ma relativamente al procedimento di adozione della tariffa forense, senza toccare la regola di diritto sostanziale della inderogabilità dei minimi (cfr. ex multis, Cass. 12840/2003; Cass. 7094/2006; Cass. 28718/2008).
5. In secondo luogo la Corte si dedica al cuore della questione, evocato
anche in questa causa dalle parti che avevano interesse a non applicare i minimi: mi riferisco all’argomento della presunta incompatibilità della regola
della inderogabilità dei minimi con il Trattato CE, e dunque alla conseguente
necessaria disapplicazione degli stessi in base al principio della prevalenza del
diritto comunitario. Numerosi sono i parametri comunitari che nel tempo sono
stati evocati al riguardo: sia le norme sulle intese restrittive della concorrenza, che, ad esempio, quelle sulla libera prestazione di servizi. La Corte di cassazione sceglie ovviamente di affrontare il tema rifacendosi alla giurisprudenza della Corte di giustizia, e ne ripercorre sinteticamente le conclusioni. Metodo certamente condivisibile: in verità sulla questione le istituzioni europee
non sempre hanno concordato. Senza rincorrere tutti i momenti di una vicenda ormai lunga, che si è snodata anche attraverso prese di posizione politiche, mozioni, comunicazioni, e quindi atti non normativi, possiamo sinteticamente dire che la Commissione europea (e con essa la nostra AGCM) ha
sempre avuto sul punto una posizione fortemente orientata nel senso di ritenere violata la libertà di concorrenza, mentre il Parlamento europeo ha più
volte manifestato opinioni meno intransigenti e più vicine a quelle rappresentate dalle organizzazioni di rappresentanza professionale nazionali ed europee. Del pari si sono articolate in modo molto eterogeneo le posizioni delle forze
politiche italiane, o almeno di quelle che sul punto hanno maturato una posizione, e financo le ricostruzioni dottrinarie. La Corte deve però trovare dei
punti fermi, perché deve rispondere alla domanda di giustizia, e, circa le conclusioni cui pervenire, non può che rifarsi alla giurisprudenza dell’organo investito dai Trattati della gravosa responsabilità della corretta interpretazione
degli stessi.
6. La Corte non si ferma peraltro al mero richiamo della giurisprudenza
comunitaria conferente, ma anzi la rilegge e ne offre la propria interpretazione, quasi consapevole, forse, che anche di tale giurisprudenza sono state fornite letture diverse, e perfino, in un caso, opposte. Proprio su quel caso la
Cassazione si sofferma ampiamente: e sta qui, a mio avviso, il portato più
importante della pronunzia, ed anche la sua maggiore utilità. Mi riferisco al
caso deciso dalla Corte di giustizia con pronunzia in data 5 dicembre 2006,
cause riunite C-94/04 e C-202/04, più noto come caso Cipolla Macrino, dal
nome delle parti. Sulla sentenza precedente, la cd. sentenza Arduino (Corte
di giustizia 19 febbraio 2002, in causa C-35/99), la Cassazione si limita a un
richiamo, perché nessuno può dubitare che la sentenza deponga inequivocabilmente nel senso della piena compatibilità delle tariffe (e dei minimi) con il
quadro comunitario: “gli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e
81 CE) – dice la Corte di giustizia – non ostano all’adozione da parte di uno
Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla
base di un progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa
che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell’ordine, qua-
684
Rassegna Forense – 3/2010
Parte Seconda – Giurisprudenza
lora tale misura statale sia adottata”. Anche se la Cassazione non lo fa, per
condivisibili esigenze di economia della decisione, vale la pena in questa sede, per completezza, sviluppare almeno la linea argomentativa principale di
quella decisione. Il giudice italiano remittente, in quel caso, aveva adito la
Corte del Lussemburgo per far rilevare la asserita violazione dell’art. 85 trattato CE da parte della normativa italiana in materia di tariffe forensi, deducendo che queste, adottate da un ente qualificabile come associazione di imprese (il Consiglio nazionale forense) integrerebbero intese restrittive della libertà di concorrenza. La linea argomentativa sostenuta dalla Corte poggiava
fondamentalmente sul riconoscimento del fatto che le tariffe professionali,
seppur proposte dall’ordine, sono comunque approvate dal Ministro della Giustizia, dietro parere del Consiglio di Stato e del CIP, e che dunque l’atto è sostanzialmente oltre che formalmente imputabile ad un’autorità dello Stato.
Ciò impedirebbe di riconoscerne l’origine in organismi espressione della categoria che rende le prestazioni professionali e che avrebbe perciò interesse a
promuovere intese restrittive della concorrenza. Peraltro l’art. 60 del regio
decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 dispone che la liquidazione degli
onorari sia effettuata dagli organi giudiziari in base ai criteri stabiliti dall’art.
57 del medesimo decreto legge, tenuto conto della gravità e del numero delle
questioni trattate. Inoltre, in talune circostanze eccezionali, il giudice può,
con una decisione debitamente motivata, derogare ai limiti minimi fissati in
applicazione dell’art. 58, r.d. cit. Pertanto non si può ritenere che lo Stato italiano abbia rinunciato ad esercitare il proprio potere delegando ad operatori
privati la responsabilità di prendere decisioni di intervento nel settore economico, cosa che avrebbe portato a privare del suo carattere pubblico la normativa di cui trattasi. Per le ragioni indicate, non può essere nemmeno addebitato allo Stato italiano di imporre o di favorire la conclusione, da parte del
C.N.F., di intese in contrasto con l’art. 81 CE o di rafforzarne gli effetti, né di
imporre o favorire abusi di posizione dominante in contrasto con l’art. 82 CE,
o di rafforzarne gli effetti.
7. La Corte descrive a fondo, come accennato, il contenuto della seconda
fondamentale decisione, la sentenza Cipolla Macrino. Su questa decisione, invero più articolata e complessa della precedente, sono infatti fioccate interpretazioni diverse. Richiamo al riguardo un episodio emblematico, che forse
gli osservatori più attenti del settore non hanno dimenticato. All’indomani del
deposito della decisione, nel dicembre 2006, a pochi mesi dal Decreto Bersani, che è dell’estate di quell’anno, due comunicati stampa commentarono la
sentenza in modo diametralmente opposto, tanto da far dubitare il lettore che
l’oggetto fosse il medesimo. Il Consiglio nazionale forense salutò la decisione
come una sconfessione dell’operato del Governo, che era intervenuto con decreto legge per regolare una materia discussa da decenni, ed aveva dichiarato (perfino nella lettera della norma) di farlo in adempimento di vincoli comunitari; il Ministero dello sviluppo economico vide invece nella decisione la conferma della correttezza dell’impostazione seguita. Chi aveva ragione?
8. Oggi, dopo quattro anni, soccorre l’operatore allora (e forse ancora oggi) un po’ disorientato la pronunzia in commento, che offre una vera e propria “interpretazione autentica” del contenuto decisorio della sentenza Cipolla
Rassegna Forense – 3/2010
685
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sui limiti di tariffa forense
Macrino: “la conformità al principio comunitario della libera concorrenza di
quelle norme del diritto interno in virtù delle quali è imposta la inderogabilità
dei minimi di tariffa forense, costituisce orientamento confermato dalla più
recente sentenza della Corte di giustizia del 5 dicembre 2006”. Non ci sono
più dubbi: aveva ragione chi riteneva che il diritto comunitario non imponesse
di rimuovere la norma sui minimi, ed aveva torto chi riteneva che la si dovesse abrogare per violazione del Trattato, ferma restando la discrezionalità del
legislatore nell’apprezzare l’opportunità o meno della misura. La garanzia della tutela della qualità della prestazione professionale a tutela dei consumatori
e la buona amministrazione della giustizia sono – ha detto ieri la Corte di giustizia, e dice oggi la Cassazione – “le ragioni imperative di interesse pubblico”
che giustificano una limitazione del principio di libera prestazione di servizi ad
opera di una norma interna che fissi minimi inderogabili. Ma la pronunzia in
commento non si ferma qui. La Cassazione si pone sulla scia della scelta operata a Lussemburgo e si assume l’onere di attuarla entrando nel merito della
situazione italiana, e calando nel contesto socioeconomico nazionale il principio affermato per tutta l’Unione dalla Cipolla Macrino. Spetta al giudice nazionale – aveva detto la Corte di giustizia – valutare se le ragioni di interesse
pubblico che in astratto possono giustificare un regime di minimi tariffari sono
rinvenibili in concreto, in ciascun Paese. La Cassazione non si tira indietro, e
sviluppando uno spunto già proprio della Cipolla Macrino (il numero dei legali), la completa e la prosegue, affermando che “pur non essendo una garanzia
della qualità dei servizi non si può certo escludere – ed anzi deve affermarsi –
che nel contesto italiano, caratterizzato da una elevata presenza di avvocati,
le tariffe che fissano onorari minimi consentano di evitare una concorrenza
che si traduce nell’offerta di prestazioni “al ribasso”, tali da poter determinare
un peggioramento della qualità del servizio”.
“Non si può certo escludere – ed anzi deve affermarsi”, dice la Corte: e
dunque ben può il legislatore prevedere minimi inderogabili senza paura di
violare il diritto comunitario, perché appunto i fenomeni di offerte al ribasso
che la rimozione dei minimi inevitabilmente comporta possono incidere negativamente sulla qualità del servizio, in danno dell’utente consumatore.
9. Tralasciando altri profili propriamente processuali, accompagnano la
descritta parte motiva centrale della decisione altre interessanti affermazioni,
solo in parte confermative degli assetti consolidati in materia. Tra questi ultimi rientra certamente l’affermazione del principio per cui l’inderogabilità dei
minimi non si spinge al punto di impedire all’avvocato di effettuare prestazioni professionali anche in modo gratuito, per ragioni morali o di amicizia e/o
parentela, a meno che la rinunzia non risulti “posta in essere strumentalmente per violare la norma imperativa sui minimi tariffari”. Questo passaggio
sull’eventuale rinunzia volontaria conduce il giudice a porre il tema dell’equilibrio dei rapporti tra avvocato e cliente, nel caso delle convenzioni di cui si è
detto. Il principio dell’irrilevanza della rinunzia strumentale a violare la regola
dell’inderogabilità dei minimi può collegarsi al tema della preminenza della
parte forte (l’impresa) su quella debole (l’avvocato), nel quadro di un rapporto che il giudice definisce “parasubordinato”. Riconoscendo la doverosa applicazione al caso di specie del principio della automatica rivalutazione moneta-
686
Rassegna Forense – 3/2010
Parte Seconda – Giurisprudenza
ria dei crediti di lavoro (art. 429, comma 3, c.p.c.), la Cassazione si richiama
alla conferente giurisprudenza costituzionale per la quale tale norma di favore
si applica anche al lavoro autonomo caratterizzato dalla continuità e dalla coordinazione delle prestazioni eseguite, nonché dalla personalità delle stesse
(Corte cost. 10 maggio 1978, n. 65; sul punto vedi anche Corte cost. n.
76/1981). Se la ratio di disposizioni processuali quali quella richiamata è appunto quella di proteggere una certa parte di un rapporto economico, perché
in questi casi il legislatore “ha preso posizione a favore della parte socialmente più debole, considerando la tutela che ne consegue un momento necessario dei suoi fini politici generali” (così la Corte), allora il favor va accordato
anche al caso di specie in quanto in esso ricorrono i requisiti richiesti dalla
norma: continuatività, coordinazione, prevalenza personale della prestazione.
L’avvocato “convenzionato” e pagato sotto i minimi, ai quali magari ha dovuto formalmente rinunziare perché costretto, è in rapporto di tipo parasubordinato con il cliente, e dunque ha diritto alle tutele sostanziali e processuali
proprie di tale regime. Non è poco, e la Corte riconosce sul punto di discostarsi anche dalla propria giurisprudenza (contra, Cass. 23 marzo 1983, n.
2036). Non sono abbattuti i confini (e le differenze di trattamento normativo)
del lavoro subordinato e del lavoro autonomo, ma più limitatamente si alza il
velo sul lavoro solo formalmente autonomo che in realtà non è svolto in condizioni di autonomia e indipendenza, bensì sotto la preminenza di un clientecommittente che è la vera parte forte della relazione economica. È una linea
a mio avviso molto interessante, che può essere foriera di ulteriori sviluppi.
Perché è più coerente con la cornice di riferimento costituzionale nella quale
va inscritta – ad avviso di chi scrive – la disciplina del lavoro professionale.
Questo infatti, pur non essendo lavoro subordinato, è comunque “lavoro” e
non attività di impresa ex art. 41 Cost, e dunque reclama, in via di principio,
e (ovviamente) per quanto possibile, l’applicazione di una serie di norme costituzionali che sono per lo più immaginate afferenti solo alla sfera del lavoro
dipendente. Taluni contestano perfino un assunto – ad avviso di chi scrive –
indubitabile, e cioè che quando la Costituzione impone alla Repubblica di tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35), essa si riferisce
anche al lavoro dei professionisti. Le verità è che, anche tra gli osservatori
specializzati e gli studiosi, assai difficilmente si pensa al lavoro professionale
quando ci si sofferma sui diritti del lavoratore di cui agli artt. 36 e ss. Cost.,
ché anzi, più in generale, ben raramente si pensa al professionista quando le
norme (o il linguaggio comune) evocano il “lavoratore”. Come se il lavoro
fosse solo quello subordinato, o addirittura solo quello manuale. Con ciò dimenticando che nel porre a fondamento della Repubblica proprio “il lavoro”,
senza ulteriori denominazioni o limitazioni di senso, ed anzi rifiutando espressamente la pur proposta menzione dei “lavoratori”, il primo articolo della Costituzione non ha solo escluso che il richiamo al lavoro potesse avere una declinazione di tipo classista a discapito di taluni ceti o classi sociali, ma anzi ha
probabilmente fornito una indicazione decisiva per interpretare correttamente
le successive disposizioni costituzionali sul lavoro e sui lavoratori, come disposizioni che in via di principio riguardano tutto il lavoro, e non solo la sfera
del lavoro subordinato.
Rassegna Forense – 3/2010
687