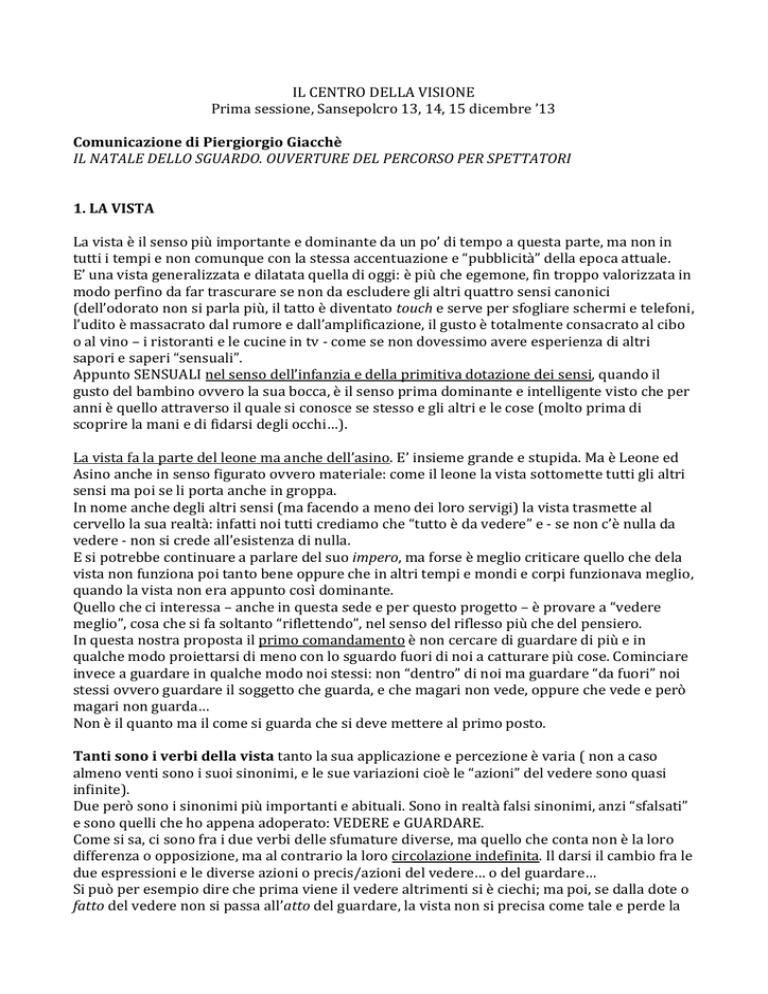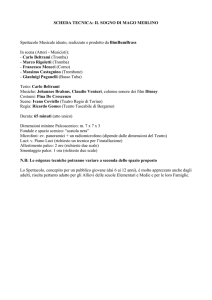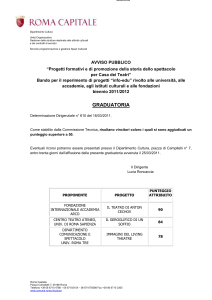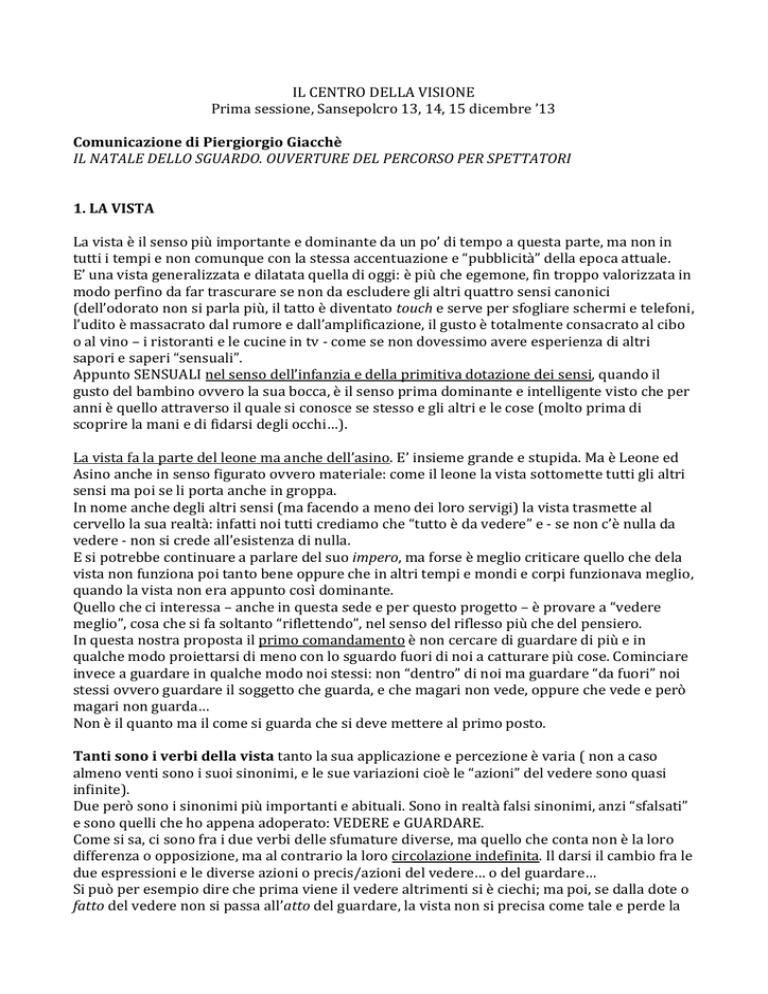
IL CENTRO DELLA VISIONE
Prima sessione, Sansepolcro 13, 14, 15 dicembre ’13
Comunicazione di Piergiorgio Giacchè
IL NATALE DELLO SGUARDO. OUVERTURE DEL PERCORSO PER SPETTATORI
1. LA VISTA
La vista è il senso più importante e dominante da un po’ di tempo a questa parte, ma non in
tutti i tempi e non comunque con la stessa accentuazione e “pubblicità” della epoca attuale.
E’ una vista generalizzata e dilatata quella di oggi: è più che egemone, fin troppo valorizzata in
modo perfino da far trascurare se non da escludere gli altri quattro sensi canonici
(dell’odorato non si parla più, il tatto è diventato touch e serve per sfogliare schermi e telefoni,
l’udito è massacrato dal rumore e dall’amplificazione, il gusto è totalmente consacrato al cibo
o al vino – i ristoranti e le cucine in tv - come se non dovessimo avere esperienza di altri
sapori e saperi “sensuali”.
Appunto SENSUALI nel senso dell’infanzia e della primitiva dotazione dei sensi, quando il
gusto del bambino ovvero la sua bocca, è il senso prima dominante e intelligente visto che per
anni è quello attraverso il quale si conosce se stesso e gli altri e le cose (molto prima di
scoprire la mani e di fidarsi degli occhi…).
La vista fa la parte del leone ma anche dell’asino. E’ insieme grande e stupida. Ma è Leone ed
Asino anche in senso figurato ovvero materiale: come il leone la vista sottomette tutti gli altri
sensi ma poi se li porta anche in groppa.
In nome anche degli altri sensi (ma facendo a meno dei loro servigi) la vista trasmette al
cervello la sua realtà: infatti noi tutti crediamo che “tutto è da vedere” e - se non c’è nulla da
vedere - non si crede all’esistenza di nulla.
E si potrebbe continuare a parlare del suo impero, ma forse è meglio criticare quello che dela
vista non funziona poi tanto bene oppure che in altri tempi e mondi e corpi funzionava meglio,
quando la vista non era appunto così dominante.
Quello che ci interessa – anche in questa sede e per questo progetto – è provare a “vedere
meglio”, cosa che si fa soltanto “riflettendo”, nel senso del riflesso più che del pensiero.
In questa nostra proposta il primo comandamento è non cercare di guardare di più e in
qualche modo proiettarsi di meno con lo sguardo fuori di noi a catturare più cose. Cominciare
invece a guardare in qualche modo noi stessi: non “dentro” di noi ma guardare “da fuori” noi
stessi ovvero guardare il soggetto che guarda, e che magari non vede, oppure che vede e però
magari non guarda…
Non è il quanto ma il come si guarda che si deve mettere al primo posto.
Tanti sono i verbi della vista tanto la sua applicazione e percezione è varia ( non a caso
almeno venti sono i suoi sinonimi, e le sue variazioni cioè le “azioni” del vedere sono quasi
infinite).
Due però sono i sinonimi più importanti e abituali. Sono in realtà falsi sinonimi, anzi “sfalsati”
e sono quelli che ho appena adoperato: VEDERE e GUARDARE.
Come si sa, ci sono fra i due verbi delle sfumature diverse, ma quello che conta non è la loro
differenza o opposizione, ma al contrario la loro circolazione indefinita. Il darsi il cambio fra le
due espressioni e le diverse azioni o precis/azioni del vedere… o del guardare…
Si può per esempio dire che prima viene il vedere altrimenti si è ciechi; ma poi, se dalla dote o
fatto del vedere non si passa all’atto del guardare, la vista non si precisa come tale e perde la
sua principale funzione. Quindi però, in successione, se poi dall’atto del guardare (cioè del
vedere in azione) non si torna a vedere come illuminazione, cioè a carpire e accorgersi e infine
penetrare quello che si è guardato, la nostra vista ancora una volta fallisce - nel senso che non
siamo in grado di vedere quello che guardiamo.
E ancora, se proprio si vuole, dopo questo ultimo “vedere” illuminato, bisognerebbe ancora
tornare al guardare come riflessione (ri-guardare) e poi al ri-vedere come considerazione… e
così via, anche se mi fermo qui…
“E così via…” però è corretto, perché la staffetta fra Vedere e Guardare si sposta sempre in
avanti in modo incessante e intanto viaggia dentro di noi in modo automatico: la vista diventa
così più interiore e perfino intima, chiama in causa il terzo occhio del cervello, che infine vede
sempre e vede anche ad occhi chiusi.
Solo allora – a occhi chiusi – ci si accorge che il vedere/guardare torna a coniugarsi con gli
altri sensi, confondendosi e confluendo in un sempre più profondo “sentire”.
Sentire è il verbo dei sensi, prima ancora di essere sinonimo di udire. Sentire lo si fa anche con
l’olfatto e il tatto e infine perfino il gusto…
E non è un caso se se – che nelle arti e nel teatro indiano – è con il verbo e il concetto del
“gustare” (inteso come assaporare) che si definisce la dote e l’atto di quell’azione e sensazione
che noi chiameremmo ancora “vedere”.
Ma poi in effetti, davanti o dopo uno spettacolo o un’opera d’arte, cosa diciamo e sentiamo di
dire se non il nostro “gusto”? mi piace o non mi piace si dice come si fosse a tavola, ancor
prima di essere un giudizio è un puro parere sul “piacere”.
Mi fermo qui perché non so andare avanti per questa strada, ma questo punto d’arrivo è
sufficiente a fare alcune riflessioni e considerazioni critiche sulla Vista, la vista nostra, la vista
di oggi e di qui… E poi, spericolandoci, anche sulla vista delle nuove generazioni e del futuro
che verrà…
Allora ci viene da pensare se quell’adagio a cui sempre tutti abbiamo creduto, è ancora oggi e
qui accertabile o appena accettabile: “Chi vivrà, vedra?”
Oggi questo è davvero solo da sperare e per di più tutto da dimostrare.
La vista che impera e che determina ogni atto e fatto del soggetto, in realtà si sta letteralmente
“perdendo”: c’è troppo da vedere e di conseguenza si guarda tutto e non si vede niente (o
viceversa, fermando o frenando la legge del loro inseguimento e perfezionamento all’infinito
che abbiamo già descritto.
Non siamo però qui per studiare una malattia che pure è “dentro” gli occhi di tutti, ma al
contrario per suscitare una possibile ripresa e riscatto dell’atto anzi dell’ARTE DEL VEDERE. Il
vedere e il guardare formano un intreccio ma anche una crescita percettiva che li fa aspirare a
diventare un’arte: forse non un vero mestiere ma una dotazione artigianale propria delle
nostre tecniche del corpo. Una tecnica che va sviluppata e cioè prima di tutto va alimentata,
altrimenti non cresce o non cresce nella direzione giusta: verso la Qualità e non verso la
Quantità che è già troppa.
Conviene per nutrirsi e crescere prima di tutto e sopra tutto “vedere arte”, se si vuole
apprendere l’arte del vedere, aumentare la dote e la dose dell’atto dello sguardo.
Ma andare a vedere l’arte senza aumentare la propria arte del vedere è un disastro. Ed è
esattamente quello che sta succedendo a noi tutti con il turismo culturale – con le gite
intelligenti della terza età ma anche della prima e seconda a caccia di musei e monumenti:
siamo tutti impegnati a darci da fare e da correre pur di vedere arte che non si sa guardare, e
non per incompetenza della cultura ma per insufficienza della vista.
Peggio, talvolta nemmeno vediamo ma lasciamo che la macchina fotografica guardi e accumuli
per noi reperti che non vogliamo vedere ma prendere (o riprendere, che è lo stesso)!
Così diventiamo collezionisti ignoranti. Oppure, se ci impegniamo e se ci studiamo su
diventiamo anche “eruditi” sapienti. Ma non diventiamo quasi mai “esperti”.
ERUDITI O ESPERTI? Ecco altri due sinonimi da discutere: raccogliere saperi o sviluppare
esperienze sono in effetti due fatti diversi e spesso contraddittori. Sono certo complementari
– o almeno dovrebbero esserlo, perché un po’ di sapienza non fa male all’esperienza – ma è
difficile nel mercato culturale attuale tenere in piedi il loro difficile equilibrio o tenere in
forma la loro capacità di scambio.
2. LE IMMAGINI
In altri mondi e tempi c’erano come sappiamo tutti (ma non immaginiamo più) molte meno
“cose da vedere”. Ma forse questo non è esatto o non è corretto, perché il mondo è sempre
stato grande e vario e pieno di cose. Questo però è esatto se si intende – come oggi si intende –
che in altri mondi e tempi c’erano (e ci sono ancora) molte meno IMMAGINI. Cioè, non la parte
spettacolare delle cose , ma “cose” prodotte perché diano spettacolo di sé, “cose” fatte apposta
per la vista la vista e il suo atto e il loro “consumo”.
Il nostro mondo attuale e occidentale è pieno di immagini, di molte e sempre nuove
immagini prodotte e proposte in milioni di milioni e per di più contemporaneamente. Molte
delle cose che vediamo sono immagini fatte per essere viste: c’è come si sa nel nostro mondo
un’offerta, anzi un’imposizione di immagini che riempiono lo spazio sociale e il tempo
quotidiano, che si succedono in velocità e prolificano in quantità fino a “ieri” inimmaginabili.
A queste immagini nuove si somma poi il “patrimonio” o il “repertorio” ormai infinito delle
immagini residue dei tempi e dei mondi passati. Accumulare patrimonio e repertorio si è
sempre fatto? No. O almeno non quanto si fa nella nostra epoca in cui si vuole o forse si deve
recuperare tutta la storia, magari per alimentare la corsa della storia presente, oppure perché
la storia ha finito di correre ed è tutta passata…
Ma lasciando perdere questa divagazioni e tornando alle immagini e alla loro quantità e
varietà, c’è poi da aggiungere a quelle “cose” anche i loro “fantasmi”: cioè alle immagini nuove
e vecchie si sommano le associazioni, ibridazioni, invenzioni e confusioni soggettive. Tutto
quello che intendiamo per “immaginario” dipende in gran parte dalle immagini, che lo saziano
e lo orientano, perfino lo manipolano togliendolo alla nostra primitiva libertà e povertà…
Lo zoo infinito dell’immaginario attuale è un bestiario che ci guarda e ci possiede al suo
interno? Forse sì, se è vero che poi – a tutte queste immagini che ci circondano e “ci guardano”
– aggiungiamo ben volentieri noi stessi “in immagine”! E mi riferisco alla cura della nostra
immagine e quindi la nostra stessa trasformazione – ma è meglio dire “trasferimento” – in
immagine.
Chi di noi sfugge all’ordine o al desiderio di diventare immagini?
Chi poi non sente o subisce la necessità di far proliferare e pubblicizzare e moltiplicare la
nostra immagine perché abbia visibilità (se non addirittura popolarità, o infine successo)? Chi
non aspira alla tv o non usa social media, i new media, la sua propria pagina video personale?
E quanti passano molto tempo a curare la propria immagine personale, più della sua stessa
persona, e talvolta a dispetto del suo stesso corpo e della sua salute.
Vogliamo diventare immagine e dobbiamo spendere molto o tutto il nostro immaginario
per costruirsi e proporsi “a immagine e somiglianza” dell’Immagine.
In definitiva ne abbiamo bisogno. Vogliamo essere guardati perché altrimenti non crediamo di
esistere. O ancora, vogliamo e dobbiamo essere guardati anche perché noi in realtà abbiamo
perso il nostro un tempo sicuro e perfino strafottente “punto vista”, e sono sempre più le
immagini – anche la nostra stessa immagine – quelle che “ci guardano”.
Un tempo non era così…
In un paese di campagna umbra o toscana, appena cinquanta ma forse è meglio dire cento
anni fa, la gente, in gran parte analfabeta, aveva certo bisogno di immagini, forse più di noi.
Aveva infatti bisogno di insegne dipinte invece che scritte, di immagini sacre al posto delle
sacre scritture, eccetera. Anzi, a guardar bene, aveva bisogno soprattutto di immagini
funzionali come segnali o di immagini trascendenti come simboli. E molte per non dire quasi
tutte le “immagini”, quelle artificiali costruite apposta per essere viste (ma anche perché ci
vedessero) erano sacre. Ed erano poche, rispetto ad oggi. Molto poche.
Così, per tornare alla vista, nel mondo contadino o paesano di una volta la sua applicazione
era per lo più funzionale: funzionale al lavoro, alla caccia, all’amore per qualcuno e all’incanto
per la natura. Quindi, un’altra vista era quella che si spostava dall’ordinario e si affacciava
sullo straordinario: per esempio verso un quadro della madonna, un’icona lungo la strada che
portava ai campi, una statua di cristo morto o del santo patrono… Poche madonne o santi o
icone, per ogni paese; e ogni paese aveva le sue.
Così anche in casa le immagini erano poche e ciascuno aveva le proprie: qualche ritratto
(magari con sotto i lumini se era di un morto), una decorazione dipinta sul letto di ferro,
qualche cartolina, un disegno o un oggetto che sembrava un disegno stando sempre appeso
alla parete… Pochi oggetti e poche anche le loro immagini, le loro ombre. Insomma poche
immagini. Rare immagini.
Così era infine anche fuori di casa, perché si vedevano sempre gli stessi monti o colline e fiumi
e campi e gli stessi alberi e perfino gli stessi uomini e donne: le nascite e i matrimoni e le
morti muovono lentamente il paesaggio antropico noto, straconosciuto eppure sempre sotto
osservazione. Non era un caso se – come nei western – appena arrivava uno straniero tutti lo
notavano, lo guardavano, lo giudicavano.
Il vedere era anche è soprattutto riconoscere, e controllare e verificare che tutte le cose e le
genti siano al loro posto.
Poi magari l’arrivo di un piccolo circo o l’attesa e la sorpresa di una grande festa, cioè
l’apertura e la meraviglia della vista straordinaria…
Ma anche queste occasioni straordinarie erano, come si dice, “a misura d’uomo”, cioè nei
tempi e nei modi che ogni uomo può metabolizzare. E per di più “a misura di paese” cioè con il
limite del luogo che ci contiene e ci riassume: tutte le cose vedute erano cioè sottoposte a un
personale ma anche collettivo “punto di vista”. E c’era – ci doveva essere – una grande
armonia fra “personale” e “collettivo”. Il punto di vista soggettivo partecipava della
soggettività sociale cioè della “cultura” in modo molto più coerente e pesante di oggi.
E infine – questo è davvero essenziale – tutto il vedere e il guardare di tutti era influenzato o
orientato da qualche immagine più alta delle altre. Più sacra delle altre. Più condivisa delle
altre.
Quella o quelle immagini che svolgevano per tutti o quasi il ruolo di “centro della visione”.
Non possiamo né vogliamo tornare indietro nel tempo o cambiare il nostro luogo. E però
siamo qui – in questo percorso per spettatori – anche per ritrovare o meglio reinventare quel
Centro.
Non quello di una volta, non qualcosa di necessariamente comune. Magari un centro non
collettivo e solo personale… E però avere un “centro” è oggi forse più importante del “punto”
di vista. Lo è almeno per lo spettatore e la sua arte dello sguardo.
Il centro infatti nutre il punto, lo rende figlio di qualcosa o di qualcuno…
3. LA VISIONE
La visione non è la veduta. La visione è qualcosa che si rapporta e intanto si discosta dalla
veduta. La visione è “credere di vedere” e non “vedere per credere”.
La visione è il fenomeno più alto della vista, eppure è un abbaglio, una patologia. In apparenza
la distorce ma in realtà la esalta sia come capacità che come sensazione. Viene talvolta vissuta
e raccontata come una sorpresa casuale ma in realtà, per potersi permettere “visioni”,
bisogna avere – culturalmente e socialmente e però anche soggettivamente – superato la vista
ordinaria, banale, oggettiva della quotidianità. Bisogna aver fatto avanzare il contrasto e il
percorso fra “vedere e guardare e ancora vedere”, per poter avere e gustare il miracolo
semplice della visione.
Una visione si impone come spettacolo in sé e per sé: mirabile visu, dicevano i romani, che
vuol dire semplicemente “guardabile a vedersi”.
La visione è – abbiamo detto – “credere di vedere” ma nello stesso tempo è anche “non
credere a quello che si vede”.
La visione è un bisogno di vedere quello che non c’è, o meglio è un simultaneo vedere e non
vedere che fanno cortocircuito.
Sogno o son desto?, si dice quando si è sorpresi dalla visione. Vedo o non vedo? cioè è vero o
soltanto mi immagino di vedere?
Anche una semplice ma eccezionale “immagine” può provocare una visione: a questo servono
le immagini e gli spettacoli “d’arte”. E però, anche in quel caso, la visione è prima di tutto un
atto del soggetto che guarda.
Non è un’allucinazione, anzi in qualche modo lo è, ma non sempre e non solo necessariamente
provocata dall’esterno, ma soprattutto elaborata, aiutata, delibata dall’interno di chi “ha la
visione”. Insomma, chi ha una visione in parte la fa: la riceve e la insegue, la incontra e la
metabolizza, ne è nutrito e la nutre dialogandoci, può procrastinarla e talvolta persino
ripeterla o riprodurla “tra sé e sé”.
Una volta la visione era frutto della cultura, una volta era figlia della religione o della magia
(in mondi e tempi in cui la cultura magico-religiosa era il caos che avvolgeva e dominava il
nostro cosmo sociale e personale).
Ma anche adesso – anche quando “non c’è più religione” – può avvenire una visione. Non è
poi un evento sempre così alto e sovrastante, ci sono anche piccole visioni, discontinue
occasioni di avere visioni… Solo che oggi – più di ieri – esiste una visione soltanto se il
soggetto che guarda si dispone in un certo modo: si apre e si allena al vedere-guardare-vedere
mentre intanto si dispone a credere e insieme non credere a quello che vede.
Ma non si fa da soli la visione. L’occasione dell’avere una visione è sempre o quasi sempre
provocata dall’esterno: per questo e a questo serve soprattutto l’Arte, una immagine o
spettacolo d’arte. E’ sempre più spesso e quasi soltanto una proposta d’arte ciò che chiama in
causa la propria arte del vedere. E la visione è l’apice (anche infimo ma pur sempre vertice)
della personale “arte del vedere”.
Ecco cos’è uno spettacolo, nel senso dell’arte dello spettacolo: non qualcosa di
confezionato e finito in se, racchiuso nella sua dichiarazione di novità e pretesa di
straordinarietà e infine attestato da un certificato di residenza nel modo e mondo del
consumo spettacolare. Piuttosto dovrebbe o vorrebbe essere una proposta o un’offerta che
“provoca” o almeno “invita” la messa in atto della visione in luogo della veduta. Che attiva in
noi una disposizione e una capacità di essere visionari, talvolta in modo potente e obbligato e
talaltra in modo appena accennato e fragile e flebile (ma sufficiente a far sì che il soggetto
vedente possa diventare, con una sua dote e atto in più, visionante).
L’arte aspira a questo risultato: ricerca questo effetto e si costruisce come causa di questo
effetto.
L’arte non è in sé un effetto, anche se molta arte spettacolare contemporanea si concepisce e
si offre in sé e per sé come un effetto. Ma allora – in quel caso – raccoglierà magari il nostro
consenso, attiverà magari il nostro consumo, solleciterà magari perfino il nostro “gusto”, ma
non attiva la nostra “visione”.
Una visione che – come dicevano è indotta da un oggetto e però poi condotta dal soggetto.
La visione è sempre cioè il risultato di una relazione, una relazione che si sviluppa come un
un doppio processo che riguarda rispettivamente l’oggetto d’arte e il soggetto che la lo
incontra.
4. IL TEATRO
Questa centralità e indispensabilità della “relazione” pone il Teatro davvero al Centro (della
questione) della Visione.
Tutte le arti hanno a che fare con questa stessa questione e prevedono o auspicano la visione
come obiettivo. Ma non tutte le arti hanno però la stessa capacità e in primis nemmeno la
stessa necessità di proporsi e prodursi “spettacolarmente”.
Tutte le arti hanno lo spettacolo come esito fruitivo, come linea di rapporto e talvolta come
modo di consumo di chi le incontra. Un quadro? Una statua? Una musica? Una poesia? Un
romanzo? Tutti i linguaggi e gli oggetti artistici cercano cioè “anche” un loro spettacolo, ma
non per questo sono in sé e per sé (e per noi fruitori) “spettacolari”, quando non assumono
direttamente questo scopo e non adeguano le loro forme verso questa funzione rendendola
prioritaria e per così dire evidente.
Dare emozioni, ma anche dare sensazioni, conoscenze, elevazioni, riflessioni, critiche,
illuminazioni, deviazioni, ecc. : molte e varie sono le direzioni che vanno considerate e che
dettano le forme dell’arte.
Il teatro è invece una arte dello spettacolo, anzi il “teatro” è il luogo e il modo che infine può
abbracciare come un ‘cognome di famiglia’ tutte le altre arti dello spettacolo: danza o opera
lirica o circo ma perfino spettacoli sportivi e l’infinito oggi diluito panorama delle performing
arts può riconoscersi all’interno di questo generale e generico cognome di famiglia. Tanto che
teatro e spettacolo rischiano di essere confusi per sinonimi; tanto che il teatro può anche
sembrare l’antenato del cinema e poi della televisione e infine di facebook.
Teatro è “spettacolo dal vivo” – si dice anche nelle leggi ministeriali – ma più propriamente è
una parte, una forma dello spettacolo dal vivo: è “spettacolo vivente”.
Il rapporto di mediazione, confusione, rappresentazione fra Arte e Vita passa per il teatro, più
che per lo Stadio, o il Circo o altri generi “dal vivo”. Non c’entra “il bello della diretta” ma il
peso della compresenza e della relazione fra attore e spettatore davanti a una
rappresentazione, ovvero a una finzione della vita (o alla vita della finzione).
Ma la farò breve. Perché poi il teatro è al centro della questione della visione? Non perché
esplicitamente teso a prodursi come spettacolo ovvero fondersi insieme al suo spettacolo, ma
per il genere di linguaggio che lo caratterizza, e infine per lo spazio-tempo-corpo che il Teatro
è.
Il teatro è un costume (dicevano una volta) ma anche un’arte (almeno dai primi del
Novecento, da quando ha rivendicato e ottenuto un suo “statuto d’arte”).
Ma quale arte è? E’ l’arte della “rappresentazione per azioni” – diceva Aristotele (e ancora
nessuno ha meglio definito in sintesi il linguaggio teatrale).
E le azioni però che sono?
Sono a loro volta, una successione di minimi spettacoli: le azioni scenica sono una alternanza
di apparizioni e sparizioni, ovvero di tutto quello che appare e scompare in una scena data o
presunta, tutti gli effetti e le parole e le entrate e le uscite degli attori e le musiche e i silenzi…
insomma ogni elemento-momento che modifica con la sua presenza e poi assenza un quadro
scenico, un campo del vedere, un’area del fare.. insomma un Teatro.
Questa alternanza di apparire e sparire è la danza di chi o di cosa si “offre” alla visione: si fa
vedere e non vedere, provoca l’apparizione nella mente quando avviene la sparizione nella
scena. La danza delle azioni è fatta apposta per stimolare e far proseguire l’atto visionario
dello spettatore.
Se non dà una visione, il teatro fallisce il suo scopo: vorrà dire che avviene qualcosa che però
non dà “visioni”. Perché? Talvolta non ci riescono gli artisti in scena; altre volte (molte di
meno) può essere incapace il pubblico in sale. Talvolta non ci riesce la scommessa della
finzione? Talvolta non ci riesce la scommessa della relazione?
Sempre ci sarà un difetto nella costruzione e successione delle “azioni”.
Ma infine non importa se ci riesce o no. Molto teatro lo si fa e lo si guarda per così dire “in
attesa” di un altro spettacolo di teatro che ci riesca, che “abbia successo”. E’ però importante
che a produrre la visione, sia la scena che la sala, ci provino.
E per quanto ci riguarda nel nostro Percorso per spettatori (per il nostro progetto IL CENTRO
DELLA VISIONE), importa che siamo d’accordo sull’assunto anzi sull’obbligo che fa del teatro
il luogo del rapporto privilegiato tra azione e visione, della ricerca incessante di questa
combinazione e corrispondenza divisa fra due luoghi e due ruoli, fra l’attore e lo spettatore.
Provare per credere. O forse, crederci per poterci provare. Questo è lo scopo del nostro
percorso triennale intitolato al Centro della Visione.
5. UN PROGRAMMA
Qualche linea o qualche promessa per il percorso che abbiamo deciso di proporre.
Stiamo ancora costruendo la nostra proposta e vorremmo che fosse un percorso più che un
discorso. In ogni caso, non un corso!
Stanno facendo “corsi per spettatori” un po’ dappertutto e in tutti i teatri. Affidati a critici o
organizzatori e raramente ad artisti, tutti i teatri maggiori e minori prima o poi (o sempre)
progettano “corsi per lo spettatore”. Spesso con il primo fine di “fidelizzare” un pubblico,
mentre il secondo fine è quello di “prepararlo”, ma forse meglio sarebbe dire “informarlo”.
Di regola questi “corsi” servono all’istruzione ma non per l’uso. Si danno molti elementi o
ingredienti di cultura teatrale, in modo da accrescere l’erudizione (sulla drammaturgia, la
recitazione, la regia ma anche le nuove o vecchie “arti performative”), ma non l’esperienza.
Il paradosso di questi corsi è appunto la distanza tra diventare Esperto e fare Esperienza. E la
direzione di questi corsi va sempre nel senso di avvicinare lo spettatore alla scena e ai suoi
temi e problemi, di costruire un pubblico più competente ma non per questo più attivo – non
per questo parte consapevole e viva dell’arte dello spettacolo “vivente”.
Non è “sbagliato” tutto questo far corsi e ricorsi. E’ vero cioè che “sapere” di più e meglio la
cultura teatrale è una dotazione da non trascurare. Anche e soprattutto oggi che – a detta di
attori professionisti che fanno stages formativi – non solo gli spettatori ma anche moltissimi
“attor giovani” non conoscono o disconoscono la teoria e la tecnica e infine i risultati della
ricerca e gli obiettivi della sfida teatrale dei grandi maestri del secolo scorso (da Stanislavskj a
Grotowski per fare due nomi).
Non è sbagliato dunque aumentare la conoscenza della cultura teatrale contemporanea, ma –
a nostro avviso – non è l’essenziale. La nostra proposta si orienta su un diverso obiettivo: in
questi tempi e teatri è necessario che lo spettatore rifletta innanzitutto su se stesso e sul
proprio ruolo e modo di vedere-ascoltare-sentire. Fare esperienza non è vedere di più ma
vedere meglio e soprattutto vedersi dentro: lo spettatore – soprattutto quello che va a teatro –
dovrebbe recuperare la sua identità e maturare una propria responsabilità fruitiva. Dovrebbe
interrogarsi in ordine alla sua curiosità e apertura, per far crescere la sua “domanda” di teatro
prima di porsi davanti alla sovrabbondante “offerta” spettacolare. Dovrebbe riscoprire o
reinventare il suo posto e peso nel quadro della “relazione” e nel modo della “reazione” allo
spettacolo vivente – di cui fa parte, anzi controparte. Dovrebbe interrogarsi sulla sua
capacità e sensibilità di “guardare” (nel senso già spiegato) per ritornare ad essere partecipi
del fenomeno teatrale.
TUTTO QUESTO non è per tutti e tanto meno tutti sono o siamo uguali.
In teatro non valgono le leggi del mercato culturale. Il teatro da sempre produce élites e le
separa e le stratifica. Non è facile ammetterlo e magari non è conveniente, ma un genere
“minore” e “vitale” come il teatro non può - per costituzione e per dimensione - entrare nella
dimensione e costituzione della attuale “cultura di massa”.
Il teatro non è democratico, non è assimilabile al consumo né al servizio, se non nel senso che
è “aperto a tutti”, ma infine è scelto e si pone in relazione con pochi.
Pochi per volta, e pochi anche tutti insieme: il teatro non può certo competere con altri generi
spettacolari massmediatici.
Ma non si dice questo per polemica, ma al contrario per ragionevole “autocritica”. Quella
stessa che ci porta ad ammettere un’altra banale verità: non è vero che “il teatro fa bene”, non
è vero che “fa crescere”.
E’ vero però che si può trarne una educazione e perfino una elevazione culturale e perfino
spirituale, se non diamo a queste parole l’enfasi con cui si gonfiano fino a farle esplodere. E’
vero cioè che l’esperienza teatrale (anche da semplice spettatore) può essere sfruttata per un
proprio cambiamento, approfondimento, fecondazione…
A QUESTO FINE, due sono le direzioni principali della nostra proposta per alimentare la
identità e la abilità - la propria “sensibilità”, nel senso dei cinque sensi - di spettatori (di
spettatori teatrali prima di tutto, ma poi anche di osservatori, fruitori, critici di altri spettacoli e
processi e prodotti, artistici e non). Banalmente possiamo descriverle come le attività di: a)
interrogarsi; b) confrontarsi.
INTERROGARSI vuol dire riflettere sul perché e sul come andiamo a teatro, ma soprattutto su
come sappiamo fruire e quanto ci conviene (quanto cioè se ne può trarre sul piano di un
arricchimento esperienziale e –precisiamo– “organico”, cioè che attiene alla sensorialità
intelligente e alla riflessione emotiva).
INTERROGARSI ovvero “studiarsi dentro”, mentre si guardano spettacoli o altre offerte d’arte
o occasioni “per lo sguardo” che il percorso de Il Centro della Visione intende programmare, al
fine di stimolare o resuscitare sensibilità che abbiamo ma che non sempre riusciamo ad
attivare (e talvolta non consideriamo importanti).
INTERROGARSI significa innanzitutto riconoscere la quota e la qualità della nostra reazione
fruitiva all’azione scenica, a partire da quella minima e fisica, da quella “reazione” organica ed
emotiva che arriva prima della più ponderata “risposta” intellettuale e critica.
INTERROGARSI non è semplice. Bisogna infatti “sospendere il giudizio” ovvero bypassare
almeno momentaneamente la nostra valutazione, per “approfondire il gusto” come complessa
applicazione del senso. Bisogna sospendere -ancor prima del giudizio- il nostro abituale modo
di considerarsi “cliente” ricevente e non “partner” interlocutorio di una proposta artistica o di
un evento spettacolare. Senza esagerare e farsi prendere la mano o la mente da assurde
parentele o complicità: partner non vuol dire coniuge, ma soltanto e appena riconoscere che
lo spettacolo è dato da una inevitabile e spesso non gradevole “coniugazione”.
CONFRONTARSI è l’altra indispensabile e contemporanea attività del nostro percorso.
Se l’interrogazione è in fondo soltanto una nuova postura (lo spettatore che guarda se stesso),
serve un confronto con esperti e perfino con eruditi – ma anche con eventi e occasioni e
linguaggi diversi dal teatro e perfino non spettacolari – perché prenda senso e sostanza la sua
stessa interrogazione.
Il calendario de Il Centro della Visione (sempre abbinato alle attività che KILOWATT
programmerà durante il corso dell’anno – prima fra tutte il Festival) prevede sessioni di
incontro-confronto con persone o eventi utili al nostro percorso. In primo luogo e in primo
piano si tratta di confrontarsi con personaggi che abbiano uno “sguardo professionale”, a
cominciare da chi guarda l’arte o lo spettacolo “dall’altra parte”, cioè gli artisti.
E’ un confronto essenziale, ma lo abbiamo chiamato così per evitare la compiacenza e la
sudditanza di un “incontro”: ferma restando la loro evidente professionalità (e se si vuole
“superiorità”), gli attori o registi o scrittori o poeti o pittori o musicisti… che cercheremo di
invitare servono ad alimentare il tema e scavare meglio il problema dello “sguardo”. Sono da
considerare piuttosto “altri” spettatori, visto che hanno un loro modo di vedere-ascoltaresentire. Un modo che viene “prima” del loro e quindi del nostro “spettacolo”.
C’è una visione – un modo di vedere prima ancora di un mondo da inventare – che precede
l’atto scenico e l’atto artistico. C’è una visione cioè che precede e alimenta la successiva
proposta di “visione” per lo spettatore.
Non è vero che siamo tutti artisti, ma è vero che siamo tutti spettatori (anche e soprattutto gli
artisti): quelli che fanno o danno spettacolo hanno dunque – o dovrebbero avere – esperienze
di veduta e di visione che danno origine e forza al loro lavoro.
Chi “mette in scena” (o in pellicola o in pagina…) infine “mette in visione” per altri.
Soprattutto se è artista di teatro, dovrebbe essere consapevole di proporre una causa che
attivi l’effetto della “visione” degli spettatori: e non solo la veduta di quello che in effetti è
mostrato (o filmato o dipinto o scritto…) ma la visione di quello che non si vede, a cui tende
l’opera o verso cui scommette l’artista.
QUESTO CONFRONTO FRA VISIONI è la più importante alimentazione e riflessione che Il
Centro della Visione intende proporre.
Quindi questo genere di “confronti” non avverrà soltanto con artisti, ma anche con studiosi,
operatori, critici… Non in quanto eruditi ma in quanto esperti, cioè più consapevoli e
responsabili del proprio sguardo o studio.
Questi incontri - per così dire “teorici” - serviranno certo ad ampliare i nostri saperi ma
soprattutto a relativizzare quello che già sappiamo e proviamo. Servono anche a proporre dei
problemi e attivare delle discussioni fra spettatori di diverse arti, fra spettatori di diverse
epoche o realtà.
Si può fare qualche esempio, in previsione di un definitivo programma:
a) conferenze di storia su “come guardavano” il loro teatro gli antichi romani (Savarese),
durante il medioevo (Guarino) nel periodo barocco (Filippi), nell’Ottocento (Guccini).
b) dibattiti sulle problematiche relative al pubblico di oggi da parte di direttori di festival, di
organizzatori teatrali, di critici professionisti, anche per cogliere meglio verso dove va la
proposta del teatro attuale, in quale cultura e società dell’oggi e del domani si colloca, come
dipende o riflette sulla crisi culturale che è evidente nel nostro tempo e mondo.
c) aperture verso campi e mestieri diversi e certamente divisi ma coniugati all’arte e allo
spettacolo (racconti ed esperienze di educatori e ricercatori ma magari anche sacerdoti,
genitori, ecc.).
d) incontri fra di noi e per noi stessi: brevi temi da fare e occasioni seminariali in cui proporsi
come relatori e quindi esporsi come alimentatori della nostra stessa ricerca del “centro della
visione”. Non per esibirsi ma per confrontarsi, una volta che ciascuno di noi crede di aver
trovato un tema sul quale intende riflettere e proporre per primo la propria “lezione”. Intanto
un primo “tema” per tutti e da subito lo proponiamo noi, in forma di compito per le vacanze di
natale per tutti, sul proprio “Natale dello sguardo” (VEDI ALLEGATO).
6. UN “FINE” PER IL CENTRO DELLA VISIONE
Infine resta da spiegare la struttura del nostro percorso sullo “sguardo”, ovvero come darsi un
fine e come sfruttare un mezzo che – nel concreto – diano organizzazione e ordine al nostro
Centro della Visione.
In sintesi ci si propone di orientare le Interrogazioni e i Confronti con artisti ed esperti in
modo da sottolineare e sondare tre livelli diversi dello sguardo, che banalmente ma con una
certa presunzione di esattezza si possono intitolare: 1. A PRIMA VISTA; 2. A GUARDAR BENE;
L’ULTIMO SGUARDO.
Queste tre frasi non sempre potranno essere corrispondenti alle tre fasi del primo, secondo e
terzo anno de Il Centro della Visione, ma nella nostra intenzione e attenzione vorrebbero
caratterizzarle in maniera prevalente.
In sintesi, si tratta di accentuare:
1. l’abilità di cogliere e fabbricare visioni per così dire immediate (molti artisti lavorano su
questo livello intuitivo in cui si vede il talento ma anche la prima fase di un processo della
visione);
2. la capacità di penetrare e riflettere e selezionare in profondità (la fase della costruzione e
della narrazione e infine della rappresentazione);
3. l’esigenza di un superamento e perfino di un testamento, un Vorrei Vedere che spesso tocca,
se non l’invisibile, il desiderabile (la fase dell’effetto da dare, della sensazione da suscitare, del
“non so che” che si vorrebbe almeno indicare se non sfiorare).
Possiamo fare qualche esempio, accennando a due artisti che abbiamo già invitato per alcune prossime
sessioni, Pippo Delbono come regista e autore di teatro e di cinema e Mariangela Gualtieri come
poetessa ma anche attrice dei suoi stessi versi. Chi già conosce i film di Pippo Delbono o le poesie di
Mariangela Gualtieri sa che dipendono molto da una loro intuitiva e straordinaria “prima vista”; ma
poi, il lavoro di costruzione delle loro opere avviene sulla base e con una fase di elaborazione più
attenta e successiva di quando si deve e si riesce a “guardar bene”; infine, l’effetto o la sensazione che
si vuole toccare o che si riesce a indicare, quando l’opera funziona, deve avere la forza e il fascino di un
“ultimo sguardo”, uno sguardo che non vede o uno sguardo che ci guarda.
Cosa si cerca di vedere o di “dare a vedere” nell’arte se non qualcosa che non c’è e che però si
sente? Da una poesia di san Juan de la Cruz mi permetto di citare un verso che è anche un
ripetuto refrain: “Por toda la hermosura nunca yo me perdere, si no por un no so que, que se
alcanza por ventura...”. Traduco: “Per tutta la bellezza io non mi perderò mai, se non per un
‘non so che’ che si coglie per ventura…”
Il fine del nostro percorso non è certo raggiungere questo vertice, ma ricordarsi della sua
esistenza e della sua ricerca. Come dire che ‘il fine dello sguardo’ o anche ‘il centro della
visione’ è indubbiamente una verticalità, cioè una profondità e al contempo una elevazione
verso un punto che superi lo sguardo e perfino annichilisca lo spettatore.
Si potrebbe dire “qualcosa che si sente” ma che sta fuori dei sensi, ovvero qualcosa che supera
il “piacere” e diventa una “festa”.
A questa festa in realtà non ci si arriva quasi mai né da attori né da spettatori, ma arrivarci
non è poi indispensabile.
Molti attori non ci provano o molti spettatori non ci tendono più? Forse perché i primi non ci
arrivano o perché i secondi vi rinunciano.
Molti – attori o spettatori – negano che questa ansia e aspirazione verticale esista o resista
dentro di loro? Forse – o senza forse – perché mentono perfino a se stessi.
Quello che si vuole dire però è che il fine irraggiungibile disegna una direzione. E che intanto
tiene in piedi e dà senso al “mezzo”. E se la festa è un fine il mezzo è davvero il piacere, e non è
poco.
Insomma, a teatro e non solo a teatro, il piacere del gioco cioè il ludus è un mezzo e non un
fine. Non si vuole con questo abbassarlo ma al contrario nobilitarlo. Il “mezzo” infatti non è
solo uno strumento, ma tutto quello “che sta in mezzo” e che si attraversa o si esperisce come
“godimento”. Ma se eliminiamo il fine, il mezzo diventa “fine a se stesso” e – come si capisce
bene – non sta più in piedi.
Forse il fine – nel senso dell’obiettivo ragionevole e concreto – di un percorso come Il Centro
della Visione, è allora proprio quello di dare sostegno e senso al “mezzo”. Se però – togliendo il
fine – non vogliamo più che questo aleatorio e raro “piacere” dello sguardo e del gioco non si
ispiri a un più alto fine, allora perché tormentarsi? Perché venire qui a interrogarsi e
confrontarsi sul Centro della Visione?
In fondo gli stessi artisti o le stesse occasioni che qui vi proporremo, non sono infine che
conferenze, spettacoli, occasioni di consumo che sono reperibili nel mercato e consumabili
ovunque.
Se quindi alle nostre sessioni non ci si aggiunge un metodo e un merito basato su una
personale voglia di cambiare e di studiare se stessi come spettatori… Se al programma del
Centro della Visione ciascuno non aggiunge la propria personale ansia di ricerca e di
conoscenza, non c’è nessuno che possa dare valore e senso a una esperienza che di ridurrà a
semplice e occasionale “consumo”.
UNA NOTA SUL CONSUMO E SUL MERCATO
Noi tutti non possiamo negare di essere abitanti e perfino residenti di un “mercato”.
Noi stessi che siamo qui a proporvi un viaggio verso il Centro della Visione, non possiamo dire
di non essere interni e perfino corrotti dal mercato.
Infine, ne adopriamo il linguaggio e orientiamo le proposte come si fa nel mercato: il prezzo
da pagare, il tempo da spendere, gli spettacoli che programmiamo, le offerte che proponiamo,
gli incontri che organizziamo… ma di più, il linguaggio pubblicitario, il lavoro degli
organizzatori, la funzione dell’ufficio stampa e infine questa stessa lunghissima conferenza è
un’altra ennesima cosa da consumare…
Dal punto di vista e di acquisto del mercato, anche il Centro della Visione non fa che
aumentare le cose da vedere, ma non è questo il vero obiettivo dello studio ovvero del nostro
desiderio. Al contrario – con la vostra complicità e il vostro impegno – l’esito che vorremmo
dare a questo progetto de IL CENTRO DELLA VISIONE è vedere di meno ma vedere meglio. E
“criticare” di più. E’ cercare il centro e riflettere sulla visione in modo da armare una
scontentezza e non una pienezza.
Cercare “altro” non vuol dire accumulare dell’altro ancora, ma criticare l’uno, cioè le nostre
abitudini e le nostre compiacenze.
L’apertura e l’interesse è una postura necessaria ma non significa che dobbiamo approvare
tutti e ammirare tutto. Al contrario, ciascuno dovrebbe concentrarsi e svilupparsi – a modo
suo – nel “centro” della visione. Diventare meno disponibile: costruire delle domande anziché
abbandonarsi a tutte le offerte. Guardare di meno e però cercare di vedere l’invisibile: la
visione verso cui ognuno tende, a dispetto dell’enorme instancabile e sovrabbondante mercato
delle vedute…
La visione trova sempre meno spazio e meno possibilità se si è in presenza di troppe
immagini e di eccessive esperienze ordinarie della vista.
L’ECCEZIONALITA’ E LA RELAZIONALITA’ sono le coordinate che il teatro propone, ed è per
questo che il teatro sarà privilegiato dal nostro percorso. Anche davanti a uno scadente lavoro
e un brutto spettacolo, cercare l’eccezione e approfondire – in quel caso ma solo in quel caso –
la relazione, è il compito dello spettatore.
Non diamo però a questa eccezione un valore “eccezionale”: l’eccezione non è
necessariamente un vertice innegabile, ma viaggia e la si incontra anche dentro una
artigianale onestà e una dignitosa mediocrità.
Saper estrarre l’eccezione e quindi applicare la regola della relazione è il “fine” dello
spettatore, che lo sappia o no, che lo voglia o no.
Saper attendere di vedere, coniugare il ruolo dello spettatore con il regalo dell’Aspettatore è il
suo mezzo, la sua regola, il suo regalo. Ma non per questo il regalo va dato comunque e a
chiunque…
Una volta Ugo Volli disse a un gruppo teatrale fatto di tutti suoi amici che ci tenevano che lui
fosse presente alla loro “prima”, gli rispose: “State attenti prima di chiamarmi, mi fate
spendere e quindi perdere due ore del mio tempo, della mia vita… “
Questa minaccia, questa esigenza, dovrebbe nascere in ciascuno di noi…
Siamo qui per apprendere non la capacità critica ma la sana crudeltà dello spettatore. Il suo
teatro della crudeltà.