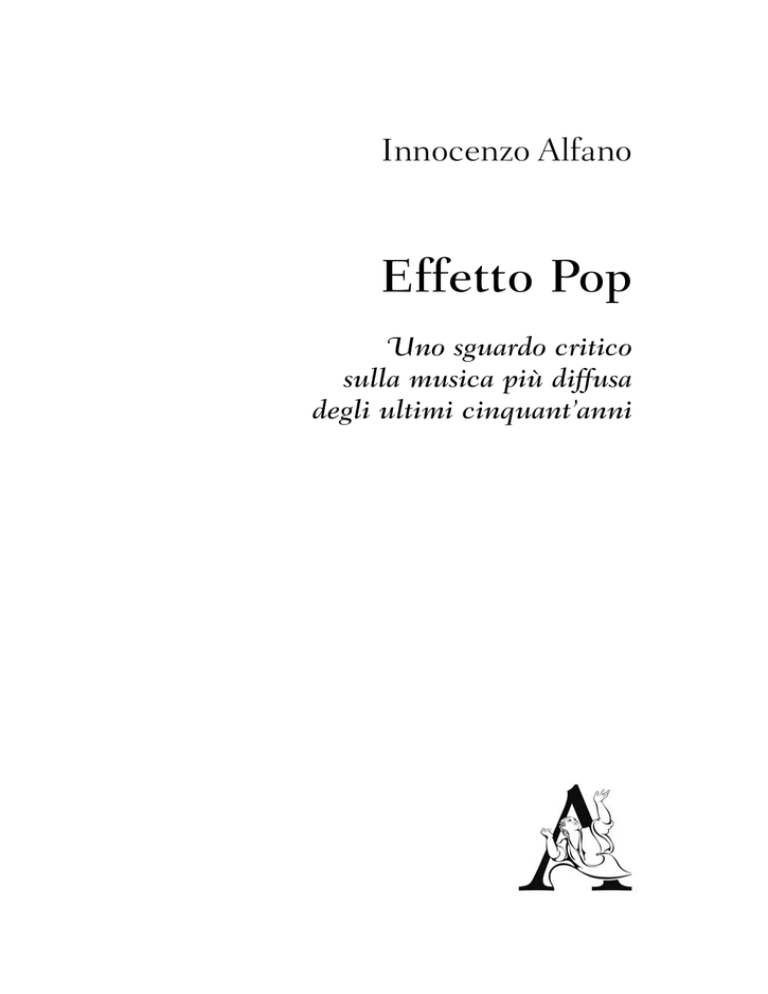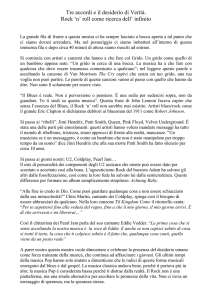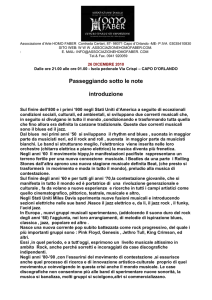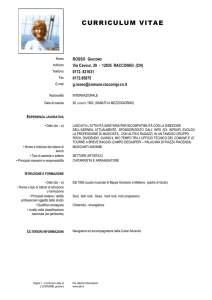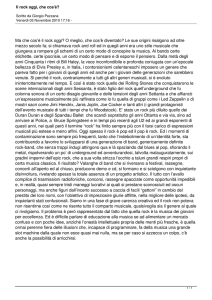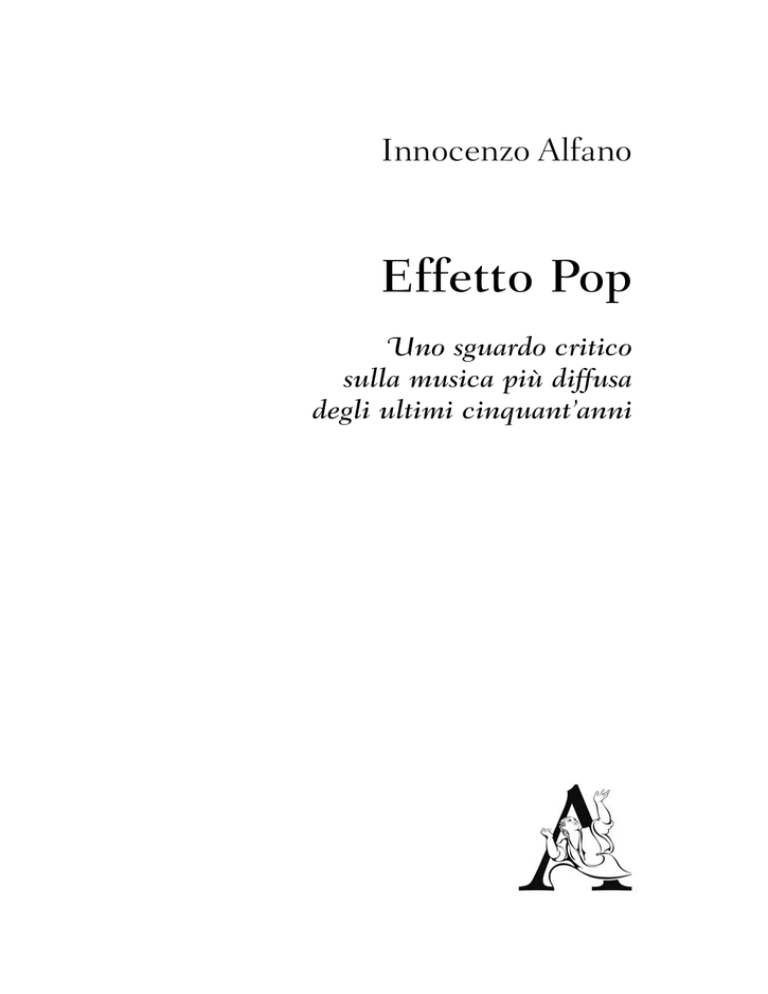
Innocenzo Alfano
Effetto Pop
Uno sguardo critico
sulla musica più diffusa
degli ultimi cinquant’anni
Copyright © MMVIII
ARACNE editrice S.r.l.
www.aracneeditrice.it
[email protected]
via Raffaele Garofalo, 133 A/B
00173 Roma
(06) 93781065
ISBN
978–88–548–2233–7
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: dicembre 2008
Indice
9. Introduzione
15. Ai piedi del Colosseo… britannico
23. L’ideologia (perversa) dell’ascolto musicale
29. Santana: non solo Carlos
37. Die Mensch Maschine? Nein, danke. Due parole
sulla “ricerca” musicale
51. Lucio Battisti regala emozioni, e la musica pop
in Italia cambia volto
83. Diritti, e doveri, d’autore
91. Il mondo meccanico degli Spirit parte prima
99. Non ne avete ancora avuto abbastanza? Impressioni di un
concerto estivo dei New Trolls
107. Looking back there's nothing I regret. La musica
dei Family nella casa delle bambole
121. Era solo una questione di gusti (racconto breve)
131. Tutta la “verità” su Jeff Beck
137. Lo strano caso del rock progressivo
145. Il mondo meccanico degli Spirit parte seconda
7
Indice
8
153. Provaci ancora, Keith! Splendori (pochi) e miserie (tante)
nella musica dei Rolling Stones
221. Sì ma che strumento suoni? Musica e informazione
nell’epoca dei “divi”
229. “The Velvet Underground & Nico”: capolavoro mancato
della musica rock
251. 1968 e dintorni: tra musica e rivolta negli Stati
Uniti d’America. A proposito d(e)i Chicago
263. Il principio della variazione nella musica rock: i Beatles
“rivoluzionari” e il Sergente Pepper
Appendice: Non solo pop
279. Trionovo, una bella realtà musicale in Calabria
283. Dal rock alla classica: la musica dei Genesis rivista
in versione da camera
287. Viaggio nel mondo della chitarra battente
Introduzione
Dagli anni ’60 del secolo scorso, e fino ad oggi, sono stati scritti
molti libri sulla musica pop e rock. Il taglio che di solito si è dato, e si
continua ancora a dare, a quel genere di pubblicazioni – perlomeno in
Italia – è di carattere celebrativo quando non addirittura apologetico,
ed in molti casi si giunge ad imbarazzanti (ma, evidentemente, non dal
punto di vista di chi scrive quei libri) fenomeni di vero e proprio culto
della personalità nei confronti di interi gruppi o di singoli musicisti,
oppure di entrambi. Raramente si parla però, in quei testi, di musica in
senso stretto, cioè di quello che succede da un punto di vista squisitamente sonoro nelle tantissime incisioni discografiche che ogni autore
cita quasi a memoria dimostrando di conoscere alla perfezione, e soprattutto di preferire, dati come il colore delle etichette, i codici alfanumerici stampati sui dischi e il formato delle copertine piuttosto che
il materiale musicale inciso sui vinili o masterizzato nei compact disc.
Il problema, in ogni caso, è che in quei libri di musica non si parla di
musica non perché gli autori decidano volontariamente di privilegiare
quella strada potendo scegliere tra due diversi approcci, ma perché,
come disse una volta Ottavio Cecchi, «si sa bene che nel paese del
melodramma, nessuno sa la musica. Si va a orecchio, si canticchia, ci
si gloria di avere un passato in cui abbondano le grandi firme dei musicisti».1 Cecchi diceva queste cose trent’anni fa, ma la situazione non
è affatto cambiata nel lasso di tempo che separa quelle sue frasi da ciò
che succede al giorno d’oggi. Anzi, probabilmente è peggiorata.
Il grande problema della musica pop e/o rock, ma forse sarebbe più
corretto definirlo il suo dramma, è dunque quello dell’ignoranza musicale (altri qui userebbero il termine “incompetenza”, io però preferisco essere più preciso ed usare, quindi, il termine esatto). Una ignoranza pressoché totale mostrata sia da quelli che si limitano soltanto
ad ascoltarla, dal vivo o su disco, sia dalla maggioranza dei musicisti
che incidono canzoni e tengono concerti. Il rock ed il pop sono stati, e
continuano ad esserlo, un grandissimo affare, una vera e propria man1
Cfr. Ottavio Cecchi, Mahler e la Vanoni, in «Rinascita», Settimanale fondato da Palmiro
Togliatti, n. 28 – anno 35, 14 luglio 1978, p. 18.
9
10
Introduzione
na caduta dal cielo, per l’industria discografica e per una parte dei
numerosi musicisti aggregati ad essa, ma per la cultura musicale intesa
nel senso più profondo e nobile dell’espressione si è trattato di una
tragedia di proporzioni colossali, una sorta di irrazionale regressione
ad uno stadio infantile dell’arte dei suoni come, credo, mai prima se
ne era vista una. Un tempo, prima che l’industria si impossessasse (anche) della musica, chi praticava quest’arte, sia pure ad un livello
amatoriale, con ogni probabilità possedeva almeno qualche nozione
teorica di base della disciplina con cui aveva deciso di cimentarsi, ed
in ogni caso anche chi suonava semplicemente “ad orecchio” si sforzava sempre di farlo meglio che poteva, cercando nel contempo di
emulare, e se possibile superare, quelli considerati più bravi, i quali
erano bravi non perché l’avesse detto qualche critico “specializzato”,
ma perché tutti capivano la differenza tra uno capace di suonare correttamente uno strumenrto musicale ed uno che invece quelle capacità
non le aveva (di quest’ultimo fenomeno, ed in particolare della volontà di suonare uno strumento musicale nel modo più corretto possibile,
sono stato testimone frequentando, e qualche volta suonando insieme
a loro, negli anni Ottanta e Novanta, i vecchi suonatori di mandolino
non professionisti ancora in attività nella provincia di Cosenza, dove
sono nato e dove ho avuto la fortuna di imparare la musica, ed il piacere di praticarla, suonando il clarinetto nella Banda Musicale “San
Leone” di Saracena).
Ora non più: si suona (nel pop e nel rock) per avere “successo”,
senza preoccuparsi più di tanto, e il più delle volte senza preoccuparsene affatto, di sapere se quello che si sta facendo è fatto bene oppure
no, badando cioè, come si suol dire, più all’immagine che alla sostanza. Per una verifica di queste mie affermazioni basterebbe chiedere ad
uno qualsiasi dei musicisti pop e rock, compresi quelli che partecipano
al Festival di Sanremo (non esclusi i vincitori), che cosa sia un accordo di Do maggiore, perché si chiami così e che relazione c’è, e qual è
la differenza, tra questo accordo ed il suo relativo minore La. Problemi e questioni da 1ª elementare (se esistesse) di una qualunque scuola
di musica, ma che nel mondo piuttosto distratto del pop e del rock,
con l’eccezione del cosiddetto “rock progressivo”, vengono del tutto
ignorati, con il risultato che i musicisti rock più famosi e ricchi del
mondo non riescono in genere ad andare oltre, per tutta la loro vita, un
Introduzione
11
modo di suonare superficiale, pieno di errori quando decidono di avventurarsi nei territori ingarbugliati delle parti solistiche, nonché livellato sempre più verso il basso. In compenso, quando va bene, riescono
a diventare ricchi e famosi in pochi anni o addirittura in pochi mesi,
ma senza sapere, in fondo, il perché.
In questo volume, volendo dare un taglio un po’ diverso, diciamo
pure originale, ad un libro che parla di musica pop e rock, e dopo aver
già pubblicato due testi nei quali mi ero a suo tempo dedicato quasi
esclusivamente all’analisi armonica e comparativa di un certo numero
di brani degli anni ’60 e ’70, ho raccolto una ventina fra saggi ed articoli – ma c’è pure un breve racconto nel quale la musica viene “raccontata” da due personaggi e una voce narrante – nei quali il fenomeno della musica pop viene analizzato da varie angolazioni: analitiche,
storiche, sociologiche, giornalistiche e politiche, il tutto secondo un
taglio prevalentemente critico (uno dei capitoli del libro affronta il tema della musica pop solo incidentalmente, trattandosi di una riflessione sulla musica classica contemporanea, mentre un altro, un saggio
che contiene argomentazioni musicali analitiche e ben due esempi su
pentagramma, è stato diviso in due parti esatte per rendere meno pesante la sua lettura “tutta d’un fiato” a chi ama la musica ma non la
conosce). In fondo al volume il lettore troverà anche, nella sezione
chiamata “Non solo pop”, tre articoli che hanno in apparenza poco o
nulla a che fare con la musica oggetto del titolo di questo libro. In realtà due di essi hanno con il pop diversi legami, più o meno (in)diretti,
e questa è la ragione per cui sono lì. Il terzo invece, un breve articolo
sulla chitarra battente, è in effetti completamente avulso dal contesto e
dagli argomenti scelti per questa pubblicazione, pur essendo un testo –
per metà recensione di un libro e per metà commento di un concerto –
nel quale la materia affrontata è, ad ogni buon conto, quella musicale.
Ma, se con il pop ed il rock non c’entra nulla, perché quell’articolo si
trova dentro il volume? Beh, ho deciso di inserirlo nel libro per due
ragioni. La prima è che a furia di chitarre elettriche distorte e sintetizzatori, in Italia stiamo correndo seriamente il rischio di smarrire qualunque riferimento alle nostre ricche tradizioni musicali autoctone,
molte delle quali appartenenti al mondo e alla civiltà (ex) contadine,
finendo col perdere, insieme ad esse, anche l’identità ed il senso di
appartenenza di ciascuno di noi ad un popolo, ad una regione o, più
12
Introduzione
semplicemente, ad una comunità. La seconda ragione è che, nel mio
caso, le tradizioni e l’identità da difendere, pena la loro scomparsa e la
sostituzione con pericolosi fenomeni di solitudine sociale, purtroppo
così tipici del nostro tempo, sono quelli del Sud dell’Italia e in particolare della Calabria, la mia terra d’origine (da molti anni, però, vivo in
Toscana), una regione dove la pratica della chitarra battente ha una
lunga storia ed un repertorio assai vasto.
All’epoca in cui pubblicai gli altri miei due libri di musica, ossia tra
il 2004 e il 2006, gli amici e tutti quelli che mi dicevano di aver letto
le riflessioni di carattere musicale da me raccolte in quei due volumetti, mi confidavano che, appena comparivano esempi musicali nel corso della lettura, gli stessi venivano puntualmente saltati. Onestamente
non so come abbiano fatto, i miei amici e gli altri, a leggere il resto, e
soprattutto che cosa abbiano alla fine letto, visto che entrambi i libri
sono pieni di esempi musicali: 15 nel primo, intitolato Il caso del rock
progressivo, e 30 nel secondo, Verso un’altra realtà, e tutti e 45 con
relativo, più o meno lungo, commento. Il fatto è che, secondo me,
scrivere libri di musica senza fare uso della notazione musicale, o almeno senza fare mai riferimento a questioni come l’armonia, il ritmo,
gli intervalli, le altezze dei suoni, il tempo, ecc., sarebbe come scrivere
libri di matematica in cui non compaiono mai dei numeri o libri di storia in cui non ci sono date. In pratica un controsenso bell’e buono.
Purtroppo devo però dire che questa spiacevole contraddizione rappresenta più o meno la regola anche nei corsi di musica pop e rock attivati nelle università italiane, dove, in base alla mia esperienza diretta, ho
potuto constatare, con dispiacere, come si preferisca dare a questa disciplina un taglio prevalentemente sociologico, evitando perciò di
scendere nei dettagli e tra le pieghe delle partiture, in particolare di
quelle più complesse (partiture virtuali, s’intende, perché nel rock, a
parte rarissime eccezioni, non ci sono partiture, e le stesse, se si desidera averle, vanno costruite da zero a posteriori attraverso le trascrizioni ricavate dall’ascolto dei dischi), con il risultato che quei corsi si
trasformano molto facilmente in luoghi di ritrovo non per studiosi di
musica ma per fans della musica, in questo caso della musica rock. Ed
allora ecco che a lezione capita di conoscere, come mi è in effetti capitato, il patito di Elvis Presley e del rock’n’roll delle origini,
l’adoratrice della cantante Mariah Carey, il nostalgico dei Pink Floyd
Introduzione
13
e degli anni ’70, e così via. Tutte persone normali, s’intende, e pure
simpatiche, ma non molto interessate agli aspetti analitici presenti nella musica che loro amano (e che probabilmente non sarebbero, in base
a quello che si è detto finora, neppure in grado di comprendere). Aspetti dei quali, in ogni caso, ben difficilmente si parla a lezione. Comunque, ora il peso degli esempi, nel caso di questo mio terzo libro
dedicato all’arte dei suoni, è drasticamente diminuito: non più decine
ma soltanto due, cosicché chiunque deciderà di dare un’occhiata al
contenuto di Effetto Pop non sarà costretto a leggerlo, diciamo così,
saltellando.
Il titolo che ho scelto per questo libro non ha un significato particolare, anche se, visti gli argomenti trattati, e soprattutto il modo in cui
tali argomenti sono stati affrontati, rende bene l’idea che avevo in
mente quando ho iniziato a mettere nero su bianco alcune mie personali riflessioni attorno al fenomeno della musica pop e rock, iniziando
col pubblicarle dapprima su riviste che hanno ospitato quegli articoli,
e in seguito pensando di ampliarle e di raccogliere tutto il materiale,
sia quello edito sia quello – la maggior parte – inedito, in un unico volume. Tra le riviste che hanno accolto i miei scritti vorrei qui ricordarne almeno due, quelle a cui mi sento più legato. Si tratta di «Contrappunti», Quaderno trimestrale del Centro Studi per il Progressive Italiano, con sede a Genova, animata dallo scrittore e saggista Riccardo
Storti, e «Apollinea», Rivista bimestrale di arte, cultura, ambiente, turismo, attualità, del territorio del Parco Nazionale del Pollino, con sede a Castrovillari, in provincia di Cosenza, diretta da Pietro Napoletano, scrittore, poeta e profondo studioso della lingua Arbëresh, la lingua degli albanesi sbarcati nella penisola italiana (in particolare in Calabria), e qui stabilitisi, dopo che il loro territorio venne invaso dai
turchi nel corso del XVI secolo.
Tornando al titolo del libro devo comunque dire che la scelta è caduta un bel giorno su Effetto Pop perché, oltre ad essere un titolo adeguato agli obiettivi del volume, richiamava in me la figura del compianto professor Carlo Alberto Madrignani, docente di Letteratura italiana presso l’Università degli Studi di Pisa. Con Madrignani, scomparso il 6 maggio 2008, avevo sostenuto il mio primo ed unico esame
di Letteratura italiana all’università, all’inizio degli anni 2000, dopo
aver seguito, da ottobre a maggio, l’intero suo corso, a quel tempo an-
14
Introduzione
cora annuale. Pur non avendolo conosciuto a fondo, conservo di lui un
piacevole ricordo, come professore e come uomo. Del professor Madrignani esiste una raccolta di saggi intitolata Effetto Sicilia: è il titolo
di quel volume che ha ispirato il titolo del mio.
Ma la dedica più sentita che vorrei fare, per questo libro, è al mio
caro amico Peppe Diana, di Saracena, che purtroppo non c’è più. Peppe era una persona sensibile ed un ragazzo cordiale con tutti, sempre
pronto alla battuta di spirito, mai pessimista e pieno di vita come pochi altri da me conosciuti. Amava, come il padre Leone, un eccellente
mandolinista, la buona musica, ed era egli stesso un ottimo musicista.
Gli piacevano Johann Sebastian Bach e i Genesis, e al pianoforte di
casa sua, e qualche volta anche nel corso di qualcuno dei suoi tanti ed
indimenticabili piano-bar estivi, cercava, con buoni risultati, di riprodurli entrambi, nei suoi anni migliori. Poi il tunnel nel quale era entrato fin da giovane, dapprima in modo spensierato ma poi con sempre
maggiore consapevolezza, ha cominciato a consumarlo, lentamente,
fino a che un giorno di maggio del 2008 è giunto al termine di quel
tunnel, ritrovando però non la luce bensì soltanto, e per sempre, le tenebre. Aveva 46 anni e mi mancherà.
P.S. Tra le dediche implicite di questo libro c’è quella ai miei genitori, che, anche quando non sono nominati direttamente, nel mio cuore
occupano sempre lo spazio più grande.
Ai piedi del Colosseo… britannico
«Una volta completato l’album abbiamo convocato i due ragazzi
della crew, preso le casse amplificate da 100 watt e, sistemato tutto
quanto su due piccoli furgoni, ci siamo imbarcati su di una nave che
salpava in direzione dell’Europa continentale, per un tour nel corso
del quale abbiamo spesso suonato al cospetto di gente piuttosto
perplessa…». Con queste simpatiche parole, riportate all’interno della
copertina di una non recentissima edizione in cd di quell’album (Castle ESMCD 643, del 1998), Jon Hiseman racconta brevemente, e con
affetto, le vicissitudini che fecero da contorno alla pubblicazione del
primo, storico 33 giri degli inglesi Colosseum, avvenuta nel mese di
marzo del 1969. “Those Who Are About To Die Salute You – Morituri Te Salutant”, questo il titolo scelto per la confezione del loro vinile
d’esordio dai cinque musicisti di un gruppo che presto sarebbe stato
da molti indicato come l’inventore, o tra gli inventori, del cosiddetto
jazz-rock. Caspita!, verrebbe da dire. Eh sì, perché essere considerati
inventori di qualcosa che poi dura nel tempo, suscitando l’interesse di
un numero sempre maggiore di persone, è senz’altro un fatto eccezionale e che non può che riempire d’orgoglio i soggetti protagonisti della scoperta o invenzione. Tuttavia, e qui sta il vero problema, di solito
è estremamente difficile stabilire, in particolare nell’arte, se uno ha, un
bel giorno, davvero inventato qualcosa di cui fino a quel momento non
esisteva traccia alcuna. Le cose, come sappiamo, stanno quasi sempre
in modo un po’ diverso, tanto che lo stesso Hiseman, nelle medesime
note di copertina, aggiunge, con tipico buon senso albionico, che secondo lui i Colosseum, per quanto coraggiosi ed originali, non hanno
inventato proprio alcunché, ma hanno invece avuto la straordinaria
fortuna di trovarsi «nel posto giusto al momento giusto e con le orecchie ben spalancate».
Il batterista Jon Hiseman è stato (e lo è ancora), senza ombra di
dubbio, il leader di quel complesso: quello che scriveva i commenti
all’interno delle copertine dei dischi e quello che contribuiva, forse
più degli altri, a plasmare l’immagine esterna del gruppo, attraverso
15
16
Effetto Pop
uno stile musicale vigoroso e sempre incline al virtuosismo (la doppia
grancassa del suo kit di tamburi è forse l’aspetto più appariscente del
proprio status di batterista leader). L’epoca dei batteristi rock anonimi,
grazie a personaggi come Hiseman e altri della sua stessa generazione,
si avviava, dunque, rapidamente al tramonto.
Nell’estate del 1968 Jon Hiseman si trova a Roma per una vacanza
e, all’ombra del Colosseo, decide di lasciare la formazione di John
Mayall nella quale ha militato per circa sei mesi e con cui ha da poco
inciso il pregevole 33 giri “Bare Wires” (Decca SKL 4945). Con Mayall sono, in quel periodo, anche il sassofonista Dick Heckstall-Smith
ed il bassista Tony Reeves, i quali, allettati dalla proposta di Hiseman
di formare un nuovo gruppo, accettano di seguirlo nell’avventura abbandonando l’armonicista di Manchester. Un vecchio compagno
d’infanzia di Hiseman e di Reeves, Dave Greenslade, viene reclutato
poco tempo dopo affinché si occupi delle parti di tastiera (organo
Hammond e piano). La band a questo punto è già costituita: un quartetto in cui l’amore per il jazz e per il rhythm’n’blues dovrà essere aggiornato, nelle intenzioni di chi ne fa parte, tenendo conto della nuova
ed eccitante moda rappresentata dal rock, visto, quest’ultimo, come ottimo collante e come sicuro veicolo per una musica che si desidera robusta, coinvolgente e, soprattutto, ben eseguita. Ma nel rock del 1968,
lo sappiamo, un chitarrista era (quasi) d’obbligo, e così, dopo alcune
settimane di ricerche, il valido James Litherland viene scelto per unirsi
agli altri quattro, con il compito aggiuntivo di badare anche alla quasi
totalità delle parti vocali. Ora i Colosseum possono cominciare davvero a fare sul serio.
I mesi invernali a cavallo tra 1968 e 1969 sono mesi di intenso ed
attento lavorio, nonché di ricerca di quella sintesi sonora tra jazz,
blues e rock così spasmodicamente anelata dai cinque musicisti britannici di cui ci stiamo occupando in queste pagine. Tra concerti tenuti
presso il noto Marquee Club di Wardour Street, e radio sessions per la
BBC, pian piano vengono fuori gli otto pezzi che, con l’approssimarsi
della primavera, vedranno la luce in formato ellepì per la gioia dei
(non tantissimi) fans di quel quintetto. Prima però viene anche pubblicato un 45 giri, l’unico in quattro anni esatti di attività, passato quasi
inosservato eppure contenente due dei migliori brani registrati dai Co-
Ai piedi del Colosseo… britannico
17
losseum nel corso della loro breve ma interessantissima carriera: Walking In The Park e Those About To Die (Fontana TF 1029). L’ellepì,
di lì a poco, farà decisamente meglio con un lusinghiero 15esimo posto nelle charts d’oltremanica. I due brani, pubblicati come facciata A
e B del medesimo singolo, vengono sistemati sul long playing in apertura e chiusura dei rispettivi lati, quasi a voler suggerire, a chi ascolta
il disco, che i Colosseum incarnano esattamente quella musica, e che
tutto ciò che vi sta in mezzo altro non può essere se non una sintesi, a
volte un po’ più sofisticata del lecito, di quei due estremi. Fa anche
una certa impressione, ascoltando i due pezzi del 45 giri, notare come
i Colosseum abbiano puntato all’inizio della loro avventura musicale
non su brani da classifica, evento normalissimo e quasi ovvio per quel
tipo di formato, ma su due composizioni brillanti e di eguale livello
qualitativo, di cui la seconda addirittura pirotecnica.
Walking In The Park è dunque il biglietto da visita dei Colosseum,
che si presentano sul grande palcoscenico del rock, di quello che conta, nientemeno che con una cover, incisa come lato A di un 45 giri e
proposta come primo brano della facciata A del long playing
d’esordio! Incoscienza? Niente affatto, perché i Colosseum, che sono
un gruppo formato da ottimi musicisti, sono bravi nel trasformare un
gentile rhythm’n’blues della Graham Bond Organization di alcuni anni prima (1965), in un brano d’assalto, adatto al clima teso e anche un
po’ perverso del rock fine anni Sessanta. La tonalità, che è Sol maggiore, non viene in ogni caso cambiata rispetto alla versione originale
del pezzo, e neppure l’alternanza tra questa e l’unico altro accordo
presente nei quasi quattro minuti di musica del brano, cioè Do maggiore (quarto grado della scala di partenza). Dick Heckstall-Smith, che
aveva tra l’altro lavorato con Graham Bond, non vuole spazio per sé
in questa nuova versione della “passeggiata nel parco”, limitandosi ad
eseguire, assieme all’organo di Greenslade e al basso di Reeves,
l’inciso discendente iniziale, che viene reiterato così tante volte da non
poter essere rimosso tanto facilmente dalla memoria dell’ascoltatore.
E neppure all’organo viene affidato l’assolo di rito, così come ascoltato invece quattro anni prima nel 33 giri “There’s A Bond Between Us”
(Columbia SX 1750), ma guarda caso proprio all’ultimo arrivato, e
cioè il chitarrista James Litherland, che per l’occasione sfodera una se-
18
Effetto Pop
rie di incisivi effetti wah-wah degni dei migliori sperimentatori del periodo con la sei corde elettrica (Jeff Beck, Jimi Hendrix, Eric Clapton). Visto che si tratta di una grande cover, per il finale non si usa la
dissolvenza come nell’ellepì di Bond ma una chiusura con tutti i crismi della solennità. Naturalmente blues.
Plenty Hard Luck è, come recita la didascalia posta sotto il titolo
del brano, nient’altro che «A Blues that just appeared one afternoon».
Mah, sarà anche un blues venuto fuori per caso un pomeriggio del
1968 o del 1969, ma intanto si osservi quella “b” di blues che diventa
maiuscola nel titolo, e si intuirà subito che, sì, di blues si tratta, ma,
per l’appunto con la “B”. L’introduzione con dissolvenza in entrata è
già una bella sorpresa, perché di solito i brani rock di quattro minuti e
mezzo non sono così imprevedibili fin dallo start, e ancora meno lo
sono i blues. Come elementi melodici da proporre all’ascoltatore ci
sono poi nuovamente degli incisi discendenti, il primo dei quali, di
cinque note, eseguito dal sax tenore sulla seguente successione armonica: Fa maggiore, Mi bemolle maggiore, Re bemolle maggiore, Si
bemolle maggiore, Fa maggiore (note: la-sol-fa-re-fa). Questa volta
però sono l’organo Hammond prima e il sax dopo a disegnare gli assolo della composizione, il primo in un’atmosfera piuttosto rilassata,
mentre il secondo, quando tocca ad Heckstall-Smith dire la sua, in un
contesto via via sempre più teso e nervoso. Qui è possibile osservare,
cioè ascoltare, i notevoli effetti frullato ottenuti da Heckstall-Smith col
proprio strumento, nonché, immaginiamo, l’uso simultaneo di due
sassofoni (diversamente dunque dalla sovraincisione), sul modello reso popolare nel jazz da Roland Kirk.
Mandarin viene annunciata come una composizione basata su di un
modello intervallare appartenente alla cultura musicale giapponese
(«Based on a Japanese soft scale»). In realtà è qualcosa di molto più
avventuroso per le orecchie degli amanti del rock di quell’epoca. Il
tema non diatonico usato in apertura (ascendente la prima metà: dodo♯-fa-sol-sib-do; discendente la seconda: do-lab-sol-fa-reb-do) è in
effetti costruito intrecciando due delle più importanti scale della tradizione musicale giapponese, la scala yo e quella in, ma una volta espletato questo compito, ai Colosseum rimane tutto il tempo per fare an-
Ai piedi del Colosseo… britannico
19
che dell’altro. Allora ecco che i riflettori si accendono per illuminare il
basso elettrico del baffuto Tony Reeves, che dapprima nel registro
grave, tipico del suo strumento, e in seguito in quello acuto con uso
del pedale wah-wah, ricorda a tutti quanti che anche il cugino povero
della chitarra, se vuole, può essere uno strumento solista efficace ed
intrigante. L’insegnamento di Jack Bruce, risalente al tempo in cui era
stato il bassista dei popolarissimi Cream (luglio 1966 – novembre
1968), non era dunque risultato vano. L’ultimo sussulto è però di Greenslade, grazie ad una chiusura muscolosa realizzata applicando
l’effetto fuzz al suo organo Hammond.
Debut segue a ruota nella scaletta e chiude anche il primo lato della
vecchia edizione in vinile dell’album (Fontana STL 5510). Il blues ritorna qui prepotente ed in una veste corale nella quale un po’ tutti i
membri dei Colosseum hanno modo di mettersi in luce con estesi interventi solistici. E già che ci sono approfittano pure dell’assenza di
parti vocali per restare più a lungo sotto i riflettori. Heckstall-Smith ha
così modo di tornare a farsi udire con forza aprendo la serie degli assolo, prima perciò che eseguano il loro rispettivamente Greenslade,
Hiseman e Litherland, quest’ultimo attraverso alcune brevi frasi di
chitarra elettrica nel finale della composizione. La tonalità usata per
questo brano è quella, inedita, di Re maggiore, con movimenti sul IV
e sul V grado, secondo il classico schema delle 12 battute del genere
musicale scelto per questi 6 minuti e 20 secondi di musica. Su di un
metro binario in 4/4, inoltre, non può non essere notato il ritmo di bolero adottato da Hiseman un attimo prima dell’inizio del lungo assolo
di Dick Heckstall-Smith (01:40). Un po’di mesi dopo, i Colosseum riprenderanno questa idea ritmica per incidere un’ottima versione rock,
rimasta tuttavia nel cassetto per quasi due anni, del famoso Bolero di
Maurice Ravel (si veda a questo proposito l’antologia “Collector’s
Colosseum”, pubblicata dall’etichetta Bronze nel 1971 con il codice
ILPS 9173).
Beware The Ides Of March apre la facciata B del long playing ed è
fatta per essere ricordata nel tempo. Verso la fine del 1968 la musica
rock, in Inghilterra, cominciava ad essere una faccenda molto seria, e
per questo necessitava di musicisti preparati sul piano teorico ed in
20
Effetto Pop
grado di districarsi con disinvoltura all’interno di generi e stili diversi.
L’accostamento di questo pezzo dei Colosseum con l’Air dalla “Suite
Orchestrale in Re Maggiore” n. 3 di Johann Sebastian Bach non deve
perciò stupire più di tanto, perché la voglia di sperimentare era in quei
giorni assai diffusa e soprattutto sincera, così che anche delle vecchie
forme strofa-ritornello o chorus-bridge, come pure di tante altre cose,
si cominciava a fare volentieri a meno.
Beware The Ides Of March è un brano diviso in due sezioni nettamente distinte l’una dall’altra per atmosfera, procedimenti esecutivi,
scelte armoniche e ritmiche, timbro. La forma ABA' conclusiva non è
rarissima nel rock di quegli anni, e infatti ciò che colpisce maggiormente durante l’ascolto di questa composizione sono piuttosto, oltre
alla buona qualità organizzativa dell’insieme, l’affiatamento raggiunto
dai Colosseum come gruppo e la cura minuziosa riservata a ciascun
intervento strumentale. L’insistito e straziante uso di feedback da parte
di Litherland nel corso del suo lungo assolo (sezione B), contrapposto
al suggestivo e memorabile tema bachiano, rappresenta, in un simile
contesto, la giusta e doverosa dichiarazione di autonomia da parte di
musicisti vogliosi di affermare la propria indipendenza artistica nei
confronti di qualunque genere musicale. Ma, e questo credo sia in
fondo il messaggio di un brano come Beware The Ides Of March, senza dimenticare il nobile passato.
The Road She Walked Before allenta di molto la tensione generata
dalle scelte stilistiche operate dai Colosseum nei cinque brani precedenti (facciamo però notare, solo per curiosità, che se l’ascolto del cd
venisse fatto iniziare dalla traccia numero 6 anziché dalla 1, e nessuno
potrebbe impedircelo, la considerazione appena fatta non sarebbe più
valida). L’idea per la realizzazione di questo brano è di HeckstallSmith, che però limita il suo intervento a pochi riff e, più in generale,
ad un ruolo di mero accompagnamento, che in molti passaggi non risulta neppure troppo evidente. Ma, lo ricordiamo, i Colosseum erano
una band con una voglia matta di suonare e di divertirsi, e perciò non
aveva alla fin fine molta importanza se chi suggeriva un’idea melodica
oppure ritmica risultava poi messo un po’ in disparte al momento della
sua realizzazione musicale. Ciò che contava, evidentemente, era solo
il funzionamento del gruppo, cosa che però avrebbe permesso, in caso
Ai piedi del Colosseo… britannico
21
di successo, anche la più che probabile crescita individuale di ciascuno dei propri componenti. Tornando al brano, va detto che si tratta di
una breve composizione costruita ancora una volta attorno allo schema blues delle 12 battute, nella tonalità di Si bemolle maggiore. Molto
“anni Sessanta” nello spirito, prevede interventi di congas, maracas e
fraseggi pianistici di vaga ambientazione “latin”.
Backwater Blues è la seconda ed ultima cover inserita dai Colosseum in questa raccolta di otto brani dedicata prevalentemente alla
musica del diavolo (il blues, appunto). La principale novità, in questo
brano di Huddie Leadbetter detto Leadbelly, è data dalla presenza in
formazione del chitarrista Jim Roche, di stanza nei Colosseum prima
dell’arrivo di Litherland. Il lavoro alla chitarra elettrica di Roche è,
nella prima parte di questo blues lento in Sol maggiore, davvero notevole. Il suo è uno stile piacevolmente fluido ed a tratti quasi virtuosistico, degno di nota per un musicista sconosciuto ai più e che rimarrà
nei Colosseum per un tempo brevissimo, e tuttavia sufficiente ad incidere e consegnare alla storia della musica rock questo magico assolo
(in seguito Roche suonerà per alcuni mesi negli East Of Eden e quindi
in altre formazioni ancor meno note). La seconda parte del brano è invece appannaggio quasi totale di Heckstall-Smith, che ivi ha modo di
esibirsi sia al sax tenore sia al sax soprano, dando vita, insieme a Reeves, anche ad un atipico duo basso elettrico-sassofono (02:44-03:47)
nonché a breaks di stampo jazzistico a ridosso del finale (05:0205:24), dopo un assolo piuttosto lungo.
Those About To Die, sistemato come detto in fondo alla facciata B
del 33 giri, è il brano più ricco, da un punto di vista armonico,
dell’intero album, e anche quello che, ma questo riguarda evidentemente solo chi scrive, un po’ di anni addietro mi rivelò con piacere
l’esistenza di questa eclettica formazione inglese ed il suo passaggio
all’interno di quell’intrigante vortice sonoro che fu il rock alla fine
degli anni Sessanta. “Stop and go” mozzafiato che uno si chiede come
diavolo facessero, e spericolato jazz-rock ante litteram sono gli ingredienti di un brano nel quale tutti e cinque i membri dei Colosseum
danno il massimo e il cui risultato, a mio parere, deve essere annoverato tra le cose più interessanti di tutto il rock compreso tra il Monte-
22
Effetto Pop
rey Pop Festival (giugno 1967) e la pubblicazione di “Collector’s Colosseum” (autunno 1971). A proposito della tecnica dello “stop and
go”, così perfetta in questo brano, si potrebbe anche sospettare, e farlo
in maniera legittima, che lo studio di registrazione, con la possibilità
di registrare separatamente ciascuna delle singole parti strumentali per
poi ricompattarle tutte quante insieme, alla fine, in sede di montaggio,
abbia potuto dare un aiuto determinante nella riuscita di questa notevole incisione. Insomma, che l’eccellente risultato di quello che oggi
ascoltiamo dal 33 giri o dal compact disc sia il frutto esclusivo di un
piccolo e banale trucco consentito dal progresso tecnologico realizzato
nel corso degli anni Sessanta. Potrebbe anche essere così, in teoria, solo che io ho visto i Colosseum in concerto il 25 febbraio 2006
all’Auditorium Flog di Firenze aprire il loro show proprio con Those
About To Die, e riprodurre fedelmente le complicate strutture ritmiche
di quel pezzo del 1969, senza il minimo svarione e anzi con straordinaria scioltezza. Era dunque tutto vero. Per quanto riguarda l’armonia
va ricordato che il brano è in Sol maggiore e che, oltre allo scontato
IV grado (Do maggiore), si possono anche ascoltare accordi di Fa minore7, Sol minore7, La minore7, Do minore7, Re minore7, Mi maggiore, Fa maggiore e Re maggiore. Tutti questi numerosi accordi minori di 7ª danno chiaramente la misura di quanto vicino ai modelli jazzistici sia un brano straordinario ed irripetibile come Those About To
Die.
P.S. La formazione del concerto di Firenze, oltre a far registrare un
paio di avvicendamenti rispetto a quella originaria, che però risalgono
al periodo compreso tra la fine del 1969 e l’inizio dell’anno successivo, presentava Barbara Thompson, moglie di Hiseman, al posto del
compianto Dick Heckstall-Smith, e anche lei ai sassofoni tenore e soprano. La signora Thompson è stata, a mio avviso, la sorpresa più piacevole dell’intera serata, riuscendo con molta grazia, ma anche con
grinta quando questa era necessaria, a non far rimpiangere una figura
indimenticabile come quella dell’occhialuto sassofonista dei gloriosi
ed ancora validi Colosseum.