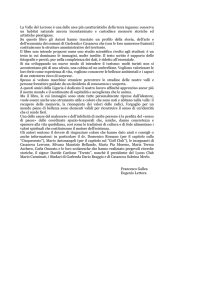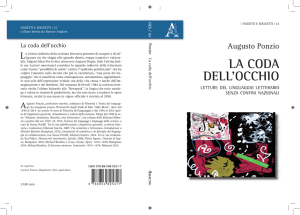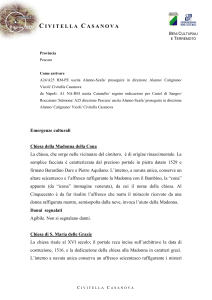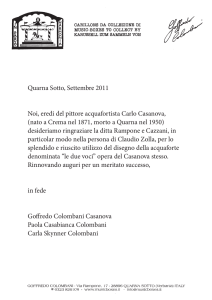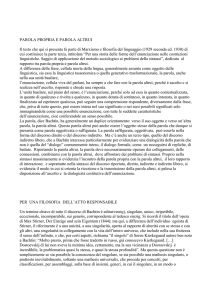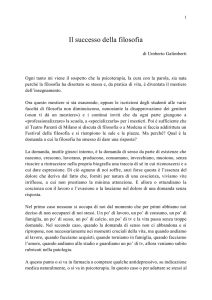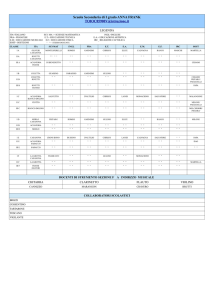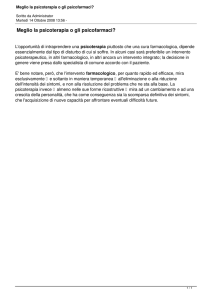International
RIVISTA TELEMATICA QUADRIMESTRALE - ANNO XXV
NUOVA SERIE - N. 74 - MAGGIO-AGOSTO 2011
1
Segni e comprensione International
Pubblicazione promossa nel 1987 dal Dipartimento di Filosofia e
Scienze sociali dell’Università degli Studi di Lecce, oggi Università del
Salento, con la collaborazione del “Centro Italiano di Ricerche
fenomenologiche” con sede in Roma, diretto da Angela Ales Bello.
Questa rivista si pubblica anche con contributi del M.I.U.R., per il
Prin “Fenomenologia, riflessione etico-politica ed estetica dal Novecento in
poi: testi e temi della filosofia dei paesi del Mediterraneo”, attraverso il
Dipartimento di Filosofia e Scienze sociali dell‟Università del Salento.
General Editor/Direttore responsabile
Giovanni Invitto ([email protected])
Steering Comittee/Comitato direttivo
Giovanni Invitto, Università del Salento (Editor/Direttore
responsabile) Angela Ales Bello, Università Lateranense; Angelo Bruno,
Università del Salento; Daniela De Leo, Università del Salento; Antonio
Delogu, Università di Sassari; Aniello Montano, Università di Salerno; Paola
Ricci Sindoni, Università di Messina.
Editorial board/Comitato editoriale
Jean-Robert Armogathe, École Normale Supérieure de Paris (F);
Renaud Barbaras, Paris I – Sorbonne (F); Francesca Brezzi, Università di
Roma 3 (I); Bruno Callieri, Università di Roma 1 (I); Mauro Carbone,
Université Jean Moulin Lyon 3 (F); Giovanni Cera, Università di Bari (I);
Claudio Ciancio, Università del Piemonte Orientale (I); Françoise Collin,
fondatrice di «Les Cahiers du Grif» (F); Umberto Curi, Università di Padova
(I); Roger Dadoun, Université de Paris VII-Jussieu (F); Franco Ferrarotti,
Università di Roma 1 (I); Renate Holub, University of California – Berkeley
(Usa); Roberto Maragliano, Università Roma Tre (I); William McBride, Purdue
University, West Lafayette, Indiana (Usa); Augusto Ponzio, Università di Bari
(I); Pierre Tamianiaux, Georgetown University (Usa); Christiane Veauvy,
Cnrs (F); Sergio Vuskovic Royo, Universidad de Valparaiso (RCH); Chiara
Zamboni, Università di Verona (I)
Team/staff di redazione
Siegrid Agostini; Daniela De Leo (responsabile); Lucia De Pascalis
Maria Teresa Giampaolo, Rosetta Spedicato.
2
Sede
Comitato Scientifico e Segreteria hanno sede presso il Dipartimento
di Filosofia e Scienze
sociali, Università del Salento – Via M. Stampacchia – 73100 Lecce
– tel.0832.294627; fax 0832.294626. E-mail: [email protected].
Amministrazione e pubblicità
Piero Manni s.r.l., Via Umberto I, 51 73016 San Cesario di Lecce –
Tel. 0832.205577. Periodico iscritto al n. 389/1986 del Registro della Stampa,
Tribunale di Lecce.
3
Questa rivista è sui siti: http: //www.segniecomprensione.it e
http://www.mannieditori.it/rivista/segni-e-comprensione; e ha dei rimandi al
Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali e al Siba con i link:
dipfil.unile.it/seo-start/page/home.rivista_online/seo-stop/index.php? e sibaese.unisalento.it/index.php/segnicompr
NOTE PER GLI AUTORI
I contributi scientifici possono essere scritti in una delle seguenti
lingue: italiano, francese, inglese e saranno pubblicati nella lingua in cui
perverranno. L‟articolo deve riportare, prima del testo, il titolo, Autore e il
relativo istituto di appartenenza, indirizzo per la corrispondenza e un abstract
(di max 900 battute, scritto in italiano/inglese/francese) con parole-chiave
(fino a 5) ed essere redatto secondo le norme redazionali riportate sul sito.
Per la sezione “Saggi” i testi non dovranno superare le venti cartelle
di 30.000 battute, spazi inclusi e comprese le note bibliografiche. Per le
“Note” non si dovranno superare le 10.000 battute, spazi e note inclusi, con
le medesime caratteristiche dei Saggi.
I testi vanno inviati alla Direzione, indirizzati alla seguente e-mail:
segniecomprensione@ libero.it.
I testi, in forma anonima, verranno esaminati da due referees,
esterni al Comitato Direttivo, e competenti nelle diverse tematiche trattate dai
contributi. Questi forniranno al Comitato Direttivo gli elementi necessari per
valutare la correttezza e l‟utilità, segnalando la necessità di modifiche o
integrazioni per migliorarne le caratteristiche o evidenziando gli aspetti che,
se non correttamente modificati, ne potrebbero impedire la pubblicazione.
4
INDICE
Saggi
7
Roger Dadoun
MARE COLOSTRUM.
DE LA MÉDITÉRRANÉITÉ
17
Luciano Ponzio
MICHAIL BACHTIN, UN FILOSOFO IN DIALOGO
CON LA FILOSOFIA DELLA SUA EPOCA
40
Giancarlo Rizzo
LA LINGUA PERFETTA E LA LINGUA UNIVERSALE
NEL PROGETTO UTOPICO DI SAMUEL HARTLIB
56
Giacomo Fronzi
L‟ALTRO CASANOVA. LE MEMORIE NELL‟IMMAGINARIO
CINEMATOGRAFICO
DI FEDERICO FELLINI
Note
77
Graziano Scolari
IL SENSO DELL'ESSERE. APPUNTI FENOMENOLOGICI
94
Francesco Tarantino
LA PSICOTERAPIA ALLA RICERCA DI SE STESSA.
SU IL “PAESE DEGLI SMERALDI” A CURA DI L. A. ARMANDO E
A. SETA
5
Resoconti
117
Roberto Pettenati
FORME DEL RICONOSCIMENTO E TEORIA CRITICA.
A PROPOSITO DI AXEL HONNETH
122
Stefania Macaluso
CHIARA ZAMBONI E IL PENSIERO IN PRESENZA
126
Paolo Armellini
BURKE E L‟INDIA
128
Andrea D‟Urso
IL FONDO E LA FORMA. LA SEMIOSI, LA SEMIOTICA, L‟UMANO
133
Gianni Donati
SENTIMENTI RAGIONE FEDE
138
Maurzio Daggiano
IL VOLTO NEL PENSIERO CONTEMPORANEO
142
Ardian Ndreca
LE STANZE DELLA MODERNITÀ
6
MARE COLOSTRUM.
DE LA MÉDITÉRRANÉITÉ
*
di Roger Dadoun
Paradox of the Mediterranean - the sea murderess, a barrier for fleeing immigrants – a
magnificence of Roman Antiquity. The Mediterranean, mare nostrum, our beach house
– childhood home. Where is this attraction for the South, the Mediterranean from? A
writer such as Albert Camus claims his Mediterraneity (from Algeria, marked by
colonialism and poverty, to Spain, his mother country, and Italy, a bridge between sun
and culture, and finally Greece, the fulcrum of Humanism) ; James Joyce conceives
Dublin as an extension of the Mediterranean, whose wisdom is perhaps in excess (of
people, cultures, races, voices in Ulysses ...). As for Camus, the best word to
characterize his relationship with the South could be nostalgia, but in the meaning of
noces-algia (Noces – work made in early youth - algia - pain). A relationship of love
and hate, as it is suggested by the French homonimy between the words mère mother - and mer - sea, which is declined under the sign of colostrum - the milk drunk
by the twins Romulus and Remus before the fratricide from which Rome was founded
(blood and violence, bad mother), the magnificent "blue milk" of the Mediterranean,
drunk by a sharp look (beauty and serenity, good mother). The sea of the
Mediterranean, colostrum – huge Rome, first milk, the best one, as yellow as the sun a symbol of the universal fantasy of becoming again a newborn, showed that we are
able to elevate our soul.
Paradoxe de la Méditerranée - mer assassine, barrière pour les migrants en fuite magnificence de l'Antiquité romaine. La Méditerranée, mare nostrum, notre maisonmer - maison-mère. D'où vient cette attirance pour le Sud, la Méditerranée? Un auteur
comme Albert Camus revendique sa méditerranéité (de l'Algérie marquée par le
colonialisme et la pauvreté à l'Espagne, terre maternelle, puis à l'Italie, passerelle entre
soleil et culture; et, enfin, à la Grèce, couronne de l'humanisme); James Joyce, lui,
conçoit Dublin comme une extension de la Méditerranée, dont la sagesse réside, peutêtre, dans l'excès (excès de gens, de cultures, de races, de voix contenus dans
Ulysse...). Pour en revenir à Camus, le meilleur terme pour caractériser le rapport qu'il
entretient avec le Sud pourrait être celui de nostalgie, mais dans le sens de nocesalgie (Noces – œuvre de jeunesse - algie - douleur). Une relation, par extension,
d'amour-haine, comme le suggère l'homonymie entre les mots mère et mer, qui se
décline sous le signe du colostrum - le lait bu par les jumeaux Romulus et Rémus,
avant le fratricide fondateur de Rome (le sang et la violence, la mauvaise mère); le "lait
*
Insegna all'Università di Parigi VII-Jussieu. Ha compiuto studi di critica letteraria e
cinematografica, di analisi antropologica e psicanalitica.
7
SAGGI
Abstract
7
bleu", magnifique, de la Méditerranée, absorbé par le regard qui le contemple (beauté
et sérénité, la bonne mère). La mer Méditerranée, colostrum - Rome colossale, le
premier lait, le meilleur, jaune comme le soleil - symbole du fantasme universel de
redevenir un nouveau-né - à condition, toutefois, d'être capable d'élever son âme.
Paradosso del Mediterraneo – mare assassino, barriera per migranti in fuga –
magnificenza dell‟Antichità romana. Il Mediterraneo, mare nostrum, nostra casa mare –
casa madre. Da dove viene quest‟attrazione per il Sud, il Mediterraneo? Un autore
come Albert Camus rivendica la sua mediterraneità (dall‟Algeria, segnata da
colonialismo e povertà, alla Spagna, terra materna, poi all‟Italia, ponte fra il sole e la
cultura; e, infine, alla Grecia, corona dell‟umanesimo); James Joyce concepisce
Dublino come estensione del Mediterraneo, la cui saggezza sta, forse, nell‟eccesso (di
gente, di culture, di razze, di voci, contenuto in Ulisse…). Tornando a Camus, il
termine migliore per caratterizzare il suo rapporto con il Sud potrebbe essere quello di
nostalgia, ma nel senso di noces-algia (Noces – opera di gioventù – algia – dolore). Un
rapporto, per estensione, di odio-amore, come lo suggerisce l‟omonimia francese fra le
parole mère – madre – e mer – mare, che si declina sotto il segno del colostrum – il
latte bevuto dai gemelli Romolo e Remo, prima del fratricidio dal quale nasce Roma (il
sangue e la violenza, la cattiva madre); il “latte azzurro”, magnifico, del Mediterraneo,
bevuto dallo sguardo che lo contempla (bellezza e serenità, la buona madre). Il mare
del Mediterraneo, colostrum – Roma colossale, il primo latte, quello migliore, giallo
come il sole – simbolo della fantasia universale di ri-diventare neonato, a patto, però, di
essere in grado di elevare l‟anima.
8
_____________________________
Elle est bien agitée, par les temps qui coulent, notre mer
Méditerranée, qui n‟est guère plus, de par astreinte de mondialisation, que
petiote mare. Depuis qu‟on ne cesse de l‟halluciner en avatar - encore un, ô
mânes romaines, marranes, étrusques ou barbaresques - et en bâtard
abâtardi – c‟est fou ce que ça cafouille toujours côté pères (Paterfamilias) et
mères (Mamma mia) – de ce nouveau hochet géo-politique nommé Union
Pour la Méditerranée, les vagues marines sont devenues hargneux barbelés
de sel rongeur pour les candidats aux exils (et il n‟y a même plus un Zeus
avec son aigle Second Empire apprivoisé par Péguy dans Clio pour protéger
le banni, le fuyard, l‟exsul, le xenos) et recyclables linceuls pour ceux qui, sur
embarcations de misère, fuient des “ patries ” qui ne sont “ pères ” et “ mères
” que pour famine, corruption, torture, crime - pour le plus grand “ bien ” des
véloces “ plans de carrière ” des politiciens Occidentaux et des épais
8
opaques portefeuilles d‟actionnaires et trafiquants plus Occidentaux qu‟eux tu
meurs.
Mais - le vent du large serait-il en train de tourner ? Experts causant
et photographes filmant nous racontent que la planète se réchauffe. Nous
pouvons donc, les prenant au vol et au verbe, imaginer que “ Mère
Méditerranée ”, avérant un rêve millénaire, va prendre elle aussi son petit
coup de chaud - et qu‟ainsi, aux noires écumes et bulles amères
engloutissant packs de cadavres et chavirées barcasses, se mêlerait un peu
du lait et du miel de la tendresse humaine. Si tu t‟imagines, si tu hallucines,
voici donc notre fantasme mis à plat sur horizontal horizon (car mortelle est la
verticale abyssale) : à la mer bousillée par tant de ravages et aux reflets
rougissant de tant de sanglants naufrages, succèderait donc, ô Hulot, un
beau lac d‟argent serti de maternants bisous?
Nos années de lycée, et peut-être même l‟école primaire de nos
jours, ont fait, font toujours retentir à nos oreilles éblouies l‟impériale formule
des Romains qui, balayant d‟un geste large la cartographie de leurs
conquêtes maritimes, décrétèrent la Méditerranée “ Mare nostrum ”. (Et
martial roulement de tambours, et trompettes d‟une millénaire renommée !). “
Mer nôtre ”, disaient-ils, cette mer est à nous, elle est nous-mêmes, pour les
siècles des siècles : l‟espace conquis vaut passeport pour l‟éternité. Il y avait
de quoi: une simple carte des Etats et Provinces de l‟Empire, arrêtée, disons,
au IIème siècle de notre ère, donne tout son éclat chamarré à la légitimité de
la proclamation latine - qui n‟hésiterait pas à s‟annexer en prime, en outremer et outre-terre, littéralement dessinée, la Mer Noire, et plus encore, autour
et alentour. L‟opulent et vorace empire ottoman eut beau, par la suite,
rivaliser de munificence et de puissance d‟assimilation dans son agile ingestion du brouet méditerranéen, il dut, parvenu aux marches les plus
occidentales, mettre les pouces.
Sud, Soleil et Simoun - d‟un air de famille
Ces fastueux empires, combinant poigne de fer et sonore rhétorique
de bronze, le code et le yatagan, semblaient être parvenus, au vu d‟un
certain nombre de critères, tant matériels que spirituels, à donner aux
populations autochtones du pourtour méditerranéen, respectant autant que
faire se peut leurs us et coutumes, comme un air de famille, ombre portée de
quelque auguste Paterfamilias – air que l‟on pourrait, avec tout le vague à
l‟âme possible, caractériser en donnant tout leur souffle à un signifiant
géographique (fantasme géopolitique) : le Sud, ou son équivalent le Midi, et à
un élan libidinal : course vers un Soleil dont l‟aveuglant éclat dérobe à nos
regards, et il a bien failli réussir (M. Gimbutas, 1989), tout un harem de
9
9
mères-concubines, de déesses-mères (Mare nostrum jouant le rôle de
Maison-mer pour toute la famille, fut-elle honnie de tous de ceux qui,
relégués dans les mares ou sorties d‟égouts, poussaient une ancestrale
clameur : “ Famille, je vous hais ! ”).
Toute perspective de psychanalyse géopolitique du Bassin
méditerranéen se devrait d‟aller voir de plus près, plus au fond, ce que sont
et valent et comment et pourquoi perdurent ce Sud et ce Soleil, ce Midi et
ces Déesses-Mères, et le prétendu Air de famille. Ce prolifique Bassin est un
proliférant carrefour d‟innombrables lignes de force enchevêtrées et
d‟opulentes lignées historiques, mythologiques, anthropologiques – qui ont
“généré” des analyses aussi minutieuses et éclairantes qu‟interminables,
dans lesquelles il serait périlleux de se plonger, au risque de se noyer. L‟on
se contentera donc ici d‟une très cursive référence à un auteur qui
revendiqua pleinement sa Méditerranéité, nommément Albert Camus, tel
que, nous reportant à une lointaine époque, nous l‟avions présenté dans un
numéro de la revue méditerranéenne Simoun (Oran, n°3, juin 1952), sous le
titre : “ Albert Camus le Méditerranéen, Le rêve de lumière et le complexe du
clos-obscur ”.
Cette analyse, d‟inspiration psychanalytique, portait sur les
dernières pages de son ouvrage L’homme révolté (1951), à propos duquel
certains critiques à peau blême [“ blême ” - pour rappeler une chaleureuse
rencontre “ professionnelle ” avec Camus au quotidien Alger Soir, animé par
une équipe socialiste venue de Paris : au rédacteur en chef qui s‟était plaint
de la chaleur, il lança, un tantinet glaçant, “ Vous avez un visage qui ne
prend pas le soleil!”] parlèrent d‟une inspiration „ club-méd. ‟ de l‟écrivain
pied-noir. Pages lyriques, dans lesquelles Camus magnifie “ la pensée de
Midi ”, “ pensée solaire ” comme il le répète, il en loue “ la dure lumière ”, et
formule ce clair et définitif propos : “ dans la lumière, le monde reste notre
premier et dernier amour ”. Lumière et amour se lisent et se détachent sur
des moires à grandes ondes marines, portées par “ le vent dur, venu des
mers ”. “ Lumière dure ” et “ vent dur ” déclament la dure durée de la “
tradition méditerranéenne ”, expriment, Camus insiste, ” une exigence
invincible de la nature humaine, dont la Méditerranée garde le secret. ”
Espagne, Italie, Grèce - de la Méditerranéité
Une Méditerranée qui enferme en son sein “ le secret ” d‟ ” une
exigence invincible de la nature humaine ”, ce n‟est pas peu dire, et c‟est
peut-être en dire trop. Il faut, à défaut de preuves et d‟arguments (mais ce
n‟est pas le lieu), à tout le moins signaler des épreuves adjacentes, faire état
de quelques ancrages, jeter l’ancre en telles criques ou baies marines qui
10
10
puissent, reliées entre elles par de singuliers itinéraires, dessiner l‟esquisse
de l‟un des multiples profils méditerranéens réels ou potentiels. Camus a
pour assise, au départ, l‟Algérie, sa terre natale – mais c‟est une Algérie dans
laquelle le colonialisme (Camus journaliste dénoncera “ la misère en
Kabylie”) et la bourgeoisie (Camus est pauvre) ont inscrit de tels conflits et
déchirures qu‟il est vital, pour l‟imaginaire et la méditation et le corps même
de l‟artiste, de s‟y soustraire et de se porter ailleurs.
Parmi les ailleurs les plus sensibles abordés par Camus, il y a au
premier chef l‟Espagne, à laquelle il est viscéralement attaché par une mère
d‟origine espagnole, veuve murée dans le silence, mais aussi par un
sentiment psycho-politique de révolte, qui trouve son expression dans la
pièce écrite avec son équipe du Théâtre du Travail, à Alger, Révolte dans les
Asturies (1936) : une Espagne, dure mère, libertaire et anarchiste, brillera
toujours comme un éclat de “ lumière dure ” sur la Méditerranée de Camus
(et sur la nôtre aussi bien). Il y a l‟Italie, qui s‟impose comme le passage
obligé pour tous ceux qui sont en quête d‟une liaison rationnelle, romantique
ou mystique, ou banalement touristique, entre Soleil et culture. Comme en
témoigne une abondante littérature, pour les cohortes d‟écrivains et d‟artistes
avides d‟aller à la rencontre de formes et mesures lumineuses,
harmonieuses, rigoureuses, heureuses, et d‟une démesure maîtrisée (à
l‟exemple de la chorégraphie du Zarathoustra de Nietzsche, que Camus aime
citer ?), initiatiques sont le “ Voyage en Italie ”, et son prolongement plus
aventureux et plus sensuel, le “ Voyage en Orient ”. “ J‟entre en Italie, dit
Camus, terre faite à mon âme. ” Au jardin Boboli de Florence, c‟est sous les “
énormes kakis dorés dont la chair éclatée laissait passer un sirop épais ”
(n‟est-ce pas déjà, seins solaires et lactescent nectar, l‟annonce de notre
colostrum ?) que Camus a la révélation qu‟ ” au cœur de [s]a révolte dormait
un consentement ” : consentir à la terre, à l‟ici-bas qui est notre “ royaume ”,
et consentir à se construire et se régler soi-même à la mesure de ce qui est.
Survient, inattendue après ces claires et fortes affirmations, cette
question: “ quelle démesure ” ? Ce ne saurait être, en pareil contexte, que la
démesure d‟une mer assez puissante et assez humanisée pour en avoir la
maîtrise, et en mesure, si l‟on peut dire, d‟ ” enfermer ”, de contenir, au
double sens du terme, la démesure : profil d‟une mer “ humaniste ”, donc,
d‟un “ humanisme ” bercé par les flots et les ressacs (alternant avec les
innombrables et dévastatrices mises à sac terrestres !), esquisse d‟une
sagesse de la Méditerranée, dont la dé-mesure, “ naturelle ” dirions-nous,
gorgée de soleil et la lumière, se trouve paradoxalement en mesure de se
dresser contre la “ démesure inhumaine ” et les fureurs de l‟histoire. (“ Une
limite, dans le soleil, les arrête tous ”). Autre point d‟ancrage de la triplice
camusienne de la Méditerranée : la Grèce qui, amoureusement assumée (la
11
11
“ Grèce de l‟ombre ” y trouve place), en est à la fois le couronnement et la
source. C‟est le profil que propose la conclusion de L’homme révolté : “ Nous
choisirons Ithaque, la terre fidèle, la pensée audacieuse et frugale, l‟action
lucide, la générosité de l‟homme qui sait. ” Roc du réalisme, et audace,
fidélité, volonté, sobriété, activité, lucidité, générosité, conscience – c‟est, en
une intime et inextricable liaison mer-terre, toute une éthique, tout un
humanisme terre-à-terre (“ qui se donne au temps de sa vie… se donne à la
terre ”) ou terre-à-mer (“ paroles de courage et d‟intelligence qui, près de la
mer, sont même vertu ”) que Camus parvient à loger dans son homérique
Ithaque, définie comme point de départ et point d‟aboutissement du
persévérant et périlleux périple accompli par Ulysse, sagace navigateur
polymetis (aux mille ressources), qui inaugure à sa manière - mythologie
persillée de réel - une Méditerranée féconde en rencontres, ruses,
traquenards, violences, tourments, polymétissages.
Noces, souffrance et nostalgie: Noces-t-algies
Dans la très sommaire analyse de la “ pensée de midi ” qui est au
cœur battant de L’homme révolté, j‟avais utilisé l‟expression “ nostalgie de la
lumière ”. Camus avait aussitôt relevé ce terme de “ nostalgie ”, pour le
récuser. S‟expliquant avec une grande cordialité, il souligne que le rapport
intense et fondamental qu‟il entretient avec le monde méditerranéen, non
seulement n‟est pas de l‟ordre de la nostalgie, mais au contraire constitue le
nerf à vif, la sûre et vitale assise fondatrice à la fois d‟une résistance “ lucide ”
face à “ l‟époque et ses fureurs adolescentes ”, d‟un engagement résolu dans
les conflits déterminants de la société et de la culture, et d‟une vision globale
raisonnée de la réalité humaine, forte de cette perspective : “ nous tous,
parmi les ruines, préparons une renaissance ”.
Il importe assurément d‟accueillir dans toute leur gravité les
remarques réfléchies et volontaristes de Camus. Mais sachant que l‟âme
humaine est un patchwork, un sac de nœuds de pulsions-motions-émotionshallucinations-volitions-illusions-ratiocinations
insusceptibles
de
toute
direction unique, on notera que la nostalgie, qui fait le présent se retourner
sur le passé, emporte un mouvement réciproque du passé revenant en force
dans le présent (ou l‟inverse - la symétrie brouillant les pistes du temps). On
pourrait donc, “ pour aller vite ” selon une exécrable expression médiatique,
et pour rejoindre sans plus tarder notre crucial objectif, préserver le principe
d‟une “ nostalgie ” méditerranéenne chez Camus, en prenant le risque de
démonter l‟expression et de composer un montage en forme de structure
insolite, plus “dure”, à visée synthétique. Du coup, combinant “Noces” (1938),
œuvre hautement significative, seule véritablement “ poétique ”, de Camus
12
12
(dite naïvement “ de jeunesse ”), et “ souffrance ” (algie, du grec algos,
douleur, marqueur d‟un “ avoir mal ”), un des ressorts essentiels de sa
réflexion (marquée précisément par la réalité historique et vécue et le
problème moral et métaphysique du “ mal ”), on passe de la commune et
souvent “ triste ” nostalgie à une homonymie plus râpeuse (rappeuse !),
d‟allure baroque, joycienne, voire kabbalistique: “ Noces-t-algie ”. Cette “
Noces-t-algie ”- là a au moins l‟avantage de marquer une certaine
sophistication (notion plutôt nébuleuse, mais qui nous évite les trivialités
sociologiques ou anthropologiques d‟une “ complexité ” passe-partout), et de
suggérer, par delà la vision propre de Camus, la possibilité d‟une perception
qui ne soit pas trop simplificatrice du monde méditerranéen.
[Outre son laborieux mais suggestif alliage, qualifier notre singulière
“ Noces-t-algie ” de “ kabbalistique ” présente l‟intérêt collatéral de
s‟interroger sur la possibilité de considérer la Kabbale hébraïque - naissant
sur des fondations bibliques, et se développant, avant de connaître des
apports continentaux, dans tout le bassin méditerranéen - comme une strate
d‟ ” étrangèreté ”, originale dans l‟institution humaine de la Méditerranée,
strate à peu près totalement occultée, qui se distingue moins par le “ secret ”
allégué dans tant de lieux communs que par une “ discrétion ” relevant de la
méditation et de la prudence. On voit mal comment la perspective, caressée
par beaucoup, d‟une culture méditerranéenne renaissante pourrait
sérieusement faire l‟économie d‟une référence aux principes et méthodes de
la Kabbale, travail créateur sur la lettre, précieux exercice pour un autre
usage (rigoureux, ouvert, “ non-violent ”, “ scientifique ”) du texte et de la
parole. Et voici que, par une imprévisible mais congruente association, nous
vient à l‟esprit le nom même de James Joyce, l‟écrivain irlandais-européenplanétaire parvenu, entre autres exploits littéraires, dans son immense bassin
littéraire intitulé Ulysse (1922), à inscrire en palimpseste, sur le récit
homérique, en forme de précipité, l‟espèce de circumnavigation
méditerranéenne que constituent les déambulations urbaines, dans la “ chère
et sale Dublin ”, du Juif Léopold Bloom. Si l‟Ulysse de Joyce se distingue,
suprêmement, par la démesure maîtrisée des styles, langues, cultures,
personnages et références pressurés de tous les horizons – irrésistible et
familière s‟y affirme l‟étonnante prégnance, en éclairages multiples, de
plages culturelles méditerranéennes abordées par cet écrivain vivant au long
cours un rude exil scandé de joyeuses noces intellectuelles (ô Homère,
Dante, Bruno, Vico, et autres compagnons). De sorte que l‟atlantique et raide
Irlande, à travers le réalisme minutieux, âpre et sans concession qui la
portraiture, se présente à nos yeux éblouis telle la progéniture à la fois
bâtarde et légitime d‟une Méditerranée qui refuse d‟être contrainte dans des
13
13
limites géographiques ou culturelles, et dont un Joyce méditerranéen, jubilant
barde insolent et insoleillé, porte la voix d‟encre.]
“Voie méditerranéenne” ? Voie d‟eau, ou retrouvaille du Colostrum?
Si une “ voie méditerranéenne ” peut être tracée, qui ne soit pas trop
sillonnée d‟utopies, et ne risque pas trop de tourner en voie d‟eau ou eau de
boudin, il conviendrait sans aucun doute, poussant à fond le principe de
contrariété inhérent à notre “ Noces-t-algie ” (propice, on s‟en excuse, aux
céphalalgies), de faire entendre sur de nouvelles partitions, sur de nouveaux
accords (écologie libertaire du penseur américain Murray Bookchin, par
exemple) les “cymbales du soleil” d‟un Camus (L’Etranger, 1943), et
d‟intégrer avec mesure le lyrisme de ces Noces qui exaltent d‟un même
mouvement une “ nature ” maîtresse femme accueillant en son sein (holding
à couper le souffle) une humanité ingrate, gâcheuse, “dé-naturée”, “ nihiliste
”, et une exigence de “ vérité ” qu‟exténuent les intempérances et logorrhées
médiatiques. Mais, étant posé un lyrisme bien tempéré, il faudrait bien et
surtout et plus que jamais en pareille “ voie ” aussi antique voire préhistorique
que futuriste prendre à bras le corps les “ fureurs ” de l‟époque et ses
bouffées de délires et cortèges de souffrances (algies) toujours
recommencées. [Et le -t- central de “ Noces-t-algie ”, sur lequel pivotent les
deux grandes puissances humaines de l‟accord (avec la “ nature ”) et du mal
(dans l‟ ” histoire ”), pourrait, chevillé au corps de l‟expression, désigner une
fonction “ t ” du temps qui marquerait avec force la spécificité de chacune des
étapes et formations créatrices ou criminelles de l‟odyssée humaine].
On a si souvent joué sur l‟homonymie française mer-mère qu‟on a
scrupule à reprendre les annonces faites à Mère Méditerranée. Laquelle est
bien une belle et sale tête de Janus. “ Mauvaise mère ”, du genre de celles
dont se plaignent patients sur divan analytique ou comédiens sur scène
tragique - elle l‟est, avec une constance et une férocité qui médusent (qui
Médée-usent): sur ses rivages, et les terres antérieures, et les plus hautes
eaux, le sang, où que ce soit, n‟a cessé de couler, et la haine et le crime de
fleurir – et sang et haine et crime se cherchent toujours, sans relâche, et les
trouvent, de nouveaux terroirs et foyers, et ils n‟ont que l‟embarras du choix.
La Rome, dont retentissait au début de notre esquisse le “ Mare nostrum ”, “
s‟origina ”, comme aiment dire les psychanalystes friands d‟originaire,
lorsque Romulus et Remus, deux chenapans, collèrent leur bouche vorace à
l‟octuple téton d‟une miraculeuse Mère Louve. Tu parles d‟un miracle ! Le lait
tourna en sang, et Rome vint au monde quand Romulus liquida illico presto
son frère Remus. Hydre Méditerranée: un foyer ici s‟éteint – s‟allume un
autre là. D‟une rive à l‟autre du grand Bassin, d‟Ouest en Est et du Nord au
14
14
Sud et d‟un siècle à l‟autre et d‟une génération à l‟autre, violences,
désolations, incendies, bûchers, famines, pillages, assassinats, massacres,
expulsions, génocides, ethnocides, abominations (avec, presque toujours, en
première ligne, ces fameuses “ nations ” et “ communautés ”)
s‟accomplissent, se répondent, s‟échangent, se conjuguent, s‟exacerbent, se
dépassent, se surpassent. Azur rouge sur toutes les Méditerranées.
Et pourtant, sinon “ bonne-mère ”, comme l‟annonce tel accent du
sud, phocéen, du moins mère encore “ suffisamment bonne ”, good enough,
ô cher Winnicott, pour entendre une pressante et désirante demande.
Chaque jour, sur la mer ineffable, homérique, une “ aurore aux doigts de rose
” se lève. Dans l‟eau même souillée, avec ses plaques de visqueux
mélanomes qui font (sur trafics maritimes néfastes autant que fructueux)
s‟élever dans le ciel bleu des tours pharaoniques dont une seule suffirait à la
survivance, alimentaire, politique ou médicale, de tout un peuple, le corps et
l‟âme retrouvent d‟inouïes caresses, plongent dans la lovante vague d‟une
maternelle nostalgie; et le regard, convié à une soudaine numineuse noce,
reconnaît encore “ l‟azur l‟azur l‟azur ” qu‟il boit qu‟il boit qu‟il boit tel un lait
bleu purificateur–lustrale eau de jouvence.
Comment nommer cette soif, ce désir – proprement originaires ? Si
tentaculaire, surchargée, polymorphe et perverse est la monumentale
archéologie de la Méditerranée que qui parle de “ Renaissance ” doit aller au
plus profond de la “ naissance ” (du sujet, mais peut-être aussi de l‟humanité
même), s‟employer à sonder et creuser encore plus avant dans nos âmes
asséchées, assoiffées, aux abois, pour atteindre quelque source maternelle
première, une primordiale offrande de la vie même… Le seul nom qui nous
vienne présentement aux lèvres est celui de Colostrum (de la colossale
Rome au mammaire colostrum, c‟est “ poétique ” écoulement du “ nostrum ”,
abyssale chute en Mère Méditerranée !) - Colostrum, merveilleuse sécrétion
lactée, d‟un jaune solaire, puissance protectrice, qui, portée aux lèvres du
nouveau-né à ses tout premiers jours, constitue le plus précieux et gracieux
rite de passage pour l‟entrée dans le monde et l‟amour.
Rêver la Méditerranée comme “ Mare colostrum ”, nourrice première
pourvoyeuse d‟un “ tout est bon ”, relève sans doute du fantasme, raciné
profond, d‟un devenir-nourrisson (G. Groddeck, 1923) – mais il faut au moins
“ cela ” pour être à la hauteur, abyssale, de l‟actuelle et effarante
dessiccation de l‟âme.
15
15
Riferimenti bibliografici
MARIJA GIMBUTAS, Le langage de la déesse (1989), éditions Des
femmes, 2005.
GEORG GRODDECK, Le Livre du ça (1923), Gallimard, 1976. Autre
titre: Au fond de l’homme, cela. Le livre du ça, Gallimard, 1963.
16
16
MICHAIL BACHTIN, UN FILOSOFO IN DIALOGO
CON LA FILOSOFIA DELLA SUA EPOCA
*
di Luciano Ponzio*
Abstract
Bakhtin describes himself as a philosopher, and his approach to all disciplines – such
as linguistics, philology, psychology, sociology, literary criticism, semiotics, etc. –, that
come into play in his research, as a specifically “philosophical approach”. The properly
philosophical orientation of Bakhtin's philosophy is determined by his shift in focus
beyond specialist boundaries. Bakhtin develops his research beyond the conventional
boundaries of any single discipline, with an interdisciplinary interest, a dialogical
disposition, and at once a theoretical attitude capable of radical criticism. Among his
philosophical references, apart from Kant and the exponents of neokantinism, there are
Hegel, Kierkegaard, Husserl, Splenger, Bergson, Dilthey, Zimmel, Schopenhauer,
Nietzsche, whose thought he draws from and revises in an original way.
Bakhtine, quand il en a l'occasion, se déclare “philosophe”. L'objet dont Bakhtine
s'occupe dans sa recherche se situe au point de contact et d'interaction de disciplines
variées. Ceci ne peut donc être qualifié ni de linguistique, ni de philologique, ni d'ordre
critico-littéraire, ou sociologique, ou sémiotique, et cætera. Étant situé irréductiblement
hors du champ spécialisé, il présente en même temps tous ces aspects et nécessite le
dialogue, la confrontation, la collaboration entre les discours des secteurs disciplinaires
variés, et c'est précisément pour cela que la manière la plus adéquate pour définir
l'analyse qui s'en occupe est celle qui la qualifie de “philosophique”. En ce qui
concerne de façon spécifique la philosophie de Bakhtine, nous trouvons parmi ses
auteurs de référence – en plus de Kant e des représentants du neo-kantisme – Hegel,
Kierkegaard, Husserl, Splenger, Bergson, Dilthey, Zimmel, Schopenhauer, Nietzsche,
desquelles il reprend la pensée en l‟élaborant de façon originelle.
Bachtin in molteplici occasioni si definisce un filosofo, così come definisce “filosofico”il
suo approccio alla ricerca in discipline come la linguistica, la filologia, la psicologia, la
critica letteraria, la sociologia, la semiotica eccetera. L‟orientamento della filosofia di
Bachtin è determinato dallo spostamento del focus oltre i confini dell‟ambito
specialistico. Egli sviluppa la propria ricerca ben oltre i confini convenzionali di ogni
singola disciplina, con interessi interdisciplinari, disposizione dialogica e atteggiamenti
*
Ricercatore in Filosofia e teoria dei linguaggi nella Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere dell‟Università del Salento, Lecce, dove insegna Semiotica del testo.
17
17
teorici capaci di attuare una critica radicale. I suoi riferimenti filosofici, oltre a Kant e al
neokantismo, sono hegel, Kierkegaard, Husserl, Splenger, Bergson, Dilthey, Rimmel,
Shopenhauer, Nietzsche, dei quali rivisitò il pensiero in maniera assolutamente
originale.
_____________________________
1. Filosofia come incontro di parole
L‟intento di questo testo è approfondire un aspetto trascurato
generalmente negli studi dell‟opera di Michail M. Bachtin. Bachtin è stato
soprattutto considerato un teorico e un critico della letteratura. E ciò è anche
giusto, ma comporta una visione parziale che finisce con essere non solo
riduttiva ma anche travisante rispetto alla prospettiva specifica e
all‟orientamento fondamentale della ricerca bachtiniana. Questa prospettiva e
questo orientamento adeguatamente considerati nella loro peculiarità vanno
caratterizzati come “filosofici”. Benché, per il suo interesse per la scrittura
letteraria, Bachtin sia stato visto generalmente come un teorico della
letteratura, egli stesso, invece, si considerò sempre un filosofo. “Sì, filosofo.
E così sono anche restato fino ad oggi. Sono un filosofo”: così dice Bachtin
nelle conversazioni che si svolsero tra il 22 febbraio e il 23 marzo del 1973
tra lui e Viktor D. Duvakin.
Per tutta la sua vita egli si è sempre occupato di questioni filosofiche
e lo stesso interesse per la letteratura e per il rapporto tra “autore” ed “eroe”
ebbe inizio a partire dal problema della responsabilità (“Arte e responsabilità”,
del 1919, è il suo primo scritto di cui abbiamo notizia) e dall‟interesse per la
filosofia morale (come sappiamo da un altro dei suoi primi scritti, il saggio
degli inizi degli anni Venti pubblicato soltanto nel 1986 e tradotto in italiano
con il titolo Per una filosofia dell‟atto responsabile.
Non perde occasione Bachtin per dichiarare che la sua ricerca ha un
carattere eminentemente filosofico. E ciò non solo nei suoi scritti iniziali, dove
afferma che gli interessa particolarmente la filosofia morale e dove indica
l‟etica come “filosofia prima”, ma anche in tutto l‟arco della sua vita. Così per
esempio, in Problema del testo (1959-1961) egli esordisce dicendo che, in
quanto ciò di cui intende occuparsi si colloca al confine tra discipline diverse,
fuori dalle chiusure specialistiche, la sua analisi è “filosofica”.
Ciò che egli denomina, nella seconda edizione di Dostoevskij
(1963), metalinguistica, per indicare il proprio tipo di analisi, può essere
senz‟altro indicato come “filosofia del linguaggio”. L‟espressione “filosofia del
18
18
linguaggio” è già nel titolo del libro del 1929 con Valentin N. Vološinov,
Marxismo e filosofia del linguaggio. Qui “filosofia” caratterizza un
atteggiamento critico, in base al quale lo stesso marxismo dell‟epoca andava
considerato e discusso soprattutto per liberarlo, come Bachtin e Vološinov
esplicitamente dicono, da “categorie meccanicistiche” caratteristiche di un
“materialismo meccanicistico predialettico” e da un sociologismo positivista
che considera i “fatti”, come dati indiscutibili.
Bachtin è soprattutto interessato alla scuola di Marpurgo. Alla
filosofia di Cohen, Natorp, Casirer, cioè a quell‟orientamento che va sotto il
nome di neokantismo, ma egli ne prende le distanze in maniera critica. La
concezione cassireriana dell‟“uomo come animale simbolico” trova la sua
radicalizzazione e inveramento nella filosofia di Bachtin in quanto filosofia del
linguaggio. Ma, al tempo stesso Bachtin tiene conto della lezione di Marx,
spesso direttamente nominato nei testi suoi e del suo circolo, secondo cui il
linguaggio è la coscienza, reale, pratica, esistente anche per altri uomini e
dunque la sola esistente anche per me stesso.
Come sappiamo dalle sue conversazioni del 1973 con Duvakin, la
sua profonda conoscenza della filosofia europea avviene per Bachtin da
autodidatta. È per conto proprio che Bachtin legge, a parte la filosofia
classica, testi di filosofia moderna e a lui contemporanea, testi che non solo
non erano tradotti in Russia ma di cui non era neppure nota l‟esistenza. Anzi
egli sostiene che la formazione di ciascuno debba sempre avvenire
studiando per conto proprio, sempre, perché le istituzioni scolastiche, ufficiali,
per quanto valide, non possono, in realtà, dare un‟istruzione che possa
soddisfare pienamente l‟esigenza di approfondimento e aggiornamento di
cisacuno, a meno che non si voglia diventare un semplice “funzionario del
sapere”. Bachtin leggeva i libri filosofici soprattutto in lingua tedesca, sia che
si trattasse di testi originali o di traduzioni.
L‟interesse di Bachtin per la scuola di Marburgo risale già al periodo
di studio a Odessa, interesse comune a lui e al fratello Nikolaj, ed è quindi
antecedente alla conoscenza, avvenuta a Nevel‟ nel 1918, di Matvej I.
Kagan, uno degli amici più intimi di Bachtin, che aveva studiato filosofia in
Germania, a Lipsia, a Berlino e a Marburgo frequentando il maestro della
scuola neokantiana, Hermann Cohen, ed anche P. Natorp ed E. Cassirer.
Sappiamo che Bacthin nel 1918 a Nevel‟ tiene un breve corso di filosofia per
“l‟intelligencija locale”, concentrando l'attenzione su Kant e il neokantismo:
Cohen, Rickert, Natorp, Cassirer (v. la “Sesta conversazione” con Duvakin).
Nel periodo di Nevel‟, Bachtin si occupa anche di filosofia della
musica, di estetica musicale, del rapporto fra musica e mito, rifacendosi a
Hegel e soprattutto a Schelling, tematiche riprese da Lev V. Pumpjanskij, nei
suoi corsi di filosofia della musica. Nel circolo filosofico di Nevel‟, dove c‟è
19
19
anche Vološinov (che raggiunge Nevel‟ nel 1919) e Boris Michailovic
Zubakin, si svolgono discussioni su argomenti filosofici: sul rapporto tra
crisianesimo e socialismo, arte e socialismo, sul senso della vita, sul senso
dell‟amore, sul rapporto tra Nietszche e il cristianesimo, su Leonardo da Vinci
la concezione del mondo
Come abbiamo detto, l‟interesse principale di Bachtin, già a Nevel‟,
è la filosofia morale, e sappiamo dalle sue conversazioni con Duvakin che,
durante le lunghe passeggiate con Marija Veniaminovna, Pumpjanskij e
Kagan, egli esponeva la sua “filosofia etica” e che il lago, a dieci chilometri da
Nevel‟, sulle sponde del quale i tre sedevano per conversare di filosofia, fu da
loro chiamato "Lago della Realtà Morale". Sappiamo anche che
successivamente nel 1920 a Vitbesk, dove agli amici di Bachtin si
aggiungono Pavel N. Medvedev e Ivan Ivanovi∫ Sollertinskij, tiene una serie
di conferenze pubbliche, tra le quali: Il momento morale nella cultura, La
parola, La filosofia di Nietzsche.
Molto presto Bachtin, sicuramente già nel periodo di Nevel‟, si
discosta dalla filosofia kantiana e neokantina, come risulta sia dalle sue
relazioni tenute in varie occasioni tra i suoi amici o, pur sempre in forma
privata, in circoli più ampi, sia nel suo scritto degli inizi degli anni Venti, K
filosofii postupka [Sulla filosofia dell‟atto] (1920-24, trad. it. 2009).
Un altro autore precocemente noto a Bachtin, e quasi del tutto
sconosciuto a quell‟epoca in Russia, è Søren Kierkegaard, di cui risente
particolarmente la sua concenzione della singolarità e del problema della
scelta. Un concetto chiave di tutto il discorso di Bachtin degli scritti degli inizi
degli anni Venti, ma di cui anche, direttamente o indirettamente, risente il suo
studio su Dostoevskij del 1929, è edinstvennji, singolare, unico, irripetibile,
eccezionale, incomparabile, sui generis, corrispondente al tedesco einzig.
Der Einzige und sein Eigentum si intitola l‟opera (1844) di Max Stirner, ma
per Bachtin, a differenza dell‟individuo egoista di Stirner, l‟unicità, la
singolarità, implica il rapporto con l‟altro, è essa stessa alterità. Ed è appunto
questa sua implicazione e questo suo coinvolgimento che distinque la
singolarità dell‟esistenza di ciascuno secondo Bachtin da “il singolo”di Søren
Kierkegaard, autore di cui egli sottolinea la vicinanza a Dostoevskij per il tipo
di problematica da entrambi affrontata e per la stessa profondità (M. Bachtin,
1973: p.115). Qualche rapporto con l‟incontro, avvenuto abbastanza presto,
con l‟opera di Kierkegaard ha certamente l‟attenzione di Bachtin per il
concetto di ironia, come “forma del tacere”, come dissidenza nei confronti del
discorso dominante e come modalità dello scrittore caratterizzato dal suo
“parlare indiretto”, come Bachtin sottolineava ancora negli scritti degli ultimi
anni, come gli negli appunti del 1970-1971.
20
20
2. Costruzione della parola filosofica come traduzione
Bachtin costruisce il suo linguaggio in russo, per poter parlare dei
problemi filosofici che lo interessano fin dall‟inizio della sua ricerca,
traducendo fondamentalmente dal tedesco. Sul calco del tedesco egli
costruisce tutta una serie di vocaboli che fanno parte del suo idioma, e che
non sono adeguamente comprensibili e traducibili in altre lingue se non se ne
conosce la provenienza. Bachtin, nei suoi primi scritti, inventa il proprio
idioma filosofico sulla base del linguaggio filosofico circolante fuori dalla
Russia, soprattutto tedesco. Tra i suoi autori di riferimento, oltre a Kant e ai
rappresentanti del neokantismo: Hegel, Kierkegaard, Husserl, Splenger,
Bergson, Dilthey, Zimmel, Schopenhauer, Nietzsche, il cui pensiero egli
riprende e rielabora in modo originale.
Bachtin fa ricorso alla parola russa obraz per rendere ciò che in
tedesco è Bild, Gebild, “immagine”, “configurazione”. Impiega
dolzenstvovanie per riferirsi al dovere nel senso del Sollen kantiano, a ciò
che mi obbliga. Introduce l‟espressione ucastnoe myslenie, pensiero
partecipativo, non indifferente, tedesco teilnehemendes Denken, Distingue
“dannost‟” e “zadanost‟”, ciò che è dato e ciò che è dato da fare, da
conseguire, che è dato come compito, equivalenti, in tedesco, a aufgegeben
e gegeben.
Riprende il concetto di Lebenphilosophie, filosofia della vita, ma
orientandolo in una direzione ben diversa dal “vitalismo contemporaneo”,
titolo del suo saggio pubblicato nel ‟26 in una rivista di biologia sotto il nome
del suo amico biologo Ivan I. Kanaev, dove, anche con riferimento a
Bergson, ne aveva fatto oggetto di critica, ma sempre, va detto, in maniera
costruttiva.
Riprende il concetto kantiano di “architettonica” concependolo come
dispositivo spazio-temporale e assiologico di organizzazione del momdo
incentrato intorno a un io nel suo rapporto singolare con gli altri e con gli
eventi . In base alle sue letture filosofiche conia i concetti centrali della sua
ricerca quali trasgrediente, exotopico, extralocalizzazione, “vnenakodimost‟”.
3. Coscienza, ideologia, responsabilità
Oggetto di discussione nel circolo di Bachtin, per lo meno già nel
1924-1925, nel periodo in cui di esso fanno parte, oltre a Pumpjanskij,
Judina, Vološinov, Medvedev, anche M.I. Tubjanskij, il biologo Kanaev, K. K.
Vaginov, è anche Sigmund Freud e il freudismno soprattutto per quanto
21
21
concerne le implicazioni filosofiche della psicoanalisi. In Freudismo,
pubblicato nel ‟27 sotto il nome di Vološinov, autore del saggio del 1925 Po
tu storonu sotstial‟nogo: o freidzmi [Dalla parte opposta del sociale:
Freudismo], si considera soprattutto il rapporto tra linguaggio, inconscio e
ideologia sociale, svolgendo una critica costruttiva e tutt‟ora attuale e valida
dei presupposti filosofici della psicoanalisi. Essa, soprattutto per il rapporto
che stabilisce tra inconscio, linguaggio e ideologia, anticipa, ma con apporti
originali, la reinterpretazione della psicoanalisi da parte di Jacques Lacan e la
critica a Freud di Gilles Deleuze e Felix Guattari. L‟interesse per Freud, per
quanto riguarda sia l‟inconscio, sia la seduta psicoanalitica, è evidentemente
collegato con la concezione bachtiniana del carattere dialogico dell‟io e della
parola attarverso la quale l‟io si costituisce, prende coscienza di sé, compie
le sue scelte e si manifesta a se stesso e agli altri.
Per il rapporto di continuità che Bachtin individua fra inconscio,
coscienza e ideologia sociale, lo studio delle ideologie non può trovare la
propria base nella psicologia, ma al contrario è la psicologia che deve basarsi
sullo studio dell‟ideologia sociale. Sicché, Bachtin insieme a Vološinov, nel
libro del 1929, discute ampiamente e critica la teoria di Dilthey di una
psicologia onnicomprensiva e interpretativa che fornirebbe la fondazione
delle scienze umane.
Come abbiamo anticipato, ben presto Bachtin prende le distanze da
Kant e dai neokantiani, che accusa di teoreticismo, cioè di “astrazione del
mio singolare io”. Il difetto principale dell‟etica formale di Kant e dei
neokantiani sta, secondo Bachtin, nel fatto che essa non riesce a liberarsi del
difetto dell‟“etica materiale”, che consiste nella concezione dell‟universalità
del dover essere.
La categoria del dovere è intesa, da Kant e dai neokantiani in
termini di una categoria universale, pertanto in termini conoscitivi, astratti,
sicché la coscienza morale diviene coscienza teorica, teoreticizzata. Poiché
l‟imperativo è concepito anche dall‟etica formale kantiana come universale ed
è subordinato alla sua capacità di essere universale, la filosofia kantiana e
quella neokantiana non sono in grado di rendere conto dell‟atto singolare.
Dalla responsabilità morale senza alibi, in cui ciascuno si trova nel
posto che occupa insostituibilmente nel mondo e di fronte agli altri, si può
certamente tentare di fuggire, dice Bachtin in Per una filosofia dell‟atto (19201924) riparandosi dietro alla responsabilità speciale, relativa, di ruolo. Ma
staccata dalla responsabilità assoluta, la responsabilità speciale perde di
senso, diviene pura responsabilità tecnica, semplice rappresentanza di un
ruolo, semplice esecuzione, fino a presentarsi come impostura.
Bachtin individua la crisi contemporanea nello scadimento
dell‟azione ad azione tecnica nella separazione fra l‟atto, divenuto privo di
22
22
motivazione, e il suo prodotto, che in tal modo perde di senso. È questa
un‟interpretazione molto vicina a quella della fenomenologia di Edmund
Husserl, ma in Bachtin, diversamente da quanto avviene in Husserl che fa
appello alla coscienza intenzionale, il senso è conferito dall‟azione
responsabile che risponde all‟unicità di ciscuno nel proprio essere al mondo
senza alibi. Per Bachtin “la filosofia della vita può essere solo una filosofia
morale”.
Inoltre Bachtin mette in evidenza come lo svuotamento di senso e la
degradazione della azione conduca inevitabilmente a cercarne una
motivazione biologica ed economica elementare, a fare appello alla nuda
individualità biologica, l‟atto-bisogno. Nell‟esaminare tale aspetto, Bachtin si
riferisce esplicitamente a Spengler, del quale evidenzia l‟incapacità di
riconoscere la teoria e il pensiero momenti all‟azione anziché il suo opposto.
4. Un dialogo ininterrotto con la filosofia contemporanea
In Per una filosofia dell‟atto responsabile, Bachtin attribuisce alla
filosofia morale il compito di descrivere “la concreta architettonica” incentrata
sul singolo reso unico dalla suo essere assolutamente insostituibile nella
responsabilità a cui l‟evento del suo esistere senza alibi, lo pone di fronte.
Tale descrizione presuppone che essa si realizzi a partire da una posizione
esterna, extralocalizzata, exotopica, altra, differente e al tempo stesso non
indifferente, ma a sua volta partecipativa. Si danno così due centri di valore –
reciprocamente altri dal punto di vista spazio-temporale e assiologico –
quello dell‟io e quello dell‟altro, che sono “i due centri di valore della vita
stessa”, intorno ai quali si costituisce l‟architettonica dell‟atto responsabile.
Ebbene è nella scrittura letteraria che Bachtin trova realizzata tale
descrizione che la sua filosofia morale si propone nei confronti della
architettonica, dato che proprio essa instaura un rapporto che permette il
mantenimento dell‟alterità di tale architettonica considerandola da un punto di
vista trasgrediente, extralocalizzato, exotopico, a sua volta unico e altro.
Ecco dunque spiegato l‟interesse, prettamente filosofico, del rapporto fra
autore ed eroe nell‟ambito del testo letterario, a cui Bachtin dedicherà grande
spazio in tutta la sua ricerca.
L‟interesse per la filosofia, in tutti i suoi aspetti e problematiche,
attraversa l‟opera bachtiniana. Interessato soprattutto alla filosofia morale e
all‟estetica, egli esamina e discute, soprattutto in rifermento a questi due
ambiti, le posizioni teoriche di Bergson, Nietzsche, Rickert, Cohen, Husserl,
Schopenhauer, Spengler. Troviamo citati questi autori in Per una filofia
dell‟att responsabileo. Ma anche in L‟autore e l‟eroe nell‟attività estetica
23
23
(1924) si fa esplicito riferimento ad alcuni di essi per quanto riguarda la loro
posizione nei confronti dell‟estetica: Cohen, Bergson, Schopenhauer e inoltre
a Hegel e a Schelling.
Negli appunti del 1971 ritorna la discussione, già presente negli
scritti giovanili, della concezione delle scienze umane (le scienze dello
spirito) in Dilthey, di cui Bachtin critica la netta contrappozione con le scienze
naturali, contrapposizione, osserva Bachtin, confutata dall‟ulteriore sviluppo
delle scienze umane stesse.
In Per una metodologia delle scienze umane (1974) riprende il
problema posto da Dilthey circa la comprensione sostenendo che la
comprensione ha un carattere inevitabilmente dialogico e si realizza come
incontro, come evento, il quale evento ha come momento necessario la
valutazione. A proposito dell‟incontro, che definisce come “il momento
supremo della comunicazione”, Bachtin cita Jaspers di Philosophie (2 voll.
1932), in cui il rapporto tra incontro e comunicazione è direttamente
considerato. C‟è in Dilthey, dice Bachtin, un non interamente superato
monologismo. La dialettica monologica di Hegel, esemplificata nel
monologismo della Fenomenologia dello spirito, permane. E permane anche
nel cosiddetto “materialismo dialettico”.
La dialettica, dice Bachtin negli Appunti del 1970-1971, si ottiene
eliminando le voci e il loro rapporto con la materialità del corpo e del
linguaggio, trasformando le repliche in contrapposizioni di idee e di concetti
astratti. Si ottiene così, come egli precisa in Per una metodologia delle
scienze umane (1974) un testo continuo, in cui scomparsa l‟alternanza delle
voci e il contatto dialogico tra testi e rimane un contatto di opposizioni senza
più l‟apertura verso un senso profondo e infinito.
Di Spengler, a cui, fin dagli scritti iniziali, Bachtin aveveva prestato
particolare attenzione, pur mostrandone i limiti, viene considerara, in
Risposta a una domanda del Novyj Mir (1970), la concezione della cultura
come un circolo chiuso, anziché, come Bachtin afferma più volte, come unità
aperta. Tuttavia Bachtin riconosce a Spengler, malgrado questa concezione
della cultura come qualcosa di compiuto, il merito di aver scoperto, nella sua
analisi della cultura classica, nuove modalità di senso, partecipando alla
grande impresa della “liberazione dell‟antichità classica dalla prigionia del
tempo”.
Non mancano riferimenti anche ad Heidegger negli appunti del
1970-71, dove Bachtin osserva che lo scrittore primario non ha una parola
diretta, e a nome suo non dice nulla, ovvero indossa la veste del tacere.
Semmai, egli aggiunge, citando Heidegger, sarebbe meglio dire che l‟essere
stesso parla attraverso lo scrittore. Adottando le diverse forme del tacere
(l‟ironia, la metafora, l‟allegoria, la parabola, la parodia), lo scrittore può
24
24
scegliere anche “la via di far parlare il mondo e prestare ascolto alle parole
del mondo (Heidegger)”.
Tuttavia, la concezione bachtiniana ci sembra incompatibile con
l‟ontologia heideggeriana, e già in Per una filosofia dell‟atto, è possibile
trovare, attraverso la critica al “dionisismo” di Nietzsche, una sorta di critica
ante litteram dell‟ontologia di Heidegger, là dove Bachtin osserva che la
partecipazione di ciascun esistente umano al proprio mondo nel suo insieme
non coincide con una irresponsabile auto-resa all‟essere, con l‟essere
posseduti dall‟essere.
Complessivamente considerata la filosofia bachtiniana consiste nel
porre in dialogo – un dialogo sostanziale e non formale – sfere e ambiti
generalmente considerati separati: mondo umano e mondo naturale, arte e
vita, verbale e non verbale, generi letterari e generi del parlare ordinario,
scienze umane e scienze naturali, psiche individuale e ideologia sociale,
discorso proprio e discorso altrui, responsabilità tecnica e responsabilità
morale, parola e corpo, dialogo dostoevskiano e corpo grottesco rabelesiano.
Tutto questo è sintetizzato nella frase “La vita per sua natura è dialogica.
Vivere significa partecipare a un dialogo” (“Piano per il rifacimento del libro su
Dostoevskij”, 1961, in Bachtin 1979).
Questa formula, da una parte, può essere usata come epigrafe della
filosofia bachtiniana, dall‟altra dice come questa filosofia sia aperta all‟altro,
all‟alterità, sia rivolta all‟ascolto, in un dialogo ininterrotto non solo con il
proprio tempo, con la contemporaneità, ma anche con “un tempo grande”. Ed
è proprio l‟orientamento, fin dall‟inizio, verso la parola letteraria, la quale
proprio nel “tempo grande” vive, a fare della filosofia bachtiniana una filosofia
in dialogo con il nostro tempo.
5. Critica letteraria e critica filosofica
Il contributo complessivo dato da Bachtin con la sua opera può
essere valutato in termini di “critica”. Questa nozione è stata spesso,
interpretando Bachtin, erroneamente limitata, alla “critica letteraria”,
riducendo Bachtin a un critico della letteratura o, talvolta, dell‟arte in
generale. “Critica”, nel caso di Bachtin, non vale, almeno non unicamente, in
senso letterario, anche se egli dette una grande importanza al punto di vista
della letteratura; ma ciò sempre subordinatamente ai suoi interessi per la
filosofia del linguaggio o, secondo l‟espressione che pure usa, per la
“metalinguistica”.
Certamente Bachtin ha segnato una svolta anche nel campo della
teoria e della critica della letteratura, mostrando in cosa consista la sua
25
25
“letterarietà” e in che modo da parte della critica letteraria esso vada letto e
interpretato nella sua “specificità” di testo letterario, non riducendolo a un
documento storico, a un reperto filologico e neppure (come fa Lotman) a una
componente o a una espressione di una data cultura considerata come un
sistema nelle cui strutture e nella cui sincronia (la contemporaneità) esso
rientri (Bachtin nei suoi scritti dei primi anni Settanta, quali gli Appunti, la
Risposta alla rivista “Novyj mir” e “Per una metodologia delle scienze
umane”. prende esplicitamente posizione contro la “segregazione del testo”
tramite categorie meccaniche quali “opposizione”, “avvicendamento dei
codici”).
Il contributo di Bachtin è principalmente alla “critica” intesa in senso
filosofico. Si tratta precisamente della ripresa da parte sua del concetto di
“critica” dopo Kant e Marx.
Bachtin mostra che la critica, sia nel senso kantiano di critica della
ragione pura, di ricerca delle condizioni di possibilità, sia nel senso marxiano,
di critica delle ideologie e in particolare dell‟economia politica cui sono
direttamente o indirettamente collegate, non possono prescindere dalla
filosofia del linguaggio, da una rinnovata interpretazione tra lingua e parola,
da una riconsiderazione del ruolo del segno, verbale e non verbale, per la
formazione delle idee, della “coscienza ufficiale” e della “coscienza non
ufficiale”, o del cosiddetto ”inconscio”.
La cosiddetta “coscienza di classe” e la cosiddetta “falsa coscienza”
non esistono fuori dal linguaggio, dai luoghi ufficiali del discorso, dagli
stereotipi, dalle intenzioni e pregiudizi che abitano le parole che normalmente
usiamo. Soprattutto è la dimensione dialogica delle parole che, secondo
Bachtin, va recuperata in una critica in senso filosofico che tenga conto della
“materia linguistica” di cui le idee sono necessariamente fatte.
La ragione umana è una “ragione dialogica”. Da ciò la critica della
ragione, condotta tenendo inevitabilmente conto della critica nel senso di
Kant e nel senso di Marx, non può più prescindere, anche per la
complessificazione in atto della cultura e per l‟incidenza sempre maggiore
che la parola svolge nella sua conservazione e nel suo mutamento,
nell‟ottenimento del consenso, nella formazione e nella diffusione delle
ideologie, in qualsiasi atto decisionale, in qualsiasi scelta sia che riguardi se
stessi sia che riguardi gli altri, sia che riguardi il “mondo degli oggetti”.
I valori, morali, religiosi, politici, economici, non sussistono fuori
dalla materia del linguaggio e dallo scambio dialogico delle parole, il quale
consiste in un coinvolgimento tra parola propria e parola altrui, e all‟interno
del discorso proprio fra identità e alterità, indipendentemente dalla volontà e
dalla consapevolezza di ciascuno. Ciascuno vi si trova coinvolto nella sua
responsabilità senza alibi dovuta alla inalienabile alterità.
26
26
Tale alterità si presenta proprio nel linguaggio come irriducibile
materialità nei confronti dell‟identità sia essa individuale, come quella di una
coscienza o di un io, o collettiva come quella di una comunità o di una lingua
o di un sistema culturale. Con questo spostamento del centro dall‟identità
all‟alterità, Bachtin effettua, rispetto alla critica kantiana, un‟ulteriore
rivoluzione copernicana, in base alla quale la critica bachtiniana della ragione
è la messa in discussione non soltanto dell‟orientamento dominante della
filosofia occidentale, ma anche di quello della logica della ideologia
dominante nella contemporaneità.
Alla interpretazione in senso letterale e meccanicista della metafora
marxiana della struttura e sovrastruttura, Bachtin contrappone, anziché una
opposizione verticale – in cui per quanto intesa dialetticamente, perdura il
carattere deterministico da parte della cosiddetta “base economica” nei
confronti delle cosiddette “sovrastrutture ideologiche” –, un rapporto di ordine
effettivamente dialettico perché dialogico sul piano, questa volta, orizzontale
fra le facce di una sorta di Giano bifronte (figura ricorrente in Bachtin): il
rapporto fra cultura e vita.
Si tratta dell‟intrigo dialogico tra istituzioni, ruoli, identità, azioni e
ideologie ufficiali da una parte, e la singolarità di ciascuno nel rapporto con
se stessi, con il mondo e con gli altri, per il quale l‟atto, nella sua modalità di
evento irripetibile distinto dall‟azione come risposta semplicemente formale,
diventa decisivo; ovvero dell‟intrigo dialogico tra una responsabilità soltanto
formale, tecnica e quindi delegabile, la “responsabilità speciale”, e una
responsabilità sostanziale, senza alibi, non derogabile e non delegabile, la
“responsabilità morale”, che è quella di ciascuno nella sua singolarità, nel suo
posto unico in cui nessun altro può trovarsi, nella sua eccezionalità vissuta
che lo pone, come altro, in senso non relativo ma assoluto, in un rapporto
con l‟altro, fuori ruolo, fuori appartenenze, fuori identità.
Sul piano linguistico, alla responsabilità formale, generica,
indifferentemente intercambiabile, corrisponde il “significato”: l‟azione verbale
e non verbale ha un significato certamente e quel significato dice che sul
piano formale ciò che è detto e ciò che è fatto risponde o non risponde a
determinate regole di ordine normativo linguistico, etico, religioso, giuridico:
Ma ciò che manca è il senso, che può essere conferito solo dal fatto che
quell‟azione diventa l‟atto di un singolo determinato, in un determinato e
irripetibile contesto, all‟interno di una determinata architettonica unica con i
suoi specifici parametri temporali spaziali e assiologici, con le sue coordinate
fondamentali: io-per-me, io-per-altri, altri-per-me.
La validità di una norma, la verità di un giudizio non sono in grado di
spiegare la loro accettazione a tal punto da diventare criterio di scelta non
semplicemente formale – quella di cui è capace anche un impostore, chi
27
27
simula, chi agisce solo per salvare le apparenze, in conformità della propria
identità, appartenenza, ruolo, posizione –, ma sostanzialmente determinante
sul piano della vita singolarmente vissuta, da parte di chi non solo ne
comprende il significato ma, sottoscrivendolo, compiendo con ciò un passo
decisivo, un atto irreversibile, gli dà anche un senso.
Bachtin, a questo proposito, esplicitamente distingue, in Per una
filosofia dell‟atto responsabile, la propria concezione da quella di Heinrich
Rickert basata sull‟idea del dovere come suprema categoria formale, e
afferma, richiamandosi a Edmund Husserl che la veridicità teoretica non è
sufficiente affinché un giudizio diventi concretamente un dovere; per il
compimento del dovere in quanto ciò che io devo adesso, io soltanto e
nessun altro, non basta il riconoscimento della validità di un giudizio o di una
norma; l‟attuazione del dovere non è deducibile dalla proposizione che lo
afferma, ma si aggiunge ad essa dall‟esterno. Per passare dal
riconoscimento del dovere non solo all‟azione che si limita a compierlo ma
all‟atto che invece non solo lo compie, ma anche ne coglie il senso,
rinnovandolo e rendendolo vivo alla luce del contesto concreto in cui lo
riconosce come proprio, ci vuole un salto, e questo salto non può avvenire se
non sulla base della scelta del singolo. Anticipando quanto Husserl affermerà
in maniera approfondita e articolata nella Crisi delle scienze europee, Bachtin
osserva:
28
È terribile tutto ciò che è tecnico, una volta che sia astratto dall‟unità
singolare dell‟esistere di ciascuno e abbandonato alla volontà della
legge immanente del suo sviluppo; esso può improvvisamente
irrompere in questa unità singolare della vita di ciascuno come forza
irresponsabile, deleteria e devastante (M. Bachtin, 2008:p. 49).
Bachtin, nel considerare il rapporto io-altro, prende le distanze da
alcune posizioni abbastanza accreditate, tra le quali quella di Henry Bergson
basata sulle nozioni di “intuizione” e “immedesimazione”.
Queste due nozioni sono collegate. Con la nozione bergsoniana di
“intuizione” si afferma la possibilità di un rapporto immediato e diretto con ciò
che funge da oggetto fino alla compenetrazione, alla immedesimazione della
visione con l‟oggetto visto. Ciò vale anche nel rapporto con l‟altro: la
conoscenza partecipativa perviene alla coincidenza. all‟“immedesimazione”,
all‟“empatia”, La critica di Bachtin alla comprensione rispondente intesa e
descritta in termini di “immedesimazione”, di “empatia” ha nell'intera sua
opera – dall‟Autore e l‟eroe nell‟attività estetica fino ai suoi scritti degli anni
Settanta – un ruolo centrale per quanto riguarda la sua concezione la
partecipazione e il coinvolgimento con l‟altro.
28
La nozione di immedesimazione, non diversamente da un certo
estetismo cui è collegata, ha nei confronti dell‟estraneità il preconcetto della
possibiiltà del suo superamento. Bachtin, invece, fin dagli scritti degli inizi deli
anni Venti, insiste sul carattere “transgrediente” e di “exotopia” del rapporto
con l‟atro: l‟io e l‟altro sono reciprocamente extralocalizzati e nessuno dei due
può mettersi al posto dell‟altro, può mettersi nei panni dell‟altro. La
comprensione rispondente presuppone, secondo Bachtin, la distanza,
l‟unicità, la non intercambiabilità, l‟alterità, e non può mai diventare
coincidenza con l‟altro.
Il concetto di immedesimazione, come coincidenza con l‟altro,
comporta, dice Bachtin, ammesso che sia mai possibile, la perdita della
unicità del posto unico che ciascuno occupa al mondo e dunque presuppone
l‟affermazione del carattere inessenziale della mia unicità e dell‟unicità del
mio posto. Inoltre, egli aggiunge ironicamente, se mai potesse darsi
immedesimazione, il risultato sarebbe un “impoverimento”:c‟è uno solo là
dove c‟erano due.
Ben diverso dalla immedesimazione – come illusorio perdersi
nell‟altro, frutto dell‟astrazione teoreticistico-estetico che perde di vista le
singolarità esistenziali e che quindi è concretamente irrealizzabile – è l‟“atto
responsabile” dell‟abnegazione, la “sostituzione”, come dice Emmanuel
Lévinas fino al sacrificio di sé, all‟altro, come nella situazione di “ostaggio”,
dove l‟unicità, la singolarità, l‟insostituibilità, di chi compie l‟atto di
abnegazionhe cancellata ma anzi esaltata.
Fra l‟io e l‟altro, intercorre, per Bachtin, un rapporto di dissimetria, di
non reciprocità. Ciò rende la concezione di Bachtin del rapporto io-altro ben
diversa dalla relazione “io-tu” di Martin Buber, al quale invece Todorov rinvia
per spiegare la posizione di Bachtin.
La relazione con l‟altro in quanto centrata sulla responsabilità senza
alibi dell‟io comporta una ineliminabile asimmetria, una fondamentale non
convertibilità. che la differenziano nettamente dalla relazione io-tu di Buber,
che, come fa notare Lévinas (“Martin Buber” in Lévinas 1982), è reversibile e
somiglia alla relazione con l‟altro vista da un terzo non partecipe, per il quale i
ruoli di io e di tu possono essere scambiati e ciscuno può essere tu o io
indifferentemente. Ed è proprio questa non reciprocità, questa non
scambiabilità di posizioni tra l‟io e l‟altro, quando il punto di vista non è quello
di un terzo, ma quello dell‟io nella sua assoluta insostuibilità di centro
responsabile, che rende non valida l‟interpretazione dellla della relazione di
alterità in termini di empatia e di immedesimazione.
Non solo non valido ma anche sviante è l‟accostamento della
posizione di Bachtin per quanto riguarda il rapporto con l‟altro, a quella di
Sartre e di Heidegger (come invece lo stesso Todorov propone). Né l‟essere-
29
29
con (Mit-sein) heideggeriano né l‟essere-per sartriano (quest‟ultimo basato, in
L‟essere e il nulla, sul rapporto soggetto-oggetto), hanno qualcosa a che
vedere con la relazione bachtiniana di io-altro.
L‟altro non è strumentale alla manifestazione dell‟Essere, né è
riducibile a una categoria conoscitiva funzionale alla conoscenza di sé e al
raggiungimento della verità. L‟altro è trascendente rispetto all‟essere, e per
questo richiede a sua volta a chi si pone nei suoi confronti in una posizione di
ascolto, di comprensione rispondente, di assumere una posizione exotopica,
extralocalizzata, rispetto alle proprie maschere identitarie, alle proprie
appartenenze, ai luoghi comuni della propria contemporaneità. Bachtin dice
esplicitamente negli appunti del 1970-71 (M. Bachtin trad. it. 1979: pp. 354355), che il rapporto con l‟altro esce completamente fuori dalla sfera
dell‟essere, perché comporta non semplicemente il voler sentire che richiede
(e impone) il silenzio, ma presuppone l‟ascolto e la posizione complementare
del tacere; e perché nel rapporto con l‟altro, in cui interviene la posizione di
testimone e giudice, si passa dall‟essere al sur-essere (nadbytie), dal
significato al senso. Il rapporto con altri fuori ruolo, fuori identità, fuori dalla
responsabilità tecnica, formale, è fuoriuscita dall‟essere, dell‟essere-così del
Mondo, ed è la condizione della possibilità di emancipazione dalla “Realtà”
così come essa si presenta per la coscienza ufficiale, per l‟ideologia
dominante. È nella possibililità dell‟incontro con l‟altro la possibilità di
emancipazione dall‟essere, dall‟orine delle cose, dall‟ordine del discorso.
Da qui l‟importanza attribuita da Bachtin all‟artista, particolarmente
lo scrittore: la sua particolare exotopia gli consente, al tempo stesso, la presa
di posizione critica nei confronti dell‟attuale, della contemporaneità, e nello
stesso tempo la posizione di ascolto per una comprensione dell‟altro fuori
dall‟essere così delle cose:
L‟artista è appunto colui che sa situare la sua attività fuori dalla vita,
colui che non soltanto dall'interno partecipa alla vita (pratica, sociale,
politica, morale, religiosa) e dall'interno la comprende, ma che anche la
ama dal di fuori, là dove essa esiste per sé, dove essa è rivolta fuori di
sé e ha bisogno di un‟attività extralocalizzata e avulsa dal senso. La
divinità dell‟artista sta nella sua appartenenza a un‟extralocalità
suprema (Ivi, p.172).
Il dialogo tra arte e vita, il dialogo tra testi, tra i testi della vita
quotidiana e quelli artistici, tra rappresentazione ordinaria e raffigurazione
artistica, consiste nel loro reciproco dover rispondere gli uni degli altri. L‟arte
è provocata dalla vita e la vita è provocata dall‟arte, dice Bachtin fin dal suo
primo articolo del 1919 che su questo rapporto rifletteva. Si tratta di rivolgere
al mondo uno sguardo non impedito o distorto dalle abitudini che
30
30
impediscono di vedere e di ascoltare. E ci vuole la complicità di una
tavolozza in cui ci siano i colori della vita, perché si possano organizzare
tonalità e sfumature dalle intensità giuste e dagli accostamenti giusti in un
testo di scrittura che sorprende e sconfina malgrado strategie convenzionali
di difesa: difesa dalla non-indifferenza, dal coinvolgimento, dall‟ascolto,
dall‟incontro con l‟altro di sé e da sé.
6. Riflessione filosofica e parola riportata
Non è casuale che nel libro del 1929 con V. N. Vološinov, Marxismo
e filosofia del linguaggio Bachtin dedichi la terza e ultima parte all‟incontro di
parole, cioè all‟incontro tra parola propria e parola altrui, prendendo in esame
le diverse modalità di percepire e di riportare il discorso altrui. Questa parte è
indubbiamente bachtiniana (comunque si voglia risolvere l‟oziosa questione
della “paternità” di questo libro apparso sotto il nome di Vološinov) ed è
strettamente collegata con il primo capitolo della seconda parte del libro di
Bachtin su Dostoevskij, apparso lo stesso anno (1929), intitolata “Tipi della
parola prosaica. La parola in Dostoevskij” (M. Bachtin, trad. it. 1997: pp. 185214), dove mostra come il discorso indiretto libero svolga un ruolo centrale
nella tendenza attuale del romanzo che egli indica come “polifonica” e che fa
iniziare con Dostoevskij.
A differenza del discorso diretto e di quello indiretto, in quello
indiretto libero – o “discorso diretto improprio”, come Bachtin lo chiama –
avviene un‟interazione dialogica all‟interno di una stessa voce, quella
dell‟autore, fra discorso riportante (dell‟autore) e discorso riportato (dell‟eroe).
In una stessa enunciazione, il punto di vista del discorso riportante e quello
del discorso altrui riportato s‟incontrano. Qui la parola diviene a due o più
voci, interiormente dialogica o polilogica. Mentre nel discorso diretto e nel
discorso indiretto, il discorso altrui riportato è presente come oggetto del
discorso, il discorso indiretto libero fuoriesce dal rapporto soggetto-oggetto e
i due discorsi si incontrano e interferiscono fra loro senza che l‟uno diventi
oggetto dell‟altro.
Al discorso diretto riporta il discorso altrui tale e quale. Il discorso
indiretto per rendere il contenuto, l‟intonazione, il punto di vista, il senso del
discorso altrui è costretto ad assumere una forma discorsiva e analitica nei
suoi confronti. Mentre il discorso diretto si limita alla presentazione, il
discorso indiretto in qualche modo raffigura il discorso altrui. La necessità del
ricorso al commento, all‟interpretazione, all‟analisi impedisce che, nella forma
del discorso indiretto, il discorso altrui sia semplicemente riflesso, riprodotto,
rappresentato. Benché nel discorso indiretto ci sia l‟interferenza dialogica fra
31
31
il discorso proprio e il discorso altrui, è essenzialmente il discorso riportante a
dominare su quello riportato. Pertanto l‟orientamento del discorso indiretto è
generalmente monologico, come quello del discorso diretto. Invece, nel
discorso indiretto libero, non solo la parola dell‟autore, cioè la parola che
riporta, influisce su quella riportata, ma anche quest‟ultima modifica quella
che riporta, nel suo lessico, nella sintassi e nello stile. Il discorso indiretto
libero ha un carattere eminentemente dialogico. Soprattutto nell‟ambito della
scrittura letteraria, e particolarmente in quel tipo del genere romanzo che
Bachtin indica come “polifonico”, la parola dell‟autore e quella dell‟eroe, i loro
mondi, le loro intonazioni, punti di vista, orientamenti interagiscono
dialogicamente.
Queste riflessioni di Bachtin sul discorso indiretto libero sono state
riprese dal filosofo francese Gilles Deleuze non solo per quanto riguarda
l‟idea bachtiniana del discorso indiretto libero come forma essenziale del
nuovo romanzo inaugurato da Dostoevskij, ma anche del nuovo cinema nella
forma della “soggettiva libera indiretta” descritta e praticata da Pasolini.
Questo tipo di ripresa cinematografica attarverso l‟incontro di diversi pianisequenza, rende possibile, come fa nel romanzo il discorso indiretto libero,
l‟incontro di punti di vista differenti, di mondi differenti, di livelli differenti, di
triviale e nobile, di basso materiale corporeo e alto decoroso, di profano e
sacro, di quotidiano e fantastico, di prosaico poetico, di banale e di sublime.
Possiamo chiamare questo incontro di posizioni, di prospettive
differenti “narrazione lirica dialogica”. Tuttavia Bachtin in “La parola nella vita
e nella poesia”(M. Bachtin, trad. it. 1997: pp. 185-214) ha mostrato che la
capacità di alzarsi in “volo” della scrittura letteraria si trova già nella “parola
della vita”, nella parola prosaica, quotidiana. Nessuna contrapposizione,
dunque, per Bachtin, tra “lingua convenzionale” e “lingua poetica” (come
credevano invece i “formalisti russi”).
A meno che non ci si riferisca non alla “enunciazione”, cellula viva
del parlare, ma alla “frase”, cellula morta del sistema della lingua. Una
differenza questa che gioca un ruolo determinante per comprendere il
rapporto tra lingua e scrittura letteraria e che ha giocato – e gioca – brutti
scherzi ai linguisti quando non ne tengano conto quando parlano della
“parole” come messaggio codificato e da decodificare in base al codice
lingua senza tener conto della mediazione dei linguaggi interni alla lingua,
della sua inevitabile appartenenza (sempre) a un genere di discorso, del
senso, del contesto, del sottinteso, della sua specifica accentuazione,
dell‟enunciatore e del destinatario. Sia la linguistica cosiddetta “tassonomica”,
sia quella generativo-trasformazionele non conoscono altro che la frase,
risentendo del rapporto genealogico della linguistica con la filologia, la quale
è nata come studio di lingue morte. La frase, studiata dalla linguistica
32
32
tassonomica, diversamente dall‟enunciazione, non è di nessuno e non è
rivolta a nessuno; non ha né tempo né luogo; non esprime nessuna
valutazione, può essere ripetuta infinitamente restando invariata nella sua
accentuazione. È priva di senso, non ha contesto, non ha sottinteso, non ha
intonazione. Conseguentemente la linguistica della frase si interessa,
riguardo alle tre dimensioni del segno, soltanto della sintattica (concernente
sia la “prima articolazione”, quella della fonologia sia la “seconda
articolazione”, quella della sintassi) e della semantica (come studio del
significato astratto, fisso, fuori contesto) e ignorando la pragmatica, cioè ciò
che riguarda il senso, l‟orientamento della parola viva verso la comprensione
rispondente, la sua richiesta d‟ascolto, l‟intenzione che la muove e la anima.
L‟eccezioni ci sono naturalmente, ed anche i travisamenti nella vulgata della
stessa linguistica saussuriana. Ciò vale per lo stesso Saussure. Si può
parlare oggi di un "ritorno a Saussure", ricostruendo il “testo saussuriano”
rispetto al Corso di linguistica edito da Secheaye e Bally e rileggendolo una
volta liberato dalle distorsioni dei suoi redattori. Ci limitiamo a segnalare sotto
questo riguardo il rencente libro a cura di De Mauro (Saussure 2005), Nel
Saussure "originale" è ridefinita la stessa opposizione tra langue e parole: la
langue è vista come "deposito passivo", la parole invece come "forza attiva e
autentica origine dei fenomeni che poi si riscontrano, mano a mano" nella
langue. E per quanto riguarda la linguistica cosiddetta “strutturale”, un
discorso completamente a parte meritano studiosi come Louis Hjelmslev (v.
Caputo 2010, in cui la teoria del linguaggio di Hjelmslev viene restituita al di
là degli stereotipi che hanno impedito di coglierne l‟effettivo contributo di
ordine non solo linguistico ma anche semiotico) e Émile Benveniste. Di
quest‟ultimo intanto segnaliamo la nuova edizione e la nuova traduzione
italiana, rispetto all‟originale Problèmes de linguistique generale (1966, trad.
it. Problemi di linguistica generale,1971) – “il libro dell‟enunciazione” come lo
chiamava Roland Barthes – dal titolo Essere di parola. Semantica,
soggettività, cultura, a cura di Paolo Fabbri, 2009, che si propone di
“spostare l'accento di insistenza e introdurre un'intonazione interrogativa,
contro quella assertiva delle molte divulgazioni” (“Introduzione” di P. Fabbri).
Benveniste, considerando nella frase l‟articolazione in enunciato e
enunciazione, mette soprattutto in evidenza la dimensione enunciativa e
interlocutiva della parola, attraverso la riflessione sull‟enunciazione nel suo
processo generativo del senso.
33
33
7. Filosofia e “visione cosmica”
Per Bachtin ciascun io è situato al centro di un sistema generale di
relazioni che egli indica come architettonica, precisamente come
“architettonica della responsabilità”. L‟io può restringere tale architettonica
alla responsabilità tecnica, formale, e dunque ridurla all‟ambiente
imediatamente circostante, di gruppo, familiare, professionale, o di
appartenenza etnica, nazionale, di fede religiosa, o estenderla come
“responsabilità dell‟esistenza senza alibi” all‟intero universo, in senso
“planetario”, “solare” o addirittura “cosmico”.
La visione della filosofia bachtiniana è di tipo cosmico. Per questo
Bachtin si interessa della “visione carnevalesca del mondo”, della
“concezione del corpo grottesco”. La concezione dialogica bachtiniana è
inseparabile dalla riflessione sul carnevalesco e sul corpo grottesco, dal
“realismo grottesco”. Non è casuale che nella seconda edizione del
Dostoevskij, Bachtin inserisca una nuova parte appositamente dedicata al
rapporto tra il romanzo polifonico e la “letteratura carnevalizzata”.
Bachtin vede nel carnevale medievale il realizzarsi della festa come
modalità specifica di espressione dell‟umano; è la festa come concezione del
mondo, come capacità dell‟uomo di tendere a fini superiori rispetto a quelli
del lavoro e dei bisogni necessari. La festa è liberazione dal regno della
necessità, dalla gerarchizzazione sociale, è manifestazione u-topica,
fuoriuscita dai luoghi obbligati del linguaggio e del comportamento, è
tendenza verso l‟universalità, ben diversa dalla “festa ufficiale”, che ne è,
come il lavoro-merce rispetto al lavoro creativo, inventivo, innovativo, la
forma alienata. La festa carnevalesca apre verso una visione grande del
mondo ben diversa da quella della festa ufficiale intenta al mantenimento
dell‟ordine sociale, alla stabilità delle gerarchie, dei privilegi e delle differenze
sociali. Alla serietà della festa ufficiale si contrappone la comicità della festa
carnevalesca, il suo riso ridente, aperto, coinvolgente
Nella visione carnevalesca il corporeo e il materiale hanno un
carattere fortemente partecipativo, aperto, positivo e coinvolgente; non si
riducono a forme egoistiche e separate di vita individuale interessata
unicamente alla cura di sé, al proprio particolare tornaconto. L‟elemento
corporeo è “grandioso, esagerato, infinito”. Il principio materiale corporeo è
percepito nella visione carnevalesca, dice Bachtin, come universale e si
oppone a qualsiasi tipo di distacco, a qualsiasi isolamento e confinamento in
se stessi, a qualsiasi identità di appartenenza, a qualsiasi idealità astratta, a
qualsiasi pretesa di senso staccato e indipendente dal resto dell‟universo. Il
corpo e la vita corporea assumono “un carattere cosmico e nello stesso
tempo universale; […] non sono affatto il corpo e la fisiologia nel senso
34
34
stretto e preciso dei nostri tempi, non sono né interamente individualizzati, né
staccati dal resto del mondo. […] Il portatore del principio materiale e
corporeo non è qui né l‟essere biologico isolato, né l‟individuo borghese
egoista” (M. Bachtin, trad. it. 1979: p. 24).
Nell‟oceano infinito di immagini grottesche del corpo, infinito sia dal
punto di vista dello spazio sia del tempo, che riempie tutte le lingue, tutte le
letterature e anche il sistema gestuale, il canone corporeo dell‟arte, della
letteratura e di qualsiasi linguaggio decoroso dei tempi moderni appare come
un‟isoletta piccola e limitata. Ma d‟altronde questo canone non aveva mai
dominato nella letteratura classica. Soltanto negli ultimi quattro secoli ha
assunto un ruolo predominante nella letteratura ufficiale dei popoli europei
(Ivi, p.350).
Negli appunti degli anni Cinquanta, Bachtin distingue perciò tra
un‟“esperienza piccola” e un “esperienza grande”. Quest‟ultima è
un‟esperienza limitata, povera angusta, egoistica dell‟io, del corpo e del
mondo. Invece nell‟esperienza grande, il mondo non coincide con se stesso
(non è ciò che è), non è chiuso e non è compiuto. In esso c‟è la memoria,
che scorre e si perde nelle profondità umane della materia e della vita
illimitata, l‟esperienza di vita di mondi e di atomi. E la storia del singolo
comincia per questa memoria molto tempo prima rispetto ai suoi atti
conoscitivi (al suo “io” conoscibile).
35
Questa memoria grande non è memoria del passato (in senso
astrattamente temporale); il tempo è relativo in rapporto ad essa. Ciò
che ritorna in eterno e ciò che il tempo non restituisce. [...]. Il momento
del ritorno è stato percepito da Nietzsche, ma è stato da lui interpretato
astrattamente e meccanicisticamente. [...] Nell‟esperienza grande tutto
brulica di vita, tutto parla, è un‟esperienza profondamente dialogica (M.
Bachtin, 1993: pp. 194-195).
.
Ciò spiega anche il fascino che su Bachtin esercitarono artisti come
Velimir Chlebnikov e Kazimir Malevič, che egli ritenne le figure più importanti
dell‟avanguardia russa. Nelle conversazioni con Viktor Duvakin del 1973(M.
Bachtin, 2003: pp.219-221), di Chebnikov “presidente del globo terrestre”,
Bachtin dice che era una persona profondamente carnevalesca; in lui il
carnevalesco non era esteriore, teatralità, maschera ma forma interiore delle
sue emozioni, del suo pensiero del suo linguaggio. Per quanto riguarda
Malevič, Bachtin osserva che la sua opera artistica e teorica era orientata
secondo una prospettiva cosmica, e, in questo senso, egli continuava la
tradizione di Chlebnikov: ciò che lo interessava era l‟universale, il
macrocosmo, l‟universo intero. Di Malevič con cui fu in diretto rapporto di
35
amicizia negli anni 1921-22 a Vitebsk, sottolineava l‟idea del suo
“suprematismo” come “cognizione suprema”, come eccedenza, come
fuoriuscita dal “mondo degli oggetti”.
Riferimenti bibliografici
SERGEJ S. AVERINCEV, Simbolo (1993), trad. it. di L. Ponzio della
voce Sinvol della Kratkaja litereraturnaja enčiclopedija (vol. VI, Mosca 1971,
coll. 826-831), “Symbolon”, IV, 1, 2008, pp. 89-102.
MICHAIL M. BACHTIN (v. anche Medvedev e Vološinov) Iskusstvo i
otvetstvennost’ [Arte e responsabilità], “Den‟ iskusstva” (Nevel‟, 13 sett.
1919); in BACHTIN 1979, trad. it. 1988, pp. 3-4.
K filosofii postupka, a cura di S. G. Bočarov, in Filosofia i sociologia
nauki i techniki, 1920-24 (Per una filosofia dell’atto responsabile, trad. it. di L
Ponzio, a cura di A. Ponzio, Pensa Multimedia, Lecce 2008).
Autor i geroj v estetčeskoj tvorčestva (frammento del cap. I), a cura
di S. G. Bočarov, in Filosofia i sociologia nauki i techniki Esegodnik 1984-85,
1924 (L’autore e l’eroe nell’attività estetica. Frammento del primo capitolo,
trad. it. di L. Ponzio in appendice a, in M. M. BACHTIN, K filosofii postupka
trad. it. 2008, pp. 159-184).
Problemy tvorčestva Dostoevskogo, Priboj, Leningrado 1929,
(Problemi dell’opera di Dostoevskij, trad. it. e cura di M. De Michiel, introd. di
A. Ponzio, Edizioni dal Sud, Bari 1997).
Problemy poetiki Dostoevskogo, Sovetskij pisatel‟, Mosca, 1963, 2a
ed. rivista e ampliata di Bachtin 1929 (Poetica e stilistica di Dostoevskij, trad.
it. di G. Garritano, Einaudi, Torino 1968).
Tvočestvo Fransua Rable i narodnaja kul’tura srednevekov’ja i
Renessansa, Chudozevennaja literatura Mosca 1965 (L’opera di Rabelais e
la cultura popolare, trad. it. di M. Romano, Einaudi, Torino 1979).
Voprosy literatuty i estetiki, Chudozevennaja literatura, Mosca 1975
(Estetica e romanzo, trad. it. di C. Strada Janovič, Einaudi, Torino 1979).
Estetica slovesnogo tvorčestva, Iskusstvo, Mosca 1979 (L’autore e
l’eroe trad. it. di C. Strada Janovič, Einaudi, Torino 1988).
Sobranie sočinenij [Raccolta delle opere], Russkie slovari, Mosca
1996-2008.
36
36
Appunti degli anni 1940-1960, a cura di M. DE MICHIEL E S. SINI,
“Kamen‟. Rivista di poesia e filosofia”, 15, 2000a, pp. 5-72.
Autor i geroy [L’autore e l’eroe], a cura di S. G. Bočarov, “Ažbuka”,
S. Pietroburgo 2000b.
Besedy V.D. Duvakina s M.M. Bachtinym (1973), 1a ed. 1996,
nuova ed. Soglasie, Mosca 2002 (In dialogo. Conversazioni con V. D.
Duvakin trad. it. di Rosa Stella Cassotti, introd. di A. Ponzio, ESI, Napoli
2008).
Linguaggio e scrittura (scritti 1926-1930), a cura di A. Ponzio, trad.
it. di L. Ponzio, Meltemi, Roma, 2003.
Dagli appunti degli anni Quaranta, trad. it. di F. Rodolfo, a cura di A.
Ponzio, “Corposcritto”, 5, Edizioni dal Sud, Bari 2004.
Parola propria e parola altrui nella sintassi dell’enunciazione (parte
terza di Bachtin e Vološinov 1929), trad. di L. Ponzio, a cura di A. Ponzio,
Pensa, Lecce 2010.
MICHAIL M. BACHTIN, IVAN I. KANAEV, PAVEL N. MEDVEDEV, VALENTIN N.
VOLOŠINOV, Bachtin e le sue maschere. Il percorso bachtiniano fino alla
pubblicazione dell’opera su Dostoevskij (1919-29), a cura di A. Ponzio, P.
Jachia E M. De Michiel, Dedalo, Bari 1995.
NIKOLAJ M. BACHTIN, Iz žizni idej. Stat’i, Esse, Dialogi, Labirint,
Mosca, 1995 (La scrittura e l’umano. Saggi, dialoghi, conversazioni, introd. e
trad. di M. de Michiel, present. di A. Ponzio, Edizioni dal Sud, Bari 1995.
ÉMILE BENVENISTE , Essere di parola. Semantica, soggettività,
cultura, a cura di P. Fabbri, Bruno Mondadori, Milano 2009.
SERGEJ G. BOČAROV, À propos d’une conversation et autour d’elle, il
testo russo è apparso in Novoe literaturnoe obozrenie, 1993, 2, pp. 71-83,
trad. franc. in C. Depretto 1997, 180-204.
MASSIMO A. BONFANTINI, SUSAN PETRILLI, AUGUSTO PONZIO, I dialoghi
semiotici, Edizioni scientifiche Italiane, Napoli 2006.
CRAIG BRANDIST, DAVID SHEPHERD, GALIN TIHANOV, The Bachtin Circle,
Manchester University Press, Manchester 2004.
FRANCO CORONA (a cura di) Bachtin teorico del dialogo, Franco
Angeli, Milano 1986.
GILLES DELEUZE 1984-1989, L’immagine movimento. Cinema 1;
L’immagine tempo. Cinema 2, Milano, Ubulibri.
CATHERINE DEPRETTO (a cura di), L’héritage de Mikhaïl Bakhtine,
Presses Universitaires de Bordeaux, Bordeaux 1997.
PAVEL A. FLORENSKIJ, Attualità della parola. La lingua fra scienza e
mito, a cura di E. TREU, introd. di V. V. Ivanov, Guerini, Milano 1989.
EDMUND HUSSERL, La filosofia come scienza rigorosa (1911), Pref. di
Giuseppe Semerari, Laterza, Bari 1994.
37
37
VIAČELASLV V. IVANOV, Il significato delle idee di Bachtin sul segno,
l’enunciazione e il dialogo per la semiotica contemporanea (1973), in A.
PONZIO (a cura di) 1977, pp. 67-104.
PAOLO JACHIA, AUGUSTO PONZIO (a cura di) Bachtin &... , Laterza,
Bari-Roma 1993.
IVAN I. KANAEV, Sovremennyj vitalizm, “čelovek i Priroda”, 2002 (Il
vitalismo contemporaneo, 1926, 1, pp. 33-42; 2, pp. 9-23, trad it. di M. De
Michiel in A. PONZIO, a cura di, 2002a, pp. 21-44 (nuova ed. della versione
pubblicata in BACHTIN, KANAEV, MEDVEDEV, VOLOŠINOV 1995; ripubblicato in
“Dialogue, Carnival, Chronotope”, 1993, 4, pp. 99-116).
Søren Kierkegaard Om begrebet ironi, 1841 (Sul concetto di ironia,
trad. it. e a cura di D. BORSO, Guerini, Milano 1989.
Gjentagelsen, 1843a (La ripetizione, trad. it. e a cura di D. Borso,
Guerini, Milano 1991.
Enten-Eller, 1843b (trad. it. di A. Cortese, 1976-89, Enten-Eller, 5
voll, Adelphi, Milano, 1987).
Opere, a cura C. Fabro, Piemme, Casale Monferrato 1995.
EMMANUEL LÉVINAS, Totalité et Infini, Nijhoff, La Haye 1961 (Totalità e
infinito, trad. it. di A. Dell‟Asta, introd. di S. Petrosino, Jaca Book, Milano
1980).
Humanisme de l’autre homme, Fata Morgana, Montpellier 1972
(Umanesimo dell’altro uomo trad it. di A. Moscato, Il melangolo, Milano1995).
Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Nijhoff, La Haye 1974
(Altrimenti che essere o al di là dell’essenza trad. it. di S. Petrosino e M. T.
Aiello, Jaca Book, Milano 1983).
Sur Blanchot, Fata Morgana, Montpellier 1975; (Su Blanchot, trad. it.
di A. Ponzio, introd. di M. Fistetti e A. Ponzio, Palomar, Bari 1994).
1976 Noms propres, Montpellier, Fata Morgana; trad. it. a cura di F.
P. Ciglia, 1984, Nomi propri, Casale Monferrato, Marietti.
KAZIMIR S. MALEVIČ, Suprematismo. Il mondo della non-oggettività, a
cura di F. Rosso, De Donato, Bari 1969.
Scritti, a cura di A. B. Nakov, Feltrinelli, Milano 1977.
La pigrizia come verità effettiva dell’uomo, 1919; trad. it. di M. A.
Curletto, il nuovo melangolo, Genova, 1999.
KAZIMIR MALEVIČ., Suprematismo, a cura di G. Di Milia, Abscondita,
Milano 2000.
PAVEL N. MEDVEDEV (e Michail Bachtin) Formal’nyi metod v
Literaturovedeni, Priboj, Leningrado 1928 (Il metodo nella scienza della
letteratura trad. it. di R. Bruzzese, a cura di A. Ponzio, Dedalo, Bari 1977).
PIER PAOLO PASOLINI, Empirismo Eretico, 1972, Milano, Garzanti,
2003.
38
38
AUGUSTO PONZIO (a cura di) Michail Bachtin. Semiotica, teoria della
letteratura e marxismo, Dedalo, Bari 1977.
MICHAIL BACHTIN. Alle origini della semiotica sovietica, Dedalo, Bari
1980.
Segni e contraddizioni. Tra Marx e Bachtin, Bertani, Verona 1981.
Tra semiotica e letteratura. Introduzione a Michail Bachtin,
Bompiani, Milano 1992; 2ª ediz. ampliata, 2003.
Signs, Dialogue and Ideology, J. BenjaminS, Amsterdam, 1993.
Scrittura, dialogo, alterità. Tra Bachtin e Lévinas, La Nuova Italia,
Firenze 1994.
La rivoluzione bachtiniana. Il pensiero di Bachtin e l’ideologia
contemporanea, Levante, Bari 1997a.
The dialogic nature of sign, Legas, Ottawa 2006a.
La cifrematica e l’ascolto, Graphis, Bari 2006b.
Fuori luogo. L’esorbitante nella riproduzione dell’identico, Meltemi,
Roma 2007.
Tra Bachtin e Lévinas, Scrittura, dialogo, alterità, Palomar, Bari
2008.
AUGUSTO PONZIO, SUSAN PETRILLI, Philosophy of Language, Art and
Answerability in Mikhail Bakhtin, Legas, Toronto 2000.
Views in Literary Semiotics, Legas, New York/Ottawa/Toronto 2003.
La raffigurazione letteraria, Mimesis, Milano 2005a.
LUCIANO PONZIO, Icona e raffigurazione. Bachtin, Malevič, Chagall,
Adriatica, Bari 2000; nuova ed. 2008.
Visioni del testo, Graphis, Bari 2002; IV ed. 2010.
Lo squarcio di Kazimir Malevič, Spirali, Milano 2004.
L’iconauta e l’artesto. Configurazioni della scrittura iconica, Mimesis,
Milano 2010.
FERDINAD DE SAUSSURE, Scritti inediti di linguistica generale, a cura di
T. De Mauro, Laterza, Bari-Roma 2005.
VALENTIN N. VOLOŠINOV (e Michail Bachtin), Il linguaggio come
pratica sociale (saggi), 1926-30a, a cura di A. Ponzio, trad. it. di R. Bruzzese
e N. Marcialis, introd. di A. Ponzio, Dedalo, Bari 1980.
La parola nella vita e nella poesia (1926) e altri saggi, 1926-30b,
trad. it. di L. Ponzio in M. M. Bachtin, Linguaggio e scrittura, a cura di A.
Ponzio, Meltemi, Roma 2003
Frejdizm, Gosizdat, Mosca-Leningrad, 1927 (Freud e il freudismo
trad. it. di L. Ponzio, a cura di A. Ponzio, Mimesis, Milano 2005).
Marksizm i filosofija jazyka, Priboj, Leningrad 1929 (Marxismo e
filosofia del linguaggio, trad. it. di M. De Michiel, a cura di A. Ponzio, Manni,
Lecce 1999).
39
39
A LINGUA PERFETTA E LA LINGUA UNIVERSALE
NEL PROGETTO UTOPICO DI SAMUEL HARTLIB
*
di Giancarlo Rizzo
Abstract
The essay revolves around linguistic interests of the philosopher Samuel Hartlib (16001662). In his papers we find a specific track of the seventeenth-century English
language debate, marked significantly by two different researches but in many ways
profoundly interconnected: the search for the perfect language and for the universal
language. While in the first case he intends to find a linguistic structure that can
accurately reflect the ontological essence and the structure of reality, in that way
responding to the need for a cognitive nature, in the second he wants to achieve the
use of a language that can overcome all the boundaries and differences of dialects,
thus responding to the essentially communicative need.
Le sage tourne autour de l'intérêt de la linguistique du philosophe Samuel Hartlib
(1600-1662). Dans ses papiers, nous trouvons des trace spécifique sur le débat
linguistique anglais du XVIIe siècle, marqué de façon significative par deux recherches
distinctes, et pour plusieurs part profondément connectés: la recherche de la langage
parfait et du langage universel. Dans le premier cas, on parle de trouver une structure
linguistique qui refléter l'essence et la structure ontologique de la réalité, en répondant,
par conséquent, a un besoin de nature de la connaissance, le second est de parvenir à
l'utilisation d'une langue qui peut pour surmonter toutes les frontières et les différences
des barrage linguistique, répondant ainsi à un besoin essentiel de communication.
Il saggio ruota attorno agli interessi linguistici del filosofo Samuel Hartlib (1600-1662).
Nelle sue carte troviamo una specifica traccia del dibattito linguistico secentesco
inglese, segnato in modo significativo da due ricerche distinte ma per molti versi
profondamente connesse: la ricerca della lingua perfetta e quella della lingua
universale. Mentre nel primo caso si intende trovare una struttura linguistica in grado di
riflettere fedelmente l‟essenza ontologica e la struttura del reale, rispondendo, così, ad
un‟esigenza di natura conoscitiva, nel secondo si vuole conseguire l‟uso di una lingua
*
Laureato in Lingue e Letterature Orientali presso l‟Università Ca‟ Foscari di Venezia
con una tesi sulle deviazioni eterodosse nella confraternita islamica Qadiriyya e in
Filosofia presso l‟Università degli Studi di Milano con una tesi sul concetto di destino
nel medioevo. Studioso di mistica islamica, collabora con le riviste "Il Dialogo" (Torino),
"Aperture" (Roma), "A Oriente!" (Milano) e "L‟Ateo" (Firenze).
40
40
in grado di superare ogni confine e differenza di idioma, rispondendo quindi ad
un‟esigenza sostanzialmente comunicativa.
_____________________________
1. Radici e sviluppi del coinvolgimento di Hartlib nel dibattito
linguistico
Il dibattito linguistico secentesco inglese è segnato in modo
significativo da due ricerche distinte ma per molti versi profondamente
connesse: la ricerca della lingua perfetta e quella della lingua universale.
L‟elemento di differenziazione fra i due campi risiede nel carattere stesso
dell‟oggetto di ricerca: mentre nel primo caso si intende trovare una struttura
linguistica in grado di riflettere fedelmente l‟essenza ontologica e la struttura
del reale, rispondendo, così, ad un‟esigenza di natura conoscitiva, nel
secondo si vuole conseguire l‟uso di una lingua in grado di superare ogni
confine e differenza di idioma, rispondendo quindi ad un‟esigenza
sostanzialmente comunicativa. Le vicende legate a queste ricerche, pur
seguendo uno svolgimento teoricamente autonomo, presentano almeno due
aspetti fondamentali in comune: il punto di partenza, la lingua del nomoteta
Adamo, paradigma di perfezione e di universalità insieme e l‟artificialità del
risultato finale. In entrambi i casi, la lingua che risponde ai requisiti richiesti
deve essere una lingua escogitata ad hoc dall‟uomo, inventata e non
scoperta fra quelle naturali già esistenti. Spesso le due direzioni si
presentarono coincidenti, in quanto la lingua perfetta, cioè esatta, veritiera,
veniva presentata anche come lingua transnazionale.
Le radici del dibattito sulla lingua perfetta possono essere
rintracciate nelle riflessioni sul linguaggio sviluppate da Bacone, in particolare
in relazione agli idola fori, le false idee derivanti da un errato uso della lingua.
L‟esigenza che Bacone intendeva esprimere era quella di una lingua in cui i
nomi corrispondessero davvero e in modo trasparente e diretto alle cose,
senza confusioni né riferimenti illusori ad oggetti di realtà inesistenti. Il
termine “real character”, che avrebbe avuto notevole fortuna soprattutto fra i
linguisti inglesi, fu coniato proprio da Bacone per indicare segni convenzionali
che dovevano essere in grado di riferirsi direttamente ad oggetti e nozioni pur
non rappresentandoli visivamente.
41
41
Se la lingua perfetta possiede come requisito fondamentale la
capacità di rispecchiare fedelmente l‟essere, la lingua universale può essere
definita genericamente come la lingua parlata da tutti gli uomini del mondo.
Un‟antica tradizione, che trasse ispirazione dal testo della Genesi, identificò
la lingua universale con quella originaria, parlata prima della distruzione della
1
torre di Babele .
Il concetto di lingua universale era da sempre legato alla supposta necessità
di costruire una lingua artificiale utilizzabile e comprensibile a tutti, in grado di
lenire la sostanziale insoddisfazione per le lingue naturali, percepite come
inadeguate, anche semplicemente per la loro pluralità. In particolare nel
dibattito svoltosi fra i secoli XVI e XVII, l‟imprecisione e l‟insufficienza delle
lingue utilizzate nei vari paesi venivano indicate come gravi carenze in grado
di invalidare sia la possibilità di comprendersi reciprocamente fra genti di
idiomi differenti sia, più a monte, la possibilità di conoscere, ponendosi alla
base dei dibattiti concernenti sia la lingua perfetta che la lingua universale. I
problemi della scienza e della comunicazione apparivano quindi strettamente
connessi con la questione linguistica, che veniva investita di significati e
implicazioni di amplissima portata. Ne deriva che l‟ideale della lingua
universale non poteva che porsi, come quello della lingua perfetta, come
“non-luogo”, ”luogo perfetto” privilegiato per i pensatori coinvolti a vario titolo
nei dibattiti scientifici, pedagogici ed irenici di ogni epoca, con una particolare
2
sensibilità rilevabile nei secoli XVII e XVIII .
Tale dibattito linguistico rappresenta un‟area tematica molto fertile
nell‟orizzonte concettuale del filosofo Samuel Hartlib (1600-1662) pensatore
di centrale importanza nella vita culturale inglese moderna. Dalle sue carte si
evince che non ideò nessuna lingua filosofica o universale, la sua relazione
con questo “non-luogo”, con questa forma di utopismo, si sostanzia dei
rapporti con gli inventori di tali strutture linguistiche. In questo senso, è
possibile affermare che in questo settore Hartlib esercitò con impegno il
1
Il riferimento è in Genesi, 11, 1-9. Per uno studio generale cfr. UMBERTO ECO, La
ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, Laterza, Roma/Bari 1993.
2
Mary M. Slaughter enfatizza la prima di queste dimensioni sostenendo che la vera
motivazione alla base dei vari progetti di lingue universali fu, nella maggior parte dei
casi, più scientifica che linguistica, cfr. MARY M. SLAUGHTER, Universal languages and
scientific taxonomy in the seventeenth century, Cambridge University Press,
Cambridge 1982. Paolo Rossi, invece, ricorda la rilevanza di Comenio quale ispiratore
di Leibniz nel suggerire la necessità di una lingua universale come premessa
fondamentale per una stabile pace religiosa, cfr. PAOLO ROSSI, Lingue artificiali,
classificazioni, nomenclature, in Aspetti della rivoluzione scientifica, Morano, Napoli
1971.
42
42
prezioso ruolo, a lui molto familiare, di patrocinatore e fautore di pubblicazioni
e contatti epistolari, indubbio quindi il valore storico del suo contributo.
L‟interesse per l‟invenzione di un linguaggio universale che avrebbe
potuto rendere le comunicazioni internazionali agevoli e libere dai vincoli
legati alle differenze delle lingue era inscritto naturalmente nella formazione
culturale di Hartlib. Egli fu un intelligencer, figura tipica della sua epoca
caratterizzata dall‟estrema eterogeneità degli interessi, delle attività e dalla
predilezione per ruoli di mediazione. Incarnava, per le sue vicende
biografiche e per le sue attività e corrispondenze intellettuali, l‟ideale del
poliglotta erudito: secondo quanto riferisce Dury, Hartlib conosceva il
polacco, il tedesco, l‟inglese ed il latino, e lo stesso Dury pare non fosse da
meno, visto che conosceva il latino, l‟inglese, il francese e il tedesco3.
L‟esigenza di formarsi una solida e ampia conoscenza linguistica non
ammetteva trascuratezze se si voleva comunicare con gli studiosi di tutti i
paesi del mondo e conseguire il massimo grado di sapienza. Significativo, in
questo senso, il fatto che in un‟opera esplicitamente utopica come la
Cristianopoli di Andreae, compaiano chiari riferimenti a questo tipo di
esigenze. Narrando le conoscenze in possesso degli abitanti della Città di
Cristo, si afferma:
Quelli che sono d‟età matura qui s‟adoperano anche attorno alle varie
lingue, non per saperne di più, ma per potere comunicare con un
maggior numero di abitanti della terra, tanto vivi che morti, e per non
essere costretti a fidarsi dell‟uno o dell‟altro grecastro. Affermano che
la nomenclatura è la cosa più importante e che è necessario in
aggiunta solo un piccolo studio della grammatica. Iniziano con una
facile lettura, che collegano con un‟altra lettura simile già
conosciuta(Cfr. J. V. Andreae, 1983:p. 151).
43
Il contesto nel quale si collocava la riflessione sulle lingue universali
e filosofiche coinvolgeva un‟ampia ed articolata area di problemi
particolarmente cara al circolo hartlibiano. Infatti la comunicazione scientifica
in Inghilterra viveva una fase di transizione per quanto concerneva la scelta
della lingua più idonea da utilizzare, in quanto si stava gradualmente
affrancando dal predominio assoluto del latino. Gli ambienti puritani si
mostravano particolarmente ostili alla permanenza della lingua latina, non
solo per la sua identificazione con il mondo dell‟erudizione elitaria, ma anche
3
Si tratta di una caratteristica non isolata anche nell‟ambito del circolo animato dallo
stesso Hartlib, se, come informa il biografo di Boyle, Thomas Birch, John Pell
conosceva il latino, il greco, l‟ebraico, l‟arabo, l‟italiano, il francese, lo spagnolo ed il
tedesco, cfr. T. BIRCH (a cura di), The Works of the Honourable Robert Boyle, J. & R.
Rivington, London 1744, p. 35.
43
per il suo significato religioso: il latino era visto inevitabilmente come la lingua
del Papa e dei cattolici. A queste considerazioni si aggiungevano spesso
critiche sulla difficoltà di apprendimento della grammatica latina e la sua
imperfezione, rivelata da numerose irregolarità. In Inghilterra, come negli altri
paesi europei, l‟affermazione delle lingue volgari incontrò tenaci resistenze
da parte delle roccaforti della tradizione erudita e cattolica. È indicativo, a
titolo di esempio, che Nicholas Culpeper, nella sua A Physicall Directory, or A
translation of the London Dispensatory, pubblicata a Londra nel 1649,
lamenti l‟intolleranza mostrata dai papisti e dal Collegio dei medici
rispettivamente contro i testi teologici e medici in volgare.
In questo periodo di fermento e di rinnovamento, la ricerca di una
nuova lingua appariva connessa direttamente alla questione della
corrispondenza e della comunicazione internazionale, sempre più vasta e più
complessa, anche per quanto concerneva aspetti pratici come i traffici
commerciali (si pensi ai contatti con le culture americane); ai dibattiti
sull‟ecumenismo e l‟irenismo (che si confrontavano con problemi come la
conversione degli infedeli e la diffusione dei testi sacri); alle esigenze della
nuova scienza sperimentale (che richiedeva una terminologia precisa ed
adeguata ad esprimere nozioni inedite); alle numerose proposte di riforme
pedagogiche (che sollevavano problemi circa la facilità e la velocità di
apprendimento della lingua, ma anche circa la necessità di superare
l‟assoluto predominio delle lingue morte).
In relazione a questi elementi, all‟interno del circolo hartlibiano era
diffusa una consistente curiosità per le questioni legate alla lingua universale,
curiosità che induceva gli associati a ricercare informazioni su progetti anche
relativamente lontani nel tempo e di area francese4. Risaliva, per esempio,
agli anni Venti del XVII secolo l‟invenzione di un misterioso alfabeto
universale da parte del francese Jean Le Maire5; di tale invenzione sia
Theodore Haak sia Comenio riuscirono a ricevere notizie un ventennio più
tardi attraverso la mediazione di Mersenne. Caratteristica di questo alfabeto
4
A proposito della particolare attenzione riservata da Hartlib agli ambienti intellettuali
francesi, è interessante ricordare che egli riferì, nel 1640, di un progetto di lingua
universale che sarebbe stato messo a punto da Cartesio, ma del quale, tra i documenti
che dimostrano l‟indubbio interesse cartesiano per il tema, non è rimasta traccia. Per
l‟atteggiamento critico assunto da Cartesio nei confronti dell‟ipotesi di una lingua
universale perfetta e realmente utilizzabile, cfr. ROBERTO PELLEREY, Le lingue perfette
nel secolo dell’utopia, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 32-33.
5
Si tratta di JEAN LE MAIRE (1601-1643), gentiluomo della Camera del re Luigi XIII, che
inventò un metodo per apprendere velocemente e facilmente le lingue ed eseguire con
rapidità traduzioni, uno strumento per facilitare la navigazione e anche uno strumento
musicale simile al liuto.
44
44
doveva essere la sua utilità, in quanto avrebbe consentito di superare i
confini linguistici permettendo di comunicare con tutti i popoli.
Non è privo di rilevanza il fatto che anche Théophraste Renaudot6,
autore ben noto a Hartlib, abbia sempre mostrato una vivace attenzione per
la questione della lingua universale e le sue implicazioni filosofiche: le
conferenze parigine affrontarono spesso il tema, incentrandosi
sull‟argomento dell‟ordine e dell‟armonia della natura, ai quali doveva
corrispondere un linguaggio analogamente armonico ed ordinato, se l‟uomo
intendeva conseguire una vera ed esatta conoscenza. Le conclusioni tratte
da questi dibattiti vennero pubblicate in francese nel 1636 e quattro anni più
tardi erano già note in Inghilterra, come rivelano indicazioni presenti nelle
carte di Hartlib. Considerando la solerzia con la quale Hartlib assunse
informazioni sulle attività di Renaudot, è facile comprendere che si verificò
un‟osmosi tra il gruppo francese ed il circolo coordinato da Hartlib circa i
progetti di lingua filosofica universale, sebbene non esistano documenti in cui
venga esplicitamente indicato Renaudot come fonte.
Un altro progetto francese aveva attratto l‟attenzione di Hartlib fin
dal 1635: le note risalenti a quell‟anno informano che, tramite l‟amico Sir
William Boswell, membro del Gresham College e ambasciatore all‟Aja,
Hartlib venne a conoscenza della presenza in Inghilterra di D. P.
Champagnolles, inventore di un progetto di lingua universale. Annotazioni del
1639, inoltre, rivelano che Hartlib possedeva una copia di un libro
dell‟Odissea omerica stampato nel carattere ideato da Champagnolles,
sebbene a quell‟epoca non ne conoscesse pienamente il funzionamento né il
destino seguito dal momento dell‟invenzione. Solo nelle Ephemerides di
Hartlib del 1650 compare una breve spiegazione del linguaggio concepito dal
francese, basato presumibilmente sul principio dell‟abaco, cioè
sull‟utilizzazione di un sistema di radici generali variamente completate, in
modo tale che la desinenza di ogni parola venisse indicata tramite una
piccola griglia composta da quattro quadrati occupati da vari segni (punti o
trattini) di significato numerico. È interessante notare come per quanto
concerne Champagnolles, al pari di altri inventori di analoghi alfabeti o
caratteri, la segretezza fosse sentita necessaria, una sorta di obbligo e di
tutela al tempo stesso. In questo modo, paradossalmente, strutture
6
THEOPHRASTE RENAUDOT (1584-1653), nato a Loudun, è considerato il padre del
giornalismo moderno francese in quanto fondò la Gazette de France, probabilmente
nel maggio 1631; studiò a Montpellier e viaggiò numerosi anni per il paese,
apprendendo informazioni preziose e formulando nozioni innovative nel campo della
medicina e della chirurgia; ottenuto il favore e la protezione di Richelieu a partire dal
1612, Renaudot assunse la carica di “Commissario generale dei poveri validi ed
invalidi”.
45
45
linguistiche concepite per facilitare e perfezionare la comunicazione
universale finivano, per volontà dei loro stessi ideatori, per essere relegate a
limitate cerchie di eruditi e “specialisti”. La dialettica tra “esoterismo” e
“democrazia intellettuale”, tra tendenza al monopolio e incoraggiamento del
libero commercio delle idee è dunque un motivo che ritorna anche in
relazione ai progetti di lingua universale.
Anche un esponente di spicco degli ambienti intellettuali germanici
in cui affondava le radici la cultura originaria di Hartlib, Johann Heinrich
Bisterfeld, era coinvolto nel dibattito sulle lingue universali: nel 1638, dopo
aver viaggiato in Francia, in Olanda e in Inghilterra, e in particolare dopo una
visita a Mersenne, scrisse a Hartlib e Haak accennando ad un nuovo
linguaggio universale. Nell‟opera pubblicata postuma, nel 1661, Alphabeti
philosophici libri tres, Bisterfeld aveva manifestato un profondo interesse per
gli aspetti classificatori insiti in un progetto di alfabeto filosofico in grado di
raccogliere e sistematizzare con completezza e razionalità tutti i termini
tecnici e scientifici.
Risulta di particolare rilevanza, anche alla luce della circolazione dei
testi appartenenti alla letteratura utopica continentale in Inghilterra, osservare
che un‟altra opera scaturita dagli ambienti intellettuali continentali e legata
alle tematiche linguistiche era nota a Hartlib: si tratta della Philosophiae
rationalis partes quinque di Campanella, pubblicata a Parigi nel 1638, sulla
possibilità di creare una lingua artificiale caratterizzata da un vocabolario
basato sulla natura delle cose e da una “grammatica filosofica” differente
rispetto a quella delle lingue naturali.
Per quanto concerne i progetti anglosassoni, Hartlib appare
altrettanto vigile e sensibile a cogliere informazioni su disparati disegni, di
differente spessore.
Nelle Ephemerides hartlibiane compaiono notizie circa il progetto di
“carattere reale” ideato dal Reverendo Johnson su suggerimento di William
Bedell, vescovo di Kilmore e amico di Hartlib. Note risalenti al 1641
accennano ad un certo “Mr. Flower”, docente al Jesus College di Oxford, che
avrebbe appreso il linguaggio geroglifico di Johnson tanto da riuscire a
comunicare con quest‟ultimo servendosene. L‟interesse di Hartlib per
l‟invenzione si sarebbe protratto negli anni, come dimostrano i dati registrati
nelle note del 1649, in cui egli informa che essa venne ripresa ed integrata
proprio tra il 1649 ed il 1650 dal medico paracelsiano John French, vicino al
circolo hartlibiano.
Nel carteggio fra Hartlib e Robert Boyle si trovano importanti
riferimenti alla questione della lingua universale. In particolare, in una lettera
inviatagli da quest‟ultimo il 19 marzo 1646/7 è contenuta un‟interessante
46
46
osservazione circa il carattere internazionale e quindi interlinguistico dei
simboli matematici.
Se il progetto del Carattere Reale conseguirà i suoi risultati, sarà in
grado di fare ammenda in buona parte presso il genere umano per ciò
che la superbia degli uomini distrusse alla torre di Babele. E in verità,
poiché i nostri caratteri matematici vengono compresi da tutte le
nazioni d‟Europa nello stesso modo, sebbene ogni popolo esprima
quella comprensione con la propria lingua, non immagino alcun fattore
che renda impossibile la stessa cosa che già vediamo in atto con i
numeri, ma con le parole (T. Birch 1744:p. 22).
La peculiare e consueta universalità dei segni numerici rappresenta
dunque, agli occhi di Boyle, una concreta speranza in vista della costruzione
di una lingua universale composta da caratteri reali.
Boyle venne a conoscenza del progetto di carattere reale ideato da
Francis Lodwick proprio attraverso la mediazione di Hartlib. Boyle si
interessò a lungo dei progetti di lingua universale, stimolato da un netto
disprezzo per ogni ricerca intellettuale che si riduca a vuoto studio delle
parole e per ogni inutile abbellimento dello stile. Egli, inoltre, fece parte della
commissione istituita appositamente nel maggio 1668 dalla Royal Society per
studiare le possibili applicazioni pratiche della lingua filosofica ideata da John
Wilkins.
Il 1647 conobbe la nascita di due progetti di lingue universali, quello
di Francis Lodwick, esposto nell‟opera A Common Writing e quello di Kinner.
Quest‟ultimo, nel giugno di quell‟anno, espose a Hartlib il suo progetto di una
lingua artificiale, intesa sia come rimedio alla babelica confusione delle lingue
naturali sia come potente aiuto alla memoria. L‟idea di un abbozzo di lingua
filosofica era nata in Kinner dall‟esigenza di migliorare le correnti
classificazioni botaniche e dalla necessità di sistematizzazione delle nozioni
più complicate e difficili espresse dagli studiosi di scienze naturali.
L‟ispirazione che guidava tale progetto suscitò l‟interesse di Petty che tentò di
realizzarlo, attorno al 1650, per poter disporre di una terminologia botanica
funzionale, sebbene pare che non abbia conseguito i risultati sperati. William
Petty lavorò ad una lingua universale composta di caratteri più facili di quelli
utilizzati comunemente e ad un Dictionary of sensible words volto ad
eliminare ogni ambiguità insita nel linguaggio. Nell‟Advice, Petty auspica
un‟istruzione meno libresca e più pratica per i fanciulli e propone di scrivere
non soltanto secondo le modalità comuni, ma anche di rendere più veloce
questa operazione usando strumenti che definisce genericamente “Reall
Characters”, senza esporre la sua prospettiva riguardo a ciò che essi
dovrebbero essere. Mersenne aveva manifestato analoghi interessi a partire
47
47
dal 1640 e aveva rivolto la sua attenzione agli scritti di agricoltura di Plattes,
come risulta dalla corrispondenza con Haak. In questa direzione si
muovevano anche le riflessioni e gli studi del naturalista John Ray, che
collaborò anche con Wilkins. Hartlib conosceva le ricerche naturalistiche e le
attività classificatorie condotte da Ray e scambiava informazioni su di esse
principalmente con John Worthington. Hartlib aveva infatti inviato a
quest‟ultimo il manoscritto dell‟opera di Jungius Isagoge Phytoscopica, che
era stata poi prestata a Ray. Si trattò di un contributo non irrilevante nel
percorso intellettuale di Ray, poiché lo scritto di Jungius avrebbe fornito al
naturalista elementi preziosi per le opere botaniche da lui scritte fra il 1650 ed
il 1659. Hartlib aveva ottenuto, in cambio, una lettera dello stesso Ray ed una
copia della sua prima opera, il Catalogus plantarum circa Cantabrigiam
nascentium, conosciuta anche come Cambridge Catalogue, inviatagli nel
1660 e pubblicata nello stesso anno.
Gli anni Cinquanta non videro scemare l‟interesse di Hartlib per il
tema della lingua universale, se, come sembra probabile, egli conobbe Sir
Thomas Urquhart, autore dell‟Ekskubalouron (1652), opera che contiene un
progetto per un linguaggio simbolico composto da elementi semplici che
corrispondevano a nozioni prime.
Nelle Ephemerides del 1655, compare un riferimento ad un altro
inventore di lingue universali, il nobile svedese Benedict Skytte,
particolarmente attento agli studi etimologici e comparativi tra le lingue come
elementi preparatori alla creazione di un idioma in grado di contenerle e al
contempo correggerle.
Nello stesso anno, una lettera dell‟informatore politico svizzero
Etienne Polire inviata a Hartlib fornisce un dato importante per comprendere
la rilevanza ed il significato del coinvolgimento di Hartlib nella vasta sfera
della criptologia. Polier comunica al suo interlocutore la disponibilità a fornire
notizie sulla corte francese, ma specifica che l‟eventuale corrispondenza
dovrebbe svolgersi in un linguaggio cifrato, scelto fra quelli hartlibiani, dello
stesso Polier oppure fra quelli contenuti nell‟opera di “Gustavus Selenus”
Cryptomenytices et cryptographiae libri IX. L‟opera, pubblicata nel 1624, è
uno dei maggiori esempi dell‟“arte della criptologia” del secolo; lo
pseudonimo nascondeva il Duca Augusto il Giovane di Brunswick-Luneburg,
il quale era convinto sia dell‟utilità pratica del compendio da lui composto sia
del rischio che esso potesse essere utilizzato per scopi non edificanti come,
per esempio, attività spionistiche. Pare che Hartlib possedesse una copia
dell‟opera o che potesse consultarla liberamente, tanto da acquisire una
conoscenza adeguata dei linguaggi cifrati che vi erano analizzati. Il
riferimento a linguaggi propri dello stesso Hartlib sembra inoltre suggerire un
48
48
suo impegno in prima persona, seppur non confermato da pubblicazioni o
scritti specifici.
Hartlib fu probabilmente a conoscenza anche del progetto di Cave
Beck e delineato nell‟opera The Universal Character, by which all the nations
of the world may understand one anothers conceptions reading out of one
Common Writing their own mother tongues, pubblicata a Londra nel 16577.
Poco dopo la pubblicazione dello scritto, infatti, Hartlib ricevette una lettera di
George Dalgarno in cui quest‟ultimo, al fine di promuovere il suo progetto di
lingua universale, critica quello di Beck e manifesta la sua delusione per la
scarsa portata innovativa del suo “carattere”. Sebbene, dunque, Hartlib
possa non aver letto l‟opera di Beck, tuttavia raccolse pareri e commenti su di
essa, a conferma della sua volontà di mantenersi costantemente informato
circa le pubblicazioni sul tema linguistico. Un aspetto che potrebbe aver
attratto l‟attenzione di Hartlib sulla nuova lingua inventata da Beck fu
l‟accenno esplicito contenuto nell‟epistola dedicatoria dell‟opera alla sua
utilità per il commercio e per la diffusione della vera religione.
Sui problemi connessi alla lingua universale, Hartlib fu in
corrispondenza con numerosi associati e studiosi di diverso spessore che si
interessarono a vario titolo dell‟argomento: è possibile ricordare, per
esempio, gli scambi epistolari intercorsi tra Hartlib e Joachim Hübner,
Faustus Morstyn, Elias Ashmole e John Pell. In particolare, quest‟ultimo,
matematico e linguista, fu inventore di un “character” e partecipò attivamente
alla discussione sullo schema di una lingua filosofica elaborato da Dalgarno,
8
insistendo sull‟utilità di un sistema di scrittura “brachigrafico” e “tachigrafico” .
Come ultimo atto nella vicenda che lo aveva legato per poco meno
di un trentennio alle vicissitudini della lingua universale, Hartlib contribuì in
9.
qualità di editore alla pubblicazione dell‟Ars signorum (1661) di Dalgarno Il
7
Si tratta di CAVE BECK (1623-1706?), parroco della Chiesa di Saint Helen a Ipswich.
La lingua proposta da Beck consiste in un sistema di combinazioni numeriche che
rappresentano i termini radicali, al quale è abbinata la serie delle lettere per la
specificazione di tempo, caso, genere e numero. Beck afferma di essersi ispirato a
Bacone, Wilkins e, significativamente, al missionario Matteo Ricci (per le informazioni
da lui fornite sulla scrittura cinese).
8
Dalgarno ideò un sistema di questo tipo e inviò a Hartlib un passo del Vangelo di
Giovanni (16, 1-2) trascritto secondo tale sistema; Hartlib, come si arguisce da una
lettera indirizzata proprio a Pell datata luglio 1657, ne fu entusiasta ed auspicò una
trascrizione integrale del testo biblico.
9
La lingua filosofica di Dalgarno consiste sostanzialmente in un dizionario basato sulla
classificazione logica delle idee e degli oggetti, divisi in 17 classi supreme designate da
altrettante lettere dell‟alfabeto. Ogni classe suprema si divide a sua volta in sottoclassi
distinte per la variazione della seconda lettera. Il concetto classificatorio che sta alla
base della lingua filosofica di Dalgarno prevede che ogni oggetto simile sia designato
49
49
suo intervento avvenne dopo che ebbe interpellato Lodwick, quattro anni
prima, affinché gli esprimesse le sue opinioni sul progetto dello scozzese.
Lodwick rilevò i limiti del progetto, ma espresse un giudizio complessivo
moderatamente positivo e si rese disponibile per finanziare almeno
parzialmente gli studi di Dalgarno. Quest‟ultimo, alla fine degli anni
Cinquanta, temette di essere vittima di una sorta di plagio perpetrato dal suo
rivale Wilkins, anch‟egli appoggiato da Lodwick: da una lettera inviata a
Hartlib emerge infatti che, dopo un periodo di assidua frequentazione e aperti
dibattiti sul tema della lingua universale, Dalgarno si aspettava che Wilkins
utilizzasse illegittimamente le sue riflessioni, sebbene fosse convinto che non
potesse trarne credito e consistenti guadagni, in quanto lui, nel frattempo,
aveva perfezionato ulteriormente le sue concezioni.
2. Un dibattito fra Inghilterra e continente
La visita di Comenio in Inghilterra del 1641-1642 rappresenta uno
degli episodi più rilevanti nell‟ambito delle attività e interessi di Hartlib ai temi
della lingua perfetta e della lingua universale. In particolare, questo episodio
appare significativo al fine di valutare l‟effettivo peso assunto dalle riflessioni
continentali nella tradizione culturale britannica e, di conseguenza, stimare la
reale incidenza del ruolo di intermediario giocato da Hartlib anche per quanto
concerne i dibattiti linguistici.
L‟opera di Comenio in cui emerge con maggior chiarezza e rilievo il
tema della lingua filosofica è la Via Lucis, scritta proprio durante il soggiorno
inglese ma pubblicata ad Amsterdam solo nel 1668.
L‟ideale pansofico comeniano si realizza nella ricerca di un metodo
empirico e di una logica induttiva, secondo il modello baconiano, e quindi di
un linguaggio, che consentano all‟uomo di penetrare e di dominare tutto il
reale, che garantiscano cioè il possesso della sapienza universale. Il
maggiore ostacolo alla diffusione della luce e della penetrazione della
pansofia presso tutti i popoli consiste, secondo Comenio, nella molteplicità e
nella varietà delle lingue, superabile solo attraverso la realizzazione della
“monoglottia”, cioè di una lingua comune in tutto il mondo; e la monoglottia
da parole molto simili. Dalgarno fu autore anche dell‟opera Didascalocophus or the
deaf and dumb man’s tutor, pubblicata a Oxford nel 1680, in cui viene elaborato un
metodo per l‟istruzione dei sordomuti, e di un alfabeto composto da segni manuali. È
interessante notare che sia in Beck sia in Dalgarno compaiano due requisiti richiesti
alla lingua perfetta: essa dev‟essere di facile apprendimento (Dalgarno pensa che
siano necessarie due settimane, mentre Beck ritiene sufficienti addirittura due ore) e
deve prestarsi all‟utilizzazione orale come a quella scritta.
50
50
coinciderà con la “panglottia”, in quanto onnipervasiva, sia quanto a
diffusione sia quanto a capacità di cogliere l‟essere nella sua essenza. La
ricerca di questa lingua perfetta ed universale potrebbe avvenire, secondo
Comenio, in due modi: si potrebbero scegliere dalle lingue esistenti i loro
migliori elementi, creando un‟ulteriore lingua che sarebbe così distinta ma
anche legata a tutte le altre; oppure, e questo risulta il metodo preferibile, si
può creare un linguaggio radicalmente nuovo, privo di riferimenti alle lingue
utilizzate, ispirato direttamente dalle cose. La lingua pansofica sarebbe aliena
da imperfezioni in quanto rifletterebbe l‟armonia della natura, e sarebbe
estremamente ricca in quanto renderebbe conto della varietà degli esseri
naturali e delle loro proprietà. Nella prospettiva di Comenio, però, questa
lingua non avrebbe dovuto sostituire totalmente il latino, il greco e l‟ebraico:
essi, infatti, essendo stati utilizzati per esprimere e diffondere il Verbo, sono
depositari di una dignità che mantiene il suo valore.
La visita di Comenio si colloca in concomitanza con il sorgere del
10
movimento culturale inglese incentrato sul progetto di una lingua filosofica .
Ma, al di là di questa osservazione meramente cronologica, il dibattito
sull‟effettiva influenza esercitata da Comenio sulla riflessione anglosassone
circa la lingua universale rimane aperto.
Una tesi molto interessante è stata sostenuta, su questo tema, da
Subbiondo. Essa consiste nell‟affermazione di una relazione di tipo “mezzofine” tra la lingua filosofica e la riforma pedagogica nel pensiero di Comenio e
di un‟influenza comeniana diretta e determinante su John Wilkins, uno dei
massimi teorici della lingua perfetta, e sul dibattito inglese in generale, tale
per cui anche negli ambienti britannici le due questioni, linguistica e
pedagogica, si posero in stretta continuità fra di loro. In quest‟ottica, dunque,
la lingua universale auspicata da Comenio e ricercata da numerosi pensatori
inglesi del periodo non si pone semplicemente come il rimedio alla
confusione linguistica post-babelica, ma rappresenta il rimedio all‟ignoranza
post-edenica, in quanto sarebbe in grado di ristabilire il contatto originario e
innocente con le cose e, di conseguenza, il dominio sulla natura.
L‟opera in cui Wilkins delineò il suo progetto di lingua universale fu
11.
An Essay Towards a Real Character
Seth Ward ebbe il merito di suggerire
10
Mentre in Francia il dibattito sulla lingua universale raggiunse la sua massima
fioritura nella prima metà del Seicento, in Inghilterra giunse a maturazione nella
seconda metà del secolo; un esempio significativo della precocità francese rispetto agli
ambienti anglosassoni può essere costruito dagli scambi epistolari sul tema avvenuti
fra Mersenne e Cartesio a partire dal 1629.
11
Lo scritto venne pubblicato a Londra nel 1668 a cura della Royal Society, alla quale
era dedicata, come rivela la nota riportata a fianco del frontespizio, datata lunedì 13
aprile 1668 e relativa all‟incontro dei fellows che si espresse a favore dell‟iniziativa. Il
51
51
a Wilkins la composizione di un trattato che coinvolgesse tematiche legate
alla grammatica, alla semantica, alla fonetica, ma che contenesse rilevanti
riflessioni filosofiche concernenti l‟affascinante questione della lingua
universale. È probabile che Wilkins abbia posto mano al saggio a partire dal
1657 oppure, al più tardi, nel 1659; lo ultimò nel 1665, ma l‟incendio di
Londra del 1666, distruggendo le due copie già stampate e la versione
manoscritta, ne ritardò la pubblicazione.
L‟ambizioso scopo perseguito da Wilkins, ma da lui stesso ritenuto
non ancora pienamente realizzato dal suo scritto, era quello di fornire una
“chiara espressione di tutti gli oggetti e di tutte le nozioni che sono
classificabili nei discorsi”.
Wilkins propone riferimenti espliciti all‟opera svolta dall‟Accademia
della Crusca e dall‟Accademia francese, entrambe impegnate nella
compilazione di dizionari ragionati, al fine di suffragare la necessità del suo
saggio: quest‟ultimo, infatti, sarebbe in grado di proseguire lo spirito delle due
imprese continentali, potenziandone l‟utilità pratica per l‟intero genere umano
attraverso l‟aggiunta del carattere di universalità.
Wilkins condivideva con Comenio la relazione tra lingua filosofica e
riforma educativa, in quanto anch‟egli vedeva tra questi elementi un
necessario rapporto di inclusione e di strumentalità della prima rispetto alla
seconda. In questo senso va letto il riferimento costante alla facilità che
caratterizzava il “carattere reale” di Wilkins: l‟unicità del linguaggio, derivante
dalla sua universalità, comportava, insieme ad un‟estrema semplificazione
nelle comunicazioni fra le nazioni, anche la possibilità di apprendere in un
solo idioma tutte le parole necessarie ad esprimere tutti i concetti. D‟altra
parte, si trattava di un orientamento congeniale e non nuovo agli ambienti
inglesi, in quanto già emerso negli scritti baconiani.
La prospettiva di Wilkins nei confronti della lingua universale, inoltre,
era caratterizzata, come quella di Comenio, da una spiccata sensibilità
religiosa che faceva sì che si individuasse in essa principalmente un prezioso
strumento per facilitare gli scambi di conoscenze fra i vari paesi, la diffusione
del Cristianesimo e lo smascheramento degli errori di interpretazione delle
Sacre Scritture che erano all‟origine di sanguinosi conflitti.
Nell‟epistola che apre il saggio di Wilkins si legge:
trattato, molto ampio, è suddiviso in quattro parti, a loro volta comprendenti
rispettivamente cinque, dodici, quattordici e sei capitoli; vi sono esposti numerosi ed
eterogenei argomenti, tra i quali l‟origine e la struttura degli alfabeti e delle lingue (con
particolare attenzione agli sviluppi della lingua inglese), la classificazioni degli esseri
naturali, le categorie logiche aristoteliche, le regole grammaticali ed ortografiche e,
nella parte conclusiva, il progetto di lingua universale.
52
52
In aggiunta a quell‟estremamente ovvio vantaggio che ne deriverebbe,
cioè la facilitazione del reciproco Commercio tra le diverse nazioni del
mondo e il perfezionamento dell‟intera conoscenza della natura, esso
[il “carattere reale” di Wilkins] condurrebbe analogamente alla
diffusione della conoscenza della religione. Dopo il dono dei miracoli,
in particolare quello delle lingue, riversato sugli Apostoli nella fase
nascente del Cristianesimo, non c‟è nulla che sia in grado più del
progetto qui proposto di realizzare quelle speranze, che consistono
nella diffusione della religione. A questo sarà opportuno aggiungere
che il presente progetto contribuirà anche in modo sostanziale a
chiarire alcune delle nostre attuali differenze in ambito religioso
evidenziando molti errori avventati che si rifugiano dietro espressioni
ingannevoli e false che, una volta svelati attraverso argomentazioni
filosofiche e rese coerenti rispetto all‟autentico e naturale significato
delle parole, appariranno inconsistenti e contraddittorie; e molte di
quelle che pretendevano di essere misteriose e profonde nozioni,
espresse con parole altisonanti, per mezzo delle quali alcuni si sono
guadagnati la fama, dopo essere state esaminate in questo modo, si
riveleranno o assurdità o nozioni molto banali e sterili.
La lingua universale, quindi, si poneva come strumento di diffusione
del messaggio religioso autentico e di smascheramento delle imposture:
proprio attraverso la seconda funzione si sarebbe esplicata la prima, poiché
la verità sarebbe emersa dalla demolizione delle ambiguità e dagli errori insiti
in molte dottrine fantasiose. Questi ultimi venivano considerati da Wilkins
sostanzialmente errori linguistici, dovuti ad un linguaggio oscuro e retorico
che nascondeva attraverso parole ed espressioni contorte o eleganti concetti
oziosi e puerili. È interessante il riferimento al miracolo della polilalia: Wilkins
è convinto che il lavoro da lui intrapreso, sebbene non perfetto, come spesso
ammette nel corso della lettera, sia in grado di imitare gli effetti prodigiosi che
si erano verificati grazie a quel dono divino concesso agli Apostoli e ai primi
12
Cristiani .
Le due aree di convergenza indicate hanno indotto numerosi
studiosi ad assumere una posizione simile a quella argomentata da
Subbiondo. D‟altra parte, già Benjamin DeMott, prima di Subbiondo, aveva
sostenuto che Comenio ebbe un ruolo determinante e diretto sulla
formazione del movimento stesso e sugli orientamenti dei dibattiti da esso
animati. Tale posizione sembra essere suffragata da alcune note rintracciate
tra le carte di Hartlib in cui si ricollega il progetto di Wilkins di una lingua
filosofica ad autori che si occuparono di disegni simili in anni precedenti.
DeMott ha interpretato questi riferimenti come accenni a Comenio e a
12
Il miracolo è narrato negli Atti degli Apostoli, 2, 4-11.
53
53
Cyprian Kinner e ha rafforzato la sua tesi sostenendo che la parte della Via
Lucis dedicata alla trattazione della lingua universale potrebbe risalire al
periodo del soggiorno inglese di Comenio.
Sul fronte opposto si sono schierate Vivian Salmon, Marta Fattori e
Brigitte Asbach-Schnitker. In particolare, Vivian Salmon tende ad affermare
con decisione l‟autonomia e l‟originalità delle riflessioni linguistiche
britanniche. La Salmon dissente da DeMott soprattutto per quanto concerne
l‟ultimo argomento qui ricordato, in quanto è assai probabile che nel periodo
intercorso fra il 1641 e il 1668, data di pubblicazione della Via Lucis,
Comenio abbia rivisto e modificato l‟opera, forse proprio nella parte in
questione.
Inoltre, Wilkins non faceva parte del circolo hartlibiano al tempo
della vista di Comenio e quindi potrebbe addirittura non averlo neppure
13.
incontrato
Subbiondo tenta di dirimere la questione ponendo in luce che
Comenio effettivamente riferisce di interventi sul testo della Via Lucis
successivi alla prima stesura del 1641, ma non specifica né le parti cambiate
né quelle che cominciarono a circolare in Inghilterra nella forma manoscritta,
all‟indomani della sua partenza; questo argomento, dunque, non è in grado di
dimostrare un‟influenza diretta del pensiero linguistico comeniano sugli
ambienti inglesi; inoltre non è possibile stabilire con certezza se Wilkins e
Comenio si siano incontrati nel 1641, nonostante alcune fonti comuni e la
comune conoscenza di Hartlib e Theodore Haak. In virtù di queste
considerazioni, Subbiondo opta per una cauta conclusione di compromesso:
probabilmente è scorretto affermare un‟influenza comeniana a senso unico
sugli ambienti inglesi, mentre pare ragionevole ipotizzare un mutuo scambio
di spunti e suggestioni sulla lingua universale fra i due ceppi, continentale e
britannico.
Un‟ulteriore ipotesi interpretativa in linea con la conclusione di
Subbiondo potrebbe individuare in Comenio colui che impresse un nuovo
corso ai dibattiti anglosassoni, spostando significativamente l‟attenzione dai
già noti e più volte esplorati aspetti del “carattere reale” al tema della
creazione di una vera e propria lingua universale. Prima del 1641, infatti, non
erano mai comparsi in Inghilterra trattati dedicati esplicitamente e
specificamente alle lingue universali, ma piuttosto sistemi alfabetici o tabelle
di segni linguistici non integrati in strutture linguistiche complesse. Questa
13
L‟inizio della corrispondenza fra Wilkins e Hartlib risale effettivamente solo alla metà
degli anni Quaranta; gli scambi epistolari si sarebbero protratti fino agli anni Cinquanta;
è possibile ipotizzare contatti negli anni precedenti alle prime lettere se si pensa che
Haak, già conosciuto sia da Hartlib sia da Wilkins nel 1641, abbia avuto la funzione di
tramite, ma non esistono prove certe in tal senso.
54
54
interpretazione, che appare piuttosto realistica, implicherebbe l‟attribuzione a
Comenio di un ruolo molto rilevante nel panorama degli studi linguistici
anglosassoni e, di conseguenza, consentirebbe di individuare nell‟intervento
hartlibiano, un fattore significativo, seppure indiretto, di sviluppo del dibattito
in materia.
Riferimenti bibliografici
J. V. ANDREAE, Descrizione della repubblica di Cristianopoli, Guida,
Napoli 1983.
T. BIRCH (a cura di), The Works of the Honourable Robert Boyle, J. &
R. Rivington, London 1744.
U. ECO, La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea,
Laterza, Roma/Bari 1993.
M. SLAUGHTER, Universal languages and scientific taxonomy in the
seventeenth century, Cambridge University Press, Cambridge 1982.
P. ROSSI, Lingue artificiali, classificazioni, nomenclature, in Aspetti
della rivoluzione scientifica, Morano, Napoli 1971.
R. PELLEREY, Le lingue perfette nel secolo dell’utopia, Laterza,
Roma-Bari 1992.
55
55
L’ALTRO CASANOVA.
LE MEMORIE NELL’IMMAGINARIO CINEMATOGRAFICO
DI FEDERICO FELLINI
di Giacomo Fronzi*
Abstract
The cinematographic representation of the character of Giacomo Casanova (17251798) by Federico Fellini can only be understood taking into account two elements: the
category of great seducers and the 18th Century. As for the first aspect, this paper
emphasizes the differences and similarities between Casanova and Don Giovanni.
Concerning the second aspect, Casanova seems to embody the ambiguities and
contradictions of “the Age of Reason”. These two aspects contribute to explain Fellini‟s
work, which aims at demystifying this character by questioning the traditional model of
the Italian seducer. This “other Casanova” must not be interpreted solely in a fantastic
manner but also in a metaphorical one. Its current value lies in the existential behavior
expressed by the modern man which can be portayed through the image of an eye
flowing across reality without interpreting it, neither emotionally nor judgmentally. This
is the “non-life”.
La traduction cinématographique du personnage de Giacomo Casanova (1725-1798)
réalisée par Federico Fellini ne peut être pas vraiment comprise qu‟en relation avec
deux éléments: la catégorie des grands séducteurs e le dix-huitième siècle. Pour ce
qui concerne le premier aspect, cet article souligne les différences et les similitudes
entre Casanova et Don Giovanni. Quant au deuxième aspect, Casanova semble
incarner en soi les ambiguïtés et les contradictions du “siècle des lumières”. Ces deux
aspects contribuent à éclaircir l‟opération de Fellini, qui vise à démythifier le
personnage en bouleversant le modèle traditionnel du séducteur italien. Cet “autre
Casanova” ne doit pas être interprété de façon fantastique, mais aussi métaphorique.
Son actualité réside dans l‟attitude existentiel manifesté par l‟homme contemporain et
qui se présente dans la forme d‟un œil qui regarde la réalité sans l‟interpréter, ni avec
le sentiment, ni avec le jugement. C‟est la “non vie”.
*
Laureato in Filosofia presso l‟Università del Salento. Ha conseguito il titolo di dottore di
ricerca in Etica e antropologia filosofica. Attualmente collabora con la cattedra di
Estetica, in qualità di assegnista di ricerca. Si è diplomato in pianoforte presso il
Conservatorio “T. Schipa” di Lecce.
56
56
La trasposizione cinematografica del personaggio di Giacomo Casanova (1725–1798)
realizzata da Federico Fellini può essere compresa solo se si considera la relazione
che intercorre fra due elementi: la categoria del grande seduttore ed il diciottesimo
secolo. Per quanto riguarda il primo aspetto, questo saggio sottolinea le differenze e le
similitudini fra Casanova e Don Giovanni. Per ciò che concerne il secondo aspetto,
Casanova sembra incarnare le ambiguità e le contraddizioni del “secolo dei lumi”.
Questi due aspetti contribuisco a chiarire l‟opera di Fellini, che si propone di
demistificare questo personaggio mettendo in discussione il modello tradizionale del
seduttore italiano. Quest‟ “altro Casanova” non deve essere interpretato soltanto in una
maniera fantastica ma anche in una metaforica. La sua attualità risiede nell‟assunzione
della condotta esistenziale dell‟uomo moderno, la quale può essere raffigurata
attraverso l‟immagine di un occhio che scruta la realtà senza interpretarla, né con il
sentimento né con la ragione. Questa è la “non-vita”.
_____________________________
1.Il secolo dei seduttori
57
Sono Giacomo Casanova, cavaliere di Seingalt. Di Venezia. Nacqui a
Venezia nel 1725. Mia madre era celebrata attrice Zanetta. Discendo
da una famiglia antichissima. Non ho mai avuto una meta fissa. Mi
sono lasciato andare dove mi spingeva il vento… Ricordandomi i
piaceri avuti me li rinnovo, e rido delle pene sofferte che non sento
più… Ho avuto tutti e quattro i temperamenti: il flemmatico, il
sanguigno, il bilioso, e il melanconico. Adattando l‟alimentazione alla
mia costituzione, ho sempre goduto di buona salute. Sentendomi nato
per il sesso diverso dal mio, lo amai sempre e me ne feci amare per
quanto possibile… Amai i piatti dal sapore forte: il pasticcio di
maccheroni d‟un bravo cuoco napoletano, l‟ogliapòdrida, il merluzzo di
Terranova molto vischioso, la cacciagione il cui aroma sconfina con il
puzzo, i formaggi la cui perfezione si rivela quando i piccoli esseri che
li abitano cominciano a diventare visibili… Amai soprattutto la mia città,
antica e gaia, crudele e tenerissima ( F. Fellini, B. Zapponi, 1976: p. 3).
Con queste parole, nella sceneggiatura originale scritta da Federico
Fellini e Bernardino Zapponi per il Casanova felliniano (1976), il protagonista
57
1.
si presenta. Questo incipit, in verità, non troverà poi effettiva realizzazione
Al suo posto troviamo le immagini di una Venezia notturna e oscura alle
2
prese con un‟inedita celebrazione dello sposalizio con il mare . Secondo
Fabrizio Borin, non aver seguito questa traccia iniziale riflette l‟intenzione di
Fellini di eliminare dalla sceneggiatura “i motivi della libertà e della curiosità,
[…] perché il regista non pensa di dover dare spessore allo spirito
indipendente ostentato da Casanova, che invece considera bloccato,
ingabbiato e schiavo del carattere e dei propri istinti erotici” ( F. Borin, 2007:
p.73). Sul modo di concepire il personaggio, da parte di Fellini, torneremo più
avanti. È interessante riscontrare come quest‟idea iniziale sia stata fatta
propria, quasi trent‟anni più tardi, da Laurence Dunmore, il quale fa recitare al
suo libertino un monologo (della durata di circa due minuti) nel quale il
protagonista, John Wilmot, conte di Rochester, si presenta a coloro i quali,
uomini e donne, si accingono ad assistere alle sue gesta. Così come era
previsto inizialmente da Fellini e Zapponi per Casanova, Dunmore fa venire
fuori dal buio il libertino, creando immediatamente un‟atmosfera densa di
attesa e di curiosità.
Questo rapido riferimento al monologo iniziale recitato da John
Wilmot, letterato e libertino realmente esistito (proprio come Casanova) tra il
1647 e il 1680, non è solo interessante come dimostrazione della vasta eco
che il film di Fellini ha generato, ma è anche utile ad inquadrare il soggetto,
Giacomo Casanova (1725-1798), la cui veste cinematografica realizzata da
Fellini non può essere compresa fino in fondo se non la si mette in relazione
a due elementi: la categoria alla quale generalmente viene associato, vale a
dire quella dei grandi seduttori, e l‟epoca in cui Casanova è vissuto, quindi il
Settecento.
La figura di Casanova viene fatta coincidere, nell‟immaginario
comune, con quella del grande seduttore italiano, perfetta sintesi tra libertà di
pensiero e d‟azione, fascinazione, seduzione e ambiguità. Questi caratteri
possono, però, essere attribuiti ad una moltitudine di figure apparentemente
simili, le cui gesta la storia e la letteratura hanno contribuito a rendere
proverbiali e “mitiche”. Fra queste, spicca, per notorietà e variegata
trattazione, quella del Don Giovanni, la cui prima veste letteraria ci è fornita
1
Non si tratta dell‟unica variazione rispetto alla sceneggiatura originale, nella quale
erano previste numerose scene che poi non sono state realizzate.
2
Inedito perché, come ha scritto Gian Luigi Rondi, non si tratta del solito matrimonio
col mare. Il Doge è presente, “ma taglia un nastro che permette a qualcuno,
piombando in acqua, di tagliare a sua volta un altro nastro che dovrebbe lasciare
emergere dalle acque una misteriosa testa di donna. Chi è? “Una specie di nume
lagunare – l‟ha definita Fellini – la grande madre mediterranea, la femmina misteriosa
che abita in ciascuno di noi”“ (G. L. RONDI, in “Il Tempo”, 11 dicembre 1976).
58
58
da Tirso de Molina (fray Gabriel Téllez dell‟Ordine della Merced), con il suo El
burlador de Sevilla y convidado de piedra (1630).
La storia del Burlador è nota. Il seduttore, sotto le mentite spoglie di
Don Ottavio, tenta di conquistare donna Anna, la quale, accortasi del tranello,
urla ed invoca l‟aiuto di qualcuno. Giunge il padre, don Gonzalo, che, nel
tentativo di difendere la figlia, si scontra in duello con Don Juan e viene
ucciso. Si susseguono altre vicende, che coinvolgono personaggi maschili e
femminili. Tra queste vicende, ne emerge una per pregnanza e rilevanza.
Una notte, Don Juan si aggira in un cimitero, quando, all‟improvviso,
riconosce la statua di don Gonzalo, alla quale si rivolge con ilarità e
leggerezza. Don Juan invita a cena don Gonzalo, presso la propria casa,
compiendo in questo modo un oltraggio gravissimo: ha infranto il divieto di
tenere separato il mondo dei vivi da quello dei morti. Don Gonzalo si
presenterà, come Convitato di pietra, e rilancerà l‟invito, ma questa volta
presso la propria dimora, l‟inferno. Il dramma, che ha una dimensione
escatologica, si conclude con la caduta di Don Juan nell‟inferno e con la sua
successiva e definitiva redenzione.
Nella versione di Tirso, Don Juan, l‟eroe (che si può considerare il
primo dei tre elementi che caratterizzano il “sistema dongiovannesco”), è un
giovane nobile, figlio traviato di buona famiglia, ed è presentato come
seduttore o ingannatore di donne. Quest‟ultimo aspetto distintivo dell‟eroe
implica la presenza delle donne, di un gruppo femminile (secondo elemento
del sistema), costituito da Anna, nobile e figlia di Don Gonzalo, Tisbea, la
pescatrice, Isabella, nobile fanciulla, e Aminta, giovane campagnola. A questi
elementi, va aggiunto il terzo, il più innovativo, che consiste nelle sembianze
che vengono date al Morto che ritorna, ossia quelle di una statua di pietra.
Per la sua ambiguità di materia e di vita, di pesantezza e di animazione, la
statua che parla e cammina è una forma creata per turbare, per produrre a
colpo sicuro l‟effetto di inquietante estraneità.
A partire dall‟analisi della figura di Don Giovanni condotta da Jean
Rousset (Id., trad. it. 1980), è possibile individuare un fondo mitico presente
in quello che è stato definito “sistema dongiovannesco”. Il Don Giovanni,
nonostante apparentemente contravvenga ad alcuni requisiti necessari per
poter parlare di mito (l‟anonimato, l‟essere “fuori dalla storia”, ecc.), sembra
conservare dei tratti che, opportunamente analizzati, tanto in una prospettiva
storico-antropologica quanto in una letteraria, potrebbero consentire di
considerarlo un vero e proprio “mito”. Non sarebbe mito, sostiene Rousset,
sulla base delle definizioni di Eliade, Lévi Strauss o Vernant, perché non si
colloca in una società arcaica ma nell‟era storica. Ciononostante, “la
presenza attiva del Morto, della Statua animata crea un legame con l‟aldilà e
con il sacro”( Ivi, p.5), ricalcando le vicende di una leggenda popolare
59
59
conosciuta nell‟occidente cristiano, il cui riferimento implicito farebbe
riaffiorare, nel Don Giovanni originario, un “fondo mitico dimenticato”. A ciò si
aggiunge l‟importanza del pasto e dello scambio alimentare, presenti a più
riprese nelle varie versioni letterarie e teatrali del mito.
Se questo avvicina Don Giovanni al mito, ciò che nuovamente lo
allontana è un altro elemento: “i miti non hanno autore” (Lévi Strauss).
Eppure, Don Giovanni non ha tardato a rendersi indipendente dal suo
inventore e dal testo del fondatore. Esso giunge a vivere una vita propria,
recuperando perciò l‟elemento caratteristico del mito che è l‟anonimato,
legato al suo durevole potere sulla coscienza. Ma con chi si identifica lo
spettatore? Con le vittime del libertino? Con il delinquente dal fascino
seduttore, con il ribelle glorificato nel romanticismo? Don Giovanni è una
figura variabile, plastica, ora modello positivo ora modello negativo. Da tale
plasticità – prosegue ancora Rousset – derivano, a causa dell‟azione di lunga
durata sull‟immaginazione collettiva, l‟usura e la degradazione. Cosa resta
del Don Giovanni secentesco nel Don Giovanni ottocentesco? L‟identità
originaria è evaporata. Attraendo su di sé tutto l‟interesse, “l‟eroe si è
allontanato dallo scenario iniziale, ha perduto il contatto con il Convitato e
l‟epilogo sovrannaturale. Morte del mito e, quindi, prova che il mito è riuscito,
fin troppo bene” (Ivi, p.7).
Vi sono alcuni topoi ricorrenti nelle varie reinterpretazioni del mito di
Don Giovanni. Il topos del seduttore, però, pur nella sua quasi necessarietà
non risulta essere quello centrale, dal momento che, come precisa ancora
Rousset, nelle vicende di personaggi come il duca di Lauzun, il marchese de
Sade o Casanova, manca il rapporto con il Morto e con il soprannaturale. È
possibile, però, ricostruire un legame tra Don Giovanni e gli altri famosi
seduttori? Quali sono le caratteristiche che li accomunano e quali quelle che
li differenziano? Dal momento che queste pagine sono dedicate al Casanova
felliniano, mi limiterò a fare dei riferimenti al alcune delle relazioni che si
possono individuare tra Casanova e Don Giovanni, con una maggiore
attenzione a quest‟ultimo, indubbiamente uno dei miti moderni per
eccellenza.
Siamo a Praga. È il 29 ottobre 1787. Va in scena il Don Giovanni di
Mozart, riscuotendo un enorme successo. La prima rappresentazione di
Praga si sarebbe dovuta allestire alcuni giorni prima, nell‟ambito dei
festeggiamenti tributati all‟arciduchessa Maria Teresa, nipote di Giuseppe ii,
e il principe Antonio di Sassonia, novelli sposi in viaggio di nozze ed in visita
a Praga. Come ci ricorda Giovanni Macchia, le grandi dame della società
praghese riuscirono a convincere il governo a non mandare in scena il Don
Giovanni, poco idoneo alla visione di due sposi regali. Venne addotta la
scusa che gli allestimenti non erano ancora pronti, quando, invece, il motivo
60
60
era un altro: “se i due spettatori imperiali avessero capito di quel “dramma
giocoso” quel che c‟era da capire, lanciandosi l‟un l‟altro occhiatacce di
disgusto, avrebbero dovuto abbandonare la sala prima della fine dello
spettacolo” (G. Macchia, 1989: p. 147). Così, andarono in scena Le nozze di
Figaro e il Don Giovanni venne rinviato al 29 ottobre. In quel giorno, però, la
mancanza, nei lussuosi palchi, dell‟arciduchessa e del principe non si fece
sentire più di tanto. Al loro posto vi era un personaggio che da sé, grazie alla
sua sola presenza, assegnava alla rappresentazione un tocco di scandalo e
di modernità. “Il Don Giovanni che si agitava sulla scena aveva nel pubblico
un suo “doppio” in carne ed ossa” (Ivi, p.148): Giacomo Casanova. Mozart
aveva trentun anni, mentre Casanova ne aveva sessantadue. Le vicende alle
quali il veneziano assiste rappresentano, per lui, un salto indietro nel tempo,
un ritorno a quel che aveva animato la sua vita e il suo passato, pur nella
diversa, più oscura e più drammatica trama creata dal genio mozartiano.
Probabilmente la visione del Don Giovanni ha accentuato in
Casanova, per un verso, la volontà di scrivere la storia della propria vita, per
altro verso, il già forte bisogno di differenziarsi dagli avventurieri e impostori
che affollavano il Settecento. Casanova si sentiva diverso. Si sentiva un
pensatore che non dilapidava la propria esistenza rincorrendo in modo
estenuante ed ossessivo il piacere, senza preoccuparsi di lasciare tracce di
sé. Icosameron e Histoire de ma vie. In questi titoli era, invece, riposto
l‟obiettivo di Casanova: dare forma letteraria (quindi, potenzialmente eterna)
alla propria vita. Non si trattava di rendere immortale la vita di un libertino, ma
quella di un libertino-pensatore, lontano da quel tono demoniaco, infernale e
criminale che caratterizzava, ad esempio, Don Giovanni (Ivi, p.150).
Per quanto riguarda queste due figure, quindi, ci sono almeno tre
elementi che stabiliscono immediatamente delle differenze e che fanno del
primo un mito e del secondo un “quasi-mito”(J. Rousset trad. it 1980 : p.14). Il
primo elemento è il fatto che mentre Don Giovanni è un personaggio di
finzione, Giacomo Casanova, come abbiamo già detto, è realmente esistito.
Prima di diventare un personaggio letterario e cinematografico è stato un
uomo in carne ed ossa, le cui gesta hanno attraversato i secoli grazie alla
loro “versione cartacea”: Histoire de ma vie. Il secondo elemento è l‟assenza
di quel repertorio di “invarianti” che collegano le vicende di Casanova ad un
fondo mitico. Quel che lo rende, invece, un quasi-mito è il fatto che così
come Don Giovanni si è presto staccato dalla figura originaria del burlador e,
quindi, dal suo primo autore, Casanova, dopo la sua morte, è passato di
opera in opera, di autore in autore, come se non appartenesse più a se
stesso, ma a tutti e a nessuno, riconoscendo, dunque, in questo
quell‟anonimato (per quanto anomalo) proprio del mito, “legato al suo
61
61
durevole potere sulla coscienza collettiva che si accompagna ad un‟attitudine
a nascere e rinascere trasformandosi continuamente” (Ivi, p.6).
Il terzo importante elemento di differenziazione è costituito dalla
totale incultura di Don Giovanni. Mentre quest‟ultimo probabilmente non
aveva al suo attivo neppure la lettura di un libro, Casanova si era occupato e
aveva scritto di un po‟ di tutto, di filosofia e di teatro, di cabala e di poesia, di
epica e di magia. Tant‟è che Casanova non si trovava a Praga per diletto o
per piacere, ma per individuare possibili sottoscrittori per l‟edizione del suo
Icosameron.
La rappresentazione del 29 ottobre conferma Casanova nel suo
intento di procedere nella narrazione della sua storia, anzi, delle sue
innumerevoli storie, bandendo sensi di colpa e remore. Egli voleva tirare fuori
una confessione, la quale non poteva che prendere la forma dello scandalo,
dell‟opera cinica e proibita, che sarebbe circolata in mezza Europa,
costituendo una sfida lanciata al diffuso moralismo e alla storia, un‟opera i cui
ingredienti sarebbero stati il vitalismo, la gioia, la ricerca del piacere e della
felicità, senza alcuna tragedia.
Procedendo in maniera più sintetica, un elemento che accomuna le
storie dei due seduttori è l‟ovvia presenza di un gruppo femminile, sebbene,
nel caso di Casanova, si tratti di un gruppo più indefinito e variegato, che
spazia sì tra donne di ceto sociale diverso, perfino tra donne con notevoli
differenze di età, ma che manca di quella sorta di simmetria tra i personaggi
femminili che, ovviamente, è possibile ritrovare nella finzione letteraria. Li
separa nuovamente l‟assenza dell‟oltraggio dovuto all‟affronto lanciato al
Morto, poiché non vi è alcuna presenza di morti nella storia di Casanova.
Ciò che li accomuna è, senza dubbio, lo sfondo storico e culturale
all‟interno del quale questi personaggi si muovono, sfondo che ci riporta
immediatamente al secondo elemento di cui parlavo in apertura, vale a dire
all‟ambiguo carattere dell‟illuminismo europeo.
Nell‟appendice alla sua Breviario di estetica, Benedetto Croce
affronta il rapporto tra spirito e senso nel Settecento, secolo che vede la
nascita dell‟estetica come disciplina, per dirla con il filosofo, “moderna e
mondana”. Tale rapporto, nel Settecento, è improntato sulla reciproca
influenza dei due elementi: lo spirito si sensualizza ed il senso si spiritualizza.
Una stessa varietas, ma sempre all‟interno dell‟unitas, proprio a proposito di
quanto si sta dicendo, emerge dalla lettura kierkegaardiana del Don Giovanni
di Mozart. Il filosofo danese mostra come l‟ambivalenza della natura umana,
ben nota ai classici nella forma del „doppio‟ apollineo-dionisiaco, diventi col
cristianesimo una vera e propria antitesi, e come la sensualità acquisti tutto il
suo rilievo e addirittura diventando “un principio”, ossia “una forza, una
potenza” del mondo, propriamente “l‟erotico”, come scrive Kierkegaard in
62
62
Enten-Eller, solo nel momento in cui si trasforma nel demoniaco, nel
peccaminoso contro lo „spirituale‟.
La letteratura sull‟argomento è evidentemente troppo vasta. Ma,
rimanendo nell‟alveo di una lettura del personaggio felliniano, ricorrerò ora
all‟analisi di alcuni elementi tipici della riflessione estetica e di certi suoi
sviluppi storici, in particolare al pensiero di Søren Kierkegaard, che ha
assegnato filosoficamente all‟“estetico” la dignità e la legittimità di un
atteggiamento esistenziale, proprio per come accade con i grandi seduttori e
libertini. Occorre giusto ricordare, avendo posto l‟accostamento, che
Giovanni Macchia, relativamente alle categorie del dongiovannismo e del
libertinismo, propone una distinzione. La corrente libertina, scrive Macchia,
ha le sue origini nel Rinascimento italiano e grazie ad esso trova diffusione e
nuovo sviluppo in Europa: “spiriti forti, liberi pensatori, francamente atei,
intelligenze sottili, che affermano l‟indipendenza e l‟autonomia della ragione,
e hanno in sospetto il sentimento, come base della falsa fede, delle
superstizioni e delle credenze” (G. Macchia, 1991: p. 59).. Questa libertà,
primariamente di pensiero, in un secondo momento assume i connotati della
libertà erotica e sessuale, cosicché il libertinismo risulterà in qualche modo
corrotto dal dongiovannismo. Pertanto, discutere di seduttori e libertini, di
Don Giovanni e Casanova, significa muoversi in bilico tra libertinismo e
dongiovannismo, tra libertà di pensiero e libertà sessuale, tra intellettualismo
ed eros (finanche patologico).
Per quanto riguarda il ruolo ed il peso dell‟“estetico” nell‟orizzonte di
Kierkegaard, Theodor W. Adorno ha sostenuto: “la sintesi dei significati […]
può riuscire alla costruzione solo quando se ne siano resi chiari e nitidi gli
elementi”. Adorno rileva la possibilità di individuare tre significati dell‟estetico
in Kierkegaard, che, pur nella loro interconnessione, offrono un quadro più
articolato del problema. Secondo un primo significato, “estetico” indicherebbe
“il campo delle opere d‟arte e della riflessione teorica sull‟arte”, per come
questa si presenta, ad esempio, nel primo volume di Aut-Aut. Il secondo
significato rinvia invece all‟estetico come atteggiamento, quindi ad una
“sfera”, quella estetica, capace di orientare i comportamenti senza dover fare
ricorso a principi etici. Questo secondo uso della parola “viene definito
esplicitamente già in Aut-aut: “l‟estetica nell‟uomo è quello per cui egli
spontaneamente è quello che è; l‟etica è quello per cui diventa quello che
diventa. Chi vive tutto immerso, penetrato nell‟estetico, vive esteticamente”“.
Il terzo significato, per concludere, è il meno frequentato da Kierkegaard,
tanto che lo si ritrova soltanto nella Postilla conclusiva non scientifica. In
questo luogo, “l‟estetico è riferito alla forma della comunicazione soggettiva,
[in quanto] “il pensatore soggettivo deve subito rivolgere la sua attenzione al
fatto che la forma dovrà avere artisticamente altrettanta riflessione quanta
63
63
egli stesso, esistendo, ne ha nel suo pensiero” (Th.W. Adorno, trad. it. 1983:
pp. 47-51).
Di questi tre significati di “estetico”, quello a cui è stata riservata
maggiore attenzione da parte della letteratura critica è senz‟altro il secondo,
non soltanto perché costituisce, come già rilevava Adorno, il significato
centrale nell‟opera del pensatore danese, ma perché utilizza in maniera
originale il termine “estetico” per individuare un atteggiamento esistenziale,
inteso come ciò per cui chi vive “è immediatamente ciò che è”3. Questa sorta
di primato dell‟estetico è quanto Adorno rinviene nell‟ambito della teoria delle
tre sfere (estetica, etica e religiosa). La prima, lungi dal costituire una forma
di esistenza meno vincolante e puramente esteriore, viene rivalutata
dall‟analisi adorniana e rilanciata come la sfera entro cui, più delle altre, la
4
verità riesce a mostrarsi . Kierkegaard rende quindi problematico il rapporto
tra estetica ed etica, giacché la seduzione sensuale, per il filosofo,
massimamente espressa da Don Giovanni, si presenta come la possibilità di
sottrarre l‟estetica sia al rigore deterministico del pensiero sia alla
giurisdizione dell‟etica, al fine di offrirle, in tal modo, una legittimità ed una
dignità nuove.
Quella di Kierkegaard è un‟interpretazione pregnante e
filosoficamente densa della figura del Don Giovanni mozartiano, che ha
contribuito, in parte, a rafforzare l‟idea di un fondo filosofico nel mito di Don
Giovanni e, in parte, a rimarcare la complessità del rapporto tra razionalità e
sensibilità, tra etica ed estetica. Si è trattato, però, di un tentativo isolato,
rispetto alle innumerevoli analisi del mito dongiovannesco, condotte negli
ambiti musicologico, letterario, psicologico o antropologico. A questo
proposito, Umberto Curi ha creduto opportuno rilanciare l‟approccio filosofico
adombrato soprattutto nel saggio kierkegaardiano, proponendo, in Filosofia
del Don Giovanni, un‟analisi filosoficamente orientata a richiamare
3
È una definizione contenuta ne L’equilibrio tra l’estetico e l’etico nell’elaborazione
della personalità (Enten-Eller. Un frammento di vita, seconda parte, a cura di A.
Cortese, 5 tomi, Adelphi, Milano 1976-89, tomo V, p. 46).
4
Resta una questione aperta, rileva Paolo Pellegrino, se la critica di Adorno alla “logica
delle sfere” renda giustizia ai problemi interpretativi della filosofia di Kierkegaard, il
quale distingue tre forme di esistenza o modi di vita, che Adorno chiama sfere. Lo
stadio estetico è caratterizzato da un orientamento verso il piacere, alla ricerca della
pura gioia dei sensi. Alla forma di esistenza etica corrisponde il comportamento
orientato verso la responsabilità. Tale stadio si trova in un rapporto di negazione
rispetto a quello estetico. Il modo di essere religioso presuppone un Sé che si
relaziona a se stesso in rapporto a Dio. Questo stadio è, a sua volta, la negazione
degli altri due. Per raggiungere lo stadio religioso occorre un “salto esistenziale” (cfr. P.
PELLEGRINO, Estetica e comunicazione nel panorama teorico del Novecento, Congedo
Editore, Galatina 2008, p. 92).
64
64
l‟attenzione
sull‟eccessiva
presenza,
nell‟amplissima
bibliografia
dongiovannesca, di interpretazioni del mito strutturate ricorrendo in maniera
quasi esclusiva all‟elemento seduttivo, erotico e sensuale. Secondo Curi,
infatti, una rilettura filosofica delle tre versioni “classiche” del mito di Don
Giovanni (vale a dire, quelle di Tirso, di Molière e di Mozart) fa emergere il
fatto che in questi testi “è totalmente introvabile l‟immagine convenzionale di
Don Giovanni come impenitente seduttore o come insaziabile consumatore di
relazioni sessuali, mentre emergono con grande forza altri aspetti della
personalità dell‟eroe, e dell‟intera vicenda, irriducibili allo stereotipo del
collezionismo erotico, e provvisti invece di una specifica pregnanza filosofica,
5
abitualmente del tutto trascurata nelle interpretazioni correnti del mito” .
Questo nuovo ed originale approccio, che privilegia l‟individuazione
di tematiche filosoficamente e teologicamente rilevanti nel mito di Don
Giovanni, riconducendo ad esse la grandezza, la fama ed il successo del
mito, non risolve le vicende dongiovannesche in banali e insulse storielle, ma
le inserisce all‟interno di un percorso interpretativo che lascia emergere nel
mito di Don Giovanni alcune fra le questioni filosofiche e teologiche più
controverse dell‟età moderna: dal rapporto fra tempo ed eternità al problema
della Grazia e dell‟insufficienza della fede nel processo di salvazione, dal
tema dell‟essenza bellica dell‟amore a quello della relazione fra identità e
alterità per come si configura tra Don Giovanni e il suo servo, fino al tema
della morte e della giustizia divina. La complessità del mito è evidente e
riflette la complessità di un intero secolo, il Settecento, nel quale, accanto al
trionfo della ragione, dell‟Aufklärung (rischiaramento), si fa egualmente largo
l‟oscurità e l‟ambiguità della sensazione.
In questo quadro, anche Giacomo Casanova, come uomo e come
personaggio, non può che essere considerato espressione di una tale
generale complessità, nelle cui articolazioni non si trova solo la tendenza a
sfuggire dalle maglie della tradizione e della magia, ad uscire dallo stato di
minorità, per dirla con Kant, ma vi è anche una tendenza opposta, orientata
verso la penetrazione delle zone oscure del soggetto, verso la passione,
verso il sublime, verso l‟ambiguo, verso l‟orrido. Il pensiero di Casanova è il
pensiero del Settecento, vale a dire un “pensiero errante”, esaltazione della
dimensione del viaggio, che non ha solo una valenza antropologica ma
anche, e soprattutto, artistica e letteraria. Il viaggio si pone come la prima
esperienza del limite: non solo e non tanto limite geografico quanto e
soprattutto limite sociale e culturale.
5
U. CURI, Filosofia del Don Giovanni. Alle origini di un mito moderno, Mondadori,
Milano 2002, p. 8.
65
65
Giacomo Casanova contraddice, com‟è proprio della cultura
settecentesca, l‟ideale classico e razionalista del piacere come staticità e
contemplazione, affermando, invece, il piacere come viaggio, come
dinamismo accompagnato dall‟inquietudine. Da queste posizioni si arriva
facilmente al loro rovesciamento, con ipotesi filosofiche che vedono il trionfo
dell‟eccedente, dell‟eccesso e dello sregolato. Nel Settecento si afferma
l‟idea che le passioni e il piacere sensuale abbiano pieno diritto di
cittadinanza nella vita umana. Tutto il secolo è percorso dalla letteratura
licenziosa, gotica, immorale; esso oscilla pericolosamente tra moralismo e
immoralismo, tra razionalità e sensualità, tra ricerca del limite e superamento
di tale limite. È il secolo di opere come Filosofia nel boudoir (Sade, 1795),
Relazioni pericolose (De Laclos, 1782), I gioielli indiscreti (Diderot, 1747), ma
anche di romanzi gotici come il celeberrimo Il castello di Otranto (Walpole,
1764) o il famosissimo Il monaco (Lewis, 1796).
Il Settecento, dunque, non è il secolo che tende sempre e soltanto
alla ragione, non è il secolo idilliaco come spesso si tende a sottolineare.
Nico Orengo, nella prefazione all‟edizione Bompiani de Il monaco, parla del
Settecento in questi termini: “è un secolo dai nervi fragili, femminile, sensibile
alle vertigini del vuoto, della noia. Fra eleganze e galanterie, il fascino ci va
soggetto non è tanto della “solarità”, quanto del suo contrario. Non è la luce
del giorno ad attrarlo, quanto il grande universo del notturno e i suoi teatri:
foreste, rovine, cimiteri e grotte sotterranee […]. Ma al di là del perimetro
rassicurante che la ragione ha tracciato ci sono i fantasmi del primitivo, del
barbarico, del proibito”. La negatività acquisisce un nuovo potere e si cercano
nuovi limiti, di volta in volta valicabili, sui quali costruire i propri spazi di
piacere. Il marchese De Sade e Casanova forse mostrano, al limite estremo,
che il secolo della ragione vive una realtà più profonda e segreta: “è lanciato,
a gradi diversi e in forme diverse, nella ricerca di un limite inaccessibile”( J.
Chouillet, 1974: p. 128), muovendosi sul crinale tra la ragione e la passione.
Limite, piacere, profondità insondabili, sublime, terrore, tutte tematiche che
confluiranno nell‟elaborazione di Edmund Burke, preludio alla
6
baumgarteniana Aesthetica del 1750 .
Se queste, a grandissime linee, sono le direttrici del Settecento e
questo è lo sfondo culturale sul quale si muovono i grandi seduttori, ciò che
ancora accomuna Don Giovanni e Giacomo Casanova e che li rende
caratteristici è anche la molteplicità di giudizi che si possono esprimere
rispetto alle loro vicende. Come non c‟è in Don Giovanni e in Casanova solo
6
Cfr. E. BURKE, Inchiesta sul bello e il sublime, a cura di G. Sertoli e G. Miglietta,
Aesthetica edizioni, Palermo 1985; A.G. BAUMGARTEN, Riflessioni sulla poesia, a cura
di P. Pimpinella e S. Tedesco, Aesthetica Edizioni, Palermo 1999; ID., L’Estetica, trad.
it. di F. Caparrotta, A. Li Vigni e S. Tedesco, Aesthetica Edizioni, Palermo 2000.
66
66
il seduttore e il voluttuoso, ma anche il trasgressore, colui che, peccatore o
delinquente, si mette insolentemente in rotta di collisione e al di fuori delle
regole e delle norme. Di questo Don Giovanni “deviante”, ad esempio, il
romanticismo ne ha fatto un fuorilegge, un glorioso ribelle di cui la sua
mitologia aveva bisogno; la nostra epoca, invece, ha privilegiato in Don
Giovanni, nella stessa misura, “sia il rappresentante marginale di una classe
di cui rifiuta i valori, sia l‟oppositore, l‟uomo che rifiuta una società in cui non
trova più posto”( J. Rousset, trad. It. 1980: p. 138).
Come per Don Giovanni, chiunque si sia accostato all‟opera di
Casanova non ha potuto fare a meno di prendere posizione su di lui e di
giudicarlo. C‟è quindi “chi l‟ha definito “meschino, litigioso e detestabile”
7
(Charles de Ligne nelle sue Oeuvres ); chi ha trovato in lui un uomo
straordinario (Alfred de Musset); chi l‟ha giudicato “energico, briccone
matricolato”, dalla sensualità tipicamente italiana e che promana dalle sue
8
pagine in maniera soffocante (Heinrich Heine nelle sue Briefe aus Berlin );
chi infine ha dubitato dell‟autenticità di ciò che il veneziano scrisse” (G.
Ricchezza, 1966: p. 5).
Casanova è moderno e mondano, è schietto e spigliato, è talvolta
cinico, insolente, personaggio rocambolesco, ma è anche l‟antesignano degli
arrampicatori sociali, nella sua costante tendenza a raggiungere una
posizione sociale che non aveva per nascita. È “il prototipo del play-boy,
cinico nello sfruttare le sue relazioni, deciso come pochi a vivere alle spalle
degli altri, continuamente mosso da un‟irrequieta curiosità che lo porta dalla
letteratura alla cabala, dalle matematiche alla massoneria, dagli studi
umanistici ai giochi proibiti” (Ivi, p.6).
Casanova è diverso da Don Giovanni così come lo è rispetto al
marchese De Sade. Attivista instancabile e libero da ogni filosofia, il primo;
ministro del culto, di terribile e lugubre serietà, non di rado attraversata da
scosse di irresistibile humour, il secondo. Tale è la tensione dialettica che si
crea tra i due personaggi nell‟universo erotico di Guillaume Apollinaire, che,
nella sua straordinaria “mobilità”, è stato anche editore e scrittore di libri
erotici. Apollinaire mi permette di specificare i caratteri di Casanova e a
distinguere quest‟ultimo dagli altri seduttori. Don Giovanni non rientra negli
interessi dello scrittore francese, per via del suo essere un eroe del calcolo e
della strategia ragionata, per il fatto di essere una figura nella quale “l‟impulso
irresistibile di godere, l‟esaltazione nella ripetizione e nel numero, venivano
raggelati da un metodo, che provocava lutti e disastri” (G. Macchia 1989:
p.169).
7
8
Cfr. CH.J. DE LIGNE, Oeuvres, Champion, Paris 2005.
Cfr. H. HEINE, Briefe aus Berlin, Hoffmann und Campe, Hamburg 1973.
67
67
Apollinaire ama invece la pura avventura, pertanto si affeziona al
“suo” Casanova, personaggio che gode della vita, che allontana da sé
tragedia, tristezza e noia, preferendo ad esse la gaiezza, la tenerezza e
l‟eternità dell‟attimo che fugge. Casanova, in definitiva, – come scrive
Macchia – commetteva peccati e non delitti.
Quanto detto finora caratterizza il Casanova della tradizione ed è ciò
che emerge dalla lettura delle sue famose Memorie, soprattutto, dall‟alone di
mito che ha circondato questa figura nel corso dei secoli. La sua
trasposizione cinematografica, però, non intende affatto ripercorrere questo
sentiero. Aver affiancato Casanova a Don Giovanni e aver delineato i
caratteri ambigui del Settecento sono operazioni utili a far emergere l‟occhio
critico con il quale Fellini osserva ed analizza il personaggio. Nella sua
particolarissima e celebrata rivisitazione della storia del veneziano, Federico
Fellini ha inteso tratteggiare il profilo di un Casanova estraneo al libro delle
sue memorie, così come anche al Settecento e alla sua cultura, liberandosi
da qualsiasi preoccupazione di fedeltà alla storia o alla tradizione.
2. Il film
9
Il film , della durata di 148 minuti e interamente realizzato negli studi
di Cinecittà, frutto di tre anni di lavoro, di liti e di polemiche, si apre con
un‟inquadratura in campo lungo nella quale compaiono molte figure, in gran
parte mascherate, che partecipano ad una funerea edizione della famosa
cerimonia del ringraziamento al mare, nei pressi del Ponte di Rialto. Tra di
esse, in abiti bianchi, si staglia un personaggio, anch‟esso mascherato. È
Giacomo Casanova, impegnato a leggere una lettera nella quale lo si invita a
9
Dal punto di vista della storia cinematografica del personaggio Giacomo Casanova,
ricordiamo che la pellicola felliniana segue a: Casanova (1918) di Alfréd Deésy; Das
Herz des Casanova (Germania, 1918) di Erik Lund; Casanovas erste und letzte Liebe
(Austria, 1920) di Julius Szoreghi; Casanova (1927) di Alexandre Volkoff; Les amours
de Casanova (Francia, 1934) di René Barberis, L’avventura di Giacomo Casanova
(1938) di Carlo Bassoli; Les Aventures de Casanova (Francia, 1947) di Jean Boyer; Il
cavaliere misterioso (1948) di Riccardo Freda; Le avventure di Giacomo Casanova
(film del 1954, per il quale l‟allora sottosegretario allo spettacolo Oscar [“mani di
forbice”] Luigi Scalfaro impose 22 tagli alla sceneggiatura e 28 alla pellicola) di Steno,
alias Stefano Vanzina; Infanzia, vocazione, prime esperienze di Giacomo Casanova,
veneziano (1969), di Luigi Comencini. Dopo il film di Fellini, appariranno: Casanova &
Company (Austria/Italia/Francia/Rft 1976) di Franz Antel; Il mondo nuovo (1982) di
Ettore Scola; Le retour de Casanova (Francia, 1992) di Edouard Niermans; Goodbye
Casanova (Stati Uniti, 2000) di Mauro Borrelli; Il giovane Casanova (Francia, Italia,
Germania, 2002) di Giacomo Battiato; Casanova (Stati Uniti, 2005) di Lasse Hallström.
68
68
raggiungere la riva dell‟isolotto di San Bartolo, per incontrare la monaca
Maddalena, con la quale, di lì a poco, si apparterà, sotto lo sguardo
incuriosito dell‟abate de Bernis, ambasciatore francese a Venezia, nascosto
dietro un enigmatico dipinto.
È il primo incontro amoroso di un Casanova ancora giovane e
rampante, nella ricostruzione che ne fa lo stesso Casanova, divenuto ormai
un vecchio e malandato bibliotecario nel castello di Dux, in Boemia, alla fine
dei suoi giorni. Quello con la monaca non era che l‟ennesimo gesto
sregolato, al termine del quale, tra sventolanti e vistose onde lagunari
10
rigorosamente di plastica , Casanova viene arrestato e condannato, dal
tribunale della Santa Inquisizione, ad essere rinchiuso nei Piombi, dai quali,
però, fuggirà presto. È l‟inizio delle avventure di Giacomo, avventure che si
snodano tra amori e incontri, attraverso mezza Europa, da Venezia a Parigi,
da Londra a Parma, da Forlì alla Germania, da Roma alla Boemia.
Giacomo Casanova è pensato da Federico Fellini come una specie
di ombra, la sua, la nostra, quella di ogni italiano, “un‟immagine fastidiosa,
con la quale sarebbe giusto fare i conti, non puoi tagliarla fuori, perché devi
trovare il modo di conviverci”(G. Angelucci, L. Betti 1977: p.21). Casanova è
un attore nato, è un bambinone e un play-boy di provincia, ma che riesce a
raggiungere tutte le cose sognate. Nelle sue Memorie, a riequilibrare il senso
di noia che può provocare la lettura dell‟estenuante elenco di personaggi,
luoghi e donne, c‟è la curiosità di leggere, dietro quel catalogo, la volontà di
apparire, di sembrare, non tanto un seduttore, quanto un uomo di cultura, un
letterato del quale si parlerà nei tempi avvenire. In una delle ultime scene del
film, lamentandosi dell‟insopportabile comportamento canzonatorio e
irrispettoso che alcuni uomini della corte del conte di Waldenstein assumono
nei suoi riguardi, in particolare il suo ritratto affisso sulle pareti del “luogo di
decenza” con materia fecale, Casanova dice:
Osservate pure è un ritratto molto somigliante. [Dopo queste parole,
Casanova, in silenzio e sospirando, si sofferma ad osservare quel
disegno che lo ritrae da giovane, con nostalgia e tristezza, quasi con
amore]. Fu stampato come illustrazione del mio famoso romanzo
Icosameron. Lo avete letto per caso? Mi permetterò di offrirvene una
copia. Io credo che dopo la mia morte si parlerà di me per moltissimi
10
Fabrizio Borin, a questo proposito, rileva come il fatto “che Fellini visualizzi una
Venezia sempre sulla scena e per di più pietrificata, “plastificata”, è qualcosa che può
apparire un modo inedito di concepire le sue ideazioni scenografiche, solo a chi, molto
distrattamente, non tenesse conto che la finzione plastificata, la ricostruzione in studio
di porzioni di spazio, ovvero dell‟esibizione intenzionale del falso in quanto più ricco e
fantasticamente più vero del vero, è una delle cifre caratterizzanti la sua opera
complessiva” (F. BORIN, op. cit., p. 52).
69
69
anni avvenire, come autore di quell‟opera. Sono un celebre scrittore
italiano. Conoscerete il mio nome, certamente. Giacomo Casanova, da
Venezia, letterato, filosofo
Questa sequenza lascia emergere in modo chiaro la triste fine che
gli è toccata in sorte. Sbeffeggiato, deriso, sottovalutato e dimenticato. È
l‟esito finale di quello che Fellini ha definito un “esistenzialismo di superficie,
totale”, destinato a consumarsi nel dramma finale di un uomo che, con la
virilità e la giovinezza, ha perso, in definitiva, la propria identità.
La pellicola felliniana è particolarmente complessa, ricca di elementi
fantastici, attraversata da personaggi improbabili e costellata di oggetti
onirici. Si potrebbe forse ipotizzare una, seppure vaga, influenza di Alejandro
Jodorowsky sull‟immaginario di Fellini? Nel 1973 era uscita la pellicola The
Holy Mountain, forse l‟opera principale del regista ebreo-ucraino, summa
della tensione estrema, enigmatica, onirica e magica propria dell‟universo
fantastico di Jodorowsky. Un analogo orizzonte sembra caratterizzare il
proscenio sul quale si muove il Casanova di Fellini, un proscenio fatto di
lampi surreali, di paesaggi inafferrabili e di personaggi enigmatici, a
cominciare dalla prima amante che compare: una maliziosa e simpatica
monaca. Questo primo incontro amoroso fa emergere i caratteri distintivi del
personaggio: il legame, per quanto contraddittorio, con la religione cristiana
(è nel corso delle messe domenicali presso il convento che la monaca si è
11
accorta del giovane Casanova ) e la perenne ed ininterrotta attrazione per le
donne, attrazione che cresce con l‟aumentare dell‟anomalia e trasgressività
dell‟incontro. Il primo e l‟ultimo incontro, infatti, costituiscono, per quel che
riguarda la trasgressione, i due poli tra i quali Casanova si muove nel corso
della sua vita. La prima e l‟ultima donna rappresentano i due limiti estremi
che il seduttore, con profondo piacere, oltrepassa: Maddalena, la monaca, e
Rosalba, la donna meccanica.
L‟incontro con la monaca, dal punto di vista formale e non narrativo,
non costituisce però solo un momento di presentazione del personaggio o, a
narrazione conclusa, uno dei due estremi tra i quali si muove Casanova.
Rappresenta anche un episodio nel quale è facile individuare quel che via via
11
Il rapporto di Casanova con la Chiesa cattolica romana è anch‟esso molto ambiguo,
così come il suo rapporto con le donne. Nel primo caso, infatti, si oscilla tra un‟evidente
reiterata trasgressione delle più elementari norme di condotta e un‟altrettanto evidente
tensione verso la spiritualità cristiana, incarnata però da un enigmatico e improbabile
papa che ride sguaiato. Nel secondo caso, Casanova, mentre dimostra poeticamente
una profonda adorazione e venerazione nei confronti della donne, al contempo ne
mette in pratica il disprezzo, abbandonandosi ad un uso sfrenato e senza limiti del loro
corpo.
70
70
emergerà in maniera sempre più vistosa, vale a dire un‟attenzione quasi
maniacale all‟elemento espositivo, alla costruzione degli ambienti, alla
minuziosa messa in scena non solo di persone ma anche di oggetti. Fellini si
preoccupa infatti di caratterizzare in maniera forte tanto i personaggi quanto
gli oggetti, dei quali si può individuare una forte carica simbolica, ora più
esplicita, ora più nascosta.
In una delle scene iniziali, si nota come sopra la maschera di
Casanova ci sia un cappello rosso che, oltre a risaltare sul bianco delle vesti,
è di forma triangolare, una forma geometrica che si ripresenta in diverse
occasioni durante tutto il film: all‟angolo della camera nella quale Casanova
incontra la monaca, sulle vesti della giovane Annamaria, come mobilio sotto
forma di prisma in casa della marchesa d‟Urfé, come ciondolo (nella forma di
una piramide) al collo della marchesa, come valigia. La ripetuta presenza del
triangolo può significare due cose. Come triangolo allude, probabilmente, al
sesso femminile (esplicitamente celebrato in una sequenza della scena nella
balena); mentre, come prisma potrebbe fare riferimento all‟analogo simbolo
massonico, la cui presenza si spiega facilmente con la nota adesione di
Casanova alla Massoneria.
Un altro oggetto che caratterizza specificamente il personaggio è
una sorta di tabernacolo, sempre presente (tranne in occasione della sfida
romana, tutta ginnica e, pertanto, al limite con il comico, tra Casanova e il
cocchiere Richetto), nel quale Casanova conserva gelosamente e
diligentemente un uccello metallico che, come fosse un carillon, viene
azionato prima delle performance amorose del giovane veneziano, quasi a
propiziare e favorire l‟ottima riuscita delle stesse. Il risultato artistico di questa
scelta, contribuisce a tingere di ridicolo, se non di grottesco, tutte le imprese
d‟amore che Casanova, nel corso dell‟intera storia, porterà a termine,
accompagnate dalle “insinuanti musiche del maestro Nino Rota”( F. Borin,
2007: p.49).
In effetti, il Casanova tradizionale viene del tutto reinventato da
Fellini, il quale durante la conferenza stampa di annuncio dell‟inizio del film,
tenuta il 6 giugno del 1975, così si esprimeva:
Anziché nei panni vitalistici dell‟infaticabile conquistatore, io lo penso
come un vecchio goffo, disfatto e disadattato, anche un po‟
burattinesco, come un italiano imprigionato per tutta la vita nella pancia
di sua madre, da cui non ha mai saputo uscire. Chiuso nella sua umida
placenta, il mio Casanova sarà un mitomane che non ha mai provato
autentiche passioni, e che ora, giunto al tramonto, quasi rispondendo
irritato alle domande di un molesto intervistatore, tenta di riscrivere con
71
71
l‟antica spavalderia le proprie memorie, con risultati macabri e
disastrosi12
L‟intenzione fondamentale di Fellini era proprio quella di “sottoporre
ad analisi le forme stereotipate dell‟immodificabile Mito dell‟Erotismo
Maschile Italiano: un modello talmente nazionale da essersi trasformato in
patrimonio umanistico internazionale”( Ivi, p.10).
Ed ecco che Fellini procede dissacrando il personaggio,
realizzando un‟operazione di straniamento, di capovolgimento del modello
tradizionale, a cominciare dalla scelta dell‟attore protagonista, il “lunare”
Sutherland, decisamente opposto rispetto alla tradizionale immagine di un
Casanova italiano, dall‟occhio nero, magnetico, dalla pelle e dai capelli
scuri13. La cifra artistica del film è tutta nella poetica che sottende ad esso,
14
una poetica fatta di vaghezza, di tenui onirismi , di fantasie sfocate, di
situazioni e personaggi abnormi e assurdi, quasi carrolliani (si pensi alla
bambina teologa Edwige o alla donna gigante Angelina).
Si spiega così l‟esigenza principale di Fellini, vale a dire quella di
poter seguire meticolosamente la ricostruzione scenografica delle vicende,
12
Ivi, p. 32. Una analoga operazione demolitoria dell‟uomo e del personaggio
Casanova era stata compiuta, quindici anni prima dell‟uscita del film di Fellini, da
Robert Abirached, nel suo saggio Casanova, ou la dissipation, Grasset, Paris 1961;
trad. it. Casanova, o la dissipazione, introd. di L. Sciascia, Sellerio, Palermo 1977.
13
Casanova è interpretato magistralmente da Donald Sutherland, “attore dalla faccia
cancellata, vaga, acquatica, che fa venire in mente Venezia. Con quegli occhi celestini
da neonato, Sutherland esprime bene l‟idea di un Casanova incapace di conoscere il
valore delle cose e che esiste soltanto nelle immagini di sé riflesse nelle varie
circostanze” (G. ANGELUCCI, L. BETTI [a cura di], Il Casanova di Federico Fellini,
Cappelli Editore, Bologna 1977, p. 32). Vale la pena ricordare che il produttore iniziale
del film, Dino De Laurentiis, sostituito poi da Alberto Grimaldi, spingeva, contro la
volontà di Fellini, affinché il protagonista fosse interpretato da Robert Redford. Il
passaggio da Redford a Sutherland è stato comunque caratterizzato dal vaglio di altre
ipotesi, come Michael Caine, Gian Maria Volontè, Alberto Sordi e altri attori. Le vicende
legate alla lavorazione del film sono ripercorse, attraverso il riferimento ad articoli usciti
in quel periodo, nelle pagine del volume Il Casanova di Federico Fellini. Per
un‟accurata ricostruzione di queste vicende, cfr. altresì F. BORIN, “Avventure e
disavventure produttive”, in ID., op. cit., pp. 23-48.
14
Il tema del sogno è senz‟altro uno degli elementi caratterizzanti l‟opera. A questo
riguardo, Gian Luigi Rondi ha scritto che si tratta di “un sogno. Che si conclude con un
sogno nel sogno. Un sogno sul sesso che, in realtà, è un sogno sulla morte. È dunque
un incubo. L‟Inferno. Messo in scena nel Settecento, ma “letto” oggi, quasi riepilogando
i temi fondamentali felliniani (dalla Dolce vita a Otto e mezzo, al Satyricon a Roma, allo
stesso Amarcord): la madre, la donna, l‟educazione religiosa, il circo. Riproposti ancora
fra il gioco e la beffa, ma in chiave, ormai, di disperazione” (G. L. RONDI, op. cit.).
72
72
cosa che poteva accadere soltanto rimanendo all‟interno degli studi di
Cinecittà. L‟immagine a cui pensava per Casanova era un tipo di immagine
che andava controllata da vicino, realizzando le prospettive, i volumi, i colori
e soprattutto la luce, secondo la sua fantasia e senza inconvenienti esterni.
Da ciò scaturisce un film fortemente “teatrale”, nel quale gioca un ruolo
fondamentale tanto la precisione nella ricostruzione degli ambienti quanto la
meticolosità nella realizzazione dei costumi di Danilo Donati, per i quali Il
15
Casanova ha ottenuto l‟oscar nel 1976 . Ma l‟attitudine “teatrale” si può
comprendere fino in fondo se la si affianca a quella “pittorica”, alla quale
esplicitamente Fellini fa riferimento. Con Il Casanova, il regista riminese
cerca di pervenire all‟essenza ultima del cinema, al “film totale”, di riuscire,
cioè, a fare della pellicola un quadro: “Se uno si mette davanti a un quadro,
può averne una fruizione completa e ininterrotta. Se si mette davanti a un
film, no. Nel quadro sta dentro tutto, basta guardarlo per scoprirlo. Il film è un
quadro incompleto; non è lo spettatore che guarda, è il film che si fa guardare
dallo spettatore, secondo tempi e ritmi estranei e imposti a chi lo contempla.
L‟ideale sarebbe fare un film con una sola immagine, eternamente fissa e
continuamente ricca di movimento. In „Casanova‟ avrei voluto veramente
arrivarci molto vicino: un intero film fatto di quadri fissi”( G. Angelucci, L. Betti,
1977 : p. 73).
Tutto il film cresce attorno all‟idea della fissità racchiusa nel ricordo
del vecchio Casanova, attorno al quale non succede nulla, se non ciò che i
suoi occhi vedono e la sua mente crea.
In fondo, il Casanova di Fellini è un immaturo, una figura che vive
del (e nel) proprio autocompiacimento e del successo con le donne,
malcelando l‟insoddisfazione per non essere riconosciuto come un grande
scrittore e letterato. Non si può dire che sia quindi un uomo forte, a dispetto
di quanto si propone di dimostrare, attraverso le sue esibizioni atletiche e
meccaniche, quanto invece un uomo debole, quasi patetico, che pensa al
suicidio non appena viene meno la corrispondenza tra sensi e desideri. Dove
lo portavano, in definitiva, i viaggi attraverso i corpi delle donne? Come gli
15
Il film otterrà poi, l‟anno seguente, il David di Donatello per la migliore musica,
composta da Nino Rota. La componente musicale va tenuta poi in forte considerazione
rispetto alla resa finale. Borin, a questo proposito, rileva ripetutamente la determinante
significatività delle composizioni di Rota in Fellini: “l‟episodio del circo londinese non
avrebbe il forte fascino che emana senza l‟incantesimo – anche visivo – della musica.
Allo stesso modo, gli eventi che vedono protagonista Casanova con la bambola
meccanica, non avrebbero senso, o lo avrebbero in maniera diversa, senza i delicati,
infantili carillon, sostegno e ispirazione della presenza dell‟automa nelle ultime azioni
casanoviane” (F. BORIN, op. cit., pp. 170-71). Su questo tema, cfr. S. PERUGINI, Nino
Rota e le musiche per il Casanova di Federico Fellini, Sabinae, Rieti 2009.
73
73
dice l‟ubriaco e drogato Egard, che giace stravaccato su una panca della
taverna, mentre Casanova cerca l‟enorme donna la cui visione lo aveva
distolto dalle intenzioni suicide: in nessun luogo. “Casanova finisce per
diventare un Superman ed è guardato con gli occhi freddi di chi capisce che
dietro l‟esibizione della sua millanteria c‟è l‟alienazione tragicomica di chi è
sempre vissuto in modo inautentico”( E. Bispuri, 2003: p. 142)
Il personaggio tratteggiato da Fellini non va letto solo in chiave
fantastica, ma anche in chiave metaforica. La sua attualità sta in un
atteggiamento esistenziale che l‟uomo contemporaneo manifesta e che si
presenta nella forma di “un occhio vitreo che si lascia scorrere sulla realtà
senza interpretarla né con un sentimento né con un giudizio. È la „non vita‟,
con il suo fascino d‟acquario, uno smemoramento da profondità marina” ”( G.
Angelucci, L. Betti, 1977: p. 34). Casanova vive dei propri piaceri, non
avendo però coscienza della profonda rigidità che lo caratterizza e che lo
imprigiona. Come il suo uccello e come la sua ultima conquista, Casanova è
meccanico: lo è nei sentimenti, anche quando crede e dichiara di aver trovato
l‟amore, così come lo è nei gesti. Questa mancata coscienza non è però
totale. È possibile intuire, in alcuni momenti, la sofferenza del personaggio,
che, almeno in due occasioni, con Enrichetta e, soprattutto, con Isabella,
spera di potersi redimere, di condurre una vita diversa, serena, nella quiete
del suo studio, rinunciando alla inutile e noiosa libertà, per essere
amorevolmente guidato, per sempre, da una sola donna. L‟incoerenza e
l‟immaturità del personaggio riemergono però di lì a poco, in tutta la loro
potenza, esplodendo in un caotico, bizzarro, ridicolo e quasi orrido incontro a
cinque. Casanova percorre sempre ed inevitabilmente la medesima strada,
cade sempre negli stessi errori, oscillando tra piacere e dolore, tra godimento
e sofferenza, tra amore e morte, non potendo egli parlar d‟amore senza
ricorrere ad immagini funebri.
La sintesi cinematografica di Fellini, autentico capolavoro, ci
restituisce l‟immagine sbiadita e goffa di un seduttore in declino, di una figura
che tende a recitare, più o meno consapevolmente, la parte del seduttore
fascinoso e incantatore, dell‟uomo che attrae le attenzioni materiali delle
donne ed intellettuali degli uomini. Non è invece che un prodotto artificiale,
ieri del mito mediterraneo e oggi del cinema, come ha scritto Rondi, sempre
in bilico tra un gioioso irriverente sorriso e un più profondo luttuoso dolore,
segno inconfondibile della tragicità di fondo del personaggio, la tragicità di un
“burattino che guarda il mondo con occhi di pietra”(Ivi, p. 73).
74
74
Riferimenti bibliografici
ABIRACHED R., Casanova, ou la dissipation, Grasset, Paris 1961;
trad. it. Casanova, o la dissipazione, introd. di L. Sciascia, Sellerio, Palermo
1977.
ADORNO TH.W., Kierkegaard. La costruzione dell’estetico (1933),
trad. it. di A. Burger Cori, Longanesi, Milano 1983 (i ediz. 1962).
ANGELUCCI G., BETTI, L. (a cura di), Il Casanova di Federico Fellini,
Cappelli Editore, Bologna 1977.
BAUMGARTEN A.G., Riflessioni sulla poesia, a cura di P. Pimpinella e
S. Tedesco, Aesthetica Edizioni, Palermo 1999.
ID., L’Estetica, trad. it. di F. Caparrotta, A. Li Vigni e S. Tedesco,
Aesthetica Edizioni, Palermo 2000.
BENEVELLI E., Analisi di una messa in scena. Freud e Lacan nel
Casanova di Fellini, Dedalo, Bari 1979.
BISPURI E., Interpretare Fellini, Guaraldi, Roma 2003.
BORIN F., Casanova, l‟epos, Palermo 2007.
BURKE E., Inchiesta sul bello e il sublime, a cura di G. Sertoli e G.
Miglietta, Aesthetica edizioni, Palermo 1985.
CHOUILLET J., L’esthétique des Lumières, puf, Paris 1974.
CURI U., Filosofia del Don Giovanni. Alle origini di un mito moderno,
Mondadori, Milano 2002.
ID. (a cura di), Don Giovanni. Variazioni sul mito, Marsilio, Venezia
2005.
DE LIGNE CH.J., Oeuvres, Champion, Paris 2005.
FELLINI F., ZAPPONI B., Il Casanova di Fellini, Einaudi, Torino 1976.
FRANZINI E., L’estetica del Settecento (1995), il Mulino, Bologna
2002.
HEINE, H., Briefe aus Berlin, Hoffmann und Campe, Hamburg 1973.
KEZICH, T., Fellini, Bur Rizzoli, Milano 1988.
ID., Fellini del giorno dopo. Con un alfabetiere felliniano, Guaraldi,
Rimini 1996.
KIERKEGAARD S., Enten-Eller. Un frammento di vita, a cura di A.
Cortese, 5 tomi, Adelphi, Milano 1976-1989.
MACCHIA G., Tra Don Giovanni e Don Rodrigo. Scenari secenteschi,
Adelphi, Milano 1989.
ID., Vita avventure e morte di Don Giovanni, Adelphi, Milano 1991.
PELLEGRINO P., Estetica e comunicazione nel panorama teorico del
Novecento, Congedo Editore, Galatina 2008.
PERUGINI S., Nino Rota e le musiche per il Casanova di Federico
Fellini, Sabinae, Rieti 2009.
75
75
RICCHEZZA G., Casanova. Il genio della seduzione, Giovanni De
Vecchi Editore, Milano 1966.
RONDI G.L., in “Il Tempo”, 11 dicembre 1976.
ROUSSET J., Il mito di don Giovanni (1978), trad. it. di A. Marchi,
Pratiche Editrice, Parma 1980.
W ILLIS D., JOHNSON A., Two Views on Fellini’s Casanova, in “Film
Quarterly”, vol. 30, no. 4, Special Book Issue (summer 1977), pp. 24-31
76
76
Abstract
The author elaborates a very personal “metaphisics”, which retracing some of the
principal “topoi” of the western thoughts points, in the last resort, to a rehabilitation of
“light”, meant as a place of ultimate meeting between thought and being. It is inevitable
the reference to Heideger, of which the author borrows the question on the sense of
being, but declining it in a very different direction and with other intentions. The
voluntary absence of any exegetical attention leaves place to a speculative fit which
combines two antithetical philosophical perspectives. Parmenides on the one side and
phenomenology on the other one. Starting from these fundamental coordinates, we
observe an outline of what could be defined as a “phenomenological establishment of
Parmenides‟ ontology”, the need of being and the consequent impossibility of not being
are phenomenologically translated in the desire of totality. More precisely, the
incompleteness of every experience and, more generally, the mortality of human
nature remand to the feeling of a complete totality, to a willingness of eternity which
requires, as a consequence, a definitive conciliation of opposites. The sense of being ,
in this way, coincides with the sense of life ad as a topic of enquiry particular
experiences of consciousness are proposed,- as love, crying, laughing, memory – in
which the author glimpses the key for a conclusive mechanisms of resolution.
L'auteur élabore une "métaphysique" très personnelle qui, en re-parcourant certains
des principaux topoi de la pensée occidentale, vise une réhabilitation de la "lumière"
entendue comme le lieu d'une rencontre définitive entre la pensée et l'être. La
référence à Heidegger est, par là-même, inévitable, Heidegger à qui l'auteur emprunte
la question sur le sens de l'être pour l'orienter ensuite, toutefois, vers des horizons
différents et dans des intentions tout autres. L'absence volontaire de toute attention
exégétique laisse place à un élan spéculatif qui conjugue, d'un seul geste, deux
perspectives philosophiques antithétiques: Parménide d'un coté, et la phénoménologie
de l'autre. A partir de ces coordonnées fondamentales, se dessine le brouillon de ce
que l'on pourrait définir comme une "fondation phénoménologique de l'ontologie
parménidienne": la nécessité de l'être et la conséquente impossibilité du non-être se
traduisent phénoménologiquement dans le désir de totalité. Plus précisément,
l'inachèvement de chaque vécu et, d'une façon plus générale, la mortalité de la nature
humaine renvoient au sens d'une totalité achevée, à une volonté d'éternel qui exige, en
miroir, une conciliation définitive des extrêmes. Le sens de l'être en arrive, alors, à
*
Scrittore. Si è laureato in Ermeneutica filosofica.
77
NOTE
IL SENSO DELL'ESSERE. APPUNTI FENOMENOLOGICI
*
di Graziano Scolari
77
coïncider avec le sens de la vie et les questions se posent au travers des vécus de
conscience déterminés - l'amour, les larmes, le rire, la mémoire - dans lesquels
l'auteur entrevoit la clé d'un mécanisme de résolution définitif.
L'autore elabora una personalissima "metafisica", che ripercorrendo alcuni dei maggiori
topoi del pensiero occidentale mira, in ultima istanza, a una riabilitazione della "luce",
intesa come luogo di un incontro definitivo tra il pensiero e l'essere. Inevitabile il
riferimento a Heidegger, di cui l'autore prende a prestito la domanda sul senso
dell'essere per declinarla, però, in tutt'altra direzione e con tutt'altri intenti. La volontaria
assenza di ogni attenzione esegetica lascia il posto a uno slancio speculativo che
coniuga in un unico gesto due prospettive filosofiche antitetiche: Parmenide, per un
verso, e la fenomenologia, per l'altro. A partire da queste coordinate fondamentali,
assistiamo a un abbozzo di ciò che potrebbe definirsi come una "fondazione
fenomenologica dell'ontologia parmenidea": la necessità dell'essere e la conseguente
impossibilità del non-essere si traducono fenomenologicamente nel desiderio di
totalità. Più precisamente, l'incompiutezza di ogni vissuto e, più in generale, la mortalità
della natura umana rinviano al senso di una totalità compiuta, ad una volontà di eterno
che esige, per riflesso, una definitiva conciliazione degli opposti. Il senso dell'essere
viene, allora, a coincidere con il senso della vita e a tema d'indagine si pongono
determinati vissuti di coscienza - quali l'amore, il pianto, il riso, la memoria - in cui
l'autore intravede la chiave di un definitivo meccanismo di risoluzione.
_____________________________
78
La ricerca del senso dell‟essere – inteso come il senso
onnicomprendente la totalità – è qualcosa di appartenente certamente ad un
pensiero comune e non di completamente esclusivo dell‟orizzonte della
riflessione filosofica, anche se di questa è caratteristica. È comunque da
questa che prenderemo l‟avvio per questa ricerca.
La domanda “quale è il senso dell'essere?”, anche se non sempre
posta espressamente, è sempre situata sullo sfondo della storia del pensiero,
e è stata posta nella filosofia contemporanea espressamente da Heidegger,
sin da Essere e tempo. In questa sede non si è avuta in definitiva una
risposta, e la questione è stata ripresa successivamente; nei seguenti Che
cos'è la metafisica e Introduzione alla metafisica, più in particolare, si supera
l'impostazione data alla questione in Essere e tempo: qui si ha che nella
prima impostazione data alla questione il senso dell'essere era occultato,
perché, come nella tradizione filosofico-metafisica, si poneva la questione
sull'essere, si considerava l'essere, senza considerare il nulla; la questione
78
viene allora riproposta nella domanda “Perché vi è l'essente e non il nulla?”
(M. Heidegger, trad. 1987: pp. 59-79; trad. 1968: pp. 13-43).
Secondo Heidegger in questa domanda non si ricerca sull'essente
(ovvero su queste cose che già sono), si ricerca perché l'essente è (ovvero
sul perché queste cose, che sono, sono) e perché non ci sia piuttosto il nulla,
la domanda mira dunque in ultimo all'essere – e dunque al senso, per cui
questo essere, che è, è. Heidegger nella Introduzione alla metafisica pone in
evidenza che, per trovare il fondamento dell'essere dell'essente (e dunque il
senso dell‟essere), è necessario prima aver compreso l'essere stesso. E
allora vien a porre, ancor prima della domanda “Perché vi è l'essente e non il
nulla?”, la domanda preliminare “Che cosa ne è dell'essere?”, ma a questa
domanda non trova risposta, in quanto, nell‟apertura storico-temporale in cui
si può porre la questione, si è precompresi nell'occultamento nei confronti
dell'apertura aperta da questa, in quello che Heidegger chiama “l'oblio”
dell'essere, ovvero: dall‟apertura del momento storico-temporale, in cui
siamo, e che ci consente la visuale, si trova occultato e dimenticato il senso
di questo “essere”, dunque non si può aver risposta alla questione “Che cosa
ne è dell‟essere?”. Questo il percorso intrapreso da Heidegger nella
Introduzione alla metafisica (M. Heidegger, trad. 1968: p. 13 e ss.). Dunque,
in conclusione, non si ha risposta alla domanda “Perché vi è l'essente e non il
nulla?”, la domanda sul senso dell'essere.
Ma, se ricerchiamo il senso dell'essere, ricercando l'essere come
l‟onnicomprendente, l‟insieme degli essenti (di tutte le cose che sono), questo
non può esser mancato per la mancanza di un qualcosa: in Heidegger, il
nulla, o, l‟apertura storico-temporale. Se il senso è veramente il senso
dell'essere, questo senso dovrà comprendere questo “essere” come ciò che
è e già è, senza bisogno dell‟introduzione di ulteriori essenti prima di questo.
Se il fine è veramente il senso dell'essere, questo non può esser difatti
qualcosa a cui si può arrivare per speculazione o ponendosi domande,
questo è qualcosa che si dà, se si dà, già nell‟essere. Con il domandare, con
il pensiero astratto, si rimane, in realtà, sempre all'esterno dell'essere. Ma per
ricercare il senso dell'essere è necessario non porsi fuori dell'essere – come
con il guardar questo a partire dal nulla dell'essere, nella domanda “Perché
l'essente e non il nulla?” –, ma trovarsi già entro questo, nell' essere.
Dunque, in conclusione, per la questione “quale è il senso
dell'essere?” si arriva a questa risposta: il senso dell'essere è il senso che si
può dare nell' essere; e allora, in questo, sarà l'essere stesso a rivelare il suo
senso: è necessario dunque ricercare nell'essere che si è dato e si può dare
– e l'essere che si è dato, è l'essere, che, in ultimo e fondamentalmente,
all'esperienza del vissuto sempre si è dato –. Questa vien ad essere dunque
la fonte della ricerca: l'esperienza del vissuto dell'io, l'essere che all'io si è
79
79
dato. L'essere è difatti sempre essere per un pensiero ed il pensiero è
sempre pensiero per l'esperienza del vissuto dell'io. Questa sarà l'origine e la
scaturigine di questo “essere”.
La domanda allora sarà: qual è il senso che qui si può rivelare?
Si è detto, riguardo al senso dell'essere, che questo ha il suo senso,
se si darà un senso nell' essere; e nell'essere primitivamente si disvela che
questo ha un senso, se è possibile che l'essere continui ad essere. Se è
possibile che il senso si possa dare.
E, se è possibile che si possa dare, non si può dare in un momento
per poi non potersi dare più, è necessario che sempre si possa dare: non è
possibile un senso non compiuto, un senso per esser tale dev'esser di per se
stesso compiuto – è necessario dunque che questo “essere” possa essere.
Non è possibile pensare ad un essere che prima sia e poi non sia, nello
stesso “essere” vi è dunque il continuare ad essere. Questo è dallo stesso
1.
senso di questo “essere”
Nel pensiero dell‟essere portato avanti in Essere e luce, in cui si
comprende la realtà dell‟essere a partire dall‟essere di Parmenide come
realtà interamente compiuta e autoconchiusa, non è possibile un essere, che
prima sia e poi non sia, non può sussistere costitutivamente una cesura
interna ad esso nel suo essere, il concetto di morte risulta non in esso
2.
possibile Il concetto di morte, come negazione di essere, è la negazione di
un senso nell'essere, che possa essere e continuare ad essere. Se è
possibile la sensatezza, non si può che negare lo stesso concetto di morte.
Dunque l'essere ha un senso, se si può dare un senso nell'essere, e
questo risulta esservi, se vi è un essere dopo la morte; si ha allora, che
questo essere, questo essere che primitivamente si è dato, da solo non può
concludere il suo senso, apre, invero, ad un senso. Si ha difatti la morte, e
questa è rivelativa, poiché mostra, invero, che ciò che vi è, è un senso noncompiuto, una incompiutezza. Questa incompiutezza è altresì rivelativa,
poiché lo stesso darsi di una incompiutezza presuppone essa stessa, alla
base, una compiutezza. L'incompiutezza, che è sentita, dunque, rivela altresì
che un senso in realtà vi è stato, si è dato. E questo senso dato, che è sentito
incompiuto, rivela altresì uno compiuto.
Dunque, in conclusione, si rivela che vi è un senso nell'essere; è
questo senso, che adesso si vien a ricercare.
1
Il senso di questo “essere” non può venire a negarne l'essere, e dunque il sempre
essere di questo “essere”. Questo è ciò a cui conduce il pensiero dell'essere portato
avanti nel nostro libro: G. SCOLARI, Essere e luce. Intorno allo stesso essere della
morte e della vita, Lit Verlag, Berlin 2009.
2
Cfr. il concetto di morte come non con-possibile all'essere, colto nel suo senso
d'essere.
80
80
Si è detto che la morte è rivelativa, ed è rivelativa in particolare
perché con la morte comunque intesa vi è una negazione di qualcosa di
proprio, e vi è la sofferenza; questo è qualcosa che all'esperienza si rivela, la
sofferenza da parte dell'anima per la morte in generale e in particolare per
3.
quella di chi ama La sofferenza è rivelativa, perché mostra in realtà che un
senso nell'essere si è dato, se vi è la sofferenza, invero, qualcosa
d'importante si è dato. Si ha intanto che, se vi è la sofferenza, vi è anche
l'amore. Ciò che si è dato, comunque ed incontrovertibilmente, è l'amore
come opposizione radicale al non-esserci-più di un qualcosa e volontà per il
poter-essere di questo. E qui incomincia ad affacciarsi un senso, una
compiutezza che si rivela nell'incompiutezza. Dunque nell'essere si rivela che
vi è un senso e questo senso è rivelato dall'amore.
Qui inizia a presentarsi un senso costitutivo per l‟essere della nostra
esperienza vivente, il proprio essere risulta nel suo senso originariamente
unito all'amore, si disvela che l'io è originariamente essere-per-l'amore.
L'essere-per-l'amore risulta un essere originario dell'io, questo è ciò
che si evidenzia nei momenti estremi, nel momento rivelativo della morte. Il
momento della morte è rivelativo, poiché non presentandosi la possibilità di
avere altri momenti dopo, nel nostro rapporto all'altro, si evidenzia il
complesso del nostro rapporto all'altro nella sua totalità. In questi momenti vi
è la sofferenza, e la sofferenza dell'anima per ciò che ama rivela che l'essere
dell'altro può esser non meno importante del proprio essere e che l'esseredell'altro non può esser originariamente scisso dal proprio essere. Il proprio
essere non si può concepire già di per se stesso come un essere “per sé”,
ma già originariamente come un “essere-per-l'altro”.
L'originario essere-per-l'amore dell'io si disvela nel momento
estremo della morte, in questo si ha difatti che per l'anima vi è
un'impossibilità di distaccarsi da ciò che ama; ciò che costituisce il nostro
rapporto all'altro è un originario rapporto di co-appartenenza all'essere, al
poter esistere, che si ha con l'essere dell'altro, questo si esplica nel
costitutivo essere-per- e voler stare-con-l'altro. Questo è qualcosa che si
trova al di là ed ancor prima di ogni "fare" concreto, anche se non è possibile
fare alcunché, si dà la volontà di essere sempre uniti a ciò che amiamo, si
sente l'impossibilità del distaccamento dall'altro per sempre, poiché vi è un
rapporto di co-appartenenza all'altro che si radica nell'essere, nell'essere che
sempre è. E questo si dà perché l'essere del soggetto è originariamente
3
Veniamo a considerare qui la realtà della morte nel modo più generale e originario
come il non-esserci-più di un qualcosa: la non-possibilità di esserci più, di un ritorno di
qualcosa per noi. Di converso consideriamo l‟amore nel modo più generale e originario
come il poterci-essere-ancora: la possibilità di esserci ancora di un qualcosa per noi.
81
81
essere-per-l'amore, donde il voler sempre poter-essere con l'altro; nei
momenti estremi si trova una apertura all'originario essere-per-l'amore.
Dunque si è posto in evidenza che partiamo già da un senso, ed al
tempo stesso questo senso, come viene a presentarsi, si mostra anche
incompiuto. Se il momento della morte ci porta di fronte ad una
incompiutezza, se si sente l'incompiutezza, è perché si sente il bisogno, la
necessità di una compiutezza; e ciò che si sente di fronte alla morte con la
incompiutezza è la sofferenza. Questo è ciò che si mostra come
autoevidenza ed è ciò che è da considerare.
La volontà di comprendere la sofferenza, e, con questa, i momenti di
solito considerati negativi dell'esistenza, apre ad uno spazio proprio del
discorso filosofico. Il pensiero comune, difatti, ha di solito la tendenza a
preferire i momenti positivi a quelli negativi, e finisce per tender di gettare
nell'oblio quelli negativi, per trascurare e non considerare l'importanza e la
rivelatività del negativo. La volontà di considerare la sofferenza è una
apertura alla considerazione dei momenti ritenuti negativi al di là della precomprensione in cui si vengono a trovare nel pensiero comune, per aprire
alla loro possibile rivelatività. Nel pensiero comune, la comprensione posta in
atto di fronte alla sofferenza ricerca di sfuggirla e superarla più che altro. Se
vi è la sofferenza, vi è la presenza di un momento negativo e dunque vi è la
ricerca che questo sia superato: ma perchè vi è questa sofferenza? Quale è il
significato esistenziale della sofferenza nel proprio rapporto fondamentale
all'essere, nel rapporto che sempre lega al fondo l'io all'essere? Che cosa
rappresenta la sofferenza nell'esperienza del vissuto? Con questo
domandare il pensiero filosofico può andar oltre rispetto alla precomprensione in cui si trova la sofferenza nel pensiero comune. Questo, si è
detto, ha di solito la tendenza a fuggirla, a cercare di superarla, piuttosto che
a considerarla rivelativa; eppure si può sentire, almeno con una parte
verecondita dell'io, che i momenti negativi e di sofferenza sono comunque
momenti importanti per il vissuto. Dall'esperienza vissuta si ha, che
comunque i momenti negativi e di sofferenza possono esser invero rivelativi.
E qui si apre ad uno spazio proprio del discorso filosofico.
Se vi è la sofferenza, vi è il bisogno di uscire da una situazione
negativa, di mancanza, in cui si è. Dunque la sofferenza, che si rivela nei
confronti del momento della morte, porta a manifestazione una situazione di
mancanza, vi è mancanza di un qualcosa. Nella sofferenza che vi è per il
momento della morte si può rivelare invero un senso. La sofferenza
manifesta indubbiamente un momento negativo per la vita dello spirito, ma
questo momento negativo, che vi è con la morte, manifesta invero un
positivo: un momento negativo, nella vita dello spirito, si può manifestare, se
vi è sempre uno positivo. Il positivo che si può affermare, a cui si arriverà
82
82
anche dalla apertura di significati derivanti dal momento del pianto compreso
in senso originario, è la necessità di uscita dalla comprensione in cui si è,
4.
dalla pre-comprensione in cui si è, riguardo al momento della morte
Dunque la mancanza, che è portata a manifestazione con la
sofferenza, riguardo al momento della morte, è indigenza relativa alla
comprensione in cui già si è di questo momento. La sofferenza manifesta che
questa comprensione non può soddisfare, non è quella del proprio bisogno
più proprio, con questa non si è “a casa” – vi è bisogno di un'uscita da questa
e dunque di un'altra comprensione, questa è da superare.
Dunque il senso, che si manifesta con la sofferenza per il momento
della morte, il senso che ha da venir fuori, è il sentire l'impossibilità della
comprensione in cui si è, riguardo a questo momento. Questo è ciò che
deriva anche dall'ascolto delle profondità più ultime del proprio essere,
derivante dal disvelamento del momento rivelativo del pianto, il sentire
l'impossibilità, da parte di un livello verecondito dell'io, di questo pur radicato
concetto, donde l'apertura ad una possibilità di superarlo.
Dunque la sofferenza implica sempre una situazione di mancanza,
che è sempre mancanza di un bene, ma al contempo questo bene cercato, di
cui l'io soffre, porta all'esigenza che quel bene vi sia, altrimenti non potrebbe
darsi sofferenza di alcunché.
Abbiamo considerato ciò di cui vi sarebbe la mancanza nella
sofferenza per il momento della morte, ciò che la presenza di questa
sofferenza può venire a rivelare. Dobbiamo adesso soffermarci sul momento
del pianto compreso in senso originario: con questo consideriamo un
momento di caratteristica afflizione e scontro interno tra realtà in disaccordo
interne alla vita dello spirito. In questa considerazione troviamo il fenomeno
del riso, che manifesta uno scontro tra due realtà percepite primitivamente in
disaccordo, che poi vien a compensarsi in esso, e all‟opposto quello del
pianto, che rappresenta sempre uno scontro tra due realtà in antitesi, che ha
ancora da esser compensato. Il pianto non vien ad esser interpretato nel
modo in cui si tende ad interpretare nel pensiero comune, ma vien ad esser
rivelativo di realtà interne costitutive della vita dello spirito. Il pianto, come la
sofferenza, si trova pre-compreso in una interpretatività “negativa”, da questa
4
Questa comprensione in cui si è, riguardo al momento della morte, non è un
momento teoretico distaccato, in cui si vien al concepimento del momento della morte
al livello concettuale, ma è ciò che può esser detto dalla pre-comprensione del
pensiero ermeneutico: quell'insieme di credenze e di acquisizioni che sempre vengon a
costituirci, che ne siamo coscienti o meno, in quanto appartenenti ad una tradizione
storica ed ad una cultura. Qui abbiamo una pre-comprensione, in quanto vi è una
comprensione in cui già si è, in cui già ci si vien a trovare.
83
83
veniamo adesso ad uscire, per attendere all'apertura di significati che da
questo può derivare.
In questo è necessario superare l'immagine “intellettualistica” del
sapere dominante nel pensiero, che si basa sulla priorità data alla ragione
sulle altre forme dell'esperienza vissuta, come può esser il sentimento;
questa sembra vedere sempre nella via della ragione la via che porta alla
verità, e non nella via del sentimento. In questo si vuol superare anche
questa tradizionale dicotomia tra ragione e sentimento, col superamento di
questa dicotomia si cerca di arrivare ad una comprensione più unitaria e
completa del proprio essere, in cui i sentimenti non siano considerati di per
se stessi scissi ed in opposizione alla ragione, ma siano anzi rivelativi di ciò
che è più importante per il vissuto. Di qui si vuol pervenire ad un esito, in cui
il sentimento non solo non sia fuorviante dalla verità, ma possa anche essere
un modo più originario per arrivare ad essa, in questo si vuol porre in luce
come anch'esso ha una sua razionalità ed una sua ragion d'essere per la via
della verità.
La priorità del sentimento è già stata vista dalla filosofia del
romanticismo. Il sentimento autenticamente romantico è la rivelazione del
divino nel mondo. Nel pensiero romantico, il sentimento, a differenza della
ragione, non frappone cesure tra l'intima essenza dell'universo e l'intima
essenza dell'uomo; è nel sentimento che si ha la saldatura tra la natura e
l'uomo – ed in questo anche tra momento sensibile e razionale.
Il senso del superamento della dicotomia ragione/sentimento, è
arrivare ad un sentimento, che non venga ad esser in contrasto con la
ragione, ed ad una ragione che non sia mai contro il sentimento. Le vie della
ragione e del sentimento vengon a convergere in questo in un'unica via, che
sempre poi sussiste al fondo del pensiero: la via del “sentire” più originario
che si dà nella totalità dell‟esperienza vivente, in cui si dà in sintesi la
comprensione dell'intera realtà al pensiero. Questo “sentire” è il sentire che
ha il valore veritativo dell‟Erlebnis (il vissuto) per la filosofia della vita, il
sentire come er-leben, il percepire che si dà con lo stesso vivere e il darsi
della verità di esso. In questo, l'apertura alla rivelatività della sfera della
complessità del sentimento è apertura alla rivelatività della sfera della
complessità dell'esperienza vivente.
Questo “sentire” più originario è il sentire come esperire vivente. La
realtà di questo “sentire” è la realtà dell'esperire vivente. In questo si dà la
verità di un qualcosa, semplicemente poichè si esperisce questo qualcosa,
poiché questo si dà nell'esperienza vivente nella sua interezza ─ come
nell'esperire vivente la verità di un qualcosa non è data a partire da nessuna
teorizzazione apposta, ma semplicemente dall'esserci e dal dispiegarsi
interamente di questo qualcosa ─ (da questo esperire vivente si vien sempre
84
84
a fondare l'orizzonte in cui si dà il senso, qualsiasi senso al pensiero, senso a
partire da cui si può dare l'essere, qualsiasi essere).
Dall'ambito di questo “sentire”, che si dà nell'esperienza vivente, nel
vissuto, in cui si dà in sintesi l'intera realtà nella comprensione del pensiero,
si dà la sfera delle credenze.
Il “sentire” è ciò che vien sempre a determinare l'accoglimento delle
5
credenze e delle fedi (come può esser l'accoglimento di un credo religioso ).
Questo non è qualcosa che vien ad esser operato eminentemente dalla
ragione. Per questo non può esservi qualcosa come una prova di una verità
religiosa valida per tutti, messa in opera dalla ragione. Questo è il caso delle
dimostrazioni dell'esistenza di Dio, esse non risultano avere il valore
determinante per l'accettazione di una fede. Questa accettazione è qualcosa
che deriva difatti da qualcosa di più profondo e fondamentale, da qualcosa
che si può ricondurre a quella sfera che abbiamo visto come sfera del
“sentire” (momento di sintesi dall'esperienza del vissuto per l'esperienza del
vissuto), che può avere una priorità su gli altri momenti della vita conoscitiva.
La priorità del “sentire” è qualcosa che si ritrova nella priorità data al
momento emozionale nella analisi fenomenologica di Scheler. Questa priorità
si vien a mostrare, in Scheler, nel fatto che l'oggettività dei valori non ha lo
stesso significato dell'oggettività delle cose e che tale oggettività è
accessibile solo all'emozione. In questo Scheler differenzia un'intelligenza
della riflessione razionale, da un'intelligenza di un sentimento emozionale, di
una percezione affettiva. Quanto sussiste nello spirito di emozionale
possiede fattori costitutivi di natura originariamente a priorica indeducibili ed
inderivabili dal pensiero.
A partire da Scheler si può aprire ad una visione della
fondamentalità del momento emozionale: come può il momento emozionale
esser anche più fondamentale rispetto al momento razionale.
Questo si evidenzia nell'esperienza del vissuto. Il cucciolo che
segue la madre sa il suo bene, anche senza una vera e propria conoscenza
di questo6, ciò che ha da sapere lo sa di già, e questo suo sapere e qualcosa
che deriva dall'ambito del momento emozionale e non da alcun momento
razionale. Il momento emozionale si può evidenziare come momento più
fondamentale. Questo è ciò che guida nell'esperienza vivente, in ciò che è
più importante.
5
Al riguardo, nella considerazione di un credo religioso, R. OTTO, ne Il sacro, riconosce
all'irrazionale un ruolo insostituibile per questo sentimento; irrazionale che non è posto
in una mera contrapposizione al razionale.
6
Così si percepisce, ad esempio, l'esser buono dello zucchero, senza alcuna
conoscenza della composizione chimica di questo o di qualsiasi altra conoscenza
sviluppata su questo – è esplicato da Scheler .
85
85
Ciò che in Scheler è detto dal sentimento emozionale riporta a ciò
che si è detto con il “sentire”.
Ciò che si è detto con il “sentire” è qualcosa di non immediatamente
presentificabile e definibile, proprio perché questo “sentire” è ciò che sempre
è. Questo “sentire”, che è esperire vivente, sempre accompagna l'essere
come la sua propria forma di vita, e non si dà forma di vita al pensiero che
non sia accompagnata da questo. Come il lògos di Eraclito, proprio perchè è
ciò che sempre è, il sentire può risultare ciò che vi è di più nascosto ed
7.
ignoto
In questo si può riportare al momento della luce, come vien ad esser
presentato in Il pensiero dell'essere e la luce8, la luce che è ciò che per
l'anima sempre è. La vita dell'anima è sempre difatti un “sentire”, che è
sempre un esser-illuminati, un esser pervasi da qualcosa d'altro da sé, ciò
che è detto dalla luce, che è originario incontro di pensiero ed essere, a
partire da cui si dà l'apparire di ciò che è.
La forma propria dell'esser-esposto-alla luce è ciò che per l'anima
sempre è. Questo esser-esposto-alla luce è ciò a partire da cui si dà il senso,
9.
a partire da cui le cose sono come sono
Dunque per aprire ad una interpretazione positiva e rivelativa della
manifestazione sensibile e emozionale, è necessario uscire da quella forma
del pensiero che abbiam visto come la pre-comprensione dell'immagine
“intellettualistica” del sapere, in cui il sentimento sembra esser qualcosa già
di per sé opposto al sapere; in questa ciò che ha origine dal vissuto, i fatti
7
Questo è ciò che dice Eraclito del lògos, nel frammento 1: “Di questo logos che
sempre è gli uomini non hanno intelligenza, sia prima di averlo ascoltato, sia dopo di
averlo ascoltato; benchè infatti tutte le cose avvengano secondo questo, essi
assomigliano a persone inesperte, pur provandosi in parole ed in opere tali sono quelle
che io spiego, distinguendo secondo natura ciascuna cosa e dicendo come è. Ma agli
altri uomini rimane celato ciò che fanno da svegli, allo stesso modo che non sono
coscienti di ciò che fanno dormendo” (B 1 Ediz. Diels-Kranz).
8
Cfr. in G. SCOLARI, op. cit., la parte dedicata all'identità della luce: pp. 45-52.
9
L'esser-esposto-alla luce come momento che dà il senso, a partire da cui le cose
sono, si può comprendere a partire dall'esempio del costituirsi dell'essere della
bellezza. La bellezza di una figura, come di un'opera d'arte, non può esser
comprensibile e riducibile ad una descrizione fenomenica di termini fisici. Non vi è una
descrizione definitiva di una figura, che può determinarla come significativamente bella
per ognuno. Il significato della bellezza non può mai esser ridotto ad una mera
descrizione di proprietà fisiche. La significatività di una figura bella si vien a costituire a
partire dalla luce dell'anima ─ dal vissuto, che fa capo all'interiorità della propria anima
─, da questo esser-esposto-alla luce, che per l'anima sempre è, ed a partire da cui si
dà il senso che unifica gli elementi e le proprietà fisiche in uno, che offre il senso della
bellezza, a partire da cui si dà l'essere della bellezza.
86
86
della propria realtà di vita, l'esperienza vissuta, sono qualcosa che vien a
contrapporsi a ciò che è propriamente conoscitivo, a ciò che è vera
conoscenza. Ciò che qui si vien a mancare è che ogni conoscenza, per esser
realmente e pienamente vera conoscenza non può contrapporsi di per sé e
venir meno ad una qualsiasi espressione della realtà di vita che già
comprende il tutto in sé, e trova il suo valore proprio dall'inerenza al vissuto,
dal poter entrare realmente in rapporto e valere all'esperienza vivente, alla
verità della totalità della vita (in questo una conoscenza che sia in una sfera
apodittica, al di là del vissuto, è in definitiva una conoscenza alienata dai
propri bisogni più ultimi, non è veramente la propria conoscenza, un sapere
autentico e onnicomprensivo, che è sempre in fondo sapere per la vita).
La verità della realtà dell‟espressione sensibile e emozionale e dei
sentimenti con la loro legittimità di autoimporsi, si può evidenziare dagli esiti
10,
dell'opera di James dove troviamo, ad un'ultima analisi, che tutto ciò che in
definitiva vien a sussistere e esser alla base del nostro sapere, sono sempre
i sentimenti e le fedi, che muovono l'io: per James, qualsiasi idea, anche la
più apparentemente impersonale, è sempre prodotto di un sentimento che
sta a cuore all'individuo che l'afferma.
Il momento del sentimento, in conclusione, non può finire per esser
considerato contrapposto al momento razionale – a cui può risultare invece
inestricabilmente legato nella costituzione del sapere –, ma ha da esser al
contrario compreso insieme ad esso in un sapere che ricerchi l‟apertura
completa alla realtà della vita.
Tutto questo discorso è per introdurre alla considerazione del
momento dell‟espressione sensibile e emozionale, come può esser il pianto,
e del momento positivo e negativo che questo sempre reca con sé. Se vi è
un momento negativo in questo, è perché anche questo ha una sua ragione
di essere e può rivelare qualcosa, e questo qualcosa si vuol considerare. La
sofferenza e il dolore non sono compresi qui come semplice momento
negativo da superare, ma ciò che è rivelativo del proprio rapporto costitutivo
11.
fondamentale all'essere Questa sofferenza rivela, con la sua datità, che vi
è, al fondo, un rapporto all'essere che sempre vien a costituire il proprio
essere, un rapporto di trascendenza nei confronti dell'essere. Si mostra qui,
difatti, la presenza di un momento negativo, rispetto a cui il vissuto del
10
In James si pone in evidenza complessivamente il ruolo delle credenze alla base di
tutto il nostro pensiero, di tutta la nostra possibile conoscenza. Cfr. in particolare W.
JAMES, La volontà di credere, a cura di G. Graziussi, Principato, Milano 1966.
11
Per rapporto costitutivo fondamentale all'essere si intende il costitutivo rapportarsi
dell'apertura dell'io all'essere, rapporto che a fondamento del proprio essere sempre è:
la dialettica io/non-io costitutiva dell'io, dunque il costitutivo rapportarsi dell'io all'essere.
87
87
soggetto non può non venir a muoversi, in rapporto al quale sempre si attua
un movimento di trascendenza.
La sofferenza rivela, nel proprio rapporto costitutivo all'essere, una
situazione di mancanza, come un dis-accordo nel rapporto dell'io all'essere;
ciò che si vien a ricercare è il perché di questa situazione, il prender
coscienza di questa per aprire ad un suo superamento.
Veniamo dunque a considerare la situazione di mancanza, il disaccordo nel rapporto all'essere, nel momento del pianto: questo vien qui
compreso in un modo originario come manifestazione di mancanza e
scissione interna all‟anima. Veniamo dunque a considerare questo, in
riferimento al perché ed al quando vi è. Vi è questo momento, come
manifestazione di scissione e scontro interno di realtà antitetiche al livello del
momento emozionale, quando vi è qualcosa di impossibile per l'io, qualcosa
per cui la realtà interiore in fondo manifesta un qualcosa che non riconosce
come possibile, in questo vi è il sentire con una parte più profonda
dell'interiorità (con la via di quello che abbiamo visto come il “sentire”,
momento più originario dell'espressione razionale) una impossibilità; vi è il
sentire (un sentire che non può esser ancora al livello dell'esser coscienti)
con una parte nascosta e verecondita del sé l'impossibilità del non-essercipiù, in cui abbiamo compreso la realtà della morte: questa è l'impossibilità
della comprensione in cui si è rispetto a questo momento del non-esserci-più
– di qui si apre, con la presa di coscienza di questa impossibilità, ad una
uscita da questo, alla possibilità di superarlo.
Vediamo di comprendere che cos'è questo non-esserci-più, con
questo si può aprire ad una comprensione del perché vi è del pianto. Ciò che
è caratteristico del momento del pianto – e del negativo del sentimento in
genere – è la presenza del qualcosa-perso-per sempre; il pianto può esser
per la morte di chi si ama, ma ci può esser il pianto per una morte con un
concetto più esteso di morte. Veniamo qui ad introdurre un concetto
originario di morte, un concetto di morte come lo abbiamo espresso nel nonesserci-più: un momento dal quale un qualcosa, un qualsiasi cosa, che si è
dato, non può più essere, non può più darsi all‟essere, dunque un concetto di
morte come negazione originaria di essere.
E dunque ciò che caratterizza il pianto, come abbiamo compreso
questo come cifra di dolore non compensato nell‟anima, non è
necessariamente la morte di un qualcuno, questo può esser per un qualcosa
che non è più e non può più essere, ciò che lo caratterizza è la non
possibilità di darsi di un qualcosa, la non-possibilità del tornare indietro, il
qualcosa che non è più e, si può pensare, non è più per sempre. Per l'io
questo non vien accolto come possibile. Questa è l'impossibilità della morte,
del non-esserci-più, che si sente nel pianto. Ciò che qui si manifesta è che,
88
88
ciò che è stato, e dunque ciò che è stato nella memoria, non può non esser
più, ha sempre da essere.
Si può di qui venir a disvelare la fondamentalità della memoria. Si è
detto che il pianto può esser per il non più esserci di un qualcosa, non per
qualcosa di determinato, ma per un qualsiasi cosa, come il pianto di un
bimbo per un oggetto che non ha più, per un qualsiasi-cosa-che è; ciò che è
fondante è che, qualcosa che è stato nel vissuto dell'io, anche qualcosa di
solamente sperato, qualcosa, comunque, di cui l'io nel vissuto ha partecipato,
a cui è stato affezionato, e dunque qualcosa che è stato nella memoria ─
come insieme contenente passato, presente e futuro ─ non è più. Ciò che è
fondante qui è la memoria, l'inerenza di un qualsiasi-cosa-che è (un ente) alla
memoria dell'io.
Ciò che fonda il valore come l'essere proprio di un ente è dunque la
memoria (G. Scolari, 2009: pp. 98-99). Si è visto che il pianto può esser per
un qualsiasi cosa che non è più, anche per qualcosa di non vivente, ciò che
rende vivente quel dato oggetto, o quella data entità, è il fatto che questo è
stato nella memoria, l'inerenza di questo nella memoria; la memoria è ciò che
dà l'essere a questo ente, ciò che dà ad esso la propria realtà vivente.
Questo si può venir a comprendere a partire dalla questione, posta
da Heidegger nella Introduzione alla metafisica (M. Heidegger, trad. 1968:
pp. 43-46), sull'essere dell'ente. Nella prima sezione della Introduzione alla
metafisica vien posta la questione: dove è da ricercarsi l'essere di un ente?
Heidegger prende in esame diversi esempi di ente, tra cui quello di
un portale: “Il portale di una chiesa romanica è essente. Come e a chi si
manifesta il suo essere? Allo storico dell'arte che lo visita e fotografa durante
un'escursione, all'abate, che, insieme ai suoi monaci, fa il suo ingresso nel
portale nel dì di festa, oppure ai fanciulli che giocano alla sua ombra nel
giorno di sole? Che cosa ne è dell'essere di questo essente?” (M. Heidegger,
trad. 1968: p. 45).
Dunque in quale delle apparizioni, in che cosa, di un ente è da
ricercarsi l'essere di quell'ente?
Qui si ha, che l'apparizione che fonda l'essere di un ente è
l'apparizione inerenziale, ovvero dell'inerenza, di quell'ente alla memoria
dell'io. Ciò che fonda l'essere di un ente con la sua propria individualità è
l'inerenza di quell'ente alla memoria con la sua individualità: se prendiamo
una qualunque cosa, questa è per me quello che è, non per una sua propria
costituzione, che una volta compresa conferirebbe a quello l'essere, ma per il
suo esser stato e per il suo poter esser sempre appartenente al vissuto
dell'io: così, ad esempio, una penna è quello che è, trova la sua
individuazione, per esser stata partecipe di determinati momenti, per aver
89
89
passato diverse vicende insieme alla vita individuale dell'io, per il fatto di
esser entrata in alcune storie del vissuto e proprio in quelle.
Essa dunque è quello che è dal suo esser nella memoria. All'inizio
quell'oggetto, come altri, non aveva un suo determinato proprio significato,
ma dopo aver partecipato ai vissuti dell'io, esser entrato in determinate storie,
che fanno capo ad una memoria, questo oggetto, come altri, assume un suo
significato, un suo valore proprio; e ciò può valere non solo per un oggetto,
ma per un qualsiasi-cosa-che è; esso è quello che è per questo suo essere
appartenente alla memoria dell'io. Chiedersi che cos'è quell'ente a
prescindere dal vissuto della memoria dell'io, con la sua individualità, è
chiedere riguardo a qualcosa di non realmente esistente, mera astrazione;
quell'ente è, in realtà, sempre un ente con il suo essere individuale per un io
e per il suo vissuto; ciò che dà il significato, fonda l'essere, è sempre la
memoria. È sempre la memoria dell'io con le sue storie.
In questo modo si può venir a situare l'essere – al di là delle
astrazioni del pensiero concettuale che ricerca l'essere degli enti – nel
vissuto, nella realtà della vita: in questo orizzonte risulta esser la memoria la
“casa” dell'essere.
Ritorniamo adesso al momento di commozione del pianto. Si è detto
che nel pianto si ha il “sentire” una impossibilità, questo non è invero
qualcosa di cui si è a coscienza, ma è qualcosa che risulta occultato e
coperto. Adesso si ricerca invece una apertura ad una comprensione di
questo, si ricerca un suo disvelamento.
Il fatto del passar sopra rispetto al “sentire”, che vi è nel pianto è
connesso ad una situazione di non-coscienza rispetto a momenti emozionali,
che vengon comunque a costituire l‟intera vita dello spirito e della coscienza.
Si vien adesso a considerare il pianto al fine di trovare l'evidenza nascosta
del “sentire”, che si ha in questo.
Vi è il pianto quando vi è il bisogno dello scaturire di un sentire più
profondo, un sentire profondo e nascosto, nascosto dall'abitudine, dallo stato
abitudinario in cui si pre-è, che deve venir fuori, uscire dall'occultamento. Vi è
un sentire, che è in diretta opposizione a quella che si è visto come la precomprensione in cui l'io è, la comprensione dell'essere in cui sempre si vien a
trovare, la comprensione-apertura originaria alla realtà in cui l'io si trova, un
sentire, che è in diretta opposizione a quella che possiamo configurare come
la “ipostatizzazione concettuale” della vita dello spirito (con “ipostatizzazione
concettuale” si intende la sfera di quelle che si sono affermate, consolidate,
come le convinzioni più ultime e profonde, di cui si può esser a coscienza o
meno, da cui deriva la comprensione-apertura all'essere a partire da cui si
può dare il pensare e l'agire).
90
90
Nel pianto si manifesta come l'urtare della vita dello spirito con
qualcosa di altro da sé che le si oppone; questo urto è urto con l'impossibilità,
che si è rinvenuto impossibilità della comprensione della realtà in cui si è, di
ciò che si è visto come “ipostatizzazione concettuale” della dinamica dello
spirito.
Al contempo si sente come un urtare dell'anima con se stessa,
come una parte dell'anima che si urta con un'altra, che si opponga ad un'altra
(una parte che, come in minoranza, per la sua lontananza dalla
coscienzialità, vien come a dover erompere per farsi sentire). Dunque vi è
come una opposizione interna all'anima, si compie come uno scontro
dialettico tra momenti opposti interno alla vita dell'anima12.
Questo scontro dialettico interno all‟anima è qualcosa che, almeno
al livello della realtà inconscia prima delineata, si vien a superare, la realtà
antitetica (di antitesi che si presenta al sentire dell‟anima) è qualcosa che ha
da esser superata: dopo questi momenti di scontro interno di opposizioni
della vita dell‟anima e superamento, vi è una ri-comprensione di queste in
una sintesi e una compensazione, come l‟apparire di un arcobaleno dopo la
tempesta.
Dunque al livello della realtà inconscia questa realtà antitetica vien
ad esser superata: come risulta questa dialettica interna al livello della realtà
della coscienza, dell‟”ipostatizzazione concettuale”?
Lo scontro dialettico interno all‟anima implica il superamento
dell‟opposizione, l‟antitesi che si presenta a questa. Come si vien a
considerare questo scontro al livello della realtà della coscienza?
Questo scontro dialettico implica un momento di sintesi, che è
appunto l‟uscita dall‟impossibilità, che si rivela nella situazione del pianto.
L‟impossibilità, che qui si vien a portar fuori rendendosi manifesta, è
l‟impossibilità del non-esserci-più, che prima abbiamo visto, l‟impossibilità
della morte come il non-esserci-più senza ritorno di un essere, di un qualsiasi
essere.
12
Nel pianto si sente un urto. Un urto è ciò che vien rilevato esservi da Wittgenestein
nell'etico, in questo vi è un avventarsi contro i limiti del linguaggio. Questo determina
un urto e Wittgenstein afferma: l'urto indica qualcosa (Cfr. L. WITTGENSTEIN, Lezioni e
conversazioni, a cura di M. Ranchetti, Adelphi, Milano 1967, pp. 21-22). Anche qui
l'urto indica qualcosa, ma la cosa rispetto a cui l'anima entra in urto, i limiti del
linguaggio, non sono qualcosa di invalicabile e rispetto al quale non vi è nulla oltre
(come in Wittgenstein); questi limiti si danno qui proprio come limiti da superare, questi
vengono ad esser mutati e ricompresi nell'espressione della vita dell'anima. L'urto
indica lo scontro dialettico interno alla vita dell'anima.
91
91
Che cosa porta a questo scontro dialettico interno all‟anima, che
cosa rappresenta e significa questo nel darsi ed evolversi della vita ed
espressione di questa?
Questa anima concepita come vita dello spirito, che si esprime e
realizza come lògos (che è anima, ragione, volontà, senso), come realtà
evolutiva e dinamica, si trova realizzata in una realtà dialettica diveniente, per
questo presenta all‟interno opposizioni e superamenti. Nella situazione vista il
lògos dell‟anima presenta una scissione interna, come una diffrazione (se
consideriamo questa come realtà luminosa e pensiamo al fenomeno della
diffrazione della luce studiato dalla fisica). La scissione, che qui si presenta, è
scissione tra il “sentire” dell‟esperienza vivente e la realtà della coscienza,
che si è vista come “ipostatizzazione concettuale”, con cui è chiuso e formato
il lògos. Questa ipostatizzazione è necessario superare, per ricomprendere la
scissione interna al lògos, che è poi scissione tra lo stesso lògos come
coscienza propria individuale e l‟essere, che è il “totalmente-altro-da sé” che
contro a lui è ─ ovvero tutto ciò che si oppone a questo e con cui questo è
sempre in rapporto dialettico oppositivo e ricompositivo ─ . Dall‟impossibilità
del non-esserci-più, del pensiero del non-ritorno dell‟essere, vi è il richiamo
alla necessità dell‟integrazione di questo lògos, che è coscienza, pensiero,
spirito vivente produttivo che si scinde e compone nella realtà dinamica.
Tutto quanto si è detto porta al richiamo della necessità
dell‟integrazione di questo lògos: come si è visto l‟”essere-dell-altro” si rivela
proprio inscindibile fondamentalmente dal proprio essere ─ qualsiasi essere
è tale per la fondamentale appartenenza alla memoria come luogo
dell‟apparire e sussistere dell‟essere e per questa ci è proprio ─ . Dunque
ogni essere, in quanto ci è proprio, e in quanto ha una appartenenza
fondamentale al proprio essere, è necessario che sia nell‟integrazione al
lògos proprio della memoria e dunque per questo possa essere e darsi ad
essere nel rapporto proprio ad esso: in questo si supera il pensiero del nonesserci-più senza ritorno, in cui qualcosa non può più darsi ad essere per il
suo essere che ci è proprio.
A questo si arriva anche dal pensiero dell‟essere sviluppato nel mio
libro Il pensiero dell'essere e la luce: qui si manifesta la costituzione stessa
13
dell‟essere, che si mostra come proprio, nell‟essere che è eterno ─ l‟essere
che si dà è necessario che sia per il suo darsi e sempre potersi dare.
In conclusione si perviene alla realtà dell‟essere di ogni essente,
ogni cosa che è, nel suo darsi e sempre potersi dare, come costituentesi nel
lògos al di là delle scissioni di questo, secondo ciò che gli è proprio nella
13
Cfr. la necessità dell‟essere eterno per il darsi dello stesso essere in G. SCOLARI, op.
cit., partic. pp. 55-61.
92
92
appartenenza – la propria inerenza – alla memoria, che integra l‟essere di
ogni essente oltre le scissioni nel suo passato, presente e futuro. Questo
troviamo anche dal verso di Parmenide, secondo il quale ogni essere
bisogna che sia proprio per il suo proprio essere: “Eppure anche questo
imparerai: come le cose che appaiono bisognava che veramente fossero,
essendo tutte in ogni senso” (Fr. 1 vv. 31-32). Al contempo si arriva a
realizzare l‟essere di ogni essente come ciò che, al livello logico-costitutivo,
ha da essere e sempre da essere per il suo stesso senso: la necessità
costitutiva dell‟essere eterno per l‟essere di ogni essente.
Riferimenti bibliografici
I Presocratici, Frammenti e testimonianze, Laterza, Roma-Bari
1993.
M. SCHELER, Gesammelte Werke, M. Frings (hg.), Bonn 1995.
R. OTTO, Il sacro, tr. it. di E. Buonaiuti, Feltrinelli, Milano 1992 (ediz.
orig. R. Otto, Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und
sein Verhältnis zum Rationalen, Bech, München 1936).
W. JAMES, La volontà di credere, a cura di G. Graziussi, Principato,
Milano 1966.
L. W ITTGENSTEIN, Lezioni e conversazioni, a cura di M. Ranchetti,
Adelphi, Milano 1967.
M. HEIDEGGER, Essere e tempo, Longanesi, Milano 1976 (ediz. orig.
M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, Niemeyer, Tübingen 1927).
ID., Che cos' è la metafisica?, in ID., Segnavia, Adelphi, Milano 1987
(ediz. orig. M. HEIDEGGER, Wegmarken, Klostermann, Frankfurt a. M. 1971).
ID. Introduzione alla metafisica, Mursia, Milano 1968 (ediz. orig., M.
HEIDEGGER, Einführung in die Metaphysik, Niemeyer, Tübingen 1966).
G. SCOLARI, Essere e luce. Intorno allo stesso essere della morte e
della vita, Lit Verlag, Berlin 2009.
93
93
LA PSICOTERAPIA ALLA RICERCA DI SE STESSA.
SU IL PAESE DEGLI SMERALDI A CURA DI L. A. ARMANDO E
A. SETA
*
di Francesco Tarantino
Abstract
This paper examines the book by L. A Armando and A. Seta Il paese degli smeraldi
that brings together a choice of three thousand posts received in a blog made by
patients or people who have interacted with the theory and practice of psychotherapy
by M. Fagioli. The author points out that the book draws its cue from considerations of
those patients and people on that specific theory and practice to discuss problems
related to psychotherapy in general. He does not merely summarize and analyze the
chapters of the book, but also offers its views concerning the relationship between
psychotherapy, science, ideology and social aspects. He finally suggests that Il paese
degli smeraldi could help the phenomenological approach in psychotherapy which, as it
is known, allows specific investigations on the experiences of the patient or empathetic
relationship between therapist and patient.
Ce texte prend en examen le livre de L. A. Armando e A. Seta Il paese degli smeraldi,
soit le recueil de trois mille post publiés dans un blog par des patients ou des gens
ayant eu affaire à la théorie et à la pratique psychanalytiques de M. Fagioli. L‟auteur
met l‟accent sur le fait que le livre naît des considérations de patients et de personnes
sur cette théorie et cette pratique en particulier, pour discuter de problèmes qui
concernent la psychothérapie en général. Loin de se limiter à résumer et analyser les
chapitres du livre, il propose aussi des observations personnelles concernant le rapport
entre psychothérapie, sciences, idéologie et aspects sociaux. Il soutient, enfin, que Il
paese degli smeraldi peut apporter une contribution à l‟approche phénoménologique
en psychothérapie laquelle, on le sait, permet d‟enquêter sur le vécu du patient ou sur
le rapport empathique entre le thérapeute et le patient.
Questo scritto prende in esame il libro di L. A. Armando e A. Seta Il paese degli
smeraldi che raccoglie una scelta dei tremila post fatti pervenire in un blog da parte di
pazienti o persone che hanno interagito con la teoria e la pratica psicoterapeutica di
M. Fagioli. L‟Autore mette in evidenza come il libro prenda spunto dalle considerazioni
di quei pazienti e persone su quella specifica teoria e pratica per discutere problemi
che riguardano la psicoterapia in generale. Egli non si limita a riassumere ed
analizzare i capitoli del libro, ma propone anche proprie considerazioni inerenti al
rapporto tra psicoterapia, scienza, ideologia ed aspetti sociali. Sostiene infine che Il
paese degli smeraldi può fornire un contributo all‟approccio fenomenologico in
*
Dirigente Psicologo Psicoterapeuta presso il SERT di Copertino - ASL Lecce.
94
94
psicoterapia che, come è noto, permette indagini particolari sui vissuti del paziente o
sul rapporto empatico tra terapeuta e paziente.
1.Premessa
Il paese degli smeraldi è il titolo suggestivo di un volume che
raccoglie una scelta dei tremila post fatti pervenire in un blog1 da parte di
pazienti, ex pazienti o persone che, a vario titolo, hanno interagito con la
teoria e la pratica psicoterapeutica di M. Fagioli o che fanno riferimento ad
esse.
Il filo conduttore di questo libro, che arditamente traspone nel
cartaceo ciò che normalmente è dedicato a restare nei circuiti telematici, è
una riflessione critica su tale teoria e tale pratica concepita però non come
fine a se stessa, ma come occasione per discutere problemi che riguardano
la psicoterapia in generale.
Inizierò questa recensione con un breve riassunto dei contenuti dei
capitoli del libro e dando nel corso di tale riassunto qualche notizia sulle
suddette teoria e pratica; proporrò poi alcune mie considerazioni sul
problema del rapporto tra psicoterapia, scienza e ideologia e sulle
implicazioni sociali della psicoterapia.
95
2. Dalle testimonianze alla storia della “teoria della nascita”
Il libro è suddiviso in sette capitoli rispettivamente intitolati:
“Testimonianze e racconti”, “Sul blog”, “Sulla cura”, “Sui rapporti”, “Sulla
teoria”, “Alcune opinioni a confronto” e “Sulla storia”.
Il primo capitolo propone testimonianze e racconti di quanti hanno
avuto a che fare con la pratica terapeutica di Fagioli nota come “analisi
collettiva” (di qui in avanti indicata con le sole iniziali ac) e con il suo
impianto teorico. Sono persone che si definiscono pazienti bisognosi di cure
psicologiche, o studenti, o semplicemente simpatizzanti dell‟ac, come pure
intellettuali. Gli stessi curatori del libro mettono in guardia il lettore poiché il
racconto dei vissuti, da parte di un paziente o anche di una persona
all‟interno di una normale relazione, può dare adito a gravi fraintendimenti ed
equivoci: in una relazione psicoterapeutica la possibile commistione del
1
Il blog sta nel sito www.antonelloarmando.it. Il titolo del libro oggetto di questa
recensione è: ARMANDO L. A., SETA A. (a cura), Il paese degli smeraldi. Testimonianze
e riflessioni sulla pratica e sulle ipotesi teoriche dello psichiatra Massimo Fagioli,
Mimesis, Milano 2009.
95
transfert può complicare, di per sé, la comprensione dei significati.
Segnalano inoltre il rischio di dare spazio a pettegolezzi. Partono però dal
presupposto che “bisogna anche tener conto delle contestazioni che da molte
parti vengono rivolte alla psicoterapia in genere, ossia di essere una
disciplina scarsamente trasparente quanto a procedimenti e verificabilità dei
risultati”; insomma, si avverte da più parti l‟esigenza di “rendere pubblici e
visibili metodi, procedure, e risultati” al fine di superare la rappresentazione
sociale della psicoterapia come “pratica esoterica e suggestiva , ossia poco o
nulla scientifica” (Armando - Seta, 2009: p. 23).
Il capitolo successivo traccia l‟evoluzione dell‟ac a partire dagli anni
settanta dividendola in due periodi: il primo in cui essa fa notizia per la sua
originalità dovuta a un esplicito allontanamento dall‟ortodossia freudiana e
alla rottura sia del setting duale che del setting dei piccoli gruppi; il secondo
in cui essa va incontro a un‟involuzione. I curatori del volume sostengono che
il blog rappresenta il momento dell‟impatto dell‟ac “con la società civile, con
la sua imprevedibilità e spontanea attitudine alla ricerca della conoscenza
attraverso le vie più diverse, che da circa un decennio si è dotata, come
strumento di dialettica democratica, anche di internet e dei blog” (Ivi, p. 63).
Il blog pone due interrogativi: il primo riguarda il tentativo dello psichiatra
romano di “accreditare una teoria sulla realtà umana” attraverso la via
politica; il secondo riguarda l‟“ossessione mediatica” per la ricerca di uno
spazio di visibilità per l‟ac stessa (Ivi, pp. 63-64). Questo capitolo si conclude
con due interventi il primo dei quali evidenzia le ombre dell‟ac medesima e la
responsabilità che comporta una critica poiché espone coloro i quali hanno
creduto in essa (e ne hanno tratto vantaggi) a una crisi la cui portata è
difficilmente valutabile, mentre il secondo insiste sull‟utilità del dibattito
pubblico sulle psicoterapie e sull‟evidenziazione dei loro sviluppi anomali.
Nelle pagine che seguono si capitolo descrive, da un lato, quanto si
svolge nell‟ac, nei piccoli gruppi terapeutici (che l‟affiancano) e nelle terapie
individuali; dall‟altro tutte le iniziative collaterali alle pratiche
psicoterapeutiche propriamente dette, come convegni, lezioni universitarie,
interessi per il cinema, per l‟architettura, per il disegno, ecc.. Per come riferiti,
i vissuti di quanti hanno partecipato a queste attività presentano un percorso
simile: un iniziale entusiasmo, una speranza positiva, un impegno personale
di discussione di se stessi e il successivo insinuarsi di perplessità.. Questi
vissuti, come può essere facilmente immaginabile, possono accompagnare
un qualsivoglia percorso psicoterapeutico. Il capitolo mostra come lo
strumento fondamentale utilizzato da Fagioli e dagli psicoterapeuti della sua
scuola sia l‟interpretazione della negazione della realtà del terapeuta, non
però solo nel suo manifestarsi nel setting, ma anche in occasione di eventi a
questo esterni, quali quelli costituiti dalle suddette iniziative, e soprattutto da
96
96
episodi del passato e del presente della vita privata di Fagioli. A tale
proposito i curatori così si esprimono: “La svolta ermeneutica, consistente
nella riformulazione del racconto di questo fiorire di eventi, ha dato luogo nel
tempo a veri e propri cicli narrativi, che si sono finora ripetuti a intervalli di
anni andando a costituire una sorta di cosmogonia dell‟ac.” (Ivi, p. 79). Gli
eventi, raccontati nel libro, cambiano nei contenuti, ma ripetono uno schema
destinato a rafforzare il carisma dell‟analista fino a farne una figura quasi
leggendaria. Il capitolo illustra poi una differenza tra la frequentazione dei
piccoli gruppi e quella del grande gruppo dell‟ ac.: i piccoli gruppi servono per
l‟ingresso nel grande gruppo, all‟interno del quale (almeno nelle intenzioni dei
partecipanti) si sviluppa, lungo un continuum, un processo di cura,
formazione e ricerca senza che vi sia, tuttavia, la necessaria specificazione e
distinzione dei momenti. Il capitolo propone quindi il problema se l‟ac sia una
terapia o un‟ideologia, sia fondata sul transfert o sul carisma, comporti una
dipendenza transitoria o interminabile, realizzi un continuum tra cura,
formazione, ricerca o una semplice confusione tra questi processi. E‟ ovvio
che i partecipanti al grande gruppo, in quanto la cura è identificata con la
formazione e la ricerca, non si sentano solo pazienti che effettuano un
percorso terapeutico, ma soprattutto cercatori di conoscenza attraverso un
processo di formazione che ritengono possa dare solo l‟ac. Questa ha come
matrice la psicoanalisi che comporta un cammino basato su una significativa
relazione affettiva, l‟analisi del transfert, dei sogni, delle fantasie, delle
aspirazioni e dei vissuti esistenziali dei partecipanti; insomma l‟analisi ha
normalmente obiettivi molto più generali rispetto ad altre psicoterapie. È
inevitabile che il materiale preso in considerazione sia molto vasto. Tuttavia,
considerata la dimensione pubblica e la numerosa affluenza di persone in
ogni seminario, è certo che il setting acquisti altre caratteristiche.
Innanzitutto, proprio per la grossa dimensione del fenomeno, si crea una
complicità che nel tempo genera inaccessibilità alla critica e quindi
autoreferenzialità. In definitiva, in tali interazioni e movimenti culturali il
coinvolgimento affettivo dovrebbe essere limitato in quanto può esporre
l‟individuo con disturbi psicologici a situazioni scarsamente gestibili.
Naturalmente ciò può capitare anche in altri gruppi, dove c‟è un forte
coinvolgimento emotivo e personale, ma che non hanno finalità di cura.
Il quarto capitolo pone sostanzialmente il problema se il gruppo
dell‟ac presenti analogie con una setta o una chiesa. L‟elemento
fondamentale, che appare dai racconti, è l‟aspettativa utopica di rapporti
diversi da quelli normali. I curatori bene fanno ad evidenziare come i
partecipanti dell‟ac costituiscano, in senso lato, una comunità anche se non
97
97
2
vivono insieme e, pur non conoscendosi, rispettino una regola comune ; e
come un‟aspettativa utopica, connessa all‟ideale di fondare una società su
rapporti diversi, costituisca parte centrale nello sviluppo della “teoria della
nascita” e dell‟ ac. In altre parole, il gruppo, anziché ridurre la predetta
aspettativa utopica, la favorirebbe e stabilizzerebbe indirizzandola verso un
cammino di ricerca, cura e formazione, a tinta psicoanalitica, rivestito dal
nuovo abito “fagioliano”, facendo terra bruciata di tutto il freudismo.
Quindi l‟autore si sofferma sulla teoria che orienta l‟ac, ovvero sulla
cosiddetta “teoria della nascita” (si vedano soprattutto Fagioli 1972 [1976,
seconda ed.]; 1974; 1975), la quale si innesta su importanti questioni cui la
ricerca scientifica non ha dato risposte univoche, come il rapporto mentecorpo, con particolare riferimento alla genesi delle interazioni tra aspetti
biologici e psicologici nello sviluppo del funzionamento mentale. Tale teoria
può essere considerata un modello dello sviluppo mentale normale e
patologico basato su due enunciati fondamentali: quello della fantasia di
sparizione e quello della prima immagine-ricordo. Il primo deriva dalla critica
del concetto freudiano di istinto di morte: secondo Fagioli (1976, p. 56), tale
istinto non può essere inteso solo come ritorno allo stato precedente in
quanto questo ritorno presuppone un‟azione di sparizione o annullamento
3
della realtà attuale denominata appunto “fantasia di sparizione” . Il secondo
enunciato deriva dall‟ipotesi che alla nascita la precedente realtà materiale
98
2
Se è vero che i seminari sono nati come contenitore di un gruppo di persone deluse
dai movimenti politici del „68 e del ‟77, è probabile che l‟ac abbia formato un gruppo
comunitario in senso lato e, per alcuni aspetti, analogo nelle modalità ed aspettative
ad altri gruppi come i “figli dei fiori” o i reduci della “beat generation”.
3
Il libro rivolge tre obiezioni alla suddetta definizione dell‟istinto di morte. La prima è
che la fantasia di sparizione, in quanto diretta non su immagini ma sulla realtà esterna
che si presenta alla nascita, produrrebbe lo stesso ritorno allo stato anteriore prodotto
secondo Freud dall‟istinto di morte (ARMANDO - SETA, 2009, p. 147). La seconda è che
vi sarebbe una dicotomia tra nascite sane o malate (p. 147) fondata sulla diversa
consistenza dell‟immagine neonatale; pertanto, si chiedono gli autori, come si può
affermare, senza contraddirsi, che si nasce sani ed uguali se poi
contemporaneamente, in base alla diversa consistenza dell‟immagine ricordo, si
produce una diversità e quindi una maggiore o minore sanità mentale? La terza
obiezione, forse la più importante, riguarda la possibilità di una fantasia diretta contro
immagini di “esprimersi prima delle formazione della prima immagine alla quale essa
concorrerebbe”(p. 148): si può concepire una fantasia senza psiche? Personalmente
aggiungerei un'altra obiezione: come si può parlare di pensiero senza coscienza? Che
cosa significa inconscio? Rappresenta solo il rimosso o è tutto ciò che non appare
alla coscienza? Se l‟inconscio è tutto ciò che non appare o non è presente nel campo
attuale della coscienza, è difficile argomentare un pensiero senza coscienza (o una
coscienza senza pensiero).
98
del rapporto feto-liquido amniotico si trasformi nella realtà immateriale di
un‟immagine-ricordo di tale rapporto la quale costituirebbe l‟inizio della
psiche umana.
Il sesto capitolo è il più avvincente. Lalli mette in risalto il carattere
“politico” della pratica di Fagioli affermando che “costituire una falange di
circa 1.000 persone, sempre presenti, sempre pronte ad applaudire gli amici
e fischiare i presunti nemici; avere una rivista e poi un settimanale che si
adeguino alla linea ideologica di Fagioli, i cui direttori possono essere
licenziati se non si attengono alle direttive; avere un gruppetto che recita alla
perfezione gli scritti del maestro; avere un addetto stampa che amplifica e
costruisce notizie; screditare tutti coloro che la pensano in modo diverso
utilizzando etichette diagnostiche e maldicenze varie; ebbene, questi sono gli
stessi metodi che la politica, così come la conosciamo, dimostra di usare
giornalmente” (Armando-Seta, 2009: p. 178). Armando riconosce invece una
iniziale validità nel discorso di Fagioli e parla di una sua successiva
4
involuzione prendendone definitivamente le distanze (Ivi, p. 182) . Un
5
partecipante al blog (Ivi, pp. 186-187) si chiede come mai due studiosi e
clinici come Lalli e Armando non si siano accorti per tempo dei limiti di quel
discorso del quale sono stati i garanti accademici.
Lalli, risponde
affermando che si è allontanato dall‟ac quando si è reso conto obiettivamente
4
Credo che la presa di distanza di Armando da Fagioli debba essere fatta risalire alla
differenza di visioni che vi è sempre stata tra loro e che risulta già dal confronto tra
l‟articolo di Armando “Sul punto di vista della storiografia” del 1961 e quello di Fagioli
“Alcune note sulla percezione delirante paranoicale e schizofrenica” del 1962:
Armando ha una visione storica della realtà della psiche umana, mentre Fagioli
sembra subordinare la stessa visione storica alla comprensione individuale orientata
in senso naturalistico o essenzialistico. Su questa differenza mi sono soffermato nella
mia recensione del 2007 al libro di Armando La ripetizione e la nascita. Ritengo
fuorvianti i commenti di G. Bruco (2007) a tale (mia) recensione fondati, tra l‟altro,
sull‟assunto che “nessun filosofo ci ha mai detto da dove il pensiero nasce”. La
tendenza naturalistica dell‟interpretazione di Fagioli della realtà psichica è stata
evidenziata già nel 1979 da Poggiali (1979, p.44) quando scrive che “Fagioli tenta una
composizione [delle scissioni del freudismo] con le armi del suo arsenale naturalistico”.
Poggiali coglie anche l‟assenza di visione storica di Fagioli nel momento in cui
evidenzia che questi “è assai avaro nel dirci che il terreno critico che lui rivendica nei
confronti di Freud lo condivide con pochi altri” (p. 51). G. Bruco sembra non dare il
giusto peso alla riflessione filosofica nella psicologia e psicopatologia che ritengo
invece fondamentale: già Jaspers affermava che: “Colui che si è preso la pena di
riflettere a fondo sulla filosofia critica è al sicuro dal porsi molti falsi problemi, da
discussioni superflue, e da pregiudizi impaccianti, che hanno una parte importante in
psicopatologia in quelle menti non adusate al lavoro filosofico (1983, p. 7).
5
Lalli, negli anni Settanta, contribuì all‟iniziale svolgimento dei seminari di ac presso la
sede di Viale di Villa Massimo, in Roma.
99
99
che quanto scritto da Fagioli era contraddetto dai suoi comportamenti e al
riguardo afferma: “Fagioli non fa psicoterapia né formazione, e mi sembra
che molte lettere del blog lo dimostrano chiaramente, ma che al massimo
può fare solo ricerca.” (Ivi, p. 189). Di diverso tenore è la posizione di
Armando (Ivi, p. 190) il quale rileva che, da una parte, la sua adesione al
discorso fu convinta, e niente gliene lasciava presagire l‟involuzione, dall‟altra
che l‟aver sperimentato gli aspetti negativi del seguito di quel discorso gli dà
una possibilità in più di capire fenomeni analoghi di più ampia portata. Lago
interviene in questo dibattito per sostenere che le posizioni di Armando e Lalli
sono sovrapponibili sino ad un certo punto. Egli afferma che Armando
sbaglia nel riconoscere la validità del primo periodo dell‟ac e concorda con
Lalli nel darne un giudizio complessivamente negativo. Il paragrafo di questo
capitolo intitolato “Mare azzurro e mare verde” riprende in considerazione
l‟eventualità che l‟ac abbia somiglianze con una setta e non con una scuola
di psicoterapia. Lalli a tal proposito parla più di indottrinamento che di scuola
di psicoterapia: “Credo che quando una persona così pervasivamente tende
a fare indottrinamento, possiamo parlare di setta. E di fronte ad un
atteggiamento settario, non credo che esista alcuna possibilità dialettica” (Ivi,
p. 209). Anche per Seta vi sono somiglianze tra ac e setta: ella afferma che
“le analogie con l‟organizzazione delle sette sono suggestive, a volte
imbarazzanti. Soprattutto gli aspetti di credenza ancora tipici dell‟ac
6
rafforzano questo parallelo, bisogna ammetterlo” (Ivi, p. 213) .
L‟ultimo capitolo ripercorre la storia dell‟ac utilizzando il romanzo di
Baum (1978), Il mago di Oz, cui fa riferimento il titolo del libro. I curatori
ricordano come la sua protagonista, Dorothy, inizi, sotto la spinta di un
uragano che ne sradica la casa, un percorso di conoscenza insieme a tre
compagni
desiderosi di rinvenire
intelligenza, coraggio e affettività
attraverso appunto l‟incontro con il mago di Oz.
6
Ellenberger (1976, p. 55) mette in evidenza come “la moderna psichiatria dinamica è
divisa in un certo numero di scuole, ciascuna delle quali ha la sua dottrina, i suoi
insegnamenti, il suo training”. Il fiorire delle attuali scuole di psicoterapia, in alcuni casi
in contrasto tra di loro, ripropone uno statuto scientifico piuttosto frammentario con
tendenze talora settarie. Jaspers (1983, p. 822) evidenzia altresì l‟aspetto settario
delle scuole di psicoterapia. A tal proposito così si esprime: “ Esistono anche
psicoterapeuti importanti, liberi, assolutamente indipendenti, ma la massa ha bisogno
del raggruppamento; solo in tale modo, infatti, ottengono una specie di istanza
oggettiva, nel cui nome agiscono, dalla quale ricavano la sensazione di una
conoscenza assoluta e di una superiorità di fronte ad altre sette”. L‟aspetto settario
può essere alimentato se una scuola di psicoterapia poggia le sue conoscenze e
pratiche sugli aspetti autoreferenziali e ideologici che giustificano teoria e tecnica dei
trattamenti psicoterapeutici all‟interno dello stesso gruppo o linea teorica.
100
100
Per Fagioli tale vento poteva liberare “da quella coartazione
dell‟inconscio, della fantasia, del desiderio e da quella scissione tra pubblico
e privato che avevano costituito la condizione dell‟affermarsi della società
borghese” (Armando-Seta,2009: pp. 220). Egli avrebbe proposto la cura dei
nefasti effetti di quel vento “che avevano portato chi l‟aveva fatto proprio alla
delusione, e da questa alla rabbia distruttrice della lotta armata per poi
riconferire valore all‟ignoranza e soccombere alla seduzione della religione e
della droga” (Ivi, p. 221). Gli autori del libro riconoscono che tale cura vi fu,
come è stato accennato, negli anni sessanta e settanta, ma affermano che
poi l‟ac ha avuto un‟involuzione riproponendo gli stessi meccanismi della
Società Italiana di Psicoanalisi (SPI) di quegli anni. Secondo loro, ciò che più
ha portato a questa involuzione è stato il fatto che Fagioli ha voluto
presentare il proprio paradigma come privo di formazione e di storia, per cui
“quello che era stato o aveva voluto essere il paradigma di una nascita
uguale spariva nell‟affermazione di una nascita diversa e unica e nella
volontà di darle credenziali che dicevano di ripetizione, perché erano in tutto
simili a quelle che analoghi miti avevano cercato di darsi in passato”
(Armando-Seta, 2009: pp. 221-222).
Qual è il senso del riferimento del suo titolo al romanzo di Baum Il
mago di Oz? Nel romanzo si possono cogliere due aspetti: da un lato
l‟imposizione di una determinata visione del mondo, dall‟altro l‟esigenza di
ricerca della conoscenza del mondo esterno e di se stessi.
Il primo aspetto è connesso all‟autoreferenzialità che, parafrasando
il capitolo de Il mago di Oz (Baum, 1987) intitolato “La città degli smeraldi”, è
determinata dagli occhiali speciali che si fanno indossare agli abitanti di tale
città. La visione che si ha, dopo averli indossati, è a tinta unica.
7
L‟imposizione degli occhiali verdi porta a vedere la realtà stessa in un unico
modo sino a farne una verità assoluta in senso ideologico. La visione della
realtà infatti non è determinata solo dagli stimoli visivi, o dagli occhi, ma
anche dalla percezione medesima che dà significato alla realtà visiva. La
percezione tuttavia risulterebbe alterata, sino a limitare la critica personale,
non solo per l‟effetto degli occhiali, ma anche per l‟imposizione di tale
misura, peraltro propagandata da giustificazioni e credenze mistificate cioè
ideologizzate (“perché se non mettete gli occhiali, lo splendore e la bellezza
della Città degli Smeraldi vi accecheranno”, Baum,1987, p. 87). Ma è solo un
7
Riporto un passo cruciale del romanzo: „Io sono il guardiano della Città, e poiché mi
domandate di vedere il Grande Oz, vi accompagnerò al suo palazzo. Però, prima di
tutto, dovete mettervi gli occhiali.‟ „Perché mai?‟ – chiese Dorothy. „Perché, se non
mettete gli occhiali, lo splendore e la bellezza della Città degli Smeraldi vi
accecheranno. Perfino gli stessi abitanti della città devono portare gli occhiali giorno e
notte. E sono tutti assicurati agli occhi con un lucchetto!” (BAUM, 1987, p. 87).
101
101
trucco, come si sa. D‟altra parte gli abitanti della Città degli Smeraldi credono
nella bontà del grande Oz. Questi infatti è un buon governatore e, come
mago, è molto stimato oltre ad essere temuto per i suoi poteri.
Il secondo aspetto è rappresentato da una richiesta della
protagonista del romanzo. Dorothy chiede al mago di poter ritornare nel
Kansas, cioè nel suo paese dove sono rimasti i suoi parenti, vale a dire i suoi
affetti. In senso lato, il viaggio rappresenta la ricerca dell‟identità. Alla fine del
viaggio Dorothy scopre che ha sempre posseduto i mezzi per tornare a casa
(che simbolicamente esprime un ritorno alla realtà). Ella, tuttavia, non ne era
a conoscenza, come le fa notare la fata buona Glinda. Anche i compagni di
Dorothy, prima di ricevere ciò che chiedono, cioè intelligenza lo
Spaventapasseri, cuore l‟Omino di stagno, e coraggio il Leone, sono avvertiti
dallo stesso mago di Oz che già possiedono tali capacità. Infatti, allo
Spaventapasseri che reclama un cervello nuovo di zecca, Oz risponde così:
“Non ne hai bisogno: ogni giorno tu impari qualche cosa. Un bimbo appena
nato il cervello ce l‟ha, eppure non sa servirsene. Non c‟è che l‟esperienza
che renda intelligenti, e quanto più a lungo uno vive su questa terra, tanto più
è certo di accumulare esperienza” (Ivi, p. 147). Al Leone, sulla stessa
falsariga, così dice: “Quel che ti manca è la fiducia in te stesso. Non c‟è
creatura al mondo che non provi paura nel trovarsi di fronte al pericolo. Il
vero coraggio consiste nell‟affrontare il pericolo proprio quando si ha paura, e
questo genere di coraggio a te non manca certo” (Ivi, p. 148). Al Boscaiolo di
Stagno, il mago fa notare, in modo piuttosto paradossale, che “un cuore, in
generale, rende infelice chi lo possiede. Se tu avessi dell‟esperienza sapresti
che è una bella fortuna quella di non averne” (Ivi, p. 149).
Il mago di Oz, secondo Baum, rappresenta un prigioniero di se
stesso in quanto intrappolato in un ruolo, quello del ciarlatano, che non
aveva scelto. Egli infatti era diventato un mago poiché si era venuto a
trovare, per caso, a contatto con gente stupida: “Mi trovai subito in mezzo a
gente così sciocca che, vedendomi scendere dalle nubi, credé che io fossi
un gran mago. Naturalmente io non cercai di dissuaderli, vedendo che
avevano grande paura di me, e io promisi loro, invece, di far tutto quello che
8
essi avrebbero desiderato” (Ivi, p. 147) . Il significato del romanzo è evidente:
bisogna fare appello alle capacità individuali attraverso un percorso comune.
8
L‟essere intrappolato in un ruolo che non è il proprio è una situazione che può
verificarsi nella vita di ogni giorno e dare corso ad equivoci duraturi. Ellenberger
(1976, p. 11) racconta di uno studioso che era andato ad osservare l‟arte degli stregoni
divenendo in seguito sciamano pur essendo partito da presupposti che negavano
ogni fondo di verità alla stregoneria. Questo autore così conclude: “D‟altra parte,
Quaselid riferisce i propri successi senza evidentemente ricordare di aver incominciato
102
102
3. Psicoterapia, scienza e ideologia
Come ho accennato, Il paese degli smeraldi si serve del discorso
sulla vicenda, che considera marginale, dell‟ac per proporre una serie di
questioni generali, in particolare quelle riguardanti il rapporto tra psicoterapia,
scienza e ideologia e quelle riguardanti gli aspetti sociali della psicoterapia. In
questo paragrafo mi soffermo sulla prima questione e nel successivo
sull‟altra.
In generale, l‟evidenza scientifica di una psicoterapia dovrebbe
prevedere la somministrazione di un dato trattamento psicoterapeutico a un
gruppo sperimentale di pazienti con stessa diagnosi, attuando un confronto
con un gruppo di controllo nonché la verifica, a parità di condizioni, con altra
terapia mirante alle medesime finalità.
L‟evidenza scientifica in psicoterapia si fonda sul superamento di
specifiche prove d‟efficacia attraverso un insieme di procedure basate
sull‟EPB (Evidence Based Psychology cioè Psicologia Basata sull’Evidenza).
In generale è opportuno: 1) partire da un‟attenta selezione di casi clinici
secondo un campionamento casuale, 2) effettuare uno studio differenziale
con “gruppi di controllo”, 3) riscontrare che il risultato di ogni procedura
psicoterapeutica non sia legato al caso o ad un effetto placebo, 4) controllare
9
gli effetti soggettivi inerenti all‟interpretazione dei risultati .
Michielin (2003, p.17) ritiene che l‟efficacia, fondata sull‟EPB, deve
essere sottoposta a un confronto con le relative rassegne scientifiche e a
un‟attenta meta-analisi. Lo studio delle rassegne scientifiche cerca di
evidenziare da svariati punti di vista un particolare tema mettendone in
risalto le diversità e le affinità. La meta-analisi, invece, individua i metodi
statistici adoperati, vale a dire le forme di stima di gruppi omogenei nonché
le standardizzazioni di procedure di ricerche differenziate. Il predetto autore
(2003, pp.18-19) ritiene anche che vi sono importanti difficoltà
nell‟applicazione dell‟EPB tra cui: 1) le caratteristiche della personalità del
terapeuta che incidono in maniera differente sugli stessi risultati; 2) i
cambiamenti nel tempo degli interventi; 3) la problematicità ad impiegare
la carriera con l‟intenzione di smascherare quei trucchi che adesso applica egli stesso,
e con molta fortuna.”
9
Riporto quanto già ho rilevato in un‟analisi specifica dell‟evidenza in psicoterapia nel
mio lavoro del 2004 Nuove frontiere in psicoterapia ipnotica. La prospettiva
fenomenologico-esistenziale. Si veda in particolare P. MICHIELIN , Prove di efficacia e
linee guida per i trattamenti psicologici e le psicoterapie, „‟Psicopuglia‟‟ n.16, 2003,
pp.17-28
103
103
una metodologia fondata sulla “cecità” che concerne la validazione dei
risultati di una psicoterapia occultando il metodo impiegato, i pazienti e gli
stessi valutatori. Lo stesso Michielin (2003, pp.18-20) ritiene infine che la
valutazione dell‟efficacia delle psicoterapie deve tener conto: 1) del confronto
dei risultati in gruppi di pazienti; 2) della confrontabilità dei gruppi con
caratteristiche simili; 3) della confrontabilità delle rilevazioni basate su
strumenti oggettivi; 4) della rilevanza dei risultati in quanto riferiti alla qualità
della vita del paziente; 5) dell‟ accuratezza del follow-up; 6) della
completezza della descrizione dei risultati; 7) di una sufficiente analisi
statistica dei risultati.
Attualmente molti procedimenti psicoterapeutici non hanno i
necessari riscontri con tali metodi poiché l‟orientamento fondato sull‟EPB si
va diffondendo, specialmente in Italia, solo in questi ultimi anni. Nella realtà
attuale abbiamo due gruppi di psicoterapie: il primo, di matrice psicodinamica
(psicoanalitica) o umanistico-esistenziale, non ha ancora sufficienti studi che
dimostrino l‟evidenza scientifica, soprattutto per la difficoltà di provare
sperimentalmente l‟efficacia di procedimenti interpretativi in cui prevale
l‟aspetto soggettivo del terapeuta; il secondo gruppo comprende psicoterapie
di ordine cognitivo, comportamentale e relazionale, in cui invece si diffonde
sempre più la pratica dell‟EPB.
È evidente che le psicoterapie del primo gruppo tendono a basarsi
10
sull‟autoreferenzialità . Le psicoterapie fondate sulla “teoria della nascita”
possono essere inquadrate nel primo gruppo e quindi è più difficile ritrovarne
l‟evidenza scientifica sia sperimentale che clinica.
I curatori de Il paese degli smeraldi sostengono che l‟ac “ha con
crescente determinazione eluso ogni confronto critico, accentuando il proprio
arroccamento in un‟autoreferenzialità” (Ivi, p. 10). Essi sottolineano pure che
la teoria della nascita non si è mai costituita come “scienza normale”, alla
10
L‟autoreferenzialità può essere rapportata a sistemi autoreferenziali o autoricorsivi
(autoregolazione, auto-organizzazione, immagine di se stessi) come evidenziato da P.
Watzlawick, J. H. Beavin, Don D. Jackson (1971). In filosofia, l‟autoreferenzialità si
riferisce: 1) alla problematica della riflessione su cui si fonda la coscienza; 2)
all‟ermeneutica in quanto nello studio della storia, dell‟essere e del linguaggio vi è
sempre un momento autoreferenziale dal quale si sviluppa il “circolo della
comprensione”; 3) alla logica e allo studio del linguaggio e cioè ai paradossi dove si
sono sviluppati due orientamenti: a) il primo basato sul principio “antifondazione”
secondo cui non sono ammessi insiemi che comprendano se stessi, b) il secondo si
fonda su una teoria circolare della verità basata sull‟autoreferenzialità costitutiva del
predicato “vero”. In psicoterapia l‟autoreferenzialità si esprime con la mancanza di
studi sul piano delle evidenze sperimentali e cliniche.
104
104
11
maniera intesa da Khun (1969) , né la comunità scientifica né la comunità
sociale avendo mai riconosciuto che essa fornisse un nuovo paradigma; e
che quest‟atteggiamento di chiusura ha favorito un andamento
autoreferenziale del percorso fagioliano (Ivi, p. 152).
Il riconoscimento è autoreferenziale quindi
non solo per la
mancanza di verifiche, ma soprattutto perché il paradigma è riconosciuto
valido da un ristrettissimo gruppo cementato da un coinvolgimento emotivo.
In altre parole, le enunciazioni teoriche non hanno trovato condivisione nella
comunità scientifica. Per esempio il libro che contiene le principali “scoperte”
di Fagioli (1972), anziché avere i riscontri da tale comunità, in termini
sperimentali e clinici, li ha avuti (autoreferenzialmente) dalle enunciazioni
teoriche nell‟altro suo libro del 1974, seguito dall‟altro del 1975, e così via.
La stessa ac ha seguito questa modalità: invece di ricercare il vaglio,
attraverso studi sperimentali e clinici, della comunità scientifica, ha riprodotto
le sue forme d‟impianto originario.
La mancata verifica e l‟autoreferenzialità della “teoria della nascita”
fanno di essa una sorta di ideologia. L‟aspetto autoreferenziale e quello
ideologico, nell‟opera di Fagioli, rappresentano così due facce della stessa
medaglia. In particolare non è necessario che una “credenza” sia valida o
meno, oggettiva o soggettiva, realizzabile o irrealizzabile, ciò che è
importante per l‟ideologia è la capacità della stessa credenza di controllare i
comportamenti in un contesto specifico. Di conseguenza l‟ideologia è un
sistema di idee, una visione del mondo, impregnati di dogmatismo,
dottrinarismo ed estremismo dove dominano gli aspetti emotivi e irrazionali.
Si può asserire quindi che l‟ideologia, specialmente nelle forme
riduttive o estreme, può fuorviare i processi critici, in ogni forma di
conoscenza, in quanto li condiziona negativamente con comportamenti
emotivi. Gli aspetti autoreferenziale e ideologico, spesso complementari,
possono fuorviare il setting psicoterapeutico, connotandolo talora come uno
12
spazio manicomiale “a tempo” in cui vengono agite le dinamiche della follia .
11
Secondo Khun, un “paradigma” ne sostituisce un altro per risolvere le irregolarità
o i limiti di quest‟ultimo ponendosi come nuovo “paradigma” che viene così accettato
dalla comunità scientifica; naturalmente anche il nuovo “paradigma” può essere
sostituito da un altro per le anomalie che nel tempo può produrre e così via. Peraltro il
rafforzamento di un determinato paradigma, nato dalla ricerca, avviene anche per una
sorta di consolidamento sociale ed istituzionale. Si veda (Khun1969 e Abbagnano
2006, p. 22).
12
Una testimonianza ne Il paese degli smeraldi (p. 27) evoca il senso ideologico: “Ho
vissuto tutte le tappe: la disperazione precedente l‟incontro con lo psicoterapeuta, la
diffidenza, il trasporto entusiasta […], il rifiuto dei genitori e amici trasformatosi ben
presto in violenza, l‟odio e la paranoia, […] l‟allontanamento”. Il significato ideologico
105
105
Dal discorso fatto sinora emerge che una psicoterapia dà garanzie
se vi è una verifica o riscontro da parte della comunità scientifica dove siano
condivisi linee teoriche e procedure concrete. In altre parole, un buon
procedimento psicoterapeutico deve essere caratterizzato da evidenza
scientifica sperimentale e clinica. L‟evidenza scientifica, peraltro, elimina la
segretezza e quindi mette al riparo da ogni forma di settarismo o
autoreferenzialità. La comunità scientifica infatti si situa all‟interno di un
contesto sociale e culturale anche di carattere internazionale includendo la
possibilità di dibattiti pubblici a diversi livelli.
Il libro stimola una domanda tanto semplice nella formulazione
quanto complessa nella risposta: allo stato dell‟arte attuale può la
psicoterapia, in quanto settore della psicologia, avere riscontri sul piano
dell‟evidenza scientifica?
La psicologia, a cui si rifanno i diversi metodi psicoterapeutici,
stenta ad avere uno statuto scientifico. Essa si caratterizza, per certi versi,
come una “protoscienza”. Attualmente la psicologia è caratterizzata da
almeno sei linee di tendenza o di ricerca che, secondo Mecacci (1999, pp.
VIII-IX), si identificano con la linea fenomenologica,
psicodinamica,
comportamentistica, cognitivistica, storico-culturale e biologica, ciascuna
delle quali ha proprie metodologie, assunti teorici, specifici campi d‟azione e
aree d‟indagine. Di conseguenza, sempre per Mecacci, la psicologia
moderna è caratterizzata dalla convivenza di vari orientamenti senza che vi
sia ancora una condivisione degli assunti di base che è una condizione
necessaria perché essa acquisisca statuto scientifico. Egli pertanto ritiene
(Ivi, p. X) che la psicologia abbia le caratteristiche di una “scienza dello
spirito”, cioè di “un‟ermeneutica e di una narrazione” del mondo psichico, per
cui “anche le prospettive naturalistiche e sperimentali non sarebbero che uno
dei tanti e vari modi di studiare la psiche umana”. In altre parole, la nascita
della psicologia come scienza, su basi sperimentali, così come è successo
13
per le altre scienze, è ancora lontana .
è segnalato pure da A. Seta: “L‟ac non è un luogo di contenimento di patologie
psichiatriche, la patologia psichiatrica non vi ha (e forse non vi ha mai avuto)
cittadinanza. Il punto è invece quello del fenomeno o gruppo carismatico. Un punto
importante, questo, per cui persone altrimenti definibili sane entrano in un sistema
tolemaico e su certi argomenti, certe aree, si rivelano di fatto non disponibili al
confronto”. La stessa psichiatra continua affermando che nell‟ ac “nessuno è malato,
ma si crea un meccanismo che può far star male gli altri, quelli fuori dal gruppo.
Mentre per chi sta dentro è garanzia di stabilità” (p. 119).
13
Armando (1986), a tal proposito, attraverso una dettagliata analisi storica, evidenzia
come la psicologia, intesa come scienza, sia un‟ invenzione.
106
106
Alla luce di tali considerazioni, lo studio delle evidenze scientifiche
dovrebbe essere ricercato in coerenza con la linea o prospettiva a cui si
riferisce il ricercatore. Per esempio questi, se si muove nell‟ambito della
psicoanalisi (o psicologia dinamica), non può ricercare l‟evidenza con i
metodi sperimentali poiché il loro uso fuorvierebbe la stessa natura della
ricerca; analogo discorso vale per i comportamentisti, i cognitivisti,
relazionali, ecc. proprio per la specificità dei campi d‟indagine: l‟inconscio, il
14
comportamento, gli aspetti cognitivi, le relazioni e così via . L‟elaborazione
invece concettuale (o l‟impianto teorico), cioè la manipolazione di essenze,
dovrebbe essere ricercata con una metodologia ispirata dalla fenomenologia
che è specificatamente orientata verso questo tipo di ricerche. Questo
potrebbe essere un modo transitorio per ricercare l‟evidenza scientifica,
senza naturalmente escludere quella che attualmente viene praticata su base
sperimentale che tuttavia non può essere l‟unica.
La “teoria della nascita” e l‟ac non sembrano rapportabili a nessuna
di queste linee di ricerca; di conseguenza il loro riscontro di evidenza
scientifica resta problematico.
4. Psicoterapia e aspetti sociali
Per quanto riguarda i rapporti tra psicoterapia e aspetti sociali
nonché politici (un tema centrale nel libro), si può partire dalla distinzione
proposta da Jervis (1975, p. 389) tra psicoterapia in senso lato, e
psicoterapia in senso stretto. In quest‟ultimo senso si parla di psicoterapia
professionale secondo criteri accreditati da un punto di vista scientifico
(psicoterapia con evidenza scientifica). Nel primo senso, secondo Jervis (Ivi,
p. 390), si tratta di qualcosa di semplice che “rappresenta il grado zero”
poiché è “l‟aiuto dato, quasi senza saperlo, da una persona qualsiasi, da un
amico, da un‟amica, da un portinaio o dal barista. A volte si tratta di persone
disposte ad ascoltare e capaci di reagire con buon senso”. Tuttavia, al fine di
evitare equivoci, qualsiasi forma di psicoterapia deve essere utilizzata
necessariamente da professionisti, appositamente formati, in riferimento a un
15
ordinamento giuridico . L‟ac, nei suoi primi anni, ha svolto probabilmente
una funzione psicoterapeutica in senso lato.
14
Ho sviluppato tale argomento, in “Esistenze artificiali ed addictions” (2008). La
difficoltà, nella validazione sperimentale delle psicoterapie, proviene anche dal tipo di
psicoterapia stessa che si prende in considerazione.
15
Resta inteso che la psicoterapia (come pure la professione di psicologo) può essere
esercitata, nella nostra normativa nazionale, solo dagli iscritti al relativo Ordine e Albo
professionale (L. n. 56 del 1989). In definitiva la psicoterapia in senso lato si
107
107
La distinzione tra psicoterapia in senso lato e in senso stretto
sottende però la presenza di un filo sottile che le unisce e che può spiegare
la complessità dei trattamenti di cura psicologica. Questo legame può
spiegare anche l‟interesse sociale verso la psicoterapia stessa e le sue
deviazioni. Inoltre nel momento in cui si apre la finestra che tiene unite
psicoterapia professionale e forme di aiuto varie (o di sostegno morale o di
solidarietà), possono transitare elementi ideologici, connessi a una
determinata dimensione politica, anche nelle psicoterapie professionali
caratterizzate da evidenza scientifica. Quindi anche attraverso i trattamenti
terapeutici con psicoterapie accreditate vi può essere una commistione con
aspetti autoreferenziali e ideologici che lo psicoterapeuta, talora in modo
inconsapevole, può far passare alterando così il processo psicoterapeutico
stesso e trasformando il setting di cura in qualcosa d‟altro.
Il paese degli smeraldi evidenzia bene questo aspetto attraverso
numerosi racconti e testimonianze che mettono in risalto gli aspetti
ideologici. Inoltre la psicoterapia stessa, nel momento in cui non è depurata
da questi aspetti, potrebbe essere veicolo di stabilizzazione,
16
destabilizzazione o di trasformazione di determinate visioni politiche .
Il paese degli smeraldi quindi può ancor più stimolare ricerche
sull‟evidenza scientifica delle psicoterapie, specialmente quelle che
direttamente o indirettamente sono rinforzate da visioni ideologiche tendenti
ad affermare determinati modelli politici della società. Per esempio, uno
psicoterapeuta professionista, nel momento in cui tinge una psicoterapia con
un determinato colore politico o credo religioso, tende ad andare oltre il suo
mandato professionale. È una questione etica, ma non solo. Vi è in gioco il
rapporto, in generale, tra scienza e filosofia. E la psicoterapia (e con essa la
psicologia in quanto disciplina empirica) non può sottrarvisi. Le
testimonianze, evidenziate nel libro, pur connotate da una pregnante
differenzia da quella professionale giacché riguarda proprio l‟aiuto dato alle persone
attraverso una capacità empatica che alcuni individui posseggono naturalmente, o
tramite il sostegno morale o ancora il rapporto di amicizia, comprese le forme di
solidarietà.
16
A ciò il libro accenna quando parla dei rapporti tra alcuni movimenti politici come il
„68 e l‟ ac. Il discorso si potrebbe allargare sino ai rapporti tra riforme psichiatriche
(legge 180/1978) e movimenti politici che, negli anni settanta del secolo scorso, hanno
sostenuto tali movimenti con ideologie di tipo conservatore o progressista Si pensi alla
critica ideologica delle classi differenziali degli anni Sessanta e Settanta (anteriori alla
legge 517/1977), in Italia, che includevano riferimenti ad una visione riformista o
marxista, contro una conservatrice o liberale, ecc.
108
108
soggettività, hanno un valore determinante per quanto concerne le
17.
connessioni tra psicoterapia in senso lato e psicoterapia professionale
5. Alcune considerazioni conclusive
Ho iniziato questo scritto con una breve sintesi dei capitoli del libro
curato da Armando e Seta proponendo poi alcune mie considerazioni sul
rapporto tra psicoterapia, scienza e ideologia nonché sulle relative
implicazioni sociali.
Per rendere più chiaro e concreto quanto ho esposto sin qui mi
avvarrò del riferimento a due miei lavori, rispettivamente del 1980 e del
18.
2009
Nel primo ho analizzato l‟ultimo capitolo del celebre romanzo La
coscienza di Zeno di Svevo, evidenziando quello che può essere definito il
punto di vista del paziente in una terapia psicoanalitica, anche se in una
forma “romanzata”. Le osservazioni che Svevo, attraverso l‟interposta
persona di Zeno, fa in tale capitolo, sono pertinenti. Eccone una: “La mia
cura doveva essere finita perché la mia malattia era stata scoperta. Non era
altro che quella diagnosticata dal defunto Sofocle sul povero Edipo: avevo
19
amato mia madre e avrei voluto ammazzare mio padre” .
Zeno,
17
La psicoterapia professionale, infatti, non è avulsa dalla realtà e ha il suo riferimento
nel mondo quotidiano (Lebenswelt) di ognuno di noi dal quale non si può prescindere;
nella realtà quotidiana esistono forme di solidarietà, di sostegno morale e di rapporto
empatico che ci danno un‟idea generale della psicoterapia stessa. Tale
precomprensione facilita la conoscenza della psicoterapia stessa e la rende attuabile.
Inoltre le connessioni tra psicoterapia in senso lato e psicoterapia professionale sono
rappresentate dai vissuti dei pazienti e dei terapeuti stessi attraverso un‟analisi
fenomenologica. Husserl, in La crisi delle scienze europee e la fenomenologia
trascendentale, evidenzia la differenza tra psicologia nell‟ambito del mondo quotidiano
(psicologia ingenua) e psicologia empirica. Secondo tale autore ciò che serve alle
discipline psicologiche empiriche, non sottoposte ad epoché, è la costruzione di un
proprio essere in sé e per sé accessibile tramite la “percezione interna” all‟“io”
riflettente; in altre parole la psicologia fenomenologica tiene presente il mondo
“prescientifico già dato” che rappresenta il depositario di tutte le ovvietà peraltro
indispensabili alle scienze obiettive (p. 236). Naturalmente la psicoterapia in senso lato
come è stata specificata si pone nel mondo prescientifico.
18
F. TARANTINO, “La critica di Svevo a S. Freud”, in Folia neuropsychiatrica, XXIII,
1980, fascicolo I-IV. F. Tarantino “La psicoterapia ipnotica nella prospettiva
fenomenologico-esistenziale”, PsicoPuglia, n. 11, 2009.
19
I. Svevo 1938, p.444. Il romanzo fa anche riferimento agli aspetti autoreferenziali o
ideologici della psicoanalisi, per esempio: “Non debbo costringermi ad una fede né ho
da simulare di averla. Proprio per celare meglio il mio pensiero, credevo di dimostrargli
un ossequio e lui se ne approfittava per inventarne ogni giorno di nuove” (p. 444).
109
109
protagonista del capolavoro di Svevo, spera con la psicoanalisi di cominciare
una nuova vita, ma ben presto si ricrede ed emette un giudizio alquanto
negativo. Un merito de Il paese degli smeraldi può essere scorto nel fatto
che esso si situa nella linea della riflessione critica sulla psicoterapia
inaugurata dal romanzo di Svevo. Al pari del racconto e della testimonianza
sulla propria esperienza dell‟analisi che questi propone attraverso Zeno,
anche i racconti e le testimonianze raccolti ne Il paese degli smeraldi
mancano di verifica oggettiva sotto il profilo sperimentale e clinico; tuttavia,
proprio il fatto che nei due casi non siano i terapeuti a presentare i casi clinici
ma i pazienti o ex pazienti esprimendo la propria esperienza, i propri vissuti
e la sperimentazione sulla propria pelle della validità o meno dei
procedimenti psicoterapeutici, può costituire un punto di partenza per
ulteriori studi nel campo della ricerca di evidenze scientifiche in psicoterapia.
20
Nel lavoro del 2009 si è mostrato come la psicoterapia, nella
prospettiva feonomenologico-esistenziale, sia rapportabile all‟esserci come
cura in quanto chiarisce i rapporti con le dimensioni squisitamente umane; la
cura è qualcosa che si dispiega nel tempo, cercando, nel suo divenire,
incessantemente l‟essere nella sua autenticità, in quanto già “gettato” in una
determinata situazione. Tale lavoro, che è una sintesi di miei precedenti
21
studi , sviluppa in modo particolare alcune tematiche di Heidegger (1970,
2006), trattate in Essere e Tempo e nella sua opera postuma Contributi alla
filosofia (dall‟evento).
Naturalmente l‟“esserci come cura” non riguarda in senso stretto un
determinato procedimento psicoterapeutico, ma il prendersi cura di se stessi
(l‟esserci) e dell‟Altro, cioè il prendersi cura reciproco. In altre parole l
“esserci” si caratterizza appunto come un “prendersi cura”, in un processo
formativo personale, in cui l‟incontro con l‟altro è determinante. L‟approccio
fenomenologico è importante perché può limitare gli aspetti fuorvianti
dell‟autoreferenzialità (o ideologici) che possono transitare nello svolgimento
dei trattamenti psicologici, pure in maniera indiretta, alterando, sotto la
parvenza di scientificità, il normale processo psicoterapeutico. Qui la
riflessione attraverso la fenomenologia, soprattutto in relazione alla
sistematizzazione di concetti derivanti dai dati empirici o di fatto, può
arrecare un contributo specifico proprio laddove non è possibile trattare con i
20
Ho sviluppato in modo particolare questi tempi nel primo capitolo del mio volume
Nuove Frontiere in psicoterapia ipnotica. La prospettiva fenomenologico- esistenziale,
Amisi, Milano, 2004.
21
In particolare mi riferisco ai miei volumi: Tossicomanie ed esistenza. Aspetti
psicologici e psicoterapeutici, Capone, Cavallino di Lecce, 1995 e Nuove Frontiere in
psicoterapia ipnotica. La prospettiva fenomenologico- esistenziale, Amisi, Milano,
2004.
110
110
metodi sperimentali (oggettivi) gli aspetti della realtà interiore, cioè lo
psichismo nelle sue variegate dimensioni. D‟altro canto, l‟approccio
fenomenologico può dare un apporto nella ricerca delle evidenze scientifiche
in psicoterapia proprio per la peculiarità del suo metodo che permette di
cogliere i vissuti (e quindi le soggettività). Questi difficilmente possono
essere studiati con i metodi psicologici sperimentali. La fenomenologia,
poiché permette una forma di conoscenza basata sulla sospensione del
nostro atteggiamento naturale o dei nostri giudizi sul mondo esterno
(epoché), può depurare dall‟autoreferenzialità i rapporti umani e quelli
psicoterapeutici. In termini psicodinamici, non mi riferisco solo al transfert e al
controtransfert, o al contenimento dei meccanismi di identificazione
introiettiva e proiettiva, ma a qualcosa di più ampio. Mi riferisco ad un abito
mentale, o ad uno stile di vita, che lo psicoterapeuta deve adottare, per
limitare gli aspetti negativi dell‟autoreferenzialità, nella pratica professionale.
Calvi (2005) ritiene che l‟epochè sia un metodo importante non solo
nella psicoterapia fenomenologica ma in ogni forma di psicoterapia nel
22
momento in cui prende in esame i vissuti del paziente . La psicoterapia
dunque non può in generale fare a meno dell‟approccio fenomenologico che
permette indagini particolari sui vissuti o sul rapporto empatico tra terapeuta
e paziente, dove i metodi sperimentali o tradizionali della psicologia
incontrano seri limiti. A tal proposito sono molti gli autori sia a livello
internazionale, come Binswanger (1964), Jaspers (1965) e May (1977), sia a
livello nazionale, come Cargnello (1967), Callieri (1980,2001) e lo stesso
Calvi (2005) che hanno messo in evidenza l‟importanza dell‟approccio
fenomenologico ed esistenziale in psicopatologia e in psicoterapia.
Callieri (2004) inoltre, in una postfazione ad un mio volume del
23
2004 ,
ha messo in risalto l‟utilità dell‟approccio fenomenologico in
Psicoterapia attraverso opportuni riferimenti a Schapp e all‟analisi narrativa.
La psicoterapia stessa secondo tale autore (Callieri, 2000, p.15) è una
variante del colloquio narrativo. Per questo motivo mi sono soffermato in
modo particolareggiato sull‟analisi narrativa del racconto di Baum da cui è
tratto il titolo del libro curato da Armando e Seta.
In particolare i vissuti che appaiono nei post raccolti ne Il paese
degli smeraldi, possono assumere un rilevante significato se analizzati
22
Ho messo in risalto l‟importanza dell‟epochè in un lavoro dedicato alla gruppoanalisi
dell‟esserci del Di Petta (si veda F. TARANTINO, Di Petta e la gruppoanalisi dell’esserci
nella cura delle tossicomanie: la prospettiva fenomenologica ad “alzo zero”,
“Comprendre. Archive International pour l‟Anthropologie et la Psychopatyologie
Phénomènologiques”, n.15,2005).
23
B. CALLIERI, “Postfazione”, in F. Tarantino, Nuove Frontiere in psicoterapia ipnotica.
La prospettiva fenomenologico- esistenziale, Amisi, Milano, 2004.
111
111
proprio alla luce di un‟analisi narrativa data dal filosofo Schapp. Questo
autore inverte il primato della percezione husserliana della cosa per dare
importanza alla storia, poiché la cosa al di fuori della storia non sarebbe
niente; in altri termini “nell‟uomo la storia prende il posto della percezione”
(citato da Callieri, 2000, p.12). In altre parole vi è un legame stretto tra come
le persone si impigliano nelle loro storie (autoimpigliamemto) e la
connessione con le storie degli altri in un intreccio molto complicato.
Lo stesso Invitto (2002, p.23) valorizza la funzione della storia nello
sviluppo del pensiero umano mettendo in risalto come l‟ultimo Husserl non
valutasse più “l‟essenza fuori del fatto, l‟eternità fuori del tempo e il pensiero
filosofico fuori dalla storia”.
L‟analisi dei vissuti dei post de Il paese degli smeraldi mette in
evidenza proprio questo intreccio (o invischiamento) tra le storie personali
(peraltro succedutesi nel tempo) e le storie delle altre persone che hanno
condiviso il percorso dell‟ ac nonché di quelle che se ne sono allontanate.
L‟analisi dei vissuti dei post, sia pure nella loro estrema diversità o
opposizione, inoltre mette in evidenza modalità esistenziali peculiari dei
partecipanti all‟ac in cui la possibilità di essere, in una forma diversa (o
nuova), prende il sopravvento sull‟essere concepito come semplice
presenza. L‟esistenza, concepita come semplice presenza o possibilità di
24
essere, è stata trattata in modo particolare da Longhi (1993)
nella sua
importante opera Il segno psicopatologico.
La possibilità di essere, insieme al significato delle cose stesse,
può essere colta anche nei vissuti (Erlebnisse) personali naturalmente dopo
che sono stati depurati attraverso l‟azione riflessiva dell‟epochè. Il senso
dunque che emerge dal libro curato da Armando e Seta, attraverso l‟analisi
dei vissuti manifestati nei “post”, è rapportabile agli aspetti scientifici ed etici
della psicoterapia che peraltro sono tematiche attuali ed importantissime.
Per quanto riguarda la questione dello statuto scientifico della
psicoterapia ho messo in risalto, in più occasioni, come questa, per evitare le
distorsioni dell‟autoreferenzialità e dell‟ ideologismo, debba rapportarsi alle
evidenze scientifiche all‟interno della comunità scientifica stessa e del suo
contesto storico e sociale.
Qui può essere utile la riflessione di Heidegger (1999, p.76)
secondo cui “le scienze dello spirito e anche le scienze che si occupano
degli esseri viventi, debbono necessariamente essere inesatte per poter
restare rigorose”. La fenomenologia, con il suo metodo dell‟epochè, offre un
24
L. LONGHI, Il segno psicopatologico, Capone, Cavallino di Lecce, 1993. Tale autore
si muove sulla scia tracciata, in Essere e Tempo, da Heidegger (1970. p.70) secondo
il quale l‟ “essenziale non sta nel reale, più in alto si trova la possibilità”.
112
112
contributo peculiare nella ricerca delle evidenze scientifiche tenendo sotto
controllo gli aspetti fuorvianti legati all‟autoreferenzialità e all‟ideologismo, che
rappresentano delle “variabili” dal difficile controllo sperimentale o clinico. In
questa direzione, allora, Il paese degli smeraldi, attraverso i suoi dati grezzi,
riferiti ai vissuti agiti nel mondo quotidiano della vita (Lebenswelt) di coloro i
quali hanno interagito con l‟ac, offre un contributo soprattutto nelle fasi
preliminari nella ricerca sperimentale e clinica delle evidenze scientifiche in
psicoterapia.
Per quanto riguarda gli aspetti etici della psicoterapia, vale la
riflessione di Husserl (1961, pp. 287-289) secondo la quale la scienza
“essendo la funzione necessariamente più alta dell‟umanità”, favorisce un
“auto comprensione ultima dell‟uomo come essere responsabile del suo
essere umano”
Queste breve considerazioni ed accenni ad importanti temi
psicopatologici e psicoterapeutici ad orientamento fenomenologico ci portano
a precisare meglio il contributo che il lavoro di Armando e Seta può offrire. Il
paese degli smeraldi, in definitiva offre un insieme di dati interessanti, da
analizzare con l‟approccio fenomenologico-esistenziale tenendo presenti
ovviamente i principali contributi in campo nazionale ed internazionale.
Naturalmente ciò richiede uno specifico lavoro differente, ma senza
soluzione di continuità, con quello effettuato in questo scritto che pertanto
ha le caratteristiche di un‟analisi fenomenologica propedeutica. Lo scopo di
questo mio lavoro infatti, come ho accennato nella premessa, è finalizzato a
porre alcune considerazioni sul problema del rapporto tra psicoterapia,
scienza e ideologia nonché sulle relative implicazioni sociali.
Riferimenti bibliografici
AGOSTINO D‟IPPONA. Le confessioni, Ed. Paoline, Milano, 1987.
AMMANITI M.: ANTONUCCI, F., JACCARINO, B., Appunti di
Psicopatologia, Bulzoni, Roma, 1975.
ARENDT H., HEIDEGGER M.:(Briefe 1925 bis 1975. Unde andere
Zeugnisse). Trad. it.: Lettere 1925-1975, Edizioni di Comunità, Torino, 1998.
ARMANDO L. A., L’invenzione della psicologia, Nuove Edizioni
Romane, Roma, 1986.
ID., La ripetizione e la nascita. Scritti di storia della Filosofia e della
Psicoterapia, (1961-2004), Liguori, Napoli, 2004.
ID., Cura e verità. Recensione-saggio,del libro di Massimo Fagioli,
Lezioni 2002, Roma,
113
113
ARMANDO L. A. SETA A., Il paese degli smeraldi. Testimonianze e
riflessioni sulla pratica e sulle ipotesi teoriche dello psichiatra Massimo
Fagioli, Mimesis, Milano, 2009.
Il Potere della psicoanalisi, Armando, Roma, 1974.
BAUM L.F.,(The Wonderful Wizard of Oz, 1900). Trad. it.: Il Mago di
Oz, Rizzoli, Milano, 1978.
BARISON F.: “Principi di una psicoterapia fenomenologica”, in
PETRELLA F., Modelli e tecniche in psicoterapia,Centro Scientifico Torinese,
Torino, 1979.
BINSWANGER L., Tre forme di esistenza mancata, Il Saggiatore, 1964.
BRUCO G., “La teoria della nascita come fondamento delle scienze
umane. Linee per una epistemologia di formazione professionale, in Segni e
Comprensione, XXII, 65, 2008.
CALLIERI B.:,“Postfazione” in F. Tarantino, Nuove Frontiere in
psicoterapia ipnotica. La prospettiva fenomenologico- esistenziale, Amisi,
Milano, 2004.
CALLIERI B.,”La prospettiva fenomenologica come possibile
presupposto all‟incontro psicoterapeutico”, in Attualità in psicologia, XVI, n .12, 2001.
ID:, ”Dall‟Analisi al racconto: analisi esistenziale e/o analisi
narrativa?, in Attualità in psicologia, XV, n .1, 2000.
CALLIERI B., “Psichiatria”, Ed. Encicl. Ital., V 1980.
CALVI L., Il tempo dell’altro significato. Esercizi fenomenologici di uno
psichiatra, Mimesis, Milano, 2005.
CARGNELLO D. (a cura), E. MINKOWSKI, V. VON GEBSATTEL, E. W.
STRAUSS: Antropologia e psicopatologia, Bompiani, 1967.
D‟AMORE G., Breve storia della psicoterapia in Italia. Linee di
sviluppo dal secondo dopoguerra alla metà degli anni ’70, in “Attualità in
psicologia”, XV, n.1, 2000.
DI PETTA G., Gruppoanalisi dell’esserci. Tossicomanie e terapia delle
emozioni condivise, Angeli, Milano, 2006.
ELLENBERGER H.F., La scoperta dell’inconscio, Boringhieri, Torino,
1976.
FAGIOLI M., Alcune note sulla percezione delirante paranoicale e
schizofrenica, in “Archivio di Psicologia, neurologia e psichiatria”, 4, 1962.
ID., Istinto di morte e conoscenza, Armando, Roma, 1972 (seconda
edizione 1976).
ID., La marionetta e il burattino, Armando,Roma, 1974.
ID., Psicoanalisi della nascita e castrazione umana, Armando, Roma
1975.
114
114
HEIDEGGER M.,Sein und Zein (1928), Trad. it., Essere e tempo,
Longanesi, Milano, 1970.
ID., Beitrage zur Philosophie (vom Ereignis) 1989. Trad. it.,
Contributi alla filosofia (dall’evento), Adelphi, Milano 2007.
HUSSERL E., Ideen zu einer reinen Phänomenologie und
phänomenologischen Philosophie (1959), Trad. it., Idee per una
fenomenologia pura, Einaudi, Torino, 1969.
ID., Die Krisis der europaischen Wissenschaften und die
transzendentale Phänomenologie (1959). Trad. it., La crisi delle scienze
europee e la fenomenologia trascendentale, Il saggiatore, Milano, 1968.
INVITTO G., Esistenza/ Estetica, Capone, Cavallino di Lecce, 1994.
ID., La tessitura di Merleau-Ponty, Mimesis, Milano, 2002
JERVIS G., Manuale critico di Psichiatria, Feltrinelli, Milano, 1975.
JASPERS K., Allgemeine Psychopathologie (1913), Trad. it.
Psicopatologia generale, Il Pensiero scientifico, Roma, 1982 .
KHUN T., La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino, Einaudi,
1969.
LONGHI L., Il segno psicopatologico, Capone, Cavallino di Lecce,
1993.
ID., Compendio di psicopatologia fenomenologica, Capone,
Cavallino di Lecce, 1995.
MAY R., L’indirizzo esistenziale. in ARIETI S., American Handbook of
Psychiatry, 1959. Trad. it., Manuale di Psichiatria, Boringhieri, Torino, 1969.
MECACCI L., Storia della psicologia del Novecento, Laterza, Bari,
1999.
MICHIELIN P., Prove d’efficacia e linee guida per i trattamenti
psicologici e le psicoterapie, Convegno organizzato dall‟Ordine degli
Psicologi della Puglia a Bari nel 2003, in “Psicopuglia”, 2004.
MUELLER F. N., Histoire de la Psycologie, 1978, Trad. It., Storia della
Psicologia, Mondadori, Milano, 1978.
POGGIALI A., Le malie della strega, in “Psicoterapia e scienze
umane”, 2., 1979.
PACI E., Prefazione, in HUSSERL E., La crisi delle scienze europee e
la fenomenologia trascendentale, cit.
SCIOMMERI R., Seminari, Armando, Roma, 1976.
SVEVO I., La coscienza di Zeno, Milano, Dall‟Oglio, 1938.
TARANTINO F., La critica di Svevo a S. Freud, in “Folia
neuropsichiatrica”, XXIII, 1980, fascicolo I-IV.
ID., La psicoterapia ipnotica nel trattamento dell’insufficienza
mentale, in “Rivista Italiana di Ipnosi clinica e sperimentale”, giugno 1991.
115
115
ID., Psicologia dell’educazione e psicoterapia infantile. Esperienze e
ricerche, Congedo, Galatina, 1993.
ID.,Tossicomanie ed esistenza. Aspetti psicologici e psicoterapeutici,
Capone, Cavallino di Lecce, 1995.
ID., Il contributo della fenomenologia nella diagnosi psicologica, in
“AUPI Notizie”,. 2-3, 1996.
ID., La psicoterapia ipnotica nella prospettiva fenomenologicoesistenziale. Casi clinici, in “Rivista Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ipnotica”,
XX, .4, 2000.
ID., Fondamenti fenomenologici nella psicoterapia ipnotica neoericksoniana”, in Ipnosi del 2000: il pensiero di Milton Erickson e dei neoericksoniani. Costruire ponti di comprensione verso il futuro, XII Congresso
Nazionale, Milano, 2001.
ID., Nuove Frontiere in psicoterapia ipnotica. La prospettiva
fenomenologico- esistenziale, Amisi, Milano, 2004.
ID., Il disagio esistenziale dei minori nell’evoluzione delle
tossicomanie: prospettive e proposte, in “Voci di strada“, XVI, 3, 2004.
ID., Devianze e tossicodipendenze giovanili in una prospettiva
esistenziale, in “Voci di strada“, XVII, 1, 2005.
ID., Meccanismi psicologici delle tossicodipendenze, in “Mission“, 23,
2007.
ID., Esistenze artificiali ed addictions, in “Psicopuglia“, 6, 2008.
ID., Di Petta e la gruppoanalisi dell’esserci nella cura delle
tossicomanie. La prospettiva fenomenologica ad alzo zero, in “Comprendre“,
15, 2005.
ID., Addiction ed approccio evolutivo-esistenziale, in “Asclepliadi“,
VII, 14, 2008.
ID., La psicoterapia nella prospettiva fenomenologico-esistenziale,
“PsicoPuglia“, n. 11, 2009.
VAN DEN BERG, Fenomenologia e Psichiatria, Bompiani, Roma,
1961.
WATZLAWICK P, BEAVIN J. H., DON JACKSON D., Pragmatic of human
comunication, 1967, Trad. it.: Pragmatica della comunicazione umana,
Astrolabio, Roma, 1971.
116
116
La discussione sul concetto di riconoscimento ha generato anche
una serie di equivoci che rischiano di annacquare il significato del pensiero di
Honneth. Il senso del volume che presentiamo - A. Honneth, Capitalismo e
riconoscimento, trad. it. di Marco Solinas, Firenze, Firenze University Press
2010, che è una raccolta di saggi di Honneth, per la prima volta tradotti in
italiano e riuniti dal curatore sotto il titolo di Capitalismo e riconoscimento, è
proprio quello di non disperdere il potenziale critico della teoria del
riconoscimento. Nel testo, nonostante la sua discontinuità, sono riconoscibili
due direttrici: da un lato l‟autore si misura ripetutamente con il compito di
giungere ad una definizione sufficientemente precisa del concetto, tale da
sfuggire al rischio di un suo uso improprio (capitoli I, II e V); dall‟altro si
impegna nell‟analisi del determinato rapporto tra socializzazione ed
individualizzazione, tra riproduzione sociale e formazione dell‟identità
individuale che viene a crearsi nell‟epoca del “capitalismo reticolare” (III e IV
capitolo). Il titolo scelto privilegia questa seconda linea di riflessioni e da essa
partiremo.
Nei capitoli III (“Autorealizzazione organizzata. Paradossi della
individualizzazione” ) e IV (“Paradossi del capitalismo”, scritto insieme a
Martin Hartmann) Axel Honneth spinge a fondo l‟analisi sociologica delle
contraddizioni indotte dal neoliberismo sulla vita individuale attraverso lo
strumento del paradosso, mostrando che le contraddizioni di origine
economica, traslate nelle sfere non economiche, si rovesciano in esiti
paradossali sul processo di autorealizzazione. La tesi fondamentale del libro
consiste nell‟affermare che l‟individualizzazione ha perduto quel carattere di
crescita dell‟autonomia che aveva nel passato, grazie al quale aveva assunto
anche un valore critico verso l‟ordine costituito, ma si sta rovesciando in un
sistema istituzionalizzato di attese che, da un lato, alimenta il mercato e,
dall‟altro, genera un senso di vuoto interiore e di inutilità personale. L‟analisi
procede tenendo come riferimento la fenomenologia dell‟individualizzazione
descritta da Georg Simmel (Individualismus, 1917), secondo cui questo
processo era accompagnato da una crescente differenziazione dei percorsi
di vita, da un sempre maggiore isolamento degli attori sociali, dall‟aumento
delle facoltà riflessive e dalla crescita dell‟autenticità dei singoli. Se non c‟è
dubbio che il fondamento su cui è cresciuta, nella “età socialdemocratica”, la
conquista dell‟autonomia è stata la soddisfazione dei bisogni materiali, è
*
Docente di Filosofia e Storia.
117
RESOCONTI
FORME DEL RICONOSCIMENTO E TEORIA CRITICA.
A PROPOSITO DI AXEL HONNETH
*
di Roberto Pettenati
117
anche vero che questa tendenza ha assunto oggi un valore diverso, come se
fosse necessario per l‟individuo compensare attraverso l‟acquisto compulsivo
di beni di consumo una carenza di modelli culturali e significati alternativi che
dovrebbero far parte del mondo della vita. La soddisfazione dei bisogni
materiali è stato anche il terreno preferito del consumismo, sul quale il
mercato ha continuato ad agire creando le nuove dipendenze dal superfluo,
da prodotti che sono in grado di restituire una qualche gioia di vivere a
persone che l‟hanno perduta. Il sogno romantico di costruire la propria
biografia come un percorso sperimentale di autorealizzazione si è
trasformato in quell‟individualismo edonistico che è oggi uno dei fattori
principali per orientare il mercato e la produzione. La ricerca di uno stile di
vita inconfondibile (l‟aspirazione romantica) ha innescato una spirale tra stili
di vita originali e offerte pubblicitarie che li sfruttano, riproponendoli come
modelli apprezzati socialmente e quindi persuasivi a livello subliminale,
specie per le giovani generazioni.
La ricerca della autorealizzazione individuale viene sfruttata come
l‟ultima e la più efficace forza produttiva poiché lega a sé direttamente i
soggetti nella fase della loro formazione, quindi senza che possano disporre
di una coscienza critica di fronte a modelli contraffatti: l‟emancipazione
individuale che in passato era una conquista, o comunque una richiesta
interna, del soggetto diventa oggi una richiesta esterna, un obbligo che
genera a sua volta forme di disagio di fronte alla fatica di essere originali ad
ogni costo. L‟ampliamento degli orizzonti esistenziali in cui sperimentare se
stessi, che si può anche descrivere come sradicamento, sta sicuramente
all‟origine dell‟acutizzarsi delle crisi adolescenziali. La paradossalità della
situazione consiste nel rovesciamento degli ideali in obblighi e nella fine di
ogni individualismo autentico proprio nell‟epoca che ne fa la sua bandiera:
esito paradossale generato dal fatto che la lotta per il riconoscimento delle
individualità avviene sullo sfondo delle trasformazioni indotte dalla rivoluzione
neoliberale. Lo spirito del neocapitalismo, infatti, vuole l‟anima del lavoratore,
cioè la condivisione degli obiettivi e la dedizione personale ad essi, secondo
dinamiche già sperimentate dalla manipolazione totalitaria delle masse.
Lungo questa strada si perdono i confini tra sfera pubblico-professionale e
sfera privata: l‟individualizzazione creata dal neoliberismo è connotata da una
richiesta di totale flessibilità della vita privata rispetto alle esigenze
dell‟impresa e degli investimenti in cui è impegnata, addirittura da una
richiesta di creatività nel senso di dover mobilitare tutte le energie di cui si è
dotati per scovare nuove soluzioni; il dipendente deve avere un completo
coinvolgimento emotivo e motivazionale verso gli obiettivi dell‟impresa
sacrificando ogni altra dimensione di sé.
118
118
Senza seguire tutti passaggi del discorso, ci trasferiamo sul piano
categoriale per delineare rapidamente le principali questioni affrontate.
All‟inizio del volume è posto il saggio “Riconoscimento e riproduzione sociale”
in cui Honneth affronta il nodo del rapporto tra conflitti redistributivi e conflitti
identitari secondo la distinzione operata da Nancy Fraser per cui alla fase
delle lotte per il controllo dei beni e dei mezzi di produzione sarebbe
subentrata una serie di conflitti di natura diversa, quella per l‟affermazione
dell‟identità di gruppi e/o movimenti; il legame tra i primi e i secondi risulta
così scisso in modo da rendere i conflitti per il riconoscimento un fatto
essenzialmente culturale, generato da differenze di valori, rispetto alle lotte
secolari dei lavoratori e dei popoli del Terzo Mondo. Honneth rifiuta
decisamente questa distinzione netta: storicamente i movimenti di liberazione
coloniale e dei lavoratori erano sia lotte per il controllo delle risorse sia
affermazione della volontà di costituirsi come soggetti politici indipendenti.
Infatti le rivendicazioni ad una maggiore giustizia sociale nascono tanto dalle
implicazioni normative dell‟uguaglianza di diritto (ai membri di uno stato
democratico viene promesso un trattamento egualitario) quanto dall‟idea che
ogni individuo, in una società democratica, debba avere la possibilità di
essere stimato socialmente per le sue prestazioni.
Le regole sociali della redistribuzione non possono essere ricondotte
semplicemente ai rapporti di produzione: in realtà “sono sempre delle lotte
simboliche sulla legittimità del dispositivo socio-culturale che fissa il valore di
occupazioni, qualità e contributi sociali. Ne consegue che la lotta
redistributiva stessa, di contro a quanto sostenuto da Nancy Fraser, è
sempre ancorata ad una lotta per il riconoscimento” (p.18). Chiarito che le
lotte per il controllo delle risorse rientrano pienamente nella categoria di
conflitti per il riconoscimento, Honneth affronta, nel secondo saggio (“Lavoro
e riconoscimento”), il limite più evidente delle versioni in chiave puramente
identitaria-culturale della teoria, vale a dire la rinuncia a difendere una
qualsiasi concezione emancipativa ed umanizzante del lavoro; lavoro che
nell‟epoca moderna è sempre stato il medium fondamentale dell‟integrazione
e dei diritti. La teoria critica della società vive oggi una grande difficoltà ad
affrontare gli sviluppi attuali del sistema di produzione e la posizione
determinata che gli uomini vanno ad occupare al suo interno: “la distanza tra
le esperienze del mondo della vita sociale e i temi della riflessione negli studi
sociali verosimilmente non è mai stata tanto ampia quanto oggi: mentre in
questi ultimi il concetto di lavoro sociale non riveste più un significato
prioritario, attorno ad esso ruotano invece, ancor più che in passato, le
necessità, le paure, le speranze dei soggetti interessati” (p. 20). Né per
Honneth vale rifugiarsi in una critica esterna al mercato globale, magari
ispirandosi alle riflessioni di Richard Sennett in The Craftsman (2008, trad. it.
119
119
L’uomo artigiano, Feltrinelli): anche riconoscendo il valore del recupero
dell‟attività manuale per la formazione umana, la debolezza di queste
posizioni sta nel fatto che l‟arte e l‟artigianato oggi sono marginali per la
riproduzione sociale. Occorre piuttosto sviluppare la „critica immanente‟ al
sistema economico, richiamandosi a quelle norme morali che sono implicite
nello scambio sociale di prestazioni e mostrare così gli aspetti paradossali
del mercato rispetto al tema dell‟autorealizzazione individuale.
Il mercato e l‟organizzazione del lavoro non possono venir
considerati solo nella prospettiva dell‟efficienza economica: in esse si gioca
la vita degli individui, in un sistema di aspettative implicite (ad esempio, la
legittima pretesa di dare un contributo alla cooperazione sociale e di
conquistarsi perciò una autonomia personale); in altri termini deve consentire
alle persone di entrare a far parte della cooperazione attraverso cui il sistema
si riproduce, e in questa prospettiva emergono le norme morali in esso
implicite. Per svolgere questo ruolo di integrazione sociale il mercato deve
soddisfare alcune condizioni: anzitutto offrire a tutti la possibilità di un lavoro
in grado di garantire l‟autonomia personale; poi fare in modo che gli individui
dispongano di un‟occupazione stimata pubblicamente; renderli consapevoli
della dignità del proprio contributo al benessere collettivo; rendere
trasparente il sistema delle ricompense sulla base dell‟importanza delle
funzioni svolte. La critica immanente ci pone così dinanzi alle domande
radicali: veramente il mercato è in grado di integrare progressivamente le
persone nello scambio sociale? Davvero il capitalismo neoliberista è in grado
di garantire ad un numero sempre maggiore di persone la libertà e
l‟autorealizzazione? A quale genere di riconoscimento possono aspirare i
giovani, dato il carattere strutturale e non più congiunturale, della crisi
dell‟occupazione?
Nell‟ultimo saggio (“Riconoscimento come ideologia”) Honneth
prende spunto da una riflessione di Althusser, formulata peraltro in un
contesto discorsivo del tutto diverso, con cui si attribuiva al riconoscimento
una funzione ideologica come meccanismo gratificante all‟interno di un
sistema: si pone perciò il problema di indicare le condizioni nelle quali la lotta
per il riconoscimento mantenga il suo potenziale critico verso le pratiche del
dominio e giustifichi normativamente forme di resistenza. La sfida è
impegnativa poiché gli individui si muovono sempre all‟interno di un sistema
culturale che prevede sempre forme di pubblica valutazione dell‟agire,
fondamentali per la costruzione dell‟identità. Come distinguere, anche in
epoche passate, le forme ideologiche del riconoscimento da quelle motivate
da un‟esigenza morale universalizzabile? Honneth crede di poter individuare
alcune condizioni storiche: ad esempio, una forma di riconoscimento è falsa
quando la maggior parte dei soggetti coinvolti si ribella apertamente contro di
120
120
essa. Ma può accadere che una forma di riconoscimento possieda una
certa credibilità, come avviene quando la rivoluzione neoliberale definisce i
lavoratori dipendenti come imprenditori di se stessi, in quanto suggerisce una
prospettiva allettante. Tali forme ideologiche però si scontrano con un limite
oggettivo, con il loro deficit strutturale: sono impossibilitate a mantenere le
promesse. In altre parole si spalanca un abisso tra le forme di riconoscimento
promesse e le soddisfazioni realmente ottenute. Il criterio di cui disponiamo
è verificare se e quanto le condizioni materiali, istituzionali e giuridiche dei
soggetti riconosciuti mutano nel senso desiderato: mentre le forme
ideologiche di riconoscimento soddisfano soltanto la condizione di migliorare
l‟autostima (per ciò è sufficiente l‟immaginario), ma non quella di
cambiamento materiale, le forme autentiche dovrebbero soddisfare sia la
condizione di una migliore autostima sia quella di produrre nello stesso
tempo una trasformazione reale dei rapporti intersoggettivi.
121
121
CHIARA ZAMBONI E IL PENSIERO IN PRESENZA
*
di Stefania Macaluso
Chiara Zamboni esplicita nell‟introduzione di Pensare in presenza.
Conversazioni, luoghi, improvvisazioni (Liguori, Napoli 2009, pp. 185)
l‟intento di questa sua pubblicazione: “Ho scritto questo libro perché volevo
sapere quali pratiche fossero all‟opera nel ragionare con altri e nel pensare in
presenza “.
Il testo si presenta come un‟articolata disamina dell‟incontro
intersoggettivo che genera pensiero autorevole, condizione che si verifica
quando si mette in circolo energia riflessiva in grado di attivare contatti
spirituali, di cogliere significati arricchenti. Il ritrovarsi insieme per discutere
secondo tali modalità, origina scambio cognitivo, apertura veritativa,
confronto creativo, piuttosto che dialettica sofistica, potere della parola,
scontro conflittuale.
L‟Autrice analizza le peculiarità di questa pratica positiva, cioè
incarnata e vissuta, attraverso percorsi trasversali storico-filosofici a partire
da incisivi contributi di diversi autori ed autrici sulla relazione dialogica come
pratica filosofica. Viene chiarita anche la finalità del discorso ragionato in
presenza che consiste nel “dare parola” alle interrogazioni ineludibili del
pensare, non per la pretesa di risolvere le questioni ma gli esseri umani,
perché “in quanto mancanti e imperfetti, hanno bisogno del discorso di altri
esseri umani” (p. 28). La stessa Zamboni ha appreso tale pratica dagli
“scambi tra donne in presenza” finalizzati a liberare la forza riflessiva delle
donne desiderose di mettere in discussione il “simbolico dominante”,
esperienza inaugurata dalla rivoluzione femminista con lo scopo di
reinterpretare il pensiero egemone, ed elevata a metodo di lavoro all‟interno
della comunità di filosofia femminile di Diotima della quale l‟Autrice fa parte.
Docente di Filosofia del linguaggio, Chiara Zamboni, nella prima
parte del testo, “Le forme dello spazio vivo di pensiero”, individua
nell‟aderenza personale al linguaggio, una peculiarità del genere femminile
che fa del pensare in presenza una performance, un mettersi in gioco
secondo una reciprocità carica di efficacia creativa del sé e significativa del
reale. L‟aderenza del linguaggio all‟essere, la corrispondenza tra la realtà del
vivere e la ricerca del senso della vita, la coerenza tra il desiderio di pensiero
e il desiderio di verità senza pretesa di possesso, conferiscono autorità alla
discussione filosofica che scaturisce dall‟armonia tra l‟io pensante e l‟io
biografico nel suo darsi agli altri in modo reale, incarnato, sessuato. Il
pensiero in presenza non teme l‟andamento dialogico privo di premesse
*
Dottore di ricerca di Filosofia.
122
122
apodittiche; è aperto piuttosto al disvelarsi intuitivo della verità all‟intelligenza
la quale procede nella sofferta tensione dello stare in paziente attesa pur di
fronte allo scacco della contraddizione, all‟ambiguità degli abbozzi intuitivi,
all‟impossibilità di trarre dal confronto orale una sintesi definitoria. L‟Autrice
avverte che il rischio di un tale scacco è in realtà ciò che dà valore alla
discussione perché garantisce l‟originalità e la creatività da “pratiche
filosofiche positiviste” che sclerotizzano il pensiero in reiterazioni dommatiche
e lo irrigidiscono nella reificazione della realtà.
Il pensare in presenza è un “ruminare in silenzio” che apre alla verità
implicita, mette in comunicazione spirituale i corpi, accende la possibilità di
riconoscere le “parole vere dette da altri”, fa dell‟ascolto un passaggio
comunicativo che sprigiona il “potenziale di verità” presente nelle parole ma
anche in certi silenzi che penetrano tutto l‟essere al di là delle intelligenze.
L‟Autrice analizza vari contesti del dialogo in presenza, mettendo in
luce il valore filosofico del linguaggio orale comune, il quale, come il
linguaggio di scrittura, sebbene in forme diverse, è dotato di articolazione
retorica; inoltre sfata l‟assunto che fa corrispondere la complessità retorica
del linguaggio alla comprensione della realtà. Lo scambio orale in presenza
viene colto come reciprocità tra i soggetti in dialogo sui temi oggetto di
riflessione, una “contrattazione implicita” che può fare a meno della
mediazione esplicita del linguaggio. L‟Autrice passa in rassegna le varie
figure retoriche del discorso in presenza, per esempio quella dell‟allusione la
cui forza evocativa travalica l‟esigenza descrittiva o definitoria, poiché il
vissuto concreto della realtà passa attraverso la parola che narra esperienze
la cui realtà è comunicata prima che spiegata: la presenza stessa autorizza
la narrazione allusiva, frammentaria, efficacemente evocativa.
Pensare in presenza secondo le regole dell‟ascolto, dell‟attenzione,
della stima e della fiducia reciproche, crea uno scambio comunicativo che va
al di là dell‟esplicitazione del pensiero stesso. Il vissuto che comprova tale
modalità di “incontro” è quello dell‟empatia il cui concetto l‟Autrice estende
oltre quello di “esperienza di un vissuto che è dell‟altro” riferendolo “anche
alla capacità di cogliere l‟intenzione significante che guida il discorso
dell‟altro” (p. 61).
Nei dialoghi platonici Chiara Zamboni indica il modello di retorica
della persuasione che qualifica il discutere in presenza quale via filosofica
orientata verso la verità, meta di un procedere dialettico che non esaurisce il
proprio percorso. Lo stile del persuadere è quello maieutico che presuppone
una tensione d‟eros verso la verità, esercizio dell‟arte di dialogare con altri
che crea comunità di pensiero. La persuasione è sorgiva quando è aperta
all‟incontro fiducioso, quando è pura, libera da ogni ansia di convincimento,
aperta al disvelamento a noi dell‟altro e di noi stessi, diversamente dalla
123
123
“falsa persuasione” a cui induce il tecnicismo dell‟argomentare e la retorica
formalizzata. A questo proposito la differenza di genere nel propendere verso
l‟una o l‟altra forma di “persuasione” costituisce un interessante paradigma
che Zamboni frequentemente ripropone per focalizzare la novità di un fare
filosofico con cui vale la pena confrontarsi per illuminare una modalità che
non è affatto nuova ma piuttosto affonda le radici nella filosofia antica e che
tuttavia nel corso dei secoli ha finito per rimanere adombrata
dall‟istituzionalizzarsi di altre posture filosofiche. Il pensiero maschile,
genericamente inteso ma non necessariamente attribuibile a tutti gli uomini,
assume la coincidenza parmenidea tra pensare ed essere quale esito
dell‟azione formale del pensiero che sola può garantire l‟accesso alla verità.
In modo collaterale piuttosto che contraddittorio, l‟argomentare dialogico che
tendenzialmente è proprio delle donne, si pone al di là della comprensione
intellettuale solipsistica della verità, scopre e gusta la rivelazione di una forza
trasformatrice intrinseca al rapporto di fiducia che si stabilisce nella stessa
relazione tra dialoganti, per il solo fatto di pensare in presenza accomunati
dallo stesso desiderio di verità.
Nella seconda parte del volume l‟Autrice abbandona l‟analisi
trasversale storico-filosofica per scendere nelle profondità del “sentimento
della presenza”. La presenza umana possiede una tipicità ben distinta da
quella cosale: è coinvolgimento corporeo che crea legami invisibili di natura
affettivo-spirituale che s‟intersecano in una complessità che né il linguaggio
né la percezione possono portare ad evidenza. L‟Autrice, arricchendo ancora
la sua analisi con citazioni autorevoli, focalizza tale complessità della
relazionalità umana nell‟intrecciarsi del misterioso gioco tra le molteplici
componenti consce e inconsce, psichiche e sensoriali, corporee e spirituali.
Infinite connessioni non delimitabili di legami intersoggettivi attraversano gli
spazi e i tempi della storia di ciascun io e fondano i dinamismi di
trasformazione che la relazione implica.
L‟analisi dell‟ontologia relazionale così condotta da Chiara Zamboni,
include, oltre alla relazione io-tu, quella col divino la cui presenza
trasformatrice si rivela nello stesso logos filosofico.
L‟Autrice passa infine a considerare altre forme di pratica relazionale
come quelle psicanalitica e teatrale per ampliare ancora la prospettiva ai
luoghi del discutere, mettendo in luce come lo spazio stabilisca la possibilità
stessa della coesistenza relazionale. L‟ordine delle relazioni che si pone tra
le cose e le persone che abitano i luoghi del nostro stare, provoca una
“risonanza d‟anima”: l‟architettura della casa ne diventa una metafora.
Il percorso di C. Zamboni nell‟universo della relazione
intersoggettiva, al fine di comprendere lo specifico del pensare in presenza,
si conclude con una sorprendente connessione di natura estetica: il
124
124
godimento della presenza giova alla politica. La tesi non poteva che essere
proposta da una donna filosofa impegnata a cercare la verità in un pensare
politico, cioè carico di efficacia rappresentativa del bello e del buono, tale da
costituire forza trasformatrice. La sintesi è tanto sorprendente quanto
coerente e la stessa Autrice ne attribuisce la matrice alla modalità
rivoluzionaria con cui il femminismo ha riproposto il passaggio ontologico tra
il pensare l‟essere come oggetto e il mettere la soggettività di chi pensa al
centro del pensare stesso. La relazione intersoggettiva implica la piacevole
percezione
dell‟altro
come
trascendenza.
Tale
riconoscimento
dell‟irriducibilità dell‟altro che non ammette esercizio alcuno di dominio, rivela
un godimento d‟essere, un piacere contemplativo verso cui è maggiormente
sensibile il genere femminile, rispetto al “sapere simbolico fallico” che aspira
a codificarsi in un linguaggio regolato e controllabile che soddisfa lo spirito di
appropriazione.
La conclusione alla quale ci conduce l‟Autrice è che solo la relazione
aperta all‟alterità, come il caso dei legami singolari che le donne sanno
creare, può costituire un “movimento metonimico di contatto e di
compresenza” (p. 166) tale da proiettarci verso la pratica politica tesa a
tradurre il pensare in presenza in azione trasformatrice.
125
125
BURKE E L’INDIA
*
di Paolo Armellini
La questione del rapporto tra cultura e istituzioni indiane con il
modello costituzionale inglese alla fine del „700 costituisce un tema di grande
interesse per il pensiero politico. Se ne è interessata Donatella Buonfiglio che
ha dedicato il suo libro a La questione indiana nel pensiero politico di
Edmund Burke (FrancoAngeli, Milano 2008, collana del Dipartimento di Studi
politici, Facoltà di Scienze politiche, Sapienza - Università di Roma), il quale
presenta caratteri di approfondimento riguardo ad uno degli aspetti meno
conosciuti del pensiero di Burke, cioè il rapporto tra il costituzionalismo
britannico e la civiltà indiana, attraverso la polemica condotta contro W.
Hastings lungo l‟arco di un ventennio di discorsi parlamentari. Tale questione
è stata tra l‟altro poco affrontata negli studi italiani su Burke, se si esclude la
pubblicazione ora di E. Burke, Scritti sull’Impero (a cura di Abbatista, UTET,
Torino 2009). Orientandosi con spiccato senso storico fra una gran messe di
saggi e scritti e valutando con perizia le diverse ma frammentarie
interpretazioni offerte dalla critica al problema indiano in Burke, l‟autrice ha
condotto uno studio che si può ritenere uno dei più aggiornati e sistematici
sul tema. La tesi è corredata da un articolato quadro storico, che riguarda sia
la situazione inglese che quella indiana. Ciò permette al lettore di stabilire un
contatto coi diversi eventi che hanno contraddistinto un‟epoca complessa
come quella della colonizzazione britannica dell‟India, paese che al suo
interno presenta diversi orientamenti culturali e religiosi e una complessa
struttura istituzionale.
Ciò ha spinto l‟autrice ad elaborare una nozione di civiltà che ha un
carattere dinamico e non statico, per poter dar conto della insufficienza della
categoria di dispotismo, derivante per lo più da Montesquieu, che, applicato
al mondo orientale e in modo specifico all‟India da molta cultura dell‟epoca,
ha finito per giustificare da parte di W. Hastings, per esempio, l‟utilizzo di
metodi tirannici nei confronti delle autorità e delle popolazioni indiane durante
il suo periodo di potere.
Oltre a offrire un corretto quadro storico e filologico, Donatella
Buonfiglio cerca di cogliere il nesso tra la lunga storia della questione indiana
e gli altri molteplici temi che accompagnano la produzione burkeana volta a
difendere la peculiarità della storia inglese nel periodo delle rivoluzioni
settecentesche, evitando tentativi di frazionarne gli aspetti, ma cercando di
offrire una visione organica del suo pensiero. La questione dei diritti dei
coloni americani e degli irlandesi come anche la difesa delle popolazioni
*
Ricercatore in Storia delle Dottrine Politiche presso l‟Università La Sapienza, Roma.
126
126
indiane vanno cioè poste in relazione al problema della natura umana e della
sua piena realizzazione nella società, attraverso il rifiuto di teorizzazioni
astratte e la convinzione che l‟ordine sociale sia garantito non soltanto
dall‟affermazione dei diritti, ma anche e soprattutto da quella saggezza
pratica sedimentata nei costumi e nella tradizione. In Burke cioè va sempre
considerato il legame che esiste nella concretezza storica fra l‟elemento
puramente razionale della natura umana e la dimensione delle passioni e dei
sentimenti, che permettono di cogliere della politica l‟aspetto per cui autorità
e libertà non si trovano disgiunte, ma trovano nei costumi e nelle istituzioni
una forma di razionalità storica capace di consegnarsi alle generazioni senza
menomare la possibilità di innovazioni dettate dalle circostanze e
dall‟attualità.
L‟asistematicità risulta coessenziale ad una mente come quella del
filosofo irlandese che rimane sempre ancorata alle circostanze e al dato
storico. Ma Donatella Buonfiglio mostra come l‟ordine dei pensieri e delle
riflessioni in Burke non si pieghi mai ad una visuale di tipo storicistico,
illustrando in modo originale che i discorsi da lui tenuti alla commissione non
si siano limitati a illustrare i rapporti fra il governo coloniale britannico e le
autorità indiane, ma si siano nutrite dei contenuti più pregnanti della sua
riflessione politica riguardo alla società, la costituzione, i diritti dei popoli e la
rappresentanza politica.
127
127
IL FONDO E LA FORMA. LA SEMIOSI, LA SEMIOTICA,L’UMANO
*
di Andrea D’Urso
L‟idea di semiotica che viene fuori dalla prospettiva di Hjelmslev,
maestro di segni danese prediletto negli studi di Cosimo Caputo, torna a fare
da pre-testo nel volume Il fondo e la forma. La semiosi, la semiotica, l’umano
(Pensa Multimedia, Lecce-Brescia 2010), che riunisce tre saggi inediti e tre
rivisitati da precedenti miscellanee. Il primo capitolo (inedito) prende il la dalla
“semiotica del non”. Si tratta della riapertura del discorso sulla sub-logica del
linguaggio, già discussa dal nostro autore in Semiotica e linguistica (2006) e
in Hjelmslev e la semiotica (2010), entrambi editi da Carocci. L‟opposizione
non esclusiva, bensì dialettico-dialogica, tra intensivo ed estensivo sostenuta
da Hjelmslev – per il quale il primo termine è sempre una specificazione
restrittiva del secondo che in sé lo include come possibilità – è ora applicata
alle distinzioni già discusse da Rossi-Landi, qui esplicitamente citato da
Caputo, tra segnico e non segnico, e alle sottocategorie che ne conseguono:
segnico-comunicativo e non segnico-comunicativo; segnico-comunicativo
verbale e segnico-comunicativo non verbale. Il lettore, soprattutto il meno
specialista, noterà perciò di trovarsi immediatamente proiettato nell‟articolata
terminologia hjelmsleviana, ampiamente illustrata nella coeva monografia
succitata.
Il rapporto dialettico e di possibilità – termine trascurato ma forse
appropriato sarebbe quello d‟interpenetrazione – che sussiste tra il segnico e
il non segnico (o ciò che Rossi-Landi definiva il “residuo corporale dei
messaggi non-verbali”) permette a Caputo non solo di riprendere il discorso
sulla molteplice messa in forma della materia (materia signata), disquisito in
altri suoi studi, e rimarcare la simultanea compresenza nell‟uomo delle
corporeità (o materialità) semiosica e semiotica, ma anche di evidenziare,
con ciò, la continuità esistente tra mondo naturale e animale e mondo
umano, per il fatto che l‟uomo è al contempo “spazio fisico che vive nel flusso
della comunicazione-vita al pari di tutte le altre corporeità viventi” e “spazio
logico per la soluzione di problemi pratici legati alla sopravvivenza sotto la
spinta problematica dell‟ambiente” (p. 40). Il salto qualitativo dell‟umano, “che
costituisce il vero vantaggio evolutivo sulle altre specie viventi” (pp. 67, 77),
*
Insegna Semiotica e Letterature comparate nella Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università di Siena
128
128
sta proprio nell‟avere, oltre alla possibilità (zoosemiosica) di comunicazione
non verbale, la capacità di “modellazione sintattica”, come la chiama Sebeok,
ossia lo hjelmsleviano “universale principio di formazione”, la saussuriana
“facoltà di linguaggio”, che poi è pure ciò che permette di assolvere le
funzioni indicate come “simbolica” da Cassirer e “metaoperativa” da Garroni
(p. 45), “e che filosoficamente possiamo anche chiamare logos”, dice Caputo
(p. 60).
È per questo che l‟uomo può essere considerato un “animale
linguistico” (p. 42) o “semiotico” (pp. 84, 101, 127) e che, seguendo una
formula di Augusto Ponzio che dà il titolo al secondo capitolo del libro, “tutto il
segnico umano è linguaggio”: esso, aggiunge Caputo, “è caratterizzato da
questo doppio livello, segnaletico e semiotico, formale e materiale, naturale e
soprattutto storico” (p. 62) che contraddistingue rispettivamente la “creatività
normalizzante o segnaletica” dei linguaggi limitati (come quello della
matematica) e la “creatività semiotica” di quelli illimitati (come le lingue
verbali). Se l‟umano “è il nodo delle relazioni vitali in cui il bíos, la materia o la
corporeità vivente prende una piega più complessa” (p. 100), ossia “è quella
forma di vita nella quale il reagire vira nel rispondere” (p. 101), non v‟è più
scissione tra semiosi e vita, semiosfera e biosfera, studio della logica del
segno o semio-logi(c)a e studio della logica della vita o bio-logi(c)a: la
semiotica diventa pertanto una bio-semio-antropo-logi(c)a che tiene cioè
conto tanto dei tratti della semiosi prettamente umani e sociali quanto di
quelli animali e in comune col resto del vivente (cfr. pp. 74-75, 77). “La
scienza dei segni è intrinseca alla scienza della vita”, riassume dunque
Caputo con Sebeok (p. 110). “La questione del segno mette in campo […] la
questione della relazione. […] La relazione in tutte le sue declinazioni è la
condizione della vita in tutte le sue forme, da quelle più elementari e semplici
a quelle più complesse e astratte della metacultura” (p. 115). Ecco allora che
le radici della semiotica possono essere individuate nella semeiotica: “di
conseguenza la storia della semiotica può cominciare, come appunto fa
Sebeok, con l‟antica medicina e con Ippocrate, con le pratiche magiche,
fisiognomiche, astrologiche, anziché con le prime riflessioni sulle lingue
verbali o storico-naturali” (p. 111).
Proprio dopo un excursus storiografico sulle filosofie del segno
succedutesi da Aristotele a Bacone, da Ockham a Cartesio, da Locke a
Leibniz, Caputo discute l‟approccio logico-filosofico di Jean Poinsot e quello
medico-magico di Giovan Battista Della Porta, rispettivamente nei capitoli
quinto (inedito) e sesto. Per limiti di spazio, lasciamo al lettore la ricerca di
quel che può avere di peculiare il Tractatus de signis (1632) del frate
domenicano Giovanni di San Tommaso (al secolo Jean Poinsot) rispetto
all‟aristotelismo tomistico, e di cosa possa ricavare la semiotica su questa
129
129
scia, prolungata da Locke e Peirce, nell‟essere considerata un altro nome
della Logica, “nel senso in cui la intendevano gli Antichi, ossia facoltà di
ragionamento, o di pensiero” (p. 116), soprattutto se tale ars logica è quella
di un futuro censore dell‟Indice dei libri proibiti della Santa Inquisizione. In
questa lista nera era già finito Della Porta, col cui De humana
Physiognomonia (1586) si va ancora più indietro nel tempo e sul fronte
opposto dell‟inquisito e di una rilettura dell‟aristotelismo non proprio
“canonica”. Per quanto questa sia accattivante, specialmente nel rintracciare
i possibili rapporti tra uomo e natura in quella che Caputo definisce
“cosmosemiotica” (p. 159), le “inferenze dellaportiane”, storicamente
determinate “dal discorso sociale” dell‟epoca in cui cercano conferma (cfr. p.
181), non mancano di far presentire certi risvolti dell‟antropologia
lombrosiana…
Presagendo fin dal 1777-78 tali possibili degenerazioni, lo scienziato
gobbo, nonché aforista satirico, G. C. Lichtenberg criticava la fisiognomica
del pastore protestante J. K. Lavater, emulo svilente di Della Porta,
preferendole una meno pregiudiziosa patognomica o “semiotica degli affetti”
e immaginando una sarcastica analisi delle code (degli animali e dei
parrucconi): “Taglia pure il tuo alberello come ti pare, e pianta i tuoi fiorellini
secondo le sfumature che ti sono più comprensibili, ma non giudicare il
giardino della natura in base al tuo orticello”, scriveva mordacemente.
Insomma, rileggendo intrigantemente le categorie dellaportiane in chiave
hjelmsleviana e segnalando le affinità delle riflessioni che vanno da Della
Porta e Poinsot a Peirce e Sebeok, nel Fondo e la forma il percorso dalla
glossematica alla fisiognomica si svolge a ritroso (“dal presente verso il
passato”, scrive Caputo, per indicare la direzione della “prospettiva
storiografica”, p. 104). Se allora l‟ottica del volume può apparire retrospettiva
è forse anche perché manca di una conclusione prospettica, non però nel
senso additato da Caputo, “dal passato verso il presente”, in cui lo sguardo si
volgerebbe sempre all‟indietro; bensì dal presente verso il futuro. Compito
che l‟autore lascia al lettore. Magari, la prospettiva semiotica ci
guadagnerebbe ad aprirsi su territori che restano purtroppo solitamente
esclusi dal suo panorama. Vorremmo qui provare a suggerire qualche
esempio.
Il discorso filosofico di Garroni sull‟immagine e sul gioco del
fantasticare (cfr. cap. 2) può essere espandibile verso la poesia in base agli
apporti del XX secolo; anche la “menzogna”, nel libro discussa solo a livello
logico-filosofico (pp. 63-65), può essere vista come mistificazione del
linguaggio, cui non si esimerebbe la stessa fisiognomica: “Ogni uomo ha il
suo backside morale che non mostra se non vi è costretto e nasconde il più a
lungo possibile con i calzoni delle belle maniere”, scriveva ancora
130
130
ironicamente Lichtenberg. Nel terzo capitolo, poi, la distinzione metodologica
e ad uso analitico compiuta da Rossi-Landi tra analogia e omologia (pp. 7576) può essere riconsiderata dal punto di vista di alcuni poeti che usano i due
vocaboli come sinonimi, nonché dell‟accezione negativa che assume l‟omologo come omologazione (riconducimento del due all‟uno, sì, ma nel senso di
riduzione del molteplice all‟Unico; in altre parole: uni-formazione), e di una
valutazione positiva dell‟analogia (sovrapposizione dell‟uno – che però in
realtà è spesso un terzo dialettico, unificante ma non omologante – al due).
In fondo se, come scrive Caputo, il logos “consente dei salti, raccordando
elementi anche molto lontani” (p. 60), non è proprio grazie all‟analogia, base
peraltro presunta della fisiognomica dellaportiana? Così, il simbolo, “gloria e
fardello dell‟uomo”, osservato solo nei suoi usi comunicazionali mistificatori
(su Auschwitz, cfr. pp. 84-88), può essere scrutato sul piano poetico, su cui
maggiormente si espleta; per esempio, giusto negli anni evocati del nazismo
e contro la sua mitologia mortifera, i surrealisti lottavano per “l‟elaborazione di
un mito collettivo proprio della nostra epoca”: insomma, la distinzione rossilandiana dell‟ideologia in reazionaria e rivoluzionaria varrebbe anche
nell‟analisi socio-(semio)-logica della poesia…
Ma in semiotica si parla raramente di essa, e del sogno che talvolta
la crea giacché il sogno è, come il linguaggio, elemento antropogenico, degli
ominidi; infatti, il problema è lo stesso: se la poesia è modellazione analogica
e il sogno vi contribuisce, resterebbe sempre da capire come linguaggio e
metalinguaggio (in cui rientrano quindi anche analogia, poesia, sogno e
interpretazione del sogno) permettano di trasformare il mondo. Ora, benché
Caputo omologhi il logos, “modalità di formazione” (p. 127) nelle sue varie
definizioni suddette, alla “logica poetica” di cui parlava Vico (pp. 45, 62), la
questione non è risolta: se la logica della poesia è in realtà analogi(c)a – cioè
logica superiore o contraria, come vuole l‟etimologia, il che è di per sé
significativo – resta il problema del mutamento (quasi in senso aristotelico)
dell‟ana-logico in mero logico, e così del logos da linguaggio (come
modellazione generale) a discorso (logico), ragione (come mera razionalità).
Tale problematica non emerge nel libro, ma è implicita fin dalle pagine
introduttive che citano Locke, il quale pare ben lungi da Vico (rappresentante
della versione forte del Paradigma della sostanza), già solo per il fatto di
segnare il punto di transito tra forma debole (aristotelismo) e forma forte
(Saussure) del Paradigma dell‟arbitrarietà del segno. Del resto, la sua
distinzione tra Filosofia naturale, Semiotica ed Etica (ossia Filosofia morale),
ricorda quella di Zenone di Cizio che distingueva già tra Fisica, Logica ed
Etica. È invece un altro Zenone (di Elea), allievo di Parmenide, a riportarci al
paradigma del suo maestro, origine della onto-teo-logi(c)a metafisica, di cui
Caputo non manca giustamente di evocare i rischi (cfr. pp. 86, 122).
131
131
Dal nostro punto di vista, il fatto è quindi che c‟è sem(e)iotica e
semio(e)tica. Se l‟analisi “scientifica” serve e si asservisce alle ragioni di una
Logica e ai fini di un‟Etica prefissate, è un a priori, quindi ideo-logica, cioè
funzionale al discorso di un modello presupposto e preposto a una egemonia
socio-culturale: perciò Rossi-Landi parlava della “scienza buona mamma”.
L‟analisi materiale e materialista del segno, che è quindi una semeiotica,
dovrebbe favorire la comprensione dello stato attuale del mondo vivente o
inanimato (physis). L‟interpretazione non è certo dissociabile bensì presente
fin già dall‟intervento analitico. Ma è la valutazione o conoscenza (gnome)
dello stato delle condizioni ottenuta dall‟interpretazione dei sintomi e delle
sindromi che deve portare a una relativa legge (nomos) di comportamento
etico e azione pratica, la quale viene cioè a posteriori anziché essere posta a
monte dell‟operazione analitica come pre-giudizio, dettame da non violare,
norma cui attenersi, insomma deontologia che è appunto discorso (logos) sul
dovere (deon). Il dovere andrebbe cioè inteso non rispetto all‟obbligatorietà di
un precetto, ma semmai nel senso – che è anche direzione, che va
dall‟analisi alla condotta come risposta – di quell‟atto necessario di fronte allo
stato di cose esaminato.
Potremmo concluderne che la fisio(g)nomi(c)a, quale filosofia
naturale, non più solo viso-(g)nomica, è con ciò chiamata a superare la sfida
di quel dibattito pretestuoso e per nulla dialettico che la vuole divisa già nella
sua ambigua etimologia (cfr. p. 14), per essere invece connotata come una
fisiognomica semiotica e diventare connotante di una semiotica fisiognomica
come la chiama Caputo, ossia al contempo determinata e determinante – e
qui rischiamo la terminologia hjelmsleviana. E sempre in tal senso (e
direzione) l‟analisi sem(e)iotica può ambire a essere o mutarsi in una
semioetica, ravvisabile, come rivela l‟etimologia, quale filosofia morale del
segno e del sintomo al contempo: (semio)etica critica, senza escludere che
una critica (semio)etica, cioè filosofico(-linguistico)-morale, impregni
d‟argomentazioni teoriche l‟atto pratico suddetto. Così si cementa il rapporto
dialettico tra teoria e prassi, e tra interpretazione – che è comunque
valutazione, quindi sempre ideologica – e trasformazione della materia. Già il
poeta André Breton mise in risalto il nesso irrinunciabile tra le due nel
discorso destinato al Congresso degli scrittori per la difesa della cultura, nel
1935 a Parigi, sostenendo, contro ogni assimilazione dogmatica dell‟XI Tesi
su Feuerbach di Marx, “che l‟attività di interpretazione del mondo deve
continuare ad essere legata all‟attività di trasformazione del mondo”.
Il fondo e la forma è quindi un libro da leggere, magari in senso
inverso, per capire utilmente quali sono (e quali non sono) le basi teor-etiche,
come direbbe Caputo, da cui si potrebbe giungere a simili conclusioni.
132
132
SENTIMENTI RAGIONE FEDE
*
di Gianni Donati
Nel presentare il volume Pensieri varî di Santino Cavaciuti (Pensieri
vari: tra sentimento, ragione e fede, Le Mani, Recco – Genova 2009, pp.
260), la densa introduzione di Adriana Dentone puntualizza, come lei dice,
l‟Ontologia cristiana di Santino Cavaciuti, una specie di summa delle
riflessioni di questo filosofo, che si riferiscono cronologicamente soprattutto
agli ultimi anni e sono armonizzate sul leit-motiv del concetto di libertà, l‟idea
centrale dell‟Autore. I Pensieri sono raccolti in sei Parti dedicate ad altrettanti
problemi „fondamentali‟: estetico-linguistico, gnoseologico, ontologico,
antropologico, morale, religioso, visti nello spazio delle „sfere‟ del Sentimento,
della Ragione e della Fede. Data la dovizia di temi trattati, mi limiterò a
rilevare alcune idee tra quelle che mi paiono particolarmente significative.
Nella parte dedicata al primo problema, quello estetico-linguistico,
Cavaciuti alterna fresche visioni personali poetiche ed estetiche, annotate
nell‟età più giovane, alle complesse, ma chiaramente articolate, intuizioni
dell‟età più matura e, nella sezione di pensieri di linguistica, tratta, fra l‟altro,
della distinzione tra parola e contenuto, dell‟origine del linguaggio –
sviluppando la tesi dell‟origine “poetica” dello stesso – e va alla ricerca di
conferme (nel pensiero di autori antichi, moderni e contemporanei) di sue
proprie idee (ad es. con Leopardi sul “ruolo fondamentale delle metafore nel
processo di appercezione del reale” (p. 28). Talvolta, si limita a confutare
asserzioni di vari pensatori, spiegando, sempre garbatamente, il senso del
proprio intervento; altre volte risale alle fonti primarie di concetti espressi da
studiosi contemporanei. O ancora: questo processo a ritroso può tornare fino
alle Sacre Scritture per individuarvi espressioni a base di fondamentali
acquisizioni culturali giunte fino a noi: come quella riguardante l‟Iconografia
cristiana (p. 39) nel detto del salmista “Ostende faciem tuam et salvi erimus”.
La seconda parte, relativa al problema gnoseologico, argomenta su
Libertà e Conoscenza, sul “conoscere” proprio delle Scienze naturali e
intorno all‟idea di “verità” in rapporto all‟ “amore”. Sovente Cavaciuti prende
spunto da autori di diversa estrazione per esplicitare, però, idee non comuni,
come quella del senso ultimo delle cose, che risiede nelle Idee, le quali, a
loro volta, esistono in una Mente Infinita: ecco, allora, l‟idea del mondo quale
“ambiente” del Verbo (p. 45): se il mondo è tale (creato, cioè, proprio in
*
Insegnante di scuola primaria. Laureato in Materie Letterarie e in Pedagogia presso
l'Università di Genova, ha collaborato con le riviste "Studi Sciacchiani", "Segni e
comprensione", "Chiesa Locale" (dioc. La Spezia).
133
133
relazione al Verbo), allora ha un significato diverso da quello che si pensa
normalmente. Questa tesi, del mondo inteso appunto come “ambiente” del
Verbo, è una delle proposte più importanti tra le molte idee nuove di questo
libro e comporta necessariamente la dottrina della creazione: secondo
l‟Autore, pertanto, la creazione non solo è opera del Verbo divino, ma ne
sarebbe anche in funzione, quale “ambiente” del Verbo che si incarna.
Esplorando, poi, i modi della conoscenza, è possibile trovare
conferme al primato della libertà, un primato ontologico oltre che morale:
riconoscerlo consente di uscire sia dal solipsismo, cui giunge l‟idealismo, sia
dal monismo, cui secondo Cavaciuti giunge l‟intellettualismo: basandosi,
infatti, solo sul pensiero diventa molto difficile comprendere la pluralità
dell‟essere. Ancor più della conoscenza, a fondamento dell‟essere, e quindi
dell‟esistenza, c‟è soprattutto l‟amore, che è la “realizzazione” piena della
libertà. Questa – spiega l‟Autore – in quanto libertà “iniziale”, è destinata a
“svilupparsi”, a “maturare”, a “realizzarsi”, e la “realizzazione” della libertà è
l‟amore, poiché la libertà “iniziale” è possibilità di creatività, di donazione; e la
donazione in atto è appunto amore (p. 48).
Ben undici paragrafi costituiscono il corpus concernente il problema
ontologico (Terza Parte) che riporta riflessioni sull‟essere, su libertà ed
essere, su essere e “possibilità”, sulla “libertà”, sull‟essere del Mondo, sulla
Bellezza, la Molteplicità, lo Spirito, l‟Eternità, la Relazione, il “caso”. In queste
pagine si arriva al nucleo del pensiero cavaciutiano: il dinamismo ontologico
che scaturisce dal ”primato” della libertà comporta la concezione dell‟ essere
come essenzialmente creante. Connessa con il dinamismo ontologico è
quella che l‟Autore chiama “vocazione”, “chiamata”. È questa un‟altra tesi
caratteristica e nuova: la libertà “iniziale”, in quanto possibilità di donazione,
di creatività, avverte, come tale, in se stessa un‟innata vocazione a realizzare
questa sua possibilità. Nella misura in cui la libertà ascolta la propria
“vocazione”, si attua, assieme alla posizione in essere di nuove entità, la
“realizzazione” della libertà e, con essa, l‟amore e il bene (morale); nella
misura in cui, invece, la volontà non ascolta la propria vocazione, si ha il
“rifiuto” dell‟essere, e, con esso, il male (morale). Nel prosieguo della Terza
Parte si ha un susseguirsi di riscontri còlti nelle tesi di vari Autori, che il
Nostro commenta dimostrando l‟aderenza, ora totale ora parziale, con le
proprie idee di fondo. Così per Marcel, Rigobello, Pareyson e altri. Cavaciuti,
inoltre, sostiene come al fondo dell‟essere non vi sia il determinismo, ma la
libertà, e parla di una certa “trinità”, riscontrabile nell‟essere quale libertà,
data dalla libertà come possibilità; quindi dalla “vocazione” della stessa
libertà; infine dal “frutto” della libertà, cioè dal ”nuovo” che essa pone in
essere. Questa “trinità” dell‟ essere-libertà potrebbe ritenersi, secondo
l‟Autore, come, una “traduzione” del Mistero Trinitario. Nella sezione
134
134
Sull‟“essere” del mondo spunta nuovamente l‟idea del mondo quale
“ambiente” del Verbo incarnato, e, naturalmente, il discorso si sofferma sul
principio creazionistico. Cavaciuti propone una revisione del concetto di
creatio ex nihilo, un principio – si legge, infatti, a pag. 99 – forse “non del tutto
esatto, in quanto ritengo che il mondo sia, in realtà, una “riproduzione” – se
così si può dire – delle qualità, o almeno di certe qualità del Verbo, in
particolare della sua “bellezza”“. La sezione comporta anche altri numerosi
temi e tesi. Fra essi mi limito a segnalare: l‟idea di bellezza come “annuncio”
dell‟amore; la molteplicità del reale, giustificata dalla libertà in quanto
“creatività”); la tesi dell‟eternità divina come animata da un certo dinamismo
qual è quello dell‟amore; l‟idea dell‟essere come relazione, sulla base
dell‟idea dell‟essere come amore; la critica del casualismo, in quanto
intrinsecamente autocontraddittorio.
Le sezioni Pensieri genericamente antropologici, Sulla Corporeità,
Pensieri di carattere sociologico, Sulla Storia e la Filosofia, Sull’Alterità,
formano la Parte Quarta, dedicata al problema antropologico. Cavaciuti
accosta l‟espressione di J. Ratzinger, dell‟uomo come essere in fieri, tratta
dal libro Introduzione al Cristianesimo, alla sua tesi che, come detto, vede
l‟uomo come un “invitato” a “realizzarsi” (p. 116). L‟Autore mette, poi, in
guardia da certe concezioni antropologiche miranti a risolvere tutto nella
dimensione temporale (vedasi la cosiddetta “donazione degli organi”) in
un‟ottica di riduzione del corpo a cosa (p. 124). E a proposito di corporeità,
nelle pagine che seguono, si ribadisce un aspetto che caratterizza l‟uomo:
quello di essere usufruttuario e non padrone del proprio corpo. I „pensieri‟ di
tipo sociologico commentano anche tematiche attuali: tra queste, i
“mascheramenti” politici nel dare nuove connotazioni ai vari movimenti.
Cavaciuti denuncia, inoltre, la crisi di certi valori che hanno fatto la civiltà:
crisi del matrimonio, della famiglia, della religiosità, citando il verso del
Foscolo “Dal dì che nozze, tribunali ed are”, un “trinomio” di cui oggi rimane
efficiente solo quello dei “tribunali”.
I tre paragrafi della quinta parte accorpano le osservazioni relative al
problema morale: Morale e libertà, Sull’amore, Sul Male. Cavaciuti presenta il
problema del male, forse “il più grave” − dice – della Teologia e della filosofia.
La sua interpretazione riprende il concetto di possibilità insita nella libertà,
cosicché la sezione Sul Male inizia trattando della “possibilità” del male
stesso, “possibilità” presente nella libertà come tale. Tratta, quindi, del
concetto di “invito” a passare dalla “possibilità” alla sua realizzazione, con la
connessa conseguenza di accoglimento e rifiuto. In definitiva, il male è effetto
della non-accoglienza dell‟invito stesso, di quella “vocazione” propria della
libertà.
135
135
La sesta ed ultima parte concerne “pensieri” Sulla Religione in
generale, Sull’idea di Dio, Intorno al Cristo, Sulla Sacra Scrittura, Sulla
liturgia, Sulla Vergine Maria. Nella prima sezione, tra molte considerazioni
sugli scritti di Santi e Padri della Chiesa, risalta quella su “uno dei problemi
più difficili anche storicamente della dottrina cristiana […] quello della
conciliazione della libertà dell‟uomo con la “grazia” soprannaturale di Dio” (p.
181). Cavaciuti propone la riconsiderazione del concetto di Grazia, la quale
non è sostituzione della libertà umana, ma un aiuto, che prevede pure
l‟intervento dell‟ intelligenza, della volontà libera e della corporeità. Un altro
pensiero che emerge per originalità, e che già A. Dentone, in prefazione,
definisce “straordinariamente forte”, riguarda il problema di un dialogo
religioso con l‟Islam: perfino San Francesco, che lo aveva tentato, ha dovuto
recedere. Secondo il nostro Autore, “si potrà trattare con i musulmani su
questioni che non toccano la Fede, ma non oltre” (p. 184), ed è da ritenersi
un‟illusione anche il tentativo di assimilare l‟Islam − “corpo non assimilabile” –
tramite una sua progressiva laicizzazione: proprio questo puntare sulla
laicizzazione costituirebbe un‟indebolimento, sempre maggiore, del nostro
mondo postcristiano. Nella sezione Sull‟idea di Dio, troviamo il pensiero che
ne parla come Causa incausata, da Cavaciuti avvicinata al concetto di Dio
come Libertà, che è, appunto, causa incausata. La sezione più corposa di
tutto il testo (oltre trenta pagine) è intitolata Intorno al Cristo. Fra le numerose
idee espresse qui dal Cavaciuti segnalo quella del “legame diretto” del Cristo
stesso con gli Apostoli, legame - si direbbe “fisico” - che pare continuare,
nelle relazioni delle Comunità cristiane dei secoli seguenti, sia con la Chiesa
Vescovile sia, nella campagna, con la Chiesa Plebana; oggi, ci restano i
Sacramenti a conservare questo legame “fisico” nella realtà cristiana.
Seguono i commenti ad espressioni del Salmista, di Santi e di Filosofi,
commenti tutti ancorati all‟idea più sopra esposta del mondo quale
“ambiente” del Verbo incarnato. Cavaciuti la riprende spesso: ora per chiarire
il “senso” del mondo, ora per evitare, proprio con questa idea del mondo
come “ambiente”, lo sfociare nel panteismo, ora per trovare nelle lettere di
San Paolo le ragioni di tale concezione.
V‟è da citare, inoltre, l‟idea della “consistenza ontologica” del male,
inteso come possibilità radicale, anche se non come realtà radicale (p. 240).
Nei “pensieri” Sulla Sacra Scrittura, si afferma che Antico e nuovo
Testamento sono sulla linea dell‟ “invito”. Vi è, poi, lo spazio di uno sguardo
al mondo protestante, per dire che l‟attenzione alla sola Scrittura non pare
sufficiente – la storia lo dimostra – a fondare una solida religiosità. Questo
concetto viene ripreso nella penultima sezione Sulla Liturgia, e in cui, fra
l‟altro, viene sottolineata l‟importanza dell‟Ufficio Divino, che è “la preghiera
più alta e perfetta”, in quanto costituita soprattutto da preghiere-poesie.
136
136
Come i grandi Padri della nostra lingua, Cavaciuti conclude i suoi
“pensieri” nella figura della Vergine, figura rigeneratrice e salvifica nei
confronti non solo dell‟uomo ma anche della natura. È una similitudine a
chiudere la riflessione sulla Vergine: come la bellezza delle giovani donne è
in funzione dei figli, mediante l‟amore da questa suscitata, la bellezza
integrale di Maria sussiste “in funzione dell‟Amore”, suscitato in funzione alla
Redenzione e, con essa, alla ragione ultima del mondo.
L‟insieme di tutti i “pensieri”, che spaziano – come abbiamo visto −
in vari campi della problematica filosofica, e anche religiosa, dà l‟impressione
di un impianto piuttosto originale − le idee che abbiamo rilevato ne possono
essere una prova, se pur parziale − e merita la nostra attenzione. Quanto qui
esposto vuole essere soltanto una indicazione necessariamente limitata della
ricchezza di questo pensiero, per il quale esorterei a compiere una lettura
diretta del volume, di cui ho cercato di tracciare almeno alcune linee di fondo.
137
137
IL VOLTO NEL PENSIERO CONTEMPORANEO
*
di Maurzio Daggiano
Nella stratificazione dell‟esserci umano e, in particolar modo, in
quella regione dell‟umano come corporeità, il pensiero filosofico del
Novecento ha portato il volto umano in quanto tema etico, antropologico ed
ontologico. Questo non vuol dire che il volto non sia stato mai considerato
significativo in precedenza, ma il rapporto con l‟ontologia cartesiana delle due
res e la scissione dell‟essere umano tra anima e corpo, conduceva ad una
devitalizzazione del volto nell‟oggettualità di un realismo ingenuo, oppure, ad
una rarefatta spiritualizzazione idealistico-speculativa, versanti filosofici non
più accettabili dopo la fenomenologia di Husserl-Heidegger. Il volume a cura
di Daniele Vinci Il volto nel pensiero contemporaneo (Il Pozzo di Giacobbe,
Trapani 2010, pp. 553) si propone come una guida (ovviamente non
esaustiva ma estremamente utile) nel realizzare una mappa cognitiva molto
ampia, ben articolata, sulla produzione filosofico-tematica attorno al volto
dell‟uomo contemporaneo. Come sostiene il curatore, i nomi imprescindibili
che hanno ispirato questa monografia, in un intreccio costante (ora implicito
ora esplicito), sono: Max Picard, Emmanuel Lévinas e George Simmel . Da
qui “il panorama, con sorpresa, si è andato rapidamente allargando.
Risalendo alla radice fenomenologica del discorso levinasiano, sono emersi i
nomi di Edmund Husserl, Edith Stein e Max Scheler con i loro studi
sull‟empatia e la corporeità espressiva” (p. 7).
Il volume raccoglie, secondo una scansione in cinque sessioni, il
contributo di ben trentatré autori fra italiani e stranieri (autori specialisti in
diversi ambiti di ricerca), in un percorso che parte dalle premesse bibliche del
tema del volto (Radici), giunge ad esplorare, tramite un approccio teoretico,
la declinazione ontico-antropologica del volto e “la dimensione gnoseologica
che approda ad istanze etiche” (Alla luce del volto/ Pensatori del volto), per
poi passare a tematizzare il volto come raffigurazione, ritratto, auto-ritratto
(Rifigurazioni); ed infine il nesso del volto umano con il nostro tempo negli
ambiti della letteratura, del cinema, della medicina estetica e dei nuovi media,
ora, con la diffusione capillare e globale dell‟identità virtuale tramite l‟idea di
volto vissuta con Facebook (Tornino i volti).
Sebbene il lavoro complessivamente non sostiene una tesi, ma
intende offrire al lettore gli strumenti concettuali e bibliografici (e i possibili
approcci) per accostarsi al tema, secondo il curatore l‟idea di fondo, che
*
Dottore di ricerca in Filosofia presso l‟Università del Salento.
138
138
ispira l‟intero progetto, è l‟eclissi del volto dell‟uomo contemporaneo: “L‟eclissi
del volto è una preziosa chiave ermeneutica attraverso la quale leggere i
grandi fenomeni che hanno segnato la nostra contemporaneità. La
massificazione, il totalitarismo, la guerra su scala mondiale non hanno forse
significato la perdita, la discriminazione, la distruzione dei volti umani?” (p. 9).
Se nel secolo scorso il totalitarismo ha distrutto la libertà espressiva della
singolarità del volto (lo ha negato, deturpato, discriminato), la perdita del
volto è la chiave ermeneutica per guardare all‟oggi, proprio in un periodo
storico in cui il nostro sguardo è sempre più assediato nel suo percepire il
mondo dalla moltiplicazione di vissuti e dall‟esposizione massiva ed
oggettuale di una folla-di-visi: nei giornali, nelle pubblicità, sullo schermo di
un televisore, di un cinema, o di un computer.
E qui notiamo un fenomeno singolare. Di fronte all‟esposizione
violenta e continua di cui viene fatto oggetto, il volto umano sembra
rispondere ritraendosi. Lo si vede nei volti televisivi, in particolare in quelli
femminili. È come se, davanti a una doppia esposizione – luce artificiale degli
studi e sguardo meccanico della telecamera –, il volto preferisca
nascondersi, lasciando a propria protezione un simulacro “plastificato” (p.
10). Ma come è possibile che il volto si nasconda? E si nasconde a chi? Nel
saggio di Mauro Maria Morfino possiamo comprendere che: “la trasparenza
del corpo non è di questo mondo” (p. 15); partiamo quindi ancora una volta
dalla corporeità. La lingua ebraica coglie questo aspetto della corporeità
poiché non consente di dire il volto, al singolare, ma i volti della persona: il
termine plurale panim “non è mai attestato al singolare e viene considerato
un plurale tantum” (p. 13). In questa eccedenza il nostro volto è il volto di
volti. In questo dinamismo del volto, il suo essere relazionale si esprime
continuamente e si manifesta, nel senso non-oggettuale di Lévinas.
Relazionalità interna e relazionalità esterna; sono dunque i nostri volti. Come
sta l‟esserci in questa relazionalità infinita con i volti nostri, quelli interiori, e i
volti ai quali rispondo all‟appello relazionale del Mitsein?: “L‟essere interiore e
l‟aspetto esteriore non coincidono mai esattamente. E ciascuno ha la propria
collezione di maschere che utilizza a perdita d‟occhio! Sottrarsi si
contrappone ad “affacciarsi” e a partire dalla propria faccia un gettare un velo
sulla propria manifestazione”. In questo caso solo un lavoro sulla propria
attenzione circa questi aspetti della corporeità, la connessione di sé e la
sottrazione di sé, permette di orientarsi nella dis-attenzione, di non
inciampare e farsi del male.
Vedere il volto vuol dire essere accolti alla presenza di qualcuno.
L‟altro ci prende in considerazione, e nel rispondere all‟appello dell‟altro
richiediamo pari riconoscimento: “Dato che il volto è quella parte del corpo
umano, quindi dell‟uomo, che meglio è in grado di manifestare espressioni
139
139
differenziate, è ovviamente logico che il linguaggio abbia preso il termine
panim come punto di partenza per numerosi modi di dire riguardanti i rapporti
interpersonali e quelli tra l‟uomo e Dio. […] Panim è un termine relazionale,
che descrive relazioni […] indica presenza reale e personale, denota
rapporto e incontro (o rifiuto di questo)”. Quindi gli stessi attributi semantici
dell‟incontro dell‟uomo con il proprio partner sono vissuti a posteriori rispetto
alle possibilità dei vissuti che rispondono all‟appello dell‟assolutamente altro.
Lo spazio di questo stare “faccia a faccia” possiede come Gestalt la sua
qualità d‟incontro. La tonalità ambientale è emotivamente intonata
nell‟estroflessione del cuore: “Il testo biblico quando pronuncia il
singolarissimo plurale panim riguardo all‟umano, è quella di trovarsi davanti
al sigillo indelebile, allo sphragis dell‟estroflessione del cuore, luogo per
eccellenza della registrazione-esternazione dell‟interiorità” (p. 15). Ed in nota:
“In antropologia biblica è improponibile parlare di panim senza chiamare in
causa il leb, il cuore”. In ogni “faccia a faccia ” sta l‟esempio fenomenologico
fondamentale per comprendere il volto nel suo donarsi.
Nella ricerca sul fenomeno originario della donazione del volto, la
fenomenologia rappresenta il metodo più adeguato. Negli studi sull‟empatia,
con il saggio di Laura Boella, sappiamo che per tematizzare qualcosa come
l‟empatia si suppone intercorporeità, il vissuto empatico si fonda
sull‟originaria interdipendenza corporea che lega gli esseri umani: “permette
di cogliere a livello percettivo-motorio gli aspetti che fanno da ponte tra sé e
l‟altro […]. L‟empatia in effetti si sviluppa dalla quasi immediata intuizione
della prospettiva dell‟altro a una costruzione e messa in relazione di questa
con la propria che porta a valutare le distanze o le affinità” (p. 132). Per
comprendere fenomenologicamente la relazionalità spaziale dello stare
“faccia a faccia”, in breve l‟empatia, lo sguardo percettivo è, qui, più legato al
sentire della corporeità emotivamente intonata, vale a dire, non comprende
affatto il sistema relazionale dello spazio intersoggettivo della corporeità
cinestetica, ma del sentire diretto con il campo di espressione pre-verbale del
corpo altrui, in quanto trasposizione intuitiva e sintetica del corpo dell‟altro
con il proprio corpo, come afferma Max Scheler “possiamo percepire
internamente anche gli altri, in quanto cogliamo il loro corpo come il campo di
espressione delle loro esperienze” (p.137). La percezione empatica
coinvolge diversi livelli della costituzione antropologica dell‟essere umano, a
partire dai livelli profondi emozionali della naturalità del corpo come
organismo vivente, semplicemente emozionale, e che condividiamo con gli
animali, così come i processi di attivazione dei sistemi neuronali: “È ormai
acquisito che per empatizzare ci vuole attività corporea, che le neuroscienze
oggi stanno esplorando a livello di attivazione di specifici sistemi neuronali (i
mirror, ma non solo) correlati alla percezione innanzitutto visiva, a movimenti
140
140
e reazioni del corpo e emozioni (gesti, mimica facciale e delle labbra,
conduttanza cutanea)” (p. 133). Il volto si costituisce sempre come relazione,
anzi è relazione con l‟estraneità. Relazionalità non oggettuale, e nemmeno
ingenua. Il volto dell‟altro, come ci ricorda Levinas mette in questione la mia
spontaneità: “L‟estraneità dell‟Altro – la sua irriducibilità a Me – ai miei
pensieri e ai miei processi, si attua appunto come una messa in questione
della mia spontaneità, come etica” (p. 297). Il volto, infatti, in quanto
incarnazione del mostrarsi dell‟altro, sfugge di per sé ad ogni processo di
afferramento simbiotico delle proprie aspettative emozionali. Di fronte ad una
simile inafferrabilità del volto come mai pienamente agguantabile, mai
afferrabile, la filosofia continua instancabilmente il suo lavoro di visione
fenomenologica dell‟unità dell‟essere animato umano di fronte all‟eclissi del
volto. Ciò non riguarda soltanto la risposta alle radicali forme di eclissi del
mondo
contemporaneo,
ma
anche
dell‟impossibilità
di
vivere
quotidianamente il volto come tema.
Atteggiati naturalmente, noi viviamo i volti ma non ne facciamo mai
tema filosofico, non lo viviamo come tema. Questa mancanza non è una
deficienza del nostro esserci ma di una modalità di pensiero che, per ragioni
intrinseche alla costituzione umana, vive direttamente nel contenuto
fenomenico della propria esperienza del volto senza interrogarsi
sull‟originarietà fenomenologica del volto.
141
141
LE STANZE DELLA MODERNITÀ
*
dI Ardian Ndreca
L‟amore per la verità ha portato Paolo Miccoli, in Stanze della
modernità (Urbaniana University Press, Studia 57, Città del Vaticano 2010,
pp. 276), ad esplorare nella sua ricerca, in un vasto arco di tempo, diversi
percorsi filosofici, che vanno dagli antichi ai contemporanei. Egli ha concepito
la sua indagine, in questa raccolta di saggi pubblicati in tempi diversi, come
un procedere attraverso le “stanze della modernità”, divise in dialettica,
storia, morale/religione, estetica. In questa analisi si sente l‟esigenza di
approfondire la struttura stratificata della realtà sia in senso diacronico sia in
quel che risulta dallo stesso plesso essenziale dei fenomeni presi in
considerazione.
Nella parte denominata “dialettica” l‟Autore ha incluso scritti che
riguardano G. Bruno, G. Vico, G. W. F. Hegel, H. Bergson, M. Heidegger, Th.
W. Adorno, C. Fabro. Del pensiero di Giordano Bruno lo stimola la tensione
verso un modo nuovo di dialogare, che portava il Nolano ad un linguaggio
autonomo e libero dagli schemi aristotelici. Questo amore per la verità,
espresso nella forte attrazione che esercitò su di lui il pensiero antico, rende
Bruno, agli occhi di Miccoli, un filosofo che parla della sapienza degli antenati
con un linguaggio nuovo. Qui lo studioso coglie le avvincenti indicazioni
dell‟autore della nova filosofia riguardanti la concezione della vita polimorfa e
della natura stessa.
Di Giambattista Vico gli interessa il modo particolare di guardare il
passato come un fare verace, nonché le riflessioni sull‟estetica. Della filosofia
della storia di Vico, Miccoli apprezza molto l‟intreccio con la metafisica e
l‟idea che la Provvidenza rimane, anche dopo la caduta, una “maestra di
sapienza volgare”, pronta a svelare in tutti i tempi e in tutte le circostanze la
via verso l‟ideale.
Nella lettura del giovane Hegel egli nota criticamente come il vizio di
fondo sia stato la strumentalizzazione storica dell‟idea di Dio, la quale non
regge di fronte ad una ragione onnivora che si guadagna il primato sulla
realtà delle cose. In questa critica gli viene in aiuto anche l‟esegesi hegeliana
di C. Fabro, condotta sia da un punto di vista metafisico tomista sia dalla
critica di Kierkegaard.
Uno degli autori della “stanza dialettica” che ha interessato Miccoli è
anche Bergson, la cui metafisica della volontà viene delineata come
*
Docente di Storia della filosofia moderna presso la Pontificia Università Urbaniana,
dove dirige l‟Istituto per lo Studio dell‟Ateismo e delle culture (I.S.A.).
142
142
conoscenza unificante alla luce di un‟esperienza unitaria della vita. La
Lebensphilosophie bergsoniana è intenta ad “auscultare il palpito fontale
della realtà”, donde scaturisce l‟energia creativa che guida la materia.
L‟emergere delle nostre azioni attraverso la durée, porta all‟incontro con
l‟Assoluto e al superamento della molteplicità. Proprio l‟Assoluto, rileva
Miccoli, assume in Bergson un triplice significato: “ciò che si sottrae al
linguaggio dei concetti e dei simboli, ciò che qualifica intensivamente il reale
finito come empirismo radicale, ciò che fa tutt‟uno con l‟intuizione intesa
come atto di vita nella vita” (p. 59).
La riflessioni heideggeriana invece viene letta come un tentativo
diretto ad “arginare lo strabismo teorico della tradizione classica che ha
confuso e identificato l‟essere (Sein) con l‟ente (Seiende)”. Due sono gli
itinerari seguiti da Heidegger: 1) il ritorno all‟idea parmenidea dell‟essere
attraversando il disagio e la decadenza dell‟Occidente, descritti da Nietzsche
come compimento naturale delle metafisiche, 2) la scoperta nel “Dire
originario” della “poesia pensante” e della “verità nascosta” che si rivela. Nel
linguaggio, interpretato come “casa dell‟essere”, accade la non-ascosità
dell‟originario, ovvero il dis-velamento nel tempo della connessione con
l‟essere. Così Heidegger pensa di aver superato la Seinsvergessenheit,
malattia strutturale dell‟uomo, il quale finalmente si palesa “pastore
dell‟essere”.
Anche le riflessioni che riguardano le altre “stanze” puntellano il
percorso filosofico di Paolo Miccoli, il quale si mostra pronto a interloquire
con pensatori lontani dalla sua visione, senza però rinunciare alla critica
serrata. Questa diventa un‟esigenza e un‟opportunità nei confronti di una
metafisica impigritasi entro schemi che assomigliano a delle corazze pesanti
e inutili, nei riguardi del cogito cartesiano e della riduzione fenomenologica,
nei confronti della tendenza di psicologizzare il soggetto agente e pensante
oppure di ridurre la sua densità ontologica nel linguaggio semantico.
Per questo Miccoli ripropone temi antichi e moderni, non esita e
prendere spunti dall‟antropologia di Agostino e dalla visione storica di Vico,
dall‟estetica di Schiller e di R. Assunto.
Tutto si concentra all‟interno di un‟esigenza etica, che, nel dire di
Bergson, è quella di “invertire la direzione abituale del pensiero”. All‟interno di
un tempo accelerato che coinvolge sempre più parzialmente la struttura
antropologica dell‟uomo, Miccoli avverte l‟urgenza di individuare i “bisogni
essenziali” (G. Capograssi) e di indicare con realismo la possibilità di
realizzarli. In quest‟ottica lo scandaglio delle quattro “stanze” assume
significato poietico, perché volge a completare una visione filosofica ben
precisa che da una parte declina facili soluzioni artefatte, mentre dall‟altra
143
143
coniuga l‟antropologia all‟estetica, l‟etica alla filosofia del linguaggio, la
metafisica della volontà alla mistica.
Questa maturazione di pensiero ha portato l‟Autore, peraltro
impegnato per lungo tempo nello studio del fenomeno dell‟ateismo, della
secolarizzazione, del nichilismo e della filosofia della storia, a diffidare –
all‟interno del pensiero - sia delle vedute parziali sia degli sguardi sinottici.
Il postmoderno, nel tentativo di stringere l‟assedio alla modernità
lacerata dalla fine delle grandi ideologie e dalla crisi del pensiero forte, ha
prodotto una serie di diffrazioni seducenti che vanno dall‟estetica alla morale,
dall‟ermeneutica alla critica delle grandi narrazioni e dei loro presupposti. È
dunque in questione l‟attualità del pensiero stesso e la possibilità di
ancoraggio a dei punti fissi. Ma un pensiero senza presupposti
(voraussetzungslose) pare impossibile, perché siamo noi stessi il
presupposto del pensiero. Nell‟Ottocento sembrava che quei punti fissi
dovevano essere indicati dalla scienza, ma questa, come notava Leon
Tolstoj, non è in grado di indicarci come dobbiamo vivere.
Dalla lettura di questa raccolta di saggi di Paolo Miccoli cogliamo
molteplici tracce e suggestioni, che vanno dall‟etica all‟estetica, dalla politica
alla metafisica. Tutto ciò è presentato in modo organico, poiché è preceduto
dalla consapevolezza di un pensiero imparentato con l‟esigenza pratica di
cogliere la verità per vivere in essa.
Affiora così l‟urgenza di educare e di formare l‟uomo (Schiller),
l‟importanza della storia come storia di salvezza (Agostino, Vico), la
dimensione mistica della vita, il rapporto uomo-natura, l‟estetica come
pedagogia verticale (R. Assunto), ecc. La ricerca di Miccoli non si arresta in
nessuna stanza o cubicolo che attraversa; egli si protende nella direzione
dell‟Assoluto, di cui tutte le stanze sono anticipazioni distanziate, quasi “cifre”
jaspersiane.
Gli uomini, ripetiamo con Eric Weil, sono il dolore e la pena della
negatività finita, ed è da qui che inizia l‟accesso all‟Assoluto; per questo è
utile ripercorrere insieme a Miccoli, con coraggio e con senso critico, tutte le
stanze della modernità.
144
144