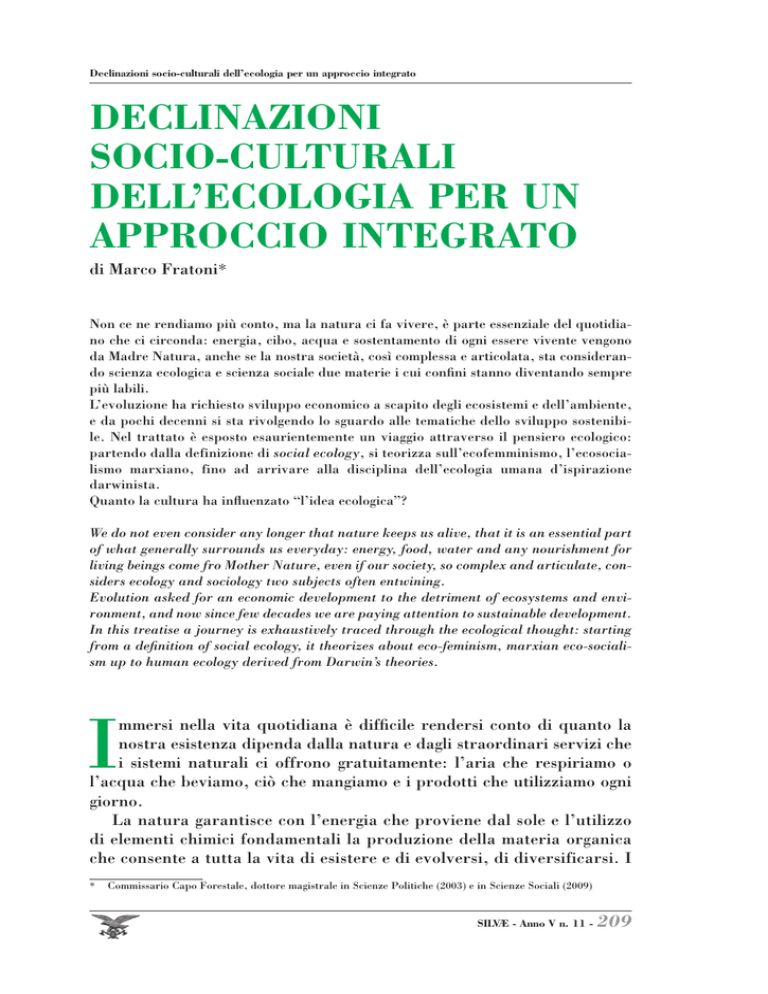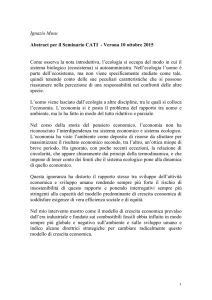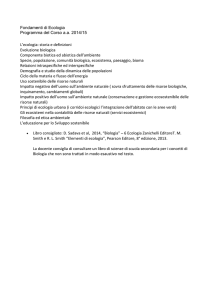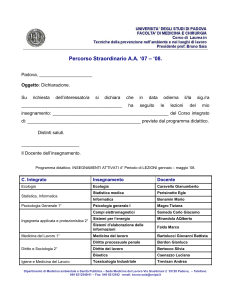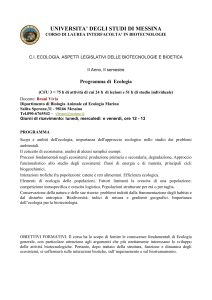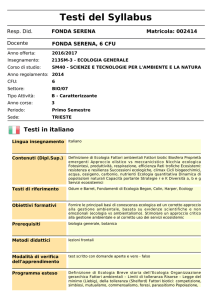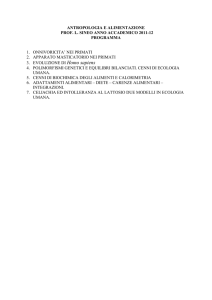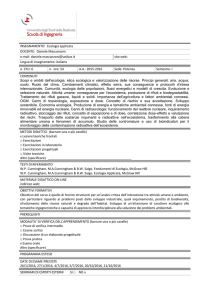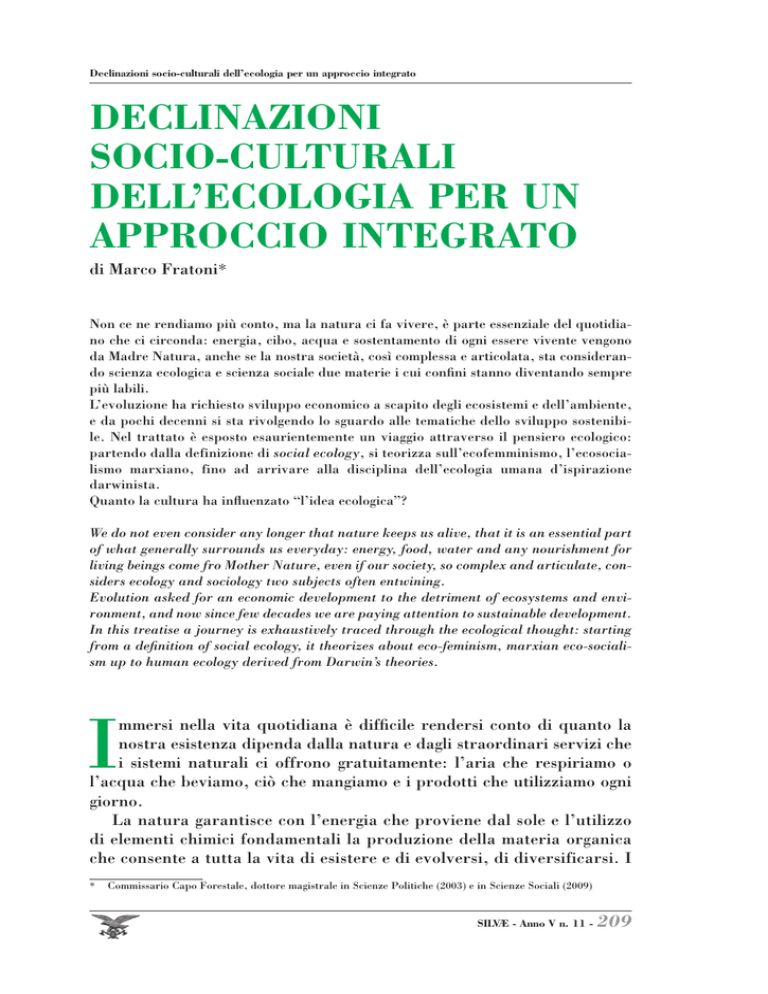
Declinazioni socio-culturali dell’ecologia per un approccio integrato
DECLINAZIONI
SOCIO-CULTURALI
DELL’ECOLOGIA PER UN
APPROCCIO INTEGRATO
di Marco Fratoni*
Non ce ne rendiamo più conto, ma la natura ci fa vivere, è parte essenziale del quotidiano che ci circonda: energia, cibo, acqua e sostentamento di ogni essere vivente vengono
da Madre Natura, anche se la nostra società, così complessa e articolata, sta considerando scienza ecologica e scienza sociale due materie i cui confini stanno diventando sempre
più labili.
L’evoluzione ha richiesto sviluppo economico a scapito degli ecosistemi e dell’ambiente,
e da pochi decenni si sta rivolgendo lo sguardo alle tematiche dello sviluppo sostenibile. Nel trattato è esposto esaurientemente un viaggio attraverso il pensiero ecologico:
partendo dalla definizione di social ecology, si teorizza sull’ecofemminismo, l’ecosocialismo marxiano, fino ad arrivare alla disciplina dell’ecologia umana d’ispirazione
darwinista.
Quanto la cultura ha influenzato “l’idea ecologica”?
We do not even consider any longer that nature keeps us alive, that it is an essential part
of what generally surrounds us everyday: energy, food, water and any nourishment for
living beings come fro Mother Nature, even if our society, so complex and articulate, considers ecology and sociology two subjects often entwining.
Evolution asked for an economic development to the detriment of ecosystems and environment, and now since few decades we are paying attention to sustainable development.
In this treatise a journey is exhaustively traced through the ecological thought: starting
from a definition of social ecology, it theorizes about eco-feminism, marxian eco-socialism up to human ecology derived from Darwin’s theories.
I
mmersi nella vita quotidiana è difficile rendersi conto di quanto la
nostra esistenza dipenda dalla natura e dagli straordinari servizi che
i sistemi naturali ci offrono gratuitamente: l’aria che respiriamo o
l’acqua che beviamo, ciò che mangiamo e i prodotti che utilizziamo ogni
giorno.
La natura garantisce con l’energia che proviene dal sole e l’utilizzo
di elementi chimici fondamentali la produzione della materia organica
che consente a tutta la vita di esistere e di evolversi, di diversificarsi. I
*
Commissario Capo Forestale, dottore magistrale in Scienze Politiche (2003) e in Scienze Sociali (2009)
SILVÆ - Anno V n. 11 -
209
Declinazioni socio-culturali dell’ecologia per un approccio integrato
sistemi naturali del nostro pianeta sono in grado di auto-rinnovarsi e di
generare la vita, per questa capacità sono stati definiti life-support
systems1.
Oggi che tutta la cultura scientifica è in una situazione di ebollizione,
i confini disciplinari risultano sempre più labili, la percezione della
nostra incapacità di comprensione della realtà è sempre più elevata. La
consapevolezza che la natura non si possa capire con semplici relazioni di
causa ed effetto è ormai consolidata. Gli stessi concetti centrali della
nostra conoscenza sono ben lungi dall’avere una chiara comprensione:
regna pervasivamente un diffuso senso di incertezza2.
L’ecologia, fondata a partire da chiari confini disciplinari, è scienza
complessa ed intrigante. Nutrita dalle straordinarie novità concettuali ed
operative di discipline diverse ed innovative, la moderna scienza ecologica cerca di tracciare mappe utili e praticabili affinché le nostre società
possano vivere in armonia con i sistemi naturali.
Chiarendo gli obiettivi fissati e i metodi osservati, si cercherà, in questo breve approfondimento, di battere la via semplice, ma ambiziosa,
che porta alla verificazione di una posizione ecologica alternativa,
testandone legittimità e opportunità predittiva. Il futuro delle nostre
relazioni con il mondo naturale sembra infatti dipendere dalla capacità
di sensibilizzazione, consapevolezza e cultura, e andrà concretandosi in
una effettiva integrazione dei sistemi naturali con quelli socio-economici
da esperirsi per il tramite privilegiato di approcci innovativi, transdisciplinari e aperti.
Ma cominciamo dal partecipare alcune riflessioni.
E.P. Odum asserisce, senza chiosare, che “l’ecologia è diventata sempre più una disciplina integrata che associa scienze naturali e sociali”3. È
evidente che l’ecologia mantenga una forte e fondamentale radice nelle
scienze naturali, ma non è più esclusivamente un soggetto biologico. L’ecologia storicamente considerata una hard science perché ricorre alla
strumentazione concettuale della matematica, della fisica, della chimica,
etc…, veste con sempre maggiore assiduità i panni di una soft science,
complici le interferenze del comportamento umano con la struttura e la
funzione degli ecosistemi. “L’ecologia come integrazione di scienze naturali e sociali ha un tremendo potenziale applicativo di interesse per l’uomo, dato che situazioni del mondo reale, quasi sempre coinvolgono componenti delle scienze naturali e sociali, economiche e politiche. Ciascuno
1
2
3
Odum E.P., Principi di ecologia, Piccin, 1973 e Odum H.T., Environment, Power and Society, Wiley Interscience, 1971
Giddens A., Modernità, ecologia e trasformazione ecologica, in P. Ceri (a cura di), Ecologia politica, Feltrinelli, 1987
Odum E.P., Basi di Ecologia, Piccin, 1988
210 - SILVÆ - Anno V n. 11
Declinazioni socio-culturali dell’ecologia per un approccio integrato
di questi due gruppi di componenti non può essere trattato separatamente se si vogliono trovare soluzioni definitive a problemi di importanza critica”4.
Proprio la necessità di comprendere sempre meglio l’oggetto della
scienza ecologica ha rafforzato le ricerche relative alle interrelazioni tra
sistemi naturali e sistemi umani. Comprendere la storia delle relazioni tra
la specie umana e la natura richiede uno sforzo di integrazione di differenti prospettive, teorie e strumenti di numerose discipline nell’ambito
delle scienze naturali, sociali ed umanistiche. Tutte le ricerche sostenute
da uno straordinario sforzo di connessione tra conoscenze, culture e pratiche, sono chiamate a fornire chiavi interpretative della realtà e proposte di azione più adeguate.
Del resto si vive simultaneamente l’ambiente naturale, la società
(ambiente sociale o milieu), il sistema economico nel quale operare. Questi aspetti della vita vengono troppo spesso trattati come se fossero tra di
loro separati. I confini sono invece sfumati anche se apparentemente possono sembrare netti, le connessioni esistenti sono molteplici. Le risposte
della politica e del mondo del mercato, alle sfide che la modernità ci impone, sono ancora dominate da una visione settoriale e non integrata della
realtà.
Come ricorda Edgar Morin “l’intelligenza parcellizzata, compartimentata, meccanicistica, disgiuntiva, riduzionistica, rompe il complesso
del mondo in frammenti disgiunti, fraziona i problemi, separa ciò che è
legato, unidimensionalizza il multidimensionale”5.
La questione affrontata ci obbliga ad un diverso ragionamento, interdisciplinare e multicriterico, più cosciente e consapevole. La realtà è in
continuo mutamento (in fieri). La verità dei fatti cambia al variare di chi
la osserva e la vive (da uno scienziato in laboratorio ad un politico, da un
giornalista ad un operaio, da un pigmeo della foresta africana ad un business man americano), vista, operata e considerata in tanti modi e sempre
adottando modalità differenti.
L’esempio più chiaro dell’impossibilità di isolare il discorso ambientale dalle sue implicazioni sociali è dato dall’approccio della social ecology. Sin dagli anni sessanta l’americano Murray Bookchin, che della
social ecology è l’esponente più noto e vilipeso, analizza la crisi ambientale alla luce delle dinamiche ideologiche, storiche e politiche della
società occidentale6. Proprio in quanto ecologia, la social ecology predilige una visione organica della società. Tra la comunità e gli individui
4
5
6
ibidem
Morin E. e Kern A.B., Terra-Patria, Raffaello Cortina Editore, 1994
(n.d.r.) L’opera che sintetizza il pensiero di quegli anni è Our Synthetic Environment del 1962 mai pubblicato
in Italia.
SILVÆ - Anno V n. 11 -
211
Declinazioni socio-culturali dell’ecologia per un approccio integrato
sussiste una relazione olistica: entrambi appartengono ad un unico insieme, e i loro processi devono essere considerati come forme di uno sviluppo interdipendente. Se da un lato, cioè, sono gli individui a creare la
società, dall’altro è anche la società (come luogo in cui si consolidano e
condividono valori, immagini, linguaggi, pratiche, modelli economici e
politici) e creare gli individui. È in questo, dice Bookchin, che la società
è una seconda natura per l’uomo: una natura non meno autentica della
prima e da cui l’uomo non si allontana mai. Come l’ambiente per l’ecologia, dunque così la società è per l’ecologia sociale un territorio di relazioni. Sebbene possano essere rinvenute alcune ascendenze comuni, il
punto di vista di Bookchin non coincide interamente né col marxismo né
con l’anarchismo. La sua ecology of freedom serve piuttosto a mettere in
luce che la prima e fondamentale forma di libertà per Bookchin non è
tanto l’assenza materiale di costrizioni, quanto la consapevolezza che al
dominio dell’umanità sulla natura va sostituito l’idea di una interdipendenza, strutturale e funzionale. Questa presa di coscienza rappresenta
una nuova forma di umanesimo o se si preferisce di nuovo illuminismo
ecologico, “un passaggio dal cielo alla terra, (…), dalle divinità alla
gente”7.
Quale integrazione? Evoluzione della scienza ecologica
Come osserva il professor Fulvio Beato “l’ordine di problemi qui
segnalato come centrale si genera da un interrogativo tanto semplice
quanto radicale: quale sapere per l’ambiente? Quale sapere, con riferimento alla nostra problematica, relativo alla rete di relazioni che si
stabiliscono tra sistemi sociali e sistemi ambientali naturali ed artificiali, tra biosfera, tecno sfera e socio sfera? Si tratta di un interrogativo cruciale tanto sul piano della costruzione dei quadri di riferimento
teorico per l’insieme delle scienze umano-sociali quanto sul piano del
trasferimento delle conoscenze acquisite nella formulazione di politiche pubbliche fondate sull’informazione scientifica e sulla partecipazione sociale”8.
La matrice eminentemente sociale di un siffatto stato di cose rimane
quella individuata da Jean Piaget nel saggio sui Problèmes généraux de
la recherche interdisciplinaire et mécanismes communs (1970). Con riferimento alla scienze umane e sociali, egli poneva, accanto agli ostacoli
logici ed epistemologici, la tragique répartition dell’assetto istituzionale
degli insegnamenti universitari.
7
8
Bookchin M., L’ecologia della libertà, Eleuthera, 1986
Beato F., Rischio e mutamento ambientale globale, Franco Angeli, 1998
212 - SILVÆ - Anno V n. 11
Declinazioni socio-culturali dell’ecologia per un approccio integrato
D’altro canto, che una vasta gamma di forze - politiche, amministrative, scientifiche, professionali e culturali - sia di fatto in concertazione
“contro tentativi anche cauti di affermare la dimensione interdisciplinare, o, almeno, la più perseguibile logica della multidisciplinarietà, costituisce ormai un dato accertato”9. E tuttavia le barriere e le difficoltà che
si frappongono alle forme plurime di negoziazione dei diversi orientamenti disciplinari nello studio dei sistemi uomo-ambiente, non debbono
produrre come esito, pena la segmentazione di ciò che è nell’essenza globale ed interconnesso, la rinuncia all’arginamento della atomizzazione
dei problemi o un ripiegamento sulla semplice riorganizzazione del sistema delle conoscenze acquisiste.
La questione ecologica, nella sue caustiche implicazioni, va affrontata
attraverso un approccio disciplinare multipolare.
La parola ecologia deriva dal greco oikos, che significa casa (ovvero
posto per vivere), e logos, che significa discorso. L’ecologia è, quindi, lo
studio della vita nella casa con particolare riguardo a tutte le relazioni (o
ai modelli di relazione) tra gli organismi ed il loro ambiente.
Si deve attribuire a Ernest Haeckel, biologo tedesco di convinta fede
darwiniana, in Generelle Morphologie der Organismen (1866), la primagenia del termine: “il corpus di conoscenze riguardanti l’economia della
natura10: l’indagine di tutte le relazioni dell’animale sia con il suo
ambiente organico sia con il suo ambiente inorganico; (…); l’ecologia è lo
studio di tutte le interrelazioni complesse che Darwin chiamò condizioni
della lotta per l’esistenza”. Anche se, giustamente, fanno notare gli storici, l’idea di ecologia nasce molto prima del suo nome. Per Donald Worster è quella di Darwin “la figura più importante nella storia dell’ecologia”11; per l’ecologo Charles Krebs: “egli è il giusto padrino della scienza
dell’ecologia perché ha riconosciuto le intricate connessioni tra l’ecologia
e l’evoluzione”12.
Con Haeckel nasce ufficialmente la prima fase del pensiero scientifico ecologico (c.d. dell’ecologia ambientale). La scienza ecologica abbandona l’antica immagine del mondo basata sulla metafora di una natura
materna ed accogliente (il grande organismo) e sull’immediata corrispondenza tra macrocosmo (natura) e microcosmo (essere umano), e
cede il passo alla visione riduzionistica e meccanicistica accreditandosi
come moderna scienza, in grado di tradurre in modelli matematici e
9 ibidem
10 (n.d.r.) Con la locuzione economia della natura C. Darwin nella sua opera principale Sull’origine della specie
(1859) intende sostenere che tutta la natura si presenta come un sistema ordinato, ben regolato, di interazioni
fra piante e animali e tra essi e il loro ambiente.
11 Worster D., Storia delle idee ecologiche, Il Mulino, 1994
12 Krebs C.J., Ecology, Benjamin Cummings, 2001
SILVÆ - Anno V n. 11 -
213
Declinazioni socio-culturali dell’ecologia per un approccio integrato
equazioni fisiche la complessità del mondo vivente e delle sue relazioni
con l’ambiente.
Con l’ipotesi Gaia di James Lovelock ha inizio la seconda stagione dell’ecologia (c.d. ecologia globale). Nel 1979 la Oxford University Press
pubblica Gaia. A New Look at Life on Earth, primo lavoro di James
Lovelock, scienziato indipendente. L’ipotesi sostenuta è molto stimolante:
l’intera biosfera viene presentata come una entità autoregolata, in grado
di mantenere vitale il nostro pianeta mediante il controllo dell’ambiente
chimico e fisico. Ricorda Wolfang Sachs che “l’apparizione del volto della
terra colpì tutti; (…); l’improvvisa consapevolezza dell’unicità della
terra ha consentito l’emergere di una nuova emozione e la prima osservazione del globo come unicum ha rappresentato un salto nella storia dell’autopercezione dell’umanità13”. È grazie al contributo, romantico
ancorché speculativo, dell’ipotesi Gaia, che la scienza ecologica di stampo riduzionistico mette le ali e realizza un gap qualitativo, riconosce l’emergente necessità di aprirsi verso orizzonti disciplinari alteri, cerca il
confronto aperto con le scienze umane trovandovi la giusta via per reinterpretare la complessità del reale.
La moderna ecologia di secondo corso, anche detta ecofilosofia, si sviluppa sue due direttrici ermeneutiche complementari: da un lato un più
classico approccio scientista di tipo riduzionista, dall’altro una prospettiva precipuamente olistica.
La proposta scientista risente dell’influenza dell’ecologia scientifica
tradizionale. Adotta ancora uno sguardo troppo meccanicistico nei confronti della natura, che, una volta reificata, viene ridotta a mera res
extensa, costretta nella sola dimensione quantitativa. Il mantenimento
di siffatte basic assumptions comporta l’impossibilità di scorgere il
necessario retroterra analitico capace di elevare a statuto filosofico le
accreditate elaborazioni scientiste. Non mancano contributi brillanti e
significativi. Ma il modello scientista rimane imbrigliato nelle maglie
della fallacia naturalistica, non riuscendo a superare l’impasse fra essere e dover essere.
Fra questi indirizzi la ricordata ipotesi Gaia e il c.d. biologismo sociale.
Quella sociobiologica è una prospettiva, ancorchè relativamente
attuale, pure ancorata alle dottrine di C. Darwin e H. Spencer. Per il
suo più noto esponente, l’americano E.O. Wilson14, la sociobiologia è lo
studio sistematico delle basi biologiche di tutte le forme di comportamento sociale in tutte le specie di organismi, compreso l’uomo. Aggres13 Sachs W., Ambiente e giustizia sociale, Editori Riuniti, 2002
14 (n.d.r.) Si ricordi tra le sue opere Sociobiology: the new synthesis, 1975, Harward University Press, 25th Anniversary Edition, 2000.
214 - SILVÆ - Anno V n. 11
Declinazioni socio-culturali dell’ecologia per un approccio integrato
sività, comportamento sessuale, interazioni, rapporti parentali o semplicemente di parentela, rapporti di genere, etc…, sono tutti argomenti cari alla sociobiologia ma sui quali l’arena scientifica tende a dividersi. Lo stretto parallelismo instaurato tra comportamenti umani e
comportamento animale conduce spesso i sociobiologi a perdere di vista
le qualità distintive della specie umana rispetto a quella animale. Al di
là delle polemiche che di frequente riesce a sollevare, la sociobiologia si
afferma più per ciò che rivela sulla vita degli animali, che per quanto
dimostra a proposito del comportamento umano. E infatti sono riusciti
a dimostrare che alcune specie animali sono molto più socievoli di quanto si ritenesse in precedenza e che i gruppi animali hanno una considerevole influenza sul comportamento dei loro membri15. In buona
sostanza nessuno può negare la presenza di una base biologica al comportamento sociale ma, deve riconoscersi che, tale ipostasi biologica
non compare mai allo stato puro. La sociobiologia tende a configurare
se stessa come autonoma rispetto al mondo culturale, sociale, politico,
economico16. Rectius il comportamento biologicamente fondato va inteso sempre come mediato culturalmente. L’uomo è ovviamente condizionato biologicamente ma le società umane si specificano storicamente in
modi che non sono direttamente determinati dall’essere biologico dell’uomo: ogni condizionamento biologico appare mediato socialmente,
non è mai immediato17.
Nel panorama nostrano, recentemente, è Mariachiara Tallachini18 a
ribadire che, fin dai suoi albori, l’ecologia è portatrice di due anime
espressioni di una doppia natura, una olistica e l’altra riduzionistica,
ammonendo che lo stesso Arne Naess fosse solito distinguere l’ecologia
come scienza dall’ecologia come sistema filosofico.
Ed infatti, il quid pluris offerto dall’ecologia globale di seconda generazione (c.d. ecofilosofia) risiede tutto nella sua dimensione olistica19.
L’olismo ecofilosofico trova la sua più alta espressione nel pensiero e nelle
opere del ricordato filosofo norvegese Arne Naess, studioso di Spinoza e
di positivismo logico, docente all’Università di Oslo. Nell’estate del 1973
la rivista Inquiry pubblica un articolo breve ma per certi versi rivoluzio15 F. Crespi, Il pensiero sociologico, Il Mulino, 2006.
16 (n.d.r.) Si osservi come lo stesso Wilson quando cerca di indicare qualche conseguenza delle determinanti biologiche nel concreto comportamento umano è costretto ad usare il condizionale: il suo programma di ricerca
sociobiologico si arresta, non può andare oltre l’ipotetico.
17 A. Izzo, Storia del pensiero sociologico, Il Mulino, 2003.
18 Tallachini M. (a cura di), Etiche della terra. Antologia di filosofia dell’ambiente, Vita e Pensiero, 1998
19 (n.d.r.) Il termine olismo è stato coniato nel 1926 dall’uomo politico sudafricano Jan C. Smuts per indicare la
tendenza generale della natura a raggruppare ordinatamente in ogni settore e fase della realtà, unità strutturali in complessi dotati di proprietà qualitativamente nuove rispetto alle componenti (si veda in merito La Vergata A., Filosofia e biologia, in Rossi P. (a cura di), La filosofia volume II. La filosofia e le scienze, Garzanti,
1996).
SILVÆ - Anno V n. 11 -
215
Declinazioni socio-culturali dell’ecologia per un approccio integrato
nario dal titolo The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. La contrapposizione tra superficiale (shallow) e profondo (deep) è
funzionale allo scopo di distinguere un approccio ambientalistico (c.d.
ecologia di superficie) da un approccio ecologico (c.d. ecologia profonda):
il primo caratterizzato da un atteggiamento di tutela paternalistica della
natura, prevalentemente concepita come risorsa per l’uomo (assimilabile
alle posizioni antropocentriche e, in qualche misura, biocentriche20), il
secondo animato dall’idea di una identificazione con l’ambiente naturale, riconosciuto come portatore di un intrinseco valore (attestato su posizioni ecocentriche). La deep ecology di cui parla Naess non è soltanto la
disciplina a cavallo tra scienza naturale e filosofia della natura nomenclata da Haeckel un secolo prima. Traguardando le posizioni etiche dell’ambiente secondo cui la tradizionale immagine dell’imperialismo umano
sulla natura deponeva in favore di un modello orizzontale aperto alla
considerazione di una responsabilità verso i soggetti non umani, la deep
ecology si spinge ancora oltre. Essa non mira solo a edificare una nuova
cultura dell’ambiente, ma avanza una vera e propria visione ecologica del
mondo. Ridisegnare la cornice complessiva del rapporto uomo-natura e
imparare a vedere questo rapporto in una ottica unitaria e non più dualistica diventano, quindi, il progetto di questa corrente di pensiero. Più
di un’etica strictu sensu, essa si rivolge a vari aspetti della vita sociale e
individuale, proponendosi come completa rivisitazione di abitudini mentali e stili di vita.
Per quanto ridotto qui ai suoi termini generici è questo il modello ecocentrico, polemico e innovativo, della deep ecology. All’idea di una realtà
composta da elementi individuali, si preferisce l’ipotesi di una realtà
costruita su una rete relazionale. Ciò significa sostituire il classico paradigma individualistico con un fresco, generale modello olistico. Nell’affermare e realizzare un cambio di paradigma la deep ecology si propone
non solo come approccio filosofico, ma anche come sistema cognitivo,
etico e sociale. Il richiamo all’olismo, così vivo all’interno dell’environmental debate, ben rappresenta il segno della necessità di una visione a
tutto campo, in cui il rapporto tra uomo e natura non viene posto più in
termini dicotomici, ma di complementarietà e co-appartenenza.
L’uomo e la natura possono essere concettualmente separati, devono
riconoscersi in un unico orizzonte di riferimento. Tutto quanto nella
realtà si discosti da questa ideale contiguità e continuità deve essere sottoposto ad una analisi critica sistematica. Anche la società occidentale,
con il suo ordine gerarchico, con la sua divisione in classi, diventa un
20 (n.d.r.) Si veda per un ulteriore approfondimento Pagano P., Filosofia ambientale, Mattioli 1885, 2006
216 - SILVÆ - Anno V n. 11
Declinazioni socio-culturali dell’ecologia per un approccio integrato
momento da superare. L’ecologia può e deve fornire una strada alternativa.
Altre declinazioni
Al pari della social ecology, anche il c.d. ecofemminismo lega strettamente la crisi ambientale a strutture e rappresentazioni culturali presenti nelle società affluenti dell’occidente. Nasce dall’idea che nelle società
tradizionali regolate dal patriarcato, donne e natura siano assoggettate
ad un paritetico dominio, frutto della stessa logica di sopraffazione. Nessuna emancipazione per le donne, nessuna soluzione alla crisi ecologica:
una equazione che impone alle istanze femministe di legarsi a quelle del
movimento ecologico nel tentativo di opporsi ai rapporti di dominio che
informano il modello relazionale, per “provvedere ad una revisione radicale socio-economica”21. Le dicotomie umanità-natura e uomo-donna
sanciscono la superiorità della mente sul corpo, dell’oggettivo sul soggettivo, della ragione sull’emotività. L’antropocentrsimo diventa ben presto
una forma generalizzata di androcentrismo: le ragioni della battaglia ecofemministista mette alla gogna tanto il sessismo che il naturismo, in quanto ideologie caratterizzate da una comune cornice concettuale oppressiva
contraddistinta da una logica di dominio. Ergo, la questione ambientale
si tinge di rosa, assurgendo a “a femminist issue”22, come peraltro è
dimostrato dai numerosi punti di incontro tra le filosofie dell’ambiente e
le rivendicazioni femministe. Scrive Greta Gaard: “L’ecofemminismo
chiede la fine di forme di oppressione, nell’idea che nessun tentativo di
liberare le donne (o ogni altro gruppo oppresso) avrà successo senza un
uguale tentativo di liberare la natura”23. Anche qui l’idea dominante è
che gli esseri umani non sono astratti individui, separati dall’ambiente
sociale e naturale che li circonda.
Ancora una volta l’ecologia rivela un intrinseco potenziale sovversivo,
capace di sollevare ed ispirare una critica severa agli atteggiamenti ideologici dominanti.
A queste dottrine radicali si affianca, sul piano della teoria politica,
l’ecosocialismo (o ecomarxismo): una forma di socialismo post-ideologico
anche detto rosso-verde. Solo in epoca relativamente recente alcune delle
posizioni che si richiamano all’eredità del pensiero di Marx hanno avviato una riflessione sui problemi sollevati dalla questione ambientale.
21 Ruether R.R., New Woman/New Earth. Sexist Ideologies and Human Liberation, Seabury Press, 1975
22 Warren K.J., Ecofeminism. Introduction, in Zimmerman M.E. et al., Environmental Philosophy. From Animal
Right to Radical Ecology, Prentice Hall, Upper Saddle River, 1998
23 Gaard G.C. (a cura di), Ecofeminism: Women, Animals, Nature, Temple University Press, 1993
SILVÆ - Anno V n. 11 -
217
Declinazioni socio-culturali dell’ecologia per un approccio integrato
Nonostante il comune riferimento ad un paradigma forte delle scienze
sociali, occorre notare che, tra gli autori neomarxisti, esiste oggi un
ampio ventaglio di orientamenti che non possono qui essere ricostruiti nel
dettaglio ma che, comunque, non hanno ancora trovato una sintesi generalmente accettata.
Per quanto riguarda il versante politico di questa linea di pensiero,
occorre sottolineare l’importanza del marxismo americano e, in particolar modo, della figura del sociologo ed economista James O’Connor. In
diversi saggi, egli cerca di reinterpretare la teoria marxiana del capitalismo, valorizzandone gli elementi che possono essere ritenuti tuttora
fecondi come strumenti di interpretazione della crisi ambientale che
coinvolge le società capitalistiche contemporanee (O’Connor 1988). Inoltre, egli puntualizza il contributo che i movimenti ecologisti recano alla
lotta anticapitalistica e auspica una sempre più forte convergenza tra la
tradizione socialista e il pensiero ambientalista (O’Connor 1992). I temi
proposti da questo autore sono al centro di un interessante dibattito, che
trova una delle sue sedi nella influente rivista Capitalism Nature Socialism la cui edizione americana è diretta dallo stesso O’Connor (di questa
esistono inoltre una edizione in spagnolo, diretta da Juan MartinezAlier, e una in italiano, il cui titolo attuale è Ecologia Politica e il cui
orientamento ideologico è aperto non solo ai contributi del marxismo,
ma anche a quelli di altre forme di pensiero critico come l’eco-femminismo, il pensiero ambientalista di tradizione non occidentale e le varie
forme di critica radicale ai modelli dominanti di sviluppo socio-economico).
Per quanto riguarda il versante teorico, una posizione di rilievo è
indubbiamente quella di Peter Dickens, un sociologo inglese in cui il riferimento al marxismo classico è presente, ma è coniugato con altre linee
del pensiero contemporaneo con esso compatibili, come ad esempio la
sociologia di Anthony Giddens o la cosiddetta epistemologia del realismo
critico di Roy Bhaskar e, ancora, con richiami allo sviluppo delle scienze
biologiche. Un contributo significativo alla sociologia dell’ambiente, da
parte di Dickens, lo si trova nel libro Society and Nature del 1992, cui va
aggiunto un più recente testo del 1996, Reconstructing Nature, che sviluppa le idee del precedente.
Per Dickens è auspicabile il superamento della rigida divisione del
lavoro tra scienze fisico-biologiche e scienze sociali. Entrambi i campi
disciplinari, infatti, operano con un metodo analogo, che va dall’osservazione dei fenomeni all’analisi dei loro meccanismi generativi, anche se
è vero che esistono significative differenze tra i fenomeni naturali e quelli storico-sociali.
218 - SILVÆ - Anno V n. 11
Declinazioni socio-culturali dell’ecologia per un approccio integrato
Ora, se si assume un punto di vista scientificamente unificato, si deve
essere pronti a riconoscere che “l’ordine sociale è contenuto condizionato dall’ordine naturale da cui esso emerge e su cui, a sua volta, retroagisce” (Bhaskar 1989, Dickens 1992). La constatazione di questo incapsulamento dell’ordine sociale nell’ordine naturale non deve tuttavia condurre ad un riduzionismo naturalistico, ovvero ad una concezione in cui
la società sia considerata semplicemente come un’entità subordinata alle
leggi di natura. Al contrario, il realismo critico - sostenuto da Bhaskar e
dallo stesso Dickens - si propone di interpretare la relazione delle società
umane con la natura come la dipendenza non da qualcosa di estraneo, ma
da un’entità di cui l’uomo stesso già fa originariamente parte. La natura,
infatti, può essere intesa - secondo la celebre frase di Marx - come il
“corpo inorganico dell’uomo”: non solo il corpo umano è esso stesso parte
della natura, ma anche la vita fisica e spirituale dell’uomo implica un
costante contatto con quella parte della natura che è diversa dal corpo
umano, poiché essa è al tempo stesso fonte dei mezzi immediati di sussistenza dell’uomo ed è la materia, l’oggetto e lo strumento della sua attività vitale.
Ma il filone sociologico che affronta più direttamente la relazione
ambiente/società o, se si vuole, il binomio natura/cultura, è, all’inizio del
diciannovesimo secolo, quello della Scuola di Chicago.
Partendo dall’analisi delle città e delle profonde trasformazioni che
essa subisce in quegli anni, questo gruppo di studiosi (tra cui ricordiamo
soprattutto Robert E. Park, Ernest W. Burgess, Harvey W. Zorbaugh),
subendo indubbiamente l’influenza del darwinismo, si propone di fondare una nuova disciplina, definita ecologia umana, che consiste nello studio delle relazioni spaziali e temporali degli esseri umani in quanto
influenzati dalle forze selettive, distributive e adattive che agiscono nell’ambiente. Questa nuova disciplina pretende di applicare alle società
umane, per la verità a volte un po’ forzatamente, le caratteristiche comportamentali rinvenibili nell’ecologia vegetale, i.e. un ordine biotico (una
base biologica innata e caratteristica della specie), fondamento, a sua
volta, dell’ordine sociale. Proprio nell’utilizzazione, da parte di Park, di
Burgess e dei loro colleghi, di questo doppio piano di lettura, appare il
tentativo di rendere intelligibile l’intima relazione esistente tra la dimensione naturale e quella costruita, sia socialmente sia spazialmente. Le
aree naturali (le zone in cui si divide la città e che presentano caratteristiche omogenee per la composizione sociale o etnica della popolazione, o
per gli stili di vita adottati o le funzioni sviluppate), infatti, costituiscono
il punto di incontro tra i principi che regolano ontogeneticamente tutte le
specie, da un lato, e i meccanismi regolativi sociali ed economici, dall’alSILVÆ - Anno V n. 11 -
219
Declinazioni socio-culturali dell’ecologia per un approccio integrato
tro. Nella definizione di questo concetto troviamo così i meccanismi che
operano nella relazione tra territorio e comunità sociali. I principi di
competizione, di invasione e di simbiosi, a cui obbediscono tutte le specie
viventi, sono all’origine della particolare configurazione della città: il
primo spiega la lotta, da parte dei gruppi etnici o dei ceti sociali, per accaparrarsi un territorio il più possibile rispondente ai propri bisogni, mentre il secondo rende ragione dell’alternarsi di differenti popolazioni sulle
varie aree urbane, e infine il terzo rileva le molteplici forme di integrazione tra popolazione e territorio, nonché di uniformazione all’interno
degli abitanti di un’area naturale.
Ferme restando le critiche che si possono muovere all’ingenuità e al
semplicismo con cui il gruppo della Scuola di Chicago ha spesso ritenuto
di risolvere il rapporto in questione, si deve tuttavia riconoscere che questo approccio rappresenta l’ultima tematizzazione esplicita in campo
sociologico, fino al risveglio di interesse contemporaneo, e peraltro limitato a settori specialistici (come, del resto, brevemente argomentato in
queste pagine).
Terza fase
La concreta attuazione dei programmi ecologici di seconda generazione equivale ad una vera e propria rivoluzione culturale, che richiede la
messa in discussione dei sistemi di pensiero consolidati e la capacità di
elaborare e attuare tempestivamente azioni e politiche capaci di futuro,
in grado cioè di interpretare, anticipare, prevedere quello che sta avvenendo e ciò che potrebbe aver luogo, alla luce delle migliori conoscenze
scientifiche.
Possono dirsi maturi i tempi per un terzo stadio della scienza ecologica? È auspicata una stagione post-moderna dell’ecologia, che la renda più
qualificata e disponibile ad affrontare e risolvere la crescente complessità
del vivente attraverso un suo forte coinvolgimento culturale.
Ma, quand’anche l’edificazione di una ecologia culturalmente mediata non apparisse troppo ardita, quali fondamenti epistemologici interverrebbero a sostegno di questa inedita prospettiva?
La dimostrazione della sopravvenuta necessità di una nuova dimensione ecologica è, come evidenziato in apertura del presente lavoro,
davanti gli occhi di tutti. Soluzione edificante ed edificanda risulterà,
pertanto, quella più prossima all’analisi integrata di sistemi naturali e
culturali che, indagando lo stretto legame esistente tra natura ed essere
umano, sappia comunque tenere in conto l’intima relazione tra evoluzione naturale ed evoluzione socio-culturale. Ogni proposta di soluzioni ori-
220 - SILVÆ - Anno V n. 11
Declinazioni socio-culturali dell’ecologia per un approccio integrato
ginali dovrà essere subordinata alla conduzione attenta di un programma
idoneo a creolizzare la componente sistemica naturale e quella sociale.
Solo l’integrazione delle conoscenze scientifiche ottenute specialmente
dalle discipline di impostazione olistica e di taglio storico (come la biologia, geologia, ecologia, climatologia, oceanografia, etc…), armonizzate
con la conoscenza delle interrelazioni ricavate dalle scienze umanistiche
e sociali, mirate a valutare, sia a livello regionale che mondiale, i rapporti
intrasistemici esistenti, assicura la sopravvivenza del pianeta, in quanto
imprescindibile condicio sine qua non del cambiamento prospettico
auspicato.
Beato (si veda il paragrafo 2) non è il solo a ricordare l’esistenza di
forti barriere, soprattutto culturali, che impediscono di affrontare con
capacità innovativa e di futuro le sfide che abbiamo di fronte e soprattutto di affrontare i problemi in un approccio realmente negoziato e transdisciplinare24.
È indispensabili un confronto a tutto campo con ciò che la cultura rappresenta, anche in relazione alla elasticità interpretativa del suo essere
sistema25.
Recentemente il genetista di popolazioni Luigi Luca Cavalli Sforza ha
proposto una interessante definizione di cultura dal taglio più evolutivo:
“L’accumulo globale di conoscenze e di innovazioni, derivante dalla
somma di contributi individuali trasmessi attraverso le generazioni e diffusi al nostro gruppo sociali, che influenza e cambia continuamente la
nostra vita”. Lo stesso sostiene altresì che la cultura abbia una base biologica “si può dire che la cultura sia un meccanismo biologico, in quanto
dipende da organi, come le mani per fare gli strumenti, la laringe per parlare, le orecchie per udire, il cervello per capire, etc…, che ci permettono di comunicare fra noi, di inventare e di costruire nuove macchine
capaci di esercitare funzioni utili e speciali, di fare tutto quel che è necessario, desiderato e possibile”. (…). “L’uomo ha potuto avere una evoluzione molto rapida rispetto ad altri organismi viventi, pechè ha sviluppato la cultura più di tutti gli altri animali. Infatti la cultura può esser considerata un meccanismo di adattamento all’ambiente straordinariamente
efficiente”26.
Secondo l’etologo Konrad Lorenz “l’evoluzione culturale dell’umanità
procede dritto davanti a sé, sempre più veloce; in questo momento ha
raggiunto un movimento così rapido che non è esagerato affermare che,
24 Gunderson L.H., Holling C.S. e Light S.S., Barriers and Bridge sto the Renewal of Ecosystem and Institutions,
Columbia University Press, 1995
25 (n.d.r.) Per una definizione anche contenutistica del concetto di cultura si veda Signorelli A., Antropologia culturale, McGraw-Hill, 2007
26 Cavalli Sforza L.L., L’evoluzione della cultura, Codice Edizioni, 2004
SILVÆ - Anno V n. 11 -
221
Declinazioni socio-culturali dell’ecologia per un approccio integrato
al confronto con l’evoluzione culturale, l’evoluzione genetica possa essere considerata trascurabile, addirittura uguale a zero. I mutamenti della
cultura umana si compiono secondo ritmi tanto veloci da escludere del
tutto che lo sviluppo genetico della specie possa tenervi dietro, possa
restare al passo”. Quale via di uscita? “La sensibilità degli uomini verso
determinati valori. L’evoluzione della vita organica sul nostro pianeta e
nel nostro presente procederà verso l’alto oppure verso il basso? Sarà
l’uomo a decidere e ne porterà l’intera responsabilità”27.
Il monito è ben chiaro: senza una specifica sensibilità per i valori, al
problema dell’agire umano non si potrà dare risposta alcuna, né con
comandi, né con divieti. Ma l’attuale formazione di valori sconta il fatto
che la cultura dominante è fondamentalmente economica e tecnocratica,
carente di conoscenze e di approcci di stampo ecologico e men che meno
umanistico.
Il problema culturale è essenzialmente una questione giocata su scale
di sistemi valoriali.
Il grande dilemma del ragionamento ambientalista per il grande studioso di Harward, Edward Wilson, deriva dal conflitto fra valori di lungo
periodo e valori a breve termine. La scelta dei valori per il futuro immediato della propria comunità è relativamente impegnativo, scegliere per il
futuro lontano dell’intero pianeta richiede una accresciuta consapevolezza. Meticciare le due visioni per creare un’etica ambientalista universale
è tanto complesso quanto necessario28.
La stragrande maggioranza dei policy makers ignora le basilari conoscenze dell’ecologia, vive in una dimensione culturale distante dalla natura, dalle conoscenze delle sue funzioni, dei suoi processi, delle sue dinamiche.
Un tentativo sui generis, nella direzione di un maggiore e più consapevole coinvolgimento culturale delle hard sciences, è rappresentato dall’interpretazione agita dall’ecocritism (ecologia letteraria o ecocritica). Il
termine spunta tra le righe di un articolo datato 1978 di Wiliam
Rueckert, sebbene l’idea di una critica letteraria ecologica appartiene ad
un libro, datato 1972, di Joseph Meeker, The Comedy of Survival: Studies in Literary Ecology, con la prefazione di Konrad Lorenz. Nelle
intenzioni di Meeker l’ecologia letteraria avrebbe dovuto occuparsi dello
studio dei temi e delle relazioni biologiche che appaiono nelle opere letterarie e, al tempo stesso, di rinvenire il ruolo occupato dalla letteratura
nell’ecologia della specie umana. L’interpretazione ecologica dei testi letterari permette di acquisire e trasmettere una coscienza critica del rap27 Lorenz K., Il declino dell’uomo, Edizioni ISEDI, 1990
28 Wilson E.O., Il futuro della vita, Codice Edizioni, 2004
222 - SILVÆ - Anno V n. 11
Declinazioni socio-culturali dell’ecologia per un approccio integrato
porto tra essere umano e ambiente. Come scrive Scott Slovic “non esiste
una singola opera letteraria che non possa essere fatta oggetto di interpretazione ecocritica”29. Del resto sono sempre più numerosi gli studi
dedicati a intersezioni tematiche e prospettiche ad esempio con l’ecofemminismo, con la sociologia e le questioni di giustizia sociale, la scrittura
nativa e afroamericana, con l’ecologia urbana e gli studi sul paesaggio, il
cinema, l’arte, la pratica pedagogica , la semiotica30.
In epoca post-moderna, l’idea che un ordine culturale possa proficuamente informare i migliori propositi ecologici è communis opinio, condivisa anche da intellettuali prossimi a posizioni di matrice tradizionalmente scientista.
L’ecologa Nancy Langston ha scritto che “tutte le ipotesi sono soltanto
modelli parziali, semplificazioni del mondo influenzate dalle lenti culturali attraverso le quali guardiamo la natura. Tuttavia i modelli implicano
che lo scienziato si rapporti con il mondo in un modo importante: il metodo scientifico richiede che egli si accosti al mondo con mente aperta; si
suppone che egli consideri le sue idee con umiltà, che modifichi le sue ipotesi se i risultati non le sostengono. Questo processo non è mai privo di
pregiudizi; le idee iniziali su come dovrebbe funzionare il mondo plasmano il modo in cui si costruiscono le ipotesi, ciò che si vede quando ci si
accinge a verificare quelle ipotesi è ciò che si ritiene valga la pena di notare. La storia dell’ecologia è consistita in una lunga serie di negoziazioni
con il mondo naturale, (…). L’ecologia non è in grado di offrire una visione del mondo pura, non contaminata dalla politica e dall’incertezza; tuttavia è uno strumento essenziale per rendere più sostenibili le relazioni
dell’uomo con la natura”31.
Conclusioni
Gli uomini si confrontano da sempre con la natura che li circonda e
con la quale interagiscono.
Nel corso della storia le concezioni umane della natura sono via via
mutate in funzione delle diverse ipotesi culturali relative al ruolo della
specie umana sulla terra, e tali idee hanno a loro volta influenzato i modi
in cui la nostra specie trasforma e modifica i sistemi naturali del pianeta.
La cultura (come insieme di pratiche e valori), non seguendo i tempi
classici dell’evoluzione biologica, si diffonde con grande rapidità ed
29 Slovic S., Ecocriticism: Containing Moltitudes, Practising Doctrine, in Ecocriticism at the MLA: a Roundtable,
Asle News, 11/1 - 1999.
30 Iovino S., Ecologia letteraria, Edizioni Ambiente, 2006.
31 Langston N., in Dodson S.I. et al., , Ecologia, Zanichelli, 2000.
SILVÆ - Anno V n. 11 -
223
Declinazioni socio-culturali dell’ecologia per un approccio integrato
influenza le percezioni individuali, il nostro modo di vedere il mondo,
condiziona ciò che ciascuno di noi considera importante e suggerisce i
comportamenti che possono essere ritenuti appropriati o inappropriati a
seconda delle situazioni.
Sappiamo bene che oggi il modello culturale di origine occidentale,
basato sull’impostazione di società industriali e post-industriali, tecnologicamente avanzate e ispirate a principi economicistici e consumistici
radicati in una sconfinata rete commerciale globale, è dominante, ormai
esteso a livello planetario e sta penetrando persino nelle società che ancora vivono con relazioni sociali che potremmo definire di economia di sussistenza. Comprendere quanto la cultura imposta dai codici dominanti
sia distante dall’originale legame e dal contatto fisico con i sistemi naturali è il vero e centrale problema che impedisce la compiuta attuazione di
politiche di sostenibilità e integrazione.
L’interdisciplinarietà ricercata si colloca in una dimensione che è e
deve essere dichiaratamente prospettica. Ricerca interdisciplinare non
significa connessione di conoscenze già acquisite, ma condizione per la
loro acquisizione. E questo nuovo modo di sorgere della scienza è possibile perché al fondo dell’esigenza interdisciplinare sta il principio dell’unità della scienza. La tensione all’unità è sentita da tutte le discipline
come un ritorno alle origini, alla riscoperta della primagenia del conoscere. Ove si accetti una siffatta concezione sarà necessario riconoscere
che la interdisciplinarietà non è sollecitata dalla necessità o dall’opportunità di collegare in un sistema ciò che è noto, ma è richiesta dallo sviluppo che non solo la scienza, ma anche l’esistenza, vuole avere.
Il contributo di una cultura ecologica inclusiva e narrativa agevola la
comprensione della complessità sociale, spariglia la edulcorata gerarchia
tra ecologia della natura ed ecologia della società, riconoscendo il valore
di una differenza che è soprattutto unitas multiplex del vivente.
224 - SILVÆ - Anno V n. 11