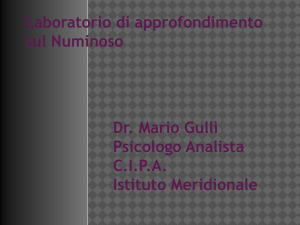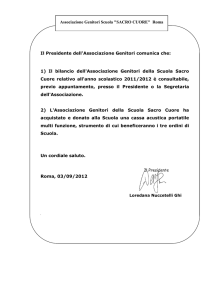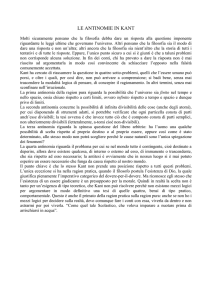G. Limone, L’irrimediabile libertà. Percorsi e figure, in “Filosofia e teologia”, Anno XII,
1(1998), pp. 79-92, ISSN 1824-4963.
L’irrimediabile libertà. Percorsi e figure
di Giuseppe Limone
La libertà è un problema. Nel senso che è un problema non solo il parlarne come di un quid del
mondo, ma già l’universo che il suo nome evoca e – nascostamente – decide. Il nome, infatti, non è una
semplice denotazione della cosa: è una decisione sulla cosa. Ma questa «decisione» implica, la si espliciti
o no, un’argomentazione. Argomentazione le cui tracce possono riconoscersi in decostruzioni di modelli linguistici, in analisi di stili di pensiero, in ermeneutiche di figure, per l’individuazione di alcuni specifici blocchi problematici ragionati. S’intende, qui, tracciare solo un diagramma di possibili vie.
1. La prima via: dell’implicazione («analitica»)
«Penso, dunque sono». La proposizione cartesiana continua a far discutere come origine della modernità. «Penso, dunque sono» o «Penso, dunque penso che sono»? È stato Emanuele Severino a mettere in luce come questo «sono» non concerne ancora l’essere in atto (l’essere formale), ma solo l’essere
del cogitare in relazione al cogitatum1: e che il passaggio decisivo dall’essere del cogitare all’essere formale
del cogitante accade solo nell’ulteriore snodo in cui, operando con l’idea chiara e distinta della causalità,
si afferma che nella causa dell’idea cogitata «si trovi per lo meno tanta realtà formale quanta realtà oggettiva contiene questa idea»2.
Ma c’è una questione nascosta nella proposizione affermata da Descartes come incontrovertibile.
Essa riguarda prima che la sua dichiarata autoevidente verità, il fatto che, nel qualificare pensare questa
cosa che qui ora in me accade, sto già postulando, implicando, che in essa si diano: 1. uno specifico
dell’uomo; 2. un itinerario – concludibile o no, ma di cui si postula l’esperibilità – verso una cercata verità. Chiamare questa cosa «pensare» significa averne già deciso – nascostamente deciso – i connotati.
Descartes non dice «Agisco, dunque sono», perché anche di questo agire potrei dubitare. Ma dubitare è
pensare. È pensare? Pensar di pensare è già essersi decisi per i connotati intrinseci nella qualificazione
linguistica «pensare». Ossia, per un quid che non è un mero meccano. Per una libertà cercante e per una
verità cercata. Per un quid che commisura, pondera e decide. Per una ragione. In tale contesto, sia la
proposizione cartesiana sia le proposizioni scettiche che Cartesio combatte (in quanto si autoaffermino
1
2
E. SEVERINO, La filosofia moderna. I grandi problemi del pensiero moderno da Cartesio a Hegel, Rizzoli, Milano 1991, pp. 62- 67.
E. SEVERINO, La filosofia moderna. I grandi problemi del pensiero moderno da Cartesio a Hegel, cit., p.67 s.
pensieri), appartengono al medesimo universo di verità. Che dica o che neghi la «verità», se assumo
questo mio dire e negare come «pensare», mi pongo come dicente verità. Ma ciò per la ragione da me
medesimo posta in cui mi pongo – mi qualifico – pensante: ossia nel mio disconoscermi come automa
o meccano. L’autocomprendersi come pensanti è un autocomprendersi come autoorientantisi verso una
verità. Quindi, come agenti una libertà.
Scrive Kant: «Questo biasimo [quello esercitato contro un uomo che dica «una menzogna malefica»
da cui derivi «alla società un certo scompiglio»3] si fonda su una legge della ragione, per cui questa si riguarda come una causa che poteva e doveva determinare altrimenti la condotta dell’uomo, indipendentemente da tutte le dette condizioni empiriche [che l’hanno determinata]»4. «Quindi – dice Kant – la ragione, malgrado tutte le condizioni empiriche del fatto, era pienamente libera, e il fatto è da ascrivere
interamente alla sua omissione»5. In realtà, nota Kant, «In questo giudizio d’imputazione è facile vedere
che si pensa che la ragione non subisca l’influsso di tutta quella sensibilità; che essa non si muti (…),
che in essa non preceda uno stato che determini il successivo; e però che essa non appartiene punto alla
serie delle condizioni sensibili che rendono necessari i fenomeni secondo le leggi naturali»6. Cioè, si implica che «essa, la ragione, è presente e unica in tutte le azioni dell’uomo in tutti gli stati del tempo»7,
perché «essa stessa non è nel tempo, e non capita, per così dire, in un nuovo stato, in cui prima non era
…»8. D’altra parte, a conclusione, Kant si affretta a precisare che «con ciò non abbiamo inteso di esporre la realtà della libertà (…) Che anzi, non abbiamo neppure voluto dimostrare la possibilità della libertà
…»9. «La libertà – nota Kant – qui è trattata solo in quanto idea trascendentale, onde la ragione pensa di
iniziare assolutamente la serie delle condizioni del fenomeno mediante qualcosa di incondizionato rispetto al senso …»10.
Ci si domanda. Questo discorso kantiano, concernente specificamente l’agire, come potrebbe non
riguardare pur anche quello specifico agire che è il conoscere e il pensare? Ci si dirà che, in Kant, il conoscere non è l’agire. Ma perché mai gli argomenti kantiani sviluppati in relazione all’agire non dovrebbero essere ripetibili per il conoscere e il pensare, perlomeno ove si rivolga l’attenzione non solo alla ragione in quanto guarda l’uomo che agisce ma anche alla ragione in quanto guarda l’uomo che conosce e
che pensa? Gli argomenti che valgono per l’agire (in quanto teso al bene) come potrebbero non valere,
a fortiori, per il conoscere e per il pensare (in quanto tesi al vero)?
E. KANT, Critica della Ragion pura, vol. II, Laterza, Bari 1972, p.443.
Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 KANT, Critica della Ragion pura, vol. II, cit., p. 445.
10 Ibidem.
3
4
In realtà, la ragion teoretica kantiana, mentre afferma, della «libertà», sia la possibilità (il fatto che
non sia autocontraddittorio pensarla11) sia l’indimostrabilità teoretica, d’altra parte, però di fatto la implica, la libertà, nella stessa idea di ragione che la ragione, operando, di sé medesima ha. In effetti, la ragion teoretica kantiana vive un’antinomia anche in termini diversi da quelli da Kant rappresentati. Infatti, da un lato, la legge della ragione implica la libertà, dall’altro esprime la necessità 12: due piani distinti
che, in una delle antinomie kantiane (nel terzo conflitto delle idee13), si presentano trasferiti sull’unico
piano di una rappresentazione bipolare.
Per Kant, l’azione morale presuppone necessariamente la libertà14. Ci si domanda. Come potrebbe
non supporla l’azione pensante?15 La scienza moderna e contemporanea, sviluppandosi lungo le due
coordinate di un pensiero che misura e di un pensiero che cerca, costituisce progressivamente, per così
dire, due poli di una contraddizione clandestina. Significativa, in proposito, la posizione di Michel Foucault, collocabile in uno dei fuochi in cui questa contraddizione esplode. Da un lato, infatti, nella sua ricerca stratigrafica si annuncia un «uomo» che, sottoposto a un potere scientificizzato capace di numerarlo in ogni punto del suo essere, non c’è più; dall’altro, proprio il Foucault scienziato che studia questo processo, esplicitamente afferma contro i suoi critici: «Ci si lasci almeno liberi quando si tratta di
scrivere»16.
2. La seconda via: della «genealogia per distacco»
Libertà è distaccarsi. Da una «Totalità». Che, nell’atto stesso in cui accade il distacco, degrada a «totalità». Ossia, a una totalità rappresentata, che, ipso iure, non è più Totalità. Rispetto alla quale il nominare
stesso è incoativa presa di distanza, tentato raggio di fuga. Qui, libertà è poter «smettere il gioco» di cui
si è parte. Potremmo vederne alcune figure.
a. In un percorso che lega Hegel e Lacan è stato osservato come la «funzione simbolica» - come funzione del Logos nominante - è la funzione umana del Logos che, nominando, proietta il nominato in
E. KANT, Critica della ragion pura, vol. I, p.27 s., e vol. II, p.435 ss. E ciò valga anche se c’è un punto in cui Kant lo nega
(vol. II, p.445): in realtà, l’oscillazione teorica è dovuta al fatto che egli intende negare di aver fondato la possibilità reale, non di
aver ammesso la possibilità logica.
12 Kant ne è consapevole: «La libertà (…) trattata in quanto idea trascendentale (…) s’avvolge in un’antinomia con le sue
proprie leggi, che essa prescrive all’uso empirico dell’intelletto» (Critica della ragion pura, vol. II, p.445).
13E. KANT, Critica della ragion pura, vol. II, p.368 ss.
14 E. KANT, Critica della ragion pura, vol. I, p. 28.
15 È un punto su cui, per certi versi, si svolge la stessa critica di Kelsen a Kant: «Se, come afferma Kant, la ragion teoretica e
la ragion pratica sono la medesima ragione, ma due distinte facoltà conoscitive, non è possibile ritenere vero ed esistente, dal
punto di vista della ragion pratica, ciò che non può esser ritenuto vero o esistente dal punto di vista della ragion teoretica,
come (…) il libero arbitrio» (Hans KELSEN, Il problema della giustizia, Einaudi, Torino 1975, p. 97, sub nota 5).
16 M. FOUCAULT, L’archeologia del sapere, Rizzoli, Milano 1980, p. 25. In un dibattito, avvenuto a Eindhoven, fra Noam
Chomsky e Michel Foucault (di cui dà conto Giustizia e natura umana, Edizioni Associate, Palermo-Sao Paulo [Brasile] 1994) è
molto interessante notare come, contrariamente a Chomsky, Foucault ripetutamente sfugga a ogni tentativo di ancorare la
«creatività» a una «soggettività» e a una «libertà» (p. 35 ss., p.47, p. 47 s, p. 50, etc.).
11
una rete di nuovi possibili futuri17: un dire che non è il mero «dire-ripetere», ma è quel «dire altrimenti
all’altro» in cui accade il «disassoggettamento»18.
b. Per uno strano paradosso del logico, lo stesso teorema di Gödel, in quanto nega la possibilità di
un sistema che possa costituirsi come metasistema di ogni possibile sistema, apre un varco sfondazionale a questa «libertà». L’infondabilità di ogni sistema formalizzato – l’inaffidabilità radicale di ogni fondamento detto che si ponga come ultimo – può essere una paradossale apertura, sul versante del fondamento, a quest’altra libertà. C’è un fenomeno linguistico indoeuropeo, studiato da Emile Benveniste.
Egli si domanda se tra il latino «fides» («fiducia»), il gotico «beidan» («attendere») e l’antico slavo «beda»
(«costringere») ci possa essere vicinanza e come possa questa vicinanza essere semanticamente disegnata. La risposta che Benveniste dà inclina per l’istituibilità di un preciso sentiero di collegamento: « … si
può immaginare che il rapporto fra beidan e baidjan sia analogo a quello fra il greco peithomai ‘fidarsi di’ e
peitho ‘spingere qualcuno a obbedire’. Questo vale anche per l’antico slavo beda ‘costrizione’»19. Assumendone specifiche suggestioni teoretiche, potrebbe qui dirsi: fondare è fidarsi, fidarsi è fondare.
c. Le figure politologiche della «libertà da» e della «libertà di» si rivelano, in questo contesto, regionali specificazioni di un tale staccarsi. Il no è la sottostruttura del sì; staccarsi, la precondizione del riprendere parte.
d. Per certi versi, le teorie dell’«evento», pur delegittimando – spiazzando – come antropomorfica e
priva di senso la libertà, costituiscono, per così dire, il metalivello del pensiero che si distacca dal proprio essere pensiero costringente ogni parte in una totalità strutturata. Sono teorie che pensano, in realtà, l’«evento» prospettando – proiettando – l’atto del proprio distacco in termini topologici: in una «situazione» che buca il determinismo («l’indecidibile è un attributo fondamentale dell’evento»20). Nel
nuovo contesto teoretico, l’evento è, per così dire, nel topos della struttura, la proiezione geometrica
della libertà. Un mito della caverna alla rovescia.
Molte delle teorie che spiazzano la libertà sembrano farlo attraverso totalità strutturate troppo presto: con un penultimo scambiato per ultimo.
3. La terza via: quella del «sacro»
Intendiamo riferirci, qui, in modo particolare, all’analisi centrale che Rudolf Otto svolge del sacro 21.
Il sacro è, per Otto, innanzitutto, il numinoso. Il «numinoso» che è il «sovrappotente»22, il «tremendo»23,
il «deinòs»24: ciò verso cui e a partire da cui l’uomo non può far altro che incarnare l’assoluta propria
B. ROMANO, Per una filosofia del diritto nella prospettiva di Jacques Lacan, Bulzoni, Roma 1991.
B. ROMANO, Per una filosofia del diritto nella prospettiva di Jacques Lacan, cit., p. 265.
19 E. BENVENISTE, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, Einaudi, Torino 1976, vol. I, p. 89.
20 A. BADIOU, L’essere e l’evento, Il Melangolo, Genova 1995, p. 499.
21 R. OTTO, Il sacro. L’irrazionale nell’idea del divino e la sua relazione al razionale, Feltrinelli, Milano 1989.
22 R. OTTO, Il sacro, cit., pp. 28-30.
23 R. OTTO, Il sacro, cit., p. 24.
24 R. OTTO, Il sacro, cit., p. 51.
17
18
subordinazione in quanto condizione del nulla25. Il luminoso non può assolutamente essere detto attraverso determinazioni razionali. Anzi, di più, il numinoso non può essere detto neanche attraverso determinazioni ontologiche, fossero pure determinazioni «ultrarazionali»26. Unilaterale ed erroneo, infatti,
sarebbe tradurre «santo» con «trascendente», ossia con una specifica connotazione ontologica27. La quale, per così dire, pur indicando il soprarazionale, viene a configurarlo pur sempre in forma razionale:
neutralizzandolo. Il come neutralizza il che. Il numinoso è, invece, nel fondo, una reazione radicale
dell’anima non spiegabile per concetto28. Una reazione intrinseca nello «sgomento»29. Otto dice anche
«il fondo dell’anima»30. Un «a priori»31.
Per intendere bene una tale prospettiva, bisogna capire come Otto critichi lo stesso «sentimento di
dipendenza» a partire dal quale Friedrich Schleiermacher indica l’accesso al numinoso. Infatti, per Otto,
un tale sentimento configurerebbe il numinoso in una troppo generica situazione di creaturalità32, laddove, invece, per lui, nel numinoso si è di fronte a una «cosa» che, «nonostante tutte le somiglianze e
tutte le analogie, è qualitativamente diversa da tutti i sentimenti analoghi»33. Non solo. Otto, mentre critica la «sedicente teologia dialettica»34 e il suo discorso sull’«Altro», afferma che «l’autentico mirum è …
il “completamente altro”, il thàteron, l’anyad, l’alienum, l’aliud valde, l’estraneo straniero … assolutamente
fuori dell’ordinario e con l’ordinario in contrasto, e ricolmante quindi lo spirito di sbigottita sorpresa»35. Infatti,
«le raffigurazioni degli spiriti e le concezioni affini sono piuttosto tutte forme posteriori di “razionalizzazione”, che tentano di chiarire in una qualsiasi maniera l’enigma del mirum, e hanno sempre l’effetto di
indebolire e assottigliare l’esperienza stessa. Da essa rampolla non già la religione, bensì la traduzione razionale della religione, la quale finisce poi in una così massiccia teoria con interpretazioni così banali, che il mistero ne è decisamente cacciato»36.
Tutto il lavoro compiuto dall’interpretazione del numinoso appare, in realtà, un lavoro surrettizio e
complesso di traduzione dell’irrazionale in schemi razionali. Il numinoso come irrazionale di Otto non è,
quindi, il non razionale in quanto opposto al razionale; né il non razionale in quanto distinto dal razionale;
né il non razionale in quanto sopra-razionale, ma è la sovrappotenza in quanto anteriore a queste distinzioniarticolazioni: è – dal punto di vista ‘a valle’, ex post, di quest’articolazione – il venire a coincidere e a combat-
R. OTTO, Il sacro, cit., p. 30 ss., p. 94, p. 36 s.
R. OTTO, Il sacro, cit., p. 62.
27 Ibidem.
28 R. OTTO, Il sacro, cit., p. 22.
29 R. OTTO, Il sacro, cit.,.p. 21.
30 R. OTTO, Il sacro, cit., p. 48.
31 R. OTTO, Il sacro, cit., p. 134.
32 R. OTTO, Il sacro, cit., p. 22 s, p.48, p. 142 ss.
33 R. OTTO, Il sacro, cit., p. 20. La sottolineatura è nostra.
34 R. OTTO, Il sacro, cit., p. 186.
35 R. OTTO, Il sacro, cit., p. 35.
36 R. OTTO, Il sacro, cit., p. 35 s. Le sottolineature sono nostre.
25
26
tersi di tutte queste contestuali determinazioni: è «simbolo»37. In questa prospettiva, gli attributi ontologici
di Potenza, di Ordine, di Bene, di Giusto, di Bello si rivelano, in realtà, progressive enucleazioni –
estrapolazioni – di idee razionali dal costato del numinoso: mettendolo in regolato assetto di ragione. E ci
accorgiamo di aver qui nominato – non a caso – alcuni dei medievali trascendentali dell’Essere. Ma, se
ben si osserva, le progressive costole del Numinoso non sono meri concetti razionali: sono simboli. La
Potenza è simbolo. L’Ordine è simbolo. Il Bene è simbolo. Il Giusto è simbolo. Il Bello è simbolo. Sono rappresentazioni mentali - «noemi-segni» - in cui si dà la forza dei simboli. In realtà, ciò che appare in
questione e che la neutralizzazione razionale del Numinoso a suo modo intepretativamente decide è: la
Potenza del Numinoso è Selvaggia Potenza, in quanto tale autoconsistente nel suo dover essere rispettata
oppure invece consiste in determinazioni razionali che ne rendono convincente l’impero? Detto in altri termini: è la Potenza ad imporre arbitrariamente il Valore come Valore o è il suo Valore intrinseco a rendere
persuasiva la Potenza? Cogliere nel Numinoso determinazioni razionali significa, per così dire, decidersi
emozionalmente per una prospettiva ottimistica dello stesso. Assumerlo, cioè, interpretativamente in
un’accezione che lo rende, appunto, razionalmente avvistabile, almeno in linea tendenziale. Ossia: dire
Ordine della Potenza è dire che in essa è leggibile un Ordo (= non Le appartiene il Tremendum
dell’Arbitrario, dell’Imprevedibile). Dire Bene dell’Ordine è dire che in questo Ordo è leggibile un Bene,
un Giusto (= non Gli appartiene il Tremendum del Male). Dire Bello di questo Giusto è dire che il suo
Fascinare è positivo (= non Gli appartiene il Tremendum dell’Orrido). In realtà, nel Numinoso potrebbero
vivere le molteplici Commistioni Tremende che caratterizzano gli Dei indoeuropei, di cui si è occupata la
più agguerrita critica storico-antropologica (vedi Kerenyi, Dumézil, Zimmer, Eliade, etc.). Ma dire questi attributi nella loro distinzione (formale, o modale, o accidentale), se non nella loro separazione, è dire
che essi possono anche essere colti nella loro relativa autonomia (dire Potenza non è dire Ordine; dire
Ordine non è dire Giusto; dire Giusto non è dire Bello). E dire tutti questi attributi come interpenetrati e
connessi è, invece, che il Numinoso è stato messo in assetto di ragione. In articolato, persuasivo, addomesticato assetto di ragione. Di una ragione conciliata38.
Ma che cos’è, in questo contesto, la libertà se non un’altra – una ulteriore – costola del luminoso? Lo
«Spirito che soffia dove vuole», che, nella sua numinosità, è «sovrappotenza» schiacciante e terrifica, neutralizzato in forma razionale, diventa appunto libertà. È quanto Rudolf Otto vigorosamente sottolinea
per il cristianesimo e contro Hegel. «In Giovanni il cristianesimo assimila dalle religioni vitali luce e vita e
a pieno diritto, perché solo nel cristianesimo luce e vita si trovano a casa loro. Ma che cosa sono luce e
vita? Chi non lo sente è di legno. Sono una esaltazione dell’irrazionale. Non si creda che tutto ciò non sia veÈ evidente che in questa «forma» in cui l’emozione il fatto e il valore sono un tutt’uno indistinto nella «reazione dell’anima», anteriore a
ogni articolazione, la distinzione razionale moderna tra «fatto» e «valore» non ha significato. O meglio: si rivela una paradossale
fallacia. Ossia, una negazione della «fallacia naturalistica» che genera una «fallacia razionalistica».
38 In realtà, tutto il percorso medievale di discussione intorno ai concetti di «Potestas absoluta» e di «Potestas ordinata», tutto
il plurisecolare dibattito fra «volontarismo teologico» e «razionalismo teologico» («il Bene è Bene perché Dio lo vuole, oppure all’inverso, Dio vuole il Bene perché è Bene?») sono un commento travagliato a questo problema.
37
ro anche di quell’inciso giovanneo al quale i razionalisti amano riportarsi con più vivo compiacimento:
“Dio è Spirito” (IV, 24). A queste parole faceva appello Hegel per riconoscere e proclamare il cristianesimo come la religione più sublime, perché la genuinamente spirituale, poggiante cioè su Dio come Spirito, vale a a dire come assoluta ragione. Ma questo si chiama grossolanamente fraintendere poiché, parlando di
Spirito, Giovanni non pensa affatto all’assoluta ragione, bensì a ciò che è in assoluto contrasto con tutto il mondo, con ogni
carne, all’essenza cioè puramente celestiale e ,miracolosa, a tutto ciò che è misterioso e sorprendente, che è al di là di ogni
comprensione e di ogni intelligenza umana. Ha di mira cioè lo Spirito che “dove vuole soffia. Tu cogli molto
bene la sua voce, ma non sai donde venga e dove si diriga”»39.
Il Numinoso «che soffia dove vuole» diventa, elaborato razionalmente, libertà. Libertà che è una sua
costola, una sua scheggia. E il processo di neutralizzazione razionale significa, appunto, trovare strade
alla comprensione, e – quindi – alla relazione con il suo Evento. Alla «ratio» in quanto «relatio»40. Ma la stessa
libertà – già costola razionale del Numinoso – può essere messa in (ulteriore stato di) ragione. Può essere
ulteriormente neutralizzata. Relazionandola a una responsabilità. La libertà che si autocircoscrive in una
responsabilità è il corrispettivo di un Dio che si autocircoscrive in un Bene e di un Dio che si autocircoscrive in una relazione: con l’uomo. Il dialogo di Dio con l’uomo non è altro che la forma mitica – narrante – di un Numinoso che si neutralizza in una razionalità e in una relazionalità.
Il Dio biblico fa l’uomo a sua immagine e somiglianza. Farlo simile a sé significa farlo razionale, pensante, libero. Nella strategia mirata a trovare una somiglianza con Dio opera in realtà la strategia del costruire la razionalità di quel Dio. Ciò che nella via discendente – da Dio all’uomo – è somiglianza, nella via ascendente – dall’uomo a Dio – è apofaticità. La somiglianza è una delle strategie della neutralizzazione. Ragione e libertà si rivelano due precise forme geometriche di elaborazione dal numinoso.
Il numinoso – una costola del numinoso –, quindi, trànsita nell’uomo come libertà. Forse è la segreta
ragione per cui la libertà – in quanto appartiene all’ordine del simbolo come ordine del valore – imperiosamente resiste a ogni tentativo di spogliarne e ritrascriverne le note in una mera descrittiva analitica41.
In questa prospettiva, tutte le critiche – da Senofane a Spinoza – rivolte contro la visione antropomorfica degli dei provano troppo. Perché la stessa idea di ragione implicata nella ragione delle cose e la stessa
idea di ragione che critica l’antropomorfismo degli dei sono, in quanto libera contemplazione della necessità, un’antropomorfosi del divino.
4. Il mito di Prometeo
Del mito di Prometeo esistono più varianti. Esso sembra, però, nascondere un nucleo forte essenziale. Quasi un archetipo. Donde una sapienza sommersa può essere, forse, disoccultata. Un archetipo, inR. OTTO, Il sacro, cit., p. 98. Le sottolineature sono nostre.
Si direbbe: Il Bene è ‘ciò che Dio vuole’ – qualunque cosa egli voglia – o Dio vuole il Bene perché è Bene? La prima forma
dice il possibile «irrazionale» del numinoso (è la prospettiva del «volontarismo teologico»); la seconda forma, la sua «razionalità» (è la prospettiva del razionalismo teologico).
41 Per una simile impresa, vedi L’idea di libertà, Feltrinelli, Milano 1996.
39
40
fatti, può darsi – si dà – come struttura invariante nella declinazione di molte varianti. Il cui molteplice esistere spesso, lungi dall’oscurare la radice comune, meglio la svela. Meglio ne svela l’inconfessato. Non
occorre, in questo senso, che un «archetipo» sia immutabile: basta appartenga a uno strato di durevolezza
più duro della fluida storicità. Durevolezza che non implica necessariamente fondazioni ontologiche.
Prometeo è colui che ruba il fuoco agli dei. È colui che dona il fuoco agli uomini. È colui che Zeus
mette in catene per potergli carpire ciò che sa. Ma è anche colui che plasma gli uomini a immagine degli
dei (Ovidio, Metamorfosi). In Ovidio, per esempio, c’è il Prometeo che plasma gli uomini, non il Prometeo che ruba il fuoco. C’è da domandarsi. 1. Il Prometeo che plasma gli uomini a immagine degli dei e il
Prometeo che agli dei ruba il fuoco non possono essere visti come declinazioni di un medesimo nucleo
essenziale? 2. E, d’altra parte, il Demiurgo platonico che plasma le cose a immagine delle idee non può rivelarsi, nella declinazione del medesimo nucleo, lo stesso Prometeo che dona e che ruba? 3. E, d’altra
parte ancora, ha da fare con la figura del Prometeo che dona e che ruba, e col Prometeo che plasma, il
Prometeo che, incatenato, sa? Quel Prometeo, cioè che, in quanto pensa, sa? In un medesimo modello
mitico (un semidio che media il divino e l’umano) due istanze opposte sembrano confliggere: da un lato, un
«donare» che è conforme al piacere del dio; dall’altro, un «rubare» che è contrario al piacere del dio. Da un
lato, un «sapere» che Dio permette; dall’altro, un «sapere» che Dio vieta. Da un lato, un pensare che Dio
dona; dall’altro, un pensare che Dio teme. Ma queste istanze opposte non sono per caso una medesima istanza, còlta nella sua ambivalenza? Cioè: il semidio che media il divino e l’umano, portando agli uomini – facendo transitare negli uomini – un divinum quid, non realizza per caso contro la potenza di Dio una potenza a favore della potenza di Dio? «Contro»: perché gli sottrae. «A favore»: perché ne è continuazione. Un realizzare che è un contrastare; un contrastare che è un realizzare. Un dono che è un furto; un furto che è un dono.
Già nel Prometeo che ruba il fuoco per donarlo sembra risuonare un’ambivalenza che dà a pensare.
Anche il Dio biblico consente all’uomo una conoscenza (l’albero della vita e le altre piante del paradiso) vietandogliene un’altra (la conoscenza del bene e del male). Anche il Dio biblico crea l’uomo
«come» Lui: «a immagine Sua» (Gen. 1, 27). Ma l’uomo pecca appunto perché vuole diventare «come»
Dio (Gen. 3, 5).
Il fuoco è di Dio. E, nel transitare nell’uomo, può diventare contro Dio. Ora, la libertà, costola del divino – che nel divino è, per definizione, intrinseca al bene –, continuandosi nell’uomo, in lui però si scinde in
possibilità alternative: le possibilità del bene e del male.
Proviamo a leggere questa situazione nei termini del mito sopradescritto. Se la libertà è la somiglianza
con Dio come dono, una libertà integrale (che, come in Dio, pretenda di essere intrinseca al bene e quindi
istitutiva della distinzione bene/male) sarebbe l’uguaglianza con Dio come furto. E il furto è superbia. Se la
libertà è la somiglianza con Dio, il peccato ne è il paradossale compimento. La somiglianza sta
all’uguaglianza come l’uomo sta a Dio. E come al peccato sta la libertà.
È inverosimile pensare che nel possibile parallelismo mitico fra le due figure del somigliare e del rubare
risuoni l’unico fuoco della libertà? Ivan Karamazov lo sa42.
In questo senso, Prometeo rappresenta tutte e tre le vie qui individuate per avvistare la libertà: 1. è colui che, avendo la libertà del suo pensare, è incatenato da chi, contro di lui che «sa», può (Eschilo, Il Prometeo incatenato); 2. è colui che si è staccato dagli dei staccandone il fuoco (Eschilo); 3. è colui che, staccandone il fuoco, ha fatto transitare nel mondo un pezzo del divino (Esiodo, Ovidio, Luciano).
5. I fratelli Karamazov
Per una singolare coincidenza simbolica, il discorso che Ivan Karamazov tiene ad Alioscia nel libro
V de I fratelli Karamazov consta di due parti («Ribellione» e «Il Grande Inquisitore», capitoli IV e V del libro V)43 che potrebbero costituire, rispettivamente, il commento ai due grandi problemi che investono
l’uomo contemporaneo: la libertà di Dio e la libertà dell’uomo. La libertà di Dio che significa, in un
universo problematico razionale, la responsabilità dell’uomo. «Libertà di Dio» e «libertà dell’uomo» che si
riconducono, entrambe, a un unico problema: quello della responsabilità di Dio.
Il primo problema (libertà di Dio). Posto che il male è produrre ingiustificatamente dolore e posto che
non nuocere a chi non nuoce – all’innocente – equivale al principio di non contraddizione nel regno dell’etica44,
come spiegare, come giustificare il dolore dei bambini? Come dire: posto che il dolore dei bambini torturati e uccisi è, nella vita, irrisarcibile per sempre, la questione della giustizia tocca un livello di ultimativa
radicalità: o Dio non esiste o l’uomo è immortale.
Il secondo problema (Libertà dell’uomo). Posto che il male è causare ingiustificatamente dolore, come
giustificare, in Dio, il suo esser causa dell’uomo che causa ingiustificatamente dolore? Come giustificare,
cioè, il suo esser causa di chi causa dolore?Con la «libertà»? Ma Dio può giustificare la propria responsabilità di Dio adducendo la libertà dell’uomo? (Per giunta, differenza fra le responsabilità dell’insieme e le
responsabilità dei singoli).
Dall’aporia si esce? Vediamola nell’ottica di Ivan Karamazov, nelle due prospettazioni che egli dà del
problema teologico. Nel primo caso, Dio produce direttamente il dolore; nel secondo caso, indirettamente. In
ogni caso, ingiustificatamente. Nel primo caso, la giustificazione – posto che una giustificazione possa (se ci
moviamo in un universo «razionale») esserci – manca perché, facendo soffrire un bambino, si nuoce a un
innocente. Nel secondo caso, la giustificazione – posto che una giustificazione possa esserci – manca perché,
rendendo libero l’uomo, si rende libero chi non può e non vuole essere libero: e chi l’ha fatto libero
non poteva non saperlo. Infatti: 1. l’uomo non «può» essere libero. E: 2. l’uomo non «vuole» essere liF. Dostoevskij, I fratelli Karamazov, Einaudi, Torino 1993, p. 326: «… Si vede che gli uomini stessi ne avranno colpa: gli era
stato dato il paradiso, loro han voluto la libertà e han rapito il fuoco al cielo, pura sapendo che sarebbero stati infelici» [libro V, cap.
IV. La sottolineatura è nostra].
43 Vedi F. Dostoevskij, I fratelli Karamazov, cit.
44 Sul punto del «non sacrificare l’innocente» vedi S. COTTA. Giustificazione e obbligatorietà delle norme, Giuffrè, Milano 1981, p.
116 ss.
42
bero. Fra le due condizioni c’è conflitto, non contraddizione. Perché l’uomo, se è libero, non «può» essere
libero? Non può perché non ha la struttura adeguata a questa sua libertà. E perché non «vuole» essere libero, dal momento che è libero? Non vuole perché sa che non può. Solo pochissimi eletti sfuggono a questa legge. Possono essere tutti i moltissimi altri sacrificati ai pochissimi? Così come non può essere nessuno – nemmeno uno solo – sacrificato a tutti gli altri, nemmeno i moltissimi possono essere sacrificati ai
pochissimi Eletti. Ma – contra Ivan – il problema rinasce in altra guisa: possono i pochi Eletti essere sacrificati alla maggioranza venendo bruciati? L’etica può ricondursi a una statistica? Può diventare il rogo,
o qualsiasi strumento di annientamento, il braccio armato di un’etica statistificata?
Il conflitto che il Grande Inquisitore istituisce con Cristo – a cui Cristo non risponde o, se si vuole, a
cui Cristo risponde tacendo – è la precisa messa in scena di un’aporia essenziale. Egli – il Grande Inquisitore – accusa Cristo di non amare gli uomini 1. perché non può non sapere che essi sono deboli; 2. perché non può non sapere che essi non vogliono la libertà; 3. perché chiede agli uomini più di quanto essi
possano dare; 4. perché, con le sue richieste di amore e di libertà, salva i forti e non i deboli, i pochi e non
i molti, gli eroi e non i disgraziati. Laddove, invece, egli – il Grande Inquisitore – li ama 1. perché per
loro ha mangiato locuste e radici; 2. perché sopporta eroicamente – reggendo in assoluta solitudine la
conoscenza del Bene e del Male – di dire la menzogna per amore: e il miracolo, il mistero e il potere diventano strumenti di questo amore; 3. perché si fa infelice per i deboli e per i molti; 4. perché si fa infelice per l’altrui felicità; 5. perché, anche se Dio non esistesse, egli agisce così.
Ma che cosa il Grande Inquisitore non fa? Egli non salva tutti, ma i deboli e i molti. E, coloro che
non salva, brucia. Per la salvezza degli altri. Alcuni innocenti bruciati per la salvezza di altri. Ma può il
bene ridursi al principio della maggioranza? Può un’etica ridursi a una statistica della felicità?45 Il Grande
Inquisitore, infatti, non salva tutti. Né ama Cristo, che l’ama. Il Cristo pellegrino che, tacendo alle accuse
e alla condanna dell’Inquisitore, lo bacia, restituisce all’aporia ontologica in scena la sua contraddizione
radicale. Aporia che ha una concisa rappresentazione teatrale nella stessa conclusione in conclusiva:
l’Inquisitore, che condanna Cristo al rogo («Domani ti farò bruciare. Dixi»46), lo lascia andare; Cristo,
che non risponde alle sue accuse, lo bacia e «dilegua»47. Entrambi si contraddicono? Entrambi si integrano? Ognuno apre all’altrui verità? La risposta, forse, è nel silenzio del Dio pellegrino. Ma l’aporia rimane, indistrutta. Quell’aporia che si era annunciata fin dalla scena introduttiva: la folla si accalca intorno a Cristo, riconoscendolo e acclamandolo, ma poi non fa nulla per sottrarlo all’arresto ordinato
dall’Inquisitore48.
L’aporia, spogliata della messa in scena che la fa parlare, si sedimenta nelle sue linee essenziali. I casi
sono due. Se l’uomo non è libero, come può Dio giustificare il dolore che Egli attraverso l’uomo immediaPer una perimetrazione problematica del colloquio fra Ivan e Alioscia, vedi l’acuta esplorazione di Vincenzo VITIELLO,
in ID., Topologia del moderno, Marietti, Genova 1992, pp. 176-188.
46 F. Dostoevskij, I fratelli Karamazov, cit., p. 347.
47 Dostoevskij, I fratelli Karamazov., pp. 349-350.
48 Dostoevskij, I fratelli Karamazov, cit., pp. 333-334.
45
tamente produce? E, d’altra parte, se l’uomo invece è libero, come può Dio giustificare il dolore che mediatamente produce producendone il produttore, soprattutto con riguardo ai bambini? La libertà è interruzione
del rapporto di causalità? Ma, se nella libertà dell’uomo Dio si continua interrompendosi, ossia se la libertà
dell’uomo è un effetto del libero ritrarsi di Dio, ciò non significa, da una parte, che la libertà dell’uomo è
una continuazione di Dio? E non significa, dall’altra, che anche il libero ritrarsi di Dio risponde a una
responsabilità verso l’irrisarcibile che consente (la sofferenza dei bambini)? La ‘libertà’, che in Dio era
costitutivamente consustanziata col Bene, nell’uomo si spezza: nelle possibilità alternative del Bene e del
Male. E questo ‘spezzarsi’ snatura il continuarsi di quella libertà. Ma, d’altra parte, se s’incrociano la prima e
la seconda parte del discorso d’Ivan (quella sui bambini trucidati – responsabilità di Dio – e quella sugli
uomini deboli – responsabilità dell’uomo), la contraddizione si rivela intrinseca allo stesso itinerario argomentativo
del personaggio dostoevskiano: infatti, se l’uomo che produsse dolore non era libero, perché rifiutargli il perdono? E, se invece era libero, perché trascurare che non era altezza della sua libertà?
6. Il punto. La ‘contraddizione’. Il senso
Libertà di Dio e libertà dell’uomo si contraddicono? Dio ha fatto gli uomini liberi? Ma davvero sono
liberi? O non è piuttosto vero che essi non sono veramente liberi perché sentono di non potere (essere
all’altezza di) questa supposta libertà – e quindi diventano, di fatto, liberi di non voler essere liberi? Il conflitto, còlto in apicibus, lungi dal dimostrare conclusivamente alcunché, sembra istituire una consunzione
continuata tra proposizioni contraddittorie che non aprono a una soluzione, ma depongono una miseria. La miseria di un logos che si sforza di capirla. Se, infatti, il logos potesse almeno dimostrare che Dio
non esiste, tutto – si direbbe con Ivan – è permesso. Ma, se tutto è permesso, che cos’è mai la libertà? E,
se nulla è permesso, che ne è della libertà? Il luminoso della libertà è dell’uomo in quanto è di Dio – è da
Dio. Se Dio non c’è e se l’uomo non c’è, il mondo è una gabbia di fatti. In cui non ha domicilio il ‘pensare’. Né l’‘agire’. Né, forse, il ‘sentire’. In cui potrà tentarsi, forse, come varco di fuga, solo un inedito
conato di prova: fondato sul bisogno di sfuggire al determinato. Quasi una prova estetica della libertà. E,
con essa, di Dio. Come dire: credo alla libertà – a Dio – non perché si dimostri, ma perché, se non ci
fosse, il mondo sarebbe una gabbia di fatti, sarebbe banale. Non solo. Non potrebbe neanche ‘pensarsi’.
E chi pensasse di ‘pensarlo’ come necessitato, farebbe un’eccezione per sé.
Che si tratti della libertà come via trascendentale del ‘pensare’, della libertà come via genealogica del
‘distaccarsi’ o della libertà come via del ‘sacro’, questa libertà che ci questiona appare, sempre, scheggia
del numinoso. Non riducibile, quindi, a una descrittiva, assiologicamente neutra, di fatti. Ma una libertà
come scheggia del numinoso configge, appunto, col numinoso di cui è scheggia. Compaiono qui, simultaneamente, un conflitto e una continuazione.
Un’aporia, presentandosi per ragionamenti o per figure, non è mai fine in sé. Dato un sistema di
pensiero, una contraddizione sollevata al suo interno non (necessariamente) lo falsifica. Essa, invece, lo
interroga. Per sollecitarlo a precisare. La contraddizione non distrugge il sistema: apre una questione alla
quale il sistema è chiamato a rispondere. Dato il contesto di pensiero in cui si pone una teologia ebraico-cristiana, la contraddizione sollevata al suo interno fra la libertà di Dio e la libertà dell’uomo non distrugge i suoi assunti: mostra che chi la solleva ne sente la necessità. Riaprendovi una questione che, negata, al modo del principio di non contraddizione, sempre imperiosamente risorge: la questione del senso.