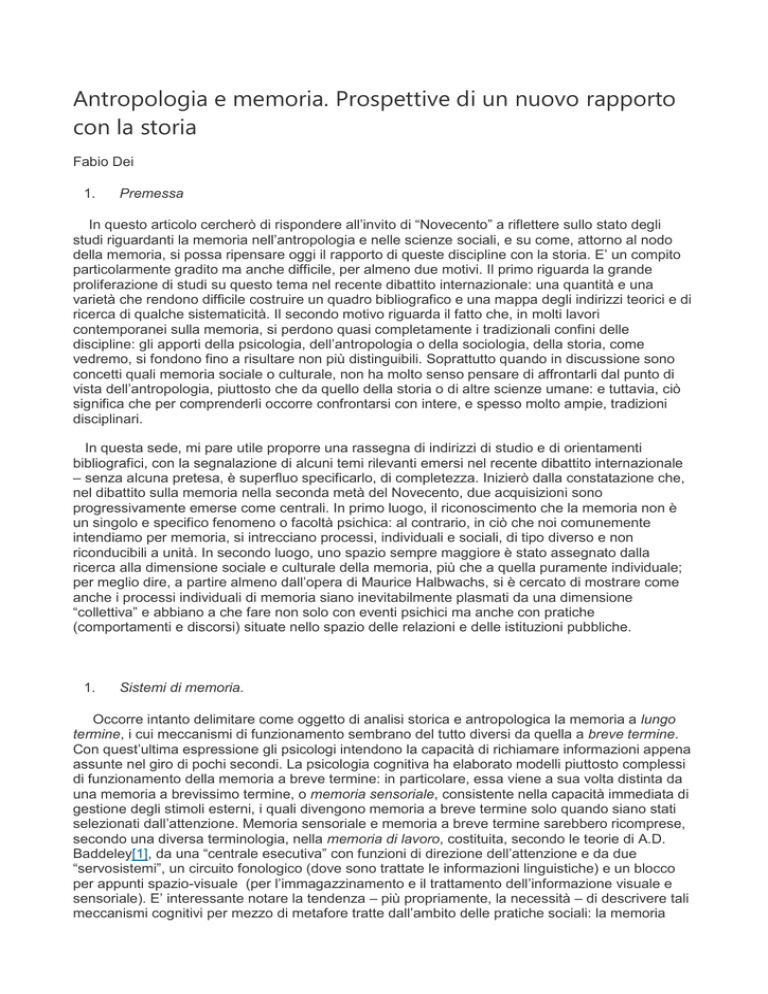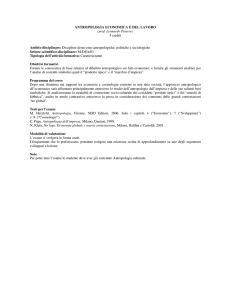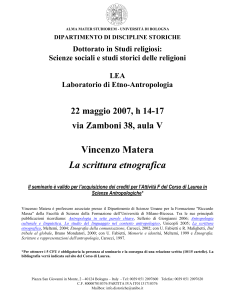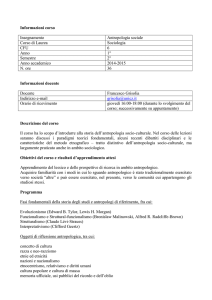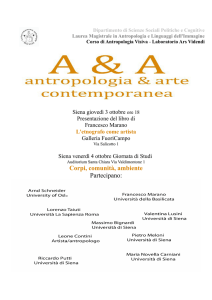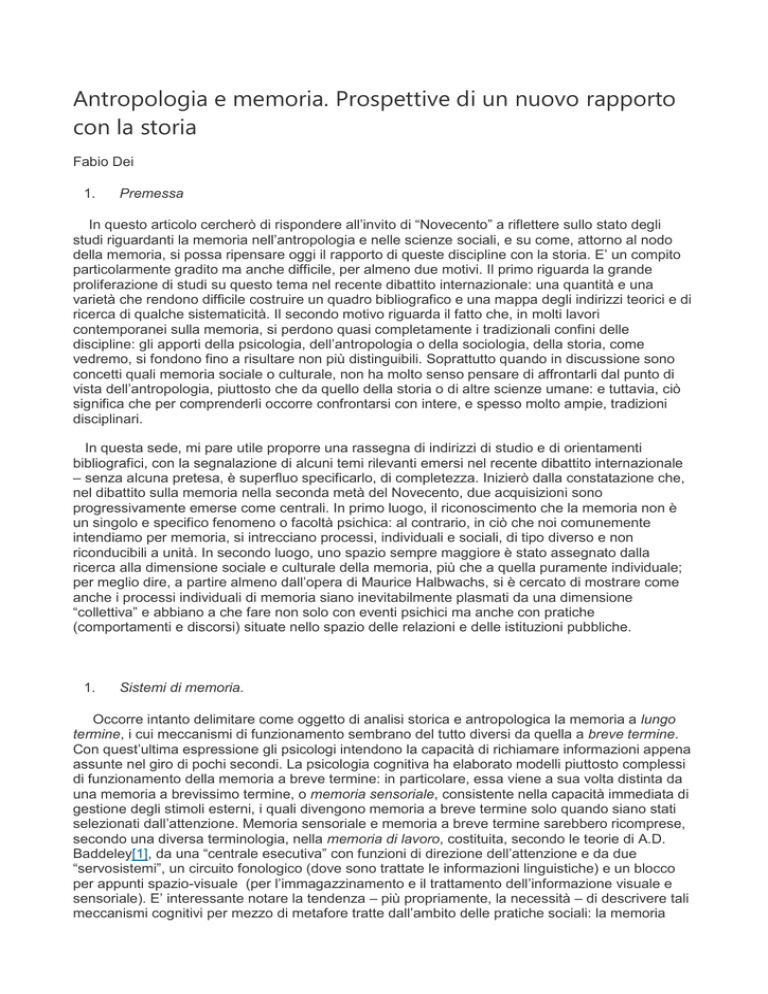
Antropologia e memoria. Prospettive di un nuovo rapporto
con la storia
Fabio Dei
1.
Premessa
In questo articolo cercherò di rispondere all’invito di “Novecento” a riflettere sullo stato degli
studi riguardanti la memoria nell’antropologia e nelle scienze sociali, e su come, attorno al nodo
della memoria, si possa ripensare oggi il rapporto di queste discipline con la storia. E’ un compito
particolarmente gradito ma anche difficile, per almeno due motivi. Il primo riguarda la grande
proliferazione di studi su questo tema nel recente dibattito internazionale: una quantità e una
varietà che rendono difficile costruire un quadro bibliografico e una mappa degli indirizzi teorici e di
ricerca di qualche sistematicità. Il secondo motivo riguarda il fatto che, in molti lavori
contemporanei sulla memoria, si perdono quasi completamente i tradizionali confini delle
discipline: gli apporti della psicologia, dell’antropologia o della sociologia, della storia, come
vedremo, si fondono fino a risultare non più distinguibili. Soprattutto quando in discussione sono
concetti quali memoria sociale o culturale, non ha molto senso pensare di affrontarli dal punto di
vista dell’antropologia, piuttosto che da quello della storia o di altre scienze umane: e tuttavia, ciò
significa che per comprenderli occorre confrontarsi con intere, e spesso molto ampie, tradizioni
disciplinari.
In questa sede, mi pare utile proporre una rassegna di indirizzi di studio e di orientamenti
bibliografici, con la segnalazione di alcuni temi rilevanti emersi nel recente dibattito internazionale
– senza alcuna pretesa, è superfluo specificarlo, di completezza. Inizierò dalla constatazione che,
nel dibattito sulla memoria nella seconda metà del Novecento, due acquisizioni sono
progressivamente emerse come centrali. In primo luogo, il riconoscimento che la memoria non è
un singolo e specifico fenomeno o facoltà psichica: al contrario, in ciò che noi comunemente
intendiamo per memoria, si intrecciano processi, individuali e sociali, di tipo diverso e non
riconducibili a unità. In secondo luogo, uno spazio sempre maggiore è stato assegnato dalla
ricerca alla dimensione sociale e culturale della memoria, più che a quella puramente individuale;
per meglio dire, a partire almeno dall’opera di Maurice Halbwachs, si è cercato di mostrare come
anche i processi individuali di memoria siano inevitabilmente plasmati da una dimensione
“collettiva” e abbiano a che fare non solo con eventi psichici ma anche con pratiche
(comportamenti e discorsi) situate nello spazio delle relazioni e delle istituzioni pubbliche.
1.
Sistemi di memoria.
Occorre intanto delimitare come oggetto di analisi storica e antropologica la memoria a lungo
termine, i cui meccanismi di funzionamento sembrano del tutto diversi da quella a breve termine.
Con quest’ultima espressione gli psicologi intendono la capacità di richiamare informazioni appena
assunte nel giro di pochi secondi. La psicologia cognitiva ha elaborato modelli piuttosto complessi
di funzionamento della memoria a breve termine: in particolare, essa viene a sua volta distinta da
una memoria a brevissimo termine, o memoria sensoriale, consistente nella capacità immediata di
gestione degli stimoli esterni, i quali divengono memoria a breve termine solo quando siano stati
selezionati dall’attenzione. Memoria sensoriale e memoria a breve termine sarebbero ricomprese,
secondo una diversa terminologia, nella memoria di lavoro, costituita, secondo le teorie di A.D.
Baddeley[1], da una “centrale esecutiva” con funzioni di direzione dell’attenzione e da due
“servosistemi”, un circuito fonologico (dove sono trattate le informazioni linguistiche) e un blocco
per appunti spazio-visuale (per l’immagazzinamento e il trattamento dell’informazione visuale e
sensoriale). E’ interessante notare la tendenza – più propriamente, la necessità – di descrivere tali
meccanismi cognitivi per mezzo di metafore tratte dall’ambito delle pratiche sociali: la memoria
come attività di immagazzinamento sembra la metafora portante della teoria degli anni ’60, il
“centro di controllo” connesso a servosistemi specifici si afferma successivamente, mentre dagli
anni ’80-’90 diviene dominante il linguaggio della programmazione informatica.
Il concetto di memoria a lungo termine indica invece la capacità di ritenere informazioni per un
tempo superiore ai pochi secondi che caratterizzano la memoria di lavoro. Si è soliti suddividere la
memoria a lungo termine, sulla base dei lavori di E. Tulving[2], in tre diversi sistemi: la memoria
procedurale, quella semantica e quella episodica. La prima consiste in capacità o competenze
incorporate, che operano quasi sempre in modo implicito e che spesso non sono facilmente
verbalizzabili. Molte attività basate su tecniche del corpo, dallo svolgere determinati lavori,
all’andare in bicicletta, al digitare sulla tastiera di un computer, presuppongono una memoria di
questo tipo, che viene acquisita in modo lento e progressivo e che difficilmente, o comunque in
tempi assai lunghi, può esser dimenticata. Si tratta di una componente fondamentale del concetto
antropologico di cultura, se è vero, come scrive Paul Connerton, che la nostra esistenza sociale ha
una natura “essenzialmente corporea”[3].
La memoria semantica consiste nel nostro sapere generale sul mondo, e contiene sia una
“enciclopedia”, sia i segni e le regole che permettono l’uso e la comprensione del linguaggio.
Come afferma Tulving, essa “registra non le proprietà percettive degli stimoli, ma piuttosto i loro
referenti cognitivi”[4]. La memoria episodica, infine, registra eventi o episodi, collocabili con relativa
precisione in termini spazio-temporali, di cui il soggetto ha avuto esperienza. Per questo nesso con
l’esperienza diretta, viene talvolta definita memoria personale o autobiografica – anche se è un
problema controverso nella psicologia cognitiva se memoria episodica e autobiografica siano
coestensive: vi sono infatti in quest’ultima elementi non strettamente episodici e, d’altra parte, non
tutte le fonti della memoria episodica risalgono a reali esperienze biografiche.
Memoria semantica ed episodica sono congiuntamente definite anche come memoria
dichiarativa, in quanto mirano a rappresentare il mondo o il passato – in contrapposizione alla
memoria abituale o procedurale, che rappresenta il requisito di abilità pratiche e non ha obiettivi
rappresentativi. La prima aspira alla verità ed è di solito formulabile verbalmente, la seconda aspira
all’efficacia e, come detto, è di solito incorporata in tecniche del corpo di cui non si ha
consapevolezza linguistica. Parzialmente sovrapposta alla distinzione dichiarativa-procedurale è
quella tra memoria esplicita e implicita. Quest’ultimo concetto è stato introdotto dalla psicologia
sperimentale per dar conto di quei casi in cui si è influenzati da un’esperienza passata senza
essere consapevoli di ricordare (come negli esperimenti sul priming, in cui l’apprendimento di certi
stimoli risulta migliore quando vi sia stata una precedente esposizione, non ricordata
esplicitamente, a quegli stessi stimoli). La memoria implicita riguarda non solo abilità procedurali
incorporate, ma anche episodi e stimoli verbali, iconici, sensoriali: il lavoro con persone colpite da
amnesia suggerisce trattarsi di un sistema mnestico che funziona in modo indipendente da quello
della memoria esplicita[5].
Rientra in quest’ambito problematico anche il concetto di memoria involontaria, coniato, com’è
noto, da Marcel Proust a proposito del celebre episodio della madeleine che apre La ricerca del
tempo perduto: uno stimolo, in questo caso gustativo, che apre improvvisamente un intero
scenario di ricordi dimenticati, con un forte alone affettivo e l’immediata associazione a immagini e
a luoghi[6]. La psicologia sperimentale rivolge invece scarsa attenzione al tema psicoanalitico del
rimosso. La psicoanalisi, in effetti, problematizza non tanto le modalità cognitive di acquisizione
della memoria, quanto le dinamiche psichiche che consentono o impediscono l’accesso alla
memoria, oppure consentono un accesso in forme oblique e distorte; oppure, ancora, producono
“fantasie”, cioè ricordi di episodi non realmente accaduti. Si tratta di una cornice che rende il
rapporto col passato assai più complesso e mediato rispetto al modello dell’immagazzinamento e
recupero di informazioni.
2. Memoria come processo interpretativo.
Questi modelli di sistemi di memoria elaborati dalla psicologia sperimentale sono per lo più
basati sulla “misurazione” di performance mnemoniche in situazioni controllate di laboratorio,
secondo una metodologia che si fa risalire allo psicologo tedesco Hermann Ebbinghaus.
Lavorando a cavallo tra Ottocento e Novecento, quest’ultimo ideò un metodo di studio del lavoro
della memoria consistente nella ripetizione di sillabe senza senso da parte di soggetti individuali –
con l’obiettivo di isolare il funzionamento della memoria “pura” da “contaminazioni” di ordine
contestuale, relative alle conoscenze pregresse e al mondo vitale dei soggetti stessi. In questo
isolamento consiste la forza del metodo ma al contempo, ovviamente, la sua debolezza, dal
momento che non è affatto chiaro quanto i modelli costruiti in laboratorio possano dirci sull’uso
della memoria in contesti di vita reale. Nella psicologia novecentesca, a questo orientamento
metodologico se ne oppone uno centrato invece sulla osservazione di contesti pragmatici e
socioculturali reali di uso della memoria, che ha il suo riferimento classico nell’opera di Frederic C.
Bartlett. Docente a Cambridge negli anni ’30, Bartlett sostiene una visione che oggi chiameremmo
“interpretativa” della memoria, concependola come uno “sforzo verso il significato” (an effort after
meaning): vale a dire, “non come la capacità di immagazzinare dati passati, ma come un processo
di ricostruzione che, partendo dagli interessi e dalle conoscenze presenti del soggetto, tenta di
ricostruire a posteriori il significato del ricordo”[7].
L’orientamento di Bartlett, poco seguito intorno alla metà del secolo, quando gli studi psicologici
erano dominati dal comportamentismo, ha ispirato successivamente alcuni orientamenti di ricerca
che hanno assegnato un ruolo metodologico centrale all’osservazione delle modalità pratiche di
uso della memoria in contesti di vita quotidiana, in contrapposizione agli esperimenti di laboratorio.
Di particolare importanza il lavoro di Ulrich Neisser, fondatore di un approccio cosiddetto
“ecologico” alla ricerca sulla memoria – espressione che si riferisce appunto alla necessità di
collegare le prestazioni mnemoniche al contesto pratico di vita in cui esse sono impiegate, proprio
quel contesto che la ricerca di laboratorio mira invece ad eliminare[8]. Questa metodologia apre la
psicologia cognitiva all’analisi delle componenti sociali, culturali e storiche della memoria: un punto
decisivo, sul quale mi soffermerò tra un istante.
Vorrei prima osservare come l’approccio di Bartlett, così come quello ecologico o pragmatico di
Neisser, attribuiscano centralità a fenomeni che hanno importanti implicazioni per la storiografia e
l’antropologia, vale a dire quelli della falsa memoria e delle distorsioni del ricordo. Si tratta di
aspetti del funzionamento della memoria che non possono esser interpretati come pura perdita o
incompletezza di informazioni, bensì come il prodotto di attive strategie di ricostruzione del passato
sulla base non solo delle esperienze e del sapere presente, ma di strutture di senso. Bartlett ha
introdotto il concetto di schema per indicare simili strutture relativamente stabili e resistenti
all’oblio, sulle quali i ricordi si innestano e si plasmano; la ricerca cognitiva più recente preferisce
parlare di copioni (scripts), un termine che sottolinea maggiormente la natura narrativa delle
strutture, che tendono a configurarsi come sequenze di eventi attorno ai quali le informazioni si
organizzano. Schemi e copioni svolgono una funzione di filtro rispetto alla possibilità di integrare
esperienze o contenuti della memoria a breve termine nella memoria a lungo termine; ma, ciò che
più conta, essi sembrano in grado di plasmare i ricordi in configurazioni coerenti. E’ in questo
quadro della costruzione di narrazioni significative sul passato che i fenomeni dei “falsi” ricordi,
delle distorsioni e dello stesso oblio vanno compresi.
Questa prospettiva è piuttosto diversa da quella psicoanalitica, la quale suppone invece che il
ricordo reale (ad esempio, un evento traumatico) continui ad esistere, intatto, nelle profondità della
psiche, schermato tuttavia da elaborazioni secondarie che lo rendono invisibile o irriconoscibile. La
distorsione e il falso ricordo rappresentano una forma patologica, i cui prototipi possono essere
riconosciuti nel sintomo nevrotico e nel lavoro onirico. Il percorso analitico di scavo e decifrazione
(si pensi alla pervasività delle metafore archeologiche nel discorso freudiano) è in grado di
riportare alla superficie il ricordo reale, dissolvendo le coperture di superficie. Nella prospettiva
cognitivista, invece, non si può parlare di un ricordo “reale” che sarebbe celato dal ricordo falso o
dall’apparente oblio: il lavoro di plasmazione degli schemi o degli scripts è costitutivo del normale
funzionamento della memoria, e non esiste al di fuori di esso (se non nella sperimentazione di
laboratorio) un livello di maggiore autenticità, di ricordi-copia perfettamente fedeli all’originale.
Tuttavia, la psicologia cognitiva riprende dalla psicoanalisi alcune idee chiave sui meccanismi che
guidano il lavoro degli schemi: ad esempio lo spostamento e la condensazione. Neisser ha
introdotto il concetto di memoria “repisodica” (repisodic) per indicare la tendenza a ricordare più
eventi analoghi come se si trattasse di un unico episodio: una strategia di condensazione che
produce un ricordo in sé falso, il quale conserva tuttavia un fondamentale elemento di verità[9].
Dovremmo forse chiamare questi ricordi non tanto falsità quanto finzioni, nel senso del termine
che Clifford Geertz usa per definire le descrizioni etnografiche nel loro rapporto con la “realtà”:
qualcosa di costruito, di modellato attraverso strategie rappresentative (prevalentemente
linguistiche e retoriche) alle quali non si applica facilmente la dicotomia vero/falso[10]. E’ ovvia la
rilevanza di questi temi per le discipline che fanno uso di fonti orali: essi influenzano a fondo il
problema della verità della testimonianza e del suo rapporto con il sapere storico o etnografico. In
sostanza, ed è un punto sul quale tornerò più avanti, la consapevolezza del carattere “costruito”
delle memorie, in particolare di quelle autobiografiche, ci impedisce di assumere le testimonianze
in un’ottica realista, spingendoci invece ad esaminarne la configurazione retorica e discorsiva e la
contestualizzazione pragmatica: a cercare di capire, in altre parole, quanto sono influenzate da
modelli narrativi, dalla situazione comunicativa in cui emergono, dalle finalità in senso lato
“politiche” dei narratori, e così via.
Negli anni ’90, il problema dei falsi ricordi è però emerso nell’attualità politica, oltre che nel
dibattito scientifico, in relazione a un altro tipo di testimonianza, quella giudiziaria. In particolare
negli Stati Uniti si sono sviluppate accese dispute attorno alla cosiddetta “sindrome da personalità
multipla”, un disturbo psichico di natura dissociativa che insorgerebbe in individui che hanno subìto
e rimosso abusi sessuali nell’infanzia (quasi sempre in ambito familiare), i quali vengono “ricordati”
in seguito a trattamento analitico o psichiatrico. Sulla base di questi ricordi traumatici, molti pazienti
hanno intentato cause giudiziarie contro loro stessi familiari, e ciò ha evidentemente portato in
primo piano il problema della attendibilità di una memoria “recuperata”, e della possibilità che, sia
pure con la totale buona fede degli interessati, simili memorie siano indotte sulla base di modelli
“narrativi” condivisi dallo psichiatra e da un più ampio ambiente culturale di appartenenza[11]. Nel
1992 è stata fondata negli Stati Uniti una False Memory Syndrome Foundation, che riunisce
genitori colpiti, o che intendono cautelarsi, da accuse sulla base di memorie recuperate a seguito
di trattamento psichiatrico. Una controversia politica e mediale che ha coinciso con “la
polarizzazione tra psicologi clinici che difendevano la necessità e la validità del memory recover e
gli psicologi cognitivisti [...] i quali mostravano, sulla base di risultati sperimentali, quanto facilmente
si possano provocare ricordi sbagliati mediante gli effetti della comunicazione posteriore”[12].
3. Memoria collettiva.
Ciò che interessa di più sottolineare, tuttavia, è un altro punto; la concezione bartlettiana della
memoria come “sforzo verso il significato”, come attiva interpretazione del passato sulla base di
schemi psicologici connessi alla vita concreta del presente, apre la strada alla considerazione degli
aspetti sociali del ricordare. In questa prospettiva, e ancor più in quella ecologica, l’atto psichico
del ricordare non può essere inteso separandolo dal contesto del mondo vitale e delle pratiche
comunicative, che è per definizione un contesto sociale e culturale. Gli stessi concetti di schema e
script non possono esser concepiti, in una prospettiva ingenuamente empirista, come proprietà
della mente individuale: essi si riferiscono piuttosto a un elemento strutturante che preesiste al
pensiero individuale e che trae forme e contenuti dalla dimensione della cultura. E’ questa la
cerniera, o meglio ancora il punto di profonda saldatura, fra lo studio psicologico della memoria e
gli studi storici e sociali.
E’ su questo punto di giuntura che insiste il contributo di un altro importante studioso, questa
volta di provenienza sociologica, che può esser considerato il precursore degli studi sociali della
memoria. Mi riferisco naturalmente a Maurice Halbwachs, seguace di Durkheim scomparso nel
1945 nel lager di Büchenwald, e autore di tre importanti libri sul tema della memoria[13]. Per lungo
tempo largamente ignorato, soprattutto in Italia, Halbwachs è oggi al centro di una rinnovata
attenzione anche al di fuori degli studi strettamente sociologici. L’idea centrale del suo lavoro è
l’applicazione al campo della memoria del concetto durkheimiano di “rappresentazione collettiva”,
intesa come una categoria del pensiero che precede l’elaborazione individuale e che è radicata
nelle istituzioni e nelle pratiche sociali. Durkheim, Mauss e altri esponenti della scuola francese
avevano letto in questa direzione numerose forme di quello che si chiamava allora il “pensiero
primitivo”, dalla religione, alla magia, alle forme più elementari di classificazione del mondo
naturale. Il loro programma era di rottura radicale con l’empirismo socio-antropologico, che
pensava di poter dedurre le credenze e le istituzioni culturali dai processi speculativi della mente
individuale, ma anche con il razionalismo kantiano, le cui categorie venivano di fatto relativizzate e
ricondotte a un più fondamentale determinismo sociale.
Halbwachs tenta di spingere questo programma sociologico fin all’interno della psicologia,
dunque proprio sul terreno in apparenza più prossimo alla dimensione puramente individuale.
L’atto individuale del ricordare è a suo parere possibile solo sulla base di “quadri sociali” (cadres
sociaux) che sono logicamente antecedenti a qualsiasi singolo ricordo. Tali quadri non si limitano a
selezionare i ricordi: piuttosto, li producono. Halbwachs rovescia infatti la filosofia della memoria
prevalente nella Francia di inizio secolo, quella di Bergson, secondo la quale tutte le esperienze di
un individuo sono sempre presenti sotto forma di ricordi latenti o inconsci nella sua mente, senza
che nulla si perda mai veramente. A suo parere, al contrario, non c’è nulla che propriamente si
“conserva”, e i ricordi sono ricostruzioni sempre orientate sul presente:
… al di fuori del sogno il passato, in realtà, non ricompare allo stesso modo, anzi tutto sembra
indicare che esso non si conserva affatto, a meno che non lo si ricostruisca a partire dal presente.
[…] I quadri collettivi della memoria non sono costituiti dalla combinazione dei ricordi individuali,
non sono delle semplici forme vuote dove i ricordi, venuti da altrove, si inseriranno, ma sono, al
contrario, esattamente gli strumenti di cui la memoria collettiva si serve per ricomporre
un’immagine del passato che si accordi in ogni epoca con il pensiero dominante nella società[14].
In questo passo si coglie anche la differenza rispetto al concetto bartlettiano di “schema”,
qualcosa di più simile a una “forma vuota” in cui ricordi venuti da altrove trovano (o non trovano,
venendo quindi eliminati) una loro collocazione. I quadri sociali non sono pure strutture cognitive:
hanno invece un forte contenuto di senso, una “sostanzialità” che corrisponde a quella del gruppo
sociale cui si riferiscono. Infatti, come nota Paolo Jedlowski in una densa introduzione all’edizione
italiana di La memoria collettiva, nell’ottica di Halbwachs “ricordare, per un individuo, corrisponde a
riattualizzare la memoria di un gruppo sociale cui egli appartiene o ha appartenuto in passato”[15].
Il che significa che la memoria del gruppo è in qualche modo più reale – perlomeno
sociologicamente – della memoria individuale (anche se la memoria individuale, soprattutto nelle
società complesse, può sovrapporre al proprio interno più quadri sociali, dal momento che ogni
individuo appartiene a molteplici e differenziati gruppi, come la famiglia, i pari età, la cerchia
professionale, quella associativa etc.).
Qui la riflessione di Halbwachs apre una linea di ricerca assai diversa da quella cognitivista –
pur condividendone, come si è detto, alcuni punti di partenza. Halbwachs è interessato
prevalentemente alle funzioni sociali della memoria: la vede come un aspetto delle pratiche sociali,
non come un loro prerequisito. La memoria esprime la solidarietà fra l’individuo e il gruppo o i
gruppi sociali cui appartiene. Il che significa, in altre parole, che il ricordare è una pratica
performativa e non puramente rappresentativa, la cui logica si intreccia cioè con quella delle altre
pratiche sociali e in senso lato politiche. Significa, inoltre, che la memoria interna, cioè i
meccanismi psichici del ricordare, non può esser studiata separatamente dalla memoria esterna,
vale a dire da quei dispositivi tramite i quali le società incorporano tramite una codificazione
simbolica la memoria del passato in oggetti, in luoghi o in pratiche; dispositivi che includono le
tecnologie comunicative, dalla scrittura a Internet, i processi di monumentalizzazione, i rituali
celebrativi e commemorativi.
E’ vero, come nota lo stesso Jedlowski[16], che Halbwachs non è particolarmente interessato a
una sistematica storia delle tecnologie di esteriorizzazione della memoria, di conservazione e
riproduzione di immagini del passato tramite oggetti materiali: tuttavia, la sua opera apre lo
scenario per una simile storia e antropologia delle forme concrete e mutevoli che la memoria
assume nelle società. Uno scenario che finirà per saldarsi con quelli aperti dalla psicologia sociale,
e sul quale si avventureranno nuovi indirizzi di studio soprattutto nell’ultimo quarto del Novecento.
Nei paragrafi che seguono, vorrei esplorare tre aspetti di queste analisi sociali della memoria, o,
meglio ancora, indagini sulla memoria come fenomeno sociale: l’indirizzo di analisi del discorso, le
indagini empiriche sui rituali celebrativi e quelle sull’incorporazione della memoria in luoghi e
oggetti materiali.
4. La costruzione linguistica del ricordo.
L’analisi del discorso, come gli indirizzi della sociologia di orientamento fenomenologico
(interazionismo simbolico, etnometodologia), tende a considerare le pratiche quotidiane di
interazione fra le persone come l’unica realtà sociologica che è possibile descrivere in modo
oggettivo. I costrutti e le astrazioni teoriche di cui ci serviamo normalmente nella vita quotidiana
non fondano quelle interazioni, ma ne sono il prodotto; il che vale anche per i concetti utilizzati
dalle scienze sociali, come “società” o “cultura”, e dalla psicologia, come “mente” o, appunto,
“memoria”. La psicologia sociale giunge ad assumere questo punto di vista riprendendo e
radicalizzando le posizioni di Bartlett. Per quest’ultimo, come abbiamo visto, la memoria non è il
ripescaggio di informazioni in un magazzino “interno”, ma l’attiva costruzione di resoconti del
passato sulla base di schemi culturali condivisi; e tuttavia, questa attività costruttiva avviene
comunque all’interno della testa delle persone. L’analisi del discorso, invece, colloca la memoria
“là fuori”, all’interno delle pratiche discorsive e simboliche quotidiane e di precise circostanze
comunicative, prescindendo da ogni ipotesi sull’esistenza di “facoltà” o processi mentali e di entità
interne quali i “ricordi”, concepiti come oggetti da immagazzinare e ritirar fuori al momento giusto. I
“ricordi”, in questa chiave, sono un sottoprodotto del nostro modo di parlare del passato.
E’ curioso come a Bartlett si richiamino oggi sia gli approcci cognitivisti, come quello
rappresentato da Neisser, sia quelli che potremmo definire socio-costruzionisti. I due approcci si
contrappongono sul piano del riconoscimento del proprio oggetto di studio: il cognitivismo è
interessato a processi mentali che per l’orientamento etnometodologico sono finzioni discorsive.
Occorre infatti chiarire che l’analisi del discorso intende il linguaggio in modo radicalmente antirealista: esso è uno strumento di gestione, di creazione e mantenimento delle relazioni sociali,
prima ancora che una forma di rappresentazione del mondo. Secondo la lezione di Wittgenstein, il
significato delle parole consiste nel loro uso. Ciò può apparire controintuitivo, dal momento che
siamo abituati a un uso del linguaggio in cui certe parole rappresentano certe cose: occorre però
considerare che ciò accade “solo all’interno di forme di vita sociale già costituite da modi di parlare
in cui queste parole sono usate”[17]. Seguire fino in fondo questo approccio richiede al ricercatore,
nella tradizione fenomenologica, di sospendere l’assunzione di una serie di categorie che fanno
parte dell’ordinario orizzonte della propria esperienza in quanto attore sociale. Tutti viviamo
all’interno di mondi “naturali” che sono di fatto costituiti dalle nostre ordinarie pratiche linguistiche e
relazionali: tanto più è profonda questa costituzione, tanto più difficilmente riusciamo a uscirne e a
coglierla come oggetto di descrizione sociologica. Il costruzionismo sociale richiede dunque uno
sforzo di estraniamento che presenta importanti affinità con l’esperienza antropologica. Il passo
forse più difficile da accettare è la rinuncia a utilizzare l’idea di un soggetto stabile e di una
coerente e continuativa “esperienza vissuta” come risorse della propria comprensione dei
fenomeni mentali e sociali. Ciò che prendiamo normalmente come un assunto, deve esser visto
come un problema: il problema del
perché, in questo momento della storia, noi immaginiamo noi stessi in un certo modo: pensiamo
di esistere fin dalla nascita come individui isolati e separati, di racchiudere al nostro interno un
“pensiero” o una mentalità” contrapposta a un mondo materiale a sua volta privo di ogni processo
mentale. Ciò vale anche per i nostri ricordi: nella nostra esperienza del ricordare (o, perlomeno, in
ciò che noi diciamo la nostra esperienza del ricordare) sembra che facciamo sempre riferimento a
qualcosa che sta dentro di noi, come un’immagine o un’impressione, un oggetto di qualche
tipo[18].
Mi sembra difficile accusare queste posizioni, come fa Giovanna Leone in un suo pur ottimo
libro sulla memoria autobiografica, di “scarsa attenzione per la soggettività individuale”[19]: al
contrario, la soggettività è posta al centro di un programma di ricerca, di cui è però l’oggetto e non
la risorsa o assunto implicito. La psicologia sociale riprende qui pienamente l’insegnamento di
Goffman, secondo il quale l’Io contemporaneo è il prodotto e non la condizione dei microrituali
dell’interazione che costellano la nostra vita quotidiana; e apre uno scenario che si interseca, fino a
risultarne indistinguibile, con quello dell’antropologia culturale. Quest’ultima non mira soltanto a
studiare le forme esteriorizzate e pubbliche di memoria, in contrapposizione a quelle interne e
private, secondo un approccio che manterrebbe ferma l’autonomia di entrambe. L’antropologo
Maurice Bloch, ad esempio, critica quegli approcci alla memoria esterna che la vedono come una
semplice estensione evolutiva della memoria interna, allo stesso modo in cui gli utensili sono una
estensione (o una esteriorizzazione, nel linguaggio di André Leroi-Gourhan) della mano. In questo
modo, si assumerebbe in modo acritico l’esistenza di una memoria interna, pura rispetto ai
condizionamenti storici e sociali, e si guarderebbe alle istituzioni culturali come ad una specie di
hard disk che aumenta le capacità di immagazzinamento al di là di quanto è possibile all’individuo.
Occorre invece, sostiene Bloch, considerare come l’influenza sociale operi all’interno stesso delle
facoltà mnemoniche individuali; il che implica capire che la produzione fenomenologica della realtà
degli stati di cose passati (dei ricordi) è “largamente influenzata dalla storia, o per meglio dire dalla
visione che le persone hanno di sé nella storia e, attraverso le nozioni di persona e di luogo, dalle
loro varie concezioni dell’etica e delle intenzioni”[20]. In altre parole, vi sono molte possibili folk
psychologies (concezioni della persona, del suo rapporto con la società e con la storia, delle sue
motivazioni all’agire) che influenzano il significato che il ricordare ha nelle varie culture: e con esse
la psicologia, non meno che l’antropologia, non può fare a meno di confrontarsi.
Il problema della discourse analysis non consiste dunque nella scarsa attenzione al livello
soggettivo del ricordare, poiché essa mira a una integrazione metodologicamente nuova del livello
individuale e di quello sociale. Sul piano epistemologico, semmai, il costruzionismo radicale si
scontra con il problema della verità. Se ogni resoconto sul passato è una costruzione plasmata
dalle esigenze di senso del presente, e guidata da criteri non di esattezza rappresentativa ma di
efficacia pragmatica, che ne è del problema della verità fattuale e oggettiva del ricordo? Non
rischiamo di sostituire al concetto di verità quello di accordo consensuale, con le difficoltà e i
paradossi, sia epistemologici sia etici, che ciò implicherebbe? Non sentiamo forse tutti l’importanza
decisiva di mantenere separato il piano della verità oggettiva – “come sono andate veramente le
cose” – da quello dell’utilità o funzionalità di una certa versione degli eventi, o del consenso
comune su di essa? E non è forse su questa separazione che si basa la storia, in quanto
conoscenza scientificamente fondata del passato?
Qui si aprono naturalmente problemi riguardanti lo statuto epistemologico del sapere storico, che
porterebbero molto lontano e implicherebbero tipi diversi di considerazione (p.es. la natura e la
varietà delle fonti impiegate, i modi del loro trattamento critico, le regole della costituzione della
narrazione storiografica come “genere” distinto da rievocazioni del passato nel discorso
comune)[21]. L’analisi del discorso forse trascura la possibilità che in ogni resoconto del passato
prodotto in “buona fede” (ma il concetto di “buona fede” è di per sé assai problematico, e
presuppone una trasparenza e una autonomia della coscienza individuale difficile, come abbiamo
appena visto, da assumere) vi sia una autentica istanza rappresentativa, una irriducibile pretesa di
affermare la verità oggettiva.
Tuttavia, senza bisogno di spingerla alle sue estreme conseguenze epistemologiche, l’analisi del
discorso ci mostra al di là di ogni dubbio come l’istanza rappresentativa e quella pragmatica siano
inestricabilmente mischiate nel discorso quotidiano (se non in quello storiografico); e come
l’appello alla “verità oggettiva” sia proprio una delle principali strategie retoriche impiegate per far
prevalere una versione su un’altra. Ciò apre programmi di ricerca di grande interesse sulle pratiche
del ricordare insieme. Ne è un esempio il lavoro di Middleton e Edwards dedicato all’analisi
linguistica e relazionale della diffusa pratica domestica del guardare gli album fotografici di
famiglia. Siamo abituati a pensare a questa attività come a una contemplazione di ricordi già
compiutamente e stabilmente presenti nella memoria individuale dei membri della famiglia, con le
foto che servono da richiami o esche per l’estrazione di materiali mnemonici solidamente
immagazzinati. Questi autori mostrano in modo assai convincente, sulla base dell’analisi
etnografica, come al contrario sia qui in gioco la costruzione cooperativa – e talvolta conflittuale e
negoziata – dei ricordi; come anzi, soprattutto per i bambini, si tratti di situazioni in cui si impara a
ricordare, vale a dire si acquisiscono le regole del gioco linguistico e delle reazioni emotive
associate al “ricordare insieme” e alla rappresentazione del passato comune[22].
La metodologia impiegata in queste analisi tende a mettere in luce le strategie retoriche, nonché
i microcontesti di potere, nel cui quadro si interpretano fonti (le foto e i souvenir, ad esempio) per
sostenere particolari versioni del racconto del passato. E’ un’analisi che può applicarsi non solo ai
contesti di vita quotidiana, ma anche alle situazioni di produzione formalizzata di memoria, come
quello giudiziario o quello storiografico. La concezione stessa delle fonti orali e della
“testimonianza”, ad esempio, muta fortemente qualora si assuma il punto di vista della etnografia
della conversazione. Per quest’ultima, le narrazioni autobiografiche prodotte dai testimoni non solo
sono costruzioni interpretative che ricostruiscono selettivamente il passato per mezzo di strategie
retoriche e del riferimento a generi o modelli che danno forma al racconto; di più, esse sono il
prodotto del contesto comunicativo in cui vengono “raccolte”, vale a dire della relazione linguistica
e “politica” fra narratore e ricercatore. La pragmatica dell’incontro etnografico, in altre parole,
influenza ciò che viene detto e il suo significato in misura assai maggiore di quanto la pur raffinata
metodologia della storia orale di solito riconosca[23] Ciò non rende meno importanti le fonti orali
per la conoscenza storica ed etnografica: ci rende però consapevoli della particolare complessità
del trattamento critico che esse richiedono quando vengono assunte come documenti, e della
molteplicità di piani ermeneutici cui rinvia la loro interpretazione.
5. Oggetti e riti commemorativi
“Per fissarsi nella memoria di un gruppo, una verità deve presentarsi sotto la forma concreta di un
avvenimento, di una figura personale o di un luogo”, scrive Halbwachs in Memorie di
Terrasanta[24]. In quest’opera del 1941, egli studia attraverso la documentazione storica la
complessa vicenda del riconoscimento e della ricostruzione, dopo le Crociate, di una “topografia
leggendaria” che risulta dal compromesso tra la fisicità reale dei luoghi e dei percorsi dei
pellegrinaggi, da un lato, e dall’altro la tradizione teologica e l’immaginario cristiano medioevale. I
luoghi santi sono il principale terreno di plasmazione di un passato che gioca un ruolo cruciale per
l’identità e per la memoria culturale cristiana.
Agli antropologi, abituati a lavorare in società senza scrittura, l’incorporazione della memoria in
luoghi e oggetti è abbastanza familiare. Ne sono un classico esempio le “vie dei canti” della
mitologia australiana, percorsi naturali costellati dalle tracce lasciate dagli antenati o eroi culturali,
rievocate attraverso performance coreutiche e musicali. Il paesaggio è qui la materia prima in cui si
inscrive il passato, e costituisce la vera e propria struttura della memoria collettiva. A proposito
degli Aranda, l’etnologo T.G.H. Strehlow scriveva negli anni ’40 che
le montagne, i ruscelli, le sorgenti e gli stagni non sono per lui aspetti del paesaggio piacevoli o
interessanti. Ognuno fu creato da uno degli antenati da cui egli discende. Nel paesaggio che lo
circonda, legge la storia dei fatti e delle gesta degli esseri immortali che venera […] Tutto il paese
è per lui come un albero genealogico antico e sempre vivo[25].
Claude Lévi-Strauss, commentando questo passo nella sua opera forse più importante, vi scorge
un esempio della capacità del “pensiero selvaggio” di integrare la storia all’interno di un ordine
spaziale, di ricomprendere la diacronia all’interno della sincronia. Un ulteriore esempio di questa
modalità di trattamento del tempo e della storia, da parte dei sistemi (sociali e intellettuali) che egli
definisce classificatori, è rappresentato dai churinga. Si tratta di oggetti rituali, anche in questo
caso australiani, che rappresentano il corpo fisico di un antenato, detenuto dalla persona vivente
che ne è ritenuta la reincarnazione; sono tenuti usualmente nascosti e usati solo in occasioni
cerimoniali. La loro funzione, per Lévi-Strauss, è quella di “rendere vero, in forma tangibile,
l’essere diacronico della diacronia entro la sincronia stessa”[26]: essi sono una manifestazione
diretta e materiale del passato all’interno del presente. Per farli apparire meno esotici, Lévi-Strauss
li raffronta ai moderni archivi, non tanto per le conoscenze che in essi sono contenute, ma per la
loro materialità, la loro natura di oggetti che ci mettono direttamente in contatto con la “pura
storicità”. Se gli archivi andassero distrutti una volta che le fonti sono state tutte pubblicate, egli
osserva, noi non perderemmo alcuna conoscenza, ma il passato resterebbe privo del suo “sapore
diacronico”: sarebbe pensabile ma non fisicamente testimoniato[27].
Sia gli archivi che i churinga incorporano dunque la memoria di un gruppo sociale, in un senso
che va ben al di là delle specifiche informazioni che veicolano: ne sono i materiali portatori, e
questo fa di loro degli oggetti in qualche modo sacri, da conservare e maneggiare con modalità
rituali. L’accostamento tra churinga ed archivi trova tuttavia un limite nella fondamentale distinzione
che lo stesso etnologo francese avanza tra due modelli di società, contrapposte proprio intorno al
modo di considerare il tempo passato e di elaborazione sociale della memoria. Da un lato vi sono
le società “calde”, come quella occidentale moderna, che “interiorizzano risolutamente il divenire
storico per farne il motore del loro sviluppo”; dall’altro le società “fredde”, che “cercano…di
annullare, in modo quasi automatico, l’effetto che i fattori storici potrebbero avere sul loro equilibrio
e la loro continuità”. Un obiettivo conseguito non attraverso l’impossibile negazione del divenire
storico, ma attraverso la sua ammissione “come una forma senza contenuto: c’è sì un prima e un
dopo, ma il loro solo significato è di riflettersi l’un l’altro”[28]. In altre parole, il presente è visto
come la costante ripetizione di eventi già accaduti e agiti dagli antenati in un passato mitico. Il
tempo è concepito in modo circolare più che vettoriale, e si presta dunque particolarmente ad
essere inscritto nell’ordine spaziale, sincronico e stabile del mondo materiale, sotto forma di
elementi del paesaggio o di oggetti duraturi; oppure, nell’ordine altrettanto stabile e metastorico del
rituale.
La contrapposizione tra società fredde e calde è uno dei tentativi tramite cui gli studi sociali
hanno cercato di dar conto di una fondamentale trasformazione della memoria sociale nel
passaggio dalla tradizione alla modernità. Alcuni autori l’hanno riletta in termini di differenza tra
oralità e scrittura come modalità prevalenti della comunicazione sociale. Nel primo caso la
memoria ha una coerenza rituale, è cioè depositata in riti (e in narrazioni mitologiche ad essi
strettamente legate) che si tramandano secondo il principio di una integrale e meccanica
ripetizione; nel secondo si può parlare di una coerenza testuale che apre lo spazio dell’esegesi e
dell’interpretazione[29]. L’idea chiave in queste e simili teorie è che la modernità, in virtù della
discontinuità che istituisce nei confronti del passato, sviluppi una consapevolezza della storicità,
del trascorrere inesorabile e irreversibile del tempo, che sarebbe sconosciuta alle culture
tradizionali, immerse invece in un tempo genealogico o strutturale[30] dominato dal mito dell’eterno
ritorno. Proprio questo senso di discontinuità con il passato, avvertito sul piano storico generale
come su quello generazionale e autobiografico, pone un problema di ricostruzione della memoria
tramite istituzioni e pratiche sociali specifiche.
Un’idea analoga sta anche alla base della distinzione proposta da Pierre Nora tra milieu de la
mémoire e lieux de la mémoire, che sta alla base del suo noto progetto di studio sistematico dei
luoghi della memoria francese[31]. Nora, per la verità, ha in mente una discontinuità che si
produce negli ultimi due secoli nella cultura di massa: ma il concetto su cui lavora resta quello del
passaggio da una comunità che vive un tempo circolare ed è costantemente immersa nella
memoria, tanto da non percepirla come problema e da non essere neppure consapevole della sua
esistenza, a una comunità che vive un tempo vettoriale ed è ossessionata dallo sfuggire
inesorabile del tempo, organizzando la propria cultura attorno alla produzione di memoria. Una
dicotomia così netta è difficilmente sostenibile, così come quella tra società calde e fredde. In
realtà, le scienze sociali contemporanee tendono oggi a un deciso scetticismo nei confronti di tutte
quelle categorie che assolutizzano la distanza fra “modernità” e “tradizione” (incluso freddo e
caldo, oralità e scrittura e, come per Nora, memoria vissuta e consapevolezza storica): vedono
anzi nel concetto stesso di tradizione una proiezione etnocentrica dell’autoconsapevolezza della
modernità. Sistematicamente, le indagini etnografiche (ma potrei aggiungere, credo, anche quelle
storiche) su società “tradizionali” mostrano una complessità irriducibile al modello sociologico –
anche e soprattutto in relazione alle concezioni del tempo e alla gestione sociale della
memoria[32].
Nondimeno, il concetto di “luogo di memoria” si è dimostrato straordinariamente fecondo, per la
capacità di aprire nuovi scenari alla comprensione della struttura simbolica degli spazi sociali e
delle pratiche celebrative e commemorative – in contesti “moderni” come in quelli “tradizionali”.
Sviluppando fino in fondo le intuizioni di Halbwachs, lo studio della memoria collettiva dei gruppi
sociali ha abbandonato il terreno delle “rappresentazioni” mentali o puramente discorsive, per
praticare vasti progetti di etnografia degli spazi pubblici e del loro “arredo” simbolico, e, al
contempo, delle pratiche rituali di tipo commemorativo. Gli ultimi anni hanno così visto una grande
fioritura di studi su monumenti, musei, memorial, denominazioni di luoghi e strade, elementi del
patrimonio culturale, raduni, cortei e manifestazioni celebrative, festival, tradizioni più o meno
inventate, film e programmi televisivi. Jay Winter ha parlato di un “boom della memoria” nella
storiografia contemporanea, sostendendo che, sia nel mondo anglosassone sia in molte scuole
europee, il tema della memoria è divenuto “il concetto centrale attorno al quale si organizzano gli
studi storici, una posizione un tempo occupata dalle nozioni di razza, classe, e gender”[33].
Qualcosa di simile si potrebbe dire per antropologia, sociologia e psicologia sociale, discipline
nelle quali la memoria non rappresenta più soltanto un tema teorico di rilievo, ma diviene spesso il
motivo strutturante della stessa ricerca empirica. Anzi, come accennato, in molti studi recenti i
confini disciplinari divengono difficilmente distinguibili: è come se scegliere la memoria come asse
portante della ricerca costringesse non tanto a un’apertura interdisciplinare, quanto a una vera e
propria rottura delle partizioni classiche del sapere umanistico.
6. Memoria ufficiale e vernacolare.
Se la distinzione di Nora tra “ambiente” e “luoghi” di memoria, o tra comunità vivente della
memoria e commemorazioni del passato storico, è in sé assai dubbia, essa suggerisce però la
presenza di diversi livelli o modalità di costruzione pubblica della memoria, che vanno meglio
precisate. Possono risultare più utili in questa chiave distinzioni come quella formulata da Assman
tra “memoria comunicativa” e “memoria culturale”, intese come modalità che non si succedono
evolutivamente ma coesistono in ogni compagine sociale. La prima è basata principalmente sulla
comunicazione orale quotidiana e su un ambito relazionale relativamente ristretto (famiglia,
comunità locale, gruppi associativi), ha un basso grado di istituzionalizzazione e gerarchizzazione
(non vi sono cioè membri del gruppo che per principio detengono maggiori diritti interpretativi), e
risale indietro nel tempo per poche generazioni: più indietro vi è solo un indistinto passato che
tende a trascorrere nell’oblio. La memoria culturale si determina quando un evento del passato
supera questa barriera dell’oblio ed entra nel patrimonio di ricordi istituzionalizzati di una comunità.
Alla caducità del tempo, essa contrappone dunque elementi di permanenza e di stabilità, che
rappresentano fattori di identificazione di un gruppo, consentendogli – in senso durkheimiano – di
percepirsi come un’unità. La memoria culturale è dunque fortemente istituzionalizzata, legata alle
forme di potere, gestita da specialisti o professionisti, e tende a costituire un “canone” di ciò che
nel passato è prezioso, fondativo, esemplare. Nelle culture antiche studiate da Assman tale
canone ha carattere “sacro”, è cioè separato dal sapere e dalle pratiche ordinarie e quotidiane: ma
la sua funzione sociale resta analoga anche all’interno di culture secolarizzate[34].
Troviamo qui la contrapposizione tra una memoria istituzionale e formalizzata e una che
potremmo chiamare popolare o quotidiana; un punto chiarito ancora meglio da un’altra coppia di
concetti, memoria “ufficiale” e “vernacolare”. John E Bodnar, nel contesto di uno studio sul
patriottismo e la memoria pubblica americana del Novecento, ha formulato così queste nozioni:
La memoria pubblica emerge al punto di intersezione fra espressioni culturali ufficiali e vernacolari.
Le prime derivano dagli interessi di leader o autorità culturali a tutti i livelli della società, in posizioni
di preminenza in piccole città o in comunità etniche, oppure nelle burocrazie educative,
governative o militari. Questi leader sono accomunati dall’interesse per l’unità sociale e per la
continuità delle istituzioni esistenti, e dalla lealtà allo status quo. […] La cultura ufficiale si fonda su
una riaffermazione della realtà in termini ideali, evitando la complessità e l’ambiguità: essa
presenta il passato su basi astratte, sacrali e senza tempo […] Dall’altra parte, la cultura
vernacolare rappresenta una gamma di interessi particolari, che affondano le radici in parti
dell’insieme sociale. I difensori di tali culture sono numerosi, e mirano a proteggere valori e a
riaffermare visioni della realtà derivate da esperienza diretta in piccole comunità, piuttosto che
dalle comunità “immaginate” di una vasta nazione. […] Le espressioni vernacolari trasmettono il
senso di come la realtà sociale è avvertita, non come dovrebbe essere. La loro stessa esistenza è
una minaccia per la natura sacra e atemporale delle espressioni ufficiali[35]
Nonostante una certa ambiguità nella nozione di “vernacolare”, e la assunzione per nulla
scontata di una omogeneità della cultura “ufficiale”, questa impostazione del problema introduce
opportunamente l’elemento del conflitto nella comprensione dei luoghi e delle pratiche della cultura
ufficiale. Questo è un progresso importante rispetto alle più classiche nozioni di schemi o quadri
sociali della memoria, che Bartlett e Halbwachs sembravano intendere come ampi scenari di
condivisione, espressione dell’unità del gruppo sociale e non delle sue fratture interne. Luoghi,
oggetti e riti della memoria si configurano dunque non come meccaniche strategie di affermazione
di valori identitari indiscussi e obbligatori, ma come scenari di confronto, di contestazione, di
negoziati fra “voci”, interessi e interpretazioni diverse. Essi sono sì espressione del potere, ma in
un senso che include le dinamiche conflittuali che percorrono il tessuto sociale sull’asse egemoniasubalternità.
Il “memory boom” di cui parla Winter si è occupato però prevalentemente del livello istituzionale
e egemonico, concentrandosi in particolare sulle strategie della memoria usate dagli Stati-nazione
in età contemporanea per costruire un consenso e un senso di identità e appartenenza di massa.
Su questo piano, l’interesse per il concetto di memoria si è saldato con l’influenza di studi come
quelli di Mosse sulla nazionalizzazione delle masse e di Hobsbawm e colleghi sull’invenzione della
tradizione[36]. Secondo una diffusa interpretazione, il modello di memoria culturale che oggi ci è
più familiare, legata a un’ampia identità nazionale (o alla sua immaginazione), nasce con le grandi
rivoluzioni moderne, l’americana e la francese. Prima, quelle che si registrano sono memorie
puramente locali oppure memorie dinastiche di respiro cosmopolita. Sono le rivoluzioni, con il loro
culto di un “nuovo inizio” e con il loro senso di rottura con il passato, a dar luogo a espressioni
topografiche e rituali di memoria in grado di coinvolgere la totalità dei “cittadini”. Monumenti, parate
militari e civili, raduni di massa, comizi nei luoghi pubblici più rappresentativi, bandiere e inni
nazionali, insieme al dispiegamento di un’ampia gamma di simboli dalla forte capacità di
coinvolgimento emotivo, sono gli strumenti che consentono l’immaginazione di una comunità
moderna, secondo la celebre espressione di Benedict Anderson: gli strumenti che consentono a
persone lontane, che non si sono mai viste né sentite, di considerarsi legate da un medesimo
passato e da una memoria comune[37]. Questo processo raggiungerà il suo apice nella
mobilitazione militare di massa in occasione delle grandi guerre, soprattutto della Prima Guerra
Mondiale, e nelle celebrazioni di vittoria o di lutto che ad esse fanno seguito.
Questa plasmazione nazionalista di una memoria comune presuppone ovviamente, al tempo
stesso, una condivisione di oblio. Un oblio non solo nei confronti del passato (ad esempio delle
divisioni che contrastano con l’attuale senso di unità), come nella citatissima espressione di Ernest
Renan[38], ma anche di componenti del presente che non sono viste come fondanti del più
profondo nucleo identitario. Le minoranze etniche, le donne, le classi lavoratrici entrano raramente
a far parte delle memorie ufficiali della nazione, né sono soggetti attivi delle pratiche simboliche di
commemorazione: questo ruolo è per lo più riservato alle élites maschili. Colpisce particolarmente
l’assenza delle donne, alle quali in età moderna non si erigono monumenti, e il cui ruolo è
prevalentemente allegorico (come nelle immagini della Libertà o delle Repubbliche), o di gestione
del lutto per i morti delle guerre. John Gillis fa notare ad esempio come in Francia e Inghilterra, con
l’eccezione della regina Vittoria, gli unici monumenti eretti a donne riguardino figure dei tempi premoderni. La modernità sembra ricordare le donne solo per il loro impersonale ruolo di mogli e
madri, e non per le loro specifiche azioni e personalità[39].
7. I luoghi della memoria oltre il nazionalismo.
La fase classica delle politiche celebrative nazionaliste esalta dunque la memoria pubblica
istituzionale, lasciando in secondo piano le memorie private e vernacolari, almeno nella misura in
cui non si collocano nel quadro della grande narrazione nazionale (la biografia e la storia locale, in
questo quadro, acquistano senso solo come declinazioni particolaristiche della “storia patria”). Si
tratta tuttavia di una fase che sembra progressivamente esaurirsi nella seconda metà del XX
secolo. Una serie di fattori politici e culturali indeboliscono il ruolo dello Stato nazione, che non è
più l’esclusivo detentore dei mezzi di comunicazione e degli strumenti per la costruzione di
immaginazione comunitaria. La religione civile degli Stati-nazione, che venerano sé stessi
attraverso il proprio passato, è messa in discussione dai disastri della Seconda guerra mondiale; e
i movimenti degli anni ’60 indirizzano la loro critica proprio alle istituzioni fondanti la memoria
culturale del nazionalismo (esattamente come la rivoluzione borghese l’aveva rivolta ai luoghi e ai
tempi sacri della Chiesa e dell’Antico Regime). Inoltre la globalizzazione, la creazione di “sfere
pubbliche diasporiche”, come le chiama l’antropologo Arjun Appadurai, il flusso di “immagini in
movimento che incrociano spettatori deterritorializzati”[40], aprono nuove possibilità per la
costituzione di memorie e identità trasversali, cosmopolite o etniche, transnazionali o
particolaristiche. La memoria culturale si fa assai più complessa rispetto alla descrizione di
Assman: non è più controllata strettamente da specialisti accreditati, non si concentra in luoghi e
spazi ben delimitati: nei decenni finali del Novecento, si presenta come ulteriormente secolarizzata
e come “più democratica”.
Contemporaneamente, la polverizzazione e desacralizzazione della vita pubblica, insieme
all’etica fortemente individualista della società tardo-moderna, conducono a una personalizzazione
delle pratiche di memoria. Coltivare memorie autobiografiche e familiari, in precedenza prerogativa
dei ceti aristocratici o delle élites alto-borghesi, diviene un fenomeno di massa. I diari, le
celebrazioni dei compleanni e degli anniversari di famiglia, la raccolta e periodica consultazione di
fotografie o di videoriprese, la conservazione sistematica di archivi personali (con epistolari, vecchi
quaderni di scuola, documentazione di viaggi e altri eventi significativi), le collezioni di souvenir queste e altre pratiche rievocative e rivolte al passato sono cospicuamente presenti nella
quotidianità della vita privata e domestica nel mondo contemporaneo.
E’ come se, indebolendosi le forme pubbliche e istituzionali della memoria culturale, la funzione
del ricordare ricadesse più direttamente sugli individui, i quali si sentono obbligati a registrare, a
collezionare, a salvare il più possibile i ricordi dalla loro caducità. “Mai in passato si è ricordato e
collezionato così tanto, e mai il ricordare è stato così compulsivo”, scrive ancora Gillis[41]. Si
conserva di tutto, e in questo siamo aiutati dallo sviluppo delle tecnologie di registrazione e di
archiviazione delle informazioni: con la diffusione di magnetofoni, videocamere, personal computer
e supporti digitali a basso costo diviene possibile realizzare archivi personali e familiari di grande
ampiezza. Nell’incertezza su cosa sia più importante ricordare, si può registrare e mettere da parte
tutto, e ci sentiamo in dovere di farlo, come se le nostre esperienze perdessero autenticità se non
lasciano traccia in un supporto archiviabile. In una certa misura, si vive in funzione della futura
memoria: si cercano cioè, ad esempio nell’ambito del turismo, certe esperienze allo scopo di
poterle poi ricordare, rievocare, narrare.
Questa diffusione e polverizzazione delle pratiche di memoria, che saturano la vita quotidiana di
individui e famiglie, ha a che fare con la più generale natura diffusa e privata della ritualità nel
mondo contemporaneo. I piccoli rituali della quotidianità, come ha mostrato Erving Goffman,
possono essere ancora letti secondo la chiave durkheimiana della “produzione del sacro”. Solo
che il sacro non è in questi casi la società, la comunità nella quale l’individuo tendenzialmente si
annulla fondendosi con gli altri, ma lo stesso self individuale. Alla narrazione nazionale del
passato, come origine del significato della storia, si sostituisce la moltitudine delle narrazioni
autobiografiche, tendenzialmente tutte registrabili e raccoglibili in un unico grande archivio, che
attraverso la rete può divenire immediatamente accessibile a tutti.
In qualche modo, dunque, la grande corrente di studi sulle politiche e le poetiche della memoria
dei moderni Stati-nazione finisce per ricongiungersi con gli interessi per la cultura popolare, per le
pratiche vernacolari e quotidiane di gestione del ricordo: due livelli che è sempre più difficile tenere
oggi distinti. Così come è difficile tenere distinti, per riprendere un punto toccato in apertura di
questo articolo, gli approcci, le metodologie, gli strumenti concettuali, di diverse discipline.
8. L’uso pubblico di memoria e identità.
Vorrei concludere questa rassegna accennando ad alcuni rilevanti problemi che emergono dalle
correnti di studio fin qui esaminate – problemi che avrebbero naturalmente bisogno di una
trattazione di ben altra ampiezza. Intanto, se è vero che viviamo oggi in uno scenario mnestico
post-nazionale, saturo di autobiografia e di oggetti, luoghi e discorsi della memoria tanto
frammentati quanto pervasivi, ciò sembra creare un problema, come si è espresso Charles
Maier[42], di “eccesso di memoria”. Rischiamo un po’ di assomigliare a Funes, il personaggio di
J.L. Borges dalla memoria ipertrofica, che ha “più ricordi da solo di quanti non ne avranno avuti gli
uomini tutti insieme, da che mondo è mondo “, e che “due o tre volte aveva ricostruito una
giornata intera; non aveva mai esitato, ma ogni ricostruzione aveva richiesto un’intera
giornata”[43]. Funes è citato spesso come esempio della necessità dell’oblio; ma l’immagine della
sua mente “come un deposito di rifiuti” si presta bene anche a rappresentare il nostro ambiente di
memoria, ingombro da icone del passato formato usa e getta.
L’eccesso di memoria riguarda però anche la produzione storiografica e antropologica. Abituate
a lavorare in regime di relativa scarsità di fonti, queste discipline non si trovano a loro agio in
scenari di fonti sovrabbondanti, in universi archivistici che non potranno mai esser controllati in
modo integrale. Ma soprattutto, ciò che più conta, storia e antropologia sono inevitabilmente
coinvolte nei processi sociali di produzione di memoria: anzi, all’interno del discorso pubblico esse
godono di uno statuto privilegiato – in quanto produttrici scientificamente accreditate di resoconti
sul passato, sulla tradizione, sull’identità culturale. Storici e antropologi sono gli specialisti di quella
memoria culturale che, per altri versi, è invece il loro oggetto di studio. Lo dimostra il loro frequente
coinvolgimento (soprattutto degli storici: il ruolo pubblico degli antropologi è almeno in Italia assai
meno importante) come arbitri o periti tecnici in casi di conflitti nella memoria sociale: ad esempio,
nelle situazioni di “memoria divisa” che ancora oggi dibattono le comunità colpite da eccidi
nazifascisti nell’Italia del ’43-’45. Mentre gli storici studiano la memoria divenendo consapevoli dei
complessi processi culturali tramite i quali essa si costruisce e si plasma, e dunque della sua
natura politicamente e retoricamente strutturata, essi sono chiamati nell’arena pubblica e
istituzionale a testimoniare la semplice e assoluta “verità”, a farsi interpreti di una versione tecnica
(cioè non politica) e oggettiva (cioè non retorica) del passato. In questo ruolo, si trovano fra l’altro a
“competere” con altre figure di portatori o specialisti della memoria, in particolare con quella del
“testimone”, divenuta centrale nello scenario mediatico degli ultimi decenni. Annette Wieviorka, in
un brillante saggio, ha mostrato l’emergere progressivo del testimone come figura-chiave nella
memoria culturale dell’Occidente – un fenomeno legato soprattutto alla memoria della Shoah e
databile, a suo parere, a partire dal processo Eichmann. Wieviorka ha insistito sulla profonda
tensione che si determina fra il sapere e il discorso del testimone e quelli dello storico: la
prospettiva soggettiva, autobiografica ed empatica del primo può rappresentare una fonte per il
secondo, che deve tuttavia trascenderla per conseguire un punto di vista generale, collettivo,
criticamente analitico. Il processo di Gerusalemme inaugura il sogno di una storia costruita come
somma di autobiografie, come “giustapposizione di racconti d’orrore”; e Wieviorka si chiede se
“questa volontà di non pensare in termini generali, o in termini collettivi, non rappresenti in realtà la
negazione stessa della storia. Essa distruggerebbe proprio quell’operazione intellettuale che
consiste nel costruire un racconto e che chiamiamo, per l’appunto, fare storia”[44].
Per un antropologo è difficile accettare una così severa riserva nei confronti della prospettiva
soggettiva del testimone, e una divaricazione così netta fra la prospettiva autobiografica e quella
storica: quest’ultima, secondo la tradizione epistemologica della disciplina, non può essere
raggiunta se non passando per la prima. Tuttavia il problema che Wieviorka pone è reale: ella si
riferisce al rischio che lo spettacolo del racconto emotivamente partecipato delle esperienze di vita
si sostituisca a un sapere del passato costruito in modo scientifico, che sia cioè possibile
sottoporre a costante critica e falsificazione secondo criteri condivisi dalla comunità degli studiosi.
La grande sofferenza che emana dai racconti dei sopravvissuti alla Shoah, come i testimoni del
processo Eichmann, può esser considerata come sintomo di autenticità e “verità” della narrazione
del passato, ma anche come un muro di fronte al quale il metodo storiografico non può che
infrangersi[45]. E questo problema sembra porsi con grande forza nello scenario mediale attuale,
caratterizzato appunto dalla spettacolarizzazione dell’intimità biografica e in particolare della
esperienza del dolore. Per inciso, si può ritenere che anche il dibattito odierno sul revisionismo
storico risenta di questa modalità della memoria, confondendo il problema della comprensione di
percorsi autobiografici legati al fascismo (“i ragazzi di Salò”) con il problema del giudizio storico.
Nel loro ruolo di specialisti nella gestione pubblica della memoria, storici e antropologi si
trovano inoltre coinvolti in un ulteriore dilemma, relativo al tema dell’identità. Memoria e identità
sono strettamente legate. Com’è evidente, quella che un gruppo sociale percepisce come propria
identità si concretizza nelle produzioni – discorsive, monumentali, rituali – della sua memoria
collettiva; d’altra parte, il modo in cui la memoria viene pubblicamente costruita e gestita dipende in
larga misura da quella stessa percezione di identità, dai significati, dai valori, dalle finalità che si
ritengono fondamentali indicatori di appartenenza. Elaborato e sostenuto nel corso del Novecento
dall’antropologia, il concetto di identità culturale è da alcuni decenni al centro di una radicale
revisione critica all’interno della disciplina. Pur nato da una irrinunciabile istanza anti-etnocentrica,
il concetto è stato reificato, inteso come una sorta di proprietà sostantiva dei gruppi sociali –
qualcosa che si può ad esempio”perdere”, “recuperare”, una qualità inscritta nei “caratteri”
personali o nel patrimonio culturale. uesta QQ Una simile idea essenziale di cultura si è
ampiamente diffusa dal discorso delle scienze sociali a quello comune, politico e mediale. Ci si
raffigura il mondo come naturalmente diviso in una molteplicità finita di unità culturali discrete, dai
confini più o meno netti e stabili; un immaginario che si lega strettamente alle strategie di
autolegittimazione del moderno Stato-nazione. Richard Handler, un antropologo che ha spinto
assai in profondità la critica all’idea stessa di identità culturale, parla in proposito di
una diffusa teoria della cultura e della società che sostiene una ideologia nazionalista
globalmente egemonica. In questa prospettiva, le nazioni sono immaginate come oggetti o cose
naturali che esistono nel mondo reale. In quanto oggetti naturali, esse possiedono una identità
unica, che può esser definita in relazione a precisi confini spaziali, temporali e culturali[46]
L’odierna critica antropologica si appunta sul fatto che tali identità “naturali” sono in realtà
costruite in base a interessi ed esigenze del contesto presente, e si salda con la discussione che
abbiamo cercato di seguire sul concetto di memoria sociale: fino a riconoscere che “siamo
costantemente impegnati a rivedere le nostre memorie per adattarle alle nostre attuali identità”, nel
quadro di “complesse relazioni di classe, di genere e di potere che determinano ciò che viene
ricordato (o dimenticato), da chi, e a quale scopo”[47].
Non solo: nata come “innocente” strumento di auto-riconoscimento e immaginazione di comunità
nazionali, l’ideologia identitaria diviene progressivamente sostegno di politiche di esclusione e
aggressione; in epoca di globalizzazione, la troviamo all’opera nel quadro di movimenti xenofobi e
neorazzisti, di fondamentalismi culturali di vario tipo, e soprattutto nei fenomeni della violenza
cosiddetta etnica e dei genocidi – dalla Shoah alla ex-Jugoslavia[48]. Il problema è dunque: in
quale misura storici e antropologi coinvolti nelle pratiche di costruzione, gestione, valorizzazione
della memoria e dell’identità pubblica si fanno “complici”, per quanto inconsapevolmente, delle
ambiguità etico-politiche, oltre che epistemologiche, dell’ideologia nazionalista? In che misura il
lavoro sul patrimonio culturale, sulla tradizione folklorica, sugli archivi scritti o orali,
apparentemente mosso da motivazioni innocenti e da alti e puri ideali culturali, si può rivelare
dipendente da presupposti ideologici che supportano un ordine egemonico, un potere dagli effetti
discriminatori? E’ quanto sostiene un’ampia letteratura che, a partire dagli anni Ottanta, ha
“decostruito” il concetto di patrimonio culturale (heritage) e le pratiche di tutela e di rivendicazione
identitaria ad esso legate, mostrandone i nessi strettissimi con le politiche nazionaliste e insistendo
sugli effetti deleteri dell’esportazione su scala globale del modello euro-americano dei beni culturali
come icone della identità di gruppo:
In tutto il mondo, il patrimonio culturale risponde a comuni esigenze e incorpora tratti comuni. Ma
esigenze e tratti sono definiti sulla base di una gelosia sciovinista. Ci confrontiamo gli uni con gli
altri corazzati all’interno di identità, le cui somiglianze ignoriamo o non vogliamo vedere,
inventando o distorcendo invece le differenze per sottolineare la nostra superiorità. Esaltando le
nostre eredità ed escludendo quelle degli altri, creiamo una situazione endemica di rivalità e
conflitto[49].
Anche qui si manifesta il difficile rapporto che storici e antropologi intrattengono con le pratiche
sociali di costruzione della memoria e dell’identità: protagonisti direttamente coinvolti in tali pratiche
da un lato, in quanto “specialisti” del passato o dell’identità culturale, dall’altro distaccati e critici
osservatori. La storia, come osserva Assman, è una fra le molte forme di produzione di una
memoria pubblica, differenziandosi semmai per il suo carattere “freddo” da quelle “culture del
ricordo” i cui contenuti sono sempre in stretta relazione con l’identità del gruppo che ricorda[50].
Essa è allora stretta in un duplice rischio: il rischio di appiattirsi sulle auto-rappresentazioni e sulle
istanze identitarie egemoniche e, inversamente, quello di un distacco critico che separa
completamente il ricercatore dalla partecipazione alle politiche culturali della società in cui vive. Se
entrambi questi approdi sono inaccettabili, non v’è tuttavia alternativa a muoversi all’interno della
tensione che essi definiscono. Partecipare alle pratiche di costruzione della memoria pubblica e
del patrimonio culturale, restando consapevoli dei complessi meccanismi che li costituiscono
retoricamente e politicamente nel presente, è il difficile compito che accomuna oggi, a me pare,
storici e antropologi.
[1] A.D. Baddeley, La memoria di lavoro, trad. it. Milano, Cortina, 1990 (ed. orig. 1986) ; Id., La memoria umana. Teoria e
pratica, trad. it. Bologna, Il Mulino, 1992 (ed. orig. 1990)
[2] E. Tulving, “Episodic and semantic memory” in E. Tulving, D. Donaldson (eds.), The Organization of memory, 1972;
E. Tulving, Elements of episodic memory, Oxford University Press, 1983. Com’è stato notato, questa tripartizione ricalca
quella stabilita dalla filosofia di inizio secolo tra memoria abituale o operativa, memoria proposizionale e memoria dei
ricordi; v. John Sutton, “Memory”, in Stanford Encyclopedia of Phylosophy, 2003,
[3] Paul Connerton, Come le società ricordano, trad. it. Roma, Armando, 1999 (ed. orig. 1989), p. 89
[4] Tulving, “Episodic and semantic memory”, cit., p. 386
[5] Daniel L. Schachter, Alla ricerca della memoria. Il cervello, la mente e il passato, trad. it. Torino, Einaudi, 2001 (ed.
orig. 1996), p. 169 sgg.
[6] Giovanna Leone, La memoria autobiografica. Conoscenza di sé e appartenenze sociali, Roma, Carocci, 2001, pp. 501.
[7] G. Leone, La memoria autobiografica, cit., p. 80. L’opera principale di Bartlett è Remembering, del 1932 (trad. it. F.C.
Bartlett, La memoria. Studio di psicologia sperimentale e sociale, Milano, Angeli, 1974). L’idea di un rapporto di
determinazione inversa tra passato e presente non era peraltro nuova alla riflessione umanistica: ne è un interessante
esempio quanto Italo Svevo scriveva ai primi del secolo: “Il presente dirige il passato come un direttore d’orchestra i suoi
suonatori. Gli occorrono questi e quei suoni, non altri. E perciò il passato sembra ora tanto lungo ora tanto breve.
Risuona o ammutolisce. Nel presente riverbera solo quella parte ch’è richiamata per illuminarlo o per offuscarlo” (cit. in
Aleida Assmann, Ricordare. Forme e mutamenti della memoria culturale, trad. it. Bologna, Il Mulino, 2002 [ed. orig.
1999], p. 18).
[8] Di Neisser è disponibile in traduzione italiana il volume Psicologia cognitivista, Firenze, Giunti, 1976 (ed. orig. 1967);
ma il testo probabilmente più rappresentativo dell’approccio ecologico è U. Neisser (ed.), Memory Observed:
Remembering in Natural Contexts, San Francisco, Freeman & Co., 1982. V. anche G. Cohen, Memory in the Real
World, London, Lawrence Erlbaum.
[9] Neisser ha studiato questa strategia della memoria a proposito del caso della testimonianza resa al processo
Watergate da un collaboratore di Nixon, John Dean: le sue deposizioni, confrontate con prove documentali oggettive,
dimostravano che egli univa in singoli episodi una serie di fatti e informazioni che appartenevano a situazioni fra loro
slegate. Gli episodi riferiti erano fattualmente falsi, mai avvenuti: tuttavia, si trattava di “drammatizzazioni” che
rappresentavano in modo esemplare la sequenza di eventi reali, il “significato” delle vicende indagate. Come commenta
Giovanna Leone (I confini della memoria. I ricordi come risorse sociali nascoste, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1998, p.
15), “questo ricordo va considerato non come un errore di trascrizione, ma come una rielaborazione creativa, che
permette di cogliere il succo dell’intera sequenza, seppure espresso in un ricordo formalmente ‘sbagliato’”. V. U. Neisser,
“John Dean’s memory: A case study”, Cognition, 9, 1981, pp. 1-22. Per un’ampio esame dal punto di vista psicologico
dei problemi della falsa memoria v. D.L. Schacter (ed.), Memory Distortion. How Minds, Brains and Societies
Reconstruct the Past, Harvard, Harvard University Press, 1995.
[10] C. Geertz, Interpretazione di culture, trad. It. Bologna, Il Mulino, 1987 (ed. orig. 1973), p. 53
[11] Ipotesi, questa, resa assai probabile dal fatto che la MPD ( Multiple Personality Disorder ) è un classico esempio di
ciò che gli antropologi chiamano culture-bound syndrome, cioè una malattia presente solo in uno specifico contesto
culturale. L’MPD è infatti stata diagnosticata massicciamente negli Stati Uniti negli ultimi 15-20 anni, e sembra del tutto
assente da ogni altra epoca e cultura medica. Si veda in proposito la discussione contenuta in Ian Hacking, La riscoperta
dell’anima. Personalità multipla e scienze della memoria, trad. it. Milano, Feltrinelli, 1996 (ed. orig. 1995) e Paul Antze,
“Telling stories, making selves: Memory and identity in Multiple Personality Disorder”, in P.Antze-M.Lambek (eds.),
Tense Past. Cultural Essays in Trauma and Memory, New York-London, Routledge, 1996, pp. 3-24. Si veda anche il
cap. 9, “Guerre della memoria”, in D. L. Schachter, Alla ricerca della memoria, cit., pp. 269-306
[12] Gerald Echterhoff, “Falso ricordo (false memory)”, in Nicolas Pethes-Jens Ruchatz (a cura di), Dizionario della
memoria e del ricordo, trad. it. Milano, Bruno Mondadori, 2002 (ed. orig. 2001), pp. 190-91.
[13] I quadri sociali della memoria, trad. it. Napoli, Ipermedium, 1997 (ed. orig. 1925); La memoria collettiva, trad. it.
Milano, Unicopli, 1996 (ed. orig. postuma 1950, ma scritto negli anni ’30); Memorie di Terrasanta, trad. it. Venezia,
Arsenale, 1988 (ed. orig. La tipographie légendaire des Evangelis en Terre Sainte, 1941).
[14] M. Halbwachs, I quadri sociali della memoria, cit., p. 3
[15] P. Jedlowski, “Introduzione”, in M. Halbwachs, La memoria collettiva, cit., p. 26
[16] Ibid., p. 27
[17] J. Shotter, “The social construction of remembering and forgetting”, in D. Middleton - D. Edwards (eds.), Collective
Remembering, London, Sage, 1990, p. 121
[18] Ibid., pp. 121-2
[19] G. Leone, La memoria autobiografica, cit., p. 30
[20] M. Bloch, “Internal and external memory: different ways to be in history”, in P.Antze – M.Lambek (eds.), Tense Past,
cit., p. 217. L’obiettivo esplicito della crititca di Bloch è il celebre libro di Jack Goody, L’addomesticamento del pensiero
selvaggio, trad. it. Milano, Angeli,
uno studio del ruolo della scrittura come dispositivo mnemonico, e del suo ruolo
nella plasmazione delle forme del pensiero razionale. La più classica trattazione del ruolo della memoria esterna nel
quadro più generale dell’evoluzione umana, vista come sequenza di successive esteriorizzazioni che liberano
progressivamente la mano dal peso delle funzioni biologiche e del lavoro materiale, e la mente dal peso della
memorizzazione interna, è probabilmente quella offerta da A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, trad. it. Torino, Einaudi,
19 (ed. orig. ), vol. II.
[21] Rimando in proposito a F. Dei, “La libertà di inventare i fatti: antropologia, storia, letteratura”, Il gallo silvestre, 13,
2000, pp. 180-96
[22] David Middleton, Derek Edwards, “Conversational remembering; A social psychological approach”, in D. Middleton,
D. Edwards (eds.), Collective Remembering, cit,, p. 3 sgg.; Degli stessi autori si veda anche “Conversational
remembering and family relationships: How children learn to remember”, Journal of Social and Personal Relationships, 5,
1988, pp. 3-25.
[23] Si vedano ad esempio le considerazioni metodologiche in Giovanni Contini, Alfredo Martini, Verba manent. L’uso
delle fonti orali per la storia contemporanea, Roma, NIS, 1993, pp.12 sgg., e in Alessandro Portelli, “Problemi di metodo.
Sulla diversità della storia orale”, in C. Bermani (a cura di), Introduzione alla storia orale, vol. I, Roma, Edizioni Odradek,
1999, pp. 149-66: in questi contributi il problema della produzione congiunta del significato da parte di narratore e
ricercatore è affrontato con chiarezza, ma non inquadrato nella cornice sociolinguistica ed etnometodologica propria
dell’etnografia della conversazione. Il che implica il rischio di sopravvalutare la “trasparenza” del discorso del testimone.
Per una recente discussione in chiave costruttivista del ruolo del contesto di ricerca nella produzione di narrazioni
autobiografiche, si vedano gli articoli di K.Tschuggnall, H. Welzer, “Rewriting memories: Family recollections of the
National Socialist past in Germany”, e di Alessandra Fasulo, “Hiding on a glass roof, or a commentator’s exercise on
‘Rewriting memories’”, entrambi in Culture and Psychology, 8, 2002, pp. 132-45, 146-52.
[24] Cit. in Ugo Fabietti,Vincenzo Matera (a cura di), Memoria e identità. Simboli e strategie del ricordo, Roma, Meltemi,
1999, p. 40
[25] Cit. in Claude Lévi-Strauss, Il pensiero selvaggio, trad.it. Milano, Il Saggiatore, 1964, p. 263 (ed. orig. 1962; il testo di
Strehlow è del 1947)
[26] Ibid., p. 258
[27] Ibid., p. 262.
[28] Ibid., pp.254-5
[29] La rilettura delle contrapposizioni tra pensiero selvaggio e addomesticato, o fra società fredde e calde, in termini di
evoluzione della scrittura, è sostenuta ad esempio da Jack Goody, L’addomesticamento del pensiero selvaggio, trad. it.
Milano, Angeli, 19 (ed. orig.). Di coerenza rituale e testuale parla Jan Assman nel suo importante lavoro sulla memoria
culturale (La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche, trad.it. Torino, Einaudi,
1997 (ed. orig. 1992), vedendone degli esempi nelle antiche culture, rispettivamente, egiziana ed ebraica.
[30] La più classica trattazione antropologica del tempo “strutturale” è probabilmente quella di Edward E. EvansPritchard, I Nuer: un’anarchia ordinata, trad. it. Milano, Angeli, 1985 (ed. orig. 1940), p. 160: nella società pastorale
africana dei Nuer, “la storia valida termina a un secolo e la tradizione…ci porta indietro soltanto a dieci o dodici
generazioni nella struttura del lignaggio”, così che “la distanza tra l’inizio del mondo e il giorno d’oggi rimane inalterata. Il
tempo, in tal modo, non è un continuum, ma una relazione strutturale costante tra due punti: la prima e l’ultima persona
in una linea di discendenza agnatica […] Al di là del ciclo annuale, il calcolo del tempo è una concettualizzazione della
struttura sociale e i punti di riferimento sono una proiezione nel passato delle relazioni attuali fra gruppi di persone”.
[31] Pierre Nora, “Entre mémoire et histoire. La problematique des lieux”, in P. Nora (sous la direction de), Les lieux de
mémoire, vol. I, Paris, Gallimard, 1984
[32] Per una critica assai radicale su questi punti a Nora, accusato di “ignoranza storica e pregiudizio”, si veda Elizabeth
Tonkin, Raccontare il nostro passato. La costruzione sociale della storia orale, trad. it. Roma, Armando, 2000 (ed. orig.
1992), p. 166.
[33] Jay Winter, “The generation of memory: Reflections on the ‘Memory Boom’ in contemporary historical studies”,
Bulletin of the German Historical Institute, 27, 2002, p. 1 (http://www.ghi-dc.org/bulletin27F00/b27winterframe.html). A
questo boom Winter ha dato del resto il suo notevolissimo contributo con un celebre testo sui monumenti della Grande
Guerra: J. Winter, Il lutto e la memoria. La Grande Guerra nella storia culturale europea, trad. it. Bologna, Il Mulino, 1998
(ed. orig. 1995). Si vedano anche i contributi raccolti in J. Winter, E. Sivan (eds.), War and Remembrance in the
Twentieth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
[34] Jan Assman, La memoria culturale, cit. passim; v. anche Dietz Bering, “Memoria culturale”, in N. Pethes, J. Ruchatz
(a cura di), Dizionario della memoria e del ricordo, cit., pp. 316-19.
[35] John E. Bodnar, Remaking America. Public Memory, Commemoration, and Patriotism in the Twentieth Century,
Princeton, Princeton University Press, 1992, pp. 14-15; si veda anche S. M. Rowe, J.V. Wertsch, T. Y. Kosyaeva,
“Linking little narratives to big ones: Narrative and public memory in history museums”, Culture and Psychology, 8 (1),
2002, pp. 96-112.
[36] Gorge L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse. Simbolismo politico e movimenti di massa in Germania (18151933), TRAD. IT. Bologna, Il Mulino, 1975 (ed. orig. 1974); E.J. Hobsbawm, T. Ranger (a cura di), L’invenzione della
tradizione, trad. it. Torino, Einaudi, 1987 (ed. orig. 1983).
[37] V. John R. Gillis, “Memory and identity: The history of a relationship”, in J. R. Gillis (ed.), Commemorations. The
Politics of National Identity, Princeton, Princeton University Press, 1994, p. 7.
[38] “L’oblio, e dirò perfino l’errore storico, costituicono un fattore essenziale nella creazione di una nazione”; E. Renan,
Che cos’è una nazione, trad. it. Roma, Donzelli, 1993, p. 7 (ed. orig. 1882).
[39] J. R. Gillis, “Memory and identity…”, cit., pp. 11-12.
[40] Arjun Appadurai, Modernità in polvere. Dimensioni culturali della globalizzazione, trad. it. Roma, Meltemi, 2001 (ed.
orig. 1996), p. 17
[41] “Memory and identity..:”, cit., p. 14
[42] C. Maier, “Un eccesso di memoria? Riflessioni sulla storia, la malinconia e la negazione”, Parolechiave, 9, 1995, pp.
29-43y
[43] Jorge Luis Borges, “Funes, o della memoria”, in Finzioni, trad. it. Milano, Mondadori, 1980 (ed. orig. 1944), p. 90
[44] A. Wieviorka, L’era del testimone, trad. it. Milano, Cortina, 1999 (ed. orig. 1998), pp. 105-6
[45] Come nota Wieviorka (Ibid., p. 100), neppure l’avvocato difensore di Eichmann osava contestare la veridicità e la
pertinenza delle numerosissime testimonianze che intervengono nel processo, tanto forte è la loro intensità emotiva ed
etica. Eppure proprio quelle testimonianze pongono problemi riguardo l’ “autenticità” della memoria, se è vero che già
Hannah Arendt notava l’assenza in esse della “capacità di distinguere tra ciò che l’interessato aveva vissuto sedici o
forse vent’anni prima e le cose che aveva letto e udito e immaginato nel frattempo” (H. Arendt, La banalità del male.
Eichmann a Gerusalemme, trad. it. Milano, Feltrinelli, 1999 (ed. orig. 1963), p. 231.
[46] R. Handler, “Is ‘identity’ a useful cross-cultural concept?”, in J.R. Gillis (ed.), Commemorations, cit., pp. 28-29
[47] J R. Gillis, “Memory and identity”, cit., p. 3
[48] La letteratura antropologica sul nesso tra la violenza etnica e le politiche di identità del moderno Stato-nazione è
assai estesa. Per una visione d’insieme rimando ai contributi raccolti in A.L. Hinton (ed.), Genocide. An Anthropological
Reader, Oxford, Blackwell, 2002; A.L. Hinton (ed.), Annihilating Difference. Anthropology and Genocide, Berkeley,
California University Press, 2002. Per una formulazione sintetica e ormai in qualche modo classica della tesi che
attribuisce alle ideologie identitarie e culturaliste un’ampia parte di responsabilità nella violenza e nelle pratiche di pulizia
etnica si veda A. Appadurai, “Dead certainty: Ethnic violence in the era of globalization”, Public Culture, 10 (2), 1998, pp.
225-47. Per un mio più ampio commento su questa letteratura, rimando a F. Dei, “Antropologia del genocidio”,
Parolechiave, numero monografico dedicato a “Occidentalismo”, in corso di stampa.
[49] David Lowenthal, “Identity, heritage, and history”, in J. Gillis (ed.), Commemorations, cit., p. 41. Questo autore ha
dedicato alla critica dell’heritage alcuni importanti studi, tra i quali Past is a Foreign Country, Cambridge, Cambridge
University Press, 1985, e The Heritage Crusade and the Spoils of History, Cambridge, Cambridge University Press,
1998; v. anche P.Gathercole, D.Lowenthal (eds.), The Politics of the Past, London, Unwin Hyman, 1990. In campo
strettamente antropologico, l’analisi delle implicazioni nazionaliste del patrimonio culturale è stata sviluppata soprattutto
dall’antropologia critica nordamericana: particolarmente significativo lo studio di Richard Handler sul Quebec
(Nationalism and the Politics of Culture in Quebec, Madison, Wisconsin University Press, 1988). Per un’applicazione di
un simile approccio al contesto italiano v. Berardino Palumbo, L’Unesco e il campanile. Antropologia, politica e beni
culturali in Sicilia orientale, Roma, Meltemi, 2003.
[50] J. Assman, La memoria culturale, cit., p. 18
Descrivere, interpretare, testimoniare la violenza
.Dei
Lo sviluppo di una sistematica attenzione alla violenza avviene dunque in relazione, da un lato, ai
mutamenti delle condizioni strutturali nelle quali il lavoro antropologico ha luogo, dall’altro alla
svolta riflessiva della disciplina e alla “crisi della rappresentazione” che la investe. Chi decide di
affrontare questo campo si trova così di fronte, in primo luogo, al problema di come scrivere la
violenza. I modelli discorsivi classici, dalle trasparenze etnografiche di Evans-Pritchard ai cristalli
semiotici di Lévi-Strauss, sembrano poco appropriati; né vengono molto in aiuto le vaghe formule
postmoderne che suggeriscono rappresentazioni dialogiche e polifoniche. Ciò che occorre
ripensare è il presupposto usuale della scrittura etnografica, che – classica o postmoderna – si
pone l’obiettivo di scoprire e restituire un ordine culturale, l’ethos di una società, la profonda
coerenza di un modo di vita. È proprio quest’ordine che viene disintegrato nelle situazioni di
violenza radicale. Soprattutto nelle “nuove guerre” di fine XX e inizio XXI secolo, la distruzione
delle più basilari strutture antropologiche non è più soltanto un effetto collaterale dei combattimenti,
ma un obiettivo consapevolmente perseguito. Le operazioni di pulizia etnica, come osserva Mary
Kaldor (1999, p. 116), mirano a rendere un territorio inabitabile, non solo colpendone
l’organizzazione produttiva, ma anche “istillando ricordi insopportabili sulla patria di un tempo
oppure profanando tutto ciò che ha un significato sociale”: ad esempio “attraverso la rimozione dei
punti di riferimento fisici che definiscono l’ambiente sociale di particolari gruppi di persone”, oppure
“la contaminazione attraverso lo stupro e l’abuso sessuale sistematico…o mediante altri atti di
brutalità pubblici e molto visibili”.
L’antropologa Carolyn Nordstrom, a proposito delle sue esperienze in Sri Lanka e in Mozambico,
parla di guerre in cui il controllo del territorio è perseguito disseminando paura, brutalità e
assassinio. La “cultura del terrore” che ne risulta si basa sulla “forzata decostruzione delle realtà
accettate nella vita quotidiana, in modo da disabilitare i sistemi basilari di significato e di
conoscenza, quelli che definiscono i mondi della vita delle persone e rendono comprensibile
l’azione [...] Se la cultura fonda la società, e la società fonda la costruzione sociale della realtà,
allora disabilitare le cornici culturali equivale a disabilitare, per la popolazione civile, il senso stesso
di una realtà vivibile, nonché la capacità individuale di agire…” (Nordstrom 1992, p. 261). Se
l’obiettivo della scrittura antropologica è farci cogliere il punto di vista dei nativi, cioè ricostruire la
compattezza fenomenologica del loro mondo, di fronte alla violenza radicale si tratta piuttosto di
restituire il senso della dissoluzione di un mondo culturale. E’ come se l’etnografo, abituato a
cercare di seguire faticosamente la via che porta al significato, dovesse adesso ripercorrerla a
ritroso. E in questo tornare indietro la stessa nozione di “ragione etnografica” viene messa in
discussione. Nordstrom nota come il tentativo di capire le ragioni della guerra e della violenza “si
avvicini pericolosamente all’obiettivo di rendere la guerra ragionevole”, e rischi di fatto di “mettere a
tacere la realtà della guerra” (1995, p. 138). Dunque, la ricerca di significati e ragioni della violenza
contrasterebbe profondamente con l’obiettivo etnografico di comprendere il ruolo della violenza nel
mondo-della-vita degli attori sociali.
Qui tocchiamo un punto importante. Si può ben sostenere, naturalmente, che in quanto attività
umana la violenza è una pratica significativa e governata-da-regole come tutte le altre, e che
comprenderla equivale a scoprire tali regole e significati; se pensassimo che comprendere
equivalga a perdonare, confonderemmo “l’idioma disciplinare delle scienze sociali con il linguaggio
quotidiano” (Abbink 2000, pp. xii-xiii). Ma l’argomento sollevato da Nordstrom mette proprio in
discussione l’adeguatezza del normale linguaggio delle scienze sociali, con i suoi effetti
distanzianti e generalizzanti, con la sua ricerca di un coerente insieme di motivi, ragioni, cause1.
Un ulteriore problema si pone per quegli etnografi che lavorano in contesti dominati dalla violenza
di stato, dove le atrocità, le torture e la repressione sono al tempo stesso supportati e celati da un
ordine discorsivo normalizzante, che le mostra appunto come ragionevoli e necessarie (ad
esempio presentando il terrore come contro-terrore; v. Chomski 2004). Alcuni autori, in particolare
M. Taussig, hanno avvertito il rischio di parlare del terrore con un linguaggio eccessivamente
contiguo a quello che il terrore copre – contiguo se non nei contenuti, almeno nella forma di un
ordine discorsivo conciliante, di una asettica chiusura nelle convenzioni accademiche, di un
realismo che normalizza lo status quo. La complicità è reale, non soltanto simbolica, dal momento
che il fatto stesso di parlare della violenza (ad esempio la diffusione di un repertorio di storie di
atrocità) è parte integrante della “cultura del terrore”, è anzi ciò che le permette di funzionare. Il
legame indissolubile di violenza e ragione che fonda lo Stato moderno (il “discorso della ragione
come guanto di velluto che nasconde il pugno d’acciaio”) è per Taussig2 all’origine dell’inevitabile
aporia in cui cadono i tentativi delle scienze sociali di parlare della violenza. Aporia che prende la
forma di mimesi tra la rappresentazione e ciò che viene rappresentato3.
Costruire un controdiscorso, scrivere del terrore contro il terrore, diventa allora una faccenda assai
complicata, che richiede – almeno per Taussig - una sovversione delle convenzioni compositive e
della “poetica del bene e del male” radicata nel discorso egemonico; per accostarsi invece a quella
poetica dello sciamanismo e della guarigione cui fa cenno in conclusione del saggio qui
presentato, e che svilupperà nella sua più nota monografia (Taussig 1987). Ne risulta una scrittura
frammentaria, discontinua, più evocativa che analitica e peraltro non sempre facile da seguire –
soprattutto nelle opere degli anni Novanta. Non tutti gli etnografi sono, come Taussig, ossessionati
dalla compenetrazione tra discorso e potere, e dai tranelli mimetici di una violenza che può
infiltrarsi nelle forme stesse della sua rappresentazione e persino della sua denuncia. Tutti sono
però alla ricerca di forme di scrittura adeguate a restituire la particolare tensione fra aspetti
epistemologici, emozionali ed etici della propria esperienza di ricerca. I problemi sollevati
dall’etnografia della violenza non sono forse diversi da quelli che caratterizzano oggi l’etnografia
tout court; si manifestano però in modo più accentuato e spesso decisamente drammatico. Ad
esempio, la classica tensione malinowskiana fra l’esperienza di partecipazione soggettiva del
ricercatore, da un lato, e dall’altro le esigenze di oggettività della rappresentazione, cambia aspetto
quando il ricercatore è coinvolto in esperienze di altissimo impatto emotivo, di terrore, di rabbia, di
odio che annullano ogni possibile margine di distacco scientifico.
Ancora, uno dei problemi sollevati dalla svolta riflessiva dell’antropologia – il diritto dell’etnografo di
parlare in nome dei soggetti della sua ricerca – assume qui caratteristiche peculiari. Non si tratta
solo del fatto, ormai ampiamente affermato dalla tradizione dei cultural e postcolonial studies, che
la presa di parola antropologica per conto degli “Altri” si fonda su presupposti di potere non
analizzati, collocando i prodotti antropologici nell’ambito del discorso coloniale. Il posizionamento
politico e discorsivo degli etnografi della violenza è più complesso e ambiguo di quello classico
analizzato da critici come E. Said e G. Chakrabarti Spivak. In molti casi, la “presa di parola” è
concordata con gli attori sociali, i quali possono vedere nel rapporto con l’etnografo, nella scelta di
affidare alla sua scrittura informazioni riservate, segrete o magari strettamente intime, un
importante ritorno comunicativo e pragmatico. I terroristi nord-irlandesi che concordano con
l’etnografo le modalità di scrittura di un libro a loro dedicato (Sluka 1989, 1995a); i parenti dei
desaparecidos argentini che confidano nel ricercatore, straniero e scientificamente obiettivo,
perché si faccia portatore di una denuncia che in patria non riesce a farsi sentire (Robben 1995); i
rifugiati che vedono nell’intervista biografica una legittimazione della loro storia e un
riconoscimento del loro status (Malkki 1995a), sono solo alcuni fra gli esempi di un rapporto non
unilaterale, di un complesso negoziato tra gli “interessi” dell’etnografo e quelli dei suoi interlocutori.
Il problema che si pone è di tipo diverso, e riguarda la messa in scena dello spettacolo del dolore e
della sofferenza. Proprio per la sua pretesa di mantenersi vicina all’esperienza vissuta, di mostrare
la violenza non nella genericità delle sue “ragioni politiche” ma negli effetti sui corpi e sulle
soggettività degli attori sociali, l’etnografia lascia emergere in primo piano i dettagli delle atrocità e i
tormenti della memoria di chi è sopravvissuto. Questo sguardo ravvicinato, sia sull’orrore della
violenza fisica e della tortura, sia sull’umiliazione e la disperazione di persone colpite alle basi
stesse della propria dignità e dei propri affetti, produce per il lettore un effetto irriducibilmente
ambiguo. La descrizione puntigliosamente dettagliata delle sevizie subite dagli indios del
Putumayo, nel saggio qui presentato di Taussig, ne è un esempio; non meno forti e disturbanti
sono i resoconti delle scene di genocidio, degli stupri e delle torture eseguite pubblicamente, delle
mutilazioni dei corpi che punteggiano le etnografie delle “nuove guerre” contemporanee. Da un
lato, lo shock emotivo che tutto ciò provoca può diventare strumento di testimonianza e di
denuncia: la scrittura consegue il suo scopo scuotendo e indignando il lettore, e combattendo così
quell’indifferenza che troppo spesso ha accompagnato le violenze di massa nella modernità.
Dall’altro lato, tuttavia, lo spettacolo ravvicinato della violenza può suscitare effetti pornografici e
voyeuristici, e la scrittura etnografica degenerare in una messa in scena in cui corpi e anime afflitti
sono arbitrariamente e talvolta oscenamente esposti nella loro più profonda intimità4. Ci si chiede
allora se la trasparenza etnografica sia un atteggiamento moralmente legittimo di fronte alla
sofferenza, e se l’indignazione militante non possa troppo facilmente trapassare in morbosità: tanto
più all’interno di un contesto comunicativo e mass-mediale che ci ha fin troppo abituati allo
sfruttamento delle immagini di violenza e alla penetrazione morbosa dell’intimità emotiva a fini di
audience e di successo commerciale (Sontag 2003, p. 83 sgg.). Non è forse immorale usare quel
dolore per sostenere la nostra impresa rappresentativa? Non sarebbe più corretto e rispettoso
tacere, ritrarre lo sguardo in nome di una pietà che non è forse del tutto compatibile con la ragione
etnografica? Naturalmente, tacere non serve però a portare testimonianza, a rendere o almeno a
chiedere pubblicamente giustizia per le vittime.
Il confine tra i due aspetti dell’etnografia della violenza – testimonianza e spettacolo, denuncia e
pornografia – non è mai ben definito. N. Scheper-Hughes e P. Bourgois (2004, p. 1) lo fanno
dipendere dalla capacità di tener conto delle “dimensioni sociali e culturali” che conferiscono
significato alla violenza, non limitandosi a rilevarne i soli “aspetti fisici”. Ma per lavori antropologici
questa è poco più di una tautologia. Più che dalla natura del testo (o dalle intenzioni dell’autore), la
risoluzione in un senso o nell’altro dell’ambiguità sembra dipendere da effetti di lettura e dalle
diverse sensibilità dei lettori. E’ curioso che uno stesso autore, ad esempio il già citato Taussig,
possa esser considerato da alcuni come ossessivamente volto a sottolineare “il perverso erotismo
della violenza estrema” (Avruch 2001, p. 643); da altri (e a mio parere più sensatamente), come
portatore, “con la sua capacità di raffigurare il terrore visceralmente”, di “una istanza morale contro
il potere esercitato nelle sue forme più grottesche” (Green 1995, p. 107).
Una possibile uscita dall’ambiguità può consistere in una etnografia centrata attorno alle voci
dirette dei testimoni, in grado di aggirare (almeno in apparenza) i rischi di effetti estetizzanti e
voyeuristici. In effetti, questa strategia è cospicuamente presente nella letteratura recente – a
fronte di un uso assai limitato delle fonti orali nella tradizione etnografica anglosassone. L. Green
(1995, p. 108) sintetizza questo atteggiamento nella formula dell’ “antropologo come uno scriba,
che documenta fedelmente le storie narrate dalla gente, ciò che essi hanno visto, sentito,
annusato, toccato, interpretato e pensato”. Qui sorgono tuttavia nuove difficoltà. Intanto, quando i
testimoni sono i perpetratori della violenza piuttosto che le vittime, la posizione morale del
ricercatore si fa ancora più complessa ed equivoca. Ciò accade in numerosi lavori sul terrorismo o
su gruppi di guerriglia (dove gli interlocutori sono quasi sempre al tempo stesso esecutori e
vittime)5, sulla violenza di stato, o su crimini comuni in contesti non bellici. La tensione fra le
convinzioni e il senso di giustizia dell’etnografo, da un lato, e dall’altro la sua propensione
professionale a empatizzare con gli informatori e a guardare il mondo dal loro punto di vista, si fa
qui fortissima. Le riflessioni di A. Robben (1995) sulle interviste ai militari argentini responsabili
della “guerra sporca”, su cui tornerò oltre, ne sono un esempio. Ancora più forte, per l’ampio uso di
trascrizioni di intervista e per il dilemma morale consapevolmente sollevato dall’autore, è il lavoro
di P. Bourgois (1995) sugli stupri di gruppo nei quartieri portoricani di New York. Lo spazio lasciato
al racconto diretto ed esplicito dei violentatori lascia emergere per intero il loro inquietante universo
morale, e produce un profondo effetto etnografico e pornografico al tempo stesso6.
Il problema della voce dei testimoni ha però una dimensione più ampia, che riguarda anche le
vittime stesse e che è stato messo a fuoco in primo luogo dagli storici. La storiografia
contemporanea sulla Shoah, ad esempio, ha guardato con un certo disagio al ruolo crescente
assunto nei media dalla narrazione autobiografica come strumento principale di rappresentazione
degli eventi. Se la storia di vita e la memoria individuale sono fonti importanti per il sapere storico,
esse non possono tuttavia sostituirlo e rendersi del tutto autonome, come sembra accadere in
quella che A. Wieviorka ha chiamato “l’era del testimone”. Ora, contrapporre nettamente il discorso
storico e la testimonianza biografica, il primo rivolto alla ragione e alla ricerca critica della verità, la
seconda al “cuore” e alla costruzione del senso (Wieviorka 1998, pp. 153-54), è una
semplificazione inaccettabile dal punto di vista antropologico. I dubbi sollevati da Wieviorka e da
altri storici sono però tutt’altro che infondati. Non si tratta tanto di deplorare il carattere parziale e
soggettivo della testimonianza e della memoria. Il perseguimento dell’ “imparzialità” sembra non
avere molto senso in contesti di violenza estrema; e passare attraverso il piano degli effetti
soggettivi della violenza e del terrore è indispensabile, come abbiamo visto, per un approccio che
si voglia definire etnografico (ne è un ottimo esempio il saggio di V. Das incluso in questo volume).
Ciò che occorre evitare è però l’assolutizzazione delle versioni testimoniali come rappresentazioni
realistiche della verità. Il lavoro antropologico sulle storie di vita, così come gli studi psicologici
sulla memoria individuale e collettiva, ci mostrano la complessità delle procedure di plasmazione
culturale del ricordo autobiografico, di fusione tra esperienze personali e modelli culturali diffusi7.
Ciò rende i racconti testimoniali documenti di inestimabile valore antropologico, senza che tuttavia
il discorso etnografico stesso si possa esaurire in essi o nascondersi dietro la loro autorità. Il
rischio del ventriloquismo etnografico denunciato in un famoso passo di C. Geertz (1988, p. 145) si
fa qui particolarmente forte; così come peraltro si fa forte, se non insormontabile, la difficoltà di
sottoporre a critica delle fonti e ad esercizi di distaccato scetticismo i racconti drammatici ed
emotivamente esplosivi delle vittime di violenza estrema. Ancora una volta, l’impatto con il dolore e
la sofferenza, oltre che con l’implicita o esplicita richiesta di solidarietà e partecipazione umana,
sembra paralizzare l’atteggiamento “scientifico” e porre in questione le più consolidate forme di
scrittura.
Vorrei far notare la prossimità tra questi problemi e quelli posti dal dibattito storiografico ed
epistemologico sulle modalità di rappresentazione della Shoah – un ambito con il quale
l’antropologia ha finora dialogato troppo poco. Anche in questo caso, sono centrali i dilemmi etici
sollevati dalla rappresentazione della sofferenza e quelli relativi al rapporto tra scrittura ed eventi
estremi. Quale forma espressiva consente di parlare legittimamente della Shoah – nel senso di
restituire la natura terribile e peculiare dell’evento, e rispettare al contempo la memoria delle
vittime? Come Adorno sosteneva che è barbaro fare poesia dopo Auschwitz, non potremmo
considerare ugualmente inappropriata sul piano etico la scrittura saggistica e accademica, con il
suo sfoggio di erudizione, le sue note a piè di pagina, il suo compiacimento intellettualistico
(Kellner 1994, p. 409)? L’oggettivazione e il distanziamento storiografico non contrastano forse con
le istanze della memoria e del lutto? E, soprattutto, il medium ordinante e normalizzante della
scrittura non tradisce di per sé l’essenza estrema della pratica genocida, che consiste proprio nello
spezzare l’ordine e la normalità culturale? Come osserva J. Young (1988, p. 16), “una volta scritti,
gli eventi assumono l’aspetto della coerenza che la narrativa necessariamente impone loro, e il
trauma della loro non assimilabilità è superato” – laddove è proprio la traumatica straordinarietà ciò
che la testimonianza intenderebbe restituire.
Sulla base di queste premesse, il dibattito si concentra sul realismo come strategia di
rappresentazione. Si sostiene da un lato la necessità di rappresentare la Shoah attraverso uno
stile “fattuale”, che conceda il meno possibile alla costruzione letteraria e agli interventi
esplicitamente autoriali8. Dall’altra, si obietta che quando la realtà stessa diventa così estrema e
aberrante, straordinaria rispetto al contesto culturale comune, un semplice linguaggio fattuale non
è più in grado di restituirne la qualità. Il primo argomento è molto forte: l’esperienza della Shoah
segnerebbe il limite invalicabile oltre il quale non può spingersi la decostruzione postmoderna
dell’oggettività e della verità storica. Come pensare di mettere in discussione la fondamentale
realtà dell’evento, o meglio, come accettare la possibilità di una medesima “infondatezza” di più
versioni narrative, ad esempio quella dei carnefici e quella delle vittime? La ripugnanza morale per
gli esiti relativistici del decostruzionismo, potenzialmente di supporto alle tesi negazioniste, ha
spinto molti autori in questa direzione9; e l’argomento è spesso ripreso nella letteratura etnografica
sulla violenza. Di fronte all’enormità delle stragi, delle torture e degli stupri, e alla profondità della
sofferenza incontrata, sembra intollerabile l’idea di una pluralità di versioni possibili degli eventi e
della dipendenza dell’idea stessa di verità da finzioni retoriche10.
Tuttavia, come detto, la letteratura etnografica è ben lontana dal seguire modelli di scrittura
cronachistica e fattuale. Al contrario, proprio lo sforzo di cogliere la verità ultima della violenza,
l’autenticità di una esperienza straordinaria e non convenzionale, spinge i ricercatori verso forme di
scrittura varie e complesse – di tono più modernista che realista, con ampio uso di riflessioni
soggettive e di estratti di diari e note di campo, con lo stretto intreccio tra narrazioni di eventi e
sollecitazioni teoriche e interpretative, la giustapposizione di contesti ottenuta attraverso i frequenti
riferimenti letterari. Un’analisi in questo senso del corpus etnografico prodotto dagli anni ’90 ad
oggi sarebbe estremamente interessante. Il piano etnografico non è tuttavia centrale nei saggi di
questo volume, che mirano piuttosto a costruire una cornice teorica in cui inquadrare i fenomeni
della violenza di massa contemporanea. Nel resto dell’introduzione, vorrei discutere appunto alcuni
aspetti del dibattito teorico.
Torniamo così a chiederci se per un’antropologia della violenza sia possibile separare la
discussione “intellettuale”, come si esprime Asad, da un impegno pratico (politico, etico). Il
problema viene esplicitamente posto in molta letteratura etnografica, in termini di inevitabile
coinvolgimento personale del ricercatore e di umana solidarietà nei confronti delle vittime. Ma
raramente la tensione fra i due aspetti della conoscenza e dell’impegno viene portata fino alle sue
conseguenze più significative. Chi lo fa è ancora una volta Scheper-Hughes, secondo la quale la
testimonianza etnografica della violenza conduce necessariamente verso una concezione militante
della disciplina. Nel già ricordato recente lavoro con P.Bourgois sulla violenza in guerra e in pace,
parla dell’antropologo come di una persona “responsabile, riflessiva, moralmente o politicamente
impegnata”, che sappia “prender parte quando necessario e rifiutare i privilegi della neutralità”
(Scheper-Hughes, Bourgois 2004, p. 26). Rispetto alla situazione etnografica classica, nei contesti
di violenza diviene impossibile ottenere e mantenere ogni forma di “distanziamento” dagli
interlocutori: “che tipo di osservazione partecipante, che tipo di testimonianza oculare è
appropriata di fronte al genocidio e alle sue conseguenze, o anche soltanto di fronte alla violenza
strutturale e all’etnocidio? Quando l’antropologo diviene testimone di crimini contro l’umanità, la
pura empatia scientifica non basta più” (p. 27). L’atteggiamento del distacco trapassa troppo
facilmente in quello dello spettatore, e persino del complice. Semplicemente, non si può evitare di
schierarsi – il che significa porre la propria competenza e il proprio sapere al servizio di una causa,
rovesciando una intera tradizione di disimpegno accademico ma restando fedeli a quello che per
Scheper-Hughes è il “mandato originario” dell’antropologia:
schierare saldamente noi stessi e la nostra disciplina dalla parte dell’umanità, della
salvezza e della ricostruzione del mondo –anche se possiamo non esser sempre sicuri
di cosa ciò significhi e di cosa ci venga richiesto in momenti particolari. In ultima analisi,
possiamo solo sperare che i nostri celebrati metodi della testimonianza empatica e
impegnata, dello “stare con” e dello “stare là”, per quanto possano apparire vecchi e
stanchi, ci forniscano gli strumenti necessari per fare dell’antropologia una piccola
pratica di liberazione umana (ibid.)
La formulazione è abbastanza appassionata ma anche abbastanza modesta da risultare
convincente. Nessuno negherebbe un qualche grado di impegno nei confronti delle persone di cui
si rappresentano ( o si “studiano”) le sofferenze; resta tuttavia aperto il problema di quali valori e
obiettivi rappresentano le fedeltà ultime dell’antropologo. Quelli della conoscenza o quelli della
partecipazione? Dell’epistemologia o della politica? Per quanto non necessariamente in contrasto,
questi obiettivi hanno diversa natura e possono trovarsi a confliggere anche in modo
estremamente drammatico. Scheper-Hughes parte dall’implicito presupposto che la verità è
rivoluzionaria, e che la denuncia delle sopraffazioni e il sostegno alle vittime facciano tutt’uno con
la ricerca dell’oggettività11. Questo può essere anche vero in ultima analisi, ma i percorsi del rigore
metodologico e scientifico e quelli della solidarietà politica sono spesso assai diversi. Il problema si
pone soprattutto in relazione alla principale fonte dell’antropologia della violenza, cioè i racconti
delle vittime sopravvissute e dei testimoni diretti. L’epistemologia ci spinge a praticare verso questi
racconti una critica delle fonti: ad esempio, a non assumerli immediatamente come resoconti
realisti, a studiarne le forme di costruzione retorica e di adesione a modelli culturali, eventualmente
a farne risaltare le interne inconsistenze e così via. Ma questo rigore metodologico non serve ai fini
della solidarietà, e può anzi risultare controproducente sul piano pratico e politico (si pensi ai
racconti dei rifugiati e dei richiedenti asilo; v. Daniel-Knudsen 1995), e intollerabile sul piano etico:
che senso hanno le sottigliezze analitiche di fronte a persone che hanno subito violenze e lutti
terribili? Di fronte alla loro tragedia e alla loro sofferenza, che importanza ha come la raccontano?
L’atteggiamento critico sembra voler negare la verità assoluta di quelle esperienze; la
sofisticazione teoretica sembra del tutto fuori posto, quasi immorale, a fronte della semplice
enormità del Male e del Dolore che traspirano da quelle biografie.
Nell’etnografia della violenza, questo punto è espresso con grande efficacia da Antonius Robben,
in un intenso testo (1995) di riflessione su una ricerca condotta in Argentina sulla memoria dei
crimini della giunta militare. Robben intervista tre categorie di persone: militari coinvolti più o meno
direttamente nei crimini, ex-guerriglieri e parenti dei desaparecidos. Avverte con forza la tendenza
di tutte e tre queste componenti a tirare e far schierare il ricercatore dalla propria parte, a chiedergli
di condividere la propria visione del mondo: e conia per questa tendenza la nozione di “seduzione”
(nel senso etimologico del termine) etnografica. Quest’ultima si manifesta in modo particolarmente
drammatico nel rapporto con i parenti delle vittime. Robben si sofferma ad esempio sul suo
incontro col padre di uno scomparso, un ragazzo della Gioventù Peronista rapito nel 1976 a
diciassette anni. L’uomo racconta dei suoi tentativi di avere notizie del figlio, attraverso contatti con
ufficiali dell’esercito. Il climax del suo racconto è l’incontro con un colonnello, in servizio attivo, che
ha promesso attraverso la mediazione di amici di dargli informazioni:
Dopo che gli ebbi raccontato tutto, [il colonnello] disse: “Guardi, immagini che suo figlio
abbia il cancro [… ] e si trovi in una sala operatoria dove ci sono un macellaio e un
dottore: preghi che sia il dottore a operarlo”. Quest’uomo aveva infilato un pugnale
nella mia ferita e lo rigirava dentro di me. “Mi scusi, signore – dissi – ma lei sa
qualcosa?” . “No, no, sto solo soppesando le possibilità e facendo una supposizione”.
Avrei voluto prenderlo per la gola e strangolarlo; […] per la prima volta in vita mia
provavo il desiderio di uccidere qualcuno […] perché ero disperato. Non può
immaginare con quanta soddisfazione mi disse quelle cose. E lei dovrebbe analizzare il
fatto che quell’uomo era in servizio attivo (ibid., pp. 92-3).
“Ma io ero incapace di analizzare”, commenta Robben. Il testimone lo ha “incorporato nel suo
tormento”; le domande di approfondimento che avrebbe voluto fare gli si spengono sulle labbra, e
può solo “condividere in silenzio il dolore di quest’uomo” (ibid., p. 93). Se questa partecipazione
può essere fondamentale per la comprensione della natura degli eventi studiati, essa implica
tuttavia grandi rischi. Quando il ricercatore è sopraffatto dall’emozione, e sente di non poter fare
nessun’altra domanda, perché non c’è nient’altro da chiedere di fronte all’enormità della tragedia,
allora rischia di non esser più ricercatore. “In questi momenti di completo collasso della distanza
critica tra i due interlocutori, perdiamo ogni dimensione dell’impresa scientifica” (ibid., p. 94);
quest’ultima implica per l’appunto distanza, scetticismo, lucidità e obiettività, valori diversi rispetto a
quelli della solidarietà morale e politica (v. anche Robben 1996, che rilegge il problema della
seduzione etnografica alla luce dei concetti psicoanalitici di transfert e controtransfert).
Malgrado le apparenze, le posizioni espresse da Scheper-Hughes e Robben non sono alternative.
Esprimono invece una tensione alla quale il lavoro antropologico non può sfuggire. Robben pensa
che dalla seduzione etnografica ci si debba programmaticamente difendere: ma sa bene, lui per
primo, che cederle almeno per un po’ è una condizione della comprensione – soprattutto quando
ciò che ci interessa non è una pura conoscenza fattuale, ma il significato della violenza nella
memoria e nella vita delle persone. Per quanto riguarda Scheper-Hughes, anche il suo appello
all’impegno può difficilmente essere eluso; ricordandosi però che l’antropologo può forse dare il
suo piccolo contributo alla “liberazione umana” continuando a fare il suo mestiere, e non
trasformandosi in un attivista politico tout court. Il che significa continuare a seguire le regole del
metodo, della critica delle fonti, del rigore argomentativo; e anche mantenere quella certa dose di
distacco da immediate finalità pratiche che è sempre requisito del lavoro scientifico, e di cui il
vituperato disimpegno accademico non è che un’espressione. In altre parole, comprensione critica,
partecipazione morale e impegno politico possono magari coesistere nella stessa persona, ma
sono destinati a non fondersi mai completamente gli uni negli altri: nella loro costante tensione,
vorrei suggerire, risiede la forza particolare del lavoro antropologico.
1 Peraltro, sembra eccessivo e inutile spingere questa critica fino al concetto stesso di ragione, come fa Nordstrom, o
contro la tendenza antropologica alla “ricerca del senso”. Quest’ultima oscurerebbe i concreti “individui che vivono,
soffrono e muoiono, i quali sono la guerra”; e le ragioni, di fronte alle questioni di vita e di morte, sono rimpiazzate da una
“cacofonia di realtà” (1995, p. 137). A parte la vaghezza di quest’ultima formula, non è chiaro dove stia la contraddizione
fra la ricerca del senso e il metodo etnografico della studiosa, centrato sulla raccolta di storie individuali e sull’analisi del
simbolismo della violenza e di quello della resistenza quotidiana. Proprio il suo sforzo di attingere la realtà soggettiva del
dolore, del “disfacimento del mondo” e i tentativi di ricostruirlo con i mezzi della cultura testimonia a favore di una
nozione di comprensione antropologica come elucidazione delle ragioni e dei significati che rendono umane certe
pratiche. Cfr. anche Nordstrom 1997, 2004, Finnström 2001.
2 1992, p. 115. Questo tema è di fatto l’asse portante dell’intera opera dello studioso, che esplora il nesso violenzaragione-stato in una serie assai compatta di volumi degli anni ’80 e ’90 (Taussig 1983, 1987, 1992, 1993, 1997, 1999).
3 A proposito dei resoconti di Handenburg e Casement sulle atrocità coloniali nel Putumayo, discussi nel saggio qui
presentato, Taussig osserva come, per quanto critici nell’intenzione, essi “presuppongono e rafforzano quegli stessi
rituali dell’immaginazione coloniale cui gli uomini soccombevano torturando gli indiani. Nel loro cuore immaginativo,
queste critiche erano complici con ciò a cui si opponevano” (Taussig 1987, p. 133). Sulla stessa linea si collocano le
osservazioni mosse da Taussig alla poetica conradiana di Cuore di tenebra.
4 Un esempio tanto noto quanto drammatico di questa ambiguità è rappresentato da una foto di Kevin Carter, vincitrice
nel 1993 del premio Pulitzer: una bambina sudanese denutrita, crollata a terra con un avvoltoio appostato a pochi passi
di distanza. La foto, di grande impatto comunicativo, ha svolto un ruolo importante nel mobilitare l’opinione pubblica
internazionale attorno ai problemi della carestia provocata in quegli anni nel Sudan meridionale dalla guerra civile. D’altra
parte, la stessa realizzazione della foto sembra implicare profondi problemi etici. Lo stesso fotografo ha raccontato di
aver atteso venti minuti che l’avvoltoio spiegasse le ali. Non ha forse strumentalizzato la situazione, anteponendo la
ricerca di un’immagine di successo all’imperativo dell’aiuto? Inoltre, la diffusione mediale della foto non finisce per
spettacolarizzarla, rendendo la stessa sofferenza della bambina una forma di intrattenimento? Il dilemma è reso più
drammatico dal suicidio, nel 1994, dello stesso autore della foto – un suicidio che, come hanno commentato A. e J.
Kleinman (1997, p. 7), sembra disintegrare la dicotomia morale tra soggetto e oggetto di quella foto, fondendo le
rispettive sofferenze.
5 Si vedano ad esempio i lavori sui guerriglieri sick di J. Pettigrew (1995) e C.K. Mahmood (1996), quelli sui terroristi
nord irlandesi di Feldman (1991, 2000) e Sluka (1995a, 1995b), sul contesto israelo-palestinese di Swedenburg 1995 e
Bornstein 2001.
6 Il lavoro di Bourgois (1995; v. anche Bourgois 1996) è incentrato su un gruppo di spacciatori di crack portoricani.
L’autore fa un lungo periodo di osservazione partecipante: diventa loro amico, ci fa sentire le loro voci, ricostruisce una
cultura subalterna la cui violenza esteriore è sottodeterminata dalla violenza emarginante e discriminante della cultura
egemonica. Ma l’empatia e la solidarietà politica dell’etnografo vacillano quando i suoi amici iniziano a raccontargli degli
stupri di gruppo che compiono abitualmente. Per quanto disgustato, continua a fare il suo lavoro, e ci offre le voci
narranti degli stupratori, con il loro gusto da bravata, i loro risolini, le usuali patetiche giustificazioni (“è quello che lei
voleva”), la loro “cosmologia”. Ci troviamo immersi in un universo di relazioni sociali, di rapporti uomo-donna, di principi
morali particolarmente rivoltanti, e la distaccata testimonianza etnografica sconfina a tratti nella pornografia più oscena.
Assai inquietante è anche il contributo dell’antropologa americana Cathy Winkler (1991, 1995), che descrive uno stupro
da lei stessa subito cercando di utilizzare le tecniche di osservazione etnografica, dunque con una sconcertante
attenzione per il dettaglio, e con il tentativo di capire e restituire il punto di vista dell’aggressore. Sono ricostruiti i gesti, i
dialoghi, l’atteggiamento dello stupratore, il terrore della vittima. Per l’autrice, questo racconto è evidentemente una delle
risposte possibili al trauma: oggettivare se stessi e le proprie emozioni, riconquistare la padronanza della situazione, e
anche raccogliere elementi che possano servire ad ottenere giustizia. Per il lettore, è una costante e dolorosa
oscillazione fra l’identificazione narrativa con la vittima e una sorta di effetto morbosamente pornografico, l’impressione
di star assistendo a qualcosa che non si dovrebbe vedere, perlomeno non così da vicino.
7 Per una più approfondita discussione del rapporto tra ricordo individuale e sociale, in relazione a una ricerca sulla
memoria degli eccidi nazifascisti di civili nella Toscana del 1944, rimando a Dei 2005.
8 Si vedano ad esempio le posizioni del filosofo B. Lang (1990), che ammette solo la possibilità di una cronaca fattuale
degli eventi della Shoah, condannandone ogni resa attraverso un linguaggio figurato e stilizzato, o attraverso forme
narrative e di emplotment, colpevoli di introdurre un significato e un’intenzione autoriale estranee all’autentico contesto
del genocidio e irrispettose dell’esperienza delle vittime. Sul piano etico, è come se un persistente lutto imponesse di
tenere sotto stretto controllo l’impulso all’espressione artistica e creativa, a favore di uno stile impersonale in cui il
linguaggio è per quanto possibile trasparente.
9 Fondamentali sono i saggi raccolti in Friedlander (ed.) 1992, e in particolare la discussione fra H. White e C. Ginzburg
(per la traduzione italiana dei loro due testi v. White 1999 e Ginzburg 1992)
10 “Chi sostiene un’idea dell’etnografia come puro racconto pone l’autorità degli studiosi (sia pure involontariamente) al
servizio dei sinistri tentativi di negare l’Olocausto, la «guerra sporca» latino-americana e altri recenti episodi di
distruzione organizzata. Attraverso la lente postmoderna, essi divengono semplicemente «racconti» o «finzioni», il che è
repellente in termini sia intellettuali che morali..:” (Suárez-Orozco, Robben 2000, p. 12 nota).
11 Una convinzione che è implicitamente o esplicitamente condivisa da molte etnografie contemporanee della violenza.
Si veda ad esempio il lavoro sui guerriglieri sick di C.K. Mahmood (1996), che teorizza un’etnografia “partigiana” e
“militante”, e in cui la ricercatrice dichiara di porsi al servizio dei suoi interlocutori ex-guerriglieri, per “salvare” la loro voce
e contribuire così ai loro obiettivi politici e ideologici – finalità ultima, questa, della ricerca, in contrapposizione all’
“oggettivismo” degli studi accademici e dell’antropologia classica. Ci si può chiedere fino a che punto, con tali premesse,
ci troviamo ancora di fronte a un libro di antropologia (l’autrice dichiara persino di aver rivisto il testo sulla base delle
“correzioni” ideologiche dei suoi interlocutori; v. Dusenbery 1997 per una critica a questi aspetti); ma soprattutto, si può
notare la contraddizione tra, appunto, la critica all’oggettivismo accademico e la pretesa, più volte riaffermata dall’autrice,
di parlare in nome della “verità” (v. anche Mahmood 2001).
Esiste un'antropologia postmoderna?
Fabio Dei
Nel discorso antropologico corrente sono molto frequenti i riferimenti a una corrente cosiddetta
"postmoderna" della disciplina. L'antropologia si trova oggi priva di grandi scuole teoriche cui
aderire o con cui dissentire, com'era stato qualche tempo fa con lo strutturalismo; sembra inoltre
attraversare una fase di frammentazione disciplinare, con la moltiplicazione dei sub-specialismi e
dei relativi quadri di riferimento teoretico e metodologico. In questa situazione, il postmodern è
uno dei pochi argomenti comuni di conversazione, per così dire.
Ma, singolarmente, è un trait d'union in negativo. I riferimenti ad esso sono quasi invariabilmente
critici. Per la conversazione antropologica - la letteratura come le chiacchiere di corridoio - è quasi
rituale la presa di distanza dagli "eccessi relativistici postmoderni", cui si imputano crimini quali la
"perdita dell'oggetto" e la rinuncia a ogni criterio di oggettività nella costruzione del sapere
antropologico. In ogni argomentazione metodologica, è inevitabile che a un certo punto emerga la
polemica con chi crede che tutta l'antropologia sia riducibile a una forma di rappresentazione
letteraria, che le cose concrete là fuori nel mondo, dure come rocce, altro non siano che
costruzioni retoriche del ricercatore. Così come è inevitabile che compaia la critica a chi vorrebbe
trascinare la disciplina lontano dal metodo scientifico, in direzione dell'arte.
Il problema che qui vorrei porre è se davvero esista qualcosa come una scuola postmoderna di
antropologia - un paradigma postmoderno, se vogliamo, includente uno specifico sfondo teoretico,
la selezione di alcuni problemi o tematiche rilevanti, un peculiare metodo di lavoro e così via.
Come si comprenderà, pongo la domanda in modo retorico: la risposta, a mio parere, è no.
Parlando di antropologia postmoderna si attribuisce fittizia coerenza a una gamma molto varia e
diversa di apporti riflessivi che - nell'ultimo quarto di secolo, più o meno - hanno ripensato le
condizioni costitutive della disciplina. Un ripensamento imposto, da un lato, da un mutato clima
epistemologico; dall'altro, dalle mutate condizioni culturali e socio-politiche in cui ha luogo la
ricerca enografica - in altre parole, da nuove coordinate del sapere antropologico, dalla parte "del
soggetto" come da quella "dell'oggetto".
Questi apporti non forniscono un nuovo "canone" antropologico, né precetti normativi su come
praticare l'etnografia e l'antropologia. Ciò che essi fanno è acuire la sensibilità autoriflessiva della
disciplina. In questo modo - ed è il punto che vorrei sottolineare - essi influiscono a fondo sulle
possibilità della storiografia antropologica, dischiudendo nuove prospettive da cui guardare al
passato della disciplina. Ciò non significa, come avviene nei mutamenti paradigmatici descritti da
Kuhn, riplasmare la storia degli studi alla luce e a maggior gloria delle nuove convinzioni teoriche l'atteggiamento che Stocking, per la storia dell'antropologia, ha chiamato "presentismo". Al
contrario, i contributi del cosiddetto postmodernismo hanno minato le basi stesse di una storia
degli studi presentista, interna, "progressista", dominata da un'unica prospettiva privilegiata: hanno
invece incoraggiato lo sviluppo di una molteplicità di punti di vista e di un atteggiamento - sempre
per usare la terminologia di Stocking - "storicista".
Non mi pare un caso che, proprio in coincidenza con la fase "postmoderna", sia emerso uno
specifico filone di storiografia antropologica, del tutto nuovo rispetto alle classiche storie degli studi
costruite sotto forma di manuali di "scienza normale". Questo filone è esemplificato proprio dalla
History of Anthropology curata da Stocking e pubblicata dalla University of Wisconsin Press. Si
tratta di un'opera costruita secondo un modello "divergente", nei contenuti come nella forma. Essa
non tenta più di ricomprendere in una trattazione sistematica l' "evoluzione" del pensiero
antropologico (come suona il titolo del classico manuale di Marvin Harris): attraverso saggi
autonomi, che propongono stili diversi e prospettive dichiaratamente parziali, si mira invece a
restituire l'irriducibile varietà e ricchezza delle tradizioni di pensiero e delle pratiche di ricerca
all'interno della disciplina.
Precursore del postmodern è generalmente considerato l'approccio interpretativo di Clifford
Geertz - nonostante gli espliciti e insistenti dinieghi di quest'ultimo a tale paternità putativa. Ma il
nucleo forte del movimento è identificato in un gruppo - non particolarmente numeroso, peraltro - di
studiosi statunitensi, accomunati dalla partecipazione a quel libro-manifesto che è stato Writing
Culture, del 1986 (Clifford-Marcus, 1986). Writing Culture, come si sa, è dedicato all'analisi delle
etnografie come testi. Smascherando le pretese di oggettività e di neutralità - epistemologica e
politica - dell'antropologia classica, il libro mostra come i resoconti etnografici siano invece costruiti
sulla base di strategie retoriche che a loro volta nascondono relazioni politiche di dominio. Rendere
trasparenti la politica e la poetica dell'etnografia, come suona il sottotitolo, è il progetto di Writing
Culture. A tale progetto partecipano antropologi, storici delle idee, critici letterari; e in esso
vengono messi in gioco strumenti analitici e orientamenti teorici abbastanza nuovi per
l'antropologia, presi in prestito soprattutto dalla critica letteraria e culturale: in modo particolare,
giocano un ruolo importante il decostruzionismo e gli studi foucaultiani sulle relazioni tra sapere e
potere.
Writing Culture introduce un linguaggio analitico e un atteggiamento critico verso l'antropologia
classica che, nel corso degli anni '80 e dei primi anni '90, ha una certa diffusione. Su questa scia
nascono altri testi significativi, da parte di autori quali James Clifford (1988) , Vincent Crapanzano
(1992), Renato Rosaldo (1989), Stephen Tyler (1987), Louise Pratt, e in particolare il volume di
Marcus e Fisher Anthropology as Cultural Critique, divenuto il più diffuso manuale di "antropologia
critica" all'inizio degli anni '90. George Marcus, docente di antropologia alla Rice University, è stato
forse lo sponsor più convinto e sistematico di questo filone di studi, anche attraverso la sua
direzione della rivista Cultural Anthropology.
Ma bastano alcuni autori, un manuale e una rivista a fondare un movimento, anzi una vera e
propria svolta paradigmatica? Su un piano puramente fattuale, ciò non sembra affatto probabile,
né verosimile. La mia impressione è che stia accadendo col postmodern quel che era avvenuto
con il relativismo nel dibattito degli anni '60 e '70. Si sentiva allora, come oggi, il bisogno di
etichettare una posizione estrema, dalla quale prendere le distanze. Ma quanti antropologi o
filosofi, in quegli anni, si dichiaravano apertamente relativisti? Allo stesso modo, quanti antropologi
si dichiarano oggi a chiare lettere fautori di un approccio post-moderno? L'unico che lo abbia fatto
esplicitamente, nel gruppo di Writing Culture, è forse Stephen Tyler, il quale ha provocatoriamente
sostenuto l'abbandono della nozione stessa di rappresentazione culturale come telos della
disciplina (1986, 1991). Tutti gli altri autori citati non amano definirsi postmoderni, né si
attribuiscono etichette di scuola di nessun altro tipo. Ma il bisogno di rappresentarsi posizioni
estreme cui reagire è forte. L'orientamento di analisi testuale è così trasformato in un paradigma
teorico, e gli sono attribuite caratteristiche che non possiede affatto.
In primo luogo, lo si tratta come un movimento compatto, che tenta di sviluppare posizioni
unitarie e di conquistare una sorta di egemonia internazionale. Ma ciò è a dir poco fuorviante. E'
nota e nettissima, ad esempio, la contrapposizione tra Geertz e il gruppo di Writing Culture; ma
anche all'interno di quest'ultimo coesistono gli approcci, i programmi di ricerca e gli stili di scrittura
più diversi, che non tentano neppure di amalgamarsi in qualcosa di simile a un canone. Inoltre, non
ha alcun fondamento l'idea di una egemonia sul quadro contemporaneo degli studi che viene
spesso attribuita a questo indirizzo. Negli stessi U.S.A., dove è più diffuso, l'approccio testuale
resta minoritario. Gran parte dei dipartimenti di antropologia continua a lavorare su progetti di
ricerca di tipo tradizionale, e in un quadro di riferimenti metodologici e teoretici che non rompe
certo con l'impianto dell'antropologia classica, pur affinandolo ed eliminadone certe ingenuità. Le
principali riviste internazionali di antropologia, come Man, L'Homme, Current Anthropology,
American Ethnologist e American Anthropologist, negli ultimi dieci anni si sono occupate del
postmodern solo saltuariamente e con articoli quasi invariabilmente critici, talvolta vere e proprie
stroncature (con l'eccezione dei più recenti numeri di American Anthropologist; ma è significativo
che le aperture "postmoderne", proposte dal 1994 dai nuovi direttori Barbara e Dennis Tedlock,
abbiano suscitato una vera e propria rivolta tra gli antropoliogi americani; v. Saunders, 1995: 18
sgg.)
E' vero, semmai, che l'antropologia testuale ha contribuito a diffondere un nuovo lessico, fatto
prevalentemente di prestiti dalla critica decostruzionista, e che talvolta assume l'aspetto di un
gergo un po' fastidioso. Ed è vero, in positivo, che ha contribuito a diffondere nella disciplina una
più alta sensibilità, come si dice, auto-riflessiva, una accresciuta consapevolezza delle più comuni
strategie di costruzione dei documenti e delle rappresentazioni etnografiche. Ciò ha inferto un
colpo decisivo a un certo modo di scrivere i resoconti etnografici. Oggi è ad esempio improponibile
l'uso acritico di vecchie convenzioni retoriche, quali il presente etnografico (una rappresentazione
culturale non collocata in coordinate storiche) o la prospettiva dell' "occhio di dio" (l'osservatore
non incluso nella descrizione del contesto osservato). In generale, la consapevolezza che la
scrittura non è un mezzo neutrale di rappresentazione è un grosso passo avanti per l'antropologia
(anche se non necessariamente questo porta a scrivere etnografie migliori). Ma, ancora una volta,
tutto ciò non fa certo una "scuola".
Soprattutto, è importante sottolineare come le critiche al realismo ingenuo dell'antropologia e
dell'etnografia classiche non implichino necessariamente la proposta di un nuovo canone, di una
guida normativa alla pratica di ricerca e alla produzione di resoconti. Writing Culture non apre un
movimento d'avanguardia, non pretende di dire come si deve fare e scrivere correttamente
l'antropologia. Il suo eccessivo carico autoriflessivo, per così dire, lo priva dell'ingenuità necessaria
per proporre nuovi stili o nuove teorie totalizzanti. Questa, in effetti, è una caratteristica in comune
con i movimenti postmodernisti che, in arte come in filosofia, non si sono mai presentati come
avanguardie. Piuttosto, essi hanno giocato con i vecchi stili e con le vecchie teorie,
scomponendole e ricomponendole in nuove configurazioni.
Nell'antropologia degli ultimi anni, ad esempio, termini come "dialogico" o "polifonico" sono stati
erroneamente intesi come proposte di scrittura di avanguardia, alternative alla classica monografia
realista interamente dominata dal potere e dal sapere dell'autore. Pretendere di produrre testi
integalmente "dialogici" o "polifonici" piuttosto che "realisti" o "monologici", come talvolta è stato
fatto, equivale a fraintendere il senso in cui questi termini sono stati introdotti nella riflessione sulle
basi epistemologiche della disciplina. La componente del dialogo e la molteplicità delle voci sono
caratteristiche necessariamente inerenti all'incontro etnografico, e che in modo più o meno diretto
si manifestano, magari inconsapevolmente, in tutti i resoconti degli antropologi - come necessaria
e ineliminabile in qualsiasi scritto etnografico è la componente autoriale, l'orchestrazione delle voci
da parte dell'autore, anche quando questa si manifesti nella finzione del dialogo non mediato,
come nel discusso Moroccan Dialogues di Kewin Dwyer (1982) o in Tuhami di Crapanzano (1980).
Dunque, le nozioni di dialogicità e polifonia, su cui ha insistito in modo particolare James Clifford
(prendendole in prestito da Baktin), alludono più a una dimensione di lettura applicabile a ogni
forma di etnografia, che non a un nuovo canone di produzione etnografica. Come Marcus e
colleghi hanno esplicitamente riconosciuto, esse riguardano le condizioni della ricezione più che
quelle della produzione del testo.
"Il punto - essi affermano - non è tanto cambiare radicalmente le pratiche di scrittura, come
qualcuno teme, quanto cambiare le condizioni di ricezione del lavoro antropologico: vale a dire,
creare un ambiente aperto, più di quanto non accada oggi, a molte e alternative letture delle opere
di antropologia. Non si tratta di far emergere una 'nuova letteratura' da 'tutto questo parlare'
[l'antropologia testuale]; al contrario, il senso di tutto questo parlare sta proprio nell'impedire
l'avvento di una nuova letteratura, rifiutando di prescrivere ciò che dovrebbe essere, e
caratterizzando invece ciò che già è" (Tyler-Marcus 1987: 274).
Lo stesso vale per la nozione di riflessività, che non è affatto un invito a forme di scrittura
diaristica e incentrata sulla soggettività del ricercatore - "confessionale", come l'ha definita Geertz anche se la scrittura confessionale diviene una possibilità legittima di organizzazione del resoconto
etnografico.
L'unica proposta in positivo che viene dal gruppo di Writing Culture, in particolare da George
Marcus, è quella di aprire una fase sperimentale, come viene definita ( con espressione a mio
parere infelice), di produzione di resoconti etnografici (Marcus-Fisher 1986; Marcus 1992, 1994). In
questa nozione di etnografia "sperimentale", piuttosto ambigua, vi è certamente il senso di una
rottura con il passato; ma non vi è la proposta di un mutamento paradigmatico, di passaggio ad
una nuova fase di "scienza normale", o, se vogliamo, di affermazione di un nuovo genere
letterario. Piuttosto, si sottolinea la pluralità degli approcci e delle strategie di rappresentazione
culturale, e il loro carattere necessariamente "ironico" - per usare un altro termine entrato nel
gergo, a indicare la consapevolezza della natura retorica del proprio discorso, del fatto che non vi
è alternativa all'uso di strategie che colgono la realtà in modo limitato e "letterario". Ironia è il
sognare sapendo di sognare, secondo la celebre espressione di Nietszche. Per inciso, è questo
che si intende quando si raffronta il resoconto antropologico alla letteratura di fiction - e non certo
la raccomandazione di scrivere le etnografie sotto forma di romanzi, né l'assurda affermazione,
attribuita al postmodern dai suoi critici, che non v'è alcuna differenza tra letteratura e antropologia.
Dietro l'invito di Marcus alla sperimentazione vi è l'idea che l'antropologia debba rimodellarsi
sulle nuove condizioni che definiscono oggi l'incontro etnografico. Qui tocchiamo il cuore del
problema. Le riflessioni che troviamo accomunate sotto l'ombrello postmodern non sono soltanto
l'ultima moda americana, l'ultimo prodotto di importazione dai mercati fascinosi ma torbidi
dell'ermeneutica e del decostruzionismo, l'ultimo fastidioso gergo specialistico. Esse esprimono
l'esigenza di comprendere le mutate condizioni di possibilità del sapere antropologico,
profondamente diverse rispetto alla fase classica della disciplina, quella rappresentata dalle scuole
di Boas e Malinowski. Lo fanno forse in forme talvolta troppo radicali e pretenziose, ma con un
grado di consapevolezza epistemologica che non mi pare altrettanto sviluppato in altri indirizzi
dell'antropologia contemporanea. Il problema che si trovano ad affrontare, in un certo senso, è
quello della periodizzazione della storia dell'antropologia, dei momenti di discontinuità nelle
condizioni - interne ed esterne - del suo sapere.
Ciò che non si è capitp è che Writing Culture è, in definitiva, un libro di storia degli studi. Cerca
di rispondere alla domanda: quali condizioni hanno consentito all'inizio del secolo la nascita
dell'antropologia moderna? E cerca di rispondere alla maniera degli storici delle idee, uscendo
dall'autorappresentazione interna alla disciplina e indagando le sue relazioni con contesti culturali
e sociali più ampi. Schematizzando fortemente, queste condizioni sono indicate nella costruzione
di modelli standard di oggetto etnografico e di soggettività etnografica; modelli poggianti su basi
politiche (il colonialismo, essenzialmente, la separazione e l'asimmetria di potere tra l'Occidente e
il Resto del Mondo) ed epistemologiche (il positivismo, il realismo, a loro volta non slegati dal
dominio politico). L'ulteriore domanda che viene posta è che cosa accada dell'antropologia quando
queste condizioni politiche ed epistemiche vengono meno o mutano radicalmente.
Questo è un problema centrale non solo per l'approccio testuale. E' diffusa la convinzione che in
qualche momento e da qualche parte, a partire dagli anni '60, l'antropologia sia entrata in crisi e le
sue condizioni costitutive siano mutate. Crisi dell'oggetto - con la decolonizzazione e le sue
conseguenze nei rapporti tra Occidente e Resto del Mondo; crisi del soggetto, con la progressiva
perdita di fiducia nelle possibilità di una rappresentazione oggettiva, distaccata ed eticamente
neutrale dell'Altro, e con la crescente consapevolezza del coinvolgimento della soggettività
antropologica nell'incontro etnografico e nelle stesse strategie descrittive. Stocking, che non ha
certo simpatie postmoderne (1992: 7 sgg.), ha di recente letto questa rottura in termini di
cambiamento di "tradizioni paradigmatiche". E' chiaro, egli scrive, che il periodo classico
dell'antropologia moderna è giunto alla conclusione dopo il 1960, con l'apertura di una lunga fase
di "crisi". Stocking ritiene che dagli anni '80 in poi la crisi possa dirsi, come si esprime,
"addomesticata", il periodo di transizione concluso, e che negli Stati Uniti, ad esempio, i maggiori
dipartimenti universitari abbiano ripreso una normale routine di ricerca, anche se con maggiori
difficoltà, non da ultimo economiche, rispetto al passato. E tuttavia, aggiunge, il "lavoro ordinario",
the usual business, di questa antropologia post-classica differisce per molti aspetti significativi da
quello che era stato in passato. Ecco come: "Con la fine degli imperi coloniali, [...] i popoli
tradizionalmente studiati dagli antropologi sono divenuti parte di 'nazioni nuove', orientate verso un
rapido muamento socio-culturale [...] A fronte di un rapido mutamento sociale e di restrizioni
nell'accesso ai luoghi di ricerca, non è più apparso realistico, neppure sul piano normativo,
considerare come obiettivo privilegiato dell'inchiesta antropologica la scoperta di una 'alterità' non
europea pura e incontaminata. Nè è stato più possibile considerare tale inchiesta come neutrale
sul piano etico, o priva di conseguenze su quello politico. Una nuova consapevolezza della
riflessività inerente all'osservazione partecipante ha messo in discussione le assunzioni sia
metodologiche che epistemologiche della tradizionale ricerca etnografica di terreno" (Stocking,
1990: 358-59).
Non molto diversa è la prospettiva delineata da Geertz nel suo ultimo libro, After the fact
(anch'esso, per inciso, un impotante contributo di storia degli studi). che sintetizza le "alterazioni
nelle condizioni del lavoro etnografico" nei seguenti punti. Prima di tutto, l'antropologia ha risentito
della "vertigine morale ed epistemologica che ha colpito la cultura nell'età post-strutturalista, postmodernista, post-umanista, l'età delle svolte e dei testi, del soggetto evaporato e del fatto
costruito...". Una vertigine che ha dato origine a un' "ansia radicale", articolata nelle seguenti
"preoccupazioni", come le definisce Geertz :"preoccupazione sulla legittimità del parlare a nome
degli altri; preoccupazione per gli effetti distorcenti delle assunzioni occidentali sulla percezione
degli altri; preoccupazione per il ruolo ambiguo che il linguaggio e l'autorità svolgono nella
raffigurazione degli altri (1995: 128-29).
Dall'altro lato, dice Geertz, non sono state solo le "idee" a cambiare, ma il mondo stesso. La fine
del colonialismo ha trasformato le modalità di accesso al "campo" e il ruolo di potere e di distacco
di cui l'antropologo classico godeva; gli antropologi non lavorano più in contesti intellettualmente
"vergini", ma devono confrontarsi con il lavoro di altri studiosi, spesso nativi; infine, il numero degli
antropologi è aumentato a dismisura, e ciò non è privo di conseguenze sulla pratica della ricerca e
sulle modalità di scrittura (Ibid.).
Usare la nozione di antropologia "post-classica", come fa Stocking, è forse più elegante e meno
impegnativo che non dire "post-moderna" - espressione, quest'ultima, che si porta dietro un
ingombrante fardello dal dibattito filosofico e artistico. I due termini hanno però in comune l'idea di
uno sviluppo degli studi che procede per rotture epistemiche e non per continuità. Comprendere la
natura della rottura post-classica, e comprendere le condizioni che rendono possibile oggi un
sapere antropologico, sono i problemi che pone il cosiddetto postmodern, che in questo pare
tutt'altro che una frivola moda ma, anzi, un erede della più seria riflessione storiografica ed
epistemologica.
Identità, culture e mondi della vita
(Fabio Dei)
1. Periodicamente, l’antropologia abbandona e mette il veto su nozioni e termini che in passato aveva
largamente sfruttato: è il caso di “primitivo”, di “totemismo”, di “tribù” e “tribale”, di “credenza”. Questi
termini, mentre magari si diffondono nel linguaggio comune, si associano per gli antropologi a profondi
pregiudizi etnocentrici e a una distorta comprensione del proprio oggetto di studio. Essi spariscono allora dal
linguaggio specialistico: se proprio non si può fare a meno di usarli, si ricorre alla cautela delle virgolette.
Di recente, una sorte analoga è toccata all’identità culturale. Questa nozione, nel corso del Novecento, è
stata a lungo rivendicata come risorsa-chiave per una comprensione non etnocentrica delle pratiche e delle
istituzioni sociali “altre”; di più, come una peculiarità dell’intelligenza antropologica rispetto a forme di
determinismo biologico, psicologico, economico. Con le sue implicazioni relativistiche, l’identità culturale
ha rappresentato la fondamentale barriera contro un senso comune che gerarchizzava le forme di vita e
svalutava il diverso come inferiore. Ma alla fine del secolo, l’identità si è trovata schiacciata da due lati, in
una morsa inesorabile. Da un lato, si è posto il problema dei suoi usi pubblici. Se per buona parte del secolo
la rivendicazione relativistica delle identità era stata un supporto al riconoscimento della pari dignità degli
“altri”, più di recente essa sembra divenuta al contrario strumento di discriminazioni xenofobe, di forme di
stigmatizzazione e neorazzismo, di ideologie che hanno supportato conflitti etnici e persino genocidi.
Trasformandosi in una generica nozione del discorso comune, l’identità ha radicalmente invertito il proprio
segno etico-politico. Dall’altro lato, parallelamente, la critica epistemologica che ha accompagnato la svolta
riflessiva dell’antropologia ci ha impedito di considerare l’identità culturale come proprietà sostantiva di un
gruppo umano, che l’antropologia potrebbe cogliere e oggettivamente descrivere. Le costruzioni identitarie,
quelle dei nativi come quelle degli antropologi, sono finzioni. Abbiamo imparato come le tradizioni siano
inventate con la finalità di immaginare comunità: e come le rappresentazioni etnografiche delle identità
siano non meno compromesse con strategie retoriche e immaginative; per non parlare del loro radicamento
nel potere-sapere coloniale. Al luogo comune per cui ogni popolo ha la sua identità culturale o etnica, si è
dunque sostituita l’altrettanto comune critica alle concezioni essenzialiste dell’identità.
2. Questa critica è un passo dovuto e irreversibile. È la prima cosa che ci sentiamo di dire, oggi, quando
pensiamo a un uso pubblico dell’antropologia. Sarà capitato a tutti noi di insistere sulla critica al senso
comune essenzialista in occasioni divulgative come corsi di aggiornamento, oppure nelle lezioni di
introduzione alla disciplina (come quelle che ci capita sempre più spesso di fare in mini-moduli di uno o due
crediti didattici, in corsi di laurea in cui l’antropologia è prevista in quantità assai modiche, come una spezia
pregiata ma troppo piccante). Quando “identità” o “cultura” entrano nello strumentario linguistico del
neorazzismo leghista, dei movimenti xenofobi e dei più aggressivi nazionalismi, sentiamo ovviamente il
bisogno di smarcarci; e lo stesso vale, sia pure in modo meno drammatico, per i loro ingenui usi sul mercato
del patrimonio e del turismo. Su questo punto insistono giustamente i pochi libri che hanno cercato negli
ultimi anni di collocare l’antropologia nella sfera pubblica, ad esempio Contro l’identità di Francesco
Remotti ed Eccessi di culture di Marco Aime.
Tuttavia, il nostro nuovo posizionamento rispetto al tema dell’identità culturale non risolve tutti i problemi:
apre anzi una nuova agenda teorico-epistemologica della quale dobbiamo essere consapevoli. Dove ci porta
la critica all’indentità? Non è che, nella foga di mostrarci antiessenzialisti, finiamo per trovarci su terreni
altrettanto infidi e molto – troppo - lontani dalla originaria ispirazione del discorso antropologico? Mi pare
che la questione non sia pensata con sufficiente lucidità nel dibattito contemporaneo. Nei miei lavori degli
ultimi anni, mi sono trovato a riflettere in proposito a partire da campi specifici di ricerca, come
l’antropologia della violenza e quella del patrimonio. Abbiamo qui a che fare con pratiche e processi sociali
fortemente intrisi di sentimenti etnici e religiosi, di forme di appartenenza, di rivendicazioni localistiche e
comunitarie; siamo di fronte a soggetti che si muovono in campi di differenze che essi stessi percepiscono
come fondanti la loro umanità. Ora, espungere dal nostro lessico la nozione di identità è condizione forse
necessaria ma certo non sufficiente per comprendere questi aspetti. Se non è più una risorsa del discorso
antropologico, l’identità ne è almeno un oggetto – che abbiamo difficoltà a concettualizzare. A meno di non
voler sostenere che, una volta dissolto il mistificante velo culturalista, la verità delle cose ci si riveli in tutta
la sua abbagliante oggettività: una verità fatta esclusivamente di rapporti di forza, lotta per le risorse,
interessi economici e politici, che producono i sentimenti identitari come mere forme di ideologia e falsa
coscienza.
Quest’ultima è per l’appunto la tentazione che pervade alcuni influenti indirizzi delle scienze sociali di
oggi. Penso in particolare alle diverse articolazioni degli studi postcoloniali, da un lato, e dall’altro a indirizzi
neo-marxisti come quello rappresentato da J.-L.Amselle. Qui si pone giustamente l’accento sulle
implicazioni economico-politiche di ogni costruzione identitaria: ma da questa considerazione si passa
senz’altro – con un non sequitur argomentativo - a negare l’autonomia della dimensione culturale,
considerata come integralmente riconducibile (sotto la forma dell’ideologia o della falsa coscienza, appunto)
a quella dell’economia politica. In questa prospettiva, non esistono differenze ma solo disuguaglianze
prodotte dai rapporti di potere. Diversamente dal marxismo classico, si riconoscono le disuguaglianze
relative ai rapporti coloniali e di genere, oltre che a quelli di classe. Ma l’epistemologia è la stessa,
incardinata sulla dicotomia tra le condizioni reali (materiali) del potere e i suoi “spettri”. Come nell’
Ideologia tedesca, le discipline che teorizzano gli spettri del potere sono denunciate come a loro volta
ideologiche - riflessi e al tempo stesso strumenti di sostegno del dominio. È questa la logica nascosta di una
ragione etnologica che saremmo chiamati oggi a smascherare e superare. Ciò ha portato tra l’altro a una
liquidazione radicale della storia dell’antropologia, che in un libro come Logiche meticce finisce per apparire
– da Tylor e Mauss fino a Lévi-Strauss e Geertz – come una enorme macchina per la produzione
dell’illusione culturalista, ingenuamente inconsapevole dei modi in cui l’alterità viene prodotta dal dominio,
o ancora peggio asservita ai suoi interessi. Una rappresentazione caricaturale, che non tiene conto degli
aspetti per così dire antiegemonici che hanno fin dall’inizio caratterizzato la disciplina, facendo perno
proprio sul concetto di cultura.
Siamo di fronte a una curiosa involuzione epistemologica, che si presenta come rivincita delle teorie forti
contro l’ermeneutica e gli approcci interpretativi - accusati di assumere le differenze come date (invece che
come prodotte) e di aprire la strada al più pericoloso culturalismo. La storia degli studi assume strane
traiettorie. Come detto, era stata proprio l’antropologia interpretativa a “decostruire” per prima i concetti di
identità e cultura, nel quadro di una riconsiderazione critica delle modalità di produzione del nostro sapere.
La riflessione sulle retoriche e sulle politiche dell’etnografia dipendeva dal rifiuto di fondare l’antropologia
su epistemologie realiste e oggettiviste, e si collegava allo sforzo di sostituire un approccio storicamente
avvertito e “comprendente” a quello esplicativo e nomotetico che caratterizzava la fase classica della
disciplina. Il postcolonial l’ha trasformata nello smascheramento di un’ideologia, impostando l’analisi
culturale sulla fondamentale contrapposizione tra apparenza e realtà, illusione e verità oggettiva. Si tende
talvolta ad accomunare tutta la fase post-positivista delle scienze sociali sotto etichette unitarie, quali
postmodernismo e simili, che creano però confusione e ci impedicono di scorgere questa basilare
divaricazione epistemologica.
3. Un corollario delle posizioni finora descritte (talvolta implicito talvolta esplicitamente formulato) è il
seguente: se le differenze culturali sono sempre sottodeterminate, esse non sono costitutive della razionalità
umana, dunque del modello di soggetto agente razionale che sta alla base della nostra antropologia. In altre
parole, i soggetti sono in linea di principio tutti uguali. La loro cultura - i loro valori, le loro credenze, le loro
finalità esistenziali e i loro criteri di razionalità – sarebbero dappertutto gli stessi, se non intervenissero fattori
esterni (relazioni di dominio) a produrre disuguaglianze mascherate da diversità. Si apre qui una teoria
sociale che torna a poggiare su un modello – sostanzialmente illuminista - di agente umano astratto e
universale, nel quale la diversità si insinua solo dall’esterno, come conseguenza della discriminazione.
L’umanità ideale sarebbe allora fatta da cittadini del mondo intercambiabili, privi di alcuna identità o
radicamento localistico: questi fattori di differenziazione sono solo il frutto di manipolazioni delle coscienze,
e devono esser “spiegati via” più che “compresi” dalla teoria sociale.
Contro i rischi di stigmatizzare categorie di persone richiamando la loro “cultura” – una strategia che
contrassegna in modo inequivocabile il neo-razzismo - noi insistiamo giustamente sul carattere individuale
della agency, della scelta, della responsabilità, della colpa. Ma ciò può portarci, attraverso una serie di
scivolamenti, a reintrodurre forme di individualismo metodologico che contrastano con le più profonde
eredità della nostra disciplina. Ad agire sono sempre singole persone, certo: i “tipi” (i “trobriandesi”, i
“nuer”, i “balinesi”, così come i “romeni”, gli “albanesi” o gli “extracomunitari”) sono costruzioni fittizie
sulla cui ambiguità epistemologica e politica tanto si è ormai scritto. Eppure la nostra vocazione è a
considerare il carattere culturalmente – cioè socialmente - condizionato dell’agire e del pensare individuale.
Se non ci fosse altro che la razionalità individuale dietro alle pratiche sociali, non ci sarebbe proprio bisogno
dell’antropologia.
Ha ragione allora Marco Aime ad affermare che l’antropologia “occupa uno spazio tra un’idea astratta di
eguaglianza sociale e l’erezione di barriere culturali insormontabili” (p. 133). Il suo fortunato libro Eccesi di
culture enuncia proprio in copertina, come principio chiave, che “a incontrarsi o a scontrarsi non sono
culture, ma persone”. E a p. 54 cita Alessandro Dal Lago che, contro la tendenza a etnicizzare i conflitti,
commenta: “si dovrebbe parlare soltanto di individui che interagiscono tra loro e con la società”. D’accordo,
affermazioni di questo tipo sono comprensibili e condivisibili contro i pregiudizi essenzialisti, che
rappresentano gli individui come prigionieri di culture di cui sarebbero inconsapevoli portatori, secondo un
modello da “invasione degli ultracorpi”. Ma attenzione: per contrastare i pregiudizi e le semplificazioni non
c’è bisogno di rinunciare a un aspetto centrale della nostra tradizione scientifica. Dovrebbe essere ovvio che
in antropologia, come in sociologia, il piano individuale non è sufficiente a comprendere le pratiche umane;
e che anzi l’ “individuo” è il prodotto di complessi processi di plasmazione storica e culturale.
Se è vero che nei contesti che definiamo multiculturali abbiamo a che fare con singoli individui, sono però
individui profondamente intessuti da reti di differenze – ibride quanto si vuole, certo, ma non per questo
meno decisive nel costituire la soggettività di un attore sociale. Aime dice, più giustamente, che sono
persone – e non individui – a incontrarsi e scontrarsi: persone, cioè esseri fatti di cultura e di storia, che pure
portano il peso della scelta morale e della responsabilità giuridica. E le differenze tra loro non sono certo
soltanto il frutto di scelte private e arbitrarie: sono da un lato legate al posizionamento socio-economico,
dall’altro a qualcosa che se non vogliamo chiamare cultura dovremo pur riuscire a definire in qualche modo.
Qualcosa che ha a che fare con i gruppi di origine, con il fatto di esser nati ed esser stati educati in luoghi e
tempi particolari, di aver conosciuto forme specifiche di addomesticamento del mondo, di avere una certa
lingua madre, di aderire a certe visioni e precetti religiosi e così via.
Questi elementi non si dispongono in configurazioni ordinate e discrete, che possano essere positivamente
descritte e classificate dagli antropologi. Non crediamo più allo statuto oggettivo dei nostri costrutti teorici,
così come non crediamo all’essenzialismo identitario degli attori sociali. Ma ciò non rende meno concrete
queste disposizioni differenziali dei soggetti umani – radicate negli aspetti più basilari dell’esistenza, nel
corpo, nella nascita e nella morte, nelle relazioni familiari, nel rapporto ravvicinato con l’ambiente naturale e
sociale. Insistere sul fatto che le persone vivono in universi di significato non del tutto coincidenti può
apparire una mossa insopportabilmente relativistica e culturalista solo se la si combina con una
epistemologia naturalistica e deterministica. Questo era in effetti il limite del relativismo di matrice
nordamericana, rappresentato ad esempio da Herskowits, per il quale le “culture” erano entità empiricamente
esistenti, positivamente descrivibili e classificabili dall’esterno (non si capisce da quale prospettiva); e per il
quale il relativismo era una verità oggettivamente dimostrabile – un paradosso di cui non sembra mai essersi
reso conto. I paradossi e le difficoltà aperte dal suo celebre Statement on Human Rights erano frutto non
dell’istanza di riconoscimento della diversità, ma dell’uso di una nozione reificata di cultura – una versione
antropologica di quello che Popper chiamava il “mito del framework”. Per un’antropologia intesa come
raffronto e interpretazione di sistemi di significato incommensurabili (cioè non riducibili a equivalenza
logica), a loro volta radicati in forme pratiche di vita, ciò che non ha senso è la tematica
relativista/antirelativista in sé.
4. Tornando all’argomento principale, la dismissione del concetto essenzialista di cultura e di quello
correlato di identità culturale lascia aperti nella nostra agenda due grandi problemi. Il primo è quello del
“sentimento etnico”: perché i gruppi sociali agiscono aggregandosi attorno a sentimenti di appartenenza?
Noi sappiamo ad esempio che le “identità” hutu e tutsi, oppure serba e croata, non sono affatto forme di
appartenenza/esclusione “naturali”, e neppure storicamente tanto profonde da poter spiegare l’odio e la
violenza “etnica” cui ci è toccato assistere. Pensiamo che la violenza ha prodotto la forza dell’identità e
dell’odio, e non viceversa. Ci resta però da capire in che modo il sentimento etnico è stato incorporato tanto
in profondità da quei soggetti, così da renderli protagonisti delle atrocità che conosciamo. Meno
drammaticamente, nel campo del patrimonio, sappiamo bene in che misura siano inventate le tradizioni o le
immaginazioni comunitarie che fondano oggi tante forme di revival festivo, di compiacimento regionalistico,
di folklorismo. Ciò non sminuisce però il grado di coinvolgimento e la forza delle passioni e dei legami che
attorno alle “tradizioni” si aggregano. Come collochiamo tutto ciò in una prospettiva antropologica?
La risposta classica era che i sentimenti identitari esistono perché esistono positivamente, là fuori nel mondo,
le identità culturali: qualcosa che sta al di sopra degli individui determinandone il comportamento e le idee, e
che l’antropologia può descrivere e classificare oggettivamente. La risposta della più radicale critica
anticulturalista è che i sentimenti identitari sono una sovrastruttura ideologica, che maschera da un lato e
dall’altro supporta forze molto più strutturali, come gli interessi economici e i rapporti di dominio; a spiegare
questi ultimi sarebbe sufficiente una teoria universalista e utilitarista della soggettività umana. Ecco, la
comprensione antropologica sembra doversi collocare in uno spazio intermedio tra queste due risposte,
entrambe in sé insufficienti.
Il che porta al secondo problema: la centralità, per l’intelligenza antropologica, del radicamento dei soggetti
umani in mondi della vita. Mondi che – anche nel villaggio globale – hanno una qualità sempre in qualche
modo locale. Se riesce a smarcarsi dalle metafisiche materialiste, basate sul determinismo di strutture più
profonde e più reali, così come da quelle idealiste che reificano la cultura, l’antropologia può sviluppare la
sua affinità elettiva per una prospettiva fenomenologica: una prospettiva nella quale la teoria prende l’aspetto
del resoconto descrittivo – il che equivale a dire interpretativo – di contesti locali di pratiche e di significati.
È in questa dimensione che può esser riletta la questione dell’identità, depurandola dai suoi residui
naturalistici e deterministi. L’antropologia si interessa alla costruzione dell’agency in rapporto a modalità
peculiari – locali e comunitarie - di addomesticamento del mondo. Una definizione che apparirebbe ovvia e
scontata, se non fosse per la forza della contrapposta tendenza a considerare oscurantista e reazionaria
l’insistenza sul radicamento locale e comunitario – sul fatto che le differenze sono irriducibili perché legate a
forme pratiche di vita. Si tratterebbe di una mossa di esclusione e di chiusura: affermando un’appartenenza,
la si negherebbe agli altri. Con il rischio, ancora una volta, di fondare scientificamente la xenofobia. Dire che
siamo tutti uguali ha implicazioni più progressiste: sembra ad alcuni che solo una qualche forma di
universalismo antropologico possa fondare l’uguaglianza politica e la parità dei diritti.
Ma simili argomenti confondono il piano normativo con quello descrittivo del discorso; l’ordine legale o
costituzionale con quello concretamente esistente ed etnograficamente rilevabile. Affermare che tutti sono
uguali, nel senso che tutti hanno o dovrebbero avere gli stessi diritti, significa enunciare un ideale etico e
normativo che non ha affatto bisogno di esser sostenuto da una “realtà di fatto” antropologica; un ideale,
anzi, che trae significato proprio dall’esistenza empirica della diversità. Un punto che il femminismo, ad
esempio, ha ormai da tempo riconosciuto, preferendo rivendicare la differenza piuttosto che demonizzarla,
ed elaborando una concezione sessuata della soggettività come fondamento della parità normativa.
Va da sé che ciascuna di queste argomentazioni avrebbe bisogno di uno sviluppo assai più ampio; così
come troppo vasti dovrebbero essere i quadri di riferimento bibliografico. In sintesi, ho cercato di indirizzare
l’attenzione su due aspetti che mi sembrano decisivi in questo nostro dibattito sulla nozione di identità
culturale – o, per meglio dire, sul suo abbandono. Da un lato, l’utilità di tornare ad una più rigorosa
attenzione agli aspetti epistemologici del problema – oggi spesso sepolti sotto una certa confusione
ideologica, che in indirizzi come quello postcolonial è a malapena mascherata dalla caratteristica gergalità e
oscurità espressiva. In secondo luogo, il riconoscimento della vocazione dell’antropologia per la costituzione
fenomenologica di mondi locali. È chiaro che il concetto di “locale” va oggi ridefinito in modo non
puramente spaziale. La quantità e la qualità di oggetti, luoghi, persone, risorse comunicative che formano
oggi la base del nostro mondo della vita è diversa, certo, da quella degli Alchipa che piantavano ogni volta il
centro del loro universo. Quello che Hermann Bausinger ha chiamato il processo di “espansione”,
coincidente con la modernità tecnologica e politica, ha ampliato a dismisura gli orizzonti spaziali, temporali
e sociali delle tradizionali comunità locali. Ma non ha cancellato la necessità di vivere in mondi
addomesticati e ordinati. Anche gli individui più cosmopoliti abitano un orizzonte di riferimenti ordinati e in
un certo modo ristretti, “locali” e irriducibili, connessi con le loro forme pratiche di esistenza, che
l’antropologia può studiare empiricamente. Il vecchio sogno anarchico, una repubblica di cittadini del
mondo, può forse essere un alto e commovente ideale etico; ma certo, se mai potesse esistere qualcosa di
simile, l’antropologia diverrebbe una pratica assai poco interessante.
La libertà di inventare i fatti: antropologia, storia, letteratura
Fabio Dei
1. La svolta retorica nelle scienze umane.
Nell’ultimo quarto di secolo, molte scienze umane e sociali si sono trovate immerse (con fastidio,
ansia o eccitazione, a seconda dei punti di vista) in dibattiti sulla natura letteraria e retorica dei
rispettivi saperi. La storiografia, l’antropologia culturale, la sociologia, la psicologia e altre
discipline, sia pure in modi diversi, hanno dovuto riflettere sulla presenza di una dimensione
letteraria nelle proprie procedure di costruzione e trasmissione della conoscenza; una dimensione
che almeno in apparenza sembrerebbe confliggere con quella della scienza, della fattualità,
dell’oggettività cui tali discipline aspirano per nascita e per rango.
Questa attenzione alla dimensione letteraria è stata giudicata - e criticata - da molti come una
concessione a recenti ed effimere mode accademiche. Una simile critica è tuttavia ingiusta e
superficiale. La svolta retorica ha profonde radici nei dibattiti epistemologici che hanno percorso le
scienze umane fin dal loro apparire, in particolare nella antica disputa tra gli approcci naturalistici e
quelli che potremmo chiamare comprendenti. A lungo tali dibattiti si sono incentrati sul problema
dell’oggettività rappresentativa, dunque della natura del rapporto tra osservatore e oggetto: hanno
dunque seguito piste analoghe a quelle battute dalla filosofia delle scienze naturali, interrogandosi
sui problemi del realismo e sulle teorie della verità come corrispondenza, sulla universalità o
relatività storico-culturale dei criteri di razionalità, e così via. Negli ultimi decenni svariate fonti
filosofiche - dalle eredità wittgensteiniane, all’ermeneutica di Ricoeur e Gadamer, al pragmatismo
di Rorty - hanno conferito un’angolatura particolare a tali dibattiti, indirizzando l’attenzione sulle
condizioni pratiche della produzione del sapere socio-antropologico. La scrittura è apparsa come la
principale di queste condizioni pratiche, secondo una celebre tesi esposta da Clifford Geertz negli
anni ’70, che segna idealmente l’avvio della svolta retorica in antropologia:
Se volete capire che cos'è una scienza, non dovete considerare anzitutto le sue teorie e le sue
scoperte (e comunque non quello che ne dicono i suoi apologeti): dovete guardare che cosa fanno
quelli che la praticano [...] Che cosa fa l'etnografo? Scrive (Geertz 1987 [1973]: 41, 58).
Nella prospettiva aperta da Geertz (che sarà sviluppata da altri anche oltre e contro le sue stesse
intenzioni) la scrittura non è solo neutrale strumento di trasmissione di una conoscenza acquisita
indipendentemente da essa, il cui statuto e la cui validità si giocherebbero nello spazio interamente
epistemologico che si apre fra Soggetto e Oggetto. Al contrario, la scrittura è la dimensione al cui
interno la pratica conoscitiva si definisce, e che plasma le stesse categorie solo apparentemente
assolute di soggetto e oggetto. I grandi problemi epistemologici - com'è possibile l'accesso ad altre
menti, com'è possibile l'oggettivazione di un'esperienza eminentemente soggettiva e partecipativa
come quella etnografica, com’è possibile evitare l'etnocentrismo nel confronto interculturale - si
rivelano per così dire sottoprodotti di pratiche rappresentative che avvengono all'interno della
scrittura. Quello che finora sembrava un problema di realismo epistemologico, finisce per apparire
come un problema di realismo letterario.
Per inciso, questa svolta retorico-letteraria è stata probabilmente più forte in antropologia che in
altre discipline. Certo, anche storiografia, sociologia, psicologia hanno affrontato analoghi
problemi; le stesse scienze naturali non ne sono state immuni. Ma è solo in antropologia che la
sfida letteraria e il dibattito sulla scrittura hanno occupato di prepotenza il centro dei dibattiti
metodologici ed epistemologici, presentandosi come l’unico vero nucleo comune di discussione in
epoca post-strutturalista e nel pieno della crisi delle Grandi Teorie. Ciò può esser considerato
sintomo della permanente debolezza dello statuto della disciplina, ancora ben lontana dal divenire
una scienza normale nel senso di Kuhn; oppure, al contrario, come manifestazione di una
particolare raffinatezza riflessiva. In ogni caso, pochi antropologi hanno potuto evitare di prender
posizione in proposito, anche se le reazioni alla svolta retorica sono state assai diverse:
dall’entusiasmo “rivoluzionario” di alcuni, alla feroce critica di chi ha visto in essa una forma
estrema di relativismo cognitivo, implicante il rischio di perder contatto con l’oggetto del proprio
studio e di rinunciare a quell’impegno verso la verità che dovrebbe esser caratteristico di ogni
intrapresa scientifica.
2. Il problema del realismo
Per l’antropologia culturale, le conseguenze dell'apertura di questa prospettiva sono
principalmente due, ed emergono entrambe con forza negli anni ‘80, soprattutto dopo la
pubblicazione dell'epocale volume Writing Culture (Clifford-Marcus 1997 [1986]). La prima è la
possibilità di rileggere l'intera storia degli studi antropologici come una successione non di teorie o
metodi ma, principalmente, di pratiche testuali o di generi di scrittura. La seconda è l'apertura a
nuove forme di rappresentazione culturale, riflessivamente consapevoli della dimensione testuale
in cui si collocano e pronte a superare le convenzioni classiche della scrittura etnografica. Per
entrambi questi punti è centrale il problema del realismo. Una letteratura ormai assai ampia
concorda nel caratterizzare la fase classica dell'antropologia novecentesca (sommariamente, dagli
anni Venti in poi) come dominata dal genere etnografico della “monografia realista”. Il termine
“realismo” è qui usato in senso prettamente letterario: vale a dire, in riferimento alla narrativa
ottocentesca e all’insieme di strategie stilistiche e retoriche da essa elaborate, volte a produrre
convincenti effetti di realtà. Tali strategie sarebbero appunto rintracciabili nella composizione delle
etnografie classiche, operanti a tutti i livelli del testo - dalla sua architettura complessiva, alle scelte
lessicali e sintattiche, alla presenza di figure retoriche, agli espliciti o impliciti rinvii intertestuali.
Tratti caratterizzanti della monografia realista sarebbero, fra gli altri, l'olismo rappresentativo,
l'attenzione ridondante al dettaglio, la modalità impersonale di narrazione, l'uso del presente
etnografico, la predominanza del visualismo descrittivo.
In sostanza, l'oggettività scientifica cui l'antropologia aspira si rivela come una finzione retorica: il
problema della corrispondenza epistemologica alla realtà, come detto, trapassa senz’altro in un
problema di effetti retorici di realtà. La storia degli studi, riletta in chiave testuale, suona più o meno
così: il genere realista, codificato dalle monografie etnografiche di Malinowski e dei suoi allievi,
avrebbe soppiantato e reso non scientifiche vecchie forme di scrittura antropologica informate al
genere del romance, e rappresentate ad esempio dal Ramo d'oro di James G. Frazer. Pur aprendo
spazi discorsivi nuovi e di grande ricchezza, il genere realista ha tuttavia il torto di dissimulare le
effettive condizioni della ricerca etnografica e della produzione del sapere antropologico,
nascondendo completamente ad esempio il ruolo della soggettività del ricercatore e delle singole
individualità degli informatori, la dimensione dialogica della ricerca, le condizioni storiche e
politiche in cui essa avviene e così via. La consapevolezza di tali mistificazioni dovrebbe spingere,
secondo alcuni (v. p.es. Marcus-Fisher 1994) a sperimentare nuove forme di scrittura etnografica,
che si liberino delle convenzioni realiste e facciano un uso consapevole di diverse e più ampie
strategie retoriche, narrative, poetiche (mutuate ad esempio dal modernismo e dal postmodernismo artistico) nel tentativo di restituire l'esperienza dell'incontro etnografico nella sua
pienezza e complessità.
3. La demarcazione fra resoconto etnografico e fiction
A quindici anni da Writing Culture, c'è oggi da dubitare del successo di questa fase sperimentale
della scrittura etnografica. Così come, passata l'eccitazione per la “scoperta” del realismo
etnografico, c'è da dubitare della coerenza e utilità di questa nozione. Fino a che punto è possibile
tarsportare nell'analisi dei testi etnografici la categoria letteraria di realismo? Gli studi in proposito
sembrano non riuscire a andar oltre alcune generiche - per quanto suggestive - affinità (v. MarcusCushman 1982, Webster 1986, Spencer, 1989, Thornton 1989). In particolare, mi sembra vi sia un
grande problema che l'antropologia testuale non sembra aver risolto, e forse neppure affrontato
seriamente: quello delle differenze fra testo letterario e testo antropologico. Dopo che abbiamo
riconosciuto la dimensione letteraria e retorica dell'antropologia, e le affinità tra realismo
etnografico e realismo letterario, come possiamo demarcare i due tipi di testi? Che fra un saggio
antropologico e una fiction narrativa esista una differenza sostanziale è fuor di dubbio: per quanto
possano esistere casi di confine, i due tipi di testo risultano immediatamente riconoscibili sul piano
intuitivo. Aprendo un libro, sappiamo subito se ci troviamo di fronte a un romanzo o a un saggio
etnografico o antropologico, qualunque sia il format di quest'ultimo - tradizionale o sperimentale,
classico o post-moderno, monografia realista, trattato comparativo, resoconto riflessivo o
dialogico. E' possibile dar conto di questa differenza intuitivamente evidente nei termini di una
teoria del testo antropologico? Naturalmente, se seguiamo la prospettiva retorico-letteraria, non
possiamo pensare che la differenza consista semplicemente nei rapporti tra il testo e la realtà, e si
fondi dunque su dicotomie quali fatti-finzioni, verità-immaginazione, oggettività-soggettività. Da un
lato i fatti, la verità, l'oggettività stanno per così dire anche dalla parte della fiction, che si pone
comunque obiettivi di rappresentazione o evocazione a partire dall'esperienza della realtà.
Dall'altro, la letteratura scientifica è permeata a sua volta di soggettività, immaginazione, finzione,
tanto che il suo realismo, come abbiamo visto, è esso stesso un effetto retorico.
Se evitiamo questi assunti epistemologici, è tuttavia ancora possibile dar conto della differenza tra
ciò che significa scrivere (e leggere) un resoconto antropologico e un romanzo o una poesia? Il
riferimento a criteri extra-testuali (chi è l'autore, se è un antropologo professionale, se ha fatto
davvero ricerca, se il libro è pubblicato da una University Press o da un editore commerciale etc.)
non fornisce evidentemente una risposta. Lo stesso vale per il rispetto delle convenzioni
accademiche di scrittura: oggi che le convenzioni “realiste” classiche (il presente etnografico,
l'impersonalità descrittiva etc.) sono superate, e si è ampiamente diffuso tra gli antropologi l'uso
consapevole di esplicite strategie letterarie, pure un confine resta, ed è di solito facilmente
percepibile.
La svolta retorica in antropologica non sembra riuscita a definire un simile confine: ed è infatti su
questo punto che si accaniscono i suoi critici, sostenendo che l'impossibilità di distinguere tra
invenzione letteraria e saggio scientifico precipiterebbe la disciplina negli abissi dell'irrazionalismo.
Ogni possibilità di verifica o di valutazione di un resoconto antropologico verrebbe meno,
dipendendo la sua credibilità esclusivamente dalle capacità persuasive del testo. L'antropologia
finirebbe così per sganciarsi da quell'obiettivo del perseguimento di una verità oggettiva che, per
quanto problematico sul piano epistemologico, resta centrale nell'etica della ricerca scientifica.
Possiamo cominciare ad affrontare questo tema, con le sue ambiguità, partendo proprio dal già
ricordato contributo fondativo di Geertz. Esplorando le implicazioni del radicamento del sapere
antropologico nella pratica della scrittura, Geertz esplicita con chiarezza il problema della
demarcazione rispetto al romanzo, ponendo a confronto un resoconto storico-etnografico che trae
dalla propria ricerca sul campo e Madame Bovary. Rileggiamo il passo:
Elaborare delle descrizioni orientate rispetto agli attori sulle complicazioni sorte tra uno sceicco
berbero, un trafficante ebreo e un soldato francese nel Marocco del 1912 è chiaramente un atto
immaginativo, non tanto diverso dalla descrizione ad esempio delle complicazioni tra un dottore
francese di provincia, la sua sciocca moglie adultera e il suo inetto amante nella Francia
dell'Ottocento. In quest'ultimo caso i personaggi sono rappresentati come se non fossero esistiti e
gli avvenimenti come se non fossero accaduti, mentre nel primo sono rappresentati come se
fossero, o fossero stati, reali. Questa è una differenza di importanza non trascurabile: in effetti,
proprio quella che madame Bovary aveva difficoltà ad afferrare. Ma l'importanza non sta nel fatto
che la sua storia fu creata mentre quella di Cohen venne solo annotata. Le condizioni e lo scopo
della loro creazione (per non dir nulla della maniera e della qualità) sono diverse, ma l'una è fictio,
“una costruzione” quanto l'altra. (Geertz 1987 [1973]: 53-4).
Dove sta allora l'importanza della differenza tra i due tipi di testo, dunque tra il lavoro del
romanziere e quello dell'etnografo? In che senso le condizioni e lo scopo delle loro rispettive
creazioni sono diverse? Geertz ci lascia con un buon margine di incertezza in proposito: e lo
stesso vale per gli studi successivi degli autori che fanno capo al movimento di Writing Culture.
4. Racconto storico e finzione letteraria: il ruolo delle fonti
Possiamo cercare qualche aiuto esplorando il terreno della storiografia, che si è trovata e si trova
di fronte allo stesso tipo di problema. Caduto il mito positivista di un lavoro storico radicato nella
pura fattualità, la disciplina ha progressivamente acuito la consapevolezza della ineludibilità della
dimensione letteraria nella costruzione del proprio sapere, giungendo, con l'opera di Hayden
White, a una svolta letteraria non dissimile (anche se forse meno capillarmente influente) da quella
antropologica. Lo testimonia il mutamento di linguaggio e di prospettiva che la filosofia della
storiografia ha subito negli ultimi 20 anni - ben rappresentato, ad esempio, dall'evoluzione
dell’opera di uno studioso importante come Jerzi Topolski (1975, 1997): da un dibattito interamente
epistemologico, dettato dal raffronto con il metodo delle scienze naturali e imperniato attorno ai
problemi della corrispondenza oggettiva, della generalizzazione, della spiegazione, della verifica, a
un interesse centrato sulle modalità retoriche e persuasive di costruzione del racconto storico.
Gran parte degli storici, tuttavia, sembra avere pochi dubbi su ciò che differenzia il loro lavoro da
quello del romanziere: vale a dire, un qualche tipo di radicamento fattuale che non elimina gli
aspetti immaginativi e retorici della scrittura storica, ma perlomeno pone ad essa limiti e condizioni
ai quali non è invece soggetto il romanziere. In definitiva, pochi storici rifiuterebbero la celebre
affermazione di Momigliano (1984: 479), secondo il quale “la differenza tra un romanziere e uno
scrittore è che il romanziere è libero di inventare i fatti [...] mentre lo storico non inventa i fatti”.
Topolski, in un recente contributo (1997: 19), riformula questo principio sostituendo al concetto di
“fatti” quello di “fonti”. La base del racconto storico, i mattoni di cui per così dire esso è fatto, sono
a suo parere “proposizioni affermative [...] che includono informazioni desunte direttamente o
indirettamente dalle fonti” (Ibid.: 43). Tali proposizioni non determinano affatto la forma e il senso
complessivo del racconto storico, la cui costruzione implica una serie di procedure che sono in
gran parte comuni al lavoro letterario - tanto che da una stessa base fattuale possono generarsi
innumerevoli racconti o “universi narrativi” di tipo storico. Tuttavia tale radicamento empirico è
necessario perché un universo narrativo possa definirsi storico (Ibid: 25): il riferimento a
informazioni desunte dalle fonti, e la conseguente esclusione di contenuti da esse non suffragati,
rappresentano le regole del gioco del racconto storico, i limiti posti alla libertà immaginativa
dell'autore.
Da tutto ciò consegue la necessità di un'organizzazione del testo assai diversa da quella del
romanziere: p.es. la tendenza a evitare i dialoghi, le introspezioni psicologiche, l'analisi dei dettagli
delle azioni e delle motivazioni umane - non perché tutto ciò sia di per sé contrario al “metodo”
storico, ma perché non sarebbe quasi mai supportato da fonti adeguate. Il romanziere, anche nel
caso di romanzi storici la cui struttura generale sia rigorosamente basata su fonti, non deve
sottostare a tali limiti, e può fornire la sua interpretazione degli eventi lavorando inventivamente
sulle motivazioni degli agenti, sulle loro sensazioni ed emozioni, sui loro dialoghi e così via. La
posizione di Topolski non sarebbe forse condivisa da alcuni esponenti del post-modernismo
storiografico, come ad esempio lo stesso Hayden White, F.R. Ankersmith o H. Kellner - per quanto
anche questi ultimi, sostenitori di un radicale anti-realismo, ammettano la possibilità di applicare la
concezione classica di verità come corrispondenza al livello della “cronaca”, cioè alle proposizioni
fattuali elementari assunte dal racconto storico. In ogni caso, possiamo qui assumere quella di
Topolski come una formulazione abbastanza sofisticata di un punto di vista diffuso, senza il quale
non si riuscirebbe a dar conto della distinzione ovvia e intuitiva tra racconto (o universo narrativo)
storico e racconto (o universo narrativo) letterario. Il problema che vorrei porre è se una simile
prospettiva può risultare accettabile anche per l'etnografia e l'antropologia. Il riscontro con le fonti,
o meglio la proibizione di scrivere ciò che le fonti non consentono di scrivere, è davvero ciò che fa
la differenza tra l'antropologo e il romanziere, tra Madame Bovary e la vicenda geertziana del
mercante Cohen e delle pecore rubate?
5. L’indipendenza delle fonti in antropologia
Dovremmo chiederci in primo luogo se la nozione di fonti ha la stessa valenza per la storiografia e
per l'antropologia. Tipicamente, il rapporto delle due discipline con le fonti è molto diverso. La
storiografia assume classicamente le fonti come esistenti precedentemente e indipendentemente
dal ricercatore che le individua: sono semplicemente là, in attesa di esser scoperte in qualche
archivio, o in qualche sito archeologico, e ci resteranno, a disposizione di studiosi che vogliano
controllarle e valutare sulla loro base i racconti storici che le incorporano. L'etnografo, nella
situazione tipica di lavoro sul campo, deve invece produrre le sue fonti, attraverso la
partecipazione soggettiva alla vita culturale del gruppo umano che sta studiando. Lo fa soprattutto
attraverso i due metodi principali dell'etnografia: l'osservazione diretta e il dialogo con gli
informatori. Naturalmente, anche lo storico (soprattutto nel campo della storia orale) può utilizzare
l'osservazione diretta e il dialogo (ma si dice allora che lo storico usa un metodo etnografico); così
come l'etnologo può (anzi, deve, quando ve ne sia l'occasione) utilizzare dati archivistici, reperti di
cultura materiale, e comunque fonti “cristallizzate” e preesistenti (e si dice in tal caso che usa un
metodo storico). Nondimeno, il nucleo delle rispettive pratiche di ricerca è assai diverso. Il
principale problema dell'etnografo è quello di ricavare dati oggettivamente spendibili da una
esperienza soggettiva di partecipazione culturale: ciò che viene fatto “inscrivendo” (per usare
ancora il linguaggio di Geertz) l'osservazione in diari e note di campo, in liste, diagrammi e altre
forme grafiche, in documenti fotografici e filmici, e fissando il dialogo nel format del questionario o
dell'intervista, della storia di vita, della fonte orale. Questo tipo di fonti sono poi incorporate nel
resoconto etnografico complessivo, rappresentandone il livello di fattualità, di referente empirico.
In altre parole, l'etnografia implica un processo di oggettivazione dell'esperienza del ricercatore in
“dati”, e il fissaggio di questi in “fonti” per mezzo della scrittura o di altre forme di inscrizione; tali
fonti saranno a loro volta incorporate nel più complesso resoconto etnografico. Ma è chiaro come il
processo di oggettivazione e inscrizione coinvolga già a pieno titolo l'autorialità dell'etnografo e le
relative procedure retoriche; cosicché, le fonti non sono abbastanza indipendenti dal testo per
poter funzionare da discrimine tra un resoconto realmente etnografico e uno meramente
finzionale. Beninteso, anche nella storiografia l’indipendenza delle fonti non è cosa banale e
scontata. Lo stesso Topolski fa notare ripetutamente che le fonti storiche hanno la stessa struttura
narrativa del racconto storico (1997: 56, 220). Ciò vale sia per le fonti indirette (testi, discorsi,
raffigurazioni compiute, come una cronaca, un diario, la registrazione di una storia di vita etc.), che
si presentano immediatamente sotto forma di produzioni autoriali; sia per le fonti dirette
(“frammenti del passato che esistono o possono essere osservati direttamente dallo storico”, come
reperti archeologici, prodotti della cultura materiale, oggetti d'arte; ibid .: 53), che per esser
utilizzate nel racconto storico devono esser testualizzate e narrativizzate dal ricercatore. Tuttavia,
nella storiografia sembra possibile mantenere per così dire una separazione fra poteri - il potere
autoriale dello storico e quello delle fonti - che si controllano e si limitano criticamente a vicenda;
laddove l'etnografo tende ad accentrare su di sé questi diversi poteri, esercitando un'autorità che,
proseguendo nella metafora politica, potremmo definire dispotica (anche se, auspicabilmente,
illuminata).
Mi sembra di poter dire che nel sapere storico le dispute fattuali si compongono abbastanza
facilmente in presenza di fonti adeguate: ed è possibile (anche se non troppo frequente) che la
scoperta di nuove fonti, prima sconosciute, risolva definitivamente problemi e dibattiti aperti. Ciò è
consentito da un livello relativamente alto di indipendenza delle fonti, riconosciuto dall'insieme
della comunità scientifica: da qui, ad esempio, lo scandalo suscitato da coloro che rifiutano di
sottomettersi a fonti ampiamente riconosciute dagli altri studiosi - come nel caso del cosiddetto
negazionismo sul tema della Shoah. Qui non è in gioco solo l'interpretazione di un evento storico,
per quanto importante, ma lo statuto stesso della disciplina, nonché la possibilità per gli storici di
sostenere una politica della memoria. In etnografia la situazione è piuttosto diversa. L'etnografo si
fa di solito carico direttamente dell'attendibilità delle fonti: quest'ultima viene a dipendere dalla
credibilità complessiva del resoconto testuale, più che il contrario. Come si esprime Geertz (1990
[1988]: 5), di fronte all'autorità dell'etnografo il lettore si trova nella condizione di prendere o
lasciare. Non a caso, le dispute fattuali sono difficilmente risolvibili con il semplice ricorso a fonti
indipendenti o a nuove “scoperte”: ciò che tali dispute mettono in gioco, come nel caso del famoso
dibattito fra Margaret Mead e Derek Freeman sulle isole Samoa, è l'autorità complessiva
dell'etnografo. In ogni caso, dato il carattere estremamente situato e quasi contingente
dell'esperienza dell'incontro etnografico (in un dato momento e luogo, con certi particolari
informatori etc.), nonché il coinvolgimento soggettivo del ricercatore, la cui presenza fa parte della
realtà da studiare, è praticamente impossibile in etnografia la procedura di controllo tipica del
lavoro storico, che consiste nel ripercorrere puntualmente le stesse fonti utilizzate dagli studiosi
precedenti per valutare la fondatezza empirica delle loro narrazioni. L’etnografo che intenda
compiere un re-study può tentare di vivere esperienze analoghe a quelle del suo predecessore e di
avere accesso a una realtà culturale più o meno simile, cioè allo stesso “oggetto”: ma ciò non
equivarrà mai a ripercorrere puntualmente le fonti originali Si collega a ciò una ulteriore differenza
tra fonti etnografiche e storiografiche, relativa a quel processo che Collingwood chiamava di reenactment. Le fonti, egli sosteneva, giocano nella conoscenza storica un ruolo evocativo oltre che
direttamente informativo, offrendo una sorta di presa diretta esperienziale con il passato: a partire
da esse, lo storico può ricreare il passato nella propria coscienza come complessiva esperienza
vissuta (v. Topolski 1997: 57). Questo concetto, formulato da Collingwood in termini forse troppo
psicologici, è stato tuttavia variamente rielaborato dal pensiero ermeneutico contemporaneo, che
ha sottolineato la capacità delle fonti di aprire scenari immaginativi, di innescare quelle “fusioni di
orizzonti” nelle quali sembra consistere la comprensione storica. Lo storico partirebbe dunque da
“oggetti” inerti, dissepolti dalla polvere del tempo, per ricreare da essi il passato come esperienza
vissuta o come universo in senso fenomenologico. Ora, l'etnografo si trova per certi versi in una
situazione diametralmente opposta: partendo da un'esperienza vissuta, da una condizione di
partecipazione diretta e totale, egli deve produrre dati oggettivi, fonti cristallizzate, oggetti inerti. Si
potrebbe perfino sostenere che parte della sua abilità consiste nello stendere su questi oggetti un
po’ di polvere del tempo, per farli apparire abbastanza “primitivi” e lontani dall'esperienza del
lettore occidentale - se è vero, come ha sostenuto Johannes Fabian (1983), che l’ “allocronia” o
distanziamento temporale dell’altro è una strategia basilare dei moderni studi antropologici.
6. Retorica e teoria.
In questo senso, le fonti sono il prodotto terminale nel processo della scrittura etnografica, più che
una materia prima che esiste indipendentemente da essa e che può servire a demarcarla da una
scrittura puramente finzionale. Dove possiamo cercare allora una soluzione al problema della
demarcazione? Il problema, come ripeto, è: che cosa ci fa riconoscere immediatamente come
non-fiction opere come Argonauti del Pacifico occidentale, The Nuer, Il pensiero selvaggio, Dio
d'acqua, Nisa, Tuhami, per citare titoli rappresentativi di generi, stili e forme di autorità etnografica
le più diversi? Evidentemente, non si tratta solo di fiducia nelle pretese dell’autore di raccontare
una storia vera. Così come non possono esser determinanti gli stratagemmi testuali che gli
etnografi utilizzano (consapevolmente o meno) per convincere il lettore di esser stati davvero sul
campo, di aver conosciuto direttamente e da vicino quella data cultura (ad esempio i riferimenti alle
circostanze del fieldwork, i ringraziamenti iniziali a istituzioni finanziatrici e a informatori locali, le
fotografie che ritraggono il ricercatore in piena osservazione partecipante, magari impegnato a
scrivere sul suo taccuino di appunti). Lo stesso vale per gli “effetti di realtà”, che pure potremmo
attribuire anche ai generi post-realisti (giacché il modernismo, come suggerisce Hayden White,
aspira in fin dei conti a una rappresentazione più profonda e perciò più fedele della realtà; White
1999: 136-7). Ma nessun effetto di realtà ci impedisce di riconoscere un romanzo realista come
romanzo; né lo stratagemma manzoniano del manoscritto ritrovato ci inganna per un attimo sulla
natura finzionale dei Promessi sposi. Cos’altro hanno dunque in comune i testi etnografici sopra
citati? Forse si dovrebbe rovesciare la domanda, chiedendosi che cos’hanno in comune i testi di
fiction. Che cosa ci consente di individuare immediatamente come testi letterari I Promessi Sposi,
Madame Bovary, Cuore di tenebra o Ulysses, e di distinguerli dalla non-fiction? In questo modo,
l’onere della demarcazione verrebbe a poggiare su una teoria del romanzo, definendosi tutta la
non-fiction - come accade nelle librerie inglesi - in modo residuale. Sarebbe anche interessante
studiare i casi ibridi o di confine. Ad esempio prodotti esplicitamente finzionali o fantastici composti
tuttavia secondo i canoni della non-fiction, come certi lavori di Borges o, su un piano
completamente diverso, The Blair Witch Project; e, all’inverso, prodotti che aspirano allo statuto
non solo di “storie vere”, ma anche di documentazione etnografica e storica, pur utilizzando
tecniche compositive romanzesche - A scuola dallo stregone, ad esempio, o quelle produzioni che
vengono talvolta definite “docu-dramma” o “faction” (dalla fusione di fact e fiction), come il film di
Oliver Stone JFK, che negli Stati Uniti ha sollevato un ampio dibattito sulle modalità postmoderne
di rappresentazione degli eventi (White 1999: 118 sgg.).
Continuo però a pensare che l’antropologia culturale non possa sottrarsi al tentativo di capire che
cosa distingue le proprie rappresentazioni da prodotti “puramente” finzionali. Potremmo affrontare
il problema partendo dalle evidenti forzature riscontrabili nei tentativi di applicare meccanicamente
all'etnografia le categorie del realismo letterario. Non essendovi qui lo spazio di discutere in
dettaglio alcuni di questi tentativi, mi limiterò a un punto a mio parere importante. L’analisi testuale
sembra trascurare le peculiarità della struttura compositiva del testo etnografico, che viene forzata
entro la generica nozione letteraria di “trama” (plot ; v. a questo proposito Marcus-Cushman 1982,
ma anche p). Se consideriamo la struttura compositiva come la cornice di senso di un testo, al cui
livello si definiscono i rapporti tra autore, lettore e oggetto o “materia narrativa”, non possiamo non
rilevare una decisiva differenza tra romanzo e resoconto etnografico. Nel primo caso (e non solo
nel romanzo realista) l'autore chiede al lettore l'immediata identificazione con un universo
narrativo. La pratica della lettura si basa essenzialmente su questo patto di identificazione, diciamo
su questa finzione partecipativa che liberamente sottoscriviamo quando apriamo la prima pagina di
un romanzo. L'interfaccia tra autore e lettore assume la forma di un “come se”, che consente di
sospendere la normale attenzione critica alle pretese denotative del discorso, o per meglio dire di
rimodulare l’attenzione in rapporto alle regole di quel particolare universo narrativo. In tale cornice,
ogni effetto di realtà (ivi incluso il flusso di coscienza modernista) serve a rafforzare il gioco della
partecipazione, senza mai sospendere le condizioni del “come se” inizialmente stipulato. Nel testo
etnografico non esiste una cornice di “come se”, né al lettore è richiesto un patto di partecipazione,
o l’uso di regole di valutazione critica del discorso (della sua coerenza, verosimiglianza etc.)
diverse da quelle ordinarie. L’autore stabilisce con il lettore un rapporto di interlocuzione diretta,
che si articola in discorsi descrittivi e argomentativi inscitti in una cornice (esplicita o implicita) di
riferimenti teorici. La “materia narrativa” è assunta come oggetto del dialogo tra autore e lettore,
dunque distanziata da entrambi e investita di valore di verità-falsità. L’effetto “realista” della
conduzione impersonale del discorso e della scomparsa della soggettività autoriale, così spesso
notato (e deplorato) dagli antropologi “testuali”, è solo apparente. L’autore resta sempre presente
nella cornice dell’etnografia: come il lettore sa bene, è sempre lui che parla, o riporta le parole di
altri facendosene in qualche modo garante. Questo, come altri effetti di realtà, giocano dunque
ruoli diversi e per certi aspetti contrapposti all’interno della fiction e della non-fiction: nella prima
rafforzano la partecipazione del lettore all’universo narrativo, nella seconda rafforzano
l’oggettivazione dei contenuti e il loro distanziamento dal qui-e-ora rappresentato dal dialogo
teorico autore-lettore.
Certo, all’interno di un testo etnografico così impostato sono incorporate descrizioni e narrazioni
che fanno uso di espedienti stilistici e retorici tipici della letteratura, che utilizzano dunque le risorse
connotative e figurali del discorso: ma è solo attraverso lo spazio denotativo aperto dalla cornice
teorica che esse acquistano senso per il lettore. (Lo stesso potremmo forse dire per il lavoro dello
storico, nel quale la dimensione narrativa - in apparenza più vicina al plot letterario, è quasi sempre
collocata in coordinate teoriche - segmentazioni periodizzanti del tempo, classificazioni,
generalizzazioni, spiegazioni etc.). Inversamente, quando il discorso teorico e argomentativo
interviene all'interno del romanzo (e può intervenire anche massicciamente), esso resta inscritto
nel patto (consapevolmente fittizio) di identificazione del lettore con la materia narrativa,
nell’originario “come se”. Mi rendo bene conto del carattere esplorativo e un po’ improvvisato di
queste osservazioni, che andrebbero sostanziate sul piano di una teoria della pratica di lettura (v.
p.es. Iser 1975). Un punto mi sembra comunque ineludibile: la necessità di dar conto, all’interno di
un approccio retorico-lettarario alla scrittura etnografica e antropologica, non tanto della presenza
dei fatti, quanto di quella della teoria. Il discorso antropologico si sviluppa attorno a una
dimensione teorico-argomentativa che non può esser facilmente ricondotta a strategie retoriche, e
che è anzi in grado di inglobare queste ultime per le proprie finalità conoscitive e comunicative.