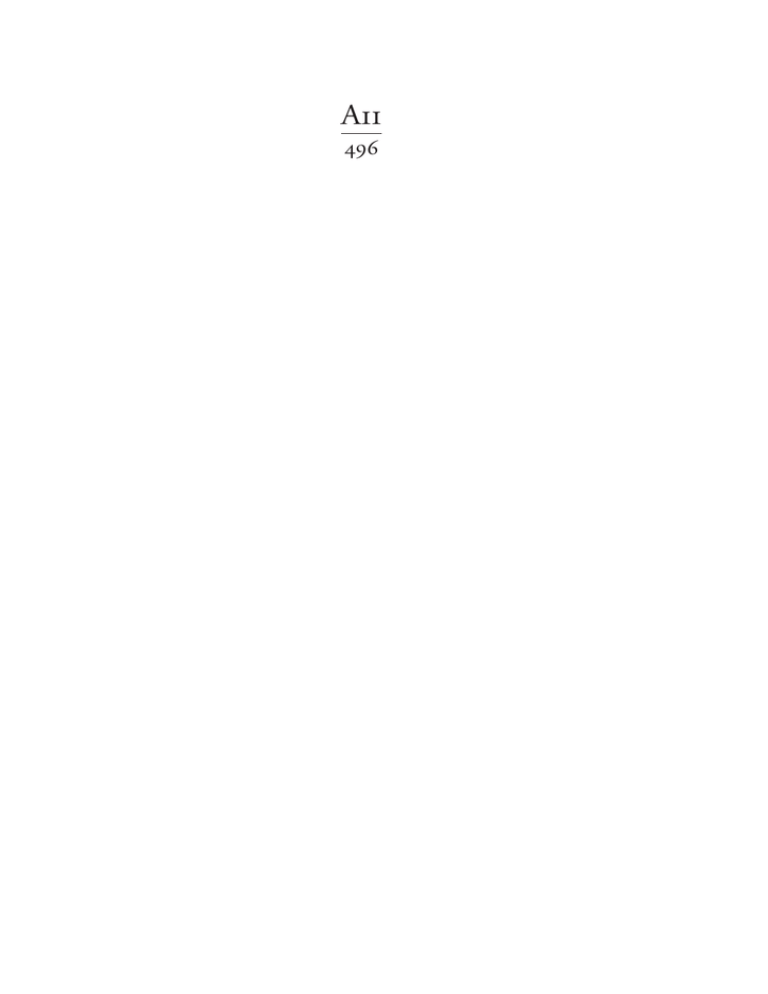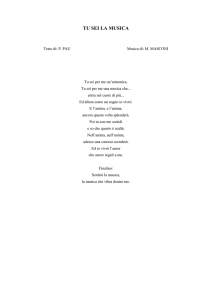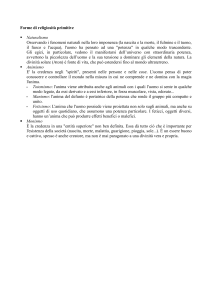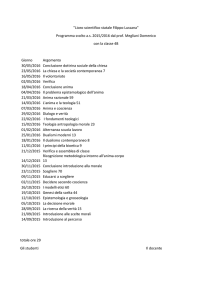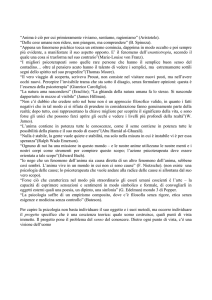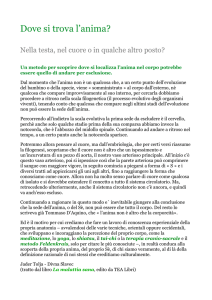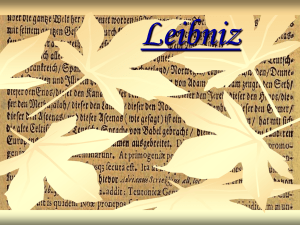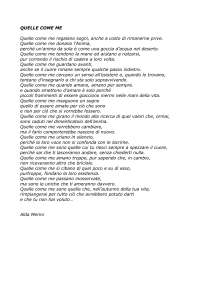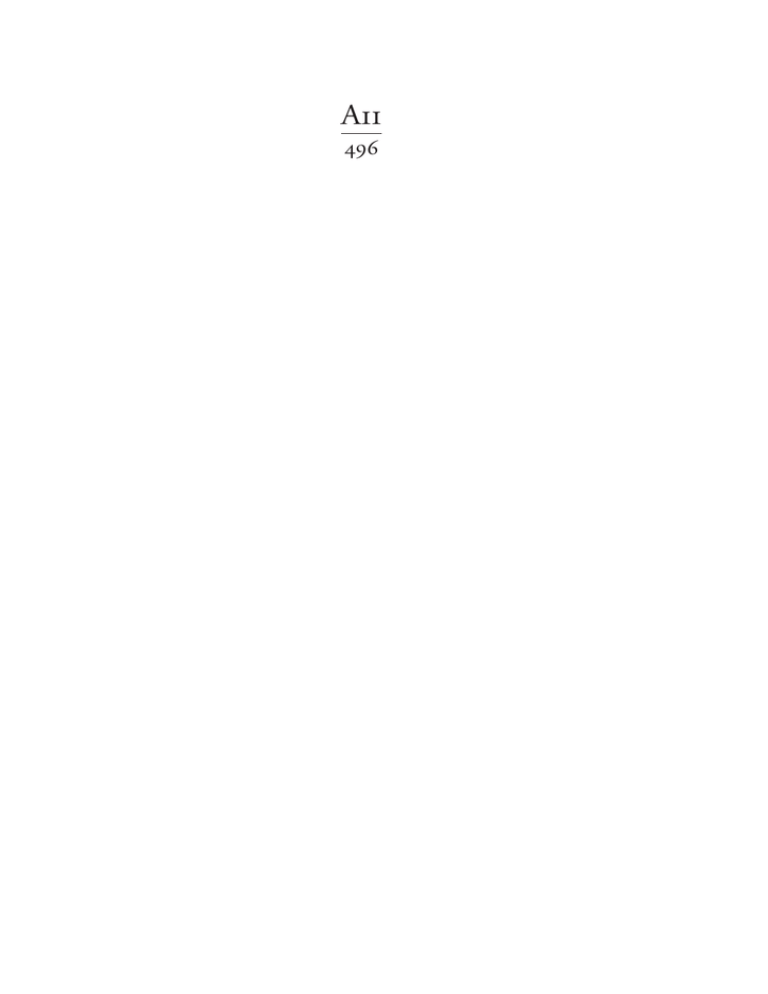
A11
496
Tommaso Ariemma
IMMAGINI
E CORPI
DA DELEUZE A SLOTERDIJK
Copyright © MMX
ARACNE editrice S.r.l.
www.aracneeditrice.it
[email protected]
via Raffaele Garofalo, 133/A–B
00173 Roma
(06) 93781065
ISBN
978–88–548–3098–1
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: febbraio 2010
Indice
9 Introduzione
11 Capitolo I
Iconofagia
1.1. Desidero, dunque siamo, 11 – 1.2. L’essere speciale, 12 – 1.3. Qualcosa di oscuro
nell’anima, 14 – 1.4. Avere o fare l’immagine, 18 – 1.5. Baci e morsi, 20 – 1.6. Il morso
dell’immagine. A partire da Burroughs, 21
23 Capitolo II
Compagnia e circuito delle immagini
2.1. Tesi I: L’immagine porta in superficie il problema filosofico fondamentale, 23 –
2.2. Tesi II: L’immagine “c’è” per un corpo capace di sentire se stesso, 25 – 2.3. Tesi III:
Non c’è “immagine a sé”, “in generale” o “pura”, 27 – 2.4. Tesi IV: Se l’immagine c’è,
c’è anche un circuito di immagini, un circuito iconico, 30
35 Capitolo III
Homo homini imago. Per una critica del farsi spazio
3.1 L’esprimersi dentro, 35 – 3.2. Il farsi spazio e la retorica della nascita, 38 – 3.3.
Nudità e sistema di sguardi, 41
45 Capitolo IV
Simulazione del nudo e civilizzazione video-cristiana
4.1. Singolarità dello strip-tease, 45 – 4.2. Per una decostruzione della nudità seconda,
45 – 4.3. L’immagine del corpo e la nudità seconda, 47 – 4.4. Immunizzazione e nudi-
8
Indice
tà, 48 – 4.5 Baudrillard e la transustanziazione del nudo, 50 – 4.6. Il cristianesimo dietro la simulazione, 51 – 4.7. La civilizzazione video-cristiana, 53 – 4.8. Fare e inventare
la carne, 54 – 4.9. La rivolta del gesto e dell’immagine, 56
59 Capitolo V
Sul contenimento dello sguardo e delle immagini
5.1. Dall’iconofagia al controllo dell’ambiente visivo, 59 – 5.2. Ottiche occidentali, 60
– 5.3. Lacrime e pittura, 65 – 5.4. Polizia estetica, 67
71 Capitolo VI
Lineamenti di termoestetica
6.1. Visualizzazione e climatizzazione. A partire dal design, 71 – 6.2. Il segreto del design, 72 – 6.3. Lo stato gassoso dell’economia, 74 – 6.4. Atmosfera e sensibilità, 76 –
Termoestetica dei media, 78 – Termoestetica dell’arte, 80
85 Appendice
Corpo in frammenti. Il male in pittura da Botticelli a Bacon
95 Nota al testo
97 Bibliografia
Capitolo I
Iconofagia
1.1. Desidero, dunque siamo
«Desiderare – ha scritto Giorgio Agamben – è la cosa più semplice
e umana che sia»1.
Desiderare è certo una cosa semplice, dato che qualsiasi cosa può
innescare il desiderio. Ma perde ogni semplicità se pensiamo al fatto
che il desiderio complica ogni volta ciò che è semplice – l’uno.
Il desiderio, infatti, è sempre un più d’uno, fatto di almeno due cose: un desiderante e un desiderato.
Desidero, dunque siamo.
Potremmo ripensare in questo modo la celebre frase cartesiana cogito ergo sum, penso dunque sono.
Potremmo così violare quella forte credenza nell’individuo, che,
come ha osservato il sociologo Norbert Elias, è mossa dalla convinzione che l’individuo sia «un homo clausus, un piccolo mondo a sé
che esiste indipendentemente dal mondo al suo esterno […] Qualsiasi
altro uomo appare perciò ugualmente un homo clausus; anche il suo
nocciolo – la sua essenza, il suo io effettivo – appare come qualcosa
che al suo interno è separato mediante un muro invisibile da tutto ciò
che sta fuori, e quindi anche da tutti gli altri uomini»2.
1
G. AGAMBEN, Profanazioni, Nottetempo, Roma 2005, p. 57.
N. ELIAS, La civiltà delle buone maniere, trad. it. di G. Panzieri, il Mulino, Bologna
1998, pp. 78-79.
2
12
Capitolo I
Interrogare la natura del desiderio ci permetterà di oltrepassare
questa prima chiusura esistenziale, una chiusura ideologica. Ci permetterà di fare problema della nota opposizione tra interno ed esterno,
ovvero di rispondere alla questione posta da Elias in questi termini:
È forse il corpo il recipiente che ha racchiuso al suo interno l’io effettivo? È
forse la pelle il confine tra «interno» ed «esterno»? Che cosa è il guscio
dell’uomo e che cosa è il nocciolo? L’esperienza dell’«interno» e
dell’«esterno» appare così immediatamente evidente che ben difficilmente ci
si pongono tali quesiti; sembra che non ci sia bisogno di sottoporli a indagine.
Ci si accontenta delle metafore spaziali «interno» ed «esterno», ma non si fa
nessun tentativo per indicare seriamente l’«interno» nello spazio; […] questa
immagine preconcetta dell’homo clausus non soltanto domina la scena in
gran parte della società ma, in misura elevata, anche nelle scienze umane3.
Il nostro punto di partenza sarà una particolare lettura filosofica: la
lettura che Deleuze fa di Leibniz.
Partiremo da Leibniz, perché la sua idea di chiusura dell’anima è
decisamente singolare. Anzi, a rigore (come vedremo), speciale.
La sua concezione, che rafforza la credenza nell’individuo promossa da Cartesio, offre tuttavia il fianco a una singolare decostruzione.
Proprio la concezione estrema della chiusura individuale si rovescia
nel suo opposto, in una singolare apertura.
Partiremo da una lettura suggestiva di Leibniz, una lettura che permette di ripensare meglio tale “speciale” chiusura e con essa la natura
del desiderio. Prima di seguire la lettura di Deleuze, attraverso un vero
e proprio pedinamento teorico, sarà opportuno esplicitare ciò che debba intendersi, in questo caso, per “speciale”.
1.2. L’essere speciale
Oggi si intende, per “essere speciale”, qualcosa di esclusivo, di unico, di solo.
Ripensare il senso dell’essere speciale è di fondamentale importanza per vedere quanto, in realtà, ciò che si intende oggi per speciale sia
3
Ivi, p. 79.
Iconofagia
13
un vero e proprio impoverimento della sua complessità, del suo senso
originario.
Non c’è essere speciale senza un più d’uno e soprattutto non si dà
essere speciale senza immagini. È la filosofia medioevale a indicarci
un tale senso dell’essere speciale4. Specie è il termine usato dalla filosofia medievale per indicare soprattutto l’immagine, il darsi delle cose
alla conoscenza che le riceve, e che pertanto diviene speciale.
Come è stato opportunamente osservato:
L’essere speciale è assolutamente insostanziale. Esso non ha luogo proprio,
ma accade a un soggetto, ed è in esso come un habitus o un modo d’essere,
come l’immagine è nello specchio. […] I medievali chiamavano la specie intentio, intenzione. Il termine nomina la tensione interna (intus tensio) di ogni
essere, che lo spinge a farsi immagine, a comunicarsi5.
Nell’anima non vi sono cose, ma immagini, specie di cose6.
L’anima, nell’accogliere tali specie, si comporta come uno specchio,
lo “speciale” per eccellenza.
È, infatti, per i filosofi medioevali lo specchio a fornire il modello e
il paradigma attraverso il quale poter definire cosa accade all’anima
quando conosce.
Speciale è ciò che si riferisce alla specie, alla “conoscibilità” delle
cose, ovvero alle immagini. Speciale è, dunque, ciò che dipende dalle
immagini, ciò che riflette, ciò che le riflette, facendo figura.
Dobbiamo attendere proprio Leibniz per una originale ripresa della
natura riflessiva, cioè speciale, dell’anima.
Per Leibniz l’anima è una monade, ed è chiusa, senza porte né finestre: tuttavia essa possiede una natura speculare (cfr. Principi razionali della natura e della grazia). È uno specchio che riflette il mondo intero da un determinato punto di vista.
Si comincia già ad intuire quanto la chiusura dell’anima, così come
è intesa da Leibniz, possa rivelarsi una singolare apertura. Come uno
4
Cfr. E. COCCIA, La trasparenza delle immagini. Averroè e l’averroismo, Bruno Mondadori, Milano 2005.
5
G. AGAMBEN, Profanazioni, cit., pp. 61-62.
6
Cfr. Ivi, p. 61.
14
Capitolo I
specchio, essa non ha porte né altre aperture, perché è tutta aperta, nella sua riflessione, speciale.
Ne La piega. Leibniz e il Barocco, Deleuze legge la chiusura della
monade come una singolare apertura verso il mondo.
Più che un semplice specchio, l’anima è una camera oscura (costituita da una serie di specchi)7. Oltre alla riflessione, c’è l’oscurità. C’è
qualcosa di oscuro nell’anima.
1.3. Qualcosa di oscuro nell’anima
Suggestive quanto complesse sono le pagine che Deleuze dedica a
Leibniz nel suo testo La piega, così intricate e dense da rendere quasi
irriconoscibile la sua filosofia. Tuttavia diversi interventi che Deleuze
opera sul corpo degli scritti leibniziani sono ancora per noi preziosi
per avvicinarci ancora meglio a quanto di oscuro vi è nell’anima e alla
sua natura speciale. Di particolare interesse ci sembra la deduzione
morale che Deleuze rintraccia nell’esigenza, per Leibniz, che l’anima
abbia un corpo. Io devo avere un corpo perché c’è qualcosa di oscuro
in me: è questo per Deleuze il primo argomento circa la deduzione
morale:
Io devo avere un corpo: è una necessità morale, un’«esigenza». E, per prima
cosa, devo avere un corpo perché c’è qualcosa di oscuro in me. Già questo
primo argomento mostra la grande originalità di Leibniz. Egli non dice che
solo il corpo spiega quanto c’è d’oscuro nello spirito. Al contrario, lo spirito
è oscuro, il fondo dello spirito è scuro, ed è proprio questa natura scura che
spiega ed esige il corpo. […] Non c’è dell’oscuro in noi perché abbiamo un
corpo, ma noi dobbiamo avere un corpo perché c’è dell’oscuro in noi:
all’induzione fisica cartesiana, Leibniz sostituisce una deduzione morale del
corpo8.
Tuttavia ci pare che, nel momento in cui viene individuata, la deduzione morale venga subito abbandonata per una causalità inversa:
7
Cfr. G. DELEUZE, La piega. Leibniz e il barocco, a cura di D. Tarizzo, Einaudi, Torino
2004, p. 139.
8
Ivi, p. 139.
Iconofagia
15
l’anima oscura spiega il corpo, non il contrario9. Dov’è la moralità del
corpo? Perché è bene, è giusto, è meglio avere un corpo?
Qui “bene” è inteso nel senso di ciò che si ha, del proprio avere. E
per avere qualsiasi cosa io devo avere prima un corpo. È un esigenza
morale, in vista di qualsivoglia bene.
Deleuze non ci pare porre in questi termini la questione, optando
per un discorso causale, senza che intervenga il minimo discorso sulla
bontà dell’avere un corpo.
In fondo, Deleuze non può avanzare una deduzione morale perché
aggira il problema dell’appetitus in Leibniz.
È curioso: una monografia su Leibniz, in cui, in maniera puntuale e
precisa, ogni concetto viene descritto e quasi riscritto, la parola “appetito”, concetto fondamentale in Leibniz, vi compare una sola volta,
all’interno di una sola proposizione, velocissima10.
Da buoni investigatori, ormai sulle tracce di qualcosa che sembra
mancare, che sembra mancato, si è certi di essere sul luogo in cui si è
consumata più di una omissione. Nella pagina (dell’edizione italiana)
in cui accenna all’appetito, Deleuze fa un rapido riferimento alla fame,
ma il modo in cui questa viene introdotta nel testo non solo la separa
dall’appetito, ma fa apparire la fame un mero esempio. Scrive Deleuze:
Per quanto brusca sia la bastonata al cane che mangia, questi avrà comunque
avuto tante piccole percezioni del mio arrivo furtivo, del mio odore ostile,
dell’alzarsi del bastone – tutte percezioni soggiacenti alla conversione del
piacere in dolore. In che modo la fame potrebbe seguire la sazietà se tante
piccole fami elementari (di sali, di zuccheri, di grassi, ecc.) non insorgessero
a ritmi alternati e avvertiti?11
Ci sembra pertanto opportuno recuperare ciò che in questa pagina è
stato espunto, rintracciandolo nei corsi preparatori a La piega che Deleuze ha dedicato a Leibniz. Come afferma nella seduta del
29/04/1980:
9
Cfr. ivi, p. 140.
Ivi, p. 142.
11
Ibidem.
10
16
Capitolo I
[…] secondo Leibniz, l’anima ha due facoltà fondamentali: l’appercezione
cosciente che è composta da piccole percezioni incoscienti, e ciò che chiama
l’appetizione, l’appetito, il desiderio. E noi saremmo fatti di desiderio e di
percezioni. Ora, l’appetizione è l’appetito cosciente. Se le percezioni globali
sono fatte di un’infinità di piccole percezioni, le appetizioni o grossi appetiti
sono fatti di un’infinità di piccole appetizioni. Come potete vedere le appetizioni sono i vettori corrispondenti delle piccole percezioni, diventa un inconscio molto strano. La goccia del mare alla quale corrisponde la goccia
d’acqua, alla quale corrisponde una piccola appetizione presso colui che ha
sete. E quando io dico: “Oddio, ho sete, ho sete”, che cosa faccio? Esprimo
grossolanamente un risultato globale delle mille e mille piccole percezioni
che mi attraversano, e delle mille e mille appetizioni che mi attraversano. Che
cosa vuol dire? All’inizio del ventesimo secolo, un grande biologo spagnolo
caduto nell’oblio, si chiamava Turrò, fece un libro col titolo in francese: “Les
origines de la connaissance” (1914 – L e origini della conoscenza) ed è un
libro straordinario. Turrò affermava che quando diciamo “io ho fame” – aveva una formazione puramente biologica –, e ci diciamo che è Leibniz che si è
svegliato, è un vero risultato globale, ciò che egli chiama una sensazione globale. Impiega i suoi concetti: la fame globale e le piccole fami specifiche. Dice che la fame come fenomeno globale è un effetto statistico. Di cosa è composta la fame come sostanza globale? Di mille piccole fami: fame di sali, fame di sostanze proteiche, fame di grassi, fame di sali minerali, ecc… Quando
dico “io ho fame”, io faccio alla lettera, dice Turrò, l’integrale o
l’integrazione di queste mille piccole fami specifiche. Le piccole differenziali
sono le differenziali della percezione cosciente, la percezione cosciente è
l’integrazione delle piccole percezioni. Molto bene. Vedete bene che le mille
piccole appetizioni sono le mille fami specifiche. E Turrò continua, perché
c’è tuttavia qualcosa di strano a livello animale: come fa l’animale a sapere di
cosa ha bisogno? L’animale vede delle qualità sensibili, ci si getta sopra e le
mangia, tutti mangiamo delle qualità sensibili. La mucca mangia del verde.
Essa non mangia dell’erba, e tuttavia non mangia un verde qualsiasi poiché
riconosce il verde dell’erba e non mangia soltanto il verde dell’erba. Il carnivoro non mangia delle proteine, mangia la cosa che ha visto, non vede delle
proteine. Il problema dell’istinto, al livello più semplice, è: come si spiega il
fatto che le bestie mangiano pressappoco ciò che gli conviene? In effetti, le
bestie per il loro pasto mangiano la quantità di grassi, la quantità di sale, la
quantità di proteine necessaria all’equilibrio del loro “ambiente” interiore. E
il loro ambiente interiore che cos’è? L’ambiente interiore è il luogo di tutte le
piccole percezioni e le piccole appetizioni12.
12
Lezione del 29/04/1980, disponibile su www.webdeleuze.com (traduzione lievemente
modificata)
Iconofagia
17
Il lungo brano riportato pone, rispetto al passo de La piega, diversi
problemi: in primo luogo, Deleuze collega, come fa Leibniz,
l’appetizione al desiderio.
Ribadisce, seguendo Leibniz e coerentemente con tutta la sua filosofia, che noi siamo fatti di percezioni e di desiderio, desiderio che investe le percezioni e le coordina13.
Ne La piega scompare ogni riferimento al desiderio, e, come abbiamo già detto, non dedica all’appetizione che un solo rigo. Nel brano
della sua lezione, inoltre, collega l’appetizione alla fame, esplicitamente. E fa un importante riferimento al biologo spagnolo Turrò, che
scompare nel testo dedicato a Leibniz.
Traccia di quanto il riferimento alla fame e alla nutrizione sia comunque implicito e decisivo nell’espressione dell’anima, è il sottolineare di Deleuze, ne La piega, «il brulichio digestivo delle piccole percezioni»14.
L’anima ha appetiti, cioè delle inquietudini.
Ha la necessità di passare da una piccola percezione all’altra – in
questo consiste l’appetizione – ma sopratutto, e qui fa il suo ingresso
il corpo, queste piccole percezioni devono essere trattenute, assorbite,
tenute insieme, nel movimento dell’appetizione.
L’anima fa l’integrale (dice Deleuze seguendo Turrò) di queste
piccole appetizioni che il corpo sembra soddisfare. Il corpo è buono,
la sua esistenza è buona, perché è capace di soddisfare e sviluppare gli
appetiti, i desideri, dell’anima.
Essi non si chiariscono che mediante il corpo, poiché attraverso il
corpo l’anima si rappresenta il mondo: «così si conoscono i satelliti di
Saturno e di Giove solo per il movimento che si fa nei nostri occhi»,
scrive Leibniz ad Arnauld15.
Un’anima senza corpo sarebbe un’anima incapace di avere appetiti
e dei desideri nitidi e distinti.
Desidero quella donna, perché il corpo ha permesso che la sua immagine mi si chiarisse nel fondo oscuro dell’anima, assorbendo odori,
rilasci ormonali, percorrendo con gli occhi le sue forme, toccandole.
13
Ibidem
G. DELEUZE, La piega, cit., p. 151.
15
Cfr. R. FABBRICHESI LEO, Leibniz: monade e armonia, Cuem, Milano 1998.
14
18
Capitolo I
Il risultato di questo pasto oscuro è il tingersi progressivo
nell’anima di un’immagine. Deleuze dice che l’anima leibniziana è
tappezzata di dipinti trompe-l’oeil e nello stesso tempo che è fatta come una camera oscura16. Allora, quando si tratterà di sviluppare la
proposizione “io devo avere un corpo, perché c’è qualcosa di oscuro
in me”, secondo una deduzione morale, bisognerà affermare che vi è
un’esigenza morale del corpo nella stessa misura in cui davanti a una
tela vi è l’esigenza morale del pittore: è sempre un corpo che rende
possibili le immagini.
1.4. Avere o fare l’immagine
L’oscurità dell’anima ha aperto la strada, implicitamente, seguendo
il non detto di Deleuze, a una esigenza morale dell’immagine.
Tuttavia, in relazione al problema della sua realtà, l’esigenza
dell’immagine diviene subito un problema complesso.
Pur necessitando di tutte le piccole percezioni e di tutte le piccole
appetizioni, essa non è la somma di queste, ma una sorta d’insieme,
ovvero qualcosa di più di un semplice composto.
Non essendo raggiunta per l’associazione atomistica di tutti i piccoli elementi consumati attraverso il corpo, si direbbe che a fare
l’immagine sia stata l’anima.
Una soluzione di comodo, questa. Semplificante e degna del romanticismo più sfrenato.
In verità, è assai difficile sapere se l’anima abbia fatto l’immagine
o abbia colto anch’essa attraverso il corpo. L’immagine le è venuta,
potremmo dire, esprimendo con questa proposizione, dal senso ambiguo, l’indecidibilità tra l’avere e il fare.
Tale ambiguità permea già il De anima (III, 3) di Aristotele, fino al
celebre dilemma di Samuel Beckett che conclude le due versioni di un
suo celebre testo (la cui seconda versione non a caso intitolata
L’image ) ora con l’espressione c’est fait j’ai fait l’image (è fatta ho
16
Ibidem, p. 46.
Iconofagia
19
fatto l’immagine), ora con c’est fait j’ai eu l’image (è fatta ho avuto
l’immagine)17.
Ad un’analisi genetica, però, l’indecidibilità pare sbilanciarsi dal
lato dell’avere, perché non vi è desiderio o appetito, ciò che farebbe
l’immagine nell’anima, senza a sua volta un’immagine che lo investa.
Ciò che chiamiamo immaginazione esprimerebbe proprio
l’inquietudine dell’anima che oscilla tra l’avere e il fare l’immagine,
ovvero tra un’immagine interna e un’immagine esterna.
Parafrasando Aristotele, non vi è desiderio privo dell’immagine che
lo renda possibile.
Nella sua monografia su Bacon, Deleuze accenna a qualcosa di
singolare che accade al pittore, ovvero al fatto che egli non trova mai
dinanzi a sé una tela bianca:
È un errore credere che il pittore si trovi dinanzi a una superficie bianca.
All’origine della credenza nella figurazione c’è questo errore: se infatti il pittore fosse dinanzi a una superficie bianca, potrebbe riprodurvi un oggetto esterno, che quindi fungerebbe da modello. Ma non è così. Il pittore ha molte
cose nella testa, intorno a sé o nell’atelier18.
A questo punto, chiamiamo iconofagia il processo attraverso il quale, mediante il corpo, non solo assumiamo in modo oscuro dati sensibili, ma altrettante immagini.
Come ha sottolineato Deleuze in Logica del senso19, il corpo non fa
che mangiare, ma c’è un momento, una sorta di beatitudine, in cui il
corpo perde la sua profondità e raggiunge la superficie, fino a mangiare ciò che si direbbe incommestibile.
In questo caso, proprio l’immagine.
17
Cfr. B. CLÉMENT, Avere o fare l’immagine?, in AA. VV., Ai limiti dell’immagine, Quodlibet, Macerata 2005, pp. 150-159.
18
G. DELEUZE, Francis Bacon. Logica della sensazione, trad. it. di S. Verdicchio, Quodlibet, Macerata 1995, p. 157.
19
Cfr. G. DELEUZE, Logica del senso, trad. it. di S. De Michelis, Feltrinelli, Milano 2005,
p. 165.
20
Capitolo I
1.5. Baci e morsi
Si può obiettare che ciò che qui si sta avanzando sia un consumo
simbolico, che tutto ciò che abbiamo detto è metaforico.
Invece, non si sta parlando di un falso consumo, ma del consumo
reale del simbolico, cioè dell’immagine. Senza questo consumo, senza
la dinamica dell’iconofagia, non si potrebbe parlare, come oggi si fa,
di un consumo delle immagini20.
È il consumo a cui siamo condannati, il consumo a cui anche
l’anoressica, che sembra non mangiar nulla, non può sottrarsi.
C’è un consumo reale dell’immagine, nei confronti della quale si
può provare nausea, piacere, ossessione.
La fame dell’immagine, lungi dunque dall’essere qualcosa di metaforico, investe aspetti fondamentali della nostra esistenza. Come quello dell’amore, dove non si può non cibarsi di immagini.
«Quanto ho detto della fame si può facilmente estendere al bisogno
d’amore»21: sono parole di Valéry, mentre tenta il paragone classico,
ma mai opportunamente tematizzato, tra il mangiare e l’amare.
Si ha un bel paragonare il desiderio, come fa Sartre22, a un divorare
l’altro, senza notare che esso è realmente un cibarsi dell’altro,
dell’altro in effigie, ovvero in quella virtualità irriducibile, di cui pure
si costituisce l’esperienza del mondo.
In uno dei suo ultimi racconti, Italo Calvino, forse perché agisce
già nella sfera dell’immaginazione, sembra prendere sul serio questo
consumo (del) simbolico, proprio a proposito dell’esperienza amorosa:
Sotto la pergola di paglia d’un ristorante in riva a un fiume, dove Olivia mi
aveva atteso, i nostri denti presero a muoversi lentamente con pari ritmo e i
nostri sguardi si fissarono l’uno nell’altro con intensità di serpenti. Serpenti
immedesimati nello spasimo di inghiottirci a vicenda, coscienti d’essere a nostra volta inghiottiti dal serpente che tutti ci digerisce e assimila incessante-
20
Cfr. F. C ARMAGNOLA, Il consumo delle immagini. Estetica e beni simbolici nella fiction
economy, Bruno Mondadori, Milano 2006.
21
P. VALÉRY, Scritti sull’arte, trad. it. di V. Lamarque, Guanda, Milano 1984, p. 155.
22
Cfr. J. -P. SARTRE, L’essere e il nulla, trad. it. di G. del Bo, Il saggiatore, Milano 1997,
p. 450.
Iconofagia
21
mente nel processo di ingestione e digestione del cannibalismo universale che
impronta di sé ogni rapporto amoroso e annulla i confini tra i nostri corpi23.
Ma è nella Pentesilea di Kleist che il nodo mangiare/amare viene a
esplicarsi per via negativa: Pentesilea, l’amazzone protagonista
dell’opera, che uccide, sbranandolo, Achille, confonde il consumo
dell’immagine dell’amato con il consumo del suo corpo organico. In
questo consiste la sua follia: nell’aver scambiato la presenza corporea
con la realtà dell’immagine. È ciò che si evince dal suo famoso monologo:
Amore, orrore [letteralmente: baci, morsi] fa rima, e chi ama di cuore può
scambiare l’uno con l’altro. […] Quante, attaccate al collo dell’amante, ripetono di continuo queste parole: che l’amano, oh, l’amano così tanto, che per
amore potrebbero anche mangiarlo24.
1.6. Il morso dell’immagine. A partire da Burroughs
Non vi è distinzione reale tra il consumo dell’immagine, ovvero il
consumo spettrale, e il consumo fisiologico, ma distinzione modale:
l’assunzione dell’immagine non passerebbe semplicemente per la
bocca o per i sensi, intesi organicisticamente.
Non passerebbe neanche in modo esclusivo per la visione, perché,
come nota Aristotele (cfr. De anima 424 a5-20), c’è immagine anche
ad occhi chiusi: la visione non le è essenziale. A far precipitare il consumo dell’immagine nel metaforico è certo la centralità data alla bocca, al consumo orale. Ma, come giustamente fa notare Derrida:
L’introiezione o l’incorporazione dell’altro, si sa, ha tante risorse, riusi e
sotterfugi… Essa può inventare tanti orifizi, al di là di quelli di cui si crede di
disporre naturalmente, come per esempio la bocca25.
23
I. CALVINO, Sotto il sole giaguaro, Mondadori, Milano 1995, pp. 47-48.
H. KLEIST, Pentesilea, trad. it. di E. Filippini, Einaudi, Torino 1989, pp. 89-90.
25
J. DERRIDA, Retorica della droga, trad. it di C. Verbaro, Teoria, Roma-Napoli 1993,
p. 42.
24
22
Capitolo I
È stato lo scrittore William S. Burroughs a svincolarsi da questo
primato, soprattutto nella sua opera più celebre, non a caso intitolata
Naked Lunch – Pasto Nudo, parlando di organi che diventano bocche,
a cominciare dalla pelle, dagli occhi. Scrive: «Nel posto dove regna il
buio assoluto la bocca e gli occhi sono un organo solo che balza avanti
per mordere con denti trasparenti…»26.
Nella sua spietata analisi del corpo del drogato, egli non manca di
parlare di una fame di immagini, più accentuata nel suo corpo27.
Un corpo, quello narrato da Burroughs, intrinsecamente famelico,
del quale non manca di elaborare un’algebra del Bisogno e del Nutrimento, svincolata da ogni riduzione organicistica e che, ovviamente,
permette di pensare la distinzione modale del consumo dell’immagine.
Tale distinzione prevede, inoltre, la non assimilazione dell’immagine rispetto agli altri cibi.
Il consumo dell’immagine sarebbe il consumo di ciò che, anche se
introiettato, resterebbe indigeribile. Resterebbe, semplicemente.
Rientrerebbe nella sfera di ciò che Derrida ha chiamato il morso, o
il boccone28, come qualcosa che, benché mangiato, resta nella bocca, e
il suo consumo sarebbe l’impossibile consumo dell’eterogeneo, un
consumo non assimilante.
Piuttosto, un consumo costituente, un consumo che non mira al
mantenimento di un sé, ma precisamente a introdurre dell’altro in sé,
secondo un’estensione non omogenea dell’anima.
L’anima non può, dunque, far a meno dell’immagine che arriva a
popolare il suo fondo oscuro. L’immagine e l’anima si accompagnano.
È giunto il momento di dedicare a tale compagnia almeno qualche
tesi.
26
27
W. S. BURROUGHS, Pasto nudo, trad. it. di F. Camagnoli, Adelphi, Milano 2005, p. 33.
Cfr. W. S. BURROUGHS, Checca, trad. it. di K. Bagnoli, Adelphi, Milano 1998, Prefa-
zione.
28
Cfr. J. DERRIDA, La verità in pittura, trad. it. di G. Pozzi, Newton-Compton, Roma
2005, p. 194.