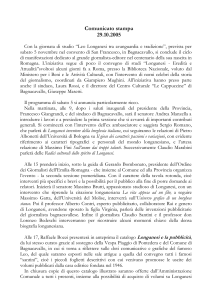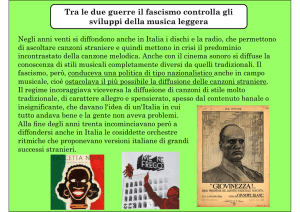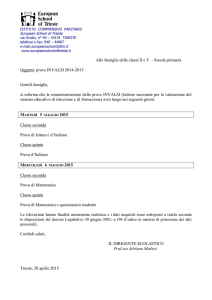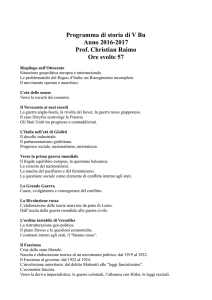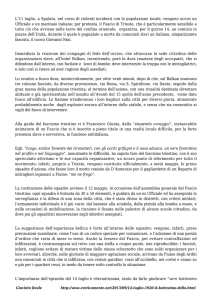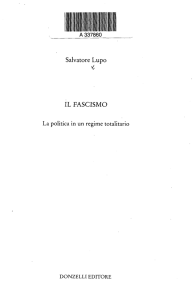Leo Longanesi, il borghese conservatore
Leo Longanesi, il borghese conservatoredi Francesco Giubilei del 20/06/2016
Scrivere un libro su Leo Longanesi senza essere influenzati dalla biografia che Indro
Montanelli e Marcello Staglieno gli dedicarono nel 1984, oltre che una carenza bibliografica,
costituirebbe una grave mancanza nella comprensione del personaggio. Appurato il valore
del libro di Montanelli e Staglieno e costatata la presenza di altri testi dedicati alla figura di
Longanesi, è lecito domandarsi l’utilità di un’altra biografia sull’intellettuale romagnolo.
Le motivazioni sono molteplici: anzitutto il libro di Montanelli e Staglieno, uscito negli anni
’80, è fuori commercio e difficilmente reperibile (al di là delle biblioteche), in secondo luogo
per dire una banalità – che in realtà non è tale – non si finisce mai di scrivere e raccontare la
vita dei grandi uomini.
Una terza motivazione è la coltre di silenzio calata negli ultimi anni sulla vita e sulle opere di
Longanesi, un destino comune ai personaggi scomodi e difficilmente etichettabili. Sintetizzare
la sua figura con una definizione è complesso: controcorrente, irriverente, conservatore
scomodo
(come lo definì Andrea Ungari nel titolo del suo libro).
Chiamarlo “fascista” sarebbe invece errato (eppure fu lui a coniare il celebre motto
“Mussolini ha sempre ragione”), allo stesso modo l’etichetta di antifascista non gli si
addiceva. Fu un borghese e allo stesso tempo critico e fustigatore dei vizi della borghesia
italiana, un personaggio scomodo ma dotato di un intuito giornalistico, un humour, una
raffinatezza d’intelletto che difficilmente nella storia culturale italiana si sono riscontrati in
altre personalità.
Lo stesso Longanesi era conscio di questa sua incollocabilità: “lo storico che fra cent’anni
scriverà la storia di questo straordinario ‘Italiano’, se pure in quel tempo userà ancora
dedicarsi a una simile professione, dovrà essere un bel tipo. Solo un matto potrebbe
intraprendere un tale lavoro; ma vedrete che il matto si troverà”
Mitizzò l’Ottocento consapevole che il mondo che rimpiangeva non era mai esistito, o meglio
non era esistito come l’immaginava lui: “gli serviva, quel mondo, come contrappunto alla
volgarità del mondo moderno con cui non si riconciliò mai. Longanesi detestava la volgarità”.
Longanesi si oppose per tutta la vita alle tentazioni della modernità consapevole che ogni
cosa scade lasciando spazio alla moda successiva, destinata anch’essa, dopo qualche tempo,
a essere sostituita:
“il moderno invecchia e il vecchio torna di moda”.
L’uomo e l’intellettuale spesso non coincidono: grandi giornalisti si sono dimostrati piccoli
uomini, non sempre le qualità professionali si equivalgono con le doti umane.
Nella biografia di Montanelli e Staglieno emerge un Longanesi sicuro di sè, a tratti spavaldo
e, in alcune occasioni, addirittura violento o con esternazioni irriguardose (come nel caso
Gobetti e Matteotti) durante il periodo fascista.
In apparenza una persona diventa da quella del dopoguerra, delusa, disillusa e forse senza
più stimoli. Non credo tuttavia nella descrizione fatta da Massimo Fini in un articolo
pubblicato sul suo sito dal titolo emblematico “I due volti di Longanesi”, in cui contrappone
un Longanesi “vincitore” durante il fascismo a un Longanesi “sconfitto” nel dopoguerra.
Prendendo spunto da alcuni episodi raccontati nella bibliografia di Staglieno e Montanelli,
Massimo Fini scrive: “il Longanesi vincitore era molto diverso da quello sconfitto, era becero,
violento, sopraffattore, sicuro di sè, opportunista, spietato con gli altri ma non con se stesso,
e volgare” e rincara la dose citando la spedizione punitiva contro Toscanini o le
raccomandazioni per fare pubblicare un libro a Camillo Pellizzi.
In realtà si tratta di una visione parziale del carattere di Longanesi e, se certi suoi
comportamenti ed esternazioni sono senz’altro da condannare, vi sono alcune attenuanti per
i gesti di Leo.
Nonostante Fini nel suo articolo scriva: “Si dirà che allora Longanesi aveva poco più di venti
anni, ma (…) solo in questa epoca di giovanilismo si è affermato, chissà perchè, il principio
che a quell’età uno non è responsabile di quello che fa” la giovane età è sicuramente una
attenuante.
Inoltre non dimentichiamo di contestualizzare comportamenti di Longanesi nel periodo
storico in cui sono avvenuti. Se il suggerimento a Pellizzi di dedicare un libro ad Arpinati per
accrescere la possibilità di pubblicazione non è un gesto di grande valore etico, si inserisce in
un contesto storico dove simili azioni erano la prassi. Così come la promessa allo stesso
Pellizzi si scrivere un articolo critico su L’Italiano contro l’editore Bemporad – suggerendo tra
le righe “di pubblicarti il libro sotto la penna di grossi guai” – appare, purtroppo non norma
conservata anche nella editoria contemporanea: figuriamoci al tempo.
Chi era quindi in realtà Leo Longanesi? Un intellettuale che approfittava della sua posizione
privilegiata durante il fascismo e caduto in disgrazia dopo la fine del regime, oppure un
editore, un giornalista, scrittore, pittore anticonformista e difficilmente etichettabile in
qualsiasi epoca? Accusarlo di aver aderito in modo totale al fascismo sarebbe una falsità;
basti pensare alla decisione del regime di far cessare, dopo soli due anni di attività, le
pubblicazioni Omnibus. La sua adesione fu a tratti opportunistica, certamente atipica, legata
più al fascismo che la figura di Mussolini, anch’egli romagnolo, esercitava su di lui che a reali
convinzioni.
Il figlio di Leo, Paolo Longanesi, in uno scritto intitolato “Longanesi, un antidoto contro la
mediocrità”, colse la difficoltà di ricordare la personalità di Longanesi spiegando come,
essendo Leo morto quando lui era ancora bambino, le persone che lo avevano conosciuto in
vita “andavano fornendo a me e agli altri nulla più che i vividi ricordi adatti solo a regalare
Leo Longanesi nel ruolo di personaggio. Sfuggiva sempre, dalle loro descrizioni, la
dimensione della persona.
La migliore eredità di Longanesi e l’unico modo che ci rimane per comprenderlo realmente, è
la sua opera che si articola in varie discipline: dalla scrittura all’editoria, dalla pittura al
giornalismo poiché, come annota giustamente il figlio Paolo, “il nostro tempo non ci consente
di avere sotto mano molti altri esempi come il suo, essenziale nella qualità e abbondante
nella quantità”.
La grandezza di Leo consisteva nel suo essere poliedrico, difficilmente incasellabile, sempre
con la battuta pronta. Sapeva trasmettere le proprie idee e pensieri attraverso un linguaggio
che lo caratterizzava in modo inconfondibile: “Longanesi detesta gli articoli lunghi, usa gli
aforismi, le finestre, cambia i caratteri a secondo degli autori, cerca gli autori in funzione dei
caratteri tipografici che preferisce”[7]. Nel suo giornalismo univa il linguaggio politico a
quello letterario conquistandosi un proprio pubblico attraverso “volute sovrapposizioni e
ricercate in-comprensioni”.
(…)
Leo Longanesi fu un fustigatore dei vizi del bel paese, lo fece con grande ironia ma anche
nello stile schietto e diretto che gli apparteneva provenendo da una terra dove la concretezza
veniva prima di tutto: “se vogliamo trarre un utile dalla lezione di questo uomo, dobbiamo
rassegnarci a riconoscere i nostri difetti che egli vide e descrisse circa mezzo secolo fa senza
però mai essere un inquisitore. Superato questo scoglio avremo l’occasione di mettere le
mani sull’eredità che Longanesi ci ha lasciato”.
Dal ’45 in avanti Leo comprese che il suo lavoro difficilmente sarebbe stato compreso dalla
maggioranza degli italiani, eppure le sue pubblicazioni e riviste raggiungevano un grande
pubblico ottenendo successo e ottimi riscontri.
“I nostri ammiratori, Dio mio, meglio non conoscerli” scriveva in La mia signora e aggiungeva
“superficiali sì, ma di buona famiglia”.
Un personaggio con posizioni politicamente scorrette come Longanesi, non poteva che non
essere compreso dalla società del tempo. Appoggiò idee scomode, spesso perdenti, mai
legate al sentire e all’opinione comune. Tuttavia non condivido l’analisi di Marco Vallora in La
patria col bagno: “riuscire a comprendere come un’intelligenza tanto folgorante e in fondo
anticonformista, una genialità così moderna e sulfurea, sia poi stata messa al servizio non
diciamo delle cause perse, che sarebbe anche encomiabile e simpatico, ma di idee stantie e
grevi, odorose di scadente tabacco e di scottante cialtronaggine”. Longanesi scelse sempre la
strada più difficile; frondista e castigatore dei vizi del regime – così come lo sarà, per tutta la
vita, dei vizi degli italiani – e nostalgico di un fascismo che aveva ripensato nella sua mente,
non riuscì mai a integrarsi appieno nel tempo in cui viveva.
Di tutte le sue decisioni, quella che stupisce di più un osservatore esterno, fu la scelta
nostalgica nel dopoguerra. In fin dei conti Mussolini gli aveva fatto chiudere Omnibus, un
episodio di tale gravità da poter essere facilmente utilizzato per cercare di riabilitarsi come
oppositore del fascismo nel dopoguerra. Così avevano fatto molti intellettuali legati al regime
tanto quanto Longanesi che assunsero posizioni antifasciste. Su Leo gravava però come una
scure il fatto di essere stato l’artefice della frase “Mussolini ha sempre ragione” che gli
rimase addosso per tutta la vita.
Leo, da sempre bastian contrario, giudicava un tradimento la decisione di tanti giornalisti,
scrittori e politici che avevano aderito al fascismo usufruendo dei vantaggi legati all’iscrizione
al PNF, di dichiararsi convinti antifascisti non solo rinnegando il proprio passato ma
attaccando apertamente il fascismo.
E dire che proprio lui, il 25 luglio del ’43, si era unito alla folla che festeggiava a Roma la
caduta del regime.
Bibliografia:
_Francesco Giubilei, Leo Longanesi il borghese conservatore, edizioni Odoya 2015
_Un conservatore scomodo. Leo Longanesi dal fascismo alla Repubblica, Firenze, Le Lettere,
2007
_ Montanelli I. Staglieno M, Leo Longanesi
_Longanesi e gli italiani di Mariuccia Salvati in Longanesi e italiani, Faenza, Edit Faenza, 1997
L’Italia dall’antifascismo all’anticomunismo: il
triennio 1947/1949
L’Italia dall’antifascismo all’anticomunismo: il triennio 1947/1949di Giuseppe Baiocchi del
18/06/2016
Dalla fine del conflitto alla guerra fredda, se si deve guardare ad una cronologia, bisogna
osservare un triennio fondamentale: dall’ 8 agosto del 1945 fino al momento in cui Truman
lancia la proposta della guerra fredda, di fronte alla aggressione crescente della Unione
Sovietica nei confronti dell’Europa dell’Est, in qualche modo rappresentata dalle crisi di
Berlino del 1948.
La guerra fredda comincia quando Truman abbandona il sogno rooseveltiano di creare una
unità mondiale delle forze vincitrici della 2°guerra mondiale, comprendente anche l’Unione
Sovietica. Franklin Delano Roosevelt, quando accettò di stipulare l’alleanza con Stalin dopo
l’invasione tedesca dell’URSS, fece abbandonare al presidente ogni remora ideologica
antisovietica, e buona parte delle critiche aspre mosse dall’ opinione pubblica americana
consapevole delle nefandezze staliniane (le famose “purghe staliniane”). La teoria del
presidente americano vacillò quando i russi non si presenteranno alla conferenza per la
riorganizzazione planetaria dopo la guerra.
La guerra fredda nacque con Truman, braccio destro di Roosevelt e co-artefice del New Deal.
Dal 1941 al 1947 l’ideologia dominante, sulla quale imperniare la nuova visione degli assetti
globali, si stava formando sull’opposizione pratica e teorica che gravitava intorno al concetto
politico di fascismo e antifascismo, e quest’ultimo, per le potenze vincitrici, era sicuramente il
campo ideale entro cui far risorgere la democrazia europea.
L’idea del nuovo ordine mondiale si palesò dunque nel triennio 1947-1949 quando, nel corso
di soli tre anni, ebbero luogo degli avvenimenti geopolitici talmente rilevanti, tali da mutare il
pensiero politico strategico dell’ordine mondiale.
Questi accadimenti, in ordine, furono:
1) La guerra civile in Grecia, nella quale le forze comuniste greche cercarono di uscire
dall’ordine di Yalta ( che faceva del paese greco uno stato che doveva essere considerato
‘occidentale’ dalla famosa “cortina di ferro”, per la spartizione dell’Europa in aree di
influenza).
2) Il biennio 1947-1948, durante il quale l’Unione Sovietica cercò di ridiscutere la divisione
della Germania e quindi di scatenare in essa il focolaio permanente di divisione
internazionale, agevolando la distruzione della democrazia nei paesi dell’Europa dell’Est
avviata nel 1946 in Polonia e finita del 1948 in Ungheria, e che portò alla formazione dei
primi stati satellite di tipo imperialista.
3) La vittoria di Mao in Cina con la fondazione della Repubblica popolare cinese.
Nel 1947 tale evento non sarebbe nemmeno stato contemplato dall’opinione pubblica, poiché
il nazionalismo di Chiang Kai-Shek era molto forte. La vittoria di Mao Zedong sul Guamindang
(KHT) partito nazionalista cinese, mutò gli equilibri il 1 ottobre del 1949: ottocento milioni di
persone diventavano comuniste, con un miliardo e più di esseri umani inghiottiti dal cono
d’ombra degli altri regimi comunisti. Mao riprese inizialmente il modello totalitarista e
comunista di Stalin, che spirerà nel 1953.
Tutto si svolse in una rapidità di tempi sconvolgente e la discriminante fascismo/antifascismo
cedette il posto ad un’ altra discriminante che fu quella tra comunismo e anticomunismo.
Inizia ad essere chiaro che la ricostruzione geopolitica del mondo che comincia in questo
fatidico triennio non si muove nella prospettiva che aveva spinto gli alleati a sconfiggere il
nazismo e rispristinare la democrazia, ma avvenne in uno scenario che subì una
trasformazione radicale. Non fu più Hitler, ma Stalin. Gli ultimi rimasugli del fascismo, quello
portoghese e quello spagnolo, vennero inglobati nel processo atlantista statunitense e
giudicati come “necessari”.
In Spagna, Italia, Grecia e Turchia vennero stabilite le basi militari americane per avere una
testa di ponte diretta con il nemico comunista.
Questo fece sì che si guardò ai fascismi della America Latina solo in chiave anti-comunista e
quindi la politica statunitense non solo fu tollerante, ma intese offrire protezione ai piccoli
regimi autocratici di stampo fascista. Si riteneva, difatti, che questi potevano essere ottimi
baluardi alla penetrazione di quei movimenti marxisti/comunisti i quali disponevano di grandi
forze.
Così, tutte le dittature dell’America Latina iniziate negli anni trenta e che si formeranno nel
primissimo dopoguerra furono la risposta imperialista statunitense alle risposte imperialiste
sovietiche, che iniziarono a spartirsi il pianeta.
Nel 1956, l’Unione Sovietica invaderà l’Ungheria, mentre di contro, gli Stati Uniti, tuteleranno
le più sanguinose dittature latine per un disegno, ambo le parti, di stampo imperialista.
Gli aspetti ideologici che porteranno alla demonizzazione del nemico nel contesto della
narrazione storica e culturale, giustificheranno tutti gli operati. Si accettò dunque che la fine
della rivoluzione greca portasse al potere Metaxa, un dittatore fascista, e fu permesso alla
gran parte dell’Intelligence hitleriana di fuggire nell’America latina, vivendo al riparo in quei
regimi che gli Stati Uniti stavano tutelando.
Anche in Italia l’epurazione degli uomini che erano stati il nerbo del regime fascista non
avvenne mai, in modo da favorire quell’equilibrio necessario che portò alcuni ex-fascisti al
comando di movimenti politici fondamentali per la ricostruzione della stessa politica italiana,
sempre in chiave anti-comunista.
Tutti gli uomini, membri delle resistenze dei loro paesi, che avevano costruito i loro ideali
morali e civili sotto il principio anti-fascista, nel 1947-1949 si trovarono nella difficile
decostruzione dei loro stessi valori. Le forze moderate dell’antifascismo, come le forze
cattoliche, liberali, che avevano combattuto contro il fascismo, doverono immediatamente
abbandonare quell’appartenenza, costretti a ridimensionarla, per dar spazio all’anticomunismo imposto dalla politica atlantista statunitense che con il Piano Marshall stava
ricostruendo l’Italia, la quale si trovava in uno stato di tremenda miseria alla fine del conflitto
mondiale.
In tre anni l’assetto geopolitico mutò inaspettatamente per tutta l’opinione pubblica
mondiale. I fascismi in Europa ci sono ancora, non solo dove li si epura male (come in Italia),
ma anche dove si proteggono. L’irrisolta questione, lasciata in eredità del
fascismo/antifascismo, non si risolse con la dicotomia comunismo-anticomunismo. In un
paese come l’Italia, che del fascismo era stato l’inventore, la questione ideologica rimase
fortemente irrisolta, soprattutto poiché il fascismo non venne imposto da un altro paese
“straniero” ma nacque e si sviluppò autonomamente in Italiana, fino ad essere esportato
come modello fuori dalla Nazione (modello che nei paesi della penisola iberica si è rivelato
molto duraturo).
L’eredità del fascismo è ancora presente nella testa degli italiani, che diviene tanto più
vivente, quanto più la nostra repubblica non costruisce istituzioni, livelli culturali, dinamiche
di socializzazione attorno alla critica del fascismo. Questa operazione sacrosanta di cui il
paese aveva bisogno per interrogare la propria coscienza civica, ci fu impedita, poiché nel
1949 si diffuse l’idea di un altro totalitarismo: quello comunista. E’ chiaro che l’oblio di questo
passato, impedisce alla nazione di fare un esame di coscienza, ritrovando molto spesso
individui che hanno abbandonato l’ideale fascista solo perché costretti e che continuano in
cuor loro a credere in ideali che oggi per l’epoca in cui viviamo sono oramai inapplicabili.
Queste persone, dati alla mano, sono sicuramente molto più numerose di quelle che dal 26
dicembre del 1946 si schiereranno nel Movimento sociale italiano, che nella storia politica del
paese sarà destinato ad essere solamente una minoranza.
Giorgio Almirante, storico segretario del Movimento Sociale Italiano, partito politico di destra,
di cui è stato uno dei fondatori nel dicembre 1946 insieme ad altri reduci della Repubblica
Sociale Italiana.
Tutto ciò sarà visibile, quando il sistema dei partiti usciti dalla guerra si disintegrò negli anni
90 e intorno ai campi ideali in cui si ricostruisce il centro destra in Italia, riemersero
vecchissime tradizioni che facevano riferimento a quelle memorie troppo spesso dimenticate,
occultate, ma mai analizzate criticamente nel periodo successivo al 45. E’ fondamentale
pensare l’Italia in questo contesto. L’Italia ebbe anche un problema ulteriore, per via del suo
posizionamento strategico. Un problema anche geografico, che ereditò lo stesso Mussolini
quando capì benissimo che l’Italia non poteva essere geopoliticamente una Svizzera venti
volte più grande, poiché la posizione geografica la inseriva nelle condizioni di entrata nel
conflitto (a differenza ad esempio della Spagna).
Altri paesi come la Francia, la Spagna, l’Inghilterra, l’Olanda hanno sempre fatto parte di quel
mondo occidentale in cui l’Italia si apprestava ad entrare. L’Italia del ventennio aveva un’
identità più che europea, mediterranea; l’occidente non era molto presente nell’identità
nazionale, non era presente il “campo occidentale” poiché l’unico spazio che conoscevamo
era “il nostro spazio vitale”.
L’Italia della rivoluzione fascista, fino al 1943, voleva imporsi come potenza planetaria,
definendo lo spazio geografico e geopolitico con la forza. Quando si disintegrò il regime
fascista, cosa rimase nelle macerie? L’appartenenza dell’Italia ad un campo geopolitico che
non esisteva più, poiché il Regio esercito combattè nel 1943 come co-belligerante dei
britannici, senza minimamente immaginare come sarebbe stato l’ordine mondiale (in quegli
anni antifascista e rooseveltiano). Inoltre (dato da non sottovalutare) la monarchia che
combatteva alla fine del conflitto contro la Repubblica di Salò, non era certamente
antifascista, se si considera che solo due anni prima Amedeo di Aosta fu il vicerè dell’Impero
italiano in Africa orientale. Difatti, proprio per tale motivo, la monarchia in Italia perdette, alla
fine del conflitto, qualsiasi legittimità per la rappresentanza del paese negli anni a venire. Il
referendum del 1946 segnò la fine di una legittimità fortissima (forse spinta anche dagli
americani) e si crea poiché la ricollocazione geopolitica del paese comporta l’assoluta
estraneità della monarchia italiana al nuovo orizzonte mondiale atlantista.
Il tricolore con lo stemma sabaudo, prima bandiera dell’Italia unita, dal 1861 fino al 1946
L’ordine ideologico mondiale si stava delineando intorno a due mondi, due sistemi opposti e
polarizzati, nei quali la terza via non era prevista, se non per piccoli stati. Dunque la
definizione di dove collocarsi era fondamentale e non a caso nel 1947 in Italia si ruppero tutti
i governi di unità nazionale antifascista e si formarono governi centristi filo-occidentali e filoamericani, poichè quella discriminante diventò immediata.
L’Italia aveva il partito comunista, che aveva la più alta rappresentanza europea occidentale:
sindacati, cooperative, uomini intellettuali, centri di cultura. Tutte macchine politiche di
sinistra. Il PCI non chiese mai che l’Italia entrasse a far parte del patto di Varsavia, chiese
qualcosa di impossibile: la via del neutralismo. Insieme a socialisti e ad alcuni liberali si
opposero perciò all’ingresso dell’Italia nella NATO.
La scelta dell’Italia fu la NATO (L’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord) e fu
comunque una scelta sofferta (senza l’Italia non ci sarebbe stata un’ Europa unita). Ad
esempio se si prende la Jugoslavia, questa decise di essere comunista, ma non filosovietica,
subendo pressioni di tutti i tipi per essere riassorbita in tale orizzonte.
Quando gli USA si dichiareranno favorevoli alla guerra di Korea, la NATO sarà avvertita solo
dopo l’inizio delle operazioni militari. Questo comportamento ci fa comprendere come il peso
politico dell’Europa, uscita distrutta dal secondo conflitto, fosse praticamente inesistente.
Oggi gli eventi dimostrano che è avvenuto un cambiamento da parte statunitense, ma le
problematiche europee sono soprattutto di stampo economico, proprio per una variazione
economica atlantista americana dopo il 1990. Gli Stati Uniti nella conferenza di Bretton
Woods del 1944, sanciscono le linee che contraddistingueranno i principi liberisti statunitensi.
1)Libero scambio
2) Principio di uguaglianza (welfare)
3) Lo Stato diventa regolatore del sistema economico
4) Ripresa economica dell’Europa (Piano Marshall de 1948)
5) Nuovo equilibrio monetario dalla Sterlina britannica legata al Dollaro come moneta
centrale
6) Creazione di istituzioni in grado di far funzionare i mercati.
La Conferenza di Bretton Woods si svolse dal 1 al 22 luglio del 1944 nella cittadina di Bretton
Woods nel New Hampshire in USA
La storia dell’Italia si inserisce all’interno di questo cammino che la vedrà coinvolta, insieme
alla Germania Ovest, come uno dei paesi che beneficerà di più di tali fondi. Il Piano Marshall
permetterà l’innovazione dei sistemi produttivi, i prestiti gratuiti alle imprese e una forte
spinta all’immissione della tecnologia nel paese.
In questa confusione ideologica, i partiti centristi del primo dopoguerra hanno avuto il merito
di spostare l’attenzione del cittadino verso un nuovo futuro possibile. La visione di un futuro
di prosperità e felicità per il paese è l’unico merito delle élite politiche italiane che hanno reso
visibile il sogno, all’interno di scenari compositi. I manifesti della democrazia cristiana
rappresentano spesso il benessere che la vittoria del partito, avrebbe portato al paese. Da
questo punto di vista la letteratura di quegli anni è meravigliosa, soprattutto è meravigliosa
la capacità di diffondere quegli slogan popolarissimi che riscriveranno la storia del
dopoguerra italiano. Unita al piano Marshall vi è una concezione nuova del Welfare: la
democrazia non è un insieme semplicemente di regole, come volevano le tradizioni liberaldemocratiche ottocentesche, ma un insieme di progetti che si costruiscono sul principio
dell’eguaglianza e che provengono dal dibattito democratico dell’antifascismo, iniziato negli
anni venti, in Italia. Si radica così negli anni la convinzione che la democrazia sia
imprescindibilmente legata all’idea di benessere collettivo, e che sia generatrice di pace.
Pace, democrazia e welfare saranno il trinomio cardine costitutivo delle democrazie
occidentali, anche dell’Italia, che lo inserirà nella sua costituzione. E’ chiaro che poi il
processo di costruzione del Welfare, insieme all’equa ridistribuzione del reddito, consentirà il
pieno sviluppo del paese (con i miti del miracolo economico) e avrà un suo fondamento
nell’Italia del dopoguerra. L’Italia faticherà ad eliminare il welfare del fascismo, però è
indubbio come questa sia la dimensione in cui la storia del nostro paese si iscrive e dove si
applica una democrazia socialmente interventista nella quale avviene una assoluta novità per
lo scenario internazionale che sarà la più grande eredità dell’antifascismo europeo.
Per approfondimenti:
_Alberto De Bernardi, “Una dittatura moderna: il fascismo come problema storico” Edizioni
Mondadori Bruno
_Alberto De Bernardi, “Discorso sull’antifascismo” 2007 Edizioni Mondadori Bruno
_Alberto De Bernardi, “Un paese in bilico. L’Italia degli ultimi trent’anni” 2014, Laterza
Edizioni
© L’altro – Das Andere – Riproduzione riservata
Rappresentare l’Italia nel Nuovo Mondo:
Alberto Tarchiani (2)
Rappresentare l’Italia nel Nuovo Mondo: Alberto Tarchiani (2)di Dario Neglia del 25/05/2016
Agli inizi degli anni’50 può quindi dirsi che l’Italia aveva in gran parte compiuto quel cammino
di “ritorno” nella vita politica internazionale.
In fondo, a paragonare la posizione raggiunta dal paese con quella occupata all’indomani
dell’8 settembre 1943, il risultato era notevole: l’Italia aveva beneficiato dell’ERP, era stata
membro originario del Patto Atlantico, era entrata altresì nel Consiglio d’Europa in quello
stesso 1949, ed infine si era stabilizzata anche in chiave interna con le elezioni dell’aprile
1948.
Restavano ancora aperte solo due grandi questioni: la prima, quella dell’ingresso all’ONU, che
si sarebbe risolta nel 1955; e la seconda, più grave, pressante e bruciante, la piaga aperta
della Questione Triestina.
Sulla città di San Giusto la congiuntura del sistema politico internazionale parve accanirsi
oltremodo. Come ha scritto De Castro, autore di un opera monumentale, forse la più
importante sull’argomento:
Al problema di Trieste furono sempre precedenti, contemporanee o successive varie altre
questioni, di solito molto importanti per i difficili equilibri internazionali che implicavano.
Trieste servì come moneta di scambio, come spauracchio, come causa di remore, come
anello di una difesa, come pomo della discordia, come tutto quanto essa non era o non
avrebbe voluto, né dovuto essere. L’Italia, per la quale la questione giuliana, prima, e la
triestina, poi, furono il maggior problema del dopoguerra, dovette sempre destreggiarsi
cercando di parare i colpi che venivano a danneggiare la questione stessa, rimbalzando da
altre situazioni internazionali .
Fu la guerra fredda, in poche parole, ad insinuarsi di continuo nelle maglie del problema
triestino, elevando la contesa Italia-Jugoslavia al livello dello scontro bipolare Stati UnitiUnione Sovietica e viepiù riflettendo i toni di quest’ultimo, ora di flebile compromesso, ora di
contrapposizione aperta.
Per ironia della sorte, benché i toni cambiassero, l’unica parte danneggiata restava sempre la
stessa: l’Italia.
Bisogna dire apertis verbis che la condotta statunitense in questo dossier non fu per nulla
onorevole. Tutte le vicende che ruotarono intorno al problema del TLT, in sede di Conferenza
di pace, lasciarono gli italiani e De Gasperi – per tacere di Tarchiani – con l’impressione di
essere stati traditi da Washington. Gli Stati Uniti erano il principale patronus dell’Italia a
livello internazionale e di certo avevano una particolare responsabilità nella vicenda; ma
considerando il tutto da un altro punto di vista, si può dire che forse gli italiani peccarono un
po’ di ingenuità.
Ancora una volta nelle parole di De Castro, questo rapporto ambivalente viene sintetizzato in
modo perfetto:
Tutto ci portava verso gli Stati Uniti e tanto ci portava che, vedendo la buona accoglienza,
poggiammo subito su di loro, senza renderci conto, altrettanto subito, che noi eravamo, per
gli Stati Uniti stessi, uno dei pezzi della scacchiera internazionale, un pezzo di un certo valore
— diciamo un alfiere, un cavallo — mentre il nostro problema numero uno, la nostra regina
nei problemi scacchistici postbellici, la Venezia Giulia, era per loro soltanto una delle tante
pedine, che bisognava giocare per salvare altri pezzi che, nel loro gioco erano i principali […]
.
Le vicende relative alla sorte di Trieste si risolsero nella prima parte degli anni’50, ma una
premessa fondamentale era stata posta pochi anni addietro: un comunicato ufficiale,
rilasciato appena prima delle elezioni politiche italiane del 1948, la cosiddetta Dichiarazione
Tripartita.
Il 20 marzo 1948 le tre potenze occidentali alleate (Stati Uniti, Gran Bretagna, e Francia)
rilasciarono un comunicato ufficiale: in quella che era stata una vera e propria escalation
propagandistica tra i due blocchi per influenzare l’esito delle elezioni italiane, l’URSS si era
giocata la carta riguardante la promessa di una restituzione integrale delle colonie all’Italia, e
gli occidentali avevano rilanciato (in maniera del tutto sconsiderata) proclamando che Roma
sarebbe tornata in possesso nientemeno che dell’intero TLT!! Vi sono state diverse
interpretazioni storiche circa la ratio di questo avventato proclama; ciò che pare certo, ad
ogni modo, è che qualunque fosse la motivazione degli Alleati, essi non si accorsero che così
facendo avrebbero letteralmente incatenato la politica estera italiana in quest’ambito. E così
infatti fu.
Per tutta la durata del lunghissimo (dieci anni) negoziato diplomatico su Trieste, il governo
italiano sarebbe stato condannato a non poter prescindere dalla Dichiarazione Tripartita,
perché – non è difficile da capire – da quel momento in avanti accettare qualsivoglia
compromesso sarebbe stato percepito come una sconfitta da parte dell’opinione pubblica
italiana. La Dichiarazione ormai aveva fissato un livello di aspettativa al di sotto del quale non
si poteva andare, e poco importa che si trattasse di un’aspettativa del tutto irrealizzabile. A
peggiorare ulteriormente le cose per il nostro paese, il 28 giugno del 1948 il PCI veniva
espulso dal COMINFORM: adesso Tito non era più un nemico da contrastare, ma addirittura
un quasi-alleato da blandire con lusinghe, aiuti finanziari e militari, perché stava lì a
dimostrare la frantumazione del compatto blocco sovietico, e di certo non andava
scontentato con qualche scelta pro-Italia riguardo Trieste.
Josip Broz Tito
Dunque gli anni si susseguirono senza che l’Italia potesse riuscire a trovare una soluzione ad
essa favorevole del problema; e verrebbe da dire che, date le premesse, era nell’ordine delle
cose che andasse così. A partire dal 1952, tuttavia, iniziò una fase diplomatica molto più
dinamica che si sarebbe infine risolta con lo sbrogliamento della matassa.
In questa sede non è necessario né opportuno ripercorrere tutti i passaggi della snervante
dialettica negoziale che interessò Italia, Alleati, e Jugoslavia a partire dal 1952. La girandola
di incontri e scontri, proposte e controproposte, che si ebbe è stata giustamente definita, a
tratti, «diplomazia allo stato puro» .
Ciò che importa, invece, è citare che anche in questo caso si ebbe un summit dirimente da
parte italiana a cui parteciparono De Gasperi, e tutti i principali ambasciatori nelle capitali
occidentali, compreso quindi Tarchiani.
Citata in varie fonti, la riunione diplomatica avrebbe dovuto scegliere la linea da tenere
riguardo la questione Triestina, in particolare in risposta ad una proposta americana che si
presentava come l’ennesimo sforzo fatto dagli statunitensi, di sicuro non all’altezza di quanto
previsto dalla Dichiarazione Tripartita, ma d’altra parte quanto di meglio si potesse ottenere
in quel frangente.
Dalle memorie di Tarchiani emerge in maniera molto chiara la contrapposizione tra i
diplomatici da un lato, i quali tutti – chi più, chi meno – erano ormai propensi ad accettare la
soluzione di compromesso proposta da Washington; e De Gasperi dall’altro, uomo politico in
tutto e per tutto, che lucidamente capiva di non poter prescindere dalla Dichiarazione
Tripartita, pena il suo futuro al governo.
Gli schieramenti erano ormai, da una parte, quello di chi avrebbe voluto chiudere la
questione, accettando il massimo che da essa si sarebbe potuto cavare; dall’altra parte,
quello di chi, come lo statista trentino, non accettava di piegarsi e dimenticare quanto gli
anglo-franco-americani avevano un tempo promesso.
Tra questi due gruppi, Tarchiani era di certo l’esponente di punta del primo.
Egli infatti aveva capito più di ogni altro che il tempo era ormai (e probabilmente era sempre
stato) un fattore che danneggiava la posizione italiana.
Bisognava accettare ciò che gli statunitensi avevano proposto, sebbene così facendo la
Dichiarazione Tripartita sarebbe divenuta ipso facto uno chiffon de papier; poiché del resto –
secondo quanto Tarchiani riteneva – essa già di fatto lo era; bisognava solo accettare la
proposta americana, senza modifiche, e premendo affinché la si ponesse a Tito a carattere ne
varietur: ovvero, traducendo il gergo diplomatico, prendere o lasciare.
Ma purtroppo questa non fu la decisione del Presidente del Consiglio. La volontà di proseguire
sulla strada della ricerca della “soluzione migliore”, senza capire che tale era ormai
l’accettazione rassegnata del “male minore”, portò al fallimento dell’azione degli americani,
che avevano sperato di risolvere una questione ormai senza via d’uscita con una proposta
loro. Tarchiani nel suo diario non nascose l’amarezza non solo a causa di un aspro diverbio
che l’aveva contrapposto a De Gasperi, verso cui nutriva infinita stima ed affetto, ma
soprattutto per aver mandato al macero una soluzione che, nelle sue parole,
[…] se riusciva ci dava Trieste, Capodistria, Isola, e Pirano; se non riusciva per intero, ci dava
comunque assai più di quello che avemmo in seguito; se non riusciva affatto, non metteva
minimamente in pericolo il poco, pochissimo, che riuscimmo poi con tante fatiche ad ottenere
nel 1954 .
Fortunatamente però, l’inerzia non è una legge che si applica a lungo nelle relazioni
internazionali, così una volta che fu modificato il contesto in cui si svolgeva il dramma di
Trieste le carte in tavola vennero sparigliate ed aumentò la volontà di tutti i partecipanti a
che la questione fosse risolta.
A partire dal ’53 si verificarono cambiamenti importantissimi: in America Eisenhower
sostituiva Truman come Presidente degli Stati Uniti; in Inghilterra Churchill ritornava a
ricoprire la carica di Primo Ministro; e in Italia, non da ultimo, si concludeva l’era
degasperiana.
La politica italiana entrò nella fase turbolenta occupata dai deboli governi centristi: esecutivi
instabili, ma che paradossalmente proprio per questo non potevano permettersi che la
questione Triestina restasse loro appesa sul capo, come una spada di Damocle.
Ad agosto del ’53 si ebbe una riprova di questo e si toccò pericolosamente l’acme:
un’agenzia di stampa jugoslava pubblicò un comunicato incredibilmente duro in cui con tono
intransigente si dichiarava la necessità per la Jugoslavia di «riprendere seriamente in esame
l’atteggiamento jugoslavo di fronte al problema triestino».
A Palazzo Chigi saltarono i nervi un po’ a tutti, e Pella decise addirittura, per la prima (e finora
unica!!) volta nella storia della Repubblica Italiana, di mobilitare tre divisioni ed una batteria
anti-aerea di sede a Gorizia, per inviarle al confine nordorientale.
Questa piccola crisi, che rientrò in breve tempo, dimostrò ormai a tutti che il problema
andava risolto, per non rischiare di peggiorare oltre le cose. Gli americani, decisero di fare un
ultimo disperato tentativo, e Tarchiani cercò in ogni modo di convincere Roma a supportare
per l’ultima volta gli sforzi di Washington. Agli inizi di febbraio del nuovo anno, 1954, sia Pella
sia Tito acconsentirono a tenere a Londra degli incontri segretissimi tra i rappresentanti dei
tre paesi coinvolti. Il modello era il seguente: i due plenipotenziari americano e inglese
avrebbero incontrato i rappresentanti jugoslavo e italiano separatamente, prima l’uno e poi
l’altro, con l’obiettivo di trovare un compromesso che andasse bene ad entrambe le parti,
ovviamente.
La proposta che infine venne partorita ancora una volta non era favorevole all’Italia, ed
ancora una volta Scelba, che a febbraio aveva sostituito Pella a capo del Governo, si trovò a
dover decidere se bere dall’amaro calice pur di chiudere la ferita, o proseguire in modo
disperato e senza certezze. Con sofferenza, decise infine che la proposta americana andava
accettata.
Fu così che, non senza l’incontro di un funzionario americano con Tito stesso per convincere
quest’ultimo, il 5 ottobre 1954 venne parafato l’Accordo di Londra, che in sostanza traduceva
con un memorandum quella che era la situazione del TLT sul terreno, con pochissime
rettifiche di confine; la zona B sarebbe rimasta ufficialmente alla Jugoslavia, mentre l’Italia
finalmente avrebbe ripreso possesso della Zona A, compresa Trieste.
In fin dei conti, quasi mai nella storia la diplomazia ha potuto modificare al tavolo negoziale
ciò che è stato già deciso manu militari, e di certo le vicende relative al TLT non sono che un
ulteriore esempio di ciò.
L’asimmetria di fondo nella questione, con la Zona B da subito nelle mani di Tito, mentre – si
badi bene – l’Italia non raggiunse mai la medesima condicio possidentis riguardo la Zona A
misero il nostro paese in una posizione a dir poco malagevole per trattare con Belgrado,
impedendo a Roma di poter impostare le trattative come meglio avesse creduto.
Questo, ad ogni modo, non toglie che solo la buona volontà del Maresciallo avrebbe potuto
portarlo a cedere del territorio, in cambio di qualche tornaconto beninteso; in alternativa,
restava solo la violenza, cosa a cui nessuno voleva fare ricorso, dopo neanche dieci anni dalla
fine della guerra e soltanto per una “futile” questione come Trieste, né l’Unione Sovietica né
gli Stati Uniti, né la Francia né l’Inghilterra, e probabilmente in verità neanche l’Italia.
In conclusione, il 1954 fu l’anno della fine del lungo calvario compiuto dalla città di Trieste, e
per estensione anche della «Via crucis» percorsa dall’Italia dopo l’8 settembre 1943.
La fase del dopoguerra aveva ormai chiuso tutte le questioni rimaste in sospeso, l’anno
successivo sarebbero caduti anche i veti reciproci dei due blocchi e l’Italia, insieme a molti
altri paesi, sarebbe stata ammessa al Palazzo di vetro newyorkese. Si era chiuso un lungo
capitolo e se ne apriva un altro, molto diverso. Quanto a Tarchiani, una volta compiuta la
missione per riportare Trieste dentro i confini nazionali, si concluse anche il suo periodo come
ambasciatore negli Stati Uniti.
L’ultimo anno, appunto il ’54, fu venato da una certa malinconia per il diplomatico,
probabilmente in parte dovuta al cambio di sede ed alla messa a riposo . Ma al di là di
questo, sembra in realtà che la tristezza di Tarchiani provenga più che altro dalla
constatazione di essere ormai fuori posto: non solo gli Stati Uniti non erano più quelli di un
tempo ed egli non riusciva più a comprenderli, ma anche la stessa Italia era cambiata,
diversa da quella che aveva conosciuto dieci anni fa, e pare che nel nuovo orizzonte non vi
fosse spazio per uomini come lui.
Tarchiani appartenne sempre, infatti, a quella generazione eroica di uomini che ricostruirono
il paese dalle macerie della guerra, sia in senso materiale sia soprattutto cercando
faticosamente di riacquistare il rango e il prestigio perduti. L’ambasciatore fu insomma un
rappresentante dell’Italia degasperiana, in tutto e per tutto, quindi non meraviglia che una
volta che lo stesso De Gasperi fu uscito di scena , anche Tarchiani capì che era venuto il suo
tempo.
Da ultimo, chi fu l’ambasciatore Tarchiani, e cosa resta di lui oggi? Un testimone del suo
tempo, certo, a conferma della famosa massima del cancelliere Von Bülow che voleva la
diplomazia essere principalmente «una poltrona in prima fila per il dramma della storia», ma
anche qualcosa di più.
Tarchiani fu l’ambasciatore politico par excellence tra le tante nomine politiche del
dopoguerra; in molti casi egli stesso si trovò a dover impostare di sana pianta l’azione da
compiere negli Stati Uniti, senza che gli provenissero informazioni di dettaglio da Roma. Ciò
che lo mosse fu la sua ferma convinzione che l’Italia avrebbe dovuto reintegrarsi nel mondo
occidentale, schierarsi dalla parte della democrazia e del libero mercato: in una parola, non
rinnegare la propria storia e la propria identità, ambedue aspetti che portavano
consequenzialmente il nostro paese – e Tarchiani fu tra coloro che lo capirono prima e più
degli altri – non ad appartenere al gruppo dei neutrali, non a scendere in campo dalla parte di
Mosca, bensì al contrario a non poter fare a meno di abbracciare l’orizzonte atlanticoeuropeo, sforzandosi in particolare di diventarne uno dei pilastri portanti.
La vulgata vuole che, in fondo, i diplomatici siano sempre un po’ malati di esterofilia, ed in
questo Tarchiani non fece eccezione. Il fascino che gli Stati Uniti emanavano su di lui fu
all’origine della sua incondizionata fiducia nei confronti dell’America, a volte mal riposta, altre
volte tradita, ma senza che si trattasse mai di una specie di culto fine a sé stesso.
Fu Tarchiani il miglior ambasciatore italiano di quel tempo? Probabilmente no, se si giudica la
finezza della sua analisi politica, probabilmente sì se si considera il contributo fattuale che
egli diede nel definire le relazioni italo-statunitensi dell’epoca. In fin dei conti, egli fu sempre
e soltanto un autentico servitore dello Stato animato da grande patriottismo, e questa –
checché ne dica la vulgata – è la più importante ed indispensabile caratteristica per fare il
diplomatico, ed ancor prima esserlo.
A posteriori, si può dunque veramente stimare infondata la preoccupazione di De Gasperi,
quando questi decise di affidare la missione di rappresentare la “nuova Italia” in America ad
un uomo come Tarchiani: metafora di un decennio di storia italiana e modello per le
generazioni a venire, pur nell’oscurità dei tempi egli non avrebbe mai dimenticato quale
fosse la sua bussola:
Così con un abbraccio ci lasciammo. Vidi ancora De Gasperi, mi pare il giorno seguente, 20
febbraio 1945 all’aerodromo di Ciampino, ove venne a salutarmi ed abbracciarmi con
estrema cordialità, mentre salivo, col mio piccolo drappello di collaboratori, su di un bimotore
militare americano che doveva condurmi a Casablanca, ove ne avremmo trovato un altro per
Washington. Tutto era quanto mai incerto in questa spedizione. Nessuno, tanto meno io, era
in grado di prevedere a un dipresso quel che sarebbe avvenuto subito e in seguito. Eravamo
in mano di un destino impenetrabile. Sapevamo soltanto che di qua e di là avremmo spese
senza risparmio le nostre forze ad aiutare l’Italia.
Per approfondimenti:
_S. Romano, Guida alla politica estera italiana, Milano, Rizzoli, 2002
_G. Mammarella e P. Cacace, La politica estera dell’Italia. Dallo Stato unitario ai giorni nostri,
Bari, Laterza, 2010
_ P. Craveri, Prefazione a D. Fracchiolla, Un ambasciatore della “nuova Italia” a Washington.
Alberto Tarchiani e le relazioni tra Italia e Stati Uniti 1945-1947, Milano, Franco Angeli, 2012
_A. Tarchiani, Dieci anni tra Roma e Washington, Mondadori, Milano, 1955
_A. Ciarrapico, Le ombre della storia, Aracne, Roma, 2012
_A. Varsori, L’Italia nelle relazioni internazionali dal 1943 al 1992, Bari, Laterza, 1998
_D. De Castro, La questione di Trieste, vol. I, Lint, Trieste, 1981
© L’altro – Das Andere – Riproduzione riservata
Rappresentare l’Italia nel Nuovo Mondo:
Alberto Tarchiani (1)
Rappresentare l’Italia nel Nuovo Mondo: Alberto Tarchiani (1)di Dario Neglia del 24/05/2016
All’indomani della Seconda Guerra Mondiale, l’Italia era un paese in macerie.
Lo era dal punto di vista materiale ovviamente, con un sistema economico-produttivo messo
allo stremo dal conflitto, ma ancor di più lo era considerando gli aspetti immateriali. È stato
scritto con parole caustiche: L’Italia del 1939-40 era già una grande potenza sui generis: era
“l’ultima delle grandi potenze” o – come si diceva sin dall’800 – “la prima delle potenze
minori”. Ma l’Italia che esce dalla seconda guerra mondiale è piuttosto e senz’altro
“l’impotenza” fatta persona .
Per la seconda volta, e forse anche in modo più clamoroso della prima, era stato confermato
il cliché che voleva gli italiani infidi e traditori. Le vicende dell’8 settembre, la fuga del Re da
Roma, avevano lasciato strascichi pesanti, permettendo da un lato di salvare ciò che restava
formalmente della Monarchia, ma infliggendo allo stesso tempo un colpo mortale al prestigio
di casa Savoia.
Vittorio Emanuele III viene accolto a Brindisi, dalle truppe rimanenti dello Stato Italiano
Il paese era insomma prostrato dalla guerra civile, frantumato nella propria coscienza
nazionale, faticosamente impegnato nel costruire un progetto politico per il futuro e
disperatamente bisognoso di «progresso economico e sicurezza militare» .
In un tale contesto si ripropose – per quei celebri corsi e ricorsi storici – una situazione simile
a quella dell’immediato post-Unità: come dopo il 1861, così anche nel ’45 la condizione
politico-istituzionale interna al paese era di una fragilità tale, che – in breve – la
sopravvivenza stessa dello Stato dipendeva dalle azioni delle potenze straniere.
La politica estera diveniva, quindi, il campo principale sul quale giocare le proprie carte,
ripartendo da zero, «da una matita e da un foglio di carta» , come pare avesse detto Badoglio
a Brindisi, con la consapevolezza che non era più permesso commettere sbagli perché ogni
singola mossa sarebbe stata decisiva.
L’Italia doveva acquistare, come disse Churchill, «il biglietto di ritorno» verso la politica
internazionale, da cui evidentemente le vicende del secondo conflitto mondiale avevano
ormai esclusa. Ed in quest’ottica entra in gioco la diplomazia.
Il rilancio della politica estera italiana andava attuato ricostruendo in primis proprio l’intera
rete diplomatica, anch’essa distrutta dal conflitto. Ed occorreva più che mai fare scelte ben
ponderate.
Quando, infatti, dopo l’8 settembre e la formazione della Repubblica di Salò, venne chiesto ai
vari esponenti del corpo diplomatico di schierarsi, pochi furono quelli che seguirono
Mussolini, ricordando il loro giuramento di fedeltà fatto nei confronti del Re. Nonostante
questo, non vi era a quel tempo abbondanza di funzionari al Ministero degli Esteri, complice
anche la famigerata infornata del 1928, che grazie alla tessera del PNF aveva fatto entrare
nella “carriera” numerose personalità di nomina politica (ora chiaramente messe ai margini).
Risultava insomma difficile, adesso, scegliere i Capi Missione per le sedi più importanti:
segnatamente le principali capitali occidentali.
Nel dicembre 1944 De Gasperi fu chiamato a ricoprire il dicastero degli Esteri e fece una
scelta deliberata: andare a pescare tra gli esponenti di spicco dei principali partiti anti-fascisti
dell’epoca. Questa strategia si basava sulla nomina politica di personalità che potessero
offrire una nuova immagine del paese una volta all’estero, che potessero fungere da specchio
della “nuova Italia” appunto, per rimarcare con forza la discontinuità col recente passato
fascista. Data la particolarità del caso, era preferibile inoltre che esse conoscessero già a
sufficienza i paesi di accreditamento, e che fossero in qualche modo “in sintonia” con
l’ambiente politico del luogo. Così a Londra fu inviato il conte Carandini, liberale; in Francia il
socialista Saragat, che vi aveva vissuto durante l’esilio; ed a Mosca, unica eccezione, il
diplomatico di carriera Pietro Quaroni, ma solo per ragioni puramente logistiche. Quaroni, al
momento della nomina, si trovava a Kabul, quindi trovandosi già “oltre le linee” era l’unico
che avrebbe potuto raggiungere l’Unione Sovietica agevolmente. Oltre a ciò, egli era anche
uno dei pochi diplomatici italiani dell’epoca a conoscere il russo.
Restava vacante la sede più importante dal punto di vista strategico: Washington.
L’egemonia statunitense sulla seconda metà del Novecento non è una sorpresa per chiunque
abbia una minima conoscenza storica del periodo. L’America fu per l’Europa fonte di
protezione militare e di sostegno economico, modello di crescita e di articolazione politica,
finanche il processo di unificazione europea fu stimolato dal volano statunitense, come non
tutti forse sanno. Ma se questa dipendenza era valida per buona parte delle nazioni europee,
lo era a fortiori per l’Italia. Non esisteva, a conti fatti, altro paese che avrebbe potuto
assicurare quella crescita economica e quella sicurezza militare di cui il nostro paese aveva
bisogno, se non l’America.
Per la carica di primo ambasciatore d’Italia del dopoguerra negli Stati Uniti, De Gasperi scelse
infine Alberto Tarchiani, sessantenne giornalista ed esponente politico di spicco del Partito
d’Azione, che aveva vissuto a lungo in passato negli Stati Uniti, prima come corrispondente e
poi esule dal fascismo.
Alberto Tarchiani, Roma, 11 novembre 1885 – Roma 30 novembre 1964 è stato un
giornalista, politico e diplomatico italiano
Il rapporto tra i due iniziò con una certa diffidenza da parte dello statista trentino, ma in
seguito sarebbe divenuto molto più stretto, con Tarchiani a fungerne da «occhio e […] mente
negli Stati Uniti, paese che [De Gasperi] conosceva poco e rispetto a cui non si muoveva con
la stessa sicurezza che in Europa.
Ed è utile ed interessante studiare il decennio di Tarchiani a Washington, perché – stante la
sede di destinazione ed il periodo storico – egli si trovò a misurarsi con tutti i nodi
fondamentali e dirimenti della politica estera italiana dell’epoca, i quali toccarono sempre
Roma passando però per Washington.
Rappresentare un paese quale l’Italia nel 1945 non era di certo compito facile.
La classe dirigente italiana, infatti, fondò la condotta della politica estera dopo il Secondo
Conflitto mondiale su due ordini di ragionamento, entrambi a dir poco fallaci: il primo era che
«la guerra era stata perduta dal fascismo, non dalla nazione italiana», distinzione assai
scabrosa, di cui gli interlocutori esteri difficilmente avrebbero colto l’eventuale veridicità.
Tarchiani scriverà pure nel suo diario che «vi erano anche coloro che, per essere sempre stati
avversi all’avventura fascista all’interno e all’estero, non si sentivano minimamente colpevoli,
[ed] avevano sempre sostenuto che l’Italia era stata vittima di un colpo di Stato e di poteri
arbitrari e irresponsabili, e non poteva essere chiamata a risarcire danni da cui essa stessa
aveva, e più di ogni altro, subìto nocumento e offesa». In secondo luogo era presente il
concetto che «il mondo, dopo il conflitto, sarebbe stato retto dalle stesse norme che avevano
regolato nell’anteguerra i rapporti fra gli Stati» , anche in questo caso riflessione che
mancava di cogliere lo spirito dei tempi che si preannunciava, ossia l’irrigidimento prodotto
nelle relazioni internazionali dall’imminente conflitto bipolare.
Essendo queste le premesse e le aspettative italiane, non meraviglia che i primi anni dopo il
’45 furono tutti un inanellarsi di delusioni e fallimenti per Roma, per De Gasperi e per
Tarchiani. Il primo smacco che la “nuova Italia” dovette incassare, in ordine di tempo, fu la
mancata ammissione alla Conferenza di San Francisco, e quindi alla costituenda
Organizzazione delle Nazioni Unite. Nonostante il motivo ufficiale fosse solo che la lista dei
paesi invitati era già stata diramata e quindi immodificabile, la realtà era che si voleva
impedire a Mosca di sollevare una questione analoga con i tanti altri paesi del blocco
comunista anch’essi rimasti fuori dal consesso.
A nulla valsero le perorazioni dell’ambasciatore presso il Dipartimento di Stato, Roosevelt
prima e Truman poi; a nulla servì rimarcare che «dopo tanti sacrifici, tante rovine, tante
prove di buona volontà» il popolo italiano fosse ancora considerato «il paria della situazione
internazionale, il povero che si lascia alla porta».
Futile fu appigliarsi al fatto che l’Italia «malgrado le sue attuali sventure […] [fosse] la più
grande delle Nazioni escluse, a vario titolo, dalla Conferenza».
Addirittura foriero di un’altra grave delusione fu l’idea, venuta allo stesso Tarchiani, di
propiziare l’ingresso italiano a San Francisco con un’ingenua e intempestiva dichiarazione di
guerra italiana al Giappone, che era ormai in ginocchio ma non ancora battuto.
La dichiarazione alla fine ci fu, perché Tarchiani si era esposto troppo con i suoi interlocutori
americani, ed ovviamente si trattò solo di un gesto a dir poco simbolico, ma non servì a nulla.
Non solo l’Italia non sarebbe stata ammessa all’ONU, ma per di più si aggiungerà la beffa al
danno, e il Trattato di pace siglato tra Giappone e Alleati non menzionerà in alcun punto
l’Italia . Ma la rielaborazione della perdita di status del nostro paese doveva ancora passare la
fase più acuta.
Chi si accosta ai diari, corposi, scritti dall’ambasciatore Tarchiani durante il suo decennio di
permanenza a Washington a primo acchito potrebbe restare spiazzato: da lettore inesperto
della materia ci si potrebbe stupire infatti che l’argomento principale di più di due terzi
dell’opera sia (apparentemente) privo di legami con gli Stati Uniti: ossia una città
oltreoceano, situata a più di settemila chilometri ad Est di distanza: Trieste. Lo stupore,
tuttavia, sarebbe inadeguato.
A partire dalla notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 1945, quando la città di San Giusto fu
invasa dalle truppe di occupazione jugoslave che vi rimasero per oltre un mese, la Questione
Giuliana prima, e Triestina poi, sarebbe divenuta nelle parole dello stesso Tarchiani «il
problema territoriale dominante per la diplomazia italiana».
Il confine nordorientale del nostro paese verrà amputato dell’Istria, in seguito al Trattato di
pace che l’Italia fu costretta a firmare alla Conferenza di Parigi del ‘47. Subìta l’onta della
perdita di territorio, ormai saldamente controllato dalle truppe del Maresciallo Tito e per
liberare il quale sarebbe occorsa una vera e propria nuova offensiva a guerra ormai conclusa,
l’Italia dovette incassare un altro torto spaventevole: la perdita della stessa Trieste.
Truppe Jugoslave titine entrano a Trieste
In sede di stesura del Trattato si decise di seguire la proposta francese che prevedeva la
divisione del territorio giuliano, conteso tra Italia e Jugoslavia, in due parti: la Zona A e la
Zona B. Quest’ultima comprendeva l’Istria e sarebbe andata sotto il controllo di Belgrado, la
prima invece includeva Trieste e sarebbe stata controllata dagli angloamericani del GMA . Nei
diari di Tarchiani, il cosiddetto Territorio Libero di Trieste (TLT) formato appunto dalle due
zone, viene definito senza mezzi termini «un mostruoso aborto, nato dal connubio del
principio apparente di giustizia con una effettiva sopraffazione».
Nato per essere solo una sistemazione provvisoria, il TLT si sarebbe invece stabilizzato nel
tempo, nonostante gli sforzi di De Gasperi, e Tarchiani in primis, per tentare in ogni modo di
sanare la «ferita principale» ricevuta dall’Italia quale punizione per le colpe passate.
Da tale punto di vista, non deve meravigliare dunque che l’ambasciatore avvertisse come se
in qualche modo la missione per Trieste fosse uno dei principali compiti che gli erano stati
affidati. Era scontato che le leve principali da muovere fossero quelle statunitensi, essendo
l’America il principale paese che poteva fornire aiuto e supporto all’Italia.
Eppure il cammino per risolvere la questione sarebbe stato molto lungo.
Il biennio ‘47-’49 apportò i primi successi alla politica estera italiana.
La guerra fredda ormai incombeva, granitica presenza, contrasto prima silente ma poi vie più
palpabile tra Occidente e blocco sovietico.
L’Italia – che peraltro era territorio di confine tra i due blocchi (a causa di Trieste, poiché Il 5
aprile 1945 Tito aveva siglato un trattato di assistenza e mutua collaborazione con Stalin) –
aveva aderito prontamente al Piano Marshall, trattandosi unicamente di ricevere
finanziamenti; ma quando, a partire dal 1947, si cominciò a parlare di alleanze militari, e
riarmo, per contrapporsi alla sovietizzazione già incipiente nell’Est-Europa, a Roma si capì
che adesso si trattava di fare una chiara scelta di campo.
Tutti i diplomatici dell’epoca, ma Tarchiani – ancora una volta meglio degli altri – avvertirono
chiaramente, compresero, e diedero comunicazione a Roma, del fatto che era ormai prossima
la creazione di un sistema organico di difesa e cooperazione politica tra le nazioni europee e
gli Stati Uniti.
Restarne fuori sarebbe stato un errore strategico di gravità incalcolabile.
Sebbene a posteriori possa risultare difficile immaginare che il nostro paese potesse
abbracciare il campo comunista, avendo già beneficiato degli aiuti dell’European Recovery
Program e soprattutto essendo stato liberato dalle forze alleate, ciò nondimeno va detto che i
venti del neutralismo terzaforzista spiravano in modo consistente, alimentati dalla sinistra
socialiste, dalla Chiesa, e da una parte della stessa Democrazia Cristiana.
Bisognava dunque decidere, ma De Gasperi aveva capito intelligentemente che, prima di
discutere di una questione cruciale del genere, andava superato lo scoglio delle elezioni
politiche. Pertanto una volta che le consultazioni dell’aprile 1948 ebbero consegnato la
vittoria alle forze che chiaramente si identificavano col blocco occidentale , poté ragionarsi in
modo approfondito dell’adesione o meno dell’Italia al futuro Patto Atlantico, e delle condizioni
a cui farlo.
Nell’estate di quell’anno si ebbe una fitta rete di comunicazioni scritte tra i principali
ambasciatori dell’epoca ed il conte Sforza, nominato ministro degli Esteri l’anno precedente .
Partendo da un documento dell’ambasciatore a Mosca, Manlio Brosio, in cui si sosteneva che
la scelta migliore da cui il paese avrebbe più beneficiato era la neutralità (!!), si svilupperà un
vero e proprio “carteggio sulla scelta di campo”, in cui Tarchiani sarà uno dei critici più
spietati delle tesi brosiane, dimostrando ad abundantiam che la neutralità non era scelta né
logica, né fattibile e né conveniente per l’Italia.
Manlio Brosio – 1897-1980
In uno scritto dell’ambasciatore a Washington, rivolto a Sforza, che vale la pena riportare per
intero, si testimonia non solo il vigore dialettico e concettuale del diplomatico, ma anche con
quanta passione e coinvolgimento egli vivesse quei momenti:
[…] non può esistere equidistanza: – quando da un lato si sono ricevuti e si ricevono enormi
aiuti materiali e politici, e dall’altro nulla, se non richieste di riparazioni;- quando da un lato vi
è il piano Marshall in funzione da cui dipende notevole parte del nostro vivere e del nostro
assestamento, e dall’altro soltanto la promessa di una palingenesi comunista; – quando da un
lato si può essere armati e messi in grado di difenderci, e dall’altro, non v’è speranza di
protezione, ma v’è invece minaccia d’insurrezione interna o d’invasione straniera; – quando
da un lato v’è chi ci vuol dare Trieste e dall’altro chi ce la vuol togliere; chi ogni giorno ci
appoggia con ogni sorta di interventi, di agevolazioni e di favori da noi richiesti, e chi, ogni
giorno ci ostacola (perfino nel caso di un modesto posto nelle N.U.); – quando da un lato vi
sono gli Stati Uniti con interessi italiani enormi (e tra gli altri quello di molti milioni di emigrati
del nostro sangue, il cui apporto all’Italia è noto) e dall’altro l’U.R.S.S. che d’italiani non ha
che sepolti e dispersi; “Equidistanza” non mi sembra né parola né fatto possibile. Perciò sono
costretto a ripetere una volta ancora: cerchiamo di proteggerci quanto è possibile prima che
sia troppo tardi, appoggiandoci fermamente a coloro che hanno, secondo ogni ragionevole
previsione, fondate probabilità di vincere una guerra che purtroppo, per moltissimi sintomi,
mostra di avvicinarsi .
De Gasperi e Sforza, tuttavia, erano riluttanti a schierarsi apertamente; forse memori ancora
del clamoroso disastro che era stato il Patto d’acciaio, ed in fondo consapevoli della scarsa
voglia con cui l’opinione pubblica italiana voleva sentir parlare ancora di alleanze militari. Di
certo essi non erano in grado, quasi per un blocco psicologico, di mandare quel forte segnale
di buona volontà, sicuro e definitivo, che gli Stati Uniti si aspettavano per inserire anche
l’Italia nel sistema difensivo occidentale. Si tenga conto che militarmente l’Italia di quegli
anni era a tutti gli effetti incapace di rispondere a qualunque attacco le fosse portato. Che ciò
fosse dovuto, in buona parte, anche al contingentamento imposto al naviglio di guerra,
all’esercito, ed all’aviazione, dal Trattato di pace punitivo, è di certo un altro aspetto della
questione da tenere in buona considerazione.
Washington infatti non era tendenzialmente ostile ad accettare un partner come Roma, che –
si consideri – sarebbe stato sostanzialmente un peso per gli altri membri dell’alleanza,
obbligati a difendere il vero e proprio anello debole della catena. Tuttavia, per farlo, gli Stati
Uniti si attendevano una prova inconfutabile del fatto che Roma volesse entrare a far parte
dell’alleanza senza distinguo, mercanteggiamenti o clausole di altro tipo.
Si consideri che già in precedenza, a marzo del 1948, Francia, Gran Bretagna e i paesi del
Benelux si erano uniti nel “Patto di Bruxelles”, in risposta alla precondizione richiesta dagli
Stati Uniti per un impegno militare difensivo di Washington nei confronti del Vecchio
Continente: ossia che si avesse una minima forma di coordinamento politico tra gli Stati
europei. L’Italia, che era stata invitata ad aderire (ma ad aprile avrebbe avuto la
consultazione elettorale, come si ricorderà) clamorosamente sceglierà di rifiutare,
provocando «un irritato e diffidente stato d’animo» al Dipartimento di Stato.
In questo clima di attesa negli Stati Uniti ed irresolutezza in Italia, il nostro paese rischiò in
modo pericoloso di essere seriamente lasciato ai margini del nuovo sistema difensivo
atlantico, ed alla fine fu proprio grazie a Tarchiani se si diede la spallata risolutiva, recidendo
– in altri termini – quello che ormai era chiaramente divenuto un nodo gordiano.
In risposta ad un ennesimo memorandum inviato da Sforza, titubante ed inconcludente come
al solito, ma in cui si aggiungeva in modo significativo che per la prima volta all’ambasciatore
era lasciata ampia facoltà di emendamento dello stesso testo , il diplomatico si avvalse
largamente di tale facoltà concessagli ed una volta per tutte trasformò leggermente il senso
del documento, in modo però che questa volta fosse ciò che gli americani volevano leggere .
Mentre la prima versione del testo recitava – come «candida espressione del nostro [scrive
Sforza, N.d.A.] pensiero» – che il documento aveva come scopo «quasi esclusivo di far
conoscere al Governo americano i nostri pensieri più intimi e l’autentico stato d’animo
dell’opinione pubblica italiana», adesso nella versione rimaneggiata da Tarchiani i dubbi
erano stati spazzati via. Si leggeva:
«[il] Governo italiano vede con favore sua eventuale partecipazione Patto attualmente in
discussione, destinato organizzare difesa politico-militare Occidente, nonché a relative
trattative»
E dopo aver sottolineato la necessità di avere delle rassicurazioni sulla situazione che il TLT
rappresentava, avendo la promessa che questo sarebbe stato incluso nella zona di protezione
(poichè, titubanze o meno, questo era il reale problema del Governo italiano. Si pensi che le
truppe titine erano a poca distanza dalle mura triestine), si affermava con chiarezza:
«[…] qualora tale precisazione pervenisse [sul TLT, N.d.A.], Governo italiano sarebbe lieto
mettere in moto, per partecipazione a Patto e a relative trattative, quella procedura che fosse
per essere stabilita».
Era finalmente il passo decisivo per mettere in moto a cascata gli eventi successivi. Di certo
non si può dire che, dopo il telegramma emendato da Tarchiani, la strada per l’ingresso
dell’Italia nel Patto Atlantico si trasformò tutta in discesa, ma per lo meno il processo fu
attivato.
Gli altri membri della costituenda alleanza continuavano a rimanere dubbiosi sull’utilità
dell’ingresso di Roma, come è stato detto in precedenza, alcuni finanche ostili (e.g. i paesi del
Benelux). Alla fine fu solo grazie alla Francia che il nostro paese poté essere ammesso, nelle
vesti del suo ministro degli Esteri, a firmare il Trattato dell’Atlantico del Nord, il 4 aprile 1949.
Nato: l’organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord
Parigi aveva infatti fatto della partecipazione italiana addirittura una questione pregiudiziale
e non per buonismo s’intende, ma per estendere il baricentro strategico più a sud, nel
Mediterraneo, in modo da poter coprire anche l’area algerina. Fu, quindi, grazie a questo
preziosissimo supporto strategico d’oltralpe che il nostro paese diventò uno dei membri
originari della futura NATO; ciò nonostante, dal punto di vista interno (e anche per quanto
riguarda l’azione diplomatica svolta presso gli Stati Uniti) l’operato di Tarchiani fu
fondamentale. Non a caso, Egidio Ortona, a quel tempo diplomatico di sede appunto
all’ambasciata d’Italia a Washington, scriverà queste parole nel suo diario:
Sono esattamente quattro anni che Tarchiani, allora rappresentante di un paese ancora
nemico, presentava le sue credenziali al Presidente Roosevelt. Oggi è raggiante. Mi dice che
se dovesse farsi guidare dal suo buon senso oggi scriverebbe a De Gasperi rassegnando le
sue dimissioni per completata missione!
Per approfondimenti:
_S. Romano, Guida alla politica estera italiana, Milano, Rizzoli, 2002
_G. Mammarella e P. Cacace, La politica estera dell’Italia. Dallo Stato unitario ai giorni nostri,
Bari, Laterza, 2010
_ P. Craveri, Prefazione a D. Fracchiolla, Un ambasciatore della “nuova Italia” a Washington.
Alberto Tarchiani e le relazioni tra Italia e Stati Uniti 1945-1947, Milano, Franco Angeli, 2012
_A. Tarchiani, Dieci anni tra Roma e Washington, Mondadori, Milano, 1955
_A. Ciarrapico, Le ombre della storia, Aracne, Roma, 2012
_A. Varsori, L’Italia nelle relazioni internazionali dal 1943 al 1992, Bari, Laterza, 1998
_D. De Castro, La questione di Trieste, vol. I, Lint, Trieste, 1981
© L’altro – Das Andere – Riproduzione riservata