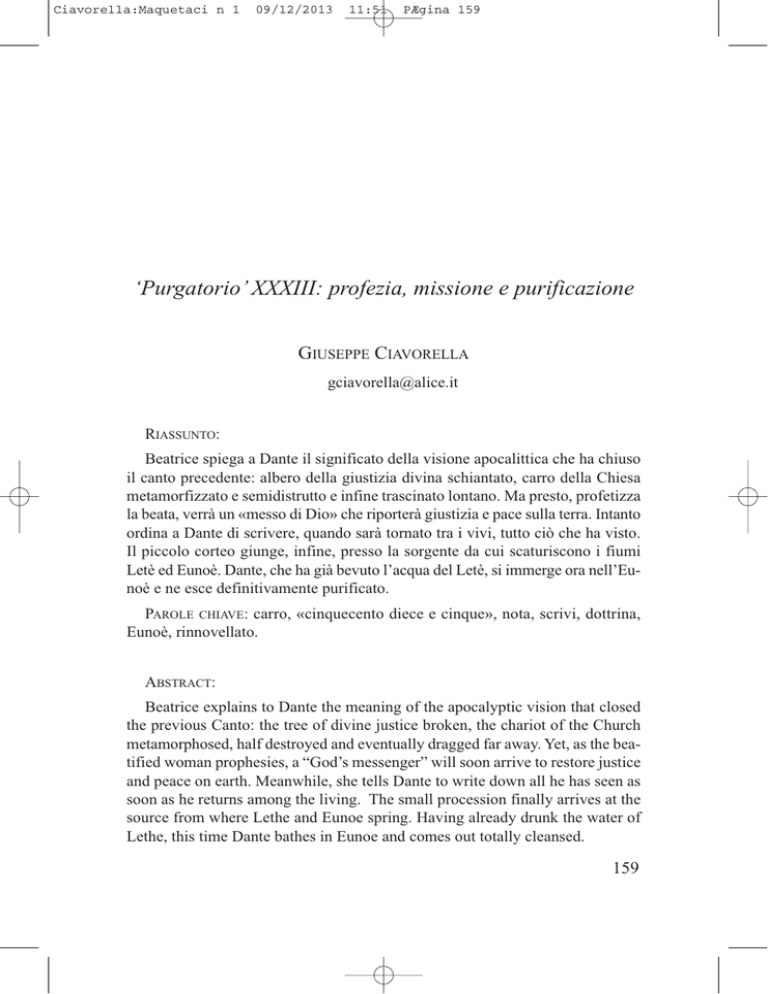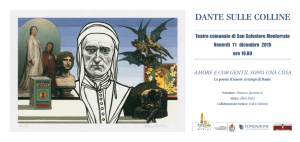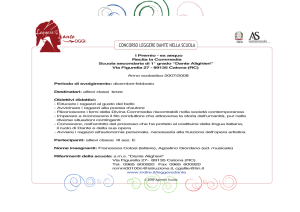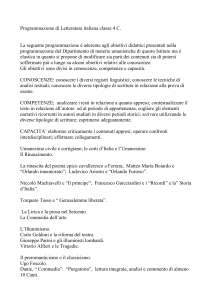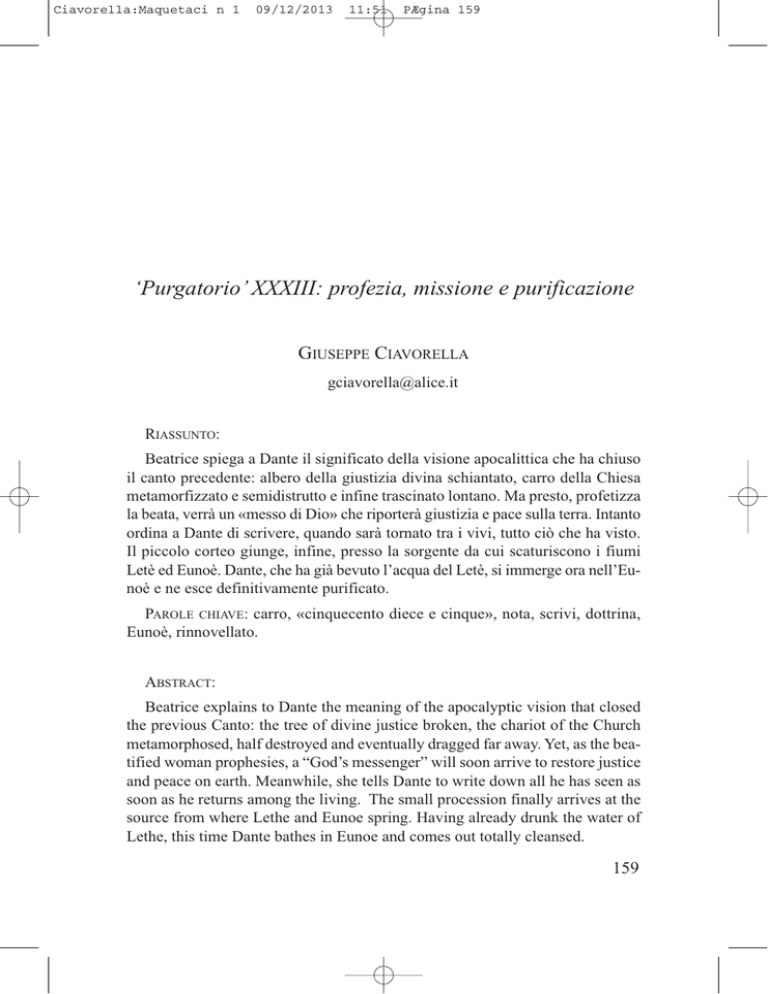
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
PÆgina 159
‘Purgatorio’ XXXIII: profezia, missione e purificazione
GIUSEPPE CIAVORELLA
[email protected]
RIASSUNTO:
Beatrice spiega a Dante il significato della visione apocalittica che ha chiuso
il canto precedente: albero della giustizia divina schiantato, carro della Chiesa
metamorfizzato e semidistrutto e infine trascinato lontano. Ma presto, profetizza
la beata, verrà un «messo di Dio» che riporterà giustizia e pace sulla terra. Intanto
ordina a Dante di scrivere, quando sarà tornato tra i vivi, tutto ciò che ha visto.
Il piccolo corteo giunge, infine, presso la sorgente da cui scaturiscono i fiumi
Letè ed Eunoè. Dante, che ha già bevuto l’acqua del Letè, si immerge ora nell’Eunoè e ne esce definitivamente purificato.
PAROLE CHIAVE: carro, «cinquecento diece e cinque», nota, scrivi, dottrina,
Eunoè, rinnovellato.
ABSTRACT:
Beatrice explains to Dante the meaning of the apocalyptic vision that closed
the previous Canto: the tree of divine justice broken, the chariot of the Church
metamorphosed, half destroyed and eventually dragged far away. Yet, as the beatified woman prophesies, a “God’s messenger” will soon arrive to restore justice
and peace on earth. Meanwhile, she tells Dante to write down all he has seen as
soon as he returns among the living. The small procession finally arrives at the
source from where Lethe and Eunoe spring. Having already drunk the water of
Lethe, this time Dante bathes in Eunoe and comes out totally cleansed.
159
Ciavorella:Maquetaci n 1
Tenzone 14
09/12/2013
11:51
PÆgina 160
2013
KEY WORDS: chariot, «five hundred, ten and five», note, writest, doctrine,
Eunoe, renewed.
Siamo all’ultimo atto del grandioso dramma liturgico che si svolge nel
Paradiso terrestre, e che ha come attori protagonisti Dante e Beatrice,
come attori secondari Matelda, Virgilio e Stazio e come comparse, più o
meno attive, «cento» angeli e alcune decine di figure simboliche. Un
dramma che si svolge in cinque atti: nel primo, che ha funzione di introduzione, Dante arriva nell’Eden e incontra Matelda (canto XXXVIII); nel
secondo, avanza la processione allegorica dei libri sacri del Vecchio e del
Nuovo Testamento, con al centro il carro della Chiesa (canto XXIX); nel
terzo, appare in trionfo Beatrice, che rimprovera duramente Dante peccatore e lo costringe ad una umiliante confessione, cui segue l’immersione
purificatrice del pentito nel Letè (cc. XXX-XXXI); nel quarto, Dante assiste al “mistero” della «pianta dispogliata», è investito da Beatrice della
missione di scrivere, «in pro del mondo che mal vive», tutto ciò che vede,
e assiste alla visione apocalitica della degenerazione della Chiesa (canto
XXXII); nel quinto (quello che ora esamineremo, costituito dal canto
XXXIII) Beatrice rinnova a Dante il conferimento della missione poetica,
profetizza la venuta di un «Cinquecento Diece e Cinque», restauratore
della giustizia e della pace nella Chiesa e nell’Impero, e invita infine il
pellegrino all’immersione finale rigenerante nell’Eunoè, che lo rende
«puro e disposto a salire a le stelle».
Quando incomincia l’ultimo canto del Purgatorio è quasi mezzogiorno:
sono passate sei ore da quando Dante ha messo piede nel Paradiso terrestre (era da poco sorto il sole). La visione apocalittica è appena terminata
e le sette Virtù, che hanno assistito insieme con Beatrice, Dante, Matelda
e Stazio al triste spettacolo/visione della progressiva devastazione e corruzione della Chiesa, cantano in lacrime il Salmo 79 [78], che incomincia
con le parole: «Deus, venerunt gentes»; e lo cantano in modo antifonale,
‘alternandosi’, cioè, nel canto dei versetti, ora le tre Virtù teologali ora le
quattro Virtù cardinali.
160
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
PÆgina 161
Purgatorio XXXIII
Giuseppe CIAVORELLA
‘Deus, venerunt gentes’, alternando
or tre or quattro dolce salmodia,
le donne incominciaro, e lagrimando;
e Beatrice, sospirosa e pia,
quelle ascoltava sì fatta, che poco
più a la croce si cambiò Maria.
(vv. 1-6)
È una «dolce salmodia» quella cantata dalle Virtù, ma di una dolcezza
dolorosa, perché le parole del salmo esprimono dolore profondo, come
doloroso è stato lo spettacolo della visione apocalittica, che al salmo è in
parte ispirata:
Deus,venerunt gentes in hereditatem tuam. (polluerunt templum
sanctum tuum, / posuerunt Ierusalem in ruinas. […] Usquequo,
Domine? Irasceris in finem? […] / Adiuva nos, Deus salutaris nostri, / propter gloriam nominis tui et libera nos; / et propitius esto
peccatis nostris propter nomen tuum. […] Et redde vicinis nostris
[…] quod exprobaverunt tibi, Domine» [O Dio, sono venute genti
straniere nei tuoi possedimenti, / hanno profanato il tuo sacro Tempio, / hanno ridotto Gerusalemme in rovina. [...] / Fino a quando,
o Signore? Sarai sdegnato per sempre? [...] / Soccorrici, o Dio, nostro salvatore / per la gloria del tuo nome e liberaci; / e perdona le
nostre colpe per amore del tuo nome [...] / Fa’ ricadere sui nostri
vicini [...] / l’oltraggio che ti hanno fatto, Signore].
Il salmo si riferisce alla conquista di Gerusalemme da parte dei Babilonesi, alla sua distruzione e alla conseguente schiavitù degli Ebrei a Babilonia; il canto del Salmo, qui nel Paradiso terrestre, è perciò un
commento melodico alla visione apocalittica, terminata con l’immagine
del carro della Chiesa trascinato nel folto della selva dal gigante: la Chiesa
avignonese serva dei re di Francia, come il popolo ebreo fu schiavo dei
re di Babilonia. Ma il canto è anche in relazione con ciò che Beatrice dirà
fra poco a Dante: come il salmista invoca la vendetta di Dio sui Babilonesi
e sui loro alleati (pur ammettendo le colpe degli Ebrei, dimentichi della
legge del Signore), così Beatrice prometterà la venuta di un «Cinquecento
161
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
PÆgina 162
Tenzone 14
2013
diece e cinque, / messo di Dio», che ristabilirà la dignità della Chiesa e riporterà l’ordine e la giustizia sulla terra. Intanto, sospirando pietosa,
ascolta la «dolce salmodia» delle Virtù, così trasfigurata dal dolore che
Maria, ai piedi della croce, dovette mutarsi nel volto poco più di lei. Tutto
il dolore del Vecchio e del Nuovo Testamento è richiamato, in pochi versi,
a dare la misura della tragedia che la Chiesa e l’Europa politica contemporanea stanno vivendo. «Un gruppo gotico di iacoponica espressività»,
commenta Franco Lanza (1967: 1217).
Ma poi che l’altre vergini dier loco
a lei di dir, levata dritta in pè,
rispuose, colorata come foco:
‘Modicum , et non videbitis me;
et iterum, sorelle mie dilette,
modicum, et vos videbitis me’.
(vv. 7-12)
Beatrice passa, per la terribile visione cui ha assistito e per il canto del
salmo che ha ascoltato, dal dolore all’indignazione, e infine all’appassionata profezia della resurrezione morale della Chiesa. Ricordiamo che Beatrice era rimasta seduta per terra presso il tronco dell’albero della
conoscenza del bene e del male, ‘innovato’ di foglie e fiori, anche durante
lo spettacolo apocalittico; ora si alza in piedi accesa di sacrosanto sdegno.
Sembra rivolgersi solo alle Virtù, in risposta al loro canto («rispuose»), ma
le sue parole riguardano anche, anzi soprattutto, Dante, che vede, ascolta
e, «ritornato di là», dovrà tutto riferire con assoluta precisione, dando testimonianza di come la realtà storica terrena, ecclesiale e politica, sia vista
e giudicata in cielo. Le parole latine sono riprese fedelmente dal Vangelo
di Giovanni (16, 16): Gesù annuncia agli Apostoli, durante l’ultima cena,
la sua prossima morte («Modicum, et non videbitis me» [Ancora un poco
e non mi vedrete]) e la sua resurrezione («et iterum modicum, et videbitis
me» [e di nuovo ancora un poco, e mi vedrete]). Ma il linguaggio di Gesù
non è chiaro: Egli parla «per similitudini» (in proverbiis), e i discepoli
162
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
PÆgina 163
Giuseppe CIAVORELLA
Purgatorio XXXIII
non capiscono, e glielo dicono, infatti, ma credono ugualmente. E anche
Beatrice parla (e parlerà ancora) «per similitudini», usando le parole di
Gesù, o un linguaggio simile a quello di Gesù; e Dante crederà, anche se
non capirà, e riferirà fedelmente. Beatrice è qui, chiaramente, figura di
Cristo e della Chiesa. Le sue parole qui, e soprattutto più avanti, come si
vedrà, non sembrano alludere ad altro che alla speranza, anzi alla certezza
di una riforma morale della Chiesa (Beatrice vede in Dio e Dante crede
fermamente nelle parole di Beatrice beata, parola vivente di Dio). Ma alcuni significativi indizi (il salmo «Deus, venerunt gentes» cantato dalle
Virtù, alludente all’esilio babilonese; il fatto che le parole di Beatrice
siano una «risposta» al canto delle Virtù; l’allusione inequivocabile, nella
visione apocalittica, al trasferimento della sede pontificia in terra di Francia [Purg. XXXII, 148-60], e quindi al lungo periodo di permanenza in
quella regione, definito spesso ‘cattività babilonese’ [o ‘avignonese’] o
‘esilio babilonese’; infine il tono acceso, quasi un grido, con cui Beatrice
cita le parole di Gesù), autorizzano una più precisa, e più semplice, interpretazione: la sede pontificia resterà a Roma ancora per poco, poi sarà
trasferita in Provenza (1305), ad Avignone (1308); ma non resterà a lungo
in terra di Francia, poi tornerà nuovamente a Roma. Ovviamente, in questa interpretazione, il trasferimento della sede pontificia è una profezia
post eventum (quando Dante scrive il canto XXXIII del Purgatorio [probabilmente nel 1313] il trasferimento è già avvenuto), mentre il ritorno
non lontano dei pontefici a Roma vuole essere una vera profezia, che però
non si è ancora avverata, né si avvererà essendo Dante vivo: i papi ritorneranno a Roma solo nel 1377. Il Poeta trasforma in profezia la sua grande
speranza.1 E che Dante possedesse in alto grado la virtù della Speranza,
lo sapeva benissimo Beatrice, che nel Cielo Stellato, quando Dante sta
per essere esaminato da S. Giacomo sulla seconda delle tre Virtù teologali,
afferma, sostituendosi al suo «fedele»:
«La Chiesa militante alcun figliuolo
non ha con più speranza, com’è scritto
163
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
PÆgina 164
Tenzone 14
2013
nel Sol che raggia tutto nostro stuolo:
però li è conceduto che d’Egitto
vegna in Ierusalemme per vedere,
anzi che ’l militar li sia prescritto».
Paradiso XXV, 52-57
E ci piace ricordare anche le parole che Bruno Nardi scrive a proposito
della convinzione di Dante che Dio avrebbe provveduto a riportare la giustizia sulla ‘terra desolata’: «E allora il sangue di Cristo fu dunque versato
invano? Dio avrebbe dunque abbandonato l’umanità al suo destino, e il
grande dramma cosmico dovrebbe concludersi colla vittoria dello spirito
del male? L’ottimismo cristiano di Dante e la sua fede nella provvidenza
gl’impedivano di pensare, non che di pronunziare, una simile bestemmia»
(19902: 265-326, alla p. 271).
Continuiamo con la nostra lettura.
Poi le si mise innanzi tutte e sette,
e dopo sé, solo accennando, mosse
me e la donna e ’l savio che ristette.
Così sen giva; e non credo che fosse
lo decimo suo passo in terrra posto,
quando con li occhi li occhi mi percosse;
e con tranquillo aspetto «Vien più tosto»,
mi disse, «tanto che, s’io parlo teco,
ad ascoltarmi tu sie ben disposto».
(vv. 13-21)
Si ricompone, in piccolo, il corteo, ripartendo dall’albero (tutti gli altri
componenti della grande processione sono risaliti in cielo; cfr. XXXII, 8890). Dirige la piccola processione Beatrice, che dispone l’ordine del corteo: davanti stanno le sette Virtù, con in mano i sette candelabri, poi viene
Beatrice, sola, in posizione centrale, seguono infine Dante, Matelda e Stazio: «quasi immagine – commenta Mario Apollonio – del ricostruirsi della
Chiesa nella illuminazione dello Spirito e con la salvaguardia intellettuale
della Rivelazione» (1951: 775). Dopo lo scatto di indignazione, Beatrice
164
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
PÆgina 165
Purgatorio XXXIII
Giuseppe CIAVORELLA
riacquista la serenità: ella sa, perché lo legge in Dio, che l’umiliazione
della Chiesa non durerà a lungo. Non è possibile dire se i ‘passi’ (nove o
dieci che siano) abbiano un significato allegorico: le congetture non sono
mancate. Ci limitiamo a ricordarne due: la prima (già avanzata dal Pascoli
(1952 [1904]: 1534) e riconfermata da M. Palma di Cesnola (1995: 67, ma
per la datazione degli eventi citati nel canto interessano tutte le pp. 73-97)
legge nei “quasi dieci passi” i quasi dieci anni che passano dalla morte di
Beatrice (8 giugno 1290) all’inizio del viaggio ultraterreno di Dante (8
aprile 1300): ne sarebbe conferma la «decenne sete» di Purg. XXXII 2;
la seconda vede nel numero un’allusione agli anni che intercorrono tra
l’anno del trasferimento della sede pontificia in Francia (1305) e l’anno
della morte di Clemente V e Filippo il Bello (1314), gli artefici (o responsabili) del trasferimento: tale congettura, avanzata da Ernesto Giacomo
Parodi (1965 [1921]: 245-47) implica, ovviamente, che questo canto, ultimo del Purgatorio, sia stato composto dopo la morte dei due personaggi;
il che, secondo gli studi più recenti, appare poco probabile. La prima ipotesi sembra perciò più plausibile.
Sì com’io fui, com’io dovea, seco,
dissemi: «Frate, perché non t’attenti
a domandarmi omai venendo meco?».
Come a color che troppo reverenti
dinanzi a suo maggior parlando sono,
che non traggon la voce viva ai denti,
avvenne a me, che sanza intero suono
incominciai: «Madonna, mia bisogna
voi conoscete, e ciò ch’ad essa è buono».
(vv. 22-30)
Beatrice (la quale “sa” che Dante desidera spiegazioni su ciò che ha
visto, perché «ritornato di là», dovrà riferire tutto in un poema) cerca di
mettere a suo agio Dante, ancora intimidito dalla bellezza celestiale della
donna, oltre che dalla severità con cui ella lo ha accolto. L’appellativo
«frate» (già tante volte usato dai penitenti incontrati lungo i gironi del
165
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
PÆgina 166
Tenzone 14
2013
Purgatorio) è espressione della carità che unisce, nel nome di Dio, le
anime salve; ma è la prima volta che Beatrice lo usa rivolgendosi a Dante.
Nota Umberto Bosco nel suo commento alla Commedia:
il rapporto tra Beatrice e Dante assume, già in questo canto, un carattere nuovo che rimarrà d’ora in poi costante. La donna cessa di
essere la donna dello stilnovo e anche la severa rampognatrice, per
diventare sollecita e amorevole ammaestratrice; Dante assume la
figura d’un docile scolaro, desideroso di apprendere, anche se talvolta sprovveduto, come appare subito in questo stesso canto».
Notazione certamente valida, ma che richiede forse qualche precisazione. Noi preciseremmo, per esempio, che Dante conserva, e conserverà
sempre, verso Beatrice “troppa reverenza”, un atteggiamento che rassomiglia molto a quello che oggi si usa definire complesso di inferiorità (il
senso di colpa, che le accuse di Beatrice avevano ridestato in lui, dovrebbe
essere stato, invece, cancellato dall’immersione nel Letè; ma non sempre
è così); dimostra ciò anche il «voi» con cui le rivolge (e sempre le rivolgerà) la parola (ha dato del «voi», per deferenza, anche a Farinata – che
in verità sa anche affrontare «a viso aperto» – e lo darà ancora a Cacciaguida), come «a suo maggior parlando». Aggiungeremmo che Dante non
può non averlo, il complesso di inferiorità: lo richiedono la situazione
narrativa (Beatrice è non solo beata, e non è solo la sua ‘salvatrice’, ma è
apparsa nel Paradiso terrestre fra «cento» angeli, «come Cristo» trionfante) e la psicologia del personaggio: non solo del Dante viator dell’oltretomba, ma dello stesso Dante della Vita nuova, che in presenza di
Beatrice era colto da tremore, e che mai a Beatrice viva ebbe il coraggio
di rivolgere la parola. I sentimenti del Dante della Commedia per Beatrice
beata, insomma, non sono molto diversi da quelli del Dante della Vita
nuova per Beatrice viva, ma già poeticamente ‘angelicata’: c’è sostanziale
coerenza, su questo, tra il libello giovanile e il poema della maturità. Che
la Beatrice della Commedia, poi, non sia più ‘la donna dello stilnovo’,
166
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
PÆgina 167
Purgatorio XXXIII
Giuseppe CIAVORELLA
era già manifesto fin dal suo colloquio nel Limbo con Virgilio (Inf. II, 52117).
Ed ella a me: «Da tema e da vergogna
voglio che tu omai ti disviluppe,
sì che non parli più com’om che sogna.
(vv. 31-33)
Si direbbe che Beatrice non apprezzi la risposta di Dante: vi legge ancora il timore e la vergogna con cui egli ha ascoltato le sue severe accuse
di traviamento, dopo ch’ella «di carne a spirto era salita» (Purg. XXX,
127). Un simile Dante non può scrivere tutto ‘quel che ha visto’ nello
spettacolo apocalittico della devastazione della Chiesa: che non era un
sogno ad occhi aperti, ma una terribile realtà storica presentata in forma
visionaria e simbolica. Deve perciò ‘svegliarsi’ e ragionare, per capire veramente il dramma religioso e politico che lacera il mondo cristiano e prepararsi alla grande e difficile missione che gli è stata affidata. Né, d’altra
parte, Beatrice ha finito di ammaestrarlo su ciò che ha visto: ha ancora da
rivelargli cose importantissime, che dovrà riferire al «mondo che mal
vive», e ha perciò bisogno di un Dante pienamente padrone di sé. Per questo lo scuote imperiosamente: «voglio». Così parlava ai profeti il Dio
degli Ebrei.2
Sappi che ’l vaso che ’l serpente ruppe,
fu e non è; ma chi n’ha colpa, creda
che vendetta di Dio non teme suppe.
(vv. 34-36)
È una terzina davvero ermetica (come ermetiche sono spesso le pagine
dell’Apocalisse, che Dante qui cita) e ne diamo, perciò, la parafrasi e la
spiegazione: ‘Sappi che il carro («vaso») che fu rotto dal drago («serpente»), non esiste più («fu e non è»); ma coloro che sono colpevoli di ciò,
credano pure che la giustizia punitiva («vendetta») di Dio è certa e presto
o tardi colpirà («non teme suppe»)’. Le parole «vaso» e «serpente» richiamano le parole «carro» e «drago» di Purg. XXXII, 131-32 (che si in167
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
PÆgina 168
Tenzone 14
2013
seriscono nella scena ‘apocalittica’ compresa nei vv. 130-35). Il carro
della Chiesa ha subìto una così mostruosa metamorfosi (Purg. XXXII,
136-47) ed è stato trascinato così lontano dalla sua vera sede (Purg.
XXXII, 157-60) che si può dire che (al tempo in cui Dante vede, ascolta
e scrive) non esista più agli occhi di Dio (qualcosa di simile dichiarerà S.
Pietro in Par. XXVII, 23-24: «il luogo mio che vaca / ne la presenza del
Figliuol di Dio»).3 L’espressione «fu e non è» è ripresa da Apoc. 17, 8:
«bestia quam vidisti fuit et non est» [la bestia che hai visto fu e non è]:
Dante cerca sempre un sostegno alle proprie parole profetiche nelle Scritture. Suona, però, piuttosto strana l’espressione con cui Beatrice accompagna l’annuncio dell’immancabile castigo divino: «non teme suppe». Le
spiegazioni sono state diverse. I commentatori trecenteschi della Commedia fanno riferimento ad un’usanza importata dalla Grecia secondo la
quale «se uno uccidea un altro, e egli potea andare nove dì continui a
mangiare una suppa per die suso la sepoltura del defunto, né ’l Comune
né i parenti del morto non faceano più alcuna vendetta. Ed usasi in Firenze
di guardare per nove dì la sepoltura d’uno che fosse ucciso, acciò che non
vi sia suso mangiato suppa» (Jacopo della Lana). Altre interpretazioni
sono state avanzate da commentatori successivi (fra cui Bernardino Daniello, Guido Mazzoni, Herbert D. Austin, Francesco Torraca); la più probabile, però, è ritenuta ancora quella trecentesca del Lana.
Ma il vocabolo [«suppe»] – commenta Franco Lanza – ha una sua
forza sarcastica e dispregiativa sufficiente, anche senza una proiezione storica, ad inserirlo in quelle espressioni che usualmente confortano, nel linguaggio dantesco, il distacco tra la giustizia e
l’empietà, l’altezza divina e la bassezza umana: simile, in tal funzione, a certe invettive dei beati che culmineranno nel “lascia pur
grattar dov’è la rogna” di Cacciaguida o nella “cloaca” maledetta
da San Pietro (Par. XVII 129 e XXVII 25) (Lanza in LDS 1967:
1221).
168
Non sarà tutto tempo sanza reda
l’aguglia che lasciò le penne al carro
per che divenne mostro e poscia preda;
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
PÆgina 169
Purgatorio XXXIII
Giuseppe CIAVORELLA
ch’io veggio certamente, e però il narro,
a darne tempo già stelle propinque,
secure d’ogn’intoppo e d’ogne sbarro,
nel quale un Cinquecento Diece e Cinque,
messo di Dio, anciderà la fuia
con quel gigante che con lei delinque.
(vv. 37-45)
Il riferimento è ancora alla visione apocalittica (Purg. XXXII, 124-126
e 157-160). L’aquila («aguglia») è simbolo dell’Impero (come il carro è
simbolo della Chiesa); il Poeta (per bocca di Beatrice) intende perciò dire
che l’Impero (istituzione divina, come la Chiesa) non resterà per sempre
vacante («sanza reda», ‘senza erede’). Dante, infatti, considerò l’Impero
vacante dopo la morte di Federico II (1250) «non ostante che Ridolfo e
Andolfo e Alberto poi eletti siano, appresso la sua morte e de li suoi discendenti» (Conv. IV III 6). Sarà vero «erede» Arrigo VII (1308-1313). Ma
si tenga presente che Dante considera vacante (per indegnità di chi lo occupa) anche il soglio pontificio (cfr. Par. XXVII, 23-24, cit.). Le due massime istituzioni terrene non hanno guida. Da questa convinzione scatta la
profezia del «Cinquecento Diece e Cinque». Beatrice usa un linguaggio
di tipo ‘astrologico’, ma è un uso, il suo, che può essere definito strumentale, perché, dovendo essa (Dante poeta, in realtà) fare una profezia, non
può non parlare «per similitudini» (in proverbiis, per usare la terminologia
evangelica), come usava talvolta Gesù con i suoi discepoli. Beatrice parla
‘astrologico’ perché, al tempo di Dante, la dottrina degli influssi stellari
(che, non si dimentichi, anche per i teologi avevano come causa prima
Dio, donde la ‘certezza’ di Beatrice, che in Dio legge il futuro) era comunemente accettata, e compresa. Ma per i lettori del nostro tempo è forse
meglio tradurre il linguaggio ‘astrologico’ dei vv. 40-45 in linguaggio
corrente: ‘perché io vedo con assoluta certezza, e perciò lo rivelo a te,
stelle ormai vicine a sorgere («propinque»), sicure di poter superare ogni
ostacolo e ogni sbarramento («sbarro»), che ci daranno («a darne») un
tempo nel quale un liberatore («un Cinquecento Diece e Cinque»), inviato
(«messo») da Dio, ucciderà («anciderà») la meretrice («fuia») insieme
169
Ciavorella:Maquetaci n 1
Tenzone 14
09/12/2013
11:51
PÆgina 170
2013
con quel gigante che con lei commette peccato («delinque»)’. Beatrice, in
sostanza, annuncia la non lontana venuta di un inviato divino (designato
misteriosamente con il numero «Cinquecento Diece e Cinque», in numeri
romani DXV, anagrammabili in DVX; in numeri arabi, 515), che riporterà
la giustizia nella Chiesa e nell’Impero, uccidendo sia la «fuia» (la «puttana sciolta» di Purg. XXXII, 149) sia il «gigante» (il «feroce drudo»
della «puttana»; Purg. XXXII, 152 e 155).4 Ci permettiamo di ricordare
che era «da ciel messo» l’angelo che aprì la porta della Città di Dite,
chiusa dai diavoli che non volevano far entrare Dante (Inf. IX, 85). Lo
sdegno di Beatrice ricorda lo sdegno del «messo» celeste che apre la porta
infernale: «Ahi quanto mi parea pien di disdegno! / Venne a la porta e
con una verghetta / l’aperse, che non v’ebbe alcun ritegno» (Inf. IX, 8890). Forse non è arbitrario ipotizzare un nesso fra il canto infernale e i
canti XXXII e XXXIII del Purgatorio.5
Ma l’enigma del numero «Cinquecento Diece e Cinque», al quale si è
soltanto accennato, richiede un discorso un po’ lungo. La discussione sul
significato da attribuire al misterioso numero con cui è identificato il
«messo di Dio» incomincia già nel Trecento, con i primi commentatori
della Commedia (Jacopo della Lana, l’Ottimo Commento, Pietro di Dante,
Benvenuto da Imola, Francesco da Buti). Subito, nella trascrizione in cifre
romane del numero 515, DXV, e nel relativo anagramma, DVX (cioè
DUX), si lesse un’allusione generica ad «uno Imperadore», ovvero ad
«alcuno giustissimo e santissimo Principe il quale reformerà lo stato della
Chiesa e de’ fedeli cristiani» (Ottimo Commento). Solo nel Cinquecento,
con il Vellutello e il Daniello, il «messo di Dio» è identificato con Arrigo
VII di Lussemburgo, «uomo di grandissimo valore e pieno di singular bontade e giustizia» (Daniello). Nel Settecento Pompeo Venturi e Baldassarre
Lombardi tornano a rilevare (dopo i primi commentatori del Trecento)
che Dante, nell’indicare il «messo di Dio» con un numero, imita «lo stile
profetico di san Giovanni nell’Apocalisse, ove il Santo indica il nome dell’Anticristo: “numerus eius sexcenti sexaginta sex” [il suo numero è seicento sessanta sei (in numeri romani: DCLXVI; in numeri arabi: 666)]» (B.
Lombardi). Commenta Pietro Mazzamuto (da cui soprattutto traiamo le
170
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
Giuseppe CIAVORELLA
11:51
PÆgina 171
Purgatorio XXXIII
informazioni in sintesi): «sono proposte che resteranno nella storia dell’esegesi del DXV».6 Nell’Ottocento le interpretazioni risentono spesso del
clima politico risorgimentale e nazionalistico. Al ‘tedesco’ Arrigo VII
viene preferito Cangrande della Scala (Niccolò Tommaseo), o addirittura
Uguccione della Faggiuola. Quando Dante compone l’ultimo canto del
Purgatorio, osserva il Tommaseo, Arrigo VII è già morto [in verità molti
studiosi sostengono che era ancora vivo, e di questo parere siamo anche
noi], mentre Cangrande, già nominato vicario imperiale, sarà capo della
Lega ghibellina nel 1318. Viene anche proposta un’interpretazione neoguelfa-clericale: DXV è acrostico di “Domini Xristi Vicarius” [Vicario
del Signore nostro Cristo], dove “Vicarius” è un papa; o si collega il numero «Cinquecento Diece e Cinque» con il Veltro di Inf. I, per cui DXV è
acrostico di “Domini Xristi Vertagus” [Cane da caccia di Cristo nostro
Signore], e si identificano Veltro e DXV. Nel Novecento i contributi più
originali vengono da Robert Davidsohn (1902) e, soprattutto, da Ernesto
Giacomo Parodi (1965 [1921]). Il Davidsohn ritiene che in «Cinquecento
Diece e Cinque» sia da leggere una data, e precisamente il 1315, «somma
dell’anno 800, nel quale ebbe luogo l’incoronazione di Carlo Magno, e del
515 del verso dantesco» (Mazzamuto): il 1315 è l’anno in cui Ludovico
di Baviera è eletto imperatore, ed è anche l’anno, secondo una leggenda
medioevale, in cui incomincerà una nuova fase della storia del mondo.
Se si ritiene valida la proposta del Davidsohn, la data di composizione
del nostro canto è da porre dopo il 1315 (o quanto meno ipotizzare una revisione del canto successiva al 1315). Il Parodi distingue nettamente tra
Veltro e DXV: il primo corrisponde ad una profezia incerta e approssimata,
il secondo ad un preciso personaggio storico, che non può che essere Arrigo VII, «vivo e presente» nel momento in cui Dante compone l’ultimo
canto del Purgatorio, «stretto e angustiato da terribili ostacoli, ma predestinato dalla volontà di Dio e dalla santità della sua missione a trionfarne
da ultimo con impreveduta facilità» (Parodi).7 E l’interpretazione del Parodi, per la rigorosa documentazione che la sostiene, è ritenuta ancora
oggi la più convincente tra le moltissime avanzate in sette secoli di studi
danteschi. È chiaro, però, che tale interpretazione presuppone che l’ultimo
171
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
PÆgina 172
Tenzone 14
2013
canto del Purgatorio sia stato composto prima della morte di Arrigo VII
(24 agosto 1313), cosa non impossibile, se si accetta come data certa
(come noi riteniamo), per la composizione del canto VI del Purgatorio, il
mese di dicembre 1310. Più recente l’interpretazione di Robert E. Kaske,
che vede nel DXV lo stesso Cristo, che ritorna sulla terra per sconfiggere
definitivamente l’Anticristo e fare giustizia (in DXV sarebbero da leggere
le lettere iniziali dell’espressione liturgica «Vere Dignum et iustum est»,
insieme con il simbolo della croce «X» [Kaske 1961: 185-254]). Andrea
Battistini ritiene convincente l’interpretazione del Kaske (in L’Alighieri
29, 2007: 98-99).
Nicolò Mineo (1998: 42-43) ritiene opportuno rinunciare ad identificare il DVX con un personaggio storico. Ecco che cosa scrive il critico in
un suo recente saggio (premetto che per Mineo la puttana e il gigante
dell’“apocalisse di Dante” raffigurano rispettivamente la Curia papale
corrotta e l’Anticristo, secondo l’interpretazione che dell’Apocalisse di
San Giovanni avevano data Gioacchino da Fiore e gli spirituali francescani, come Pietro di Giovanni Olivi e Ubertino da Casale):
Il nostro problema a questo punto sarà non già stabilire chi possa
essere il «Cinquecento diece e cinque», ma cosa questo rappresenti
dal punto di vista apocalittico-escatologico. Mentre non è certo da
dimostrare che la simbolizzazione nella forma del numero sia da
ricondurre alla strutturazione apocalittica e sia procedimento adottato in analogia col testo giovanneo. Orbene, la figura apocalittica
a cui la tradizione esegetica riconosce il compito continuato, dalla
passione di Cristo sino alla fine del mondo, di combattere alla testa
dei buoni contro le forze del male è l’angelo Michele, che in figura
di Cristo combatterà contro l’Anticristo reale. Quest’ultimo compito anzi è quello maggiormente messo in luce nei commenti all’Apocalisse. [...] Se pertanto l’erede dell’aquila combatterà, nello
spirito di Michele, e quindi di Cristo [...] contro l’Anticristo proprio, ne deriva che questo è da riconoscere nello stesso gigante.
Per ultima (perché la più recente) diamo l’interpretazione di Michelangelo Picone. Questi, convinto che esista una relazione tra la profezia del
172
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
Giuseppe CIAVORELLA
PÆgina 173
Purgatorio XXXIII
«Veltro» (‘cane da caccia, veloce ma anche grande’), del primo canto
dell’Inferno, e la profezia del «Cinquecento Diece e Cinque», dell’ultimo
canto del Purgatorio, propone di individuare, nel misterioso personaggio
alluso nel numero, Cangrande della Scala (individuazione peraltro non
nuova, come si è già detto); e propone, nello stesso tempo, di leggere (invece che «Cinquecento diece e cinque») «cinque cento diece e cinque»
(lettura che i manoscritti consentirebbero), cioè, in mumeri romani, VCXV;
in questa sigla si possono leggere – dichiara Picone – «le iniziali di una
frase che recita “Vicarius Canis in Christo Victoriosus”» [Cangrande Vicario Vittorioso in Cristo]. E spiega lo studioso: «Frase che non ci inventiamo noi, ma che corrisponde all’intitolazione dell’Epistola XIII, quella
contenente la dedica del Paradiso a Cangrande. Dice appunto il primo
comma di quella lettera: “Magnifico atque victorioso domino Cani Grandi
de la Scala sacratissimi Cesarei Principatus […] Vicario generali […]»
(Picone 2008: 92). In verità nell’intitolazione dell’Epistola XIII non compare il nome di Cristo («sacratissimi» è riferito a «Cesarei Principatus»,
e Cangrande risulta aver guerreggiato non nel nome di Cristo, ma dell’Imperatore, di cui era Vicario), ma la proposta di Picone, per la diversa
e nuova lettura del numero, ci pare che meriti di essere presa in considerazione non meno delle altre.
Rinunciamo ad esprimere una nostra interpretazione (ma cfr. la nota n.
5). Ci limitiamo a dire che la spiegazione data dai primi commentatori
della Commedia del Trecento (fra i quali sono, è bene ricordarlo, due autori che conobbero personalmente e intimamente Dante: Pietro figlio di
Dante, innanzitutto, e l’autore dell’Ottimo Commento [il notaro Andrea
Lancia?], che poterono ascoltare dallo stesso Poeta l’interpretazione che
essi ci hanno tramandato, e in particolare Pietro), che cioè l’“enigmatico”
numero è sigla di DXV=DVX, resta, dopo tanto discutere, la sola (quasi)
certezza, sulla quale la stragrande maggioranza degli interpreti non ha
difficoltà a consentire.
Riprendiamo la lettura del canto.
173
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
PÆgina 174
Tenzone 14
2013
E sappi che la mia narrazione buia,
qual Temi o Sfinge, men ti persuade,
perch’a lor modo lo ’ntelletto attuia;
ma tosto fier li fatti le Naiade,
che solveranno questo enigma forte
sanza danno di pecore o di biade.
(vv. 46-51)
Dopo il linguaggio ‘astrologico’, il linguaggio ‘mitologico’: della mitologia degli enigmi e delle profezie, che spesso annebbia il cervello, come
la stessa Beatrice avverte. Perché il linguaggio mitologico, se non si conoscono bene i miti, può essere anche meno comprensibile di quello astrologico (per rinfrescare la memoria del lettore, diamo perciò alcune
spiegazioni in nota sui miti citati, tanto più che Dante commette un errore
di citazione, che complica il discorso).8 Per semplificare ulteriormente la
lettura delle due terzine, obiettivamente difficile, diamo anche la parafrasi
dei versi: ‘E sappi che la mia profezia oscura, com’erano oscure quelle
fatte da Temi o dalla Sfinge, non ti persuade, perché come quelle ottenebra
(«attuia») l’intelletto; ma presto i fatti che accadranno saranno («fier») essi
stessi rivelatori («le Naiade»), e risolveranno questo difficile enigma senza
recar danno né a greggi né a campi coltivati’. Beatrice, cioè, non chiede a
Dante di sforzarsi di capire la profezia del «Cinquecento Diece e Cinque»:
non sarebbe in grado di capire (in verità Dante poeta sa che i lettori del
canto si proveranno a spiegare l’«enigma forte»; ed è questo, anzi, ch’egli
vuole, ed è questo che inevitabilmente tenteranno di fare i lettori).9
Tu nota; e sì come da me son porte,
così queste parole segna a’ vivi
del viver ch’è un correre a la morte.
E aggi a mente, quando tu le scrivi,
di non celar qual hai vista la pianta
ch’è or due volte dirubata quivi.
174
(vv. 52-57)
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
Giuseppe CIAVORELLA
11:51
PÆgina 175
Purgatorio XXXIII
È rinnovato da Beatrice in questi versi il conferimento della missione
poetica e profetica a Dante (cfr. Purg. XXXII, 103-105); e nello stesso
tempo è imposto al Poeta di riferire con la massima esattezza ciò che ha
visto e sentito: i fatti chiariranno anche ciò che ora sembra oscuro allo
stesso Dante, che vede e sente. Il critico Enzo N. Girardi mette in relazione, questo momento fondamentale del “viaggio”, con il capitolo conclusivo della Vita nuova, in cui Dante accenna al progetto di composizione
di un’opera poetica al cui centro sarà Beatrice. Scrive il Girardi (1989:
659):
Ora, poiché l’indizio più rilevante di tale progetto costruttivo della
Commedia lo si trova, com’è noto, già prima della Commedia, nel
finale della Vita nuova, là dove Dante dichiara essergli apparsa una
«mirabile visione, ne la quale io vidi cose che mi fecero proporre
di non dire più di questa benedetta infino a tanto che io potesse
più degnamente parlare di lei» – una visione, dunque, di cose legate a Beatrice, incentrate su Beatrice, tali da non poterne trattare
se non trattando di Beatrice; sembra logico che chi muove da questo primo indizio esterno verso il poema, dovendo scegliere un
punto d’arrivo che corrisponda per tema e per linguaggio a quella
partenza, lo trovi proprio qui, in questa mirabile visione di cose
assai più ardue e complesse di quelle della Vita nuova, comprensive dell’esperienza politica, filosofica e letteraria successiva al libello giovanile, ma tuttavia imperniate su Beatrice, interpretate da
lei, e, ancora, elaborate in un linguaggio traslato e visionario che
è molto simile a quello del libello stesso.
Il linguaggio di Beatrice è effettivamente «traslato e visionario» per
quanto riguarda il futuro: è un linguaggio profetico. Ma per quanto riguarda il passato e il presente ha la concretezza delle cose viste: quella del
duplice spettacolo della «pianta due volte dirubata» e della visione apocalittica; un linguaggio simbolico, certo, ma concreto, perché fatto di figure identificabili e di atti interpretabili. E se Dante ha qualche difficoltà
a capire (e dimostrerà di averle), ella è pronta a dare le spiegazioni necessarie. Aggiungeremmo una precisazione. Anche Cacciaguida e S. Pietro,
175
Ciavorella:Maquetaci n 1
Tenzone 14
09/12/2013
11:51
PÆgina 176
2013
nel Paradiso, conferiranno a Dante la missione di narrare al «mondo che
mal vive» ciò che ha visto in tutto il suo viaggio ultraterreno, e lo faranno,
certamente, con maggiore autorevolezza e solennità, proporzionate al loro
superiore prestigio gerarchico e al luogo celeste in cui si trovano; ma se
Dante ha voluto che la missione gli fosse conferita per prima da Beatrice,
lo ha fatto certamente per qualche motivo. Ora, noi crediamo che il motivo non possa essere che di riconoscenza; duplice riconoscenza: d’ordine
poetico e d’ordine religioso. Dante riconosce a Beatrice il merito di avergli ispirato, prima, la poesia d’amore che lo ha fatto uscire «de la volgare
schiera» (Inf. II, 105), e poi il grande «poema sacro», che lo porrà alla
pari (ne è convinto) con i grandi poeti classici. E riconosce a Beatrice
anche il merito, forse superiore al primo, di averlo salvato dalla «selva selvaggia», nella quale stava per smarrire irrimediabilmente la «diritta via».
E se il «poema sacro» gli è ispirato da Beatrice, poteva non essere Beatrice a conferirgli per prima la missione poetica e profetica, le cui origini
sono nella volontà di Dio? L’investitura missionaria che riceve da Beatrice
ha per Dante un significato più profondo di quelle che riceverà da Cacciaguida e San Pietro.
Torniamo al nostro testo, e precisamente al v. 54. Esso è la parafrasi di
un aforisma del De civitate Dei XIII, 10, di S. Agostino: «nihil aliud tempus vitae huius, quam cursus ad mortem» [il tempo della vita terrena non
è altro che un correre alla morte] (cfr. Purg. XX, 38-39, dove lo stesso
concetto è espresso con parole diverse). Scrive Vittorio Cian: «Un verso
tremendo questo, che resta la definizione più profondamente medievale
e plastica, nel suo ritmo rappresentativo, della vita terrena: una corsa alla
morte» (Cian 1958: 665). Beatrice ricorda in sostanza a Dante, perché lo
ricordi ai vivi, che la vita terrena deve essere vissuta nella prospettiva
della vita eterna. Quindi porta il discorso sulla «pianta», cioè sull’albero
della conoscenza del bene e del male, intorno al quale si è svolto il ‘mistero’ rappresentato nel canto XXXII. L’espressione «or due volte dirubata» è interpretata in modi diversi; accenniamo alle due spiegazioni più
accreditate (che risalgono rispettivamente ai commentatori trecenteschi
Francesco da Buti e Jacopo della Lana). L’avverbio «or» – osservano i so176
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
PÆgina 177
Purgatorio XXXIII
Giuseppe CIAVORELLA
stenitori della prima spiegazione – accenna al tempo presente e sembra
perciò far riferimento alla visione apocalittica appena svoltasi; l’espressione «due volte dirubata» dovrebbe allora intendersi: ‘derubata prima
dall’aquila (che scendendo sul carro ruppe foglie, fiori e scorza) e poi dal
gigante (che sciolse il carro dalla pianta e lo trascinò con sé nella selva)’.
Se si guarda alla sintassi, questa è l’interpretazione più plausibile. Non si
può non osservare, però, che l’aquila non deruba la pianta, ma la danneggia; e la distinzione è netta al v. 58. Se si guarda, invece, a tutta la rappresentazione allegorica che si svolge nel canto XXXII (e non solo alla visione)
e si dà a «or» il significato di ‘a questo punto, dopo quanto hai visto qui
nel Paradiso terrestre’, l’espressione «due volte dirubata» può intendersi:
‘derubata prima da Adamo (e quando la processione arriva presso la
pianta, questa è ancora «dispogliata» di foglie, fiori e frutti) e poi dal gigante (che trascina via il carro legato alla pianta: e il carro era stato legato
dal grifone alla pianta come cosa a lei appartenente; cfr. XXXII, 49-51)’.
Questa seconda interpretazione a me sembra più convincente.
Qualunque ruba quella o quella schianta,
con bestemmia di fatto offende a Dio,
che solo a l’uso suo la creò santa.
Per morder quella, in pena e in disio
cinquemilia anni e più l’anima prima
bramò colui che ’l morso in sé punio.
Spiega Lino Pertile:
(vv. 58-63)
l’albero è l’unica res che Dio creò per sé in tutto il Paradiso terrestre. Esso è dunque il segno e il simbolo del potere sovrano di Dio
e allo stesso tempo della condizione subalterna dell’uomo nel
creato. [...] La giustizia di Dio, dichiara Beatrice, si esprime non
solo nel decretum che vieta l’“uso” dell’albero all’uomo [Genesi
2, 16-17], ma anche nella forma stessa dell’albero (Pertile 1998:
165-66).
177
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
PÆgina 178
Tenzone 14
2013
La «bestemmia di fatto» è il sacrilegio, e si distingue dalla «bestemmia
di parola»: la prima, ovviamente, più grave della seconda. E poiché l’albero (come chiarirà fra poco Beatrice; vv. 71-72) è, simbolicamente, l’albero della giustizia divina, Adamo e il gigante (o il gigante e l’aquila, che
«schianta» l’albero e il carro, il cui timone è fatto col legno dell’albero
[cfr. Purg. XXXII, 51]; o, meglio ancora, Adamo, l’aquila e il gigante)
hanno violato la giustizia di Dio. Adamo, secondo la Bibbia, visse 930
anni: e furono tutti anni di «pena», perché, avendo commesso il peccato
originale appena sei ore dopo la sua creazione (cfr. Par. XXVI, 118-142),
fu subito cacciato dal Paradiso terrestre; aspettò poi con sofferto «disio»
nel Limbo per 4302 anni la Redenzione di Cristo, che lo liberò dal Limbo
e gli permise di ascendere al Paradiso.
Dorme lo ’ngegno tuo, se non estima
per singular cagione essere eccelsa
lei tanto e sì travolta ne la cima.
E se stati non fosser acqua d’Elsa
li pensier vani intorno a la tua mente,
e ’l piacer loro un Piramo a la gelsa,
per tante circostanze solamente
la giustizia di Dio, ne l’interdetto,
conosceresti a l’arbor moralmente.
(vv. 64-72)
Nell’albero edenico della conoscenza del bene e del male – ammonisce
Beatrice – è da riconoscere, in senso morale («moralmente»), la Giustizia
di Dio; esso è raffigurato così alto e con la chioma così singolarmente
«travolta» (a forma di cono rovesciato) per significare – come spiega Benvenuto da Imola – che «scientia Dei est altissima in infinitum; revolutio
autem figurat quod nullus potest ascendere vel attingere ad illam altitudinem» [la scienza di Dio è eccelsa all’infinito; lo stravolgimento della
cima significa che nessuno può salire e raggiungere quell’altezza]. La
scienza di Dio, e perciò anche la giustizia di Dio (che si esprime anche in
proibizioni), è inarrivabile da mente umana.10 Ma Dante, nonostante tutti
i segni esterni («circostanze») con cui l’albero della conoscenza del bene
178
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
Giuseppe CIAVORELLA
11:51
PÆgina 179
Purgatorio XXXIII
e del male si presentava, sembra non aver capito il significato morale della
proibizione («interdetto») fatta da Dio ad Adamo di cibarsi dei suoi frutti;
e perciò il linguaggio di Beatrice torna severo, quasi come quando ella accusava Dante dei suoi peccati (Purg. XXX e XXXI). La severità si spiega
anche con la necessità che Dante si renda ben conto dell’importanza della
missione che gli è stata affidata: per compierla perfettamente il suo intelletto deve essere libero da pregiudizi terreni, la sua memoria lucida e precisa, la sua volontà determinata. Si direbbe che Beatrice voglia che Dante
capisca bene ch’egli ha sì ‘lavato’ i suoi peccati, ma che la sua mente è rimasta ‘incrostata’ dagli errori della filosofia razionale, da lui seguita per
anni: se vuole capire perfettamente le verità delle Sacre Scritture e gli insegnamenti dei Padri della Chiesa e dei teologi, e soprattutto se vuole eseguire bene la difficile missione che gli è stata affidata, deve liberarsi dal
pregiudizio filosofico che la ragione può spiegare tutto. Per rendere più
efficace il suo discorso Beatrice usa due similitudini: realistica la prima,
mitologica la seconda. La prima ha come termine di paragone le acque del
fiume Elsa (affluente di sinistra dell’Arno), le quali sono così ricche di
carbonato di calcio che incrostano gli oggetti che vi sono immersi. Beatrice, cioè, accusa Dante di avere rivolto per così lungo tempo il suo interesse, pratico e filosofico, ai beni terreni, da cui ricavava un piacere
falso ed effimero, che la sua mente è rimasta ‘incrostata’ dall’errore; conseguentemente egli è ora incapace di sollevarsi dalle verità parziali del
mondo materiale alla verità suprema dello spirito: dalla filosofia puramente razionale (fondata sulle sole virtù cardinali) alla teologia (assistita
dalle virtù teologali). La seconda similitudine ha come termine di paragone il mito di Piramo e Tisbe, al quale Dante aveva già accennato in
Purg. XXVII, 37-39: il giovane Piramo amava Tisbe, ricambiato, ma i
loro genitori ne ostacolavano le nozze; i due giovani decisero allora di
fuggire, e si diedero appuntamento sotto un albero di gelso. Giunse per
prima all’appuntamento Tisbe, ma la giovane, impaurita dall’apparizione
di una leonessa, fuggì, lasciando cadere il suo mantello, che la belva, che
aveva appena ucciso un bove, macchiò di sangue. Quando Piramo sopraggiunse, vide il mantello di Tisbe insanguinato e, pensando che la sua
179
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
PÆgina 180
Tenzone 14
2013
compagna fosse stata uccisa da una belva, disperato si trafisse con la
spada. Tisbe, passato il pericolo, tornò indietro e trovò Piramo morente;
disperata, si uccise sul corpo del compagno. Il sangue dei due giovani si
sparse sulle radici del gelso, che da quel giorno produsse more rosse, invece che bianche. La morale del mito sarebbe (dico ‘sarebbe’ perché è
piuttosto forzata) che, come il sangue di Piramo mutò i frutti del gelso,
così il piacere dei «pensier vani» ha mutato la mente, già pura e virtuosa,
di Dante.
Ma perch’io veggio te ne lo ’ntelletto
fatto di pietra e, impetrato, tinto,
sì che t’abbaglia il lume del mio detto,
voglio anche, e se non scritto, almen dipinto,
che ’l te ne porti dentro a te per quello
che si reca il bordon di palma cinto».
(vv. 73-78)
Sono versi piuttosto enigmatici, che si prestano a diverse interpretazioni; noi diamo qui la nostra: ‘Ma poiché io ti vedo indurito come pietra
nell’intelletto e, oltre che pietrificato («impetrato»), anche oscurato
(«tinto») da quei pensieri vani, così che la luce delle mie parole ti abbaglia,
voglio anche che tu le porti dentro di te, se non proprio scritte in chiari caratteri, almeno come un’immagine dipinta che ti aiuti a ricordarle, per lo
stesso motivo per cui il pellegrino di ritorno dalla Terrasanta porta il bastone da viaggio («bordon») ornato di una foglia di palma’. Con l’accenno
al «bordone» (il robusto bastone dal manico ricurvo del pellegrino), Beatrice intende ricordare a Dante che il viaggio che egli compie nell’oltretomba è anche un pellegrinaggio di espiazione: come il pellegrino, per
voto, va a visitare la Gerusalemme terrena per vedere i luoghi dove visse
e morì Cristo, così Dante, per una speciale grazia divina, ma anche per
purificarsi dai suoi peccati, va a visitare, attraversando prima l’Inferno e
il Purgatorio, la Gerusalemme celeste, dove Cristo trionfa (cfr. Par. XXXI,
43-45, 103-08); e come il pellegrino terreno cinge con una foglia di palma
il bordone, come segno e ricordo del pellegrinaggio compiuto e del voto
180
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
PÆgina 181
Giuseppe CIAVORELLA
Purgatorio XXXIII
sciolto (la palma è pianta tipica dei Luoghi Santi), così Dante riporterà
sulla terra il ricordo di tutto ciò che ha visto e sentito e, come segno della
grazia particolare che Dio gli ha concesso facendogli visitare l’oltretomba
ancora vivo e affidandogli un’importante missione, racconterà il suo viaggio in un poema: questo sarà, per coloro che lo leggeranno, prova della veridicità della narrazione e per lui, Dante, un richiamo continuo ad esser
degno dell’eccezionale grazia che gli è stata concessa. Acuta l’osservazione di Peter Dronke (1990: 121-22) a proposito dell’«intelletto impetrato» di Dante:
Mi sembra che sia difficile non interpretare le allusioni di Beatrice
alla “pietrificazione” di Dante come richiami caustici al suo legame
con la “bella petra”, la donna che aveva ispirato Così nel mio parlar
e le altre “rime petrose”. È come se Beatrice stesse dicendo che
Dante era arrivato ad appartenere a quella “petra” così profondamente da non essere più pronto ad accogliere la stessa Beatrice
(Dronke, 1990: 121-22).
Ricordiamo che nella «bella petra» si identifica comunemente la filosofia, al cui studio Dante si era dedicato dopo la morte di Beatrice. Ma,
come abbiamo detto, le interpretazioni di queste due terzine sono diverse;
ci limitiamo a riportare quella di Enzo Noè Girardi (1989: 667):
Il senso insomma mi pare questo: ma poiché il tuo intelletto è fatto
impermeabile come pietra e, di più, tale pietra è fatta nera come lavagna, sicché la luce, il senso delle mie parole ne vien respinto,
voglio che tu le porti, se non scritte almeno dipinte su questa nera
superficie per conservarle fin tanto che sarai in grado di intenderle.
È il caso di far notare come l’espressione «voglio anco» richiami il
«voglio» del v. 32: Beatrice intende trasmettere la propria volontà, che è
volontà soprannaturale, a Dante, come faceva Dio con i profeti ebrei. Le
metafore dell’«intelletto impetrato» e «tinto» riprendono le similitudinimetafore dell’«acqua d’Elsa» e di «Piramo a la gelsa».
E io: «Sì come cera da suggello,
181
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
PÆgina 182
Tenzone 14
2013
che la figura impressa non trasmuta,
segnato è or da voi lo mio cervello.
Ma perché tanto sovra mia veduta
vostra parola disïata vola,
che più la perde quanto più s’aiuta?».
(vv . 82-87)
La prima terzina è la risposta di Dante alla missione affidatagli da Beatrice: l’impegno del Poeta-pellegrino a comporre la Divina commedia
quando sarà tornato sulla terra (impegno che è in corso di attuazione nel
momento in cui Dante scrive questi versi); in termini penitenziali, è il
momento conclusivo della satisfactio operis, terzo ‘gradino’ del rito della
Penitenza, dopo la contritio cordis e la confessio oris (cfr. Purg. XXXI,
91-102). Ma si noti la solennità della risposta del Poeta: la promessa di riferire fedelmente le parole di Beatrice (cfr. vv. 52-57) si configura come
un voto: Beatrice rappresenta Cristo, e la promessa fatta a lei è una promessa fatta a Dio. Dante non può non mantenerla (cfr. Par. V, 19-84, dove
Beatrice spiega a Dante l’importanza del voto). Ma mentre esprime solennemente la sua promessa, il pellegrino è colto da un dubbio: dovrà riferire
alla lettera anche le parole che non capisce? E se gli chiedono spiegazione
di quelle parole, che cosa potrà rispondere? E soprattutto: perché a volte
le parole di Beatrice gli sembrano così difficili da capire, che ha l’impressione che ella parli un’altra lingua, a lui incomprensibile, di un livello
molto più alto di quello dell’uomo? Dante personaggio esprime il suo
dubbio usando un linguaggio metaforico, quasi nel tentativo di adeguarsi
all’espressione “alta” di Beatrice: la capacità di comprendere è resa con
la metafora della «veduta», la ‘vista intellettuale’, che insegue le parole
che ‘volano via’, sfuggendo alla comprensione; a questa metafora si adeguano i sintagmi «più la perde» e «quanto più s’aiuta». Osserva Andrea
Battistini (2007: 96):
182
Queste continue professioni di inadeguatezza […] potrebbero valere non solo come monito all’“umana gente” a stare “contenti al
quia”, essendo la Ragione incapace di conoscere, mentre si è ancora in via, la Rivelazione […], ma anche come avviso agli esegeti
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
PÆgina 183
Purgatorio XXXIII
Giuseppe CIAVORELLA
a non volere chiarire pienamente il senso di una profezia che per
definizione è oscura e mai completamente decifrabile.
La metafora della ‘parola alata’ è antichissima, com’è noto: risale a
Omero.
«Perché conoschi», disse, «quella scuola
c’hai seguitata, e veggi sua dottrina
come può seguitar la mia parola;
e veggi vostra via da la divina
distar cotanto, quanto si discorda
da terra il ciel che più alto festina».
(vv. 85-90)
La risposta di Beatrice è severa: un vero atto d’accusa. È l’ultima, e
più grave, accusa che Beatrice rivolge a Dante: egli ha seguito una filosofia («dottrina») razionalistica, tutta rivolta a «pensier vani», esclusivamente mondani, e la sua mente ne è ancora come ‘incrostata’.
Anche Virgilio, quando era ancora guida – ricorda il Singleton
(1978: 165) – aveva parlato della sua “scola” (Purg. XXI, 33) e
dei limiti ad essa imposti, più che mai evidenti ora che la guida è
Beatrice: lo stesso fatto che egli abbia guidato solo fino ad un dato
punto, perché “più oltre” non discerneva, sottolinea ancor meglio
quelle limitazioni.
A proposito di queste due terzine, si suole citare, giustamente, Isaia, 55,
8: «I miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le mie vie sono le vostre
vie, dice il Signore; perché, quanto i cieli sono più alti della terra, tanto
le mie vie sono più alte delle vostre e i miei pensieri dei vostri pensieri».
Nel verso 90 si allude al Primo Mobile, il cielo più ampio, più alto e più
veloce; esso è anche il più distante dalla Terra, la quale, nella concezione
astronomica aristotelico-tolemaica, è al centro dell’universo. Ma nel verbo
«discorda» è implicato, oltre al significato di distanza, anche quello di
183
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
PÆgina 184
Tenzone 14
2013
contrasto: la Terra è concepita da Dante come la parte più impura dell’universo (e infatti Lucifero ne occupa esattamente il centro), così che i
cieli che circondano la Terra sono tanto più nobili quanto più distanti sono
da essa. E il Primo Mobile è il più distante (con l’eccezione, ovviamente,
dell’Empireo, sede di Dio e dei beati). L’accusa che Beatrice rivolge a
Dante ha una notevole importanza sia nella biografia culturale di Dante
sia per quanto concerne la costruzione del poema. Torneremo, perciò,
sull’argomento.
Ond’io rispuosi lei: «Non mi ricorda
ch’i’ straniasse me già mai da voi,
né honne coscienza che rimorda».
«E se tu ricordar non te ne puoi»,
sorridendo rispuose, «or ti rammenta
come bevesti il Letè ancoi;
e se dal fummo foco s’argomenta,
cotesta oblivion chiaro conchiude
colpa ne la tua voglia altrove attenta.
Veramente oramai saranno nude
le mie parole, quanto converrassi
quelle scovrire a la tua vista rude».
(vv. 91-102)
L’accusa di Beatrice sembra cogliere di sopresa Dante, che dichiara di
non ricordare di essersi mai allontanato da Beatrice e dalla «dottrina» da
lei rappresentata, cioè dalla retta interpretazione delle Scritture; e aggiunge di non provare alcun rimorso per uno ‘straniamento’ che non ricorda.11 L’osservazione di Dante, ingenua nella sincerità della sorpresa,
induce al sorriso Beatrice, che cambia atteggiamento nei riguardi del suo
interlocutore; non tanto, però, da impedirle di fargli osservare (con logica
sottile) che proprio dal fatto che egli non ricorda si deduce la sua colpevolezza, perché le acque del Letè (e non può non ricordare la sua immersione nel fiume) cancellano solo la memoria del peccato (cfr. Purg.
XXVIII, 127-132; XXXI, 100-102): se non avesse commesso colpa,
184
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
Giuseppe CIAVORELLA
11:51
PÆgina 185
Purgatorio XXXIII
Dante ricorderebbe ogni cosa. Beatrice promette infine a Dante che da
quel momento si rivolgerà a lui con parole semplici, tali da poter essere
comprese da un intelletto limitato, qual è quello di Dante vivo. E già in
questo suo discorso, al mutato atteggiamento verso il pellegrino, corrisponde un cambiamento del registro linguistico: non più parole alte e misteriose, tali da riuscire quasi incomprensibili a Dante, ma parole del
linguaggio comune, dette con tono familiare. L’ultima terzina è tutta costruita sulla metafora della ‘nudità’ della parola: una parola deprivata della
luce metafisica che abbaglia l’intelletto umano e la rende inaccessibile
(cfr. v. 75: «sì che t’abbaglia il lume del mio detto»).
Aggiungiamo ora (come anticipato) qualche altra considerazione a
quanto già detto, poiché l’argomento è importante. Cominciamo col chiederci: l’accusa che Beatrice rivolge a Dante in questi versi, è la stessa che
gli aveva già rivolta, indirettamente, in Purg. XXX, 124-38, e in particolare nei versi 130-32: «e volse i passi suoi per via non vera, / imagini di
ben seguendo false, / che nulla promession rendono intera»? (nei quali
versi è probabile il ricordo di Conv. II XII 5-7, dove Dante parla del suo
‘innamoramento’ per la filosofia: «cominciai tanto a sentire de la sua dolcezza, che lo suo amore cacciava e distruggeva ogni altro pensiero»).
Sembrerebbe di sì, è la stessa accusa, visto che Dante, in risposta (vv. 9193), afferma di non ricordare di essersi mai «straniato» da lei, che è proprio la colpa di cui Beatrice lo ha accusato. Ma perché allora ripetere la
stessa accusa? La spiegazione può essere questa: l’immersione nel Letè
ha cancellato in Dante il ricordo del traviamento filosofico; ma Dante
deve ritornare in mezzo al «mondo che mal vive» e se non ricorda di aver
già commesso un errore dottrinario gravissimo, può ricadere nello stesso
errore; ed ecco allora Beatrice ‘restaurare’ il ricordo nella sua memoria.
Resta, però, il problema della ‘qualità’ del traviamento di Dante, del
quale sono state proposte diverse soluzioni. Per Scartazzini-Vandelli, la
«scuola / c’hai seguitata» è la scuola «della scienza umana, della mera filosofia che cerca la verità di ragione, scuola che Dante ha seguitato con
tanto ardore, che l’amore per la filosofia, da lui giudicata ‘somma cosa’,
“cacciava e distruggeva ogni altro pensiero” (Conv. II XII 5-7), e poco egli
185
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
PÆgina 186
Tenzone 14
2013
curava la più alta scienza, quella delle verità rivelate, raffigurata in Beatrice». Dante, cioè, per superbia intellettuale, si sarebbe allontanato dalla
fede, e ciò sarebbe dimostrato da molti passi del Convivio. Di parere non
diverso è Luigi Pietrobono, per il quale «la “scuola” a cui Beatrice accenna è proprio quella che ritiene d’innalzarsi con il pensiero alla medesima altezza della parola rivelata». Non è di questo parere, invece,
Michele Barbi (in Bullettino della S.D.I IX, 13), secondo il quale la colpa
di cui Beatrice rimprovera Dante nel Paradiso terrestre (sia in Purg. XXX
sia in Purg. XXXIII)
è una sola: di aver amato più i beni mondani che Dio; e la «scuola»
che ha seguitato è la povera sapienza del mondo, i «difettivi sillogismi che fanno battere in basso l’ali», l’«accorger nostro scisso»,
la «veduta corta di una spanna»: invece di levarsi dietro a Beatrice
a conoscer ed amar «lo bene di là dal qual non è a che s’aspiri»,
s’era lasciato traviare dal «falso piacere» de «le presenti cose», e
aveva volto «i passi suoi per via non vera, Immagini di ben seguendo false, Che nulla promission rendono intera».
Per il Barbi, insomma, il peccato di Dante è stato non tanto dottrinale,
quanto morale, e non ha implicato un allontanamento dalla fede.
Dissente dal Barbi Étienne Gilson (1987: 95-96 e nota 13) , che scrive:
In Purg. XXX Beatrice rimprovera a Dante di essere caduto là dove
noi lo troviamo all’inizio della Divina Commedia, con le tre fiere,
così in basso che solo la paura dell’inferno poteva ormai correggerlo; in Purg. XXXIII Beatrice lo rimprovera di aver aderito ad una
«scuola» la cui «dottrina», come Dante adesso vede bene, non può
seguire la sua «parola» e il cui metodo («vostra via») è tanto lontano da quello di Dio quanto la terra è lontana dal cielo. [...] Se
questo non gli viene detto per ricordargli che un tempo ha contato
troppo sulle forze della ragione, non si vede davvero cosa potrebbe
significare.
Ma il Gilson sostiene anche che l’amore per la ‘donna gentile’ (la filosofia) non venne meno nell’animo di Dante neanche dopo il suo ritorno a
186
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
PÆgina 187
Purgatorio XXXIII
Giuseppe CIAVORELLA
Beatrice (la teologia): «Vi è stata, a un certo punto, un’inversione della gerarchia di questi due amori nell’animo di Dante, e anche una temporanea
dimenticanza di Beatrice, ma il ritorno di Beatrice non comportò mai
l’esclusione della “donna gentile”» (1987: 95, nota 12). Il Gilson, insomma, sostiene la diversità delle accuse di Beatrice a Dante in Purg. XXX
e Purg. XXXIII: colpe morali, nel primo caso, colpe dottrinali, nel secondo.
A me sembra, però, che l’accenno di Beatrice alle eccezionali doti intellettive di Dante (Purg. XXX, 109-120) e all’errore da lui commesso quando
«volse i passi suoi per via non vera, / imagini di ben seguendo false, / che
nulla promession rendono intera» (vv. 130-32) si possa interpretare non
solo come traviamento morale, ma anche come traviamento dottrinale (pur
senza ipotizzare una vera caduta nell’eresia); e che quindi in Purg. XXXIII,
85-90, Beatrice non faccia altro che ribadire le accuse precedenti, perché
Dante (come abbiamo detto) dovrà tornare sulla terra, per giunta investito,
per volontà divina, di una missione profetica e poetica.
Ritorniamo ai versi del canto.
E più corusco e con più lenti passi
teneva il sole il cerchio di merigge,
che qua e là, come li aspetti, fassi,
quando s’affiser, sì come s’affigge
chi va dinanzi a gente per iscorta
se trova novitate o sue vestigge,
le sette donne al fin d’un’ombra smorta,
qual sotto foglie verdi e rami nigri
sovra suoi freddi rivi l’alpe porta.
Dinanzi ad esse Eufratès e Tigri
veder mi parve uscir d’una fontana,
e, quasi amici, dipartirsi pigri.
(vv. 103-14)
Riprende la narrazione dopo il lungo e oscuro discorso profetico di Beatrice e il dialogo, piuttosto animato, fra la beata e il discepolo dalla «vista
rude». È ormai mezzogiorno e il sole brilla alto e luminoso («corusco») sul
187
Ciavorella:Maquetaci n 1
Tenzone 14
09/12/2013
11:51
PÆgina 188
2013
meridiano del Purgatorio, dopo essersi gradualmente spostato (secondo la
concezione astronomica medievale) da oriente a occidente, da un meridiano all’altro. Ora che è quasi a perpendicolo sul monte del Purgatorio
(siamo nell’emisfero sud, nell’equinozio di primavera), sembra muoversi
più lentamente. Sono trascorse circa sei ore da quando Dante, poco dopo
l’alba, ha messo piede nel Paradiso terrestre; fra poco, dopo che l’acqua
dell’Eunoè lo avrà definitivamente purificato, «salirà alle stelle» insieme
con Beatrice. E non è un caso, probabilmente, che l’ “ascensione” avvenga
sei ore dopo l’arrivo nel Paradiso terrestre e a mezzogiorno. Dante aveva
scritto nel Convivio che Cristo, morendo al colmo della sua vita, «l’ora del
giorno de la sua morte [...] volle consimigliare con la vita sua; onde dice
Luca che era quasi ora sesta quando morio, che è a dire lo colmo del die»
(IV XXIII 11); e aveva aggiunto che «la sesta ora, cioè lo mezzo die, è la
più nobile di tutto lo die e la più virtuosa» (IV XXIII 15).
È, dunque, quasi mezzogiorno quando le sette Virtù, che, con in mano
i candelabri, guidano la piccola processione, si fermano al margine di una
radura, simile a quelle che si incontrano in alta montagna, dove i ruscelli,
dalle acque fredde, scorrono in mezzo all’erba verde, sotto i rami neri
degli alberi. Quando Dante raggiunge le Virtù, vede davanti a sé, in mezzo
alla radura una sorgente, dalla quale escono, abbondanti di acque ma lenti
nello scorrere, due ruscelli, che si dirigono in direzioni opposte, come
fanno due amici che separandosi si salutano. Siamo nel Paradiso terrestre,
e al Poeta vengono in mente i nomi dei fiumi Eufrate e Tigri, citati in Genesi 2, 10-14: «Et fluvius egrediebatur ex Eden ad irrigandum paradisum,
qui inde dividitur in quattuor capita. Nomen uni Phison […] Et nomen
fluvio secundo Geon […] Nomen vero fluminis tertii Tigris […] Fluvius
autem quartus ipse est Euphrates» [Un fiume usciva da Eden per irrigare
il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si
chiama Pison (…) Il secondo fiume si chiama Ghicon (…) Il terzo fiume
si chiama Tigri (…) Il quarto fiume è l’Eufrate]. Ma forse qui, più che il
passo della Genesi, Dante ha presente Boezio, De Consol. Philos. V, m.
I: «Tigris et Euphrates uno se fonte resolvunt / et mox abiunctis dissociantur aquis» [il Tigri e l’Eufrate sgorgano da un’unica fonte / e presto,
188
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
PÆgina 189
Purgatorio XXXIII
Giuseppe CIAVORELLA
diramandosi le loro acque, si separano]. Ma Matelda gli ha già detto che
quei due fiumi hanno nome Letè ed Eunoè (cfr. Purg. XXVIII, 127-33):
il Letè lo ha già visto, e vi si è anche immerso, dunque l’altro non può essere che l’Eunoè. Resta dunque il fatto che il Poeta, pur citando indirettamente la Bibbia e Boezio, dà ai due fiumi che bagnano il Paradiso
terrestre due nomi che ricordano la mitologia greco-romana, quasi a significare che la sua invenzione poetica attinge sia alla fonte cristiana sia alla
fonte pagana (ricordiamo che la descrizione naturalistica del Paradiso terrestre è prevalentemente di derivazione ovidiana; cfr. Purg. XXVIII, 1-21,
49-51). Il paesaggio (e in qualche modo anche la situazione) è quello che
si era presentato a Dante quando, entrato nella «divina foresta spessa e
viva», era giunto sulle rive del Letè (cfr. Purg. XXVIII, 25-33): là era
l’inizio del cammino nell’Eden ritrovato, qua è la conclusione del cammino. Fra poco, infatti, Dante spiccherà il volo per il Paradiso.
«O luce, o gloria de la gente umana,
che acqua è questa che qui si dispiega
da un principio e sé da sé lontana?».
Per cotal priego detto mi fu: «Priega
Matelda che ’l ti dica». E qui rispuose,
come fa chi da colpa si dislega,
la bella donna: «Questo e altre cose
dette li son per me; e son sicura
che l’acqua di Letè non gliel nascose».
(vv. 115-23)
Beatrice è invocata nello stesso tempo come simbolo della Sapienza
divina («luce») e come donna gloriosa («gloria de la gente umana»). L’enfasi della domanda può giustificarsi con la straordinarietà (la «novitate»
del v. 108) del fenomeno, umanamente inspiegabile; straordinarietà che
(aggiunta a quella di tutti i mirabili avvenimenti che si sono succeduti nel
Paradiso terrestre) provoca in Dante non solo stupore, ma anche una momentanea amnesia, perché Dante in effetti sa, e dovrebbe perciò ricordarsi, che i due fiumi sono il Letè e l’Eunoè. Ma c’è forse dell’altro. Si
svolge, infatti, nelle terzine 115-23 (con epilogo nella terzina 124-26) una
189
Ciavorella:Maquetaci n 1
Tenzone 14
09/12/2013
11:51
PÆgina 190
2013
sorta di commedia degli equivoci: Dante non può (non dovrebbe) aver
dimenticato le spiegazioni dategli da Matelda in Purg. XXVIII, 121-33
(perché il Letè cancella solo il ricordo del peccato); Beatrice non può non
sapere che Matelda ha già informato Dante sui due fiumi e sull’unica sorgente; Matelda sa che Beatrice e Dante sanno, ma risponde a Beatrice con
l’aria di discolparsi. Perché questa commediola, in cui sembra quasi che
Beatrice, rinviando Dante a Matelda, voglia mettere in imbarazzo «la
bella donna»? È un gioco, indubbiamente: Beatrice prende amabilmente
in giro Dante, che si è rivolto a lei con tanta enfasi per chiedergli una spiegazione inutile; Matelda ha capito e asseconda Beatrice nel gioco. Alla
fine, a trovarsi realmente in imbarazzo non è Matelda, ma Dante, che è costretto ad ammettere la propria amnesia, o sbadataggine, clamorosamente
contraddicendo quanto lui stesso, con enfasi (è recidivo!), aveva affermato
nei vv. 79-81 (e ancora Beatrice avrà amabilmente sorriso di lui). Narrativamente, la scena ha funzione di “alleggerimento” (e forse anche di autocritica: Dante Poeta costringe Dante personaggio ad ammettere, fra le
altre cose – vedi confessione – la propria distrazione). Beatrice ha già tentato di mettere a suo agio Dante, ancora pieno di soggezione verso di lei,
donna amata e beata, e già così severa nell’accusarlo di peccati gravi: gli
ha sorriso e si è rivolta a lui con un linguaggio non più enigmatico e quasi
incomprensibile (cfr. vv. 46-47, 82-84), ma con un linguaggio quasi popolare: con «parole nude» (cfr. vv. 94-102). Evidentemente Dante non ha
capito, o non è riuscito ancora a vincere il proprio complesso di colpa e
di inferiorità. E Beatrice ricorre allora all’ironia (in realtà autoironia del
Poeta, sempre presente a se stesso); con maggior fortuna, si direbbe, perché da questo momento la narrazione procede speditamente verso il lieto
fine del canto, che è anche il lieto fine di tutto il Purgatorio.
Degno di nota, poi, è che per la prima volta qui viene pronunciato il
nome di «Matelda»: quasi una “agnizione” finale nello stile della commedia classica. Ma a questo proposito si può aggiungere un’altra considerazione. Con la rivelazione del nome della «bella donna», che ha guidato
Dante a Beatrice nel Paradiso terrestre, si scioglie un mistero (Chi è la
‘bella donna’? Qual è il suo nome?) protrattosi per sei canti. Nell’ultimo
190
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
PÆgina 191
Purgatorio XXXIII
Giuseppe CIAVORELLA
canto del Purgatorio, cioè, il Poeta (attraverso Beatrice) prima pone al
lettore un «enigma forte» col numero «Cinquecento diece e cinque» e poi
(quasi a compensazione del primo) ne scioglie un altro, che ha portato
avanti astutamente lungo tutto il Paradiso terrestre, con tutti gli accorgimenti che la retorica gli offriva (perifrasi, soprattutto, elegantemente variate secondo le circostanze). Se lo scioglimento del mistero del nome di
Matelda avviene in forma di commediola (ma il mistero dell’identità storica del personaggio resta, e resterà, irrisolto; a meno che non si voglia riconoscere che Dante, creando la figura di Matelda, abbia inteso creare un
nuovo mito cristiano del Paradiso terrestre, in concorrenza con il mito pagano dell’età dell’oro, cantato da Ovidio nelle Metamorfosi, con il quale
perciò Dante si confronterebbe;12 e in tal caso ogni riferimento storico del
personaggio Matelda sarebbe vanificato), il «Cinquecento diece e cinque»
resta davvero un «enigma forte», vero e drammatico, e tale vuole restare
fino al suo inverarsi nella storia; perché quella del «DXV» vuole essere
una vera profezia, in cui Dante Poeta, e cristiano convinto, crede veramente, perché «fede è sustanza di cose sperate / e argomento de le non
parventi» (Par. XXIV, 64-65), e Dante è certo che Dio, prima o poi, farà
giustizia di tutte le ingiustizie e nefandezze che vengono commesse sulla
terra dai potenti, laici o ecclesiastici che siano.
Ma riprendiamo la lettura dei versi, avviandoci alla conclusione.
E Beatrice: «Forse maggior cura,
che spesse volte la memoria priva,
fatt’ha la mente sua ne li occhi oscura.
Ma vedi Eunoè che là diriva:
menalo ad esso, e come tu se’ usa,
la tramortita sua virtù ravviva».
(vv. 124-29)
La «maggior cura» può essere stata la visione apocalittica a cui Dante
ha appena assistito: Beatrice stessa l’aveva invitato a osservare lo spettacolo con grande attenzione, perché avrebbe dovuto poi riferirne «in pro
del mondo che mal vive», una volta «ritornato di là»; o può essere stato
191
Ciavorella:Maquetaci n 1
Tenzone 14
09/12/2013
11:51
PÆgina 192
2013
il trauma psicologico della confessione, a cui Beatrice stessa l’ha costretto. Non si può, d’altra parte, escludere che nelle parole di Beatrice ci
sia una lieve ironia all’indirizzo di Dante (sarebbe intonata al sottile spirito di commedia di cui abbiamo parlato); Vittorio Cian (1958: 670), per
esempio, ipotizza che l’oblio di cui parla Beatrice sia dovuto «fors’anche
alla presenza di lei, che aveva turbato fino al tremore il suo spirito, come,
laggiù, in terra, e come, poche ore innanzi, allorché riconobbe i “segni
dell’antica fiamma”». Escluderei, invece, che si svolga in queste terzine
«una scena finissima di gelosia femminile» (Pietrobono) tra Beatrice e
Matelda.
Si apprende, poi, dall’invito che Beatrice rivolge a Matelda, che la
«bella donna» ha il compito specifico di guidare le anime, che giungono
purificate nel Paradiso terrestre, all’immersione nel Letè, prima, e nell’Eunoè, dopo. Che l’Eunoè abbia la virtù di ravvivare il ricordo del bene compiuto, dopo che il Letè ha cancellato il ricordo dei peccati, è stato già detto
a Dante, appunto, da Matelda in Purg. XXVIII, 127-29 (e non è certamente
un caso che il Poeta rievochi quelle parole in Purg. XXXIII, 127-29, cioè
esattamente cinque canti dopo: là quasi all’inizio del viaggio nel Paradiso
terrestre, qua quasi alla fine; Dante ama le simmetrie). Il rito dell’immersione nell’Eunoè, che sta per celebrarsi, non fa parte, stricto sensu, del rito
della Penitenza (conclusosi con l’abolitio peccati dell’immmersione nel
Letè), ma ne costituisce come il naturale coronamento: è espresso, in forma
rituale, il positivo effetto spirituale che l’abolitio peccati determina sul penitente. Come chiarisce Andrea Battistini (2007: 103), è lo stesso S. Tommaso a precisare che alla Penitenza segue la «revivificatio virtutum ac
meritorum». Dino S. Cervigni (1989: 193) precisa ulteriormente, sempre
citando S. Tommaso: «Non solo il penitente può riacquistare “aliquid
maius” – una condizione superiore a quella precedente – ma può anche
riottenere le opere buone compiute in stato di grazia e poi ‘mortificate’ a
causa del peccato». E Dante traduce, appunto, in rito le parole di S. Tommaso: «opera prius mortificata […] recuperant efficaciam perducendi eum
qui fecit ea in vitam aeternam: quod est reviviscere. Et ita patet quod opera
mortificata per poenitentiam reviviscunt» [le opere prima mortificate dal
192
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
PÆgina 193
Purgatorio XXXIII
Giuseppe CIAVORELLA
peccato […] recuperano l’efficacia di condurre colui che le ha compiute
verso la vita eterna: che è rivivere. E così è chiaro che le opere mortificate
rivivono grazie alla penitenza] (Summa theologiae III, q. 4, a. 5). Nei versi
di Dante sopravvive la parola di Tommaso: nell’invito che Beatrice rivolge
a Matelda, «la tramortita sua virtù ravviva», è chiara l’eco delle espressioni
«revivificatio virtutum» e «opera prius mortificata recuperant efficaciam».
E l’eco perdura negli ultimi quattro versi del canto.
Jacques Le Goff (1981: 404), che ha studiato in particolare la “nascita”
del Purgatorio, commenta così l’immersione nell’Eunoè: «È la metamorfosi definitiva della memoria, anch’essa mondata dal peccato. Il male è dimenticato, sussiste soltanto la memoria di quanto vi è di immortale
nell’uomo, il bene. Anche la memoria ha raggiunto la soglia escatologica». Ma forse si può leggere nelle parole di Beatrice e nell’immersione
nell’Eunoè anche un altro significato, rapportandolo alla missione, e cioè:
Dante dovrà comporre il suo poema con mente libera da ogni umano pregiudizio, ricordando solo ciò che è bene verso Dio e verso gli uomini.
Come anima gentil, che non fa scusa,
ma fa sua voglia de la voglia altrui
tosto che è per segno fuor dischiusa;
così, poi che da essa preso fui,
la bella donna mossesi, e a Stazio
donnescamente disse: «Vien con lui».
(vv. 130-35)
Sembra di capire, da questi e dai precedenti versi, una maggiore autorità di Beatrice rispetto a Matelda. Il breve episodio va però inquadrato in
tutta la vicenda: il viaggio di Dante è voluto da Dio, che ha affidato a
Beatrice l’incarico di organizzarlo e guidarlo; Matelda, ubbidendo in questo momento a Beatrice, ubbidisce a Dio. Non può esserci vera subalternità in cielo, se non a Dio; e Matelda è senz’altro, come Beatrice, creatura
celeste. La rappresentazione in forma di commedia rientra nel realismo
psicologico a cui si ispira l’intero poema.
193
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
PÆgina 194
Tenzone 14
2013
S’io avessi, lettor, più lungo spazio
da scrivere, i’ pur cantere’ in parte
lo dolce ber che mai non m’avria sazio;
ma perché piene son tutte le carte
ordite a questa cantica seconda,
non mi lascia più ir lo fren de l’arte.
(vv. 136-41)
Non è qui chiarito se Dante sia immerso da Matelda nell’Eunoè, come
già nel Letè, o se beva da sé l’acqua. Dalle parole di Beatrice e dal gesto
di Matelda, che prende per mano Dante, si dovrebbe supporre che si ripeta
il rito dell’immersione come nel fiume della dimenticanza; ma non si può
non tener conto del fatto che sulla riva del Letè Dante era svenuto e che
Matelda era stata costretta a trascinarlo dentro le acque del fiume, a immergergli la testa nell’onda, perché ne bevesse, e ad aiutarlo a raggiungere
l’altra riva. Qui Dante è del tutto cosciente e può quindi immergersi da
solo e bere l’acqua rigeneratrice, come fa Stazio: Matelda si limiterebbe
ad accompagnarli sulla riva, «donnescamente». Quanto alla terzina 13941, «pare proprio che Dante avesse determinato anticipatamente la lunghezza approssimativa di ogni cantica, assegnando a ciascuna un dato
numero di carte, come poi, dalla composizione di molti codici, risulta che
fecero spesso gli antichi trascrittori del Poema» (Scartazzini-Vandelli).
Lo «fren de l’arte», comunque, allude alle norme retoriche (di equilibrio,
di simmetria, di proporzione, ecc.) che regolavano le composizioni poetiche fin dall’antichità classica. Commenta Franco Lanza (1967: p. 1231):
«L’appello di Dante al lettore qui viene pòrto su un piano di affettuosa
condiscendenza, come un invito alla comprensione, una scusa per il largo
tratto del poema che viene contratto in sì breve spazio; […] ed è un modo
discreto di associare chi legge al compito profetico che il poeta si è assunto, di farlo partecipe d’un messaggio che riguarda lui come ogni vivente».
Io ritornai da la santissima onda
rifatto sì come piante novelle
rinovellate di novella fronda,
puro e disposto a salire a le stelle.
194
(vv. 142-45)
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
Giuseppe CIAVORELLA
11:51
PÆgina 195
Purgatorio XXXIII
Ricordi classici (soprattutto da Virgilio: Eneide VI, 205 ss.; XII, 788;
Georg. III, 235) e biblici (soprattutto da S. Paolo: Ebrei 6, 6; Efes. 4, 23)
e, come si è detto, della Scolastica, confluiscono ad arricchire il senso di
questi versi conclusivi del Purgatorio. Ma il riferimento più vicino è alla
«pianta dispogliata» che «si rinovella» di foglie e fiori quando il grifone
lega il carro al suo tronco (Purg. XXXII, 52-60): si ripete simbolicamente
per Dante personaggio il mistero della Redenzione operata da Cristo per
l’intera umanità: la renovatio è pienamente attuata, il pellegrino dell’oltremondo è perfettamente riconciliato con Dio e può salire a Lui. Ma ci
pare anche che nella replicazione «novelle», «rinovellate», «novella» si
possa cogliere un’eco della Vita nova: come già nel libello giovanile, dopo
il ritorno a Beatrice e la ‘mirabile visione’, Dante si sente rinascere a vita
nuova («Incipit vita nova...»: diamo un’interpretazione un po’ diversa da
quella tradizionale; più precisamente: mentre accettiamo il sintagma vita
nova come titolo del “libello giovanile” (confermato del resto dallo stesso
Dante in Convivio I I 16), pensiamo che Dante, con il medesimo sintagma,
alluda ad un suo nuovo modo di intendere la vita, dopo la ‘mirabile visione’, sia come uomo e cittadino sia, soprattutto, come poeta), così ora,
dopo aver bevuto l’acqua dell’Eunoè in presenza e per volontà di Beatrice,
egli sente rinascere il proprio spirito ad una ancora più alta «vita nuova»,
che gli spalanca le porte del Paradiso e della «mirabile visione» di Dio.
È mezzogiorno nel Paradiso terrestre, dove Dante è giunto quella stessa
mattina all’alba, l’ora prima, secondo il calcolo antico-medievale. Fra
poco Dante spiccherà il volo per il primo dei Cieli paradisiaci: quello
della Luna. Dante, dunque, rimane nell’Eden esattamente quanto vi rimase Adamo, come lo stesso nostro progenitore affermerà in Par. XXVI,
139-42: «Nel monte che si leva più da l’onda, / fu’ io, con vita pura e disonesta, / da la prim’ora a quella che seconda, / come ’l sol muta quadra,
l’ora sesta». Adamo fu cacciato dal Paradiso terrestre e non vi potè più tornare; Dante, invece, vi ritorna, grazie alla Redenzione, e vi ritorna da vivo
per una speciale grazia dell’Onnipotente, che ha voluto fare di lui il poetaprofeta di una nuova era cristiana.
195
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
11:51
PÆgina 196
Tenzone 14
2013
NOTE
Della terzina 10-12 (e di altri versi poco chiari di questo canto) è stata proposta una interpretazione piuttosto diversa da Peter Dronke. Scrive lo studioso:
«Beatrice assume simbolicamente la parte di Cristo nel suo porgere la rivelazione
e la redenzione a Dante. È a Dante (o alle virtù latenti in lui) che effettivamente
ella si rivolge usando le parole di Cristo. Ella rimarrà in cielo ed egli dovrà tornare sulla terra per ricordare e tramandare le sue parole rivelate: in quel “poco”
che Dante ha ancora da vivere non la vedrà, ma poi – come lei ha promesso – la
rivedrà e starà con lei per sempre (XXXII, 101-2). Esattamente allo stesso modo,
nell’episodio narrato da Giovanni, Cristo promette ai discepoli un momento di
pianto seguito da un tempo in cui “io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore ne gioirà
e nessuno vi toglierà la vostra gioia” ([Giovanni]16:22)» (Dronke 1990: 117).
L’interpretazione del Dronke mi pare un po’ troppo ‘facile’, quasi una parafrasi
dei vv. 100-02 di Purg. XXXII, che non hanno certo bisogno di spiegazione. Ho
l’impressione che lo studioso non tenga conto delle parole del Salmo 79 [78]
cantato dalle Virtù, parole alle quali Beatrice risponde («rispuose»), e che si riferiscono all’esilio babilonese (con evidente richiamo alla ‘cattività avignonese’
del Papa e della sua corte, chiaramente allusa nei versi 148-60 di Purgatorio
XXXII).
1
Guglielmo Gorni ricorda Ezechiele 2, 6: «Come già Ezechiele (“Tu ergo, fili
hominis, ne timeas eos, neque sermones eorum metuas … Verba eorum ne timeas, et vultus eorum ne formides” [‘Ma tu, figlio dell’uomo, non temerli, non
aver paura dei loro discorsi… Non temere le loro parole, e non lasciarti impressionare dalle loro facce’], Dante per compiere la sua missione, deve liberarsi da
ogni timore o rispetto umano» (Gorni 1990: 120). Michelangelo Picone interpreta
diversamente il v. 33: «Già al v. 33 Beatrice invita Dante a passare dalla fase del
sogno a quella della sua interpretazione, dalla visione avuta nel canto XXXII all’evidenziamento del senso da attribuire a quella visione» (Picone 2008: 90).
2
Totalmente diversa l’interpretazione di Michelangelo Picone, per il quale il
carro non simboleggia la Chiesa, ma la poesia, e in particolare la storia della poesia di Dante, «dal libello giovanile al poema sacro della maturità, passando attraverso la drammatica esperienza dell’esilio» (Picone 2008: 81); nei vv. 34-36,
sostiene il critico, «Beatrice sta […] semplicemente e coerentemente parlando
della fine della poesia, dovuta all’attuale gravissima decadenza del mondo poli3
196
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
Giuseppe CIAVORELLA
11:51
PÆgina 197
Purgatorio XXXIII
tico e religioso. La “vendetta di Dio”, a cui Beatrice fa riferimento al v. 36, riguarda pertanto le persone e i fatti che hanno causato l’eclisse della poesia, l’impossibilità di fare poesia in un mondo tralignato» (Picone 2008: 91). È inutile
precisare che non siamo d’accordo con Picone.
4
Merita una spiegazione etimologica la parola «fuia». Il termine significa letteralmente ‘ladra’, maschile «fuio», ‘ladro’ (cfr. Inf. XXII, 90, e Par. IX, 75),
probabilmente dal lat. «fur», ‘ladro’ o *«fura», ‘ladra’: la meretrice è «fuia» perché ha occupato, quasi rubandolo e comunque usurpandolo, il luogo destinato
da Dio alla santa Chiesa (così che la sede pontificia è moralmente vacante). Ma
per Umberto Bosco la meretrice, simbolo della Chiesa corrotta, è «fuia» perché
è «una ladra del potere terreno, che spetta solo all’impero». Ma a proposito dei
vv. 37-45, ritengo utile citare le parole di un grande studioso di Dante, Bruno
Nardi: «Ristabilita l’universalità dell’impero, la chiesa sarà obbligata a rinunziare
a ogni dominio terreno e potrà attendere in povertà ed umiltà alla sua missione
puramente spirituale e ad insegnare col suo esempio agli uomini il distacco dai
beni caduchi, per rivolgere tutti i suoi desideri alla beatitudine dell’altra vita.
Solo così torneranno a splendere i due soli che sono necessari a rischiarare agli
uomini il duplice cammino: quello della felicità terrena e quello della beatitudine
celeste. […] Disgiunta la spada dal pastorale e ristabilita l’indipendenza reciproca
del papato e dell’impero, la pianta edenica, dirubata una seconda volta, tornerà
a rinverdire e a germogliare come al momento della Redenzione per opera di
Cristo» (Nardi 19902: 278-79).
Ci sia consentito di rimandare ad una nostra ‘lettura’ del canto IX del Purgatorio, dove ipotizziamo che l’angelo «da ciel messo» di Inferno IX, 85, sia figura simbolica della Divina commedia (Ciavorella 2008: 60-62). Vogliamo qui
proporre l’ipotesi che anche il «Cinquecento Diece e Cinque» possa alludere alla
Commedia? Non esattamente, anzi escluderemmo questa ipotesi, almeno come
allusione diretta. È possibile, invece, ammettere l’allusione indiretta, accettando
l’identificazione del DXV con Arrigo VII, l’imperatore che accese in Dante la
speranza sia di un ritorno dall’esilio a Firenze («Se mai continga che ’l poema
sacro…»; Par. XXV, 1) sia di una restaurazione della pace imperiale e cristiana
nel mondo occidentale (Epistola V, indirizzata «Universis et singulis Ytalie Regibus et Senatoribus…»). Di questa speranza (di cui si fa profeta Dante attraverso
l’investitura poetica conferitagli da Beatrice) si alimenta, e risuona, tutta la Commedia. E ne è come il simbolo la corona posta sul «gran seggio» della candida
5
197
Ciavorella:Maquetaci n 1
Tenzone 14
09/12/2013
11:51
PÆgina 198
2013
rosa su cui siederà l’imperatore «ch’a drizzare Italia / verrà in prima ch’ella sia
disposta» (Par. XXX, 133-38).
Mazzamuto 19842 (ma cfr. anche Rembadi Damiani 2005). Giorgio Petrocchi, nel suo testo critico (che noi in linea di massima seguiamo, ma non qui), riporta il numero tutto in lettere minuscole. Antonio Lanza riporta il numero con
le iniziali maiuscole: “Cinquecento Diece e Cinque”; soluzione accettabile, diremmo, essendo il riferimento a un nome proprio di persona non identificata (in
Alighieri 19962: 530).
6
7
Nota Robert Wilson: «Se si ammette che l’aquila (v. 38), come in Purgatorio
XXXII, è un simbolo dell’Impero romano, allora la prima parte della profezia (vv.
37-39) deve con ogni probabilità riferirsi a un imperatore, l’erede dell’aquila.
Per Dante, nel 1300, l’erede dell’Impero è assente, dal momento ch’egli considerava Federico II come l’ultimo Imperatore romano legittimo. È possibile, allora,
che la profezia si riferisca all’incoronazione di Arrigo VII a Roma il 29 giugno
1312» (Wilson 2008: 115 [traduzione nostra]).
Temi, Sfinge, Naiade sono personaggi mitologici, presenti nelle Metamorfosi
di Ovidio, da cui quasi certamente Dante li deriva. Alla dea Temi, figlia di Urano
e della Terra, era consacrato, sul monte Parnaso, un santuario, dal quale erano
emessi oracoli particolarmente enigmatici (cfr. Metam. I, 347-415: mito di Deucalione e Pirra). Sfinge era una mostruosa creatura biforme, con corpo di leone
e busto di donna; appostata su una rupe lungo la strada che conduceva a Tebe
(città vicina al monte Parnaso), poneva domande enigmatiche ai viandanti, e li
uccideva se non sapevano rispondere; ma Edipo, figlio di Laio, re di Tebe, riuscì
a dare la risposta giusta, e Sfinge, umiliata, si uccise gettandosi dalla rupe
(Metam. VII, 759-65). Le Naiadi erano le ninfe delle sorgenti e dei fiumi, e anche
di queste narra Ovidio; ma Dante qui le cita erroneamente, perché, avendo un
testo non corretto dell’opera di Ovidio, leggeva «Naiades» invece di «Laiades»
(in Metam. VII, 759-60, dove il testo corretto è: «Carmina Laiades non intellecta
priorum / solverat ingeniis» [Il figlio di Laio aveva risolto l’enigma che prima
nessuno aveva capito]; Dante invece leggeva: «Carmina Naiades non intellecto
priorum / solvunt ingeniis»): ‘Laiade’, cioè “figlio di Laio”, era il patronimico di
Edipo. Come Dante leggevano i suoi contemporanei (e tutti i commentatori della
Commedia del Trecento), che, nel tentativo di dare una spiegazione plausibile
del testo scorretto di Ovidio, attribuirono alle Naiadi capacità interpretative degli
enigmi, immaginando anche che esse suscitassero la gelosia di Temi, perché i
Tebani preferivano rivolgersi alle Naiadi, piuttosto che a lei. Quanto al v. 51, si
8
198
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
Giuseppe CIAVORELLA
11:51
PÆgina 199
Purgatorio XXXIII
allude alla vendetta di Temi per la morte-suicidio di Sfinge, causata da Edipo
(«Naiade», per Dante): come narra Ovidio, Temi mandò contro i Tebani una belva
a divorare greggi e a devastare campi coltivati (Met. VII, 759-65 e oltre).
R. Wilson sente nel termine «enigma» un’“eco” della lettera di S. Paolo 1
Cor. 13, 12: «Videmus nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie ad faciem; nunc cognosco ex parte, tunc autem cognoscam, sicut et cognitus sum»
[Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa («in aenigmate», da aenigma, -atis), allora vedremo faccia a faccia; ora conosco in modo imperfetto, allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto]; e conclude: «Se
si accetta almeno una qualche allusione alla lettera di S. Paolo, si aggiunge un significato escatologico al verso di Dante e si propone un approccio interpretativo
che accetta una comprensione incompleta ora, insieme con una promessa di
piena, diretta conoscenza quando la predizione sarà realizzata» (Wilson 2008:
120 [trad. nostra]). La proposta di lettura di Wilson ci pare accettabile. Anche
qui abbiamo preferito la lettura «sappi» di Antonio Lanza a quella «forse» di Petrocchi. Scrive Lanza: «L’asserzione di Beatrice non ha nulla di dubitativo: il
forse, quindi, è fuori luogo».
9
Degna di nota la precisazione di Kenelm Foster: «the notion of justice implies that of order – order in human society and in the cosmos and between cosmos and its Creator. So much is traditional (see St Thomas, Summa theol., I a, 21,
I ad 3)» [la nozione di giustizia implica quella di ordine – ordine nella società
umana e nel cosmo e tra il cosmo e il suo Creatore; vedi S. Tommaso Summa
ecc.] (Foster 1957: 45). Questa precisazione porta ad includere, nella spiegazione
di Beatrice, il riferimento alla visione apocalittica, nella quale l’ordine della
Chiesa, che è espressione della volontà divina, appare sconvolto dal progressivo
corrompersi delle istituzioni politiche ed ecclesiastiche.
10
Dino S. Cervigni ha chiarito, con puntuali citazioni della Summa theologiae
(III, q. 89, a. 1-6), il significato teologico-penitenziale dei vv. 91-96: «È Dio che
distrugge o dimentica il peccato, secondo una terminologia metaforica comune
alla Bibbia, alla scolastica e anche al testo poetico dantesco. […] Primo effetto
dunque della penitenza è la distruzione o dimenticanza del peccato da parte di
Dio: ciò che nell’esperienza di Dante pellegrino si verifica tramite l’immersione
nel fiume Letè. Vale la pena notare a questo proposito che, mentre nella Bibbia
l’atto della dimenticanza viene attribuito a Dio, nella Commedia è Dante pellegrino che dimentica il suo traviamento […]: non solo importante trasferimento
d’una metafora dal creatore alla creatura, ma indice anche che Dante è stato pu11
199
Ciavorella:Maquetaci n 1
Tenzone 14
09/12/2013
11:51
PÆgina 200
2013
rificato del suo peccato e di ogni altro debito con esso connessso tramite l’ascesa
purificante del Monte Purgatorio» (Cervigni 1989: 191). Aggiungeremmo una
precisazione, per noi importante: la purificatio di Dante non è completa quando
egli giunge nel Paradiso terrestre dopo l’ascesa del Sacro monte; sarà completa
solo dopo il rito sacramentale della confessione (che comporta piena contritio
cordis e confessio oris, alle quali Beatrice costringe il pellegrino), e dopo l’immersione nel Letè (il momento della deletio peccati, ‘cancellazione del peccato’).
Salendo il Purgatorio Dante non si ‘purifica’ dei peccati (non c’è, appunto, deletio
peccati, e infatti non è sottoposto, se non simbolicamente, alle pene cui sono sottoposti i veri penitenti), ma delle istintive tendenze ai diversi peccati (puniti nei
vari gironi), non controllate dalla ragione. Se così non fosse, sarebbero inutili sia
la confessione sia l’immersione nel Letè: non avrebbero, cioè, piena giustificazione i canti XXX-XXXI.
Su Matelda personaggio e sul mito dantesco del Paradiso terrestre ci permettiamo di rimandare a una nostra recente “lettura” del canto XXVIII del Purgatorio: Ciavorella 2011.
12
200
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
Giuseppe CIAVORELLA
11:51
PÆgina 201
Purgatorio XXXIII
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
ALIGHIERI, D. (19962): La commedìa, testo critico secondo i più antichi
manoscritti fiorentini, a cura di A. Lanza, Anzio, De Rubeis.
APOLLONIO, M. (1951): Dante. Storia della ‘Commedia’, II, Milano,
Vallardi, pp. 775-777.
BÀRBERI SQUAROTTI, G. (1979): «L’allegoria», in Letture classensi, VIII,
Ravenna, pp. 135-160.
BATTISTINI, A. (2007): «Tra memoria e amnesia. Lettura di ‘Purg.’
L’Alighieri 29, n. s., pp. 93-106.
XXXIII»,
BELLOMO, S. (2001): «Il canto XXXIII del ‘Purgatorio’», in Lectura Dantis Turicensis, ‘Purgatorio’, a cura di G. Güntert e M. Picone, Firenze, F.
Cesati Editore, 2001, pp. 503-515.
BORSELLINO, N. (1991): «Visione e profezia (‘Purgatorio’ XXXII)», in
ID., «Sipario dantesco. Sei scenari della ‘Commedia’», Roma, Salerno
editore, 1991, pp. 72-87.
CERVIGNI, D.S. (1989): «L’Eunoè o il ripristino del bene perduto», in
Filologia e critica dantesca. Studi offerti ad Aldo Vallone, Firenze, Olschki, pp. 175-198.
CIAN, V. (1958): «Il canto XXXIII del ‘Purgatorio’» [1936], in Letture
dantesche, vol. II, ‘Purgatorio’, a cura di G. Getto, Firenze, Sansoni, 1958,
pp. 657-672.
CIAVORELLA, G. (2008): «‘Purgatorio’ IX: il sogno, Lucia e l’angelo
portiere», L’Alighieri 31, pp. 43-76.
CIAVORELLA, G. (2011): «‘Purgatorio’ XXVIII: Matelda, Critica letteraria 150, fasc. 1, pp. 3-37.
CRISTALDI, S. (1988): «Dalle beatitudini all’‘Apocalisse’. Il Nuovo Testamento nella ‘Divina Commedia’», in Letture classensi 17, Ravenna,
Longo Editore, pp. 23-68.
201
Ciavorella:Maquetaci n 1
Tenzone 14
09/12/2013
11:51
PÆgina 202
2013
DAVIDSOHN, R. (1902): «Il “cinquecento diece e cinque” del ‘Purgatorio’» in Bullettino della Soc. Dant. Italiana IX, pp. 129-131.
DAVIS, C.T. (19842): «Veltro», in Enciclopedia dantesca, Roma, Istituto
per l’Enciclopedia Italiana,vol. V, pp. 908-912.
DRONKE, P. (1990): «Le fantasmagorie del Paradiso terrestre», in ID.,
Dante e le tradizioni latine medioevali, Bologna, Il Mulino, 1990, pp. 97129.
FOSTER, K. (1957): God’s tree. Essays on Dante and other matters,
London, Blackfriars Publications, pp. 33-49.
FRUGONI, A. (1972): «Il canto XXXIII del ‘Purgatorio’», in Nuove letture
dantesche, V, Firenze, Le Monnier, pp. 235-253.
GILSON, É. (1987): Dante e la filosofia [1939, 1953, 1972], trad. it.,
Milano, Jaca Book, 1987.
GIRARDI, E.N. (1989): «Il canto XXXIII del ‘Purgatorio’», in Lectura
Dantis Neapolitana, vol. II, ‘Purgatorio’, a cura di P. Giannantonio, Napoli, Loffredo, pp. 653-670.
GORNI, G. (1990): «Cifre profetiche», in ID., Lettera Nome Numero,
Bologna, Il Mulino, pp. 109-131.
GRECO, A. (1981): «Il canto XXXIII del ‘Purgatorio’», in Letture della
Casa di Dante in Roma, vol. II, ‘Purgatorio’, Roma, Bonacci, pp. 777795.
KASKE, R. E. (1961): « Dante’s “DXV” and “Veltro”», in Traditio, XVII
, pp. 185-254.
LANZA, F. (1967): «Il canto XXXIII del ‘Purgatorio’», in Lectura Dantis
Scaligera, vol. II, ‘Purgatorio’, Firenze, Le Monnier, 1967, pp. 12131234.
LE GOFF, J. (1982): La nascita del Purgatorio, Torino, Einaudi, 1982.
202
Ciavorella:Maquetaci n 1
09/12/2013
Giuseppe CIAVORELLA
11:51
PÆgina 203
Purgatorio XXXIII
MAZZAMUTO, P. (19842): «Cinquecento diece e cinque», in Enciclopedia Dantesca, Roma, Istituto dell’Enciclpoedia Italiana, vol. II, pp. 1014.
MINEO, N. (1998): «Gli spirituali francescani e l’‘apocalisse’ di Dante»,
La Rassegna della Letteratura italiana, a. 102, n. 1, pp. 26-46.
MOORE, E. (1903): «The DXV Prophecy», in ID., Studies in Dante, III Series, Oxford (rist. 1968), pp. 253-283.
PALMA DI CESNOLA, M. (1995): Semiotica dantesca. Profetismo e diacronia, Ravenna, Longo, 1995, pp. 73-97.
NARDI, B. (1967): «Il mito dell’Eden» [1922], in ID., Saggi di filosofia
dantesca, Firenze, La Nuova Italia, 1967, pp. 334 ss.
NARDI, B. (19902): «Dante profeta», in ID., Dante e la cultura medievale, Laterza, Bari, pp. 265-326.
PARODI, E. G. (1921): «La data della composizione e le teorie politiche
dell’‘Inferno’ e del ‘Purgatorio’», in ID., Poesia e storia nella ‘Divina
Commedia’, a cura di G. Folena e P. V. Mengaldo, Vicenza, Neri Pozza,
1965, pp. 233 ss.
PASCOLI, G. (1904): «Il canto XXXIII del ‘Purgatorio’», in ID., Prose, II:
Scritti danteschi, a cura di A. Vicinelli, Milano, Mondadori, 1952, pp.
1525-1551.
PAZZAGLIA, M. (1998): «Il ritorno di Beatrice», in ID., Il “mito” di Beatrice, Bologna, Pàtron, pp 123-151.
PERTILE, L. (1998): La puttana e il gigante. Dal Cantico dei Cantici al
Paradiso Terrestre di Dante, Ravenna, Longo.
PICONE, M. (2008): «L’“enigma forte”: una lettura di ‘Purg.’ XXXII e
XXXIII», L’Alighieri 31, n. s., pp. 77-92.
PORCELLI, B. (1987): «Progressione e simmetria nella sequenza di
‘Purg.’ XXVIII-XXXIII», Studi e problemi di critica testuale 35, pp. 141155.
203
Ciavorella:Maquetaci n 1
Tenzone 14
09/12/2013
11:51
PÆgina 204
2013
REMBADI DAMIANI, P. (2005): «“Un cinquecento diece e cinque”:
un’ipotesi per risolvere l’“enigma forte” di Dante», Studi Danteschi LXX,
pp. 103-117.
ROSSI, V. (1921): «Il canto XXXIII del “Purgatorio”», in Lectura Dantis
Romana, Torino, S.E.I., 1965.
SINGLETON, CH. S. (1978): La poesia della «Divina Commedia», trad.
ital., Bologna, Il Mulino, pp. 151-174, 291-448.
WILSON, R. (2008): Prophecies and profecy in Dante’s ‘Commedia’,
Firenze, Olschki.
204