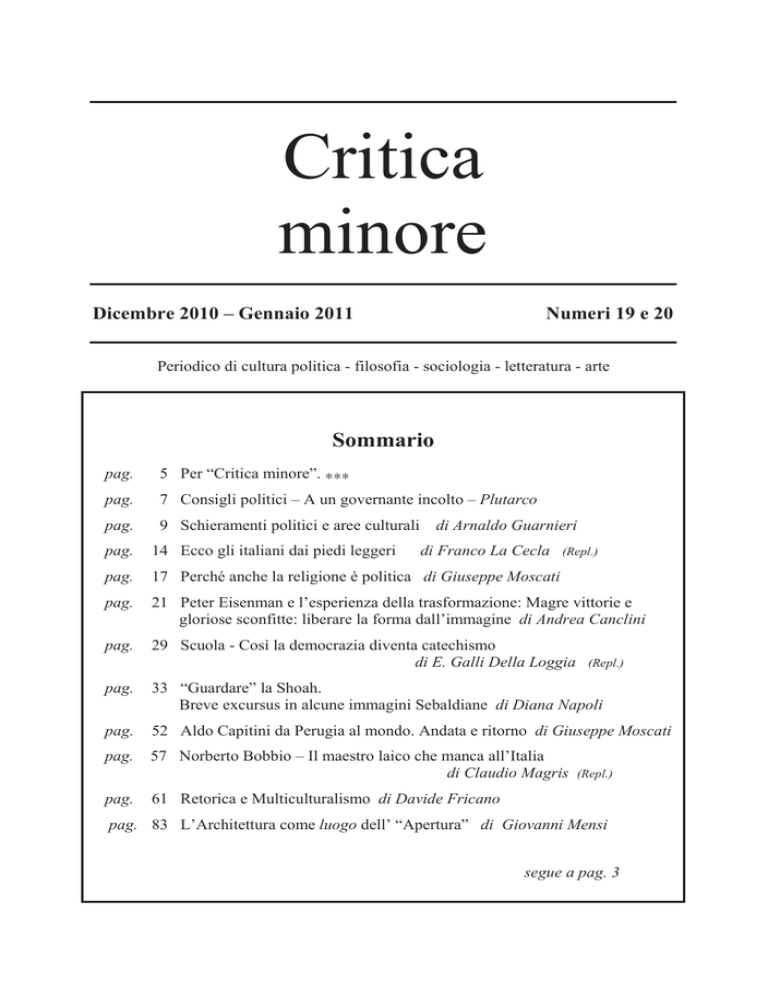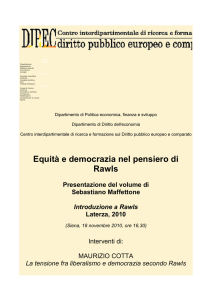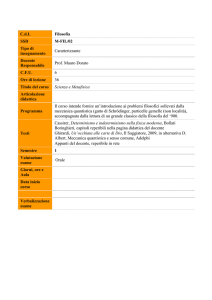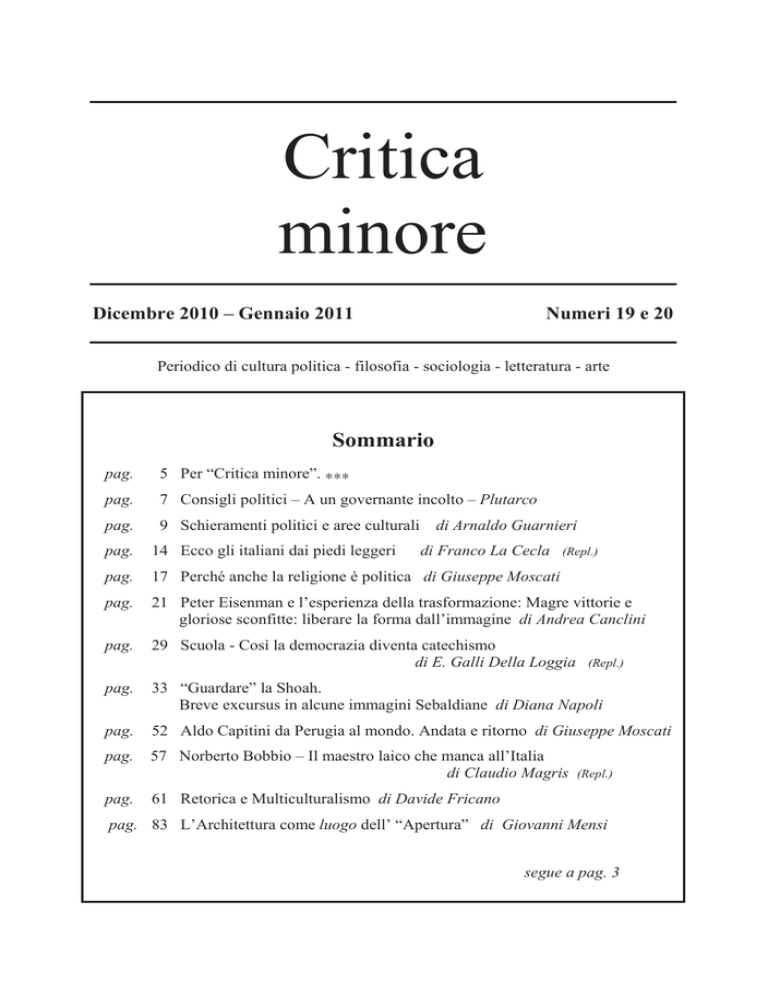
Critica
minore
Dicembre 2010 – Gennaio 2011
Numeri 19 e 20
Periodico di cultura politica - filosofia - sociologia - letteratura - arte
Sommario
pag.
5 Per “Critica minore”. ***
pag.
7 Consigli politici – A un governante incolto – Plutarco
pag.
9 Schieramenti politici e aree culturali di Arnaldo Guarnieri
pag.
14 Ecco gli italiani dai piedi leggeri
di Franco La Cecla
pag.
17 Perché anche la religione è politica di Giuseppe Moscati
pag.
21 Peter Eisenman e l’esperienza della trasformazione: Magre vittorie e
gloriose sconfitte: liberare la forma dall’immagine di Andrea Canclini
pag.
29 Scuola - Così la democrazia diventa catechismo
di E. Galli Della Loggia
(Repl.)
(Repl.)
pag.
33 “Guardare” la Shoah.
Breve excursus in alcune immagini Sebaldiane di Diana Napoli
pag.
52 Aldo Capitini da Perugia al mondo. Andata e ritorno di Giuseppe Moscati
pag.
57 Norberto Bobbio – Il maestro laico che manca all’Italia
di Claudio Magris
pag.
(Repl.)
61 Retorica e Multiculturalismo di Davide Fricano
pag. 83 L’Architettura come luogo dell’ “Apertura” di Giovanni Mensi
segue a pag. 3
Il presente fascicolo (numeri 19 e 20) della rivista “Critica minore” è stato
realizzato anche con il contributo di:
=\JPXQW=DOHVNL6WLFKWLQJ
$PVWHUGDP
La rivista “Critica minore” è disponibile nelle seguenti librerie:
La rivista “Critica minore” è disponibile nelle seguenti librerie:
Milano:
Libreria Feltrinelli
Libreria Rizzoli - Galleria
Mantova: Libreria Feltrinelli
Sondrio: Libreria Alice
Perugia: Libreria L’altra
Verona:
Libreria Cortina Editrice
Libreria Gheduzzi - Le giubbe rosse
Libreria Ghelfi e Barbato
Libreria Rinascita
Brescia
Libreria Cidneo
Libreria Feltrinelli
Libreria Ferrata
Libreria Il Libraccio
Libreria La Fenice
Libreria Punto Einaudi
Libreria Punto Giunti
Libreria Resola
Libreria Rinascita
Libreria Tarantola
Libreria Tebaldo Brusato
Libreria Università Cattolica
Libreria Universitaria (Via S.Faustino)
e inoltre presso:
Brescia
Biblioteca Queriniana
Emeroteca comunale
Biblioteca 1^ Circoscrizione
Biblioteca 2^ Circoscrizione
Sala di lettura “Cavallerizza”
Galleria dell’Incisione – Via Bezzecca
Verona
Società letteraria
Critica
minore
Periodico di cultura politica - filosofia - sociologia – letteratura - arte
E-mail : [email protected]
Sito web: www.criticaminore.it
E-mail sito: [email protected]
____________________________________________________________________________________
Direttore Responsabile: Arnaldo Guarnieri
Direzione e redazione: Via Cacciadenno, 18 - 25133 Brescia Tel. / Fax 030 2004662
Autorizzazione Tribunale di Brescia n. 60 del 19.11.2001
Stampa: Com & Print srl – Editoria e Stampa
e-mail: [email protected]
Via della Cascina Pontevica, 40 (Fraz. Folzano) 25010 Brescia Tel. 030 2161291
Editore: Arnaldo Guarnieri Via Cacciadenno 18 - 25133 Brescia
Questo numero è stato chiuso in redazione il 20 dicembre 2010 e viene distribuito gratuitamente.
E’ vietata la riproduzione non autorizzata, anche parziale, dei testi e delle immagini.
Sommario (2^ parte)
pag.
91 Le nuove regole contro la crisi di Natalino Irti
pag.
93 Cara sinistra riconquista la cultura
pag.
95 Abuso dell’arte per un’estetica al potere di Maristella Cervi
(Repl.)
5 domande a Vincenzo Cerami
a cura di Giovanna Mancini (Repl.)
pag. 115 Il concetto di critica in Foucault: dalla Riforma a Kant di Antonio Coratti
pag. 127 La Prima Guerra mondiale
di Giuseppe Moscati
pag. 142 L’italiano, una lingua democratica di Vittorio Messori
(Repl.)
pag. 145 Il principio di neutralità in Bruce Ackerman: una proposta di giustizia
distributiva dopo Rawls
di Paola Chiarella
pag.
179 Il mercato unico non basta più: l’Europa ora punti sulla cultura
di Antonio Puri Purini (Repl.)
pag. 181 INVITO ALLA LETTURA:
(a cura di Gianmaria Merenda)
George Steiner: Heidegger; Michele Mari: I demoni e la pasta sfoglia;
Jacob von Uexküll: Ambienti animali e ambienti umani. Una passeggiata
in mondi sconosciuti e invisibili; Valerio Magrelli: Nero sonetto solubile.
Dieci autori riscrivono una poesia di Baudelaire; Antonin Artaud: Al paese
dei Tarahumara e altri scritti; Daniele Benati: Opere complete di Learco
Pignagnoli; Christoph König: Strettoie. Peter Szondi e la letteratura;
Adolf Reinach: La visione delle idee; Daniel C. Dennet: Coscienza. Che
cosa è.
ARTE
pag. 201 Sculture ceramiche di Tonino Negri
Sito web
www.criticaminore.it
e-mail: [email protected]
7RQLQR1HJUL6FXOWXUDFHUDPLFD´$UWHLQ*LDUGLQRµ,VRODG·(OED
Per
“Critica minore”
Con il 2011, la nostra rivista entra nell’area temporale del decimo
anno di attività.
Come spesso accade, viene voglia (dopo dieci anni di pensieri, di
scritti, di parole che sono prodotto di analisi, di confronti, di intese,
di approfondimenti) viene voglia, dicevamo, di un piccolo bilancio.
Per segnare uno spazio, oltre che un’area temporale.
Per assicurare uno spazio praticabile per tutti quei giovani (e non
più giovani) che desiderano ancora ragionare, studiare, “teorizzare”
e, sostanzialmente, capire prescindendo dalla politica militante,
dallo scontro fisico, dall’ineleganza, dal cattivo gusto, dallo
sberleffo.
Prescindere fin che si può, naturalmente, fino a quando la
sconcezza non rischia di entrarti in casa, chè, allora, ci si difende
con tutti i mezzi che la dignità e la decenza (pur sempre)
consentono.
Dieci anni di discorsi, di comportamenti e di scelte che hanno
riunito, attorno a “Critica minore”, alcune migliaia di amici e di
lettori provenienti da tutte le regioni d’Italia e, sempre più, anche
dall’estero.
Un sincero profondo ringraziamento a coloro che ci hanno finora
sostenuto con la convinzione, palese, che si tratta di salvaguardare,
fin che si può, una specie preziosa e protetta, quella della libera
cultura critica.
* * *
5
7RQLQR1HJUL6FXOWXUDFHUDPLFD´$UWHLQ*LDUGLQRµ,VRODG·(OED
______________________
Consigli politici
_____
A un governante incolto
“Il potere non riesce a nascondere i vizi e come gli
epilettici quando si trovano in luoghi elevati soffrono di
vertigini e sono attanagliati dall’angoscia, così le persone
incolte e ineducate, quando la fortuna li favorisce
attribuendo loro fama e ricchezza, immediatamente sono
sovrastate dalla vertigine del potere e incominciano a
rovinare in basso.
Per maggiore chiarezza: come capita quando ci troviamo
di fronte a due vasi, uno integro e uno rotto, possiamo
distinguerli soltanto se versiamo al loro interno del liquido
che vedremo colare da quello incrinato, così le anime
guastate non riescono a contenere il potere e lasciano
uscire avidità, desideri di vendetta, ira, arroganza e
volgarità”.
Plutarco
Plutarco: Consigli politici – “A un governante incolto”.
(Traduz. Milano 1994 – Edizione “Les Belles Lettres”, Paris 1984)
_____________________
7
7RQLQR1HJUL6FXOWXUDFHUDPLFD´$UWHLQ*LDUGLQRµ,VRODG·(OED
Schieramenti politici e aree culturali
di Arnaldo Guarnieri
E’ sempre più evidente che la partita politica (e non tanto quella elettorale)
si gioca sulla tenuta culturale dei vari schieramenti che si danno battaglia in
questo periodo, nel nostro Paese.
Che cosa significa: “tenuta culturale”? Significa la presenza o meno, di uno
spessore storico, di una consapevolezza dei significati e delle scelte politiche
da parte di generazioni di militanti, nonché di una accettabile profondità
speculativa nelle elaborazioni teoriche che hanno fondato quelle scelte e
quei significati.
Senza questo patrimonio ideale, morale ed intellettuale, uno schieramento
politico ha un valore strettamente simbolico, addirittura il peso effimero di
un gesto.
Un buon numero di osservatori e di frequentatori di questo tipo di
problematiche, si spinge anche oltre, nel constatare, per esempio, il diffuso
desiderio di un recupero nostalgico delle ideologie da parte soprattutto di
concentrazioni partitiche nuove o seminuove.
Si pone, in questo caso, la questione se siano esse (le ideologie) recuperabili
a tutti gli effetti e rilanciabili nel cuore dell’attualità e della contemporaneità
più immediata, o se abbiano semplicemente il diritto di essere riconosciute
come semplici coefficienti organizzativi e/o riferimenti orientativi molto
generici.
Del resto la dimensione del “post-ideologico” non si è ancora guadagnata i
“galloni” di una vera e propria “categoria dello spirito” a tutti gli effetti, di
una esauriente e matura fenomenologia politica ed esistenziale (soprattutto
in Italia). Sembra piuttosto che il vissuto un po’ schizofrenico di quei partiti
che vogliono prendere le distanze dalle ideologie di provenienza, non riesca
ancora a mettere a punto una convincente area culturale alternativa.
Bisogna riconoscere che non è cosa facile costruire, in uno spazio mentale
nuovo, il “lessico” morale e teorico di un messaggio politico che interpreti i
reali bisogni spirituali e materiali di una nuova epoca storica. Soprattutto
quando questa “nuova epoca” è abitata da un popolo che si rifiuta spesso di
essere tale, preferendo mettersi in pratica piuttosto come agglomerato di
etnie caratterizzate da consuetudini, al posto di veri propri caratteri culturali,
capaci di contributi e interpretazioni originali.
Mai come in questo momento ritorna di attualità la celebre immagine del
“trovarsi in mezzo al guado”. Solo che, in questo particolare momento, essa
9
significa che le “forze politiche” sono estenuate dallo sforzo di una intensiva
disintossicazione anti-ideologica e, mentre non hanno ancora concluso
l’auto-terapia in atto, non hanno, contemporaneamente, creato i presupposti
per un futuro sufficientemente strutturato. Un futuro fondato, soprattutto, su
finalità sociali che non escludano la dimensione individuale nella scelta dei
principi morali, e rilancino contemporaneamente quella collettiva, nella
individuazione di regole cogenti e universalmente riconosciute.
L’attualità ci dice clamorosamente, che, in Italia, persiste una forma di
isterismo generalizzato che denuncia soprattutto la mancanza di prospettive
reali e stabili.
Si sprecano gli stereotipi come, per esempio: “…la navigazione a vista “,
“…la flessibilità come nuova capacità di intendere la vita stessa e non solo i
rapporti di lavoro…” ecc. ecc.
Se questi “princìpi” fossero stati formulati in un periodo di ridente opulenza,
essi non apparirebbero gravemente sospetti come appaiono ora! Si tratta,
ovviamente, di “princìpi” di una sociologia spicciola costruita su misura per
certi contenitori economici che tendono a stabilizzare alcuni vecchi centri di
potere, a carico di generazioni di forza-lavoro, che dovranno rassegnarsi ad
essere perennemente fluttuanti e, come minimo, a vivere alla giornata, cioè,
di fatto, senza le risorse psicologiche e materiali per poter formulare un
libero giudizio politico sulle dinamiche sociali e sui rapporti umani.
Cioè, in sostanza, senza la possibilità di una valutazione contrassegnata dalla
presenza di una cultura critica.
In un periodo di crisi gravissima dei rapporti umani (oltre che economici)
dove la famiglia degrada nel familismo” e si trasforma da “punto di
partenza” (per il suo approdo vero e appropriato che è la società) in “punto
di arrivo”, cioè cittadella fortificata nella quale trovare definitivo rifugio
psicologicamente armato; per proseguire nel progressivo e consapevole
impoverimento critico della scuola e dei suoi connotati culturali
fondamentali (si veda in “Critica minore” sito web l’articolo di E. Galli
Della Loggia dell’8 novembre scorso, dal Corriere della Sera), tutto sembra
concorrere drammaticamente a privare quelle cosiddette “forze politiche”
del supporto decisivo della cultura che (quando c’è davvero come insieme di
valori ispiratori) diventa punto di riferimento per tutte le classi sociali che
cominciano a confluire in variegate realtà di popolo e che, finalmente, si
attivano nella costruzione di nuovi modelli e di nuove sintesi unitarie di
bisogni e idealità.
Senza retroterra culturale (inopinatamente sepolto insieme alle ideologie),
senza neppure intravedere la sponda opposta immersa nella nebbia più fitta,
il “passaggio del guado” si presenta rischiosissimo.
Per restare nella metafora, prima di gettarsi nelle acque gelide del fiume,
bisognerebbe organizzare sulla sponda di partenza tutta una rete di garanzie
10
e di strutture ben studiate e collaudate per vincere ogni ostacolo e ogni
imprevisto.
Per fare ciò occorrono unità di intenti, abilità tecniche, consapevolezze
morali, limpide intelligenze.
Ma più si elencano le risorse che sarebbero necessarie, più si allontana la
fiducia nella possibilità di completare quel processo di formazione di una
“italianità” che rimane ostinatamente un miraggio.
L’Italia è: “Un Paese troppo lungo” (recita il titolo di un bel libro
recentissimo di Giorgio Ruffolo).
Un Paese che per ampi periodi ha subito pesanti invasioni straniere e
sottomissioni che hanno lasciato segni indelebili e “veleni” come il
servilismo e il ricorso all’espediente delle “vie brevi” per conseguire i
risultati, (come carattere peculiare di una buona parte della penisola!)
La “vocazione europea” che ha caratterizzato molte e prestigiose
testimonianze e sostanziali omogeneità di stile e di qualità morali tra gli
intellettuali italiani di ogni latitudine (anche nei periodi più oscuri della
nostra vita politica) è presente e viva in splendidi scritti e opere di ogni
genere. Basterebbe non umiliare con il giudizio di irrilevanza la ricerca di
queste risorse intellettuali e morali, per riattivare antiche e nuove energie e
riversarle in un intelligente, intenso programma di recupero. Si tratta di un
immenso patrimonio che, nel giro di pochi anni, porterebbe frutti abbondanti
per tutta la comunità, nonostante le molte centrali di dirottamento, di
travisamento e di vera e propria dequalificazione programmata, che si
attivano sempre tempestivamente, in questo paese, che sembra aver
dichiarato guerra all’ingegno, all’eccellenza, alla qualità e, in definitiva, alla
cultura.
E non è sufficiente “voltarsi indietro” per ritrovare i connotati culturali
peculiari di una forza e di una esperienza comune.
Ci sono ex esponenti politici di primo piano (soprattutto democristiani) che
rievocano volentieri, in questo periodo e in ripetute occasioni pubbliche,
vicende significative della vita politica italiana (a volte anche scabrose) per
dimostrare, in sostanza che “governare è difficile” soprattutto quando la
necessaria mediazione deve avvenire tra la moralità e il potere.
La mediazione di potere è un conto, la mediazione politica è un altro.
Perfino Aldo Moro, in varie occasioni, scelse la prima delle due (benché
certamente a malincuore) con grande determinazione (vedi lo scandalo
Lockheed).
Questo “voltarsi indietro” nella rievocazione di dinamiche politiche
trascorse (non certo limpidissime dal punto di vista della coerenza morale)
può anche essere un aspetto della vita culturale di un Paese, perché rivela la
consapevolezza spesso sofferta delle difficoltà, appunto, di una mediazione
che dovrebbe essere sempre politica e mai di “potere”.
11
L’azione di governo, in un paese come l’Italia, si è sempre rivelata
estremamente ardua anche perché chi governa si è sempre trovato di fronte
ad una diffusa indulgenza nei riguardi di un’anti-cultura militante, sensibile
solo ai richiami populistici pronti a legittimare qualsiasi comportamento
trasgressivo, purchè funzionale a qualche “convenienza” non solo privata.
La convivenza civile, in Italia, è il risultato residuale ed enfatico di uno
scontro fisico tra esigenze individualistiche o tra clans.
Se c’è chi ritiene di “voltarsi indietro” per recuperare un po’ di spessore
esperienziale collettivo e di vita almeno propedeutica alla politica, vi sono
anche, al contrario, alcuni esponenti vecchi e nuovi, di altri schieramenti,
che non azzardano neppure questo tipo (in fondo elementare) di scelta, nel
timore di peggiorare la propria situazione. Essi preferiscono parlare
avidamente di futuro perché solo guardando avanti sperano in nuovi, radicali
riscatti, rispetto a tenebrosi trascorsi epocali.
In un recente convegno che ha visto riuniti i responsabili europei di periodici
impegnati in argomenti di “cultura politica”, il rappresentante di una rubrica
radiofonica svizzera, con toni sinceramente affranti, ha dichiarato che
l’Italia, spesso, impiega tesori di intelligenza per indicare la necessità di un
recupero del livello culturale medio dei propri lettori. Il risultato, però, è
clamorosamente insufficiente visto che i militanti dell’anti-cultura (che
spesso operano in strutture criminogene istituzionalizzate) dispongono di
mezzi dissuasivi di grande portata capaci di eliminare i centri di propulsione
culturale più qualificati. La conclusione di quell’analisi chiara e puntuale è
stata che il “caso Italia” non può avere altro che una soluzione europea.
In attesa, però, che l’Europa si coalizzi per lanciare all’Italia un buon
salvagente, aprendo una solida carta di credito circa le nostre possibilità di
ricostruzione civile, gli schieramenti politici dovrebbero innanzitutto
accantonare definitivamente gli impulsi faziosi e le dipendenze settarie che
distruggono in partenza ogni possibilità di far cultura. Essi dovrebbero,
quindi, procedere ad una serena acquisizione delle testimonianze di qualità
che provengono con grande generosità e ricchezza dalla società civile “prepolitica”.
Questa società civile “pre-politica” è sempre più diversa da quella alla quale
si fa spesso riferimento nel corso del dibattito politico in corso.
Gli esponenti dei vari partiti che si confrontano abitualmente tendono ad
assimilare la società civile a quella politica, con la battuta sbrigativa: “…la
società civile ha la classe politica che si merita!”
Sono, per fortuna, in molti in Italia, a constatare che c’è un abisso tra la vera
società civile e la classe politica. Una profonda differenza sulla quale si
fondano esplicitamente molte (e ultime) speranze concrete di rinnovamento
sociale.
12
La vera società civile ignora, progressivamente, le varie forme di potere che
la classe politica si attribuisce per rigenerare se stessa. La vera società civile
si rivolge, da tempo, alla cultura, al dibattito reale, al confronto genuino tra
le forze sociali per rifondare la politica sui rapporti umani autentici e dar
luogo ad istituzioni e strutture finalmente non deviate e non deviabili.
Questa società civile vera, sviluppa ogni giorno di più una vita parallela a
quella politica ufficiale, tanto che è sempre più intollerabile il contrasto
irreversibile tra una vita civile, da una parte, e un andazzo spurio e
millantatore dall’altro.
La storia ci insegna abbondantemente che il parallelismo tra società civile e
società incivile non è eterno e che l’evidenza, ad un certo punto, chiama
fatalmente all’impatto.
Arnaldo Guarnieri
7RQLQR1HJUL6FXOWXUDFHUDPLFD´$UWHLQ*LDUGLQRµ,VRODG·(OED
13
TRIBU’ SOCIALI
GENERAZIONE FIGLI DI ERASMUS
Dicono: “Parigi è la città italiana migliore che c’è”. Scelgono l’Europa perché la sentono
casa e così vanno a caccia della meritocrazia che da noi manca.
Ecco gli italiani dai piedi leggeri
di Franco La Cecla
C’è una nuova classe, apparentemente invisibile, che si sta formando da circa
vent’anni, una classe che non fa parte della borghesia italiana, che non rientra
nell’esercito di precari, né in quello dei raccomandati per famiglia, politica,
censo e appartenenza. E’ una strana compagine di quarantenni, trentenni,
ventenni che ha abbandonato l’Italia appena finiti gli studi, o addirittura durante
gli studi, fulminata sulla via dell’Erasmus dalla scoperta che la vita all’estero, in
Europa, poteva essere tre volte più interessante, facile, appassionante che in
Italia.
Non si tratta di emigrati nel vero senso della parola e nemmeno di una fuga di
cervelli, ma di italiani, ragazzi e ragazze, uomini e donne che stanno all’estero
in Europa “come se fossero in Italia”.
Hanno scoperto che le complicazioni burocratiche, il clima fatiscente e
ricattatorio dell’università italiana, lo strangolamento delle potenzialità giovanili
è una malattia solo italiana e semplicemente, rapidamente si sono messi in
salvo con un’ora di aereo, chi a Barcellona, chi a Berlino, chi a Parigi, chi ad
Amsterdam e altri in Polonia, Portogallo, a Londra, e perfino a Riga e Vilnius.
Io che sono più anziano di loro, ho scoperto a un certo punto che era stupido
vivere in una città cara e inefficiente come Milano e che Parigi offriva molto di
più con un costo della vita molto inferiore e un’apertura al mondo impossibile a
Milano. Quando mi chiedevano dieci anni fa perché stessi a Parigi rispondevo:
“E’ l’unica città italiana che funziona”. E non era una battuta, davvero per me
Parigi era quello che l’Italia poteva essere se non fosse stata governata negli
ultimi cinquant’anni da una classe dirigente che faceva e fa di tutto per restare
indietro rispetto all’Europa e al mondo.
La mia era una protesta contro le regole ridicole di una società, quella italiana,
che umiliava il merito e ignorava la globalizzazione con un disprezzo verso la
cultura, gli intellettuali, i ricercatori. Ricordo ancora l’incredibile piacere di
essere chiamato da agenzie sconosciute, da datori di lavoro mai visti, da centri
di ricerca i cui direttori non mi avevano mai invitato a cena, ma avevano letto le
mie ricerche. Che felicità essere giudicato dal proprio fare e non dalla propria
rete di compiacenti alleati!
Quella che mi sembrava una scelta individuale era già invece la scelta di
migliaia di architetti, esperti di comunicazione, curators d’arte, videoartisti,
fotografi, psicologi, antropologi, registi, artisti, musicisti, danzatori e danzatrici. Il
mio amico Emiliano Armani, piacentino, stava da quindici anni a Barcellona. Vi
14
era andato a cercare una formazione in Italia impossibile, quella nello studio del
grande Miralles che ti prendeva in stage, ma ti pagava anche. Incredibile per un
giovane architetto che era abituato ad essere sfruttato dagli studi milanesi o a
volte dover pagare per lavorare in un’agenzia di una grande firma.
Emiliano sta ancora a Barcellona, la situazione è cambiata, un po’ più difficile,
oggi con la crisi, ma non ha la più vaga intenzione di tornare in Lombardia.
E’ lui però a dirmi che in realtà ha scoperto di essere italiano proprio a
Barcellona. Perché, dice, gli italiani in Italia sono individualisti e non fanno quasi
mai gioco di squadra, è solo all’estero che scoprono di avere qualcosa di
particolare che li distingue dagli altri, un’italianità che gli “altri”, gli “stranieri”
riconoscono subito e che è considerata una qualità e non solo un tic nervoso. E
ribadisce che Barcellona per lui è una città italiana, nel senso che lui ci si
muove pensando di restare italiano, di non perdere i contatti con l’Italia. Ma è
da Barcellona che può agire con una libertà e una creatività che in patria
sarebbe solo punità come impertinenza giovanile e incapacità di rispettare
faccendieri, speculatori, malavitosi e politici ignoranti.
Michele Ferrà è un siciliano che si è trasferito a Berlino per impiantare una casa
di produzione di video e film. Berlino gli dà la tranquillità, l’efficienza, la
convenienza – qui la vita costa quattro volte meno che in Italia – e una rete
mondiale di contatti. Michele rimane siculo e palermitano fino in fondo, ma non
tornerebbe mai a Palermo, città a cui non perdona il carattere nero,
spaventosamente squallido e corrotto, la voragine della connivenza mafiosa e
l’incapacità di sperare e di fare. Eppure lui non diventerà berlinese, né
americano – paese in cui va spesso – né thailandese, paese in cui gira i suoi
film.
Matteo Pasquinelli è un ricercatore nel campo dei mass media e dei cultural
studies. Ha fondato Rekombinant, è una delle persone più informate e
preparate sul mondo del web, della trasformazione post-globale, delle
mutazioni del neo-capitalismo. Pensate che gli abbiamo mai offerto nulla in
Italia? Pensate che l’Università di Bologna gli abbia spalancato le porte dei
laboratori? Ma nemmeno per sogno. Allora sono dieci anni che vive sostenuto
da istituzioni britanniche, olandesi, tedesche e che continua a inventare analisi
della situazione reale, a scrivere sulle riviste specializzate, ad aprire siti. Lui non
diventerà olandese, né tedesco perché è indelebilmente uno spinozista
romagnolo, epicureo riminese, nelle sue valigie stipa, a ogni ritorno, farina di
castagne dell’Appennino e sangiovese.
Quando andiamo a spasso in una delle sue città europee alla ricerca di un
ristorante che non ci faccia troppo sentire la nostalgia a me della caponata e a
lui della piadina, ho l’impressione che qualcosa di differente sta accadendo a
una parte d’Italia.
Queste persone e molte, moltissime altre sono l’Europa, senza bisogno di
troppi discorsi e teorie, e hanno capito qualcosa che i teorici dell’Europa non
hanno mai capito: che l’euro e l’Europa sono la possibilità di restare italiani,
greci, spagnoli, francesi senza essere umiliati dalle stupide politiche nazionali
dei rispettivi paesi. Essere europei significa mantenere una propria identità
senza doverla confondere con un’appartenenza ad una classe dirigente che in
patria blocca i processi d’apertura e trasformazione.
Ovviamente questo è il quadro positivo, profondamente innovatore di questa
compagine di nuovi europei, sono quello che George Steiner chiama
15
“luftmenschafte”, uomini dai piedi leggeri, una definizione sprezzante con cui i
nazisti appellavano gli ebrei e tutti i cosmopoliti. La parte tragica sta nel fatto
che questo è il risultato di un’espulsione: per l’Italia si tratta della liquidazione di
una potenziale classe dirigente di professionisti, pensatori, ricercatori,
imprenditori. E questa è davvero una tragedia: ognuno dei miei amici italiani in
Europa condivide amari ricordi di strade bloccate, di rifiuti, di offerte di lavoro
ricattatorie, di posti universitari in cambio di una beota fedeltà alla noia
accademica.
Allora stare in Europa è diventata anzitutto una forma di cura, un dirsi: ma no,
ma no, il mondo non può essere così meschino, c’è merito, speranza,
possibilità di trovare persone con cui costruire assonanze e con cui inventare,
sperimentare, creare senza il peso di coloro che hanno sempre fatto sì che il
mondo dovesse sembrare solo un circolo chiuso e vizioso.
Franco La Cecla
FOTO S. Santioli
L’articolo sopra riprodotto è stato pubblicato domenica 1 agosto 2010 da IlSole24Ore.
Ringraziamo la direzione del giornale e l’autore per la gentile concessione.
7RQLQR1HJUL6FXOWXUDFHUDPLFD´$UWHLQ*LDUGLQRµ,VRODG·(OED
16
Perché anche la religione è politica
Alcune considerazioni a partire da La fede ferita di Mariano Borgognoni
di Giuseppe Moscati
Quella che il saggio di Mariano Borgognoni La fede ferita1 intende
riconquistare, anche grazie a un vero e proprio attraversamento dell’opera e
in particolare dell’apocalittica di Sergio Quinzio, è una posizione di
sostanziale ripensamento di ciò che è fede.
La fede di cui qui si parla è una fede ferita perché sofferta, riscoperta anche
in virtù del riconoscimento delle debolezze e fragilità e vulnerabilità, una
fede rimessa coraggiosamente in discussione. E la ferita della fede va
pensata. Così ferita, sanguinante, la fede non può proporsi come chiusa in se
stessa e priva di “timori” e “tremori” (per richiamare Kierkegaard), bensì ha
da farsi fede adulta alla Dietrich Bonhoeffer, il quale è suggeritore di una
straordinaria immagine di Cristo come essere-per-gli-altri. Anche perché,
con ironia lo ha ricordato non molto tempo fa Paolo Flores D’Arcais2, la
pretesa di conoscere la volontà di Dio e di parlare in suo nome in psichiatria
si chiama “delirio di onnipotenza”. Ripensando l’idea di fede, allora, non
possiamo che ripensare anche l’immagine di Cristo. Leggendo La fede ferita
mi è tornato in mente – fatto forse un po’ curioso – San Bonaventura, per il
quale Cristo non è più, come invece per i Padri della Chiesa, la fine della
storia, bensì il centro della storia; con Cristo e con il suo paradigma eticoreligioso, ma direi anche politico-sociale, la stessa storia sembra avere un
nuovo inizio. Anche la religione è politica.
In questo lavoro di ripensamento, la pagina di Quinzio, sentinella insonne, è
molto ficcante. Ridando centralità al testo dell’Apocalisse, infatti, egli mette
in evidenza la ferita della fede e, come dice efficacemente Borgognoni, nel
bene e nel male ci obbliga a “stare nella contraddizione”.
Non è certo facile comunicarlo, questo paradosso di una fede che è
abbandonarsi e insieme restare inquieti, ma è possibile.
La fede quinziana con cui Borgognoni discute, senza d’altra parte rinunciare
a un serio atteggiamento critico che qua e là lo porta a rimarcare anche le
1
M. Borgognoni, La fede ferita. Un confronto col pensiero apocalittico di Sergio
Quinzio, Cittadella Editrice, Assisi 2009.
2
P. Flores d’Arcais, La religione e la democrazia, La Repubblica 4 maggio 2010.
17
distanze oltre che le vicinanze3, non è una fede assoluta, caratterizzata da
quelle che Italo Mancini chiamava “le false alture spiritualistiche”, ma
piuttosto è la fede della speranza assoluta. Direi, in questo senso, che è
l’esatto contrario dell’idea della fede come possesso, che fin troppo spesso
abbiamo visto tradursi pericolosamente in arma. Se non si vuole che la fede
rischi di diventare un oggetto contundente da brandire contro l’altro, contro
il diverso, contro chiunque la pensi diversamente da se stessi e dal proprio
clan, si deve essere pronti a una rinuncia e a un impegno. La rinuncia è
quella, appunto, a una fede conchiusa e onnisciente, sicura di sé al punto da
tapparsi le orecchie alle parole dell’alterità (ogni volta etichettata in questo o
quel modo); l’impegno è quello per uno sforzo di disinnesco: dobbiamo
disinnescare la fede contundente, come dicevo, ma anche la fede-bomba a
orologeria. Vale a dire dobbiamo disinnescare quella fede che –
allontanandosi per esempio anni luce dal cristianesimo delle origini e dal
messaggio dello scándalon del Cristo che condanna il dominio e le varie
forme di idolatria – scende a patti con il potere e addirittura si fa essa stessa
potere nel senso deleterio del termine.
Andando al di là di Quinzio e volendo anche prestare attenzione all’attualità,
mi sembra opportuno citare le parole di un potente del mondo che ha oggi
nelle sue mani la preziosa possibilità di riformare il concetto stesso di
potere, se davvero dovesse riuscire – come mi auguro – a declinarlo come
potere dal basso, Barack Obama. Nel suo libro-raccolta di interventi
intitolato La mia fede4 leggiamo: «Ho l’impressione che noi facciamo un
errore quando non vogliamo riconoscere il posto che la fede occupa nella
vita della gente […]. A prescindere dal fatto che sia religiosa o meno, la
gente è stanca di vedere che la fede viene usata come un’arma d’attacco […]
per sminuire e per dividere»5. Mi ripeto: anche la religione è politica.
L’elemento del tragico è chiaramente co-essenziale al religioso e nello
specifico al cristianesimo. Da una parte ricorderei Francesco con la sua
“eccedenza di carità”, dall’altra – ma non certo in opposizione – Emmanuel
Lévinas con la sua tematica del volto ‘ferito’ dell’atro. La croce continua del
resto, fortemente, a rimanere un paradosso e un paradigma dell’etica
cristiana, ma al tempo stesso continua anche a rappresentare un simbolo
incarnato. La croce, di fatto e senza sosta, funge ancora oggi (e non può
essere diversamente) da pungolo per i cristiani affinché non si “siedano”,
non si accomodino sull’accogliente poltrona della certezza, ma sappiano
assumere in pieno la difficile opzione per il dubbio e l’altrettanto scomoda
3
Cfr., per esempio, M. Borgognoni, La fede ferita, cit., pp. 133-134.
B. Obama, La mia fede. Come riconciliare i credenti con una politica democratica,
Marsilio, Venezia 2008.
5
Ivi, p. 29 e p. 43.
4
18
sfida dell’apertura dell’ascolto reciproco e di un dialogo autenticamente
interreligioso, o meglio intrareligioso come a ragione preferisce dire
Raimon Panikkar. E dunque un dialogo aperto, senza più barriere
confessionali e che sia veramente incontro ‘con’ e ‘fra’ le interiorità
religiose dei dialoganti.
È bene tra l’altro anche interrogarsi tutti, seriamente, su una questione
cruciale: a che punto siamo, oggi, rispetto a questo processo di
trasformazione dell’interreligioso nella nuova prospettiva dell’intrareligioso,
inteso appunto come partecipazione attiva delle interiorità religiose al
dialogo?
Ripartendo da questa idea di fede in cammino, possiamo recuperare anche
una piattaforma che considero imprescindibile per affrontare alcuni temi
decisivi che si presentano a noi contemporanei in tutta la loro urgenza e
inaggirabilità, temi quali quelli del confronto genuino con l’altro, della
valorizzazione di ciò che è alterità e della stessa cooperazione interculturale.
Mi riferisco alla piattaforma conoscitivo-esistenziale dell’io-tu, buberiano e
prima ancora feuerbachiano, quale vero e proprio fondamento della verità.
Ecco la fonte profondamente umana, esigenziale, della religione, ma ecco
anche la dimensione comunitaria di quella che vorrei chiamare una laicità
responsabile: siamo agli antipodi del laicismo come pure della posizione di
indifferenza verso il sacro. Ma, ancora una volta, vediamo come la religione
sia politica.
Proprio a proposito dell’io-tu come luogo della verità, coincidente con la
verità, Leo Lestingi, scrivendo del bel classico di Lessing Nathan il saggio6,
ha affermato: «ciascuna religione dovrebbe percepire se stessa come
frammento»7, la fede «può e deve mordere nella realtà concreta e può essere
soggetto di produzione storica solo attraverso la mediazione dell’elemento
etico»)8; il segno religioso può così finalmente darsi al plurale nello stesso
momento in cui è peraltro vivibile come unico. Nello scegliere la via del
dialogo, insomma, non è necessario rinunciare all’unicità e alla peculiarità
dell’intima persuasione religiosa per questa o quella fede, che non deve
pertanto ridursi a identità esclusivisticamente irrigidita e chiusura dogmatica
(fede autoritaria e tetragona), ma che deve continuamente riscoprirsi
sentimento religioso ed esperienza religiosa, come ci suggerisce il nostro
Aldo Capitini. Ed in tal senso è un peccato che non si sia mai aperto un vero
dialogo tra Quinzio e Capitini, pur essendocene tutte le potenzialità.
6
Cfr. G.E. Lessing, Nathan il saggio, a cura e con traduz. di Leo Lestingi, Palòmar,
Bari 2009.
7
L. Lestingi, Introduzione, in G.E. Lessing, Nathan il saggio, cit., p. 22.
8
Ivi, p. 20.
19
Solo considerando il tu all’interno di una relazione orizzontale di pari diritti
e di pari dignità con l’io riusciamo dunque a intendere realmente la verità
nei termini dialogici dell’incontro tra alternative possibili, di collaborazione
piena e soprattutto di co-evoluzione. Ovvero nei termini di una crescita
comune perché comune è il bene in gioco, sia esso riconducibile alla
salvezza eterna nell’ottica del credente o, laicamente, alla vita su questa
Terra, pianeta in tutto e per tutto maltrattato (come tristemente ci ricorda il
disastro ecologico in Louisiana) per i non credenti, o comunque
riconducibile in qualche modo alla nostra responsabilità verso le generazioni
a venire.
FOTO T. Negri
Giuseppe Moscati
7RQLQR1HJUL6FXOWXUDFHUDPLFD´$UWHLQ*LDUGLQRµ,VRODG·(OED
20
Peter Eisenman e l’esperienza della trasformazione.
Magre vittorie e gloriose sconfitte: liberare la forma
dall’immagine.
“Vivere rettamente è come un’opera d’arte” (Abraham Joshua Heschel)
“La conoscenza della verità da sola non basta…” (Albert Einstein)
di Andrea Canclini
La presenza di architetti ebrei nello star system dell’architettura, si manifesta
compiutamente solo negli anni Ottanta del Novecento, a seguito delle fugaci
esperienze espressioniste di Mendelsohn. Improvvisamente, alcuni dei
principali architetti sulla scena mondiale sono ebrei, e soprattutto operano
una poetica dai forti legami con i caratteri dell’ebraismo.
L’architettura, disciplina che l’ambiente culturale ebraico tenne a lungo ai
suoi margini, inizia a incarnare la ricerca di un esito, l’ansia della ricerca di
liberazione dalla «patria portatile»: ciò accade proprio negli anni in cui
milioni di ebrei si stabiliscono negli Stati Uniti. Poche generazioni, ed
emergono i rappresentanti di una professione orientata a esprimere la propria
poetica in oggetti stabili, possibilmente duraturi.
La letteratura anticipa: circa vent’anni prima la Jewish Renaissance è
formata da scrittori come Saul Bellow, Philip Roth, Jerome David Salinger,
Norman Mailer, Arthur Miller, Isaac Bashevis Singer. Pronto, il «diverso»,
dopo avere rotto il mito dell’omologazione, irrompe anche in architettura.
Chi potrà meglio esprimere, in termini ormai post-moderni, il senso di
spaesamento, di assenza d’identificazione (a vantaggio dell’individualità),
della mancanza di topos e di «luogo», lo sgretolamento degli ideali? Chi,
meglio dell’ebreo, che di tali assenze ha sempre denunciato il disagio?
Anche in architettura la differenza si era fino allora manifestata, appunto,
come un’assenza: nel non esercitare la professione. Il disagio di esercitarla
sarà comunque inferiore a quello drammaticamente vissuto dagli artisti
impegnati nelle arti figurative, ove il conflitto tra spiritualità e impegno
artistico porrà la questione della riproduzione delle immagini sacre; in
architettura la questione è certamente minore, anche se non assente.
Per questi architetti una delle principali questioni che si pongono riguarda la
scelta di come coniugare la secolare e unica posizione del popolo ebraico
rispetto alle nazioni e ai popoli; come declinare l’assenza di stabili
istituzioni e, ciò che qui rappresenta una questione, l’assenza di luoghi?
21
Luoghi assorbiti dall’esodo, che si è fatto ed è stato tempio, scuola, dimora,
surrogato diffuso.
Spesso si è considerata la visione del mondo dell’ebraismo come una
concezione temporale, mai riducibile a un’elaborazione spaziale; lo stesso
dio ebraico compare in un momento preciso della storia del popolo, per
trarlo dalla schiavitù d’Egitto, preciso evento storico, non come creatore del
mondo, il luogo. E anche la creazione è comunque un processo che sottostà
alla condizione del tempo, i giorni della creazione.
Un’altra questione derivante dal rapporto con le nazioni e i popoli, riguarda
il fatto che la cultura ebraica ha sempre tenuto conto delle culture «altre», e
l’opposizione è stata così spesso positiva che forse la storia della cultura
ebraica può essere fatta solo in dialettica con i pensieri della storia e dei
luoghi; anche se è necessario precisare che in altre occasioni l’individualità
ebraica, riguardo ad alcune precise posizioni teoriche, ha prodotto
opposizioni integrali come, ad esempio, sul tema dell’iconografia sacra, per
cui resta valido il divieto di rappresentare il sacro in immagini.
Nel Novecento però le parti sembrano essersi rovesciate; la relatività delle
posizioni continua a essere l’obiettivo, la discontinuità e le interpretazioni
passano nei codici, la dissonanza rompe le certezze moralistiche aprendo
strade anticonformistiche verso ogni direzione. In ciò la cultura ebraica ha
prodotto figure di primo piano, contribuendo a rivoluzionare il pensiero
moderno: in dissenso alle regole assolutiste queste figure sono divenute di
dominio comune e costituiscono la ragione di maggior spaesamento
contemporaneo. In più, lo stesso concetto di «diversità» estende i propri
diritti a ogni individuo, così che lo smarrimento compone il carattere
pauroso della storia contemporanea; in ciò la cultura ebraica gioca in casa: le
teorie della dissonanza, dell’inconscio, della relatività sono nate nel suo
stesso seno, inconcepibili fuori da quella matrice, dove l’atavica condizione
di smarrimento sembra costituire i presupposti ideali per lo sviluppo.
Quali sono gli architetti ebrei, europei, statunitensi o israeliani, che sono (o
sono stati) sul proscenio dell’architettura internazionale contemporanea?
Eccone alcuni: Peter Eiseman, Frank O. Ghery, Daniel Libeskind, Zvi
Hecker, Richard Meier. E ancora: Louis Kahn, Richard Neutra, Richard
Rogers.
Paradigmatico è Peter Eisenman: quasi ottantenne newyorkese,
probabilmente il più intellettuale, colto e indipendente professionista degli
ultimi decenni, ha sempre subìto, e sempre rifiutato, la definizione di
«decostruttivista»; la vicinanza (e collaborazione) col filosofo Jacques
Derrida fu sufficiente. La ricerca della liberazione della forma dai significati
l’ha portato all’erosione del senso, per un linguaggio dalle parole spogliate,
soprattutto dalla contingenza della storia.
22
Eisenman vive una sincera passione per l’opera dell’architetto razionalista
italiano Giuseppe Terragni. Il manierismo combinatorio dell’architetto
comasco è la strada attraverso cui passeranno i virtuosismi grammaticali di
Eisenman.
Uno dei punti di partenza interpretativi per comprendere Eisenman è la
critica della concezione artistica del cubismo, inteso come un movimento
solo apparentemente dinamico, in cui invece di occuparsi dell’auto-farsi
delle forme ci si occupa del montaggio delle forme. Rigettando i dogmatismi
delle proporzioni e delle simmetrie l’ebraismo celebra la non-regolatezza del
vero, smentendo l’ideale assoluto del bello classico greco e delle sue leggi
autoritarie. Come Schönberg dissacra l’ottava e formula la dodecafonia, così
anche per Eisenman, e per altri, l’impegno sarà dissacratore e laico. Il
ricordo del vitello d’oro imporrà l’avversione ai miti, immanenti o
trascendenti, in termini quasi scientifici.
Nell’alveo artistico dell’espressionismo la poetica di Eisenman è disposta a
demolire i tabù linguistici senza ricostruirne altri; azzeratrice,
quest’operazione apparentemente negativa cerca di destrutturare, non come
operazione linguistica auto-ponentesi come visione alternativa, ma con lo
scopo stesso di escludere una visione spaziale alternativa. Non distrugge per
ristrutturare ma elimina gli idoli estetici e linguistici per porre l’autoevidenza delle forme, così che il moto della materia non si ponga solo sul
piano formale o contenutistico ma sia alla base stessa della comunicazione,
nel linguaggio. Come lo yiddish, che non ha formato strutture linguistiche
nette: chiunque tenti di formalizzarne una grammatica si trova una lingua
che si dà nervosa, breve e quasi solo parlata. Come nota Kafka, il popolo
non cede lo yiddish ai grammatici. In più, si compone quasi solo di parole
straniere e ne conserva l’originaria velocità d’uso. Serve energia per tenere
unito tutto ciò, amalgamato nell’impasto di qualche regola, ma soprattutto
con la libertà dei dialetti, che sono lo yiddish stesso. Un metalinguaggio al
quadrato.
Il mondo culturale ebraico è quindi dinamico, appassionato, esplosivo; di
fronte, il mondo culturale ellenico: statico, moderato, armonioso. Quando
l’essere greco si pone come fisso e immobile, per il mondo ebraico esso non
sarebbe nemmeno un’entità: poiché, estraniato dal movimento, non
esistente. Dunque se per i greci ogni architettura è un oggetto di per sé, che
sia il tempio o la casa, per l’ebreo invece conta l’abitare. Così il tempio
greco è fisso, ordinato secondo le leggi dell’armonia (prestabilita) mentre
l’architettura ebraica si pone come funzione, libera da formalismi,
simmetrie, rapporti, proporzioni, regole, soggetta all’unica legge del
mutamento.
24
Quando, nei primi secoli del cristianesimo, il pensiero ebraico eserciterà
qualche influenza su quello latino, la cella chiusa del tempio, che ospitava le
statue e gli idoli, verrà spalancata per essere percorsa e vissuta. La cella
aperta entra nel tempo sacro del rito, per non restare solo spazio sacro.
Eisenman, quindi; e il senso della forma; problema originario di ogni
disciplina estetica. In aperta sfida alla meccanica cartesiana, egli pone
sofisticate combinazioni ermeneutiche (ed ermetiche) in cui il grado di
nascondimento indica il grado di protezione del senso. Si può dire, infatti,
che un primo livello di nascondimento sia svelato solo dalla critica
contemporanea, informata dal modello interpretativo analitico e descrittivo;
un secondo livello interpretativo riguarda invece il pensiero poetico
dell’autore. Ma solo un terzo livello di nascondimento cela il rapporto con la
cultura ebraica. A questo livello l’opera e i suoi enigmi si pongono come
un’unità, personificazione metafisica. Forse Benjamin lo definirebbe “il
contenuto di verità di un’opera”. Anche senza riproporre qui le osservazioni
benjaminiane sui rapporti tra senso e significato, tra ricerca del contenuto di
verità e ricerca del contenuto reale, vorrei solo ricordare il valore del legame
tra i due concetti, di quanto stretto e invisibile sia il loro rapporto, di come il
contenuto reale rimanga in superficie rispetto alle stratificazioni possibili del
contenuto di verità. E quindi di come una critica che si rivolga all’opera con
obiettivo veritativo si debba porre necessariamente nella prospettiva più
difficile, anche se unica, di consentire di cercare e di trovare nell’apparire
del reale e attraverso gli strati del senso, almeno una porzione di quella
verità motrice che sta nel nucleo dell’opera, per provare ad arrivare dove sta
il presupposto della forma, dove si rivela il mistero della relazione sovrana.
Ciò può darsi solo in una visione in cui i concetti di origine e divenire siano
categorie storiche: dove, sempre con Benjamin, l’origine stia nel flusso del
divenire, dove l’origine sia ciò che scaturisce dal divenire; dove, quindi, sia
sottratta da ogni illusoria fissità, dall’essere categoria ontologica. Se dunque
la lingua crea, compie, è insostituibile non come paradigma della verità ma
per il rapporto che intrattiene con la parola. La relazione sottrae i termini da
una generica indeterminatezza. In architettura l’estetico-fenomenico domina,
eccede il metafisico, non fosse altro che per il dominio del paradigma
tecnico-scientifico nella disciplina dell’architettura contemporanea.
In Eisenman invece il testo architettonico, apparentemente chiaro e
perentorio, si mostra affondato in un’impenetrabilità oscura non appena si
cerchi di esaminarlo: la ricerca interpretativa si rivela un’inestricabile
barriera. Su tale orizzonte, solo la luce sorgente può, in trasparenza,
illuminare dal retro il foglio traslucido ove sono i tratti del testo
eisenmaniano.
26
3HWHU+HLVHQPDQ
Quella sola luce è il pensiero ebraico, nel suo darsi teorico -estetico, tanto
classico da potere essere paradigma, quel pensiero che connota l’opera è in
aperta antitesi con il paradigma greco-cristiano; dice Eisenman: “Senza fini
e senza origini, priva dell’oggetto e priva di ragione”. Questa dichiarazione
preclude al nuovo Esodo, esodo del linguaggio, dall’Egitto della ridondanza
della forma greco-cristiana verso la forma promessa. Verso la presenza di
un’assenza. Non rappresentativa, in rifiuto della tradizione iconologica; e
priva di ragione (come simulacro della verità), cioè arbitraria e artificiale.
È così tentato l’assalto: il pensiero greco teorizza la verità, il pensiero
ebraico la rende struttura, la prima sviluppando e facendosi percorrere da un
linguaggio antropocentrico, la seconda da un linguaggio logocentrico, non
solo rivolto alla mistica tradizionale ma anche al pensiero filosofico
moderno, comunque sempre attraverso la mediazione del nome, della parola,
del Logos, e del ricordo del vero che vi sta.
È solo nel cono di luce proiettivo della potente cosmica simbolica ebraica
che i principi formali eisenmaniani possono mostrare la loro essenza, per
un’architettura senza tempo, non-rappresentativa.
Parole chiave dell’ebraismo, come atopia, e instabilità assumono un valore
poetico e reale, dove lo spazio non è che la forma mobile del tempo.
Andrea Canclini
Architetto
____________________________________________
Bibliografia:
Pier Vittorio Aureli, Marco Biraghi, Franco Purini, Peter Eisenman. Tutte le
opere, Electa, 2007.
Peter Eisenman, Contropiede, Skira, 2005.
Peter Eisenman, La base formale dell’architettura moderna, Edizioni
Pendragon, 2009.
Renato Rizzi, La muraglia ebraica, Mimesis Edizioni, 2009.
Manfredo Tafuri, Five Architects, Officina Edizioni, 1981.
Matteo Zambelli, Tecniche di invenzione in architettura. Gli anni del
decostruttivismo, Marsilio Editori, 2007.
__________________________________________________
28
Scuola
Così la democrazia diventa catechismo
di Ernesto Galli Della Loggia
Non sono molti gli italiani a conoscenza del fatto che a partire da quest’anno in
tutte le scuole della Repubblica, sia nel primo che nel secondo ciclo, viene
insegnata per un’ora alla settimana una nuova materia: “Cittadinanza e
Costituzione”. Dunque d’ora in poi, dai sei ai diciotto anni, per un totale non
insignificante di 429 ore, ad ogni giovane del nostro Paese saranno impartite le
opportune nozioni per diventare un cittadino modello, nel senso, come
vedremo, di “un perfetto democratico”. E si badi: questa volta si tratta di un
insegnamento a sé stante, autonomo, il cui voto ha lo stesso valore di quello di
qualsiasi altro; insomma un vero e proprio salto di qualità rispetto
all’”Educazione civica” o all’”Educazione alla convivenza democratica” di una
volta, che erano collocate come appendici di altre materie.
Si compie così un nuovo, decisivo, passo avanti lungo quella china micidiale
che sta portando la scuola italiana al disastro: cioè la sua trasformazione dal
luogo di apprendimento che era un tempo a una sorta di insignificante agenzia
alla socializzazione. Un mutamento genetico in atto da almeno tre decenni, che
è rispecchiato nel modo più impressionante dal gergo insulso e insieme
pomposo con cui è ormai redatto ogni documento ministeriale riguardante
l’insegnamento, infarcito di “itinerari formativi”, di “percorsi di responsabilità
partecipate”, di “prese di coscienza”, di “mappe concettuali” e via di questo
passo. Del resto in uno “Statuto delle studentesse e degli studenti”, elaborato a
suo tempo dal ministro Berlinguer e peraltro caduto immediatamente nel
dimenticatoio, non si definiva forse la scuola, badando bene a evitare la parola
tabù “studio”, “una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale,
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni”? Definizione perspicua che potrebbe altrettanto bene attagliarsi per
il Touring Club o per una colonia sansimoniana.
Il “Documento d’indirizzo” emanato dal Ministero nel marzo di quest’anno (2009
N.d.r.) per spiegare in che cosa consista l’insegnamento di “Cittadinanza e
Costituzione” è per l’appunto un esempio perfetto di questo gergo pedagogicodemocratico. Ed è sintomatico della vischiosità burocratica che domina nei
ministeri, oltre che della grande timidezza culturale della destra italiana, il fatto
che al documento stesso (beninteso non solo per come è scritto ma
specialmente per quello che dice) abbia apposto la sua firma il ministro Gelmini.
La quale, com’è normale per questo genere di documenti, non ne è l’autrice,
ma evidentemente non ha potuto fare altro che adeguarsi alle idee e alle parole
di colui che è invece il vero autore dello scritto, cioè Luciano Corradini.Vale a
dire uno dei massimi esponenti di quell’oligarchia accademico-ministeriale
d’ispirazione infallibilmente “progressista”, in questo caso nella sua versione
cattolica, accumulatrice di cariche di ogni tipo, la quale da anni gestisce a suo
29
piacere la scuola italiana e che anche in questo caso ha puntualmente
presieduto il gruppo di lavoro ministeriale per l’insegnamento di “Cittadinanza e
Costituzione”. Una scelta appropriata, bisogna peraltro ammettere, dal
momento che il caposaldo del Corradini-pensiero e dei tanti che lo condividono
è proprio l’ineluttabilità, che dico l’assoluta necessità, del passaggio
dall’istruzione, tipica della vecchia scuola liberal-classista-nozionista,
all’Educazione, irraggiante invece roussoiana libertà e armonia. In questa
prospettiva “Cittadinanza e Costituzione” è chiamata per l’appunto a
rappresentare il vertice dell’Educazione.
Il documento in parola assegna alla scuola lo scopo, in pratica, di formare nulla
di meno che l’Uomo nuovo.
Stando a ciò che si legge, essa infatti dovrebbe insegnare non solo “ il
riconoscimento e la promozione della capacità da parte dello studente di
assumersi la responsabilità cognitivo-emozionale delle proprie intenzioni e
azioni” (in un ragazzo, chessò, di 15 anni?), ma altresì come “maturare la
propria capacità di cercare e di dare un senso all’esistenza”: sì, avete letto
bene: “Dare un senso all’esistenza”. Il tutto, naturalmente, sempre sotto
l’etichetta di “Cittadinanza e Costituzione”. Che in tal modo diviene l’insegna di
un prescrittivismo buonista le cui ambizioni sembrano non conoscere limiti. In
un crescendo di titanismo pedagogico quasi delirante, il documento
corradiniano-ministeriale, infatti, proclama che la materia in parola dovrà
insegnare a essere “solidali”, “responsabili”, “consapevoli”, inoltre pronti al
“dialogo”, all’”interscambio culturale”, a stare dalla parte dei “diritti umani” e
“delle altre culture” ; ancora: ad essere capaci di “gestire conflittualità e
incertezze” (?), “promuovere il benessere proprio e altrui” (?), “esprimere
sentimenti, emozioni e attese nel rispetto di se stessi e degli altri”, “esprimere
autenticamente se stessi”. Nient’altro. Non senza naturalmente una doverosa
avvertenza finale: ognuno dei traguardi pedagogico-morali di cui sopra va
inserito – e chi poteva dubitarne? – “nella prospettiva di un’etica universale”
(pp. 12-15 e 18).
E’ così che si realizza, attraverso la perdita di centralità dell’Istruzione,
nell’ideologia dell’istituzione scolastica prima ancora che nei programmi,
attraverso l’assegnazione alla scuola di compiti educativi che ostentatamente
prescindono dall’Istruzione, il distacco gravissimo tra la dimensione
dell’Educazione e quella della Cultura. E’ per questa via che si compie il
passaggio dalla scuola dei saperi, in cui si andava per apprendere qualcosa, a
quella – come leggiamo nei documenti ufficiali – dove invece si compiono
“percorsi formativi” e si acquisiscono “competenze”. Ed è così che, alla fine,
dalla scuola della pagella si passa a quella del certificato di civismo. Ma ciò che
in questo modo si perde – che in sostanza anzi sembra essere già perduto – è
qualcosa di decisivo: è né più né meno che la consapevolezza del valore
moralmente educativo del sapere in quanto tale. L’idea, cioè, cara a tutta la
tradizione umanistica occidentale, anzi cuore stesso di tale tradizione, che la
Cultura, in quanto rivolta costitutivamente alla Bellezza e alla Verità, è in sé e
per sé, in quanto tale, matrice decisiva di raffinamento etico e di crescita civile:
non si può più essere barbari, insomma, una volta che si apra Virgilio o che ci si
ponga a studiare l’algebra. L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” – la
cui appartenenza, nel documento ufficiale che ne segna l’esordio, viene non a
caso esplicitamente rivendicata al campo dell’Educazione piuttosto che della
30
Cultura – sancisce viceversa la virtuale cessazione di questo rapporto ovvio
che fino a non molto tempo fa esisteva tra i due ambiti.
Ci si può chiedere: e che male c’è? Che male c’è se l’obiettivo sacrosanto
dell’Educazione viene perseguito di per sé, autonomamente, senza passare
attraverso la Cultura, cioè attraverso l’Istruzione , attraverso l’apprendimento
della Storia, della Letteratura, della Matematica e di quant’altro? E’ presto detto,
e lo dimostra proprio il documento di cui sto dicendo. Il male è che mentre la
Cultura e l’Istruzione che ne è la principale via d’accesso lasciano liberi di
formarsi la propria identità, cioè di costruire come si vuole, con i materiali messi
a disposizione, i propri valori e la propria personalità – sicchè l’Educazione
attraverso la Cultura è realmente una educazione alla libertà per il tramite della
propria liberazione dal non-sapere, dall’ignoranza – viceversa l’Educazione
perseguita programmaticamente in quanto tale non può che essere prodotta in
modo autoritario, adottando preliminarmente un modello di personalità, una
determinata tavola di valori assunti a priori e calati dall’alto.
Quei valori, solo quelli e non altri. Nel nostro caso, ci viene per l’appunto detto, i
valori della Costituzione.
Naturalmente l’istruzione, la cultura, possono anche produrre l’adesione a
cattivi valori morali e civici. Un grande fisico, un valente filologo classico,
possono benissimo essere dei leninisti o dei nazisti. Ma ciò non fa altro che
confermare il profondo rapporto che il binomio Cultura-Istruzione ha con la
libertà e con l’autonomia personale. Dal momento che i contenuti della cultura
hanno spesso un volto oscuro e ambiguo è inevitabile, infatti, che nella libertà di
cui stiamo parlando ci sia sempre ed anche il rischio dell’errore. Ma se non ci
fosse un tale rischio, che libertà sarebbe? In realtà, quando nella scuola e poi di
conseguenza anche nella società in generale, all’Istruzione si sostituisce
l’Educazione, si apre una frattura gravissima: l’identità della persona e la sua
costruzione si slegano dalla fruizione e dall’esperienza dei prodotti culturali,
dalla loro polifonia viva ed emotivamente coinvolgente, per essere tutte affidate
all’adeguamento a una norma astratta, a una “Tavola del dover essere”. D’ora
in poi l’esperienza personale sarà pure talora ammessa, ben che vada, ma a
patto che conduca al risultato voluto: quello del Perfettismo e del Buonismo
universali.
A questo punto non starò a dire, come pure mi verrebbe subito alle labbra da
dire, che in tal modo, a dispetto delle rosee speranze dei novatori, è garantita
solo una cosa, e cioè la produzione di analfabeti da un lato e di bulli dall’altro.
M’interessa di più sottolineare come tutto l’impianto del nuovo insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione”, oltre alla frattura appena detta, produca anche un
ulteriore, grave, mutamento di prospettiva nel senso comune.
Quell’insegnamento, come si è visto, mira in sostanza a far introiettare
“eticamente” la democrazia con l’affermarne perentoriamente la prescrittività.
Ma accade così che la democrazia stessa finisca per assumere un’immagine
quanto mai discutibile. Questa, infatti, non appare più tanto come una
determinata organizzazione dei pubblici poteri in funzione precipua della
migliore tutela di un certo numero di diritti di comune accordo stabiliti, ma come
qualcosa che attiene a tutt’altro genere di ambito: come un modello di relazioni
etiche tra gli individui e tra gli individui e le istituzioni. Al posto della migliore
tutela dei diritti si sostituisce l’affermazione, sub specie della Cittadinanza, del
Bene sul Male.
31
La conseguenza ultima, che a me pare di enorme importanza, è che in questo
modo agli occhi dei giovani la Costituzione viene sottratta alla dimensione
storico-politica, che è e dovrebbe essere propriamente l’unica sua, ma
sottoposta ad un processo di eticizzazione che la trasforma nel vangelo di una
vera e propria “religione politica”, in linea di principio analogo ad altre religioni di
questo tipo che hanno funestato il Novecento: in un paradigma protototalitario.
La nostra Costituzione non è più una carta politica, dunque politicamente
discutibile, di cui si possa dire per esempio che quella tedesca o quella
americana le sono superiori, e che quindi magari può essere cambiata per
avvicinarla, chessò all’una o all’altra. No, essa è in realtà qualcosa che
trascende la mutevole realtà della storia: è la via maestra al Cittadino Perfetto,
all’Uomo Nuovo Democratico. Che per il solo fatto di essere perfetto e
democratico non risulta certo meno agghiacciante.
Ernesto Galli Della Loggia
FOTO S. Santioli
L’articolo sopra riprodotto è stato pubblicato in data 8 novembre 2009 da Il Corriere della
Sera.
Ringraziamo la direzione del giornale e l’autore per la gentile concessione.
7RQLQR1HJUL6FXOWXUDFHUDPLFD´$UWHLQ*LDUGLQRµ,VRODG·(OED
32
Guardare la Shoah.
Breve excursus in alcune immagini Sebaldiane
di Diana Napoli
1. La storia immaginaria
«Ricordo adesso, soggiunse Ferber, che lo zio Leo – professore di latino e greco
in un liceo di Würzburg, finché non lo avevano rimosso dall’insegnamento –
aveva mostrato allora a mio padre un ritaglio di giornale del 1933, in cui si
vedeva la fotografia del rogo dei libri sul Residenzplatz della città. Lo zio definì
quell’immagine una contraffazione. Il rogo dei libri, così disse, aveva avuto
luogo la sera del 10 maggio, la sera del 10 maggio, ripeté più volte e, poiché
con il buio che c’era a quell’ora le fotografie non potevano certo essere venute,
qualcuno era andato per le spicce, sosteneva lo zio, inserendo un imponente
pennacchio di fumo e un cielo notturno nero come la pece nell’immagine di un
qualsiasi altro raduno davanti alla Residenz. Il documento fotografico
pubblicato sul giornale era quindi un falso. E così come quel documento era un
falso, disse zio Leo quasi che la scoperta da lui fatta rappresentasse la prova
indiziaria decisiva, allo stesso modo tutto era sin dall’inizio una falsificazione»9.
Leo era lo zio di Max Ferber, un pittore di origine ebrea che viveva e lavorava a
Manchester, città in cui si era trasferito poco prima dell’adolescenza, alla fine
degli anni Trenta, grazie ad un visto procuratogli dai suoi genitori affinché
lasciasse la Germania.
Il passaggio riportato si riferisce ad una considerazione di Leo che, notando la
falsificazione materiale di un’immagine fotografica (foto 1) – nella fattispecie la
foto del famigerato rogo dei libri non “ariani” alla Residenzplatz organizzato
dai nazisti nel maggio del 1933 – argomentava una più generale e pericolosa
falsificazione della storia di cui la fotografia in questione, a suo parere,
testimoniava. La foto contraffatta della Residenzplatz era il segno di una realtà
il cui discorso era costituito dalla menzogna con la stessa operatoria semplicità
con cui si poteva truccare una fotografia.
9
W.G. Sebald, «Max Ferber», Gli Emigrati, Adelphi, Milano 2007, p. 197-198. Il testo
è preceduto dalla riproduzione della fotografia in oggetto [foto 1].
33
1
Restando in un campo «immaginario», dalla lettura di queste brevi righe si
potrebbe concludere la necessità di mettersi alla ricerca delle fotografie «vere», come se potesse esistere una sorta di album fotografico del mondo in cui,
Shoah – Foto 1)
IRWR
diversamente dalla immagini in cui si era imbattuto lo zio Leo, il reale sarebbe
perfettamente visibile nella sua «verità».
Non è per caso che abbiamo scelto di iniziare la nostra riflessione partendo da
questo ricordo del pittore Max Ferber, protagonista di un racconto della raccolta
Gli Emigranti, di W.G.Sebald.10. Questo ricordo, infatti, ci porta direttamente al
cuore della questione che ci interessa, cioè sapere se sia possibile fidarsi delle
immagini nella nostra «quête du réel» e, particolarmente, di quel determinato
«reale» la cui scena è occupata dalla storia della distruzione degli Ebrei. C’è un
senso nell’utilizzare immagini, in particolare fotografie, per parlare della Shoah,
per confermare il nostro discorso o, semplicemente, per comprendere? E’
sufficiente, per «vedere», smascherare l’eventuale presenza di falsificazione
materiale cui sarebbe stata sottoposta la nostra immagine?
Tali questioni non si limitano a inquadrare un problema di estetica o di
sociologia delle immagini e dei suoi usi, concernendo piuttosto il tipo di
discorso storiografico che è stato costruito intorno alla Shoah. Il problema, in
sé, è più che conosciuto e non è questa la sede per analizzarlo minuziosamente:
10
Sebald nasce in un piccolo paesino del Sud della Germania nel 1944 e la sua vita è
tragicamente terminata nel 2001 a causa di un incidente d’auto. E’ considerato uno
degli scrittori più importanti della seconda metà del XX secolo. Giovane studente lascia
la Germania (di cui aveva criticato una sorta di « complotto del silenzio » relativo alla
storia del nazismo e la Shoah almeno per i primi venti anni del dopoguerra) e si
trasferisce in Inghilterra dove diventerà professore di Letteratura all’Università di
Norwich.
34
la svolta memoriale, il dovere di memoria, le dimensioni della temporalità che
sembrano non scorrere più in maniera tradizionale, sono tutti tasselli di una
questione che trova origine in una storia della Shoah di cui la storiografia
ufficiale fatica a prendersi carico11.
Fiumi d’inchiostro sono stati spesi per definire il ruolo del testimone, per dare
una collocazione corretta ai ricordi dei sopravvissuti nel lavoro dello storico,
per calibrare gli strumenti del mestiere («les outils du métier», come avrebbe
scritto Marc Bloch) alla presenza delle vittime o dei loro familiari. E tuttavia,
questi sforzi che la metodologia storica e la riflessione storiografica hanno
profuso, non sempre sembrano riuscire a colmare quella che pare essere,
secondo un’espressione di Walter Benjamin, una «perdita dell’esperienza» –
esperienza che, nei suoi differenti livelli di comprensione, dovrebbe costituire il
sostrato per la costruzione di un sapere storico.
Ebbene, la distruzione degli Ebrei fatica ad assumere i connotati
dell’esperienza, ponendosi piuttosto come fuori da ogni storia e dunque da ogni
esperienza, la cui “mancanza” e la cui “perdita” sarebbero abbondantemente
riempite dalle immagini; noi conosciamo, tutti, le immagini divenute ormai il
simbolo dei campi di concentramento: i corpi scheletrici ammassati, i volti
scavati dietro il filo spinato; ci sono le prime fotografie scattate immediatamente
alla Liberazione, così come le immagini filmiche divenute onnipresenti, quelle
che noi vediamo in occasione delle commemorazioni o nei musei espressamente
costruiti per conservare il ricordo di questo tragico evento. Tuttavia, queste
immagini di cui siamo circondati, contengono la «verità» di quello che è accaduto? Sono sufficienti per permetterci quella che Koselleck definiva un’«acquisizione di esperienza» che, al di là dello choc iniziale12, permettesse l’ela11
Occorre spiegare che non si tratta di discutere lo stato della ricerca che ha anzi visto
dei lavoro imprescindibili, tra tutti la monumentale opera di Raul Hilberg (in particolare
La distruzione degli ebrei d’Europa, Einaudi, Torino, 1999). Piuttosto, come ricordava
Koselleck, si tratta del fatto che esiste un livello di tensione, una sorta di irrisoluta
opposizione (almeno sul piano teorico) tra una storia “reale” e una storia “scritta” e che
è il campo e il lavoro della storiografia, la quale, tra le altre cose, si pone il problema di
capire come sia possibile fare, di un’esperienza, una storia. La questione che noi
poniamo è proprio quella di cercare di comprendere quale livello di elaborazione e di
approfondimento dell’esperienza la nostra società ha elaborato relativamente alla
distruzione degli Ebrei. Tra l’altro lo stesso Hilberg si confronta con la storia della
distruzione degli ebrei vista dall’alto delle vittime e dei testimoni e lo fa in maniera
abbastanza problematica – o comunque molto differente rispetto alla sua tradizionale
impostazione storiografica – nel testo Carnefici, vittime, spettatori (Einaudi, 1996)
testo composto anche dopo la conoscenza del regista di Shoah, Lanzmann.
12
Naturalmente la sorpresa, quando si viene confrontati la prima volta con le fotografie
dei campi, è la reazione più immediata. Interessante, per esempio, è la “testimonianza”
di Susan Sontag ; non sarebbe un azzardo affermare che il suo atteggiamento fu quello
di tutta una generazione nel momento in cui vide le prime foto (cfr. il testo di S. Sontag
Sulla fotografia, Einaudi, Torino, 2004).
35
borazione di un sapere storico capace di ripensare completamente la nostra
storia?13
Questa storia (e in verità ogni storia) che noi pensiamo mercé le immagini è,
appresa in tale maniera, estremamente problematica; come hanno infatti
mostrato gli studi oramai classici di Roland Barthes e Susan Sontag, il ruolo e lo
statuto stesso della fotografia nel mondo restano problematici e ambigui,
mettendo capo ogni analisi più a paradossi che a chiarificazioni.
Ci soffermiamo brevemente sulle conosciute riflessioni di questi due studiosi, al
solo scopo di indicare i possibili effetti della presenza fotografica sul nostro
immaginario relativo alla storia della Seconda Guerra.
Con Barthes, per esempio, che ha privilegiato un approccio fenomenologico
(approccio peraltro, come vedremo, non senza importanza per il nostro
percorso), la questione potrebbe essere riassunta con la considerazione per cui
una fotografia, pur essendo evidente, non è mai trasparente14 e che dunque,
guardandola, è sempre «altro» che si guarda. Quello che ci interessa nell’analisi
di Barthes è che il lato «falso» di un’immagine, da questo punto di vista, non
risiede solo – o tanto – nella sua eventuale falsificazione materiale: senza voler
considerare quest’ultima come irrilevante, l’attenzione verso la presunta verità
dell’immagine si sposta al livello della relazione che lo sguardo tesse tra essa e
noi. La fotografia, per Barthes, ha un noema che è la sua posizione di realtà
(quello che lui chiama il «ça a été» di cui nessuno può dubitare), ma che in sé è
insufficiente per dirci qualcosa del suo significato. Quest’ultimo è tutto
nell’investimento del nostro sguardo, colpito dal punctum, dal «senso ottuso»
della fotografia che sfugge ad ogni pratica connotativa. Non c’è che la foto,
posta in «un lieu entre l’infini et le sujet», soggetto destinato a prendersi carico
di tutto ciò che, guardandolo come in un certo senso fa il punctum, finisce per
ricadere sotto il suo proprio sguardo15. La pratica connotativa che pure presiede
13
Come fanno inoltre notare Clément Chéroux e Ilsen About la maggior parte di queste
fotografie sono prive di referente e manca una riflessione sul modo in cui andrebbero
“trattate” dalla ricerca storica (che spesso se ne serve senza alcuna consapevolezza del
modo in cui analizzare). Cfr. I.About e C. Chéroux in L’histoire par la photographie,
in “Etudes photographique), 10(2001).
14
«Quoi qu’elle donne à voir et quelle que soit sa manière, une photo est toujours
invisible : ce n’est pas elle qu’on voit», R. Barthes, La chambre claire, Gallimard,
Parigi, (coll. “Cahiers du cinéma”), 1980, p. 18.
15
Barthes ha scritto che la fotografia è il suo proprio referente, che è caratterizzata da
una pienezza analogica che rende paradossale ogni sforzo di connotazione, ciò che
avviene quando costruiamo un testo servendoci di immagini. Anche se esistono delle
pratiche di produzione della fotografia che sono in sé connotative, la fotografia, nella
relazione con colui che la guarda (e anche nella sua struttura ontologica) resta isolata e
autosufficiente, senza un vero e proprio codice e, al massimo, impregnata di un senso
“ottuso” da cui solo lo «spectator» può essere toccato. Cfr.R. Barthes, La chambre
36
alla produzione di certe immagini fotografiche è già dunque la prima
coercizione, la prima falsificazione che tenta di differire la pienezza analogica
della foto. Vedremo che queste osservazioni di Barthes, ora brevemente
riportate, saranno estremamente efficaci per comprendere l’uso sebaldiano della
fotografia.
Susan Sontag, dal canto suo, ha messo in evidenza che l’utilizzo accentuato
nella nostra società dell’immagine fotografica ha reso il mondo stesso
un’immagine, nel senso che è invalsa l’abitudine di catturare il reale sotto il
segno di criteri immaginari, cioè i criteri che ci permettono di guardare o di
scattare una fotografia. Il mondo diviene così un’illusione (e anche un ricordo)
che riceve la sua attestazione di realtà dalla fotografia (che, a sua volta, mostra
la sua qualità di memento mori).
Tali questioni si traducono, in relazione alla storia della Shoah, nel rischio di
trasferire questa storia in una sorta di immaginaria «atemporalità» favorita
proprio da un utilizzo «universalistico» delle immagini (fotografiche ma anche
filmiche)16 la cui onnipresenza ha finito per creare un mondo senza alcuna
referenza – o meglio autoreferenziale – sublimazione di un incubo e delle
peggiori atrocità che proprio la traslazione in immagini-simbolo allontana dal
reale.
Come Susan Sontag aveva fatto notare, la fotografia innanzitutto anestetizza il
nostro impatto con il mondo, perché una serie continua di foto, anche con la
pretesa di documentare la realtà, di fatto ce ne allontana; in secondo luogo essa
è in fondo un’arte surreale la cui essenza potrebbe essere riassunta nella
convinzione che comprendere il mondo è un vano tentativo e che meglio
sarebbe collezionarlo; di conseguenza, la Shoah conosciuta principalmente
attraverso le immagini è divenuta senza storia, è divenuta essa stessa
un’immagine (l’immagine per eccellenza della sofferenza inconcepibile), invece
di essere conosciuta per quello che è: una produzione umana e storica
determinata17.
Le immagini a cui associamo immediatamente il nostro pensiero sulla Shoah
(quelle dei film ormai famosi, che quasi tutti hanno visto, per esempio, nelle
scuole), le fotografie dei sopravvissuti, formano una galleria in cui ci si
potrebbe condurre come in un museo. Senza alcuno sforzo di ricostruzione, né
claire, cit., et R. Barthes, L’obvie et l’obtus, Seuil, Parigi,1992 (in particolare i capitoli:
« Rhétorique de l’image », «L’obvie et l’obtus», «Le texte e l’images»).
16
Cfr. il breve saggio «La photo de presse et la libération des camps en 1945» di B.
Zaliger, in M.B. Vincent (ed), La dénazification, Perrin, Parigi, 2008.
17
A questo proposito è interessante leggere della difficoltà della storiografia a
confrontarsi con le dimensioni immaginarie e collettive della Shoah che sconvolgono i
tradizionali strumenti del mestiere dello storico. Un utile compendio è A.Wieviorka,
L’ère du témoin, Plon, Parigi, 1998.
37
di spiegazione, le immagini sono là, nella loro crudezza esemplare, impossibili
da cancellare o da distruggere. A quale storia appartengono? O a quale
esperienza possibile che il sapere storico potrebbe elaborare? Non parlano forse
da sole?
D’altronde non è di molti anni fa, a questo proposito, la polemica tra DidiHubermann e altri intellettuali raccolti attorno alla figura di Claude Lanzmann.
Se il primo ha mostrato l’esigenza di un’analisi attenta delle fotografie dei
campi, a partire dalle pochissime scattate probabilmente a guerra e sterminio
ancora in corso, Lanzmann ha sempre rivendicato la distanza esistente tra
un’immagine e la verità, arrivando addirittura ad affermare che nel caso di un
ipotetico ritrovamento di immagini concernenti direttamente lo sterminio degli
ebrei (che fossero anche immagini “dirette” delle camere a gas) avrebbe persino
forse sentito l’esigenza di distruggerle – proprio per sottolineare che il piano
della verità non è quello dell’evidenza “immaginaria”18 (spingendosi persino a
rivendicare che il suo terreno non è quello del documento, ma quello del
monumento).
Per cercare di offrire una risposta a tali questioni, o quanto meno per avvicinarci
a tali problematiche, abbiamo scelto di trarre alcuni esempi dall’opera di
W.G.Sebald. Noi non siamo specialisti di storia dell’arte o della fotografia;
tuttavia abbiamo scelto di operare questo spostamento temporaneo in una
materia che non è la nostra perché la scrittura di Sebald, interrotta, ossessionata
o portata a compimento dalle immagini, pone con forza tutte le dimensioni della
storia con le sue impasses attuali (l’ambiguità della temporalità tradizionalmente
considerata, la perdita dell’esperienza, le dimensioni dell’oblio e della memoria)
e può dunque essere considerata un luogo da cui osservare il funzionamento
della storiografia e, per quel che ci riguarda, il suo rapporto possibile con una
«dimensione immaginaria» della Shoah.
Inoltre, come nota a margine, non è inutile riportare una considerazione di
Michel de Certeau riguardante il «ruolo» della letteratura: essa non è il riflesso
18
In verità le polemiche di Lanzmann e dei suoi sostenitori si indirizzavano non tanto
all’analisi o agli interventi in sé di Didi-Hubermann, quanto alla mostra tenuta a Parigi
nel 2001 Mémoire des camps, photographies des camps de concentration et
d’extermination nazis (1933-1999) e al catalogo contemporaneamente pubblicato di
questa esposizione. La critica di Lanzmann si riferiva all’idea, sostenuta in effetti nel
catalogo, che nuove immagini avrebbero finalmente arricchito la nostra conoscenza
sulla Shoah, di cui esisteva un livello di “visibilità”, come testimoniava una foto
scattata, correndo un enorme rischio, in un campo, da un certo Alex (probabilmente un
ebreo polacco). Le considerazioni di Didi-Hubermann a proposito di due foto scattate
da Alex avevano suscitato le ire di Lanzmann, innescando una feroce diatriba
intellettuale.
38
della società, ma il suo «rovescio», nella misura in cui «elle énonce ce qui est
perçu comme manquant»19.
2. Lo sguardo obliquo
I libri di Sebald sono disseminati di immagini. Il ruolo di queste immagini che
arrestano, interrompono, scombinano o rendono opaca la scrittura è stato
oggetto di numeroso studi20. Noi ci concentreremo su un corpus molto ristretto
di immagini tratte dal romanzo Austerltiz e su due immagini del racconto «Max
Ferber»21 e ci limiteremo inoltre all’uso che di queste immagini è fatto,
ricordando che la nostra riflessione su questo autore ha una funzione euristica
allo scopo di cercare di comprendere lo sguardo che è possibile portare alla
Shoah per mezzo delle immagini.
Il nostro punto di partenza erano state le considerazioni dello zio Leo che,
fortemente indignato per la falsificazione della fotografia del rogo dei libri alla
Residenzplatz, si preoccupava della più vasta contraffazione che si stava
preparando per la storia in generale.
Già questa prima osservazione ci avvicina ad un approccio alla falsificazione
che oltrepassa la pratica materiale di alterazione dell’immagine per soffermarsi
piuttosto sulla pratica discorsiva che utilizza le immagini per confermarsi. Detto
altrimenti, è sul versante dello «sguardo» (come, in quale contesto e secondo
quali norme si esercita lo sguardo) che la falsificazione trova il suo luogo
proprio22. E se è sufficiente, per provocare indignazione, scoprire una
19
M. de Certeau, L’écriture de l’histoire, Gallimard, Parigi, 2002, nota 21, p. 430.
In effetti le interazioni tra testo e immagine nell’intera opera di Sebald e nello stesso
Austerlitz danno luogo a differenti tipi di interazione. Noi ci siamo limitati ad indicare
solo alcuni esempi pertinenti per il nostro percorso e la nostra analisi non ha nessuna
pretesa di esaustività relativamente al ruolo dell’immagine nella scrittura sebaldiana.
21
Non è questa la sede per avventurarsi in una definizione dello statuto del testo
sebaldiano : dire «finzione» o «prosa documentaria» o «romanzo documentario» è
sempre riduttivo. Si tratta di prosa che prende origine (non a titolo di semplice
«ispirazione» da persone che l’autore ha conosciuto. Le stesse immagini sono per lo più
«originali», cioè appartenute in qualche modo ai personaggi di cui si parla. Ma nel
nostro caso si tratta meno del valore «documentario» strictu sensu delle foto che
dell’uso che se ne può fare in un discorso che si costruisce attorno alla Shoah.
22
D’altronde, ad essere fortemente falsificatrice è già l’idea stessa che il mondo possa
essere riassunto in immagini, il che equivarrebbe a dire che il mondo sia un seguito di
immagini per cui ogni inquadratura è allo stesso tempo arbitraria e possibile («non
occorre che inquadrare il soggetto in maniera differente», scrivava S.Sontag). La
Sontag dichiarava che ogni fotografia non è determinata che dall’uso che se ne fa
essendo, in sé, priva di un senso univoco. In questo modo la proliferazione di fotografie
(e la proliferazione di «sensi» a esse connesso) contribuisce all’erosione della nozione
stessa di senso. Cfr. ancora il saggio di Sontag Sulla fotografia, cit.
20
39
manomissione in una riproduzione riportata su un quotidiano, cosa che era
avvenuta a Leo, non basterebbe certo la riproduzione della foto “vera” per
comprendere la storia nella sua pienezza.
L’idea, d’altronde, che esistano foto vere e foto false è introdotta e resa
possibile dalla convinzione di poter scambiare, come perfettamente coincidenti
e specchio l’una dell’altra, immagine e realtà, laddove, forse, l’intuizione più
originale a questo proposito, l’aveva avuta, alle origini di questa pratica
fotografica di creazione immaginaria del mondo, Balzac. Egli aveva in effetti
avanzato l’ipotesi che le fotografie fossero un impoverimento della realtà e non
una semplice e fedele copia, come se ad ogni scatto non si facesse che sottrarre
al reale uno degli strati di cui è costituito e, alla fine, esaurirlo23.
L’album fotografico del mondo non sarebbe altro, allora, che un mondo
fotografico autoreferenziale la cui pienezza analogica non necessiterebbe di
alcun «reale» se non per consumarlo.
Si potrebbe dire che Balzac aveva, in anticipo, smascherato l’illusione secondo
la quale le immagini abbiano la funzione di «farci vedere», in un’ideale
trasparenza, la realtà e questo soprattutto – per ritornare al nostro tema – nei
momenti in cui questa è e si mostra come «abominevole». Di fronte alla pletora
di immagini da cui siamo circondati e riflettendo sulla possibilità di risolvere la
storia della Shoah in una rappresentazione “immaginaria”, Sebald aveva
riportato, in un’intervista, una considerazione di Benjamin per cui non c’è
ragione di esagerare ciò che è già abominevole24. E questo perché le immagini
che tutti conosciamo e che, bisogna ricordare, hanno un effetto pernicioso, ci
impediscono di pensare, anestetizzando piuttosto il nostro senso morale.
Dunque, proseguiva Sebald sempre riferendosi alla storia della distruzione degli
Ebrei, «non è che in maniera obliqua, indiretta, per allusione piuttosto che
frontalmente, che si possono abbordare tali questioni»25.
Ed è proprio questa maniera “obliqua”, tipicamente sebaldiana, di utilizzare la
fotografia che cercheremo di interrogare.
Una delle fotografia più emblematiche del romanzo Austerlitz (foto 2) riportata
a pagina 197, riproduce Jacques Austerlitz, all’età di quattro o cinque anni,
vestito da paggio in occasione di una festa.
23
Si tratta di un ricordo a proposito di Balzac riportato probabilmente da Nadar e citato
da S.Sontag nel suo libro Sulla fotografia: «chaque corps dans la nature se trouve
composé de séries de spectres, en couches superposées à l’infini, foliacées en pellicules
infinitésimales… L’homme à jamais ne pouvant créer – c’est-à-dire d’une apparition,
de l’impalpable, constituer une chose solide, ou de rien faire une chose – chaque
opération Daguérrienne [sic] venait donc surprendre, détachait et retenait en se
l’appliquant une des couches du corps objecté».
24
Si tratta di un’intervista a Sebald riportata nel testo curato da L.S. Schwarz,
L’archéologue de la mémoire. Conversation avec W.G.Sebald, Actes Sud, 2009, p. 90.
Non sono riuscita a consultare la versione originale dell’intervista.
25
Ibi, p. 84.
40
Shoah - Foto 2)
IRWR
Austerlitz, professore di architettura, era arrivato in Inghilterra con un
Kindertransport, uno di quei treni speciali grazie ai quali alcuni bambini ebrei
erano riusciti a sottrarsi al nazismo; allevato presso la famiglia di un pastore
protestante e vittima di una sorta di amnesia, solo durante l’adolescenza verrà a
conoscenza del suo vero nome e solo in età adulta recupererà la propria vicenda
così come quella dei suoi genitori, vittime del nazismo, arrivando a inscriverla
nella più vasta storia tragica della seconda guerra mondiale e della Shoah.
Noi conosciamo la sua storia grazie al ricordo di un “ascoltatore” incontrato
casualmente alla stazione di Anversa, ricordo che segue il perenne ritorno del
rimosso nella vita di Austerlitz e che è inframmezzato da immagini (in
particolare fotografie) che erano state a lui legate da Austerlitz in circostanze
molto particolari e commoventi. Questo ricordo ripercorre il racconto di
Austerlitz che disvela man mano la propria biografia, dalla “scoperta” del nome
a scuola, fino alla presa di coscienza della morte dei suoi genitori, il padre
catturato probabilmente in Francia dove si era rifugiato e la madre deportata
prima a Theresienstadt e in seguito, dopo un periodo di permanenza nel
campo/ghetto, ancora verso Est trovandovi la morte.
Già solo la fotografia del paggio che abbiamo indicato solleva numerosi
interrogativi. Ritrovata dopo una peregrinazione rocambolesca per l’Europa, la
fotografia in questione testimoniava di una vita che Austerlitz aveva
completamente rimosso e che si ritrovava a dover prendere in conto a partire
dallo sguardo impietoso del paggio che non faceva che reclamare ciò che gli
spettava: «quasi le immagini avessero anche loro una memoria e si ricordassero
di come allora eravamo noi, i sopravvissuti»26. Il paggio, con il suo sguardo
interrogatore, domandava allo spettatore di scongiurare l’infelicità oramai
consumatasi a partire dal quel luogo (temporale) da cui, in maschera, guardava.
26
W.G.Sebald, Austerlitz, Adelphi, Milano, p. 197.
41
Rispetto a questo luogo temporale è Barthes che ha qualcosa da dirci. Come
scriveva ne La Chambre claire la fotografia, in relazione a noi, in un approccio
fenomenologico, non ha che un solo noema: «ça a été». La fotografia è il suo
proprio referente e la sola posizione di realtà che si possa attribuirle è il passato
di cui noi siamo i destinatari. Nessuno può dubitare che il paggio «sia stato» e
nemmeno si potrebbe dubitare che tra il suo sguardo interrogatore e Austertliz
incapace di sottrarvisi si sia consumata una catastrofe di cui il solo resto è la
capacità di Austerlitz stesso, adulto, di guardare27. Barthes scriveva che noi
siamo colpiti dal punctum di una foto che è certamente il dettaglio che ci
corrode tenendoci legati all’immagine, ma che è anche il Tempo, «l’emphase
déchirante du noème (ça a été)»28, che ha potuto offrire un luogo in cui giacere
a ciò che, fino ad arrivare a noi, è accaduto.
Tra la fotografia «image vivante d’une chose morte»29 e noi, non c’è che la
realtà che noi siamo in grado di prendere in conto. Ma cosa accade in questo
spazio di realtà, dall’inizio del quale il paggio reclama il suo « dovuto »,
scongiurando Austerlitz adulto di farvi, in qualche maniera, fronte ?
Per tentare di rispondere alle questioni sollevate dal paggio, prendiamo in esame
altre due fotografie, una di Agata (foto 3), la madre di Austerlitz, e una rubata
dal film di propaganda girato dai nazisti nel campo di Theresienstadt (foto 4).
La prima fotografia è in realtà un risultato molto tardivo della ricerca di
Austerlitz che si era messo sulle tracce dei suoi genitori cercando
disperatamente un’immagine del volto materno, di cui non aveva che ricordi
confusi. Dopo una serie di vani tentativi, nell’archivio del teatro della città di
Praga, dove sua madre aveva lavorato come attrice, Austerlitz trova finalmente
la fotografia che pareva coincidere col ricordo pur oscuro che aveva della
madre30.
Ma, prima di questo ritrovamento c’erano stati numerosi tentativi andati a
vuoto. Uno dei più emblematici riguarda il citato film che i nazisti fecero girare
27
«E ogni volta mi sentivo scandagliato dallo sguardo interrogatore del paggio, il quale
era venuto a reclamare la sua parte e ora, alle prime luci del giorno, lì sul campo vuoto,
aspettava che io raccogliessi il guanto e allontanassi la sciagura incombente su di lui»,
ibi, p. 198.
28
R. Barthes, La chambre claire, cit., p. 148.
29
Ibi, p. 123.
30
W.G. Sebald, Austerlitz, cit., p. 269.
42
IRWR
IRWR
nel ghetto/campo di Terezin allo scopo di farlo visionare da alcuni ispettori
della la Croce Rossa.
Avendo saputo della deportazione di sua madre a Theresienstadt e della
presenza di questo “film”, Austerlitz aveva pensato che forse vi avrebbe potuto
scorgere il volto della madre, suo malgrado filmata, ragion per cui si era
immerso nella visione di questo documento filmico pur cosciente che si trattava
di una falsificazione immaginaria destinata ad essere consumata dai
rappresentanti dell’organizzazione internazionale.
Anche se egli stesso aveva a studiato a fondo il lavoro di G.H. Adler31, che
aveva ricostruito minuziosamente sia il funzionamento del campo sia le
procedure adottate dai nazisti in questa costruzione immaginaria, sorta di
falsificazione al secondo grado nel senso che si era modificata la realtà ancora
prima dell’eventuale modificazione materiale dell’immagine, Austerlitz non
cessava di pensare che, se solo avesse visto il film, avrebbe potuto intuire le
reali fattezze del ghetto/prigione di Terezin e della vita che si vi si conduceva.
Tuttavia, ciò che questa visione conservava non era che una sequela incessante
di rumori e volti stranieri che apparivano al massimo per una frazione di
secondo. Preso atto di questa inafferrabilità che caratterizzava lo svolgersi della
pellicola, Austerlitz riuscì a farsi confezionare una copia del film a velocità
ridotta la cui visione si rivelò assolutamente sorprendente: era stato sufficiente
modificare la velocità delle immagini per scoprirvi il loro lato omicida. Un
minimo di attività capace di rompere l’equilibrio immaginario costruito dai
nazisti era in grado di mostrare il «nascosto». In questa nuova visione rallentata
«la cosa più inquietante […] era però la metamorfosi dei suoni. In una breve
sequenza, subito all’inizio […] l’allegra polka di un qualche compositore di
operette austriaco che si udiva nell’accompagnamento musicale della copia
berlinese, si è trasformata in una marcia funebre che si trascina con indolenza
addirittura grottesca, e anche gli altri brani musicali, sottesi al film e di cui io
sono riuscito ad identificare soltanto il cancan da La Vie parisienne e lo scherzo
dal Sommernachtstraum di Mendelssohn, si muovono in un mondo per così dire
sotterraneo, in abissi terrificanti […] nei quali nessuna voce umana è mai
scesa»32. E tuttavia, in questo mondo ctoniano, «appare il viso di una donna più
giovane, quasi indistinguibile dall’ombra nera che la circonda […]. Intorno al
collo […] porta una catenina a tre giri sottili che risalta appena sul suo abito
scuro e accollato, mentre fra i capelli, da una parte, ha un fiore bianco.
Esattamente così come mi immagino l’attrice Agàta sulla base dei miei deboli
ricordi e degli altri scarsi riferimenti che oggi posseggo, esattamente questo –
31
Si tratta del lavoro di H.G. Adler, Theresienstadt. 1941-1945.. Das Antlitz einer
Zwangsgemeinschaft. Geschichte, Soziologie, Psychologie, la cui prima edizione è del
1955.
32
W.G. Sebald, Austerlitz, cit., p. 266.
44
penso – è il suo aspetto e continuo a guardare quel viso nel contempo estraneo e
familiare»33 (foto 4).
Decostruendo una costruzione immaginaria Austerlitz aveva estratto l’orrore
che essa nascondeva, mostrando il velo fragile (l’immagine filmica, in questo
caso), con cui si era tentato di occultare una pratica si distruzione – certo si
renderà anche conto che il volto agognato non era quello di sua madre, per
vedere apparire il quale dovrà attendere un ritaglio oscuro di un quotidiano
conservato in un archivio teatrale.
Ma questo rumore di morte di cui la visione al rallentatore testimonia, non è
ancora in grado di dirci nulla sul destino della madre di Austerlitz, né della
distruzione degli ebrei, né ci mostra un’eventuale rappresentazione della Shoah.
Per ora Austerlitz non ci ha mostrato che volti: nessuna foto con corpi
ammassati, né scene di partenza presso, per esempio, il palazzo delle
esposizioni a Vysehrad, dove sua madre aveva ricevuto l’ordine di recarsi con
un piccolo bagaglio dai Tedeschi che oramai occupavano la città, e nemmeno
immagini della vita nel ghetto di Theresienstadt che era anche un campo di
concentramento.
E tuttavia, nonostante queste immagini non siano né prodotte né riprodotte, il
nostro sguardo che resta testimone è costretto ad operare uno sforzo di
ricostruzione, senza alcuna necessità di mostrare l’«immagine presente». La
posizione di passato che la foto impone a colui che la guarda porta con sé la
ricomposizione dello spazio tra il «ça a été» della fotografia e il soggetto.
Per ricostruire l’orrore di Theresienstadt, anche se certo la minuziosa analisi di
Adler esaurisce tutte le domande che ci si potrebbe porre, non c’è bisogno di
mostrare direttamente l’orrore «esagerando» come direbbe Benjamin, ciò che è
già abominevole. E’ sufficiente, per esempio, anche osservare le macabre foto
di quel che resta nel Comune di Terezin in cui è conservata ancora tutta la
disfatta di cui il luogo è stato depositario (foto 5, 6, 7): Terezin, divenuto
appunto un ordinario comune, ma che con «l’aspetto ostile delle mute facciate
delle case», «le finestre cieche», i «desolati edifici » sembra abitato dai
fantasmi.
Ma la presenza più opprimente è senza dubbio l’«Antikos Bazar» (foto 8) ,
colmo di oggetti tra i più bizzarri e il cui solo legame era «senza equivoco» il
fatto di essere sopravvissuti alla distruzione del loro proprietari.
Così, per comprendere cosa fosse accaduto in questo luogo, antica fortezza
costruita durante l’epoca moderna, bastava, da parte dello spettatore, tessere il
33
Ibi, p. 268.
45
IRWR
IRWR
IRWR
legame tra quelle porte di legno desolate, i bizzarri oggetti del bazar, i rumori
ctoniani del film di Theresienstadt al rallentatore, l’aria di dissolutezza che si
respirava nelle vie del comune di Terezin, il bel viso nell’ombra di Agata e
l’inquietante sguardo interrogatore del paggio che non cessava di reclamare che
Austerlitz «raccogliesse il guanto e allontanasse la sciagura incombente su di
lui».
L’abbandono mostrato da queste immagini, tutto ciò che costituisce il loro
punctum, dava ad Austerlitz la sensazione che le persone un tempo rinchiuse a
Theresienstadt non fossero mai state evacuate34 e per questa visione qualunque
foto l’avesse riprodotta sarebbe stata insufficiente: o perché avrebbe tolto al
reale qualcosa (uno strato di realtà, come diceva Balzac) o perché l’avrebbe
falsificato.
Le immagini attraverso cui Austerlitz si è mosso (ma questo vale per qualunque
lettore) non ci mostrano, in sé, una storia, non la spiegano né sono connotate
dalle parole che le precedono o le seguono: esse non sono nemmeno dei
semplici «aide-mémoire». Al contrario agiscono quasi come ostacolo alla
visione35 che è costretta, per «vedere», a ripartire dallo sguardo reciprocamente
interrogante che lega la fotografia e lo spettatore.
Le foto dei romanzi di Sebald non sono delle classiche foto di reportage e non si
potrebbe nemmeno parlare di foto artistiche36. Per tentare di spiegare la ragione
che ha presieduto alla loro scelta occorre ancora una volta ricordare la volontà
34
«[…] Sentii con inequivocabile certezza che quelle persone [le circa sessantamila
rinchiuse a Terezin] non erano state condotte via, ma vivevano ancora, stipate nelle
case, nei sotterranei e ne isolai, salivano e scendevano senza posa le scale, guardavano
fuori dalle finestre, si muovevano in gran numero per le strade e i vicoli e, in silenziosa
adunata, occupavano addirittura lo spazio fra cielo e terra che una pioggia sottile
tratteggiava di grigio», W.G. Sebald, Austerlitz, cit., pp. 215-216.
35
Cfr. il saggio di M. Anderson «Fino allo sciogliersi delle cose. W.G. Sebald e la
prosa della fotografia», in G. Pulvirenti (a cura di), Le muse inquiete, sinergie artistiche
nel Novecento tedesco, Firenze, Olschki, 2003.
36
Ricordiamo che nell’opera di Sebald sitrovano usi differenti della fotografia e che il
nostro proposito non era quello di analizzare la totalità del corpus di immagini
sebaldiano. Non è forse inutile ricordare una considerazione di Barthes per cui la
fotografia aveva in sé sempre qualcosa di allucinatorio, quasi arrivasse da una regione
delle follia, essendo essa un «néant d’objet» della cui realtà, però, nessuno poteva
dubitare. Per addomesticare questo lato allucinatorio della fotografia o la si rendeva
un’arte (e allora il noema della foto veniva dimenticato: che senso avrebbe di fronte ad
una foto d’arte, domandarsi «ça a été»?) o la si generalizzava trasformando il mondo
stesso in immagini. Di fronte a questi comportamenti ben radicati, bisognava scegliere :
sottomettersi («soumettre son spectacle au code civilisé des illusions parfaites») o
«affronter en elle [la Photo] le réveil de l’intraitable réalité». Cfr. R. Barthes, La
chambre claire, cit., pp. 176 et ss.
47
di Sebald di abbordare questioni come la distruzione degli Ebrei in maniera
«obliqua». Le immagini rientrano in questa volontà: il loro valore non risiede in
ciò che ci mostrano, ma in ciò che presagiscono e nascondono. Il loro valore
risiede nel modo in cui si posizionano in un luogo, come diceva Barthes, «entre
l’infini et le sujet»37 obbligando lo spettatore a riempire questo spazio con la
storia iscrittasi al suo interno e che ha come compimento il nostro sguardo.
Questo spazio riempito è il luogo in grado di ospitare una storicità, scomparsa in
una rappresentazione immaginaria della Shoah tale quella cui ci siamo abituati.
In Sebald la foto diventa lo strumento attraverso il quale invece di «vedere»
siamo costretti a interrogare lo spazio che ci separa da essa. In sé, la desolazione
opprimente delle stradine di Theresienstadt non potrebbe essere nulla più che un
esempio di degrado o disfatta della modernità. Se essa diventa il segno di una
più vasta rovina che ci permette di significare il silenzio e l’abbandono del
luogo, è perché le immagini che noi vediamo non hanno alcuna pretesa di essere
vere. In sé le immagini sono false perché è a noi che incombe l’obbligo e anche
la responsabilità di intersecarvi una storia di cui, in sé, esse sono incapaci di
testimoniare. Siamo noi a diventare i testimoni. Queste foto non illustrano nulla,
né rappresentano alcunché, né sono illustrate né, nella maggior parte dei casi,
commentate. Sono piuttosto, paradossalmente, un ostacolo alla visione,
rendendo oscura la realtà invece di illuminarla e imponendo allo spettatore lo
sforzo di rischiararla.
Sempre nel libro Austerlitz si trova una brevissima nota sul luogo della verità
che, è detto, «si trova altrove» rispetto a dove noi rivolgiamo lo sguardo38.
Questo motto spiega bene l’uso obliquo della fotografia di cui si è appena
parlato: la verità di una foto non si trova nella sua evidenza, là dove i nostri
occhi si fissano nella speranza di abbracciare con lo sguardo ciò che è accaduto
nel luogo limitato dalle dimensioni dell’apparecchio fotografico.
E’, per esempio, ciò che racconta Sebald in un’intervista ad Arthur Lubow del
2001, poco prima di morire, relativamente ad una foto in cui figuravano i suoi
genitori, suo padre e sua madre incinta accompagnati da un’amica. Come riporta
Lubow, nulla nella fotografia lasciava «vedere» il nazismo : né le bandiere con
le svastike, né la guerra con le sue privazioni e men che meno ebrei con la
divisa a righe o la vicinanza inquietante della città di Norimberga, luogo di
raduno del partito nazista. E nemmeno che l’uomo della fotografia, il padre di
Sebald era in permesso. Eppure, nonostante queste non presenze alla visione,
tutto nella fotografia portava l’impronta del nazismo, tutto era stato autorizzato
dallo Stato, compreso il nome di Winfried Georg, il bambino concepito durante
37
R. Barthes, La chambre claire, cit., p. 121
Si tratta del professore di storia di Austerlitz, secondo il quale quando noi cerchiamo
di fare della storia fissiamo il nostro sguardo sulle immagini consumante che popolano
la nostra mente, mentre la verità si trova «altrove», in un luogo in cui nessuno guarda,
cfr. W.G.Sebald, Austerlitz,cit., p. 82.
38
48
il permesso del soldato e che, una volta cresciuto, come ricorda Lubow,
prediligerà farsi chiamare Max39.
Nelle foto in questione, il regime nazista non si mostra nella visibilità dei suoi
simboli o delle sue pratiche. Esso si trova «altrove», nella coercizione esercitata
sulla realtà (su di un altro piano, ma si tratta della stessa operazione di
costruzione preliminare della realtà che aveva preceduto la realizzazione del
film su Theresienstadt: invece di falsificare l’immagine, si falsifica il mondo)
che non lascia tracce nella materialità dell’immagine ma che trova posto nel
nostro sguardo. E poiché la fotografia è evidente senza mai essere trasparente, è
forse, come diceva Kafka, solo distogliendo lo sguardo (anche chiudendo gli
occhi) che si potrebbe finalmente vedere, liberi dall’illusione che il reale si trovi
nella facile pratica di visione sensoriale di uno scatto40.
Il fatto che la dimensione abominevole della catastrofe non sia inquadrata
direttamente, ci potrebbe ricordare facilmente il tentativo di Claude Lanzmann
nel suo film Shoah, in cui la combinazione di immagini e parole crea un effetto
di distanza e in cui l’alterità di ciò che si vede resta intera. In questo film – dove
si vede quello che si vedrebbe oggi andando ad Auschwitz (un po’ come
Austerlitz che si rende nell’ordinario comune di Terezin) – le traduzioni in
“diretta” delle risposte alle domande che il regista poneva, le lunghe strade
ferrate tra un’intervista e l’altra, da New York a Tel Aviv o Treblinka, gli
interventi dello storico Raul Hilberg, l’insieme del montaggio… tutto ha come
risultato di impedire un’identificazione emotiva e di porre una distanza che
arriva fino a noi, condizione preliminare per la presenza di una dimensione di
storicità41. Lo sconvolgimento non è al livello del sentire, ma nella distanza che
obbliga a riflettere – il che si rivela uno sforzo difficile da sopportare anche
guardando il film oggi.
Ma ritorniamo agli inizi di questo excursus, alla storia di Max Ferber. Era, come
abbiamo detto, un pittore che viveva a Manchester, vicino al porto ormai a
digiuno di merci della città. La produzione principale del suo lavoro era in
realtà, più che il quadro, la polvere. Abbozzava sulla tela qualcosa che subito
dopo eliminava in un lavoro quasi infinito che produceva una calmante e grigia
polvere quasi calcificata in gran parte della sua abitazione/atelier. Ferber aveva
lasciato Monaco, come abbiamo già detto, avendo ottenuto un visto,
contrariamente ai suoi genitori che trovarono la morte sotto il nazismo.
39
W.G. Sebald in un’intervista in L.S. Schwarz, L’archéologue de la mémoire.
Conversation avec W.G. Sebald,cit., p. 175.
40
Cfr. R.Barthes, La chambre claire, cit., p. 88.
41
Ricordiamo che abbiamo citato questo film, geniale, solo a titolo di esempio, nel
senso che l’obiettivo di Lanzmann era quello di girare un film e non di “creare” un
materiale storico.
49
Nel racconto che ha per cuore la sua storia, storia dallo svolgimento labirintico
tipico delle scritture sebaldiane, la sola fotografia il cui soggetto sia
direttamente la Germania e il nazismo è quella indicata come una falsificazione
dallo zio di Ferber, Leo. Dopo questa falsificazione smascherata, nessuna foto
avrebbe potuto sopportare di essere presa come testimonianza del reale. Noi
vediamo infatti riprodotti squarci della città di Manchester, l’hotel in cui
alloggiava il narratore, l’apparecchio sveglia/teiera regalato sempre al narratore
in occasione del suo primo soggiorno inglese – quasi oggetto simbolo della
svolta grottesca presa dalla modernità.
Non ci sono altre fotografie che potrebbero essere ricondotte alla Shoah, se non
alla fine del racconto, quando allora campeggia un’immagine la cui
caratteristica è quella di non essere riprodotta. Paradossalmente molte persone
hanno avuto la sensazione di aver visto questa immagine «diretta» della
distruzione degli Ebrei e di essere guardati da uno sguardo insostenibile colto
nel presente dell’annientamento. Come si potrebbe infatti sostenere lo sguardo
di colui che sta per essere distrutto? Ebbene, questa immagine si trova alla fine
del racconto e non ci si può ricordare della lettura senza avere la certezza di
averla vista42. Ma, quando si riprende il libro per verificare e controllare se lo
sguardo sia insostenibile proprio così come ce lo ricordiamo, riaprendo il libro
non si trovano altro che queste parole, trasmesse dal narratore (del resto molto
somigliante a Sebald stesso) il quale incontra un’ultima volta Ferber
all’ospedale e ricorda, dopo questo incontro, un’esposizione, una mostra vista a
Francoforte. Si trattava di fotografie del ghetto di Lodz: «Dietro un telaio
verticale sono sedute tre donne giovani, sui vent’anni. Il tappeto, che stanno
annodando, ha un motivo irregolarmente geometrico […]. Chi siano quelle
giovani donne, non lo so. A causa del controluce prodotto dalla finestra alle loro
spalle, non riesco a vederle bene negli occhi, ma sento che tutte e tre mi
guardano, perché io sono proprio nel punto in cui si era piazzato […il
fotografo]. Delle tre giovani donne, quella in mezzo ha capelli biondo chiaro e
assomiglia in certo qual modo a una sposa. La tessitrice alla sua sinistra tiene la
testa leggermente piegata da una parte, mentre quella di destra mi rivolge uno
sguardo così fisso e implacabile che io non riesco a sostenerlo a lungo. Vado
almanaccando quale sarà stato il nome di quelle tre giovani – Roza, Lusia e Lea
oppure Nona Decuma e Morta, le figlie della Notte, con il fuso, il filo e le
forbici»43.
42
Si tratta di una sensazione provata da quasi tutti i lettori. Una testimonianza tra tutte,
quella di R.Vogel-Klein, in «Détours de la mémoire. La représentation de la Shoah dans
la nouvelle Max Aurach de W. G. Sebald», in F. Rétif (ed), L’indicible dans l’espace
franco-germanique, Parigi, 2004 e, dello stesso autore, nella raccolta sotto la direzione
di L.S. Schwarz, L’archéologue de la mémoire, cit.
43
W.G. Sebald, «Max Ferber», in Gli Emigrati, cit., p. 252-253.
50
L’immagine immateriale della Shoah diviene la sola immagine possibile e allo
stesso tempo impossibile da riprodursi. Tutte le fotografie presenti negli scritti
di Sebald rimandano in qualche maniera alla Shoah interrogando lo spettatore
affinché costui trovi lo spazio per una storia. E tuttavia la Shoah è alla fine
centrata «direttamente» in questa visione immateriale che non cessa di
ossessionarci – soprattutto quando chiudiamo gli occhi.
In luogo di una galleria fotografica da contemplare, seppur con orrore,
diventiamo i testimoni di una storia che siamo obbligati a ricostruire perché ne
siamo i destinatari di fronte all’immagine che ci guarda non cessando di
reclamare il proprio dovuto, senza che questo imponga la necessità di esagerare
l’abominevole o di cercare a tutti i costi la foto della “presenza” come fosse,
quest’ultima, l’evidenza mostrata nella sua pienezza.
Per essa è sufficiente l’indicazione di Kafka: esistono immagini che si vedono
meglio chiudendo gli occhi – proprio come, nella Biblioteca di Babele44, l’unico
libro importante, che forse contiene tutti i libri e la storia intera del mondo, non
poteva essere aperto.
Diana Napoli
Diana Napoli è dottoranda di ricerca in Storiografia all’EHESS sotto la direzione di F. Hartog.
E’ docente di Filosofia e Storia a Brescia.
Shoah - Foto 8)
IRWR
44
Si tratta del racconto di J.L. Borges, «La Biblioteca di Babele», in Finzioni, Milano,
Adelphi, 2003.
51
Aldo Capitini da Perugia al mondo.
(Andata e ritorno)
di Giuseppe Moscati
«La vita non è una foto, ma è l’attimo che se ne va
e insieme porta via i colori e porta via la verità.
E la cultura è un ideale e il sogno è quasi già realtà»
(Stefano Rosso)
«Sono nato a Perugia il 23 dicembre 1899, in una casa nell’interno povera, ma
in una posizione stupenda, perché sotto la torre campanaria del palazzo
comunale, con la vista, sopra i tetti, della campagna e dell’orizzonte umbro,
specialmente del monte di Assisi, di una bellezza ineffabile»45. Così esordisce
Aldo Capitini nella sua nota autobiografia intitolata Attraverso due terzi del
secolo, le cui bozze egli, morto il 19 ottobre 1968, non ebbe il tempo di rivedere
e le cui pagine costituiscono una sorta di testamento ‘spirituale’ – e tuttavia
profondamente laico – del filosofo umbro. Ma il testo era stato da lui comunque
consegnato in buone mani, quelle dell’amico fraterno Guido Calogero 46 che lo
avrebbe ospitato nella sua prestigiosa rivista “La Cultura”.
Ventuno anni prima Capitini aveva dedicato alla sua città un volumetto, che
aveva chiamato Perugia. Punti di vista per una interpretazione, apparso per la
prima volta all’interno della collana “Città italiane” de La Nuova Italia di Firenze.
Di quel testo, ripubblicato a cura della Regione dell’Umbria nel 1986 con
l’aggiunta di una preziosa prefazione di Walter Binni, fine letterato e altro
grande amico di Capitini, è uscita una terza edizione nel luglio 2008. Tale
riedizione, curata dal Comune di Perugia su progetto della Fondazione Centro
45
A. Capitini, Attraverso due terzi del secolo, in Id., Scritti sulla nonviolenza, a cura di L.
Schippa, Protagon, Perugia 1992, p. 3.
46
Come si legge nelle ultime lettere del loro carteggio, edito nell’ambito dell’epistolario
capitiniano che si deve alla Fondazione Centro Studi Aldo Capitini: cfr. A. Capitini – G.
Calogero, Lettere (1936-1968), a cura di Th. Casadei e G. Moscati, Carocci, Roma 2009,
p. 598 e segg.
52
Studi Aldo Capitini, era stata suggerita da Luciano Capitini, nipote del filosofo e
presidente dell’Associazione nazionale “Amici di Aldo Capitini”.
Come chiarisce lo stesso sottotitolo di questo libello, l’autore intende proporre
dei punti di vista attraverso i quali “leggere” la città di Perugia, che naturalmente
è vista nel suo insieme inscindibile di città propriamente fisica e comunità civica
in senso lato, ovvero come «qualche cosa di vivente e di rinnovantesi»47.
Questi punti di vista rappresentano dunque dei veri e propri ponti grazie ai quali
gettare sulla città delle ipotesi interpretative, che, se da una parte si
arricchiscono degli sviluppi culturali della formazione che Capitini ha maturato
con le sue esperienze tanto di autore di testi filosofici e religiosi che di docente
universitario di Filosofia morale e di Pedagogia (a Pisa, Cagliari e Perugia), in
realtà nascono anche da tutta una serie di osservazioni e partecipazioni dirette
alla vita perugina: con le parole di Capitini, «alcuni punti di vista dai quali ho
guardato e sento la città»48.
Già dalle prime battute emerge con evidenza la caratteristica fondamentale di
questo scritto, quella cioè di una riflessione filosofico-antropologica di ampio
raggio: la campagna che circonda il centro urbano non si limita ad essere luogo
meramente naturale e materico, ma agli occhi di Capitini è anche – e forse
soprattutto, direi – campagna “tutta storica” come in generale il paesaggio
umbro è paesaggio “tutto umano” perché tutto marcatamente inscritto nella
storia49. Del resto è lo stesso Binni a sottolineare quanto grande fosse l’affetto
di Capitini per le zone più campagnole e popolari del comprensorio perugino,
zone la cui peculiarità è la semplicità e che tuttavia nascondono una “forza
dentro” che coincide con quella che per Capitini è l’“armonia umbra”50.
Ma Binni è particolarmente attento anche alla cura capitiniana per la storia della
tradizione
laica
e
democratica
di
Perugia,
città
dall’acceso
spirito
d’indipendenza e dalla forte vocazione all’autonomia e alla centralità politica
47
A. Capitini, Perugia. Punti di vista per una interpretazione, Tipografia comunale,
Perugia 2008, p. 29.
48
A. Capitini, Perugia…, cit., p. 17 (corsivo mio).
49
Cfr. ivi, p. 22.
50
Cfr. W. Binni, Prefazione, in A. Capitini, Perugia…, cit., pp. 5-6.
53
contro l’assolutismo papale51. Perugia città, soprattutto, forte di quell’identità
civile medievale e primo-rinascimentale e poi ottocentesca52 che torna assai
fertile per il lavoro contemporaneo cui Capitini si dedica a trecentosessanta
gradi. Ed è a Perugia e da Perugia che Capitini «svolse la sua fecondissima
attività di lotta, di organizzazione, di educazione contro la dittatura fascista e a
favore di quell’originale “liberalsocialismo” di cui egli fu primo ideatore […], per
poi, dopo la guerra e la liberazione, farsi, a Perugia, geniale inventore di quei
“Centri di orientamento sociale” che rappresentavano per lui l’inizio di un
“potere dal basso”, di un “potere di tutti”, di una politica e di un’amministrazione
che cominci nella libera discussione di assemblee popolari»53.
Perugia è allora, scrive ancora Binni, il centro concreto e ideale dell’attività
capitiniana tutta; è l’appoggio costante dell’ispirazione di un intellettuale
radicato nella sua origine e peraltro portato dalla sua stessa più intima
persuasione a rivolgersi ad innumerevoli altri centri, anzi a ricreare egli stesso
in ogni dove un centro che possa portare con sé condivisione, comunità,
socialità. Perugia è «il luogo o l’intreccio di luoghi (quei colli, quelle vie, quelle
piazze che percorreva solo od insieme agli amici più cari) su cui collocare le
sue intuizioni più alte, le sue immagini più intense, i suoi sentimenti e i suoi
affetti più intimi e sacri e insieme un vivo nucleo di tradizione cui collegare lo
sviluppo della sua stessa prospettiva spirituale e della sua prassi coerente» 54.
Ma quali sono veramente “le sue intuizioni più alte”? Sicuramente quelle che
ritroviamo nel cuore del lavoro che, da Capitini auspicato per una condivisione
di tutti e da lui svolto in prima persona, si concentra sull’educazione
democratica, vale a dire il lavoro di coraggiosa rottura nei confronti di quegli
schemi etico-politici del passato che sono diventati inadeguati. E allo stesso
tempo il lavoro di apertura della realtà in direzione di un orizzonte di libertà,
responsabilità e giustizia sociale.
51
Emblematico è il caso del XX giugno 1859 quando «circa duemila soldati svizzeri […]
effettuarono le famose stragi “per ricondurre la città al dominio papale”» (A. Capitini,
Perugia…, cit., p. 43), il cui ricordo ogni anno rinnovava in Capitini un eccezionale
sentimento civile accompagnato da “mestizia e un senso solenne” (cfr. ibidem).
52
Cfr. W. Binni, Prefazione, in A. Capitini, Perugia…, pp. 5-8.
53
Ivi, pp. 7-8.
54
Ivi, p. 8.
54
Ecco la “realtà liberata” di cui ci parla insistentemente Capitini nel corso di tutta
la sua produzione, tesa a riscrivere una nuova etica e una nuova politica che
finalmente si pongano come fortemente critiche del realismo di trazione
machiavellica. Ecco l’“aggiunta” che, sotto varie forme e ognuno come può, tutti
siamo chiamati ad offrire a questa realtà da liberare (da liberare dai limiti della
realtà attuale): aggiunta religiosa; aggiunta politica e sociale; aggiunta filosofica,
letteraria, culturale. Quella cui guarda Capitini è dunque una realtà liberata, ma
è una realtà che parte necessariamente dal basso e che è di tutti e per tutti,
altrimenti non è, non si dà.
Al modo in cui Capitini interpreta le relazioni che danno vita alla città sono
collegati a doppio filo diversi elementi della sua filosofia, che vale la pena di
richiamare qui seppur per sommi capi.
Innanzitutto
dobbiamo
aver
presente
l’elemento
fondamentale
della
nonviolenza, che Capitini trae da Gandhi e, però, originalmente rielabora in
persuasione nonviolenta anche in virtù della frequentazione della pagina di
Carlo Michelstaedter, con il cui singolare esistenzialismo egli colloquia
intensamente.
Poi va ricordata la ferma opposizione di Capitini al fascismo e in generale al
male con cui egli invita a non collaborare, insieme all’impianto teorico-pratico
del movimento liberalsocialista, co-ideato insieme al già ricordato filosofo
romano Guido Calogero.
Ancora, la vicinanza del pensiero di Capitini con la filosofia dialogica di un
Martin Buber; le sue posizioni dell’antistoricismo e dell’antidogmatismo; le sue
battaglie contro il potere della più deteriore “cattolicità”, che gli sarebbero
costate scomunica e censura: il 1929, con il Concordato con il regime fascista –
regime di repressione, violenza, guerra e annullamento di ogni libertà –
secondo il suo modo di vedere non poteva che segnare il “tradimento del
Vangelo” da parte della Chiesa cattolica.
Si può così continuare con l’atteggiamento ‘religioso’ di fondo di Capitini: la sua
è una religione aperta ai tutti, compresi gli animali, le piante e le cose (Elementi
di un’esperienza religiosa, 1937; Religione aperta, 1955); con l’idea altrettanto
originale della compresenza (La compresenza dei morti e dei viventi, 1966);
con l’orizzonte e ideale regolativo dell’omnicrazia o potere di tutti, nessuno
55
escluso, a partire dalla considerazione ‘kantiana’ dell’altro come fine e non
soltanto come mezzo, ancora una volta in chiave anti-machiavellica.
Da tutto ciò non sono dunque scollegate le riflessioni che Capitini elabora sulla
vita umile, comune e affettuosa e sulla religiosità aperta, popolare ed eretica del
Duecento umbro, che muove da Francesco d’Assisi e giunge a Jacopone di
Todi.
Giuseppe Moscati
7RQLQR1HJUL6FXOWXUDFHUDPLFD´$UWHLQ*LDUGLQRµ,VRODG·(OED
56
NORBERTO BOBBIO
Il maestro laico che manca all’Italia
di Claudio Magris
Se fosse vivo e in età ancor
combattiva, non so se Norberto
Bobbio - trovandosi in un mondo
sempre più opposto al suo modo di
essere, di sentire e di pensare –
sarebbe più spronato a dar libero
corso alla sua vena “iraconda” ,
come egli diceva, e polemica
oppure ad abbandonarsi a una
rassegnata e stoica amarezza. Bobbio incarna esattamente ciò che
manca, sempre più vistosamente e
volgarmente, alla nostra società: la
capacità di ragionare, di distinguere, premessa fondamentale dell’onestà verso gli altri e verso se
stessi. Una volta, alle scuole
elementari, ci insegnavano che non
si possono sommare litri a chili o a
metri, cosa che ora si fa normalmente, in un coro di imbroglioni e
imbrogliati che sono spesso le
medesime persone. Mai come oggi
è mancata la laicità e Bobbio è
anzitutto un maestro di laicità, non
nel senso stupido e scorretto in cui
viene correntemente usata questa
parola, quasi significasse l’opposto
di credente, di religioso o di
praticante, come credono e vogliono far credere gli ignoranti e i
disonesti. Bobbio ha insegnato che
laico non indica il seguace di una
specifica idea filosofica, bensì chi è
capace di distinguere le sfere delle
diverse competenze; distinguere
1RUEHUWR%REELR
ciò che è oggetto di dimostrazione
razionale da ciò che è oggetto di
fede, a prescindere dall’adesione o
meno ad essa. Laicità: distinguere
fra diritto e morale, sentimento e
concetto, legge e passione; articolare le proprie idee secondo
principi logici non condizionati da
alcuna fede né ideologia; mettere in
discussione
pure
le
proprie
certezze; sceverare l’autentico sentimento dalle incontrollate reazioni
emotive, ancor più nefaste dei
dogmatismi.
Oggi viviamo in una temperie
culturale assai poco laica, funestata
dai fondamentalisti religiosi come
da quelli aggressivamente atei,
entrambi capaci di ragionare solo
con le viscere e con slogan
orecchiati. La cronaca di ogni
giorno ci mostra come si confondano e si pasticcino politica e
morale, diritto e sentimentalismo, in
un’allegra sgrammaticatura linguistica, concettuale ed etica che mette
spesso il soggetto all’accusativo e
viceversa, per scambiare i ruoli tra
vittime e colpevoli e mettere in
galera il derubato anziché il ladro.
57
Il sistema politico regredisce a una
barbarie premoderna, cancellando
progressivamente secoli di civiltà
liberale che aveva elaborato controlli e garanzie per impedire abusi
di potere. Oggi c’è più che mai
bisogno di intelligenza e di
passione come quelle di Norberto
Bobbio, che ha difeso e vissuto
questi valori – i quali, prima di
essere cardini della vita civile e del
buon governo, sono il sale
dell’esistenza quotidiana – sui
fronti più diversi, dai mirabili studi
filosofici e giuridici, che fanno di
lui un eccezionale maestro, alla
milizia etico-politica e alla presenza
generosa e creativa nella vita
culturale. In quel vero, sobrio
capolavoro che è De Senectute, un
commiato dalla vita insieme
classico e cocentemente contemporaneo, Bobbio, richiamandosi al
mito platonico dei due cavalli
dell’anima, si duole di aver
permesso al destriero irascibile di
aver prevalso su quello nobilmente
razionale, ma non so se sia
un’autocritica giustificata. Semmai,
è stato troppo mite; oggi c’è
bisogno più dell’ira che della
mitezza a lui cara, nel baraccone in
cui ci troviamo.
La sua lucidità nasce da un cuore
generoso, ricco di affetto e amicizia, di ironia e autoironia.
Bobbio ha insegnato che la
battaglia del pensiero è talora pure
una battaglia contro la propria
passione, ma sempre nutrita di
passione, anche quando deve
dolorosamente dominare quest’ultima. Il cuore va sempre ascoltato,
anche quando urta contro la legge,
ma sapendo che spesso il cuore è
pure “pasticcio e gran confusione”,
come ha scritto in un suo romanzo
un altro grande piemontese, Stefano
Jacomuzzi. La sofferta chiarezza
chiamata a far rispettare l’umano,
anche quando ciò – nel groviglio
delle contraddizioni – può far male
al cuore, affonda le proprie linfe in
quest’ultimo.
Bobbio, maestro nel difendere i
valori “freddi” della democrazia –
l’esercizio del voto, le fondamentali
garanzie giuridiche, l’osservanza
delle regole e dei princìpi logici –
sa che essi sono meno appassionanti dei valori “caldi” del
sentimento, degli affetti, degli
amori; magari pure meno appassionanti delle passeggiate nel
suo amato Piemonte o nella nostra
Torino, capitale di quell’Italia più
civile che credevamo possibile. Ma
Bobbio ci insegna che solo i valori
freddi, i quali stabiliscono condizioni di partenza uguali per tutti,
permettono a ognuno di coltivare i
propri valori caldi, di inseguire la
propria passione. La logica rende
possibile l’umanità e difende la
“calda vita”, come direbbe Saba.
Anche a rischio dell’impopolarità –
la vita vera è impopolare – come
quando Bobbio, da vero laico,
faceva chiarezza sulla vita nascente
e sui diritti del nascituro o come
quando rivendicava, in certe
vicende eclatanti che eccitavano
l’opinione pubblica in nome di
buoni sentimenti, la prosaica osservanza della legge contro l’enfasi
strappalacrime pronta a calpestare il
diritto, ponendo così le basi per
nuove ingiustizie.
58
Quasi tutte le cronache quotidiane –
politiche, giudiziarie, culturali –
smentiscono questa liberale lucidità. Ogni riga di Bobbio è una
diga contro la marea di melmosa,
sordida e sentimentale pappa del
cuore che avanza. Consapevole dei
propri limiti, Bobbio, a differenza
dei mediocri, non si sopravvalutava.
Al massimo poteva ritenere di aver
“travajè ben”, lavorato bene, come
dice un detto piemontese a lui caro.
E’ andato incontro alla morte
perplesso ma fermo nella propria
perplessità, “credendo di non
credere”, come scrive, ma dubitando pure di quella sua provvisoria posizione e non ritenendola
certo più evoluta di altre. La sua
asciuttezza è la cifra della classicità,
che consiste nella simbiosi di
passione e controllo. Anche il vero
poeta, diceva Saba, è insieme un
bambino che piange e un adulto che
non si lascia sommergere da quel
pianto.
Claudio Magris
L’articolo sopra riprodotto è stato pubblicato il 13 settembre 2009 da Il Corriere della Sera.
Ringraziamo l’autore e la Direzione del giornale per la gentile concessione.
59
FOTO T. Negri
7RQLQR1HJUL6FXOWXUDFHUDPLFD´$UWHLQ*LDUGLQRµ,VRODG·(OED
RETORICA E MULTICULTURALISMO
di Davide Fricano
Introduzione: tra Filosofia e Scienze sociali
Intorno ai primi anni ’90 si è registrato un incremento considerevole della
produzione bibliografica delle scienze sociali in merito al fenomeno del
Multiculturalismo. Antropologia, etnologia, sociologia, psicologia sociale,
concentrano la propria attenzione su di un tema che diventa il leit-motiv degli
studi di fine millennio: l’esame della possibilità (e delle eventuali modalità) di
convivenza tra culture differenti che si va affermando come esigenza primaria e
complessa via via che gli Stati cominciano ad assumere connotati multietnici
sempre crescenti. Gli eventi storici, più o meno recenti, che hanno determinato
l’emergere di questo fenomeno, e la conseguente presa di coscienza dello stesso
da parte degli intellettuali europei, si possono riassumere nell’estesa richiesta e
diffusione di forme di democrazia a livello intercontinentale attuatasi attraverso
i molteplici processi di decolonizzazione; l’attivarsi di continui e massicci flussi
di emigrazione verso i continenti “ricchi”; l’affermarsi della globalizzazione; la
fine della Guerra Fredda con la caduta dei regimi totalitari dell’est Europa.
Questi fattori avrebbero contribuito a ridimensionare fortemente la matrice
culturale fondamentale dell’Occidente: il razionalismo scientifico. Il sorgere del
Postmoderno sarebbe la causa, ed al contempo il segno, in ogni caso il fattore
essenziale della corrosione di un modello gnoseologico fino ad allora ritenuto
unico ed assoluto anche – ma non solo - perchè celebrato come tale dal
pregiudizio di una presunta superiorità culturale: stiamo parlando di quella che
Searle
definisce
Tradizione
Razionalista
55
Occidentale55
(paradigma
di
J.R.Searle (2008). Searle imputa proprio ai postmodernisti (quali ad es. Derrida,
Foucault ecc.) l’ attivazione dell’operazione culturale di erosione della tradizione di
pensiero occidentale (o, se vogliamo, della tradizione occidentale del pensiero). Tale
61
strutturazione del sapere che secoli di Filosofia hanno contribuito a produrre e
studiare). Per essere più precisi, in verità, non va però trascurato il fatto che non
sia stata per nulla estranea storicamente alla filosofia l’esperienza della
commistione culturale. Facciamo un esempio. Se da un lato è vero che
sfogliando un qualsiasi manuale di storia della filosofia tra le pagine iniziali si
troveranno interi capitoli dedicati alla peculiarità delle categorie di pensiero
Tradizione Razionalista Occidentale è caratterizzata dal riconoscere come scopo
essenziale della scienza quello di ricavare affermazioni vere, le quali dovranno
assumere forma di teorie specifiche sottoponibili a critiche. Questo principio, a sua
volta, si basa sull’assunto cha la realtà preesista e sia autonoma rispetto al linguaggio, il
quale avrebbe come sua precipua funzione quella di rappresentarla (funzione
referenziale e comunicativa). Tale prospettiva, denominata Realismo, spiegherebbe
anche perché, tra i caratteri attribuiti alla Tradizione in oggetto, quello del
“logocentrismo” sia uno dei più peculiari. Al quadro delle qualità fondamentali
tratteggiato da Searle, che in fondo fa dell’Occidente una vera e propria entità
geoculturale, una civiltà complessa data dalla sintesi articolata di etica, religione, etnia,
economia, la letteratura filosofica aggiunge ulteriori profili di rilevante pertinenza: la
credenza in un tempo cumulativo e lineare, la voglia di dominare tecnicamente la
natura, l’idea che la ragione – calcolatrice ed analitica – debba guidare le azioni (da cui
deriva una sorta di efficientismo pragmatista che vede nel successo del proprio agire il
criterio principale del proprio operato), la valorizzazione della competizione
antagonistica da cui selezionare una ristretta elites economica e politica della società
(anche se le possibilità di rientrarvi sono potenzialmente riconosciute a tutti), il
perdurante tentativo di ricomposizione unitaria ed armonica dei conflitti che pure
permanentemente strutturano le relazioni socio-culturali. Ora, secondo Searle,
l’affermarsi del Postmoderno avrebbe determinato il ridimensionamento radicale di
questa specifica tradizione culturale dettato dalla necessità di proiettarla su di un piano
di assoluta parità rispetto ad altre tradizioni culturali (le quali, anzi, sarebbero viste
come preziose riserve di spunti ed istanze assimilabili dalla civiltà razionalista europea
e angloamericana). Effettivamente alcuni tratti definitori della corrente postmoderna
mostrano in pieno una direzione contraria rispetto a quelli sopra descritti e riferiti alla
TRO: la negazione di fondamenti ultimi e unitari del sapere e dell’agire che comporta
l’affermarsi di una Ragione instabile, di un Pensiero debole cui negare unicità e natura
tecnoscientifica; la corrispettiva esaltazione della plurivocità, molteplicità, difformità,
dell’ibridazione tra forme di sapere e, quindi, di una specie di policentrismo che nasce
dalla promozione del “particolare”, del “locale”, del “diverso” che possa dar vita ad un
mondo a frammenti ben lontano dall’universalismo moderno basato sulla unicità di
fede, verità e sistema di valori. Del resto, il contesto socio-culturale di gestazione del
Postmoderno indica in modo chiaro le direttrici di sviluppo che avrebbe poi preso tale
opzione di pensiero: la società complessa di tipo postindustriale (di cui il Postmoderno
vorrebbe essere la coscienza), il poststrutturalismo francese (il decostruzionismo di
62
della tradizione filosofica (spesso volutamente aggettivata come “occidentale”,
proprio per evidenziare come la filosofia sia figlia soltanto dell’area
“geoculturale” dell’occidente) rispetto ad altre modalità di riflessione culturale
presenti in altre civiltà, è – dall’altro – anche vero che diversi autorevoli
pensatori hanno riconosciuto il debito ed il tributo culturale che il pensiero
filosofico serba nei confronti di altre culture, a cominciare da quelle orientali.
Anzi, in merito si è registrata una curiosa inversione di tendenza: mentre
accreditati filoni critici e storiografici hanno sottolineato le rilevanti differenze
tra “occidente” ed “oriente” in ordine alla natura ed ai modi di realizzazione
della speculazione cognitiva (si pensi ad esempio al capitolo introduttivo del
primo dei 5 voll. di Storia della Filosofia antica di G.Reale56), altri – più
recentemente – tendono a rivalutare le prospettive di coloro che hanno sempre
esaltato i contributi del pensiero orientale a teorie filosofiche di grande spessore
nella tradizione critica occidentale. Gli esempi in tale direzione abbondano: a
cominciare dalle tangenze tra la spiritualità religiosa indiana e i culti orfici (con
relativa dottrina della metempsicosi) rielaborati dalla filosofia platonica e
pitagorica, passando per la valorizzazione della sapienza orientale operata da
Schopenhauer e della religione persiana del VI sec. a.c. riscontrabile nello
Zarathustra nietzscheiano, sino a concludere questo tragitto con la genesi della
cosiddetta new age che pure qualche attenzione in sede filosofica ha destato.
Amartya Sen57, Nobel indiano per l’Economia nel 1998, non ha mancato di far
Derrida e l’ontologia delle Differenze di Deleuze), l’epistemologia postpopperiana
(soprattutto nella sua versione anarchica promossa da Feyerabend).
56
Editi da Vita e Pensiero, Milano, 1993. Lo stesso Autore peraltro, insieme a Dario
Antiseri, ha pubblicato un corso di storia della filosofia intitolato, non a caso, Il
pensiero occidentale dalle origini ad oggi, La Scuola, Milano, 1983.
57
L’intento dell’intellettuale indiano è quello di tutelare e promuovere tali concetti
difendendoli dalle critiche cui vengono sottoposti, soprattutto nei paesi islamici asiatici
e mediorientali, per puro spirito antioccidentale. In un articolo del Corriere della sera
del 26 febbraio 2006, criticando la confusione che spesso si fa tra “multiculturalismo” e
“pluralità di monoculture”, l’Economista indiano si spinge oltre, individuando nel gran
moghul indiano Akbar colui che più convintamente in sede politica valorizzò il dialogo
introducendovi, peraltro, spunti di marcata laicità. Egli sostenne il principio della libera
63
notare come molte delle idee che si reputano di esclusiva filiazione occidentale
sarebbero in realtà già state partorite antecedentemente in ambito orientale.
Caso emblematico: il concetto di “democrazia”. Ebbene, negli ultimi anni
soprattutto si è fatto di tale principio etico-politico il vessillo, l’emblema di un
tratto di civiltà rappresentativo in modo caratteristico della cultura politica e
sociale occidentale che – per i pregi che lo contraddistinguono – andrebbe
esportato. Amartya Sen mostra come già nei concili buddisti, o nell’impero
indiano di Ashoka (III sec. a.c.) o, ancora, nel principato buddista del
giapponese Shotoku, ben sei secoli prima della Magna Charta inglese, fossero
stati fissati in una sorta di costituzione gli ideali della tolleranza, nonché
l’importanza di una discussione pubblica che fosse incardinata su regole e che
precedesse ogni tipo di decisione politica. In cosa consiste allora la novità
registratasi nel tardo novecento? A differenza dei precedenti testè descritti i
quali, ancorché significativi, non hanno peraltro avuto la forza di imporsi in
modo diffuso nella storia del pensiero filosofico, ciò che si è verificato è la
graduale
tematizzazione,
da
parte
della
Filosofia,
del
fenomeno
“multiculturalismo”. Salvo spunti del tutto sporadici di alcuni, sparuti filosofi,
la filosofia in quanto disciplina non si era posta organicamente il problema della
multiculturalità come oggetto di riflessione cui dedicare esplicita attenzione. A
riprova di questo cambio di mentalità così radicale, prima del periodo cui ci
riferiamo non era neanche stato teorizzato il concetto di “multiculturalismo” pur
non mancando contatti tra civiltà differenti; è, infatti, lo spirito totalmente
nuovo che anima gli eventi storici che hanno condotto a nuovi confronti, a
favorire questa rivoluzione culturale. Eventi che non si presentano più come
realizzazione di una eurocentrica sopraffazione che concepisce come unica
scelta razionale nell’intraprendere il cammino di fede nel proprio credo religioso,
tracciando così il sentiero della Ragione (rahi agl) per uscir fuori dalla “terra paludosa
della tradizione”. Coerentemente con tali assunti l’imperatore, che era mussulmano, si
confrontò spesso con studiosi islamici, ebrei, cristiani, induisti ed anche con i seguaci di
carvaka, setta di pensatori indiani atei che operò dal VI sec. a.c.
64
forma di comunicazione possibile con le altre culture quella del monologo cui
concedere all’ “altro” (il “barbaro”) di assistere, ma sono l’espressione
dell’orgoglio di culture e nazionalità represse che avanzano e s’impongono
sempre di più. A tale espressione corrisponde la maturazione di una
disponibilità al dialogo paritetico da parte delle culture “dominanti”, dopo un
doloroso ed approfondito lavoro di autocoscienza vertente sui torti storici, sui
pregiudizi e gli errori culturali che hanno segnato fino a pochi decenni orsono la
storia dei rapporti tra le nazioni. Soltanto sulla base di questa mutata forma
mentis i contatti tra queste ultime sono stati inquadrati in un’altra ottica, più
elevata, apparendo come contributi critici che, per un verso, segnano i rapporti
di arricchimento e conflittualità strutturanti le comunicazioni tra queste civiltà
eterogenee, per l’altro compromettono l’integrità chiusa dell’assetto culturale e
scientifico occidentale dischiudendolo ad altri orizzonti e rendendolo più
permeabile. Alle scienze sociali e storiche andrà il compito di descrivere e
studiare le dinamiche di tale processo reso possibile dalle (e, a sua volta,
produttore delle) variazioni di mentalità e cultura filosofica di cui abbiamo
parlato.
1. Cultura, Liberalismo e Comunitarismo
Storia, Filosofia, Scienze Sociali: sarebbe ovviamente riduttivo restringere ad
una questione di pura priorità cronologica il problema della definizione dei
rapporti tra gli eventi storici accaduti, il correlativo cambiamento dell’idea di
conoscenza e realtà che la Filosofia elabora e lo studio – condotto dalle scienze
sociali – sulle conseguenze socioculturali prodotte. Per capire la specificità del
contributo filosofico all’inquadramento del tema vanno infatti presi in
considerazione due piani di riflessione, uno dei quali (il primo) si pone peraltro
come possibile nodo d’intersezione tra scienze umane e filosofia. Individuare
tale duplice prospettiva significa tener presenti: a) sia una propedeutica
definizione di “cultura”; b) sia le principali teorie che si sono cimentate nel
65
tentativo di analizzare il “multiculturalismo” giungendo a conclusioni anche
radicalmente divergenti.
- Spetta a Kluckhohn (Lo specchio dell’uomo) fornire una definizione di
“cultura” all’interno della quale sintetizzare le istanze della filosofia e quelle
dell’antropologia. Solitamente per “cultura” s’intende il patrimonio di valori e
norme condivise che una persona, in quanto membro di una comunità, riceve
dal gruppo di appartenenza. In senso generale tali valori corrispondono ai modi
di percepire, concepire ed organizzare la vita (con annessi comportamenti con
cui essi vengono realizzati). In senso più specifico tali valori si traducono in
modelli lavorativi, in forme di produzione di merci che assumono rilevanza per
la società che le confezionano e commerciano, in usi familiari, in modalità di
gestione del tempo libero, nonché nel linguaggio simbolico adoperato per
esprimere l’insieme di questi elementi. Ogni cultura si presenta come fenomeno
estremamente eterogeneo in quanto caratterizzato da un continuo dinamismo
dovuto sia alle pressioni esterne prodotte dai rapporti dialettici con le altre
culture, sia ad un livello di conflittualità interna sufficientemente apprezzabile.
Ora, secondo Kluckhohn, “cultura”, nell’accezione antropologica, non significa
soltanto questo, ma corrisponde in modo più proprio alla spiegazione che
possiamo darci della genesi di tale complesso di fattori; spiegazione che
risponde all’intimo e naturale bisogno umano di promuovere schemi con cui
esplicare il proprio agire. Ebbene, questa esigenza è ricollegata al più ampio
imperativo che spinge l’uomo a comprendere sé stesso e a capire e prevedere le
sue maniere di agire. Questo input è, come può facilmente vedersi, una
sollecitazione di carattere prettamente filosofico, dato che costituisce un oggetto
di riflessione tipico della filosofia morale.
- I connotati di intrinseca instabilità e di persistente presenza di urti, opposizioni
che segnano lo svilupparsi di una cultura, aiutano a capire come mai abbiano
preso corpo due dottrine che offrono versioni fortemente contrastanti del
66
panorama di incroci e convivenze tra molteplici, differenziate culture note anche
come “multiculturalismo”. Ci riferiamo al Liberalismo ed al Comunitarismo. A
parere dei liberali l’appartenenza culturale è privata, essa cioè può essere frutto
di auto-attribuzione e non può influire sui diritti pubblici. In altre parole, la
diversità culturale (che nelle società multietniche si presenta sempre più come
un dato di fatto cui è vano, oltre che insensato, porre rimedio)58 non può
costituire un ostacolo alla partecipazione alla vita pubblica. Il diritto di
cittadinanza prescinde dall’identità culturale. Ma se dovesse emergere (come
ormai accade sempre più frequentemente nel panorama storico) il problema di
raffrontare quest’ultima con l’identità politica, secondo il comunitarismo il
liberalismo fallirebbe perché la neutralità dello Stato in merito alle concezioni
del Bene promosse dalle varie culture (tollerandole tutte) cozzerebbe con
l’esigenza delle culture minoritarie di ottenere non soltanto tutela e
riconoscimento pubblico, ma soprattutto valenza politica. Il comunitarismo
prende vita proprio dalla denuncia dell’insufficienza del parametro liberale che
si risolve nel preferire la società (intesa come raggruppamento costituito da
vincoli esterni e retto da un contratto stipulato per pura convenienza) alla
comunità. I membri di una comunità invece subordinano il senso di
appartenenza politica al riconoscimento della loro identità etnica e culturale. Da
questo punto di vista la sopravvivenza della cultura prevale sulla tutela dei
diritti individuali. Poiché soggetti dei diritti e della libertà non sono considerati
gli individui, ma i gruppi in cui sono inseriti per tradizione, l’essenza culturale
di una comunità risulterà violata se, anziché aver cura dei diritti del gruppo, si
terranno in considerazione prevalentemente i diritti civili individuali. Si tratta in
fondo di valutare se rispettare il “principio della dignità universale”, in virtù del
quale si ritengono gli uomini tutti uguali perché ci si basa su ciò che in essi
58
Ciò spiega ad esempio perché ad avviso di Dahrendorf è inutile ricercare comunanza
di contenuti ove si registrano differenze profonde (si pensi ai credi religiosi). Si può
soltanto elaborare un insieme di norme e strumenti atti a regolamentare e formalizzare i
conflitti ed i loro meccanismi di attivazione.
67
appare uguale, oppure il “principio delle differenze” (per il quale sono le
peculiarità a dover essere valorizzate). Il secondo principio corre il rischio di
degenerare in discriminazione, il primo – invece – nega le differenze
appiattendosi nell’omologazione ad una monocultura egemone (perpetrando
così una forma di discriminazione più sottile perché, sotto la presunta
uguaglianza, dà vita ad una società disumana, cieca rispetto alle diversità). La
purezza culturale diventa così un metavalore, a fronte del quale ogni scambio si
traduce in inquinamento, contagio culturale patologico da prevenire attraverso
adeguata profilassi politica. In conclusione, il comunitarismo acquisisce una
valenza ben determinata: sembra rispondere indirettamente alla sfida lanciata
dal liberale Dahrendorf, il quale invita provocatoriamente a trattare il tema del
multiculturalismo dal punto di vista di coloro che non si trasferiscono
volontariamente in un altro Stato, di quegli emigranti per necessità – cioè – che
non hanno nessuna intenzione di lasciarsi metabolizzare ed integrare in un’altra
cultura.
2. L’Interculturalità
Tra la chiusura vagheggiata dal comunitarismo e la marginalizzazione
svalutativa e riduzionistica predicata dal liberalismo, esiste una terza via. Essa
vorrebbe mediare le due precedenti, superandone i limiti in virtù della filosofia
che la ispira, votata a legittimare e promuovere lo scambio pubblico tra le
culture. Stiamo parlando di Pannikar (2006) che denomina la sua prospettiva
“interculturalità”, proprio per sottolineare la natura effettivamente transculturale
delle comunicazioni tra i gruppi umani e degli assetti che ne derivano nelle
società politiche multietniche che vanno prendendo sempre più spazio. Egli, che
si considera in un certo senso l’esempio vivente della percorribilità della sua
ipotesi teorica59, preferisce tale denominazione a quella di “multiculturalità”
59
Essendo filosofo e sacerdote (ragione e fede, tra l’altro, non sempre, né da tutti, sono
considerati ambiti della cultura suscettibili di dialogo) ispanico ma di origine indiana.
68
perché ritiene che quest’ultima faccia rima, anche concettuale, con
“metaculturalità”; il suo principale difetto consisterebbe, cioè, nel sembrare
condizionata da un’ottica che ne tradirebbe lo spirito di fondo: parrebbe far
emergere l’idea di una cultura superiore che con generosa benevolenza ammetta
al proprio interno il contributo delle altre. Obiettivo ideale sarebbe invece, ad
avviso dello Studioso, conseguire uno stato di “relatività culturale” equidistante
sia dall’assolutismo dominante dell’omologazione, sia dal relativismo
particolaristico. L’assunto del principio da lui sostenuto è la constatazione
realistica dell’impossibilità che ogni popolo prescinda dalle proprie categorie
culturali nell’articolare i criteri di valutazione delle altre culture. L’importante
però è che vi si ricorra con la netta consapevolezza di non pretendere di imporre
quelle categorie come se fossero le uniche esistenti o idonee ad essere
utilizzate60. Di fatto, la tesi di Pannikar è quella che si presta maggiormente ad
esplicitare l’ulteriore ruolo che la Filosofia potrebbe interpretare in questo gioco
intrecciato della comunicazione interculturale. Se è vero che Pannikar tende, per
ovvi motivi, ad esaltare il dato positivo ed ottimistico del dialogo tra le culture,
ossia la sua potenziale ricchezza e fattibilità, è altrettanto vero che ammette
quanto difficoltoso possa rivelarsi l’itinerario di attuazione di questo dialogo. Le
culture in questione dovrebbero infatti reciprocamente dichiararsi disposte a
persuadersi vicendevolmente ad accogliere e rielaborare principi, valori, norme
e caratteri estranei ai propri orizzonti tradizionali. Il che già pone un problema
sostanziale, sul quale a nostro avviso s’è indagato poco e che meriterebbe
60
Ciò consente all’Autore di assumere una posizione più decentrata, non
compiutamente coincidente con l’istanza universalistica cristiana tanto cara, ad es., a
Giovanni Paolo II. Base di questa visione classica del cattolicesimo è la
presupposizione dell’aprioristica unità del genere umano, fondata sulla comunanza di
un insieme di valori validi per tutti e acquisita come dato storico ed ontologico alla luce
del quale comprendere l’autentico e pieno senso delle differenze. Soltanto così può, per
la dottrina cattolica contemporanea, spiegarsi la possibilità di dar vita a documenti
miliari nella storia dell’etica che costituirebbero la trascrizione della grammatica
universale dei valori morali (si pensi alla Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo
1948).
69
maggiore attenzione, non foss’altro che per la sua propedeuticità –
metodologica – rispetto all’avvio di questo dialogo fruttifero tanto auspicato.
L’impostazione e la soluzione di tale problema, lo anticipiamo, spettano alla
Filosofia.
3. Retorica e interculturalismo: un’ipotesi di lavoro
Il problema è, innanzitutto, di metodo e, in quanto tale, preliminare. Dire che
culture differenti, nel rispetto della loro identità, possano e – meglio – debbano
vivere il dialogo in vista di un reciproco arricchimento e sviluppo, dato anche
dall’accoglimento e dal recepimento di elementi ed istanze appartenenti a civiltà
diverse, estranee, equivale ad inquadrare il fenomeno in un ambito
comunicativo specifico: quello retorico. Occorre cioè focalizzare il versante
della comunicazione direttamente coinvolto in questa delicata operazione
dialogica di confronto reciproco. Non si tratta di valutare quali possono essere
le condizioni generali (“trascendentali”, direbbe Apel) di un tipo di
comunicazione che voglia essere strutturata su codici semantici e regole
universali e, dunque, comprensibili da tutte le popolazioni e le comunità
culturali coinvolte. La delineazione delle norme che potrebbero regolare la vita
di questa ideale comunità strutturata su un modello di comunicazione universale
è già stata abbondantemente studiata ed articolata da filosofi quali Apel ed
Habermas. Quello che invece va fatto è un salto ad una dimensione più tecnica
del processo comunicativo, da analizzare con pari attenzione. Ci si dovrebbe
infatti chiedere quale modello di logica argomentativa dovrebbe essere attivato
(e concepito) per produrre quella persuasione utile, necessaria ad effettuare gli
scambi comunicativi tra culture diverse. In altre parole: culture che si
presentano a volte radicalmente eterogenee quali tipi di argomentazione, quali
regole e strategie persuasive devono mettere in campo per convincersi
dell’opportunità di acquisire e mutuare vicendevolmente una serie di elementi,
nozioni, usi, abitudini, comportamenti, principi dissimili tra loro? Se inseriamo
tale domanda all’interno della particolare questione, sollevata da Dahrendorf,
70
degli incontri tra comunità occidentali e comunità di migranti, le possibili
risposte sono tre: 1) la procedure e le tecniche argomentative tipiche del Paese
ospitante. In questo caso il prevalere del modello argomentativo della comunità
di accoglienza costituirebbe un ulteriore segno di quella posizione di forza
tipica dei rapporti coloniali; questa si risolve, infatti, in un dominio economico,
politico e sociale vincente proprio perché già preparato dalla imposta superiorità
dei percorsi e delle procedure argomentative con cui selezionare gli elementi
culturali da offrire e assimilare; 2) procedure e tecniche retoriche del Paese dell’
“ospite” (del migrante). Una sorta di galateo comunicativo con cui la comunità
ospitante dovrebbe accettare le regole della comunicazione persuasiva delle
comunità ospitate che, però, correrebbe il rischio di tradursi in una passività
culturale eccessiva, tanto marcata da presentarsi come la forma attenuata ed
edulcorata di una vera e propria invasione; 3) una via ibrida: esiste la possibilità
di strutturare un’unica logica argomentativa universale che tenga debitamente
conto di tutti gli spunti dei modelli di comunicazione argomentativa elaborati
dalle singole comunità culturali coinvolte? Oppure le modalità persuasive messe
in atto dalle varie civiltà sono talmente distinte da rendere impraticabile (e,
forse, neanche giusta) la creazione di tale paradigma argomentativo
transculturale? Può esistere, in definitiva, una sorta di metaretorica che nasca
dall’apporto paritetico delle retoriche concepite dalle comunità etniche e
culturali inserite nel multiforme crocevia geoculturale alla cui formazione
stiamo assistendo? Se sì, tale retorica “comparata” quali caratteri dovrebbe
possedere per esercitare la sua delicata e complessa funzione di ponte di
comunicazione tra le stesse? Storicamente si sono date occasioni d’incontro tra
tecniche retoriche, inventate da comunità politico-culturali differenti? La
retorica e l’oratoria romana, ad es., trova la sua genesi nell’assimilazione della
retorica greca, opportunamente emendata secondo la forma mentis romana, per
dare peso a quegli elementi più confacenti al costume culturale, filosofico e
71
politico della civiltà latina61. Ma si tratta, in ogni caso, di un transito consumato
all’interno di codici culturali omologhi, nati dalle categorie tipiche del pensiero
occidentale (Roma non ha una filosofia propria, ma – grazie anche all’opera di
traduttore filosofico attuata da Cicerone – recepisce e sviluppa ecletticamente le
dottrine filosofiche greche). Quella che, invece, andrebbe indagata è
l’eventualità di un incontro produttivo tra retorica occidentale, africana,
orientale (tanto per rimanere all’interno di quadri molto generali e, di necessità,
generici). Come si vede, tale questione è già, di per sé, “multiculturale”. Ossia,
inquadrare il problema del “interculturalismo”, riferendolo e riducendolo alla
fattibilità degli scambi culturali tra comunità diverse, comporta la propedeutica
definizione della possibilità di uno scambio tra culture diverse che deve
avvenire “a monte”: la messa in comune delle tecniche argomentative di ciascuna
di esse che, poi, permetterà la messa in comune degli elementi più peculiari e
preziosi dei loro patrimoni culturali. Ma questo è uno spunto di riflessione non
ancora adeguatamente approfondito, in quanto privo di riscontri in termini di studi
ad esso specificamente dedicati in letteratura. Si è sempre, infatti, dato per
scontato che le argomentazioni in base alle quali avviare i molteplici confronti
dialogici tra culture diverse debbano di fatto corrispondere al modello filosofico e
retorico occidentale.
4. Profilo retorico dell’Interculturalità
E così, in attesa di vagliare contributi in proposito, possiamo limitarci a
riconoscere che almeno un aspetto emerge chiaro ed evidente dalle
considerazioni fatte: uno dei tratti pregnanti dell’interculturalità si identifica
nell’essenza e nella natura retorica della sua attuazione. Non c’è interculturalità
61
Le parti del sistema retorico greco (heuresis, taxis, lexis, hypocrisis) vengono
recuperate dalla tradizione romana (inventio, dispositio, elocutio, actio), la quale si
limita a dare maggiore spessore all’actio (rispetto alla considerazione di cui godeva la
performance recitativa dell’oratore nella tecnica retorica greca) e ad inserire, in più, la
72
che si possa realizzare senza attuare processi di reciproca persuasione, tra le
culture coinvolte, che vanno opportunamente definiti e studiati. Rimaniamo,
dunque, all’interno dell’impostazione classica sopra delineata; essa vede, come
detto, nel paradigma occidentale l’unico sino ad ora implicato in tali operazioni
comunicative interculturali. Anche qui emerge però una lacuna: non esistono
studi che facciano luce in modo mirato sul perché, per quali profili ed aspetti, la
questione multiculturale sia, appunto, una questione prima di tutto retorica. A
questa analisi daremo adesso spazio. L’interculturalità si fonda innanzitutto
sulla consensualità vissuta come tratto fondamentale del raggiungimento di un
equilibrio tra rispetto delle differenze e progressiva unificazione (equilibrio
connesso strutturalmente all’attuale, ineludibile processo di globalizzazione).
Ciò comporta un propedeutico cambiamento di atteggiamento, ossia il
conseguimento di una delle tipiche forme definitorie della “persuasione”.
L’attento perseguimento del consenso attraverso il processo persuasivo viene
infatti considerato come fondamento della convivenza civile tra istanze culturali
diversificate. Per assicurarlo occorre naturalmente muoversi entro coordinate
operative di assoluta imparzialità, in quanto tese a salvaguardare le differenze di
volta in volta registrate. Tale imparzialità non va però confusa con la
“neutralità” nei confronti delle più rilevanti concezioni etico-religiose (quelle,
ad es., vertenti sul Bene) tipica della tolleranza laica di matrice liberale checome abbiamo già avuto modo di dire – relega quel tipo di convinzioni alla
sfera del privato. Parimenti distante da un assetto dialogico improntato alla
prassi del consenso si presenta – ovviamente – il Comunitarismo, secondo il
quale se è vero che bisogna dotarsi di un sistema di regole tese a garantire
coesione all’interno della singola comunità mercè il drastico ridimensionamento
del dissenso (perché soltanto così è possibile garantire la sopravvivenza
culturale di un gruppo), è pur vero che non è ritenuto necessario valorizzare –
memoria (una sorta di catalogo delle nozioni che vanno ricordate per eseguire con
successo l’atto retorico) che mancava nella partizione greca.
73
in misura direttamente proporzionale – il consenso a livello della comunità
generale (sintesi, o meglio somma, delle singole comunità che si trovano a
comporla). Per il Comunitarismo, infatti, le finalità collettive ed i
comportamenti privati dei membri di una comunità vanno imposti,
conformandoli ai modi di vita dominanti che costituiscono lo spazio pubblico.
A parere di Rawls , invece, la Ragione Pubblica costituisce l’ambito di
discussione ottimale per la realizzazione del consenso62 soprattutto quando si
mira alla sua forma più estrema, ossia l’unanimità, e non si pone invece come
un elenco di precetti cui doversi uniformare nell’elaborare le proprie credenze
ed attivare i propri atti sociali e individuali. Ancora più distante la teoria di
Habermas secondo la quale le eredità culturali dovrebbero invece poter essere
acquisite mantenendo una piena libertà di consenso e, soprattutto, dissenso.
Ebbene, l’idea che occorra un forum pubblico entro cui sperimentare
ragionevolmente il confronto multiculturale impone allora una sfida essenziale:
giungere a concezioni che comportino adesioni forti (in quanto strettamente
legate alla persona ed alla dimensione più profonda del suo bagaglio culturale:
quella etico-religiosa) senza dividere, ma unificando più prospettive,
accogliendo quelle altrui senza però tradire le proprie – percepite normalmente
come le più vere - , ma mostrando anzi la possibilità di una ricerca concepita
come cooperazione in virtù della quale poter aver ragione insieme agli altri e
non “contro” qualcuno. Quest’idea riconduce alla dialogicità interculturale
vagheggiata da Pannikar e si fonda su una concezione dell’argomentazione
razionale tesa ad armonizzare i bisogni degli individui e delle comunità
specifiche tra loro, ponendosi come elemento istitutivo di una comunità
eponima (“argomentativa” per l’appunto) dalla quale saranno di fatto esclusi
coloro che non sono in grado di comunicare argomentativamente perché
sprovvisti di tale capacità all’interno dei loro orizzonti culturali tradizionali.
62
L’estensione del quale, è bene precisarlo, allo Studioso non interessa qualora esso
dovesse riguardare concezioni comprensive del Bene.
74
Questa comunità presenterà alcuni caratteri, o “postulati”, che sono vere e
proprie regole universali e necessarie alla modulazione dell’agire comunicativo
finalizzato all’intesa ed al consenso, ossia veicolato da quella che per Habermas
rappresenta la situazione discorsiva ideale. In essa l’argomentare esclude il
ricorso a strategie spregiudicate, articolandosi unicamente sulle norme cui prima
accennavamo: condizioni trascendentali ed a priori della comunicazione
effettuata in quel tipo di comunità. Quali sono queste regole? A quale agorà
daranno vita? Va premesso e ribadito ancora una volta che l’autentico consenso
dovrebbe concernere le procedure argomentative, gli strumenti per praticare
quel dialogo tanto auspicato tra chi parte da presupposti culturali differenti,
nonché il linguaggio stesso da adoperare per giustificare argomentativamente
l’estensione universale di valori etici che trovano invece la loro genesi in
contesti più specifici. Giocoforza, ci affidiamo per adesso all’unico modello di
argomentazione disponibile ed apprezzato: quello occidentale. Le sue regole si
costituiscono come momenti di sviluppo degli elementi che Aristotele ha
individuato come essenziali all’articolazione dell’atto retorico. La Retorica
aristotelica ha infatti poi esplicitamente influenzato tutti i tentativi fatti in sede
filosofica, linguistica e psicologica di definire – anche formalmente – i tratti
dell’argomentazione (si pensi a Perelman e Olbrecht-Tyteca con il Trattato
sull’argomentazione).
4.1 Etica nell’argomentare
Aristotele, primo teorizzatore in sede filosofica di una tecnica retorica (volta a
scoprire ciò che può essere persuasivo in ogni tema trattato), immerge
nell’eticità l’intero processo argomentativo-persuasivo, dato che i soggetti su
cui si polarizza quest’ultimo sono investiti, a vario titolo, di funzioni che
presentano aspetti di rilevanza morale. Egli sostiene, infatti, che l’atto retorico
più efficace si costituisce su tre prove tecniche, ossia escogitate direttamente dal
retore: la prova emotiva (finalizzata ad indurre nell’ascoltatore lo stato emotivo
più adatto al conseguimento della persuasione), la prova etica e quella
75
dimostrativa. Le ultime due, peraltro strettamente connesse tra loro, sono quelle
che ci riguardano da vicino. Con la prova etica il retore, attraverso il discorso
offerto all’uditorio, vuole apparire a chi lo ascolta saggio, benevolente, virtuoso
(qualità, lo sottolineamo fin d’ora, che denotano una certa dimestichezza con la
verità da parte di chi le possiede)63. Il campo etico, però, si estende sino a
comprendere anche il destinatario dell’argomentazione etico-retorica: l’intero
ragionamento retorico (quello che Aristotele definisce sillogismo entimematico)
è mirato ad attivare nell’uditorio l’articolazione di un giudizio che si estrinseca
in una scelta, una deliberazione64, cioè un ragionamento che rientra nell’area
della pratica ed il cui studio è di pertinenza della filosofia morale. Ora, ogni
tradizione culturale (e le forme di vita che le animano) si riproduce sul
presupposto di poter convincere soggetti caratterizzati da personalità
profondamente influenzabili ai fini dell’assimilazione culturale. Il che non
riguarda soltanto il transito intergenerazionale, ma concerne anche – e
soprattutto – ruoli e comportamenti di coloro i quali sono portatori di tradizioni
culturali differenti da quelle con cui vengono a contatto. Derrida ha giustamente
sottolineato come in una società multiculturale gli interlocutori dialoganti
assumono la veste di “stranieri morali”. Modello della figura di “straniero”
(xenos), ad avviso del Filosofo francese, è quella tratteggiata da Platone nel
Sofista: esso pone domande che rimettono continuamente in discussione
l’autorità del logos paterno, del padrone di casa, senza perciò risultare parricida
(in quanto non facente parte della famiglia ospitante). Lo straniero, nomade
perenne che vive in una condizione di strutturale spaesamento che alimenta il
sentimento di nostalgia verso l’ ethos rappresentato dalla lingua materna, deve
cimentarsi con valori morali (amicizia, ospitalità, pace, rispetto) che
63
Per essere ancora più precisi, ciò che conferisce spessore etico all’argomentare del
retore è la trasparenza delle sue intenzioni resa possibile dall’inserimento,
nell’argomentazione stessa, di una serie di massime e proverbi. Cfr. Retorica 1356 a 2
e 13, 1366 a 10-11, 1378 a 8, 1395 b 13-18.
76
costituiscono modalità di indirizzarsi all’ “altro” di natura strutturalmente
linguistica65. In ottica multiculturalista su tali valori66 vi può essere accordo
consensuale anche senza condivisione pienamente sentita. Tale prospettiva
definisce dunque una tipologia di ragionamento pratico che possa esprimere i
molteplici rapporti tra concezioni politico-morali diversificate per arrivare ad
un’accettabile compenetrazione di orizzonti. Così, come peraltro auspicato da
Amartya Sen, la diversità verrà celebrata come atto di scelta frutto di un libero
ragionamento (ed, in quanto tale, più apprezzabile). Ragionamento nel quale,
com’è evidente, deve essere riservato all’uditore/interlocutore un posto da coprotagonista. L’atto retorico/etico implica difatti un elevato grado di
coinvolgimento (involvement, secondo la psicologia sociale) dell’ascoltatore
dettato appunto dallo spazio primario concesso nella discussione ai suoi valori
ed interessi (sintetizzati negli endoxa e nei topoi67 ). La vera natura dell’atto
retorico, come ben messo in luce da Meyer, si rivela allora essere la
“negoziazione” che riduce le distanze tra il retore ed il pubblico attraverso un
ciclico proporsi e riproporsi di domande e risposte tra i due soggetti. Chi
argomenta ha bisogno di un interlocutore e, al di là dell’ovvia considerazione
sulla socialità di ogni atto comunicativo, ciò è confermato dallo sforzo da lui
profuso nel convincerlo. Ciò rende l’atto intrinsecamente dialogico, in quanto la
produzione del discorso che lo innerva richiede la corresponsabilità di chi parla
64
Cfr. Retorica 1357 a 1-2, 1377 b 20-21, 1391 b 18-20, 1403 b 8-10. Si veda anche
Etica Nicomachea 1113 a 4 e 11.
65
J. Derrida, (1997:118): “in senso lato la lingua, quella con cui ci rivolgiamo allo
straniero o lo udiamo, se lo udiamo, è l’insieme della cultura, sono i valori, le norme, i
significati che abitano la lingua. Parlare la stessa lingua non è soltanto un’operazione
linguistica. Coinvolge l’ ethos in generale.”
66
L’analogo di tali valori, nella Retorica aristotelica, è identificabile negli endoxa:
opinioni notevoli, in quanto diffuse nella maggioranza della popolazione o, comunque,
nella parte più qualificata di essa. Esse costituiscono spesso le premesse del sillogismo
retorico. Aristotele però ne esige la condivisione completa, pena l’esclusione dalla
comunità di riferimento e l’assoluta inutilità e nullità persuasiva dell’atto retorico che
ne dovesse essere sprovvisto.
67
Schemi argomentativi tra i più validi ed efficaci in quanto maggiormente diffusi.
77
e di colui che ascolta; tanto più marcata essa sarà, quanto più quest’ultimo
risulterà complice attivo del gioco linguistico argomentativo in virtù della sua
inclusione in esso grazie all’implicito accordo con il retore sulle premesse del
ragionamento che gli è indirizzato. Ecco perché, tornando a Pannikar, la
comunicazione interculturale per eccellenza è dialogale e non dialettica. La
dialetticità comporta la realizzazione di due logoi razionali in competizione tra
loro ed una “ragione” che funge da arbitro per stabilire quale sarà il discorso
vincente. La dialogicità, invece, lascia spazio ad un ascolto ed una
comprensione del “prossimo” tutt’altro che scontata o banale; non assolutizza le
proprie convinzioni perché, più che convincere, richiede un impegno reciproco
alla ricerca comune (anche a costo di mutare convinzioni radicate da tempo)
fondata su una forte affinità affettiva.
Appendice: verità, etica e argomentazione
L’idea che l’argomentazione debba avere una sostanza etica è stata recepita e
sviluppata da tutti i modelli contemporanei di tecnica argomentativa. Uno dei
postulati essenziali della comunità argomentativa vagheggiata da Apel è che i
membri che la compongono siano considerati “enti morali”, vincolati a
riconoscersi reciprocamente come titolari di pari diritti a prescindere dalle
differenze culturali, religiose, etniche e linguistiche. La soluzione dei problemi
che si presentano nelle comunità socio-politiche richiede infatti solidarietà e
cooperazione tra i loro membri che, oltre ad esserne protagonisti, diventano
corresponsabili dell’efficienza della società argomentativa virtuale nata per
affrontare quei problemi. Tale parità di diritti si traduce innanzitutto
nell’attribuzione a ciascuno dei partners della possibilità di impiegare discorsi
utili alla formulazioni di pretese di verità in grado di ottenere effettivo
consenso. Proprio questo è il criterio di base di articolazione dei postulati di
Apel: per rivendicare la legittima appartenenza alle relazioni degli scambi
argomentativi coloro che – appunto – argomentano, devono impegnarsi ad
evitare di offrire menzogne e falsità, devono mostrarsi disponibili ad accogliere
78
opinioni altrui qualora fossero ritenute vere, devono sottomettersi in genere ai
principi di perspicuità, trasparenza, verità e veridicità ereditati direttamente
dalla tradizione retorica aristotelica. Secondo lo Stagirita, infatti, la retorica non
è per niente esclusa dal rapporto con la verità, tutt’altro68. Semmai occorre
precisare a quale particolare tipo di verità essa si rapporta. Se esaminiamo il
ragionamento retorico, l’entimema, noteremo che esso si erige diffusamente su
eikota, ossia assunti/premesse verosimili. Ebbene, tali premesse condividono un
tratto essenziale con la tipologia di ragionamento pratico cui devono dar luogo
nel giudice-ascoltatore (cioè la deliberazione): esse hanno a che fare con ciò che
è per lo più, può in sostanza essere o non essere (o comunque essere altrimenti
da com’è). Ciò ha causato un equivoco di fondo: s’è sempre letta la logica della
retorica come una logica di serie B, che può al massimo aspirare ad un grado
inferiore di verità rispetto a quella scientifica, e ad una forma d’argomentazione
non strettamente, né rigorosamente dimostrativa (Perelman, non a caso, la
definiva una “quasi logica”) e, dunque, non razionale. Ma la retorica, lungi
dall’essere irrazionale, offre invece l’unico paradigma di razionalità adattabile
all’ambito operativo che le è proprio: quello delle azioni e dei valori. In
quest’area specifica c’è spazio unicamente per ciò che è di per sé, per sua natura
ontologica, verosimile, probabile, discutibile grazie al ricorso ad un insieme di
argomenti la cui validità e correttezza non può essere riconducibile alla
conformità a schemi prestabiliti che ne assicurino semplicemente la coerenza
con la verità degli assiomi. Ciò, ovviamente, non esclude affatto che
l’argomentazione retorica abbia carattere dimostrativo, apodittico. Anzi, come
abbiamo già scritto, la terza prova tecnica è detta anche “logica” perché si
concretizza nel fornire argomenti di per sé dotati di una certa evidenza e forza
dimostrativa. Ora, Searle ha in certo qual modo scardinato l’interconnessione tra
etica e verità che invece la retorica ha contribuito ad affermare; la Tradizione
68
Cfr. Retorica 1355 a 5-6, 16-18, 20-21, 38-39, 1357 a - b1, 1402 b 36-39, 1404 a
6, 1414 a 33-37, 1417 b 21.
79
Razionalista Occidentale, a Suo avviso, deve basarsi sul principio che la pretesa
alla verità debba essere indipendente dall’ethos di chi la propone (a sua volta
condizionato dall’etnia cui appartiene e dai pregiudizi culturali che lo
contrassegnerebbero)69. Tale concezione comporta che la giustificazione di
proposizioni cui ascrivere valore di verità possa risultare convincente per tutti i
soggetti inclusi nell’atto argomentativo. Ma questo asserto costituisce proprio il
punto debole dell’impostazione searleiana: è difficile incontrare verità valide da
tutti i punti di vista, che permettano – perciò – di bollare come “irrazionali”
coloro che dovessero rifiutarle. Infatti ogni pretesa alla verità avanzata deve
poter essere rettificabile e correggibile con l’accoglimento dei contributi altrui
più pertinenti alle nostre posizioni. Questa flessibilità, o permeabilità, non
esclude certo l’eventualità di continuare a coltivare certezze (più che verità)
assolute; anzi, spesso tale sicurezza rende praticabile il confronto dialogico
perché ci spinge ad affrontare le divergenze con la convinta fiducia di volgerle a
nostro favore.
Davide Fricano
Davide Fricano è nato a Palermo nel 1971.
Docente ordinario in Storia e Filosofia, è Dottore di ricerca in Filosofia del Linguaggio.
Collaboratore della redazione palermitana di “Aggiornamenti sociali”.
69
Per cui nella comunità fondata sulla Tradizione Razionalista Occidentale va abolito il
cosiddetto argumentum ad hominem, per il quale va ritenuto vera e credibile
un’argomentazione prioritariamente sulla base dell’affidabilità di chi la propone (e
viceversa: va rifiutata in quanto proferita da qualcuno reputato non credibile di per sé, o
incoerente rispetto al suo contenuto).
80
BIBLIOGRAFIA
Amartya Sen (2003), Identità e violenza, Laterza, Roma-Bari
Aristotele (2204), Retorica e Poetica, a cura di M.Zanatta, Utet, Torino
Bauman Z. (2003), Intervista sull’identità, Laterza, Roma-Bari
Cicerone (2006), De Oratore, a cura di E.Narducci, BUR, Milano
Cultrera F. – Pariotti E. – Schiavello A. – Viola F. (2001), Etica pubblica e
pluralismo, Edizioni Messaggero, Padova
Dahrendorf R. (1996), Diari europei, Laterza, Roma-Bari
Derrida J. (1997), Sull’ospitalità, Baldini&Castaldi, Milano
Foucault M. (1981), La prosa di Atteone, saggio sulle leggi dell’ospitalità
inserito come commento-appendice di Klossowski P., Roberta stasera, Sugarco,
Milano
Giddens A. (2000), Il mondo che cambia, Il Mulino, Bologna
Huntington S. (2001), Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale,
Garzanti, Milano
Kapuscinski R. (2007), L’altro, Feltrinelli, Milano
Kluckhon C. (1979), Lo specchio dell’uomo, Garzanti, Milano
Icona A.(2005), L’argomentazione, Einaudi, Torino
Latouche S. (2002), La fine del sogno occidentale, Eleuthera, Milano
Maalouf A. (2005), L’identità, Bompiani, Milano
Pannikar R. (2006), Pace ed interculturalità, Jaka Book, Milano
Piazza F. (2004), Linguaggio Persuasione e Verità, Carocci, Roma
Searle J. (2008), Occidente e Multiculturalismo, LUISS University Press – Il
Sole 24 ore
Taylor C. (1993), Multiculturalismo. La politica delle differenze, Anabasi,
Milano
Touraine A.(1997), Eguaglianza e diversità. I nuovi compiti della democrazia,
Laterza, Roma-Bari
81
7RQLQR1HJUL6FXOWXUDFHUDPLFD´$UWHLQ*LDUGLQRµ,VRODG·(OED
L’Architettura come luogo dell’”Apertura”
Sul ruolo di Spazio e Luogo nella città contemporanea
Non si vive in uno spazio neutro e bianco;
non si vive, non si muore, non si ama
nel rettangolo di un foglio di carta.
M. Foucault
di Giovanni Mensi
Bruno Zevi, già nel 1948, notava un fatto interessante: spesso nelle
illustrazioni fotografiche dei libri di architettura non compaiono figure
umane, se non (sfuggite all’attenzione del fotografo) come presenza
indesiderata. Trovo sia un atteggiamento comune, soprattutto tra gli architetti:
si vuole catturare un’immagine il più possibile estatica; un’immagine, cioè, che
sia “fuori dal corpo della vita”, quasi assoluta, un’astrazione dell’architettura.70
Spesso rappresentiamo e pensiamo l’architettura come un’immagine astratta,
come vivesse di per sé; anzi: come se non-vivesse. Invece che mettere in
evidenza il carattere fondamentale dell’architettura (e cioè l’abitare,
l’uomo), la si snatura, tentando ossessivamente e incomprensibilmente di
avvicinarla alla pittura, alla scultura, al cinema e alle arti visive in genere.71
70
Naturalmente la tecnologia, soprattutto quella relativa ai programmi di disegno 2D e
soprattutto 3D, amplifica enormemente la tendenza all’astrazione in fase di
progettazione e di comunicazione al pubblico. Paradigmatico, in questo senso, è lo
“spazio assoluto” che ogni schermata iniziale di default dei più diffusi programmi di
modellazione 3D presenta all’utente come tabula rasa (si noti che il termine “default”,
in informatica, sta ad indicare lo stato di un sistema in assenza di interventi); molti
architetti hanno sviluppato un linguaggio di comunicazione progettuale asettico ed
astratto che ne imita l’assolutizzazione. Il risultato è costituito da rappresentazioni in cui
la pulizia geometrica dei volumi si spinge pericolosamente nel campo della pittura
astratta. Si vedano, ad esempio, alcune presentazioni (render e disegni) dei lavori dello
studio Hadid; tra le altre, in particolare: Zollhof Media Park (Dusseldorf, 1989-1993),
Global Cities at the Tate Modern (Londra, 2007), Grand Building, Trafalgar Square
(Londra, 1985), One North Masterplan (Singapore, 2001-2021), Bahrain International
Circuit (Sakhir, 2007).
71
Il lavoro dell’architetto, in modo particolare oggigiorno, si dispiega in un mondo di
“giustapposizione degli spazi”, proprio come succede nel cinema e nelle arti visive: dal
mondo “3D” dell’immaginazione, a quello 2D del foglio di carta (o del foglio
83
Ci sono diversi motivi per cui si vuol fotografare o ritrarre un’architettura
vuota; ergo: ci sono diversi motivi per cui si vuol guardare allo spazio in
senso newtoniano, come ad un piano astratto in cui l’architettura “domina”
sul nulla. Va detto che nell’”architettura desertificata”, quella spogliata della
vita, si cela un “ospite inquietante”, per dirla con Galimberti: vi si nasconde
l’astrazione. L’astrazione non è di per sé un concetto negativo (molte
discipline ci hanno abituato alla concettualizzazione con scopi e risultati più
che nobili). È pericoloso per l’architettura. È pericoloso perché
l’architettura, come ha detto Espuelas, è l’arte del fattuale;72 è un’arte che ha
a che fare con lo spazio tanto quanto col tempo e col divenire. Qui
l’astrazione apre un processo che toglie attenzione alle cose del luogo per
portarle nello spazio assoluto dove le cose vivono di sé; come in quel “teatro
dell’assenza” che è il Padiglione (d’esposizione) dove, scrive Tafuri,
“l’uomo, spettatore di uno spettacolo veramente totale perché inesistente, è
obbligato ad una pantomima che riproduce il vagare nel labirinto urbano di
esseri-segni fra segni privi di senso, da lui quotidianamente esperito”.73 Nel
Padiglione tempo e movimento compenetrano lo spazio (ecco lo spaziotempo), ma la loro unione si dispiega nella desertica dimensione di un
mondo che non esiste. Come dire: il modello e l’ideale sono principi
generatori di possibilità, non sono architettura. Gropius, in conclusione al
suo Per un’architettura totale, scriveva: “Abbiamo incominciato a intendere
che modellare il nostro ambiente fisico non significa applicarvi uno schema
formale fisso, ma richiede piuttosto un incessante sviluppo interiore, una
convinzione che va continuamente ricreando la verità al servizio
dell’uomo”.74 Dal momento che l’architettura è il prodotto di una
prefigurazione di possibilità, non è “architettura” nemmeno lo stato di fatto
elettronico CAD), a quello di nuovo 3D della fase di rendering (ormai imprescindibile
nel processo di progettazione). A questo si aggiunga quella dimensione a metà tra il 2D
e il 3D qual è l’assonometria. È chiaro che una tale giustapposizione di spazi di lavoro e
di studio debba trovare una propria gerarchia interna, un proprio ordine. Io credo che
l’origine di buona parte della confusione disciplinare che investe l’architettura
contemporanea vada ricercata nell’incapacità di mettere ordine all’interno di questa
“giustapposizione di spazi”.
72
Si veda Espuelas, F., Il vuoto - Riflessioni sullo spazio in architettura, Christian
Marinotti Edizioni, Milano, 2009.
73
Tafuri, M., La sfera e il labirinto, Einaudi Editore, Torino, 1980, p.135. Il corsivo è
mio.
74
Gropius, W., Per un’architettura totale, Edizioni Abscondita, Milano, 2007, p.180.
84
così come ci si presenta. Modelli e preesistenze, allora, creano architettura
se interpretati criticamente e trasformati in progetto.75 Ne sono un chiaro
esempio le opere di Ungers e di Kahn: per entrambi (in modo diverso e
nonostante le accuse d’eccessivo concettualismo) l’astrazione delle forme
non procede di per sé, ma prevede sempre, ad un certo punto del processo
progettuale, quel travaso nella “Lebenswelt” che le dà motivo d’essere;
l’astrazione, per avere senso come strumento di analisi e di ricerca, deve
sempre trovare un’applicazione. Spesso, in varie discipline, l’astrazione è
stata concepita come dimensione di verità.76 A mio parere esistono verità
specifiche all’interno di una complessità data; ma tali verità portano con sé
una sola verità, lo scopo essenziale che sta al fondamento dell’architettura:
l’abitare. Esiste una verità “assoluta” per l’architettura (l’abitare) ed esistono
verità specifiche (legate al contingente) che portano con sé quella assoluta e
la mettono in pratica, relazionandola all’esistente; quindi: portano alla
presenza l’abitare, dandogli forma. L’architettura, allora, deve aprirsi ad una
doppia dimensione: è un sistema abitativo che per prodursi necessita, in fase di
progetto, sia dell’atto dell’astrazione che di quello della percezione;77 trae
origine cioè dall’unione degli elementi paradigmatici della disciplina (che
sono uno strumento) con una situazione specifica (la realtà, che dà forma a
quegli elementi). In altri termini, trae origine dalla trasformazione di una
porzione di spazio in luogo.78
75
In questo senso, nel panorama della critica e della pratica architettoniche italiane, è
fondamentale la figura di Ernesto Nathan Rogers: attento all’importanza della
continuità storica e delle preesistenze (particolarmente influenzato dalla figura e dal
pensiero di Enzo Paci) Rogers concepiva l’architettura come “sinonimo di vita (…):
realizzare un’architettura è ‘presentificare’ il passato e ‘infuturare’ il presente”.
Citazione tratta da Architettura assurda, articolo apparso su “Casabella-continuità”,
n.257, novembre 1961.
76
Tra gli altri Canguilhem, già nel ’43 (nel suo Il normale e il patologico), mette in
discussione l’astrazione dei concetti di “media” e di “normalità” in campo medico: non
terrebbero in debita considerazione la variabile particolare e soggettiva del vivente,
direttamente relazionata all’ambiente in cui vive.
77
Come sottolinea Augé, Merleau-Ponty, nella sua Fenomenologia della percezione,
“distingue uno spazio ‘geometrico’ da uno spazio ‘antropologico’ inteso come spazio
‘esistenziale’, luogo di una esperienza di relazione con il mondo da parte di un essere
essenzialmente situato ‘in rapporto ad un ambiente’”. Citazione tratta da Augé, M.,
NonLuoghi - Introduzione a una antropologia della surmodernità, Elèuthera Editrice,
2005, Milano, p.75.
78
Norberg-Schulz ha scritto: “Il luogo rappresenta quella parte di verità che appartiene
all’architettura: esso è la manifestazione concreta dell’abitare dell’uomo, la cui identità
85
É un punto delicatissimo. Spazio. Luogo. Qualche puntualizzazione al
riguardo. Io credo che lo spazio sia sinteticamente rappresentato o da un
tutto-pieno, o da un tutto-vuoto. Il miglior modo di guardare allo spazio, in
architettura, sta nel considerarlo come estensione illimitata che accoglie la
materia informe (non in-formata, cioè, da un’utilità); come ricettacolo, come
“Madre”, per dirla con Platone.79 Tuttavia l’uomo, per portare lo spazio a sé
e renderlo adatto all’abitare, deve possederlo ed occuparlo; per farlo deve
mettere mano alla materia già da sempre data e darle forma di architettura
(come ha detto Jean Nouvel, il lavoro dell’architetto si basa sul ritrattamento della materia). L’uomo deve porre nello spazio una cosa sua,
stabilendo così la presenza di un luogo.80 L’azione dell’uomo, quindi, è
determinante. In questo processo, l’architettura, in quanto cosa dell’uomo,81
non viene alla presenza per sé (ab-stracta dal mondo della vita), ma come
mezzo per stare nel mondo, per abitarlo. Lo dice chiaramente Heidegger:
“Solo se abbiamo la capacità di abitare, possiamo costruire”;82 occorre
“anzitutto imparare ad abitare”.83 Nel celebre esempio del “Ponte”, il
filosofo tedesco intende chiarire gli effetti del costruire sull’ambiente
circostante, cioè sullo spazio indifferenziato. Col costruire, l’uomo riunisce
le cose e le riconosce come parte del suo ambiente. L’architettura, quindi,
dipende dall’appartenenza ai luoghi”. Citazione tratta da Norberg-Schulz, C., Genius
Loci - Paesaggio Ambiente Architettura, Electa Editore, Milano, 2009, p. 6.
79
Sulle diverse letture dei concetti di spazio e di luogo si veda il IV capitolo Riflessioni sul
luogo dello scritto di Giovanni Piana La notte dei lampi - Quattro saggi sulla filosofia
dell’immaginazione, Editore Guerini e Associati, Milano, 1988.
80
A questo proposito sarebbe utile prendere in considerazione i due concetti su cui
Norberg-Schulz ha basato le proprie riflessioni in campo architettonico: il concetto di
“spazio esistenziale” e di “genius-loci”, trattati rispettivamente in Esistenza, spazio,
architettura (1971) e in Genius Loci - Paesaggio, ambiente , architettura (il cui
sottotitolo originale recita: Towards a phenomenology of architecture, 1979). Con
l’espressione “spazio esistenziale” l’autore intende fare riferimento alla relazione tra
“spazio” e “carattere” (tra orientamento e identificazione). Dal momento che NorbergSchulz ritiene che il luogo sia uno spazio dotato di un carattere distintivo, ritengo
plausibile tradurre il concetto di “spazio esistenziale” con luogo (come lo intendo io
qui). Col concetto di “genius loci” (spirito del luogo), invece, l’autore intende mettere
in evidenza che “l’identità dell’uomo presuppone l’identità del luogo” (Norberg-Schulz,
op.cit., p.22). Lo spirito del luogo dev’essere parte integrante del progetto di
architettura.
81
“L’architettura é ciò che la natura non può fare” (Louis Kahn).
82
Heidegger, M., Costruire abitare pensare, in Saggi e discorsi, Milano, Mursia
Editore, 2006, p.107.
83
Ivi, p.108.
86
(in quanto prodotto del costruire) produce un luogo (che, a differenza dello
spazio, è determinato dalla relazione tra pieni e vuoti). Il luogo deve la sua
presenza all’architettura stessa: il luogo non c’è prima dell’architettura.
Ecco perché luogo ed architettura sono inscindibili (quando sono scissi si
parla di non-luogo).84 Il luogo limita le cose dell’uomo entro un sistema di
relazioni; é un sistema di relazioni: è, allo stesso tempo, il confine ed il
vuoto entro cui si dispiega un sistema di relazioni. Come direbbe Aristotele,
in questo senso, il luogo è statico: il movimento (la relazione) avviene al suo
interno. Quando Le Corbusier si trova alle prese con uno stato di fatto, tanto
stimolante quanto disorientante, come quello di Chandigarh (in cui la tabula
rasa dello spazio illimitato giocava a cavallo tra le infinite possibilità e
nessuna), pronuncia una frase decisiva: “Era opportunità di occupare uno
spazio”.85 Vale a dire: di trasformare quella porzione di spazio in un luogo
attraverso l’atto dell’occupare. “Occupare” significa prendere possesso (per
primi): rendere propria una porzione di spazio ed insediarvi un luogo.
Parafrasando Einstein, in Le Corbusier, l’essenziale non sono le cose
dell’uomo (le architetture), ma lo spazio tra loro interposto.86 Lo spazio, in
questo senso, permane nel mondo dell’uomo, ma non come entità astratta: lo
spazio esiste come misura della distanza tra i luoghi. Quindi: essenziale non è
l’oggetto architettonico, ma il sistema di relazioni che produce con l’intorno.
Ecco allora che l’architettura non ha a che fare soltanto con lo spazio assoluto
(la Madre), ma anche e soprattutto con lo spazio umano in rapporto dialettico
col luogo; questo spazio “umano” è una porzione di spazio assoluto che trova
accoglienza nel luogo come misura della distanza tra i luoghi.
All’interno del concetto di luogo inteso come sistema di relazioni, però, si
agitano alcune differenze che reclamano una propria specifica
determinazione. Tali differenze sono frutto della sempre più crescente
84
Secondo Marc Augé, “se un luogo può definirsi come identitario, relazionale, storico,
uno spazio che non può definirsi né identitario né relazionale né storico, definirà un nonluogo”. Citazione tratta da Augé, M., op.cit., p.73.
85
Citazione tratta da Constant, C., From the Virgilian dream to Chandigarh: Le
Corbusier and the modern landscape, in AA..VV., Denatured Visions, The Museum of
Modern Art, New York, 1991, p.87.
86
“Occorreva una potente immaginazione scientifica per discernere che nella
descrizione dei fenomeni elettrici non sono né le cariche, né le particelle che
costituiscono l’essenziale, bensì lo spazio interposto tra cariche e particelle”. Citazione
tratta da Einstein, A., Infeld, L., L’evoluzione della fisica, Universale scientifica
Boringhieri, Torino, 1985, p.255.
87
complessità del reale cui è soggetta la città negli ultimi secoli (e, in
particolar modo, negli ultimi decenni). Michel Foucault ha parlato di una
particolare tipologia di luogo, l’”eterotopia”. L’eterotopia riassume i vari tipi
di luogo che presentano determinate caratteristiche tali da renderli
“assolutamente differenti”87 dagli altri luoghi (cioè, da quelli che
rappresentano un sistema di relazione). Si tratta di luoghi estranei al sistema
di relazioni instaurato dall’architettura. Il loro essere “assolutamente altro”,
infatti, li pone ai margini della città, fuori dalla città, al suo limite (sia in
senso metaforico che, spesso, fisico). Il luogo-altro è il luogo
dell’architettura-altra che sta fuori dal sistema di relazioni; quindi: è uno
spazio umano fuori dal luogo, emarginato. In questi particolari spazi umani
l’uomo instaura, con lo spazio e con il tempo, un rapporto innaturale: in
questi luoghi l’uomo si chiama fuori dal tempo storico e fuori dallo spazio
della città (si astrae dal sistema di relazioni) per immergersi all’interno di un
sistema di negazione e di esclusione, un frammento urbano separato, isolato
ed indipendente dal resto. Un “luogo” che manca di identità (un luogo che è
qui nello stesso modo con cui potrebbe essere altrove) non è un luogo, è un
frammento di spazio adibito ad una funzione che esula dall’abitare. Il nonluogo per eccellenza è sempre un’astrazione del luogo (un luogo-comune),88
un ritorno al modello funzionale calato (e non insediato!) all’interno dello
spazio umano. In questo senso Augé ci fa notare che “la moda del termine
‘spazio’ (…) testimonia al contempo dei temi che ossessionano l’epoca
contemporanea (la pubblicità, l’immagine, il tempo libero, la libertà, lo
spostamento) e l’astrazione che li corrode e li minaccia, come se i
consumatori di spazio contemporaneo fossero in primo luogo invitati ad
appagarsi di parole”.89 Il non-luogo è la degenerazione astratta del luogo, ma
nasce sempre da quello e si distacca da esso per isolarsi e vivere di sé.
L’enclave è la sua immagine. Secondo David Harvey,90 la crisi
87
Citazione tratta da Foucault, M., Utopie Eterotopie, Edizioni Cronopio, Napoli, 2008,
p.12. Secondo Foucault l’eterotopia è una sorta di “contro-spazio”, si tratta di una
forma di luogo che non appartiene a nessuno spazio. Alcuni esempi di eterotopia a cui
si riferisce Foucault sono: il cimitero, il museo, la biblioteca, le prigioni, le fiere, i
villaggi vacanza. Quando Augé parla di non-luogo si riferisce, tra gli altri, a club
vacanze, aeroporti, grandi magazzini, catene alberghiere.
88
Come il luogo-comune, il non-luogo ha un principio di verità (lo spazio umano), ma è
banalizzato (perde il carattere “esistenziale”).
89
Augé, M., op.cit., p.78.
90
Si veda a questo proposito il libro di David Harvey La crisi della modernità, Edizione
EST, Milano, 1997.
88
dell’urbanistica modernista deriverebbe dal processo di frammentazione della
città postmoderna in enclaves. Di conseguenza, la progettazione dello spazio
(sia pubblico che privato) tende al frammento isolato e, quindi, ad un sistema
di relazioni sempre più chiuso in se stesso. Quando un’entità non è più parte di
un sistema di relazioni chiamato ad “accudire e curare” le cose dell’uomo
decade a fondo cui attingere per il ciclo produzione-consumo (di qualsiasi cosa
induca desiderio). Di seguito, il luogo decade nell’auto-referenzialità:
l’indifferenza tra architetture, allora, genera la caduta di quella concezione
dello spazio come misura della distanza tra luoghi.91 Il luogo non è più da
nessuna parte se non in sé.
In poche parole: cade la concezione del luogo come spazio umano aperto
all’altro.
L’architettura, per potersi relazionare in modo dialettico alle altre discipline
artistiche e scientifiche, deve continuare a possedere un’identità e a
controllarla.92 Inoltre, occorre considerare la complessità e le contraddizioni
del contemporaneo come un’occasione di progetto, come un valore da
interpretare (inutile invocare un ritorno a ciò che non può più essere); occorre
guardare alla progettazione dello spazio umano come apertura al dialogo tra le
differenze per valorizzare l’identità del luogo.
“Apertura” e “Contestazione” sono i principi di un’architettura delle identità
che sappia vivere con distanza critica il proprio presente. L’Apertura è
continuità di relazioni. La chiusura del luogo è discontinuità (nelle enclaves e
nei precincts93), è presenza fuori-luogo (nelle architetture ultra-spettacolari
delle archistar), è assenza di distanza (nelle comunicazioni virtuali).
91
“Soltanto una città può essere abitata; ma non è possibile abitare la città, se essa non
si dispone per l’abitare, e cioè non ‘dona’ luoghi. Il luogo è dove sostiamo: è pausa – è
analogo al silenzio in una partitura. Non si dà musica senza silenzio. Il territorio postmetropolitano ignora il silenzio; non ci permette di sostare, di ‘raccoglierci’ nell’abitare.
Appunto, non conosce, non può conoscere distanze. Le distanze sono il suo nemico”.
Citazione tratta da Cacciari, M., La città, Pazzini Editore, Villa Verucchio (RN), 2009,
p.36
92
A questo proposito si veda il libro di Vittorio Gregotti Contro la fine dell’architettura,
Einaudi Editore, Torino, 2008.
93
“I precincts [quartieri sorvegliati; zone delimitate e protette], che siano a
iperinvestimento o a disinvestimento, centrali o periferici, vecchi o moderni, sono spazi
controllati, protetti dalla polizia, in cui si svolge un’attività specifica e da cui gli
indesiderabili vengono esclusi”. Citazione tratta da “Enclaves” e recinti, di Graham
Shane, articolo pubblicato su “Casabella”, n.597-598, Gennaio-Febbraio, 1993, p.59.
89
La frammentazione dello spazio non è una contestazione del sistema di
relazioni, ma una rinuncia al luogo, accondiscendenza allo stato di fatto. È
la rinuncia al dubbio che percorre il mondo della vita nelle sue relazioni tra
identità diverse e, insieme, la “certezza” di un mondo isolato, chiamatosi
fuori dal sistema di relazioni dell’architettura. La chiusura, in definitiva,
dimentica una legge troppo spesso trascurata: l’arte è contestazione.
In quanto domanda.
Giovanni Mensi
7RQLQR1HJUL6FXOWXUDFHUDPLFD´$UWHLQ*LDUGLQRµ,VRODG·(OED
90
Il rapporto tra norme e spazi economici
LE NUOVE REGOLE CONTRO LA CRISI
di Natalino Irti
La crisi mondiale dell’economia suscita l’attesa di nuove regole. Viene usata la
parola “regola” con qualche pudore linguistico e paura ideologica: ma essa non
può non designare la norma giuridica, emanata da una volontà che sia
provvista di forza sanzionatoria. L’appello alle regole, se non vuole sfumare
nell’impotenza del desiderio o nella fiducia più credula, è schietto appello ad
un’autorità vincolante e coercitiva.
Incalza qui una prima notazione: che così si riconosce la capacità
conformatrice del diritto nei confronti degli atti economici. Vecchia disputa, che
vede, da un lato, i teorici di un’economia auto-regolantesi, i quali chiedono allo
Stato soltanto sicurezza delle strade e difesa delle frontiere; e, dall’altro, i teorici
(e, fra di essi, l’autore del presente scritto) della priorità logica del diritto, cioè
della decisione politica che configura i singoli assetti dell’economia mediante
permessi e divieti e sanzioni. Le crisi segnano ore di riscoperta dei poteri
pubblici, di ritorno alla politica, di invocazione di norme.
Ma chi ha questa potestà regolatrice, capace di emanare norme e di garantirne
la pratica e concreta applicazione? La crisi è mondiale, e il “mondo” della
produzione e degli scambi, dell’economia reale e della finanza, non combacia
più con il territorio di singoli Stati. Si è rotta la coincidenza territoriale fra politica
diritto economia, e, mentre le prime due forze si sciolgono a fatica dal vincolo
dei luoghi, l’ultima è indefinita e sconfinata. Le norme giuridiche sono così
chiamate ad un’efficacia spaziale, che superi le antiche frontiere degli Stati, e
stringa Paesi lontani e diversi.
Il problema sta nel rapporto fra norme e luoghi, nella dissociazione di territorio
statale e spazio economico. Ne ebbe piena e lucida consapevolezza il
fondatore della scuola italiana di diritto pubblico, Vittorio Emanuele Orlando,
che, risalendo nell’aprile del 1947 la cattedra romana, teneva uno splendido
discorso su “La rivoluzione mondiale e il diritto”.
Il grande vegliardo – allora ottantasettenne – enunciava l’alternativa: o la
supremazia di uno Stato o un accordo fra Stati; o “con un procedimento di forza
o per manifestazione di libere volontà o in una combinazione, la cui misura può
essere indefinitamente varia, delle due maniere”. Orlando non mostrava
preferenze, e consegnava al futuro la scelta dell’una o dell’altra maniera.
Il problema ha oggi assunto uno straordinario rilievo: l’unità globale
dell’economia esige, o sembra esigere, l’unità globale del diritto. Il bisogno è di
ristabilire la coincidenza spaziale tra norma regolante e fatto regolato, sicchè
l’economia non dilaghi in spazi vuoti di diritto (a-nomici), e dunque di
responsabilità e di sanzioni. Forse l’alternativa non è così secca, poiché è pur
concepibile che il mondo si divida in aree economico-politiche, occidentali e
orientali, industriali e agricole, e che ciascuna – come teorizzava Carl Schmitt –
esprima un proprio nomos, un proprio criterio di ordine e di diritto. La dottrina
dei “grandi spazi”, ancorché enunciata o piegata al servizio dell’espansione
91
germanica, coglie un’esigenza profonda del nostro tempo, cioè il dilatarsi
dell’economia, e di ogni umana attività, oltre i confini degli Stati e la nascita di
connessioni spaziali secondo criteri diversi dagli antichi. Quello che un tempo si
diceva “mondo”, e ci appariva comprensibile e preciso, è ora in attesa di una
nuova definizione: è ancora un mondo o si scompone nella pluralità dei mondi?
Quale che ne sia l’esito, è da credere che il processo storico volgerà ad altre
configurazioni spaziali, instaurando, sull’intero pianeta o su singole frazioni, il
profondo rapporto fra diritto e luoghi, fra àmbiti del potere politico-giuridico e
àmbito dell’economia. La definita e chiusa territorialità cede alla spazialità, che
suscita nuovi criteri di determinazione politica e nuovi tipi di ordinamento
giuridico. La crisi economica, non diversamente da ogni altro periodo di
disordine e discontinuità, avrà, anche sotto il riguardo giuridico, una sicura
efficacia creativa.
Natalino Irti
L’articolo sopra riprodotto è stato pubblicato il 4 marzo 2009 da Il Corriere della Sera.
Ringraziamo l’autore e la direzione del giornale per la gentile concessione.
92
93
94
Abuso dell’arte per un’estetica al potere
La filosofia delle forme simboliche di Ernst Cassirer
come spiegazione dell’interdipendenza
tra arte e politica nel Terzo Reich
di Maristella Cervi
In Germania, sin dalla fine dell’800, storici dell’arte, artisti e filosofi lavorano
sul tema della forma, intesa come nuovo linguaggio attraverso cui chiarire il
mondo e come destino dell’arte che conferisce senso alla realtà. Tra questi,
Konrad Fiedler (1841-1895) inizia a guardare all’arte come luogo di produzione
del reale. Il filosofo sostiene che l’arte elabora concetti secondo leggi proprie, in
virtù del suo potere conformativo; che ogni forma d’arte si giustifica soltanto in
quanto necessaria per rappresentare qualcosa che altrimenti non sarebbe
rappresentabile. Così nasce il concetto di "pura visibilità": il vero significato di
un’opera artistica non si trova in contenuti estrinseci, come il tema
rappresentato, bensì nel modo in cui questo è reso visibile, fissato nella struttura
di una forma, che produce un senso di realtà e che denota la specificità di ogni
realizzazione artistica. Le Schriften über Kunst (Scritti sull’arte) di Fiedler, di
cui fanno parte anche gli Aphorismen (Aforismi), compariranno soltanto nel
1914, anche se già dal 1893 molti dei temi da lui trattati sono anticipati dalla
pubblicazione di Das Problem der Form (Il problema della forma) di
Hildebrand.
L’esperienza, nel suo complesso, è vista come una variabile tensione tra due
poli opposti: il mondo e l’io. Questi possono mutare nella forma, nel contenuto,
nell’ampiezza e nel significato, istituendo aspetti sempre nuovi del loro
interagire; nell’arte, però, trovano uno spazio in cui consolidarsi, per rendersi
fautori di una realtà espressa dalla loro relazione stessa, non più caotica e
mutevole, ma ordinata ed armonica. "L’antiteticità dei due poli", così la
definisce Antonio Banfi nella sua introduzione agli Aforismi sull’arte edita da
Minuziano nel 1945, confluisce in un accordo "che reciprocamente li differenzia
e li unisce", così che il mondo possa rivelarsi all’io e l’io possa aprirsi al
mondo.
Come un processo in continuo divenire, la costituzione della realtà non smette
di rinnovarsi nelle molteplici interazioni tra l’io e il mondo, e in tal modo
Fiedler recupera il trascendentalismo critico kantiano nella sua intuizione
basilare. Ogni forma, sia essa un concetto o un’opera d’arte, fa parte della realtà
e, allo stesso tempo ne è principio di sviluppo, determinando una "struttura di
ideale obbiettività" e dando vita alla natura autoproduttiva della realtà spirituale.
L’accordo reciproco tra l’io e il mondo, che confluisce nell’arte, innesca
l’elevazione dell’uomo, inteso come individuo, all’uomo, inteso come
95
espressione; dove per espressione si debba intendere l’obbiettività spirituale
hegeliana in cui momento soggettivo e momento oggettivo dell’esperienza si
ritrovano per trarre, dalla propria fusione, verità. L’io si esprime, dunque,
quando supera la sua velleità soggettiva, quando mette in moto il processo
dialettico che trascende i due momenti, soggettivo ed oggettivo. Allo stesso
modo, l’arte supera la mimesis, copia di un’entità già esistente, così come lo
statuto di prodotto immaginativo, per definirsi espressione, nei termini appena
descritti: l’arte diventa, per Fiedler, produttività artistica della realtà,
espressione intesa come complessa ed infinita tensione dialettica. Per realizzare
ciò, l’esperienza, i suoi piani intuitivi di sensibilità, le forme concrete di
espressione, la personalità dell’artista, sono coinvolte in un unico sviluppo. Non
è l’artista, alla maniera romantica, ad esprimersi, bensì l’esperienza che si
dischiude attraverso l’artista, sino a raggiungere la realtà e l’oggettivazione
artistica. "L’arte figurativa", dice Fiedler, "non si volge all’occhio, ma sorge
dall’occhio". L’attenzione si rivolge dunque non tanto all’attività dell’artista,
quanto all’attività dell’arte attraverso l’artista, come se l’occhio non dovesse
attendere di essere impresso dalla luce esterna per vedere ma come se, già
immerso nella luce del mondo, si riservasse di aggiungervi qualcosa: il suo
sguardo, la sua intuizione espressiva, una nuova forma, l’impronta del suo stile.
Lo stile è ciò che conclude l’opera d’arte secondo una legge interiore propria: lo
stile organizza l’opera e la oltrepassa, suscitando attorno a sé un mondo.
Quando Fiedler scrive ad Hans von Marées, l’amico pittore che sostenne per
anni finanziariamente e al quale dedicò il proprio tempo e le proprie
osservazioni per la formulazione delle sue teorie artistiche, esprime pienamente
questo concetto:
“Il suo quadro di aranci mi fa continuamente pensare che gli
artisti moderni o non conoscono la natura o non sanno superare
l’intuizione del particolare, mentre questa è solo il gradino più
basso, il primo inizio; quanto l’artista offre dovrebbe essere
sempre il risultato di una lunga esperienza fatta su
un’osservazione finissima della natura, altrimenti si tratterà
sempre di qualche cosa di povero, per quanto fedelmente cerchi
di rendere il dato naturale. Tutto questo baccano che si sta
facendo adesso a proposito di naturalismo e realismo è quanto
mai stolido, perché proprio coloro che vengono osannati si
limitano a conoscere della natura quel che vedono sul
momento, e per lo più non è molto. Solo chi sa molto della
natura può dare l’astrazione del sensibile, e sa limitarsi agli
elementi puramente necessari, perché ognuno di essi apre lo
sguardo di chi li sa avvicinare su tutto un mondo di immagini;
dietro ad una semplicità apparente si nasconderà così
un’infinita ricchezza, mentre ora, così spesso, dietro ad
un’apparente ricchezza non c’è che un’illimitata povertà. Nel
96
suo quadro mi sembra che ogni forma, ogni albero, ogni monte
sia tipico, la fine e il principio di tutta una serie di immagini94.”
Altro si intende invece per "maniera", che ha più a che fare con la
standardizzazione formale, come fosse copia di un originale e che, dunque, più
che stile, può essere chiamata stilizzazione: nessuna tensione interna la anima e
dal suo delinearsi non sorge dimensione del mondo alcuna. L’opera d’arte
originale, quella che come si è detto sa rivelare uno stile, si pone come
frammento di una realtà, costituendo un intreccio della trama infinita dell’arte.
A detta dello stesso Fiedler, "l’arte è un infinito, ogni opera d’arte è un
frammento, benché appaia un reale in sé compiuto"95.
Accanto alle considerazioni fiedleriane, che chiaramente recuperano gli spunti
filosofici di Schopenauer per l’ardire con cui si riconosce l’arte come aspetto
essenziale della spiritualità e, di conseguenza, di spazio produttivo della realtà,
un altro testo è destinato ad avere un notevole influsso sul ruolo delle forme
artistiche. Nel 1908 un ventiseienne, Wilhelm Worringer, ottiene la
pubblicazione a Monaco della sua prestigiosa tesi di laurea dal titolo
Abstraktion und Einfühlung (Astrazione ed empatia). Formatosi sulla filosofia
di Schopenauer, W. Worringer sottolinea la tensione che si instaura tra realtà e
forma, tra vita e astrazione: l’oggettivazione pare quindi essere ciò che
caratterizza e dà forza alla civiltà moderna; senza cristallizzare la realtà in
forme, infatti, non sarebbe possibile controllarla in alcun modo. Il concetto di
arte inizia ad allontanarsi dall’idea di tradizione artigiana, di mestiere basato sul
"saper fare", per inscriversi in un’attività proiettata al "voler fare", ovvero a
ricreare il mondo. È per mezzo dell’Einfühlung, la capacità di empatia, che è
possibile ricondursi al realismo e ad una condizione di dominio del mondo
esterno. L’analisi teorica che W. Worringer applica alla creazione artistica, pone
in evidenza l’arte come frutto di un’esigenza psichica, del Kunstwollen, il volere
artistico. Le istanze psichiche dell’uomo dettano una modalità espressiva
all’arte secondo i propri bisogni e così l’arte potrà creare un mondo a seconda
della tipologia antropologica a cui dovrà far fronte. Ritornando a Fiedler e
tenendo ben conto della filosofia di Kant volta a sviluppare l’assoluta
connessione tra l’io e il mondo, del schopenauerismo che inneggia al mondo
come volontà e rappresentazione e delle teorizzazioni worringeriane in merito al
carattere produttivo dell’arte, non si può fare a meno di evidenziare come il
mondo sembri appartenere proprio a chi (forse dovremmo dire a ciò che) lo
produce. Mi permetto di citare di nuovo gli Aforismi:
94
K. Fiedler, Aforismi sull’arte, a cura di Antonio Banfi, Alessandro Minuziano
Editore, 1945, p. 170, originale Aphorismen, in K. Fiedler, Schriften über Kunst, hrsg.
Von herman Konnerth, München, 1914, p.101.
95
Ibidem, p. 60.
97
“Il mondo è di chi agisce: questo è vero non solo
nell’accezione pratica comune, ma nel suo significato profondo
della relatività del mondo: solo la ricchezza e la vitalità dello
spirito ne sviluppano l’essere. Indebolendosi lo spirito, anche
l’essenza del mondo sbiadisce e scompare96.”
Ecco che la forma si prospetta come legge del movimento stesso della materia,
il regno delle forme è concepito come regno dello spirito e l’arte costituisce uno
dei mezzi che sono stati dati all’uomo per appropriarsi del mondo. Il principio
dell’attività artistica è la produzione della realtà, nel senso che nell’attività
artistica la realtà raggiunge la sua esistenza, mentre l’arte si configura come uno
sviluppo necessario della stessa immagine del mondo. È lo spirito a conferire un
volto alle cose attraverso l’attività della rappresentazione artistica, è lo spirito
che attraverso l’arte ottiene l’oggettivazione, nonché la comprensione del
mondo come totalità di forme: è questo il "realismo".
Analogamente, Ernst Cassirer (1874-1945) identifica nell’arte, in quanto forma
simbolica, lo strumento per la determinazione del risultato conoscitivo. Per
Cassirer è il potere del simbolo a rendere possibile il mondo delle cose umane.
L’uomo, infatti, non è in grado di cogliere se stesso e il suo mondo come
un’unità: egli si trova di fronte a svariati modi di concepire e vedere l’uomo,
tanti quante sono le varie sfere dell’attività umana. Ad un simile stato di
frammentazione percettiva, Cassirer offre una soluzione attraverso la
definizione dell’uomo come animale simbolizzatore, ovvero animal
symbolicum. Il simbolo pervade tutte le attività umane e su di esso la cultura
poggia ogni suo fondamento. Per Cassirer, dunque, il potere simbolizzatore
rende possibile anche la sfera dell’etica, che è movimento dai fatti agli ideali. La
sua intera opera è un tentativo di guidare l’uomo contemporaneo a ritrovare la
propria strada all’interno della frammentazione sociale della vita novecentesca:
quanto più ci si allontana dalla frammentarietà dell’esperienza sensibile e
l’oggetto si avvicina ad una forma estrema e perfetta in grado di garantire una
durata della coscienza, come può essere un concetto, tanto più una forma
simbolica si rende stabile e le relazioni che la coscienza stabilisce tra sé e il
mondo esterno si fanno oggettive. Ciò che permane viene distinto da ciò che
fluisce, nonostante il simbolo risulti comunque composto da elementi sensibili e
attraversato dal tempo. La forma simbolica è possibile perché nel movimento
della coscienza si stabilisce una rete di relazioni costituente l’immagine
durevole: cose, situazioni, proprietà e attività non sono per Cassirer contenuti
dati nella coscienza, ma maniere della sua attività formatrice o meglio di quella
attività produttiva dello spirito che è l’arte.
Per quanto una ricerca sulle origini del concetto cassireriano di forma simbolica
non sia ancora completa, le principali fonti filosofiche si possono suddividere in
96
Ibidem, p. 140.
98
gruppi tipologici: fonti logico-metafisiche si riscontrano in Leibniz, per la
distinzione tra conoscenza simbolica e conoscenza intuitiva formulata nelle
Meditazioni sulla conoscenza, la verità e le idee, la definizione di simbolistica
generale in De analisi situs e in primo luogo la nozione di idea come simbolo,
sviluppata in Quid sit Idea; in Kant, per il percorso proposto all’interno di una
dialettica trascendentale come principale fonte filosofica di E. Cassirer: in
particolare, per quanto riguarda il concetto di forma simbolica, si è individuata
nell’interpretazione morfologica della Critica del giudizio, espressa in Kants
Leben und Lehre (1918), una fonte diretta della teoria delle forme simboliche. A
tal proposito è possibile segnalare una citazione dal primo libro della
Antropologia kantiana, riportata nel terzo volume della Filosofia delle forme
simboliche, nel contesto della patologia della coscienza simbolica:
“Le forme delle cose (intuizioni), in quanto servono solo
come mezzi della rappresentazione mediante concetti, sono
simboli e la conoscenza relativa è detta simbolica o figurata97.”
Tra le fonti scientifiche si devono annoverare la teoria dei segni di Helmholtz, la
teoria fisica di Mach e la teoria dei simboli di Hertz. Per Helmholtz il sapere
riguardante gli oggetti precede il sapere che concerne le sensazioni; sensazioni e
rappresentazioni si definiscono però segni e non copie degli oggetti. Il segno
assume un ruolo di spicco rispetto alla copia perché non richiede alcuna
somiglianza oggettiva negli elementi ma soltanto una corrispondenza funzionale
tra le due strutture. Per quanto riguarda Mach, Cassirer rileva la relazione tra
condizione e condizionato: queste vengono in effetti riconosciute dal fisico
come il vero elemento permanente e sostanziale, ovvero come qualcosa la cui
scoperta rende possibile una stabile immagine del mondo. Hertz risulta
fondamentale per la sua definizione di spazio, tempo e massa degli oggetti
esterni, secondo un principio di coordinazione e traduzione tra dati e simboli
matematici poiché, secondo quanto formulato dallo studioso in Die Prinzipien
der Mechanik (I principi della meccanica), 1894, quel che la mente può
conoscere dipende dai simboli che crea. Il principale riferimento a Hertz,
tuttavia, si trova nel testo che Cassirer scrive ed intitola Zur Einsteinschen
Relativitätstheorie. Erkenntnistheoretische Betrachtungen (La teoria della
relatività di Einstein. Considerazioni gnoseologiche), testo chiave per la
comprensione del concetto cassireriano di forma simbolica: il termine vi
compare per la prima volta, inoltre il testo si volge a determinare l’oggetto
fisico come oggetto nel fenomeno (fenomeno che, visto con gli occhi di chi già
conosce le osservazioni di Cassirer, potrebbe essere identificato con l’arte),
97
I. Kant, Antropologia del punto pragmatico, in Scritti morali, a cura di P. Chiodi,
Torino, 1986, p. 612.
99
segnando compiutamente e consapevolmente il passaggio della teoria della
conoscenza come riproduzione, alla teoria della conoscenza come funzione,
secondo il punto di vista kantiano.
E. Cassirer è, nella sua epoca, uno dei pochi studiosi a porre la teoria
relativistica einsteiniana su un piano di simbolismo matematico, dunque su un
piano a-metafisico. Le forme della conoscenza sono riconosciute nella loro
pluralità morfologica, esistono cioè molteplici e differenti attribuzioni di forma
e di senso alla totalità della conoscenza scientifica (forma teoretica, etica,
estetica ecc.): viene così negata l’unilateralità della visione naturalistica.
L’immagine ottiene la sua liberazione da tale unilateralità, ogni singola forma si
relativizza rispetto alle altre e, poiché non la singola, bensì solo la totalità
sistematica di forme sarebbe espressione valida della realtà, ecco che è
attraverso la totalità delle forme simboliche che si perviene al concetto di una
realtà articolata nel rapporto tra l’io e il mondo.
Fonti estetiche sono rintracciabili in Hegel, per le ricerche hegeliane sul
simbolismo nell’arte e per la tensione continua verso una conciliazione tra idea
e forma:
“...die simbolische (Kunst), worin die der Idee angemessene
Gestaltung noch nicht gefunden ist, vielmehr der Gedanke als
hinausgehend und ringend mit der Gestalt als ein negatives
Verhalten zu derselben, der er zugleich sich einzubilden
bemüht ist, dargestellt wird.
…l’arte simbolica in cui non si è ancora trovata la
figurazione adeguata all’Idea, e in cui il pensiero viene
presentato piuttosto come oltrepassante la figura e in lotta con
essa, come un comportamento negativo verso la figura sulla
quale esso a un tempo si sforza di imprimersi98.”
Fonti estetiche si ritrovano poi nell’ampio studio su Goethe e sulla sua teoria dei
colori, che lascia trapelare una netta sovrapposizione tra la simbologia
cromatica e la vita, come se i due elementi della creatività non potessero
prescindere l’uno dall’altro. Infine, a tale quadro, va ricondotta anche la
filosofia del linguaggio di Humboldt, che si ricollega alla critica kantiana per il
primato riconosciuto alla forma e alla correlazione tra soggetto e oggetto e che
vede ogni lingua come manifestazione esterna dello spirito di un popolo, come
la maniera spirituale di esprimere concretamente il pensiero. Per Cassirer il
linguaggio, come l’arte, non può però assolutamente essere pensato come una
98
G. W. F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (Enciclopedia
delle scienze filosofiche), a cura di Vincenzo Cicero, Rusconi, Milano, 1996 (edizione
con testo tedesco a fronte), pp. 902-903.
100
mera opera dello spirito, bensì come una forma che rappresenti il carattere
peculiare di quest’ultimo.
Il discorso storiografico delle fonti estetiche della forma simbolica si intreccia,
per concludere con i raggruppamenti tipologici, con quello delle fonti
iconologiche, ovvero dei rapporti di Cassirer con Aby Warburg e Erwin
Panofsky.
Aby Warburg (1866-1929), attivo ad Amburgo già dai primi anni del
Novecento, è la personalità che dà inizio ad un approccio contestuale dell’opera
d’arte, influenzando l’orientamento iconologico dell’epoca. La sua indagine,
pur muovendo da posizioni formaliste di esegesi dell’opera d’arte, si orienta
verso una conoscenza contenutistica ed iconografica del testo visivo, sino a
tracciare una storia dei fenomeni artistici come testimonianza di uno sviluppo
diacronico e sincronico del simbolo. Lo stesso dominio dell’arte si colloca, per
Warburg, nella sfera del simbolo, in quanto luogo di rivelazione del profondo. Il
suo sguardo si rivolge al regno interiore della psiche, credendo che l’arte
esteriorizzi nella storia ciò che è sedimentato nel profondo dell’anima umana.
Quello di Warburg è un credo nei confronti del genio artistico: una volta trovati
i simboli che con maggiore forza di sintesi espressiva rappresentano
l’esteriorizzarsi del regno interiore, l’immagine prende forma come opera
d’arte, affermando il sensibile ad un livello di permanenza. Il simbolo è dunque
concepito come limite estremo dell’espressione: l’espressione artistica è,
oltretutto, espressione di una lotta per l’affermazione di una identità
sovratemporale in un momento di conflittualità storica tra epoche. Qui entra in
gioco il recupero dell’antico: il pathos della coscienza può rivolgersi anche ad
espressioni antiche di pathos, per il raggiungimento di una nuova formula che
rappresenti il nuovo corso della storia.
Il saggio di Cassirer del 1923, Der Begriff der symbolischen Form (Il concetto
di forma simbolica), inaugura la collana dei Vorträge der Bibliothek Warburg,
in cui compaiono i contributi più significativi della scuola iconologica e che
introduce la prima formulazione sistematica generale delle forme simboliche,
espressioni dello spirituale attraverso segni e immagini sensibili. Dal punto di
vista morfologico non si tratta di conoscere o riconoscere il significato del
simbolo in ogni manifestazione "spirituale", piuttosto di comprendere fino a che
punto l’arte, come totalità, porti in sé il carattere generale di forma simbolica,
qualora la si intenda come qualsiasi energia dello spirito attraverso la quale un
contenuto viene ricollegato- ad un segno concreto e sensibile. L’arte è in tal
senso forma simbolica. Nel 1924, nella collana medesima, appare il saggio
Eidos und Eidolon. Das Problem des Schönen und der Kunst in Platons
Dialogen (Eidos e Eidolon. Il problema del bello e dell’arte nei "Dialoghi" di
Platone), scritto in occasione di un discorso pronunciato alla Biblioteca
Warburg e in cui si chiarisce il valore sistematico della concezione platonica
dell’estetica, argomento peraltro anticipatamente affrontato rispetto al
contributo del 1925, Die Philosophie der Griechen von den Anfängen bis Platon
(La filosofia greca dalle origini a Platone): l’idea, l’eidos, si identifica con la
101
forma e diventa espressione del contenuto semantico del logos. Il filosofo
interpreta la storia della filosofia greca come la storia della configurazione del
contenuto nella forma, dunque della configurazione del logos nell’eidos. Il
problema che viene posto in risalto in questo studio tocca la natura
essenzialmente platonica di ogni estetica o speculazione postplatonica sull’arte,
tentando di superare quella dicotomia tra sensibile e intelligibile che
dichiarerebbe l’arte come non suscettibile di pensiero, in quanto puro oggetto
dei sensi. Il tentativo di Cassirer sta proprio nel ricondurre il fatto sensibile, che
costituisce l’esperienza artistica, alla forma intesa, in senso platonico, come
principio di ordinamento del reale. Per far ciò egli individua, nella storia del
pensiero estetico successiva a Platone, una tensione tra i concetti di eidos
(Gestalt, forma) e eidolon (Bild, immagine), risolvendolo in un rapporto
simbolico tra le due entità, che consiste nel riconiare l’esistenza sensibile in
forma di significato intellettuale, imprimendole il vero sigillo dell’essere e
recuperando, se vogliamo, la parusia platonica (dal greco parousìa, presenza. Si
intende la presenza attiva delle idee nelle cose). La natura non è un puro
concetto interno alle cose materiali, ma prende parte, tramite l’ordine eterno che
la domina, al regno delle forme. Cassirer mette in discussione la visione
dicotomica della filosofia di Platone, che vede generi universali contrapposti
alla molteplicità delle cose, le idee (in condizione di pensabilità, in
considerazione gnoseologica) contrapposte alle cose (in condizione di esistenza,
quindi in considerazione ontologica): in realtà è il pensiero che deve dominare,
unito al concetto, su ogni forma particolare. Inoltre, per spiegare come la forma
simbolica sia radicata direttamente nel funzionamento della coscienza, lo
studioso ricorre alla nozione di una semplice linea disegnata, di un Linienzug,
esemplificazione del funzionamento della coscienza di fronte ad un oggetto
teorizzata in ben due sue opere del 1927: Das Symbolproblem und seine
Stellung im System der Philosophie e il terzo volume della Philosophie der
symbolischen Formen. Cassirer invita dapprima il lettore a partecipare ad una
verifica percettiva, inducendolo ad osservare la linea rispetto alle sue qualità
puramente sensoriali (determinatezza spaziale, levità, spessore, direzione,
l’andamento spezzato o continuo): in tal caso, si nota come lo stato d’animo
dell’osservatore sia influenzato dall’andamento e dalle caratteristiche della
linea, che si presenta come una totalità animata. Assumendo, in un secondo
momento, un altro punto di vista e considerando la linea come una struttura
matematica, l’osservatore è spontaneamente orientato a giudicarla come schema
di una legge geometrica, scorgendovi le relazioni e le proporzioni che
rappresenta, anziché le variazioni che la distinguevano come dinamismo
espressivo. Infine, il filosofo propone una terza e una quarta prospettiva,
invitando a cogliere il Linienzug come simbolo mitico che segna la divisione tra
sacro e profano o come oggetto di contemplazione estetica. Come D. P. Verene
espone nell’introduzione a Symbol, Myth and Culture. Essays and Lectures of
Ernst Cassirer 1935-1945, si spiega, dunque, come Cassirer possa definire ogni
atto percettivo colmo di "pregnanza simbolica", se per quest’ultima si intende la
102
maniera in cui un’esperienza vissuta dalla percezione, in quanto esperienza di
senso, racchiude in sé un determinato senso non intuitivo e acquista una sorta di
articolazione spirituale. La symbolische Prägnanz suggerisce che il simbolo
inerisce alle più rudimentali manifestazioni della coscienza, ampliando
l’accezione di forma simbolica oltre la sua designazione di forme culturali.
Sempre del 1927 è anche uno degli scritti più famosi ed esemplari di Erwin
Panofsky che riprende il concetto, prima warburghiano e poi cassireriano, di
simbolo e forma simbolica dall’antichità classica all’età moderna, nel suo
contributo intitolato Die Perspektive als symbolische Form. Mentre Cassirer
pensa di collocare ogni attività simbolica all’interno di un più ampio contesto
culturale, Panofsky prevede di riferire gli sviluppi dell’arte all’interno della
Weltanschauung di un’epoca storica determinata: questi riconosce nella capacità
di produrre simboli una delle facoltà umane più importanti. Produrre simboli
significa, per lo storico dell’arte, astrarre e accostare un significato ad una
forma. A ben vedere, egli si avvicina, senza però ancorarsi ad un’analisi
psicologica, a quella visione archetipica del simbolo che la psicanalisi di
Sigmund Freud e Carl Gustav Jung diffondono nella prima metà del Novecento:
Panofsky sa che l’archetipo nasce, come informazione universale, impersonale
ed ereditaria, come possibilità di rappresentazione, da una memoria collettiva;
egli riconosce l’inconscio collettivo come tradizione riguardante una
popolazione e un periodo storico.
A questo punto è necessario inoltrarsi nella filosofia cassireriana e vedere un
po’ più da vicino le formulazioni teoriche relative alla nozione di simbolo, con
l’intento parallelo di intrecciarvi considerazioni di confronto rispetto ai
meccanismi propagandistici del Nazionalsocialismo. La politica hitleriana
ostenta una mistica celebrazione dell’uomo, una fede illimitata nell’opera
dell’uomo e la comunità è la fonte di legittimazione del potere politico. La
sostanza sacrale diventa così lo spirito del popolo, il Volksgeist, che si tramuta
in realtà storica attraverso i membri della collettività. Si deve considerare,
inoltre, che spesso le teorie del Nazionalsocialismo esulavano dal mondo
nazionalsocialista stesso e che fattori concomitanti agli avvenimenti storici
hanno potuto partecipare, talvolta, al rafforzamento delle ideologie in corso di
espansione: è questo il caso dell’interdipendenza tra la politica nel Terzo Reich
e la filosofia delle forme simboliche di Ernst Cassirer. L’intenzione non è infatti
quella di dimostrare la concausalità dei due fenomeni, quanto di stabilirne un
confronto, per evidenziare come vi si ritrovino aspetti analoghi, nonostante la
diversità delle intenzioni. Perciò è questo anche il caso del ruolo dell’arte nel
Nazionalsocialismo, del suo abuso come potere politico estetizzato al fine di
identificare l’individuo con l’organizzazione nazionale, secondo un principio
aggregante che recupera elementi del passato, li collega al presente e li indirizza
ad un futuro. L’arte si fa, durante il Terzo Reich, strumento di distinzione di un
popolo, rappresentante di un’identità nazionale, promotrice di un nuovo ordine
della realtà e dunque di un potere politico che da questa non può prescindere.
L’arte è in grado di convocare il popolo, seducendolo con la produzione di una
103
realtà attraverso immagini, anche archetipiche, o simboli. Meccanismo, se
vogliamo, riconducibile a quello delle forme simboliche di cui Cassirer parla.
Per Cassirer il mito, l’arte, la conoscenza e il linguaggio divengono tutti
simbolo, in quanto forme culturali espresse dalla coscienza:
“Wenn man die Sprache, den Mythos, die Kunst als
«symbolische Formen» bezeichnet, so scheint in diesem Ausdruck
die Voraussetzung zu liegen, daȕ sie alle, als bestimmte geistige
Gestaltungsweisen, auf eine letzte Urschicht des Wirklichen
zurückgehen, die in ihnen nur wie durch ein fremdes Medium
erblickt wird. Die Wirklichkeit scheint für uns nicht anders als in
der Eigenart dieser Formen faȕbar zu werden; aber darin liegt
zugleich, daȕ sie sich in ihnen ebensowohl verhüllt wie offenbart.
Se il linguaggio, il mito, l’arte vengono designate come forme
simboliche, si presuppone che tutti questi ritornino, in quanto
modalità definite e spirituali della forma, ad un ultimo strato
originario della realtà, uno strato che in loro stessi si scorge come
strumento ignoto. La realtà non ci appare in altro modo se non
come queste stesse forme propongono; ma allo stesso tempo la
realtà è in esse celata e altrettanto evidente 99.”
La "filosofia delle forme simboliche" proviene dal presupposto che, qualora
esista una definizione dell’essere e della natura dell’uomo, questa definizione
sia da intendere in termini di funzionalità e non di sostanzialità. Ecco dunque
che la domanda Was ist der Mensch? trova una sua risposta adeguata non in una
definizione metafisica dell’essere o fisica della natura, ma semplicemente nel
suo agire. L’azione, o meglio il sistema delle attività umane, definisce die
Sphäre des Menschenseins. Di conseguenza, l’agire politico, di per sé non
identificabile come forma simbolica ma che ad essa tende per simulare un’entità
che oltre a mostrarsi come forma sia già nel suo apparire anche significato,
instaura uno stretto legame di dipendenza con l’arte, che si designa invece come
simbolo. Posta al servizio politico, quest’ultima rende possibile un mondo
secondo le percezioni sensoriali dell’uomo (o del popolo che dir si voglia), dei
concetti che gli vengono imposti dal totalitarismo, delle istituzioni con cui viene
a contatto. L’arte, del resto come il linguaggio, diventa perciò una funzione
umana che elargisce visioni del mondo colte dall’operar politico e veicolate nel
medium espressivo. Scrive Cassirer in Zur Metaphysik der symbolischen
Formen, la quarta parte a lungo inedita della "Filosofia delle forme simboliche":
99
E. Cassirer, Philosophie der symbolischen
Buchgesellschaf, Darmstadt, 1954, Band 3.
104
Formen,
Wissenschaftliche
“[Wie die Sprache ist es die bildende Kunst, in der die Erhebung
des Menschen von] der Stufe der sinnlichen Wahrnehmung zur
Stufe des eigentlichen Sehens statt [findet]. Sie sind die beiden in
ihrem Gebrauch zusammengehörigen und zusammenwirkenden
Organe für die Gewinnung eines anschaulichen Weltbildes [...].
Nel linguaggio come nell’arte ha luogo l’elevazione dell’uomo
dallo stadio della percezione sensoriale allo stadio del vero e
proprio vedere. Linguaggio e arte sono due organi che nel loro
sviluppo si coappartengono e cooperano per il raggiungimento di
un’immagine intuitiva del mondo […]100”
Il pensiero cassireriano introduce nel panorama filosofico del Novecento una
definizione di simbolo non precisamente determinata, ma sicuramente in
connessione con la problematica della teoria della conoscenza: "il vero e proprio
vedere" di cui si parla nella citazione appena menzionata recupera, se vogliamo,
ciò che anche Leonardo da Vinci ha chiamato il "saper vedere" e ciò che Goethe
ha chiamato il "vedere con gli occhi dello spirito". Le immagini simboliche,
secondo la These der Pathologie des Symbolbewusstseins, si rendono
fondamentali ai fini dell’acquisizione del mondo e per far questo la coscienza
stabilisce di continuo relazioni, imponendosi essa stessa con una struttura
relazionale cognitiva ed operativa. In tal modo, ogni contenuto viene rimandato
ad altri contenuti attraverso mediazioni che rendono possibili totalizzazioni.
Appare chiaro che dei simboli si voglia porre in risalto il carattere prettamente
strumentale, non solo, soprattutto il partecipare dello strumento alla
determinazione del risultato conoscitivo. Ernst Cassirer, quindi, non limita la
sua visione di simbolo ad un mezzo in grado di rispecchiare un determinato
oggetto, al contrario estende le forme simboliche ad entità capaci di fornire
strumenti di conoscenza nell’unità dei fenomeni che esse stesse producono nel
loro senso. Di tutti i teorici dell’estetica del XIX secolo, egli riconosce a Konrad
Fiedler il merito di aver visto nel modo più chiaro la necessità di costruire il
sistema dell’estetica sul sicuro fondamento della critica della conoscenza.
Quest’ultimo cerca di delineare una trasposizione della "rivoluzione
copernicana" di Kant101 nel mondo delle forme artistiche: fin dai tempi antichi
due grandi principi, quello dell’imitazione e quello della trasformazione della
100
Citazione relativa al testo di E. Cassirer, Zur Metaphysik der symbolischen Formen,
ma tratta da T. Bevc, "Zur Interdipendenz von Kunst und Politik. Ernst Cassirer und die
Kunst als symbolische Form.", in W. Hofmann, H. O. Mühleisen (Hrsg. von), Kunst
und Macht. Politik und Herrschaft im Medium der bildenden Kunst, Lit Verlag,
Münster, 2005, Band 2, trad. it. a cura di Giulio Raio, Metafisica delle forme
simboliche, Sansoni, Milano, 2003, p. 100.
101
È il mutamento di prospettiva effettuato da Kant.
105
realtà, si sono contesi il diritto a essere la vera espressione dell’essenza
dell’attività artistica; ora, la disputa trova una risposta in un terzo principio, il
principio della produzione della realtà. Infatti, l’arte non è altro che uno dei
mezzi attraverso i quali l’uomo consegue la realtà. Le cose ottengono un volto
solo perché lo spirito e, nel caso del movimento nazionalsocialista, lo spirito del
popolo, lo conferisce ad esse, in un modo e in una direzione determinati della
sua attività (la rappresentazione artistica, il linguaggio). In tal modo si compie
un passo decisivo verso l’oggettivazione, verso la comprensione del mondo
come una totalità di forme, verso quel realismo tanto acclamato da Hitler.102
Cassirer estende poi questa concezione. Le varie manifestazioni dello spirito, la
scienza, l’arte, il mito, la religione sono rilette, nello stesso tempo, come
modalità ben definite finalizzate alla costituzione del reale. Facile riconoscere
come la dittatura hitleriana si sia avvalsa di arte e mito. Molto più in generale, si
evidenzia l’idea che le attività dello spirito si muovano in un universo
simbolico, per ricondursi alla determinazione di un oggetto unicamente
attraverso la mediazione di una certa struttura logico-concettuale. Nello studio
sul concetto di azione e funzione, che nella scienza moderna si è venuto
sostituendo a quello di sostanza, Cassirer mette in luce l'importanza del
linguaggio e del segno, nella costituzione degli oggetti di cui si occupa la
scienza. Egli sceglie, in questo modo, di percorrere un nuovo sentiero che guida
la rivoluzione copernicana al suo ampliamento a tutte le forme della cultura,
riconosciute nella loro irriducibile autonomia, cioè alla filosofia delle forme
simboliche. Si tratta, in realtà, di un ampliamento che coinvolge anche un
autentico mutamento di prospettiva. Nella Filosofia delle forme simboliche
permane l'esigenza sistematica caratteristica del neocriticismo marburghese, ma
essa si realizza in una "critica della cultura" in cui si considera ogni attività
spirituale nella sua forma caratteristica, nel suo manifestarsi peculiare, nel suo
(come dice Cassirer) "esser così", in una ricchezza di forme che rispecchiano la
stessa ricchezza della vita. Ciò che accomuna le diverse sfere della cultura
(linguaggio, mito, religione, arte, ecc.) è la loro natura di "forme simboliche" in
quanto rappresentano, mediante segni simbolici, il contenuto dello spirito: il
simbolo non è il rivestimento meramente accidentale del pensiero ma il suo
organo necessario ed essenziale. L'atto della determinazione concettuale di un
contenuto procede di pari passo con l'atto del suo fissarsi in qualche simbolo
caratteristico. Il compito della filosofia sarà allora quello di mostrare come
attraverso l'espressione simbolica si generino le varie forme della realtà
spirituale e, se si vuol a questo punto di nuovo invadere il territorio della
«rivoluzione tedesca», sarà utile rammentare come lo scopo del Terzo Reich sia
stato quello di rinnovare la spiritualità dei Tedeschi, facendo appello alla natura,
all’eredità germanica e dunque anche al Volk, come mito e ricettacolo di forza
vitale, come momento di contatto tra l’individuo e la «realtà superiore», lo
102
M.K. Ibidem.
106
«spirito del cosmo». Racconta G. L. Mosse in Le origini culturali del Terzo
Reich:
“La «nuova» Germania, egli asseriva (Arthur Möller van den
Bruck103), doveva venire infiammata dall’idea del passato
germanico e della potenziale grandezza futura; essa avrebbe dovuto
ridar vita, rendendole operanti nell’era nuova, alle tradizioni del
messianismo medievale. Il materialismo contemporaneo, l’esistente
società e la scienza dovevano essere dimenticati, e così l’anima
tedesca avrebbe preso lo slancio e seguito senza più deviazioni la
parabola del Geist. […] La ristrutturazione in senso corporativistico
avrebbe garantito alla nazione i benefici di una società comunitaria,
benefici che la borghesia non era stata in grado di assicurarle.
Integrando in sé certi aspetti del socialismo, il nuovo organismo
avrebbe reso santi e intoccabili particolari raggruppamenti come
gilde, stati sociali, orini, i quali dal canto loro avrebbero dovuto
subordinarsi alle necessità del Volk nel suo insieme. […]104”
Un altro aspetto del pensiero cassireriano che, pur non dimenticandone le
diverse implicazioni, può esser confrontato con il panorama ideologico nazista è
il concetto di mito, una tra le varie forme simboliche che il filosofo elenca. Se le
immagini del mito sono considerate innanzitutto simboli, il mito sarà in grado di
produrre un mondo autonomamente, in quanto attività originaria dello spirito.
Il mito possiede però un proprio significato preciso, da non confondere con
quello delle altre forme spirituali. Per Cassirer sarebbero individuabili due
filosofie della mitologia: quella di Schelling, che vede nel mito l’espressione
dello spirito; quella positivistico-psicologico-sociologica, che riscontra una
giustificazione della forma culturale mitica a partire unicamente dalla storia e
dall'organizzazione sociale. Cassirer oppone all'interpretazione positivistica del
problema mitico una riflessione trascendentale che si sforza di non dipendere
dall'esterno, dalla società e dalle influenze storiche, apprezzando ed elogiando
piuttosto la teoria di Schelling. Il mito non ricopia la realtà, bensì la struttura.
Anche nello studio del mito, perciò, Cassirer palesa un'impostazione
trascendentale diretta a studiare le condizioni che permettono la nascita di
determinati fenomeni nella storia e nelle diverse culture. Inoltre, il mito non può
che essere una forma pratica, visto il suo intimo legame con la vita dell'uomo,
col suo operare, oltre che col suo pensare e strutturare il mondo. Il mito è, da
103
A. M. van den Bruck (1876-1925), storico e filosofo della politica.
G. L. Mosse, Le origini culturali del Terzo Reich, trad. it. di F. Saba-Sardi, Il
Saggiatore, Milano, 1968.
104
107
sempre, una modalità di intendere il mondo, la modalità "antica" di
comprensione del mondo.
Per riassumere, il mito, l'arte, la religione, la storia, fanno parte dell'universo
simbolico, sono "i fili che costituiscono l'aggrovigliata trama dell'esperienza
umana". Se tutte le forme della vita culturale dell'uomo sono forme simboliche,
allora anche l'uomo potrà ormai essere definito animal symbolicum: in tal modo
si indicherà ciò che lo caratterizza e che lo differenzia rispetto a tutte le altre
specie, e si potrà capire la speciale via che l'uomo ha intrapreso: la via verso la
civiltà, (forse una civiltà superiore se osservata dal punto di vista hitleriano).
Di vero c’è che il Nazionalsocialismo sfrutta la sovrapposizione tra mundus
sensibilis e mundus intelligibilis, tra significante e significato, che il concetto di
forme simboliche alla maniera cassireriana propone: nulla ha significato al di
fuori delle forme che rappresentano il significato stesso. La rappresentazione è
riconosciuta come presupposto essenziale per la costruzione di una conoscenza
e, ancor più (ritornando al Volk), di una coscienza.
Nello studio della cultura totalitaria in genere, si ritrovano solitamente precise
formulazioni in cui si afferma che l’arte non è semplicemente una sfera
autonoma di attività dello spirito umano, ma un oggetto creato secondo scopi
predeterminati, non necessariamente utilizzato a buon fine. È inoltre del tutto
estranea alla coscienza totalitaria il concetto di arte pura, di art pour l’art, di
leggi di evoluzione dell’arte indipendenti dalla volontà umana, trattandosi esse
di teorizzazioni pericolose dal punto di vista delle ideologie dittatoriali stesse.
L’arte nazionalsocialista si ritrova pertanto a svolgere funzioni sociali con lo
scopo di plasmare la coscienza del popolo e di distoglierlo dai compiti urgenti
della lotta di classe. I nazionalsocialisti cercano di riformare l’intera cultura e di
assoggettarla alla loro ideologia, omologando l’arte al proprio apparato di
potere.
Già negli anni di scalata politica, Adolf Hitler dimostra interesse per tutti i
problemi di sensibilità collettiva, riservando attenzione ai segni, ai simboli e ai
colori, elementi essenziali della scenografia di massa. Per questo motivo è
possibile affermare che "l’appello alle masse" e "lo spirito popolare"
rappresentano, nell’arte totalitaria, due facce della stessa medaglia: così
l’appello rivolto dall’arte al popolo, all’Herrenvolk (il popolo dominatore), alla
Weltanschauung (la visione del mondo), si identifica in realtà con un appello
alle masse.
Arte, letteratura, cinema e teatro cessano, durante il periodo nazista, di essere
espressione della personalità dell’artista e vengono tollerati soltanto in quanto
utilizzabili a fini propagandistici. La propaganda stessa acquista lo statuto di
arte di "nuovo tipo" e l’organizzazione della vita artistica rientra costantemente
sotto la sua giurisdizione.
In Germania la camera di cultura dell’impero viene organizzata come parte del
ministero dell’informazione e della propaganda di Goebbels. Fondamentale
importanza ricoprono i suoi diari, a cui era dedicata una parte della giornata e
che riferiscono sulla vita di Goebbels dal 1924 al 1945: egli era così legato alla
108
sua scrittura intimistica, da predisporre che i diari fossero riprodotti in
microfilm e sepolti in una foresta nelle vicinanze di Berlino (da lui considerata
patria spirituale in cui poter dar vita a nuovi mezzi di comunicazione di massa),
mentre gli originali rimasero nella cancelleria del Reich. Con il nome di
Kampfzeit, l’era della lotta, si designa il periodo in cui Goebbels fonda i
giornali, supporto di trasformazione delle informazioni politiche in informazioni
di influenza e quindi di potere, in grado di assicurare il dominio di Hitler (il suo
eroe) sul partito e sulla Germania intera. Come Hitler, Goebbels credeva nella
superiorità della parola detta su quella scritta, come strumento di rigido
controllo. Col passare degli anni Hitler attribuisce a questo ministero,
Ministerium für Volksaufklärung105 und Propaganda, un’importanza sempre
maggiore, assegnandogli stanziamenti più consistenti e concependo la
propaganda come una rivoluzione spirituale del popolo, come un’arte effettiva.
Nel Mein Kampf Hitler si esprime così a tal proposito:
“Ich lernte dabei schon frühzeitig verstehen, dass die richtige
Verwendung der Propaganda eine wirkliche Kunst darstellt [...]
Ho precocemente imparato a comprendere che il giusto utilizzo
della propaganda rappresenta una vera arte […]106.
Die Propaganda bearbeitet die Gesamtheit im Sinne einer Idee und
macht sie reif für die Zeit des Sieges dieser Idee, während die
Organisation den Sieg erficht durch den dauernden, organischen
und kampffähigen Zusammenschluȕ derjenigen Anhänger, die
fähig und gewillt erscheinen, den Kampf für den Sieg zu führen
[...]"
La propaganda lavora la collettività nel senso di un’idea e la
rende matura per il tempo del trionfo di questa idea.
L’organizzazione procura la vittoria aggregando a sé, in modo
costante, organico e belligerante, quei partigiani che appaiono
disposti a combattere per la vittoria107.”
Le arti figurative, la letteratura, il cinema, il linguaggio in genere debbono
operare in favore della propaganda, che a sua volta deve precedere
l’organizzazione politica e guadagnare a quest’ultima il materiale umano da
rielaborare, come se si trattasse di una fabbrica del consenso. La propaganda
105
Ironicamente l’espressione di Aufklärung, illuminismo, rappresenta nel ministero di
Goebbels una maniera totalmente emotiva e irrazionale di accostarsi alla mentalità del
popolo tedesco.
106
A. Hitler, Mein Kampf, p. 193.
107
Ivi, p. 653.
109
cerca così di imporre (eliminata la parola subdolamente) una dottrina al popolo
intero, mentre l’organizzazione mira a comprendere nelle sue cornici
unicamente coloro che non minacciano, da un punto di vista psicologico, di
essere d’ostacolo all’ulteriore diffusione dell’idea bündisch, ovvero corporativa,
del Nazionalsocialismo. La concezione stessa del mondo esige di essere
trasformata in partito e venir riconosciuta come unica ed esclusiva. I manifesti
nazisti che si diffondono al primo apparire del movimento, costituiscono un
solido esempio dell’interazione propagandistica con il popolo, mentre segni e
simboli si fanno emblematici della politica hitleriana: la presenza della svastica,
nera in campo bianco e rosso, diventa sintesi di tradizione, novità e lotta108; i
baffetti del Führer permettono ai fruitori di captare a prima vista la matrice
politica del manifesto. La stilizzazione dei messaggi si accompagna, perciò, ad
un simbolismo visivo e, come M. Crouzet fa notare in Storia del mondo
contemporaneo109, l’arte non separa più artificialmente i problemi di forma dalle
preoccupazioni di sostanza, cerca piuttosto una forma, la sola che sia capace di
esprimere un contenuto umano. Il simbolo, nella sua sintesi di forma e
significato conduce ad una percezione immediata ed essenziale, ovvero a
formule stereotipate del linguaggio, dando la possibilità alle masse di
fronteggiare l’arte, di farla propria e, insieme ad essa, di far proprio anche il
regime. Così scrive Hitler nel Mein Kampf:
“L’organizzazione delle nostre truppe d’ordine richiese la
soluzione di un problema assai importante. Fino allora, il
movimento non possedeva distintivi né bandiere di partito. La
mancanza di questi simboli era dannosa per il presente e
intollerabile per l’avvenire. Gli svantaggi consistevano anzitutto in
questo, che i membri del partito non possedevano un segno esterno
permettente di riconoscere la loro comune appartenenza al nostro
movimento; e per il futuro non era ammissibile la mancanza d’un
distintivo che avesse il carattere d’un simbolo della nostra azione e
che, come tale, potesse essere opposto all’Internazionale. […]
Fummo allora fortemente occupati dal problema della nuova
bandiera, ossia del suo aspetto. Da ogni parte venivano proposte
108
Precisamente il rosso rimanda al socialismo, il bianco all’idea nazionalista e la croce
uncinata color nero ribadisce fermamente la missione di combattere. Dal sanscrito
svastika (derivante da svasti, «fortuna», «felicità»), è il segno costituito da una croce
avente bracci eguali, ripiegati ad angolo retto, che si è caricato di un valore magicoreligioso connesso con il movimento rotatorio del sole. Il segno – presente, sembra, sin
dal IV millennio a.C. nell’Asia mesopotamica, poi in India e nel Tibet – viene assunto
in Germania sin dal primo Novecento,come emblema dei movimenti razzisti antisemiti;
da questi passa al nazismo.
109
M. Crouzet, Storia del mondo contemporaneo, trad. it. di G. Manacorda, Sansoni,
Firenze, 1974.
110
che rivelavano buone intenzioni ma valevano poco. Perché la
nuova bandiera doveva non solo essere il simbolo della lotta ma
anche fare un grande effetto negli affissi, nei manifesti ecc. Chi ha
molto a che fare con la massa, sa che queste apparenti minuzie
hanno grande importanza. Un’insegna producente grande
impressione può in migliaia di casi dare la prima spinta ad
interessarsi ad un movimento. Per tale motivo dovremmo declinare
le proposte, venute da molti lati, di identificare, per mezzo d’una
bandiera bianca, il nostro movimento col vecchio Stato, o meglio,
con quei fiacchi partiti la cui unica meta è la ricostruzione d’un
regime tramontato. Inoltre, il bianco non è un colore trascinante. È
adatto a caste associazioni di fanciulle, non a travolgenti movimenti
d’un epoca rivoluzionaria. Fu pure proposto il nero: conveniva,
bensì, al nostro tempo di lutti, ma non conteneva nessuna chiara
rappresentazione della volontà del nostro movimento. Ed anche
questo colore non è abbastanza trascinante. […] Al nero-rosso-oro"
(quella dell’antico impero medievale) "non era il caso di pensare. E
nemmeno al nero-bianco-rosso," (quella della Repubblica di
Weimar) "per i già citati motivi: almeno, non nel modo in cui quei
colori erano disposti finora. Questa associazione di colori è di gran
lunga più mirabile d’ogni altra. È l’accordo più radioso che esista.
[…] Dopo innumerevoli saggi, compilai la forma definitiva: una
bandiera di panno rosso con un disco bianco, nel cui mezzo stava
una nera croce uncinata. Dopo lunghi tentativi trovai pure un
determinato rapporto fra la grandezza della bandiera e quella del
disco bianco, e così pure tra la forma e l’intensità della croce
uncinata dipinta. Ed al mio progetto ci attenemmo. […]Ed è in
realtà un simbolo110”
Nell’ottobre 1940 Goebbels fonde la direzione artistica e quella politica del suo
ministero, subordinando a tutti gli effetti l’arte agli scopi politici. Così viene
messo in luce come il compito dell’arte e degli artisti non sia soltanto quello di
unire la collettività: compito loro è di modellare, plasmare mantenendo un
legame costante con il popolo. Soltanto un’arte che crei attingendo pienamente
alla nazione può in definitiva assumere un ruolo di spicco per il popolo, per il
quale è stata creata. Sulle basi di queste speculazioni, l’arte nazionalsocialista
rivela la tendenza a soddisfare un bisogno di oggettività che si contrappone
all’instabilità, al soggettivismo, all’affermazione individuale, in un rapporto che
Berthold Hinz in L’arte del nazismo (Milano, 1975, p.21) definisce di
"correlazione": essa si trova in effetti in una realtà soprastorica e permanente
110
A. Hitler, op. cit., trad. it. di B. Revel, La mia battaglia, Bompiani, Milano, 1939
(nel testo riporto direttamente la traduzione data la lunghezza del passo).
111
che si prefigge di partire dal temporale per approdare all’eternità. Secondo le
concezioni di Goebbels, l’artista non deve più credere di dipingere per il suo
tempo, al contrario, deve cogliere il senso di una negazione del tempo storico in
cui vive ed opera, per trasformarlo in uno spazio del fare artistico, per pervenire
ad "un’arte ontologica, sostanziale", per citare Hinz. Una sostanzialità dell’arte
che si purifica dalla degenerazione (i nazionalsocialisti parlavano di Deutsche
Kunst ed Entartete Kunst, arte tedesca e arte degenerata appunto), si associa ad
una sostanzialità del popolo, che deve essere ripulito dai gruppi dei cosiddetti
emarginati al fine di costituirsi come pura razza ariana. Una definizione
sostanziale di arte e di popolo che può determinarsi come tale, in realtà, solo se
riletta, alla maniera cassireriana, in termini di funzionalità.
Nonostante E. Cassirer non appoggi mai il movimento nazionalsocialista e,
anzi da questo venga pure perseguitato data la sua origine ebraica, un confronto
tra le sue teorizzazioni filosofiche e il meccanismo politico hitleriano di
assoggettamento dell’arte al regime per trarne beneficio politico, non è affatto
azzardato. La direttiva secondo la quale l’arte totalitaria deve essere
comprensibile al popolo, oltre che fondamentalmente appoggiata dal consenso
di Adolf Hitler, costituisce un argomento centrale nella lotta per il realismo e
funge da raccordo con la Philosophie der symbolischen Formen di Ernst
Cassirer, che è in grado di delineare chiaramente il concetto di interdipendenza
tra arte e politica che sussiste all’interno del movimento nazionalsocialista del
Terzo Reich.
In nessun caso come nel Nazismo, l’identificazione di politica e arte è forse mai
apparsa tanto evidente. La stessa persona del Führer diventa un’icona,
un’incarnazione simbolica del potere politico, della nazione tedesca, del popolo.
L’arte totalitaria hitleriana può essere considerata un realismo di tipo
particolare, diverso da tutti gli altri realismi europei, poiché riflette ideologia e
mito in guisa di realtà e offre un metodo per instillare nella nazione e nel mondo
una percezione particolare, "totalrealista", come la definisce Igor
Golomstock111, arrivando ad oltrepassare ed estremizzare l’Ottocento realista,
prediletto peraltro da Hitler, sino a raccogliere gli empiti più antichi dell’arte e
recuperare i canoni classici. L’idea della lotta come forza trainante della storia e
rappresentata da immagini di guerra oltre che da uno scontro eroico dell’uomo
verso la natura, ritratti celebrativi di Hitler (sia nella pittura che nella scultura
monumentale), temi storico-rivoluzionari volti a presentare il "creatore" della
storia del Terzo Reich a capo delle masse rivoluzionarie, rappresentazioni
allegoriche del dittatore, raffigurazioni della quotidianità popolare e della
dedizione al lavoro e ancora paesaggi industriali in segno di avanzamento
sociale: con questi raggruppamenti tematici, l’arte totalitaria si pone al servizio
del culto nazionalsocialista, attribuendo alle opere d’arte il carattere simbolico
della sacralità e imponendosi come apoteosi del progresso. Così, per quanto
111
Cfr. Ivan Golomstock, L’arte totalitaria, Leonardo, Milano, 1990.
112
l’intera opera di Albert Speer, capo architetto del Terzo Reich, si sia attivata per
sublimare nell’arte gli intenti politico-propagandistici, il carattere estetico del
potere nazionalsocialista si conferma, a mio parere, come stile "oggettivante"
per la produzione e l’appropriazione di una realtà che riveste anche la volontà di
un popolo di identificarsi con l’inarrestabilità di una necessità storica.
Maristella Cervi
Maristella Cervi ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Teoria e Analisi del
testo, presso l’Università degli Studi di Bergamo.
7RQLQR1HJUL6FXOWXUDFHUDPLFD´$UWHLQ*LDUGLQRµ,VRODG·(OED
113
7RQLQR1HJUL6FXOWXUDFHUDPLFD´$UWHLQ*LDUGLQRµ,VRODG·(OED
Il concetto di critica in Foucault:
dalla Riforma a Kant.
di Antonio Coratti
Niente mi è più estraneo dell’idea di un padrone
che impone la propria legge
Foucault
INTRODUZIONE
Come Kant, nel suo famoso articolo del 1784, Risposta alla domanda: Che
cos’è l’Illuminismo, aveva incitato i suoi contemporanei al Sapere aude, al
coraggio di uscire dallo stato di minorità in cui versavano, così Foucault, in
una sua conferenza del 1978, Qu’est-ce que la critique? (Critique et
Aufklarung), invita gli individui del XX secolo ad appropriarsi degli spazi di
libertà che spettano loro di diritto, attraverso la critica, cioè attraverso un
atteggiamento, una vera e propria arte dell’esistenza.
E’ in questo contesto che l’autore di Sorvegliare e punire, delinea nuove
prospettive nel rapporto tra soggetto e potere.
La filosofia della cura di sé, la prova storico-pratica, l’arte di non essere
eccessivamente governati, sono concetti alla base della consapevolezza che
deve infondersi nel soggetto, nel singolo individuo, nell’elaborare il suo
rapporto con tutte quelle forme di dominio, manifeste o latenti, che,
quotidianamente, tentano di dirigere il suo corpo, la sua anima.
E’ solamente acquisendo questa consapevolezza che la critica diventa virtù,
diventa lo strumento per fare dell’uomo un soggetto storico in grado di
resistere, combattere, dare forma nuova al corso della storia stessa, della sua
propria storia.
Oltre il dominio.
Il pensiero di Michel Foucault è stato sempre caratterizzato da un rapporto
ambivalente tra le forme di potere che di volta in volta ha preso in
considerazione nelle sue ricerche e il soggetto su cui il potere agisce.
Sicuramente, il fatto che Foucault, soprattutto nei suoi primi scritti, si sia
dedicato profondamente ad indagare i rapporti di coercizione esercitati
all’interno di istituzioni totali, come carceri e case di internamento, ha
contribuito a far emergere visioni pessimistiche sulle possibilità di libertà
aperte agli individui, soffermandosi, come lui stesso afferma, “troppo sulle
115
tecniche di dominio” (Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste.
Volume III 1978-1985, Feltrinelli, Milano 1998).
In questo contesto, sono evidenti i motivi che hanno portato Foucault a
denunciare i limiti di quelle scienze, come ad esempio le scienze umane, che
tendono a dominare, ad imbrigliare ogni devianza dal sistema scientifico
stesso, non consentendo spazi di autonomia e libertà al di fuori dei canoni
ufficiali e facendo dell’individuo, un oggetto calcolabile e descrivibile.
La conferenza tenuta da Foucault nel 1978 presso la Société Française de
Philosophie, dal titolo Qu’est – ce que la critique? (Critique et Aufklarung),
può essere interpretata, nel concetto di critica elaborato, come un momento di
cesura nel pensiero foucaultiano, attraverso cui l’autore giungerà ai suoi
ultimi scritti, incentrati, in particolar modo, su una nuova concezione
dell’individuo.
Nell’ultimo Foucault, infatti, per l’individuo, inteso non più come mero
prodotto, investito in tutto il suo essere da relazioni di potere che lo
dominano e che, tutt’al più, egli affronta con quel minimo di resistenza
(anche se solo corporea, come in Sorvegliare e punire) di cui è capace, si
apre un territorio, non ancora esplorato, in cui egli instaura un certo tipo di
rapporto con se stesso, che non si configura necessariamente nella forma del
dominio e dell’indottrinamento. All’interno dei nuovi confini sono
accessibili, per i soggetti, spazi di auto-creazione, di edificazione di se stessi,
non solo attraverso codici imposti dai meccanismi sociali e culturali, ma
anche, e soprattutto, attraverso regole che l’individuo sceglie, allo scopo di
creare se stesso nel migliore dei modi possibili.
E’ Foucault stesso ad evidenziare questa nuova prospettiva durante un’altra
conferenza, tenutasi nel 1981, dal titolo Sessualità e solitudine : “Poco a poco
mi sono reso conto che in tutte le società esiste un altro tipo di tecniche:
quelle che permettono agli individui di effettuare, autonomamente, alcune
operazioni sui loro corpi, le loro anime, i loro pensieri, le loro condotte, e
questo in modo da produrre una trasformazione di se stessi, una
modificazione, e da raggiungere un certo stato di perfezione, di felicità, di
purezza, di potere soprannaturale. Chiamiamo queste tecniche le tecniche del
sé” (Ibidem).
Pur non cessando di essere pervasi dalle ragnatele del potere, per gli individui
si aprono nuovi spazi di autonomia, di azione, di resistenza attiva e, perfino,
di libertà. “Se si vuole analizzare la genealogia del soggetto nella civiltà
occidentale – continua Foucault – si deve tener conto non soltanto delle
tecniche di dominio, ma anche delle tecniche del sé. Si deve mostrare
l’interazione che si produce tra i due tipi di tecniche” (Ibidem).
116
Critica come atteggiamento.
Il riferimento al termine tecnica non è casuale per introdurre il concetto
foucaultiano di critica. Come l’autore afferma nella conferenza del 1978
“quel che per secoli nella Chiesa greca si è chiamata technè technòn,…era
proprio la direzione di coscienza, l’arte di governare gli uomini” (M.
Foucault, Illuminismo e Critica, Donzelli, Roma, 1997) e la critica si pone
come éthos filosofico, come atteggiamento limite, come l’arte di non essere
eccessivamente governati. “Non si tratta di un atteggiamento di rigetto.
Dobbiamo sfuggire all’alternativa del fuori e del dentro; dobbiamo stare sulle
frontiere… Caratterizzerò dunque l’ethos filosofico, proprio dell’ontologia
critica di noi stessi, come una prova storico–pratica dei limiti che possiamo
superare, e quindi come un lavoro di noi stessi su noi stessi in quanto esseri
liberi” (Ibidem).
E’ da evidenziare il fatto che, all’interno della conferenza sul concetto di
critica, il richiamo a Kant sia incentrato sull’analisi dell’articolo del filosofo
tedesco: “Risposta alla domanda: Che cos’è l’Illuminismo?” apparso nel
1784 e non sulle sue tre opere maggiori e più note.
Foucault sottolinea come nel suo articolo Kant, da un lato, abbia
caratterizzato l’Aufklarung in rapporto a uno stato di minorità nel quale
sarebbe tenuta, in maniera autoritaria, l’umanità e, dall’altro, abbia definito
questa minorità come l’incapacità dell’umanità di servirsi del proprio
intelletto senza la direzione di un altro. Se è vero, quindi, che Kant ha
effettivamente imputato la causa della minorità umana ad un’autorità che
esercita il suo potere oppressivo, è altrettanto vero che ha imputato questa
minorità a una mancanza di decisione e di coraggio dell’uomo stesso.
Seguendo questa interpretazione, Foucault evidenzia che, se la riflessione sui
limiti, presente nella Critica della Ragion Pura di Kant, consisteva
nell’indagare fin dove, attraverso la ragione, la conoscenza può
legittimamente spingersi e dove, al contrario, essa non trova più fondamento
di verità, il compito della critica della modernità, nel senso di Aufklarung,
consiste proprio nel superamento di questi limiti.
Sarebbe importante, secondo Foucault, riproporre l’Aufklarung come
questione centrale del mondo contemporaneo, proprio come fece Kant nel
suo articolo, che si presentò, all’epoca, come una critica, ovvero, un
atteggiamento critico, nei confronti dell’attualità che si stava vivendo in quel
preciso momento storico, un’analisi di ciò che è in rapporto al presente stesso
e non più in riferimento al passato, come modello da imitare o, comunque,
con cui confrontarsi.
E’ in questo senso che Foucault, in un’opera successiva, dichiarerà di
vedere nell’Illuminismo la prima epoca che si riconosce il nome che porta,
basata su una nuova filosofia, quella dell’ontologia dell’attualità (M.
117
Foucault, L’uso dei piaceri. Storia della sessualità 2, Feltrinelli, Milano,
1984).
Paolo Napoli, nella sua introduzione alla conferenza di Foucault, Qu’est – ce
que la critique? (Critique et Aufklarung), chiarisce il pensiero di Foucault sul
concetto di ontologia dell’attualità: “L’Illuminismo instaura una presa diretta
col mondo, al punto che i criteri per comprendere derivano anch’essi da quel
mondo, non possono essere presupposti in maniera astratta nell’uomo. Le
manifestazioni della ragione sono integralmente storiche, è questo il valore
permanente dei Lumi” (M. Foucault, Illuminismo e Critica, Donzelli, Roma,
1997).
L’immersione totale nel presente fa sì che l’Illuminismo stesso diventi ethos
filosofico, assuma a pieno i connotati del concetto di critica foucaultiano,
diventi atteggiamento nei confronti del presente e solo di esso, senza rimandi
a epoche altre.
Ma l’aspetto più rilevante del discorso di Foucault è quello di non trattare il
problema della critica in termini di filosofia, ma come atteggiamento da
assumere, richiamandosi fortemente all’incitamento al Sapere aude di Kant.
“La critica non appare lo strumento di un’egemonia intellettuale che segna il
privilegio di una casta; … è, invece, una forma di vita che caratterizza
l’autonomia etica di ogni individuo, il lavoro progettuale di un’esistenza.
Sottratta alla rigidità del metodo, essa resta l’esperienza pratica in cui
concepire l’esercizio della libertà” (Ibidem).
Il Soggetto e la cura di sé.
L’atteggiamento critico (come l’arte di non essere eccessivamente governati)
si pone alla base delle nuove forme di soggettività che Foucault spera
possano affiorare sulle ceneri dell’uomo, del soggetto ermeneutico cristianofreudiano, ormai morto. “Il problema politico, etico, sociale e filosofico
oggi, non è tanto di liberare l’individuo dallo Stato e dalle sue istituzioni,
quanto liberare noi stessi sia dallo Stato che dal tipo di individualizzazione
che è legato allo Stato” (M. Foucault, La cura di sé. Storia della sessualità 3,
Feltrinelli, Milano, 1984).
E’ in questo contesto che Foucault inserisce le tecniche del sé di cui abbiamo
accennato in precedenza.
Nel terzo volume sulla Storia della sessualità, Foucault evidenzia come
l’austerità nelle pratiche sessuali, o, comunque, la definizione di contesti e
limiti, non siano nati con la diffusione della morale cristiana, ma siano stati
presenti già nelle filosofie fondate sulla cultura di sé, sia nell’antica Grecia
che nella Roma imperiale. La differenza sostanziale consiste nel fatto che,
mentre la morale cristiana condannerà il sesso, il piacere, in sé, la più antica
filosofia della cura di sé interpretava la resistenza ai piaceri, ai desideri, come
118
una virtù che l’uomo voleva raggiungere per sé e solo per sé, ovvero senza il
dovere di renderne conto ad alcun sistema sociale, istituzionale o legale.
Essendo questo atteggiamento un elemento di scelta esclusivamente
personale, uno spazio di reale autonomia in cui l’individuo decide
volontariamente e razionalmente di dominare i propri istinti, le proprie
pulsioni, Foucault arriva a parlarne come una vera e propria etica.
Più esattamente, Foucault parla di un’etica come estetica dell’esistenza, come
lavoro su se stessi, costruzione del proprio essere del proprio stile di vita,
senza costrizioni esterne, nel nome della pura libertà su se stessi, sul corpo e
nell’animo. Con il Cristianesimo, la cura di sé si associa ai precetti religiosi
che predicano la rinuncia a se stessi, ai desideri, ai piaceri corporei, in nome
della salvezza eterna: quella che era un’estetica dell’esistenza, diventa una
forma di egoismo, di amor proprio nel senso rousseauiano del termine.
La cura di sé era una forma di governo di se stessi che si poneva alla base
dell’etica civile e del governo delle relazioni nella famiglia come nella
comunità, “ .. è il potere su se stessi che regola il potere sugli altri” (Ibidem).
“Nel nostro tempo” - sostiene Foucault - “dal momento che la maggior parte
di noi non crede più che l’etica possa essere fondata sulla religione, e dato
che non vogliamo un sistema legale che interferisca con la nostra vita privata,
morale e personale, dovremmo riflettere sulla possibilità di promuovere
nuove forme di soggettività attraverso il rifiuto di quel tipo di individualità
che ci è stato imposto per così tanti secoli” (Ibidem).
Kant e Foucault.
Nonostante il fatto che per introdurre il suo discorso sull’autonomia e la
libertà dell’individuo nella conferenza del 1978, Foucault abbia più volte
fatto riferimento all’esortazione di Kant al Sapere aude, tuttavia, riconosce
egli stesso che un’assimilazione incondizionata del concetto di Aufklarung
nel senso kantiano e del concetto di critica come atteggiamento, non sarebbe
corretto, in quanto “si potrebbe facilmente dimostrare che per lo stesso Kant
il reale coraggio di sapere, consiste nel riconoscere i limiti della conoscenza e
che per lui l’autonomia è lungi dall’essere opposta all’obbedienza ai sovrani”
(M. Foucault, Illuminismo e Critica, Donzelli, Roma, 1997).
Il Kant che Foucault rimuove decisamente, è quello che concepisce
l’autonomia in astratto, sulla base di canoni universali, dove, per il filosofo
francese, il problema del governo di se stessi, obiettivo positivo della critica,
risponde sempre a quel momento di differenza storica di cui l’idea di
presente è, per sua natura, portatrice e che nessun principio normativo a
priori può sopprimere.
L’uomo non deve essere pensato e la sua azione non può essere concepita al
di fuori della storia attuale; immerso in una radicale condizione storica, il
119
soggetto non ce la fa ad assumere una posizione valida a priori, all’esterno
del mondo che gli sta innanzi e del tempo in cui vive.
Ma è proprio questo rapporto così stretto tra il soggetto e la sua storia che
non permette di fondare l’atteggiamento critico su principi generali e
universali; ciò che caratterizza in maniera radicale il concetto di critica
foucaultiano è che esso, per manifestarsi, deve essere riferito a un
determinato contesto storico e a determinati rapporti, relazioni, tra il potere e
il soggetto su cui questo potere esercita la sua coercizione.
Ad una domanda postagli al termine della conferenza, Foucault risponde
evidenziando fortemente come l’atteggiamento critico che spinge ad
esprimere la volontà di non essere governati non sia una sorta di aspirazione
originaria, ma risponda alla volontà di non essere governati così, in un certo
modo, da questo o da quello, a un dato prezzo.
Sapere e Potere.
Accantonata la riflessione sulla differenza tra il concetto di Aufklarung e di
Critica nel pensiero kantiano, Foucault si propone di considerare l’aspetto
storico della questione tra il XIX e il XX secolo, in cui lo sviluppo della
scienza positivistica, di un sistema statale che si imponeva come ragione e
come razionalità profonda della storia e di una scienza dello Stato stesso,
avevano legittimato, di fatto, la Critica kantiana, molto più che il Sapere
aude dell’Aufklarung.
La questione dell’Aufklarung a partire da Kant, “per opera sua e
probabilmente in ragione di questo scarto tra Aufklarung e Critica che egli ha
introdotto”, è stata posta essenzialmente in termini di conoscenza,
“ovverossia partendo da quello che fu il destino storico della conoscenza al
momento della costituzione della scienza moderna”, fino a interrogarsi sulla
“legittimità dei modi storici del conoscere” (Ibidem) e della conoscenza
stessa.
A questo approccio Foucault propone di sostituirne un altro che indaghi
l’Aufklarung secondo il tema, non della conoscenza, ma del potere, mettendo
da parte la questione della legittimità e fondandosi sulla procedura di
evenemenzializzazione.
“Si tratta – dice Foucault – in questa pratica storico–filosofica, di farsi la
propria storia, di fabbricare, come per finzione, la storia che sarebbe
attraversata dal tema dei rapporti tra le strutture razionali che articolano il
discorso vero e i correlati meccanismi di assoggettamento (…) la questione
sposta gli oggetti familiari agli storici sul terreno del soggetto e della verità”
(Ibidem).
La differenza sostanziale con ogni filosofia della storia e con la storia della
filosofia consiste in un “ritorno all’empiricità attraverso il contenuto storico
120
stesso, che si sostituisce all’insieme dei contenuti storici elaborati altrove,
preparati dagli storici e recepiti come meri fatti” (Ibidem).
Partire dal contenuto storico attuale, secondo Foucault, significa innescare un
genere di procedura che, “sottraendosi al criterio della legittimazione…percorre il ciclo della positività, movendo dal dato dell’accettazione
per giungere al sistema dell’accettabilità, analizzato alla luce del gioco
sapere-potere” (Ibidem).
Se l’interpretazione dell’Aufklarung secondo il tema della conoscenza e della
legittimazione ha condotto, paradossalmente, al furore del potere, ciò è da
imputare al nesso inscindibile tra i due elementi: non si forma senso se non
come effetto di strutture coercitive. Già in Sorvegliare e punire (1975)
Foucault aveva evidenziato come ogni sapere, ogni verità, fosse il correlato
di un’applicazione coercitiva sui corpi, sulla materia, ovvero su ciò che c’è di
più basso.
Allo stesso modo, nulla può funzionare come meccanismo di potere se non si
afferma con procedure, strumenti, mezzi, obiettivi, che possano essere
convalidati in sistemi più o meno coerenti di sapere. Il problema da porsi,
quindi, non è descrivere ciò che è sapere e ciò che è potere, ma individuarne
il legame, così da cogliere le condizioni di accettabilità di un sistema.
Il concetto di Evento.
Nel primo scritto di Foucault, l’introduzione ad un trattato di psicologia di
Ludwig Binswanger, Sogno ed esistenza (1954), il tema centrale è
l’affermazione del sogno come simbolo, piuttosto che semplice segno, come
vorrebbe l’interpretazione freudiana, che associa il sogno a una
manifestazione dell’inconscio. Nel simbolo, sostiene Foucault, il significato
vi è già contenuto nella sua immediatezza, senza alcuna funzione referenziale
che opera, invece, nel concetto di segno. Il soggetto del sogno è il sogno
stesso, inteso nella sua totalità, nel suo essere événement, e non più
l’individuo, l’io che sogna. Interpretato come “la maniera radicale di fare
l’esperienza del proprio mondo” (M.Foucault, Introduzione a Sogno ed
esistenza, 1954) il sogno si configura, quindi, come verità autentica,
assoluta.
In L’archeologia del sapere (Rizzoli, Milano, 1971), l’oggetto di studio sono
i discorsi, considerati non come semplici insiemi di segni che rimandano a
contenuti e rappresentazioni che esistono a prescindere dal fatto di essere
nominati, ma “pratiche che formano sistematicamente gli oggetti di cui
parlano”.
Alla nozione di discorso Foucault preferisce, infatti, quella di enunciato, che
include in sé, contemporaneamente, il soggetto che parla, il testo e l’oggetto
di cui si parla, in un’immanenza che “non necessita di alcun rimando a
121
referenti originari”(Ibidem). In questo modo l’enunciato diventa événement:
“esso non viene più considerato semplicemente come la messa in opera di
una struttura linguistica, né come la manifestazione episodica di un
significato più profondo; viene considerato nella sua irruzione storica …Un
enunciato è sempre un événement che né la lingua, né il senso possono
completamente esaurire” (Ibidem).
E’ in questa prospettiva che Foucault introduce il livello archeologico di
indagine nella conferenza che abbiamo analizzato, riferendolo a quei sistemi
storici, caratterizzati da connessioni tra meccanismi di coercizione e
contenuti di conoscenza, che vengono osservati empiricamente in quanto già
accettati nel sistema, per poi analizzare e cercare di capire ciò che li rende
accettabili, non in generale, ma solo là dove questo avviene storicamente.
Scavo archeologico e ricerca genealogica.
Come l’enunciato ne L’archeologia del sapere costituiva una positività in sé,
così l’événement qui preso in considerazione (ovvero l’insieme di elementi in
cui interagiscono questo elemento di sapere, sia questo meccanismo di
potere), è preso come totalità positiva reale, ma non necessaria.
E’ chiaro come l’importante, a questo punto dell’analisi, non sia la questione
della legittimità, ovvero sapere quel che è vero o falso, fondato o infondato,
reale o illusorio, scientifico o ideologico, legittimo o abusivo; ma indagare
quali sono i legami, le connessioni che possono essere segnalati tra
meccanismi di coercizione ed elementi di conoscenza, quali giochi di
rimando e sostegno reciproco si instaurano.
Un aspetto che Foucault evidenzia a questo punto della conferenza è la
problematicità che sorge dal momento che “queste positività non si sono rese
accettabili grazie a qualche diritto originario, non si giustificano di per sé,
non costituiscono un a-priori e non sono contenute in alcuna anteriorità” (M.
Foucault, Illuminismo e Critica, Donzelli, Roma, 1997).
E’ evidente che l’intento del filosofo francese sia quello di evitare che si
possa pensare ad un fondamento, ad un sistema alla base del suo discorso
sull’événement, ovvero tornare ad una filosofia della storia, o, ancora peggio,
ad un’analisi storica che tratti le sue positività come elementi da analizzare
attraverso il ricorso alle classiche procedure esplicative.
A una genesi che si orienta verso l’unità di una causa principale gravida di
una discendenza multipla, si tratterebbe di opporre una genealogia, vale a
dire il tentativo di “restituire le condizioni dell’emergere di una singolarità a
partire da fattori multipli di determinazione, di cui non sarebbe il prodotto ma
l’effetto” (Ibidem).
Come Nietzsche aveva usato il concetto di genealogia per demistificare la
morale e spogliarla del suo carattere assoluto, eterno, riconducendola alle sue
122
origini umane, troppo umane, cosi Foucault, staccando l’ événement da
un’origine logica, da un principio di necessità, lega la loro esistenza a
semplici condizioni di accettabilità, a partire dalle quali si instaurano una
serie di relazioni discontinue, di interazioni fra le diverse positività, in cui
nessuna di queste relazioni, interazioni, risulti primaria o totalizzante.
“L’intento non è quello di non considerare più valido il principio di causalità,
che, anzi, è chiamato molte volte ad agire in questa rete di relazioni, ma
quello di evidenziare che la singolarità che emerge da questa mobilità
perpetua, da questa essenziale fragilità, si configuri come mero effetto”
(Ibidem). E se l’événement da prendere in considerazione in questo nuovo
approccio pratico-storico non è effetto di una causa unica e necessaria, ma di
una logica tipica di un gioco di interazioni, “con i suoi margini sempre
variabili di incertezza, in cui confluiscono rapporti tra individui e gruppi di
persone, che implicano soggetti, tipi di comportamento, decisioni, scelte, si
tratta di riuscire a sviluppare nuove forme di analisi strategiche”(Ibidem).
Analisi che devono tenere in forte considerazione, dunque, il potere esercitato
dai singoli individui, dai singoli événements.
Il tema del potere, da cui Foucault era partito per teorizzare la sua originale
interpretazione dell’Aufklarung, perde il suo carattere di unico principio
esplicativo, inserendosi in un rapporto indissociabile con diverse forme di
sapere e sempre inserito in un campo di possibilità e quindi di reversibilità,
di possibile ribaltamento.
Il potere non si esercita mai in via esclusiva in un determinato periodo
storico, per determinati obiettivi, ma i suoi dispositivi coercitivi provengono
sempre da tecniche più antiche, nate, magari, in contesti e per finalità diverse.
“Quando queste tecniche riaffiorano, in corrispondenza di certe svolte locali
della storia e, sempre, per un gioco di forze, il fatto di essere riadattate in altri
contesti e per altre finalità, produce effetti di verità nuovi, discorsi di potere
diversi, crea nuovi soggetti e nuovi oggetti”(Ibidem).
Il concetto di evenemenzializzazione risiede, essenzialmente, “nella
consapevolezza di qualcosa la cui stabilità, il cui radicamento e fondamento,
non sono mai tali da impedire, in qualche misura, se non di immaginarne la
scomparsa, almeno di decifrare i fattori che rendono questa scomparsa
possibile” (Ibidem).
Critica e governamentalizzazione: la Riforma.
Finora abbiamo, per lo più, evidenziato come nella conferenza sul concetto
di critica, Foucault lo abbia interpretato come un atteggiamento a
disposizione del soggetto, del singolo individuo. E’ Foucault stesso a
sostenere che “la critica, in sostanza, designa il movimento attraverso il
quale il soggetto si riconosce il diritto di interrogare la verità nei suoi effetti
123
di potere e il potere nei suoi discorsi di verità” (Ibidem).
In realtà, c’è un’altra chiave di lettura che interpreta l’atteggiamento critico
in riferimento, non al soggetto storico, al singolo individuo, ma a eventi
capitali della storia dell’occidente. In particolare, l’attenzione di Foucault è
incentrata sul fenomeno della Riforma, essendo la critica storicamente
biblica.
Come per il fenomeno dell’Aufklarung, anche in questo contesto Foucault
parte dall’articolo kantiano del 1784, in cui, riferendosi alla minorità, come
incapacità dell’umanità di servirsi del proprio intelletto senza la direzione di
un altro, Kant adotta il termine leiten, che “ha un senso religioso,
storicamente definito” (Ibidem).
E’ dunque chiaro come la governamentalizzazione si strutturi, nel pensiero
di Foucault, in modo peculiare, sulla direzione di coscienza esercitata dalla
Pastorale Cristiana per molti secoli.
Ma come giunge l’autore di Sorvegliare e Punire a vedere nel governo delle
anime la manifestazione più oppressiva di potere esercitato sugli uomini,
tanto da far emergere la critica, intesa, ora, nel senso di fenomeno storico,
culturale e sociale?
In realtà, già nell’evoluzione dei meccanismi di potere e di controllo, nel
passaggio dallo splendore dei supplizi al panoptismo, si possono rintracciare
le radici di questo pensiero foucaultiano.
Il momento del passaggio da punizioni corporee, che dovevano essere tanto
più cruente, quanto più dovevano esaltare la potenza del re, del sovrano, a
un potere esercitato silenziosamente e quotidianamente, non più per
martoriare, distruggere il corpo, ma per sfruttarne le risorse fino in fondo,
avviene in nome dell’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle
potenzialità del corpo. Il sapere, come abbiamo accennato precedentemente,
nasce, secondo Foucault, dal potere esercitato sul corpo, perché il corpo
racchiude una straordinaria capacità di resistenza, che stimola il potere alla
formazione di nuove relazioni da esperire, nuove metodologie, ovvero,
nuovo sapere.
Guidato dal metodo genealogico, Foucault rintraccia le modalità di
funzionamento del panoptismo (trasparenza, visibilità totale, attenzione ad
ogni minimo particolare negli atteggiamenti degli individui) nelle pratiche
di confessione della Pastorale cristiana.
L’attività pastorale della Chiesa cristiana era basata sull’idea,
completamente estranea alla cultura antica, che ogni individuo, per tutta la
sua vita, deve essere governato e lasciarsi governare verso la salvezza da
qualcuno al quale sia legato da un rapporto globale e, al tempo stesso,
particolareggiato, articolato, di obbedienza.
Il problema è sorto quando questa attività di direzione della coscienza si è
laicizzata, uscendo fuori dai conventi, dai ristretti gruppi spirituali,
124
espandendosi nell’ambito della società civile fin da prima della Riforma.
E’ chiaro, afferma Foucault, che la critica, “in un’epoca in cui il governo
degli uomini era essenzialmente un’arte spirituale, una pratica derivata
dall’autorità di una Chiesa” (Ibidem), si sia manifestata in un movimento
che cercasse con la Scrittura un rapporto diverso da quello legato al
funzionamento della dottrina di Dio.
Se “oggi il termine riforma indica la modifica di una situazione esistente con
qualcosa di nuovo e di diverso, nel linguaggio del XVI secolo, riformare
voleva dire rimuovere ciò che si era aggiunto nei secoli e riportare le cose a
come Dio le aveva concepite” (M.Rubboli, I protestanti, Il Mulino, Bologna,
2007).
Anche per quanto riguarda il movimento della Riforma, dunque, non si tratta
di un atteggiamento critico che intenda affermare il diritto a non essere
governati in assoluto, ma quello di non essere governati a determinate
condizioni, di essere liberi di poter mutare il proprio rapporto con questo
potere, questa verità.
In fondo “governare significa strutturare il campo di azione possibile degli
altri” e non implica riferimenti a origini naturali, normali; anche “il
governare appare come evento della storia, che va riportato in superficie per
mostrare il limite della sua comparsa e ipotizzare la possibilità del suo
mutamento” (M. Foucault, Illuminismo e Critica, Donzelli, Roma, 1997).
Il messaggio di Foucault.
Nonostante questa seconda possibile lettura interpretativa della conferenza
di Foucault sul concetto di critica, riteniamo che il fatto della scelta della
Riforma, come movimento storico di critica, riconduca al rapporto della
critica direttamente con il soggetto, con il singolo individuo.
Proprio ponendo il governo come arte pratica, come événement, come
semplice strumento per penetrare nella storia, Foucault sottolinea il
carattere occasionale anche dei movimenti, come la Riforma, che si
oppongono ad un governo in un determinato periodo; come per lanciare un
messaggio all’individuo, mostrandogli che, in fin dei conti, è lui stesso ad
avere il potere di sottrarsi al governo (a maggior ragione della sua anima)
come meglio crede, secondo le sue esigenze, i suoi desideri, le sue
aspirazioni.
“Si comprende come il gioco reciproco della governamentalizzazione e della
critica abbia prodotto fenomeni capitali nella storia della cultura occidentale.
Ma il nucleo originario della critica rinvia a quel fascio di rapporti in cui si
intessono i problemi del potere, della verità e del soggetto” (Ibidem).
Come Kant, nel suo articolo Risposta alla domanda: Che cos’è
l’Illuminismo, aveva incitato al Sapere aude i suoi contemporanei, così
125
Foucault rassicura l’uomo del XX secolo sugli spiragli di libertà che
l’atteggiamento critico, come una vera e propria virtù, ancora garantisce,
intatti.
Antonio Coratti
Il dott. Antonio Coratti è laureato in Filosofia e Scienze della Comunicazione.
BIBLIOGRAFIA
Archivio Foucault 2 (1971-1977); Feltrinelli, Milano 1997
Archivio Foucault 3 (1978-1985); Feltrinelli, Milano 1997
Binswanger L.(1954): Sogno ed esistenza, SE, Milano 1993
Dreyfus-Rabinow: La ricerca di Michel Foucault. Analitica della verità e
storia del presente, Ponte alle Grazie Edizioni, Firenze 1989
Foucault M. (1961): Storia della follia nell’età classica, Rizzoli Editore,
Milano 1994
Foucault M.(1966): Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze
umane, Rizzoli Editore, Milano 1996
Foucault M.(1975): Sorvegliare e punire. Nascita della prigione,
Einaudi, Torino 1995
Foucault M.(1976): La volontà di sapere, Feltrinelli, Milano 1996
Foucault M.(1978): Illuminismo e critica,Donzelli Editore, Roma 1997
Kant I.(1784): Risposta alla domanda: Che cos’è l’Illuminismo?, in
Bobbio-Firpo-Mathieu (a cura di): Scritti di filosofia della storia e del
diritto, UTET, Torino 1965
Rubboli M.: I protestanti, Il Mulino, Bologna 2007
126
La Prima Guerra mondiale
Risvolti storici e culturali di un’immane tragedia – Crisi di un’idea di
civiltà – La non ineluttabilità della violenza.
di Giuseppe Moscati
§ 1) Ricognizione storica di un panorama complesso
Indagare da vicino, e il più possibile nello specifico, il tema della dialettica
guerra/pace all’interno di un periodo storico vasto e complesso quale è
quello interessato dagli eventi della Prima Guerra mondiale (1914-18), se da
una parte comporta un lavoro di ricognizione storiografica non indifferente,
dall’altra offre peraltro la preziosa opportunità di individuare alcuni
fondamentali e significativi ‘intrecci’ interdisciplinari.
Va precisato innanzitutto che il conflitto della cosiddetta Grande Guerra,
coinvolgendo la maggior parte degli Stati europei e diversi altri Stati
mondiali, sviluppatosi soprattutto come lunga e logorante serie di azioni
belliche di trincea, è caratterizzato da un senso tragico della guerra, dalla
drammaticità senza precedenti. Una guerra totale, complice anche l’impiego
di armamenti radicalmente innovativi e dall’eccezionale capacità distruttiva
che avrebbero portato ad un numero elevatissimo di morti (si parla di circa
nove milioni di vittime).
L’evoluzione della tecnica bellica è, in questo periodo, indubbiamente
impressionante. Nell’anno 1915, mentre in Germania H. Junkers dà vita al
primo aereo costruito interamente in metallo, in Inghilterra ne viene
realizzato uno in grado di lanciare siluri. Vengono inoltre fabbricati, in
Francia e nella stessa Inghilterra, i primi carri armati; da lì a poco i tedeschi
avrebbero inaugurato l’impiego dei gas tossici a scopi militari (sul fronte
occidentale) e usato i primi lanciafiamme (a Verdun).
Al tempo stesso, però, è sicuramente utile ricordare come il secolo XX si
fosse presentato, almeno nei suoi anni iniziali, come un secolo di relativa e
diffusa pace o quantomeno pressoché totale assenza di conflitti. A scuotere
tragicamente le coscienze sarebbe tuttavia giunta una sensazione di terrore
generalizzato, non tanto allo scoppio vero e proprio della guerra nel mese di
agosto del 1914, bensì più precisamente nel momento in cui si cominciò a
diffondere la consapevolezza della frenetica mobilitazione degli apparati
militari, quindi dell’enorme dispiegamento di forze in campo e delle
sterminate dimensioni raggiunte dal conflitto stesso.
127
Parallelamente a tutto ciò, non va neanche dimenticato quel sottile e
articolato lavorio retorico cui i rispettivi reggenti ricorsero per addossare le
responsabilità del conflitto in atto a questa o quella nazione nemica. Il tutto,
inoltre, avveniva in un panorama di sostanziale co-implicazione di interessi
di vario genere: interessi economici – industriali, commerciali (per materie
prime e per manufatti), finanziari e legati all’investimento di capitali esteri –
, interessi politici, interessi di supremazia militare e/o di prestigio politico.
Numerose sono le questioni sollevate dalla guerra, se pensiamo a come da
più parti e con differenti accenti sia stata portata avanti la campagna
interventista; a come non siano mancati, d’altra parte, i tentativi politici e
diplomatici di opposizione all’intervento stesso in guerra, da parte di diversi
Paesi; a come, ancora, ci fosse in gioco tutta una congerie di giustificazioni
ed autogiustificazioni. Queste ultime, poi, erano di volta in volta tese a
difendere la causa di una sovranità politica, quella dello sfruttamento di una
determinata porzione di mercato internazionale o quell’altra di una
spartizione territoriale studiata ‘a tavolino’ dai potenti di turno. Il tutto, però,
a fronte di un vero e proprio, terribile massacro di popoli ‘sul campo’.
Incontriamo dunque vari elementi che danno corpo alla politica bellica
intrapresa in vario modo dai Paesi dell’Europa e non solo dell’Europa, una
volta accantonata l’idea che fosse ancora possibile praticare strategie fedeli
alla vecchia logica dell’equilibrio europeo. La propaganda militare adottata
dalle diverse nazioni, del resto, passava da una certa tendenza ad attenuare
gli effetti della guerra sulle rispettive popolazioni, alla volontà di potenza da
esercitare contro l’avversario. Essa concentrava la sua attenzione, infatti, ora
verso la retorica di incoraggiamento all’inasprimento bellicistico –
finalizzato a contrastare l’imperialismo di una potenza ostile, a vincere
l’isolamento o, più esplicitamente, a conquistare nuove terre (Germania) –,
ora verso la costruzione dell’immagine di un preteso diritto trionfante contro
il nemico sfruttatore.
Altrove, poi, la propaganda inclinava anche verso l’enfatizzazione
ideologica di quella che si voleva spacciare per “guerra di liberazione” o
addirittura per “guerra di parificazione dei popoli” (Intesa). Oppure, in
diversi casi, essa spingeva verso la giustificazione di episodi di inaudita
crudeltà, di terribili nefandezze nonché della violazione non solo della
neutralità di qualche nazione che fino ad allora si era tenuta fuori dal
conflitto, ma anche dei più elementari diritti umani di tanti e tanti individui,
militari e civili che fossero.
Muovendo dalla consapevolezza di questa intricata situazione di
corresponsabilità delle varie potenze, possiamo affermare che non a caso il
dibattito storiografico più avanzato è passato attraverso tutta una serie di
riletture degli eventi storici, delle cause o meglio delle concause nonché
delle stesse figure dei principali protagonisti politici e militari della Grande
128
Guerra. Lo ha fatto finendo, quindi, con il conquistare una notevole maturità
di riflessione critica. La quale, a volte, è risultata anche assai distante da
quelle conclusioni che erano state tratte in anni ancora troppo vicini al
dopoguerra per permettere di elaborare un’adeguata interpretazione di ciò
che ha rappresentato quel conflitto. Tale dibattito, del resto, non ha prodotto
a sua volta un’interpretazione univoca dei fatti e delle loro ricadute in senso
lato, e non è questa la sede giusta per tentare una sorta di presentazione delle
diverse posizioni storiografiche. È pur vero, tuttavia, che forse proprio
questo rappresenta il senso più intimo e vivo di quello che può intendersi per
dibattito storiografico.
Venendo a quello che è stato l’inizio dello scontro armato, si è costretti
dunque a citare un’intensa concatenazione di cause. C’era il desiderio di
raggiungere posizioni di egemonia mondiale e di dominare vaste aree di
influenza di tipo economico-politico; c’era una forte collisione tra gli
interessi propri dei gruppi forti del capitalismo tedesco – la cui azione di
controllo era rimasta fino ad allora limitata alla sola parte sud-orientale
dell’Europa – e quelli propri dei centri di potere del ben più ricco
capitalismo di matrice franco-britannica. Ma c’erano anche le aspirazioni ad
un rapido sviluppo economico e le ambizioni imperialistiche di altre potenze
europee. Interagivano, poi, nervosi antagonismi variamente ispirati alla sete
di espansione del potere colonialistico (anche e specialmente per l’Italia),
alla politica dell’autoritarismo, alle retoriche patriottiche o all’esasperazione
dei miti del militarismo e del nazionalismo.
Non mancavano, del resto, altre questioni da tempo rimaste aperte, come
quella dell’antica contrapposizione tra Austria e Russia nell’area balcanica,
area che sarebbe stata poi interessata da due guerre nel biennio 1912-13 e
nella quale giocava un ruolo di primo piano la cosiddetta Grande Serbia.
Altre annose questioni erano poi, più in generale, quella dei riemergenti
conati tanto irredentistici che sciovinistici e quella, ancora, della
disgregazione già avviata dello sterminato impero ottomano.
C’è ancora da considerare come quello della Germania di fine Ottocentoprimi del Novecento sia stato uno sviluppo davvero straordinario, sia da un
punto di vista più squisitamente economico (soprattutto quanto alla
produzione di metalli e ai progressi del settore chimico dell’industria) che da
un punto di vista più strettamente tecnologico.
Ciò, se da una parte era alla radice della volontà tedesca di raggiungere
mercati da decenni controllati da Francia e Gran Bretagna, dall’altra
costituiva il principale motivo di preoccupazione da parte proprio di queste
due potenze, per questo sempre più tra loro vicine in chiave antitedesca. Non
è secondario, allora, l’elemento del progresso della Germania nel campo
della metallurgia proprio in quanto lo ritroviamo alla base del progetto di
129
costituzione di una potente flotta che fosse finalmente all’altezza di quella
inglese.
A ulteriore complicazione del quadro, c’è anche da dire che in questi anni,
per molti Stati come spesso purtroppo è avvenuto nella storia in coincidenza
con eventi bellici, la scelta della guerra ha tuttavia, significativamente, anche
un sinonimo particolare: quello di diversivo per l’opinione pubblica rispetto
ad altri gravi problemi irrisolti di politica interna e di controllo sociale. In
diversi casi, inoltre, non possiamo dimenticare la connivenza di istituzioni
religiose ed ecclesiastiche con la politica imperialistica portata avanti dalle
potenze coinvolte nel conflitto.
Tutte queste contraddizioni che la Grande Guerra, come ogni guerra, si
portava con sé le possiamo forse ben sintetizzare grazie a una singolare e
paradossale espressione, coniata appositamente per definire uno degli
atteggiamenti di fondo propri della Prima Guerra mondiale: quella di
“pacifismo guerrafondaio”.
§ 2) Elementi culturali e intrecci interdisciplinari della dialettica
guerra/pace
Abbiamo potuto vedere, attraverso una ricognizione dei vari fattori in gioco
– economici, sociali, politici, militari e così via – che quello riferibile alla
Prima Guerra mondiale è un quadro storico assai complesso e ricco di
rimandi di vario genere.
Per limitarsi alla sola questione delle (con)cause scatenanti il conflitto
mondiale e che si è tentato qui di richiamare in forma sintetica, possiamo del
resto affermare con convinzione che ricondurre il tutto univocamente
all’episodio dell’assassinio a Sarajevo, da parte di uno studente irredentista
di origine serba, dell’arciduca ereditario austriaco Francesco Ferdinando (il
28 giugno del 1914) altro non sarebbe che una pericolosa semplificazione
storiografica (come del resto è stato più volte autorevolmente affermato).
Ma siamo al contempo anche giunti ad una prima considerevole
conclusione: ha un suo notevole interesse, per la presente indagine, il
problema della percezione della guerra da parte delle popolazioni che si
sono ritrovate al centro delle ostilità militari. Si è già detto di come la
coscienza dell’Europa sia stata sconvolta dalla repentina presa di
consapevolezza di quale e quanto imponente fosse il dispiegamento delle
forze contrapposte.
È il caso ora di aggiungere come ad una iniziale convinzione diffusa di
trovarsi all’interno di un conflitto di sostanzialmente breve durata abbia fatto
ben presto seguito una più drammatica cognizione dei tempi effettivamente
molto prolungati della guerra. Se di quest’ultima è necessario studiare le
130
cause, o come abbiamo ripetuto più volte le concause, e approfondire il
multiforme spettro delle conseguenze, crediamo allo stesso tempo anche
opportuno non sottovalutare questo ordine di considerazioni legate alla
percezione del conflitto mondiale da parte degli uomini e delle donne
testimoni della Grande Guerra.
A tale scopo non può che risultare particolarmente fecondo prendere in
esame proprio quegli intrecci interdisciplinari di cui dicevamo all’inizio,
nella convinzione – da non confondere con posizioni di tipo storicistico –
che non esista soluzione di continuità tra quello che è l’insieme degli
accadimenti propriamente storici e quello che possiamo intendere per
‘spirito culturale’ dell’uomo di una determinata epoca.
Tante e diversificate potrebbero essere le piste possibili da seguire per
tentare di cogliere lo spirito culturale appartenente all’uomo del tragico
momento storico della Prima Guerra mondiale. Si potrebbe pertanto qui fare
riferimento a svariati autori della letteratura e della filosofia, della storia
dell’arte e delle scienze.
Potrebbero risultare particolarmente indicative in questo senso le pagine di
un Georges Sorel che nel 1908, quindi sei anni prima dello scoppio della
guerra, scrive le sue sofferte Riflessioni sulla violenza; o quelle di un autore
come Oswald Spengler che, con il noto saggio del 1918 intitolato Il
tramonto dell’Occidente, comunica il senso di crisi di tutto un mondo
culturale, oltre che politico, religioso ed economico, ovvero argomenta di un
vero e proprio decadimento della forma mentis, dell’identità e del pensiero
tipici dell’universo occidentale.
Ma, anche in chiave di visione speculare, sarebbe sicuramente interessante
approfondire, da una parte, l’opera e la figura di un Gabriele D’Annunzio –
che sappiamo essere non solo il poeta esteta della straordinaria Pioggia nel
pineto, bensì anche il prim’attore della quantomeno controversa questione
della conquista di Fiume (1919-24), a sua volta collegata con il risentimento
di tanti italiani per la cosiddetta vittoria mutilata – e, dall’altra parte,
l’elaborazione teorica e l’azione concreta che traspaiono dalle Tesi di aprile
e da Stato e rivoluzione di Lenin, scritti pubblicati entrambi nel 1917.
Prestando attenzione invece a quelli che sono i risvolti più propriamente
economici di un mondo in grande subbuglio come quello lacerato dalla
Grande Guerra, viene immediato il riferimento agli studi di John Maynard
Keynes, tra l’altro autore nel ’19 di un saggio, dedicato a Le conseguenze
economiche della pace, che sarebbe poi stato a lungo al centro di un
dibattito vivace e di largo respiro.
E come non dare il giusto peso a un episodio cruciale, e per la cultura e per
la politica internazionale, come quello dell’arresto e della condanna, nel ’18,
del filosofo gallese Bertrand Russell in quanto pacifista e obiettore di
coscienza? E poi, per richiamare un altro autore indubbiamente decisivo per
131
la promozione di una cultura della tolleranza o meglio ancora di un maturo
pluralismo democratico, ricordiamo che è nel bel mezzo della guerra
mondiale, precisamente nel 1916, che il filosofo e pedagogista americano
John Dewey dà vita a quel capolavoro di Democrazia ed educazione che
tanta eredità avrebbe lasciato in consegna al panorama del pensiero
contemporaneo.
Potremmo continuare all’infinito, se per esempio volessimo raccogliere i
segni e i simboli più o meno nascosti tra le righe kafkiane de La
metamorfosi (1916) o del Nella colonia penale (’19), racconti che molto ci
trasmettono, attraverso una narrazione eccezionale sia per livello letterario
che per coinvolgimento esistenziale, del senso di tragicità di cui dicevamo
sopra.
Proviamo dunque ad esaminare alcune coordinate di fondo del nostro tema –
coordinate nelle quali si intrecciano appunto risvolti storici e risvolti
culturali – seguendo una linea di ricerca che parte dalla scienza
psicoanalitica freudiana, passa attraverso alcuni spunti della letteratura
italiana (Pirandello) e della poetica inglese (War Poets) per poi cogliere le
più vivaci suggestioni provenienti dal movimento Dada.
§ 3) La ricerca psicoanalitica di Freud e lo scontro tra eros e thanatos
Volendo per esempio analizzare la corrispondenza tra, da un lato, la
percezione della guerra da parte dei singoli individui, dei gruppi sociali o di
interi popoli e, dall’altro, quelle che sono state le espressioni più tipiche del
mondo culturale degli anni Dieci e Venti del ’900, un autore illuminante è
senza dubbio Sigmund Freud, padre della psicoanalisi, grande studioso dei
disagi psichici individuali e collettivi e delle pulsioni che risiedono a monte
dell’aggressività umana.
Un autore brillante, Freud, proprio in quanto con la sua opera ci introduce
efficacemente nel vivo di quella che abbiamo chiamato dialettica di guerra e
pace: la sua teoria psicoanalitica si concentra infatti non solo sul concetto di
pulsione, che potrebbe nel nostro caso apparire in parte generico, ma anche
su quello più specifico di “conflitto pulsionale”.
Secondo lo scienziato tedesco, l’apparato psichico dell’uomo presenta una
coesistenza di pulsioni dell’Io (dette anche pulsioni di auto-conservazione) e
pulsioni di natura sessuale; ad una lettura più profonda, poi, Freud ritiene di
individuare una distinzione possibile tra quelle che sono le pulsioni di vita,
che egli riassume sotto il termine di eros, e quelle che invece all’opposto
sono le pulsioni di morte, ovvero le pulsioni di thanatos.
È abbastanza evidente come in Freud sussista una convinzione
fondamentalmente dualistica, riconducibile in larga parte all’idea di quella
132
psicoanalitica come di una teoria dinamica e non meramente descrittiva della
psiche: quest’ultima è teatro di un perenne conflitto di forze opposte, la
forza di eros e la forza di thanatos appunto, e luogo in cui si perpetua
incessantemente la (auto)conservazione delle pulsioni stesse.
Torna particolarmente utile all’analisi del nostro tema una delle maggiori
opere freudiane, il saggio intitolato Al di là del principio del piacere, scritto
nel 1919 e pubblicato l’anno dopo e quindi di poco posteriore alla fine del
conflitto della I Guerra mondiale.
Va ricordato intanto che Freud era già stato autore, nel 1917, di una
fondamentale Introduzione alla psicoanalisi; e va segnalato anche che nel
saggio del ’19 egli affronta questioni che avrebbe poi ampiamente ripreso
nel ’23 con lo studio de L’Io e l’Es (non a caso un’altra contrapposizione di
forze). In Al di là del principio del piacere, comunque, egli sembra avvertire
ancora l’eco degli scontri bellici che avevano visto la sua Germania tra le
potenze più massicciamente implicate nella guerra.
In buona sostanza, questo importante saggio possiamo dire rappresenti una
sorta di tragica conclusione di quelle premesse sui temi della guerra, della
morte e dell’aggressività umana che Freud stesso aveva argomentato nelle
pagine precedentemente dedicate alla categoria psicoanalitica di “narcisismo
primario”. Quest’ultimo, in estrema sintesi, finisce per coincidere con un
investimento libidico – quindi ancora una volta pulsionale – dell’Io su se
stesso, prima ancora che sugli oggetti a lui esterni.
Indagando proprio in un terreno che si pone al di là del principio di piacere,
nel senso oppositivo dell’espressione, Freud sostiene che esistono
nell’apparato psichico umano degli istinti di morte opposti a quelli
propriamente libidici. Egli postula questo principio della pulsione di morte,
che può dirigersi contro se stessi (istinto di auto-aggressione) e contro gli
altri (istinto aggressivo verso l’esterno), come un principio che tende a
ristabilire una certa condizione primitiva rispetto a quella simboleggiata dal
piacere e caratterizzata dal processo di totale liberazione (scarico)
dell’energia pulsionale accumulata.
§ 4) La disgregazione del principio di verità nella visione del mondo
pirandelliana
Prendiamo adesso in considerazione l’opera letteraria di Luigi Pirandello,
altro autore che si trova a scrivere diverse pagine che sicuramente risentono
del clima di orrore prodotto dalla guerra e del senso tragico vissuto
dall’uomo della seconda metà degli anni Dieci. Pirandello, che non è
peraltro insensibile alle suggestioni offerte dagli studi psicoanalitici di
quegli anni, contribuisce in larga misura ad offrire interessanti spunti di
133
riflessione per la tematica che ci siamo proposti di affrontare.
Va innanzitutto sottolineato il fatto che un testo dalla notevole base
filosofica quale è quello della commedia di Così è (se vi pare), rappresentata
nel bel mezzo della Prima Guerra mondiale (1917), si pone come
interrogativo fondamentale sulle sorti dell’umanità.
E proprio verso il destino dell’uomo l’autore pare manifestare una profonda
pietà, visto che gli uomini sono presentati come esseri prigionieri di una
pena perenne, vale a dire come soggetti cui sfugge continuamente la
possibilità di conoscere la verità (si parla di relativismo pirandelliano) e
perciò condannati a una vita che al suo fondo mantiene sempre una fatale
malinconia.
Non solo: in maniera coerente e consequenziale con tutto ciò, nell’universo
pirandelliano è abbastanza evidente che gli uomini sono anche vincolati ad
un destino di radicale solitudine, che vanno il più delle volte incontro a
situazioni di ostilità e che comunque rimangono distanziati gli uni con gli
altri a causa di una insuperabile, disperata incomunicabilità.
Risulta dunque importante notare come Così è (se vi pare) [d’altra parte una
delle commedie più significative dell’intera sua produzione] costituisca per
Pirandello l’occasione di ragionare su uno dei temi centrali per l’opera
dell’autore siciliano: l’identità. Quell’identità che, da vecchia solida certezza
ridotta a prepotente senso della precarietà esistenziale, era stata messa in
crisi proprio dai terrificanti eventi bellici del conflitto mondiale.
Ora Pirandello non fa che trarre, magistralmente dal punto di vista letterario,
le conclusioni di quella crisi identitaria: l’uomo contemporaneo è franto
nell’intimo della sua personalità, non possiede ormai più le forti convinzioni
di un tempo ed è quindi esposto, in tutta la sua più profondamente umana
vulnerabilità, al male del mondo.
Tale male, tra l’altro, ha origine nell’uomo stesso, uomo che per giunta è per
lo più confuso dalle diverse forme in cui gli va apparendo la verità: chi potrà
mai sciogliere il dubbio sulla vera identità della donna di cui si parla nel
testo pirandelliano in questione? È effettivamente la seconda moglie del
signor Ponza, come costui afferma, o è invece la figlia della signora Frola,
come ribatte energicamente quest’ultima?
L’apparenza, insomma, la fa da protagonista, stabilendo che la verità è
appunto (solo) quella che appare, ambiguamente all’uno o all’altro
individuo, e confermando così una condizione umana di sostanziale
enigmaticità del vivere.
Il lettore/spettatore, dunque, non troverà una soluzione definitiva alla
questione sollevata da Così è (se vi pare) e alla fine perverrà a una scomoda
scoperta. Egli arriverà infatti a intuire, con un grande senso di inquietudine e
ormai sull’orlo del panico, una natura di sostanziale indefinibilità e
indecifrabilità di quella verità che a lungo aveva cercato di possedere. Egli
134
dovrà anzi non solo rassegnarsi alla realtà effettiva di questo scontro di tesi
contrastanti, concludendone che la situazione principe finisce con l’essere
quella di una conflittualità irrisolta di fondo, ma anche giungere all’amara
considerazione del fatto che non sempre può esistere un lieto fine.
§ 5) Il senso tragico della guerra nei versi dei War Poets
Spostando ora la nostra attenzione verso il primo Novecento inglese, sempre
guardando alla drammaticità della guerra per come essa è stata in qualche
modo rielaborata dall’arte e dalla cultura, nel campo della poesia troviamo
diversi aspetti particolarmente interessanti.
È intanto sufficiente anche solo una rapida lettura di alcuni di quei
componimenti poetici che possiamo annoverare nella produzione dei
cosiddetti War Poets per cogliere il senso di angoscia che dominava quegli
anni così devastati e martoriati dagli orrori della Grande Guerra.
I versi volutamente imperfetti di un Wilfred Owen, di un Rupert Brooke, di
un Siegfried Sassoon o di un Isaac Rosenberg, anzi, sembravano nascere
proprio con una forte, tenace volontà di aggrapparsi a quegli orrori per
pronunciare, in maniera il più possibile aderente alla realtà, una loro
coraggiosa denuncia.
Ma per dire quel terrore e quelle brutture era necessario rinvenire un nuovo
linguaggio e quindi anche una comunicabilità poetica radicalmente diversa
da quella appartenente alla tradizione letteraria fino ad allora in auge.
Quanto alla questione più specificatamente tecnico-linguistica, va allora
aperta una parentesi per ricordare come in questi stessi anni sia stato
veramente decisivo l’apporto del movimento anglo-americano
dell’imagismo.
Questo vivace movimento avrebbe avuto tra i suoi esponenti di area
britannica scrittori come Richard Aldington, autore di Immagini e di
Immagini di guerra (rispettivamente del 1915 e del ’19), Madox Ford, che
scrisse nel ’15 il romanzo intitolato Il buon soldato, e lo stesso James Joyce
(il cui celebre Gente di Dublino è anch’esso del ’15), che avrebbe poi
ripreso anche alcuni spunti di tecnica letteraria da Ford.
Il movimento imagista – che avrà nel poeta e critico americano Ezra Pound
il suo più energico promotore – si presentava in buona sostanza quale
proposta, in chiave antiromantica, di un’arte poetica dell’immagine dura
(hard dry image), nitida, fortemente realistica e senza infingimenti né
concessione alcuna alla retorica. Un’immagine che deve rendere la
condizione penosa in cui verte l’uomo schiacciato da un’età di bellicismo,
d’altra parte, non può che ricorrere a parole d’acciaio, a espressioni taglienti
e in generale a forme espressive estremamente dure.
135
Tornando ai War Poets e all’arte della loro war poetry, va ribadito che si
trattava appunto di poeti che prendevano in prima persona parte alle azioni
militari e poi riversavano abilmente la cruda realtà del vissuto di guerra nella
poesia. Sassoon, per esempio, trae ispirazione per le sue prime raccolte
poetiche proprio dall’esperienza vissuta nell’agone del campo di battaglia,
sia in terra francese che in Palestina.
Ne nasce una poetica della pietà, dell’amarezza e insieme del disgusto, dove
i soggetti principali diventano le vittime di una forza assurda e maligna che
non guarda in faccia nessuno perché protesa esclusivamente verso una cieca
distruzione di massa. Una poetica, tuttavia, che conosce anche alte vette di
lirismo.
Uguale discorso può farsi per i sonetti, peraltro venati di un peculiare
idealismo, di Rupert Brooke, poeta-soldato morto ventottenne in Grecia
(stessa sorte di Rosenberg, caduto sul fronte francese alla stessa età) e di cui
vennero pubblicati postumi nel ’15 i versi di 1914 and Other Poems.
Allo stesso modo anche il più popolare dei poeti di guerra, Wilfred Owen,
che da bambino con la sua famiglia aveva conosciuto pure la miseria, dopo
l’esperienza bellica sente di dover affidare ai suoi versi la triste verità dello
sterminio.
La guerra, nei componimenti di questo struggente poeta inglese in buona
parte debitore a Sassoon (che conosce in un ospedale di guerra), è vista
soprattutto come portatrice di un trauma indelebile. Lo stesso trauma che
Owen sperimenta concretamente sulla propria pelle a partire dal 1917, cioè
dopo aver riportato un forte shock da esplosione di una granata. Lo stesso
trauma che il poeta tenta di comunicare con parole che riescano a rievocare,
vividamente, la morte per avvelenamento da gas di migliaia di giovani
soldati. E così pure parole che, altrettanto efficacemente, sappiano far
riascoltare l’assordante fragore e gli odori nauseabondi dello scontro armato.
C’è questo senso di asprezza del vivere un’esperienza da testimoni di guerra,
insomma, alla base del verseggiare tipico di poesie quali Strange Meeting,
Anthem For Doomed Touth, It Was A Navy Boy, The Parable Of The Old
Man And The Young, o della più nota Dulce Et Decorum Est, poesia,
quest’ultima, che riprende una celebre frase oraziana (delle Odi) sulla morte
in guerra per capovolgerne significativamente e totalmente il senso.
E forse ci appare ancora più tragica la morte di Owen, se teniamo conto del
fatto che avvenne il 4 novembre del 1918, ovvero a una sola settimana dalla
fine delle ostilità dichiarata dall’armistizio. «Ogni orgoglioso combattente si
vanta / di far guerra alla morte per delle vite; non agli uomini per delle
bandiere», recita tristemente la sua The Next War.
136
§ 6) La rivoluzione dadaista e il sogno di una realtà alternativa alla guerra
Un altro elemento culturale di notevole interesse, oltre che di ampio respiro
internazionale, che può aiutarci a meglio definire la nostra ricerca
nell’ambito del periodo storico della Grande Guerra, è senz’altro
rappresentato dalla rivoluzione artistica promossa e sviluppata dagli
esponenti del movimento dadaista.
Nato a Zurigo, tale movimento ha avuto il suo primo e fondante manifesto il
14 luglio del 1916, recitato da Hugo Ball nei locali del Cabaret Voltaire (da
qui l’omonima rivista Dada), e si è andato sviluppando poi con notevoli
rapidità e diffusione sino al ’22, anche se molta della sua eredità artisticoconcettuale la ritroviamo ben oltre tale data.
Molti degli esponenti del dadaismo, peraltro, li scopriamo protagonisti anche
di altri movimenti contemporanei o successivi al Dada, veri e propri artisti
trasversali: il geniale alsaziano Jean Arp, per esempio, è tra i fondatori del
dadaismo eppure aderirà sia al surrealismo che al movimento denominato
Abstraction-Création, mentre il brillante dadaista tedesco Kurt Schwitters –
d’altronde convinto assertore della necessità di un’ibridazione delle arti –
passa significativamente anche attraverso esperienze espressioniste, cubiste,
costruttiviste...
È il caso di ricordare, a proposito della nascita del movimento a Zurigo,
come allo scoppio del conflitto mondiale la Svizzera avesse dichiarato la
propria neutralità; e va anche aggiunto, però, che tale movimento si è saputo
radicare in diversi Paesi come per esempio in America, in Francia e nella
stessa Germania.
Oltre a New York, Parigi e Colonia, soprattutto Berlino, la Berlino in
ginocchio, la Berlino sciaguratamente disastrata dagli eventi bellici, si è
distinta come città dadaista. Essa è infatti stata sede, tra l’altro, sia delle
riviste tedesche “Der Dada” e “Neue Jugend”, sia del ritrovo degli artisti
Dada-Club, la cui peculiarità era una netta politicizzazione in chiave
filosovietica (ecco, anche, gli effetti economici della guerra), e sia ancora
della prima Mostra internazionale del dadaismo (1920).
È significativo che tale movimento, lungi peraltro dall’abbracciare un
pensiero sistematico, si ponga già nei suoi esordi artistico-programmatici
come una sorta di potente esigenza culturale di pace o comunque di
superamento dello stato di conflitto che tanta barbarie aveva generato nelle
zone interessate dalla Grande Guerra.
Quanto al nome, per la verità, sarebbe più appropriato riferirsi al movimento
Dada, piuttosto che al dadaismo, considerando il fatto del resto non
secondario che i suoi esponenti avevano assunto, come un loro vero e
proprio imperativo morale, la battaglia contro i vari -ismi (ideologici,
artistici, letterari), ormai di moda nella cultura ufficiale a loro
137
contemporanea. Il motivo della scelta della parola Dada, peraltro, non si è
mai del tutto chiarito: si è infatti pensato al raddoppio del “da” (“sì”) della
lingua russa o a un termine scelto a caso oppure ancora, forse più
verosimilmente, ad un puro suono del tutto privo di senso.
Sta di fatto che quello del Dada si caratterizza in primo luogo come un
movimento artistico-culturale a diffusione internazionale e dalla forte carica
anticonformista. Un movimento di idee e di prodotti – dalla poesia al teatro e
alla pubblicistica, dalle arti visive alla grafica, alla musica e al cinema –
potentemente ribelle rispetto alle convenzioni, agli stessi cliché artistici e ai
canoni tradizionalistici dell’estetica, nonché, e questo ci interessa da vicino,
energicamente antibellico.
Gli esponenti che hanno animato questo movimento, anzi, hanno mossi i
loro propri passi da una ferma e compatta presa di posizione contro gli orrori
e le mostruosità della Grande Guerra. Arrivando, così, a denunciare ciò che
secondo loro costituiva il reale fondamento della logica del bellicismo, vale
a dire l’assetto politico-sociale ed economico, ma in un certo senso anche
‘culturale’, dell’ordine instaurato dalla borghesia. Tale denuncia si traduce
tanto in un’effettiva e multiforme produzione artistica che in un’articolata,
densa e ricca di sviluppi, elaborazione teorica.
La rivolta morale e lo spirito ideale insisti nell’una e nell’altra venivano
quindi alimentati dalla sincera convinzione che a generare i massacri della
Prima Guerra mondiale era stata direttamente tutta una cultura in stato di
decomposizione. Abbiamo ragione di ritenere che gli esponenti del Dada
ben poco avrebbero poi ritrovato, della loro comune aspirazione al
superamento di tutte le guerre, in quei trattati di pace con i quali si è di fatto
concluso quel logorante conflitto mondiale (Versailles, Saint Germain-enLaye, Neuilly, Trianon, Sèvres…).
La guerra, agli occhi di quella generazione di artisti e letterati così ribelle e
indomita, rappresentava il nemico numero uno da combattere senza indugi,
ma già a partire dalla sua base teorica, dalla sua giustificazione
pseudoculturale. Pur senza arrivare a forme di pacifismo utopistico, il Dada
si scagliava contro la guerra soprattutto attraverso la sua opposizione al mito
della ragione e alle sirene del progresso, al miraggio della coerenza logica e
alle false certezze di sfrenate retoriche militariste, dunque contro il dominio
del razionalismo e del positivismo di derivazione ottocentesca. Dada,
insomma, è soprattutto sinonimo di rivolta ideale e fattuale contro la guerra.
Di tutto ciò che attiene al mondo della logica ufficiale i vari Marcel
Duchamp, Guillaime Apollinaire, Tristan Tzara, Paul Eluard, Francis
Picabia, André Breton, Man Ray, Louis Aragon, Max Ernst e gli altri
arrivano così a farsi beffe. Ora con le stilettate irriverenti delle massime
satiriche, ora con l’umorismo amaro delle considerazioni sulla guerra ed ora
con la finezza ironica di opere d’arte che, se addirittura non irritano,
138
spiazzano decisamente quello che fino ad allora era il senso comune di
bellezza. Basti pensare, per questo, al celebre orinatoio duchampiano,
intitolato Fontana, del 1917 (dove il quotidiano, mutato il contesto, si fa
arte) o all’altrettanto celebre quadro raffigurante la classica Monna Lisa, ma
con tanto di baffi e pizzetto (L.H.O.O.Q., 1919). Lo fanno in nome della
massima libertà creatrice mai neanche immaginata e del principio
fondamentalmente anarcoide che risiede alla radice del loro stesso rifiuto di
‘razionalizzare’ – che equivarrebbe quindi ad accettare – un fenomeno
barbarico quale è quello della guerra.
Il Dada è allora prima di tutto voce di eversione e spirito di rivolta, è
sovvertimento di un ordine che ha prodotto guerra e dolore; non si limita ad
essere semplicemente un atto polemico, ma sperimenta forme di ribellione
universale. Oltre a ciò, proprio negli anni in cui il movimento va
sviluppandosi, se vogliamo tornare a considerare l’aspetto di quella che è
stata la percezione della Prima Guerra mondiale, l’evento bellico sembrava
veramente interminabile. Esso non faceva che provocare, tanto più in chi si
riconosceva negli ideali del Dada, un forte e diffuso senso di nausea, di
repulsione nei confronti di una realtà così drammatica che non si poteva e
non si voleva considerare come ineluttabile.
Non c’erano argini possibili a frenare la forza d’urto del significato
straordinariamente rivoluzionario delle pagine contenute in quei vivaci
manifesti, in quelle riviste e in quei giornali, in quelle vibranti poesie e in
quei sorprendenti testi teatrali, per i quali ricordiamo almeno il primo
Brecht, quello del Baal composto ad Augusta nel biennio 1918-19. Non si
poteva in alcun modo frenare l’energia prorompente di quelle opere d’arte,
frutto il più delle volte di un curioso accostamento di materiali e/o
abbinamento di forme, e di quelle esibizioni pubbliche cui i dadaisti erano
soliti ricorrere.
Non esistevano insomma paletti, in generale, per quell’inedita capacità
travolgente dell’espressione artistica del Dada. Tutto crollava dinanzi a
quelle manifestazioni ‘urlate’ di arte, fosse essa in versi o su tela, tanto da
far pensare all’autodistruzione dell’arte stessa, e d’altra parte non
mancarono forme di vero e proprio nichilismo.
Tra i bersagli dadaisti, del resto, oltre alle diverse espressioni del
modernismo sarebbero finite anche le altre espressioni della cosiddetta arte
d’avanguardia, della quale il Dada stesso è la versione più estremista. Quelle
espressioni, che pure si presentavano come innovative, tuttavia all’artista
Dada sembrano pur sempre velleitarie e, per giunta, in qualche modo
funzionali al mantenimento dell’ordine di idee e di valori propri dell’ipocrita
società borghese che è invece prioritario ed urgente abolire.
In questo senso possiamo parlare anche di una anti-arte in quanto modalità
di opposizione radicale alla tradizione e al pensiero tradizionale che hanno
139
permesso il verificarsi della profonda crisi morale di un tempo tragico come
quello della Grande Guerra. Non possiamo neanche trascurare, però, il fatto
che nelle stesse intenzioni degli esponenti dadaisti risiedeva, comunque,
l’idea che il lettore/spettatore/fruitore dei prodotti del loro ingegno fosse
direttamente chiamato in causa per distruggere un senso scontato dell’arte e
sostituirlo con un’impressione individuale, in ultima istanza strettamente
soggettiva.
La risultante dell’incontro tra la professione agguerrita e caustica del
dissenso, l’abbandono all’irrazionale e al giocoso nonsenso, e il desiderio
impellente di denuncia di cui dicevamo, quindi, può essere considerata la più
intima essenza del Dada. E quel dissenso, quell’abbandono e quella
denuncia venivano messi in pratica spesso con toni volutamente enfatici e
attraverso varie forme di pungolo della sopita opinione pubblica.
Tutto ciò ha via via trovato forme espressive decisamente originali, ispirate
al progetto di distruzione delle convenzioni sociali e delle ideologie politicoculturali dell’epoca. Ne è derivata tutta una serie di influssi esercitati a lungo
e in profondità su gran parte dell’arte moderna e specificatamente su altri
movimenti coevi o posteriori al Dada, quali tra gli altri il surrealismo,
l’espressionismo, il nouveau réalisme, il new dada e la pop-art.
Il Dada rimane comunque, al di là di tutto, simbolo di un’arte nuova per una
società e un mondo nuovi. Nuovi, ma da conquistarsi innanzitutto attraverso
il superamento della condizione tragica e delle indicibili sofferenze causate
all’umanità dalla guerra – quella Grande Guerra, guerra storicamente
determinata – e, allo stesso tempo, delle radici più profonde della possibilità
dell’insorgenza della guerra in ogni tempo e in ogni luogo.
A tale progetto erano massimamente vitali il ricorso al paradosso, fino agli
estremi limiti della corrosività, e la ricerca di una inedita capacità
comunicativa dell’arte, della poetica, della prosa e in generale della cultura.
Giuseppe Moscati
140
FOTO T. Negri
7RQLQR1HJUL6FXOWXUDFHUDPLFD´$UWHLQ*LDUGLQRµ,VRODG·(OED
LA POLEMICA SUI DIALETTI
L’italiano, una lingua democratica
di Vittorio Messori
Il guaio dell’età che avanza – parlo per esperienza – è soprattutto la noia.
Quella di chi subisce il ciclico ritorno degli stessi dibattiti, degli stessi temi, degli
stessi equivoci. E’ naturale: ogni generazione deve ricominciare da capo. Ma
per il povero anziano, è pur sempre tedioso.
Tra i “tormentoni” ricorrenti, ecco di nuovo, in queste settimane, la questione –
rinfocolata periodicamente dalla Lega – del rapporto tra lingua nazionale e
dialetti locali. Qui, i seguaci di Bossi hanno un grosso, irrisolvibile handicap
rispetto a molti movimenti stranieri federalisti o separatisti. In effetti, non vale
per l’Italia quanto – osservava Ernest Renan – è vero per altri grandi idiomi.
Il francese imposto da Parigi a occitani, bretoni, normanni, còrsi, alsaziani,
lorenesi. Il castigliano imposto da Madrid a catalani, baschi, valenciani,
galiziani, aragonesi. L’inglese imposto da Londra a gallesi, scozzesi, irlandesi. Il
russo imposto da Mosca a ucraini, bielorussi e altre etnie slave. Il mandarino di
Pechino imposto a tutti i cinesi. Due sole, grandi lingue, divenute ufficiali per
uno Stato, non sono state imposte a popolazioni in parte riluttanti: il tedesco e
l’italiano. Entrambe sono, per dire così, “democratiche”.
Per comunicare tra loro, le genti germaniche, prive di unità politica, dopo un
lento avvicinamento degli infiniti dialetti, decisero di adottare, almeno per la
scrittura, il sassone aulico in cui Lutero tradusse la Bibbia.
Quanto all’Italia, anch’essa frammentata, ebbe solo tardivamente uno Stato, ma
fu precocemente una “nazione”. A partire dal tardo Quattrocento, chi abitava la
Penisola era distinto dagli altri popoli come un “italiano”.
Ma già nel Medio Evo, tra le “nazioni” riconosciute in Europa – ad esempio,
nelle università e nelle corporazioni di mestiere – c’era quella “italiana”. Sta
soprattutto nella lingua il motivo di questa identità, malgrado lo spezzettamento
politico e le forti differenze di ogni tipo tra le Alpi e lo Jonio.
Ebbene, spesso si dimentica che, se in Italia si parla e si scrive così, ciò è
dovuto alla libera scelta degli uomini di governo e, soprattutto, di cultura, di ogni
angolo di quello che solo molti secoli dopo sarebbe divenuto uno Stato. In Italia
non ci fu una Capitale dove sedesse un’autorità che imponesse un dialetto
locale divenuto lingua ufficiale per le leggi, i tribunali, l’esercito. Da noi, ancor
più che in Germania, l’idioma comune fu una sorta di referendum, fu il frutto di
una decisione pragmatica che si impose liberamente: poiché, divenuto sempre
più arduo esprimersi in latino, occorreva una koiné italica, i gruppi culturalmente
e politicamente dirigenti finirono con l’accordarsi (prima nei fatti, e poi nelle
teorie dei dotti) sulla variante di volgare illustrato dalla triade sublime, Dante,
Petrarca, Boccaccio. Così, fu il dialetto toscano, e in particolare fiorentino, che
divenne la lingua franca per gli scambi, la letteratura e poi la cultura in
generale. Lingua “democratica”, dunque, e al contempo “aristocratica” nel
142
senso che, sino all’unità politica, fu soprattutto scritta da chi sapeva di lettere.
Ci vollero non tanto la scuola obbligatoria quanto prima l’Eiar e poi la Rai,
nonché il sonoro nei film, per trasformarlo in un idioma praticato da tutti, o
quasi.
Sta di fatto che – a differenza di un catalano nei confronti di un castigliano o di
un provenzale nei confronti di un parigino o di uno scozzese nei confronti di un
londinese – nessuno, di nessuna regione italiana, può accusare uno Stato o un
Potere di avergli imposto un idioma che, dalla sua, ha avuto semmai solo la
forza della cultura. Firenze nulla fece, se non approfittare del talento dei suoi
grandi scrittori. Quanto agli attuali “padani”, pur comprendendo alcune delle loro
ragioni, non dimentichino che, tra Ottocento e Novecento, coloro che più fecero
per dare una lingua moderna a tutti gli abitanti della penisola, facendoli uscire
dai dialetti e dal toscanismo angusto, furono il lombardo Manzoni, il ligure
piemontesizzato De Amicis, il saluzzese Pellico, il torinese D’Azeglio, il dalmata
Tommaseo, il veneto Fogazzaro, il romagnolo Pascoli, il genovese Mazzini. E
che, ancor prima, l’astigiano Alfieri, il subalpino Baretti, i milanesi Verri e
Beccaria, molto avevano fatto per radicare la lingua comune. Per tornare
all’Ottocento, il parmigiano Verdi, malgrado offerte di francesi, inglesi, tedeschi,
rifiutò di musicare libretti che non fossero in italiano; e persino il “federalista”
lombardo Carlo Cattaneo accettò di buon grado la scelta del toscano, in cui
scrisse in modo impeccabile, irridendo ai passatismi dialettali. Non irrisione, ma
furore, provocavano nel nizzardo Garibaldi coloro che mettevano in discussione
l’unità dell’idioma.
Morì accanto a lui, all’assedio di Roma, il genovese Mameli, che aveva cantato
l’unione di “Fratelli d’Italia” in tutto, a cominciare dalla lingua. Tutti “padani” o,
almeno, “nordisti”; e tutti contro la babele vernacolare, anche la loro.
“E’ la storia, bellezza!”, verrebbe da celiare con chi si ostinasse a barricarsi
sotto il suo campanile, inveendo contro una lingua che gli sarebbe stata
imposta da qualche prepotente forestiero. E’ colpa, o merito, della storia se non
si dice un chimerico “padano”, ma neanche un “lombardo” (si capiscono, forse,
uno di Sondrio e uno di Cremona, uno di Bergamo e uno di Pavia?) e, se altri
idiomi di altre regioni italiane, al Centro e al Sud, esistono, ma non sono
praticabili come lingue. Ciò non toglie che i dialetti siano una ricchezza: posso
dirlo anche perché, se mi è permesso un riferimento personale, mio padre fu tra
i più popolari e, credo, dotati, poeti in modenese. Ma è una ricchezza ancor
maggiore lo strumento divenuto pian piano comune, in quasi mille anni, ad
almeno 60 milioni di persone. Per forza propria, senza bisogno di decreti
governativi tutelati dai gendarmi.
Vittorio Messori
L’articolo sopra riprodotto è stato pubblicato il 19 agosto 2009 da Il Corriere della Sera.
Ringraziamo la direzione del giornale e l’autore per la gentile concessione alla riproduzione.
143
FOTO T. Negri
7RQLQR1HJUL6FXOWXUDFHUDPLFD´$UWHLQ*LDUGLQRµ,VRODG·(OED
IL PRINCIPIO DI NEUTRALITA’ IN BRUCE ACKERMAN:
UNA PROPOSTA DI GIUSTIZIA DISTRIBUTIVA DOPO RAWLS.
Sommario: 1. La teoria della giustizia di John Rawls. 2. Bruce Ackerman: interlocutore
critico di John Rawls. 3. La teoria della giustizia di Ackerman: i principi del dialogo
neutrale. 3.1. Il consenso razionale. 3.2. La cittadinanza. 3.3. La giustizia intergenerazionale. 3.4. L’ingegneria genetica. 3.5. Il concetto di Undominated equality.
3.6. Il valore della neutralità dello Stato. 4. Conclusioni.
di Paola Chiarella
1. La teoria della giustizia di John Rawls.
Dopo la seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti godettero per circa venticinque
anni, di un periodo di grande progresso socio-economico e scientifico, che
permise loro di imporsi, accanto all’Unione Sovietica, come potenza egemone
sulla scena mondiale.
Su questa ondata di prosperità, la Presidenza del democratico Kennedy, lanciò
negli anni 60’ il mito della New Frontier, eldorado di ulteriori conquiste
scientifiche (anche in campo spaziale) e di rivendicazioni civili a favore delle
persone di colore e delle sacche più emarginate della società.
Dopo la sua morte, il successore Johnson completò quel progetto, attraverso
l’approvazione del Civil Rights Act (1964), con il quale si vietavano le varie
forme di discriminazione razziale, del Voting Rights Act (1965), volto ad
eliminare ogni impedimento al pieno esercizio da parte dei neri del diritto di
voto e perseguendo inoltre l’intento di creare la «Grande Società», nella quale
gli americani sarebbero stati sgravati dalla piaga del pauperismo112.
Nonostante gli sforzi della Presidenza orientati in tal senso, la politica di
integrazione razziale non ottenne i risultati sperati, mentre il problema della
112
In argomento v. D. B. Rodriguez – B. R. Weingast, The Positive Political Theory of
Legislative History: New Perspectives of 1964 Civil Right Act and its Interpretation, in
Univ. of Pennsylvania Law Review, 2003, vol. 151, p. 1417 ss.; L. N. Gueron, An Idea
Whose Time Has Come: A Comparative Procedural History of The Civil Rights Act of
1960, 1964 and 1991, in Yale Law Journal, 1995, vol. 104, p. 1201 ss.; C. Lang,
Between Civil Rights and Black Power in the Gateway City: The Action Committee to
Improve Opportunities for Negroes (ACTION), 1964-1975, in Journal of Social
History, 2004, vol. 37, p. 725 ss.; R. Pildes, Law and the Political Process the
Nineteenth Annual National Student Federalist Society Symposium on Law and Public
Policy – 2000: Panel III: Voting Rights, Equality and Racial Gerrymandering Diffusion
of Political Power and the Voting Rights Act, in Harvard Journal of Law & Public
Policy, 2000, vol. 24, p. 119 ss.
145
povertà rimaneva difficile da risolversi. In un tale clima di sfiducia verso la
politica riformista, i neri manifestarono atteggiamenti di rivolta113, mentre le
classi medie preoccupate dal crescente deficit statale e dall’inflazione che ormai
salutava gli anni d’oro del precedente boom economico, si orientarono verso
l’ala conservatrice o verso frange reazionarie. Ad aggravare ulteriormente
questo quadro politico e sociale, contribuirono le caldissime polemiche
sull’opportunità della guerra in Vietnam, sui fallimenti del welfare state, sul
femminismo, sulla liberazione sessuale e sulle nuove tendenze giovanili sempre
più avvezze all’uso di droga ed alcool.
In un siffatto contesto culturale, la pubblicazione di A Theory of Justice di
Rawls114, che si proponeva di tracciare una via alla soluzione del problema delle
disuguaglianze, viene accolta con grande entusiasmo non solo dalla comunità
accademica115, ma anche dal grande pubblico116, il quale, resosi sensibile alle
problematiche innanzi considerate, percepiva nell’opera di Rawls caratteri di
novità e di freschezza di cui avrebbero potuto giovarsi le istituzioni politiche.
Inoltre, in una società già da tempo multiculturale, come quella statunitense, il
pregio di Una teoria della giustizia era quello di volere edificare una
concezione del giusto che potesse essere condivisa anche da coloro che
possedessero diverse concezioni del bene e ponendosi in una prospettiva sub
113
Si pensi alle cruente rivolte dei neri nei ghetti urbani, alcuni dei quali, come i
Musulmani Neri di Malcom X, rifiutarono la politica di integrazione cercando di
ottenere una propria indipendenza.
114
In argomento per una rilettura della teoria v. E. Pattaro – A. Verza, La realistica
utopia della giustizia. Addio a John Rawls, in Riv. int. fil. dir., 2003, p. 137 e ss.; L.
Baccelli, John Rawls fra giustizia e comunità, in Filosofi del diritto contemporanei, a
cura di G. Zanetti, Cortina, Milano 1999, p. 63 e ss.; A. Porciello, Diritto Decisione
Giustificazione. Tra etiche procedurali e valori sostanziali, Giappichelli, Torino 2004,
p. 63; W. E. Schaller, Rawls, the difference principle, and economic inequality, in
Pacific Philosophical Quarterly 79 (1998) p. 368 e ss.; J. Furman, Political
Illiberalism: The paradox of Disenfranchisement and the Ambivalences of Rawlsian
Justice, in Yale Law Journal, 1997, vol. 106, p. 1197 e ss.; J. Moriarty, Desert and
Distributive Justice in A Theory of Justice, in Journal of Social Philosophy, Vol. 33
No.1, Spring 2002, p. 131 e ss.;
115
Nella quale si era da tempo consolidata l’idea che la «filosofia politica di lingua
inglese fosse morta» e che dopo le opere di Sidgwick e Mill nessun filosofo avesse
contribuito in modo apprezzabile a questa tradizione filosofica (v. F. Romani,
Introduzione all’edizione italiana di B. A. Ackerman, La giustizia sociale nello stato
liberale, Il Mulino, Bologna 1984, p. 12, ed. originale: Social Justice in the Liberal
State, Yale University Press, New Haven and London 1980).
116
C. I. Massini Correas, La teoría contemporanea de la justicia, de Rawls a
MacIntyre, in Riv. int. fil. dir., 1993, pp. 204-205: «Aparecieron volúmenes colectivos
dedicados a la obra del profesor de Harvard se organizaron simposios, ciclos de
conferencias y congresos para debatir la nueva teoria de la justicia y los medios de
diffusión simplificaron sus ideas para hacerlas comprensibles al gran público».
146
specie aeternitatis117, appariva come teoria idonea a superare le contingenze di
una società storicamente determinata.
Rawls avvertiva infatti che la condivisione di una medesima concezione della
giustizia fosse un requisito indispensabile al fine di creare legami di convivenza
civile, in una società in cui le tendenze disgregatrici sono generalmente favorite
dai conflitti che tendono per lo più a sorgere circa il modo in cui devono essere
distribuite le risorse economiche e sociali.
Egli, pertanto, giunse all’individuazione di una concezione della giustizia,
concepita quale parametro di riferimento per le istituzioni sociali, in virtù del
compito che le stesse sono tenute ad assolvere, ovvero quello della distribuzione
dei doveri sociali, dei diritti fondamentali, dei benefici e degli oneri della
cooperazione interindividuale.
A tal fine, Rawls riteneva decisivo apportare dei correttivi alle disuguaglianze
economiche e sociali, che essendo determinate da fattori immeritati (come le
doti naturali, ad esempio, o la famiglia di origine), non appaiono di conseguenza
suscettive di essere tollerate all’interno di una società bene-ordinata118. Infatti,
nessun individuo potrebbe affermare che le proprie doti naturali siano in
qualche modo riconducibili ad un fattore meritocratico, poiché nessuno, ad
esempio, può dire di aver contribuito a nascere con una salute non cagionevole
o con un piacevole aspetto fisico. Questi fattori fortunati sono piuttosto frutto
della lotteria naturale, la quale opera secondo una logica totalmente estranea al
dominio dell’uomo e alla sue potenzialità di incidenza. Di conseguenza, dato il
carattere immeritato delle doti fisiche, è opportuno che le istituzioni sociali
prevedano dei correttivi per denaturalizzare la giustizia naturale che opera in
virtù del principio «a ciascuno secondo la propria natura»119. La giustizia
sociale invece parte dal presupposto che le doti fisiche siano irrilevanti ai fini
dell’individuazione di argomenti giustificativi della distribuzione delle risorse,
ma rilevanti al fine di procedere alla neutralizzazione delle stesse, affinché
soggetti naturalmente diseguali possano essere visti, dalla visuale prospettica
della giustizia, come eguali.
117
La prospettiva dell’eternità non è, a dire di Rawls, «un posto fuori dal mondo, né il
punto di vista di un essere trascendente; è invece una certa forma di pensiero e di
sentimento che le persone razionali possono adottare in questo mondo. E avendolo
fatto, qualunque sia la loro generazione, possono comporre insieme in un unico schema
tutte le prospettive individuali, e giungere insieme a principi normativi che possono
essere affermati da ognuno che viva sulla loro scorta, ciascuno dal proprio punto di
vista» (cfr. J. Rawls, Una teoria della giustizia, Feltrinelli, Milano 2002, p. 477, ed.
originale: A theory of Justice, The Belknap Press of Harvard University Press,
Cambridge - Mass, 1971).
118
Una società bene-ordinata è per Rawls quella in cui tutti i membri accettano i
principi di giustizia e dove le istituzioni fondamentali operano per la loro soddisfazione.
Op. cit, p. 22.
119
B. Celano, La denaturalizzazione della giustizia, Ragion pratica, 2000/14, p. 81.
147
In tal senso la “natura matrigna”120 della giustizia naturale viene ammansita e
corretta dalla giustizia distributiva avente carattere artificiale in quanto i suoi
principi sono correttivi di equalizzazione delle differenze individuati ad arte
dall’uomo. Lo stesso può dirsi per le differenze sociali, che dipendono
anch’esse dalla fortuna (chi può dire di meritare di essere nato nella famiglia a
cui appartiene? E ciò è vero, sia per chi nasce in un ambiente familiare di
elevata estrazione, sia per chi invece si ritrovi ad appartenere ad una famiglia
tristemente degradata).
Le distribuzioni naturali e sociali, afferma Rawls, non sono né giuste, né
ingiuste, sono semplicemente “fatti naturali”, mentre giusto o ingiusto può
essere invece il modo in cui le istituzioni si pongono nei loro riguardi, a seconda
cioè che avvertano o meno il problema della disuguaglianza ed intervengano in
modo adeguato121. I fatti naturali (come la povertà o le condizioni di minorità
fisica) vengono in tal modo trasformati in fatti istituzionali, conferendo
rilevanza sociale a circostanze che altrimenti verrebbero accettate passivamente
come stati di cose definitivi. La necessità che le istituzioni sociali intervengano
nei processi distribuitivi delle risorse dipende oltre che dall’inesistenza di un
qualche fattore di merito alla loro titolarità, anche dal fatto che le differenze
cagionate dalle doti naturali e sociali, possono raggiungere livelli di ingiustizia
così elevati che gli sforzi degli individui intesi a migliorare la loro condizione
potrebbero risultare del tutto inadeguati ed incapaci a sortire l’effetto di
contrastare fattori di discriminazione potenzialmente dotati di un’incidenza
continuata e pervasiva nell’esistenza di un individuo.
A queste ineguaglianze, che influenzano le opportunità che gli uomini hanno
nella vita, devono essere applicati i principi della giustizia sociale, i quali
varranno quali parametri regolatori della scelta della “costituzione politica” e
dei principali elementi del sistema economico e sociale di una comunità122 per
far in modo che lo stesso funzioni in modo equo e permetta una distribuzione di
beni sociali tale da non suscitare legittime contestazioni da parte di alcuno
individuo.
Questa attenzione nei confronti delle pretese di ciascun soggetto rende la teoria
della giustizia di Rawls quella che meglio si pone in veste di “etica pubblica”,
poiché prende in considerazione le pretese di ciascuno nell’individuazione dei
criteri distributivi delle risorse economiche e sociali, a differenza di quanto
invece faccia l’utilitarismo secondo cui i comportamenti richiesti agli individui
in una società, sono quelli che permettono di massimizzare l’utilità, la
soddisfazione, la felicità del maggior numero delle persone, essendo
quest’ultimo il parametro definitivo del giusto e dell’ingiusto. Esso ignora e
sacrifica così gli interessi della minoranza, anche se quelli del maggior numero
trovano invece soddisfazione.
120
Op. cit., p. 84.
J. Rawls, Una teoria della giustizia, cit., p. 99.
122
Op. cit., p. 24-25.
121
148
Di conseguenza, mentre gli utilitaristi adottavano una visione teleologica
dell’etica reputando giusto ciò che permette di raggiungere la felicità del
maggior numero ed anteponendo così al giusto il concetto del bene oggettivo
dell’utilità, Rawls invece adotta un’etica deontologica che antepone il giusto al
bene dove il primo non dipende da nessuna particolare concezione del secondo
e finisce per far sì che coloro che posseggono diverse concezioni del bene
possano ugualmente giungere ad un accordo intersoggettivo sui principi
distributivi.
Vi è da chiedersi, a questo punto, attraverso quale procedimento Rawls
individui i principi di giustizia, dal momento che essi non discendono da
nessuna concezione del bene e non sono tratti dalla natura o dalla ragione (come
vorrebbe un orientamento giusrazionalistico). A tal fine, si dovrebbe parlare più
che di procedimento, di procedura. Infatti i principi di giustizia sono individuati
«sulla base di una procedura di scelta neocontrattualista, che recupera le idee
giusrazionalistiche di stato di natura e di contratto sociale»123.
La giustizia come equità risponde alla nozione di giustizia procedurale pura,
nella quale la giustizia del risultato si ricava mediante il ricorso alla procedura
stessa, senza l’esistenza di un criterio indipendente di giustizia ed in una
condizione iniziale equa nella quale si trovano i soggetti deputati alla scelta.
Rawls, a tal fine, immagina che la scelta dei principi sia il frutto di un accordo
originario, di un contratto stipulato tra determinati individui che si trovano nella
cosiddetta “posizione originaria”. Essa è una situazione simile alla stato di
natura della teoria classica del contratto sociale, in quanto anche i soggetti in
questione sono liberi e tra di loro eguali, ma in tale caso lo sono grazie alla
copertura di un velo d’ignoranza che impedisce ad ognuno di avere la ben che
minima informazione circa il proprio essere determinato nella società. Rawls ha
cura di precisare che il ricorso all’artificio espositivo del contratto non è volto a
spiegare (come fecero Locke, Rousseau e Kant), l’origine della società civile,
ma procedendo verso un livello più alto di astrazione, esso viene utilizzato per
piegarlo ai fini dell’individuazione dei principi di giustizia distributiva124.
Per far sì che i soggetti impegnati nella scelta non vengano influenzati da
informazioni che li riguardano personalmente e che sarebbero tali da sfasare
l’equità del risultato, egli li colloca nel “puro regno della ragione”125, nel quale
è celata, in virtù del velo d’ignoranza, ogni conoscenza circa il posto dei
contraenti nella società, la propria fortuna nella distribuzione di doti e capacità
naturali, forza, intelligenza, concezione del bene, caratteristiche psicologiche
come l’avversione al rischio o la tendenza al pessimismo o all’ottimismo126.
Questa circostanza è chiaramente decisiva per garantire l’equità del risultato in
quanto, se i contraenti godessero di tali informazioni, certamente sceglierebbero
123
M. Barberis, Breve storia della filosofia del diritto, Il Mulino, Bologna 2004, p. 35.
J. Rawls, Una teoria della giustizia, cit., p. 27.
125
A. Porciello, Diritto Decisione Giustificazione, cit., p. 68.
126
J. Rawls, Una teoria della giustizia, cit., p. 125.
124
149
principi di giustizia più vicini ai propri interessi e di conseguenza il carattere
generale e universale dei criteri distributivi verrebbe irrimediabilmente
compromesso. L’equità del risultato inoltre viene ancora più garantita
dall’ignoranza circa le situazioni specifiche della società in cui vivono i
soggetti, non sapendo infatti né quale sia la situazione politica ed economica, né
il livello di civiltà e cultura raggiunto. I contraenti posseggono soltanto
cognizioni su fatti generali che concernono la società, comprendendo infatti
quali siano i problemi politici, i principi della teoria economica, le basi
dell’organizzazione sociale, le leggi della psicologia umana e tutti gli altri fatti
generali che influenzano la scelta dei principi di giustizia127. Infine, le parti
contraenti sanno di avere un senso di giustizia che li rende capaci di operare la
scelta dei principi distributivi e sanno inoltre di avere una propria concezione
del bene (non però quale essa sia in concreto), e di conseguenza tenderanno
verso principi che gli permetteranno di vederla realizzata128.
A questo punto si possono individuare i due principi di giustizia su cui poggia
l’intera costruzione rawlsiana e che sono il principio di uguale libertà ed il
principio di differenza, organizzati secondo un ordine lessicografico per cui il
primo gode di una posizione di priorità rispetto al secondo e ciò fa sì che la
libertà possa essere limitata solo in nome della libertà stessa129. Il primo
principio presenta la seguente formulazione: «Ogni persona ha un eguale diritto
al più ampio sistema totale di eguali libertà compatibilmente con un simile
sistema di libertà per tutti»130.
La titolarità di questo insieme di libertà fondamentali definisce il paradigma
dell’eguaglianza così come «la disuguaglianza nei diritti genera l’immagine
dell’altro come disuguale, ossia inferiore antropologicamente proprio perché
inferiore giuridicamente»131.
Le libertà fondamentali sono sostanzialmente la libertà politica, libertà di
parola, di riunione, di coscienza, di pensiero, libertà della persona, libertà di
possedere proprietà, libertà dall’arresto e dalla detenzione arbitrari132. I cittadini
di una società giusta devono pertanto godere degli stessi diritti fondamentali,
127
Op. cit., p. 126.
I principi di giustizia ricavati mediante accordo stipulato nella posizione originaria
dovranno avere i caratteri della generalità, in quanto non devono riferirsi a casi e
situazioni specifici; della universalità per quanto riguarda il profilo applicativo,
dovendo infatti valere per ogni individuo; della pubblicità in quanto i principi sono
condivisi da ciascun soggetto, essendo il frutto di un’esplicita pattuizione; della
definitività poiché i principi non possono essere modificati facendo appello ad istanze
superiori; ed infine dell’imporre un ordinamento alle pretese conflittuali secondo la
loro importanza.
129
Op. cit., p. 255.
130
Ibidem.
131
L. Ferrajoli, Diritti fondamentali, Laterza, Roma – Bari 2001, p. 26.
132
J. Rawls, Una teoria della giustizia, cit., p. 66.
128
150
non essendo ammissibile che taluno ne sia carente o vi rinunci in cambio di
maggiori vantaggi sociali ed economici, né che i sacrifici di alcuni possano
essere giustificati facendo appello ad un maggior bene aggregato come vorrebbe
la concezione utilitarista.
Il principio di libertà non è stato contestato dai critici a differenza di quanto sia
accaduto al secondo principio che presenta tale formulazione: «Le
ineguaglianze economiche e sociali devono essere: a) per il più grande beneficio
dei meno avvantaggiati, compatibilmente con il principio del giusto risparmio, e
b) collegate a cariche e posizioni aperte a tutti in condizioni di equa eguaglianza
di opportunità»133.
Il principio di differenza, sebbene subordinato nell’impianto teorico al primo
principio, rappresenta il punto nevralgico della concezione rawlsiana, perché è
quello che meglio compendia la sua visione della giustizia.
Esso è costruito al fine di rimediare agli errati esiti distributivi a cui conduce
l’uguaglianza delle opportunità. Essa si basa infatti sull’assunto che presupposto
indispensabile per la giustificazione delle disuguaglianze tra i cittadini è che
nessuno sia vittima di forme di discriminazione fondate sul sesso, sulla razza,
sulla lingua, sulle condizioni economiche o sullo status sociale. Di conseguenza
le disuguaglianze esistenti sono giustificate se determinate in modo esclusivo
dalle capacità di ciascuno. Seguendo tale ragionamento, coloro che guadagnano
di più, se non sono stati avvantaggiati per motivi riguardanti la condizione
economica, sociale o il sesso, possono essere considerati i migliori e pertanto
aventi pieno titolo a godere dei privilegi la cui posizione comporta e tutto ciò
indipendentemente dal prevedere un sistema che possa andare a vantaggio di
coloro che stanno peggio. L’uguaglianza delle opportunità sarebbe, in sostanza,
foriera del motto “che vinca il migliore!” e così facendo sottovaluta che non
basta garantire l’assenza di discriminazioni sessuali, economiche e sociali, se
non si tiene in conto il primo forte fattore di discriminazione che è quello della
differente e talvolta bizzarra distribuzione delle doti naturali. Se all’interno di
un gruppo di dieci persone, tre hanno un quoziente intellettivo elevatissimo, tre
medio, due inferiore alla media, e due pari a zero, il fatto di puntare, per
giustificare le disuguaglianze, sull’argomento dell’assenza di discriminazione
sessuale, economica e sociale, produce un esito altamente ingiusto poiché pur in
assenza delle suddette discriminazioni, gli ultimi quattro soggetti del gruppo
non potranno mai essere i migliori tra i dieci e non potranno mai giungere alle
stesse posizioni di prestigio a cui, con ogni probabilità, potranno giungere i
primi sei soggetti. Dal momento che le doti naturali non sono fattori imputabili
al merito del titolare, ne deriva che la disuguaglianza a cui esse portano deve
essere corretta.
Ora, Rawls non propone di annullare ogni tipo di differenza, ma ritiene che le
disuguaglianze presenti nella società debbano migliorare le aspettative dei meno
133
Op. cit., p. 255.
151
avvantaggiati poiché «se è vero che nessuno deve avvantaggiarsi delle
disuguaglianze naturali immeritate, è vero anche che possono esservi casi in cui
questi vantaggi arrecano un beneficio a tutti. Nessuno merita di beneficiare dei
propri talenti naturali, ma consentire a qualcuno di beneficiarne non sarà
ingiusto se questo privilegio lavorerà a vantaggio di coloro che nella “lotteria
naturale” sono stati meno fortunati»134. Come si può notare dalla formulazione
del principio di differenza, Rawls non nasconde l’importanza del principio
dell’uguaglianza delle opportunità, poiché infatti è inserito nel principio in
questione, ma lo ritiene da solo insufficiente se si vuole affrontare in profondità
il problema della diseguaglianza, ed il miglior modo per farlo è quello di
vederla operare a vantaggio dei meno avvantaggiati. In tal senso il principio di
differenza assume i caratteri del principio di riparazione «poiché, anche se non
mira ad annullare le minorazioni, tende però a porre i benefici discendenti dalle
doti naturali a disposizione di tutti, con l’obiettivo di attenuare gli effetti dei
valori del merito e dell’efficienza. […] Fornisce, infine, un’applicazione del
principio di fraternità, corrispondente all’idea di non desiderare maggiori
vantaggi se non si favoriscono contemporaneamente i meno fortunati»135.
La critica principale che viene mossa al principio di differenza, è dunque quella
di non assumere un atteggiamento veramente propositivo per il problema della
diseguaglianza, ma prevede semplicemente un artificio per renderla più
accettabile.
A questo punto ci si potrebbe domandare perché i soggetti rawlsiani
rappresentativi della scelta giungano ad un accordo proprio su questo principio
a fronte di altri egualmente prospettabili. La risposta a tale perché coincide con
il concetto di massimizzazione della posizione minima o, più notoriamente, di
maximin136. Partendo dalla consapevolezza che i soggetti coperti dal velo di
ignoranza non sanno quale sarà il posto che occuperanno nella società, essi
saranno propensi ad orientarsi a favore di un principio che migliori la propria
situazione nella sfortunata ipotesi in cui dovessero realmente trovarsi nelle
peggiori condizioni naturali, economiche e sociali. La preferibilità razionale del
secondo principio di Rawls si può spiegare attraverso questo esempio. Si
immagini di dover scegliere tra tre schemi distributivi di risorse da ripartire tra
tre soggetti, nessuno dei quali sa quale sarà la porzione che gli toccherà in
concreto.
Il primo schema prevede che al primo soggetto vengano date 10 risorse, al
secondo soggetto 9, al terzo 1.
Il secondo schema prevede invece che al primo soggetto vengano assegnate 10
risorse, al secondo 8, al terzo 2.
134
W. Kymlicka, Introduzione alla filosofia politica contemporanea, Feltrinelli, Milano
2000, p. 71.
135
A Scerbo, Giustizia Sovranità Virtù, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004, p. 75.
136
J. Rawls, Una teoria della giustizia, cit., p. 137.
152
Infine il terzo schema assegnerebbe al primo soggetto 8 risorse, al secondo e al
terzo 6.
Dinnanzi a queste tre possibilità Rawls afferma che i tre soggetti sceglierebbero
il terzo schema distributivo poiché la terza posizione è di gran lunga migliore
rispetto a quella prevista dai primi due schemi distributivi.
In una logica del genere opera il principio di differenza, poiché i contraenti, che
non sanno quale sarà la loro posizione nella società, tenderanno verso un
principio che massimizzi la condizione di coloro che stanno nella posizione
minima, dal momento che non sono in grado di escludere che essa gli capiterà in
concreto.
Per rimediare agli esiti della lotteria naturale e ai vantaggi conseguenti dalle
posizioni sociali date a ciascuno (in modo indeterminato) dalla sorte, la teoria
della giustizia di Rawls vorrebbe che fosse data a ciascuno la stessa quantità di
beni sociali, quali reddito, ricchezza, diritti e libertà, opportunità e poteri.
La posizione originaria si giustifica non solo per il fatto di creare una situazione
di uguaglianza tra le parti contraenti, dal momento che tutti hanno eguali diritti
nella procedura di scelta dei principi potendo fare proposte e avanzare ragioni
per la loro accettazione, ma anche perché essa è in grado di generare un
equilibrio riflessivo tra i principi ed i giudizi ponderati delle parti stesse. Infatti,
alla concezione della giustizia come equità non si arriva mediante un
procedimento sillogistico di derivazione da giudizi di granitico contenuto, simili
a verità assolute e immutabili, ma al contrario, i giudizi stessi possono subire a
loro volta delle rivisitazioni ed emendamenti alla luce dei principi stessi.
Si raggiunge l’equilibrio quando i principi coincidono con i nostri giudizi ed è
un equilibrio riflessivo perché si sa a quali principi i nostri giudizi si
conformano e perché, più in generale, i principi si giustificano alla luce di un
“aggiustamento globale” tra molteplici considerazioni. Raggiunto l’equilibrio,
esso non è tuttavia definitivo, in quanto nulla esclude che i giudizi stessi
possano essere nuovamente sottoposti a revisione137.
La teoria della giustizia di Rawls, da ultimo, non si pone in contrasto con il
libero mercato e con il capitalismo in generale, ma esige che il potere pubblico
intervenga nei meccanismi distribuiti delle risorse, al fine di garantire, in un
sistema di equa uguaglianza delle opportunità, correttivi alle azioni del mercato
ogniqualvolta esse si rendano incompatibili con un sistema fondato sulla
giustizia come equità. Un sistema economico giusto apporta dei limiti alla
proprietà privata, prevede imposte sui redditi e sui consumi, controlla il mercato
del lavoro, garantisce un reddito minimo e regola il fenomeno successorio.
La teoria della giustizia di Rawls, sebbene possa sembrare intuitivamente
condivisibile, presta il fianco ad una serie di critiche che i commentatori
dell’opera non hanno potuto fare a meno di rilevare.
137
Op. cit., p. 56.
153
2. Bruce Ackerman: interlocutore critico di John Rawls.
Tra i numerosi interpreti dell’opera di Rawls si pone Bruce Ackerman, che si
inserisce nel dibattito filosofico sulle questioni della giustizia nel 1980, con
l’opera La giustizia sociale nello stato liberale138, la quale, adottando una
prospettiva anti-utilitarista, giunge ad una soluzione simile a quella rawlsiana,
consistente nel proporre una distribuzione ugualitaria delle risorse, ma
divergendo da quella sotto l’aspetto metodologico e argomentativo.
Ackerman contesta, al riguardo, in primis, il ricorso all’artificio del contratto,
in quanto ritiene che i principi di giustizia ricavati nella posizione originaria
(che hanno ottenuto il consenso delle persone rappresentative della scelta) non
possano poi vincolare le stesse persone in un futuro molto lontano rispetto al
momento della scelta, né vincolare anche coloro che non abbiano preso parte al
contratto e che non si trovano in concreto in quella situazione così rarefatta di
realtà come quella ipotetica della posizione originaria. Infatti, «se gli uomini
non sono equamente vincolati dai contratti a cui hanno dato il loro consenso
effettivo, perché dovrebbero essere vincolati ad un contratto sociale a cui hanno
accordato solo un consenso ipotetico?»139. Inoltre, la visione contrattualista
presuppone che i soggetti deputati alla scelta precedano la società e siano in
possesso di diritti e doveri di cui sono già titolari dal precedente stato di natura e
la cui base di esigibilità è rappresentata semplicemente dalla promessa di
rispettare il contratto e non già dalle forme argomentative attraverso le quali si
arriva a riconoscere l’esistenza, in capo a quei soggetti, di una complessa
gamma di diritti e doveri. Ackerman ritiene infatti che il fondamento
giustificativo degli stessi, vada ritrovato non nel momento preciso in cui si
giunge ad una pattuizione, ma nella complessiva impresa discorsiva o meglio
dialogica, attraverso la quale, gli individui, ragionando insieme, si riconoscono
reciprocamente e ugualmente titolari di diritti e obblighi. Il momento
dell’accordo è, in altre parole, il punto di arrivo e non di partenza, dal quale
rivendicare nei confronti dello Stato e dei terzi, pretese soggettive.
Alla critica del contrattualismo rawlsiano, Ackerman fa seguire, in maniera
quasi immediatamente logica, quella alla posizione originaria che, come si
visto, è la condizione artificiosamente allestita da Rawls per poter piegare ai
propri fini la procedura della scelta dei principi di giustizia. In quella situazione
irreale, lontana da una dimensione pratica e nell’alveo, invece, di una
solamente teoretica, i soggetti coperti dal “velo d’ignoranza” giungerebbero,
guidati dalla ragione, ai due principi di giustizia sopra visti. Ackerman non
condivide affatto questo metodo, poiché individua in esso l’astuzia, potremmo
dire, del suo autore e non già - come direbbe Hegel - della ragione.
138
B. A. Ackerman, La giustizia sociale nello stato liberale, Bologna, Il Mulino, 1984,
(ed. originale: Social Justice in the Liberal State, Yale University Press, New Haven
and London 1980).
139
Op. cit., p. 273.
154
Infatti, è persuasiva la mossa del velo di ignoranza, (che compre tutte le
conoscenze personali dei soggetti circa la propria esistenza), perché
dimostrerebbe che i soggetti deputati alla scelta non sono mossi da nessun
egoismo volto ad avvantaggiare la categoria alla quale appartengono e pertanto
alla luce dell’argomento del maximin, il principio di differenza risulta
evidentemente la migliore tra le possibili soluzioni al problema della
diseguaglianza. Ma Ackerman muove un’obiezione precisa che è quella della
caratterizzazione dei soggetti della scelta, con la quale dimostra che l’idea
brillante del velo d’ignoranza non può funzionare. Infatti, se i soggetti non sono
provvisti di «un qualsiasi insieme di preferenza a guida del loro giudizio»140 la
possibilità di operare una scelta è pressoché nulla, in quanto aggiunge
Ackerman «ex nihilo nihil fit»141.
La caratterizzazione rawlsiana dei contraenti palesa una particolare visione
dell’identità personale, che verrebbe ad essere determinata in modo del tutto
autonomo dai legami con la realtà concreta che è poi la società. Tuttavia, se è
pur vero che Rawls non è un comunitarista (e pertanto non può avere la visione
dell’individuo come soggetto che si determina anche grazie al suo essere in
società), non si può nascondere che le vesti degli Io noumenici in cui fa calare i
contraenti, sono fin troppo asettiche e finiscono per sottovalutare le potenziali
utilità che possono derivare dalla conoscenza delle questioni concrete afferenti
la vita degli individui e della società.
Al riguardo, Ackerman afferma, in senso contrario, che «qualunque
individualità io possegga, non l’ho ottenuta indipendentemente dalla società,
bensì l’ho ottenuta come risultato dell’interazione con la società»142.
Occorre però aggiungere che Rawls, essendo consapevole che l’ignoranza
assoluta alla quale ha vincolato i contraenti avrebbe potuto prestare il fianco a
delle critiche, ha avuto cura di precisare che i contraenti hanno delle conoscenze
generali sull’economia e la politica tali da permettergli comunque di procedere
con la scelta143. Ma neanche questa mossa soddisfa Ackerman, poiché anzi
rivelerebbe chiaramente l’astuzia di cui sopra si è detto ed infatti egli osserva
«quali cose noi manipolatori del velo, dovremmo permettere ai contraenti di
vedere? Infatti le loro scelte, com’è naturale, non saranno altro che il prodotto
del nostro gioco di ombre»144. In definitiva è il contrattualista stesso a
determinare il risultato della scelta e non già i contraenti mediante l’attivazione
delle proprie esclusive facoltà mentali. Essi invero, si muoverebbero alla luce
della critica di Ackerman, come marionette sul palco della posizione originaria.
I contraenti invece di mascherare la consapevolezza che hanno di sé ed
affrontare il problema della scarsità delle risorse in una situazione di morale
140
Op. cit., p. 444.
Ibidem.
142
Op. cit., p. 433.
143
J. Rawls, Una teoria della giustizia, cit., p. 126.
144
B. A. Ackerman, La giustizia sociale nello stato liberale, cit., p. 444.
141
155
amnesia145, sono chiamati da Ackerman ad affrontare il problema a viso
scoperto, avendo piena conoscenza di chi sono e di cosa sono chiamati a fare.
Se, infatti, i soggetti deputati alla scelta dei principi di giustizia non sapessero
neanche (come vuole Rawls) quale sia la propria concezione particolare del
bene, non potrebbero individuare soluzioni pratiche, né veramente eque poiché
le trattative anteriori al raggiungimento di un accordo sarebbero esercitazioni
ioci causa ed i soggetti non saprebbero in concreto quale sia la missione da
compiere. Invece, come si vedrà, per Ackerman è essenziale avere
consapevolezza della propria concezione del bene per rivendicare diritti sulle
risorse.
Sul solco di queste critiche, Ackerman affronta la definizione rawlsiana di
classe meno avvantaggiata, nel cui interesse, alla luce del principio di
differenza, devono essere risolte le diseguaglianze. Questa definizione ha
incontrato le obiezioni anche di altri critici poiché tra la categoria dei meno
avvantaggiati, Rawls pone tutte le persone «con meno della metà del reddito e
della ricchezza medi»146e così facendo, esclude coloro che sono afflitti da
handicap genetici. Le minorazioni fisiche, anche da sole, senza il concorso della
scarsità di risorse economiche e di condizioni sociali particolari, sono tali da
incidere, spesso in modo irrimediabile sulle prospettive di una vita da vivere al
meglio delle possibilità. Per cui, sebbene la teoria di Rawls, superi il parametro
dell’uguaglianza delle opportunità, quando si appresta a trovare la soluzione al
problema, non include però, tra coloro che meriterebbero misure compensatorie,
anche gli affetti da minorazioni genetiche147. Ackerman invece discostandosi dai
critici su questo punto, ritiene che i soggetti minorati geneticamente sarebbero
comunque ricompresi nella categoria dei meno avvantaggiati, ma l’ingiustizia
consisterebbe proprio nel porli sullo stesso piano del proletario sano.
Ora, dal momento che il numero dei proletari sani è più elevato rispetto a quello
delle persone con difetti congeniti, gli interessi degli appartenenti a questa
minoranza verrebbero sacrificati per massimizzare la posizione della classe
complessivamente considerata, poiché le pretese della minoranza sarebbero
d’intralcio alle rivendicazioni del gruppo più consistente. Una persona dunque
affetta da gravi handicap secondo Ackerman, sarebbe, alla luce della teoria di
Rawls, come un «frammento sommerso» della classe meno avvantaggiata148.
Una teoria liberale invece, deve tenere seriamente conto della posizione dei
minorati geneticamente, non potendola subordinare nel perseguimento degli
interessi di altri soggetti. In tal senso, aggiunge Ackerman, «è semplicemente
grottesco rispondere alla condizione di X [persona portatrice di handicap]
145
B. A. Ackerman, R. Dworkin, J.C. Harsanyi, J. Rawls, Teorie della giustizia sociale,
a cura di A. Besussi, Ed. Unicopli, Milano 1986, p. 75.
146
J. Rawls, Una teoria della giustizia, cit., p. 95
147
W. Kymlicka, Introduzione alla filosofia politica contemporanea, cit., p. 88.
148
B. A. Ackerman, La giustizia sociale nello stato liberale, cit., p. 356.
156
raccontandogli tutte le belle cose fatte per i proletari bianchi, maschi e sani»149.
Di conseguenza ci sarebbe sfruttamento (termine che Ackerman usa per indicare
una situazione ingiustamente diseguale), non solo tra coloro che appartengono
alla classe meno avvantaggiata e gli altri soggetti più fortunati, ma anche tra gli
stessi membri della classe in questione, con la conseguente impossibilità di
provvedere al soddisfacimento delle pretese dei portatori di handicap, poiché
essendo in numero ridotto rispetto agli altri, verrebbero esclusi dagli interessi
dello stato attivista.
Al contrario, afferma Ackerman, «il liberalismo assicura ai contraenti che, per
quanto impotenti possano essere, le loro richieste non passeranno mai
inascoltate»150. Come si può rilevare, la stessa critica che Rawls aveva rivolto
all’Utilitarismo, di non tenere in conto le pretese della minoranza e di
sacrificarle invece in nome del perseguimento della massima felicità per il
maggior numero, Ackerman la indirizza a Rawls, il quale nella elaborazione del
principio di differenza si imbatterebbe nello stesso errore argomentativo.
Inoltre, la definizione di classe meno avvantaggiata presenta, secondo
Ackerman, un’altra imperfezione, che è quella di sottovalutare il fatto che
vittime di sfruttamento e di ingiuste discriminazioni possono essere anche
soggetti che appartengono alle classi medie, come gli uomini di colore e le
donne. Essi, pur potendo avere un reddito e una ricchezza pari alla media,
possono nondimeno essere vittime di sfruttamento e, di conseguenza, la teoria
di Rawls sarebbe un’elaborazione escludente le legittime rivendicazioni di
soggetti che subiscono torti pur gravi. «Una teoria liberale non ha bisogno di
sminuire i reclami di persone che si trovino in una posizione elevata nella
struttura di potere complessiva, le quali scoprono che le loro rivendicazioni […]
sono state loro negate a causa della loro razza, del loro sesso o di una
concezione del bene impopolare»151. Per tali ragioni, Ackerman ritiene che la
teoria di Rawls debba essere superata, anche perché il principio di differenza
nella sua complessiva formulazione non si sforza di risolvere il problema delle
disuguaglianze, ma si limita semplicemente ad individuare le condizioni alle
quali esse possano essere tollerate e dunque ammesse e quindi reputate, se
vogliamo, anche giuste.
3. La teoria della giustizia di Ackerman: i principi del dialogo neutrale.
La teoria liberale di Ackerman intende individuare la soluzione al problema
delle diseguaglianze, attraverso argomentazioni chiaramente differenti da quelle
di Rawls, seppure nella sostanza aventi in comune con quella una vocazione
egalitaria del meccanismo distributivo delle risorse. Il liberalismo per Ackerman
149
Op. cit., p. 357.
Op. cit., p. 358.
151
Op. cit., p. 361.
150
157
rappresenta un «modo di parlare del potere, una forma di cultura politica»152 che
esclude che in uno stato liberale qualcuno possa godere del beneficio
dell’invisibilità, ovvero del privilegio di non giustificare la titolarità ed il
godimento esclusivo di beni. Questa cultura politica trova esplicazione anche
sul piano pratico, poiché l’arroccarsi al suddetto privilegio determina
l’illegittimità del potere che ne deriva.
Da più parti dell’opera emergono infatti il valore e le potenzialità del confronto
tra gli individui i quali attraverso la continua interazione dialogica possono
evitare le ingiustizie e presentare le proprie legittime istanze. I diritti infatti, non
sono, secondo Ackerman come i frutti di un albero che crescono
spontaneamente e si presentano da sé pronti per essere raccolti da qualcuno, ma
l’unico modo per rivendicarli è la possibilità di confrontarsi con qualche
potenziale concorrente. L’uguaglianza infatti non si giustifica in base al
sentimento, ma in base ai discorsi che gli individui presentano a sostegno delle
rispettive rivendicazioni.
L’impostazione dell’opera rifugge dalla finzione contrattualista della posizione
originaria e del velo di ignoranza, ma non manca anch’essa di una buona dose
di irrealtà. Infatti Ackerman immagina di imbarcarsi insieme al lettore e a tutti
gli altri su una navicella per un viaggio di esplorazione che li porterà alla
scoperta di un nuovo mondo, sul quale decidono di atterrare e quivi insediarsi. Il
mondo che si offre agli occhi dei colonizzatori presenta un’unica risorsa, la
manna, la quale è divisibile, malleabile all’infinito ed in grado di trasformarsi in
qualsivoglia oggetto153, ma purtroppo presenta una caratteristica comune alle
risorse terrestri che è la scarsità. Per questa ragione i colonizzatori si troveranno
coinvolti in lunghi dialoghi volti a rinvenire la regola migliore per procedere
equamente alla distribuzione della manna.
Il primo elemento interessante che si coglie è che a differenza di quanto accada
nella posizione originaria di Rawls, tutti i soggetti possono partecipare alla
scelta del criterio distributivo e non soltanto alcuni soggetti rappresentativi e
questo perché l’uguaglianza di tutti va tenuta presente non solo nel momento
distributivo delle risorse, ma anche, e soprattutto, nel momento in cui si decide
come procedere nella distribuzione, perché questo è il momento cruciale in cui
si gioca veramente la partita dell’uguaglianza.
I colonizzatori del nuovo mondo nei lunghi dibattiti propongono diverse
soluzioni, che devono conformarsi a tre principi fondamentali organizzativi del
discorso liberale che, come le pareti di una diga, convogliano le argomentazioni
dei partecipanti verso una sola soluzione distributiva possibile che è quella
dell’uguaglianza delle risorse. Mentre Rawls riteneva indispensabile apportare
delle restrizioni alle informazioni godute dai soggetti rappresentativi della
scelta, Ackerman invece permette ai colonizzatori di sapere concretamente chi
152
153
Op. cit., p. 45.
Op. cit., p. 75.
158
sono e non considera quindi l’ignoranza una mossa decisiva per la scelta dei
principi di giustizia, poiché «invece che cancellare le nostre identità particolari
[…] lo stato liberale permette ad ognuno di noi di parlare del fatto che noi, dalla
vita, vogliamo cose diverse»154. È invece decisivo porre delle restrizioni al
dialogo che è definito pertanto vincolato. Infatti i colonizzatori quando
propongono gli schemi distributivi devono prestare attenzione ai principi di
Razionalità, Coerenza e Neutralità, se vogliono che le proposte avanzate siano
tenute in considerazione, poiché la minima violazione di anche uno solo dei tre
principi comporta la caducazione della proposta, in ossequio alla formula
aristotelica contra principia negantem non est disputandum. I tre principi di
giustizia non vengono ricavati attraverso un procedimento simile a quello
rawlsiano, per cui i soggetti rappresentativi della scelta si convincono
razionalmente della bontà dei principi di libertà e di differenza. Ciò si giustifica
in ragione del fatto che i principi di Ackerman sono nel loro insieme la
grundnorm presupposta che dà validità alle argomentazioni relative alla
distribuzione delle risorse. I cittadini del nuovo mondo non possono infatti
dubitare della loro giustezza ed eventualmente contestarla, poiché i principi
vengono offerti come unica possibilità per poter fondare, attraverso il loro
rispetto, un argomento distributivo accettabile. Mentre i principi di Rawls sono
principi operativi attraverso i quali si può ricavare in via diretta il criterio
egualitario distributivo, i principi di Ackerman, invece, sono principi di
giustificazione di proposte distributive, che portano in un momento successivo
all’accettazione della regola egualitaria.
A presidio dei tre principi Ackerman pone (tra gli altri) un personaggio
immaginario che è la Comandante, la quale, piuttosto che «dominare
dispoticamente tutti noi, imporrà solo certe regole di fondo alla conversazione, e
precisamente i tre principi richiesti dalla concezione liberale del legittimo
discorso sul potere»155.
Il primo di essi (Razionalità) esige che «Ogni volta che qualcuno mette in
dubbio la legittimità del potere altrui, il detentore del potere deve rispondere
non reprimendo il contestatore, ma fornendo una ragione la quale spieghi perché
egli abbia un diritto alle risorse maggiore di chi lo contesta»156. Questo principio
ha carattere generale e risponde ad un’esigenza di trasparenza nell’ambito della
titolarità e del godimento delle risorse, in quanto qualsiasi posizione di potere
deve essere giustificata, non ammettendo a nessuno, in virtù della sua posizione
sociale ed economica di comportarsi, in un regime democratico, come un
imperioso feudatario, sordo alle contestazioni dei suoi simili o, come Proteo la
divinità marina dotata di saggezza e virtù profetiche che assumeva le più
svariate sembianze per sfuggire alle domande di chi intendeva indurlo a parlare.
Il principio di razionalità esprime un’esigenza di giustificabilità delle posizioni
154
Op. cit., p. 450.
Op. cit., p. 76.
156
Op. cit., p. 42.
155
159
di potere e delle rivendicazioni al godimento non egualitario delle risorse. In
tale prospettiva i diritti hanno un fondamento dialogico non trovando sostegno
normativo in concetti quali lo stato di natura o il contratto sociale.
Il secondo principio (Coerenza) serve per preservare l’intellegibilità del dialogo
avviato dalla razionalità poiché «le ragioni addotte in una determinata
circostanza da chi esercita il potere non devono essere incompatibili con le
ragioni che adduce per giustificare le altre rivendicazioni sul potere»157.
Infine, il principio di Neutralità è come il principio di differenza di Rawls, la
pietra angolare su cui poggia tutta la sua teoria e sostiene che una
«giustificazione non è valida se richiede al detentore del potere di asserire:
a) che la sua concezione del bene è superiore a quella affermata da uno
qualunque dei suoi concittadini, oppure
b) che a prescindere dalla sua concezione del bene, egli è per natura superiore
a uno o più suoi concittadini»158.
Il principio di neutralità è quello che crea più problemi ai colonizzatori nel
momento in cui presentano le rispettive richieste riguardanti la manna. Alcuni
ad esempio, vogliono avere una porzione di manna superiore a quella degli altri
concittadini perché con essa creeranno delle cattedrali bellissime o perché la
impiegheranno per nobili scopi e dal momento che la loro concezione del bene è
superiore a quella di coloro che invece se ne serviranno solo per riempirsi la
pancia, pretendono che il meccanismo distributivo delle risorse non sia
egualitario. Tuttavia benché sia apprezzabile il fine per il quale questi soggetti
vorranno impiegare la manna, esso non è una ragione sufficiente per avere
porzioni maggiori poiché il principio di neutralità nella prima parte della
formula prevede il divieto di selettività che dichiara indifferenti, ai fini
distributivi, le concezioni del bene sostenute dai soggetti. Non è infatti possibile
operare dei giudizi di valore e discriminare così, sul piano distributivo, gli
individui a seconda di una concezione più o meno nobile del bene, poiché non
esiste alcun parametro che ci possa venire incontro in una siffatta impresa. Per
rivendicare una porzione di manna è sufficiente avere una certa concezione del
bene (qualunque essa sia) ed il dialogo neutrale traccia dunque ai colonizzatori
il sentiero che permette loro di affermare, ciascuno a suo modo, la propria
concezione del significato della vita, evitando al contempo di porre limiti alla
eguale affermazione dei loro concittadini. In virtù di ciò il diritto all’eguale
considerazione e rispetto di ciascuno è un dato indispensabile da tener ben
presente per potere fondare una richiesta che sia legittima.
I colonizzatori poi, a fronte della contestazione derivante dalla violazione della
prima parte del principio di neutralità, non potranno avanzare pretese su
porzioni maggiori di manna, dichiarando che comunque essi sono esseri
superiori ai loro concittadini e che pertanto questo basterebbe a sostenere le
157
158
Op. cit., p. 46.
Op. cit., p. 50.
160
proprie richieste. La seconda parte del principio contiene infatti il divieto di
affermazione di superiorità incondizionata, il quale prevede come dato
incontestabile l’uguaglianza morale dei soggetti ed il diritto di ciascuno
all’eguale considerazione. Uno stato liberale pertanto si deve porre, nei
confronti delle diverse concezioni del bene, così come nei confronti di tutte le
persone, quale che sia la loro posizione sociale e livello economico, in
atteggiamento di assoluta imparzialità ed equidistanza nel momento in cui si
appresta ad affrontare il problema della distribuzione delle risorse. Di
conseguenza, data l’uguaglianza morale dei colonizzatori, ne deriva che il
metodo migliore per ripartire la manna è procedere mediante una distribuzione
in parti uguali all’interno di un sistema transazionale flessibile in cui viene
concesso a ciascuno di poter scambiare liberamente i propri diritti iniziali.
Pertanto se un individuo non può chiedere di più rispetto a quanto è dato agli
altri, tuttavia può chiedere che gli venga dato almeno quanto hanno gli altri. Se
qualcuno dovesse negargli il diritto alla sua eguale porzione di manna, non ha
che difendersi mediante la mossa conversazionale «poiché valgo almeno quanto
te».
I tre principi di giustizia presentati da Ackerman concorrono a definire una terza
versione del concetto di tolleranza alternativa a quella tradizionale di «un
atteggiamento intenzionale (…) di sopportazione da parte di un soggetto
normativamente competente ad assumere un tale atteggiamento (…) rispetto ad
una condotta che è prima facie giudicata (…) come riprovevole (…), ma che
viene ammessa o non punita»159, ed anche rispetto a quella rawlsiana che è
intesa come la traduzione in diritti positivi riconosciuti ad ogni cittadino e
finisce per essere un concetto che esclude l’idea stessa della tolleranza perché i
diritti non si devono tollerare ma riconoscersi e proteggersi160.
La versione della tolleranza che emerge dall’opera di Ackerman potrebbe essere
intesa piuttosto come “principio di esercizio del diritto”161, poiché se i diritti in
genere non ci indicano le modalità del loro esercizio e della loro applicazione
concedendo ai loro titolari un certo spazio di discrezionalità, la stessa ha
bisogno di essere «resa controllabile cioè soggetta a forme intersoggettive e
pubbliche di razionalità»162, se non si vuole che si trasformi in arbitrio.
I tre principi di razionalità, coerenza e neutralità disciplinano le forme di
esercizio del diritto all’uguaglianza morale, riconosciuto ad ogni soggetto,
prescrivendo che ad ogni richiesta di legittimazione del potere venga data una
risposta, la quale non contraddica le giustificazioni di potere date in precedenza
e non faccia appello al concetto di superiorità morale o esistenziale del soggetto.
159
M. La Torre, Tolleranza, in Seminari di Filosofia del diritto, a cura di M. La Torre e
G. Zanetti, Rubbettino, Soveria Mannelli 2000, p. 152.
160
Op. cit., p. 154.
161
Op. cit., p. 158.
162
Op. cit., p. 160.
161
3.1. Il consenso razionale.
Il metodo dialogico che Ackerman predilige presenta delle affinità con la teoria
del discorso di Habermas che propone il principio D come parametro di validità
delle norme giuridiche che si legittimano non attraverso una procedura di
produzione monologica, ma in virtù di un’impresa discorsiva che coinvolge
autore e destinatario della legge. In una visione della democrazia come ideale
normativo, che recupera il valore dell’autonomia individuale e pubblica, messo
in ombra dalla visione metodologica della stessa, possono dirsi valide «soltanto
le norme d’azione che tutti i potenziali interessati potrebbero approvare
partecipando a discorsi razionali»163. Nei confronti dei potenziali interessati,
che sono in sostanza coloro che potranno subire gli effetti di una prassi generale
regolata dalla norma, le norme si pongono in una posizione di legittima
aspettativa di riscattabilità quanto a validità, nel senso che le stesse avanzano
una pretesa di legittimità discorsiva che poggia sul fatto di poter essere
accettate razionalmente164. E dunque la validità delle norme si configura a
partire dalla possibilità che su di esse si formi un consenso universale.
Questo concetto era già presente in Kant secondo il quale ogni legislatore è
tenuto a fare le leggi come se potesse derivare il contenuto d’esse dalla volontà
comune di tutto il popolo, considerando ogni suddito, che voglia essere
cittadino, come se avesse dato il proprio consenso a quella volontà. Questa è in
definitiva secondo Kant la pietra di paragone della legittimità di ogni legge
pubblica165, per cui se la legge è fatta in modo tale che su di essa sarebbe
impossibile formarsi il consenso di tutto il popolo, allora la legge non è giusta.
Invece se è «solo possibile che un popolo consenta a tale legge allora si ha il
dovere di ritenerla giusta»166.
Il principio del discorso può applicarsi a qualsiasi problematica che avanzi una
pretesa di validità e permette di dare un fondamento imparziale alle norme
d’azione. In questo modo una produzione giuridica legittima assume forma
procedurale poiché la ragione che produce le norme non poggia sui diritti
universali dell’uomo o risiede nella sostanza etica di una data comunità, ma fa
appello alle regole discorsive e argomentative il cui contenuto normativo deriva
«dalla base di validità dell’agire orientato all’intesa, dunque – in ultima istanza dalla struttura della comunicazione linguistica e dall’ordinamento insostituibile
163
J. Habermas, Fatti e norme, Guerini e Associati, Milano 1996, p. 131.
M. Lalatta Costerbosa, Diritto e potere, in Una introduzione alla filosofia del diritto,
a cura di M. La Torre e A. Scerbo, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, p. 178.
165
I. Kant, Sul detto comune: «ciò può essere giusto in teoria ma non vale per la
prassi», in Stato di diritto e società civile, N. Merker (a cura di), Editori Riuniti, Roma
1995, p. 160; ["I. Kant - Sul detto comune: questo può essere giusto in teoria, ma non
vale per la pratica” - 1793 - trad. Maria Chiara Pievatolo].
166
Ibidem.
164
162
di una socializzazione comunicativa»167. Anche Ackerman segue questo tipo di
impostazione dal momento che i diritti dei cittadini nascono attraverso l’arte
maieutica del dialogo, in quanto prima di questo momento i soggetti non
possono dirsi titolari di alcun diritto, ma i tre principi presentati dal filosofo
americano sono, da soli, sufficienti a regolare ogni questione relativa alla
distribuzione delle risorse.
Per cui, così come il procedimento discorsivo di Habermas, attraverso le forme
della comunicazione, istituzionalizza i discorsi e le trattative assegnando una
presunzione di ragionevolezza a tutti i risultati raggiunti, allo stesso modo i
principi dialogici conferiscono il crisma della ragionevolezza solo a quei
discorsi, rivendicativi o giustificativi delle risorse, conformi ai tre principi del
dialogo neutrale. Di conseguenza una proposta distributiva sarà reputata valida
in quanto incontrerà il favore di tutti i potenziali soggetti interessati dalla stessa
e non perché ad esempio prevarrà una considerazione sostenuta da interessi
personali non universalizzabili.
3.2. La cittadinanza.
Lo Stato liberale non è un circolo privato, ma è una zona pubblica in cui ciascun
cittadino può ottenere che gli sia riconosciuta la propria condizione di essere
libero e razionale ed ottenere risposta alle rivendicazioni di diritti. Essere in
possesso della cittadinanza ha dunque una rilevanza fondamentale perché essa
permette o nega l’accesso a determinate risorse e diritti.
Il godimento della cittadinanza non è riconosciuto a tutti, ma solo a coloro che
soddisfano i requisiti della stessa, rappresentati dalla capacità di superare la
«prova d’inchiesta», «la prova difensiva» e quella «comportamentale».
La prova d’inchiesta s’intende superata se si ha la capacità di avanzare richieste
di legittimazione relative a posizioni di potere del tipo «perché dovresti averla
tu e non io?»168, mentre si supera la prova difensiva se si è in grado di
rispondere neutralmente alla richiesta di legittimazione avanzata da altri come
ad esempio «perché valgo almeno quanto te»169.
Chiaramente superano questa prova soltanto gli individui che siano giunti ad
un’età tale che permetta loro di sfruttare le competenze dialogiche. Non
sarebbero ancora cittadini i neonati, i bambini e le persone incapaci. Ciò però,
se non implica l’esclusione di questi soggetti dalla previsione di forme di
protezione in loro favore, fa sì che mentre i cittadini possono rivendicare i loro
diritti facendo appello al dialogo Neutrale, i non-cittadini invece, se vogliono
acquistare diritti in nome proprio, dipendono dalle scelte politiche dei cittadini.
In una visione del genere la cittadinanza si presenta come discriminatrice, non
167
J. Habermas, Fatti e norme, cit., p. 351.
B. A. Ackerman, La giustizia sociale nello stato liberale, cit., p.126.
169
Ibidem.
168
163
solo se vista nel rapporto tra cittadini e stranieri, ma anche all’interno della
comunità stessa, tra coloro che si trovano a condividere un medesimo spazio di
vita e di azione.
Gli incapaci di sostenere un dialogo neutrale non sono, nella teoria di
Ackerman, cittadini optimo iure e neanche cittadini diminuiti. Non sono affatto
cittadini. Tale scelta non appare condivisibile, perché non si comprende l’utilità
dell’esclusione dalla cittadinanza dei neonati, dei bambini, e degli incapaci se
poi gli stessi, com’è comprensibile, non sono privati di forme di tutela. La scelta
di Ackerman porrebbe piuttosto un problema consequenziale; a questo punto
perché gli incapaci ed i bambini che non sono cittadini dovrebbero ricevere
prestazioni di assistenza a differenza degli stranieri?
Per non incorrere in tale dilemma sarebbe invece opportuno distinguere tra la
titolarità dello status civitatis e la titolarità della capacità d’agire. Lo status
civitatis è la situazione di appartenenza di un individuo ad uno Stato e gli
ordinamenti giuridici moderni lo fanno dipendere da parametri che nulla hanno
a che vedere con la capacità d’agire che invece implica l’idoneità a compiere
manifestazioni di volontà atte a modificare la propria situazione giuridica. I
parametri di riferimento per la cittadinanza sono in genere il ius sanguinis e il
ius soli.
La cittadinanza è una situazione giuridica soggettiva che invece di collegarsi
alla capacità d’agire si collega alla capacità giuridica che richiede l’evento
nascita.
Se lo status civitatis non implica automaticamente la capacità d’agire,
l’incapacità d’agire non comporta l’esclusione dallo status civitatis170.
Nel sottolineare invece la capacità di sostenere un dialogo neutrale quale
requisito della cittadinanza, Ackerman arriva ad affermare addirittura che i
diritti delle scimmie parlanti sarebbero più solidi di quelli del vegetale umano,
poiché la cittadinanza, com’egli dichiara, ha a che fare con la teoria politica e
non con la biologia. Tuttavia quest’ultima affermazione sulla cittadinanza è in
contraddizione con quanto precedentemente sostenuto, (e quindi Ackerman
stesso violerebbe il principio di coerenza) ovvero che la cittadinanza spetta
all’«Homo sapiens biologicamente maturo»171. Ma l’incapacità dei bambini di
sostenere un dialogo, o l’incapacità dei portatori di handicap di superare la
prova d’inchiesta e la prova difensiva che così determinano l’esclusione dalla
170
La Costituzione italiana, ad esempio, prevede che nessuno possa essere privato della
cittadinanza per motivi politici e men che meno, si potrebbe desumere, per ragioni di
incapacità, dal momento che la norma in questione integra e tutela principi contenuti in
altre disposizioni costituzionali, quali l’art. 3 (il principio d’uguaglianza prevede nella
sua formulazione che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali») e l’art. 2 che tutela i diritti inviolabili della
persona.
171
Op. cit., p.128.
164
cittadinanza, non è una questione di biologia? e le scimmie cosa hanno a che
vedere con l’Homo sapiens biologicamente maturo?
Nelle teoria di Ackerman invece, il «dialogo minimale necessario per la
cittadinanza stabilisce un esile legame di mutua intelligibilità fra cittadini»172 e
questo è l’unico requisito della cittadinanza. Una volta superato l’esame
dialogico ed assicurato il reciproco diritto al rispetto di ciascuno, i cittadini sono
«liberi di dissentire su tutto il resto», potendo scegliere la propria strada senza
intralciare le scelte degli altri concittadini.
Per quanto riguarda l’ultima condizione necessaria per la cittadinanza, la prova
comportamentale richiede che i cittadini debbano essere in grado di conformare
le azioni ai propri discorsi, affinché le rivendicazioni di ciascuno non si
esauriscano in un «ozioso chiacchierio». Le pretese di ciascuno devono dunque
giustificarsi sia a livello teorico che pratico alla luce della prova d’inchiesta e
della prova difensiva. Infatti nessuno, una volta avanzata la richiesta di una
porzione di manna, potrebbe appropriarsene facendo uso della forza bruta.
La cittadinanza inoltre è, in modo connaturale, discriminatrice, se vista nel
rapporto tra cittadini e stranieri. Come devono rispondere i cittadini di un paese
ricco nei confronti degli stranieri appartenenti a paesi poveri che vogliono
diventare membri di quella comunità, senza violare i principi del dialogo
neutrale? Di certo non possono fare appello ad argomenti del tipo «noi siamo
più evoluti, più civili, più buoni di voi, o semplicemente più fortunati e per
questo abbiamo ragione d’escludervi». Ackerman sostiene che l’esclusione
possa giustificarsi in ragione del fatto che la situazione economica del paese
verrebbe certamente compromessa accogliendo in modo indiscriminato gli
stranieri. Uno stato liberale deve predisporre un effettivo programma di aiuti per
i paesi sottosviluppati che intendono aprirsi ad una politica liberale e i cittadini
di quel paese devono lottare essi stessi per far in modo che la propria terra si
elevi dalla miseria e si allontani da forme di governo non democratiche. Infatti
«quando lottiamo con successo contro le forme di sfruttamento interne, non solo
costruiamo la nostra società su fondazioni più solide, ma diamo anche agli altri
un esempio del significato liberale della libertà - un esempio che riuscirà loro
utile per interpretare la loro esperienza»173.
A questo punto si pone un’altra questione rilevante; e se un soggetto di acclarata
ideologia nazista volesse diventare membro di uno Stato liberale, quest’ultimo
come dovrebbe rispondere ad una tale richiesta? Potrebbe impedirgli l’accesso
basandosi su una considerazione del tipo: “Le tue idee sulla purezza della razza
sono pericolose o più semplicemente noi non le condividiamo e nella nostra
società noi, esseri come te non ne vogliamo!”?
La richiesta del nazista non può essere negata su queste basi, perché
un’affermazione del genere, nell’intento di preservare la comunità da idee
172
173
Op. cit., p. 129.
Op. cit., p. 343.
165
discriminatrici fondate sulla superiorità della razza, infrange il divieto di
selettività e di affermazione di superiorità incondizionata, poiché le idee liberali
sono concepite come superiori a quelle naziste ed i nazisti vengono reputati, in
definitiva, essere inferiori. Basterebbe infatti che il Nazista dicesse che vale
almeno quanto i suoi concittadini per rivendicare la sua eguale porzione di
manna, in fondo se questi crede di essere superiore agli ebrei, vuol dire che fino
ad un certo punto egli si considera pari a loro.
La neutralità dello Stato deve, come diceva Rawls, tollerare anche gli
intolleranti, per cui ad esempio anche una setta religiosa intollerante dovrà
essere tollerata e questo non perché gli intolleranti non potrebbero dolersi
dell’intolleranza, ma perché viene in gioco il fattore della stabilità delle
istituzioni giuste, il quale è capace di convertire gli intolleranti alla libertà di
coscienza semplicemente sulla base del fatto che la libertà di cui essi stessi
godono è in grado di attivare un meccanismo psicologico per cui l’interesse a
non perderla viene riconosciuto come meritevole di tutela anche rispetto agli
altri. In definitiva, si ritiene che «il solo modo di ridurre l’intollerante ad
accettare la tolleranza sia non la persecuzione ma il riconoscimento del suo
diritto ad esprimersi»174, poiché sebbene ciò non garantirà la conversione
dell’intollerante è pur certo che «l’intollerante perseguitato ed escluso non
diventerà mai un liberale»175. La tolleranza cessa nel momento in cui la società
rischia seriamente di disintegrarsi, poiché la sicurezza dei cittadini e quella delle
istituzioni di libertà vengono messe in pericolo. D’altra parte sostiene Rawls,
dal momento che «esiste una costituzione giusta, tutti i cittadini hanno il dovere
naturale di sostenerla», «la giustizia (infatti) non richiede che gli uomini se ne
stiano con le mani in mano mentre altri distruggono le basi della loro
esistenza»176.
Ackerman è concorde sul fatto che la presenza di persone naziste non possa
essere sottovalutata e propone a tal fine un sistema di freni e contrappesi che
possa impedire alle deliranti idee naziste di trovare pratica attuazione. Infatti,
«l’intento è quello di dividere il comando fra una serie di uffici e di fornire a
ciascun ufficio degli incentivi istituzionali a frenare l’azione degli altri uffici,
quando i detentori della carica tentano di abusare dei loro poteri in direzioni
autoritarie»177. Tuttavia, i cosiddetti checks and balances da soli, non
potrebbero mai assicurare completamente l’assenza di una pur minima
possibilità di prese di potere totalitarie per cui, come osserva Ackerman, se lo
Stato vuole assicurare la sopravvivenza della società e proteggere i principi
liberali, potrà anche ricorrere all’uso della forza.
Il ricorso a quest’ultima è invece – dal il filosofo - precluso se tutti i cittadini
fossero convinti della bontà delle idee naziste e volessero edificare un regime
174
N. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, Torino 1997, p. 244.
Ibidem.
176
J. Rawls, Una teoria della giustizia, cit., p. 189.
177
B. A. Ackerman, La giustizia sociale nello stato liberale, cit., p. 156.
175
166
improntato a quei (dis)valori. A questo punto però non si comprende perché, il
sistema di pesi e contrappesi dovrebbe valere contro le farneticanti idee
sostenute da un solo nazista o da gruppi isolati, mentre se tutta un’intera società
fosse preda di un delirio di onnipotenza la si potrebbe lasciare libera di incorrere
in una strada senza via d’uscita178. È possibile che neanche il valore della
dignità umana e della vita possano imporsi in uno Stato liberale? Non esiste
nessuna ipoteca teorica in uno Stato liberale? Se così fosse allora ogni forma di
attività umana, da quella giuridica a quella artistica sarebbero dei passatempi in
attesa della fine, strappati del valore della bellezza del vivere insieme per vivere
bene. La maggior parte delle costituzioni liberali contiene la previsione di
principi e valori fondamentali la cui garanzia non può essere negletta poiché si
pongono, seguendo l’insegnamento di Dworkin, come “trump cards” che
prevalgono su ogni altra considerazione ed assolvono al compito di fungere da
barriera e limite contro la tentazione di esercitare forme arbitrarie di potere in
contraddizione con i diritti e i valori fondamentali. La libertà, dunque, come ha
sostenuto anche Hanna Arendt risulta, l’autentica ragione per cui gli uomini
vivono insieme in un’organizzazione politica. Senza di essa, infatti, la stessa
vita politica sarebbe priva di significato179.
3.3. La giustizia inter-generazionale.
I cittadini di uno stato liberale godono della libertà di scegliere lo stile di vita
che preferiscono e di raggiungere il proprio bene in modo del tutto autonomo,
non avendo alcun rilievo quale sia in concreto la particolare concezione del
bene, né la moralità o l’immoralità delle loro scelte. Alcune scelte personali
hanno però un raggio d’azione che va oltre l’esistenza dei loro titolari e, per tale
ragione, finiscono col riguardare anche le nuove generazioni, potendo
determinare il loro grado di benessere e la loro stessa esistenza. Viene allora in
rilievo il problema delle relazioni intergenerazionali.
I colonizzatori del nuovo mondo potrebbero decidere di mettere completamente
a loro disposizione la manna ed escludere dal godimento della stessa le nuove
generazioni? La risposta di Ackerman è negativa. Alle generazioni successive
occorre garantire un’eguale porzione di manna. Tuttavia emerge una
contraddizione nella teoria di Ackerman secondo cui l’attuale generazione
avrebbe il diritto di rifiutarsi di avere dei figli, se questa è la concezione del
bene prevalente, poiché «uno spirito che non otterrà mai un corpo terreno non
potrà mai porre la richiesta di legittimazione; (…) le sue non domande
178
È interessante a tal fine ricordare la XII disposizione transitoria e finale della
Costituzione italiana che vieta, sotto qualsiasi forma, la riorganizzazione del disciolto
partito fascista.
179
H. Arendt, Che cos’è la libertà, in Ead. Tra passato e futuro, trad. it. Garzanti,
Milano 1991, p. 196.
167
richiedono non-risposte»180. In questa prospettiva l’autonomia dei soggetti
potrebbe spingersi al punto da determinare la fine del genere umano e così
facendo il valore assoluto della vita non riesce, neanche in questo caso, ad
affermarsi. Ma il potere di bloccare la successione generazionale non incorre in
definitiva nel divieto di superiorità incondizionata per cui l’esistenza degli
attuali soggetti è reputata, vista la sua incidenza nei fatti, superiore a quella di
coloro che naturalmente verrebbero ad esistere? Se come dice Ackerman, i
cittadini non possono consumare l’intera manna perché mai potrebbero
consumare il mondo intero? In definitiva la scelta di tali soggetti incide non
solo, come legittimo, sulla propria esistenza, ma su quella dell’intero pianeta.
Ed il mondo non ha diritto di sopravvivere?
Se invece messi al mondo, i figli delle successive generazioni hanno diritto ad
avere la stessa quantità di manna ricevuta dai loro genitori. Ciò si giustifica in
ragione del fatto che un giorno le nuove generazione, depredate della loro
uguale porzione di manna, potrebbero contestare la scelta dei genitori arguendo
che «noi pensiamo che tutti i cittadini abbiano lo stesso valore a prescindere
dalla loro data di nascita. E se noi valiamo almeno quanto voi, dovremmo
cominciare la nostra vita perlomeno con la stessa quantità di manna con cui
avete cominciato voi»181. Da ciò ne deriva che i cittadini devono mettere al
mondo un numero di figli proporzionato alla quantità di manna che sono in
grado di mettere a loro disposizione rispondendo così chiaramente ad un
principio di responsabilità. Quand’anche la propria concezione del bene
consistesse nell’avere un numero elevato di figli ai quali però non si sia in grado
di assicurare una vita dignitosa, essa dovrà recedere dinnanzi alla possibilità di
dar vita ad esseri infelici e dunque dinnanzi alla violazione del principio di
uguaglianza morale dei soggetti che deve essere invece assicurato quale che sia
la data di nascita.
D’altra parte, una cattiva forma di tutela generazionale, non è meno biasimevole
di un furto consumato ai danni di un concittadino. «Qual è infatti - afferma
Ackerman - la differenza fra sottrarre i possessi iniziali del vostro prossimo e
sottrarre i possessi di un cittadino di cui sapete che sarà un vostro prossimo? È
vero che la parte lesa non contesterà immediatamente la vostra azione, ma in
questo modello abbiamo postulato che verrà un momento in cui l’Anziano sarà
chiamato dal Giovane a render conto della sua condotta. E in quel momento
l’Anziano non troverà niente di Neutrale da dire a difesa dell’atto di aver
privato il Giovane del diritto ad una posizione di partenza uguale alla sua»182.
La giustizia tra le generazioni esige dunque che la prima, la seconda e le altre
successive generazioni abbiano la stessa porzione di manna e nulla di più.
Ackerman pertanto si discosta dal piano del giusto risparmio di Rawls secondo
il quale occorre che la prima generazione predisponga uno schema distributivo
180
B. A. Ackerman, La giustizia sociale nello stato liberale, cit., p. 172.
Op. cit., p. 171.
182
Op. cit., p. 281.
181
168
in virtù del quale la seconda generazione risulti più avvantaggiata della prima,
che la terza risulti più avvantaggiata della seconda e via di seguito, finendo per
prevedere una situazione di benessere che cresce nel tempo. Infatti, secondo
Rawls il principio del giusto risparmio «rappresenta un’interpretazione,
raggiunta nella posizione originaria, del dovere naturale precedentemente
accettato di sostenere e far progredire le istituzioni giuste»183. La soluzione di
Ackerman, alternativa al programma del giusto risparmio, non sembra in realtà
migliore, perché è pur vero che ognuno auspicherebbe di vivere a partire dalla
seconda generazione e che dunque gli appartenenti alla prima si ritrovano ad
avere risorse inferiori a quelle dei loro discendenti, tuttavia, gli appartenenti alla
prima generazione vengono ugualmente tutelati dal principio di differenza
poiché ciò che loro conta è che gli svantaggiati possano trarre profitto dalla
disuguaglianza nei confronti dei loro concittadini, poiché è plausibile che
ragionino in una visione di hinc et nunc e potrebbero non avere nulla in
contrario, come farebbe ogni persona ragionevole, ad un crescente benessere
delle generazioni successive, come non si ha nessun interesse ad impedire che il
progresso tecnico e scientifico raggiunga sempre nuovi e migliori traguardi.
Nessuno direbbe mai che è ingiusta rispetto alle precedenti generazioni la nostra
possibilità di utilizzare l’illuminazione elettrica, gli aerei, i telefoni ed Internet.
Rawls d’altra parte ha avuto modo di sottolineare che comunque la relazione tra
le generazioni non dà luogo a difficoltà insuperabili ed ha trovato fuori luogo
l’obiezione suddetta, perché è evidente – egli afferma – che «noi possiamo fare
qualcosa per i posteri, ma essi non possono far nulla per noi. La situazione non
può essere mutata, e quindi non si pone alcuna questione di giustizia. Ciò che è
giusto o ingiusto è il modo in cui le istituzioni trattano i limiti naturali, e il
modo in cui esse sono strutturate per trarre vantaggio dalle possibilità
storiche»184.
L’uguaglianza morale degli appartenenti alle giovani generazioni può essere
violata anche attraverso il fenomeno successorio. Dal momento che i cittadini
hanno la più ampia libertà di scegliere come utilizzare la propria porzione di
manna, potendola anche distruggere se ciò gli arreca piacere, nulla esclude che
questi stessi soggetti possano voler che i rispettivi figli partano, nella corsa della
vita, da una posizione economica più vantaggiosa rispetto ad altri. Per
raggiungere tale scopo, i genitori potranno ad esempio aver risparmiato e
accumulato un’ingente quantità di manna da lasciare in eredità ai loro
successori. La situazione che verrebbe a crearsi non sarebbe meno lesiva
dell’uguaglianza morale dei soggetti rispetto all’ipotesi sopra presa in
considerazione. Infatti, l’effetto di tale scelta comporterà l’esistenza di soggetti
più favoriti di altri, che andranno sicuramente incontro alle contestazioni degli
sfavoriti. Come poter allora giustificare e permettere la volontà dei genitori di
183
184
J. Rawls, Una teoria della giustizia, cit., p. 245.
Op. cit., pp. 246-247.
169
avvantaggiare i propri figli? Lo si potrebbe fare facendo appello all’argomento
del vantaggio generale, o al concetto di uguaglianza di sacrifici, per cui i
soggetti sarebbero disposti a rinunciare all’eguale porzione di manna alla
condizione che la disparità di dotazione torni comunque a loro vantaggio.
Appare dunque plausibile ammettere privilegi speciali per pochi se i diritti di
tutti ne vengono arricchiti e ciò si potrebbe realizzare attraverso la previsione di
tasse di successione. In questa soluzione si possono cogliere gli echi del
principio di differenza di Rawls che considera tollerabili le disuguaglianze che
si rivolgono a vantaggio dei meno avvantaggiati.
3.4. L’ingegneria genetica.
Il rapporto tra le generazioni rileva anche sotto il profilo genetico. La questione
che si pone a questo punto è quella dell’uso dei poteri che la tecnologia mette
sempre più a disposizione in tale settore. Un dato incontrovertibile è che il
confine tra l’uguaglianza e la disuguaglianza tra i soggetti passa non solo per la
quantità di risorse e di benessere, la qualità dell’educazione, ma anche per la
salute cagionevole o vigorosa. Ed allora entro quali limiti si possono usare gli
strumenti tecnologici e scientifici nell’affascinante dominio genetico sempre
meno misterioso? Se ci fosse un Genetista Capo capace di fare bambini in
provetta, a comando, assecondando tutte le preferenze dei genitori, tutto ciò
sarebbero giusto, oltre che lecito, in uno Stato liberale? Ammettiamo che una
coppia di genitori abbia deciso di avere tre figli e per tutti e tre abbia garantito
un’eguale porzione di manna. Potrebbero questi genitori sfruttare i mezzi che la
tecnologia offre per far sì che il primo figlio sia alto, biondo, con gli occhi
azzurri, amante dell’arte e della musica e vegetariano, il secondo di media
statura, capelli neri, occhi verdi, amante della matematica e goloso di dolci, il
terzo con un fisico imponente, con poco cervello ma moltissima abilità nei
giochi olimpici e amante della dieta mediterranea?
Se tutti i genitori possono addirittura decidere di non avere figli, determinando
la fine della specie umana con la loro morte, perché non permettere loro di
creare esseri così perfetti superiori a chi, nato naturalmente, presenta gravi
handicap o anche a chi si ritrovi con un aspetto fisico poco piacevole, con
un’intelligenza mediocre e senza alcun gusto estetico, ma con un buon cuore?
Ackerman sostiene che i genitori non possono manipolare a proprio piacimento
il patrimonio genetico dei figli poiché se è pur vero che in uno Stato liberale è
riconosciuta la più ampia libertà di decidere cosa fare della manna, la differenza
che c’è tra la manna e il corredo genetico dei figli sta nel fatto che mentre i figli
generati in provetta potranno un giorno contestare le scelte operate dai loro
genitori, un pezzo di manna non potrà mai contestare al suo titolare l’uso che
questi ne abbia fatto. Con riferimento all’esempio sopra presentato, potrebbe
accadere che il primogenito dei tre figli contesti la scelta dei suoi genitori,
perché anziché essere un esteta avrebbe di gran lunga preferito passare le
170
proprie giornate in uno stadio olimpico temprando il proprio fisico con gli
effetti della ginnastica, piuttosto che trascorrere la maggior parte del suo tempo
chiuso nei musei o nei teatri. Per questa ragione, Ackerman sostiene che i
genitori non possono usufruire dei mezzi della tecnologia per assecondare i loro
gusti, ma potranno invece attraverso un’educazione liberale, che favorisca la
realizzazione delle attitudini dei figli, prospettare lo stile di vita loro più gradito,
lasciando però agli stessi la massima libertà di non seguirlo.
Questa soluzione appare condivisibile se non si vuole un mondo pieno di
infelici, ma sensibili Frankenstein le cui richieste, noi Prometei moderni, non
saremmo più in grado di soddisfare e ciò al fine di evitare, quale eterogenesi dei
fini, il risultato di una modernizzazione non più desiderata, ma subita.
Ora, se invece di generare bambini secondo il gusto dei genitori, si trattasse di
poter dare la vita solo a bambini sani ai quali non si garantisse niente di più che
una buona salute, questa possibilità sarebbe biasimevole? È possibile pensare
che un bambino sano una volta cresciuto possa contestare ai suoi genitori di
averlo corredato di un sano patrimonio genetico? Chiaramente no, ma si
potrebbe evitare che lo faccia un figlio portatore di handicap. Ed allora
Ackerman sostiene che se tutti i cittadini pensassero che un determinato corredo
genetico possa determinare una situazione di dominio genetico, il Genetista
Capo lo potrà escludere.
Occorre però che tutti i cittadini o gruppi di cittadini abbiano questa credenza.
Se lo ritenesse invece un solo soggetto, questo non sarebbe possibile, perché,
afferma Ackerman, si lascerebbe aperta la porta agli impostori, a coloro cioè
che si serviranno dei mezzi genetici per perseguire obiettivi illiberali.
Nell’esempio presentato da Ackerman, si vuole impedire che un soggetto, al
fine di imporre i propri ideali al figlio, nella scelta tra l’avere un figlio sano, ma
con un carattere poco influenzabile ed uno malato con un docile carattere, possa
scegliere la seconda opzione.
Tuttavia il problema si manifesta allorché Ackerman afferma che se un gruppo
di persone reputasse che un certo corredo genetico di tipo B sia migliore,
sebbene darà la vita ad esseri ciechi, sordi e muti, che portano però con sé nell’esempio fatto da Ackerman - il marchio dell’approvazione divina, allora si
potrebbe dare via libera al Genetista. Siamo sicuri di poter escludere che una
volta cresciuti tali soggetti non benediranno il giorno in cui i rispettivi genitori
hanno avuto questa brillante idea? Perché mai permettere ad un intero gruppo di
generare esseri infelici e non permetterlo a due soli genitori? La dittatura può
essere esercitata anche da gruppi e non solo da singoli soggetti185.
Emerge allora, dal modo con cui Ackerman affronta le questioni finora
considerate, che egli tende a sconfinare verso posizioni utilitariste, il che vuol
dire che non essendoci un parametro definitivo o assoluto di giustizia,
185
Invece, proprio il pericolo della dittatura, porta Ackerman ad escludere che quella
scelta possa essere fatta da un solo soggetto.
171
quest’ultimo potrebbe limitarsi a coincidere con ciò che la totalità del gruppo
crede e che, come è evidente, non offre, in definitiva, garanzia alcuna di
giustizia.
3.5. Il concetto di Undominated equality.
A questo punto è possibile introdurre il concetto di undominated equality che
rappresenta nell’ingegneria de La Giustizia sociale nello stato liberale
l’equivalente del principio di differenza rawlsiano in Una teoria della giustizia.
Essendo giunto ad affermare che il modo migliore per procedere alla
distribuzione della manna nell’ambiente irreale del nuovo mondo, sia quello
egualitario, consapevole che nella realtà in cui viviamo nessuno Stato possa
effettivamente fare in modo (neanche con riguardo ad una sola generazione) che
i suoi membri possano partire con uguaglianza di risorse in tutti i campi (dalla
salute ai rispettivi patrimoni), la strategia che i governanti dovrebbero attuare,
per equalizzare le differenze, è quella di procedere ad una compensazione dei
vantaggi e degli svantaggi economici e sociali, attraverso un programma
politico che premi chi ha avuto di meno in certi ambiti, con qualcosa di più in
altri. Questo piano dovrebbe attuare una compensatio dell’aliquid mancante con
un’aliqua re e scongiurare così quella che Ackerman definisce una situazione di
sfruttamento ovvero una situazione di ingiusta diseguaglianza.
Il piano compensativo dovrebbe attuare un meccanismo di tutela negativo ed
uno positivo. Per fare un esempio, ad un bambino cieco si dovrà garantire, sotto
il profilo negativo, che la cecità non lo discriminerà in altri settori, per cui la
qualità dell’educazione dovrà essere uguale a quella che ricevono i bambini
sani, poiché «il fatto che i ciechi subiscano un’ingiustizia non è un buon motivo
perché ne debbano subire un’altra»186.
Un serio piano di tutela dovrà poi fare in modo che in almeno un altro settore il
bambino sia più avvantaggiato degli altri, ad esempio sotto il profilo della
quantità di risorse. Quest’ultimo è l’aspetto positivo del piano in questione che
prevede dunque un’assistenza speciale attraverso un equipaggiamento maggiore
per i soggetti affetti da patologie invalidanti.
In tal modo, Ackerman non incorre nella critica con cui dovette fare i conti
Rawls, quella cioè di trattare allo stesso modo situazioni diseguali, allorché il
suo piano di tutela poteva ritenersi soddisfatto una volta realizzata l’eguaglianza
delle risorse.
È pur vero che nessuna somma di denaro potrà equivalere alla funzione della
vista, ma almeno una quantità di risorse maggiori equivarrà a migliorare la
situazione dal momento che un soggetto colpito dalla cecità andrà incontro a
spese maggiori soprattutto nel campo dell’istruzione rispetto ai soggetti sani.
186
B. A. Ackerman, La giustizia sociale nello stato liberale, cit., p. 330.
172
Nell’esigenza di procedere individualmente con riferimento a ciascun soggetto,
all’opera di compensazione negativa e positiva, Ackerman dimostra una
particolare attenzione per tutti i soggetti morali dal momento che ognuno vale
quanto ciascun altro, ed in virtù di ciò, attesa la grande particolarità e diversità
di circostanze di vita in cui ci si può venire a trovare, l’attività di intervento
dello Stato non può procedere mediante un ragionamento condotto per gruppi di
individui, come faceva Rawls quando parlava della classe meno avvantaggiata,
poiché esso finirebbe per passare sopra e sommergere soggetti che, pur non
rientrando nella definizione del gruppo, abbisognano ugualmente di tutela.
Infatti l’attenzione verso il soggetto non può tradursi in una tutela dello stesso in
quanto uomo, (categoria evanescente utile per le vuote declaratorie ma inutile
sul piano della tutela), ma in quanto persona perché, fissando lo sguardo su un
luogo preciso e adottando una prospettiva più ampia e sensibile si può prestare
la giusta attenzione alle effettive condizioni personali e sociali dell’individuo e
provare a trovare la soluzione più adatta alle sue esigenze.
Se l’ottica nella quale interviene lo Stato è ad personam l’uguaglianza morale
dei soggetti, lungi dal restare una conquista ideale contemplabile nel puro
mondo delle idee, diventa un principio operativo e si traduce in un meccanismo
pratico di efficace perequazione che consente di invalidare non solo
l’ingiustificato godimento di risorse da parte di qualcuno (apportandovi dei
correttivi), ma anche la stessa attività statale che, se non corregge le
disuguaglianze immeritate, finisce per essere intollerabilmente ingiusta dal
momento che - come disse Rawls - la giustizia è la prima virtù delle istituzioni
sociali (come la verità lo è dei sistemi di pensiero). E dunque, uno Stato che non
pratichi la giustizia non si giustifica né moralmente né giuridicamente.
3.6. Il valore della neutralità dello Stato.
Nel perimetro della cittadinanza lo Stato si adorna delle vesti della neutralità,
reputando indifferenti le diverse concezioni del bene, garantendo ai cittadini la
più ampia libertà di autodeterminarsi, di scegliere cioè cosa fare della propria
esistenza ed in tal maniera li rispetta come esseri pienamente morali. Lo Stato
non potrebbe indicare ai cittadini né quale sia la via migliore per conseguire il
bene, né quale sia il bene da raggiungere, ma gli uomini possono sostenere una
qualunque concezione etica e politica che ritengono valida a loro «insindacabile
giudizio»187 . Nessuno, fuorché il soggetto stesso, può stabilire cosa sia il bene e
come conseguirlo, anche in ragione del fatto che ogni individuo è diverso
dall’altro e pur in presenza di affinità culturali o di identità di valori, la
concezione del bene può essere diversa. Questa idea di autonomia morale trova
187
P. Chiassoni, Ackerman e il fantasma della libertà, in Materiali per una storia della
cultura giuridica, a. XIV, n. 2, dicembre 1984, p. 549.
173
una prima formulazione nel pensiero di Aristotele che nell’Etica Nicomachea
definisce morale l’azione che è deliberata e scelta liberamente da chi la compie
ed è presente anche in Kant per il quale il soggetto morale è il legislatore di se
stesso poiché «nessuno, - afferma il filosofo - può costringermi ad essere felice
a suo modo (nel modo cioè in cui egli si immagina il benessere degli altri
uomini), ma ad ognuno è lecito ricercare la propria felicità per la via che a lui
sembra buona, purché alla libertà degli altri di tendere ad analogo scopo, (libertà
che può coesistere con la libertà di ogni altro secondo una possibile legge
universale), egli non rechi pregiudizio alcuno (cioè non pregiudichi questo
diritto degli altri)»188.
Questo principio di libertà insieme a quello di uguaglianza e di indipendenza di
ogni membro in un corpo comune in quanto cittadino, è il fondamento dello
stato civile. Il principio di libertà ha in odio un governo paternalistico nel quale
i sudditi vengano concepiti alla stregua di figli minorenni che in quanto incapaci
di discernere ciò che per loro è utile da ciò che è dannoso, devono
passivamente attendere che il capo dello Stato giudichi al posto loro in quale
modo devono essere felici. Il bene pubblico che deve innanzi tutto essere tenuto
in considerazione è «quella costituzione legale che garantisce a ciascuno la sua
libertà mediante le leggi; con ciò rimane a lui lecito di cercare la sua felicità per
ogni qualsiasi via che gli sembri la migliore, purché egli non violi quella libertà
generale conforme alla legge, e quindi il diritto degli altri sudditi consociati»189.
La neutralità dello Stato comporta secondo Ackerman la necessità che l’azione
pubblica realizzi gli ideali di imparzialità, non-discriminazione ed eguaglianza
di rispetto attraverso un atteggiamento antiperfezionistico per cui lo Stato non è
tenuto a rendere moralmente migliori i cittadini. L’antiperfezionismo permette
di raggiungere i due importanti obiettivi della coesistenza pacifica e dell’uguale
libertà, perché l’indifferenza dello Stato di fronte alle diversità esclude che i
disaccordi morali e religiosi possano sfociare in conflitti politici e sociali e che
le convinzioni di alcuni possano ritenersi privilegiate rispetto alle altre.
Il concetto di neutralità non esclude tuttavia che individui liberi, uguali e
razionali possano concordare su «considerazioni non contestuali ed accessibili
ad un uditorio tendenzialmente universale»190. In questo modo esso supera la
relatività del pensiero morale che in quanto è anche ragionamento morale è
aperto a tutti coloro che sono dotati di ragione191.
In questo contesto viene in gioco il principio di universalizzabilità di Habermas
che si applica alle questioni morali che, a differenza delle questioni etiche che
188
I. Kant, Sul detto comune: «ciò può essere giusto in teoria ma non vale per la
prassi», cit., p. 154; [I. Kant – “Sul detto comune: questo può essere giusto in teoria,
ma non vale per la pratica” - 1793 - trad. Maria Chiara Pievatolo].
189
Op. cit., p. 161.
190
M. La Torre, Diritti umani, in Questioni di vita o morte, cura di M. La Torre, M.
Lalatta Costerbosa, A. Scerbo Giappichelli, Torino 2007, p. 13.
191
Ibidem.
174
concernono le scelte esistenziali del soggetto connesse alla sua visione della
«vita buona», riguardano le questioni di giustizia aventi ad oggetto le relazioni
intersoggettive. Le questioni dunque morali sono suscettibili di essere
universalizzate e tali da poter ottenere su di esse l’overlapping consensus a cui
faceva riferimento Rawls, mentre le questioni etiche connesse ad una «forma di
vita già data o a un certo programma di vita, non possono essere affrontate da
un punto di vista esclusivamente e fortemente normativo»192. Tuttavia mentre i
principi di giustizia di Rawls ottengono il consenso dei soggetti rappresentativi
della scelta, i principi di Ackerman non sono il prodotto di un accordo
razionale, venendo invece piuttosto imposti ed il loro rispetto non dà garanzia
che l’appello, sebbene universale, sia il frutto di un consenso consapevolmente
formatosi su di essi.
Il valore della neutralità dello Stato nella versione proposta da Ackerman
presta il fianco ad alcune critiche di Habermas. Infatti se la neutralità implica
che il «giusto ha preminenza sul bene – una preminenza fondata sulla logica
dell’argomentazione - e dunque che le questioni di vita buona devono
retrocedere dietro le questioni di giustizia»193, essa vuol anche dire che le
questioni etiche devono essere estromesse dal discorso politico? Se così fosse
allora, la neutralità sarebbe intesa come «conversational restraint» [discorso
ristretto] ed il potere politico risulterebbe dimidiato della forza necessaria a far
sì che vengano trasformati «razionalmente atteggiamenti prepolitici,
interpretazioni di bisogni e orientamenti di valore»194.
In questa prospettiva la neutralità prescriverebbe di non indagare le questioni
pratiche che sono «prima facie» controverse; essa fa in modo che le questioni di
bene siano trattate come mere faccende «private»195 e viene ad essere garantita
dall’esistenza di regole di astensione preventiva, dette anche «gag rules»
[regole bavaglio] (come il principio di neutralità di Ackerman) che però
estromettendo le questioni etiche dal dibattito pubblico, impediscono di
scandagliare e «sondare le possibilità inerenti a un’intesa discorsivamente
raggiunta»196.
Ed infine un’ultima considerazione, la procedura di Ackerman potrebbe
risultare solo apparentemente neutrale poiché anch’essa sembra prediligere una
particolare concezione della vita buona che è appunto la concezione liberale. A
tal fine ci si potrebbe chiedere: «la neutralità dello Stato è giusta in quanto
veramente neutrale o è giusta perché cara allo Stato, ovvero perché sostenuta
dallo stesso?». Su una questione analoga, relativa alla santità ed all’empietà,
discorse Socrate con Eutifrone nell’omonimo dialogo platonico. Eutifrone che
non aveva esitato ad accusare suo padre per l’omicidio di un servo a sua volta
192
M. La Torre, Norme, istituzioni, valori, Laterza, Roma-Bari 2002, p. 269.
J. Habermas, Fatti e norme, cit., p. 366.
194
Ibidem.
195
Op. cit., p. 367.
196
Ibidem.
193
175
assassino, interrogato da Socrate su ciò che è santo afferma: «è santo ciò che è
caro agli dèi, e ciò che non è caro non è santo»197. Questa definizione però
finisce per sottrarre al concetto di santità ogni rilevanza sostanziale e lo fa
coincidere con ciò che (anche arbitrariamente) piace agli dèi. Socrate
chiaramente non può che contestare tale visione. Allo stesso modo se del
concetto di neutralità non si porta avanti una qualche dimensione sostanziale ad
esso sottesa (ovvero la predilezione della concezione liberale quale ideale della
vita buona), la sua applicazione in uno Stato liberale non può in definitiva che
giustificarsi in virtù del fatto che piace allo Stato. Per superare questa obiezione
Habermas ritiene allora che si dovrebbe provare che il principio di neutralità di
Ackerman rientra «in una prassi che è senza alternative ovvero inevitabile»198 e
una prassi è inevitabile «quando – in modo non surrogabile da altre prassi –
adempie a certe funzioni vitali»199 che impedisce come dice Ackerman stesso
“gli estremi della scomunica e della repressione violenta”.
Le quattro strade maestre tracciate da Ackerman verso la neutralità liberale
sono: il realismo sulla corrosività del potere, il riconoscimento del dubbio quale
necessario passo verso la conoscenza morale, il rispetto dell’autonomia degli
uomini, lo scetticismo riguardo alla realtà del significato trascendente.
Per quanto riguarda quest’ ultimo aspetto dello scetticismo liberale esso si basa
sulla dura verità che «non esiste nessun significato morale nascosto nelle
profondità dell’universo. Tutto ciò che esiste siamo voi ed io, che lottiamo in un
mondo che non è stato creato né da noi, né da alcun altro essere»200. Da questa
constatazione ne deriva che gli unici significati che possiamo conoscere sono
quelli creati dagli uomini, benché passeggeri e superficiali.
4. Conclusioni.
Partendo dal contesto immaginario e atipico del mondo ideale descritto ne La
giustizia sociale nello Stato liberale, attraverso la metafora della “manna”,
Ackerman trova il sistema per poter affrontare una pluralità di questioni,
mettendo in evidenza che il problema della giustificazione del potere pur se
riguarda in primis quello esercitato dallo Stato, coinvolge altresì ulteriori
rapporti: quelli infra e inter-generazionali, quelli tra genitori e figli, famiglia e
scuola, non esimendo nessuno dal compito necessario di giustificare l’uso di un
certo potere.
Il fondamento storico della giustificazione del potere da parte dei governanti,
risale alla fine del ‘700, ed in particolare all’epoca della rivoluzione francese ed
197
Platone, Eutifrone, Tutte le opere, a cura di E. V. Maltese, Newton e Compton
editori, Roma 2005, vol. I, [7a], p. 39.
198
J. Habermas, Fatti e norme, cit., p. 368.
199
Ibidem.
200
B. A. Ackerman, La giustizia sociale nello stato liberale, cit., 478.
176
americana le quali hanno portato all’affermazione dello Stato di diritto e del
principio della sovranità popolare, abbattendo la figura del sovrano legibus
solutus che poteva liberamente affermare sic volo, sic iubeo. La sovranità, ora
appartenendo al popolo, fa sì che i governanti debbano rispondere del loro
operato nei confronti di quest’ultimo e non più unicamente nei confronti di Dio.
Questo cambio di referente impedisce che si possano ammantare della volontà
di Dio decisioni e poteri che trovano origine nel puro e semplice arbitrio del
sovrano.
Come nello Stato liberale non sono permessi poteri legittimati dall’uso della
forza, così nella famiglia, nella scuola e in qualsiasi altro contesto, secondo
Ackerman, occorre il rispetto della procedura indicata dal dialogo vincolato, il
quale ammette solo quelle giustificazioni di potere conformi ai princìpi di
razionalità, coerenza e neutralità.
Tra questi princìpi, quello di neutralità assume le vesti di leading rule, in quanto
garantisce, ai cittadini di uno Stato liberale, la massima libertà nel perseguire la
propria concezione del bene e, impedendo che siano ammesse imposizioni e
costrizioni in tal senso, assicura il diritto di ogni individuo ad autodeterminarsi
liberamente. Da ciò si ricava che il valore connesso alla persona umana è
invariabile poiché non è condizionato nel suo riconoscimento all’adesione ad
una determinata concezione del bene (magari quella che uno Stato totalitario
potrebbe imporre), essendo piuttosto legato all’essere uomo quale membro di
una collettività e portatore di una qualsivoglia concezione del bene.
Il compito di uno Stato liberale consiste nell’assicurare ai cittadini il suo attivo
intervento nell’opera di bilanciamento delle varie risorse, sopperendo alle
diseguaglianze genetiche, educative ed economiche che la realtà presenta. Si
individuano così i due tipi di azioni che lo Stato liberale deve tenere: una
negativa e un’altra positiva. L’azione negativa è connessa come si è visto al
valore della neutralità ed impedisce che lo Stato possa imporre una determinata
concezione del bene, l’azione positiva invece rigetta la figura dello Stato
guardiano prevedendo piuttosto un suo attivo ed efficace intervento, in chiave di
protezione delle posizioni dei soggetti deboli ed al fine di attuare le finalità della
giustizia sociale.
La teoria di Ackerman sulla giustizia è dunque caratterizzata dalla convinzione
che il dialogo sia la miglior forma per realizzare l’ideale liberale che si sostanzia
in un ordine sociale in cui soggetti liberi siano nelle condizioni di perseguire il
bene a modo proprio entro una struttura di potere giusta che riconosce
nell’uguale rispetto e considerazione di tutti i cittadini, il mezzo per
addomesticare la lotta per il potere adottando misure adeguate a garantire che:
1) nessun cittadino domini geneticamente un altro; 2) ciascun cittadino riceva
un’educazione liberale; 3) ciascun cittadino inizi la vita adulta in condizioni di
uguaglianza materiale; 4) ciascun cittadino possa liberamente scambiare i suoi
diritti iniziali all’interno di un sistema transazionale flessibile; 5) ciascun
cittadino, al momento della morte, possa asserire di avere adempiuto ai suoi
177
doveri di tutela liberale lasciando alla generazione successiva una struttura di
potere non meno liberale di quella di cui egli stesso ha usufruito.
Il passaggio dal contesto ideale del nuovo mondo a quello reale in cui viviamo,
non dà spazio all’illusione di avere trovato la pronta soluzione dei conflitti
sociali attraverso le regole del dialogo neutrale, tuttavia non toglie la
convinzione che l’impegno collettivo nella politica può trasformare in una
forma di vita ciò che appare ancora soltanto uno scheletro201.
Paola Chiarella
Paola Chiarella è dottoranda di ricerca in Teoria del diritto e ordine giuridico
europeo, Università Magna Graecia di Catanzaro.
201
Op. cit., p. 350.
178
La crisi dell’identità comune
____________________________
Il mercato unico non basta più: l’Europa ora punti sulla
cultura
di Antonio Puri Purini
Se i Paesi fondatori dell’Unione Europea – soprattutto Francia, Germania, Italia
– avessero a suo tempo deciso che anche la cultura, non solo l’economia, è
fondamentale per fare avanzare l’Europa, non ci troveremmo oggi di fronte a
una pericolosa contraddizione: da un lato, la condivisione di una moneta unica
e di uno spazio senza frontiere; dall’altro, il ritorno aggressivo di fenomeni di
nazionalismo, populismo, individualismo. Questi insidiosi avversari dell’unità
europea sono attivi in vari Paesi: in Ungheria, nei Paesi Bassi, in Belgio, in
Italia, in Slovacchia. I problemi economici e finanziari sono prevalenti ovunque.
Detto questo, se si vuole arrivare e bisogna riuscire, al sentimento di comune
appartenenza necessario a far funzionare l’Europa, è essenziale spiegare
perché si vive insieme e che cosa significhi vivere insieme. Questa è cultura.
Altrimenti non esisterà mai un’unità europea e ogni Paese si ritroverà
prigioniero di egoismi e pregiudizi.
La cultura, come desiderio di stare insieme e finezza di sentimenti, è la somma
di molte componenti: da Bach a Verdi, da Raffaello a Mondrian, da Cervantes a
Proust; ne fanno parte anche le voci di tanti cantautori. Ne abbiamo bisogno
come antidoto agli antagonismi, riscoperta di legami comuni, strumento per
sorridersi, reazione all’egoismo. Una convivenza serena non turbata da giudizi
sommari e risentimenti farà alla fine funzionare meglio anche il mercato unico.
Nel mondo globalizzato, costituisce inoltre una garanzia contro la perdita
d’identità: l’unitarietà della cultura europea ci difende dai processi
d’omologazione imperanti. L’Unione Europea viene spesso descritta come una
comunità di destini basata su comuni valori. Ma quanti vi credono veramente?
E’ ridicolo parlare di un destino comune se non si compie poi lo sforzo per unire
gli europei nella salvaguardia della propria eredità storica e culturale. Siamo
lontani da questo traguardo: abbiamo anzi fatto dei passi indietro. Alcuni
decenni orsono, le televisioni europee proponevano programmi culturali di
altissima qualità nella fascia oraria di maggiore ascolto (dai film storici di
Roberto Rossellini alla serie televisiva Civilization di Kenneth Clark); la
televisione italiana produceva anch’essa programmi eccellenti, oggi sacrificati al
mercato.
Invece di spiegare alle giovani generazioni che l’unità europea è un
investimento nel futuro ed un’avventura affascinante che rende consapevoli del
filo rosso che ci unisce, l’Unione Europea ha trascurato tradizione umanistica e
capitale umano. Ha puntato sul funzionalismo. I Paesi portatori storici del
progetto europeo hanno fatto trionfare l’indifferenza. Le pur ottime stagioni
179
musicali o esposizioni museali in tutta Europa non riescono a nascondere
l’arretramento generale subito dalla cultura. Le classi dirigenti hanno
dimenticato che una visione umanistica costituisce un valore aggiunto per
l’Europa intera e una garanzia per la democrazia. Ognuno dovrebbe essere
consapevole d’operare in un sistema unitario di valori. L’autodifesa e la
chiusura che scaturiscono dall’accantonamento del capitale umano sono la
sorgente dell’ignoranza, di pregiudizi, di risentimenti. I danni provocati
dall’indifferenza sono molteplici. La crescente emarginazione della storia,
dell’arte, della letteratura dai programmi scolastici ha portato all’esaltazione
dell’apparenza, alla concentrazione sul localismo, all’accantonamento della
solidarietà. I fatti perdono d’importanza perché non devono essere appresi; la
scelta avviene su Internet; la memoria diventa quindi irrilevante; il passaggio
all’oblio è rapido. Il mondo esterno, con cui dobbiamo confrontarci giorno dopo
giorno, perde di valore. Basti vedere in quale misura – il caso dell’Italia è
sintomatico – si moltiplica in Europa il trionfo della bruttezza sulla bellezza. Il
patrimonio culturale di molti Paesi viene maciullato, gli interessi privati
impongono sempre il proprio punto di vista. Ne consegue che la cultura, questo
è il caso dell’Italia, non offre quasi più sbocchi professionali a giovani preparati
ed entusiasti. Bisognerebbe mettere mano a parecchie modifiche: non solo nei
programmi universitari o nella collaborazione fra i musei, ma soprattutto nella
sensibilità delle persone. Serve una politica trasparente sulla difesa del
paesaggio naturale e urbano europeo. Serve una televisione, certamente in
Italia, capace di guardare all’Europa. Anche gli intellettuali potrebbero fare
molto di più: incalzare, motivare, spiegare. Per dimostrare che l’Europa non è
una nozione geografica, ma una vera comunità culturale, bisogna passare dai
propositi ai fatti. Non si tratta d’indugiare nel rituale richiamo alle comuni radici
della classicità, del cristianesimo, del rinascimento, dell’illuminismo, dei diritti
umani. La cultura va proiettata sul presente: la cultura è vita e humanitas.
Garantisce che l’Europa si sviluppi non sulla base di un’aggregazione generica
ma attraverso il sapiente incastro di tasselli che formano un mosaico comune.
Non siamo lontani dalla meta. Sappiamo di condividere una civiltà comune: i
contrassegni – le piazze, le chiese, i palazzi – lo ricordano continuamente.
Sentirsi europei significa aggiungere una dimensione alla propria città, al
proprio paese: quella europea. Per riuscire, abbiamo bisogno che la politica
affronti questi argomenti con determinazione e responsabilità. In Italia questo
oggi è un sogno. Spetta quindi alla società civile farsi carico di responsabilità
abbandonate dalla politica in attesa di tempi migliori.
Antonio Puri Purini
L’articolo sopra riprodotto è stato pubblicato il 13 agosto 2010 da Il Corriere della Sera.
Ringraziamo l’autore e la direzione del giornale per la gentile concessione.
180
,QYLWRDOODOHWWXUD
a cura di Gianmaria Merenda
181
George Steiner,
Heidegger
Garzanti, Milano, 2002, pp. 197
George Steiner, nato a Parigi nel
1929, è uno dei più importanti e
influenti letterati dei nostri tempi. Ha
insegnato in numerose università, e
tra le più prestigiose: Princeton,
Stanford, Cambridge, Oxford e
Ginevra. In questo suo libro su
Heidegger (scritto nel 1978) Steiner
fornisce una avvincente introduzione al filosofo tedesco. Non
essendo un ‘filosofo di professione’
Steiner si preoccupa, fin dall’introduzione, del linguaggio di Heidegger: quindi si impegna in modo
professionale sulla filosofia heideggeriana, più di quanto possa fare
un approccio più tecnico-filosofico.
Immediatamente siamo messi al
cospetto di un dilemma pressoché
inestricabile: Heidegger è stato uno
dei maestri della filosofia di tutti i
tempi o “un ciarlatano prolisso”?
Questa domanda nasce dall’accoglienza che gli scritti heideggeriani hanno avuto fin dal loro
primo apparire. I fans più accaniti di
Heidegger sostengono che il suo
filosofare, compreso il personalissimo linguaggio che utilizzò per
fare filosofia, è uno degli ultimi
esempi di pensiero forte. Un
pensiero che, anche solo per
essere compreso nel suo semplice
dire, richiede un certo impegno e
sforzo (ed anche una certa fede). I
detrattori più intransigenti invece
(pensiamo ad esempio a un
Bertrand Russell che nella sua
Storia della filosofia occidentale
non lo nomina nemmeno) sostengono che Heidegger non ha
prodotto nulla di rilevante e quello
che ha prodotto lo ha detto in un
modo incomprensibile (pensiamo ai
glossari che immancabilmente chiudono le edizioni delle sue opere).
Steiner, che come abbiamo accennato poco sopra non è un ‘filosofo
di professione’, propone una via
differente per comprendere il
personaggio Heidegger e la sua
filosofia. A suo parere, egli fu
l’inventore di un linguaggio tutto
suo, un ‘idioletto’, perché doveva
poter estrarre dal linguaggio la
ricchezza originaria di significato
che il tempo aveva sepolto e
corrotto; i soliti mezzi filosofici non
erano all’altezza del suo proposito.
Lo stile di Heidegger, che per i più
ha un’intrinseca incapacità al
dialogo, è per Steiner l’urgenza
fatta cosa della necessità di rallentare e trattenere il lettore al
cospetto del linguaggio stesso.
Solo in questo suo essere trattenuto, il lettore può essere condotto
alla profondità originaria del linguaggio, e quindi dell’essere stesso. Per Steiner, Heidegger è un
182
altro ordine e un’altra dimensione
del significato e dell’essere: se
potessimo cogliere Heidegger in
tutta la sua estensione con un solo
colpo d’occhio egli non sarebbe più
il filosofo che è stato e avremmo di
fatto scavalcato tutta la metafisica
occidentale. Quindi, a causa dei
nostri limiti intellettuali, attraverso
Heidegger e attraverso sua filosofia
bisogna passare. Altro aspetto
indicato da Steiner: Heidegger è il
filosofo
del
transito
e
del
movimento verso l’Essere, basta
leggere i titolo di alcuni sui fondamentali scritti per accorgersene:
In cammino verso il linguaggio,
Holzwege (Sentieri interrotti nella
traduzione italiana), Il sentiero di
campagna, Soggiorni. Viaggio in
Grecia e Segnavia.
“Martin Heidegger è il grande
maestro della meraviglia, l’uomo il
cui stupore di fronte al semplice
fatto che noi siamo invece di non
essere ha posto un luminoso
ostacolo sul sentiero dell’ovvio. Suo
è il pensiero che rende dimenticabile un’affabile attenzione, anche momentanea, all’esistere. Nella
radura del bosco, cui conducono i
suoi sentieri circolari, sebbene non
la raggiungano, Heidegger ha postulato l’unità di pensiero e poesia;
di pensiero, di poesia e dell’atto più
alto dell’orgoglio e della celebrazione umana che è il render
grazie. Ci sono metafore peggiori
con cui vivere” (p. 182).
7RQLQR1HJUL6FXOWXUDFHUDPLFD´$UWHLQ*LDUGLQRµ,VRODG·(OED
183
Michele Mari,
I demoni e la pasta sfoglia,
Cavallo di ferro
Roma, 2010, pp. 616
Michele Mari è uno degli scrittori italiani tra i più interessanti e versatili: scrive
romanzi, poesie, saggi. Scrive con uno stile originale e riconoscibile anche
quando cambia genere letterario, una sua cifra d’eccezione che ha il suo
essere nella estrema cura della parola. Questo è forse dovuto alla sua
professione: insegna letteratura italiana presso l’Università di Milano; o forse la
sua professione di docente è conseguente alla sua ossessione per la
letteratura. La tecnicità che nasce dal suo conoscere la letteratura più che
essere un pesante fardello è per Mari la possibilità di scrivere romanzi mimetici:
prosa secentesca, fan accanito dei Pink Floyd, poeta dell’amor cortese adattato
ai tempi moderni, pirata in preda ad allucinazioni marinare come in La stiva e
l’abisso.
Nell’introduzione della raccolta di saggi I demoni e la pasta sfoglia Mari ricorda
che gli scrittori prediletti dalla maggior parte dei lettori (Mari offre un lungo
elenco in cui sono compresi praticamente tutti i grandi della letteratura
mondiale: Poe, Melville, Tasso, Gadda, Conrad, Maupassant, Stevenson,
Lovecraft, Gombrowicz, Roth, Gogol’, Céline, Benjamin, Simenon, Manganelli,
King, Landolfi, Buzzati, Borges, Proust, Leopardi e moltissimi altri ancora) sono
degli ossessi: “Ossessione è da assedio, ma il suo nome scientifico,
anancasma, è da destino, ananke. Scrittori al servizio della propria nevrosi,
pronti ad assecondarla e a celebrarla: scrittori che hanno nell’ossessione non
solo il tema principale (e insieme il metodo con cui anche la più semplice
esperienza è assottigliata in pasta sfoglia verbale), ma l’ispirazione stessa, sì
184
che nessuna interpretazione mi pare fuorviante come quella che ne riconduce
l’opera a un intento salvifico, quasi la scrittura sia solo un surrogato della
pratica psicoanalitica” (p. 17). Essi sono delle persone che hanno delle
ossessioni che si riversano nello stile, nei temi, nelle storie da loro narrate,
volenti o no: la loro scrittura non è salvezza dall’assedio della vita, al contrario è
il destino che si materializza. Essi sono persone che vivono e narrano le loro
storie “nella loro provvidenziale presunzione di essere un mondo”.
I demoni e la pasta sfoglia è lo sguardo gettato sul micro-mondo di ogni
scrittore; micro-mondo che per la potenza del pensiero e della letteratura di
quegli uomini s’è riversato nel corso della storia nel nostro macro-mondo di
lettori accaniti. Ad ogni autore Mari dedica un saggio (qualcuno inedito e altri
apparsi negli anni in riviste o altri scritti) in cui sviscera l’amore e la passione
dello scrittore - e di Mari medesimo - per quel mondo ideale che solo la
letteratura sa creare: Igino Ugo Tarchetti, rappresentante della Scapigliatura
milanese, “era convinto che il fine dell’arte fosse svelare le «congiunzioni
misteriose» fra la realtà sensibile e il sovrannaturale («Dove rintracceremo noi
quella linea che separa l’immaginario dal vero? E nel mondo dello spirito, nelle
sue
vaste
concezioni,
esiste
qualcosa
che
noi
possiamo
chiamare
assolutamente reale o assolutamente fantastico?»)” (p. 83).
I lettori di questo mappamondo disegnato da Mari non hanno che l’imbarazzo
della scelta, ognuno può trovare il suo scrittore feticcio. Gadda, ad esempio,
che è talmente ossessionato dal mondo che lo circonda, dagli oggetti che lo
occupano, dalle parole che servono a descrivere quegli oggetti e quel mondo,
che nel momento in cui mette mano alla penna tutte le parole che lui cesella,
che discrimina dal vocabolario italiano, per imbastire i suoi racconti, possono far
scaturire un senso del comico anche involontario: “Votato fin da giovane al
rimuginante borbottio del misantropo, questo grande introverso ci rapisce e ci
spiazza in continuazione perché ogni sua parola è il trionfo di un’istrionica
estroversione, e porta seco la contagiosa energia del travaglio alchemico” (pp.
246-47). Oppure si può trovare il comune motivo che ha portato Poe e Melville
a scrivere, il primo Storia di Arthur Gordon Pym di Nantucket e il secondo Moby
Dick, o la balena.
Jeremiah Reynolds al ritorno da una sua spedizione iniziata nel 1829 scrisse
185
Mocha Dick: o, La balena bianca del pacifico. Oppure si può scoprire il senso
dei passages parigini descritti da Céline e da Benjamin nelle rispettive opere.
Oppure (da non confondere queste curiosità come esempi di un compendio di
banale gossip sugli autori, prodotto dalla collezione di Mari) il saggio su
Manganelli. Scrittore non ancora ‘gestito’ con sicurezza dalla critica e dai lettori,
forse perché letteralmente divorato dalle proprie Furie, forse perché abilissimo
gestore della lingua italiana, forse perché capace di “mettere il lettore con le
spalle al vuoto” - e non al muro - forse perché: “Di lui si può ben dire ciò che
egli ebbe a dire un giorno di Dante: «Era inattuale già ai suoi tempi: un
dispettoso, anacronistico, chimerico scrittore; figuriamoci oggi. E avete visto
come scrive?»” (p. 558).
Michele Mari, in I demoni e la pasta sfoglia, dà una sua interpretazione della
letteratura che i suoi (i nostri) scrittori sono capaci di produrre: “è lusso ed è
vendetta, e soprattutto non inganna mai: perché ci costringe a credere solo
quello che crede l’autore, e nessun autore, come nessun uomo, crede in
qualcosa come alle proprie passioni, alle proprie idiosincrasie e alle proprie
ossessioni” (p. 19).
7RQLQR1HJUL6FXOWXUDFHUDPLFD´$UWHLQ*LDUGLQRµ,VRODG·(OED
186
Jacob von Uexküll,
Ambienti animali e ambienti umani.
Una passeggiata in mondi sconosciuti
e invisibili.
Illustrazioni di Georg Kriszat,
a cura di Marco Mazzeo,
Quodlibet, pp. 164
Il barone Jacob von Uexküll (nato in
Estonia nel 1864 e morto a Capri
nel 1944) può essere considerato il
fondatore dell’etologia contemporanea. Non è poca cosa, anzi. Se
pensiamo solo per un attimo alle
conseguenze alle quali può portare
il sostantivo ‘etologia’ comprendiamo che un intero universo di
complicazioni si para di fronte a noi.
Von Uexküll si occupò del comportamento animale, ma come
compresero
immediatamente
i
filosofi a lui contemporanei, la sua
ricerca avrebbe avuto ripercussioni
sul comportamento politico, esistenziale e filosofico dell’uomo.
Heidegger fu tra i primissimi suoi
estimatori. Leggendo Ambienti
animali e ambienti umani non si
può non cogliere le necessarie implicazioni esistenziali che Heidegger svilupperà nella sua filosofia
dell’‘essere-nel-(rispettivo)-ambiente’. L’ambiente che von Uexküll
descrive, nel suo scorrevole saggio
del 1933 corredato dalle illustrazioni di Georg Kristzat, coincide
quasi perfettamente con l’ambiente
heideggeriano. Più in là nel tempo,
rispetto al presente di von Uexküll,
si può capire l’interessamento di
altri filosofi che hanno segnato con
forza il Novecento: tra i quali,
Maurice Merleau-Ponty, Jacques
Lacan, Gilles Deleuze e Giorgio
Agamben. L’operazione compiuta
da von Uexküll, l’osservazione
scientifica del comportamento di
insetti, aracnidi e animali, non può
che avere ricadute consistenti in
una filosofia novecentesca che tenti
di spiegare il perché della ‘brevità’
del secolo. Tutti i tragici accadimenti del Novecento possono
essere interpretati con l’etica di von
Uexküll. Gilles Deleuze, sfrenato
spinoziano, affermerà che Etica di
Spinoza altro non è che un etologia, un compendio del comportamento animale dell’uomo che vive
e non subisce il suo proprio ambiente. L’uomo con l’etologia è ricondotto al suo essere animale, al
suo comportamento reattivo rispetto agli stimoli che l’ambiente e la
propria struttura percettiva gli
impongono. Non ci sono spazi per
una morale acquiesciente, tutto si
svolge su un piano etico, umano e
animale ad un tempo. Essere e
tempo sono kantianamente correlati
(von Uexküll sarà un buon lettore di
Kant assieme all’amico poeta Rainer Maria Rilke) in von Uexküll. Basta leggere questo passo: «La
nostra impressione è che il tempo
faccia da contenitore per qualunque
187
avvenimento e che, di conseguenza, sia l’unico elemento stabile nel
continuo fluire degli avvenimenti.
Abbiamo visto, invece, che è il
soggetto a dominare il tempo del
suo ambiente. Mentre fino ad ora
avremmo detto che senza tempo
non può darsi un soggetto vivente,
ora sappiamo che occorre dire:
senza soggetto vivente, il tempo
non può esistere» (p. 53). Il saggio
di Jacob von Uexküll ha il duplice
pregio di poter essere letto per
quello che è (l’affascinante trattato
di un etologo) e per quello che può
essere (un’indagine sull’agire dell’a-
nimale uomo). Portando i concetti
Umwelt
(ambiente),
Stimmung
(tonalità emotiva) e Umgebung
(dintorni) da un contesto ‘naturalistico’ a quello decisamente filosofico, politico ed estetico ad un
tempo, si può capire come la
ricerca di Jacob von Uexküll sia
entrata capillarmente nella filosofia
di tutto il Novecento. Diventa quasi
un gioco andare a scoprire come i
suoi termini si siano prestati alla
teoresi della bio-politica.
Valerio Magrelli [1]
Nero sonetto solubile.
Dieci autori riscrivono
una poesia di Baudelaire,
Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 230
Può una poesia dissolversi nelle opere più eterogenee del Novecento? La solubilità
del sonetto Recueillement (contenuto nelle Fleurs du mal) di Charles Baudelaire è
indagata da Valerio Magrelli. Sono dieci gli autori, tutti francesi tranne Vladimir
Nabokov e Samuel Beckett, (quest’ultimo scrisse molte sue opere in francese) che
hanno sentito la necessità di inserire un qualche riferimento all’opera di Baudelaire
nei loro scritti. In ordine di apparizione: Valéry, Michaux, Céline, Prévost, Colette,
Nabokov, Beckett, Queneau, Perec e Houellebecq. Molto affascinanti sono quei
capitolo in cui Magrelli va a scovare Recueillement negli abissi degli scritti.
188
Differentemente dai casi in cui la poesia è palesemente presente nelle opere
analizzate, come in Prévost, Beckett e Houellebecq, in alcune altre opere si deve
compiere un’elaborata operazione di svelamento. Tanto più Baudelaire è nascosto
nelle pieghe del testo, tanto più la forza della poesia diventa estrema. Il capitolo
dedicato a Nabokov ne è uno splendido esempio. Magrelli sviscera il testo di
Recueillement dalle righe di Lolita per far notare quanto Nabokov scriva in lingua
inglese utilizzando segni (le parole francesi pronunciate dal protagonista) che di
fatto producono una vera e propria appropriazione della cultura europea nei
confronti di quella americana. Oppure: Perec nella sua riscrittura lipogrammatica
(Perec scrisse un romanzo intitolato La disparition, La scomparsa, in cui non
appare mai la necessaria, per il francese, lettera ‘e’) del sonetto di Baudelaire
riscrive, ri-traduce da francese a francese, la poesia in una lingua senza lettera ‘e’
riformulando il senso di una scomparsa ben più tragica: ‘e’ come ebreo, ‘e’ come
eux (in francese la lettera ‘e’ è omofona al pronome plurale ‘loro’), intendendo i
genitori di Perec. Genitori che sono scomparsi nell’orrore della Shoah. Esercizio di
stile estremo, l’opera di Perec rende visibile la possibilità di un racconto, una
soggettività, che può ancora essere tale anche e nonostante una mutilazione del
linguaggio così importante come la mancanza di una lettera. Come indica Magrelli
nel capitolo finale del saggio, Logiche di inclusione letterarie (p. 198), «la parabola
di Recueillement porta ad interrogarsi sulle logiche che regolano l’inclusione e
l’assorbimento, l’assimilazione e la dissimulazione di un testo letterario all’interno
di altri». Al di là della ‘semplice’ indagine attorno a un sonetto, per Magrelli si
troverebbe la consistente tensione logico-politica di un testo criptico che, nascosto
all’interno di altri testi (una lingua nella lingua) produce un’infezione che propaga
la tradizione all’interno del nuovo che solo apparentemente non ha nulla a che fare
con la tradizione stessa. La solubilità di Recueillement «è consistita nella diffusione
di particelle esogene, di colonie straniere, di materiali alloctoni, di presenze aliene,
ossia, altrimenti detto, di citazioni.» (p 213). Una diffusione che mette in luce la
pervasività della trasmissione del sapere letterario.
[1] Valerio Magrelli è poeta e professore di letteratura francese all’Università di
Cassino.
189
Antonin Artaud,
Al paese dei Tarahumara e altri scritti,
Adelphi, Milano 2009, pp. 245,
Antonin Artaud è stato scrittore, drammaturgo, regista e attore teatrale, saggista e
poeta. Fu vittima della pazzia: «bisogna capire che tutta l’intelligenza è solo una
ampia eventualità, e che si può perderla, […] ritrovarsi in uno stato d’estrema
scossa, rischiarata d’irrealtà, con pezzi del mondo reale in un angolo di sé» (p. 36).
Questo libro contiene delle lettere e degli scritti che possono far comprendere chi
era Artaud e quale fu la sua influenza sulla cultura francese ed europea. In
particolare Artaud fu un teorico del teatro. Il manifesto del teatro della crudeltà è il
suo progetto rivoluzionario per la rappresentazione teatrale, rappresentazione in cui
vengono ad infrangersi i confini tra gli attori e il pubblico (ricordiamo che siamo
nei primi anni Trenta e che nel 1937 pubblicherà il suo testo più importante: “Il
teatro e il suo doppio”). Collaborò con i surrealisti ma ne prese le distanze perché
in polemica con l’adesione del movimento artistico al partito comunista francese.
Nell’antologia sono contenute le lettere che Artaud scrisse a Jacques Rivière
(editore della Nouvelle Revue Française fu tra i primi a capire il valore artistico di
Baudelaire e Proust) per cercare di comprendere il rifiuto dello stesso Rivière alla
pubblicazione delle sue poesie. È interessante lo scambio epistolare per capire
come si costruisce il rapporto tra i due, il poeta e l’editore. In una prima lettera
Rivière comunica ad Artaud che non può pubblicare le sue poesie («nelle sue
poesie, gliel’ho detto dal primo momento, ci sono goffaggini e soprattutto stranezze
sconcertanti». p. 8), pur trovandole interessanti, tanto che invita lo stesso Artaud a
passare in redazione per un incontro. Rivière capisce che le «stranezze
sconcertanti» di Artaud sono il frutto di una ricerca nel linguaggio piuttosto che di
190
una mancanza di controllo, di una sgrammaticatura congenita. Altrove, in un’altra
lettera Rivière propone ad Artaud di pubblicare sulla rivista le lettere da lui
ricevute. Artaud in quelle lettere descrive la sua necessità di scrivere poesie,
formula, in un certo qual modo, una teoria della poesia, una teoria sull’uomo.
Nel testo Al paese dei Tarahumara Artaud narra con passione e partecipazione la
sua esperienza con il peyote, un cactus dalle proprietà psicotrope. Già segnato
dall’eroina, Artaud descrive un’avvincente “comunione” con la natura, con la
roccia e con il rituale dei Tarahumara: «con i Tarahumara si entra in un mondo
terribilmente anacronistico e che è una sfida a questi tempi» (p. 90). In questa frase
si possono leggere molti significati. Certamente si trova il senso di non
appartenenza di Artaud al suo tempo (siamo nell’anno 1936). Artaud denuncia un
anacronismo, in una popolazione messicana, che rivela in sottotesto, l’impreveduta
presenza dei macelli della Seconda guerra mondiale, in Europa. Di quegli eventi
egli non parla apertamente, ma, con la sua fuga dall’ordinaria realtà, ne è un critico
testimone.
Un altro testo, breve ma micidiale, contenuto in questa antologia, è intitolato Gli
argani del sangue (Realtà). È un dialogo, un solipsismo accanito con sé stesso. Le
relazioni che legano il suo corpo alla crudele realtà, costringono Artaud ad una lotta
indefinita con il proprio io, con il soggetto che si preoccupa di pensare nel suo
corpo: «in pozze di coscienza inutilizzata e che più tardi, viste da vicino, stimolerò
un giorno con un essere di volontà in me. Con un blindaggio torchiato del mio io»
(p. 229).
Artaud dà la possibilità al suo lettore di scendere nel suo inconscio, di sondare ciò
che solo apparentemente non si conosce. Una lettura che, per chi ha in mente i
deliri lisergici della beat generation (movimento artistico nato negli Stati Uniti
d’America alla fine del secondo dopoguerra e sviluppatosi fino alla fine degli anni
cinquanta), non può che essere riconosciuta in ogni pagina.
191
Daniele Benati,
Opere complete di Learco Pignagnoli,
Aliberti Editore,
Reggio Emilia 2006,
pp. 172
Il libro di Daniele Benati è divertente, caustico e costringe il lettore a pensare. È
l’esempio - letteralmente: “ciò che si tira fuori” - più lampante di cosa può fare la
letteratura quando è «di buzzo buono». Al limite del non-sense, Benati
(professore universitario in Italia e all’estero, traduttore e scrittore) riesce a dire
certe indicibili realtà della critica letteraria (cfr. l’Opera 111) e scrivere una vera
letteratura critica. Benati sfodera un’autoironia che spesso servirebbe al mondo
della critica letteraria per non prendersi troppo sul serio, ovvero, alla critica
l’ironia sarebbe utile per non rendere opaca l’opera letteraria. Benati per
compiere questa impresa si inventa il personaggio: lo scrittore Pignagnoli e
tutta la sua opera. Di questo fantomatico scrittore, leggero e colto ad un tempo,
si sa poco o nulla: «Learco Pignagnoli è nato a Campogalliano e a San
giovanni in Persicelo (…). Lavora pressa la ditta Scoppiabigi e Figli, dove tiene
dietro al loro lupo» (dal risvolto di copertina). Leggendo le 245 Opere di
Pignagnoli, però, si può capire che è una brava persona, semplice, diretta e mai
scontata. In inglese esiste una perifrasi che può farci comprendere meglio chi
sia Pignagnoli: larger than life, “più largo della vita”, esagerato, straripante. Già
queste caratteristiche non sono cosa da poco: averne di scrittori come lui…!
Il libro contiene un romanzo, una raccolta di poesie e un’Opera teatrale.
Parleremo principalmente della sezione delle Opere. Le Opere sono uno
specchiato esempio della tradizione barocca del frammento. Un barocco in cui
l’alto e il basso, il colto e l’incolto si mischiano fra loro. Piccoli brani, sentenze,
massime e brevissimi racconti formano il moderno corpus hermeticum di
Learco Pignagnoli. Si diceva, dunque, di un insieme di frammenti che tanto
ricordano Einbahnstrasse di Walter Benjamin. Anche qui, come nell’opera di
Benjamin, il cumulo di macerie dei frammenti riesce a creare un senso diverso,
differente, da quello che solo apparentemente si legge sulla carta. Dalla
barocca tragedia e dal senso di morte che da essa scaturisce, numerose,
infatti, sono le Opere che contengono riferimenti tanatologici. Si crea un
incredibile spasmo all’angolo della bocca, si forma il sorriso che si beffa di tutto:
vita, morte e miracoli della modernità (leggi ad esempio le Opere che criticano
con insistenza Alberto Moravia, Alain Elkann e Giovanni Pascoli).
Torniamo alle Opere, sono un cumulo di frammenti, talvolta eterogenei, che
permettono di vedere la realtà da un punto di vista particolare, totale e singolare
ad un tempo. Pignagnoli è un “autore” arcipelago: il suo pensiero è formato da
192
isole maggiori, pensiamo all’Opera 238, e da alcune minori, poco più che uno
scoglio franto dai flutti, vedi l’Opera 191. Per chi fosse stato in navigazione nel
mar Egeo, al largo della Grecia continentale, avrebbe certo notato le affinità con
lo sguardo di Pignagnoli: una volta che il traghetto ha lasciato il molo e s’è
diretto verso il mare aperto (la seconda navigazione platonica vorrà pur
significare qualcosa) si può già intravedere la prima isola all’orizzonte. Più ci si
avvicina all’isola, più si può scorgere la successiva e quelle limitrofe. Che vuol
dire? Pignagnoli - usciamo dalla metafora marinara e torniamo allo scrittore - è
il filosofo che riesce a trattenere (termine molto paolino, cfr. Paolo, 2
tessalonicesi 2,5-2,12) la perdita del senso causata dalle rovine barocche, e
dalle macerie delle Opere. Pignagnoli mantiene vigile lo sguardo. Sa di aver
abbandonato la terra ferma e di aver iniziato un viaggio periglioso. Però,
mantiene la rotta guardando all’orizzonte per scorgere, prima degli altri, l’isola
che verrà a posarsi sull’effimera linea geografica. Mantiene, comunque, lo
sguardo sulle isole limitrofe. In questo modo Pignagnoli riesce a tenere relate
fra loro le Opere che altrimenti tenderebbero allo sfilacciamento distruttivo,
perché spesso sono distanti fra loro per quel che riguarda il senso.
In «Opera 119» si dichiara:
«Una cosa da mettersi bene in testa è che con l’autore Learco Pignagnoli c’è
poco da farsi tante idee sbagliate. Che non ci confondiamo con Moravia. Con
Learco Pignagnoli voi vi mettete lì, non leggete niente, non voltate pagina, ma
almeno lo sapete che non state leggendo niente e che semmai, se vi salta il
ticchio di voltar pagina, lo fate solo per far piacere all’autore. Poveretto! Chissà
dov’è? Chissà chi è e cosa fa? È un atteggiamento diverso, più umano.
Leggerlo o non leggerlo, chi se ne importa? Ha scritto roba corta, roba lunga,
chi se ne importa? Ha scritto un romanzo, non l’ha scritto, chi se ne importa?
Tutto quello che ha fatto è in queste poche pagine? chi se ne importa? Non è
Alessandro Manzoni? chi se ne importa? Bisogna ragionare così. Leggere, non
leggere, chi se ne importa? È Alessandro Manzoni? Non lo è? Chi se ne
importa? Bisogna ragionar così. È così che ci si accosta a un libro di questo
genere.»
Daniele Benati è nato Reggio Emilia. Ha insegnato in università degli Stati Uniti e
dell’Irlanda. Ha tradotto James Joyce, Flann O’Brien e Ring Lardner. Con Gianni Celati
ha tradotto e curato Storie di solitari americani. È’ anche scrittore. Tra le sue opere
troviamo Silenzio in Emilia, Cani dell’inferno, Un altro che non ero io e con Paolo Nori,
Baltica 9.
193
König, Christoph,
a cura di Massimo Pizzingrilli,
Strettoie. Peter Szondi e la letteratura,
Quodlibet,
Macerata 2009, pp. 120
C’è qualcosa di molto importante che si può apprendere dalla lettura di questo
breve testo introduttivo al metodo di lavoro e alla vita di Peter Szondi,
l’egemonia dell’ermeneutica di Heidegger e di Gadamer ha un’alternativa:
«L’ermeneutica di Szondi procede in effetti ad una analisi del testo che si
scontra con le precedenti teorie, in prima linea con l’ermeneutica filosofica
inaugurata da Heidegger e professata ancora da Gadamer. L’attenzione di
Szondi per la cifra testuale, per il particolare, il frammento secondo la lezione di
Benjamin, implica una distanza critica che permette all’interprete di considerare
in una volta sia la complessità dell’opera completa che la complessità degli
oggetti particolari all’interno dell’opera stessa» (p. 12).
Non è un caso che nella vita del critico Szondi, [basta scorrere la sua biobibliografia (pp. 97-110)] ci si imbatta spesso nello sguardo, che tutto coglie,
della filosofia. Al di là dei nomi che ricorrono, Heidegger, Gadamer, Adorno e
Benjamin, basterebbe solo la loro evocazione per comprendere la portata della
ricerca di Szondi: la dialettica che necessariamente viene ad essere messa in
opera dallo stesso sguardo dell'interprete sull’opera. Cercando di comprendere
il testo nella sua totalità e nella complessità dei particolari che lo formano,
necessariamente si deve tener conto di come il testo completo e i frammenti
che lo compongono dialoghino fra loro. È la sintassi interna del testo, oltre la
sintassi della lingua scritta, a produrre la geometria che dona un senso al testo.
Citando una frase di Paul Valéry, tradotta da Szondi come prova di traduzione
per un editore, «la syntaxe est une faculté de l’âme», König ci sta indicando il
punto nevralgico del sistema ermeneutico del critico ungherese. Szondi implica
194
e complica nell’atto della critica letteraria l’anima, sua e dell’opera da criticare.
Una implicazione, scelta o imposta dalla sua stessa anima, che Szondi pagherà
con il suicidio. Portare con sé il peso della propria anima è certo un esercizio
difficile ma necessario. Fare propria anche l’anima di un’opera letteraria, come
può essere ad esempio la poesia di Celan, non deve essere stato facile. Sono
gravi, pesanti, i fattori messi in gioco dal rapporto con Celan: l’ebraismo e la
diaspora, lo stermino nazista, il rientro in Germania dopo la fine della Seconda
guerra mondiale. Questi sono problemi epocali, ma Szondi «nella sua
interpretazione «tecnico-psicologica», vorrebbe proprio portare allo scoperto il
carattere impersonale che definisce le poesie di Celan. Di conseguenza,
distoglie lo sguardo dall’autore. Non l’autore parla, bensì il testo che testimonia
Auschwitz senza farsene per questo immagine» (p. 78).
Adolf Reinach,
La visione delle idee,
a cura di S. Besoli e A. Salice,
Quodlibet,
Macerata 2008, pp. LXXIV-228
Allievo e assistente di Edmund Husserl, Adolf Reinach sarebbe stato
sicuramente un esponente di spicco della filosofia del Novecento, accanto a
Scheler e Heidegger. Purtroppo morì al fronte nel 1917 durante la Prima guerra
mondiale. Il testo che proponiamo in lettura è una raccolta degli scritti filosofici.
Questa specificazione è importante perché Reinach ebbe anche una
formazione giuridica (cfr. p. LXX) e il suo lavoro ‘giuridico’ non è presente in
questa raccolta.
Reinach, da assistente, aiutò Husserl nella revisione delle ‘Ricerche Logiche’
rimanendone ovviamente influenzato. Fu dopo la pubblicazione delle ‘Ideen’ di
195
Husserl, avvenuta nel 1913, che Reinach insieme ad altri anziché seguire il
maestro nella fenomenologia trascendentale decise di rimanere più vicino al
lavoro precedente di Husserl.
«La tesi secondo cui le idee si vedono non ricorre a un modo di dire
incontrollato, frutto di spurie reminescenze platoniche, ma esprime il nucleo più
autentico della dottrina fenomenologica di Husserl» (p. IX), così l’attacco di
Stefano Besoli nel suo approfondito saggio introduttivo: “La pregnanza del
metodo descrittivo e il rispetto delle datità. Adolf Reinach e la traccia di una
vera «fenomenologia»”.
Il centro della filosofia fenomenologica di Reinach è la visione delle idee: ovvero
il superamento dell’apparire delle cose con un rigoroso metodo d’analisi
filosofica per una visione d’essenza: il suo fu «un ampliamento di orizzonti che
portò a rimuovere le restrizioni ontologiche e le implicazioni soggettivistiche
dello psicologismo, estendendo la nozione di esperienza al di là di ciò che è
empirico in senso stretto» (p. XIII). Ecco perché le idee si vedono. Le idee
possono e devono essere trattate, si potrebbe dire analiticamente, come se ci si
trovasse di fronte a degli oggetti reali. Si devono eliminare i possibili
impedimenti, ontologici o soggettivi, che possono nuocere alla visione
d’essenza. Reinach intendeva la fenomenologia come un discorso che servisse
a vedere le cose e non un insieme di concetti che potesse solo ingabbiare il
significato «con rigide definizioni». Ci siamo riferiti ad un discorso
fenomenologico perché la ricerca reinachiana partì sempre da un’attenta analisi
delle parole utilizzate nelle proposizioni e del loro significato. Per questo motivo
si può definire Reinach un precursore della filosofia analitica.
Nel primo breve saggio della raccolta: William James e il pragmatismo, Reinach
affronta la filosofia di James. Dapprima sembra seguire e far sue le teorie del
pragmatismo, ma è chiaro da subito che l’analisi dei termini e delle
conseguenze dell’impiego di quei termini è solo il metodo fenomenologico
messo all’opera. Infatti, sul finire dello scritto Reinach, dopo aver messo in luce
i limiti della filosofia pragmatica di James (…«ridurre la verità a una qualsiasi
utilità e accordare il significato solo ai problemi da cui risultano conseguenze
pratiche»), mette in evidenza l’esistenza di una particolare scienza che affianca
le altre scienze. Questa scienza è la fenomenologia: essa senza andare oltre i
fenomeni, anzi proprio perché sa coglierli, può colmare le lacune delle scienze
positive.
Kant in questa raccolta è presente ed è studiato senza timori reverenziali da
Reinach. Un saggio concerne la critica alle regole delle inferenze razionali e un
secondo l’interpretazione kantiana del problema di Hume. La problematicità sta
nel fatto che Kant attribuisce a Hume la definizione che le proposizioni
matematiche sono analitiche.
Reinach pesando parola per parola, scompone due proposizioni kantiane tratte
dallo scritto La falsa sottigliezza delle quattro figure sillogistiche. La prima
proposizione: «Una caratteristica della caratteristica è una caratteristica della
cosa stessa» per le inferenze razionali positive e la seconda: «Ciò che
contraddice la caratteristica di una cosa, contraddice la cosa stessa» per le
inferenze negative (p. 11). Le proposizioni vengono smontate con il seguente
ragionamento: «Se assegniamo a un oggetto singolo (questo libro) una
caratteristica di proprietà (rosso) e poi a questa caratteristica di proprietà
196
assegniamo di nuovo una caratteristica di proprietà (intenso) o una
caratteristica di genere (colore), allora non possiamo attribuire all’oggetto né la
seconda caratteristica di proprietà né la caratteristica di genere senza cadere in
errore» (p. 15). È evidente che il concetto libro non ha niente ha che fare con il
concetto rosso, quindi il concetto rosso, caratteristica di una caratteristica, non
può essere una caratteristica del concetto libro. Nel secondo caso (il problema
di Hume) apprendiamo con stupore che Kant avrebbe ascritto a Hume,
sbagliando, l’opinione che le proposizioni matematiche sono analitiche. Anche
qui con il solito piglio analitico Reinach mette in luce il fatto che in Hume una
simile qualificazione porterebbe a delle aporie nella sua filosofia (p. 37).
Il saggio che più mette in chiaro il metodo reinachiano, la sua fenomenologia, è
quello che si intitola, appunto, Sulla fenomenologia. Le parole, l’espressione e il
significato sono i motivi da cui l’analisi fenomenologica deve iniziare la propria
indagine. Questo per evitare equivoci «che si trovano in particolare nella
terminologia filosofica» (p. 178). Le stesse cose che Reinach evidenziava
proprio nei saggi su Kant. Particolare punto su cui Reinach si concentra è la
conoscenza a priori. Si è detto che la sua intenzione di fenomenologia deve
superar i limiti ontologici e soggettivistici, perciò Reinach prima chiarisce la
problematicità dell’a priori e poi indica il possibile superamento di quella
problematicità: «Ciò che ci si fa incontro per così dire dall’esterno nella
percezione sensibile, pare debba essere presente «nell’interno». Così le
conoscenze a priori sono trattate da proprietà dell’anima, da qualcosa di innato
– anche se solo virtuale – a cui il soggetto ha solo bisogno di rivolgere lo
sguardo per rendersi conto di esso con indubitabile certezza. […] Vi sono delle
connessioni a priori indifferentemente dal fatto se tutti o molti o nessun uomo o
altri soggetti le riconoscano. Esse sono universalmente valide al massimo nel
senso che chiunque voglia giudicare correttamente, deve riconoscerle» (pp.
180-81). E poco oltre: «Solo una cosa è corretta: ovvero che ogni conoscenza a
priori è capace, senza eccezione, di un’evidenza inconfutabile, cioè di
un’intuizione offerente ultima del suo contenuto. Ciò che si fonda nell’essenza
di oggetti può essere portato a datità ultima nella visione d’essenza. Certo ci
sono delle conoscenze a priori che non possono essere conosciute in se
stesse, ma necessitano di essere dedotte da altre. Ma anche riconducono,
infine, a connessioni ultime in se stesse evidenti. Non le si acceterà certo
ciecamente, non si farà affidamento su un mitico consensus omnium o su
un’enigmatica necessità del pensiero – nulla è più lontano dalla fenomenologia
di ciò; esse devono invece essere portate a chiarificazione, alla datità ultima
[…]» (p. 183). Un lavoro di chiarificazione eseguito con un metodo
rigorosissimo che porterebbe la filosofia al limite di una scienza positiva. Ma
come dice Reinach alla fine del suo saggio, la filosofia non è un ‘lavoro’ del
singolo ma è l’espressione di un lavoro di molti, ripetuto, rivisto, corretto,
emendato per secoli: «Essa diverrà una scienza rigorosa – non imitando le
scienze rigorose, ma riflettendo sul fatto che i suoi problemi richiedono un modo
di procedere proprio, la cui attuazione richiederà il lavoro di secoli» (p. 188).
La raccolta è chiusa da un saggio di Alessandro Salice, Agganciarsi a
un’anima. Il domandare e i vissuti sociali della coscienza in Adolf Reinach.
L’atto di domandare è visto come un’agganciarsi all’anima della persona a cui si
pone la domanda, e ciò è possibile perché il domandare ha una veste corporea
197
e investe l’altro a cui si chiede, personalmente (cfr. in particolare pp. 204-05).
L’atto di domandare in Reinach è alla base dei suoi studi sugli atti sociali. È la
manifestazione di un bisogno che ha necessità dell’altro per essere soddisfatto.
Salice attribuisce a Reinach «il pieno merito di riconoscere e descrivere la
natura specifica di tutte quelle esperienze vissute che, come la promessa, il
comando, la richiesta ecc., per essere compiute con successo richiedono la
soddisfazione delle medesime condizioni ritrovate per la domanda. […] la
struttura ontica, la necessità di intendimento e il riferimento personale al
destinatario dell’atto» (p. 206). Gli studi reinachiani sugli atti sociali, sulla
domanda, sono per Salice ancora in statu nascendi. Si farebbe un torto a
Reinach e alla filosofia considerarli come marginali alla storia della filosofia. La
raccolta dei saggi di Reinach proposta da Besoli e Salice ha anche il compito di
andare oltre agli studi specialistici e di far conoscere la figura del giovane
filosofo tedesco a più persone.
Daniel C. Dennett,
Coscienza. Che cosa è,
Laterza,
Roma-Bari 2009, pp. 608
«La coscienza umana è praticamente l’ultimo mistero che ancora sopravvive»
(p. 31).
Daniel C. Dennett in questo suo saggio cerca di affrontare il mistero della
coscienza umana e propone una sua ipotesi come tentativo di avvicinamento
alla verità. Il suo è un approccio diverso da quello che, a suo parere, ha
contribuito a formare dei falsi miti attorno alla coscienza umana. Egli non
fornisce una soluzione al mistero, sarebbe impossibile, cerca però di togliere i
possibili impedimenti teoretici, i dogmi del pensiero, che possano mettersi di
traverso alla risoluzione del problema coscienza.
Il libro è frutto di una lunga analisi attorno al concetto. Dennett se ne occupa
dopo aver dialogato a lungo con psicologi, psichiatri, neurofisiologi, filosofi e
scienziati in genere. Le discipline scientifiche appena elencate si occupano,
ognuna per sé, dello stesso problema: quando diciamo ‘io’ cosa intendiamo?
198
Chi dice ‘io’? Chi o che cosa decide di muovere un braccio o percepisce
l’immagine che l’occhio ha inquadrato?
Secondo Dennett non ci si deve fermare alla prima evidenza: “è ovvio che ‘io’
muovo il mio braccio, che io posso dire io”. La formazione del pensiero
cosciente va oltre la semplice auto percezione dell’evento. Un primissimo
chiarimento che Dennett vuole far comprendere al suo lettore, passa attraverso
la considerazione della filosofia di Cartesio e della sua concezione dualistica
mente-corpo. Il grande accusato, infatti, sarà sempre il dualismo cartesiano:
ovvero la separazione delle facoltà mentali dalla fisicità del cervello, attributi
cartesiani che comunicano fra loro grazie all’invenzione della ‘ghiandola
pineale’. Cartesio con la sua ideazione dualistica ha segnato la storia della
filosofia e della scienza. Il grosso dubbio che si può rilevare all’analisi del
dualismo cartesiano si trova appunto nella dinamica del dialogo tra mente e
cervello. Se il cervello, la parte fisica, è facile da analizzare - oggi sempre di più
grazie all’evoluzione della diagnostica per immagini - la mente, che invece non
si trova nella fisicità del cervello – se non nei segnali di un’attività neuronale -,
pone dei problemi per la comprensione di cosa sia la coscienza umana.
Dennett chiede: se la mente, l’io che parla nei nostri soliloqui, non ha sede nel
cervello - infatti Cartesio deve escogitare la ghiandola pineale per connettere i
‘due mondi’ - dove è? Una volta che l’io ha occupato il ‘mio’ cervello, come può
governare il ‘suo’ stesso cervello?
Il percorso che Dennett imprime alla sua ricerca è doverosamente ampio ma
non particolarmente difficile da seguire. Egli infatti, per la fortuna del suo lettore,
adotta uno stile colloquiale e diretto, ricco di esempi e contro-proposte. Dennett
utilizza concetti ed esempi tratti dalla neurofisiologia, dalla fisica o dalla
cibernetica, ad esempio sono spiegati i tempi ed i modi di reazione del nostro
cervello agli stimoli esterni. La cosa più difficile da fare è eliminare ogni
possibile residuo del «Teatro cartesiano» - il cervello è un luogo in cui una
mente può agire, può interpretare la vita di qualcuno -. Fulcro di questo teatro è
l’idea che un sedicente soggetto abbia il potere di governare il cervello. Un
trascendente grande dittatore, un’eminenza grigia, «Autore Centrale» o
«Quartier Generale» occuperebbe e governerebbe la mente umana. Questo
suo potere potrebbe chiamarsi coscienza. Dennett propone altro:
«Non c’è un unico e definitivo «flusso di coscienza», perché non c’è un Quartier
Generale centrale, un Teatro Cartesiano dove «tutto converge» per essere
attentamente scrutinato da un Autore Centrale. Invece di un unico (per quanto
ampio) flusso del genere, ci sono canali multipli in cui i vari circuiti specializzati
tentano, in un pandemonio parallelo, di fare varie cose, creando man mano
delle Molteplici Versioni» (pp. 283-84).
Quindi non un unico autore della coscienza, ma una molteplicità di versioni che
nella loro intrinseca differenza produrranno il racconto migliore dell’io del
soggetto. Ogni stimolo produce nella mente tutta una serie di possibili soluzioni,
risposte fisiologiche e cognitive allo stimolo, che vengono via via vagliate ed
eliminate lasciando alla fine solo la risposta più coerente con l’integrazione del
corpo con la mente.
199
Dennett arriva a questa sua idea di coscienza attraverso la fisiologia.
L’ambiente fisico è, spinozianamente, idea della mente e quindi è un modo
differente di intendere il mondo psichico, per questo motivo non richiede un
«Autore Centrale». Dennett, esempio dopo esempio, rivela al lettore la
complessità sottostante ogni nostro atto percettivo e al conseguente atto
cognitivo (c’è un oggetto, si forma l’immagine retinica, si forma la stimolazione
neuronale che mi ‘rende cosciente’ di quell’oggetto, si forma in me la possibile
reazione all’immagine di quell’oggetto). Atto cognitivo che si definisce nel sé di
ognuno di noi. L’io coscienza che narra incessantemente, ad ognuno di noi, la
miglior storia possibile: la nostra. Forse la metafora del racconto è un po’
esausta ma coglie effettivamente il senso di una raffinazione delle risposte
multiple che il sistema della molteplici versioni richiede. Il dialogo incessante e
rapidissimo, sono ‘decisioni’ che la nostra mente prende in frazioni infinitesime
di secondo, che si sviluppa continuamente nell’incontro della nostra coscienza
con il mondo fenomenico.
Proprio per la complessità di nozioni che la teoria di Dennett mette all’opera e
per quell’imponderabile resto che non può che rimanere all’analisi dell’io
umano, il nostro autore ci avvisa dell’incompletezza del suo lavoro. Ma,
correttamente, Dennett aveva avvisato che la coscienza umana rimane un
grande ed inspiegato mistero e che tutt’al più egli avrebbe potuto fornire un
nuovo strumento di indagine.
«La mia spiegazione della coscienza è tutt’altro che completa. Si potrebbe
perfino dire che è stato solo un inizio, ma è un inizio perché rompe
l’incantesimo creato dalle idee che fanno sembrare impossibile una
spiegazione della coscienza. Io non ho sostituito una teoria metaforica, il Teatro
Cartesiano, con una teoria non metaforica («letterale, scientifica»). Tutto quello
che ho fatto, realmente, è stato sostituire una famiglia di immagini e metafore
con un’altra: ho rimpiazzato il Teatro, il Testimone, l’Autore Centrale, il
Figmento con il Software, le Macchine virtuali, le Versioni Multiple, un
Pandemonio di Homunculi» (p. 508).
Ciò che rimane al lettore è l’affascinante idea che l’io sia un racconto da
ascoltare incessantemente. Punto fermo per ascoltare senza impedimenti è
l’abbandono della filosofia cartesiana per una concezione più spinoziana della
relazione mente-corpo, una concezione che tratta la mente e il corpo come
differenti definizioni di un’unica sostanza e non come due mondi
completamente distinti.
____________________
Tutte le recensioni della rubrica “Invito alla lettura” sono curate da Gianmaria
Merenda, dottore di ricerca in Teoria e analisi del testo e dottorando in
Antropologia ed epistemologia della complessità, presso l’Università di
Bergamo.
____________________
200
ARTE IN GIARDINO
Sculture ceramiche di Tonino Negri
Mostra a cura della Galleria GULLIVER di Marciana Marina
presso Hotel Cernia – Capo Sant’Andrea (Isola d’Elba)
)RWRGL7RQLQR1HJUL
Con l’esposizione delle opere di Tonino Negri, nella stagione primavera-estate
2010, è ripreso il percorso artistico nei sentieri del Giardino delle Osmunde
dell’Hotel Cernia Isola Botanica (Sant’Andrea – Isola d’Elba), per la 6^ edizione
di ARTE IN GIARDINO.
a cura di Susanna Busoni
[…]
Il lavoro di Tonino Negri si snoda dalle grandi istallazioni, realizzate in
occasione di eventi folkloristici e feste popolari, in piazze e parchi pubblici in
Italia e all’estero, spaziando fino a lavori teatrali veri e propri, con partecipazioni
alla realizzazione di scenografie e allestimenti di spettacoli; esperienze che
trasferisce nelle opere scultoree in ceramica, materiale prediletto, nelle quali
ritroviamo il gusto del racconto fantastico, della creazione di mondi, storie e
personaggi immaginari.
Nelle sue opere la natura rimane la principale fonte di ispirazione: “- mi ispiro
all’acqua, alla terra, al fuoco, all’aria ma anche all’anima –“ , dice.
E in questo senso il lavoro con l’argilla, il contatto quindi con la terra, è per lui
una forma di meditazione che le sue sculture, le sue lampade, i suoi oggetti,
trasferiscono anche una volta ultimati.
In questo luogo la forza primaria che lo ha ispirato è stata sicuramente la magia
dell’acqua, che scorre impetuosa nei due ruscelli che qui confluiscono, per
raggiungere a valle la spiaggia e disperdersi in mare. Troviamo in ogni opera un
richiamo a questo elemento, a volte formale nelle fogge degli
elementi/contenitori che la delineano, siano essi vasi, otri o coppe dei suoi
“Giocolieri” e degli “Acquaioli”; altre volte ci chiede la partecipazione a un gioco
improvvisato e quindi ecco la fontana dei “Sette salti” che dobbiamo riempire
con una piccola zucca, ascoltando e osservando il rivolo che si tuffa da un
contenitore all’altro per arrivare alla fine e farci riprendere il giro; a volte invece
lascia che sia la natura stessa a intervenire e quindi la pioggia che riempie le
forme crea queste piccole pozze a cui si abbeverano le sue bianche colombe
mescolate ai merli e alle rondini che popolano il giardino.
Altre tracce di riferimento le troviamo nei temi dei viaggi per mare, “Naviganti” e
barche a vela gonfiate dal vento; i vasi-isola e le isole-vaso in omaggio all’Isola
d’Elba, che lui conosce da molto tempo e che racchiude nella sua storia
personale con le memorie e le immagini vissute; sirene, canti di balene
musicali, pescatori e pesci pescati; boschi misteriosi e qua e là, incagliate su
grandi massi di granito del giardino, scopriamo piccole e grandi maestose
arche, restate a secco e finalmente salvate dopo le incessanti piogge.
Susanna Busoni
203
+RWHO&HUQLD,VRODG·(OEDVHGHGHOODPRVWUD´$UWHLQ*LDUGLQRµ
Una storia di acqua, continenti e balene che cantano
di MariaGrazia Morganti
E’ soprattutto di notte che, all’Elba, si sente vivere il mare. Quando i rumori del
traffico si smorzano e dal basso arriva con le onde un vento profumato di fiori,
spezie e salsedine che aiuta gli uomini a chiudere gli occhi e riposarsi dalla
fatica di vivere. Ma se qualcuno, colpito da insonnia d’amore o dalla nostalgia
struggente di viaggi mai intrapresi, restasse sveglio a guardare verso il largo,
riuscirebbe certo a vedere coi suoi occhi lo spettacolo che Tonino Negri ha
colto.
Un mondo di acque tranquille ma pieno di sorprese, fra balene che cantano,
cernie a dondolo, pesci acrobatici color turchese che s’impilano con un guizzo
su palloni sferici per formare arditi totem balneari e sirene un po’ soprappeso,
dalle chiome arricciate come capitelli ionici, che vivono in placida simbiosi col
pesciolone che le ospita ingoiandole a metà.
Anche la luna partecipa a questa vita nata sotto il segno di una divinità bonaria,
che ha i tratti indecifrabili di quel Buddha, convenientemente assorto ed
enigmatico nell’osservare con distaccata benevolenza un microcosmo privo di
asprezze, dove nemmeno i rovi hanno le spine e tutto è governato da
un’armonia spontanea in cui non sono previsti bruschi cambiamenti di piani,
tanto meno spigoli o zig-zag.
Niente di artificioso o luccicante, solo argilla e ingobbio chiaro, tanto che
sembra quasi che sia stata l’azione congiunta del vento e dell’acqua (e non la
sapiente pazienza dell’autore) a levigare perfettamente queste forme
tondeggianti che hanno l’essenzialità e la stessa concisa ironia di un haiku,
capace di riassumere un mondo di sensazioni nel giro di poche sillabe.
Perfino Galla Placidia, l’altera figlia di Teodosio il Grande dal temperamento
guerriero che regnò con ineguagliato splendore a Ravenna, nelle mani di Negri
si trasfigura in un’immagine di donna solida e carnale, con le braccia arcuate
sui fianchi in una posa che richiama certo i canòpi etruschi ma fa di lei anche
una sorta di imperiale arzdòura, la mitica matriarca romagnola.
E’ la figura femminile, del resto, a dominare questo mondo di acque di fonte e di
mare.
Donne/nassa dal corpo a rete traforato come una veilleuse del Settecento,
donne/cariatidi che sorreggono intere isole simili a dolci di marzapane
posandole su piatti da portata o tengono la luna ben alta sulla testa, come se
temessero di perderla nel gorgo di un torrente.
Anche i Cinque Continenti hanno l’aspetto di donne dalle lunghe braccia, ben
tornite ed assorte come antichi Haniwa, le statue che i giapponesi disponevano
attorno alle tombe perché le proteggessero dagli spiriti malvagi. Sotto la loro
rigida compostezza da divinità arcaiche, però, nascondono un carattere
accomodante ed ospitale, aperto all’integrazione col mondo circostante,
disposte come sono a farsi invadere dalla natura che, qui al Cernia, occupa
qualsiasi spazio anche minimo sotto forma di esuberanze vegetali d’ogni
genere, e perfino a diventare punti di ritrovo per i numerosi uccellini del parco
botanico.
(continua pag. 207)
205
Una vena scanzonata più o meno avvertibile, percorre comunque tutta l’opera
di Tonino Negri, emergendo con malizia nelle giocose “reliquie”: il naso di
Pinocchio, la cui autenticità è garantita dalla leggendaria sincerità del suo
proprietario o la patatina “di” San Carlo, per un gioco di parole che ha
l’innocente irriverenza di uno sberleffo infantile.
Anche il sorridente minimalismo zen di certe piccole plastiche, ideali per una
meditazione tascabile e pronta all’uso, affiora chiaramente in quei Passaggi
che, si direbbe, un Pollicino molto preoccupato di non trovare più la via del
ritorno ha segnato con un sentiero serpeggiante fitto di ciottoli colorati, o nella
coppia di colombe “bizantine” che si abbeverano alla Fonte finalmente all’aria
aperta, stanche di aver atteso inutilmente Galla Placidia nel suo mausoleo per
un millennio e passa.
Un filo sottile, un rivolo d’acqua, anzi, lega fra loro tutte queste creature, dal
Navigante incoronato da un arc de triomphe ittico, che reca in sé le distese
marine attraversate, al Mago d’acqua che trasforma il suo getto in un
arcobaleno di ghiaccio, fino alla serie degli acquaioli, distanti interi continenti
ma affratellati, sembra, da un’identica fatica che li consuma fino a pietrificarne i
tratti del volto e a rendere assai simili le loro figure, chiuse entro l’ovale rigido di
un abito senza tempo né luogo.
A ben vedere, del resto, non è nient’altro che un acquaiolo in movimento anche
quel Giocoliere del Marocco che è rimasto prigioniero del proprio gioco,
letteralmente immobilizzato dalla sua stessa abilità, forse un monito ironico al
lavoro dell’artista.
Ed è ancora l’acqua ad essere scelta, per un dono rituale al cielo, da
quell’offerente chiuso in una sua privatissima dimensione atemporale, che si
situa non a caso al confluire dei due ruscelli del Cernia, luogo magico per
eccellenza, fonte di vita e di energia.
A questo punto si capisce come mai il luogo possa costituire una sorta di
lussureggiante terra promessa, dopo tanto peregrinare, per tutte quelle arche
panciute e compatte che hanno trovato qui il loro personale Ararat di pietra o di
argilla. Perché l’arte, si sa, è soprattutto gioco e illusione, e quindi un otre
bucherellato può senza sforzo trasfigurarsi in un firmamento, una lampada
diventare una scenografia deserta nell’attesa di un dramma che forse si è già
compiuto e l’Arca-lago rappresentare un luogo dell’anima, in cui sarebbe così
confortante pensare di potere essere accolti in occasione di un sempre meno
improbabile diluvio prossimo venturo.
MariaGrazia Morganti
207
FOTO S. Santioli
7RQLQR1HJUL6FXOWXUDFHUDPLFD´$UWHLQ*LDUGLQRµ,VRODG·(OED
208
7RQLQR1HJUL6FXOWXUDFHUDPLFD´$UWHLQ*LDUGLQRµ,VRODG·(OED
FOTO T. Negri
7RQLQR1HJUL6FXOWXUDFHUDPLFD´$UWHLQ*LDUGLQRµ,VRODG·(OED
Critica
minore
Periodico di cultura politica - filosofia
sociologia - letteratura - arte
SITO WEB
www.criticaminore.it
e-mail sito: [email protected]