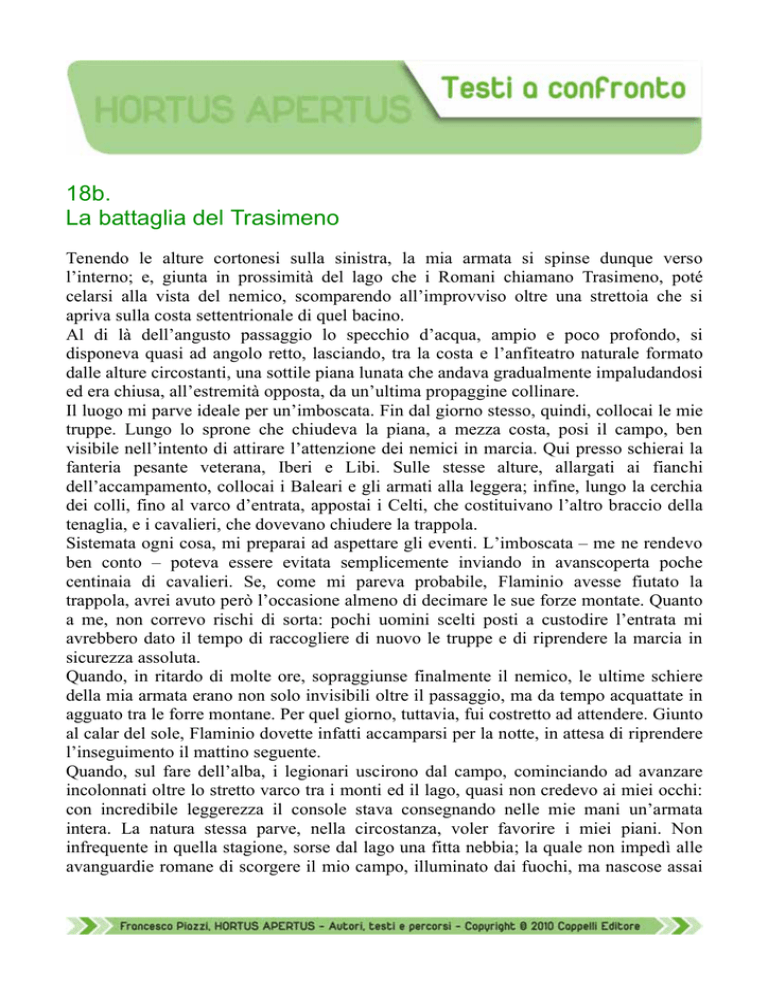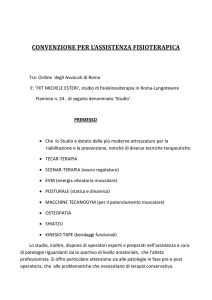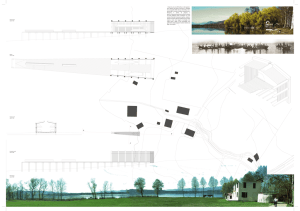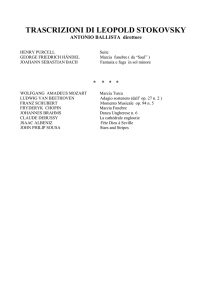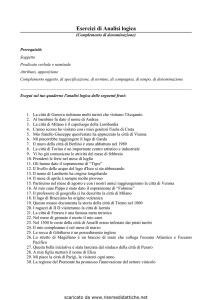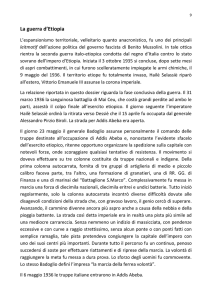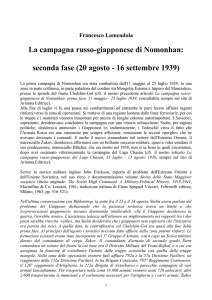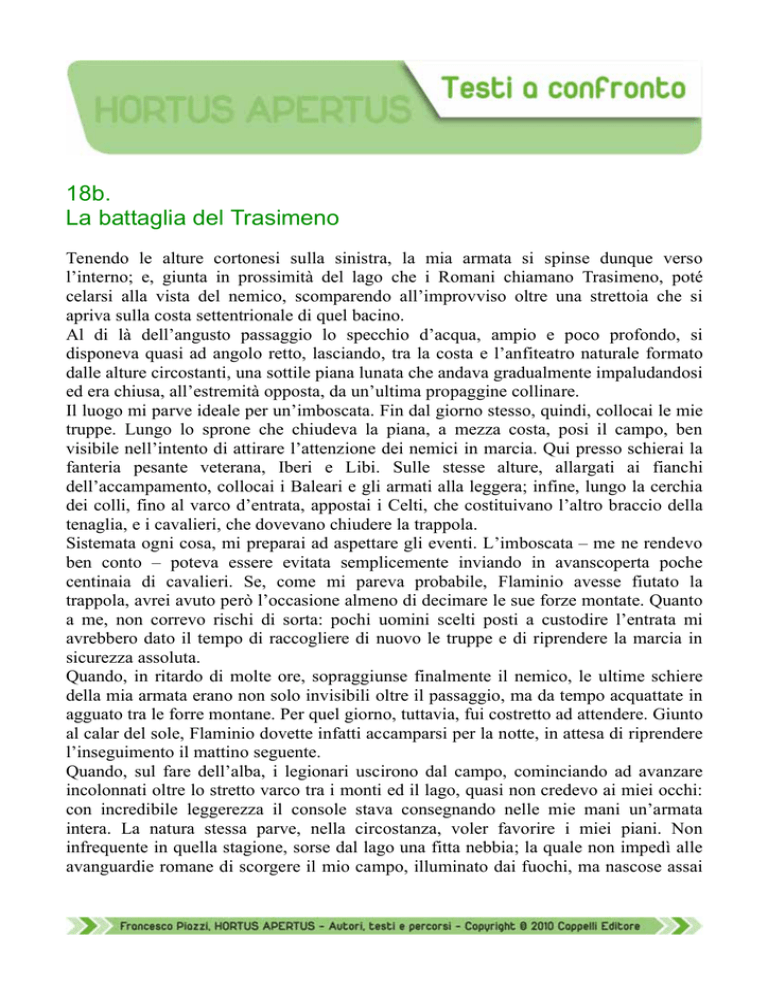
18b.
La battaglia del Trasimeno
Tenendo le alture cortonesi sulla sinistra, la mia armata si spinse dunque verso
l’interno; e, giunta in prossimità del lago che i Romani chiamano Trasimeno, poté
celarsi alla vista del nemico, scomparendo all’improvviso oltre una strettoia che si
apriva sulla costa settentrionale di quel bacino.
Al di là dell’angusto passaggio lo specchio d’acqua, ampio e poco profondo, si
disponeva quasi ad angolo retto, lasciando, tra la costa e l’anfiteatro naturale formato
dalle alture circostanti, una sottile piana lunata che andava gradualmente impaludandosi
ed era chiusa, all’estremità opposta, da un’ultima propaggine collinare.
Il luogo mi parve ideale per un’imboscata. Fin dal giorno stesso, quindi, collocai le mie
truppe. Lungo lo sprone che chiudeva la piana, a mezza costa, posi il campo, ben
visibile nell’intento di attirare l’attenzione dei nemici in marcia. Qui presso schierai la
fanteria pesante veterana, Iberi e Libi. Sulle stesse alture, allargati ai fianchi
dell’accampamento, collocai i Baleari e gli armati alla leggera; infine, lungo la cerchia
dei colli, fino al varco d’entrata, appostai i Celti, che costituivano l’altro braccio della
tenaglia, e i cavalieri, che dovevano chiudere la trappola.
Sistemata ogni cosa, mi preparai ad aspettare gli eventi. L’imboscata – me ne rendevo
ben conto – poteva essere evitata semplicemente inviando in avanscoperta poche
centinaia di cavalieri. Se, come mi pareva probabile, Flaminio avesse fiutato la
trappola, avrei avuto però l’occasione almeno di decimare le sue forze montate. Quanto
a me, non correvo rischi di sorta: pochi uomini scelti posti a custodire l’entrata mi
avrebbero dato il tempo di raccogliere di nuovo le truppe e di riprendere la marcia in
sicurezza assoluta.
Quando, in ritardo di molte ore, sopraggiunse finalmente il nemico, le ultime schiere
della mia armata erano non solo invisibili oltre il passaggio, ma da tempo acquattate in
agguato tra le forre montane. Per quel giorno, tuttavia, fui costretto ad attendere. Giunto
al calar del sole, Flaminio dovette infatti accamparsi per la notte, in attesa di riprendere
l’inseguimento il mattino seguente.
Quando, sul fare dell’alba, i legionari uscirono dal campo, cominciando ad avanzare
incolonnati oltre lo stretto varco tra i monti ed il lago, quasi non credevo ai miei occhi:
con incredibile leggerezza il console stava consegnando nelle mie mani un’armata
intera. La natura stessa parve, nella circostanza, voler favorire i miei piani. Non
infrequente in quella stagione, sorse dal lago una fitta nebbia; la quale non impedì alle
avanguardie romane di scorgere il mio campo, illuminato dai fuochi, ma nascose assai
meglio di quanto avessi fatto io stesso la minaccia disposta sul fianco dell’esercito in
marcia.
Quando fui sicuro che tutta l’armata nemica o la maggior parte di essa era entrata nella
sacca, alzai – ben visibile sopra la coltre, che copriva solo il fondovalle – il segnale di
un attacco simultaneo. Mentre la fanteria pesante punica calava da nord-est in ordine di
battaglia, sulla lunga e sottile colonna dei legionari si avventarono da ogni parte i miei
uomini.
Prima ancora di aver visto i Punici, celati dalla caligine, le sventurate truppe di
Flaminio sentirono, dal repentino clamore, di essere circondate: col lago alle spalle e
subito disanimate dalla sorpresa, irreparabilmente svantaggiate dalla posizione e per di
più gravemente inferiori di numero, esse compresero che la battaglia era perduta prima
ancora di cominciare. Impediva qualsiasi difesa efficace l’ordine stesso di marcia, con
l’esercito romano completamente allungato nella valle, che rendeva problematica la
trasmissione dei comandi; malgrado ciò, gli ufficiali e soprattutto il console si
prodigarono oltre l’umano, riordinando per quanto possibile le file e portando ovunque
il conforto della parola e dell’esempio.
Proprio attorno al console, insigne per le sue armi, si sviluppò più feroce la mischia. Mi
auguro che, nell’ora della morte, Flaminio abbia finalmente trovato, con il suo
coraggio, il riscatto dalla costante ostilità dei suoi pari. Mentre si adoperava a rianimare
la lotta, egli cadde sotto la lancia di un principe degli Insubri, a nome Ducario, che votò
ai Mani dei suoi concittadini massacrati da Roma l’anima del console.
Anche i legionari, pur nella congiuntura disperata, seppero dimostrare appieno il loro
valore, tenendo per ben tre ore testa ai miei uomini. Essi tentarono invano di dispiegarsi
nella valle. Alcuni raggiunsero – nello sforzo di battersi o di fuggire – le prime pendici
dei colli; là dove una serie di ustrina – le fosse di cremazione che ho fatto scavare io
stesso – segna ora il punto in cui le schiere più avanzate trovarono, combattendo, la
morte. Altri cercarono scampo nel lago, e furono in parte trascinati a fondo dalle
armature, in parte raggiunti e massacrati dalla mia cavalleria, che spinse i cavalli a
inseguirli nelle acque basse. Seimila uomini dell’avanguardia riuscirono addirittura a
rompere il fronte opposto, aprendosi la via con le armi nel punto in cui erano schierati
più fitti i Baleari; e ripararono su una collinetta alle spalle del campo di battaglia, sulla
quale sorgeva un villaggio etrusco. Qui, il giorno dopo, si concluse la vicenda
dell’esercito di Flaminio; raggiunti e circondati dagli Iberi e dalle truppe leggere al
comando di Maarbale, i superstiti si arresero, a patto di aver salva la vita.
Nell’occasione lasciai liberi ancora una volta gli Italici, ribadendo di essere venuto a
combattere contro Roma per la loro libertà.
(Giovanni Brizzi, Annibale come un’autobiografia, Bompiani, Bologna 2003, pp. 145 ss.)