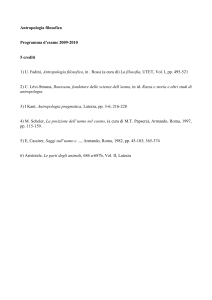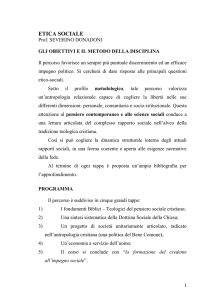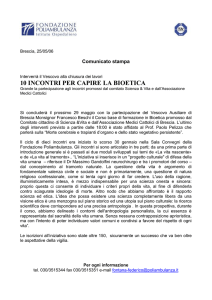179
QUESTIONI DI BIOETICA, SCIENZA E ANTROPOLOGIA FILOSOFICA
STEFANO MINIATI
Dipartimento di Studi Storico-Sociali e Filosofici, Università di Siena (Sede di Arezzo)
1. Posizione del problema
I problemi sollevati dagli sviluppi dell’indagine biomedica, che si costituiscono sempre
più come questioni-limite – ovvero come questioni di confine che impongono alla
ragione morale di forzare in maniera crescente la sfera d’applicazione delle proprie
categorie tradizionali –, coinvolgono in misura sempre maggiore l’interesse di personale
non sanitario, il quale è chiamato in varie misure a discutere sul valore e le prospettive
di quell’indagine. Di là dal concreto fatto storico che ha visto la bioetica nascere, quasi
quaranta anni fa, come «scienza della sopravvivenza» dell’intero sistema ecologico
planetario1, oggi il punto focale delle ricerche etiche nell’ambito delle scienze della
vita è sicuramente l’uomo, oggetto e insieme soggetto di procedimenti terapeutici
che sempre meno risultano inquadrabili nella prospettiva della «cura», e quindi
inseribili immediatamente nel quadro teorico delimitato classicamente dai tre princìpi
ippocratici della beneficienza, non maleficienza e giustizia, che costituivano le «linee
guida» tradizionali del rapporto medico-paziente.
Questioni come quelle se sia o meno giusto, da un punto di vista etico e giuridico,
parlare di eutanasia nei casi di gravi patologie incurabili, se sia o meno giusto
progettare interventi di genetica migliorativa sugli embrioni o ancora se il principio
dell’informazione completa data al paziente esiga anche la comunicazione di diagnosi
sfavorevoli che possiedano solo un determinato grado di probabilità, non permettono
di decidere in maniera immediata se si stia agendo a vantaggio del paziente o piuttosto
a suo danno, non consentono di capire se si stia «facendo il suo bene» (beneficienza) o
se piuttosto non stiamo «nuocendogli» (non maleficienza).
Ancora più complessa, se si vuol rimanere all’interno della deontologia ippocratica,
appare la decisione in merito all’esecuzione di terapie «giuste». Dei tre princìpi
ippocratici, quello riguardante la giustizia è stato spesso trascurato non solo all’interno
della deontologia medica, ma anche dalla gran parte delle bioetiche, oppure è stato
interpretato per lo più nel senso della giustizia sanitaria, ovvero della razionale equità
nell’uso delle risorse sanitarie disponibili2.
Non è certamente né opportuno né realistico trascurare il fattore economico
nell’odierna situazione economica sanitaria, che si trova, nei paesi occidentali, a dover
sempre più far fronte ad un’endemica scarsità di risorse e nondimeno ad un numero
180
PIANETA GALILEO 2006
crescente di persone da assistere; tuttavia la focalizzazione della giustizia unicamente
sul fattore economico deve considerarsi il sintomo da un lato di un’etica che tende
a risultare deontologicamente sempre più procedurale (fossilizzata cioè in protocolli
istituzionalizzati privi di ogni «riguardo verso la persona») e moralmente sempre più
individualista; dall’altro di una concezione del diritto che rifiuta qualsiasi fondazione
materiale (ovvero radicata in un nucleo basilare di norme capaci di fondare l’agire
positivo individuale e sociale) dello ius gentium; esso nei fatti si concreta o nella
enunciazione di princìpi estremamente formali (come nel caso dei diritti universali
dell’uomo, che subiscono, nelle applicazioni specifiche, interpretazioni del tutto
discordanti) o si polverizza nei diritti positivi, che per loro natura non sono in grado
di soddisfare le esigenze normative di una ricerca biomedica che avanza attualmente a
ritmi vertiginosi.
La maggior parte delle bioetiche assume come nucleo centrale della propria indagine
la vita dell’uomo, e assegna a questa vita un valore in base ad una scala graduata che
dipende dai presupposti dai quali prende di volta in volta le mosse. Così si parla di etiche
della sacralità della vita e di etiche della qualità della vita, di etiche della disponibilità e
indisponibilità della vita. Questa centralità è dovuta ovviamente al fatto che non è altro
che la vita ad essere strettamente connessa agli eventi della malattia e della morte, e
quindi oggetto specifico delle cure e dell’attenzione medica. Tuttavia questa attenzione
alla vita non corrisponde ad una pari chiarezza sul senso che le si deve assegnare.
Se è in buona parte vero, come ha notoriamente sostenuto Michel Foucault, che
la vita in senso biologico (non, naturalmente, filosofico-antropologico) diviene oggetto
autonomo di studio solo successivamente alla teorizzazione darwiniana – vita e lotta
per la vita come sostrato di ogni possibile processo evolutivo – a un secolo e mezzo di
distanza dalla pubblicazione de ‘L’Origine delle specie’ non vi è accordo su cosa essa sia
né dentro né fuori il mondo delle scienze biologiche3. Qui si può solo rilevare che le due
tendenze oggi dominanti, quella della «geneticizzazione della vita»4 e quella, correlata,
di definire la vita organica semplicemente come un sottoinsieme della vita codificata, la
quale comprende anche la vita artificiale, risulta insufficiente alla trattazione bioetica5.
Di fatto, questa enfasi sul fenomeno «vita» – che come ho detto è nella maggior
parte dei casi «vita umana» – pone spesso in secondo piano la questione che la fonda,
ovvero quella intorno alla riflessione sull’uomo che è agente di tale vita – anche se tale
riflessione poi è naturalmente sottesa ad ogni concezione bioetica. Ma questo «essere
sottesa» significa, a mio parere, anche essere trascurata in quanto non resa esplicita nelle
sue molteplici complessità6.
Scopo della presente indagine è quello di sondare alcune antropologie che stanno
alla base dei tipi principali di bioetica oggi presenti, e di analizzarle secondo alcuni
criteri antropo-filosofici mutuati in particolare dall’antropologia filosofica moderna,
che vede i suoi nomi più rappresentativi in Max Scheler, Arnold Gehlen e Helmut
Plessner. La caratteristica comune dell’antropologia di questi autori (parziali eccezioni
che tuttavia qui non possono essere approfondite, si devono avanzare nel caso di
QUESTIONI DI BIOETICA, SCIENZA E ANTROPOLOGIA FILOSOFICA
181
Scheler) risiede nel fatto di situarsi su di un piano puramente filosofico, che in linea di
principio rinuncia ad ogni approccio metafisico e cerca di servirsi in maniera razionale
dei risultati dell’indagine empirica sull’uomo (antropologia fisica e culturale, psicologia,
sociologia, etnologia).
La rinuncia all’approccio metafisico non significa una svalutazione del dato
sovrasensibile e sovraempirico, ma significa unicamente la delineazione di una concezione
dell’uomo che si basi almeno su un piano filosofico-empirico largamente condivisibile.
In più, le dottrine dell’antropologia filosofica moderna, con la loro indole olistica7,
consentono di riportare ad unità i disparati e polverizzanti sguardi forniti dalle scienze
umane8, e in questo trovano un notevole punto di contatto con le ragioni della bioetica,
che hanno posto di nuovo e prepotentemente sulla scena il problema «uomo» nella sua
totalità di senso. L’approccio antropo-filosofico può così forse rappresentare un valido
strumento teorico per chiarire alcune questioni bioeticamente controverse, non nel
senso di semplificare nella teoria ciò che nella pratica risulta complesso, ma al contrario
per illuminare la pratica morale di una complessità che spesso viene tralasciata9.
In questa breve esposizione desidero evidenziare in quale senso l’approccio antropofilosofico possa risultare utile alla bioetica. Tale analisi, condotta anche attraverso la
veloce descrizione di un case-study, mi permetterà di evidenziare i nessi che una visione
più globale e sfaccettata del composto umano possono intrecciare con l’indagine etica
nell’ambito delle scienze della vita. L’evidenziazione di questi nessi servirà a introdurre
la rilevanza della ripresa di un accostamento di concezioni bioetiche e antropologiche,
come possibile base per la costituzione di una bioetica capace di superare le secche di
una medicina puramente protocollare, il che è oggi da più parti richiesto in ambito
sanitario.
2. Quale antropologia filosofica per la bioetica?
La scelta di adoperare come base interpretativa alcuni elementi dell’antropologia filosofica
moderna – che qui è descritta solo in alcuni punti rilevanti per la presente indagine
– si basa principalmente sulla tendenza olistica sua peculiare, di cui anche prima si
diceva. Questa tendenza si realizza soprattutto nel considerare il lato fisico-biologico ed
il lato psichico-spirituale dell’uomo come aspetti che in misura diversa ma con lo stesso
valore costituiscono la complessa «essenza» dell’uomo. Indubbiamente ciò rappresenta
un tratto caratteristico che non è dato ritrovare, ad esempio, nell’antropologia tedesca
del XVIII secolo di Kant, Herder ed Hegel, in quella fenomenologico-esistenzialista
di Heidegger, Jaspers o Marcel, né in quelle antropologie che, al contrario di queste,
vogliono fondarsi del tutto in modo «obiettivo» sui risultati delle scienze empiriche
quali la biologia, la psicologia, l’etnologia. Nelle prime l’elemento della corporeità,
del dato fisico nell’uomo è dato per assodato e con ciò passato sotto silenzio10; nelle
seconde assurge, nelle sue componenti psico-fisico-sociali, ad unico oggetto di ricerca11.
Di un tale unilateralismo soffre precisamente anche la bioetica attuale.
Non è difficile comprendere come concezioni di questo tipo, per quanto
182
PIANETA GALILEO 2006
filosoficamente articolate e profonde, non riescano a risultare decisive per un’etica
biologica che si concentra soprattutto sulle questioni del corpo dell’uomo, dei suoi
stati patologici, ma anche della comprensione che il soggetto stesso ha di entrambi.
Sono del parere che l’enfasi utilitaristica della cosiddetta «bioetica laica» proprio sui
dati del tutto corporei di dolore e piacere fisici come misura decisiva del ragionamento
etico, non rappresenti una valida alternativa alla tradizionale sovraordinazione della
sfera spirituale dell’uomo rispetto a quella corporea, che gli esponenti della bioetica
cattolica adottano di fronte elle esigenze della ricerca biomedica attuale. La prima
impostazione si dimostra deficitaria nel momento in cui fa dell’etica una prassi
decisionale che, in ultima analisi, si basa su un bilancio puramente algometrico, il
quale suppone la completa misurabilità degli stati di dolore e di piacere. Anche il
cosiddetto «benesserismo» (o utilitarismo qualificato), ovvero l’etica delle «preferenze»,
pretende di fondare la capacità individuale di decisione su un bilancio di questo tipo, e
in definitiva si affida in maniera quasi totale alla capacità diagnostica e previsionale del
personale sanitario per poter intraprendere un’azione di carattere etico. L’etica cattolica,
da parte sua, possiede presupposti eccessivamente vincolanti (dato rivelato, autorità del
Magistero cattolico) per poter risultare condivisibile da un largo numero di persone;
inoltre propriamente assegna dignità all’uomo solo in maniera indiretta e derivata dalla
dignità del Creatore.
3. Elementi della moderna antropologia filosofica
Una diversa concezione del valore del «composto umano», qual è quella postulata ad
esempio da Arnold Gehlen, può rappresentare una valida base di partenza per ripensare
alcune questioni di bioetica. L’«antropologia elementare» di Gehlen prende le mosse
dal presupposto fondamentale per cui ciò che è spirituale nell’uomo trova una radice
profonda nella sua morfologia corporea. Questa radice non dev’essere però intesa
nel senso fisiognomico – così diffuso nella filosofia romantica e in tutto l’Ottocento,
tanto da restare a fondamento di una ben nota scuola crimonologica – che l’esteriore
sia espressione e forma dell’interiore. Una simile concezione è smentita ovunque
dall’esperienza12.
Piuttosto il corpo dell’uomo è per essenza «manchevole», ipodotato dalla natura
sia per quanto riguarda i suoi strumenti di difesa che di attacco, e questa mancanza
rappresenta il punto di partenza per il suo sviluppo culturale: l’uomo ha dovuto rispondere
con strumenti culturali alla propria insufficienza fisica. L’uomo quindi, in forza della
propria costituzione materiale, sorge come essere spirituale, l’unico essere spirituale
della terra, e in questo senso per Gehlen non ha alcun significato parlare di uomo allo
stato di natura, inteso nel senso della privazione di ogni struttura culturale13.
Ora, secondo l’antropologia gehleniana, le condizioni fisiche non rappresentano
affatto la causa delle disposizioni spirituali. Non vi è alcuna possibilità di applicare qui
un concetto causale che sia anche lontanamente affine a quello delle scienze naturali,
in quanto esso sarebbe sotto ogni riguardo troppo semplice e lineare per fornire
QUESTIONI DI BIOETICA, SCIENZA E ANTROPOLOGIA FILOSOFICA
183
un’immagine fedele del composto umano. Piuttosto le condizioni fisiche dell’uomo
rappresentano una condizione di possibilità del suo sviluppo spirituale, condizione che
è negativa in quanto incarna una mancanza, una deficienza. Il fatto di non possedere
istinti ineluttabili che, come negli altri animali, assicurino, ad ogni presentarsi di
condizioni date, una reazione adeguata e per ciò stesso vincolata; il fatto, a ciò
conseguente, di poter reindirizzare le proprie pulsioni in direzioni che risultano sempre
mediate culturalmente; l’autocoscienza, che fa sempre di ogni organo – strumento che
ci protrae verso l’esterno – soggetto (in quanto le agisce e le rende possibili) e oggetto
(in quanto noi percepiamo il fatto che percepisce) delle nostre percezioni: tutto questo,
in quanto ci conduce verso l’azione, verso l’atto decisivo del se e del come strutturare
la nostra sopravvivenza, tutto questo ha come sua condizione una struttura corporea
estremamente aspecifica e «buona per molti usi».
Non vi è, in una simile concezione, il rischio di declassare le più alte funzioni
umane a livello di semplice «sovrastruttura» di una base corporea, ovvero di inclinare
verso un puro ilozoismo? No, almeno seguendo il punto di vista dell’analisi gehleniana,
in quanto, come si è visto, ciò che è «natura», «corpo», «fisicità» è sempre mediato da
un elemento culturale, che trasforma ogni «ambiente» (Umwelt)
Umwelt) in cui l’uomo vive in
Umwelt
un «mondo» (Welt)
Welt) che trascende il dato naturale. In questo senso secondo Gehlen,
Welt
per utilizzare e parafrasare la nota espressione di Nietzsche, il corpo non si dà mai
come fatto, ma sempre come interpretazione di un fatto attraverso una facoltà mentale
«esonerata» (entlastet)
entlastet dall’esaurirsi in risposte immediate all’ambiente circostante, che
entlastet)
trova così nell’autocoscienza il principio basilare della propria azione14.
La visione gelehniana è sicuramente del massimo interesse per il fatto che tenta di
superare il dualismo mente-corpo, approdando ad un olismo che in bioetica risulta
sempre più necessario, e recupera teoreticamente il valore del corpo, che viene inserito
all’interno di un «mondo» al quale l’uomo non semplicemente si adatta, come l’animale,
ma che trasforma attraverso la cultura e in qualche modo fa «suo».
Il corpo diviene così il medium tramite cui possiamo collegare il mondo interno delle
nostre sensazioni, percezioni e riflessioni, e il mondo esterno composto da elementi
inorganici, organici e altri uomini. Verso l’esterno, quindi, il corpo diviene un vero
e proprio mediatore di cultura. Ora, però, questa cultura non può costruirsi se non
attraverso il linguaggio. Per Gehlen il linguaggio non è altro che il simbolo significante
il mondo, attraverso cui l’uomo può dire il mondo anche in assenza del mondo, con
l’unico elemento sensibile rappresentato dai vari fonemi. L’uomo non ha bisogno di
avere sempre presenti, tramite i cinque sensi, gli oggetti della propria percezione, ma
può evocarli semplicemente chiamandoli; è questa la sua «potenza», significata anche
dal primo comandamento del Decalogo, che impone di non esercitare invano la potenza
evocativa della parola che sta per l’elemento significato15.
Il linguaggio trova piena esplicazione in un sistema di comunicazione in cui vi siano
più parlanti; il pensiero stesso, che è monologo interiore, deriva in «linea diretta» dal
linguaggio, ed è «simbolo di simbolo»16, è rivolto puramente all’interiorità. La cultura
184
PIANETA GALILEO 2006
umana espressa nel linguaggio si configura allora in primo luogo come una cultura
comunitaria, che trova nel rapporto io-tu un suo fulcro imprescindibile di ricezione e
trasmissione. La possibilità umana di elaborare un mondo possiede infatti due sorgenti:
la prima sono le percezioni sensibili, la seconda la loro mediazione e rielaborazione
attraverso la cultura. Questa, tuttavia, è sempre in primo luogo tradizione, ossia
tramandamento, ed è legata perciò all’insegnamento che ognuno riceve nei primi
anni di vita, e che costituisce l’educazione, l’esser «tirati su» da parte di altri uomini.
Ciò spiega il periodo estremamente protratto dello svezzamento dei cuccioli d’uomo.
L’appartenenza dell’uomo alla comunità umana ha dunque in primo luogo un significato
legato alla sopravvivenza e alla possibilità di vivere nell’ambiente costruendosi un
«mondo».
Gehlen si riferisce in più passi ad Herder, nel momento in cui cerca un sostegno alla
sua teoria dell’uomo come essere fondamentalmente «manchevole» (Mängelwesen)17, che
è inserito, socialmente e poi anche moralmente, all’interno dell’«umanità» (Humanität),
Humanität
Humanität),
come lo stesso Herder rende esplicito nelle sue Briefe zur Beförderung der Humanität.
Tale ripresa di temi herderiani trova evidenti punti di convergenza anche con le
contemporaneee ricerche di Helmut Plessner, contenute soprattutto nel volume I gradi
dell’organico e l’uomo18, di cui Gehlen fa esplicita menzione nel suo lavoro principale19.
Plessner in ogni modo, criticando lo «strapazzamento» che Gehlen avrebbe fatto del
concetto herderiano di Mängelwesen – che a suo dire possiederebbe una «limitata forza
trainante»20 – non ritiene opportuno focalizzarsi principalmente sull’«esonero» generato
dalla prevalenza degli organi della vista e dell’udito e in seguito dal linguaggio e dal
pensiero, ma sulla nozione di uomo come animale dalla «posizionalità eccentrica»21.
Questo concetto del porre (setzen), della posizione (Setzung),
Setzung), che rimanda all’«essere
Setzung
innalzato» e insieme allo «stare», degli organismi viventi si trova in un certo senso
in contrasto con quella gehleniana in quanto ne rappresenta la controparte positiva.
Non si prendono stavolta le mosse da una privazione, ma dal trascendimento positivo,
appunto, di un limite che inerisce ad ogni vivente – il limite che lo definisce, che lo
perimetra – e che, in quanto concetto logico prima che fisico, può essere travalicato.
Ogni organismo vivente diviene ciò che ha da essere (al contrario del semplice corpo
fisico, che solamente «è») superando il limite che gli inerisce a partire dal proprio centro,
al quale rimane per sempre vincolato. Anche l’uomo diviene e supera il proprio limite,
ma in modo «eccentrico», svincolato e imprevedibile, perché, attraverso l’autoriflessione
– processo sempre inconcluso e che va ad infinitum – egli si fa oggetto e spettatore di se
stesso, acquisendo così la capacità di partirsi anche dal proprio centro, di posizionarsi
«dietro» di esso22.
Il corpo dell’uomo, inteso come unità psico-fisica, è quindi per Plessner limite e
capacità, logica e fisica, di trascendimento del centro, ed assolve la propria essenziale
«funzione mediatrice» tra centro e periferia. Tale potersi trascendere pone l’uomo in
una forma extra-istintuale di equilibrio instabile, a cui egli deve rispondere con gli
strumenti della cultura.
QUESTIONI DI BIOETICA, SCIENZA E ANTROPOLOGIA FILOSOFICA
185
Le antropologie di Gehlen e Plessner, pur riconoscendone i meriti, si pongono in
contrasto esplicito con la visione di Max Scheler, soprattutto nel non voler accettare
alcuna premessa metafisica, e nel rifiutare in maniera marcata la nozione di «spirito»
in riferimento all’uomo, la quale rimanda al dualismo, esecrato, di spirito e materia.
Nondimeno, si possono elencare una serie di aspetti centrali che Scheler condivide
con gli altri due grandi antropologi, e che ci serviranno da base per le nostre ulteriori
considerazioni in ambito bioetico. Per Scheler l’uomo è, innazitutto come essere che
possiede lo spirito,
colui che sa dir di no, l’asceta della vita, l’eterno protestatario di ciò che è soltanto realtà.
In rapporto all’animale... l’uomo è l’eterno Faust, la bestia cupidissima rerum novarum,
mai paga della realtà circostante, sempre avida di infrangere i limiti del suo essere oraqui-così, sempre desiderosa di trascendere i limiti della realtà circostante: e con ciò
anche i limiti della propria realtà personale presente23.
Questo «dir di no» alla realtà costituisce per Scheler la via che porta ad una profonda
comprensione fenomenologica degli elementi dell’ambiente e di se stesso che l’uomo
non realizza, come nella fenomenologia husserliana (da cui pure il nostro autore prende
le mosse), attraverso l’epoché,
epoché, ma attraverso l’annullamento, per tentativi successivi,
epoché
dello stesso momento della realtà. Ora, questa negazione del momento della realtà
porta l’uomo a doversi domandare quale sia il suo posto nel mondo, e questa domanda
lo conduce, seguendo Scheler, necessariamente ad interrogarsi sul principio stesso
della realtà, che nell’ultima fase del suo pensiero si incarna in un principio metafisico
areligioso.
Tale principio, lo spirito, fonda, insieme all’impulso vitale, quel che per Scheler è
la persona. La persona è ciò che caratterizza il composto psico-fisico umano informato
di spirito. Ora, questo spirito coincide con la possibilità e la realizzazione di atti
intenzionali da parte del soggetto, atti che, nella sfera etica, puntano alla realizzazione
di valori; questi, nell’ottica scheleriana, costituiscono un a priori materiale, che si
oppone da un lato all’astratto formalismo kantiano e dall’altro allo psicologismo privo
di valore universale. La persona non è un «io» oggettivabile e psicologizzabile, ma
sempre un’autocoscienza che partecipa dei propri atti e che in sé non è scientificamente
analizzabile. Della persona non fa parte il corpo fisico-oggettivo (Körper),
Körper), che è solo uno
Körper
strumento mediatore verso il mondo; fa invece parte il corpo fisico-soggettivo vissuto ed
esperito (Leib), che costituisce il perno dell’autocoscienza personale24.
La persona si trova al centro di una serie di relazioni, la cui più alta forma è per
Scheler l’amore; esse hanno carattere oggettivo, essenziale ed universale, e costituiscono
un elemento imprescindibile nella determinazione dell’autonomia personale.
4. Per un’interpretazione antropo-filosofica della bioetica
Mi pare che sia possibile porre in rilievo alcuni elementi caratterizzanti le tre
antropologie, che, a mio parere, possono venir recuperati nella costituzione di un’etica
sanitaria efficace e conforme alle esigenze attuali.
186
PIANETA GALILEO 2006
•
Considerazione del corpo come condizione (ma non causa) dello «essenza»
umana. Il corpo rappresenta il medium tra cultura e natura, e porta con sé
l’eredità genetica del genere umano.
•
Enfasi sulla comunità umana, la sola in cui l’uomo possa realizzare quella
cultura che gli consente di sopravvivere nell’ambiente. Essa è comunità genetica
e culturale, entro cui solo ha senso parlare di autonomia individuale.
•
Uomo come «essere che diviene», come possibilità vivente di trascendimento
delle proprie condizioni date.
Cominciando dal primo elemento per poi prendere in considerazione
contestualmente anche gli altri, nei confronti delle attuali istanze della ricerca bioetica
mi pare assai opportuno porre l’accento sul «corpo che siamo»25: ogni pratica medica
deve tener conto che qualsiasi intervento sul fisico coinvolge sempre già la peculiarità
dell’uomo. Ciò non è di solito tenuto nel debito conto. Quando ad esempio si discute
della ricerca di cellule staminali embrionali, da parte laica ci si concentra solamente
sul fatto se l’agglomerato cellulare possa o meno percepire dolore, mentre da parte
cattolica la preoccupazione risiede solo nel fatto se esso manifesti o meno l’infusione
dell’anima razionale, oppure si dà per assodato che la possieda ab initio, ma in questo
modo sovente si tende ad equiparare tale «anima» al corredo cromosomico, non
potendo tutelare in altro modo «oggettivo» la «personalità» della vita nascente; tuttavia
si cade così facilmente nella deriva traduciano-materialistica, che non può armonizzarsi
col personalismo ontologico di matrice tomista sostenuto dalla Chiesa in ambito
bioetico26.
Seguendo le categorie dell’antropologia filosofica moderna il corpo dell’uomo, in
quanto tale e per se stesso, è umano già in quanto insieme cellulare strutturato in un
determinato modo, more humano, anche nei suoi stadi embrionali. Quella strutturazione,
cioè, diviene necessaria condizione per l’uomo, e quindi già umana in se stessa. L’embrione
inoltre è legato al genere umano per il fatto di avere in sé le caratteristiche genetiche
della specie. La sperimentazione su di esso è una sperimentazione già sull’essere umano.
Non importa qui introdurre il concetto di «persona» e nemmeno di «individuo», basta
quello di «uomo». La legittimazione della sperimentazione non dipende dal fatto se
l’assenza della stria primitiva escluda ogni possibile dolore; non dipende nemmeno
dal fatto se l’embrione sia «persona», ovvero se possieda un’anima. Queste questioni
aggirano il problema, sia perché legittimano l’intervento sull’uomo solo a partire da
un’algometria che si pretende oggettivabile, sia perché vincolano la tutela dell’embrione
ad una deontologia basata su una fede non condivisibile da tutti e che in fondo non tutela
l’uomo in sé, ma l’integra sovranità del Creatore sulla creatura. Anche la determinazione
dell’individualità somatica diviene problematica, nel momento in cui non è peculiare
soltanto del genere umano e risulta difficilmente affermabile a certi stadi dello sviluppo
ontogenetico, quando vi è ancora la possibilità della poliembrionia27.
L’appartenenza al genere umano, che deve essere fermamente affemata come
QUESTIONI DI BIOETICA, SCIENZA E ANTROPOLOGIA FILOSOFICA
187
appartenenza di specie28, fonda invece una nozione di responsabilità che rimane
intimamente connessa a quella di giustizia (dike in senso ippocratico). Se il corpo
dell’uomo è condizione dell’umanità, operare su quel corpo non mette in gioco soltanto
la responsabilità del singolo medico o dei congiunti, ma la giustizia, ovvero il rispetto del
modus humanus di fronte al consessus hominum, ciò che propriamente fonda la nozione
di ius 29. È precisamente nella trascuratezza di questo punto che si fonda la debolezza
dell’etica laica: essa rimane estrememente individualista, e propone una nozione
dell’etica che, fondandosi in prima istanza sull’autonomia, tralascia del tutto l’aspetto
comunitario dell’agire morale. In questo senso l’etica cattolica della lex naturae risulta
meno deficitaria, ma parimenti inefficace, nel momento in cui da un lato individua il
deposito di quella lex universalmente nel cuore di ogni uomo (secondo il testo paolino
della Lettera ai Romani
Romani), ma dall’altro vincola la sua interpretazione e comprensione al
dettato (che in certa misura risulta deresponsabilizzante) dell’autorità magisteriale.
Per tornare al nostro esempio, dal punto di vista delle categorie dell’antropologia
filosofica moderna, esperimenti sull’embrione sono possibili, certamente, ma non
risultano eticamente neutri. Sono possibili in quanto rappresentano un progresso
culturale dell’umanità stessa (nel senso della plasmazione di un mondo umano), ma
trovano il proprio limite nel fatto che hanno sempre un carattere sacrificale. Chi li
organizza si trova a doverne rispondere all’umanità, non solo presente, ma anche futura,
nel momento in cui arrischia operazioni sull’uomo che generano delle conseguenze
sia nel presente sia nell’avvenire, indipendentemente dai risultati, semplicemente in
quanto precedenti che gettano un ponte tra l’astrattezza progettuale della teoria e la
realizzazione della pratica30. Solo questa concezione, credo, è in grado di alleviare quella
«solitudine etica»31 che spesso viene confusa col principio di autonomia. Autonomia
infatti non può, in senso laico, significare semplice autoreferenzialità, ovvero «libertà
da vincoli» (pur se nel rispetto della libertà altrui); da parte cattolica, l’autonomia
pensata all’interno della lex naturae, che si pretende immutabile, è d’altronde frutto
dell’incontro tardo-antico tra cristianesimo ed etica stoica e non può pretendere di avere
alcun valore universale ed eterno – per non dire dei problemi, sopra citati, generati alla
coscienza autonoma dalla interpretazione autoritativa di quella legge. Autonomia può
significare solamente libertà di scelta nel rispetto della giustizia verso l’umanità, i cui
componenti vanno intesi come enti necessitati sempre a dover rinegoziare la propria
esistenza, come enti eternamente insoddisfatti e di là da venire, a cui mal si addice ogni
fissità culturale.
Gli uomini, seguendo l’antropologia filosofica moderna, si creano «mondi» composti
da costellazioni culturali e valoriali, che risultano però costitutivamente «aperte» e
soggette esse stesse al mutamento. Che l’uomo risulti «eccentrico» nel senso di Plessner,
oppure «aperto al mondo» nel senso di Gehlen, oppure una «bestia cupidissima rerum
novarum» nel senso di Scheler, significa esattamente questo. L’uomo per sopravvivere ha
da essere autonomo, non possiede istinti che lo guidino; nondimeno questa autonomia
non riguarda il singolo, bensì il genere, perché essa risulta vincolata all’eredità fisica e
188
PIANETA GALILEO 2006
spirituale genericamente umana. In questo modo mi pare abbia un senso compiuto
l’essere legge a se stessi, se esso non deve significare un agire puramente arbitrario o una
responsabilità mediata da un’autorità superiore.
5. Conclusioni
Non è questa la sede per esporre una serie di princìpi bioetici a partire dalle categorie
dell’antropologia filosofica. Qui si voleva solamente indicare una strada e un possibile
punto di partenza, che naturalmente potrebbe anche risultare aporetico. Vorrei tuttavia
concludere, a titolo di esemplificazione di quanto detto sinora, esaminando in breve,
attraverso le categorie antropo-filosofiche, un caso di aborto terapeutico operato su un
bimbo sano.
In un ospedale fiorentino una donna ha recentemente deciso di abortire al quinto
mese di gravidanza, perché il feto viene sospettato di una atresia esofagea (interruzione
del tratto esofageo, spesso con confluenza nella trachea); la donna sostiene che questa
supposta malformazione – che al momento dell’aborto è risultato un falso positivo – le
avrebbe procurato un disagio psichico tale da non permetterle di crescere il bambino,
anche se da un punto di vista clinico la sopravvivenza dei nascituri in queste situazioni
è stimata all’80%. Il bambino viene estratto vivo, e si cerca di rianimarlo. Muore dopo
alcuni giorni32.
Da un punto di vista legale, la Legge 194 ha consentito un aborto così tardivo,
rispettando l’autonomia decisionale della madre sulla base di un referto medico e della
sua convinzione (diffusa tra l’altro in molte famiglie) di non poter far fronte a gravi
malformazioni del neonato. Secondo le norme della bioetica laica l’interesse della
madre (un «agente morale» per dirla con Tom Regan33) risulta superiore a quello del
bambino (un «paziente morale»). Secondo la visione cattolica, invece, quella vita, in
quanto dono di Dio, pur se malformata, possiede un valore che nessuna istanza della
madre può ledere o sopprimere.
A mio modo di vedere questo caso risulta emblematico nel senso della «solitudine
etica». La capacità decisionale della madre si volge qui su un terreno che le risulta
completamente inesplorato: quello della possibilità teorica di allevare un figlio con
possibili malformazioni. La sua decisione si può basare solo su quello che conosce in
base ad analisi strumentali sul feto e alla previsione di quali potrebbero essere le sue
proprie reazioni di fronte alla nascita di un figlio malato.
Entrambe queste basi sono tuttavia solo probabilistiche e non decisive. Se la donna
non è religiosa, certamente non può esserle d’aiuto nemmeno la considerazione cattolica
della sacralità derivata del feto. Tuttavia lei non potrà dubitare per un momento che suo
figlio appartenga al genere umano, geneticamente e anche culturalmente e socialmente,
in quanto la sua nascita è attesa e preparata da un contesto sociale determinato. Questo
contesto fa già di quell’esistenza fetale un bios34, una vita vissuta e irripetibile calata in
un mondo che si stava preparando ad accoglierla. A cosa rinuncia, quindi, rinunciando
a dare alla luce quella vita? Semplicemente a probabili sofferenza future? Ad un paziente
QUESTIONI DI BIOETICA, SCIENZA E ANTROPOLOGIA FILOSOFICA
189
morale, o ad uno zoe che non avrà (probabilmente mai) la possibilità di condurre
innanzi un bios?
In realtà in questo caso (ed è un’altra delle grandi questioni bioetiche) la certezza
della morte del feto abortito viene barattata con la probabilità della sua malformazione
e la probabilità di un futuro disagio della madre. Questo baratto non solo impedisce
lo sviluppo futuro di una vita biografica, ma interrompe uno svolgimento già presente.
Infatti avere una vita significa, a partire dal corpo fisico, (a) costituire, in tutto l’arco del
processo ontogenetico, una corporalità propria, che è intima, irripetibile sin dal principio
e (b) che risulta in ogni momento trascendente la situazione data semplicemente fisicopsicologica. È in base a tale situazione che in realtà non possiamo mai decidere chi è
persona e chi non lo è, essendo questa una realtà intima propria della consapevolezza
di ogni uomo.
Le decisioni che dovranno essere prese in ambito biomedico si devono porre a
partire dalla consapevolezza che nessun quadro teorico (metafisico o meno) è in grado
di deresponsabilizzarci di fronte alle nostre azioni sull’uomo, né alcuna consierazione
algometrica sugli embrioni o i feti, né alcuna autorità magisteriale. A quelle azioni si
deve certamente procedere (non è pensabile il porre limiti apriori all’avanzare culturalescientifico dell’umanità), ma dobbiamo sempre esser pronti a risponderne dinanzi al
consessus hominum. La decisione della donna e del personale sanitario, se è legittima
da un punto di vista legale ed esistenziale, proprio perché pare aver trascurato questa
responsabilità mi sembra estremamente indigente e non può essere approvata.
La complessità del composto umano, complessità biologica, culturale e sociale
insieme, deve educare ad un maggior star-di-fronte al genere umano. Questo star-difronte significa svincolamento dalla logica puramente individuale delle preferenze e
disponibilità a far proprie empaticamente le prospettive del consessus hominum, in cui
anche le proprie prospettive si inquadrano. È questo a mio modo di vedere un vincolo
capace insieme di spezzare la «solitudine etica» e di risultare condivisibile. Esso potrebbe
contribuire anche a fondare un’antropologia
antropologia medica che consideri il corpo dell’uomo ed
i suoi stati (la malattia, la salute, la morte) come parte concreta e irrinunciabile della
vita che ognuno conduce. Guarire, così, non significherebbe semplicemente, per il
medico ed il paziente, ristabilire uno status quo ante, riparare una macchina guasta, ma
aver fatto un passo avanti nel divenire di sé dell’uomo (Menschwerdung,
Menschwerdung, per adoperare
Menschwerdung
una categoria scheleriana); ammalarsi, di converso, non sarebbe mai solo inceppamento
e guasto, ma processo dell’esser vivi. Ciò che recentemente si sta cercando di proporre,
ovvero una medicina narrativa che implementi la medicina basata sull’evidenza dei
protocolli sperimentali, funzionerà solo se in quella narrazione vi sarà, da parte dei
parlanti (personale sanitario, pazienti e congiunti), consapevolezza e responsabilità
– dinanzi al consessus hominum – di fronte al valore precipuamente e complessamente
umano di ogni vita35.
190
PIANETA GALILEO 2006
NOTE
1
Cfr. [21].
Si veda su questo ad esempio [14] alla voce «giustizia sanitaria», pp. 146-149. Anche laddove
la bioetica assegna un ruolo alla categoria di giustizia, com’è il caso del «principialismo» di
Beauchamp e Childress, questa si configura sempre come rispetto delle «norme che stabiliscono di
distribuire equamente benefici, rischi e costi»; cfr. [1] p. 48. È senz’altro vero che il principialismo
ha il pregio di ammettere il consensus omnium o maiorum come base per una ridiscussione dei
princìpi, ammettendo cioè la rinegoziabilità dei valori in sede comunitaria; nondimeno questa
rinegoziaziazione possiede un carattere utilitaristico che ha rappresentato e rappresenta tutt’ora
il maggior punto critico del presunto universalismo dei «quattro princìpi».
2
3
Cfr. [20] pp. 1381-1387.
4
Cfr. soprattutto la teoria del gene autoreferenziale o «egoista» esposta in [4].
Lecaldano, nel suo Dizionario di bioetica, non fornisce una definizione generale di vita, ma
si limita a elencarne le varie tematizzazioni, affermando infine che «sembra più corretto...
considerare la nozione di vita come una nozione artificiale (o convenzionale) cui facciamo
riferimento per distinguere fenomeni diversi della natura. In questi termini, i criteri esistenti
tra esseri viventi e non viventi non potranno essere considerati oggettivi». Lecaldano fa poi
appropriatamente notare che il semplice descrivere una realtà come vivente «non sembra essere
sufficiente per attribuirle rilevanza morale»; si deve infatti ancora chiedersi se, data la nozione
di vita che incorpora talune caratteristiche, esse, come dice Lecaldano, «siano rilevanti da un
punto di vista morale»; cfr. [14] p. 327-328.
5
È del tutto significativo che nei maggiori dizionari di bioetica non vi sia traccia di una voce
«uomo», così come di «soggetto», che pure vengono usati con profusione (diverso invece il
caso di «persona» o «identità personale», che talora risultano presenti, ma la cui applicazione è
eccessivamente ampia, coinvolgendo anche il mondo animale, oppure è unilaterale, nel senso
che considera come determinante per la «persona» la sola razionalità o la sola capacità morale
o un assunto metafisico; cfr. [14] pp. 152-153 e 219-221). Anche laddove siano presenti voci
antropologiche, queste per lo più si riferiscono all’antropologia medica. È proprio a livello
fondazionale-definitorio che l’apporto dell’antropologia filosofica appare rilevante in bioetica,
evitando monismi e mostrando la complessità del campo d’indagine.
6
Questa attitudine olistica cerca di considerare come un tutto la dimensione fisica e quella
spirituale dell’uomo, la physis in modo complementare allo pneuma ed alla psyche. Essa,
problematizzando il tradizionale dualismo filosofico di mente-corpo, di anima e spirito non
diviene una filosofia della mente, non tende ad occuparsi in modo sistematico dei rapporti
mente-corpo o, meglio, mente-cervello per poter risolvere in qualche modo quel dualismo.
Piuttosto essa lo considera un dato costitutivo dell’uomo riscontrabile nell’analisi empirica, e
lascia ad altre discipline di indagarne le questioni specifiche.
7
Cfr. [15], p. 269 in cui Claude Lévi-Strauss afferma: «Il fine ultimo delle scienze umane non
consiste nel costituire l’uomo, ma nel dissolverlo». Solo in un senso ben preciso il processo
di dissoluzione dell’uomo coincide con quello di dissoluzione della nozione di «soggetto»,
dissoluzione che ha trovato nell’archeologia antropologica di Michel Foucault il punto terminale
di un lungo processo; cfr. [6], p. 414. Il senso è quello secondo cui la nozione di «soggetto»
8
QUESTIONI DI BIOETICA, SCIENZA E ANTROPOLOGIA FILOSOFICA
191
risulta segnatamente moderna, per cui è corretto parlare soltanto di una dissoluzione dell’uomo
moderno e non dell’uomo tout court.
Chi si avvicina oggi alle scienze dell’uomo si imbatte in prima istanza nel concetto di
complessità. La teoria della complessità, la cui origine rimonta innanzitutto all’omologo
termine usato in logica computazionale, in termodinamica e in biologia, concepisce l’uomo
come composto da svariate istanze, da molteplici «mondi», che stanno tra loro in un rapporto
reciproco non lineare. Ma questa complessità non può venire intesa come disgregazione, come
frammentazione dell’uomo nei suoi molti composti, perché in questo caso la somma delle
parti non sarebbe mai capace di rendere l’intero. La caratteristica, invece, dell’antropologia
filosofica moderna è quella di assumere in toto tale complessità attingendo il proprio materiale
d’analisi dalle scienze empiriche e cercando poi di ricondurlo ad un’unità complessa attraverso
gli strumenti del ragionamento filosofico; essa è, per dirla con Habermas, «un’interpretazione
filosofica dei risultati scientifici» nell’ambito delle scienze umane; cfr [12] p. 20; cfr. inoltre
anche [27] p. 257.
9
In questo senso non fa eccezione nemmeno l’antropologia nietzscheana, che vede negli stati
corporei di malattia e salute la precondizione per lo sviluppo dell’essenza diveniente dell’uomo.
Molto presto infatti questi stati fisici assumono in lui una connotazione esplicitamente moraleassiologica, che tende ad ipostatizzarli e a fissarli in un ambito extra-fisico. La malattia diviene
décadence e la salute «grande salute» necessaria per la trasvalutazione di tutti i valori.
10
Per una panoramica delle correnti contemporanee dell’antropologia filosofica si può vedere
[17], in particolare le pp. 3-29.
11
12
Cfr. [10]
13
Cfr. [9], p. 88: «’Uomini allo stato di natura’, ossia privi di cultura, non esistono affatto».
Cfr. [9] p. 98; sulla categoria dell’«esonero» in Gehlen cfr. [10] p. 89 ss. Eugenio Mazzarella,
nella sua Prefazione a [9] lamenta una prevalenza, nel pensiero gehleniano, della Welt sulla
Umwelt, al punto tale che quest’ultima risulterebbe quasi trascurata. È certo che all’interno
Umwelt
della teoria gehleniana dell’azione il sostrato puramente biologico dell’agire umano risulta non
indagabile nel suo specifico apporto alle funzioni superiori, ma deve sempre venir mediato
dalla sfera culturale. Ciò che rappresenta il punto di forza della specie umana ne costituisce
anche il limite: nell’indagine su se stesso l’uomo non è in grado di scorgere alcun elemento della
Umwelt se non all’interno della Welt. Dunque vi è comunque una «indicibilità» del fondamento
puramente aculturale dell’umano, in quanto il linguaggio, con cui l’uomo costruisce la cultura,
non può mai andare oltre se stesso. Cfr. [ix] p. 49; sul linguaggio cfr. l’intera parte seconda
di [10], e in particolare le «radici» del linguaggio pp. 229-270. La trascuratezza da parte di
Gehlen dell’apporto della Umwelt all’uomo sarà oggetto anche della critica di Plessner sotto
menzionata.
14
15
Cfr. [7] pp. 507-508
16
Cfr. [9] p. 134.
Soprattutto Gehlen si riferisce al volume di Herder Abhandlung über den Ursprung der Sprache
(cfr. [9] p. 88 in nota), e alla definizione qui contenuta dell’uomo come essere che è «compito
a se stesso»; cfr. [10] p. 59.
17
18
Cfr. [17].
192
19
Cfr. [10] pp. 299-300.
20
Cfr. [17] p. 15.
PIANETA GALILEO 2006
Cfr. [17] pp. 312-368. In generale Plessner tende a considerare poco efficace la teoria dell’azione
gehleniana, che si configura in primo luogo come «attività indirizzata alla modificazione della
natura in vista degli scopi dell’uomo»; cfr. [11], p. 33; essa si baserebbe infatti totalmente sullo
«iato» tra pulsioni e azione da esse determinata (lo iato generatore della coscienza), sul ruolo
dominante del linguaggio e sul suo «esonero» dall’azione immediata, e con ciò trascurerebbe
quei caratteri che l’uomo si porta dietro come grado speciale dell’organico: «Una concezione
del tipo umano d’esistenza come evento naturale e prodotto della sua storia la si acquisisce con
la sua contrapposizione ad altri e noti tipi d’esistenza della natura vivente. Perciò è necessario
un filo conduttore, che ho individuato nel concetto di posizionalità, un carattere fondamentale,
credo, attraverso il quale si distingue la forma animata da quella inanimata»; cfr. [17] p. 20.
La rilevanza del dato naturale, fisico-psichico, ottiene la sua centralità nella terminologia
plessneriana, che descrive rispettivamente il mondo esterno e interno dell’uomo come «corpo»
e «corporalità»; cfr. [17] p. 318. Vedi anche [24] p. 63.
21
Cfr. [17] pp. 314-315. «Come essere organizzato eccentricamente, l’uomo deve anzitutto
rendersi ciò che già è... L’uomo vive solo nella misura in cui conduce una vita»; cfr. [17] p.
333.
22
23
Cfr. [28] p. 159.
Scheler tenta così di proporre «un nuovo tipo di personalismo»; cfr. [26] p. 8. In questo
personalismo la categoria di «uomo» non coincide con quella di «persona», in quanto si danno
uomini (bambini, dementi) che non sono persone, poiché incapaci di atti intenzionali; al
contrario non è mai possibile per lui che si dia una persona non umana, in quanto solo l’uomo
risulta soggetto di atti intenzionali; cfr. [26] p. 481.
24
Cfr. [22]; per un’analisi sulla trattazione del corpo dell’uomo all’interno della storia della
filosofia occidentale cfr. [8].
25
Su tale personalismo si possono confrontare i lavori di Elio Sgreccia, ed in particolare [29]
alle pp. 60-63 La più diffusa interpretazione del corpo in ambito di bioetica cattolica è quella
aristotelico-tomista, secondo cui la materia deve risultare «predisposta» e quindi determinata
a ricevere l’anima. L’anima è così «unita sostanzialmente al corpo». In questo senso la
determinazione della materia umana costituisce già parte integrante del «composto» personale
e ne riceve così dignità. Senza dubbio questa interpretazione si avvicina in molti punti alla
visione antropo-filosofica moderna, ma se ne distanzia per un aspetto essenziale: il valore del
corpo risiede nell’essere ordinato a qualcosa di più elevato; al corpo quindi non è consentito
affezionarsi troppo, ed è lecito in taluni casi rinunciarvi in nome di un’istanza sovraordinata
(ciò che si definisce come indisponibilità condizionata della vita). Nel motto scolastico operari
corporis sequitur esse animae spiritualis si compendia efficacemente la natura della relazione
tomistica corpo-anima. Questa concezione rispecchia del tutto la duplice tendenza, mai
composta e incomponibile, presente nell’etica cristiana, della laus corporis e del contemptus
corporis. Cfr. [29] pp. 105-130.
26
Sulla concezione di individuo e dignità indviduale assegnata all’embrione cfr. quanto Vittorio
Possenti sostiene in [19].
27
28
Ciò sia detto contro l’antispecismo dichiarato di molte importanti correnti bioetiche, che
QUESTIONI DI BIOETICA, SCIENZA E ANTROPOLOGIA FILOSOFICA
193
o equiparano («verso il basso») l’uomo agli animali, oppure, all’inverso, equiparano («verso
l’alto») gli animali all’uomo. Per bioeticisti quali Peter Singer, John Rachels, Tom Reagan
e anche Tristram Engelhardt la specie uomo è sicuramente qualcosa di antiquato ed essi in
effetti la ripudiano oppure la riducono a pure definizioni inessenziali, quali appunto la capacità
di autonomia morale. Cosa significa infatti possedere una possibilità etica di scelta se non è
possibile basare questa scleta in modo più ampio rispetto alle preferenze individuali? Che senso
ha qui usare il concetto di nomos (auto-nomia)? Possiamo essere veramente legislatori di noi
stessi, quando né le condizioni materiali, né quelle culturali della nostra esistenza dipendono
dalla nostra capacità decisionale, ma risultano vincolate ad una sfera più ampia, quella
dell’umanità? Senza questa consapevolezza non rimane in realtà che l’individualismo etico e
l’estraneità morale. Porsi all’interno della sfera umana significa invece agire autonomamente
nel vincolo della libertà.
Il diritto romano stesso, nella riordinazione giustinianea (Digesta, Libro I, titolo V), si occupa
di tutelare i diritti del nascituro in quanto uomo, ovvero in quanto appartenente alla società
degli uomini e in particolare alla res publica, come si stabilisce nel XXXVII libro dei Digesta,
titolo IX § 15: «partui enim in hoc favetur, ut in lucem pro ducatur; puero ut in familiam
inducatur; partus enim iste alendus est, qui [et] si non tantum parenti, cuius esse dicitur, verum
etiam Reipublicae nascitur»; cfr. [2], pp. 167ss e 196ss. Vedo nell’appartenenza comunitaria e
statale di ogni uomo una delle patenti difficoltà di far approvare leggi sull’eutanasia attiva; esse
lederebbero il diritto statale di tutela dei propri cittadini.
29
30
Cfr. le considerazioni portate avanti da Habermas in [13].
Non posso chiamare in altro modo la concezione di «estraneità morale» presentata da
Engelhardt e perfettamente coerente con la prevalente visione individualistica dell’etica, la quale
pretende di fondare una comunione morale semplicemente su principi razionali di carattere
contrattualistico e procedurale. Cfr. [5] p. 59.
31
32
Cfr. [3] e [16].
33
Cfr. [25] pp. 140, 214-216.
Adopero qui la distinzione di James Rachels tra zoe e bios, ovvero tra vita biologica e vita
biografica. Egli sostiene che ogni essere vivente non solo è una vita, ma ha una vita, e questa è
fatta di progetti, aspirazioni, relazioni sociali. Da parte mia, tuttavia, desidero sottolineare da un
lato il carattere sociale e non solo individuale-esistenziale del «condurre una vita», e dall’altro il
fatto che zoe e bios non rappresentano un dualismo, ma si compenetrano essenzialmente, talché
non è corretto dire, con Rachels, che «uccidere non implica la distruzione di una vita» nel caso
di persone «in coma irreversibile» o di bambini con «malformazioni tali da impedire loro uno
sviluppo adeguato»; sulla base di questo argomento Rachels legittima l’eutanasia. Cfr. [23] p.
11. Lo zoe è già il bios e il bios è sempre zoe.
34
Cfr. le considerazioni svolte in [30]. In questo volume si esprime fortemente l’esigenza
di de-oggettivizzare la medicina, affinché sia possibile curare il malato e non la malattia, e
affinché il personale sanitario riesca in questo modo non semplicemente a guarire, ma anche a
«prendersi cura». L’intenzione della «medicina narrativa» presuppone tuttavia un’antropologia
profondamente «umana» nel senso che qui si è cercato di riproporre.
35
194
PIANETA GALILEO 2006
BIBLIOGRAFIA
[1] Beauchamp T. L. - Childress J. F., Princìpi di etica biomedica, Le Lettere, Firenze
1999.
[2] Catalano P., Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sisetma romano, I,
Giappichelli, Torino 1990.
[3] Cavadini F., Bambino vivo dopo l’ aborto. Scontro sulla diagnosi sbagliata, in
Corriere della Sera, 8/03/07, pp. 22-23.
[4] Dawkins R., Il gene egoista: la parte immortale di ogni essere vivente, Mondadori,
Milano 1995
[5] Engelhardt H. T., Manuale di bioetica, Il Saggiatore, Milano 19902.
[6] Foucault M., Le parole e le cose, Rizzoli, Milano 1967.
[7] Gadamer H. G., Verità e metodo, Fabbri, Milano, 1972.
[8] Galimberti U., Il corpo, Feltrinelli, Milano, 1997
[9] Gehlen A., Antropologia filosofica e teoria dell’azione, Guida, Napoli 1990.
[10] Gehlen A., L’uomo, la sua natura e il suo posto nel mondo, Feltrinelli, Milano
1990.
[11] Gehlen A., Prospettive antropologiche, Il Mulino, Bologna, 2005.
[12] Habermas J., Antropologia, in AAVV, Filosofia, Feltrinelli, Milano 1966.
[13] Habermas J., Il futuro della natura umana: i rischi di una genetica liberale, Einaudi,
Torino 2002
[14] Lecaldano E., Dizionario di bioetica, Laterza, Roma-Bari 2002.
[15] Lévi-Strauss C., Il pensiero selvaggio, Il Saggiatore, Milano 1970.
[16] Marrone C., Morto il bimbo sopravvissuto all’aborto. Aperta un’ inchiesta, è
scontro politico, in Corriere della Sera, 9/03/07, pp. 22-23.
[17] Pansera M. T., Antropologia filosofica. La peculiarità dell’umano in Scheler, Gehlen e
Plessner, Mondadori, Milano, 2001
[18] Plessner H., I gradi dell’organico e l’uomo, Bollati Boringhieri, Torino 2006.
[19] Possenti V., Individuo umano e persona, in www.portaledibioetica.it.
[20] Post G. (a cura di), Encyclopedia of Bioethics, 5 voll., MacMillan Reference Books,
New York 20033.
[21] Potter, V. R., Bioethics: The science of survival, in Perspectives in Biology and
Medicine, 1970, 14(1), pp. 127-153.
[22] Prini P., Il corpo che siamo. Introduzione all’antropologia etica, SEI, Torino 1991.
[23] Rachels J., La fine della vita. La moralità dell’eutanasia, Sonda, Torino 1989.
[24] Rasini V., Filosofia della natura e antropologia nel pensiero di Helmut Plessner, in
Annali del Dipartimento di Filosofia, Università di Firenze, 1995, vol. 1, pp. 59-77.
[25] Regan T., I diritti animali, Feltrinelli, Milano 1990.
[26] Scheler M., Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori, S. Paolo, Milano
1996.
[27] Scheler M., Uomo e storia, in Id, Lo spirito del capitalismo e altri saggi, Guida,
QUESTIONI DI BIOETICA, SCIENZA E ANTROPOLOGIA FILOSOFICA
195
Napoli 1988.
[28] Scheler M., La posizione dell’uomo nel cosmo e altri saggi, Fabbri, Milano, 1970.
[29] Sgreccia E., Manuale di bioetica, Vita e Pensiero, Milano 2003.
[30] Spinsanti S. (a cura di), Bioetica e antropologia medica, La nuova Italia scientifica,
Roma 1991.