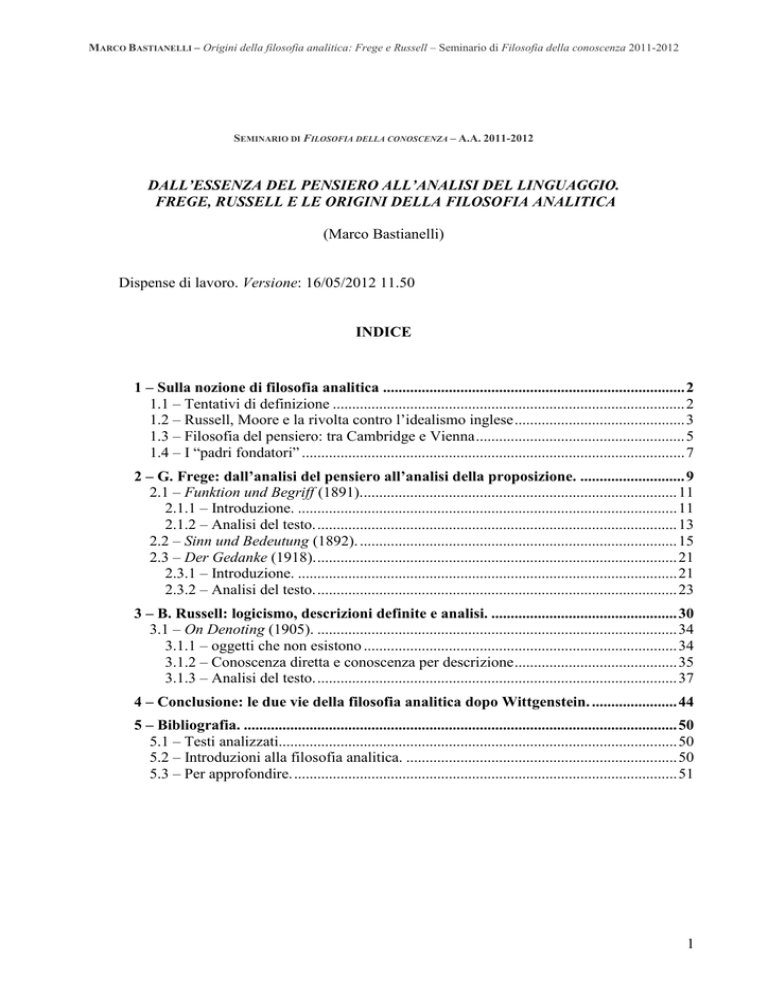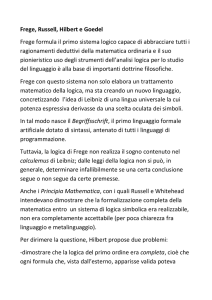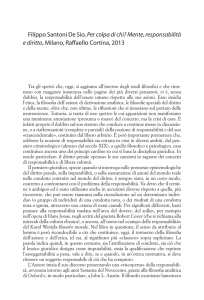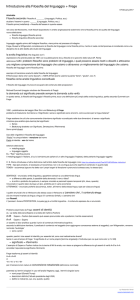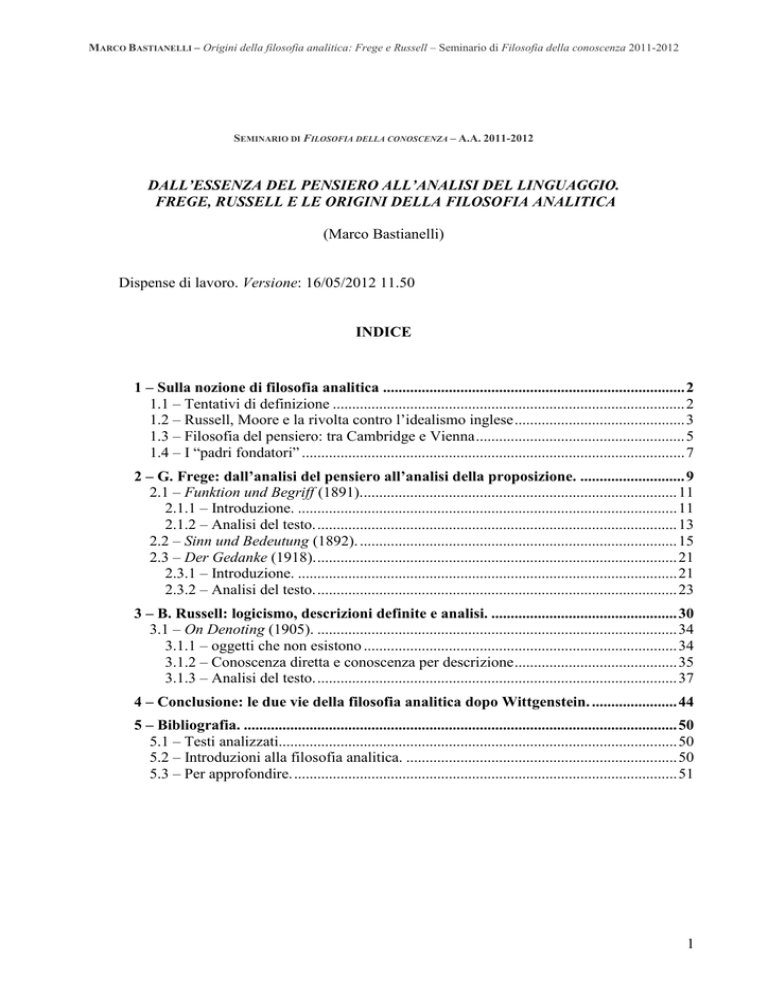
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
SEMINARIO DI FILOSOFIA DELLA CONOSCENZA – A.A. 2011-2012
DALL’ESSENZA DEL PENSIERO ALL’ANALISI DEL LINGUAGGIO.
FREGE, RUSSELL E LE ORIGINI DELLA FILOSOFIA ANALITICA
(Marco Bastianelli)
Dispense di lavoro. Versione: 16/05/2012 11.50
INDICE
1 – Sulla nozione di filosofia analitica .............................................................................. 2
1.1 – Tentativi di definizione ........................................................................................... 2
1.2 – Russell, Moore e la rivolta contro l’idealismo inglese ............................................ 3
1.3 – Filosofia del pensiero: tra Cambridge e Vienna ...................................................... 5
1.4 – I “padri fondatori” ................................................................................................... 7
2 – G. Frege: dall’analisi del pensiero all’analisi della proposizione. ........................... 9
2.1 – Funktion und Begriff (1891).................................................................................. 11
2.1.1 – Introduzione. .................................................................................................. 11
2.1.2 – Analisi del testo. ............................................................................................. 13
2.2 – Sinn und Bedeutung (1892). .................................................................................. 15
2.3 – Der Gedanke (1918). ............................................................................................. 21
2.3.1 – Introduzione. .................................................................................................. 21
2.3.2 – Analisi del testo. ............................................................................................. 23
3 – B. Russell: logicismo, descrizioni definite e analisi. ................................................ 30
3.1 – On Denoting (1905). ............................................................................................. 34
3.1.1 – oggetti che non esistono ................................................................................. 34
3.1.2 – Conoscenza diretta e conoscenza per descrizione .......................................... 35
3.1.3 – Analisi del testo. ............................................................................................. 37
4 – Conclusione: le due vie della filosofia analitica dopo Wittgenstein. ...................... 44
5 – Bibliografia. ................................................................................................................ 50
5.1 – Testi analizzati....................................................................................................... 50
5.2 – Introduzioni alla filosofia analitica. ...................................................................... 50
5.3 – Per approfondire. ................................................................................................... 51
1
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
1 – SULLA NOZIONE DI FILOSOFIA ANALITICA
1.1 – Tentativi di definizione
Sebbene l’espressione “filosofia analitica” sembri connotare un movimento unitario e ben
definito, in realtà comprende autori e indirizzi di pensiero spesso tra loro notevolmente eterogenei.
Tale eterogeneità non vale soltanto per gli sviluppi più recenti, ma anche quando si pone la questione di rintracciarne le origini. A proposito di queste ultime, però, la critica appare piuttosto concorde
nel ritenere che la filosofia analitica trovi le sue radici, almeno come comun denominatore, nelle
opere di Frege, Moore, Russell e Wittgenstein.
A livello generale, si è cercato di individuare un carattere distintivo di questa tradizione nel
particolare metodo di indagine di cui si serve: l’aggettivo “analitica”, infatti, rimanda all’analisi applicata al linguaggio, metodo che viene impiegato per affrontare i problemi filosofici tradizionali,
sulla scorta dell’impostazione fornita dagli autori sopra richiamati1.
Con la filosofia analitica, in altre parole, all’analisi è attribuito uno statuto specifico, perché
viene interpretata, almeno inizialmente sul modello delle discipline logico-scientifiche, come un
metodo che permette di chiarire la natura e il funzionamento del pensiero attraverso l’indagine sulla
forma logica del linguaggio con cui esso si esprime. Per questo carattere linguistico, l’espressione
“filosofia analitica” è stata per molto tempo utilizzata come sinonimo di “filosofia del linguaggio”,
sebbene risulti non sempre sufficientemente chiaro se tra le due denominazioni vi sia effettivamente
una tale coincidenza. Ad ogni modo, l’attenzione al linguaggio, sia esso ideale o quotidiano, costituisce uno dei principali caratteri distintivi dell’analisi filosofica come è stata a lungo esercitata soprattutto nei Paesi di lingua anglosassone, oltre che in Scandinavia, Olanda e Polonia2.
In termini generali, secondo F. D’Agostini, per definire la filosofia analitica si può ricorrere
a quattro criteri: «a) storico, ossia facendo riferimento ad autori e scuole; b) filosofico, in base ad
assunzioni fondamentali o premesse metodologiche, epistemologiche, ontologiche considerate caratterizzanti; c) stilistico, in base allo stile di scrittura e di discorso, o alle modalità di costruzione e
sviluppo degli argomenti; d) metafilosofico, in base alla concezione della filosofia, dei suoi compiti
e della sua collocazione nel quadro dei saperi»3.
Per un’introduzione alle origini della filosofia analitica, può risultare sufficiente soffermarsi
soltanto sui primi due criteri. Ciò non significa che gli altri non siano importanti; al contrario, è indubbio che, come sostiene D’Agostini, il terzo criterio si possa ritenere come «decisivo» per distinguere la tradizione analitica dalle altre correnti della filosofia contemporanea 4. Tuttavia, esso sembra più adatto a definire la tradizione successiva almeno agli anni Trenta, quando tale stile trova
progressivamente un’applicazione diffusa e consapevole, in parte col Neopositivismo logico, ma
specificamente con la cosiddetta Oxford-Cambridge Philosophy, o filosofia del linguaggio ordinario.
1
A testimonianza del fatto che si tratta soltanto del tentativo di reperire un denominatore comune, occorre osservare che
al metodo di analisi già erano ricorsi, alla fine del XIX secolo, sulla scia del rinnovamento delle discipline logiche e del
successo delle nuove teorie scientifiche, indirizzi di pensiero come il neokantismo e la fenomenologia. Secondo H.-J.
Glock, inoltre, è possibile ricostruire la storia e le applicazioni del termine analisi già a partire dall’antica Grecia, con la
distinzione tra una nozione «progressiva» di analisi, che si può far derivare da Socrate e Platone, ed una «regressiva» di
origini aristoteliche. Nel primo senso, l’analisi è rivolta a scomporre i concetti complessi in concetti più semplici, mentre nel secondo si applica alle proposizioni e ne ricerca «i principi primi», da cui esse possono essere derivate come teoremi (cfr. H.-J. GLOCK, What is Analytic Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 2008, pp. 21-26).
2
A. PAGNINI, Filosofia analitica, in P. ROSSI (a cura di), La filosofia, UTET, Torino, 1995, vol. 4, p. 148.
3
F. D’AGOSTINI, Che cos’è la filosofia analitica?, in F. D’AGOSTINI-N. VASSALLO (a cura di), Storia della filosofia analitica, Einaudi, Torino 2002, p. 3.
4
Ibid., p. 4. Lo stile analitico, secondo D’Agostini, si caratterizza per una «propensione per testi brevi, che affrontano
questioni dettagliate, si addentrano in distinzioni sottili, e spesso usano linguaggi “disciplinati”, schemi, formalismi» (F.
D’AGOSTINI, Analitici e continentali. Guida alla filosofia degli ultimi trent’anni, Raffaello Cortina, Milano 1997, pp.
205-206).
2
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
Se si cercano dunque le radici da cui la corrente analitica si sviluppa e da cui trae alimento, è
bene muovere innanzitutto dai problemi affrontati e dalle questioni metodologiche. A tale proposito,
P.M.S Hacker ritiene che la filosofia analitica abbia «una duplice radice a Cambridge, alla svolta
del secolo, nell’opera di G.E. Moore e Bertrand Russell»5. Questa tesi, che si può ritenere quella
tradizionale, è stata esposta tra i primi da J. Urmson, per il quale lo sfondo storico su cui sorge
l’analisi del linguaggio va individuato nell’atomismo logico di Russell e nella filosofia di Moore,
che egli considera «i cofondatori del movimento analitico»6. Ritiene, tuttavia, che tale contributo si
limiti alla prima fase della filosofia analitica, giacché è fondamentale il momento di passaggio in
cui, sotto i colpi di critiche interne e del Neopositivismo viennese, la metafisica dell’atomismo logico fu rigettata come fondamento dell’analisi e sostituita da un metodo imperniato sulla chiarificazione del linguaggio della scienza7.
1.2 – Russell, Moore e la rivolta contro l’idealismo inglese
Secondo l’impostazione tradizionale, dunque, il contributo di Russell e Moore consiste principalmente nell’aver condotto una critica alle correnti di derivazione idealistica che, nell’Università
di Cambridge, erano sostenute principalmente da F.H. Bradley. Russell e Moore, in particolare, sotto la guida di J.M.E. McTaggart, studiarono il testo di Bradley Appearance and Reality, pubblicato
nel 18938, che costituiva la più autorevole esposizione delle dottrine idealiste in Inghilterra. Per
qualche tempo, in effetti, furono entrambi idealisti finché, verso la fine del 1898, entrambi si ribellarono: Moore, come ricorda Russell nella sua autobiografia, «si mise alla testa della ribellione, ed
io lo seguii, con un senso di liberazione. Bradley sosteneva che tutto ciò che il senso comune crede
è mera apparenza; noi ci volgemmo all’estremo opposto, e pensammo essere reale tutto ciò che il
senso comune, quando non è influenzato dalla filosofia o dalla teologia, ritiene reale. Con la sensazione di evadere da una prigione, ci permettemmo di credere che l’erba è verde, che il sole e le stelle esisterebbero anche se nessuno li percepisse, ed anche che c’è un mondo pluralistico senza tempo
di idee platoniche»9.
È necessario precisare, dunque, che in questo contesto il termine idealismo non è usato in riferimento alla filosofia hegeliana, bensì all’impostazione filosofica di Bradley che, secondo
un’interpretazione soggettivistica e spiritualistica, rimandava piuttosto all’empirismo di Berkeley.
Ciò è evidente, ad esempio, nel saggio The Refutation of Idealism, in cui Moore esordisce definendo
«l’idealismo moderno» come la concezione che, «se pure asserisce una qualche conclusione generale intorno all’universo, asserisce che questo è spirituale»10.
Ora, Moore non si propone di confutare questa tesi, perché a suo avviso potrebbe anche essere vera e, confessa, «sinceramente lo spero»11. Ritiene invece che le argomentazioni utilizzate per
dimostrarla siano fallaci e, in particolare, lo è quella che parte dalla proposizione, che è «essenziale
all’idealismo», secondo cui «esse è percipi»12. In base a quest’ultima premessa, infatti, «di tutto ciò
di cui si può con verità predicare l’esse» si può «con verità predicare il percipi» e ciò equivale a di-
5
P.M.S. HACKER, The Rise of Twentieth Century Analytic Philosophy, in H.-J. GLOCK (ed.), The Rise of Analytic Philosophy, Blackwell, Oxford-Malden 1997, p. 57.
6
J. URMSON, Philosophical Analysis: Its Development Between the Two World Wars, Clarendon Press, Oxford 1956; tr.
it. di L.M. Leone, L’analisi filosofica. Origini e sviluppi della filosofia analitica, Mursia, Milano 1966, p. 17.
7
Cfr. ibid., pp. 142-143.
8
Tr. it. di D. Sacchi, Apparenza e realtà, Rusconi, Milano 1999.
9
B. RUSSELL, My Mental Development, Allen & Unwin, London 1959, pp. 42, 62; tr. it. di L. Pavolini, La mia vita in
Filosofia, Longanesi, Milano 1961.
10
G.E. MOORE, The Refutation of Idealism, in «Mind», 12(1903); tr. it. La confutazione dell’idealismo, in ID., Studi filosofici, a cura di G. Preti, Laterza, Bari 1971, p. 43.
11
Ibid., p. 45.
12
Ibid., p. 47.
3
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
re «che tutto ciò che è, è oggetto di esperienza» e, infine, «che tutto ciò che è, è un oggetto mentale»13.
Questo principio viene utilizzato dagli idealisti per affermare che, siccome ci sono cose che,
pur esistendo, non sono esperite da noi, allora devono essere percepite da un soggetto a noi superiore; in particolare, «poiché il mondo nella sua totalità deve essere un oggetto, dobbiamo pensare che
esso appartenga a un soggetto», a uno spirito affine al nostro. Insomma, secondo gli idealisti, «ogni
volta che si tenti di asserire una cosa qualunque di ciò che è parte di un intero organico, ciò che si
asserisce può essere vero solo dell’intero»14. L’idealismo, pertanto, comporta una forma di monismo, per il quale le cose ordinarie sono tra loro essenzialmente collegate, in modo da formare
un’unità organica che, in definitiva, è l’unica realtà veramente esistente. Moore, in particolare, ha
qui in mente la concezione di Bradley, per il quale l’Assoluto è l’unica cosa reale.
Dal punto di vista logico, Moore aveva già scagliato la sua critica al monismo di impostazione idealista nel saggio The Nature of Judgment15. Egli vi discute la tesi di Bradley secondo cui la
verità e la falsità dipendono dalla relazione delle nostre idee con la realtà. Sebbene Bradley intenda
il termine idea non come stato mentale, ma come “significato universale”, tuttavia Moore evidenzia
che, in questo senso, il termine “idea” è «pieno di ambiguità»16 e che, pertanto, è preferibile utilizzare il termine “concetto”, inteso nel senso in cui i tedeschi distinguono Begriff da Vorstellung. Nella posizione di Bradley, afferma Moore, l’ambiguità rimane, perché, il significato universale di cui
egli parla è considerato come un’astrazione da idee, in quanto lo si ottiene eliminando una parte delle nostre idee mentali, la quale diventa una sorta di contenuto separato. In tal modo, però, sebbene il
concetto non sia propriamente considerato come un fatto mentale, tuttavia sembra esserne una parte.
Il giudizio, invece, per Moore non consiste nell’attribuire parti di idee ad altre parti di idee,
perché ciò comporterebbe un regresso all’infinito, una sorta di circolo vizioso già evidenziato nel
classico argomento del terzo uomo. Pertanto, egli afferma, «quando dico “Questa rosa è rossa” non
sto attribuendo parte del contenuto della mia idea alla rosa e nemmeno parti del contenuto delle idee
di rosa e di rosso ad un qualche terzo soggetto»17. Quello che il giudizio asserisce è «una specifica
connessione di certi concetti che formano il concetto complessivo di “rosa” con i concetti di “questo” e “ora” e “rosso”; e il giudizio è vero se questa connessione è esistente»18.
In effetti, un giudizio o, meglio, una proposizione, «non è composta di parole o di pensieri,
ma di concetti» e i concetti sono «possibili oggetti del pensiero», che esistono indipendentemente
da chi li pensa. I concetti non sono parte delle nostre idee, ma esistono già prima che noi emettiamo
i nostri giudizi. Essi, cioè, sono immutabili, «non possono cambiare»19.
Di conseguenza, secondo Moore, «una proposizione non è altro che un concetto complesso».
Questo significa che la verità o la falsità di una proposizione non dipendono dalla sua relazione con
la realtà, bensì dal modo in cui i concetti che la costituiscono sono composti. Una proposizione,
scrive Moore, «è una sintesi di concetti» e «proprio come i concetti sono immutabilmente ciò che
sono, così essi stanno in infinite relazioni immutabili l’uno con l’altro». Pertanto, una proposizione
è composta di concetti in una specifica relazione tra loro e, «secondo la natura di tale relazione, la
proposizione può essere vera o falsa». Tuttavia, egli conclude, «quale tipo di relazione renda una
proposizione vera o falsa, non può essere ulteriormente definito, ma deve essere riconosciuto immediatamente»20.
La teoria del giudizio di Moore sottende l’idea di un’analisi dei contenuti oggettivi del pensiero, le proposizioni, intesi come gli elementi che compongono la realtà. Sulla stessa linea si colloca la posizione di Russell, il quale afferma:
13
Ibid., pp. 47-48.
Ibid., p. 57.
15
G.E. MOORE, The Nature of Judgment, in «Mind», 8(1899), pp. 176-193.
16
Ibid., p. 177.
17
Ibid., p. 179.
18
Ibid.
19
Ibid.
20
Ibid., p. 180.
14
4
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
«La logica che sosterrò è atomistica, in contrapposizione alla logica monistica di coloro che, in un
modo o nell’altro, seguono Hegel. Quando affermo che la mia logica è atomistica, intendo dire che condivido
la convinzione comune che vi siano cose distinte; non penso che la molteplicità apparente del mondo sia costituita semplicemente da fasi e da suddivisioni irreali di una singola Realtà indivisibile. Ne consegue che, per
suffragare il tipo di filosofia che sostengo, bisognerebbe dedicarsi prevalentemente a suffragare il procedimento di analisi. Si dice spesso che il procedimento di analisi è una falsificazione, che analizzando un determinato
processo complesso lo si falsifica, che i risultati dell’analisi sono falsi. Non credo che questo modo di vedere
sia giusto»21.
1.3 – Filosofia del pensiero: tra Cambridge e Vienna
Nella concezione di Moore e Russell, come è evidente, l’interesse principale non è il linguaggio, bensì il pensiero e, se l’analisi logico-filosofica prende come oggetto il linguaggio, lo fa
solo in quanto lo considera l’espressione dei contenuti del pensiero.
Da questo punto di vista, come rileva P. Hacker, le idee sostenute a Cambridge da Moore e
Russell avevano un corrispettivo nell’Europa continentale, e precisamente nelle riflessioni fenomenologiche di Franz Brentano22 e di Alexius von Meinong. In particolare, sostiene Hacker, la motivazione che spinse Moore a criticare l’idealismo di Bradley, «non era dissimile da quella che ispirò
Meinong e Brentano nel continente»23. Sulla stessa linea, in effetti, anche M. Dummett ritiene «che
le radici della filosofia analitica risalgano a un periodo assai anteriore all’esistenza della scuola analitica vera e propria, e, quel che più conta, che si tratti delle medesime radici della scuola fenomenologica»24.
Secondo Dummett, in particolare, la filosofia analitica è una filosofia del pensiero e, quel
che la distingue, «è il convincimento che, in primo luogo, una spiegazione filosofica del pensiero
sia conseguibile attraverso una spiegazione filosofica del linguaggio e, in secondo luogo, che una
spiegazione comprensiva sia conseguibile solo in questo modo»25. Hacker ritiene che questa caratterizzazione della filosofia analitica «lasci perplessi, poiché non è chiaro che cosa possa significare
“filosofia del pensiero”»26. Infatti, afferma, se pensiero significa proposizione, allora, «sebbene il
concetto di proposizione sia di grande interesse filosofico», tuttavia «difficilmente si può identificare con esso tutta la filosofia»; d’altra parte, se pensiero significa «pensare», allora sembra che «la filosofia del pensiero sia semplicemente una parte della psicologia filosofica»27.
D’Agostini, tuttavia, non considera questo aspetto della ricostruzione di Dummett un difetto;
al contrario, ritiene che essa sia adatta «soprattutto alla filosofia analitica delle origini»28 e, in particolare, al pensiero di Gottlob Frege. Del resto, su ciò è d’accordo anche Hacker, il quale ammette
che, «manifestamente, Frege non pensava che l’esame del linguaggio naturale fosse il modo migliore per indagare il pensiero»29. Come vedremo, in effetti, il ricorso alla formalizzazione logica fu
proprio il mezzo che egli adottò per eliminare gli equivoci e le imperfezioni del linguaggio ordina-
21
B. RUSSELL, The Philosophy of Logical Atomism, in Id., Logic and Knowledge, Essays 1901-1950, ed. by R.C.
Marsh, Allen & Unwin, Longon 1956, p. 178 (tr. it. Logica e conoscenza, Longanesi, Milano 1961, pp. 105-106).
22
Sull’importanza di F. Brentano nello sviluppo della filosofia analitica cfr.: L. ALBERTAZZI-M. LIBARDI-R. POLI, The
School of Brentano, Kluwer, Dordrecht 1996; K. MULLIGAN, Exactness, Description and Variation. How Austrian Analytic Philosophy was Done, in C. NYJRI (ed.), Von Bolzano zu Wittgenstein. Zur Tradition der österreichischen
Philosophie, Holder-Pichler, Wien 1986; K. MULLIGAN, The Expression of Exactness: Ernst Mach, the Brentanists and
the Ideal of Clarity, in R. PYNSENT, a cura di, Decadence and Innovation. Austro-Hungarian Life and Art at the Turn of
the Century, Weidenfeld and Nicolson, London 1989; B. SMITH, Austrian Philosophy: The Legacy of Franz Brentano,
Open Court, La Salle 1994.
23
P.M.S. HACKER, The Rise of Twentieth Century Analytic Philosophy, cit., p. 57.
24
M. DUMMETT, Origini della filosofia analitica, tr. it. di E. Picardi, Einaudi, Torino 2001, p. 5.
25
Ibid., p. 13.
26
P.M.S. HACKER, The Rise of Twentieth Century Analytic Philosophy, cit., p. 52.
27
Ibid.
28
F. D’AGOSTINI, The cosa è la filosofia analitica, cit., p. 10.
29
P.M.S. HACKER, The Rise of Twentieth Century Analytic Philosophy, cit., p. 53.
5
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
rio. Ciò che va evidenziato, piuttosto, è che «la filosofia analitica del ventesimo secolo si distingue,
alle sue origini, per l’orientamento non-psicologico»30.
Di conseguenza, non appare illegittimo, dato il tema della presente introduzione, partire proprio dalla sollecitazione di Dummett per proporre un percorso che presenti e analizzi alcuni testi
fondamentali degli autori che hanno, direttamente o indirettamente, costituito le basi per la filosofia
analitica. Infatti, non si può trascurare che, come afferma Hacker, «ogni caratterizzazione della “filosofia analitica” che escluda Moore, Russell e il secondo Wittgenstein […] debba essere rifiutata»31. In particolare, tale esame sarà condotto lasciando emergere come i problemi sollevati da questi autori e le modalità con cui li affrontano costituiscono il carattere distintivo di un modo di pensare europeo che, già dalla fine dell’Ottocento, ha fornito, almeno in parte, un terreno comune per lo
sviluppo delle due correnti fondamentali della filosofia del Novecento: quella analitica e quella fenomenologico-ermeneutica.
Il tentativo di ricercare le radici della filosofia analitica, perciò, ha un duplice scopo: da un
lato, vi è certamente l’intento di offrire una possibile ricostruzione della genesi di una delle più influenti correnti filosofiche attuali; dall’altro, però, vi è anche il tentativo teorico di mostrare che la
filosofia analitica si svolge sullo stesso terreno della tradizione filosofica, in senso lato occidentale,
ridimensionando l’idea che essa costituisca una tradizione autonoma. A tale proposito, occorre precisare che, sebbene vi siano alcuni tentativi di ricondurre lo stile analitico a pensatori della tradizione classica32, tuttavia sembrano più convincenti quelli che ne riscontrano le origini specifiche nella
riflessione logico-psicologica della fine dell’Ottocento33.
In questo ordine di idee, cercheremo di far emergere che la filosofia analitica è una filosofia
del linguaggio, soltanto nel senso che, sulla base di certe assunzioni teoriche, prende il linguaggio
come oggetto privilegiato di indagine. Ciò significa che essa non si riduce al linguaggio, dal momento che il suo intento principale, come si ricava dagli scritti dei filosofi che prenderemo in considerazione, resta quello di indagare il pensiero e le sue connessioni con la realtà. La domanda da cui
nasce, cioè, è quella riguardante la natura del pensiero e, nel rispondervi, i filosofi della fine
dell’Ottocento si trovarono ad affrontare il problema di distinguere la natura psicologica da quella
logica del pensiero. Questo processo è indicato solitamente come “depsicologizzazione” e investe,
in generale, la riflessione dei filosofi cui la tradizione analitica e quella fenomenologica individuano
le proprie origini.
La svolta linguistica, sostiene Dummett, va dunque considerata come espressione di una «filosofia del pensiero», che non poteva svilupparsi se prima «non avesse preso le distanze dalla psicologia filosofica», ovvero se non avesse proceduto alla «estromissione dei pensieri dalla mente»34.
La storia delle origini della filosofia analitica, perciò, non può che iniziare presentando il lavoro de30
Ibid., p. 56.
Ibid., p. 55.
32
Cfr., ad esempio: A. COFFA (The Semantic Tradition from Kant to Carnap, Cambridge University Press, Cambridge
1991; tr. it. di G. Farabegoli, La tradizione semantica da Kant a Carnap, il Mulino, Bologna 1998) che ne riscontra i
prodromi già in Kant; M. SCHLICK (Die Wende der Philosophie, in «Erkenntnis» I(1930), pp. 4-11; tr. it., La svolta della filosofia, in Tra realismo e neopositivismo, a cura di A. Pasquinelli, Bologna, il Mulino, pp. 31-32) e J.L. AUSTIN
(Philosophical Papers, Clarendon Press, Oxford 1961; tr. it. di P. Leonardi, Guerini, Milano 1990), i quali la riconducono addirittura alla metodologia di analisi dei problemi di ascendenza socratico-platonica; G.E.M. ANSCOMBE e P.
GEACH (Three Philosophers, Blackwell, Oxford 1961) ed E. TUGENDHAT (Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie, Surkamp, Frankfurt a.M. 1976; tr. it. parziale di C. Salvi, Introduzione alla filosofia analitica,
Marietti, Genova 1989), che ne individuano l’antecedente in Aristotele.
33
J.C. NYÍRI (hrsg., Von Bolzano zu Wittgenstein. Zur Tradition der österreichischen Philosophie, Holder-Pichler,
Wien), P. SIMONS (Philosophy and Logic in Central Europe, Kluwer, Dordrecht 1992) e D. FØLLESDAL (Analytic Philosophy: What Is and Why should One Engage in It?, in H.-J. GLOCK, ed., The Rise of Analytic Philosophy, Blackwell,
London 1997, pp. 1-16) ne individuano l’antecedente più lontano nella filosofia pura di B. Bolzano. K. MULLIGAN (Exactness, Description and Variation. How Austrian Analytic Philosophy was Done, in J.C. NYÍRI, hrsg., Von Bolzano zu
Wittgenstein, cit., pp. 86-97), B. SMITH (ed., Austrian Philosophy: The Legacy of Franz Brentano, Open Court, La Salle
1994) e L. ALBERTAZZI, M. LIBARDI, R. POLI (The School of Franz Brentano, Kluwer, Dordrecht 1996) rimandano
invece al realismo psicologico di Franz Brentano.
34
M. DUMMETT, Origini della filosofia analitica, cit., p. 143.
31
6
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
gli autori che, per primi, si confrontarono con il problema della natura del pensiero e, in particolare,
con Frege, che compì il passo decisivo per preparare il terreno alla svolta linguistica.
1.4 – I “padri fondatori”
Dal punto di vista storico, ciò su cui gran parte degli interpreti concordano è che le origini
della filosofia analitica possono essere individuate nell’opera di Frege. Questo non significa che egli
sia il primo filosofo analitico, ma soltanto che preparò il terreno alla svolta linguistica. Il suo contributo principale, infatti, consiste nell’aver avanzato una spiegazione della natura del pensiero che
«poggiava sul convincimento che vi fosse un parallelismo tra linguaggio e pensiero»35.
Nel corso delle sue indagini sui fondamenti logici della matematica, infatti, Frege si occupò
di questioni filosofiche fondamentali, come quelle sulla natura del pensiero e sul funzionamento del
linguaggio. In tal modo, egli delineò un orizzonte problematico che resterà un punto di riferimento
per tutti gli autori successivi e, nel farlo, definì anche i contorni di un vero e proprio metodo. Per
mezzo degli strumenti della logica formale, egli ha posto le basi per compiere il passaggio
dall’analisi del pensiero all’analisi del linguaggio con cui esso si esprime, che è uno dei tratti distintivi del metodo analitico, se non un vero e proprio «assioma fondamentale»36.
L’importanza di Frege, però, risiede anche nelle sue radici tedesche, perché,
nell’elaborazione di questo mutamento di prospettiva, egli si inserisce nella scia dei tentativi di depsicologizzazione della ricerca logico-matematica compiuti, tra gli altri, da Franz Brentano37, il quale
ha posto l’attenzione sull’oggettività del contenuto intenzionale della coscienza. Secondo
D’Agostini e Vassallo, le tesi di Brentano avrebbero avuto un influsso anche su Moore e Russell, attraverso la lettura della Analytic Psychology di G.F. Stout, pubblicata nel 189638.
Frege, tuttavia, sebbene ispirato alle concezioni della nascente fenomenologia, critica il tentativo, compiuto in particolare da Husserl, di ricondurre le nozioni logiche a oggetti di coscienza e
avanza l’idea che gli oggetti matematici e logici abbiano un loro statuto ontologico indipendente
dalla mente umana39.
Frege, Russell e Moore possono essere dunque ragionevolmente considerati i «padri fondatori»40 del movimento analitico. La loro opera, però, non avrebbe probabilmente avuto l’influenza
che oggi gli viene riconosciuta, se non fosse stata oggetto di una sintesi complessiva e di uno sviluppo teoretico ad opera del giovane filosofo viennese Ludwig Wittgenstein.
La filosofa analitica, infatti, secondo Dummett sorse soltanto quando «la svolta linguistica
fu portata a compimento», ossia «quando i filosofi abbracciarono consapevolmente la strategia seguita da Frege»41. In questo senso, allora, «se identifichiamo nella svolta linguistica il punto di partenza della filosofia analitica vera e propria, non v’è dubbio che per quanto grande sia stato
35
M. DUMMETT, Origini della filosofia analitica, cit., p. 144.
Ibid.
37
Sull’importanza di F. Brentano nello sviluppo della filosofia analitica cfr.: L. ALBERTAZZI-M. LIBARDI-R. POLI, The
School of Brentano, Kluwer, Dordrecht 1996; K. MULLIGAN, Exactness, Description and Variation. How Austrian Analytic Philosophy was Done, in C. NYJRI (ed.), Von Bolzano zu Wittgenstein. Zur Tradition der österreichischen
Philosophie, Holder-Pichler, Wien 1986; K. MULLIGAN, The Expression of Exactness: Ernst Mach, the Brentanists and
the Ideal of Clarity, in R. PYNSENT, a cura di, Decadence and Innovation. Austro-Hungarian Life and Art at the Turn of
the Century, Weidenfeld and Nicolson, London 1989; B. SMITH, Austrian Philosophy: The Legacy of Franz Brentano,
Open Court, La Salle 1994.
38
Cfr. F. D’AGOSTINI-N. VASSALLO (a cura di), Storia della filosofia analitica, cit., p. 8.
39
Per un’analisi dei rapporti tra Husserl e Frege, si vedano: V. COSTA-E. FRANZINI-P. SPINICCI, La fenomenologia, Einaudi, Torino 2002, spec. pp. 307 e ss.; R. MCINTYRE, Husserl and Frege, in «Journal of Philosophy», 84(1978), pp.
528-535.
40
J. URMSON, Philosophical Analysis, Clarendon Press, Oxford 1956; tr. it. di L.M. Leone, L’analisi filosofica, Mursia,
Milano 1966, p. 17.
41
M. DUMMETT, Origini della filosofia analitica, cit., p. 145.
36
7
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
l’apporto di Frege, Russell e Moore nel prepararne il terreno, il passo decisivo fu compiuto da Wittgenstein»42.
Attraverso l’analisi logica del linguaggio ordinario e tramite un’originale applicazione del
trascendentalismo kantiano43, Wittgenstein individua nella ricerca sui limiti del linguaggio lo scopo
ultimo dell’analisi filosofica. Come Frege, egli interpreta il linguaggio come espressione del pensiero e, seguendo l’idea di Russell per cui la forma grammaticale di un enunciato non è la sua forma
reale, riconduce tutto il linguaggio ordinario alla sua originaria forma logica. In tal modo, egli ritiene di poter eliminare le confusioni linguistiche da cui, a suo avviso, hanno origine la maggior parte
dei problemi filosofici tradizionali.
L’influenza immediata di Wittgenstein, come vedremo brevemente nelle conclusioni, si estende al Neopositivismo logico, del quale è stato per molto tempo annoverato come una sorta di
padre fondatore, senza tuttavia averne fatto mai parte; inoltre, almeno dagli anni Cinquanta, al suo
metodo di indagine si è ispirata gran parte della filosofia analitica del linguaggio44.
In entrambi i casi, tuttavia, sembra che il suo effettivo contributo sia stato solamente negativo. Nel caso del Neopositivismo, infatti, si è accentuata la tesi del Tractatus secondo la quale «su
ciò di cui non si può parlare, si deve tacere» e che «nulla può dirsi se non proposizioni della scienza
naturale», facendone così derivare che i problemi dell’etica, della religione e della metafisica andassero esclusi dall’indagine filosofica. Nel caso della filosofia analitica del linguaggio, invece, si è
troppo spesso posta l’attenzione sull’idea per cui la filosofia «lascia tutto com’è» (PU §124), dovendosi essa limitare alla mera descrizione della grammatica delle parole o degli usi effettivi del
linguaggio all’interno dei giochi linguistici.
A un lettore odierno, che è passato attraverso la critica al riduzionismo neopositivista e che
assiste a una fase, per così dire, di ritorno alla realtà dopo l’ubriacatura linguistica degli scorsi decenni, le tesi di Wittgenstein rischiano di apparire insoddisfacenti. A quale scopo, ci si può infatti
domandare, praticare l’attività filosofica? Di certo, non per restare in silenzio dopo aver chiarito che
nell’ambito del dicibile rientrano solo le proposizioni della scienza naturale; e nemmeno per passare
semplicemente in rassegna gli usi del linguaggio, come una sorta di sociologi o antropologi.
Tali aspettative, del resto, oltre che figlie di un tempo diverso, in cui dalla filosofia ci si attendono parole significative sulla realtà o su ciò che vorremmo da essa, sono legittimate anche dalla
lettura o rilettura di Wittgenstein alla luce di ulteriori elementi emersi nel corso degli anni. La lettura neopositivista, infatti, ha dimenticato o ignorato il fatto che, secondo il filosofo austriaco, aver risolto i problemi nell’ambito del dicibile «mostra a quanto poco valga l’aver risolto questi problemi», dal momento che «anche se tutte le domande della scienza trovassero una risposta, con ciò i
problemi vitali non sarebbero neppure sfiorati». La filosofia, d’altra parte, non può ridursi a mera
descrizione degli usi del linguaggio, come Wittgenstein afferma chiaramente nelle Ricerche filosofiche: «Non già che cosa siano le rappresentazioni (Vorstellungen), ci si deve domandare, o che cosa accada quando uno si rappresenta qualche cosa; bensì: come si usi la parola “rappresentazione”.
Ma questo non significa che io voglia parlare soltanto di parole (Das heisst aber nicht, dass ich nur
von Worten reden will). Infatti, nella misura in cui, nella mia domanda, si parla della parola “rappresentazione”, viene anche messa in questione l’essenza della rappresentazione […]» (PU I, §370).
42
Ibid., p. 143.
Su questi aspetti ci permettiamo di rinviare al nostro M. BASTIANELLI, Oltre i limiti del linguaggio. Il kantismo nel
“Tractatus” di Wittgenstein, Mimesis, Milano-Udine 2008.
44
Hacker ritiene che sono molte le figure che hanno svolto un ruolo nello sviluppo della filosofia analitica, ma «nessuno
grande quanto quello di Ludwig Wittgenstein» (P.M.S. HACKER, The Rise of Twentieth Century Analytic Philosophy,
cit., p. 51).
43
8
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
2 – G. FREGE: DALL’ANALISI DEL PENSIERO ALL’ANALISI DELLA PROPOSIZIONE.
Gottlob Frege (1848-1925) fu professore di logica e matematica presso l’Università tedesca
di Jena. Le sue ricerche erano rivolte a investigare la possibilità di fondare, in modo filosoficamente
sicuro, la teoria dei numeri e, di conseguenza, l’intero edificio matematico che ne deriva. Egli riteneva di poter condurre a compimento questo progetto, definito in seguito “logicista”, attraverso
l’elaborazione di un simbolismo che fosse in grado di esprimere, in modo chiaro e univoco, le relazioni logiche fondamentali che presiedono all’espressione del pensiero.
Tale ricerca si concretizzò, nel 1899, con la pubblicazione della Begriffsschrift (Ideografia)45. L’ideografia, o scrittura (Schrift) dei concetti (Begriff), si caratterizza come un simbolismo che
esprime soltanto il contenuto oggettivo del pensiero, senza alcun riferimento a fenomeni soggettivi
o psicologici. Per tale ragione, Frege afferma che essa è una sorta di «linguaggio in formule del
pensiero puro»46.
L’ideografia, dunque, aveva come suo movente principale proprio il fatto che, ogni volta che
tentiamo di esprimere un pensiero, siamo costretti a utilizzare la lingua quotidiana, la quale, però,
male si adatta a questo scopo. Come scrive Frege, «cercando di soddisfare nel modo più rigoroso
questa esigenza, incontrai un ostacolo nella inadeguatezza della lingua» e proprio «da questa necessità nacque l’idea dell’ideografia», cioè di un mezzo per esprimere soltanto «quelle relazioni che
sono indipendenti dalla natura particolare delle cose»47.
Tra l’ideografia e la lingua quotidiana, perciò, vi è un rapporto ben preciso:
«Credo di poter rendere nel modo più chiaro il rapporto della mia ideografia con la lingua di tutti i
giorni, paragonandolo al rapporto esistente fra il microscopio e l’occhio. Quest’ultimo, per l’estensione della
sua applicabilità, ha una grande superiorità nei confronti del microscopio. Considerato però come apparecchio
ottico, esso rivela certamente parecchie imperfezioni che di solito passano inosservate solo in conseguenza del
suo intimo collegamento con la vita spirituale. Ma, non appena scopi scientifici richiedano precisione nel discernere, l’occhio si rivela insufficiente. Il microscopio invece è adatto nel modo più perfetto proprio a tali
scopi, ma appunto per questo risulta inutilizzabile per tutti gli altri. […] In modo analogo la mia ideografia è
uno strumento inventato per determinati intenti scientifici e non si può condannarla se essa non è di alcuna utilità per altri scopi»48.
Di conseguenza, rispetto al linguaggio, il compito della ricerca logico-filosofica, secondo
Frege, è quello di
«spezzare il dominio della parola sullo spirito umano svelando gli inganni che, nell’ambito delle relazioni concettuali, traggono origine, spesso quasi inevitabilmente, dall’uso della lingua e liberare così il pensiero da quanto di difettoso gli proviene soltanto dalla natura dei mezzi linguistici di espressione»49.
La prima concretizzazione di queste ricerche si ebbe con la pubblicazione, nel 1884, dei
Grundlagen der Arithmetik che, come recita il sottotitolo, espone una ricerca logico matematica sul
concetto di numero. Nel 1893, inoltre, apparve il primo volume dei Grundgesetze der Arithmetik50,
in cui il logico tedesco impiega la nuova notazione per elaborare una fondazione logica della teoria
dei numeri.
Il 16 giugno 1902, tuttavia, il giovane logico inglese Bertrand Russell scrisse a Frege una
lettera, con la quale gli comunicava che il sistema da lui esposto conduceva a una contraddizione,
45
G. FREGE, Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens, Halle 1879; tr.
it., in ID., Logica e aritmetica. Saggi scelti, a cura di C. Mangione, Torino 1965, pp. 99-206.
46
Ibid., p. 104.
47
G. FREGE, Begriffschrift; tr. it. Ideografia, in ID., Logica e aritmetica, cit., p. 104.
48
Ibid., p. 105.
49
Ibid., p. 106.
50
G. FREGE, Grundgesetze der Arithmetik, begriffsschriftlich abgeleitet, Pohle, Jena, vol. 1, 1893; vol. 2, 1903. Una
traduzione parziale, ma completa nell’essenziale, si trova in ID., Logica e aritmetica, cit., pp. 475-594
9
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
legata all’ambiguità della nozione di classe e divenuta poi nota come “paradosso di Russell”51; nel
tentativo di risolvere queste difficoltà, nel 1903 Frege pubblicò il secondo volume dei Grundgesetze, quando però le sue ambizioni di fondare la matematica su basi logiche si erano ormai notevolmente ridimensionate.
Durante e dopo l’esecuzione di questo progetto di ricerca, Frege affrontò profonde questioni
filosofiche, relative alla natura della logica e delle nozioni fondamentali di essa. L’impegno su problemi a metà strada tra la logica e la filosofia lo condannò, per molto tempo, a non godere di buona
reputazione né tra i filosofi né tra i matematici, come egli stesso riconosce in un passo dei Grundgesetzte der Arithmetik:
«Le prospettive del mio libro non sono certo molto belle. È chiaro infatti che esso non piacerà a quei
matematici i quali, appena incontrano qualche espressione logica come “concetto”, “rapporto”, “giudizio”,
pensano subito: “Metaphisica sunt, non leguntur!” né a quei filosofi che, al vedere una formula, esclamano
“Mathematica sunt, non leguntur!”»52.
Nonostante questo, però, i suoi scritti teoretici ebbero una notevole influenza sul pensiero filosofico successivo, in quanto propongono distinzioni e nozioni che, come ormai la storiografia ha
ampiamente riconosciuto, si possono collocare tra le pietre di fondazione della filosofia analitica.
Tra questi scritti prenderemo in esame dapprima, in modo generale, l’articolo Funktion und Begriff
(1891) e, data la loro importanza, in modo più dettagliato gli articoli Sinn und Bedeutung (1892) e
Der Gedanke (1918).
51
Nella sua formulazione originaria, il paradosso è espresso come segue: in un villaggio vi è uno ed un solo barbiere;
sull’insegna del suo negozio è scritto che “il barbiere rade tutti – e unicamente – coloro che non si radono da soli”; ora,
se ci si chiede “Chi rade il barbiere?”, si incorre in un paradosso, giacché, se si risponde che egli si rade da solo, allora,
secondo quanto è scritto sull’insegna, non è possibile che si rada da solo; se, invece, viene raso da un altro, allora si violerebbe la premessa per cui vi è uno ed un solo barbiere. In termini insiemistici, il paradosso riguarda le classi che possono essere membri di se stesse e sarà risolto da Russell per mezzo della teoria dei tipi logici (cfr. infra, p. 31).
52
G. FREGE, I fondamenti dell’aritmetica, tr. it. in ID., Logica e aritmetica, cit., p. 492.
10
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
2.1 – Funktion und Begriff (1891).
2.1.1 – INTRODUZIONE.
Uno dei presupposti fondamentali dell’ideografia, come si è detto, è la distinzione tra gli aspetti psicologici e quelli oggettivi del pensiero. Al fine di realizzare il suo programma di fondazione logica dell’aritmetica, Frege aveva più volte ribadito la necessità di individuare la forma logica
che giace al di sotto della forma grammaticale degli enunciati. Questa ambizione si concretizza nel
ripensamento delle due nozioni chiave della logica tradizionale sin dai tempi di Aristotele, vale a dire quelle di soggetto e predicato.
Nella logica aristotelica, come è noto, sono studiate le inferenze di tipo sillogistico, a partire
da proposizioni analizzate in soggetto e predicato. L’esempio classico “Tutti gli uomini sono mortali. Socrate è uomo. Quindi Socrate è mortale” è riconducibile alla forma “Tutti gli U sono M. S è U.
Quindi S è M”. Tuttavia, come già gli Stoici avevano osservato, vi sono inferenze in cui le proposizioni non possono essere considerate in questo modo, perché operano come unità di senso. Consideriamo, ad esempio, il sillogismo “Se oggi piove, allora prendo l’ombrello. Oggi piove. Quindi prendo l’ombrello”. Un’inferenza di questo tipo è riconducibile alla forma “Se p allora q; p; dunque q”
e, come si nota facilmente, la sua validità non dipende tanto dal contenuto delle proposizioni che la
compongono, ma dai rapporti tra le proposizioni, ciascuna considerata come un tutto.
Se però non si presta attenzione al contenuto concettuale che la proposizione esprime e si
rimane fermi alla distinzione tra soggetto e predicato, allora è difficile riconoscere che, ad esempio,
le due proposizioni “A Platea i Greci sconfissero i Persiani” e “A Platea i Persiani vennero sconfitti
dai Greci”, esprimono sostanzialmente lo stesso pensiero. Pertanto, conclude Frege, «il posto del
soggetto nella successione delle parole ha linguisticamente il significato di un posto privilegiato, nel
quale si pone ciò su cui si vuol far convergere l’attenzione di chi ascolta»53. Ma questa è una distinzione chiaramente psicologica o grammaticale che, come tale, non può e non deve interessare la riflessione logica.
Per lo stesso motivo, il significato di una parola non può essere considerato a prescindere dal
senso della proposizione in cui compare. A partire da ciò, Frege formula il noto “principio di contestualità”:
«Noi dobbiamo […] prendere in esame le proposizioni complete. Soltanto in esse, a rigore, le parole
hanno un significato. Le immagini interne, che balenarono innanzi a noi allorché pensiamo a quelle proposizioni, non hanno bisogno di corrispondere alle componenti logiche del giudizio. È sufficiente che la proposizione, nella sua totalità, abbia un senso; da esso si ricava poi il contenuto delle singole parti costitutive»54.
Per poter superare le difficoltà insite nel simbolismo della logica tradizionale, Frege dichiara
di voler seguire «l’esempio del linguaggio in formule della matematica, ove solo con molto sforzo
possiamo distinguere soggetto e predicato»55. Dalla matematica, in particolare, egli evince l’utilità
della nozione di funzione, con la quale si può definire in modo più chiaro lo statuto della proposizione.
Per comprendere il senso di tale applicazione, nella Begriffsschrift si serve come esempio
dell’enunciato “l’idrogeno è più leggero dell’acido carbonico” e invita il lettore a sostituire il segno
dell’idrogeno con il segno dell’ossigeno o dell’azoto, ottenendo giudizi di senso diverso. Da ciò segue che l’enunciato suddetto può essere analizzato in una componente fissa (“… è più leggero
dell’acido carbonico”), e una variabile. Così, scrive Frege, «chiamo funzione la prima componente,
suo argomento la seconda»56. Il medesimo enunciato, tuttavia, può essere anche analizzato in “… è
più pesante dell’idrogeno”, ottenendo così una funzione diversa. In conclusione, egli afferma che
«la sostituzione dei concetti di soggetto e predicato con quelli di funzione e argomento è nella dire53
ID., Ideografia, cit., p. 111.
Ibid., p. 297.
55
Ibid.
56
Ibid., p. 126.
54
11
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
zione di separare logica e grammatica»57, ossia di rivelare i rapporti logici che sono mascherati dalla
grammatica ordinaria del linguaggio.
Frege elabora la nozione di funzione applicata all’analisi logica nel testo Funzione e concetto, del 1891, che brevemente prenderemo in esame.
57
Ibid., p. 107.
12
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
2.1.2 – ANALISI DEL TESTO.
Nello scritto Funzione e concetto, Frege esplicita l’importanza logica del concetto matematico di funzione.
L’articolo riprende il testo della conferenza Funktion und Begriff, tenuta dal logico jenese il 9 gennaio 1891, presso la
Società jenese di Medicina e Scienza naturale. In tedesco è apparso nella raccolta Kleine Schriften (a cura di I. Angelelli, Olms, Darmstadt 1967, 19902, pp. 125-142). Per la sintesi che segue abbiamo fatto riferimento alla traduzione italiana Funzione e concetto (in G. FREGE, Senso, funzione e concetto. Scritti filosofici, a cura di C. Penco e E. Picardi, Laterza, Roma-Bari 2003, pp. 3-27).
Se si esaminano funzioni del tipo “2∙13+1”, “2∙22+2”, “2∙43+4”, si osserva che esse non sono
che modi alternativi di scrivere, rispettivamente, i numeri 3, 18, 132. Pare così che la funzione non
sia altro che «il significato di un’espressione di calcolo». Se così fosse, però, «non avremmo acquisito nulla di nuovo per l’aritmetica».
Se però ci serviamo di una delle due scritture “2∙x3+x” o “2∙ ( )3+( )”, allora constatiamo che,
nei casi precedenti, «abbiamo sempre di nuovo la stessa funzione, solo con argomenti diversi, e cioè
1, 4 e 5». È perciò evidente, conclude Frege, «che l’essenza della funzione risiede in quel che accomuna queste espressioni».
In queste ultime scritture, inoltre, emerge chiaramente che «l’argomento non fa parte della
funzione, ma che insieme alla funzione forma un tutto compiuto; la funzione, infatti, in quanto tale
può dirsi incompleta, bisognosa di completamento o insatura». Quando diciamo, ad esempio, «“la
funzione 2∙x2+x”, la x qui non va vista come facente parte della funzione, perché questa lettera serve
soltanto a indicare il genere di completamento richiesto segnalando le posizioni che il segno
dell’argomento deve occupare». A partire da ciò, Frege propone di chiamare «valori» della funzione
quelli che si ottengono completando, di volta in volta, la funzione stessa.
Considerando poi altri usi del termine “funzione” in matematica e, in particolare, in geometria, egli stabilisce che, per indicare la generalità cui il termine “funzione” rimanda, «si impiegano
prevalentemente le lettere f e F, di modo che in “f(x)” e “F(x)” x rappresenta l’argomento»; in questo modo, egli continua, «il bisogno di completamento della funzione trova espressione nel fatto che
le lettere f e F recano con sé una parentesi, il cui interno è destinato ad accogliere il segno per
l’argomento».
Ogni funzione, in altre parole, esprime propriamente un concetto e, a partire da ciò, si può
operare una estensione della sua applicazione al linguaggio in generale. Anche gli enunciati assertori, infatti, nella misura in cui esprimono un contenuto concettuale, possono essere scomposti in una
parte insatura e in una satura. L’estensione della nozione di funzione dipende allora dal fatto che ora
«non sono ammessi più soltanto semplici numeri, bensì oggetti in generale». Ad esempio, precisa
Frege,
«l’enunciato “Cesare conquistò la Gallia” può essere scomposto in “Cesare” e “conquistò la Gallia”.
La seconda parte è insatura, reca con sé un posto vuoto e solo quando questo posto vuoto è riempito da un nome proprio o da un’espressione che fa le veci di un nome proprio si ottiene un senso conchiuso. Io chiamo anche qui “funzione” il significato della parte insatura. In questo caso l’argomento è Cesare».
Analogamente, ogni asserzione può essere ricondotta a una funzione: “Cesare conquistò la
Gallia” può diventare “x conquistò la Gallia” o, più in generale, F(x).
L’analisi degli enunciati per mezzo del concetto di funzione si rivela così uno strumento
proficuo, che permette a Frege di portare in luce altri problemi di grande rilevanza filosofica. In particolare, se si esaminano le uguaglianze tra espressioni matematiche, come ad esempio “2 4=4∙4”, si
nota che i segni “24” e “4∙4” significano entrambi il numero 16, sebbene in modi diversi. Analogamente, anche nel caso degli enunciati si osserva che
«quando diciamo “la Stella della sera è un pianeta il cui periodo di rivoluzione è più piccolo di quello
della Terra”, abbiamo espresso un pensiero diverso da quello espresso dall’enunciato “la Stella del mattino è
un pianeta il cui periodo di rivoluzione è più piccolo di quello della Terra”, infatti chi non sapesse che la Stella
13
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
del mattino è la Stella della sera58 potrebbe ritenere vero il primo e non il secondo. […] Occorre dunque fare
una distinzione tra senso e denotazione. “24” e “4∙4” hanno certo la stessa denotazione, sono, cioè, nomi propri
dello stesso numero, ma non hanno lo stesso senso [cioè] non contengono lo stesso pensiero».
E questa distinzione tra senso e denotazione è l’argomento discusso sistematicamente nello
scritto Senso e denotazione.
58
Entrambi i nomi denotano il pianeta Venere. Anticamente, quando tale pianeta sorgeva ad est poco prima dell’alba, lo
si chiamava Lucifero, dal latino portatore di luce. Quando appariva alla sera, invece, lo si chiamava Espero. Pare che il
primo ad accorgersi che si tratta in realtà dello stesso pianeta sia stato Pitagora.
14
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
2.2 – Sinn und Bedeutung (1892).
L’articolo Sinn und Bedeutung (Senso e denotazione) è apparso originariamente in «Zeitschrift für Philosophie
und philosophische Kritik», 100(1892), pp. 25-50. È stato quindi ristampato in G. FREGE, Kleine Schriften, a cura di I.
Angelelli, Olms, Hildesheim 1967, pp. 143-162. In italiano è stato tradotto come Senso e significato, in G. FREGE, Senso, funzione e concetto. Scritti filosofici, a cura di C. PENCO e E. PICARDI, Roma-Bari 2001, pp. 32-57.
Data l’importanza dello scritto, ne proponiamo un’ampia selezione di passi, con alcuni commenti intermedi. Il
testo di riferimento è quello della traduzione italiana contenuta in AA.VV., Filosofia del linguaggio, a cura di A. Iacona
e E. Paganini, Raffello Cortina, Milano 2003, pp. 18-26. Rispetto a questa traduzione, tuttavia, si è preferito rendere
Bedeutung con denotazione, invece che con significato, anche per uniformare la trattazione rispetto alle critiche di Russell59.
La riflessione di Frege prende spunto dalla questione circa che cosa renda due simboli diversi e, di conseguenza, su che cosa significhi, propriamente, porre un’uguaglianza tra due nomi. Ora,
questa operazione è significativa soltanto se tra i nomi che si pongono in uguaglianza vi è una differenza quanto al rispettivo contenuto concettuale. Riconoscere che a=b, infatti, è importante perché
ci dice su a e b qualcosa che, se li consideriamo ciascuno per sé, non sappiamo, e cioè che sono appunto uguali. I simboli a e b, dunque, pur essendo diversi, sono utilizzati per oggetti che sono uguali o che possono essere riconosciuti come tali e che, ad esempio, possono essere così impiegati l’uno
al posto dell’altro nei contesti in cui ricorrono.
«L’uguaglianza60 sfida la riflessione con quesiti che a essa si connettono e ai quali non è facile dare risposta. È l’uguaglianza una relazione? È una relazione fra oggetti oppure fra nomi o segni di oggetti?
Quest’ultima è la soluzione che avevo adottato nella mia Ideografia61. Le ragioni che sembrano militare a suo
favore sono le seguenti: a=a e a=b sono evidentemente enunciati di diverso valore conoscitivo: a=a vale a
priori e secondo Kant va detto analitico, mentre enunciati della forma a=b spesso contengono ampliamenti assai preziosi del nostro sapere e non sempre sono giustificabili a priori. La scoperta che ogni giorno non sorge
un nuovo Sole, bensì sempre il medesimo, è stata fra le più gravide di conseguenze dell’astronomia. Ancora
oggi non sempre il riconoscimento di un pianetino o di una cometa è qualcosa di scontato».
Tuttavia, se l’uguaglianza riguardasse solamente ciò che i segni a e b designano, allora non
potremmo scorgere l’effettiva differenza tra a=a e a=b, perché queste uguaglianze hanno importanza soltanto nella misura in cui vi sono coinvolti simboli diversi. Infatti, osserva Frege,
«quel che si vuol dire con a=b sembrerebbe essere che i nomi o segni “a” e “b” designano la stessa
cosa, nel qual caso il discorso verterebbe appunto sui segni, e verrebbe asserita una relazione fra segni».
È chiaro, però, che i segni sono simboli soltanto in virtù della loro connessione con l’oggetto
che designano. Ma questa connessione è arbitraria e, di conseguenza, tra le espressioni a=a e a=b
può sussistere una differenza
«solo se alla diversità di segno corrisponde una diversità nel modo di darsi di ciò che è designato. Siano a, b e c le rette che connettono i vertici di un triangolo con il punto mediano dei lati opposti. Il punto di intersezione di a e b coincide con il punto di intersezione di b e c. Abbiamo qui modi diversi di designare lo stes59
Si veda anche infra, p. 33.
Impiego questa parola nel senso di identità e intendo “a=b” nell’accezione di “a è identico a b”, “a e b coincidono”
[nota di Frege].
61
Scrive Frege nell’Ideografia: «L’uguaglianza di contenuto […] riguarda nomi, non contenuti». Col segno di uguaglianza «viene denotata la circostanza che due nomi diversi hanno lo stesso contenuto. […] Con l’introduzione di un segno per l’uguaglianza di contenuto viene necessariamente a crearsi la scissione nel significato di tutti i segni, potendo
essi figurare ora per il loro contenuto, ora per se stessi. […] La necessità di un segno dell’uguaglianza di contenuto si
basa quindi su quanto segue: lo stesso contenuto può venire completamente determinato in differenti modi; il fatto però
che in un caso particolare, a mezzo di due modi differenti di determinazione venga dato lo effettivamente lo stesso contenuto, è il contenuto di un giudizio. […] Risulta da ciò che i nomi differenti per lo stesso contenuto non sempre sono
semplicemente una trascurabile questione di forma, ma riguardano l’essenza della cosa stessa, se sono connessi a modi
diversi di determinazione. In questo caso il giudizio che ha per oggetto l’uguaglianza di contenuto è un giudizio sintetico in senso kantiano» (G. FREGE, Ideografia, tr. it. cit., pp. 123-125).
60
15
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
so punto e questi nomi (ossia: “il punto d’intersezione di a e b” e “il punto d’intersezione di b e c”) accennano
al tempo stesso al modo in cui esso ci è dato; pertanto nell’enunciato è racchiusa una conoscenza effettiva».
A questo punto, conclude Frege, è naturale distinguere un segno per due aspetti distinti. In
primo luogo, esso è segno di qualcosa che, scrive il logico tedesco, «io propongo di chiamare denotazione [Bedeutung]». In secondo luogo, i segni che designano la stessa cosa sono diversi perché
operano tale denotazione in un modo diverso, che è quello che egli propone di chiamare «il senso
[Sinn] del segno, nel quale è contenuto appunto il modo di darsi dell’oggetto».
Di conseguenza, nell’esempio precedente del triangolo, la denotazione delle espressioni
“punto d’intersezione di a e b” e “punto d’intersezione di b e c” è la stessa, sebbene non lo sia il
senso. Allo stesso modo, anche le espressioni “Stella del mattino” e “Stella della sera” denotano lo
stesso pianeta, ma lo fanno in modo diverso e, pertanto, hanno un senso diverso.
Occorre osservare che Frege non distingue tra nomi propri in senso stretto, come ad esempio
le parole “Venere”, “Aristotele”, “Mario” ecc., e le descrizioni, ossia quei complessi del tipo “La
Stella della sera”, “Il punto di intersezione di a e b” ecc. L’esame di questa distinzione e dei problemi a essa connessi, come vedremo, saranno questioni affrontate da Russell.
Frege osserva che, tra segno e senso, sembra esservi una connessione regolare; tuttavia,
mentre «al segno corrisponde un senso determinato e a questo, a sua volta, una denotazione determinata», «a una denotazione (un oggetto) non corrisponde un segno soltanto. Lo stesso senso può
essere espresso diversamente in lingue diverse e anche nella stessa lingua». In un linguaggio simbolico chiaro e univoco, auspica Frege, a ciascuna espressione «dovrebbe corrispondere un senso determinato; ma le lingue parlate non soddisfano questo requisito in vari rispetti, e dobbiamo ritenerci
soddisfatti quando per lo meno nello stesso contesto la stessa parola ha sempre lo stesso senso». E
continua:
«Forse possiamo convenire che un’espressione grammaticale ben costruita che funge da nome proprio
ha sempre un senso. Ma che a questo senso corrisponda anche una denotazione non è affatto detto. La locuzione “la serie meno convergente” ha un senso ma è dimostrato che non ha alcuna denotazione, poiché data una
serie convergente se ne può trovare un’altra meno convergente ma pur sempre convergente. Pertanto, quando si
afferra un senso, non si ha ancora con sicurezza una denotazione».
Il senso e la denotazione sono dunque due aspetti distinti di ogni segno che utilizziamo.
Quando parliamo, però, comprendiamo il senso di un enunciato associandolo non alla denotazione,
che ad esempio può non esserci presente in quel momento, ma a un’immagine che, per così dire,
formiamo dentro di noi, quale può essere un ricordo, un’immagine fittizia, l’idea della cosa che ci è
più familiare ecc. Lo statuto di questa immagine, che Frege propone di chiamare rappresentazione
(Vorstellung) o idea, in ogni caso,
«è il risultato di atti, sia interiori che esteriori, da me compiuti 62. L’immagine interna è spesso intrisa
di sentimenti e la nitidezza delle singole parti è disuguale e fluttuante. Neppure per una stessa persona la stessa
rappresentazione è sempre associata allo stesso senso. La rappresentazione è soggettiva: quella dell’uno è diversa da quella dell’altro. In questo modo vengono a prodursi naturalmente ogni sorta di differenze nelle rappresentazioni annesse al medesimo senso. Un pittore, un cavaliere e uno studioso di zoologia connetteranno
rappresentazioni diverse al nome “Bucefalo”63».
La rappresentazione, di conseguenza, non coincide con la denotazione, perché l’idea che ho
dentro di me di una casa, ad esempio, non è la medesima casa che ho fisicamente presente, poniamo, nella via dove abito. Il nome “Stella della sera”, dunque, è connesso all’oggetto “pianeta Vene62
Possiamo accostare alle rappresentazioni anche le intuizioni: nel caso di queste ultime le impressioni sensibili e gli atti interiori prendono il posto delle tracce lasciate nella psiche dalle prime. Per i nostri scopi la differenza è trascurabile,
poiché, accanto alle sensazioni e alle attività psichiche, a completare l’immagine dell’intuizione concorre sempre anche
il ricordo di tali sensazioni e attività. Per intuizione però si può intendere anche un oggetto, quando esso sia percepibile
dai sensi o spaziale [nota di Frege].
63
Era lo straordinario cavallo di Alessandro Magno.
16
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
re” e, al tempo stesso, alle innumerevoli rappresentazioni soggettive di ciascuno. A causa di queste
sue caratteristiche, di conseguenza, oltre che dalla denotazione, la rappresentazione differisce in
modo sostanziale anche dal senso del segno. Il senso, infatti,
«può essere possesso comune di molti e non è parte o modo della psiche individuale; e infatti nessuno
vorrà disconoscere che l’umanità ha un tesoro comune di pensieri che si tramanda di generazione in generazione64».
Quando due persone odono lo stesso enunciato, perciò, ciascuna di loro associa ad esso una
rappresentazione diversa. In tal modo, «per la rappresentazione in senso stretto dobbiamo specificare colui al quale essa appartiene e in quale momento». Tuttavia, tali persone si comprendono non
sulla base delle rappresentazioni soggettive, che non possono mai condividere in tutto e per tutto,
dal momento che hanno due coscienze diverse, bensì per quel qualcosa di oggettivo che indichiamo
come il “senso” dell’enunciato. Il senso, dunque, ha uno statuto indipendente dalla soggettività particolare di colui che lo comprende.
In base a quanto detto, Frege conclude che
«la denotazione di un nome proprio è l’oggetto stesso che con esso designiamo; la rappresentazione
che ne abbiamo è soggettiva. In mezzo sta il senso, che naturalmente non è più soggettivo come la rappresentazione ma non è neppure l’oggetto stesso».
Per chiarire meglio la distinzione, inoltre, egli formula il seguente esempio:
«Supponiamo che uno osservi la Luna attraverso un cannocchiale. Io paragono la Luna stessa alla denotazione: essa è l’oggetto che osserviamo, mediato dall’immagine reale proiettata dalla lente dell’obiettivo
all’interno del cannocchiale e dall’immagine che si forma sulla retina dell’osservatore. La prima è paragonabile
al senso, la seconda alla rappresentazione o all’intuizione».
A partire da ciò, nell’analisi del linguaggio, e in particolare quando si intende stabilire la differenza tra due nomi, si può concentrare l’attenzione su tre livelli distinti:
«La differenza può riguardare le rappresentazioni, oppure il senso ma non la denotazione, o infine anche la denotazione. Per ciò che attiene il primo livello occorre osservare che, dato l’incerto legame fra parole e
rappresentazioni, per una persona può sussistere una differenza che all’altra sfugge».
A queste differenze si aggiungono quelle che riguardano il modo in cui le parole vengono utilizzate nella poesia. Qui, infatti, sono importanti «le tonalità di luce e colore» che l’eloquenza cerca di conferire al discorso. Queste ultime «non sono obiettive, ma sta al lettore e all’ascoltatore supplirle, assecondando i cenni del poeta e dell’oratore». La possibilità di riuscire a comunicare queste
tonalità e l’accordo che si stabilisce tra poeta e lettore, però, non sarebbe possibile «se non vi fossero affinità nel modo di rappresentare degli uomini», cioè se non vi fosse quel patrimonio di “sensi”
a cui si deve fare riferimento.
A causa della soggettività e instabilità delle rappresentazioni e delle intuizioni, Frege dichiara di rinunciare a servirsi di questi termini nel prosieguo della discussione. D’ora in avanti, cioè, si
occuperà solamente di ciò che è oggettivo nella comprensione del linguaggio, vale a dire della denotazione, da un lato, e del senso, dall’altro. Ogni volta che si parla di senso, insomma, non si deve
scambiare l’elemento oggettivo che viene compreso dagli interlocutori con le rappresentazioni soggettive di ciascuno o con l’oggetto fisico che le parole denotano.
Per rendere più precisa la trattazione, Frege introduce la seguente terminologia:
64
Pertanto è controproducente impiegare la parola “rappresentazione” per designare cose tanto diverse fra loro [nota di
Frege].
17
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
«Un nome proprio (parola, segno, complesso di segni, espressione) esprime il proprio senso, e significa o designa la propria denotazione. Impiegando un segno ne esprimiamo il senso e ne designiamo la denotazione […]».
Dopo aver distinto il senso e la denotazione di nomi, Frege applica la stessa distinzione agli
enunciati in cui essi sono coinvolti e, in particolare, degli enunciati assertori. Ora, quando asseriamo
qualcosa, esprimiamo un pensiero: ad esempio, se affermiamo “La Stella del mattino è un corpo celeste illuminato dal sole”, intendiamo dire che l’oggetto denominato “Stella del mattino” ha la natura di essere un corpo celeste, e non, poniamo, di una pianta, che esso è illuminato dal sole e che non
brilla di luce propria.
Un enunciato assertorio, pertanto, è un’entità linguistica che esprime un pensiero 65. Ora, si
chiede Frege, «questo pensiero è da intendersi come il senso o come la denotazione
dell’enunciato?». Per rispondere, il logico tedesco prende in esame dapprima gli enunciati cui corrisponde una denotazione. Se nell’enunciato “La Stella del mattino è un corpo celeste illuminato dal
sole” sostituiamo un nome con un altro munito della stessa denotazione, dovremmo ottenere, in base all’uguaglianza considerata all’inizio del saggio, un enunciato equivalente. Così, sapendo che
“La Stella del mattino” denota lo stesso che “La Stella della sera”, possiamo sostituire l’occorrenza
del primo nome nell’enunciato in questione e otteniamo “La Stella della sera è un corpo illuminato
dal Sole”. Tuttavia, osserva Frege, in tal caso, il pensiero non è più lo stesso:
«infatti, ad esempio, il pensiero dell’enunciato “la Stella del mattino è un corpo illuminato dal Sole” è
diverso da quello dell’enunciato “la Stella della sera è un corpo illuminato dal Sole”. Infatti, chi non sapesse
che la Stella del mattino è la Stella della sera potrebbe ritenere vero il primo enunciato e falso il secondo».
Il pensiero, dunque, non può essere la denotazione dell’enunciato, perché esso cambia, sebbene la denotazione resti la stessa. Esso, allora, non può essere altro che il senso dell’enunciato.
Ma perché, si chiede Frege, siamo così interessati al fatto che un enunciato abbia una denotazione? «Non potrebbe forse l’enunciato avere solo un senso, ma essere privo di denotazione?». È
chiaro che vi possono essere enunciati privi di denotazione, così come esistono nomi privi di denotazione. Nomi come “Ulisse”, ad esempio, hanno chiaramente un senso, ma non denotano un individuo reale. L’enunciato “Ulisse approdò a Itaca immerso in un sonno profondo”, perciò, ha evidentemente un senso, anche se, siccome il nome proprio “Ulisse” non ha una denotazione, non ha una
denotazione.
Chi però si chiedesse se l’enunciato “Ulisse approdò a Itaca immerso in un sonno profondo”
sia vero o falso, sarebbe portato a riconoscere al nome “Ulisse” «anche una denotazione e non soltanto un senso». Infatti, sostiene Frege, «è alla denotazione del nome che viene ascritto o negato un
predicato. Colui che non riconosce al nome una denotazione non può attribuire o negare un predicato».
In tal modo, ci poniamo il problema della denotazione soltanto quando andiamo oltre il pensiero che l’enunciato esprime e ci chiediamo se l’enunciato sia vero o falso.
«Ma come mai esigiamo che ogni nome proprio abbia non solo un senso ma anche una denotazione?
Come mai non ci basta il pensiero? Per il fatto che, e nella misura in cui, siamo interessati al suo valore di verità. Non sempre è così. Ad esempio, quando ascoltiamo un poema epico siamo conquistati oltre che dalla bellezza del suono della lingua anche dal senso delle frasi e dalle rappresentazioni e dai sentimenti che suscitano
in noi. Se ci ponessimo il problema della verità metteremmo da parte il godimento artistico e ci applicheremmo
a un’indagine scientifica. Ci è indifferente se, ad esempio, il nome “Odisseo” abbia una denotazione fintanto
che consideriamo il poema alla stregua di un’opera d’arte66. Il tendere alla verità è dunque ciò che ovunque ci
spinge ad avanzare dal senso alla denotazione».
65
Come Frege precisa in nota, per pensiero si deve intendere non l’atto soggettivo del pensare, bensì «il suo contenuto
obiettivo che può diventare possesso comune di molti».
66
Sarebbe auspicabile disporre di un’espressione apposite per quei segni che hanno solo senso. Se, ad esempio, li chiamiamo “immagini”, allora le frasi pronunciate dall’attore sul palcoscenico sarebbero immagini e l’attore stesso sarebbe
un’immagine [nota di Frege].
18
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
Questo tendere alla verità, sebbene sia superfluo in poesia o in epica, è tuttavia fondamentale nelle scienze. In generale, la denotazione di un enunciato «è da ricercare in tutti quei casi in cui è
chiamata in causa la denotazione delle parti componenti; e ciò accade sempre se, e solo se, ci interroghiamo sul valore di verità»67.
Qual è, però, la denotazione di un enunciato vero? In altri termini, l’enunciato assertorio “La
Stella del mattino è un corpo celeste illuminato dal sole”, nella misura in cui è vero, che cosa denota? A questo punto, Frege è portato a ritenere che, così come il senso di un enunciato del genere è
qualcosa di oggettivo e di univocamente definito, anche la sua denotazione deve essere qualcosa di
altrettanto definito. Pertanto,
«siamo così condotti a riconosce il valore di verità dell’enunciato quale sua denotazione. Per valore di
verità di un enunciato intendo la circostanza che sia vero o falso. Non vi sono altri valori di verità. Per brevità
chiamo l’uno il Vero e l’altro il Falso. Ogni enunciato assertorio, in cui abbia importanza la denotazione delle
parti componenti, va dunque concepito come un nome proprio, e la sua denotazione, posto che vi sia, è appunto
il Vero o il Falso. Questi due oggetti vengono riconosciuti, ancorché tacitamente, da tutti coloro che formulano
un giudizio, che ritengono vero o falso qualcosa, e dunque anche dallo scettico. Il chiamare oggetti il Vero e il
Falso può apparire a questo punto della trattazione una decisione arbitraria, un mero gioco di parole, dal quale
non è lecito trarre conseguenze di ampia portata. Quel che io qui chiamo oggetto può essere inteso con precisione solo nel contesto della discussione dei concetti e delle relazioni, che rinvio a un altro articolo. Ma questo
almeno dovrebbe essere già chiaro fin d’ora, e cioè che in ogni giudizio68, per banale che sia, è già stato compiuto il passo dal livello del pensiero al livello delle denotazioni (dell’obiettività)».
Il Vero e il Falso sono dunque veri e propri oggetti, che fungono da denotazione per tutti gli
enunciati rispettivamente veri e falsi. Tuttavia, non sono oggetti reali, ma di natura puramente logica. Intendere la verità come un oggetto logico ha come conseguenza che il rapporto che intercorre
tra un enunciato vero e la verità non è assimilabile a quello tra un soggetto e un predicato. In altri
termini, la verità non è una proprietà e, pertanto, asserire “L’enunciato ‘5 è un numero primo’ è vero” non significa attribuire il predicato “vero” al soggetto “5 è un numero primo”. Scrive Frege:
«Si potrebbe essere tentati di intendere il rapporto che intercorre fra il pensiero e il Vero non alla stregua di quello che intercorre fra senso e denotazione, bensì della relazione che sussiste tra soggetto e predicato.
Infatti, si può anche dire: “Il pensiero che 5 è un numero primo è vero”. Ma se osserviamo la cosa più da vicino, ci accorgiamo che questo enunciato non dice nulla di più del semplice “5 è un numero primo”.
L’asserzione della verità risiede in entrambi i casi nella forma dell’enunciato assertorio […]. Se ne desume che
il rapporto che intercorre fra il pensiero e il Vero non va paragonato a quello che intercorre fra soggetto e predicato. Soggetto e predicato (nell’accezione logica) sono infatti parti di pensiero, e dal punto di vista del conoscere si trovano sullo stesso piano. Attraverso l’unione di soggetto e predicato si perviene sempre e soltanto a
un pensiero e non dal senso alla sua denotazione o dal pensiero al suo valore di verità. Ci si muove sempre sullo stesso piano, ma non v’è trapasso da un livello a quello successivo. Il valore di verità può far parte del pensiero tanto poco quanto il Sole, poiché non è un senso, ma un oggetto».
Questa posizione di Frege, nell’ambito della filosofia analitica è da alcuni considerata come
una versione ridondantista della verità. In altre parole, “vero” è uno pseudo-predicato, nella misura
in cui non è una proprietà degli enunciati. Affermare “L’enunciato p è vero”, pertanto, non significa
attribuire a p una proprietà che prima non aveva, ma stabilire una corrispondenza tra p e, potremmo
dire, l’oggetto logico del “Vero”. Dire “p è vero”, così, da un punto di vista strettamente formale è
ridondante, superfluo, giacché ciò equivale semplicemente a “p”.
La corrispondenza che sussiste tra tutti gli enunciati veri e l’oggetto logico “Vero” garantisce per Frege l’oggettività dei nostri giudizi sul mondo. Inoltre, è in virtù di questa corrispondenza
univoca che è possibile sostituire, in un enunciato, una parte con un’altra che ha la stessa denotazio67
Questo principio è noto anche come “tesi di composizionalità” o “tesi di estensionalità”. Come vedremo, risulterà
fondamentale per l’elaborazione della concezione di Wittgenstein nel Tractatus logico-philosophicus.
68
Un giudizio, per come io intendo il termine, non è il mero concepimento di un pensiero, bensì il riconoscimento della
sua verità [nota di Frege].
19
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
ne, ma senso diverso. La verità del pensiero, sebbene noi non la riconosciamo a prima vista, sussiste
tuttavia in virtù di tale corrispondenza.
Ogni nostro giudizio scientifico sul mondo, in altri termini, è formulato in modo tale da richiedere che, alla comprensione del senso, sia sempre associata la conoscenza del suo valore di verità.
«Se dunque il valore di verità di un enunciato è la sua denotazione, allora tutti gli enunciati veri avranno la stessa denotazione e lo stesso dicasi per tutti quelli falsi. Se ne desume che nella denotazione degli
enunciati ogni elemento di individualità viene cancellato. E pertanto il nostro interesse non può mai riguardare
la denotazione dell’enunciato soltanto; ma neppure il mero pensiero fornisce conoscenza, bensì soltanto insieme alla sua denotazione, ossia al suo valore di verità. Il giudicare può essere concepito come l’avanzare da un
pensiero al suo valore di verità. […]».
I nostri giudizi veri, di conseguenza, costituiranno quel serbatoio di oggettività che
l’umanità si tramanda. I pensieri veri, cioè, costituiscono una sorta di oggetti a cui l’umanità intera
fa riferimento quando parla o quando produce nuove conoscenze. Ma qual è lo statuto del pensiero?
Che cosa significa che il pensiero è qualcosa di oggettivo? Che cosa significa avere un pensiero vero? A queste complesse domande Frege dedicherà numerose riflessioni nel corso della sua vita, a
partire dalle quali elaborerà uno dei suoi saggi più importanti, Il pensiero.
20
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
2.3 – Der Gedanke (1918).
2.3.1 – INTRODUZIONE.
In un celebre passo dei Grundlagen der Arithmetik, Frege aveva già chiaramente indicato i
criteri fondamentali su cui si basava il suo esame critico dei fondamenti logici della matematica:
«Nella mia indagine ho tenuto come fondamentali i seguenti canoni: a) separare nettamente lo psicologico dal logico, il soggettivo dall’oggettivo; b) cercare il significato delle parole, considerandole non isolatamente ma nei loro nessi reciproci; c) tenere presente in ogni caso la differenza fra oggetto e concetto. Per
soddisfare alla prima regola, ho sempre usato la parola “rappresentazione” (Vorstellung) in senso psicologico,
tenendo ben distinte le rappresentazioni dai concetti e dagli oggetti. Quanto al secondo canone, chi non si attenga a esso si trova, per così dire, costretto ad assumere delle pure immagini interne, o degli atti delle singole
coscienze, come significato delle parole, e quindi a venir meno contemporaneamente anche al primo canone.
Per ciò che riguarda il terzo, è soltanto un’illusione ritenere che si possa fare di un concetto un oggetto senza
con ciò alterarlo»69.
A proposito del secondo canone, esso ribadisce la validità del già menzionato principio “di
contestualità”, che prevede appunto di considerare le parole sempre nel contesto in cui si trovano.
Non si tratta, tuttavia, di un’operazione di tipo pragmatico, bensì unicamente rivolta a individuare i
nessi logici delle proposizioni. Questo principio sarà ripreso e utilizzato da Wittgenstein nel Tractatus logico-philosophicus.
In relazione al terzo punto, invece, occorre ricordare il saggio Über Begriff und Gegen70
stand , del 1892, in cui Frege traccia la distinzione tra concetti e oggetti. Un concetto è un simbolo
incompleto, che può essere espresso mediante una funzione. Un oggetto, pertanto, sarà in generale
qualsiasi entità che possa costituire l’argomento di una funzione: ad esempio, l’individuo “Socrate”
può essere un oggetto della funzione “x è uomo”. Pertanto, dal punto di vista logico, gli oggetti non
sono soltanto gli individui reali, ma tutte le entità che possono completare una funzione e dar luogo
a un vero e proprio pensiero o giudizio.
Quest’ultima distinzione, insieme con quella tra senso e denotazione esaminata nel saggio
precedente, non è altro che una naturale articolazione dell’idea fondamentale per cui ciò che appartiene alla logica si colloca su un piano diverso tanto rispetto al mondo sensibile, quanto rispetto
all’insieme delle rappresentazioni soggettive.
Il pensiero pare dunque avere una sua “realtà autonoma” rispetto al processo psicologico del
pensare e ai contesti quotidiani in cui viene esercitato. L’esplicitazione di che cosa sia precisamente
questo statuto è per Frege l’oggetto di questo articolo. Egli, in particolare, rielabora le sue principali
acquisizioni nell’ambito di una sistematica e unitaria trattazione della natura del pensiero, oggetto
principale della logica e dell’analisi filosofica che essa comporta. Come per l’articolo precedente,
riportiamo un’ampia selezione del testo, alla quale premettiamo una breve sintesi dei contenuti essenziali.
Secondo Frege, la questione sulla natura del pensiero è strettamente correlata a quella sulla
natura della verità. L’interesse principale delle scienze, infatti, è quello di elaborare pensieri veri e,
di conseguenza, alla filosofia della logica spetta il compito di chiarire in che cosa propriamente consista l’attribuzione di verità e, soprattutto, se la verità riguardi i pensieri, gli enunciati o i fatti. La
prima risposta che emerge dal testo conferma l’idea che la logica si occupa delle leggi dell’essere
vero e non dei meccanismi psicologici del ritenere vero (fürwahrhalten). La parola “vero”, in secondo luogo, sembra essere un termine che esprime una proprietà e, in particolare, la proprietà di
certe immagini di corrispondere a certi fatti; tuttavia, precisa Frege, la verità non si predica propriamente delle immagini, ma degli enunciati che le esprimono. Essa, dunque, riguarda qualcosa di
oggettivo che l’enunciato esprime, vale a dire il suo senso. Ora, come già il logico tedesco aveva af69
G. FREGE, Die Grundlagen der Arithmetik, 1884; tr. it. in ID., Logica e aritmetica, cit., p. 219.
In «Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philosophie», XVI (1892), pp. 192-205; tr. it. Concetto e oggetto, in La
struttura logica del linguaggio, a cura di A. Bonomi, Bompiani, Milano 1973, pp. 373-386.
70
21
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
fermato in precedenza, il senso di un enunciato è un pensiero e, di conseguenza, la verità riguarda i
pensieri. La natura del pensiero è dunque strettamente correlata all’idea che esso, quando è vero, assume una certa “attualità”, ovvero uno statuto che è a metà strada tra le rappresentazioni, cioè qualcosa di impalpabile e mentale, e i fatti, cioè qualcosa di sensibile ed esterno. Per definire più adeguatamente questo particolare statuto dei pensieri, Frege attribuisce loro il carattere di veri e propri
“oggetti logici”, ossia di entità che abitano un “terzo regno” tra quello dei dati sensibili e quello delle rappresentazioni soggettive.
Il pensare, in conclusione, dal punto di vista della logica non va considerato come un fenomeno psicologico temporalmente e spazialmente determinato, ma come l’atto particolare di “afferrare” quelle entità oggettive senza tempo che sono i pensieri. Riconoscere un pensiero come vero,
perciò, significa afferrarlo e, in un certo senso, “attivarlo”, in modo che la sua costitutiva atemporalità diventi operativa nel mondo dei fatti e delle rappresentazioni. Di conseguenza, afferrare un pensiero significa cogliere una realtà esterna rispetto alla mente e non un costituente del flusso di coscienza.
22
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
2.3.2 – ANALISI DEL TESTO.
L’articolo Der Gedanke. Eine logische Untersuchung è apparso in tedesco nei «Beiträge zur Philosophie des
deutschen Idealismus» (2, 1918-1919, pp. 58-77). La selezione che segue è tratta dalla traduzione italiana Il pensiero (in
G. FREGE, Ricerche logiche, a cura di M. Di Francesco, Milano 1988, pp. 43-74).
Nel saggio precedente, Frege ha stabilito una connessione fondamentale tra il pensiero e la
verità, nella misura in cui tutti i pensieri veri corrispondono all’oggetto logico “Vero”. Ora, mentre
le singole scienze si occupano delle modalità con le quali si può stabilire questa corrispondenza, alla
logica spetta un compito più sostanziale, vale a dire quello di indagare la natura e lo statuto della
verità. A livello filosofico, questo problema riguarda lo statuto ontologico dei pensieri veri ed è di
natura completamente diversa da quello psicologico che consiste nell’indagare i processi mentali
con cui si crede vero qualcosa. Scrive Frege:
«La parola “vero” indica alla logica la direzione, così come “bello” la indica all’estetica e “buono”
all’etica. Certo, tutte le scienze hanno come obiettivo la verità; ma la logica se ne occupa in una maniera del
tutto diversa. […] Alla logica spetta di individuare le leggi dell’“esser vero”. […] Ora, dalle leggi dell’esser
vero risultano prescrizioni per il ritener vero, per il pensare, il giudicare, l’inferire; per questo si parla spesso
anche di leggi del pensiero. Ma corriamo qui il rischio di confondere cose tra loro differenti. L’espressione
“legge del pensiero” può venir forse presa in modo simile a “legge naturale” – si intenderebbe così quanto vi è
di generale nell’evento mentale del pensare. In questo senso una legge del pensiero sarebbe una legge psicologica e si giungerebbe all’opinione che nella logica ci si occupi del processo mentale del pensare e delle leggi
psicologiche secondo le quali esso si svolge. Ciò significherebbe però non aver capito quale sia il compito della logica, perché in questo caso la verità non otterrebbe il posto che le spetta. […] Al fine di escludere malintesi e di evitare che siano cancellati i confini tra la psicologia e la logica, assegno alla logica il compito di individuare le leggi dell’esser vero, e non quelle del ritener vero o del pensare. Nelle leggi dell’esser vero si dispiegherà il significato della parola “vero”».
Il logico tedesco precisa che la parola “vero” può essere intesa in molti modi, ma che non
tutti, però, sono di pertinenza dell’indagine logica. La parola “vero”, scrive,
«non la si deve qui adoperare con il senso che hanno “verace” o “veritiero”, e nemmeno come spesso
capita nel trattare questioni artistiche: quando ad esempio si parla della verità nell’arte, o quando la verità viene
posta come obiettivo dell’arte, quando si parla della verità di un’opera d’arte o di un sentimento vero. [...] La
verità cui pensiamo è piuttosto quella la cui conoscenza viene eretta a scopo della scienza».
A questo punto, egli riprende la questione, già sollevata al termine del saggio precedente, se
la verità sia un termine di proprietà. Siamo portati a pensarlo, perché generalmente essa si attribuisce a entità come «immagini, rappresentazioni, enunciati e pensieri». Diciamo, infatti, che
un’immagine “è vera”, che una rappresentazione “è vera”, e così via. Ma che cosa intendiamo, propriamente, quando lo diciamo?
Se si esaminano queste entità, «colpisce il fatto che siano qui raggruppati oggetti che possiamo vedere e sentire assieme ad altri che non possono venir percepiti con i sensi». A partire da
ciò, afferma Frege, si constata che vi è in realtà uno spostamento di significato:
«Infatti, possiamo dire in senso proprio che un’immagine, in quanto mera cosa visibile e tangibile, è
qualcosa di vero? e una pietra o una foglia non lo sarebbero? È ovvio che non diremmo vera l’immagine se non
vi fosse un’intenzione che essa sia vera: l’immagine deve rappresentare qualcosa. Anche la rappresentazione
non viene detta vera in sé ma solo rispetto a un’intenzione di farla corrispondere a qualcosa. È a partire da qui
che si può supporre che la verità consista in una corrispondenza di un’immagine con quanto viene raffigurato».
In altri termini, vi è un senso peculiare in cui la parola “verità” designa il sussistere di una
relazione di corrispondenza tra un’immagine e ciò che essa raffigura. Questa teoria della verità è
23
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
nota come teoria corrispondentista e, proprio a partire dalle analisi di Frege, sarà oggetto, nella filosofia analitica successiva, di numerose critiche71.
Sebbene la corrispondenza sia una relazione del tipo suddetto, il termine “vero” non denota
tuttavia una relazione, giacché non rimanda direttamente a qualcos’altro con cui l’immagine dovrebbe concordare. E anche se lo fosse, tale corrispondenza non sarebbe mai completa. Pertanto, da
un punto di vista logico non sarebbe affatto una corrispondenza:
«La corrispondenza è una relazione. Ma ciò è contraddetto dal modo d’uso della parola “vero”, che
non è un termine di relazione e non contiene alcun rimando ad alcunché d’altro con cui qualcosa dovrebbe concordare. Se non so che una certa immagine deve rappresentare il Duomo di Colonia non so con che cosa dovrei
confrontare l’immagine per decidere della sua verità. E inoltre la corrispondenza può essere completa solo allorché le cose corrispondenti coincidano, e non siano pertanto in alcun modo cose distinte. Si dovrebbe poter
controllare l’autenticità di una banconota cercando di farla combaciare stereoscopicamente con una autentica.
Ma sarebbe ridicolo il tentativo di far combaciare stereoscopicamente una moneta d’oro con un biglietto da
venti marchi. Far combaciare una rappresentazione con una cosa sarebbe possibile solo se la cosa fosse
anch’essa una rappresentazione. Ed esse combacerebbero solo se la prima corrispondesse completamente con
la seconda».
Al contrario, osserva Frege, ciò che è essenziale alla relazione di corrispondenza è proprio il
fatto che tra l’immagine e ciò che raffigura vi sia una qualche diversità. È solo così, infatti, che ha
senso stabilire la corrispondenza. Ma se le cose stanno in questo modo, allora
«non c’è nessuna concordanza completa, nessuna verità completa. E quindi non vi sarebbe proprio
niente di vero, dal momento che ciò che è vero a metà è non vero (ist unwahr). La verità non tollera i più o
meno. Ma come! Non si può stabilire che c’è verità quando sussiste una corrispondenza sotto un qualche aspetto? Ma sotto quale? Cosa dovremmo mai fare per decidere se qualcosa sia vero? Dovremmo ad esempio indagare se sia vero che una rappresentazione e un che di reale concordano nell’aspetto stabilito. Ma con ciò ci troveremmo nuovamente di fronte a una questione dello stesso tipo, e il gioco potrebbe ricominciare da capo. Fallisce quindi questo tentativo di spiegare la verità nei termini della corrispondenza. Ma con ciò fallisce anche
ogni altro tentativo di definire 1’“esser vero”. Infatti in una definizione verrebbero fissate alcune caratteristiche
e, nell’applicazione a un caso particolare, si tratterebbe sempre di vedere se sia vero o no che queste caratteristiche concordano. Così ci si muoverebbe in un circolo. È pertanto probabile che il contenuto della parola “vero” sia di una specie del tutto singolare e indefinibile».
Se dunque la parola “vero” è indefinibile, allora occorre compiere uno spostamento
dell’oggetto d’analisi. Quando ci chiediamo, ad esempio, se l’enunciato “La mia rappresentazione
corrisponde al Duomo di Colonia” è vero, infatti, non vogliamo sapere se vi è una corrispondenza
perfetta tra due oggetti (la mia rappresentazione e il Duomo di Colonia), ma se ciò che diciamo è
vero. In altre parole, non siamo alle prese con la verità di una rappresentazione, bensì con quella di
un enunciato. Occorre dunque passare dall’immagine all’enunciato con cui si esprime il relativo
pensiero:
«Si tratta adesso della verità di questo enunciato. Quella che, in modo del tutto indebito, viene chiamata la verità di immagini e rappresentazioni viene quindi ricondotta alla verità di enunciati. Cos’è che viene
denominato un enunciato? Una successione di suoni; ma a condizione che essa abbia un senso, senza voler asserire con ciò che ogni successione sensata di suoni sia un enunciato. E quando si dice vero un enunciato si
pensa in effetti al suo senso. Sembra quindi che ciò per cui si pone la questione dell’esser vero sia il senso di
un enunciato. Il senso di un enunciato è forse una rappresentazione? A ogni modo l’esser vero non consiste
nella corrispondenza di questo senso con qualcosa d’altro, perché altrimenti si riproporrebbe all’infinito la questione dell’esser vero».
L’enunciato, però, può essere vero o falso soltanto nella misura in cui è l’espressione di un
pensiero:
71
La stessa nozione di corrispondenza verrà ripresa e precisata dal giovane Wittgenstein e, intesa in senso prevalentemente fisicalistico, fungerà da base per il costituirsi delle dottrine del Neopositivismo logico. Infine, sarà proprio a partire dalla critica di questa nozione che si svilupperanno le correnti filosofiche del linguaggio ordinario e del neopragmatismo.
24
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
«Senza voler con ciò dare una definizione, chiamo pensiero qualcosa per cui possa in generale porsi la
questione della verità […]. In base a ciò posso dire: il pensiero è il senso di un enunciato – senza voler con
questo asserire che il senso di ciascun enunciato sia un pensiero. Il pensiero, in sé non sensibile, si riveste
dell’abito sensibile dell’enunciato e diviene così afferrabile da parte nostra. Diciamo che l’enunciato esprime
un pensiero».
La verità, in questo ordine di idee, pare essere una proprietà, come quelle che solitamente
impieghiamo per descrivere oggetti sensibili. Essa, tuttavia, non riguarda oggetti sensibili, ma è tale
che si può predicare solamente di un pensiero. Così, scrive Frege, la verità
«si distingue […] nettamente dalle proprietà che denominiamo con le parole “rosso”, “amaro”, “dal
profumo di lillà”. Ma non vediamo forse che il sole è sorto? e non vediamo al tempo stesso anche che ciò è vero? Il fatto che il sole sia sorto non è un oggetto che emetta raggi che giungono ai miei occhi, non è una cosa
visibile come lo è il sole stesso. Sulla base di impressioni sensibili si riconosce vero che il sole sia sorto. Ciò
nonostante l’esser vero non è una proprietà percepibile sensibilmente […]».
Tra le proprietà sensibili delle cose e la verità, tuttavia, vi è una connessione molto stretta.
Frege osserva che «dà da pensare che non possiamo riconoscere una proprietà in una cosa senza con
ciò stesso trovare vero il pensiero che questa cosa ha questa proprietà». Da ciò sembra di poter concludere che «a ciascuna proprietà di una cosa è connessa una proprietà di un pensiero, quella della
verità». Tuttavia, ribadisce,
«è anche degno di nota che l’enunciato “sento un profumo di violette” ha né più né meno lo stesso
contenuto dell’enunciato “è vero che sento un profumo di violette”. Pare così che non venga aggiunto niente al
pensiero con l’attribuirgli la proprietà della verità. […] Il significato della parola “vero” sembra essere veramente unico nel suo genere».
L’idea che la verità sia una proprietà è dunque fuorviante, come del resto era già stato affermato nel saggio precedente. Per il momento, però, Frege preferisce attenersi a questo «uso linguistico comune» e continua ad esprimersi «come se la verità fosse una proprietà, finché non verrà
trovato qualcosa di più appropriato».
A questo punto, per comprendere che cosa significhi attribuire la verità a un pensiero, egli
passa a considerare i diversi tipi di enunciati, in modo da poter distinguere i diversi modi in cui un
pensiero si esprime. Dal novero degli enunciati significativi per la discussione del problema della
verità e dello statuto del pensiero, però, ne vanno esclusi alcuni che, propriamente, o non esprimono
un pensiero o sono riconducibili ad altri. Senza indugiare su questa tematica, vale la pena riportare
un brano che riassume la questione:
«Non si vorrà contestare un senso a un enunciato imperativo, ma questo senso non è di un tipo per cui
possa porsi la questione della verità. Non chiamerò quindi pensiero il senso di un enunciato imperativo; così
pure sono da escludere proposizioni ottative e preghiere. Possono venir presi in considerazione quegli enunciati
nei quali comunichiamo o asseriamo qualcosa. Non considero tuttavia tali le esclamazioni in cui si dà sfogo ai
propri sentimenti, il gemere, il sospirare, il ridere, a meno che essi, tramite un accordo particolare, non siano
destinati a comunicare qualcosa. Ma cosa avviene nel caso degli enunciati interrogativi? Con un termine interrogativo articoliamo un enunciato incompleto, che ottiene un senso vero e proprio solo grazie al completamento da noi richiesto. Non prendiamo quindi in considerazione i termini interrogativi. Diverso è il caso degli enunciati interrogativi, ci aspettiamo di sentire un “sì” o un “no”. La risposta “sì” dice la stessa cosa che un
enunciato assertorio; perché per il suo tramite viene posto come vero il pensiero che è già interamente contenuto nell’enunciato interrogativo. Si può quindi formare un enunciato interrogativo a partire da qualsiasi enunciato assertorio. […] L’enunciato interrogativo e quello assertorio contengono lo stesso pensiero; ma quello assertorio contiene ancora qualcosa d’altro, cioè l’asserzione72. Anche l’enunciato interrogativo contiene qualcosa
72
Per sottolineare la peculiarità dell’asserzione, Frege ritiene che si debba distinguere tra il giudicare e ciò che viene
giudicato, perché altrimenti non potremmo chiaramente esprimere che asseriamo qualcosa (G. FREGE, Funzione e concetto, cit., p. 19). Così, nella sua Ideografia, introduce il “segno di giudizio” o “segno di asserzione”, che è un segno anteposto ad un enunciato per significare che esso è vero, ossia che afferma uno stato di cose realmente sussistente. Wittgenstein criticherà la funzione di quel segno, che egli ritiene inessenziale alla proposizione, giacché nessuna proposi-
25
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
d’altro, vale a dire una richiesta. In un enunciato assertorio occorre perciò distinguere due elementi: il contenuto, che esso ha in comune con il corrispondente enunciato interrogativo, e l’asserzione. Il primo è il pensiero, o
perlomeno contiene il pensiero. È quindi possibile esprimere un pensiero senza presentarlo come vero».
Gli unici enunciati in cui il legame tra pensiero e verità è palese sono quelli assertori. In un
enunciato assertorio, in particolare, si deve distinguere:
«1. l’afferrare il pensiero – il pensare;
2. il riconoscimento della verità di un pensiero – il giudicare73;
3. la manifestazione di questo giudizio – l’asserire.
[…] Un progresso nella scienza ha luogo di solito in questo modo: dapprima viene afferrato un pensiero, più o meno così come esso può ad esempio venir espresso in un enunciato interrogativo, a partire dal quale,
dopo appropriate ricerche, questo pensiero viene infine riconosciuto vero. Il riconoscimento della verità lo esprimiamo nella forma dell’enunciato assertorio; non abbiamo bisogno a questo fine della parola “vero” […]».
Ciò che caratterizza un enunciato assertorio è dunque qualcosa di oggettivo e tutto ciò che
non riguarda questa oggettività va considerato come non pertinente all’asserzione.
«Oltre a un pensiero e all’asserzione, un enunciato assertorio contiene spesso un terzo elemento al
quale l’asserzione non si estende. Sovente esso agisce sul sentimento e sullo stato d’animo di chi ascolta, o
mette in moto la sua immaginazione. Stiamo parlando di espressioni come “ahimè” e “grazie a Dio”. Questi
costituenti dell’enunciato emergono in modo più pronunciato nella poesia, ma anche nella prosa è raro che
manchino del tutto; nelle esposizioni matematiche, fisiche e chimiche sono più rari che non in quelle storiche.
Quelle che vengono chiamate scienze umane sono più prossime alla poesia (ma sono per questo anche meno
scientifiche) delle scienze rigorose, che sono tanto più aride quanto più sono rigorose – perché la scienza rigorosa è diretta alla verità e a nient’altro che alla verità. Pertanto tutti i costituenti dell’enunciato ai quali non si
estende la forza assertoria non fanno parte dell’esposizione scientifica […]».
La nozione di “forza” di un enunciato, con la conseguente distinzione tra i vari tipi di forza,
sono tra le acquisizioni più interessanti introdotte da Frege e risulteranno fondamentali per la trattazione degli “atti linguistici” di John Austin. Nell’ambito del testo che stiamo esaminando, però,
Frege si sofferma sulla sola forza assertoria e sottolinea che essa è fondamentale per portare alla luce il contenuto oggettivo, il pensiero, che l’enunciato esprime.
Ma qual è lo statuto del pensiero? In che cosa consiste la sua oggettività? La parola “oggettivo” si riferisce, in un senso più immediato e ingenuo, in primo luogo alle cose materiali:
«[…] L’uomo non ancora sfiorato dalla filosofia conosce in primo luogo le cose che può vedere e toccare, in una parola ciò che può percepire con i sensi, come alberi, pietre, case, ed è convinto che un altro possa,
in modo analogo, vedere e toccare lo stesso albero e la stessa pietra che lui stesso vede e tocca».
È evidente, però, che tra nessuna di queste cose si trova un pensiero e che, pertanto,
l’oggettività di esso è di tipo diverso. Vi è poi anche l’oggettività che riconosciamo alle rappresentazioni interiori, alle sensazioni, alle creazioni dell’immaginazione, ecc.:
«Anche chi non è un filosofo si vede ben presto costretto a riconoscere un mondo interno diverso dal
mondo esterno, il mondo delle impressioni sensibili, delle creazioni della sua immaginazione, delle sensazioni,
dei sentimenti e degli umori, un mondo delle inclinazioni, dei desideri, delle decisioni. Per avere
un’espressione abbreviata voglio raccogliere tutto ciò – escludendo le decisioni – sotto il termine “rappresentazione”».
zione può asserire di se stessa che è vera (TLP 4.442). L’asserzione, per lui, è qualcosa di psicologico, mentre la logica
si interessa solo del contenuto delle proposizioni, che non ha niente a che vedere col loro essere asserite.
73
Mi pare che fino a oggi non si sia distinto a sufficienza tra pensiero e giudizio. Forse è il linguaggio che induce a ciò.
In effetti negli enunciati assertori non abbiamo alcuna parte speciale che corrisponda all'asserire; piuttosto, che si asserisca qualcosa è insito nella forma stessa dell’enunciato assertorio. La lingua tedesca ha il vantaggio che enunciato principale e secondario si differenziano tramite la posizione delle parole. A questo riguardo va notato che anche un enunciato subordinato può contenere un’asserzione e che spesso né l’enunciato principale in sé né un enunciato secondario in sé
ma soltanto la connessione enunciativa esprime un pensiero completo [nota di Frege].
26
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
Ora, i pensieri sono molto più simili a quest’ultimo tipo di entità che non alle cose del mondo sensibile. Tuttavia, se si esaminano più da vicino le rappresentazioni, le cose sensibili e i pensieri, si possono osservare alcuni caratteri che aiutano a comprenderne i rispettivi statuti.
«In che cosa si distinguono le rappresentazioni dalle cose del mondo esterno? In primo luogo:
Le rappresentazioni non possono venir viste o toccate, né odorate, gustate, o udite.
Faccio una passeggiata assieme a un amico. Vedo un prato verde; ho l’impressione visiva del verde.
La ho, ma non la vedo.
Secondo: le rappresentazioni si hanno. Si hanno sensazioni, sentimenti, umori, inclinazioni, desideri.
La rappresentazione che uno ha appartiene al contenuto della sua coscienza.
Il prato e le rane, il sole che li illumina sono là, non importa se io li guardo o meno; ma l’impressione
sensibile del verde, che io ho, sussiste solo per il mio tramite; io ne sono il portatore. Ci sembra insensato che
un dolore, uno stato d’animo, un desiderio se ne vadano in giro autonomamente per il mondo senza un portatore. Una sensazione non è possibile senza qualcuno che senta. Il mondo interno ha come presupposto qualcuno
di cui esso è il mondo interno.
Terzo: le rappresentazioni hanno bisogno di un portatore. Al confronto le cose del mondo esterno sono
autonome.
Io e il mio amico siamo convinti di vedere entrambi lo stesso prato; ma ciascuno di noi ha una particolare impressione sensibile del verde. Io scorgo una fragola tra il fogliame verde. Il mio amico non la trova: è
daltonico. […] Nessun altro ha la mia rappresentazione; ma più persone possono vedere la stessa cosa. Nessun
altro ha il mio dolore. Qualcuno può aver compassione di me, ma in tal caso il mio dolore continua ad appartenere a me e la sua compassione a lui. Egli non ha il mio dolore e io non ho la sua compassione.
Quarto: ogni rappresentazione ha un solo portatore; non ci sono due persone che abbiano la stessa
rappresentazione […]».
Quando abbiamo a che fare con un pensiero, abbiamo a che fare con qualcosa dallo statuto
ben diverso e molto particolare. Sebbene si tratti di qualcosa di immateriale, al pari della rappresentazione, esso ha tuttavia una stabilità che ricorda quella delle cose sensibili. E sebbene ogni persona
possa pensare un medesimo pensiero, tuttavia quest’ultimo non è così strettamente collegato all’individualità del soggetto, come invece accade per le rappresentazioni. Nel caso del teorema di Pitagora, ad esempio, il pensiero che esso articola «può essere riconosciuto vero tanto dagli altri che da
me»; tale pensiero, pertanto, «non appartiene al contenuto della mia coscienza, e quindi non ne sono
il portatore»; ciò che io e gli altri facciamo è riconoscere tale pensiero come vero.
È chiaro dunque che i pensieri non sono né cose del mondo esterno né rappresentazioni. Essi
hanno uno statuto ontologico di tipo diverso, che porta Frege ad ammettere un “terzo regno”. A partire da ciò, si è parlato di un “platonismo” di Frege, nel senso che questo termine assume nella filosofia analitica successiva, vale a dire come sinonimo di “realismo” logico. Le entità logiche, come il
“Vero”, i numeri, i pensieri, sono reali, ma soltanto nel senso che sussistono in questo regno intermedio tra rappresentazione e cose sensibili. Ciò che caratterizza questo regno è la sua atemporalità:
un pensiero vero è un pensiero vero atemporalmente.
«Un terzo regno va riconosciuto. Ciò che vi appartiene concorda da un lato con le rappresentazioni,
perché non può venir percepito con i sensi, e d’altro lato con le cose, perché non ha bisogno di alcun portatore
ai contenuti della cui coscienza appartenere. Così il pensiero che articoliamo nel teorema di Pitagora è vero atemporalmente, vero indipendentemente dal fatto che qualcuno lo ritenga vero. Non ha bisogno di alcun portatore. E vero non soltanto a partire dal momento in cui è stato scoperto – così come un pianeta è in un rapporto
di azione reciproca con altri pianeti già prima che lo si scopra 74 […]».
Non siamo dunque portatori dei pensieri allo stesso modo in cui lo siamo delle rappresentazioni. Possiamo inventare un’immagine, cogliere gli aspetti emotivi che un poeta ci vuol comunicare, e così via. Avere un pensiero, però, non significa, propriamente, “elaborare” o “costruire” qualcosa. Data l’oggettività di cui godono i pensieri, Frege ritiene opportuno
74
Si vede una cosa, si ha una rappresentazione, si afferra o si pensa un pensiero. Quando si afferra o si pensa un pensiero non lo si produce, ma si entra in una certa relazione con esso, che esisteva già da prima; una relazione che è differente da quella del vedere una cosa o dell’avere una rappresentazione [nota di Frege].
27
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
«scegliere qui un’espressione particolare, e per questo ci si offre la parola “afferrare” [ted.: fassen;
ingl.: to grasp]. All’afferrare75 pensieri deve corrispondere una particolare disposizione spirituale, la facoltà di
pensare. Col pensare non produciamo i pensieri, ma li afferriamo. Infatti ciò che ho chiamato pensiero sta nella
più stretta connessione con la verità. Ciò che riconosco vero lo giudico essere vero del tutto indipendentemente
dal mio riconoscimento della sua verità, e anche indipendentemente dal fatto che io lo pensi. Il venir pensato
non è parte dell’esser vero di un pensiero. “Fatti! Fatti! Fatti!”, invoca lo scienziato quando vuole insistere sulla necessità di una fondazione più sicura della scienza. Ma cos’è un fatto? Un fatto è un pensiero che è vero.
Ma lo scienziato non riconoscerà certo come fondamento più sicuro della scienza qualcosa che dipende dai mutevoli stati di coscienza degli uomini. L’attività scientifica non consiste nel creare quanto piuttosto nello scoprire pensieri veri. L’astronomo può applicare una verità matematica nell’indagine intorno ad avvenimenti remoti che ebbero luogo quando ancora nessuno, perlomeno sulla terra, aveva riconosciuto quella verità. Egli lo
può fare perché l’esser vero di un pensiero è atemporale; e quindi quella verità non può essersi prodotta soltanto a partire dalla sua scoperta».
Certamente, afferrare pensieri presuppone qualcuno che afferri e che pensi. Tuttavia, colui
che afferra il pensiero è il portatore della facoltà di pensare, con la quale coglie il pensiero che, però, sussiste indipendentemente da tale facoltà e dalle condizioni spazio-temporali in cui viene esercitata. L’indagine logica, allora, si distingue sostanzialmente da quella psicologica: quest’ultima indaga le condizioni materiali e particolari in cui viene esercitato il pensiero; la prima, invece, si preoccupa soltanto dell’oggettività di quel “terzo regno” popolato dai pensieri.
La verità di un pensiero, dunque, riguarda la sua sussistenza atemporale. Non è, cioè, una
proprietà temporale di esso che dipende dalla nostra attitudine psicologica a riconoscerla. Per questo, riconoscere un pensiero come vero non significa dotarlo di una proprietà che prima non aveva.
Piuttosto, significa che lo abbiamo afferrato, che lo possiamo far operare nella nostra vita.
«Il pensiero che articoliamo nel teorema di Pitagora è certo atemporale, eterno, immutabile. Ma non ci
sono anche pensieri che sono veri oggi e che saranno falsi tra qualche mese? Per esempio, il pensiero che
quell’albero laggiù è coperto di foglie verdi non sarà falso tra sei mesi? No, perché non è più lo stesso pensiero. La sequenza di parole “questo albero è coperto di foglie verdi” non basta da sola all’espressione perché una
parte di quest’ultima è il momento dell’emissione. Senza la determinazione temporale che viene data dal momento dell’emissione non abbiamo un pensiero completo, vale a dire non abbiamo affatto un pensiero. Solo
l’enunciato integrato dalla determinazione temporale e completo sotto ogni aspetto esprime un pensiero. Ma se
il pensiero è vero lo è non oggi o domani, ma atemporalmente. Il presente verbale di “è vero” non accenna
quindi al presente del parlante ma è, se ci è consentita l’espressione, un tempo della non temporalità […]».
L’oggettività del pensiero è anche la proprietà per cui i pensieri risultano attuali, per cui cioè
hanno un effetto sul mondo. Ciò non accade perché i pensieri siano effettivamente capaci di azione,
cioè operino nel tempo e nello spazio. Nell’atto di afferrare i pensieri, invece, siamo noi che li caliamo nello spazio e nel tempo e che, in tal modo, ce ne serviamo per operare effettivamente nella
realtà. Tuttavia, continua Frege,
«quale valore potrebbe aver mai per noi ciò che è eternamente immutabile, che non può subire effetti
né provocarne che arrivino fino a noi? Qualcosa di completamente inattivo sotto ogni aspetto sarebbe anche del
tutto non attuale e per noi inaccessibile. Anche ciò che è atemporale, se deve essere per noi qualcosa, deve essere in qualche modo intrecciato alla temporalità. Cosa sarebbe per me un pensiero che non venisse mai afferrato da me? Con l’afferrare un pensiero tuttavia io entro in relazione con esso, ed esso con me».
Al pensiero dunque è riconosciuta oggettività ma, sembra, non attualità. Ciò nonostante, però, quando afferriamo i pensieri, in un certo senso, li rendiamo attivi, senza che ciò significa renderli veri. Il pensiero, in altri termini, ha bisogno di qualcuno che lo pensa, ma non per renderlo vero,
bensì per renderlo attuale, ossia perché abbia effetti.
75
L’espressione “afferrare” è altrettanto figurata che quella “contenuto di coscienza”. Ma l’essenza del linguaggio non
ci consente di meglio. Ciò che tengo in mano può certo venir visto come il contenuto della mano, ma lo è in un senso
del tutto diverso da quello in cui lo sono le ossa e i muscoli di cui essa è fatta, con le loro tensioni; ed è un contenuto a
essa ben più estraneo di questi [nota di Frege].
28
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica: Frege e Russell – Seminario di Filosofia della conoscenza 2011-2012
«[…] Qui manca ciò che ritroviamo ovunque negli avvenimenti naturali: l’azione reciproca. I pensieri
non sono completamente privi di attualità, ma la loro attualità è completamente diversa da quella delle cose. E
il loro agire viene liberato da un atto di colui che pensa, un atto senza il quale sarebbero inefficaci – almeno per
quel che possiamo vedere. E tuttavia colui che pensa non li crea, deve prenderli così come sono. I pensieri possono essere veri senza venir afferrati da qualcuno che pensi, e anche così non sono del tutto privi di attualità, se
perlomeno c’è la possibilità che vengano afferrati e, grazie a ciò, resi attivi».
L’importanza che, da questo momento in poi, verrà riconosciuta all’analisi logica del pensiero e alla sua espressione chiara, è strettamente connessa all’idea che i pensieri siano qualcosa di oggettivo che può avere un effetto sul mondo. In altri termini, l’analisi filosofica volta alla chiarificazione del linguaggio, è un modo per riconoscere i pensieri veri e per poterli far operare positivamente; d’ora in avanti, per i filosofi analitici la chiarificazione logica del linguaggio non è più soltanto un compito tecnico relativo ai problemi logici della matematica, ma significherà anche combattere contro gli inganni e le imposture che possono risultare dall’esprimere pseudo-pensieri o
dall’esprimere confusamente i pensieri.
Sebbene ancora legato alle questioni tecniche, sarà questo il punto di vista difeso generale
dal logico inglese Bertrand Russell e che troverà una caratterizzazione unitaria e sarà sviluppato
nelle sue implicazioni etiche nella filosofia del giovane Wittgenstein.
29
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica – Seminario di Epistemologia 2010
3 – B. RUSSELL: LOGICISMO, DESCRIZIONI DEFINITE E ANALISI.
L’altro grande esponente cui si fa ricondurre l’origine della filosofia analitica è il logico inglese Bertrand Russell, nato a Ravenscroft (Trelleck, Galles) il 18 maggio 1872 e morto a Penrhyndeudraeth (Galles) il 2 febbraio 1970.
Al contrario di Frege, la sua vita fu piuttosto movimentata e segnata, oltre che da numerosi
successi, anche da molte polemiche, sia in campo accademico sia nell’ambito del suo intenso impegno sociale. Di famiglia nobile, a seguito della morte dei genitori passò l’infanzia cresciuto dal
nonno paterno, Lord John Russell. Studiò matematica e moral sciences al Trinity College di Cambridge dal 1890 al 1894, ottenendovi nel 1895 il grado di dottore aggregato in filosofia. Alla fine
del 1895 si recò in Germania per studiare la socialdemocrazia tedesca, esperienza che si rivelò fondamentale per la formazione delle sue idee politiche. Fu lecturer a Cambridge dal 1910 al 1916,
finché fu rimosso dal grado durante la guerra per la sua opposizione alla leva obbligatoria; per gli
stessi motivi subì per sei mesi il carcere nel 1918.
Dopo aver visitato la Russia e la Cina nel 1920 e 1921, insieme alla seconda moglie, Dora
Black, fondò e diresse la Beacon Hill School (1927-32). Soggiornò dal 1938 fino alla seconda guerra mondiale negli Stati Uniti, insegnando al City College di New York e alla Barnes Foundation; fu
costretto però ad abbandonare tali incarichi per l’ostilità puritana alle sue teorie etiche e sociali. Ritornato in Inghilterra e reintegrato nel 1944 come fellow a Cambridge, ricevette nel 1949 l’Order of
Merit e nel 1950 il premio Nobel per la letteratura. Dal 1954 fino alla morte si impegnò fortemente
nella causa pacifista, per il disarmo unilaterale e contro la guerra in Vietnam. Contribuì alla nascita
del Tribunale per i crimini di guerra in Vietnam.
Con Frege, Russell condivide l’idea che la logica formale, se opportunamente elaborata,
possa costituire il fondamento rigoroso dell’intera matematica. Tale idea si venne formando nel logico inglese intorno al 1900, quando, partecipando al Congresso internazionale di filosofia di Parigi,
conobbe i risultati del logico italiano Giuseppe Peano. Indipendentemente da Frege, costui aveva
elaborato un linguaggio simbolico per assiomatizzare la matematica, servendosi delle nozioni primitive di numero, uno, successore e identità e di cinque assiomi76.
Analogamente a Frege, in altre parole, anche Russell mirava a elaborare un simbolismo adeguato ad esprimere, con chiarezza e univocità, le entità e le relazioni logiche fondamentali o, in altri
termini ancora, le strutture più generali del pensiero77. Russell utilizzò i risultati di Peano per elaborare una definizione di numero cardinale imperniata sulla nozione di classi 78 coestensive: il numero
1, in tal modo, è definito come la classe delle classi che hanno un solo elemento, il numero 2 come
la classe delle classi che hanno due elementi, e così via79.
Il suo progetto di derivazione della matematica dalla logica trovò una prima compiuta espressione nei Principles of Mathematics (1903)80, in cui è formulata la tesi logicista e sono stabiliti
i presupposti per la sua realizzazione, sulla base della nozione di classe. Come Russell dichiara nella Prefazione alla prima edizione, lo scopo principale dell’opera è «quello di provare che tutta la
76
Cfr. G. PEANO, Arithmetices principia nova methodo exposita, Bocca, Torino 1889.
Nell’Introduzione ai Principia Mathematica, Russell sostiene che l’adozione di un simbolismo invece che del linguaggio comune è motivata dal fatto che «la struttura grammaticale del linguaggio è adatta ad una gran varietà di usi.
Così, essa non possiede alcuna univoca semplicità nel rappresentare i pochi semplici, sebbene altamente astratti, processi e idee che sorgono nelle catene deduttive di ragionamento impiegate […]. La proposizione “una balena è grande”
rappresenta il linguaggio al meglio, dando espressione perspicua ad un fatto complicato; mentre l’analisi di “uno è un
numero” conduce, nel linguaggio, ad una intollerabile prolissità» (B. RUSSELL-A.N. WHITHEAD, Introduzione ai “Principia Mathematica”, tr. it. a cura di P. Parrini, La nuova Italia, Firenze 1977, p. 17).
78
Una classe, in generale, è l’insieme costituito da tutti gli elementi che godono di una certa proprietà. La classe dei
numeri primi, ad esempio, è l’insieme di tutti i numeri che sono divisibili soltanto per se stessi e per l’unità.
79
Cfr. Sur la logique des relations avec des applications à la théorie des séries, in «Revue de mathématiques», 7(1901),
pp. 115-48.
80
B. RUSSELL, The Principles of Mathematics, Cambridge University Press, Cambridge 1903; tr. it. di L. Geymonat, I
principi della matematica, Longanesi, Milano 1963.
77
30
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica – Seminario di Epistemologia 2010
matematica pura tratta esclusivamente di concetti definibili in termini di un numero piccolissimo di
concetti logici fondamentali e che tutte le proposizioni di tale scienza sono deducibili da un numero
piccolissimo di principi fondamentali»81. Il raggiungimento di questo risultato è stato reso possibile
«grazie ai progressi della logica simbolica, specialmente come venne trattata da Peano» e «il fatto
che tutta la matematica risulti logica simbolica è una delle più grandi scoperte del nostro tempo»82.
Già nel 1901, però, Russell si era imbattuto in una serie di paradossi che rischiavano di minare la riuscita del programma logicista. Tra questi, in particolare, uno riguardava la nozione stessa
di classe che, in tal modo, risultava non più affidabile come base del sistema. Il paradosso, in termini molto generali, può essere formulato nel modo seguente:
È ovvio che la classe di tutti i leoni non è un leone; tuttavia, la classe di tutte le classi è ancora una
classe. A partire da questa constatazione, si supponga che C sia la classe di tutte le classi che hanno la proprietà
di non essere membri di se stesse. Alla classe C, naturalmente, apparterrà la classe dei leoni. Ma cosa accade
con la classe C medesima? Se C appartiene a se stessa, allora C è una classe che è membro di se stessa e, di
conseguenza, C non può appartenere a C. Se invece C non appartiene a se stessa, allora, in base alla proprietà
che la definisce, C dovrebbe appartenere a se stessa. L’argomento si può portare all’infinito, incorrendo nella
fallacia del «circolo vizioso».
Resosi conto del pericolo che paradossi di questo tipo recavano alla fondazione logica della
matematica, il 16 giugno 1902 Russell scrisse a Frege una lettera, con la quale gli comunicava le
contraddizioni che derivavano da questa scoperta. Frege, come già ricordato in precedenza, non riuscì a far altro che ad aggiungere un’appendice alla imminente pubblicazione del secondo tomo dei
Grundgesetze (1903), nella quale discuteva, evidentemente senza troppa convinzione, alcune possibili soluzioni al problema.
Russell stesso, invece, già nell’appendice B dei Principles elaborò un abbozzo della teoria
dei tipi logici, la quale stabilisce una gerarchia tra le nozioni logiche. Per chiarire di che si tratta, si
ricordi che ogni classe si può ricondurre a una corrispondente funzione proposizionale83, la quale ha
i suoi valori in un certo ambito di validità. I valori di una funzione di primo grado, così, sono individui o termini, mentre una funzione di secondo grado avrà come valori funzioni di primo grado, e
così via. In tal modo, il paradosso delle classi non sussisterebbe, giacché la classe C, considerata
come elemento, è di un tipo logico diverso dalla classe C considerata come insieme.
La teoria dei tipi, però, presentava alcuni inconvenienti, perché richiedeva di operare delle
restrizioni che, dal punto di vista strettamente logico, sembravano poco rigorose e, soprattutto, non
facilmente formalizzabili. Tra queste, ad esempio, Russell fu in seguito costretto ad ammettere un
“assioma di infinità”, col quale si postula che il numero degli individui esistenti è infinito. Questo
assioma si rivela necessario per poter adeguare la definizione dei numeri come classi all’infinità dei
numeri stessi, ma comporta una presa di posizione sulla realtà, che esula dalla stretta pertinenza della logica.
In ogni caso, Russell continuò a sviluppare la tesi logicista e, assieme ad Alfred N. Whitehead, cominciò a lavorare a quello che doveva essere il secondo volume dei Principles. Questa ricerca, però, durò ben dieci anni e, alla fine, ne risultò un’opera interamente nuova e ben più complessa,
i Principia Mathematica84. Questo lavoro costituisce la messa a punto, non senza alcuni difetti formali, del programma logicista; l’innovazione principale consiste nella definitiva sostituzione della
81
B. RUSSELL, I principi della matematica, tr. it. cit., p. 27.
Ibid., p. 37.
83
Russell condivide con Frege la nozione di “funzione proposizionale”. Nei Principles ne offre la seguente definizione:
«Una proposizione, si potrebbe dire, è ogni cosa che sia vera o che sia falsa. Una espressione sul tipo “x è un uomo”
non è perciò una proposizione, non essendo né vera né falsa. Se noi diamo a x un qualsiasi valore costante, l’espressione
diventa una proposizione: come se fosse una forma schematica che sta in luogo di una qualsiasi fra una intera classe di
proposizioni […]. Io parlerò di proposizioni esclusivamente dove non vi è nessuna variabile reale: dove invece vi sono
una o più variabili reali, e per tutti i valori delle variabili l’espressione che se ne ricava è una proposizione, dirò che
l’espressione è una funzione proposizionale» (B. RUSSELL, I principi della matematica, tr. it. cit., pp. 47-48).
84
3 voll., Cambridge University Press, Cambridge 1910-13.
82
31
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica – Seminario di Epistemologia 2010
nozione di classe con quella di “simbolo incompleto”, strettamente connessa a quella di funzione
proposizionale:
«I simboli per le classi […], si dice nei Principia, sono, nel nostro sistema, simboli incompleti: ne
vengono definiti gli usi, ma non si assume affatto che presi da soli essi significhino qualcosa. Vale a dire, l’uso
di questi simboli viene definito in modo tale che, quando il definiens venga sostituito al definiendum, non rimanga più alcun simbolo di cui si possa supporre che rappresenti una classe. Pertanto le classi, nella misura in
cui le introduciamo, sono mere comodità simboliche o linguistiche, e non degli oggetti genuini come avviene
per i loro membri quando essi siano degli individui»85.
Per comprendere la portata filosofica di tali questioni, però, è necessario fare riferimento alle
convinzioni gnoseologiche che stanno alla base del progetto di ricerca di Russell. È da queste considerazioni, infatti, che derivano alcuni dei contributi filosofici più rilevanti del logico inglese.
Inizialmente, egli fece proprie le tesi realiste di Moore, il quale ammetteva l’esistenza di entità astratte, contro l’idealismo di Francis H. Bradley e John E. McTaggart allora dominante in Inghilterra. Russell, in particolare, riteneva che la logica avesse a che fare con una sorta di «regno
dell’essere» in cui esistono le entità concettuali della matematica, cioè i numeri. Successivamente,
però, in seguito alla scoperta dei paradossi, egli rifiutò tale concezione ed elaborò la ben nota “teoria delle descrizioni definite”. Prima di illustrarla, riportiamo un brano dalla Introduzione alla seconda edizione dei Principi della matematica, del 1937, in cui il logico inglese ricostruisce la questione:
«Esistono le costanti logiche? Vi è un senso di questa domanda nel quale possiamo dare una risposta
affermativa perfettamente definita: nell’espressione linguistica o simbolica delle proposizioni logiche vi sono
parole o simboli che compiono sempre la medesima funzione, cioè contribuiscono nello stesso modo al significato delle proposizioni ogni volta che si presentano. Tali sono, p. e., “o”, “e”, “non”, “se-allora”, “la classenulla”, “0”, “1”, “2”, ecc. La difficoltà consiste in ciò: quando noi analizziamo le proposizioni nella cui espressione scritta si incontrano tali simboli, troviamo che queste proposizioni non hanno dei costituenti i quali corrispondano alle espressioni in esame. In alcuni casi ciò è abbastanza ovvio: neppure il più ardente seguace di
Platone può supporre che si trovi in cielo l’“o” perfetto, e che gli “o” qui sulla terra siano copie imperfette
dell’archetipo celeste. Ma nel caso dei numeri la cosa è assai meno ovvia. Le dottrine di Pitagora, da cui ebbe
inizio il misticismo aritmetico, influenzarono tutta la successiva filosofia e la successiva matematica più profondamente di quanto in generale non si creda. I numeri erano secondo esse immutabili ed eterni, come i corpi
celesti; i numeri erano intelligibili; la scienza dei numeri era la chiave dell’universo. […] Al tempo in cui scrivevo i Principi, dividevo con Frege la credenza nella realtà platonica dei numeri, i quali, nella mia immaginazione, popolavano il regno senza tempo dell’essere. Era una fede consolante, che in seguito abbandonai con
rimpianto. […]
Nel capitolo quarto dei Principi è detto che “ogni vocabolo che compare in una locuzione deve avere
qualche significato”; e ancora: “Chiamerò termine qualunque entità che possa essere oggetto di pensiero, o
possa trovarsi in una proposizione vera o falsa, o possa essere contata come uno… Un uomo, un istante, un
numero, una classe, una relazione, una chimera, o qualsiasi altra cosa possa venir menzionata, sono sicuramente termini; e negare che la tale o tal altra cosa siano termini sarà sempre falso”. Questo modo di intendere la
lingua risultò erroneo. Che un vocabolo “debba avere qualche significato” (supposto, naturalmente, che non si
tratti di un vocabolo senza senso, ma di un vocabolo provvisto di un uso intelligibile) non è sempre vero […].
Il primo passo nel processo di cui sopra fu la teoria delle descrizioni […]».
La teoria delle descrizioni, presentata in modo compiuto nel 1905 nell’articolo On Denoting , è dunque un passaggio essenziale per comprendere l’elaborazione della tesi logicista successivamente ai Principles. Tale teoria prevede che espressioni che sembrano, apparentemente, dei
nomi, in realtà sono delle descrizioni. Se consideriamo, ad esempio, l’espressione “l’attuale re di
Francia è calvo”, essa può essere analizzata in un soggetto (l’attuale re di Francia) e in una proprietà
86
85
B. RUSSELL-A.N. WHITEHEAD, Introduzione ai “Principia Mathematica”, tr. it. cit., p. 144.
In verità, Russell propone la teoria anche in diversi scritti successivi, tra i quali, ad esempio, l’articolo “Descriptions”
si distingue per la chiarezza e la sistematicità (in Introduction to Mathematical Philosophy, Allen and Unwin, London
1919, pp. 167-180; tr. it. di A. Meotti, Le descrizioni, in Semantica e filosofia del linguaggio, a cura di L. Linsky, il
Saggiatore, Milano 1969, pp. 133-148). Abbiamo preferito presentare il testo di On Denoting perché, sebbene più complesso e non sempre altrettanto chiaro del precedente, è ormai largamente riconosciuto come testo classico.
86
32
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica – Seminario di Epistemologia 2010
(essere calvo). Il problema è che se, come Frege, riteniamo la prima espressione un termine, ossia
un nome, allora siamo costretti ad ammettere che esso non ha significato. Invece, secondo Russell,
tale espressione è un “simbolo incompleto” e deve essere parafrasato riconducendolo, in tal modo,
alle parti semplici che lo costituiscono: “Esiste un solo x che è attualmente re di Francia e tale x è
calvo”. Si ottiene così una proposizione in cui l’espressione “l’attuale re di Francia” non compare
più e che, manifestamente, non è priva di senso, ma falsa.
Infatti, mentre l’enunciato “L’attuale re di Francia è calvo” attribuisce l’essere calvo
all’individuo “l’attuale re di Francia”, il quale potrebbe o non potrebbe esistere, la soluzione di Russell consiste nel riconoscere all’“essere calvo” e all’“essere re di Francia” la proprietà di essere attribuite, entrambe, a uno e un solo individuo esistente. Siccome tale individuo non esiste, tale attribuzione dà luogo a una proposizione falsa.
Tale scomposizione delle descrizioni definite, come è evidente, costituisce di un metodo di
analisi del linguaggio che, come si è detto, diventerà uno degli elementi distintivi del metodo analitico classico.
33
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica – Seminario di Epistemologia 2010
3.1 – On Denoting (1905).
3.1.1 – OGGETTI CHE NON ESISTONO
Per meglio comprendere i problemi in discussione e le tesi contenute nell’articolo di Russell,
è necessario accennare brevemente a due questioni che riguardano la natura delle descrizioni. La
prima è quella del rapporto tra nomi e descrizioni, un problema che già era stato considerato da Frege, il quale, come abbiamo visto, lo aveva risolto attraverso la distinzione tra senso e denotazione di
un enunciato. Frege, però, non distingueva tra nomi genuini e descrizioni definite e tendeva a considerare espressioni del tipo “La Stella della sera” alla stregua di nomi che denotano una determinata
entità. In tal modo, il problema delle entità non esistenti è risolto semplicemente negando che espressioni del tipo “il quadrato rotondo” o “l’attuale re di Francia” (in tempi di repubblica) abbiano
un senso. Russell, come vedremo, riterrà insoddisfacente questa distinzione, perché, sebbene risulti
accettabile per casi come “il quadrato rotondo”, non lo è per le espressioni come “l’attuale re di
Francia”, le quali sembrano piuttosto avere un senso, nella misura in cui le comprendiamo.
Più ancora di Frege, tuttavia, nel riflettere su questi problemi Russell aveva di mira le tesi
del fenomenologo austriaco Alexius von Meinong87. Nello scritto Über Gegenstandstheorie88,
quest’ultimo risolve il problema degli enunciati che paiono sensati, ma che in realtà sono privi di
denotazione, ammettendo un universo di oggetti platonici.
Quando si parla dell’oggetto, precisa Meinong, si è indotti a pensare in prima istanza
all’oggetto del conoscere. A tale proposito, si osserva che «la totalità di ciò che esiste, con inclusione di quanto è esistito o esisterà, è infinitamente piccola se paragonata alla totalità degli oggetti della conoscenza»89. Per questo, vi è un «pregiudizio nei confronti del reale», per il quale «si considera
il non-reale come puro nulla»90. Ad esempio, gli “oggetti ideali” (uguaglianza, diversità ecc.) sussistono ma non esistono. La matematica, in particolare, è una scienza che non riguarda la realtà:
l’essere cui essa si riferisce non è mai l’esistenza, sebbene non si possa dire che i suoi oggetti, in
qualche modo, non sussistano.
A partire da ciò, egli osserva che «ciò che è destinato ad esser oggetto di conoscenza non
deve per questo necessariamente esistere»91. Ad esempio, in molti casi si può parlare delle proprietà
di un oggetto (il suo esser-così), senza che questo oggetto necessariamente esista. Da ciò Meinong
conclude che è possibile individuare un «principio dell’indipendenza dell’esser-così dall’essere».
Questo principio è importante, perché «ad esso non soggiacciono solo oggetti che di fatto non esistono ma anche quelli che non possono esistere perché sono impossibili. Non solo la celebre montagna d’oro ma anche il quadrato rotondo è tanto rotondo quanto quadrato»92.
Di conseguenza, secondo il fenomenologo Meinong, anche solo per poter esprimere il giudizio “Il quadrato rotondo non esiste”, è necessario che tale oggetto sia già, in qualche modo, disponibile alla nostra mente:
«Un qualsiasi non-ente deve esser in grado di costituire l’oggetto per lo meno per i giudizi che colgono questo non-essere […]. Per sapere che non c’è alcun quadrato rotondo devo esprimere un giudizio sul quadrato rotondo […]. Chi ama espressioni paradossali potrebbe ben dire: ci sono oggetti per i quali vale che siffatti oggetti non ci sono»93.
87
Nato a Leopoli nel 1853 e morto a Graz nel 1920, fu tra i discepoli di F. Brentano e insegnò all’Università di Graz.
AA.VV., Untersuchungen zur Gegenstandstheorie und Psychologie, a cura di A. von Meinong, Leipzig 1904, pp. 150; tr. it. a cura di E. Coccia, Sulla teoria dell’oggetto, Quodlibet, Macerata 2003.
89
Ibid., p. 24.
90
Ivi.
91
Ibid., p. 27.
92
Ibid., p. 28. Sugli oggetti impossibili, si veda anche Über die Stellung der Gegenstandstheorie im System der Wissenschaften, in «Zeitschrift für Philosophie und Philosophische Kritik», 129(1906), pp. 48-94, pp. 155-207, spec. §3.
93
A.v. MEINONG, Sulla teoria dell’oggetto, tr. it. cit., p. 28.
88
34
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica – Seminario di Epistemologia 2010
Per evitare questa conclusione paradossale, dunque, Meinong parla di un “essere” degli oggetti che è prima dell’essere o non-essere. Così, precisa, ogni oggetto «è in qualche modo già anticipatamente dato alla nostra decisione circa il suo essere o il non-essere, in una maniera che non
pregiudichi anche il suo non-essere»94.
L’essere di cui si parla nel caso di questi “oggetti impossibili”, pertanto, non è né
un’esistenza né una consistenza, ma una sorta di “terzo livello”. Si tratta di un essere a cui non si
oppone, propriamente, alcun non-essere. Dunque, non è lecito chiamarlo ancora essere:
«L’oggetto in quanto tale, senza tener conto delle particolarità occasionali o dell’apposizione (sempre/data) dell’oggettivo – si potrebbe dire forse il puro oggetto – sta “al di là dell’essere e del non essere”. [Esso] è per natura fuoriessente»95.
Come vedremo, a proposito della denotazione delle espressioni che coinvolgono “oggetti”
non esistenti, la teoria della denotazione di Russell confuta il platonismo insito nella soluzione di
Meinong criticando, al tempo stesso, la distinzione fregeana tra senso e denotazione.
3.1.2 – CONOSCENZA DIRETTA E CONOSCENZA PER DESCRIZIONE
L’altra questione che occorre brevemente considerare è la distinzione tra conoscenza diretta
(acquaintance) e conoscenza per descrizione. Questa distinzione, già presente all’inizio dell’articolo On Denoting, fu successivamente ripresa e sviluppata molte volte da Russell, fino all’elaborazione compiuta della teoria dell’atomismo logico96. In una delle sue forme più sistematiche, la distinzione è esposta nell’articolo Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description97:
«Dico che ho familiarità (I am acquainted) con un oggetto, quando ho una relazione cognitiva diretta
con quell’oggetto, cioè quando sono direttamente consapevole dell’oggetto stesso. Quando parlo di una relazione cognitiva, non intendo quella sorta di relazione che costituisce un giudizio, ma quella che costituisce una
presentazione (presentation)»98.
In altri termini, «dire che S ha familiarità con O significa essenzialmente lo stesso che dire
che O è presente a S». Tuttavia, precisa, mentre la relazione di presentazione rimanda all’oggetto
piuttosto che al soggetto (fino al punto che il soggetto diventa quasi non necessario), la relazione di
acquaintance richiede necessariamente il riferimento al soggetto e, dunque, è da preferire.
Secondo Russell, il primo e più ovvio esempio di oggetti di conoscenza diretta sono i dati di
senso (sense-data). Oltre a questi, abbiamo familiarità anche con dei termini universali, come i concetti. Ad esempio, egli scrive, «non solo siamo consapevoli di particolari gialli, ma se ne abbiamo
visti un numero sufficiente e abbiamo sufficiente intelligenza, siamo consapevoli dell’universale
giallo»99. Insomma, siamo consapevoli di almeno due generi di oggetti: particolari (tutti gli esisten-
94
Ibid., p. 29.
Ibid., pp. 31-32.
96
L’atomismo logico è la teoria per la quale l’analisi logica della proposizione rispecchia la divisione della realtà in elementi semplici e non ulteriormente divisibili. Russell cominciò a parlare di “atomismo logico” già ai tempi di On Denoting; la prima formulazione sistematica di questa tesi è nel saggio The Philosophy of Logical Atomism, del 1918 (ora
in B. RUSSELL, Logic and Knowledge, a cura di R.C. Marsh, Allen & Unwin, London 1956, pp. 177-281).
L’elaborazione più compiuta, invece, risale al saggio del 1924, Logical Atomism (ora in Logic and Knowledge, cit., pp.
323-43).
97
Originariamente apparso in «Proceedings of the Aristotelian Society», 11(1910-11), pp. 108-128; rist. in B. RUSSELL,
Mysticism and Logic (1918), pp. 209-232; in parte ripreso in ID., The Problems of Philosophy (1912), nel capitolo che
reca lo stesso titolo. Per le citazioni si fa riferimento alla versione contenuta nel vol. 6 dei Collected Papers (che riproduce quella di Mysticism and Logic), pp. 148- 161.
98
Ibid., p. 148.
99
Ibid., p. 150.
95
35
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica – Seminario di Epistemologia 2010
ti e tutti i complessi i cui costituenti sono uno o più particolari) e universali (tutti gli oggetti che non
hanno particolari tra i propri costituenti)100.
Ciò nonostante, puntualizza Russell, tra tutti gli oggetti di cui abbiamo conoscenza diretta
(familiarità), non figurano né gli oggetti fisici né le menti delle altre persone: «Queste cose ci sono
note attraverso quella che chiamo “conoscenza per descrizione”».
Con “descrizione”, continua,
«io intendo ogni sintagma (phrase) della forma “un così-e-così” o “il così-e-così”. Un sintagma della
forma “un così-e-così” lo chiamerò una descrizione “ambigua”; un sintagma della forma “il così-e-così” (al
singolare) lo chiamerò una descrizione “definita”»101.
Quando usa il termine descrizione, in particolare, lo intende sempre come sinonimo di “descrizione definita”. Ebbene, un carattere distintivo delle descrizioni sembra essere quello
dell’unicità e, di conseguenza, si può dire che «un oggetto è “conosciuto per descrizione” quando
sappiamo che esso è “il così-e-così”, cioè quando sappiamo che c’è un solo oggetto, e non di più,
che possiede una certa proprietà; e ciò implicherà generalmente che non abbiamo una conoscenza
diretta del medesimo oggetto»102. Russell conclude che, prendendo la nozione di descrizione in questo senso, ogni nome comune, in realtà, va inteso come una vera e propria descrizione.
L’analisi di una proposizione in cui sono contenute descrizioni, pertanto, ha come scopo la
risoluzione della descrizione nei suoi costituenti, sino ad arrivare a quei dati di senso primitivi e non
ulteriormente definibili:
«Il principio epistemologico fondamentale nell’analisi di proposizioni che contengono descrizioni è
questo: Ogni proposizione che siamo in grado di comprendere deve essere interamente composta di costituenti
con i quali abbiamo conoscenza diretta»103.
Se dico, ad esempio, “Giulio Cesare fu assassinato”, tale espressione è da considerarsi equivalente a “l’uomo il cui nome era Giulio Cesare fu assassinato”. In questo caso, è chiaro che “Giulio Cesare” non è un costituente del giudizio, mentre lo sono “uomo”, “nome”, “assassinio”, ecc.,
con cui ho familiarità.
La risoluzione delle proposizioni negli elementi semplici, o dati di senso, con cui ho familiarità, sarà portata avanti da Russell fino all’elaborazione delle tesi dell’atomismo logico. Tuttavia, tale concezione si rivelerà influente nella filosofia successiva soprattutto ad opera di Wittgenstein
che, nel Tractatus logico-philosophicus, ne darà una versione particolare e notevolmente diversa da
quella di Russell. Di tali differenze, però, non occorre occuparsi in questa sede.
Prima di passare a considerare il testo dell’articolo di Russell, è necessario precisare che il
logico inglese traduce con Meaning e Denotation rispettivamente i termini tedeschi di Frege Sinn e
Bedeutung. In italiano, però, esistono traduzioni difformi: a volte, infatti, sia Meaning che Bedeutung sono stati resi con significato, dando origine a un’evidente confusione. Per tale ragione, nel testo che segue abbiamo preferito tradurre Meaning con senso e Denotation con denotazione, in modo
che il riferimento alle teorie di Frege sia più evidente e che il termine significato possa intendersi
solamente come sinonimo di denotazione.
100
Nelle elaborazioni successive di questa posizione, Russell sarà sempre più cosciente delle difficoltà inerenti
all’identificazione dei dati semplici ed affermerà che l’unico nome veramente semplice è il pronome dimostrativo “questo”, indispensabile per poter definire ogni altro nome.
101
Ibid., p. 151.
102
Ibid., p. 152.
103
Ibid., p. 153; tr. modificata.
36
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica – Seminario di Epistemologia 2010
3.1.3 – ANALISI DEL TESTO.
Il testo originale di On Denoting è apparso sulla rivista «Mind» (14, 1905, pp. 479-493). La selezione che segue è tratta dalla traduzione italiana di A. Bonomi, Sulla denotazione (in La struttura logica del linguaggio, cit., pp.
179-195).
Russell considera come “sintagmi denotativi”, tutti quegli enunciati riconducibili a espressioni come: «Un uomo, qualche uomo, qualsiasi uomo, ogni uomo, tutti gli uomini, l’attuale re
d’Inghilterra, l’attuale re di Francia, il centro di massa del sistema solare nel primo istante del XX
secolo, la rivoluzione della terra intorno al sole, la rivoluzione del sole intorno alla terra». Ciò che
accomuna tutti questi casi, a prescindere dal loro contenuto, è la loro forma. Infatti, tutte queste espressioni somigliano a nomi, nel senso che si riferiscono o sembrano denotare qualcosa. I primi,
tuttavia, lo fanno in un modo diverso rispetto agli altri, nella misura in cui, coinvolgendo espressioni come “un”, “tutti”, “qualche”, “qualsiasi”, “ogni”, non denotano un individuo in modo univoco,
ma ambiguamente.
A proposito dei sintagmi denotativi, pertanto, si possono distinguere tre casi:
«(1) un sintagma può essere denotativo, eppure non denotare alcunché; p.e. “l’attuale re di Francia”.
(2) Un sintagma può denotare un oggetto definito; p.e. “l’attuale re d’Inghilterra” denota una certa persona. (3)
Un sintagma può denotare ambiguamente; p.e. “un uomo” denota non già molti uomini, ma un uomo imprecisato.
Russell ritiene che la formulazione di una teoria logica che permetta, in modo sistematico, di
analizzare tali espressioni linguistiche non è un compito facile. La questione è però importante, perché è strettamente connessa alla nostra conoscenza del mondo esterno, al modo in cui questa si forma e alle basi logiche su cui si fonda:
«L’argomento della denotazione riveste una grandissima importanza non solo in logica e in matematica, ma anche nella teoria della conoscenza. Per esempio, noi sappiamo che il centro di massa del sistema solare, a un determinato istante, è qualche punto definito, e su di esso possiamo affermare un certo numero di proposizioni; tuttavia, non abbiamo alcuna conoscenza diretta di questo punto, che ci è noto soltanto per descrizione».
L’argomentazione di Russell procede dapprima enunciando la teoria, quindi criticando le teorie alternative proposte da Frege e da Meinong e, infine, esponendo gli argomenti che sostengono
la propria teoria, con le relative conseguenze sul piano gnoseologico.
«La mia teoria è, in breve, la seguente. Assumo come fondamentale la nozione di variabile; uso “C
(x)” per indicare una proposizione104 in cui x è un costituente, dove x, la variabile, è essenzialmente e totalmente indeterminata. Possiamo poi prendere in considerazione le due nozioni “C (x) è sempre vera” e “C (x) è talvolta vera”105. Tutto, niente e qualcosa (che sono i sintagmi denotativi più primitivi) vanno dunque interpretati
nel modo seguente:
C (tutto) significa “C (x) è sempre vera”;
C (niente) significa “‘C (x) è falsa’ è sempre vera”;
C (qualcosa) significa “È falso che ‘C(x) è falsa’ è sempre vera”106»
104
Più esattamente, una funzione preposizionale [nota di Russell].
La seconda di queste nozioni può essere definita per mezzo della prima, se assumiamo che significhi “Non è vero
che ‘C(x) è falsa’ è sempre vera” [nota di Russell].
106
Anziché questo sintagma complicato, talvolta userò il sintagma “C (x) non è sempre falsa” oppure “C (x) è talvolta
vera”, che per definizione sono intese a significare lo stesso che il sintagma complicato [nota di Russell].
105
37
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica – Seminario di Epistemologia 2010
A partire dalla disamina dei casi di denotazione ambigua (o descrizioni indefinite), Russell
si sofferma soprattutto sul caso dei sintagmi introdotti da “il”, che sono quelli «di gran lunga più interessanti e difficili».
«Si consideri per esempio “il padre di Carlo II fu giustiziato”. Questa proposizione asserisce che c’era
un x che era il padre di Carlo II e fu giustiziato. Ora, il, quando sia usato in modo rigoroso, comporta unicità
[...]. Nel corso delle nostre argomentazioni, assumeremo dunque che il comporta unicità. Così, quando diciamo
“x era il padre di Carlo II” non solo affermiamo che x aveva una certa relazione con Carlo II, ma anche che
nient’altro aveva questa relazione. […] Per ottenere un equivalente di “x era il padre di Carlo II”, dobbiamo
aggiungere “Se y è altro da x, y non generò Carlo II”, oppure, ciò che è equivalente, “Se y generò Carlo II, y è
identico a x”. Pertanto, “x è il padre di Carlo II” diventerà “x ha generato Carlo II; e ‘se y ha generato Carlo II,
y è identico con x’ è sempre vera di y”».
In base a queste definizioni e a quanto detto sopra, l’enunciato “il padre di Carlo II fu giustiziato” diventa: «Non è sempre falso di x che x generò Carlo II e che x fu giustiziato e che ‘se y generò Carlo II, y è identico con x’ è sempre vera di y». Il significato di questa proposizione è il seguente: “Non è sempre falso” indica che, almeno una volta, è stato vero che “x generò Carlo II e che
x fu giustiziato”. Ora, però, la particella il comporta unicità, la quale è garantita dalla seconda parte
dell’enunciato: se esiste un altro individuo y che, allo stesso tempo, ha generato Carlo II e fu giustiziato, allora tale individuo y non può che essere identico con x.
In conclusione, afferma Russell, «la teoria sopra esposta mette capo alla riduzione di tutte le
proposizioni in cui figurano sintagmi denotativi a forme da cui sono essi assenti». Egli riconosce
che questa soluzione è poco naturale, ma ritiene anche che, come mostrerà nell’ultima parte del lavoro, essa permette di risolvere il problema degli “oggetti impossibili” ed altri enigmi logici simili.
Il logico inglese passa ora ad esaminare le teorie alternative:
«Gli argomenti in favore della teoria in questione sono tratti dalle difficoltà in cui si incorre inevitabilmente se si considerano i sintagmi denotativi come segni di autentici costituenti delle proposizioni nelle cui
espressioni verbali essi occorrono. Di tutte le possibili teorie che ammettono tali costituenti la più semplice è
quella di Meinong […]. Essa considera ogni sintagma denotativo grammaticalmente corretto come segno di un
oggetto. Così, “l’attuale re di Francia”, “il quadrato rotondo”, ecc. sono ritenuti autentici oggetti. Si ammette
che oggetti simili non sussistono, ma li si considera pur sempre oggetti. Questo punto di vista è già di per sé
poco convincente, ma l’obiezione principale, nei suoi confronti è che questi oggetti sono senz’altro tali da violare il principio di contraddizione. Per esempio, si afferma che l’attuale re di Francia esistente esiste, e anche
che non esiste; che il quadrato rotondo è rotondo, e anche che non è rotondo, e via dicendo. Ma tutto ciò non è
ammissibile, e se si scopre che una qualsiasi teoria evita simili conclusioni, essa è certamente preferibile».
In Frege non è presente tale violazione del principio di contraddizione. Tuttavia, la distinzione che egli opera tra senso e denotazione non è soddisfacente e va incontro ad alcune difficoltà.
In base alla distinzione di Frege,
«“il centro di massa del sistema solare all’inizio del XX secolo” è un sintagma estremamente complesso nel senso, ma la sua denotazione è un certo punto, che è semplice».
In tal modo,
«Il sistema solare, il XX secolo, ecc., sono costituenti del senso; ma la denotazione non ha affatto costituenti107».
107
Frege distingue sempre i due elementi senso e denotazione, e non solo nel caso dei sintagmi denotativi complessi.
Così, sono i sensi dei costituenti di un complesso denotativo che entrano nel suo senso, non le loro denotazioni. Secondo Frege, nella proposizione “Il Monte Bianco è alto più di mille metri” è il senso de “Il Monte Bianco”, non la montagna reale, a essere un costituente del senso della proposizione [nota di Russell].
38
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica – Seminario di Epistemologia 2010
Un vantaggio della posizione di Frege è che permette di comprendere la differenza che c’è
tra espressioni apparentemente sinonime, come ad esempio “Walter Scott” e “l’autore di Waverley”.
Pur denotando lo stesso individuo, infatti, questi sintagmi danno un’informazione diversa.
La teoria di Frege, però, è carente nel caso dei sintagmi denotativi che non denotano alcunché. Un enunciato come “l’attuale re di Inghilterra è calvo” sembrerebbe affermare qualcosa di ben
preciso riguardo ad un individuo concreto, “l’attuale re d’Inghilterra”. Tuttavia, se si considera
l’enunciato, apparentemente simile, “l’attuale re di Francia è calvo”, anche questo dovrebbe dire
qualcosa circa l’individuo denotato dal sintagma “l’attuale re di Francia”.
Si osserva però che questo sintagma,
«pur avendo un senso, ammesso che l’abbia “il re di Inghilterra”, non ha certo alcuna denotazione, per
lo meno in un qualsiasi senso ordinario della parola. Di qui la supposizione che “il re di Francia è calvo” debba
essere un nonsenso: ma non lo è, dato che è semplicemente una proposizione falsa».
È difficile però, secondo Russell, riconoscere a prima vista che l’enunciato “il re di Francia
è calvo” è un nonsenso. Tutti, infatti, siamo in grado di comprenderlo e, magari, possiamo anche
immaginare che ad esso corrisponda veramente un individuo che è attualmente re di Francia. Ma se
ha un senso, qual è allora, secondo la teoria di Frege, la sua denotazione?
«Ci troviamo così costretti o a fornire una denotazione nei casi in cui essa è a prima vista assente, oppure ad abbandonare la tesi che la denotazione è ciò su cui vertono le proposizioni contenenti sintagmi denotativi. Il secondo orientamento è quello da me sostenuto».
Il primo orientamento, invece, è quello fatto proprio da Meinong, per il quale, come visto,
sussistono oggetti che tuttavia non esistono. Anche Frege, però, compie un’operazione simile, nella
misura in cui fornisce, mediante definizione,
«qualche denotazione puramente convenzionale nei casi in cui non ci sarebbe, altrimenti, alcuna denotazione. Così, “il re di Francia” deve denotare la classe nulla; “l’unico figlio di Tizio” (che ha qualcosa come
dieci figli) deve denotare la classe di tutti i suoi figli, e così via. Tuttavia, anche se non conduce a nessun effettivo errore logico, questo procedimento è del tutto artificioso e non fornisce un’analisi esatta della situazione.
Così, se ammettiamo che in genere i sintagmi denotativi hanno tanto un senso quanto una denotazione, i casi in
cui sembra non esserci alcuna denotazione fanno sorgere delle difficoltà, sia assumendo che ci sia effettivamente una denotazione, sia assumendo che in realtà non ce ne sia nessuna».
Ora, secondo Russell la teoria delle descrizioni riesce a risolvere queste difficoltà. Per dimostrarlo, il logico inglese la sottopone alla prova di alcuni enigmi, giacché ritiene che
«una teoria logica può essere messa alla prova verificando la sua capacità di risolvere enigmi, ed è
quindi consigliabile, quando si discorre di logica, tenere in serbo il maggior numero possibile di enigmi, dal
momento che essi svolgono una funzione del tutto analoga a quella degli esperimenti in fisica. Formulerò dunque tre enigmi che una teoria della denotazione dovrebbe essere in grado di risolvere. Successivamente, mostrerò che la mia teoria riesce effettivamente a risolverli».
L’importanza riconosciuta da Russell al ruolo svolto dall’enigma in logica e in filosofia, non
è un semplice artificio retorico. Si può considerare, da un lato, come il risultato dell’estensione della
metodologia matematica ai problemi filosofico-gnoseologici e, dall’altro, come il primo passo di un
tipo di indagine filosofica che sarà fatta propria dalla filosofia analitica successiva. Tra l’altro, come
vedremo, è proprio la costruzione di enigmi per mettere alla prova o confutare una teoria, uno degli
aspetti più importanti del metodo filosofico inaugurato da Wittgenstein nelle Ricerche filosofiche.
L’uso di enigmi e di cosiddetti “esperimenti mentali”, infine, si rivelerà uno dei caratteri distintivi
di quello stile che, come abbiamo visto all’inizio di questo lavoro, è probabilmente l’unico elemento
distintivo della tradizione analitica su cui gli interpreti concordino.
Gli enigmi formulati da Russell sono tre, anche se, nei limiti di questa analisi, è sufficiente
occuparsi dei primi due:
39
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica – Seminario di Epistemologia 2010
«(1) Se a è identico a b, qualunque cosa sia vera dell’uno è vera anche dell’altro, e ognuno dei due potrà essere sostituito dall’altro in qualsiasi proposizione senza alterare la verità o la falsità di quella proposizione. Ora, Giorgio IV voleva sapere se Scott era l’autore di Waverley; e di fatto Scott era l’autore di Waverley.
Possiamo dunque sostituire l’autore di Waverley con Scott, e dimostrare così che Giorgio IV voleva sapere se
Scott era Scott. È però difficile attribuire al primo gentiluomo d’Europa un qualche interesse per il principio di
identità.
(2) Per il principio del terzo escluso, o “A è B” o “A non è B” deve essere vera. Pertanto, o “l’attuale
re di Francia è calvo” o “l’attuale re di Francia non è calvo” deve essere vera. Se però elencassimo da una parte
tutte le cose che sono calve e dall’altra quelle che non lo sono, in nessuna delle due liste troveremmo l’attuale
re di Francia. Gli hegeliani, che amano le sintesi, ne concluderebbero probabilmente che egli porta la parrucca».
Prima di applicare la propria teoria a questi enigmi, Russell presenta altre carenze della distinzione di Frege tra senso e denotazione, ricorrendo all’argomento noto come “Gray’s Elegy argument”. Si tratta di una parte dell’articolo molto poco chiara e che, per questo, ha sollecitato particolarmente l’attenzione della critica. Senza pretendere di esaurire la questione, perciò, cercheremo
di esplicitarne soltanto i passaggi fondamentali.
Nella distinzione di Frege, esistono forme linguistiche chiamate “sintagmi denotativi”, i quali hanno un senso ed una denotazione. Un sintagma denotativo è dunque un’entità distinta tanto dal
suo senso, quanto dalla sua denotazione. Di conseguenza, è possibile formulare proposizioni circa
un sintagma, ossia affermare o negare qualcosa del sintagma stesso.
Ad esempio, esemplifica Russell, si può dire che il centro di massa del sistema solare è un
punto e non un complesso denotativo, oppure che “Il centro di massa del sistema solare” è un complesso denotativo e non un punto. Il modo più naturale per distinguere tra quando parliamo del senso di un sintagma denotativo e quando parliamo della sua denotazione, pertanto, sembra consistere
nel servirsi delle virgolette.
Così, ad esempio, quando parliamo del sintagma denotativo “l’autore di Waverley”, possiamo riferirci al suo senso o alla sua denotazione. Se ci riferiamo al suo senso, allora intendiamo
qualcosa tipo “l’unico uomo che scrisse Waverley”; se parliamo invece della denotazione, allora ci
riferiamo all’individuo “Scott”. In altri termini, se affermiamo 1) «L’autore di Waverley è una persona, non un sintagma denotativo», questa proposizione include il sintagma “L’autore di Waverley”
come costituente, ma non parla del sintagma, bensì dello scrittore; al contrario, se affermiamo 2)
«“L’autore di Waverley” è un sintagma, non una persona», allora questa proposizione concerne il
sintagma stesso, e non la sua denotazione.
In conclusione, se C è un qualunque sintagma denotativo, quando in una proposizione occorre C, ciò di cui parliamo è la denotazione del sintagma denotativo; quando invece occorre “C”, allora parliamo del suo senso. La domanda che si pone Russell è: che cos’è “C”? è qualcosa di diverso
da C o si tratta della stessa entità? E in che rapporto stanno C e “C” con il sintagma stesso?
Fatte queste premesse, possiamo considerare l’esempio: “Il primo verso dell’Elegy di Gray
afferma una proposizione”108. Con questa proposizione, intendiamo dire che ‘The curfew tolls the
knell of parting day’ è una proposizione109. Ma se diciamo “‘Il primo verso dell’Elegy di Gray’ non
afferma una proposizione”, intendiamo dire che il sintagma “Il primo verso dell’Elegy di Gray” non
è una proposizione, dato che manca del verbo.
Così, quando parliamo di C, ci riferiamo alla denotazione del sintagma “Il primo verso
dell’Elegy di Gray”, mentre se parliamo di “C”, allora non ci si riferisce alla denotazione, ma al
senso del complesso denotativo.
Questa distinzione, però, comporta secondo Russell alcune difficoltà. Se C è l’enunciato “Il
primo verso dell’Elegy di Gray”, allora C denota “The curfew tolls the knell of parting day”. Quando intendiamo parlare del senso, possiamo farlo soltanto attraverso la denotazione: se, infatti, par-
108
109
Si riferisce alla Elegy Written in a Country Churchyard (1751) del poeta inglese Thomas Gray (1716-1771).
«Il coprifuoco suona il rintocco funebre del giorno che finisce».
40
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica – Seminario di Epistemologia 2010
liamo del “senso di C”, allora otteniamo il “senso di ‘The curfew tolls the knell of the parting day’”,
che non è la stessa cosa de “il senso de ‘il primo verso dell’Elegy di Gray’”.
Così, sembra che se vogliamo parlare del “senso di C”, dobbiamo parlare del “senso di ‘C’”.
Ma il “senso di ‘C’” non è altro che “C” stesso.
«[…] “Il senso del primo verso dell’Elegy di Gray” è lo stesso che “Il senso di ‘The curfew tolls the
knell of parting day’”, ma non è lo stesso che “Il senso de ‘Il primo verso dell’Elegy di Gray’”».
“Il primo verso dell’Elegy di Gray”, in altri termini, denota il verso “The curfew tolls the
knell of parting day”, ma esprime il senso per il quale, per così dire, queste parole sono quelle che
troviamo nel verso che appare per primo all’inizio dell’elegia di Gray. Quando parliamo del senso
di C, dunque, parliamo del senso della denotazione, cioè del senso dei versi “The curfew tolls the
knell of parting day”; quando parliamo del senso di “C”, invece, ci riferiamo al senso dell’enunciato
C, e torniamo nuovamente a parlare della denotazione.
Problemi analoghi sorgono nel caso della denotazione. Se intendiamo parlare de “La denotazione del primo verso dell’Elegy di Gray”, ciò equivale a “La denotazione di C”. Ma, se C è “Il
primo verso dell’Elegy di Gray”, allora “La denotazione di C” è equivalente a “La denotazione del
primo verso dell’Elegy di Gray”, ossia “The curfew tolls the knell of parting day”.
Queste difficoltà, secondo Russell, dimostrano che la distinzione tra sintagma denotativo,
senso e denotazione è problematica. È preferibile dunque evitarla e parlare soltanto di sensi complessi (o descrizioni) che, a volte, denotano qualcosa.
«La difficoltà che si incontra quando si vuole parlare del senso di un complesso denotativo può essere
così formulata: non appena inseriamo il complesso in una proposizione, la proposizione verte sulla denotazione; e se formiamo una proposizione in cui il soggetto è “il senso di C”, allora il soggetto è il senso della denotazione (ammesso che ve ne sia uno): ma non è certo questo che volevamo. Siamo così indotti a dire che,
quando distinguiamo senso e denotazione, ci troviamo a trattare del senso: il senso ha denotazione ed è complesso, e non c’è nulla al di fuori del senso che possa essere chiamato il complesso denotativo e di cui si possa
dire che ha senso e denotazione. Secondo il punto di vista in questione, se ci si volesse esprimere propriamente
si dovrebbe dire che alcuni sensi hanno denotazioni».
Questo, però, secondo Russell non fa che evidenziare le difficoltà connesse alla stessa nozione di senso. Anche se, invece di dire che complesso denotativo C ha un determinato senso, diciamo che C è il suo senso, tuttavia incorriamo in alcune difficoltà:
«[…] Ogni qual volta C compare senza virgolette, ciò che viene detto non è vero del senso, ma solo
della denotazione, come quando diciamo: Il centro di massa del sistema solare è un punto. Così, perché si parli
dello stesso C, ossia perché si enunci una proposizione circa un senso, è necessario che il nostro soggetto non
sia C, ma qualcosa che denota C. “C”, che è ciò che usiamo quando vogliamo parlare del senso, non deve dunque essere il senso, ma qualcosa che denota il senso. E C non deve essere un costituente di questo complesso
(come lo è de “il senso di C”): infatti, se C figura nel complesso, a figurare sarà la sua denotazione e non il suo
senso, e non c’è nessuna strada che permetta di tornare dalle denotazioni ai sensi, dato che ogni oggetto può essere denotato da un numero infinito di frasi denotative diverse».
Ciò che Russell afferma, in conclusione, è che dovremmo evitare di parlare di un sintagma
denotativo attraverso una proposizione che contiene il sintagma medesimo. Si tratta, in generale, di
una versione dei paradossi dell’autoriferimento e la teoria delle descrizioni definite dovrebbe servire
ad evitarli. Nel caso delle descrizioni, il problema nasce perché la forma grammaticale del sintagma
denotativo ci induce a trattarlo come se fosse un nome e, dunque, qualcosa di semplice. Invece, la
teoria delle descrizioni scompone il senso del sintagma, per così dire, nei suoi costituenti, in modo
che ogni proposizione in cui esso compare può essere ricondotta a un’altra in cui esso è assente.
Questo punto di vista, secondo il logico inglese, permette di risolvere gli enigmi proposti
sopra. L’idea fondamentale è che un sintagma denotativo è tale che, considerato isolatamente, non
ha un senso, ma solo, a volte, una denotazione. Esso è, cioè, soltanto una parte di un enunciato,
all’interno del quale ha senso.
41
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica – Seminario di Epistemologia 2010
«Se dico “Scott era un uomo”, questa è un’asserzione della forma “x era un uomo”, e non ha come
soggetto “l’autore di Waverley”. Abbreviando l’asserzione fatta all’inizio di questo articolo, al posto de
“l’autore di Waverley era un uomo” potremmo mettere “Una e soltanto una entità scrisse Waverley e questa entità era un uomo”. (Strettamente parlando, ciò non corrisponde a quanto affermato prima, ma è più facile da seguire)».
«[…] L’enigma circa la curiosità di Giorgio IV risulta ora risolvibile in modo semplicissimo. La proposizione “Scott era l’autore di Waverley” […] non contiene alcun costituente “l’autore di Waverley” cui sia
possibile sostituire “Scott”».
La formulazione dell’enigma su Giorgio IV, infatti, diventa: “Giorgio IV voleva sapere se
esiste un’entità che è un uomo e che ha scritto Waverley e se Scott era quell’entità”. Dato che non
compare più il sintagma “l’autore di Waverley”, non possiamo operare la sostituzione di esso con
Scott che, come visto, aveva dato origine all’enigma.
L’applicazione di questo risultato, però, non è sempre univoca. Russell osserva che è necessario distinguere due casi in cui, in una proposizione, occorrono i sintagmi denotativi. Se C=“Scott
era l’autore di Waverley”, quando diciamo P=“Giorgio IV desiderava sapere se C”, C deve essere
una proposizione. C contiene, nell’esempio, il sintagma denotativo “L’autore di Waverley”. Tale
sintagma, dunque, è sia una parte della proposizione subordinata C, sia una parte dell’intera proposizione P.
Questo può comportare un’ambiguità, perché possiamo eliminare il sintagma “L’autore di
Waverley” soltanto da C oppure dall’intera P.
«A seconda della scelta che facciamo, risulteranno proposizioni diverse. […] Quando diciamo “Giorgio IV voleva sapere se Scott era l’autore di Waverley”, normalmente intendiamo dire: “Giorgio IV voleva sapere se uno e un solo uomo scrisse Waverley e se Scott era quell’uomo”; ma possiamo anche voler dire: “Uno e
un solo uomo scrisse Waverley, e Giorgio IV voleva sapere se Scott era quell’uomo”».
Russell indica questi casi, rispettivamente, come occorrenza primaria e occorrenza secondaria del sintagma denotativo: nel secondo caso, esso ha un’occorrenza primaria perché, come è evidente, si dà per scontato che esiste un uomo che scrisse Waverley; nel primo caso, invece, si ha una
occorrenza secondaria, e non sappiamo se un tale uomo affatto esiste.
Da ciò si evince la soluzione dell’enigma relativo al re di Francia. In generale,
«Se “C” è un sintagma denotativo, per esempio “il termine che ha la proprietà F”, allora “C ha la proprietà φ” significa “uno e un solo termine ha la proprietà F, e questo termine ha la proprietà φ”110».
«Se quindi la proprietà F non appartiene ad alcun termine, o a più di uno, ne segue che “C ha la proprietà φ” è falsa per tutti i valori di φ».
Nel caso della proposizione “L’attuale re di Francia è calvo”, si hanno perciò due casi: indicando con C il sintagma “l’attuale re di Francia”, allora, se la proposizione significa “C è un’entità
che è ora re di Francia e che non è calva”, allora si tratta chiaramente di una proposizione falsa,
giacché è una congiunzione di due proposizioni, la prima delle quali è falsa.
Se invece significa “È falso che ci sia un’entità che è ora re di Francia ed è calva”, allora è
certamente vera, perché di fatto non esiste alcuna entità del genere:
«In altri termini, “Il re di Francia non è calvo” è falsa se l’occorrenza de “il re di Francia” è primaria,
mentre è vera se l’occorrenza è secondaria. Così, tutte le proposizioni in cui “il re di Francia” ha un’occorrenza
primaria sono false; le negazioni di tali proposizioni sono vere, ma in questo caso “il re di Francia” ha
un’occorrenza secondaria. In questo modo evitiamo la conclusione che il re di Francia porti la parrucca».
110
Questa è l’interpretazione abbreviata, non la più rigorosa [nota di Russell].
42
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica – Seminario di Epistemologia 2010
Questa conclusione si rivela particolarmente interessante nel caso di sintagmi che denotano
entità non esistenti:
«L’intero regno delle non-entità quali “il quadrato rotondo” “il numero primo pari diverso da 2”, “Apollo”, “Amleto”, ecc. costituisce ora un problema risolvibile in modo soddisfacente. Si tratta di sintagmi denotativi che non denotano alcunché. […] “il quadrato rotondo è rotondo” significa “c’è una e una sola entità x
che è rotonda e quadrata, e questa entità è rotonda”, che è una proposizione falsa e non vera, come sostiene
Meinong. […] La nostra teoria della denotazione ci consente invece di affermare che non ci sono individui irreali, cosicché la classe nulla è la classe che non contiene alcun membro, non già la classe contenente come
membri tutti gli individui irreali».
43
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica – Seminario di Epistemologia 2010
4 – CONCLUSIONE: LE DUE VIE DELLA FILOSOFIA ANALITICA DOPO WITTGENSTEIN.
L’esame sin qui condotto di alcuni dei testi ritenuti fondamentali per la nascita del movimento analitico, rende possibile elaborare alcune considerazioni conclusive ed indicare due vie
principali di sviluppo della riflessione successiva. Non si può naturalmente considerare la questione
in tutti i suoi aspetti, anche perché quelle che qui presentiamo come “vie di sviluppo” sono ormai
diventate, a loro volta, vere e proprie correnti del dibattito più recente. Pertanto, nella parte finale di
questa conclusione tenteremo anche di accennare brevemente alle tendenze più recenti.
Dalle analisi svolte nei capitoli precedenti sono emerse alcune tesi che si possono considerare distintive della filosofia analitica delle origini e che, in alcuni casi, ancora oggi accomunano i filosofi che si rifanno a tale movimento.
In primo luogo, la filosofia analitica si specifica come metodo di analisi del linguaggio, partendo dalla convinzione che quest’ultimo costituisce l’espressione sensibile del pensiero. A questo
proposito, il contributo di Frege risulta determinante, nella misura in cui, applicando al linguaggio
un procedimento di analisi già in uso nella cultura filosofica della fine del XIX secolo, opera una
svolta dall’analisi del pensiero all’analisi della proposizione, ossia del contenuto oggettivo degli enunciati che esprimono il pensiero stesso.
In secondo luogo, dalla svolta linguistica deriva la questione principale del significato o riferimento delle nostre espressioni linguistiche. Il contenuto oggettivo delle proposizioni, infatti, risulta inizialmente una entità dallo statuto non ben definito e che, ad esempio nel caso degli enti matematici, fa sorgere problemi circa il loro statuto ontologico. La riflessione sullo statuto dei significati
e sulle modalità del riferimento sarà uno dei percorsi di ricerca più importanti della filosofia analitica successiva.
In terzo luogo, l’analisi del significato rimanda nuovamente al problema tradizionale del
rapporto tra il linguaggio ed il pensiero. Aver invertito l’ordine di priorità dell’analisi filosofica, infatti, non elimina il problema della relazione che lega il pensare al parlare, non risolve cioè le questioni relative all’attribuzione di senso, alla comprensione dei significati, alla corrispondenza tra le
parole e le cose, e così via. Su questa base si comprende perché la ricerca odierna in filosofia analitica tenda a superare la prospettiva strettamente linguistica, rivalutando la dimensione cognitiva,
come testimoniano le numerose indagini sul rapporto mente/corpo, mente/cervello, sulle neuroscienze, ecc.
In quarto luogo, nella considerazione delle questioni filosofiche tradizionali, soprattutto sulla scorta delle prese di posizione di Frege e Russell, almeno alle origini è stato privilegiato il metodo dell’analisi logica. Il nostro consueto modo di espressione, il nostro linguaggio ordinario, non è
infatti uno strumento adatto per portare alla luce le strutture logiche fondamentali che il linguaggio,
il pensiero e la realtà hanno in comune per potersi rispecchiare l’uno nell’altro. Il ricorso al simbolismo logico, secondo i pensatori che abbiamo esaminato, permette invece di eliminare le numerose
“vesti” quotidiane che nascondono il contenuto oggettivo del linguaggio. Attraverso tale simbolismo, inoltre, si può sviluppare una metodologia di analisi che prende in considerazione soltanto gli
aspetti per cui il linguaggio è una descrizione della realtà o, nel caso della stessa logica,
un’immagine delle condizioni che rendono possibile ogni descrizione. I problemi tradizionali della
filosofia così, almeno secondo alcuni esponenti della tradizione analitica, tendono ad essere riguardati come privi di consistenza effettiva. D’altra parte, però, già dalla seconda metà del Novecento,
alcuni esponenti della filosofia analitica tendono a recuperare visioni più generali e onnicomprensive dei problemi filosofici, instaurando, in tal modo, un confronto meno aspro e più costruttivo con
autori della tradizione continentale e tornando ad occuparsi di quelle questioni che, almeno agli inizi, erano state interpretate come pseudo-problemi.
Questi elementi che sono emersi come distintivi della tradizione analitica trovano, almeno
inizialmente, una sorta di sistematizzazione nell’opera di Wittgenstein: oltre a collocarli nell’ambito
di una concezione filosofica unitaria, egli ne coglie gli sviluppi soprattutto in senso etico e riguardo
al ruolo della filosofia. Se il nucleo del linguaggio è logico ed è limitato alla descrizione della real44
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica – Seminario di Epistemologia 2010
tà, allora alla filosofia non può spettare il compito di dire, attraverso questo linguaggio, cose che,
per loro natura, ne superano i limiti. Essa non potrà che essere una chiarificazione del linguaggio,
volta a mostrare quell’ambito di questioni che, propriamente, questioni non sono, giacché non possono nemmeno venir correttamente formulate.
Alcuni pensatori hanno interpretato queste conclusioni di Wittgenstein nel senso che i problemi tradizionali della filosofia sono pseudo-problemi e che, pertanto, non spetti alla filosofia occuparsene. Si tratta di quel gruppo di pensatori raccolti soprattutto attorno al cosiddetto “Circolo di
Vienna” e da cui si sviluppò il movimento del Neopositivismo o empirismo logico.
Il Circolo di Vienna si costituì inizialmente attorno alla figura di Moritz Schlick, professore
alla Università di Vienna. Tra i suoi membri vi furono Rudolf Carnap, Herbert Feigl, Kurt Gödel,
Hans Hahn, Karl Menger, Otto Neurath e Friedrich Waismann. Le origini del gruppo risalgono al
1907, anno in cui Otto Neurath, Hans Hahn e il fisico Philipp Frank, tutti professori a Vienna, cominciarono ad incontrarsi in un caffè per discutere le tesi principali dell’empirismo di Ernst Mach
ed il convenzionalismo di Henry Poincaré. Soprattutto, però, essi rivendicavano la necessità di portare un nuovo spirito scientifico nella discussione filosofica, al fine di elaborare metodologie di indagine più chiare ed un linguaggio meno ambiguo di quello tradizionale.
Nel 1922, su proposta di Hahn a Schlick fu assegnata la cattedra di Filosofia delle scienze,
che in precedenza era stata di Mach. Il fisico tedesco Hans Reichenbach, che conosceva Rudolf
Carnap, lo fece a sua volta conoscere a Schlick nel 1924. Nel 1925 Carnap tenne una relazione ai
membri del Circolo di Vienna, dove propose una teoria che, chiaramente influenzata da Mach, riconduceva la conoscenza a dati elementari immediati. Nel 1926, infine, Carnap ottenne un posto di
assistente con Schlick e le sue idee cominciarono ad essere discusse in modo approfondito negli incontri del Circolo.
Come sappiamo, nel 1921 il Tractatus di Wittgenstein uscì sulla rivista Annalen der Naturphilosophie, mentre il suo autore aveva abbandonato la filosofia accademica e si era trasferito a
Trattenbach, in Austria, come insegnante di scuola elementare. Nel 1922 il matematico Hans Hahn
tenne un seminario sul Tractatus a Vienna e le idee che vi erano esposte attirarono l’attenzione di
Schlick, il quale vi ritrovava molti elementi dell’empirismo di Mach.
Schlick, che era solito frequentare la casa della sorella di Wittgenstein, per suo tramite conobbe Ramsey e, nel 1924, scrisse una lettera a Wittgenstein, nella quale manifestava il desiderio di
conoscerlo e di parlare del Tractatus. Wittgenstein, però, nel frattempo si era trasferito ad insegnare
nella scuola del piccolo paese di Puchberg. Dopo altri tentativi non riusciti, finalmente Schlick, insieme ad un gruppo di allievi, riuscì ad incontrarlo, nell’aprile del 1926, ad Otterthal.
I due continuarono ad incontrarsi regolarmente per un certo periodo e Schlick riferiva di
questi incontri ai membri del gruppo di Vienna. Quando Wittgenstein tornò a Vienna, gli incontri si
fecero più frequenti. Tuttavia, Wittgenstein non partecipò mai alle sedute ufficiali del Circolo di
Vienna, che si tenevano il giovedì sera. Invece, già nell’estate del 1927 era solito incontrarsi regolarmente il lunedì sera con un gruppo più ristretto, che comprendeva Carnap, Waismann e Feigl.
Wittgenstein, però, gestiva gli incontri in modo piuttosto particolare ed alcuni, tra cui lo
stesso Carnap, ne rimasero delusi. Si aspettavano, infatti, che egli utilizzasse la filosofia
dell’atomismo logico per negare il valore della metafisica. In realtà, si resero conto che la sua posizione era ben diversa. Come scrisse Carnap: «Quando avevamo letto il libro di Wittgenstein al
“Circolo” mi ero convinto, in maniera affatto erronea, che il suo atteggiamento nei confronti della
metafisica fosse simile al nostro. Non avevo prestato la dovuta attenzione alle varie affermazioni di
stampo mistico presenti nel suo libro»111.
Ciò nonostante, l’idea di Wittgenstein per la quale tutte le proposizioni sono connessioni vero-funzionali di proposizioni elementari fu combinata da Carnap con quella per cui i concetti scientifici sono costruiti sulla base delle esperienze elementari. Questa concezione divenne il sostrato ideologico del movimento e trovò espressione, nel 1929, nel celebre “manifesto” dell’empirismo lo111
R. CARNAP, Autobiografia intellettuale, in P.A. SCHLIPP (a cura di), La filosofia di R. Carnap, tr. it. a cura di M.G.
de Cristofaro Sandrini, Il Saggiatore, Firenze 1974, vol. 1, p. 27.
45
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica – Seminario di Epistemologia 2010
gico, la Wissenschaftliche Weltauffassung: Der Wiener Kreis, pubblicato a Vienna. Lo scritto, dedicato a Schlick, fu elaborato da Carnap, Hahn e Neurath.
Gli anni Trenta furono quelli più importanti per il diffondersi delle idee del Circolo di Vienna. Nel 1929 la Deutsche physikalischer Gesellschaft e la Deutsche mathematiker Vereinigung organizzarono un congresso a Praga, al quale presero parte sia i circolisti di Vienna che i membri della Berliner Gesellschaft für empirische Philosophie, ossia il gruppo di filosofi e scienziati che comprendeva, tra gli altri, H. Reichenbach, W. Dubislav e C.G. Hempel, e che divenne poi noto come
“Circolo di Berlino”. Il congresso di Praga fu l’occasione per presentare alla comunità scientifica le
idee della Weltauffassung e per stabilire un solido legame con il gruppo berlinese.
Nel 1930 Carnap e Dubislav fondarono la rivista «Erkenntnis», che ben presto divenne
l’organo ufficiale del nuovo movimento. Ancora nello stesso anno i due gruppi organizzarono un
convegno a Königsberg, nel quale si discusse soprattutto di matematica e di fisica quantistica.
All’inizio degli anni Trenta il movimento aveva ormai contatti con gran parte della cultura
europea: nel 1931 Carnap si trasferì all’Università di Praga e i circolisti avevano relazioni in Danimarca (con J. Joergensen), in Finlandia (con E. Kaila), in Inghilterra (con A.J. Ayer e L.S. Stebbing) e con gli Stati Uniti (con Ch. Morris). L’espandersi del movimento fece da motore trainante
per organizzare un grande convegno a Parigi, nel 1935, dove, tra l’altro, venne lanciata l’idea di
procedere all’unificazione del simbolismo logico-matematico e, da parte di Neurath, di costituire
una Enciclopedia della scienza unificata.
Nel frattempo, però, morì Hahn (1934) e Schlick fu assassinato da un ex-studente sulla scalinata dell’Università di Vienna (1936). In seguito all’ascesa del nazionalsocialismo, gran parte dei
membri del circolo di Vienna e del circolo di Berlino, che erano di origine ebrea, furono costretti ad
emigrare negli Stati Uniti e in Inghilterra. Con la diaspora si concluse la fase probabilmente apicale
del neopositivismo logico, alla quale seguirono contaminazioni di vario genere e di lunga influenza,
soprattutto con la scuola logica americana e con il pragmatismo112.
Il Neopositivismo o empirismo logico costituisce dunque un primo sviluppo della filosofia
analitica e, per questa ragione, non si può considerare una corrente filosofica a se stante, bensì una
parte integrante del grande flusso principale. I suoi caratteri, in sintesi, sono quelli che portano ad
interpretare l’analisi sul modello delle scienze fisico-naturali, privilegiando, accanto a quelli della
logica formale, la metodologia ed il linguaggio delle scienze nella considerazione dei problemi filosofici. Il principio fondamentale attorno a cui ruota l’analisi del linguaggio e della conoscenza dei
neopositivisti è quello del verificazionismo: la verità di una proposizione dipende dal metodo della
sua verifica, perché il significato delle parti che la compongono consiste nella corrispondenza con
una realtà possibile.
Il verificazionismo, però, fu anche la dottrina che provocò una scissione all’interno del movimento neopositivista. Nella prima metà degli anni Trenta, infatti, si cominciò a discutere sullo statuto delle esperienze elementari che avrebbero dovuto costituire la verifica delle proposizioni della
scienza. Emblematica, a tale proposito, è l’evoluzione del pensiero di Carnap: nell’opera Der logische Aufbau der Welt113, egli sosteneva che lo statuto delle esperienze elementari fosse quello dei
dati di cui parlava Mach, ossia di elementi di natura né psichica né fisica, ma neutrali, e tuttavia
strettamente connessi al vissuto soggettivo di ciascun soggetto conoscente. Successivamente, anche
a seguito delle critiche di Neurath, Carnap distingue nella scienza le proposizioni sistematiche (ossia le leggi di natura) dalle proposizioni protocollari. Queste ultime sono, propriamente, le proposizioni che si riferiscono al dato e che permettono la verifica empirica. Il riferimento è sostanzialmente al linguaggio della fisica, le cui proposizioni diventano basilari per tutte le altre scienze e, in
quest’ordine di idee, il dato si presenta sempre nella forma di una proposizione protocollare. La
concezione fisicalista, però, fu sostenuta con maggiore insistenza da Neurath, il quale vi riconosceva l’unico modo per garantire la pubblicità e l’universalità della conoscenza scientifica: il protocollo, in definitiva, doveva essere concepito come il procedimento oggettivo con cui, nella fisica, si at112
Sul carattere peculiare della filosofia americana successiva si veda G. MARCHETTI (a cura di), Il Neopragmatismo,
La Nuova Italia, Firenze 1999.
113
Weltkreis-Verlag, Berlin 1928; tr. it. a cura di E. SEVERINO, La costruzione logica del mondo, Fabbri, Milano 1966.
46
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica – Seminario di Epistemologia 2010
testa l’esperienza e, su tale modello, andava concepito il metodo di verifica delle scienze in generale.
Quella intrapresa dal neopositivismo è però soltanto la prima delle due vie seguite dalla filosofia analitica a partire dall’inizio degli anni Trenta. Per comprendere l’altra, occorre tornare alle
vicende che riguardano il pensiero di Wittgenstein dopo il suo rientro a Cambridge.
Come si è detto, durante gli anni della sua assenza, il Tractatus aveva suscitato fervide discussioni nell’ambiente filosofico inglese. Si era fatta strada l’idea che il compito della filosofia
fosse di operare un’analisi del linguaggio ordinario, col fine di chiarirne la struttura logica ed eliminare, in tal modo, quelle ambiguità che oscuravano o, nel caso dei problemi della filosofia tradizionale, fuorviavano il pensiero.
In un primo momento, l’opera di A.J. Ayer Language, Truth and Logic (1936)114 contribuì a
diffondere le idee dei neopositivisti in Inghilterra e costituì un primo terreno di confronto per le
nuove idee. Tuttavia, i filosofi inglesi non vedevano con favore il riferimento esclusivo alla metodologia della ricerca scientifica e non erano propensi ad interpretare l’analisi di Moore, Russell e Wittgenstein nel senso del principio di verificazione e della delimitazione netta del dominio della metafisica.
Il primo filosofo ad elaborare una nozione di analisi alternativa fu John Wisdom. Inizialmente, egli fu un sostenitore dell’atomismo logico di Russell, anche se evitò di incorrere in un mero
empirismo. Utilizzò la nozione russelliana di “costruzione logica” come principio guida nell’analisi
del linguaggio, ma gli elementi semplici a cui essa perviene, secondo lui, non erano necessariamente identificabili con i “dati di senso”. L’analisi che propose era dunque prettamente linguistica e si
distingueva da quella fatta propria dal neopositivismo. In un secondo momento, però, sviluppò
sempre di più l’idea della filosofia come “terapia” nel senso delle Ricerche filosofiche di Wittgenstein, in base alla quale essa non va più intesa soltanto come l’analisi di determinati concetti o linguaggi, ma anche come indagine sulle motivazioni che inducono a preferire una data posizione speculativa. In quest’ordine di idee, egli sostiene che i problemi filosofici non si risolvono mediante
l’osservazione della realtà, ma sono l’esito di uno stato di confusione psicologica della persona che
li formula. La filosofia non è però una nevrosi, ma un paradosso su cui occorre lavorare, perché i
problemi della metafisica sono illuminanti, nella misura in cui costituiscono una via per rivelare
certi nessi e certi rapporti strutturali del reale.
Le idee di Wisdom contribuirono notevolmente a distinguere la concezione inglese
dell’analisi linguistica da quella derivante dal neopositivismo. Un primo risultato di questo nuovo
modo di intendere la filosofia fu la nascita, nel 1933, della rivista «Analysis», fondata a Cambridge
da un gruppo di studiosi, tra i quali L.S. Stebbing, già in contatto con gli esponenti del Circolo di
Vienna, e Gilbert Ryle, professore ad Oxford. La rivista si proponeva di pubblicare contributi brevi,
ma in cui fossero presenti argomentazioni per provare conclusioni ben definite su problemi circoscritti e di interesse attuale. Il tipo di problemi trattati doveva riguardare la chiarificazione di espressioni linguistiche ordinarie, riconducendole a categorie logiche ben determinate ed evitando, di conseguenza, inutili speculazioni e astrazioni. Con tali canoni, la rivista diventò il punto di riferimento
per gli autori che ispiravano al nuovo metodo di analisi e rappresentò, in Inghilterra, quello che
«Erkenntnis» era nell’ambiente tedesco.
Un’ulteriore precisazione del metodo analitico fu data da Ryle, il quale, nel saggio Systematically Misleading Expressions (1932), rinunciò all’ambizione, propria dell’atomismo logico, di ricondurre tutto il linguaggio ad una comune forma logica e parlò, invece, di errori categoriali che si
compiono quando si utilizzano certe parole in un modo che non si adatta al posto che esse occupano
nella nostra grammatica. La filosofia, così, ha il compito negativo di smascherare le espressioni che,
in modo fuorviante, sono impiegate non conformemente al loro utilizzo ordinario; essa, però, ha anche un risvolto positivo, nella misura in cui consente di elaborare una sorta di “geografia concettuale”, ossia una sistematizzazione delle categorie logiche cui appartengono i diversi concetti.
114
Gollancz, London; tr. it. di G. De Toni, Linguaggio, verità e logica, Feltrinelli, Milano 1961.
47
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica – Seminario di Epistemologia 2010
Wittgenstein e Ryle si erano conosciuti alla fine del 1929 in occasione del convegno annuale
organizzato a Nottingham dalla Aristotelian Society congiuntamente con la Mind Association e in
occasione del quale Wittgenstein aveva tenuto una conferenza sulla forma logica. Nel rigido ambiente oxoniense, dove era forte la tradizione di studi classici, soprattutto sul platonismo e
sull’aristotelismo, il nuovo metodo di indagine proposto da Wittgenstein appariva poco rigoroso e
confuso. Fu per questo che, mentre a Cambridge egli raccoglieva ormai un consenso generalizzato,
ad Oxford non riuscì inizialmente a far presa.
Fu Ryle che, per primo, contribuì a svilupparlo e a renderne più sistematici i procedimenti.
Nel maggio 1947, poi, su pressione di una sua entusiastica allieva, Elisabeth Anscombe, Wittgenstein si recò a Oxford per discutere pubblicamente un articolo sul cogito cartesiano. Egli, però,
sconcertò l’uditorio oxoniense, che arrivò quasi a considerarlo un ciarlatano per la mancanza di accuratezza e di diplomazia nelle discussioni.
A partire dagli anni Cinquanta, tuttavia, anche ad Oxford si cominciò a considerare seriamente il metodo dell’analisi linguistica e a far derivare dalla sua applicazione nuove importanti conseguenze per l’analisi del linguaggio. A compiere questi progressi fu soprattutto John Langshaw
Austin, al quale si fa risalire l’origine della corrente dei filosofi del linguaggio comune (o comunlinguisti) di Oxford. Austin rielaborò la nozione wittgensteiniana di significato come uso alla luce
dell’analisi pragmatica del linguaggio, introducendo l’importante nozione di “atto linguistico”. Con
Austin e con le sempre più strette relazioni tra i filosofi di Oxford e Cambridge, si precisò dunque
l’idea di una filosofia improntata all’analisi del linguaggio, in modo distinto dal neopositivismo, al
punto che si può legittimamente parlare di “Scuola di Oxford-Cambridge” come un quasi-sinonimo
dell’espressione “filosofia analitica”.
Ora, però, in seguito all’ascesa del Nazionalsocialismo tedesco, molti filosofi tedeschi, austriaci e polacchi facenti capo al Neopositivismo furono costretti ad emigrare dall’Europa negli Stati
Uniti d’America. Qui, oltre a diffondere le dottrine neopositiviste, essi instaurarono una vitale contaminazione con la tradizione del Pragmatismo.
Negli anni Cinquanta, pertanto, si determinò una distinzione rispetto al linguaggio oggetto
dell’analisi filosofica. Negli Stati Uniti, in forza della dominante tradizione neopositivista,
l’attenzione è rivolta al linguaggio ideale, con particolare attenzione al linguaggio della scienza, secondo la tendenza sviluppata da Rudolf Carnap, Hans Reichenbach e dai loro allievi, Willard v. O.
Quine, Peter Sellars e Nelson Goodman. In Inghilterra, invece, il dibattito si svolge attorno alla figura di Wittgenstein e tende a rilanciare il linguaggio ordinario come oggetto privilegiato
dell’analisi.
Gli anni Sessanta rappresentano il momento di convergenza delle due tradizioni, nel senso
che, soprattutto ad opera di Quine, Sellars e Goodman, l’analisi statunitense si salda più strettamente alla tradizione pragmatista, operando uno spostamento sempre più netto da una visione ideale e
scientifica del linguaggio, ad una pragmatica, venendo così ad occuparsi di temi e problemi riconducibili all’uso ordinario del linguaggio. Negli stessi anni, del resto, i maggiori esponenti della filosofia analitica inglese furono chiamati ad insegnare nelle università americane e questo fu l’inizio di
una convergenza tra le dottrine della Oxford Philosophy e quelle dell’analisi americana.
È questo, dunque, il momento apicale della filosofia analitica: essa «è conosciuta in tutto il
mondo (anche se le sedi principali restano l’Inghilterra e gli Stati Uniti) e in America è considerata
“la” filosofia in senso proprio e rigoroso»115. Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni
Sessanta comincia la presa di coscienza, da parte dei suoi esponenti, di costituire una corrente filosofica con tradizioni e problematiche proprie. Al 1967 risale infine l’importante ricostruzione di Richard Rorty, The Linguistic Turn116.
Fin qui gli storici del movimento analitico sono concordi nell’individuare le tappe del suo
sviluppo, ma, «intorno alla fine degli anni Sessanta, i vari tentativi di ricostruzione e di definizione
115
F. D’AGOSTINI, Analitici e continentali. Guida alla filosofia degli ultimi trent’anni, Raffaello Cortina Editore, Milan,
1997, p. 219.
116
Chicago University Press, Chicago; tr. it. di S. Velotti, La svolta linguistica, Garzanti, Milano 1994.
48
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica – Seminario di Epistemologia 2010
della filosofia analitica si fanno meno unanimi e lineari»117. A partire da questo periodo, infatti, si
assiste ad un complesso ripensamento dell’intero movimento analitico, che avrà come esito il pronunciamento circa la crisi o la morte della stessa nozione di analisi. Nel 1979 Rorty dichiara la fine
della filosofia analitica che, a suo dire, sopravvive solo in senso stilistico o sociologico118.
Sulla scia di Rorty, a partire dagli anni Ottanta, la situazione di incertezza ha indotto alcuni
esponenti della comunità filosofica americana a parlare di filosofia post-analitica e a profilare la necessità di liberarsi della stessa dicitura analitica119. A ciò si è reagito, da un lato, difendendo la tradizione analitica e rilanciandone il programma tradizionale e, dall’altro, cercando un’apertura ed
una via di confronto con la tradizione continentale.
Un fautore del primo programma è Michael Dummett, il quale rivaluta le componenti originarie del movimento analitico, individuate nell’opera di Frege e nella sua nozione di analisi non
psicologica del pensiero per mezzo del linguaggio120.
Tra i sostenitori della seconda linea di ricerca, invece, va ricordato Ernest Tugendhat, allievo
di Martin Heidegger, il quale ha tentato di affrontare i problemi della filosofia tradizionale con gli
strumenti della filosofia analitica, che, a suo modo di vedere, «contiene in sé l’idea di una semantica
formale in grado di assumere l’eredità dell’ontologia e della filosofia trascendentale»121. Anche
K.O. Apel, mettendo a confronto il pensiero di Wittgenstein e Heidegger, fa notare come per entrambi gli autori si tratti di revocare la metafisica occidentale come scienza teoretica e giungere ad
una posizione in cui centrale è il linguaggio122. Paul Ricoeur, inoltre, ha cercato di integrare la fenomenologia e l’analisi nell’ottica di una nuova ontologia. Sul versante analitico, infine, oltre al caso di Rorty, si hanno frequenti esempi di pensatori, come ad esempio Hilary Putnam, in costante dialogo con le acquisizioni più proprie della tradizione continentale.
A questo proposito, merita ricordare la prospettiva storiografica di Ian Hacking, secondo il
quale Wittgenstein costituirebbe un fondamentale punto di saldatura tra analitici e continentali, avendo costui consentito alla filosofia anglosassone, praticamente moribonda dopo Hume, di portarsi
al livello della filosofia continentale, superando d’un solo colpo le tappe del trascendentalismo e
dell’idealismo123. Secondo questa ipotesi storiografica, con Wittgenstein e la filosofia linguistica
non sono accentuate le divergenze ma, al contrario, è colmata una lacuna che impediva una possibile convergenza.
È comunque chiaro che la filosofia analitica attuale sta tentando di recuperare la dimensione
più schiettamente esistenziale ed etica del pensiero, impegnandosi sul piano di riflessioni più ampie
e comprensive rispetto alla mera analisi del linguaggio. Il confronto con la tradizione continentale e
con i grandi temi del pensiero, da questo punto di vista, non può che rappresentare un inevitabile
approdo della sua riflessione.
117
A. PAGNINI, Filosofia analitica, cit., p. 149.
Cfr. R. RORTY, La filosofia e lo specchio della natura, tr. it. di G. Millone e R. Sallizone, Bompiani, Milano 1986, p.
131.
119
Si vedano, a tale proposito, il volume collettaneo Post Analytic Philosophy (a cura di J. Reichmann e C. West, Columbia University Press, New York 1985) e F. RESTAINO, Filosofia e postfilosofia in America (Franco Angeli, Milano
1990).
120
Cfr. M. DUMMETT, Alle origini della filosofia analitica, tr. it. di E. Picardi, il Mulino, Bologna 1990.
121
E. TUGENDHAT, Introduzione alla filosofia analitica, tr. it. parziale di C. Salvi, Marietti, Genova 1989, p. 55.
122
K.O. APEL, Wittgenstein e Heidegger: il problema del senso dell’essere e il sospetto d’insensatezza contro ogni metafisica, in ID., Comunità e comunicazione, tr. it. a cura di G. Vattimo, Rosenberg & Sellier, Torino 1973, p. 3.
123
Cfr. I. HACKING, Linguaggio e filosofia, tr. it. di B. Sassoli, Raffaello Cortina Editore, Milano 1994, p. 213.
118
49
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica – Seminario di Epistemologia 2010
5 – BIBLIOGRAFIA.
5.1 – Testi analizzati.
G. FREGE, Funktion und Begriff, in Id., Kleine Schriften, a cura di I. Angelelli, Olms, Darmstadt 1967, 19902, pp. 125-142; tr. it. Funzione e concetto, in G. FREGE, Senso, funzione e
concetto. Scritti filosofici, a cura di C. Penco e E. Picardi, Laterza, Roma-Bari 2003, pp. 327.
G. FREGE, Über Begriff und Gegenstand, in «Zeitschrift für Philosophie und philosophische
Kritik», XVI(1892), pp. 25-250; rist. in ID., Kleine Schriften, cit., pp. 167-178; tr. it. Concetto e oggetto, in G. FREGE, Senso, funzione e concetto. Scritti filosofici, cit., pp. 58-73.
G. FREGE, Sinn und Bedeutung, in «Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik»,
100(1892), pp. 25-50; rist. in ID., Kleine Schriften, cit., pp. 143-162; tr. it., Senso e
significato, in G. FREGE, Senso, funzione e concetto. Scritti filosofici, a cura di C. Penco e E.
Picardi, Roma-Bari 2001, pp. 32-57. V. AA.VV., Filosofia del linguaggio, a cura di A. Iacona e E. Paganini, Raffello Cortina, Milano 2003pp. 18-41.
G. FREGE, Der Gedanke. Eine logische Untersuchung, in «Beiträge zur Philosophie des
deutschen Idealismus», 2(1918-1919), pp. 58—77; tr. it., Il pensiero, in G. FREGE, Ricerche
logiche, a cura di M. Di Francesco, Milano 1988, pp. 43-74.
B. RUSSELL-A.N. WHITHEAD, Introduction, in Principia Mathematica, Cambridge University Press, Cambridge 1968, vol. 1, pp. 1-84 .; tr. it. ID., Introduzione ai “Principia Mathematica”, a cura di P. Parrini, La Nuova Italia, Firenze 1977.
B. RUSSELL, On Denoting, in «Mind», 14(1905), pp. 479-493; tr. it. di A. Bonomi, Sulla denotazione, in A. Bonomi (a cura di), La struttura logica del linguaggio, Bompiani, Milano
1973, pp. 179-195.
5.2 – Introduzioni alla filosofia analitica.
F. D’AGOSTINI, Analitici e continentali. Guida alla filosofia degli ultimi trent’anni, Raffaello Cortina, Milano 1997, in part. pp. 205-295
F. D’AGOSTINI – N. VASSALLO, Storia della filosofia analitica, Einaudi, Torino 2002.
E.H. RECK (ed.), From Frege to Wittgenstein: Perspectives on Early Analytic Philosophy,
Oxford University Press, Oxford-New York 2002.
M. SANTAMBROGIO (a cura di), Introduzione alla filosofia analitica del linguaggio, Laterza,
Roma-Bari 1992.
A. PIERETTI, voce Filosofia analitica, in Enciclopedia Filosofica, Bompiani, Milano 2006,
vol. 5, pp. 4167-4191.
M. DUMMETT, Origins of Analytical Philosophy, in «Lingua e stile», 23(1988), n. 1, pp. 3-49
e n. 2, pp. 171-210; poi tr. ted. di J. Schulte, Ursprünge der analythischen Philosophie, Su-
50
MARCO BASTIANELLI – Origini della filosofia analitica – Seminario di Epistemologia 2010
hrkamp, Frankfurt a.M. 1988; tr. it. di E. Picardi, Alle origini della filosofia analitica, Il Mulino, Bologna 1990; infine Origini della filosofia analitica, Einaudi, Torino 2001.
H.-J. GLOCK, What is Analytic Philosophy?, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
A. NEWEN, Analytische Philosophie zur Einführung, Junius Verlag, Hamburg 2005; tr. it. Di
V. Zini e P. Scaltriti, Filosofia analitica. Un’introduzione, Einaudi, Torino 2010.
5.3 – Per approfondire.
- Su Frege:
M. DUMMETT, Frege: Philosophy of Language, Duckworth, London 1973; tr. it. a cura di C.
Penco, Filosofia del linguaggio: saggio su Frege, Marietti Genova 1983.
L. KREISER, Gottlob Frege: Leben-Werk-Zeit, Meiner, Hamburg 2001.
M. MARIANI, Introduzione a Frege, Laterza, Roma-Bari 1994.
C. PENCO, Vie della scrittura: Frege e la svolta linguistica, Angeli, Milano 1994.
H. SLUGA, Gottlob Frege, Routledge, London 1980.
- Su Russell:
M. DI FRANCESCO, Introduzione a Russell, Laterza, Roma-Bari 1990.
M. DI FRANCESCO, Il realismo analitico: logica, ontologia e significato nel primo Russell,
Guerini e Associati, Milano 1991.
D. KAPLAN, What is Russell's Theory of Descriptions?, in W. YOURGRAU-A. ALLEN-D.
BRECK, (eds), Physics, Logic, and History, Plenum, New York 1970, pp. 277-288; rist. in
D.F. PEARS (ed.), Bertrand Russell: A Collection of Critical Essays, Anchor Books, New
York 1972, pp. 227-244; tr. it. in La struttura logica del linguaggio, cit., pp. 386-399.
R. MONK-A. PALMER (eds), Bertrand Russell and the Origins of Analytic Philosophy,
Thoemmes Press, Bristol 1996.
W. PATTERSON, Bertrand Russell's Philosophy of Logical Atomism, Lang, New York 1993.
D.F. PEARS, Bertrand Russell and the British Tradition in Philosophy, Collins, London
1967.
51