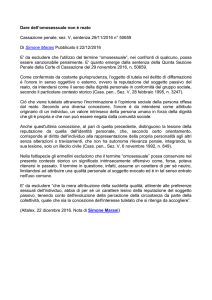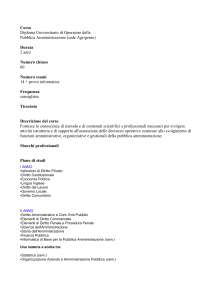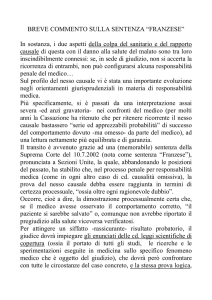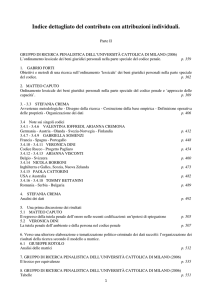LEZIONE DI DIRITTO PENALE 1
FONTI DEL DIRITTO PENALE E PRINCIPIO DI LEGALITÀ
(a cura di Massimiliano Di Pirro)
In questa lezione analizzeremo alcuni aspetti estremamente dibattuti relativi alle fonti e al
principio di legalità (inteso, quest’ultimo, nella sua latitudine più ampia, comprensiva dei
corollari dell’irretroattività e della determinatezza-tassatività).
Sul piano terminologico si ricorda che, a seguito dell’assorbimento della Comunità europea
nell’Unione europea con l’adozione del trattato di Lisbona del 2009, non è più corretto
parlare di norme e principi “comunitari” ma è opportuno parlare di norme e principi
“eurounitari” o “europei”.
Per le nozioni generali sulle fonti del diritto penale e sul principio di legalità formalesostanziale si rinvia ai manuali. Per chi utilizza il nostro manuale di diritto penale (parte
generale) di Luigi Delpino, collana Studi superiori, ed. 2013, si rinvia alla Sezione III,
capitoli 1-6.
******
1. L’incidenza del diritto europeo e delle norme Cedu sul sistema penale
1.1. Norme nazionali ed europee. In termini generali, la non applicazione di una norma
nazionale da parte del giudice è possibile soltanto qualora si sia in presenza di un contrasto
tra una puntuale norma interna con un altrettanto puntuale precetto europeo che
dovrebbe essere applicato al posto della norma interna incompatibile con esso. Questa
situazione può verificarsi, ad esempio, quando un principio generale posto dal trattato
dell’Unione europea sia stato specificato e concretizzato da una decisione della Corte di
giustizia, assumendo così, la norma europea, carattere immediatamente precettivo, e
dandosi pertanto luogo a un rapporto di applicabilità-non applicabilità, in quanto
l’applicazione di una norma esclude l’applicabilità dell’altra.
Quando, invece, si è in presenza di una situazione di non conformità della norma interna
con principi generali dell’ordinamento europeo, il giudice nazionale ha il dovere di
operare un’interpretazione conforme, ma se questa non è possibile il giudice non potrebbe
far altro che sollevare una questione pregiudiziale di interpretazione davanti alla Corte
di giustizia o una questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, co.
1, Cost.
Non si tratterebbe, infatti, di non applicare la norma italiana per applicare al suo posto la
norma europea incompatibile, ma di disapplicare o eliminare la norma interna per la non
conformità con un principio generale dell’ordinamento europeo, compito che spetta
esclusivamente alla Corte costituzionale, la cui sfera di attribuzioni verrebbe aggirata se si
ammettesse una sorta di controllo diffuso di compatibilità europea affidato a ciascun giudice
(Cass. pen. 18767/2012).
1
Diritto Penale Parte generale
Vol. ST22 – Edizione IV
1.2. Competenza penale indiretta dell’Unione europea. Con specifico riferimento alla
normativa penale, occorre sottolineare che, sebbene la legislazione penale e le norme di
procedura penale rientrino nella competenza degli Stati membri, su tale ambito del
diritto può tuttavia incidere il diritto dell’Unione europea, nel senso che gli Stati membri
devono fare in modo che la propria legislazione penale rispetti il diritto dell’Unione.
Gli Stati, cioè, non possono applicare una normativa penale che comprometta la
realizzazione degli obiettivi perseguiti da tale direttiva e da privare così quest’ultima del suo
effetto utile (Corte giustizia 6-12-2011, n. 329/11).
Può ritenersi sussistente, quindi, una competenza penale indiretta dell’Unione europea,
intesa come obbligo, per gli Stati membri, di introdurre sanzioni penali laddove siano
necessarie per garantire piena efficacia all’applicazione del diritto europeo (Corte di
giustizia 23-10-2007, causa C-440/05).
A tal fine, le norme dell’Unione europea devono presentare un grado di chiarezza tale da
poter essere utilizzate per la qualificazione della fattispecie penale, conformemente al
principio di legalità sancito dall’art. 49, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, al cui rispetto gli Stati membri sono tenuti quando infliggono una
pena diretta a sanzionare l’inosservanza di disposizioni del diritto dell’Unione, e implica che
la legge definisca chiaramente i reati e le pene che li reprimono (Corte di giustizia 31-32011, causa C-546/09, Aurubis Balgaria; 3-5-2007, causa C-303/05, Advocaten voor de
Wereld).
1.3. Il ruolo della Cedu. La Corte costituzionale, fin dalle sentenze “gemelle” del 2007
(Corte cost. n. 348 e n. 349 del 2007) ha statuito che, nel sistema delle fonti, alle
disposizioni della Cedu debba essere assegnato un rango sub-costituzionale, nel senso che:
- attraverso il meccanismo di adattamento previsto dall’art. 117, co. 1, Cost., esse integrano
il relativo precetto della Carta fondamentale e diventano parametro di legittimità
costituzionale delle altre norme dell’orientamento di fonte secondaria;
- il giudice nazionale, nell’applicare una norma del diritto interno, è sempre tenuto a
interpretarla in maniera non solo costituzionalmente orientata, ma anche
convenzionalmente orientata (ossia, conforme alla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo), considerando sia le disposizioni formalmente cristallizzate nell’articolato della
Cedu, sia le stesse norme come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Tale criterio generale ha trovato numerose attuazioni nella giurisprudenza costituzionale
(Corte cost. n. 1 e 113 del 2011; 93/2010; 138/2010; 187/2010).
Tuttavia la Consulta, nel tentativo di affinare quel “meccanismo di adeguamento” del diritto
interno alle norme di fonte sovranazionale, ha puntualizzato la portata applicativa di questo
principio, chiarendo che la stessa Corte costituzionale - e, dunque, anche il giudice comune
chiamato a effettuare, in prima battuta, quella verifica di compatibilità - non può sindacare
l’interpretazione della Cedu fornita dalla corte di Strasburgo poiché le norme della
Cedu devono essere applicate nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo, ma può soltanto valutare come e in qual misura il prodotto
dell’interpretazione della Corte europea si inserisca nell’ordinamento costituzionale
italiano.
La norma Cedu, nel momento in cui va a integrare il comma 1 dell’art. 117 Cost., da questo
ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che ne consegue in termini di
interpretazione e bilanciamento; alla Corte costituzionale, così come ai giudici comuni,
compete, insomma, di valutare la giurisprudenza europea in modo da rispettarne la sostanza,
2
Diritto Penale Parte generale
Vol. ST22 – Edizione IV
ma con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tenere conto delle
peculiarità dell’ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi
(Corte cost. 236/2011).
In altri termini, il giudice nazionale, lungi dall’essere vincolato a conformarsi al risultato
dell’esegesi autentica operata dalla Corte europea, può interpretare la norma della Cedu,
con l’unico limite di rispettare la sostanza delle indicazioni provenienti dalla
giurisprudenza di Strasburgo.
L’incidenza della Cedu sulla normativa penale interna è stata recentemente affrontata dalla
“sentenza Esposito” (Cass. pen., sez. fer., 35729/2013), che ha concluso la tormentata
vicenda dei diritti televisivi Mediaset.
Tra le numerose questioni affrontate dalla sentenza emerge l’interpretazione dell’art. 6, par.
3, lett. d), Cedu, che prevede il diritto di ogni accusato di interrogare o far interrogare i
testimoni a carico e di ottenere la convocazione e l’interrogazione dei testimoni a
discarico nelle stesse condizioni di quelli a carico.
La sentenza Esposito ha precisato che tale disposizione non risulta violata dal
provvedimento che disponga l’acquisizione delle dichiarazioni rese dal testimone residente
all’estero e non comparso per essere sentito nel corso del processo, quando la sentenza di
condanna non si sia basata in misura esclusiva o determinante sulla deposizione di
colui che l’imputato non sia stato in condizioni di interrogare o far interrogare.
Esaminando le numerose sentenze della Corte europea relative alla disposizione in esame
(Corte europea diritti dell’uomo 18-5-2010, Ogaristi c. Italia; 19-10-2006, Majadallah c.
Italia) si rileva chiaramente che, per i giudici di Strasburgo, è configurabile una violazione
dell’art. 6, par. 3, lett. d), Cedu solo se la sentenza di condanna si è basata in misura
esclusiva o determinante sulla deposizione di chi l’imputato non sia stato in condizioni
di interrogare o far interrogare, ad esempio laddove l’affermazione della colpevolezza
dell’imputato si sia fondata sulla deposizione resa nella fase delle indagini da un unico
testimone che l’accusato non sia stato messo in condizioni di poter esaminare nel
contraddittorio (Corte europea diritti dell’uomo 18-5-2010, Ogaristi c. Italia).
Questa situazione è ben diversa da quella nella quale la motivazione della sentenza di
condanna pronunciata dai giudici di merito si basi in via minimale e assolutamente residuale
sulle dichiarazioni rese dal teste nella fase delle indagini, essendo altri e ben più numerosi
gli elementi di prova orale e documentale - acquisiti nel pieno rispetto del principio del
contraddittorio - evidenziati a carico dell’imputato.
Tale soluzione interpretativa risulta coerente con il consolidato indirizzo secondo il quale le
dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente
acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea,
in applicazione dell’art. 6 Cedu - fondare in modo esclusivo o significativo l’affermazione
della responsabilità penale (Cass. S.U. 27918/2010; conf. Cass. pen. 4-4-2012): d’altro
canto, seguendo la medesima impostazione si è aggiunto che una lettura costituzionalmente
e convenzionalmente conforme della disposizione dettata dall’art. 526, co. 1bis, c.p.p.
comporta che il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali assunte dal
pubblico ministero e acquisite mediante lettura per sopravvenuta impossibilità di ripetizione
è destinato a operare solo quando le dichiarazioni medesime costituiscono il fondamento
esclusivo o determinante dell’affermazione di colpevolezza (Cass. pen. 23-9-2009,
Marinkovic; conf. Cass. 6-5-2010, Mzoughia).
3
Diritto Penale Parte generale
Vol. ST22 – Edizione IV
1.4. L’attività di allibratore tra normativa europea e norme penali interne. La
contaminazione tra normativa europea e diritto penale interno è stata indagata, in numerose
occasioni, dalla Cassazione riguardo al reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di
scommessa ex art. 4, L. 401/1989, dove si è posto il problema di stabilire se tale norma
incriminatrice sia o meno incompatibile con i principi europei sulla libertà di stabilimento e
di prestazione dei servizi.
La Corte di giustizia Ue, con la sentenza Placanica 6-3-2007, ha specificato i principi
generali posti dall’art. 49 Tfue (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) - e, prima
ancora, dall’art. 43 Trattato CE - in tema di libertà di stabilimento e di prestazione dei
servizi, affermando che tale disposizione impedisce alla normativa nazionale, da un lato, di
escludere dal settore dei giochi d’azzardo gli operatori costituiti sotto forma di società di
capitali le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati e, dall’altro, di sanzionare
penalmente i soggetti che esercitano l’attività di raccolta di scommesse in assenza della
concessione o dell’autorizzazione di polizia richieste dalla normativa nazionale, qualora
questi soggetti non abbiano potuto ottenere le autorizzazioni a causa di un rifiuto, da parte
dello Stato membro, contrario alle norme europee.
Nella sentenza Schindier 24-3-1994 la Corte di giustizia ha precisato che una normativa
nazionale che vieti agli organizzatori di lotterie di altri Stati membri di promuovere le loro
lotterie e di venderne i biglietti (sia direttamente sia per il tramite di agenti locali) nel
proprio Stato costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi di cui all’art. 49 Tfue,
anche se questa normativa può risultare giustificata se persegue scopi legati alla tutela dei
consumatori e alla protezione dell’ordine sociale.
Nella sentenza Lara del 21-9-1999 la Corte di giustizia ha poi precisato che una normativa
nazionale che impedisca agli operatori di altri Stati membri di mettere in circolazione
apparecchi automatici per giochi d’azzardo costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei
servizi di cui all’art. 49 del Trattato, ma può essere giustificata per motivi connessi alla
tutela dei consumatori e alla protezione dell’ordine sociale.
Analogamente, nella sentenza Zenatti del 21-10-1999 si è precisato che una normativa
nazionale restrittiva, che riservi a taluni enti il diritto di esercitare scommesse sportive, può
essere giustificata, qualora non comporti alcuna discriminazione in base alla nazionalità, da
esigenze di interesse generale, quali la tutela del giocatore, la lotta alle frodi e alle
infiltrazioni criminali, sempre che le restrizioni imposte dalla normativa non siano
sproporzionate rispetto a tali esigenze.
Da ultimo, la Corte di giustizia 16-2-2012 ha ribadito che:
- lo Stato italiano non può applicare sanzioni penali, per l’attività di raccolta di scommesse
esercitata senza concessione o autorizzazione di polizia, a persone legate a un operatore che
era stato escluso dalle gare in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara
destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente
attribuzione di nuove concessioni non abbiano rimediato all’illegittima esclusione di detto
operatore dalla precedente gara;
- l’art. 49 Tfue, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, impediscono che
uno Stato membro possa proteggere le posizioni commerciali acquisite dagli operatori
esistenti prevedendo determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari
e quelli ditali operatori esistenti;
Sulla base dei suddetti principi la Cassazione ha più volte sostenuto che le disposizioni di
cui all’art. 88 t.u.l.p.s. (Testo unico leggi di pubblica sicurezza) e all’art. 4, co. 4bis, L.
401/1989 non sono in contrasto con i principi europei della libertà di stabilimento e della
4
Diritto Penale Parte generale
Vol. ST22 – Edizione IV
libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione europea, poiché la normativa nazionale
persegue finalità di controllo per motivi di ordine pubblico idonee a giustificare le
restrizioni nazionali ai citati principi europei (Cass. pen., S.U., 23271/2004; Cass.
7695/2012).
La citata sentenza delle Sezioni Unite ha rilevato che il controllo per finalità di ordine e
sicurezza pubblici è presente non solo in sede di concessione per l’esercizio delle
scommesse (in relazione, ad esempio, all’idoneità dei locali), ma anche di rilascio
dell’autorizzazione o licenza di polizia richiesta dall’art. 88 t.u.1.p.s., in quanto non può
essere rilasciata a chi ha determinati precedenti penali, può essere negata a chi ha riportato
condanne per particolari delitti, non può essere data a chi sia stato condannato per reati
contro la moralità pubblica o il buon costume o per giochi d’azzardo, per delitti commessi in
stato di ubriachezza, per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per
abuso di sostanze stupefacenti e non può essere concessa a chi è incapace di obbligarsi;
inoltre, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono accedere in qualunque
momento nei locali destinati all’esercizio delle scommesse e assicurarsi degli adempimenti
prescritti dalla legge, dai regolamenti o dall’autorità.
1.5. L’ingresso clandestino nel territorio dello Stato. L’art. 10bis D.Lgs. 286/1998
incrimina l’ingresso e la permanenza illegale dei cittadini non appartenenti all’Unione
europea e degli apolidi, gli uni e gli altri indicati nel testo normativo come "stranieri" (art. 1,
co. 1), sanzionando le medesime condotte con la pena dell’ammenda.
Tale norma ha superato il vaglio di costituzionalità: la Corte costituzionale, infatti, con la
sent. 250/2010 ha precisato che la l’art. 10bis non punisce la condizione personale e sociale
di straniero clandestino o comunque irregolare, ma uno specifico comportamento, costituito
dal “fare ingresso” e dal “trattenersi” nel territorio dello Stato; si tratta, dunque, di una
condotta attiva istantanea (varcare illegalmente i confini nazionali) oppure di una
condotta omissiva permanente (non lasciare il territorio nazionale pur non avendo titolo
per il soggiorno legale in esso).
La rilevanza penale di tali condotte è correlata alla concreta lesione del bene giuridico
tutelato, individuabile nell’interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi
migratori, secondo un determinato assetto normativo, in vista di beni pubblici di sicuro
rilievo costituzionale.
In ambito europeo occorre ricordare la direttiva rimpatri (direttiva 2008/115), che si
occupa del rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare e non si
prefigge l’obiettivo di armonizzare integralmente le norme degli Stati membri sul soggiorno
degli stranieri. Tale direttiva, quindi, non vieta che il diritto di uno Stato membro qualifichi
il soggiorno irregolare alla stregua di reato e preveda sanzioni penali per scoraggiare e
reprimere la commissione di siffatta infrazione. Tuttavia, uno Stato non può applicare una
disciplina penale idonea a compromettere l’applicazione delle norme e delle procedure
comuni sancite dalla direttiva 2008/115, privando così quest’ultima del suo effetto utile
(Cote di giustizia 28-4-2011, El Dridi). Tali norme e procedure sarebbero compromesse se
lo Stato membro interessato, dopo aver accertato il soggiorno irregolare del cittadino di un
Paese terzo, anteponesse all’esecuzione della decisione di rimpatrio, o addirittura alla sua
stessa adozione, un procedimento penale idoneo a condurre alla reclusione nel corso della
procedura di rimpatrio, poiché tale modo di procedere rischierebbe di ritardare
l’allontanamento.
5
Diritto Penale Parte generale
Vol. ST22 – Edizione IV
Per quel che attiene alla compatibilità della fattispecie penale di cui all’art. 10bis con la
direttiva rimpatri, la Corte di giustizia, con decisione del 6-12-2012, causa C-430/11,
Md Sagor, ha stabilito che l’art. 10bis non contrasta con la direttiva rimpatri laddove
prevede, come reato, dell’ingresso e del soggiorno illegale. In particolare, ha rilevato,
richiamando la propria giurisprudenza precedente, che le disposizioni della direttiva rimpatri
non impediscono al legislatori nazionale di affidare al giudice penale la decisione del
rimpatrio, fatta salva l’esigenza che le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel
pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità, dando la prevalenza al
rimpatrio volontario rispetto a quello forzato con la fissazione di un periodo congruo di
durata compresa tra sette e trenta giorni per la partenza volontaria (art. 7, par. 1 e 2, della
direttiva).
Fanno eccezione al principio del rimpatrio volontario (considerando 10 della direttiva):
a) i casi in cui sussiste rischio di fuga;
b) quelli in cui la domanda di soggiorno regolare sia stata respinta in quanto
manifestamente infondata o fraudolenta;
c) i casi in cui la presenza dell’interessato nel territorio nazionale costituisca un pericolo
per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale (art. 7, par. 4),
fermo l’obbligo che tali misure siano proporzionate e non eccedano un uso ragionevole
della forza (art. 8, par. 4).
In sintesi, la disapplicazione della norma incriminatrice di cui all’art. 10bis sarebbe
giustificata nel caso di irrogazione della sanzione sostitutiva dell’espulsione senza la
fissazione del termine per la partenza volontaria, salve le eccezioni sopra richiamate, da
valutare caso per caso.
Si tratta di aspetti pertinenti al profilo sanzionatorio del fatto-reato che, nella sua struttura
essenziale, non contrasta con la direttiva in materia di rimpatri. Pertanto, la mera previsione
di una sanzione penale per l'ingresso o il soggiorno illegale dello straniero nel territorio
nazionale, non accompagnata da misure di rimpatrio forzato incompatibili con la normativa
europea, è rispettosa dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, ai sensi dell'art. 117, co.
1, Cost. (Cass. pen. 29776/2013).
2. Principio di legalità
2.1. Retroattività della lex mitior e crisi del giudicato. In via preliminare occorre chiarire
che, a fondamento del principio di retroattività della norma più favorevole al reo,
consacrato all’art. 2, co. 2-4, c.p., dimora il principio del favor libertatis, per il quale al
cittadino deve essere assicurato il trattamento penale più mite tra quello vigente al momento
del fatto e quello previsto dalle leggi successive, purché precedenti la sentenza definitiva di
condanna.
La medesima ratio sta alla base del principio di irretroattività della legge penale più
sfavorevole, anch’esso previsto dall’art. 2 c.p., al comma 1, che, rispetto al primo ha
fondamento costituzionale nell’art. 25, co. 2, Cost., secondo cui nessuno può essere punito
se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. In realtà,
sarebbe più corretto individuare la copertura costituzionale del principio nel canone di
eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. Infatti, deve ritenersi discriminatorio punire in maniera
differenziata soggetti responsabili della medesima violazione soltanto in ragione della
6
Diritto Penale Parte generale
Vol. ST22 – Edizione IV
diversa data di commissione del reato o che, a causa del diverso tempus regit actum, uno di
tali soggetti continui a essere punito mentre l’altro si sottragga a qualsiasi sanzione penale.
Il principio di retroattività della legge penale più favorevole è stato scandagliato con
particolare rigore in ambito sovranazionale.
Ai sensi dell’articolo 46 Cedu, gli Stati contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze
definitive pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e al Comitato dei Ministri è
affidato il compito di vigilare sull’esecuzione di tali sentenze, con la conseguenza che lo
Stato convenuto ha l’obbligo giuridico di adottare, sotto il controllo del detto Comitato, le
misure generali o individuali per porre fine alla violazione constatata, eliminarne le
conseguenze e scongiurare ulteriori violazioni analoghe.
Quando la Corte europea, alla quale è affidato il compito istituzionale di interpretare e
applicare la Cedu (art. 32), accerta violazioni della stessa connesse a problemi sistematici e
strutturali dell’ordinamento giuridico nazionale, pone in essere la c.d. “procedura di
sentenza-pilota”, che si propone di aiutare gli Stati contraenti a risolvere a livello nazionale
i problemi rilevati, in modo da riconoscere alle persone interessate, che versano nella stessa
condizione della persona il cui caso è stato già specificamente preso in considerazione, i
diritti e le libertà garantite dalla Cedu, come dispone l’art. 1, offrendo loro la riparazione più
rapida e alleggerendo il carico della Corte sovranazionale, che, altrimenti, dovrebbe
esaminare moltissimi ricorsi sostanzialmente simili (Corte europea 22-6-2004, Broniowski
c. Polonia).
La giurisprudenza della Corte europea, originariamente finalizzata alla soluzione di
specifiche controversie relative a casi concreti, si è caratterizzata nel tempo per una
evoluzione improntata alla valorizzazione di una funzione para-costituzionale di tutela
dell’interesse generale al rispetto del diritto oggettivo. Sempre più frequentemente,
infatti, le sentenze della Corte, nel rilevare la contrarietà alla Cedu di situazioni interne di
portata generale, danno indicazioni allo Stato responsabile sui rimedi da adottare per
rimuovere la rilevata disfunzione sistemica nel proprio ordinamento interno.
La tecnica delle cd. “sentenze-pilota”, affidata dapprima alla prassi, in difetto di un’esplicita
base normativa, è stata recentemente formalizzata nel regolamento di procedura della Corte,
emendato a tale scopo nel 2011.
La necessità degli ordinamenti interni di assicurare, anche a prescindere da un intervento del
giudice europeo sul caso concreto, il rispetto degli obblighi convenzionali, così come già
individuati dalla Corte europea, di porre fine a persistenti violazioni degli stessi e di
prevenire nuove violazioni, pone certamente delicati problemi giuridici sulla tenuta di
situazioni già definite con sentenze passate in giudicato ma in palese contrasto con i
diritti fondamentali tutelati convenzionalmente.
La Corte costituzionale ha chiarito gli effetti prodotti dalle pronunce del giudice
sovranazionale nel nostro ordinamento, nel senso di una maggiore resistenza delle norme
Cedu, nell’interpretazione data dalla Corte di Strasburgo, rispetto alle leggi ordinarie
interne, che devono essere interpretate, ove possibile, in maniera conforme alle prime.
Di fronte a violazioni della Cedu di carattere oggettivo e generale, già in precedenza
stigmatizzate in sede europea, la mancanza, nel caso concreto, di una sentenza della Corte
europea che si sia pronunciata su quella violazione non può essere di ostacolo a un
intervento dell’ordinamento giuridico italiano, attraverso la giurisdizione, per eliminare una
situazione di illegalità convenzionale (ossia, derivante dalla violazione di norme della
Cedu), anche sacrificando il valore della certezza del giudicato, da ritenersi recessivo
7
Diritto Penale Parte generale
Vol. ST22 – Edizione IV
rispetto ad evidenti e pregnanti compromissioni in atto di diritti fondamentali della
persona.
La preclusione, effetto proprio del giudicato, non può operare quando risulti compromesso,
con effetti negativi perduranti, un diritto fondamentale della persona, quale certamente è
quello che incide sulla libertà: s’impone, pertanto, in questo caso di emendare “dallo stigma
dell’ingiustizia” una tale situazione.
Sotto questo profilo, la sentenza della Corte europea 17-9-2009, Scoppola c. Italia,
presenta i connotati sostanziali di una “sentenza pilota”.
Tale pronuncia, in particolare, affronta il delicato problema dell’effettiva articolazione del
principio nulla poena sine lege consacrato nell’art. 7 Cedu (“Nessuno può essere
condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non
costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta
una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”), se
cioè abbia una portata meramente negativa, quale divieto di applicazione retroattiva sia
della norma incriminatrice sia di un trattamento sanzionatorio più sfavorevole, ovvero
se contenga anche un implicito riflesso positivo, costituito dalla esigenza di applicazione
della legge sopravvenuta più favorevole.
La Corte di Strasburgo, innovando la precedente giurisprudenza in senso restrittivo, afferma
che tale norma:
- garantisce il principio di irretroattività delle leggi penali più severe;
- impone anche che, nel caso in cui la legge penale in vigore al momento della commissione
del reato e quelle successive adottate prima della condanna definitiva siano differenti, il
giudice applichi quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, con l’effetto che,
nell’ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, costituisce violazione dell’art. 7
Cedu l’applicazione della pena più sfavorevole al reo.
A tale conclusione la Corte europea perviene privilegiando, nell’interpretazione della
Convenzione, un “approccio dinamico ed evolutivo”, che renda “le garanzie concrete ed
effettive, e non teoriche ed illusorie”.
Ne consegue la violazione dell’art. 7 nel caso in cui non venga inflitta all’imputato la pena
più mite tra quelle previste dalle diverse leggi succedutesi dal momento del fatto a quello
della sentenza definitiva.
Nel caso esaminato nella sentenza Scoppola si sono succedute nel tempo tre diverse
disposizioni di legge:
a) l’art. 442, co. 2, c.p.p., dopo la declaratoria d’incostituzionalità nella parte in cui
prevedeva la sostituzione dell’ergastolo con la reclusione di anni trenta (sent. 176/1991),
precludeva, tra il 1991 e il 1999, l’accesso al rito abbreviato per gli imputati di delitti
punibili con l’ergastolo;
b) la L. 479/1999 (legge Carotti),entrata in vigore il 2 gennaio 2000, reintroduceva la
previsione, nel caso di giudizio abbreviato, della sostituzione della pena dell’ergastolo
con quella della reclusione di anni trenta;
c) il D.L. 341/2000, entrato in vigore il 24 novembre 2000 e convertito dalla L. 4/2001,
stabilisce, in via di interpretazione autentica, che “nell’articolo 442, co. 2 c.p.p.,
l’espressione "pena dell’ergastolo" deve intendersi riferita all’ergastolo senza isolamento
diurno” e aggiunge, in chiusura del comma 2, il periodo “Alla pena dell’ergastolo con
isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella
dell’ergastolo”.
8
Diritto Penale Parte generale
Vol. ST22 – Edizione IV
Sulla base di tale quadro normativo la Corte di Strasburgo ritiene che il sig. Scoppola,
essendo stato ammesso al rito abbreviato nel vigore della L. 479/1999, avrebbe avuto diritto,
ai sensi dell’art. 7 Cedu, a vedersi infliggere la pena di anni trenta di reclusione, più mite
rispetto sia a quella prevista (ergastolo con isolamento diurno) dall’art. 442 c.p.c. nel testo
vigente al momento della commissione del fatto, sia a quella prevista (ergastolo senza
isolamento diurno) dal D.L. 341/2000 in vigore al momento del giudizio.
È indubbio che tale sentenza enuncia, in linea di principio, una regola di giudizio di portata
generale, che, in quanto tale, è astrattamente applicabile a fattispecie identiche a quella
esaminata e, quindi, il giudice dell’esecuzione, in attuazione dei principi dettati dalla Corte
EDU con la sentenza 17/09/2009, Scoppola c. Italia, può sostituire la pena dell’ergastolo,
inflitta all’esito del giudizio abbreviato, con la pena di anni trenta di reclusione, in tal
modo modificando il giudicato con l’applicazione, nella successione di leggi intervenute in
materia, di quella più favorevole, anche a costo di porre in crisi il “dogma” del giudicato,
perché altrimenti si legittimerebbe l’esecuzione di una pena illegittima, con conseguente
violazione del principio di parità di trattamento tra condannati che versano in una identica
posizione.
Diverso è il caso di una pena rivelatasi illegittima perché inflitta all’esito di un giudizio
ritenuto dalla Corte europea non equo, ai sensi dell’art. 6 Cedu: in questa ipotesi,
l’apprezzamento, vertendo su eventuali errores in procedendo e implicando valutazioni
strettamente correlate alla fattispecie specifica, non può che essere compiuto caso per caso,
con l’effetto che il giudicato interno può essere posto in discussione soltanto di fronte a un
vincolante dictum della Corte europea su quella specifica fattispecie.
Numerosi sono gli esempi nei quali la giurisprudenza ha avvertito la necessità di adeguare le
pronunce dei giudici di cognizione alle norme della Cedu nell’interpretazione datane dalla
Corte di Strasburgo e ha ritenuto, pertanto, di potere superare il principio della
intangibilità del giudicato, anche al di fuori delle ipotesi previste dal codice di rito, tanto da
pervenire, con la sentenza n. 113/2011 della Corte costituzionale, a una declaratoria
d’incostituzionalità dell’articolo 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede la revisione della
sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo per
conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea.
La crisi dell’irrevocabilità del giudicato è riscontrabile, del resto, già nell’art. 2, co. 3, c.p.,
secondo cui la pena detentiva inflitta con condanna definitiva si converte automaticamente
nella corrispondente pena pecuniaria, se la legge posteriore al giudicato prevede
esclusivamente quest’ultima, regola questa che deroga a quella posta invece dallo stesso art.
2, co. 4, c.p. (primato della lex mitior, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile).
A tale novità normativa può essere accostato, in via analogica, il novum dettato dalla Corte
europea in tema di legalità della pena: in entrambi i casi, l’esigenza imprescindibile di
porre fine agli effetti negativi dell’esecuzione di una pena contra legem prevale sulla
tenuta del giudicato, che deve cedere, anche in executivis, alla più alta valenza fondativa
dello statuto della pena.
Tale principio, d’altra parte, è stato già affermato da Cass. pen. 27-10-2011, Hauohu, che ha
ravvisato il potere del giudice dell’esecuzione di rideterminare la pena inflitta a chi sia
stato condannato per un delitto aggravato dalla propria condizione di clandestinità ex art. 61,
n. 11bis, c.p., in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità di tale aggravante (sent. n.
249/2010), con eliminazione della frazione di pena in eccesso, da considerarsi illegittima e,
pertanto, non eseguibile.
9
Diritto Penale Parte generale
Vol. ST22 – Edizione IV
In forza dello stesso principio, consolidato è l’orientamento giurisprudenziale circa la
possibilità di emendare, in sede esecutiva, l’illegalità della pena accessoria inflitta con
condanna irrevocabile (Cass. pen. 13-10-2010, Di Marco).
Questa prospettiva ha ora ricevuto conferma con la sentenza 210/2013 della Corte
costituzionale, che ha ritenuto ammissibile una modifica parziale del giudicato, nel quadro
dell’incidente di esecuzione, a fronte del sopravvenuto accertamento, ad opera della Corte
europea, dell’illegittimità convenzionale della norma sanzionatoria applicata dal giudice
della cognizione, la quale si traduce in una sua illegittimità costituzionale per effetto dell’art.
117, co. 1, Cost.
Pertanto, l’accertamento sopravvenuto, da parte della Corte costituzionale, della Corte di
giustizia europea o della Corte europea dei diritti dell’uomo, della totale o parziale
illegittimità costituzionale, convenzionale o europea, della norma penale applicata dal
giudice, nella sua parte precettiva o sanzionatoria, rende illegittima anche l’esecuzione della
pena.
2.2. Uso di gruppo di sostanze stupefacenti. Il principio di legalità è venuto in rilievo,
sotto il profilo della determinatezza della fattispecie, con riferimento al reato di consumo di
gruppo di sostanze stupefacenti. La norma di riferimento (art. 75 d.P.R. 309/1990), infatti,
contiene espressioni “elastiche”, che hanno dato vita a interpretazioni opposte.
Sul tema sono intervenute recentemente le Sezioni Unite (Cass. pen. S.U. 25401/2013),
affermando che il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nell’ipotesi di acquisto
congiunto e in quella di mandato all’acquisto collettivo a uno dei consumatori, non è
penalmente rilevante ma integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 75 d.P.R.
309/1990, a condizione che:
a) l’acquirente sia uno degli assuntori;
b) l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
c) sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la
sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente
all’acquisto.
Questo intervento a Sezioni Unite si è reso necessario per dirimere il contrasto tra
quell’orientamento secondo il quale il consumo di gruppo di stupefacenti è penalmente
rilevante sia nell’ipotesi del mandato all’acquisto sia nell’ipotesi dell’acquisto in
comune e la diversa tesi secondo la quale il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia
nel caso di acquisto in comune sia in quello del mandato all’acquisto collettivo a uno degli
assuntori e nell’originaria conoscenza dell’identità degli altri, costituisce un’ipotesi di uso
esclusivamente personale dei partecipanti al gruppo, e quindi integra l’illecito
amministrativo di cui all’art. 75 e non il reato di cui all’art. 73, co. 1 bis.
Le Sezioni Unite hanno abbracciato questa seconda tesi, criticando l’affermazione secondo
la quale l’“uso non esclusivamente personale” (penalmente rilevante) dovrebbe essere
interpretato nel senso di “uso non individuale”. In realtà, per escludere il reato è necessario
che la droga sia destinata totalmente (esclusivamente) all’uso personale e neppure in
parte alla cessione a soggetti terzi estranei all’acquisto ed alla detenzione. L’avverbio
“esclusivamente”, dunque, evidenzia che la non punibilità riguarda solo i casi in cui la
sostanza non è destinata a terzi ma all’utilizzo personale degli appartenenti al gruppo che la
codetengono.
Su questo argomento erano già intervenute le Sezioni Unite con la sentenza 28-5-1997 (p.m.
nel proc. Iacolare) che aveva affermato la rilevanza amministrativa della condotta
10
Diritto Penale Parte generale
Vol. ST22 – Edizione IV
dell’appartenente al gruppo che assuma l’incarico di procedere materialmente all’acquisto
della droga da destinare all’uso comune. A tale sentenza si richiamano anche le Sezioni
Unite del 2013.
Secondo la sentenza Iacolare sussiste l’illecito amministrativo di cui all’art. 75 d.P.R.
309/1990, e non il reato previsto dall’art. 73 dello stesso d.P.R., non solo nel caso di
“acquisto contestuale” di sostanza stupefacente per uso personale da parte di tutti gli
appartenenti a un gruppo, ma anche in quello in cui solo alcuni dei componenti del gruppo
avevano proceduto all’acquisto della sostanza per conto (su mandato) degli altri e poi
avevano proceduto alla materiale suddivisione della stessa.
Pertanto, anche nell’ipotesi del “mandato ad acquistare” il fatto doveva considerarsi solo
amministrativamente rilevante, dovendosi applicare agli acquirenti in nome e per conto degli
altri appartenenti al gruppo la disciplina civilistica del “mandato” e i relativi effetti quanto
all’acquisto e alla disponibilità della sostanza. Tutti gli appartenenti al gruppo, fin da subito,
in virtù del mandato conferito, acquistano la disponibilità pro quota della sostanza, con
l’effetto che la successiva ripartizione per l’uso in comune deve considerarsi penalmente
non significativa.
Dopo la modifica dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 ad opera della L. 49/2006 la questione del
trattamento sanzionatorio dell’uso di gruppo era stata rivisitata dalla giurisprudenza. Infatti,
la fattispecie incriminatrice (art. 73, co. 1bis, lett. a), d.P.R. 309/1990) è configurata come
sussistente, tra l’altro, quando la condotta, per il quantitativo della sostanza o per gli altri
parametri di riferimento, sia dimostrativa di un “uso non esclusivamente personale” della
sostanza stupefacente. Ciò comportava, secondo alcuni, il superamento dell’orientamento
giurisprudenziale espresso dalla sentenza Iacolare, che restringeva l’”uso di gruppo” in
ambito esclusivamente amministrativo.
Dalla norma incriminatrice riformulata dalla L. 49/2006 si faceva discendere, infatti, la
rilevanza penale dell’uso che non fosse esclusivamente “personale” (individuale), poiché –
si diceva - il legislatore, con questa espressione, aveva preso una posizione negativa nei
confronti della rilevanza solo amministrativa delle condotte in genere riconducibili all’”uso
di gruppo”. Con il che doveva ammettersi la rilevanza penale non solo dell’uso di gruppo
qualificato dal conferimento, esplicito o implicito, da parte degli appartenenti al gruppo, del
“mandato ad acquistare” la droga solo a uno o ad alcuni degli appartenenti al gruppo, ma
anche dell’”uso di gruppo collettivo”, qualificato dall’acquisto in comune della droga da
parte di tutti gli appartenenti al gruppo per l’assunzione in comune.
Nell’uno come nell’altro caso, infatti, l’uso non sarebbe esclusivamente “personale”, e, per
l’effetto, sarebbe comunque di rilevanza penale.
Una conferma di tale opzione ermeneutica la si ricavava dal “nuovo” art. 75, co. 1, d.P.R.
309/1990, laddove il fatto amministrativo è costruito eccettuando le ipotesi “di cui all’art.
73, co. 1bis”, quindi anche le ipotesi di detenzione destinate “a un uso non esclusivamente
personale”.
In realtà, la disciplina normativa di riferimento non è affatto chiara e sono intervenute
nuovamente le Sezioni Unite nel 2013, confermando che non sono punibili penalmente, e
rientrano pertanto nella sfera dell’illecito amministrativo di cui all’art. 75, l’acquisto e la
detenzione di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale che avvengano fin dall’inizio
anche per conto di soggetti diversi dall’agente, quando è certa fin dall’inizio l’identità dei
medesimi nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio
consumo, perché l’omogeneità della condotta dell’acquirente rispetto allo scopo degli altri
componenti del gruppo caratterizza la detenzione quale codetenzione e impedisce che il
11
Diritto Penale Parte generale
Vol. ST22 – Edizione IV
primo si ponga in rapporto di estraneità e, quindi, di diversità rispetto ai secondi, con
conseguente impossibilità di connotare la sua condotta quale cessione.
Qualora, invece, l’acquirente non sia anche uno degli assuntori o abbia effettuato l’acquisto
senza averne ricevuto mandato dagli altri, non sarebbe ravvisabile un’omogeneità teleologia
tra le condotte e la consegna della droga sarebbe qualificabile come cessione, sia pure
gratuita, o spaccio.
Occorre quindi che l’acquirente sia uno degli assuntori, che l’acquisto avvenga fin
dall’inizio per conto degli altri componenti il gruppo, al cui uso personale la sostanza è
destinata, e che quindi sia certa sin dall’inizio l’identità di questi altri soggetti i quali
abbiano in un qualunque modo manifestato la volontà sia di procurarsi la sostanza per
mezzo di uno dei compartecipi sia di concorrere ai mezzi finanziari occorrenti all’acquisto.
Ricorre, invece, una normale ipotesi di cessione qualora tutte queste condizioni non si
verifichino, come nel caso in cui il soggetto abbia ceduto per il consumo in comune sostanza
di cui era autonomamente in possesso per averla acquistata senza alcun mandato degli altri,
ovvero abbia acquistato su mandato di terzi ma senza essere a sua volta assuntore, ovvero
abbia ceduto parte della droga a soggetti estranei al gruppo dei mandanti.
Del resto, stante il significato equivoco delle espressioni utilizzate dall’art. 73, questa tesi
appare più conforme ai principi di tassatività, di legalità e di riserva di legge, evitando che
sia rimessa al giudice l’enucleazione in malam partem della norma incriminatrice.
2.3. Il maltrattamenti verso i dipendenti è maltrattamento verso familiari o conviventi?
Il principio di determinatezza e tassatività della fattispecie penale è messo a dura prova da
una fattispecie di frequente applicazione, qual è l’art. 572 c.p., che punisce i maltrattamenti
contro familiari e conviventi.
In particolare, si è posto il problema di stabilire se le condotte persecutorie realizzate ai
danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione, pur essendo
astrattamente riconducibili alla nozione di mobbing, sia pure in una sua forma di
manifestazione attenuata (c.d. straining), secondo un consolidato orientamento
giurisprudenziale possono integrare il delitto di maltrattamenti verso familiari o conviventi
(art. 572 c.p.) soltanto qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma
natura parafamiliare, in quanto caratterizzato da relazioni intense e abituali, dal formarsi di
consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra
(rapporto supremazia-soggezione), dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto
in quello che ricopre la posizione di supremazia, e come tale destinatario, quest’ultimo, di
obblighi di assistenza verso il primo (Cass. 6-2-2009, Perotti; 22-9-2010; 10-10-2011; 11-42012).
La modulazione di tale rapporto, dunque, avuto riguardo alla ratio della fattispecie
incriminatrice di cui all’art. 572 c.p., deve comunque essere caratterizzata dal tratto della
“familiarità” o “convivenza”, poiché è soltanto nel limitato contesto di un tale rapporto di
natura para-familiare che può ipotizzarsi, ove si verifichi l’alterazione della sua funzione
attraverso lo svilimento e l’umiliazione della dignità fisica e morale del soggetto passivo, il
reato di maltrattamenti: si pensi, in via esemplificativa, al rapporto che lega il collaboratore
domestico alle persone della famiglia presso cui svolge la propria opera o a quello che può
intercorrere tra il maestro d’arte e l’apprendista.
L’inserimento di tale figura criminosa tra i delitti contro l’assistenza familiare si pone in
linea, del resto, con il ruolo che la stessa Costituzione assegna alla “famiglia”, quale società
intermedia destinata alla formazione e all’affermazione della personalità dei suoi
12
Diritto Penale Parte generale
Vol. ST22 – Edizione IV
componenti, e nella stessa prospettiva ermeneutica vanno letti ed interpretati soltanto quei
rapporti interpersonali che si caratterizzano, al di là delle formali apparenze, per una natura
parafamiliare.
Siffatta connotazione, tuttavia, deve escludersi se la posizione lavorativa è inquadrata
all’interno di una realtà aziendale complessa, la cui articolata organizzazione — attraverso la
previsione di “quadri intermedi” — non implica l’instaurarsi di quella stretta e intensa
relazione diretta tra il datore di lavoro e il dipendente, che appare in grado di determinarne
una comunanza di vita assimilabile a quella caratterizzante il consorzio familiare.
Ne discende il manifestarsi di una realtà connotata da una marginalizzazione dell’intensità
dei rapporti intersoggettivi, nel senso che non ne viene esaltato quell’aspetto personalistico
strettamente connesso alla dinamica relazionale “supremazia-soggezione”, individuabile fra
soggetti che si trovano ad operare su piani diversi.
Se, da un lato, l’art. 572 c.p. ha “allargato” l’ambito delle condotte che possono configurare
il delitto di maltrattamenti anche oltre quello strettamente endofamiliare, è pur vero,
dall’altro, che la fattispecie incriminatrice è inserita nel titolo dei delitti in materia familiare
ed espressamente indica nella rubrica la limitazione alla famiglia ed ai fanciulli, sicché non
può ritenersi idoneo a configurarla il mero contesto di un generico rapporto di
subordinazione/sovraordinazione.
Da qui la ragione dell’indicazione del requisito della parafamiliarità del rapporto di
sovraordinazione, che si caratterizza per la sottoposizione di una persona all’autorità di
un’altra in un contesto di prossimità permanente, di abitudini di vita (anche lavorativa)
proprie e comuni alle comunità familiari, non ultimo per l’affidamento, la fiducia e le
aspettative del sottoposto rispetto all’azione di chi ha ed esercita su di lui l’autorità con
modalità, tipiche del rapporto familiare, caratterizzate da ampia discrezionalità ed
informalità.
Se così non fosse, ogni relazione lavorativa caratterizzata da ridotte dimensioni e dal diretto
impegno del datore di lavoro dovrebbe, per ciò solo, configurare una sorta di comunità
(para)familiare, idonea ad imporre la qualificazione in termini di violazione dell’art. 572 c.p.
di condotte che, pur di eguale contenuto ma poste in essere in un contesto più ampio,
avrebbero solo rilevanza in ambito civile (il c.d. mobbing in una realtà lavorativa), con
evidente profilo di irragionevolezza del sistema (Cass. pen. 28-3-2012).
Né infine, potrebbero trarsi, al riguardo, argomenti in senso contrario dall’analisi della
recente interpolazione del testo normativo attraverso la modifica introdotta dalla L.
172/2012, recante “ratifica ed esecuzione della convenzione del consiglio d’Europa per la
protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25
ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”.
La legge citata ha sostituito l’art. 572 c.p., novellandone la rubrica, ora denominata
“maltrattamenti contro familiari e conviventi”, e aggiungendo i conviventi nel novero dei
soggetti passivi del reato, ma la natura abituale e la struttura del reato di maltrattamenti
(prima “in famiglia o verso fanciulli”, ora “contro familiari e conviventi”) sono rimaste
sostanzialmente immutate.
Le novità, infatti, riguardano essenzialmente l’inasprimento del trattamento
sanzionatorio e l’estensione della tutela nei confronti di persone “comunque
conviventi”, in una prospettiva orientata, per un verso, a valorizzare l’incidenza della
relazione intersoggettiva nell’ambito di operatività della fattispecie, e, per altro verso, ad
allargare anche ad un rapporto di mera “convivenza” — non necessariamente qualificato
dalla particolare natura del legame che ha portato alla sua instaurazione — la rilevanza del
13
Diritto Penale Parte generale
Vol. ST22 – Edizione IV
rapporto “familiare”, ferme restando le altre relazioni di tipo non propriamente familiare, la
cui elencazione è rimasta immutata.
Peraltro, esclusa la configurabilità del delitto di maltrattamenti, la condotta vessatoria non è,
nei suoi contorni storico-fattuali, necessariamente irrilevante sul piano giuridico.
Al riguardo, invero, sulla base di una costante linea interpretativa, deve rilevarsi che nella
materialità del delitto di cui all’art. 572 c.p. rientrino non soltanto percosse, minacce,
ingiurie, privazioni imposte alla vittima, ma anche atti di scherno, disprezzo, umiliazione ed
asservimento idonei a cagionare durevoli sofferenze fisiche e morali alla vittima. Ne
consegue che è riservato alla valutazione del giudice di merito accertare se singoli episodi
vessatori rimangano assorbiti nel reato di maltrattamenti (ad esempio, lesioni non volute) o
integrino, invece, ipotesi criminose autonomamente volute dall’agente e, pertanto,
concorrenti con il delitto di cui all’art. 572 c.p. (Cass. 29-5-1990, Penna).
In tale prospettiva si è più volte affermato che il delitto di lesioni personali volontarie non
può ritenersi assorbito in quello di maltrattamenti in famiglia, trattandosi di illeciti che
concorrono materialmente tra loro per la diversa obiettività giuridica (Cass. pen. 7-5-1986,
Vita), così da configurare un reato autonomo in concorso materiale con quello di
maltrattamenti (Cass. pen. 11-5-2004, Di Bella; 28-3-2012).
Pertanto, le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate
alla sua emarginazione (c.d. mobbing) possono integrare il delitto di cui all'art. 572 c.p.,
anche nel testo modificato dalla L. 172/2012 esclusivamente se, il rapporto tra il datore di
lavoro e il dipendente assume natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni
intense e abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei
confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che
ricopre la posizione di supremazia (Cass. pen. 28-3-2013, n. 28603).
2.4. Il delitto di stalking. Di non agevole individuazione è la condotta tipica del delitto di
atti persecutori (c.d. stalking) previsto dall’art. 612bis c.p.
La Cassazione, con una recente pronuncia (Cass. pen. 4-4-2013, n. 27798) ha affermato che,
se è vero che per la configurabilità del reato si richiede la reiterazione delle condotte di
violenza e minaccia, è altresì evidente che non occorre una lunga sequela di azioni
delittuose per ritenere integrato il reato, essendo sufficiente che esse siano di numero e
consistenza tali da ingenerare nella vittima il fondato timore di subire offesa alla propria
integrità fisica o morale e da provocare nella stessa un perdurante e grave stato d’ansia,
ovvero un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto.
Per colorare la condotta di un sufficiente grado di determinatezza e tassatività, non può
ritenersi sufficiente una qualunque condotta che costringa la persona offesa a modificare le
proprie abitudini di vita, ma occorre un mutamento significativo e protratto per un
apprezzabile lasso di tempo dell’ordinaria gestione della vita quotidiana, quale può
riconoscersi, ad esempio, nell’avvertita necessità, da parte della vittima, di utilizzare per i
propri spostamenti percorsi diversi da quelli abituali, ovvero di modificare gli orari per lo
svolgimento di determinate attività, come pure di cessarle del tutto, ovvero ancora di
staccare gli apparecchi telefonici nelle ore notturne (Cass. pen. 27-11-2012, n. 20993).
Questa opzione privilegia un’opzione ricostruttiva della fattispecie in termini di reato di
evento, abbracciando la tesi di una parte della dottrina (VALSECCHI, Il delitto di atti
persecutori (il c.d. stalking), in MAZZA-VIGANÒ, Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica, Torino, 2009, 243), e si discosta dal prevalente orientamento giurisprudenziale
14
Diritto Penale Parte generale
Vol. ST22 – Edizione IV
che, invece, predilige un’interpretazione in termini quantitativi del concetto di
“reiterazione” (Cass. pen. 21-1-2010; Cass. pen. 7-4-2011).
In dottrina, il requisito della reiterazione è stato particolarmente valorizzato da MAUGERI,
Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica, Torino, 2010, 161, che
lo interpreta in una dimensione maggiormente conforme ai principi di tipicità e
offensività nel momento in cui l’autrice sottolinea che “la reiterazione ostinata rappresenta
il fattore empirico criminologico che è stato assunto dal legislatore ad elemento su cui si
fonda, che attribuisce il diverso e maggiore disvalore dello stalking a condotte che
altrimenti potrebbero, al limite, integrare le meno gravi fattispecie di minaccia e molestie;
rappresenta l’elemento ... su cui si impernia l’offesa agli interessi tutelati, il nucleo di
disvalore, il tipo di offesa descritto nella fattispecie in esame”.
In relazione al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa,
misura cautelare prevista dall’art. 282ter c.p.p. e finalizzata, tra l’altro, alla repressione dei
fatti di stalking, secondo un orientamento (Cass. pen. 4-4-2013) il provvedimento che pone
all’indagato il divieto di avvicinarsi a tutti i luoghi frequentati dalla persona offesa
senza di indicarli in maniera specifica deve considerarsi nullo per la sua
indeterminatezza, dal momento che la norma in questione, nella parte in cui esige
espressamente l’indicazione di “luoghi determinati”, è da considerare sostanzialmente
violata (Cass. pen. 7-4-2011): in altri termini, esprimendo in termini negativi il medesimo
principio, se si tratta di luoghi ben conosciuti dall’obbligato e chiaramente identificabili —
come, nel caso di specie, la dimora della persona offesa, il suo luogo di lavoro e la dimora
dei suoi prossimi congiunti — il provvedimento applicativo della misura non può dirsi
affetto da genetica indeterminatezza.
Tuttavia, in giurisprudenza non sono mancate prese di posizione decisamente più rigorose
assunte con riferimento all’applicazione della misura cautelare ex art. 282ter c.p.p. proprio
in relazione a fattispecie di stalking (Cass. pen. 16-1-2013), nell’ambito delle quali è stata
sostenuta l’irrilevanza dell’individuazione specifica di luoghi di abituale frequentazione
della persona offesa, sulla base dell’argomento per cui la ratio della misura in questione
sarebbe quella di vietare l’avvicinamento alla vittima nel corso della sua vita quotidiana,
ovunque essa si svolga, nei casi in cui la condotta dello stalker abbia i connotati di una
persistente e invasiva ricerca di contatto in qualsiasi luogo in cui essa si trovi.
Con la norma in questione, dunque, il legislatore prenderebbe atto dell’insufficienza di una
tutela “statica” dell’incolumità della vittima, laddove le circostanze rendano concreto il
pericolo di un’aggressione della stessa nel corso dello svolgimento della sua vita di
relazione.
Peraltro, una simile opzione ricostruttiva non troverebbe smentita nella direttiva del
parlamento europeo e del consiglio Ue n. 2001 del 13 dicembre 2011, in tema di “ordine di
protezione europeo”, il cui art. 5, lett. c), prevede in particolare che un ordine di protezione
europeo possa essere emesso solo se nello Stato di emissione è stata precedentemente
adottata una misura di protezione che imponga all’aggressore “il divieto ...
dell’avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito”: secondo i giudici di
legittimità la direttiva ben si adatta al contenuto della misura cautelare previsto dall’art. 282
ter c.p.p. dal momento che essa si limita a richiedere soltanto una definizione del
“perimetro” all’interno del quale scatta la protezione (come accade nelle ipotesi in cui sia
prescritto a taluno di rimanere ad una distanza minima esattamente quantificata dal soggetto
a tutela del quale viene emesso il provvedimento).
15
Diritto Penale Parte generale
Vol. ST22 – Edizione IV
Poiché, però, in ragione della peculiarità del reato di stalking è assolutamente imprevedibile
che le due persone vengano occasionalmente in contatto, sarebbe più ragionevole - oltre che
“di maggior garanzia per gli stessi diritti di colui che viene gravato dal divieto” - imporre
allo stalker il divieto di avvicinarsi a tutti i luoghi frequentati dalla vittima o comunque di
allontanarsi da detti luoghi in ogni occasione di incontro.
Questa tesi, individuando nella stessa persona offesa (e non nei luoghi da essa frequentati) il
riferimento centrale del divieto di avvicinamento, è certamente ispirata più ad una tutela
sostanziale della vittima che ai presupposti formali di applicabilità della misura.
Tuttavia, a parte l’assoluta impossibilità di prevedere il “come”, il “dove” e “quante volte”
la vittima e il carnefice possano occasionalmente incontrarsi, non si può fare a meno di
considerare come essa si ponga in torsione col principio per il quale la tutela costituzionale
della libertà personale, intesa come diritto inviolabile del cittadino, comporta che ogni
restrizione di essa vada adottata nei casi e modi previsti dalla legge, con esclusione quindi di
ogni possibilità di interpretazione estensiva o analogica (Cass. pen. 15-2-1988).
2.5. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale. Il divieto di analogia in
malam partem che vige nel sistema penale, corollario del principio di legalità, ha fatto
ritenere che, a fronte della mera omissione della denuncia di un reato da parte di un pubblico
ufficiale, in assenza di elementi idonei a dimostrare che tale condotta mirasse ad aiutare il
reo, ad eludere le investigazioni e assicurarsi il profitto del reato stesso, non è integrato il
delitto di favoreggiamento. È configurabile, al più, il reato di omessa denuncia se ricorrono
tutti gli elementi di tale specifico reato.
Se, ad es., un appartenente alla polizia di Stato subisce il furto della propria autovettura e,
una volta contattato da chi ne ha la disponibilità, paga una somma di denaro per ottenerne la
restituzione, senza denunciare l’estorsione ai suoi danni, non sussiste il reato di omessa
denuncia qualora egli abbia acquisito la notizia di reato a seguito di una conversazione di
natura privata, svoltasi al di fuori dell’esercizio delle funzioni e non connessa in alcun modo
ad esse. Infatti, gli appartenenti alla polizia di stato, non essendo quest’ultima una struttura
militare, non possono ritenersi in servizio permanente effettivo fuori dall’esercizio delle
funzioni (Cass. pen. 15923/2013).
Con riferimento alla configurabilità del reato di favoreggiamento, anche se su un piano
astratto dovesse ritenersi l’omissione di denuncia quale azione mirata in favore del reo,
varrebbe il principio di specialità: avremmo cioè un concorso di norme che non potrebbe che
risolversi mediante il principio di specialità in favore della norma che prevede
espressamente la condotta “speciale”, ovvero il reato di omessa denuncia di reato da parte
del pubblico ufficiale di cui all’art. 361 c.p.
L’esclusione che la condotta di omissione di denuncia integri di per sé il favoreggiamento
riguarda, ovviamente, la sua configurazione in astratto, mentre non è da escludere che, in
casi concreti, tale omissione rappresenti, in tutto od in parte, la “condotta mirata” a favorire
il reo.
Al riguardo, e proprio con riferimento alla condotta del pubblico ufficiale che rivesta anche
la qualifica di polizia giudiziaria, vanno citate due decisioni, le quali affermano che, laddove
la condotta integri sia il favoreggiamento che l’omessa denunzia, va applicato solo il primo e
più grave reato.
In un primo caso, si legge: “atteso che l’intera condotta antigiuridica della ricorrente appare
inquadrabile in un contesto di favoreggiamento, il reato di omessa denuncia attribuito
all’imputata dovrebbe, se finalizzato anch’esso a favorire l’indagato, essere sussunto per
16
Diritto Penale Parte generale
Vol. ST22 – Edizione IV
assorbimento nel più grave contestato reato di favoreggiamento di cui all’art. 378 c.p.”
(Cass. 2-7-2012, B. e altri). L’”intera condotta” consisteva in una pluralità di attività
specificamente finalizzate a consentire al “favorito” di eludere le indagini.
In un secondo caso, invece, un dipendente della polizia di Stato non solo “ostacolava le
investigazioni dell’autorità ... ritardando nell’inviare la relazione di servizio” ma le sviava
perché escludeva espressamente “che il fatto potesse essere dovuto a un attentato
dinamitardo” ed in questo contesto ometteva “di denunciare il danneggiamento
dell’autovettura”; in conseguenza, la corte affermava: “ la condotta di favoreggiamento è
consistita nell’omessa denuncia dell’attentato da parte dell’imputato, sicché la fattispecie di
cui all’art. 361 c.p. risulta assorbita in quella di cui all’art. 378 c.p.” (Cass. 16-6-2011,
Bevilacqua).
In entrambe le vicende l’omissione della denuncia faceva parte della più ampia condotta
espressamente mirata, nell’intenzione dei responsabili, al favoreggiamento.
Quest’ultimo reato, del resto, è “a condotta libera” per cui è possibile che la condotta mirata
al favoreggiamento integri, in tutto o in parte, un altro reato; e, rispetto alla configurabilità
nel caso concreto di più reati, nelle due sentenze citate è stata esclusa l’applicazione del
reato meno grave non in base al criterio di specialità ex art. 15 c.p. (che rileva in astratto) ma
in base al criterio dell’assorbimento, che riguarda l’interferenza in concreto fra le più
fattispecie criminose (ovvero l’applicazione sostanziale del principio processuale del ne bis
in idem).
In questi casi, quindi, si è fatto riferimento al principio di assorbimento, ritenendo che, nel
caso concreto, il reato a condotta libera (il favoreggiamento) più grave esaurisse
compiutamente l’intero disvalore del fatto.
2.6. L’acquisto di prodotti con marchi contraffatti. Sempre sul crinale dell’esatta
individuazione della norma applicabile, in ossequio al principio di stretta legalità del diritto
penale, si pone il problema di stabilire se l’acquirente finale di un prodotto con marchio
contraffatto, o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, risponda
dell'illecito amministrativo previsto dall’art. 1, co. 7, D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005,
poi modificato dalla L. 99/2009, di ricettazione (art. 648 c.p.) o di acquisto di cose di
sospetta provenienza (art. 712 c.p.).
La giurisprudenza più recente ritiene configurabile l’illecito amministrativo, per la
prevalenza del primo rispetto ai predetti reati alla luce del rapporto di specialità desumibile,
oltre che dall'avvenuta eliminazione della clausola di riserva “salvo che il fatto non
costituisca reato”, dalla precisa individuazione del soggetto agente e dell'oggetto della
condotta nonché dalla rinuncia legislativa alla formula “senza averne accertata la legittima
provenienza”, il cui venir meno consente di ammettere indifferentemente dolo o colpa.
Questa tesi è stata abbracciata da Cass. S.U. 22225/2012, che ha ricostruito la vicenda
legislativa che aveva preso le mosse dall’intervento del D.L. 35/2005, con cui era stata
introdotto l’illecito amministrativo dell’acquisto di prodotti con segni distintivi contraffatti o
di provenienza diversa da quella indicata sui beni.
La sentenza ha evidenziato che il percorso legislativo della norma, destinata a rafforzare il
sistema di lotta contro la contraffazione, si è caratterizzato per una più intensa repressione
delle condotte poste in essere dai soggetti diversi dagli acquirenti finali, per la progressiva
eliminazione, nell’individuazione della condotta illecita, della condizione di consapevolezza
relativa alla provenienza illegittima dei prodotti, per l’esclusione della clausola di riserva,
inizialmente prevista nella formulazione della disposizione per l’ipotesi di acquisto da parte
17
Diritto Penale Parte generale
Vol. ST22 – Edizione IV
degli acquirenti finali, poi eliminata per costoro e introdotta per la prima volta, invece, per le
fattispecie concernenti i soggetti diversi dagli acquirenti finali.
Analizzando queste specificità della progressiva sistemazione del dettato normativo, la
decisione ha individuato due profili decisivi per sostenere il carattere speciale della
fattispecie descrittiva dell’illecito amministrativo rispetto alla figura delittuosa della
ricettazione.
Il primo è rappresentato dall’inserimento dell’illecito amministrativo ex art. 1, co. 7, D.L.
35/2005 per un fatto che in precedenza ricadeva nell’orbita della norma penale (circostanza
rilevante ai fini dell’individuazione della specialità dell’illecito amministrativo, in quanto
operante “in tutti i casi in cui, ad una condotta penalmente sanzionata, si aggiunga una
disciplina normativa che la preveda anche come violazione di natura amministrativa. A
meno che il legislatore abbia inteso affiancare la sanzione amministrativa a quella penale,
l’interprete deve privilegiare l’interpretazione che valorizza la specialità, ritenendo la
depenalizzazione della condotta in precedenza costituente reato che sia presa in
considerazione dalla nuova normativa e, nel caso inverso, optando per la sola ipotesi
penalmente sanzionata (Cass. S.U. 28-10-2010, Di Lorenzo).
Il secondo aspetto riguarda le differenze strutturali tra il delitto di ricettazione e l’illecito
amministrativo (differenze che toccano il soggetto responsabile della violazione
amministrativa, ossia solo l’acquirente finale; l’oggetto materiale della condotta illecita,
rappresentato da un particolare genus di beni di provenienza illecita; il requisito psicologico,
indifferente per la configurazione dell’illecito amministrativo che si realizza sia per dolo che
per colpa), che fanno ulteriormente risaltare il carattere di specialità della norma sanzionata
in via amministrativa.
Infine, in uno sforzo di armonizzazione del sistema penale e amministrativo destinato al
contrasto della contraffazione nella materia della proprietà industriale ed intellettuale, la
decisione segnala il parallelismo che, sulla scorta dell’interpretazione prescelta, si stabilisce
rispetto alla disciplina dettata in materia di acquisto di prodotti realizzati in violazione di
opere tutelate dal diritto d’autore, dove la condotta realizzata a uso esclusivamente personale
— a differenza delle condotte realizzate a fini di commercializzazione — costituisce illecito
amministrativo ai sensi dell’art. 174ter L. 633/1941 (Cass. 30-4-2009, Cannariato).
Dispensa giurisprudenziale
La retroattività della lex mitior si applica anche all'illecito amministrativo?
Trib. Cremona 11-9-2013, n. 447
SOLLEVA
eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 1 L. 689/1981, in quanto contrastante
con gli art. 3 e 117 Costituzione, in relazione all’art. 7 Cedu, all’art. 15 del Patto
internazionale dei diritti civili e politici e all’art. 49 Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea
MOTIVI
18
Diritto Penale Parte generale
Vol. ST22 – Edizione IV
L’art. 1 L. 689/1981, intitolato “principio di legalità”, prevede che nessuno possa essere
assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima della commissione della violazione.
Non viene ripetuto perciò il principio dell’applicazione retroattiva della lex mitior, ossia
l’applicazione della legge successiva più favorevole all’autore della violazione (art. 2,
co. 2, c.p.).
Tale lacuna deve ritenersi in contrasto con l’art. 3 Cost. e col principio di
ragionevolezza e uguaglianza.
Malgrado la Corte costituzionale si sia già pronunciata in senso negativo sul punto
(Corte cost. 501/2002, 245/2003), si ritiene che l’evoluzione giurisprudenziale degli
ultimi anni, anche della stessa Consulta, imponga di riconsiderare la questione.
Infatti la Corte (Corte cost. 393/2006), occupandosi della legittimità costituzionale della
L. 251/2005, ha recentemente chiarito che la retroattività della legge più favorevole, pur
non essendo prevista espressamente dalla costituzione (a differenza dell’irretroattività
della legge sfavorevole), nemmeno in ambito penale, deve comunque considerarsi
espressione di un principio generale dell’ordinamento, legato ai principi di materialità e
offensività della violazione, dovendosi adeguare la sanzione alle eventuali modificazioni
della percezione della gravità degli illeciti da parte dell’ordinamento giuridico.
Sebbene il principio dell’applicazione retroattiva della lex mitior non sia assoluto, ha
spiegato in quell’occasione la Corte, a differenza di quello di cui all’art. 2, co. 1, c.p. (e
art. 25, co. 2, Cost.), che la sua deroga deve essere giustificata da gravi motivi di
interesse generale (Corte cost. 393/2006, 236/2011), dovendo in tal senso superare un
vaglio positivo di ragionevolezza e non un mero vaglio negativo di non manifesta
irragionevolezza.
Devono cioè essere individuati gli interessi superiori, di rango almeno pari a quello del
principio in discussione, che ne giustifichino il sacrificio.
Non si ravvisano tuttavia nella specie motivi tali da supportare il sacrificio al trattamento
più favorevole, come dimostra anche la considerazione che, in altri settori, il legislatore
ha recentemente introdotto norme del tenore dell’art. 2, co. 2, c.p.
Possono citarsi l’art. 23bis d.P.R. 148/1988 (introdotto dall’art. 1 L. 326/2000) in materia
di illeciti valutari, l’art. 3 D.Lgs. 472/1997 sulle violazioni tributarie (Cass. 1656/2013),
l’art. 46 D.Lgs. 112/1999 in materia di concessioni del servizio di riscossione, l’art. 3
D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti per illecito
penale.
Malgrado si tratti di settori speciali, non sussiste una differenza ontologica tra gli illeciti
amministrativi oggetto delle norme citate e la disciplina generale della L. 689/1981, né
si rinvengono motivi di interesse generale tali da giustificare il diverso trattamento.
Sussiste quindi violazione dell’art. 3 Cost. anche per ciò che riguarda il principio di
uguaglianza, assunte le norme citate come tertium comparationis.
Circa il fatto che le sentenze sopra richiamate riguardano specificatamente la materia
penalistica, non pare che ciò possa costituire un serio ostacolo alla loro applicazione
anche al settore degli illeciti amministrativi.
La dottrina italiana si è infatti da tempo orientata nel senso di ritenere che non
sussiste una differenza ontologica tra illeciti penali e illeciti amministrativi, sicché
la scelta del legislatore di sanzionare una certa condotta tramite l’una o l’altra sanzione
dipende e deve essere ispirata unicamente al principio di sussidiarietà (bisogno e
meritevolezza di pena), nell’ottica di un diritto penale minimo.
19
Diritto Penale Parte generale
Vol. ST22 – Edizione IV
I tradizionali corollari del principio di legalità e riserva di legge in materia penale,
pertanto, sebbene in passato siano stati riferiti alla sola materia penale, tendono oggi
invece ad essere considerati espressione di limiti generali al potere punitivo dello Stato,
e ciò anche con riferimento all’applicazione retroattiva della lex mitior, nel senso che
l’essenza afflittiva della potestà sanzionatoria – anche amministrativa - dovrebbe
essere rapportata alla valutazione che storicamente l’ordinamento operi della condotta
che intende reprimere.
Le stesse norme sopra citate che, nel corso degli anni, hanno esteso l’applicazione
retroattiva della lex mitior anche a specifici settori di illecito amministrativo sono segno
di questa evoluzione della sensibilità giuridica.
Tale omogeneità tra illecito penale e amministrativo, dal punto di vista delle garanzie
minime, connota del resto anche il quadro sovranazionale, ove pure interessanti
argomenti possono trarsi dall’evoluzione della giurisprudenza della Cedu sull’art. 7 della
Convenzione (sentenza Scoppola c. Italia 2009 e Mihai Roma c. Romania 2012), anche
alla luce dell’art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e dell’art. 49 della
Carta di Nizza.
Va premesso che la Corte di Strasburgo ha più volte ricordato che l’applicazione delle
garanzie previste dall’art. 7 non dipende dalla qualificazione da ciascun ordinamento
attribuita all’illecito e alle sue conseguenze sanzionatorie, altrimenti sarebbe assai
semplice per gli Stati eludere i dettami della Convenzione.
La Corte ha quindi elaborato una nozione autonoma di materia penale, legata a
parametri sostanziali, tra cui la natura del precetto violato e la gravità della sanzione
prevista, con la conseguenza che il nomen iuris attribuito da ciascun ordinamento ad
una fattispecie afflittiva non è che il punto di partenza per valutare la concreta
applicabilità delle garanzie convenzionali.
Così, con riferimento alla natura della precetto violato, la Corte ha ritenuto
fondamentale che la norma sia diretta alla generalità dei consociati e che il precetto
abbia finalità preventiva, repressiva, punitiva (cfr Corte EDU Ziliberg c. Moldavia, Corte
EDU Paykar Yev c. Armenia).
Nel determinare il carattere penale o meno di una sanzione cioè, la Corte ne considera
l’afflittività, usando come stella polare il finalismo della sanzione stessa, ricostruendo
in termini di dissuasione e al tempo stesso di repressione, secondo un modello
tipicamente punitivo.
Quanto alla gravità della sanzione, non è necessario ch’essa comporti la privazione
della libertà personale (cfr Corte EDU Kadubec c. Slovacchia), essendo sufficiente che
il soggetto subisca anche solo delle conseguenze finanziarie, tenendosi presente che
comunque non va considerata la sanzione in concreto applicata, ma la sanzione più
grave che l’ordinamento avrebbe potuto applicare.
Se dunque si fa applicazione di tali criteri agli illeciti amministrativi e alle relative
sanzioni, non vi è alcuna difficoltà a ritenere che anch’essi rientrino nel fuoco dell’art.
7 della CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
D’altro canto, tornando alla giurisprudenza della Corte EDU sull’art. 7, non può
trascurarsi che, nel 2009, con la sentenza 2009 Scoppola c. Italia, la Corte stessa, in
parte mutando propri precedenti orientamenti, ha espressamente affermato che il
principio dell’applicazione della legge più favorevole al reo deve considerarsi implicito
nell’art. 7 della Convenzione, anche alla luce dell’importanza acquisita dal principio in
parola nel panorama giuridico europeo e internazionale.
Il revirement è stato giustificato proprio anche dalla necessità di adeguare il sistema di
tutele CEDU alle altre carte dei diritti presenti nel panorama internazionale (ad es. art.
20
Diritto Penale Parte generale
Vol. ST22 – Edizione IV
15 Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici, art. 49 Carta dei Diritti dell’Unione
Europea).
Trattasi di una decisione ispirata al c.d. maximum standard, ossia all’esigenza di
conformare il livello di tutela assicurato dalle norme convenzionali a quello riconosciuto
da analoghe e omologhe disposizioni di matrice sovranazionale, che, nel caso di
specie, hanno espressamente innalzato il principio dell’applicazione della lex mitior al
rango di principio fondamentale del diritto penale, nell’accezione sopra esposta (lo
stesso iter argomentativo del resto di Corte cost. 393/2006).
Il tutto è stato quindi confermato in tempi recenti nella sentenza Corte europea 2012
Mihai Toma c. Romania, dove espressamente si afferma che l’art. 7 della
Convenzione, da un lato, proibisce l’applicazione retroattiva della legge penale che
vada a detrimento dell’accusato, dall’altro “garantisce l’applicazione della legge più
favorevole al reo”, con una statuizione lapidaria che sembra superare anche i residui
margini di discrezionalità che la Corte Costituzionale aveva lasciato al legislatore nella
sentenza 236/2011 (bilanciamento con altri interessi di pari rango).
L’acquisita natura di garanzia convenzionale del principio della retroattività della lex
mitior, unitamente all’inclusione dell’illecito amministrativo e delle relative sanzioni nella
materia penale ai sensi della Convenzione, comporta quindi la necessità di
riconsiderare – superandolo - l’orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass.
6712/1999, S.U. 890/1998, Cass. 8074/1998, 11928/1995), avallato in passato dalle
sentenze 501/2002 e 245/2003 della Corte Costituzionale, sfavorevole all’applicazione
alla materia delle sanzioni amministrative del principio in esame.
Per i motivi suddetti le questioni sollevate non possono ritenersi manifestamente
infondate.
La questione non può essere risolta per via interpretativa, in quanto esiste consolidata
giurisprudenza (vero e proprio diritto vivente) della Cassazione, oltre a precedenti
negativi della Corte costituzionale, che in più occasioni hanno ribadito la non
applicabilità del principio della al settore degli illeciti amministrativi, rifiutando
un’applicazione analogica dell’art. 2, co. 2, c.p., anche alla luce dell’art. 14 preleggi
(Cass. 6712/1999, Cass. S.U. 890/1998, Cass. 8074/1998) e considerando i limitati
casi in cui il principio della retroattività della lex mitior opera come casi settoriali, non
estensibili oltre il loro ristretto ambito di applicazione.
Inoltre, come già evidenziato dalla Corte costituzionale nelle sentenze 347-348/2007,
l’unico rimedio in caso di contrasto tra la normativa italiana e quella convenzionale,
laddove non sia possibile un’interpretazione conforme (come nella specie, stante il
diritto vivente contrario), non potendosi ricorrere alla tecnica della disapplicazione
(prerogativa del diritto comunitario), è il rinvio alla Consulta per violazione dell’art. 117,
co. 1, Cost. [...].
La vendita di semi di cannabis con indicazione delle modalità di coltivazione non è
punibile ex art. 82 d.P.R. 309/1990 ma può rilevare come istigazione al delitto di
coltivazione di sostanze stupefacenti ex art. 414, co. 1, n. 1, c.p.
Cass. pen. S.U. 18-10-2012, n. 47604
CONSIDERATO IN DIRITTO
21
Diritto Penale Parte generale
Vol. ST22 – Edizione IV
La questione sottoposta al vaglio delle sezioni unite è la seguente: «Se integra il reato di
istigazione all’uso di sostanze stupefacenti la pubblicizzazione e la messa in vendita di semi
di piante idonee a produrre dette sostanze con la indicazione delle modalità di coltivazione e
della resa».
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità si è espressa in modo contrastante.
Un primo orientamento [....] interpreta l’art. 82, co. 1, d.P.R. 309/1990 (Testo unico
stupefacenti) nel senso che la condotta istigatoria in esso delineata comprende l’attività di
pubblicizzazione di semi di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti con precisazioni
sulla coltivazione delle stesse. L’argomentazione posta alla base della conclusione si
incentra nel rilievo che, anche in mancanza di pubblicità volta ad esaltare la qualità del
prodotto e l’uso dello stupefacente che si ricava dalle piante, la normale finalità della
coltivazione è l’ottenimento e l’utilizzo della droga. Sussiste, pertanto, un’interconnessione
tra pubblicizzazione di semi, coltivazione degli stessi e utilizzo di sostanze stupefacenti. ...
Un’altra decisione, quella di Cass. 5 marzo 2001, Gobbi (id., Rep. 2001, voce cit., n. 39), è
stata in tale modo massimata: «Ai fini della configurabilità del reato di istigazione all’uso di
sostanze stupefacenti occorre che l’agente, per il contesto in cui opera e per il contenuto
delle sue esortazioni, abbia, sul piano soggettivo, l’intento di promuovere tale uso e, dal
punto di vista materiale, di fatto si adoperi, con manifestazioni verbali, con scritti o anche
con il ricorso al linguaggio ‘simbolico’ affinché l’uso di stupefacenti da parte dei destinatari
delle sue esortazioni sia effettivamente realizzato (fattispecie nella quale la corte ha escluso
il reato nel caso di volantinaggio da parte di studenti favorevoli alla liberalizzazione di
droghe leggere)».
Una diversa opinione (espressa da Cass. 17-1-2012, Bargelli) si discosta dalle precedenti,
movendo dal principio giurisprudenziale secondo il quale la vendita di semi di piante dai
quali sono ricavabili sostanze stupefacenti non costituisce reato perché riconducibile agli atti
preparatori privi di potenzialità causale rispetto alle attività vietate. Alla luce di tale
principio, la sentenza interpreta il rapporto tra la fattispecie penale dell’art. 82, co. 1, riferita
a chi pubblicamente istiga all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, e l’illecito
amministrativo, di cui al successivo art. 84, concernente la propaganda pubblicitaria di
sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall’art. 14. In particolare, rileva che
la condotta dell’art. 84 non possa consistere in una propaganda finalizzata alla vendita, ma
semplicemente in un’opera di diffusione senza induzione all’acquisto; nella condotta
dell’art. 82, invece, si riscontra un qualcosa di aggiuntivo che spinge all’uso del prodotto da
parte del destinatario della propaganda. Ne consegue che, nei casi in cui la pubblicità si
soffermi solo sull’illustrazione delle caratteristiche delle piante che nascono dai semi e sulle
modalità della loro coltivazione, il reato dell’art. 82 non può ritenersi sussistente perché
l’azione non è idonea a suscitare consensi ed a provocare il concreto pericolo dell’uso di
stupefacenti da parte dei destinatari del messaggio.
Innanzi tutto, è opportuno precisare che ogni tipo di inserzione pubblicitaria avente per
oggetto prodotti droganti deve essere oggetto di divieto.
Il principio ha un fondamento sovrannazionale nell’art. 10, co. 2, della convenzione di
Vienna del 1971, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 385/1981, che stabilisce:
«Ciascuna parte, tenendo debito conto delle norme della sua Costituzione, proibirà le
inserzioni pubblicitarie riguardanti le sostanze psicotrope e destinate al grosso pubblico».
Il nostro ordinamento, nell’alveo della lotta alla droga, colpisce, con una forte anticipazione
della tutela penale, ogni forma di propaganda degli stupefacenti e ogni condotta di stimolo
alla creazione, diffusione o al consumo degli stessi.
22
Diritto Penale Parte generale
Vol. ST22 – Edizione IV
Non è, tuttavia, inseribile, nel settore della inibita propaganda, la mera offerta in vendita di
semi dalla cui pianta sono ricavabili sostanze stupefacenti; l’attività che ha tale oggetto
di per sé non è vietata, configurandosi come atto preparatorio non punibile perché non
idoneo in modo inequivoco alla consumazione di un determinato reato per la considerazione
che non è dato dedurre la effettiva destinazione dei semi (Cass. 1-9-1988, Lanzuisi; 17-12012, Bargelli). [....]
Il fondamentale elemento discretivo tra le due fattispecie (i residui sono di minore
significatività in rapporto al quesito in esame) deve essere reperito nella tipologia delle
condotte; una loro precisa individuazione esclude già che in certe ipotesi nascano problemi
di conflitto.
La pubblicità è in genere concisa, non mira a proporre modelli di comportamento ed a
persuadere il pubblico facendo leva sulle presunte ragioni ideologiche che stanno alla base
della scelta suggerita; quindi, non è conciliabile con la nozione di proselitismo.
Il messaggio pubblicitario non implica un rapporto personale tra il propagandista e il
destinatario con opera di diretto influenzamento dell’uno sull’altro, per cui è da scartare che
possa essere classificato nel novero dell’induzione.
Rimane la condotta di istigazione effettuata pubblicamente (secondo la disposizione
definitoria dell’art. 266, ult. co., c.p.) che presenta un labile confine con quella di
propaganda, dato che il legislatore ha usato nello stesso contesto normativo termini diversi,
occorre che l’interprete non li omologhi e cerchi di individuare i rispettivi ambiti di
applicazione, sì da rendere ragionevole la scelta della differente risposta punitiva.
Sul punto, la citata sentenza della Cass. 17 gennaio 2012 ha focalizzato la distinzione,
ponendo l’accento sulle caratteristiche del messaggio pubblicitario che, nell’art. 84, deve
essere asettico e non deve indurre i destinatari all’acquisto o all’uso del prodotto stesso.
La corte condivide questa impostazione, anche se sono eccezionali le ipotesi di propaganda
pubblicitaria che non invoglino all’acquisto; tuttavia, il criterio individuato nella sentenza è
l’unico reperibile che, sul piano strutturale, diversifichi le condotte, incida
significativamente sul livello dell’offesa ed abbia come ricaduta di condurre la previsione
dell’art. 84 nell’alveo di una ipotesi marginale e di scarsa lesività.
Si ritiene, pertanto, che rientri nella propaganda pubblicitaria la condotta di chi si limita in
modo asettico e neutro a rendere noto al pubblico l’esistenza della sostanza veicolando un
messaggio non persuasivo e privo dello scopo immediato di determinare all’uso di
stupefacenti.
La delineata esegesi del rapporto tra norme trova riscontro nella clausola di riserva
dell’art. 84, 2° comma, non valutata dalla giurisprudenza che si è occupata dell’argomento.
Il legislatore si è reso conto che il termine propaganda può essere interpretato con parametri
non bene definiti e che tra le sue previsioni non sussiste un rapporto di specialità risolvibile
ai sensi dell’art. 9 L. 689/1981, bensì di gravità crescente, ed ha fornito una chiave per
risolvere il conflitto apparente di norme.
Occorre ora prendere in considerazione la fattispecie concreta e verificare se, come
sostenuto dal ricorrente, sia corretto il suo inquadramento nella ipotesi di reato dell’art. 82,
sotto la previsione dell’istigazione all’uso di stupefacenti; sul tema, la corte non condivide la
opinione delle sentenze che hanno risposto positivamente, perché la condotta contestata solo
indirettamente ed eventualmente conduce al consumo di sostanze droganti.
Non è possibile equiparare la nozione di stupefacente a quella di pianta dalla quale, con
determinati procedimenti chimici neppure menzionati nella pubblicità, è ricavabile una
sostanza drogante che, allo stato naturale, è compresa nelle tabelle; una simile esegesi non
23
Diritto Penale Parte generale
Vol. ST22 – Edizione IV
rientra nel novero di una plausibile interpretazione estensiva perché travalica l’ambito dei
possibili significati letterali, sia pure amplificati all’estremo, del termine stupefacente e
dilata il fatto tipico integrandolo con un’ipotesi non espressamente inclusa con palese
violazione del principio di tassatività e del divieto di analogia nel diritto penale.
Quanto precisato sul divieto dell’analogia (valevole anche per le sanzioni amministrative
per il principio di legalità inserito nell’art. 1, co. 2, L. 689/1981) non è trasferibile anche
all’art. 84 per il quale la propaganda può essere effettuata anche indirettamente, cioè,
facendo sorgere nel pubblico — in modo obliquo, dissimulato o per associazioni di idee —
il riferimento implicito alla sostanza stupefacente.
La citata norma, tuttavia, non è applicabile perché l’offerta del prodotto da parte degli
imputati era correlata da ulteriori, allettanti specificazioni. La precisazione rende il caso
non inquadrabile nella previsione dell’art. 84, perché il messaggio non era neutro ed
asettico: indicando i metodi botanici più appropriati per la resa dei semi, la pubblicità
invitava i destinatari all’acquisto dei semi come attività prodromica al successivo
comportamento consistente nella coltivazione di piante dalle quali è estraibile una sostanza
stupefacente.
Quest’ultima condotta è vietata dall’art. 26 t.u. stupefacenti e prevista come delitto dal
successivo art. 73, co. 3, perché accresce la disponibilità di droghe con conseguente pericolo
di diffusione illecita delle stesse.
Poiché gli imputati istigavano a commettere un reato con le modalità esecutive dell’art. 266,
co. 4, c.p., il caso può rientrare nella previsione dall’art. 414 c.p.; tale fattispecie si pone
come norma generale e non è applicabile in presenza di reati di istigazione più specifici.
In virtù di questo principio, il giudice ha rilevato che il delitto previsto dall’art. 82 sarebbe
una specie rispetto alla previsione codicistica; la tesi non è condivisibile perché raffronta il
reato di istigazione a delinquere con quello di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti che
deve essere escluso per la già detta ragione.
L’esatta comparazione tra norme, rapportata all’ipotesi che ci occupa, porta a concludere che
l’art. 82 non è strutturato come species rispetto al genus dell’art. 414 c.p., perché non
annovera tra le condotte punibili l’illegale coltivazione di stupefacenti. [....]
È anche inconferente, per il perfezionamento della fattispecie dell’art. 414 c.p., l’esito
dell’azione istigatrice, in virtù della clausola di indifferenza inserita nel 1° comma (che
costituisce una deroga al generale principio contenuto nell’art. 115 c.p.), ma è necessaria la
potenziale offensività della condotta che è richiesta per tutti i reati anche quando il precetto
tenda ad evitare la messa in pericolo del bene oggetto di tutela penale.
Occorre, pertanto, una ponderazione — riservata al magistrato di merito e da effettuarsi con
giudizio ex ante — circa la reale efficienza dell’azione stimolatrice a spronare le persone
con modalità tali da persuaderle a passare all’azione e da porsi come antecedente adeguato
per indurle a commettere il fatto illecito (sulla natura di delitto di pericolo concreto della
fattispecie dell’art. 414 c.p., v., tra le altre, Cass. 5-6-2001, Vencato).
Si evidenzia, inoltre, che, per la configurabilità del delitto ex art. 414 c.p. non è richiesta la
punibilità in concreto della condotta istigata, ma è necessario che la stessa sia prevista dalla
legge come reato.
Sul punto, occorre tenere nel debito conto il principio enucleato dalle sezioni unite che
(dopo avere precisato come costituisca un reato di pericolo astratto qualsiasi attività di
coltivazione non autorizzata di piante dalle quali è estraibile una sostanza stupefacente)
hanno ricordato il canone nullum crimen sine iniuria sotteso a tutti i reati che, secondo la
24
Diritto Penale Parte generale
Vol. ST22 – Edizione IV
giurisprudenza costituzionale, opera per il legislatore in astratto e per gli interpreti in
concreto quale criterio ermeneutico.
Consegue che necessita se la condotta contestata all’agente ed accertata sia assolutamente
inidonea a mettere a repentaglio il bene giuridico protetto risultando in concreto inoffensiva;
tale ipotesi ricorre quando la sostanza ricavabile dalla coltivazione non produca un effetto
drogante rilevabile (sez. un. 24 aprile 2008, Di Salvia, id., Rep. 2008, voce Stupefacenti, n.
48).
25
Diritto Penale Parte generale
Vol. ST22 – Edizione IV