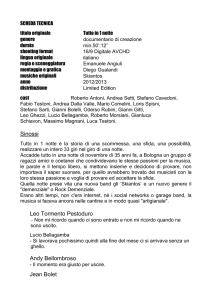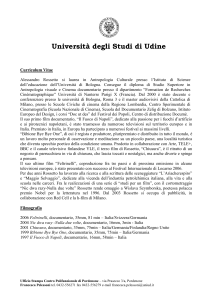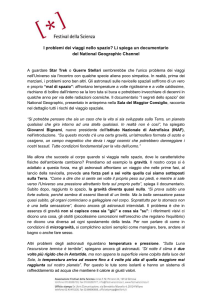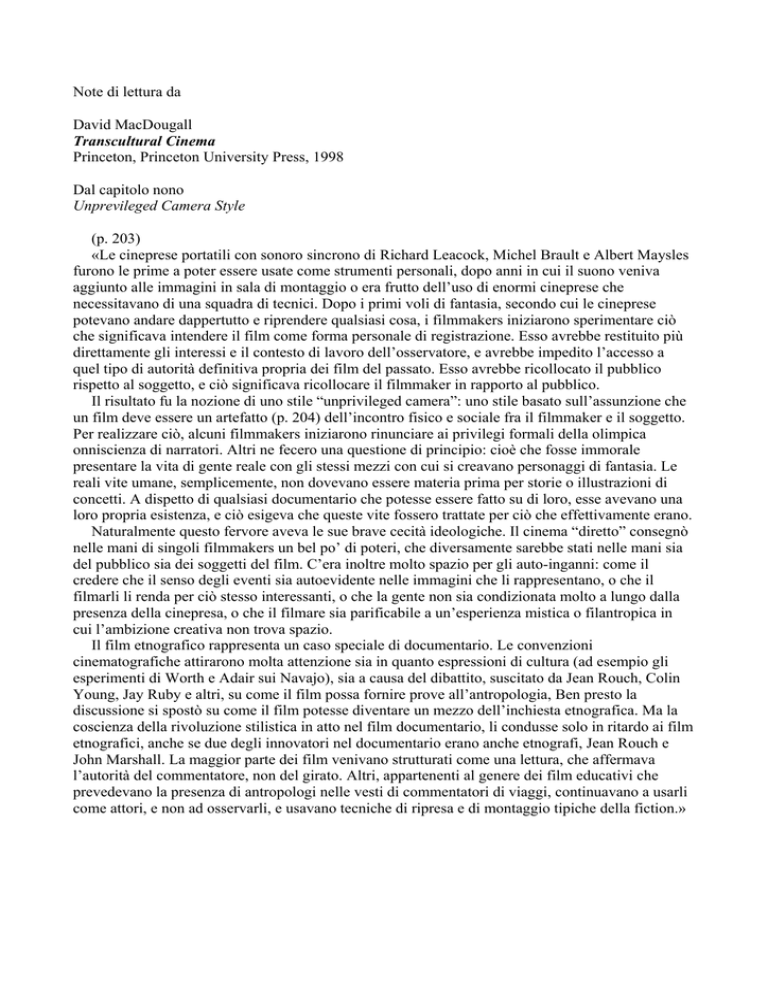
Note di lettura da
David MacDougall
Transcultural Cinema
Princeton, Princeton University Press, 1998
Dal capitolo nono
Unprevileged Camera Style
(p. 203)
«Le cineprese portatili con sonoro sincrono di Richard Leacock, Michel Brault e Albert Maysles
furono le prime a poter essere usate come strumenti personali, dopo anni in cui il suono veniva
aggiunto alle immagini in sala di montaggio o era frutto dell’uso di enormi cineprese che
necessitavano di una squadra di tecnici. Dopo i primi voli di fantasia, secondo cui le cineprese
potevano andare dappertutto e riprendere qualsiasi cosa, i filmmakers iniziarono sperimentare ciò
che significava intendere il film come forma personale di registrazione. Esso avrebbe restituito più
direttamente gli interessi e il contesto di lavoro dell’osservatore, e avrebbe impedito l’accesso a
quel tipo di autorità definitiva propria dei film del passato. Esso avrebbe ricollocato il pubblico
rispetto al soggetto, e ciò significava ricollocare il filmmaker in rapporto al pubblico.
Il risultato fu la nozione di uno stile “unprivileged camera”: uno stile basato sull’assunzione che
un film deve essere un artefatto (p. 204) dell’incontro fisico e sociale fra il filmmaker e il soggetto.
Per realizzare ciò, alcuni filmmakers iniziarono rinunciare ai privilegi formali della olimpica
onniscienza di narratori. Altri ne fecero una questione di principio: cioè che fosse immorale
presentare la vita di gente reale con gli stessi mezzi con cui si creavano personaggi di fantasia. Le
reali vite umane, semplicemente, non dovevano essere materia prima per storie o illustrazioni di
concetti. A dispetto di qualsiasi documentario che potesse essere fatto su di loro, esse avevano una
loro propria esistenza, e ciò esigeva che queste vite fossero trattate per ciò che effettivamente erano.
Naturalmente questo fervore aveva le sue brave cecità ideologiche. Il cinema “diretto” consegnò
nelle mani di singoli filmmakers un bel po’ di poteri, che diversamente sarebbe stati nelle mani sia
del pubblico sia dei soggetti del film. C’era inoltre molto spazio per gli auto-inganni: come il
credere che il senso degli eventi sia autoevidente nelle immagini che li rappresentano, o che il
filmarli li renda per ciò stesso interessanti, o che la gente non sia condizionata molto a lungo dalla
presenza della cinepresa, o che il filmare sia parificabile a un’esperienza mistica o filantropica in
cui l’ambizione creativa non trova spazio.
Il film etnografico rappresenta un caso speciale di documentario. Le convenzioni
cinematografiche attirarono molta attenzione sia in quanto espressioni di cultura (ad esempio gli
esperimenti di Worth e Adair sui Navajo), sia a causa del dibattito, suscitato da Jean Rouch, Colin
Young, Jay Ruby e altri, su come il film possa fornire prove all’antropologia, Ben presto la
discussione si spostò su come il film potesse diventare un mezzo dell’inchiesta etnografica. Ma la
coscienza della rivoluzione stilistica in atto nel film documentario, li condusse solo in ritardo ai film
etnografici, anche se due degli innovatori nel documentario erano anche etnografi, Jean Rouch e
John Marshall. La maggior parte dei film venivano strutturati come una lettura, che affermava
l’autorità del commentatore, non del girato. Altri, appartenenti al genere dei film educativi che
prevedevano la presenza di antropologi nelle vesti di commentatori di viaggi, continuavano a usarli
come attori, e non ad osservarli, e usavano tecniche di ripresa e di montaggio tipiche della fiction.»
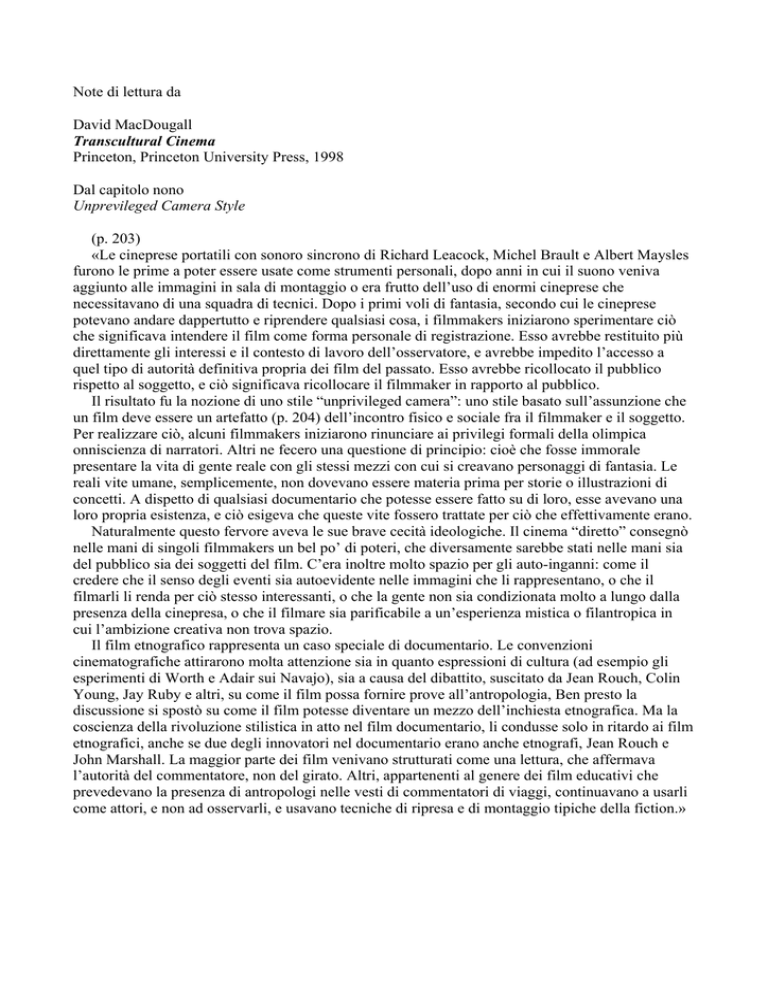



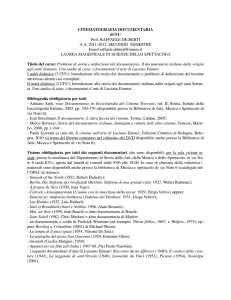
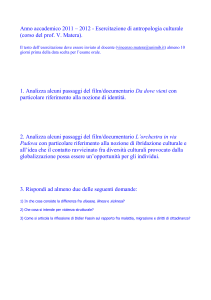

![Gli ultimi giorni [2] (1998)](http://s1.studylibit.com/store/data/005317823_1-8cea286b64940813f5ef510f7ea3985e-300x300.png)