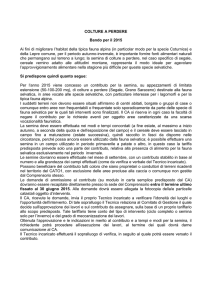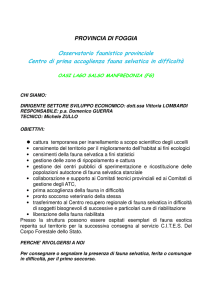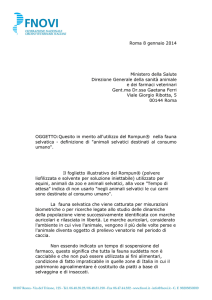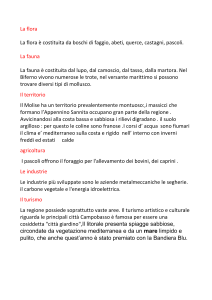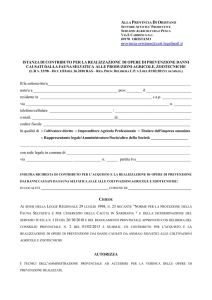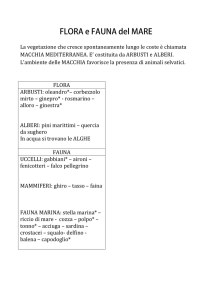LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA
CAPITOLO PRIMO
LA FAUNA SELVATICA
SOMMARIO: Capitolo primo. La fauna selvatica. – 1. In generale. – 2. La fauna nazionale. – 2.1. La cattività. – 3.
Regime giuridico. – Capitolo secondo. Profili penalistici. - 1. I delitti venatorii. – 2. Le
contravvenzioni. – 3. La tutela penale commerciale. – 4. Error, ignorantia, onus probandi. – Capitolo
terzo. Aspetti civili. - 1. La responsabilità civile in generale. – 2. Danno alla fauna. – 2.1. Fauna
selvatica e ambiente. – 2.2. Legittimazione attiva e criteri di quantificazione del danno. – 2.3. Il danno
alla fauna selvatica quale danno all’ambiente. – 2.3.1. Danno all’esemplare e danno alla fauna.
Coincidenza. – 2.3.2. La risarcibilità del danno all’ambiente. – 2.3.2.1. Il danno da reato ambientale. –
2.3.2.2. Gli interessi diffusi. – 2.3.2.3. Il danno non patrimoniale. – 2.3.2.4. Profili di risarcibilità del
danno ambientale non derivante da reato. – 2.3.2.5. Criteri di quantificazione del danno ambientale. La
restitutio in integrum. – 3. I danni cagionati dalla fauna selvatica. – 3.1. I soggetti obbligati al
risarcimento. – 3.2. I privati titolari del potere-dovere di gestione della fauna selvatica.
1. In generale.
Legislazione c.c. 842, 923 – l. caccia – r.d. 5.6.1939 n. 1016 – l. 11.2.1992 n. 157.
Le strategie legislative di tutela della sopravvivenza della fauna selvatica muovono,
tradizionalmente, dall’individuazione di specifiche specie animali sottratte, in tutto o in parte, al
libero esercizio dell’attività venatoria. Il primo testo legislativo in uso in età repubblicana – ma
promulgato in precedenza –, il r.d. 5.6.1939, n. 1016, testo unico delle norme per la protezione della
selvaggina e l’esercizio della caccia, individuava quale oggetto dei diversi regimi di tutela ivi
previsti la “selvaggina”, distinta in selvaggina ordinaria, selvaggina stanziale protetta e selvaggina
assolutamente protetta (artt. 1, 2, 3, 38). La categorizzazione dei tre tipi di selvaggina procedeva
attraverso la pedissequa indicazione di ciascuna specie animale legislativamente ricompresa sotto
l’uno o l’altro genere. Per ciascuna categoria di selvaggina erano previste speciali restrizioni
all’esercizio dell’attività venatoria, caccia e uccellagione, tutelate da sanzioni penali. Eccezioni
erano previste per le bandite, le zone di ripopolamento e cattura, le riserve (artt. 43 – 67 bis). Le
modalità di caccia ed uccellagione subivano ulteriori limitazioni finalizzate a non ledere gli interessi
di privati imprenditori, a non turbare il possesso dei fondi da parte dei proprietari, a non porre in
pericolo la pubblica incolumità e l’ordinato svolgimento della vita lavorativa (artt. 16 – 42).
Fino all’emanazione della l. caccia, nel 1977, l’imposizione di limitazioni di natura
pubblicistica all’esercizio dell’attività venatoria nei confronti delle specie animali protette fu l’unico
reale strumento di tutela della fauna selvatica. Tutti gli animali selvatici restavano, per quanto non
previsto dalla normativa vincolistica, proprietà privata del proprietario del fondo oppure di colui
che, nel rispetto della vigente legislazione in materia di caccia, se ne fosse impossessato. Tale
1
impossessamento determinava l’occupazione dell’animale e pertanto – essendo l’occupazione un
mezzo di acquisto a titolo originario della proprietà – la costituzione in capo all’occupante della
proprietà della selvaggina legittimamente catturata (artt. 842 e 923 c.c.).
La promulgazione della l. caccia determinò una rivoluzione copernicana nel concetto di tutela
statuale della fauna selvatica, con la costituzione ope legis, in capo alla Repubblica, del diritto di
proprietà sulla fauna selvatica esistente sul territorio nazionale. La conseguenza immediata fu
la configurazione del delitto di furto venatorio, commesso da chiunque, esercitando attività
venatoria al di fuori dei limiti di legge, si impossessasse al fine di trarne profitto di esemplari di
fauna selvatica, sottraendoli al proprietario – la Repubblica – che li deteneva (Cass. 7310/91, Cass.
10780/90, Cass. 9526/90, Cass. 8182/90, Cass. 11947/89, Cass. 4772/89, Cass. 313/89, Cass. 20/89,
e molte altre precedenti e conformi).
L’intera materia è stata riordinata dalla vigente l. 11.2.1992 n. 157, recante norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
La l. 11.2.1992, n. 157 qualifica come fauna selvatica oggetto della tutela legislativa (art. 2) le
specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o
temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sottopone a speciale protezione
alcune specie di animali pedissequamente elencate nonché tutte le altre specie animali che vengano
– anche successivamente – qualificate da direttive comunitarie, convenzioni internazionali o
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri come minacciate di estinzione. Esclude
dalla tutela le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole.
La tipologia di specie animali individuata dal Legislatore per la sottoposizione a tutela
evidenzia l’intento legislativo di sviluppare un regime vincolistico di “doppio binario”, che preveda
un regime di tutela sia per la fauna selvatica nazionale non a rischio di estinzione sia, ma con
maggiore rigore sanzionatorio, un regime di tutela per la fauna selvatica nazionale a rischio di
estinzione. L’utilizzo, da parte del Legislatore, dell’aggettivo “altre” per indicare alla lett. c)
dell’art. 2 le specie a rischio di estinzione indicate da fonti esterne al dettato legislativo consente di
ritenere senza alcun dubbio che nell’intenzione legislativa debbano ritenersi qualificate come
minacciate da estinzione – e per questo soggette a speciale tutela sotto il profilo sanzionatorio –
anche le specie elencate nelle lett. a) – mammiferi – e b) – uccelli – del medesimo art. 2.
Al fine di individuare con certezza l’oggetto della tutela è pertanto necessario comprendere
quale esatto significato ermeneutico vada attribuito all’espressione “specie di mammiferi e di
uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale
libertà nel territorio nazionale” adottata dall’art. 2 come descrizione della fauna oggetto di tutela.
2
2. La fauna nazionale.
Legislazione l. 11.2.1992 n. 157 2; 17.
Prima questione ermeneutica che si pone all’attenzione dell’interprete è costituita
dall’individuazione del concetto giuridico di relazione di stabile o temporanea vita in libertà
delle specie animali sul territorio dello Stato.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha percorso due linee ermeneutiche,
dapprima oscillando e poi attestandosi, in data più recente, su una interpretazione letterale e
restrittiva.
Presupposto imprescindibile della tutela accordata dalla legge n. 157
del
1992 alla fauna
selvatica e' il requisito della nazionalita', cioe' la sua relazione naturale con il territorio italiano,
per effetto della quale la specie animale diventa patrimonio indisponibile dello Stato italiano e
bene ambientale della comunita' nazionale. Ne consegue che non gode di tale tutela, ma, se del caso, di
quella accordata dalla convenzione di Washington del 3 marzo 1973, la fauna introdotta nel territorio
dello Stato per la via commerciale dell’importazione.
(Cass. 17.8.1993, n. 1013, MCP, riv. 194477).
La Suprema Corte privilegia dunque, ai fini dell’applicazione della tutela, il carattere della
naturale relazione della fauna protetta con il territorio della Repubblica, escludendo ogni esemplare
che, pur introdotto nel territorio medesimo, sia in relazione con il territorio di altri Stati.
L'oggetto sostanziale della tutela della legge 11 febbraio 1992 n. 157 non e' la sola fauna selvatica
vivente in stato di materiale liberta' nel territorio nazionale, ma la fauna selvatica in generale ovunque
esistente, onde il divieto di commercializzazione della fauna selvatica in violazione della citata
legge - divieto sanzionato dall'art. 30 lett. l) stessa legge - si riferisce in via generale ed assoluta alla
fauna selvatica che riceve protezione giuridica in Italia, a prescindere dalla provenienza. Ed invero, il
riferimento alla tutela, limitata alla fauna esistente sul territorio nazionale, contenuto nell'art. 2,
prima parte, di detta legge, va inteso quale ordinaria affermazione della possibilita' di legittimita' degli
atti di apprensione (caccia), non potendosi tali atti di regolamentazione estendere alla fauna vivente
all'estero, sulla quale lo Stato non puo' vantare il "dominium".
(Cass. 8.3.1994, n. 534, MCP, riv. 196808).
La tesi giurisprudenziale maggiormente estensiva tende a riconoscere tutela alla fauna
selvatica comunque vivente in istato di naturale libertà sul territorio della Repubblica,
indipendentemente dalla provenienza e dall’originaria relazione naturale con territori esteri.
La fauna selvatica oggetto di tutela da parte della legge n. 157 del 1992, purche' appartenente al
patrimonio dello Stato, e' costituita esclusivamente da quelle specie di animali (mammiferi e uccelli)
delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale
liberta' nel territorio nazionale, e cio' fino a quando tale vincolo permanga, perche', cessato questo,
non si rende ulteriormente esercitabile il dominio, per essere la cosa uscita dalla sfera di appartenenza
dello Stato stesso. Ne consegue che il divieto di commercializzazione o di detenzione a fini di
commercio previsto dall'art. 21 lett. bb) - della citata legge n. 157 del 1992 si riferisce esclusivamente
3
agli uccelli, loro parti o prodotti, cacciati o catturati nel territorio nazionale e non anche a quelli
importati dall'estero.
(Cass. 28.12.1994, n. 25, MCP, riv. 199390).
L’evoluzione giurisprudenziale sottolinea la centralità, per l’applicazione della tutela, non solo
della relazione della fauna con il territorio, ma anche, sotto il profilo strettamente giuridico, della
attualità del vincolo territoriale medesimo, che costituisce il motivo di sussistenza del dominium
statale che consente allo Stato di esercitare la tutela in parola.
La fauna selvatica protetta dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, purche' appartenente al patrimonio
dello Stato, e' solo quella appartenente a specie delle quali esistono popolazioni viventi, anche a
carattere temporaneo, in stato di naturale liberta' sul territorio nazionale. Ne consegue che il
divieto di commercializzazione o detenzione a fini di commercio, previsto dall'art.21 lett.bb)
della legge 157/1992, si riferisce esclusivamente ad animali prodotti, cacciati o catturati nel
territorio nazionale, e non anche a quelli importati dall’estero.
(Cass. 5.2.1998, n. 3932, MCP, riv. 209826).
L’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità è frutto di interpretazione
senz’altro letterale e restrittiva del dettato normativo, conformemente alla previsione posta dall’art.
12 c.c. Deve pertanto ritenersi che la disciplina positiva vada ricostruita nel senso dell’esclusione
dalla tutela legislativa della l. 11.2.1992, n. 157 delle specie animali importate dall’estero e non
liberamente viventi nel territorio italiano.
Tuttavia anche l’orientamentamento minoritario appare meritevole di particolare attenzione
nell’ottica di una moderna interpretazione del testo normativo vigente. Ed in effetti, non può non
sottolinearsi come l’ampia intenzione legislativa, contenuta nell’art. 2, di attribuire tutela statuale
anche a specie animali indicate da fonti di diritto internazionale – le convenzioni internazionali a
cui espressamente rinvia il Legislatore –, e pertanto a specie anche non etologicamente connesse
con il patrimonio faunistico nazionale, purché in via di estinzione, riveli un anelito legislativo di
ampio respiro, inteso alla tutela della fauna selvatica piuttosto come patrimonio della comunità
mondiale temporaneamente vivente nel territorio della Repubblica, che come connotato faunistico
del patrimonio immobile, animale e vegetale, della Repubblica e connotato dell’identità nazionale.
In tal senso depongono alcune considerazioni circa il dettato dell’art. 2. Nell’introdurre
l’elencazione delle specie protette perché minacciate da estinzione il testo normativo recita “sono
particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie”. Il fatto che le
specie elencate alle successive lett. a) e b) costituiscano parte del patrimonio faunistico nazionale,
in quanto viventi in libertà nel territorio italiano, ha di fatto reso sinora superflua la discussione
giuridica circa la necessità di coordinamento ermeneutico con la successiva lett. c).
Se infatti si intende interpretare restrittivamente il dettato normativo, deve prendersi atto che
le specie animali indicate alle lett. a), b) e c) sono “particolarmente protette”, godono cioè di
maggiore tutela rispetto a quella “generale” attribuita alle specie non in via di estinzione. Ma
4
nessun dato normativo positivo – se non il mero fatto della pedissequa elencazione – esclude la
necessità, anche per queste specie, del requisito, che appunto ha natura “generale”,
dell’appartenenza a popolazioni viventi liberamente sul territorio nazionale. Ciò significa che,
restrittivamente interpretando la norma, le specie indicate alle lett. a), b) e c) intanto sono soggette
a tutela in quanto comunque appartenenti a popolazioni viventi in istato di libertà sul territorio
nazionale. Aderendo a tale ricostruzione, si ridurrebbe per via ermeneutica l’àmbito oggettivo della
tutela posta dalla lett. c) la quale, riferendosi espressamente a specie animali individuate da
convenzioni internazionali, dovrebbe ricomprendere anche specie animali esistenti, ad esempio,
solo nel lontano oriente o nell’Africa profonda; tali specie, pure contemplate da convenzioni
internazionali verrebbero escluse dalla tutela nel territorio nazionale italiano perché non
appartenenti a popolazioni viventi in istato di naturale libertà su di esso.
Interpretando invece la norma in senso maggiormente ampio, potrebbe ritenersi che il
Legislatore abbia inteso, con la predisposizione della doppia tutela, prevedere che siano sottoposte
a protezione tutte le specie animali, in generale, viventi in istato di libertà nel territorio nazionale,
ed inoltre, indipendentemente dallo stato e dal territorio, le specie faunistiche indicate alle lett. a),
b), e c).
In tal senso potrebbe interpretarsi una sentenza della Suprema Corte, che affronta
incidentalmente la questione.
Il concetto di fauna selvatica e' riferito dalla legge 11 febbraio 1992, n.157 alle "specie", intese
come categorie generali, di mammiferi
ed uccelli, dei quali esistono popolazioni viventi
stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale liberta', sul territorio nazionale. Oggetto di
"particolare" protezione, ai sensi dell'art.2, seconda parte, della citata Legge n.157 del 1992, sono
alcune specie di mammiferi ed uccelli, espressamente indicate, nonche' tutte le altre specie di
mammiferi "minacciate di estinzione" in base alla normativa comunitaria ed internazionale
specificamente richiamata: per queste categorie esiste un divieto assoluto ed incondizionato di
abbattimento, cattura e detenzione ex art. 30 lett. B) stessa legge, senza che possa essere eccepita la
provenienza da allevamento.
(Cass. 22.7.1997, n. 7159, MCP, riv. 208961).
A supporto di tale orientamento esegetico soccorre un argomento logico. Vero è che le specie
in via di estinzione vanno specialmente protette, ma è pur vero che la tutela della fauna selvatica
non in via di estinzione è la prima strategia a disposizione dell’uomo per evitare che il rischio di
estinzione giunga ad interessare specie ancora fiorenti e diffuse. Se pertanto il Legislatore ha inteso
travalicare gli àmbiti nazionali nell’individuazione delle specie da tutelare dal rischio di estinzione,
potrebbe non esser peregrino ritenere che anche altre specie faunistiche, non etologicamente
connesse con il territorio nazionale ma in esso nondimeno viventi in istato di libertà a séguito di
introduzione per opera dell’uomo, possano ritenersi oggetto di tutela.
5
2.1. La cattività.
Legislazione l. 11.2.1992 n. 157 2; 17.
Ulteriore questione ermeneutica si pone circa il significato dello stato di naturale libertà delle
popolazioni animali che il testo legislativo pone come presupposto della tutela.
E’ necessario, in altri termini, comprendere se la nascita e/o la detenzione in istato di
cattività dell’esemplare costituisca elemento idoneo ad escludere la medesima dalla tutela
legislativa, per carenza del requisito dello status libertatis.
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha posto un insegnamento ancora
insuperato.
I volatili di allevamento devono essere ricompresi nella nozione di fauna selvatica ove risultino
appartenere ad una delle specie protette dalla legge-quadro 11 febbraio 1992 n. 157. In base
all'art. 2 della legge, letto in coordinamento con le altre disposizioni contenute nella legge, la
qualita' di fauna selvatica non viene persa per il fatto che l'esemplare sia nato o cresciuto in allevamento
quando esso appartenga ad una specie vivente in stato di libertà nel territorio nazionale.
(Cass. 12.12.1995, n. 12217, MCP, riv. 203914).
Lo stato di cattività non esclude la relazione di naturale vita della popolazione faunistica, di
cui fa parte l’esemplare, sul territorio nazionale in istato di naturale libertà.
La deduzione circa la destinazione alla vendita di cardellini in conseguenza della presenza di
numerose gabbie, in cui siano singolarmente contenuti, non e' destituita di fondamento e si fonda su
nozioni di comune esperienza, giacche' anche per gli uccellini la possibilita' di "socializzare" in un
ambiente piu' ampio e' propria del collezionista, mentre il venditore e' portato a restringere lo spazio
vitale, approntando singole gabbie per una vendita piu' rapida e per consentire all'acquirente di
osservare le diverse gradazioni di colore dei cardellini. Inoltre questa modalita' di detenzione non e'
indicativa della nascita "in cattivita'" in assenza di ulteriori riscontri, mentre l'allevamento di
fauna selvatica, che rimane tale anche se nata o temporaneamente detenuta in gabbia, giacche'
occorre considerare lo stato di naturale liberta' in cui essa dovrebbe vivere sul territorio dello Stato, e'
sottoposto ad autorizzazione regionale ed a particolari prescrizioni dall'art. 17 legge 11 febbraio 1992,
n. 157.
(Cass. 6.12.1994, n. 2950, MCP, riv. 200825).
Lo stato
di
cattività, secondo l’interpretazione della giurisprudenza, costituisce
esclusivamente una modalità imposta di nascita e/o di vita dell’esemplare di fauna, che nulla
modifica circa la qualificazione di esso come appartenente alla popolazione di animali vivente in
istato di libertà sul territorio nazionale, come tale destinataria della tutela legislativa.
Il concetto di fauna selvatica e' riferito dalla legge 11 febbraio 1992, n.157 alle "specie", intese
come categorie generali, di mammiferi
ed uccelli, dei quali esistono popolazioni viventi
stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale liberta', sul territorio nazionale. Oggetto di
"particolare" protezione, ai sensi dell'art.2, seconda parte, della citata Legge n.157 del 1992, sono
alcune specie di mammiferi ed uccelli, espressamente indicate, nonche' tutte le altre specie di
mammiferi "minacciate di estinzione" in base alla normativa comunitaria ed internazionale
specificamente richiamata: per queste categorie esiste un divieto assoluto ed incondizionato di
abbattimento, cattura e detenzione ex art. 30 lett. B) stessa legge, senza che possa essere eccepita la
provenienza da allevamento. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso con il quale l'imputato
deduceva inidonea motivazione in ordine alla circostanza della provenienza da allevamento degli
6
animali e, quindi, della carenza della natura selvatica degli stessi, la S.C., pacifico che la
detenzione riguardava due specie "particolarmente protette", espressamente vietata dalla legge e
sanzionata penalmente, ha osservato che "Il Pretore correttamente ha ritenuto che e' punita "la
semplice detenzione degli esemplari faunistici" costituiti da cigni e volpoche e, benche' non fosse
richiesto dalla normativa, ha escluso con accertamento di merito la provenienza da allevamento delle
specie in questione").
(Cass. 22.7.1997, n. 7159, MCP, riv. 208961).
La Suprema Corte ha inteso affermare che la tutela legislativa è attribuita a tutti gli esemplari
di popolazioni che, in quanto tali, vivano liberamente sul territorio nazionale. Pertanto, al fine di
escludere la tutela, non è sufficiente che il singolo esemplare sia nato o cresciuto in cattività, dal
momento che la condizione particolare dei singoli esemplari animali non esclude la loro
appartenenza alla popolazione, la quale di per sé vive liberamente sul territorio nazionale. Solo nei
limiti previsti dall’art. 17 l. 11.2.1992, n. 157, che attribuisce alle regioni il potere di autorizzare e
regolamentare l’allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale
ed amatoriale, è consentito il prelievo irregimentato, da parte del titolare dell’azienda agricola
esercente l’allevamento, di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all’art. 13,
ossia con i mezzi mediante i quali la caccia è consentita. Può pertanto sostenersi che l’animale di
cui sia stato autorizzato l’allevamento non cessi di fare parte della fauna selvatica, ma sia oggetto
di un diverso regime di tutela qualora il titolare dell’allevamento abbia agito nel pieno rispetto
delle normative regionali di autorizzazione e regolamentazione emanate in applicazione dell’art.
17 l. 11.2.1992, n. 157.
Altro argomento potrebbe svolgersi nel caso in cui si ravvisasse l’esistenza di specie animali
le cui intere popolazioni non vivano liberamente sul territorio nazionale e non siano importate
dall’estero, ma nascano e crescano, in quanto popolazioni, in cattività. Ciò avverrebbe nel caso in
cui esperimenti genetici dessero luogo alla produzione, in laboratorio, di specie animali non
riconducibili direttamente ad altre specie viventi liberamente sul territorio italiano o comunque
viventi in territorio estero. Nei confronti di tali nuove specie animali non sarebbe applicabile la
tutela legislativa per carenza del requisito della libera vita della popolazione sul territorio
nazionale.
La compiuta individuazione della fauna selvatica oggetto di tutela non può prescindere
dall’esame delle fonti normative alle quali la lett. c) dell’art. 2 espressamente rinvia.
Sono espressamente oggetto di tutela tutte le specie indicate come a rischio di estinzione da
tre fonti del diritto: le direttive comunitarie; le convenzioni internazionali; apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Deve pertanto escludersi che decreti e circolari ministeriali,
leggi emanate dalle regioni ordinarie, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome,
regolamenti locali e consuetudini possano efficacemente indicare altre specie a rischio di
7
estinzione. Deve invece attribuirsi tale efficacia ai regolamenti comunitari, notoriamente selfexecuting, ed alle leggi dello Stato.
3. Regime giuridico.
Legislazione c.c. 828 – l. 11.2.1992 n. 157 1 ; 30.
L’art. 1 della l. 11.2.1992, n. 157, riprendendo e confermando il principio ispiratore della l.
caccia del 1977, stabilisce che “la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è
tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale”.
L’affermazione legislativa in capo allo Stato del diritto di proprietà sulla fauna selvatica –
individuata nei sensi sopra indicati – produce alcuni effetti giuridici ben determinati, già enucleati
dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla l. caccia.
In tema di caccia, l'affermazione "ex lege" della proprieta' dello Stato su tutta la fauna selvatica
esistente sul territorio nazionale ha determinato l'attribuzione allo stesso di una signoria sui singoli
capi di selvaggina, che si esprime in una disponibilita' virtuale, sufficiente a rendere concreto il suo
possesso, anche se gli animali selvatici vivono allo stato di liberta' e in zone non recintate e non
sottoposte a specifica vigilanza. Ne consegue che l'uccisione di un capo di selvaggina, fuori dei casi di
specifica autorizzazione o di quelli in cui lo Stato, rinunziando temporaneamente ai suoi
poteri, consente la caccia, viola due diversi interessi: quello di carattere socio-politico, ricollegato al
mantenimento del patrimonio ambientale, appartenente all'intera collettivita', e quello di carattere
strettamente giuridico, tutelato dalle norme che, nel campo del diritto civile o di quello penale, sono
preposte alla tutela della proprietà e del possesso.
(Cass. 8.7.1991, n. 7310, MCP, riv. 187753).
Sulla base di tale ricostruzione giuridica del rapporto tra lo Stato e la fauna selvatica, fino
alla promulgazione della l. 11.2.1992, n. 157 la Suprema Corte era costantemente orientata nel
ritenere che lo Stato, oltre che titolare del diritto di proprietà, fosse anche possessore e detentore
dei singoli animali costituenti parte della fauna selvatica, di guisa che commetteva il delitto di
furto colui che, al di fuori delle ipotesi previste di legittima apprensione di animali, si
impossessava – per lo più esercitando attività venatoria – di animali costituenti parte della fauna
selvatica (Cass. 12089/82, Cass. 1788/83, Cass. 4189/84, Cass. 11523/85, Cass. 1732/86, Cass.
2074/88, Cass. 9526/90; ma v. contra Cass. 1849/89).
L’interpretazione giuridica fino ad allora privilegiata cessò a séguito della promulgazione
degli artt. 30 co. 3 e 31 co. 5 della l. 11.2.1992 n. 157, laddove si prevede che in caso di
abbattimento, cattura e detenzione di esemplari appartenenti alla fauna selvatica “non si applicano
gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale”. Il Legislatore ha pertanto ritenuto, in esercizio della
propria insindacabile discrezionalità di scelta politica, di limitare la sanzione penale per la condotta
di impossessamento illecito di esemplari faunistici alle previsioni dell’art. 30 della l. 11.2.1992, n.
157, escludendo ex lege la configurabilità del delitto di furto in relazione a simili comportamenti.
8
Lo Stato è pertanto proprietario, possessore e detentore ope legis della fauna selvatica. Esso
regola l’esercizio del proprio diritto di proprietà e del proprio possesso consentendo a determinate
condizioni l’apprensione, con conseguente acquisizione di possesso e proprietà, da parte di privati
di alcuni esemplari costituenti parte del patrimonio faunistico; autolimita altresì la tutela del
proprio diritto di proprietà e dei propri poteri di possessore e detentore escludendo la tutela penale
ordinaria apprestata dagli artt. 624, 625 e 626 c.p. per la repressione dei reati contro il patrimonio.
Sotto il profilo squisitamente civilistico, è noto come l’art. 828 c.c. stabilisca che “I beni che
costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole
particolari che li concernono e, in quanto non diversamente disposto, alle regole del presente
codice. I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro
destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”. La destinazione del bene
patrimoniale indisponibile costituito dalla fauna selvatica è del tutto originale rispetto al concetto
tradizionale di “destinazione” del bene pubblico, e deve senz’altro identificarsi nella
sopravvivenza della fauna medesima. E’ probabilmente l’unico caso di bene pubblico fornito di
destinazione autoreferenziale diretta, nel senso che la destinazione primaria della fauna selvatica è
la preservazione di sé medesima, mentre la destinazione finale, traslata, è la conservazione del
bene pubblico costituito dall’ambiente naturale e dall’ecosistema quale forma di salvaguardia del
diritto alla salute costituzionalmente garantito.
Primo corollario di tale inquadramento normativo è che nemmeno lo Stato stesso, in esercizio
dello ius utendi, fruendi ed abutendi tipico del diritto di proprietà, può disporre degli animali
costituenti parte della fauna selvatica al di fuori dei limiti e dei modi posti dalla l. 11.2.1992 n.
157.
Seconda conseguenza è costituita dall’impignorabilità degli esemplari faunistici. Il
pignoramento di un esemplare faunistico consisterebbe nella riduzione dello stile di vita
dell’animale dallo stato di libertà allo stato di cattività, così ponendone a rischio la sopravvivenza e
dunque mutandone la destinazione. Non può pertanto il privato agire esecutivamente su esemplari
faunistici – che possono anche assumere notevole valore venale – per il soddisfacimento di un
proprio credito nei confronti dello Stato e soprattutto non può, per questa via, costituire di fatto
proprie riserve di caccia private spacciandole per beni staggiti in sede di esecuzione civile.
Terzo aspetto risiede nell’astratta configurabilità guiridica dell’espropriazione per pubblica
utilità finalizzata alla tutela della fauna selvatica, ed al risarcimento dei danni cagionati a terzi per
l’esercizio di pubblici servizi, in assenza di espropriazione, finalizzati alla tutela medesima. In
materia di espropriazione per pubblica utilità relativa a beni appartenenti al patrimonio
9
indisponibile dello Stato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno posto alcuni principi
fondamentali.
I beni del patrimonio indisponibile dello Stato, in quanto soddisfano ad un bisogno pubblico e sono
soggetti ad una disciplina pubblica in ragione della loro destinazione, possono avere rilevanza per la
qualificazione pubblica dell’opera ai fini dell’espropriazione e della previsione dell’art. 46 della legge
25.6.1865 n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità, nonostante che siano soggetti anche alla
disciplina di diritto privato che non implichi sottrazione alla destinazione medesima (art. 828, capoverso,
cod. civ.). Deve ritenersi applicabile ad essi, come ad ogni altra opera pubblica, il principio, secondo il
quale la disposizione è estesa ai casi in cui il danno permanente derivi dall’esecuzione, dal mantenimento
e dall’esercizio di un’opera pubblica, compresi in tale qualificazione l’impianto e l’esercizio di un
pubblico servizio, senza che vi sia stato un procedimento di espropriazione. Tutti, invero, hanno elementi
di fatto che rientrano nell’ampia previsione tipica dell’art. 46; per tutti, quindi, ricorre il fondamento
razionale di tale norma, cioè che per i danni particolari e permanenti, non essendo invocabile un’esigenza
sociale comune a tutti, ma anzi tale esigenza essendo soddisfatta con danno del singolo, deve essere
corrisposto, per principio di giustizia distributiva, l’indennizzo. Pertanto, sono risarcibili i danni causati
dall’impianto e dall’esercizio di un pubblico servizio, i quali non ne siano conseguenza normale per tutti
ma, eccedendo tali limiti, siano particolari per alcuni e consistano in una lesione o perdita di utilità del
bene, rilevabile alla stregua della tutela giuridica dello stesso.
(Cass. SS. UU. 28.4.1961, n. 976, MCC, riv. 241238).
Deve pertanto ritenersi legittima l’espropriazione per pubblica utilità disposta a fini di tutela
della fauna selvatica, anche al di fuori della disciplina speciale posta dall’art. 15 l. 11.2.1992, n.
157 in materia di utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia.
L’art. 11 co. 6 della l. 11.2.1992, n. 157 prevede che “la fauna selvatica abbattuta durante
l’esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l’ha
cacciata”. Il cacciatore – non abusivo – assume pertanto, in luogo dello Stato, la qualità di
proprietario, possessore e detentore della fauna legittimamente cacciata.
La questione giuridica circa la natura del modo di acquisto della proprietà rappresentato
dal proficuo esercizio dell’attività venatoria va risolto nel senso dell’acquisto a titolo derivativo. Se
infatti è vero, dall’un lato, che nessun atto di volontà dello Stato concorre a deliberare il
trasferimento di proprietà dal patrimonio statale al cacciatore – dal momento che lo Stato si limita
a rinunziare al proprio diritto di proprietà sull’animale cacciato legittimamente nel momento in cui
sia effettivamente abbattuto ed appreso –, di guisa che apparirebbe configurabile un modo di
acquisto a titolo originario, alla stregua dell’occupazione, ammessa fino al 1977, è anche vero,
dall’altro lato, che non appare configurabile l’acquisto a titolo originario della proprietà di un bene
appartenente, fino alla materiale apprensione, al patrimonio indisponibile dello Stato. Ne consegue
che – pure nell’oggettiva incertezza giuridica della soluzione – appare preferibile la soluzione
consistente nell’individuazione dell’apprensione dell’animale cacciato come attività che determina
ipso facto la transizione del diritto di proprietà, ope legis, dallo Stato al cacciatore, piuttosto che la
soluzione che finisce per qualificare l’atto di apprensione medesimo come unico caso di attività del
privato idonea di per sé sola ad obliterare la qualità di bene pubblico all’oggetto
dell’impossessamento.
10
Conseguenza della previsione normativa in esame si è che il neo-proprietario dell’animale
abbattuto è colui che l’ha cacciato ed abbattuto e non già colui che per primo lo ha appreso. Ne
consegue che la condotta di colui che si impossessi di un animale cacciato da una terza persona va
qualificata, a tutti gli effetti giuridici, come impossessamento di bene mobile di proprietà altrui.
11
CAPITOLO SECONDO
PROFILI PENALISTICI
1. I delitti venatorii.
Legislazione c.p. 624; 625; 626; 628 – l. 11.2.1992, n. 157 4; 5, 30; 31 – l. 22.11.1993 n. 473.
Come diffusamente argomentato in precedenza, fino alla promulgazione della l. 11.2.1992, n.
157 la Suprema Corte era costantemente orientata nel ritenere che lo Stato, ai sensi della l. caccia,
oltre che titolare del diritto di proprietà, fosse anche possessore e detentore dei singoli animali
costituenti parte della fauna selvatica, di guisa che commetteva il delitto di furto colui che, al di
fuori delle ipotesi previste di legittima apprensione di animali, si impossessava – per lo più
esercitando attività venatoria – di animali costituenti parte della fauna selvatica (Cass. 12089/82,
Cass. 1788/83, Cass. 4189/84, Cass. 11523/85, Cass. 1732/86, Cass. 2074/88, Cass. 9526/90; ma
v. contra Cass. 1849/89).
L’interpretazione giuridica fino ad allora privilegiata cessò a séguito della promulgazione
degli artt. 30 co. 3 e 31 co. 5 della l. 11.2.1992, n. 157, laddove si prevede che in caso di
abbattimento, cattura e detenzione di esemplari appartenenti alla fauna selvatica “non si applicano
gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale”. Il Legislatore ha pertanto ritenuto, in esercizio della
propria insindacabile discrezionalità di scelta politica, di limitare la sanzione penale per la condotta
di impossessamento illecito di esemplari faunistici alle previsioni dell’art. 30 della l. 11.2.1992, n.
157, escludendo ex lege la configurabilità del delitto di furto in relazione a simili comportamenti.
L’abrogazione del delitto di furto venatorio non esclude la configurabilità di altre condotte
criminose – di cui ricorrano i presupposti – anche di maggiore gravità, commesse nell’esercizio
dell’attività venatoria.
Un esempio è fornito dalla rapina venatoria – propria o impropria – che si configura allorché
l’impossessamento dell’animale sia stato posto in essere mediante violenza o minaccia, prima o
dopo l’abbattimento.
In tema di caccia, l'esclusione, prevista in base ad insindacabili scelte di politica legislativa dall'art.
30, comma terzo, legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norma per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'applicabilita' delle norme
relative
al
furto
a
condotte (soggettivamente ed oggettivamente), tali da comportare, prima dell'entrata in vigore della
citata legge, l'applicazione di dette norme, non esercita effetto alcuno su diverse norme penali, con
speciale riferimento all'art. 628 cod. pen., non potendo dubitarsi dell'intenzione del legislatore di
escludere l'inapplicabilita' delle norme penali configuranti ipotesi di particolare gravita', quali ,
appunto, la rapina. Tale ipotesi appare configurabile non soltanto allorche' la minaccia e o la violenza
siano esercitate subito dopo la cattura (sottrazione) del capo protetto, bensi' anche (rapina propria)
allorche' siano esercitate per catturare il capo protetto.
12
(Cass. 23.5.1992, n. 6231, MCP, riv. 190412).
Non vi è dubbio sul fatto che il cacciatore che usasse violenza nei confronti del privato o del
pubblico ufficiale per impossessarsi dell’esemplare di fauna selvatica abbattuto o catturato,
commetterebbe rapina (propria o impropria a seconda delle peculiarità del fatto).
Non è invece, naturalmente, configurabile come rapina la violenza tipica del cacciatore che si
avvale delle armi per l’esercizio dell’attività venatoria. Tale condotta, in effetti, costituisce
esercizio – per quanto illegittimo – dell’attività venatoria, che deve ritenersi sanzionato dalle
norme speciali poste dall’art. 30 l. 11.2.1992, n. 157.
Il riconoscimento ai cacciatori della facoltà di utilizzare richiami vivi dal combinato disposto
degli artt. 4 e 5 l. 11.2.1992, n. 157 ha trovato uno specifico limite estrinseco, una vera e propria
norma di chiusura, nell’emanazione della l. 22.11.1993, n. 473, di modifica dell’art. 727 c.p.
(maltrattamento di animali).
Il novellato art. 727 c.p. prevede la punizione – con la pena dell’ammenda – di chiunque, fra
l’altro, sottoponga animali a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro
caratteristiche. In tale ottica, è evidente che colui che eserciti l’attività venatoria mediante richiami
vivi, anche se adeguatamente autorizzato, non può sottoporre i richiami a comportamenti e fatiche
per loro insopportabili, dal momento che, così facendo, incorre nella violazione del precetto penale
ed è soggetto alla irrogazione della conseguente pena pecuniaria.
Circa il rapporto di reciproca limitazione tra la facoltà di esercitare l’attività venatoria a
mezzo di richiami vivi ed il limite posto dalla norma penale circa le modalità di trattamento degli
animali che fungono da richiamo, la Suprema Corte ha adottato un orientamento costante.
In tema di maltrattamento di animali (art. 727 cod. pen.), l'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
(norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) prevede
espressamente l'esercizio venatorio con l'uso di richiami vivi, sempre che questo non costituisca
ipotesi di crudelta', eccessiva fatica o ingiustificata tortura. Dopo l'entrata in vigore della legge 22
novembre 1993, n. 473, che ha modificato l'art. 727 cod. pen., l'uso di richiami vivi e' vietato
anche quando e' incompatibile con la natura dell'animale, a prescindere dalla specifica sofferenza
causata. Pertanto, l'uso di gabbie per i richiami, ampiamente permesso nel vigore della pregressa
disciplina, e' ora consentito solo nelle ipotesi residuali, da valutare in concreto, di compatibilita' con
la natura dell'animale. (Fattispecie nella quale e' stato ritenuto integrata la contravvenzione ex art. 727
cod. pen., poiche' dieci volatili, quali richiami per la caccia, erano stati tenuti in minuscole gabbie,
incompatibili con la loro natura).
(Cass. 16.6.1995, n. 6903, MCP, riv. 201789).
Il richiamo vivo può essere legittimamente utilizzato, dunque, in quanto richiamo, purchè le
modalità di utilizzo non siano intollerabili per l’animale utilizzato.
Nei confronti degli animali e' consentita ogni attivita' che non rientri in uno dei divieti
specificamente dettati dalla legge 11 febbraio 1992,n.157 per la "Protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio"; quest'ultima, pero', da sola non esaurisce la tutela della fauna
stessa, poiche', a seguito della successiva entrata in vigore della legge 22 novembre 1993,n.473, di
modifica dell'art.727 cod.pen., la sfera di garanzia si e' notevolmente ampliata attraverso
l'introduzione dell'ulteriore divieto di tenere condotte che comunque possano determinare il
maltrattamento dell'animale utilizzato come richiamo o della stessa preda
catturata. Pertanto e'
13
configurabile il reato di cui all'art.727 citato quando nell'esercizio della caccia siano utilizzate
allodole imbracate e legate con una cordicella, alla quale venga impresso uno strattone, che le faccia
sollevare in volo e, poi, ricadere bruscamente perche' trattenute dal legaccio: tale comportamento
integra una sevizia, poiche' la sua ripetitivita' ossessiva viene ad incidere sull'istinto naturale
dell'animale stesso, dapprima dandogli la sensazione di poter assolvere alla primaria funzione del
volo ed immediatamente dopo costringendolo a ricadere dolorosamente.
(Cass. 20.5.1997, n. 4703, MCP, riv. 208042).
La compatibilità del sistema di utilizzo del richiamo vivo con la natura dell’animale
utilizzato non si limita pertanto al mero confronto tra il profilo della sussistenza dell’animale e le
modalità di utilizzo, ma si estende alle condizioni di vita dell’animale, che non deve essere esposto
a sofferenze fisiche di alcun genere.
La legge 11 febbraio 1992, n.157 (Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio) non esaurisce la tutela della fauna in quanto i limiti alle pratiche venatorie sono posti anche
dall'art.727 cod. pen., che modificato dalla legge 22 novembre 1993, n.473, ha ampliato notevolmente
la sfera di tutela degli animali attraverso il divieto di condotte atte a procurare a questi ultimi strazio,
sevizie o comunque detenzioni incompatibili con la loro natura. Ne consegue che le pratiche
venatorie consentite sulla base della legge n. 157 del 1992 devono essere verificate, nella loro
legittimita', anche alla luce dell'art. 727, come modificato dalla legge n. 473 del 1993.(Fattispecie in
cui la S.C. - in applicazione del principio di cui in massima - ha ritenuto sussistente il reato di cui
all'art. 727 cod. pen., nel caso in cui un uccello sia imbracato e trattenuto con un filo che gli
consenta di levarsi in volo e di ricadere in quanto strattonato dalla fune cui e' legato, pratica consentita
dalla legge n. 157 del 1992).
(Cass. 25.6.1999, n. 8890, MCP, riv. 214193).
2. Le contravvenzioni.
Legislazione c.p. 734 – l. 11.2.1992, n. 157 30 – l. 6.12.1991, n. 394 30.
La violazione delle norme poste a presidio delle modalità e dei limiti di esercizio dell’attività
venatoria è sanzionata penalmente soltanto in relazioni alle ipotesi maggiormente gravi, previste
dall’art. 30 l. 11.2.1992, n. 157, restando punite con sanzioni amministrative pecuniarie le altre
violazioni, previste dagli artt. 31 e 32.
Le condotte penalmente rilevanti sono punite con le pene dell’arresto e/o dell’ammenda, a
seconda della gravità, e vanno pertanto qualificate come contravvenzioni e non già come delitti.
Ne deriva, fra l’altro, che per la configurazione del reato non è necessaria la presenza del dolo in
capo all’agente, che il termine massimo di prescrizione, dal quale dipende l’estinzione del reato, è
di anni tre per le condotte sanzionate con la sola ammenda e di anni quattro e mesi sei per le
condotte sanzionate anche o solo con la pena dell’arresto.
E’ punito con l’arresto o con l’ammenda chiunque caccia in periodo di divieto generale;
chiunque abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli appartenenti a specie contemplate
dall’elenco previsto dall’art. 2 o esemplari di orso, stambecco, camoscio d’Abruzzo, muflone
sardo; chiunque esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve
naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini
14
urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive; chiunque esercita l’uccellagione; chiunque esercita la
caccia nei giorni di silenzio venatorio; chiunque esercita la caccia sparando da autoveicoli, natanti
od aeromobili; chiunque pone in commercio o detiene fauna selvatica in violazione della l.
11.2.1992, n. 157; chi esercita la tassidermia senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni
di legge.
E’ punito con la sola pena dell’ammenda chiunque abbatte, cattura o detiene esemplari
appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina della quale sia vietato l’abbattimento, o mammiferi o
uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque;
chiunque esercita la caccia con l’ausilio di richiami vietati.
Il potere attribuito alle Regioni dall’art. 182, 4, 5, 6 della l. 11.2.1992, n. 157 di predisporre il
calendario venatorio e modificare per specifiche esigenze di tutela della fauna locale i periodi di
tempo in cui è legittimo l’esercizio dell’attività venatoria posti dal primo comma della medesima
norma refluisce sull’applicazione del precetto penale, dal momento che sanzioni penali
conseguono alla violazione dei modi, limiti e divieti alla caccia posti dagli atti amministrativi
regionali.
Ne consegue che il procedimento amministrativo all’esito del quale viene emesso il
provvedimento amministrativo in merito di regolamentazione regionale della caccia non deve
essere affetto da illegittimità, pena la sua disapplicazione incidentale da parte del giudice penale.
In materia di caccia, l'omissione di un parere obbligatorio quale quello dell'Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica previsto dall'art. 18 della legge 11.2.1992 n.157, rende invalido , siccome in
violazione delle regole del procedimento e violazione di legge, l'atto amministrativo con cui la
Regione modifica il calendario generale di caccia, che pertanto va disapplicato incidentalmente nel
procedimento penale. (Fattispecie in cui e' stata esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. 30
lett. a) della legge 11.2.1992 n.157 atteso che, dovendosi ritenere in vigore il calendario venatorio
generale, la caccia nel giorno considerato era legittima).
(Cass. 10.2.1999, n. 1665, MCP, riv. 212601).
Ai sensi dell’art. 30 l. 6.12.1991, n. 394 è punito con la pena dell’arresto o dell’ammenda
chiunque viola il regolamento del parco naturale ed in particolare chiunque cattura, uccide,
danneggia o disturba le specie animali; qualsiasi privato che introduca armi, esplosivi e qualsiasi
altro mezzo distruttivo o di cattura senza esservi autorizzato.
Per l’individuazione di tutti i concetti normativi sui quali si fonda la configurazione della
condotta penalmente rilevante, quali il concetto di fauna selvatica, di mezzi per la caccia, di
uccellagione, deve tenersi conto di quanto osservato in precedenza.
Per quanto attiene alla questione giuridica circa la sopravvivenza del divieto di introduzione
di armi nei parchi naturali si rinvia a quanto diffusamente argomentato in precedenza, anche in
relazione alle categorie soggettive attributarie della qualità di pubblico ufficiale o comunque
autorizzate a portare armi.
15
Un esempio peculiare di applicazione del divieto di introduzione armi è fornito da un caso
sottoposto all’esame della Corte di Cassazione.
Destinatari del divieto, penalmente sanzionato, di introduzione di armi in area protetta sono tutti i
privati, termine con il quale si e'
rappresentanti
della
inteso
non
assoggettare
al divieto esclusivamente i
forza pubblica. (Fattispecie concernente l'introduzione di una carabina nel
Parco Nazionale del Gran Sasso ad opera di guardia particolare giurata, nominata per la vigilanza
volontaria venatoria nell'ambito della provincia dell'Aquila, in relazione
precisato che la vigilanza circoscritta
l'ordine
delle
all'attivita'
venatoria
da
alla quale la S.C. ha
un lato lascia impregiudicato
attribuzioni istituzionali di sorveglianza all'interno dell'area protetta, e quindi
l'esclusiva attribuzione di essa al corpo forestale dello Stato e, dall'altro, non costituisce titolo per
accedere con le armi in tale area).
(Cass. 22.5.2000, n. 5977, MCP, riv. 216012).
La guardia particolare giurata nominata per la vigilanza venatoria è tuttavia qualificabile
come pubblico ufficiale.
Le guardie venatorie, pur non essendo agenti di polizia giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni
ricoprono la veste di pubblici ufficiali poiche' esercitano poteri autoritativi e certificativi nell'ambito
dell'attivita' di protezione della fauna selvatica che, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato,
attiene ad un interesse pubblico della comunita' nazionale. E' illegittimo percio' ed integra gli estremi
contravvenzionali di cui all'art. 651 cod. pen il rifiuto delle proprie generalita' quando queste siano
richieste da una guardia venatoria nell'esercizio dei compiti di vigilanza che le sono propri.
(Cass. 23.5.1997, n. 4898, MCP, riv. 207896).
Ne consegue che il divieto di introdurre armi non si riferisce soltanto ai privati, ma anche ai
pubblici ufficiali che non siano specificamente autorizzati – per la loro qualità (si pensi ai
rappresentanti della forza pubblica) o per speciali e contingenti autorizzazioni nei casi e nei modi
previsti dalla legge – a portare armi all’interno dei parchi nazionali.
L’art. 30 l. 6.12.1991, n. 394 fa poi espressamente salva l’ipotesi di violazione degli artt. 733
e 734 c.p. Il primo sanziona penalmente con l’arresto o l’ammenda chiunque distrugge, deteriora o
danneggia un monumento se dal fatto deriva danno al patrimonio artistico nazionale. Il secondo
sanziona penalmente con l’ammenda la condotta di chiunque, mediante costruzioni, demolizioni o
in qualsiasi altro modo distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale
protezione dell’autorità.
Il primo corollario di tale richiamo è l’interpretazione autentica legislativa circa la
sussistenza di un concorso formale di norme incriminatrici penali tra l’art. 30 l. 6.12.1991, n. 394 e
gli artt. 733 e 734 c.p. Il legislatore ha inteso precisare che colui che ponga in essere le violazioni
punite dall’art. 30 risponde delle sanzioni ivi previste, ma qualora con tali condotte, od anche con
condotte ulteriori di per sé sole non sanzionate dall’art. 30, ponga in essere effettiva distruzione o
alterazione delle bellezze naturali, risponde anche del reato previsto e punito dall’art. 734 c.p., da
16
qualificarsi come reato formalmente concorrente ai sensi dell’art. 811 c.p. con l’art. 30 l.
6.12.1991, n. 394.
La rilevanza di tale questione in relazione alla tutela penale della fauna selvatica è resa
evidente dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
In tema di distruzione o deturpamento di bellezze naturali, l'art. 734 cod. pen. adotta la tecnica del
rinvio formale non ricettizio ad altra fonte, che fornisce le regole di qualificazione della distruzione
o deturpamento di quella specie di beni culturali costituito dai beni ambientali. Per definire il
concetto di bellezza naturale non puo' farsi esclusivo riferimento alla legge 29 giugno 1939 n. 1497
che tutela i beni paesistici quale fonte di godimento estetico, ma - alla luce dei principi costituzionali
(art. 9 Cost.) - va considerato il bene ambientale unitariamente considerato. Ne deriva che la tutela
fornita dall'art. 734 cod. pen. ha per oggetto le menomazioni permanenti o le distruzioni dell'ambiente,
in tutte le sue componenti essenziali, ivi compresa la fauna e la flora.
(Cass. 6.4.1991, n. 3892, MCP, riv. 187520).
Ben può ritenersi pertanto che la tutela penale della fauna selvatica proceda anche attraverso
la tutela – sia ordinaria, posta dal c.p., sia speciale, posta dalla l. 6.12.1991, n. 394 – penale
dell’ambiente, del quale la fauna è considerata dal legislatore parte integrante ed essenziale.
3. La tutela penale commerciale.
Legislazione l. 7.2.1992 n. 150 – l. 11.2.1992 n. 157 2; 5; 21; 30 – d.l. 12.1.1993 n. 2 conv. in l. 13.3.1993 n. 59 –
convenzione di Washington 3.3.1973 ratificata con l. 19.12.1975 n. 874 – reg. CEE del Consiglio 3.12.1982 n. 3626.
Per l’individuazione del contenuto dei divieti e dei concetti normativi in materia di
commercio di fauna selvatica si rinvia a quanto in precedenza argomentato.
Chiunque violi i divieti posti dagli artt. 1 e 2 l. 7.2.1992, n. 150 in materia di esemplari è
punito con la pena dell’arresto o dell’ammenda.
Chiunque violi i divieti posti dagli artt. 1 e 2 l. 7.2.1992, n. 150 in materia di oggetti è punito
con sanzione amministrativa pecuniaria.
Chiunque viola i divieti posti dall’art. 21 l. 11.2.1992, n. 157 in materia di commercio,
vendita e detenzione per la vendita, imbalsamazione e tassidermia è punito con la pena dell’arresto
o dell’ammenda ai sensi dell’art. 301
lett. l)
della l. 11.2.1992 n. 157, norma già commentata in
precedenza.
Anche la violazione del divieto vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per
l’attività venatoria è sanzionata ai sensi dell’art. 301
lett. l)
della l. 11.2.1992 n. 157, dovendosi
ricomprendere la fattispecie nel concetto di vendita proibita di fauna selvatica.
4. Error, ignorantia, onus probandi.
17
Legislazione c.p. 5, 47.
La particolare varietà di specie animali oggetto dell’esercizio dell’attività venatoria e
l’articolata normativa di tutela della fauna selvatica richiede di verificare l’astratta applicabilità
alle condotte penalmente rilevanti previste dalla normativa medesima dei profili di non punibilità
disciplinati dall’art. 47 c.p. o dell’ignoranza inevitabile della legge.
La Suprema Corte ha escluso in fatto l’applicabilità dell’errore sul fatto sottolineando la
necessità, per chi esercita l’attività venatoria, di apposita preparazione tecnica pregressa al rilascio
della necessaria licenza.
I ghiri sono fauna selvatica e specie protetta ed e' prevista una sanzione penale per la caccia agli
stessi. (Nella specie la S.C., nel rigettare il ricorso nel quale si sosteneva che il ghiro non sarebbe
selvaggina o fauna selvatica e apparterrebbe alla stessa famiglia dei topi e dei ratti, animali ai quali
non si applica la tutela normativa, ha ritenuto insufficiente l'errore sul fatto che costituisce reato o
l'ignoranza inevitabile della legge penale, essendo l'esercizio venatorio soggetto ad abilitazione
conseguibile addirittura con esame su materie tra cui la legislazione venatoria e la zoologia applicata
alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili).
(Cass. 17.10.1995, n. 10352, MCP, riv. 203157).
Altra peculiarità della tutela penale della fauna selvatica è costituita dall’inversione
dell’onere della prova nei confronti di colui che, còlto nell’atto di detenere fauna selvatica, dichiari
che essa proviene da allevamento regolarmente autorizzato.
E' possibile, per il detentore di un esemplare di fauna selvatica, dimostrarne la provenienza non
illegittima, con conseguente esclusione
di sua responsabilita' penale; l' "onus probandi"
incombe, pero', su di lui e non sull'accusa, posto che la regola generale stabilita dall'art.21, comma 1
lett. e) Legge 11 febbraio 1992, n.157 e' quella del divieto di detenzione di esemplari di fauna
selvatica. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, il Pretore, pur condividendo l'orientamento
innanzi indicato e propugnato
dalla difesa, aveva ritenuto - sulla base delle acquisizioni
processuali
- non raggiunta la prova, gravante sull'imputato, che gli esemplari di uccelli
particolarmente protetti (un'aquila reale e due falchi pellegrini) da lui detenuti fossero nati ed allevati in
cattivita').
(Cass. 2.10.1997, n. 8877, MCP, riv. 209368).
18
CAPITOLO TERZO
ASPETTI CIVILI
1. La responsabilità civile in generale.
Legislazione c.c. 2043 – l. 11.2.1992, n. 157.
La violazione delle norme poste a tutela della fauna selvatica è suscettibile di cagionare danni
e dunque di assumere la qualità di fonte di responsabilità civile.
Del pari, la gestione amministrativa degli strumenti di tutela della fauna selvatica può
determinare il verificarsi di danni risarcibili.
Lo studio sistematico dell’articolato atteggiarsi della responsabilità civile connessa alla
normativa posta a tutela della fauna selvatica impone la suddivisione dei temi d’indagine
ermeneutica in due categorie.
La prima categoria può definirsi come la materia della responsabilità civile per danni cagionati
alla fauna selvatica.
La seconda categoria attiene alla responsabilità civile per danni cagionati dalla fauna
selvatica.
2. Danno alla fauna.
Legislazione c.c. 2043 – l. 11.2.1992, n. 157 2.
Ogni condotta posta in violazione della normativa di tutela della fauna selvatica è
astrattamente idonea a cagionare un danno alla fauna stessa.
Va premesso che la violazione della normativa, di per sé stessa, non è sufficiente a ritenere
che un danno sia stato cagionato. Si ponga mente all’ipotesi in cui un cacciatore eserciti l’attività
venatoria nei luoghi e nei periodi in cui essa è vietata ma non riesca a centrare alcun bersaglio o
addirittura non riesca nemmeno a sparare o a installare le trappole, perché tempestivamente fermato
dagli addetti alla vigilanza venatoria. In tal caso, è di tutta evidenza che violazione della normativa
di tutela della fauna selvatica vi è stata, ma la fauna non ha subìto alcun danno.
Il concetto di danno alla fauna selvatica va pertanto limitato alle ipotesi in cui una condotta
umana, posta in essere in violazione della normativa vincolistica, abbia effettivamente arrecato un
danno alla fauna.
19
Il contenuto giuridico del concetto di danno alla fauna va determinato avendo riguardo alla
definizione di fauna selvatica oggetto di tutela contenuta nell’art. della l. 11.2.1992, n. 157, che
qualifica come tali le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi
stabilmente o temporaneamente in istato di naturale libertà nel territorio nazionale, nonché alcune
specie di animali pedissequamente elencate ed ogni specie sottoposta a tutela, anche
successivamente, da direttive comunitarie, convenzioni internazionali o decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Sono esclusi dalla tutela le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole
(cfr. capitolo primo, secondo paragrafo).
Prima questione esegetica che si pone all’interprete è se il danno alla fauna selvatica debba
ritenersi verificato solo allorchè la condotta vietata abbia posto in serio pericolo l’esistenza di una o
più specie animali oppure anche qualora sia stato ferito, ucciso o catturato un singolo animale o un
gruppo di animali insuscettibile di determinare pericolo di estinzione per la specie o le specie di
appartenenza.
La lettura della disciplina posta dalla l. 11.2.1992, n. 157 appare deporre senz’altro per la
seconda ipotesi.
La normativa, come in precedenza diffusamente argomentato, istituisce sì una speciale
protezione per le specie animali a rischio di estinzione, ma in nessuna disposizione appare limitare
la tutela della fauna selvatica non a rischio di estinzione al divieto di porre in essere comportamenti
astrattamente idonei a porre in pericolo la sopravvivenza della specie animale. La disciplina
vincolistica, al contrario, tutela la fauna selvatica in via generale, vietando ogni condotta non
rispettosa delle norme di tutela – anche penalmente sanzionate – anche con riferimento alla mera
cattura di un singolo esemplare.
Se dunque il legislatore – pur istituendo una speciale tutela, ancor più penetrante, per le specie
animali a rischio di estinzione – non ha inteso statuire soglie minime di punibilità dei
comportamenti umani tenuti in violazione delle norme di tutela della fauna selvatica, deve ritenersi
che la ratio legis sia improntata a proteggere il complesso della fauna selvatica nazionale mediante
la specifica protezione di ogni componente di essa da condotte vietate.
Non può dunque ritenersi che la cattura di un singolo animale o di un gruppo di animali, posta
in essere in violazione della normativa di tutela, sia consentita sol perché tale condotta non pone
concretamente in pericolo la sopravvivenza delle specie animali coinvolte, dal momento che lo
spirito della legge procede attraverso il concetto per cui la salvaguardia dell’insieme tutelato è
garantita dalla protezione di ogni singolo appartenente all’insieme stesso.
Può dunque concludersi che nell’ottica legislativa la fauna selvatica complessivamente intesa
va protetta attraverso la tutela di ciascun appartenente ad essa, sicchè il ferimento, la cattura,
20
l’uccisione, il maltrattamento anche di un singolo animale, in violazione della normativa di tutela,
cagiona danno alla fauna selvatica, indipendentemente dalla sussistenza o no di un pericolo per la
sopravvivenza delle specie faunistiche di appartenenza.
E’ necessario ora verificare se tale danno sia fonte di responsabilità civile, se sia cioè un
danno risarcibile.
2.1. Fauna selvatica e ambiente.
Legislazione Cost. 117 – c.c. 828 – l. 11.2.1992, n. 157 1; 2. – l. 8.7.1986, n. 349. – l. Cost. 18.10.2001, n. 3.
L’esegesi circa la risarcibilità del danno alla fauna selvatica presuppone l’individuazione delle
coordinate ordinamentali in cui il concetto giuridico legale di fauna selvatica si situa.
Come già diffusamente argomentato in precedenza, non vi è dubbio che la fauna selvatica
vada qualificata come bene patrimoniale indisponibile dello Stato, sicchè su tale scenario
ermeneutico deve senz’altro indagarsi per valutare se il danno alla fauna selvatica sia fonte di
responsabilità civile.
Oltre tale consistenza giuridica strettamente e tradizionalmente civilistica, tuttavia, la fauna
selvatica assume rilievo anche sotto il profilo del concetto integrato di ambiente in senso giuridico.
Il concetto giuridico di ambiente fu elevato per la prima volta a rango legislativo dalla l.
8.7.1986, n. 349 – istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale –
come complesso di condizioni ambientali conformi agli interessi della collettività ed ala qualità
della vita, e la tutela di esso fu affidata al neoistituito Ministero dell’ambiente unitamente alla
conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e alla difesa delle risorse naturali
dall’inquinamento (art. 1).
La portata innovativa della legge era notevole, dal momento che fino ad allora il concetto di
ambiente era veicolato esclusivamente da interpretazioni giurisprudenziali, che operavano una
interpretazione evolutiva e sistematica del più generico concetto di paesaggio la cui tutela è posta
dall’art. 92 Cost. come compito della Repubblica, anche in relazione al diritto alla salute garantito
dall’art. 32 Cost., latamente inteso.
L’elaborazione giurisprudenziale del concetto giuridico dell’ambiente condusse rapidamente
ad un concetto integrato dell’ambiente in senso giuridico.
L'ambiente in senso giuridico costituisce un insieme che, pur comprendente vari beni o valori quali la flora, la fauna, il suolo, le acque ecc. - si distingue ontologicamente da questi e si identifica in
una realta', priva di consistenza materiale, ma espressiva di un autonomo valore collettivo
costituente, come tale, specifico oggetto di tutela da parte dell'ordinamento, con la legge 8 luglio 1986
n. 349, rispetto ad illeciti, la cui idoneita' lesiva va valutata con specifico riguardo a siffatto
valore ed indipendentemente dalla particolare incidenza verificatasi su una o piu' delle dette singole
21
componenti, secondo un concetto di pregiudizio che, sebbene riconducibile a quello di danno
patrimoniale, si caratterizza, tuttavia per una piu' ampia accezione, dovendosi avere riguardo per la sua identificazione - non tanto alla mera differenza tra il saldo attivo del danneggiato (nella
specie, il Parco Nazionale d'Abruzzo, che lamentava il taglio abusivo di piante) prima e dopo l'evento
lesivo, quanto alla sua idoneita', alla stregua di una valutazione sociale tipica, a determinare in
concreto una diminuzione dei valori e delle utilita' economiche di cui il danneggiato puo' disporre,
svincolata da una concezione aritmetico-contabile.
(Cass. 9.4.1992, n. 4362, MCP, riv. 476707).
L’ambiente in senso giuridico trascende pertanto una mera sommatoria matematica degli
aspetti che lo compongono, costituendo un insieme al tempo stesso inscindibile ed autonomo.
Per “ambiente” deve intendersi il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative
dell’uomo protette dall’ordinamento perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno
sviluppo della persona. L’ambiente è una nozione, oltrechè unitaria, anche generale, comprensiva delle
risorse naturali e culturali, veicolata nell’ordinamento italiano dal diritto comunitario.
(Cass. 28.10.1993, n. 9727, MCP, riv. 196168).
L’ambiente è stato dunque definito dalla giurisprudenza della Suprema Corte come una entità
autonoma, costituita dal complesso sinergico di una molteplicità di elementi – fauna, flora, suolo,
acque, opere dell’uomo ed altro – strumentale e funzionale alla realizzazione del pieno sviluppo
della persona umana.
Con la l. Cost. 18.10.2001, n. 3, modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione,
il concetto di ambiente è stato elevato al rango costituzionale, ed ora l’art. 117 Cost. prevede, alla
lettera s) del secondo comma, tra le materie ove lo Stato ha legislazione esclusiva, la tutela
dell’ambiente.
Il fatto che il legislatore costituzionale abbia attribuito alla tutela ambientale rango
costituzionale senza meglio precisare il contenuto del concetto giuridico di ambiente lascia ritenere
che debba farsi riferimento, per l’individuazione dello stesso, al concetto integrato di ambiente in
senso giuridico elaborato dalla giurisprudenza della Suprema Corte sopra richiamata.
Primo corollario di tale conclusione si è che la fauna selvatica – e tralaticiamente la tutela di
essa – dovrebbe costituire uno degli elementi che compongono il complesso sinergico che
definisce l’insieme concettuale dell’ambiente in senso giuridico.
Ed allora è necessario comprendere la portata di tale nuovo assetto costituzionale anche con
riferimento ai rapporti tra la potestà legislativa esclusiva regionale in materia di disciplina
della caccia e la nuova potestà legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.
In proposito la Corte Costituzionale si è recentemente espressa.
L’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione esprime una esigenza unitaria per ciò che
concerne la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale
che possano pregiudicare gli equilibri ambientali. Come già affermato da questa Corte, la tutela
dell’ambiente non può ritenersi propriamente una “materia”, essendo invece l’ambiente da considerarsi
come un “valore” costituzionalmente protetto che non esclude la titolarità in capo alle Regioni di
22
competenze legislative su materie (governo del territorio, tutela della salute, ecc.) per le quali quel valore
costituzionale assume rilievo (sentenza n. 407 del 2002). E, in funzione di quel valore, lo Stato può
dettare standards di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze
legislative regionali ex art. 117 della Costituzione.
Già prima della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, la protezione dell’ambiente
aveva assunto una propria autonoma consistenza che, in ragione degli specifici ed unitari obiettivi
perseguiti, non si esauriva né rimaneva assorbita nelle competenze di settore (sentenza n. 356 del 1994),
configurandosi l’ambiente come bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori
e che va pertanto salvaguardato nella sua interezza (sentenza n. 67 del 1992). La natura di valore
trasversale, idoneo ad incidere anche su materie di competenza di altri enti nella forma degli standards
minimi di tutela, già ricavabile dagli artt. 9 e 32 della Costituzione, trova ora conferma nella previsione
contenuta nella lettera s) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione, che affida allo Stato il
compito di garantire la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. (…)
In questo quadro, la disciplina statale rivolta alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema può incidere sulla
materia caccia, pur riservata alla potestà legislativa regionale, ove l’intervento statale sia rivolto a
garantire standards minimi e uniformi di tutela della fauna, trattandosi di limiti unificanti che rispondono
a esigenze riconducibili ad àmbiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato. (…)
Con specifico riferimento alla questione sottoposta all’esame di questa Corte, occorre precisare che la
delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall’art. 18 della legge n. 157 del 1992 è rivolta
ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili e risponde all’esigenza di tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema per il cui soddisfacimento l’art. 117, secondo comma, lettera s) ritiene
necessario l’intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale. Come già affermato da questa
Corte nella sentenza n. 323 del 1998, vi è un “nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, nel
quale deve includersi – accanto all’elencazione delle specie cacciabili – la disciplina delle modalità di
caccia, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione
delle specie cacciabili. Al novero di tali misure va ascritta la disciplina che, anche in funzione di
adeguamento agli obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio”. (…)
La disciplina statale che prevede come termine per l’attività venatoria il 31 gennaio si inserisce, dunque,
in un contesto normativo comunitario e internazionale rivolto alla tutela della fauna migratoria che si
propone di garantire ilsistema ecologico nel suo complesso. La suddetta disciplina risponde senz’altro a
quelle esigenze di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema demandate allo Stato e si propone come
standard di tutela uniforme che deve essere rispettato nell’intero territorio nazionale, ivi compreso quello
delle Regioni a statuto speciale. (…)
(Corte Cost. 20.12.2002, n. 536).
La Corte Costituzionale – che con la sentenza la cui motivazione è stata testé citata ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale della Sardegna 7.2.2002, n. 5
(modifica dell’art. 49 della legge regionale 29.7.1988, n. 23, “norme per la protezione della fauna
selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”, concernente il periodo di caccia) che
prevedeva l’estensione del periodo venatorio oltre il 31 gennaio previsto dall’art. 18 l. 11.2.1992,
n. 157 – ha pertanto ribadito alcuni concetti fondamentali.
L’ambiente è un valore costituzionalmente protetto, inerente alla tutela dell’ecosistema ma da
esso distinto. La tutela dell’ecosistema e più in generale del valore costituzionale costituito
dall’ambiente procede anche attraverso la tutela della fauna selvatica e si riferisce anche ad
interventi minimi, che nonostante tale loro caratteristica sono comunque idonei, per la speciale
delicatezza del bene giuridico protetto, a compromettere l’integrità dell’ecosistema e dell’ambiente
nel suo complesso.
In tale ottica, deve dunque percorrersi ermeneuticamente anche la verificazione della
configurabilità di un danno alla fauna selvatica che si traduca in un danno all’ambiente.
23
Due sono, dunque, gli àmbiti esegetici di ricerca.
Il primo dei due percorsi d’indagine esegetica muove nell’àmbito della valutazione della
risarcibilità del danno arrecato alla fauna selvatica in sé stessa, quale bene patrimoniale
indisponibile dello Stato.
Deve accertarsi se il danno arrecato alla fauna selvatica – secondo il concetto di danno alla
fauna sopra enucleato – da una condotta umana tenuta in violazione della normativa di tutela
obblighi il responsabile al risarcimento del danno.
Ai sensi dell’art. 8281 c.c. i beni patrimoniali indisponibili – categoria alla quale appartiene la
fauna selvatica – sono soggetti in generale alle disposizioni del codice civile per la parte in cui non
siano oggetto di specifiche disposizioni.
Ne consegue che gli artt. 2043 e seguenti c.c. sono senz’altro applicabili, in linea di principio,
anche in relazione ai beni patrimoniali indisponibili, e dunque alla fauna selvatica.
Tanto premesso, deve osservarsi come l’art. 2043 c.c. stabilisca che qualsiasi fatto doloso o
colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire
il danno.
Correlativamente, l’art. 2059 c.c. prevede che il danno non patrimoniale deve essere risarcito
solo nei casi determinati dalla legge.
Nel caso che occupa, non vi è dubbio che la fauna selvatica costituisce, per definizione di
legge, un bene patrimoniale di proprietà dello Stato, sicchè ogni danno ad essa arrecato in
violazione della normativa di tutela va qualificato come danno patrimoniale ingiusto, come tale
senz’altro idoneo, secondo i princìpi generali della responsabilità civile, a costituire per il
responsabile fonte di obbligazione per responsabilità aquiliana, e dunque fonte di obbligo al
risarcimento del danno.
La giurisprudenza di legittimità è allo stato attestata su posizioni analoghe.
Per il caso di abbattimento di animale selvatico nella regione trentino-Alto adige, senza il prescritto
permesso della competente sezione locale della federazione italiana della caccia, deve riconoscersi
a detta federazione la legittimazione ad agire, contro l'autore dell'infrazione, per il risarcimento
del danno, indipendentemente dall'appartenenza di detto animale allo stato, considerando che la
federazione medesima, in qualita' di concessionaria "ex lege" della gestione dei territori di quella
regione istituiti in riserva di caccia (legge regionale 7 settembre 1964 n. 30), e' titolare dei poteri e delle
facolta' del concedente, e quindi e' abilitata ad agire per il ristoro del pregiudizio subito dal concedente
medesimo, e che, inoltre, in relazione ai suoi specifici compiti di tutela ed incremento del
patrimonio faunistico (d.P.G.R. 13 agosto 1965 n. 129, e successive modificazioni), puo' ricevere
anche in proprio un danno patrimoniale, per effetto dell'indicata infrazione.
(Cass. 28.10.1988, n. 5856, MCP, riv. 460364).
Il concessionario è a questi fini equiparato, secondo l’esegesi proposta, al concedente.
Ove la federazione italiana della caccia, quale concessionaria "ex lege" dei territori delle province di
trento e bolzano istituiti in riserve di diritto, proponga azione risarcitoria contro il responsabile
dell'illecito abbattimento di un selvatico, la sussistenza del danno, in misura almeno pari all'esborso
occorrente per sopperire a tale perdita (e da liquidarsi in concreto anche con l'ausilio dei parametri
indennitari fissati dalle apposite norme regionali), e' da ritenersi "in re ipsa", in considerazione
24
dell'obbligo di detta concessionaria di ripristinare la consistenza del patrimonio faunistico gestito,
anche a fronte di impoverimenti provocati da fatti illeciti, nonche' della presuntiva osservanza dei suoi
doveri (fino a prova contraria) da parte di un ente operante come "longa manus" dell'amministrazione.
(Cass. 16.5.1990, n. 4269, MCP, riv. 467222).
2.2. Legittimazione attiva e criteri di quantificazione del danno.
Legislazione c.c. 1123; 1126; 1127; 2043; 2056; 2058 – l. 11.2.1992, n. 157 7.
La giurisprudenza da ultimo citata evidenzia come la legittimazione attiva per l’azione di
risarcimento del danno alla fauna selvatica in sé considerata appartenga, ordinariamente, senz’altro
allo Stato in quanto proprietario del bene danneggiato, ma vada riconosciuta anche alle sezioni
locali della federazione italiana della caccia, quale quella di trento e bolzano, che siano
concessionarie dei territori di caccia.
Nessun altro soggetto è titolare di legittimazione attiva a proporre l’azione di risarcimento del
danno alla fauna selvatica in sé considerata.
Diversa è la questione attinente alla quantificazione del danno.
Un primo criterio di quantificazione è, naturalmente, il riferimento a parametri legislativi, ove
sussistenti.
Laddove una legge regionale stabilisca l’entità del risarcimento del danno dovuto nel caso in
cui uno o più esemplari di fauna selvatica vengano abbattuti, nulla quaestio, essendo evidentemente
applicabile il criterio legale.
Nel caso in cui non sussista un criterio legale, deve ricorrersi al criterio posto dall’art. 2056
c.c., e dunque al combinato disposto degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.
Nel caso di danno cagionato alla fauna selvatica, è evidentemente applicabile esclusivamente
il criterio posto dall’art. 1226 c.c., sicchè l’entità del danno va liquidata equitativamente.
Nel caso in cui la Federazione Italiana della Caccia, quale concessionaria "ex lege" dei territori
delle province di Trento e Bolzano istituiti in riserva di diritto, proponga azione risarcitoria
contro il responsabile dell'illecito abbattimento di un selvatico, la sussistenza del danno, in misura
almeno pari all'esborso occorrente per sopperire alla perdita derivante dall'illecito, e' da ritenersi
in "re ipsa", in considerazione dell'obbligo di detta concessionaria di ripristinare la consistenza del
patrimonio faunistico gestito; tale danno va liquidato a prescindere dalla prova di specifici
pagamenti per il reinserimento nella riserva di animale dello stesso tipo e la liquidazione va effettuata
anche in via equitativa a norma dell'art. 1226 cod. civ. potendo il giudice di merito utilizzare a tal fine,
come parametro di riferimento anche l'entita' degli indennizzi fissati dall'art. 7 del Decreto Presidente
Giunta Regionale 13 agosto 1965 n. 129 (aggiornati con D.P.G.R. 3 dicembre 1979).
(Cass. 26.5.1992, n. 6289, MCP, riv. 47382).
Nella liquidazione equitativa, la giurisprudenza sottolinea come vada tenuta presente la
circostanza per cui la federazione italiana della caccia è tenuta a reintegrare la consistenza del
25
patrimonio faunistico, sicchè la quantificazione deve tenere conto delle spese necessarie per la
reintegrazione medesima.
Tale orientamento è senz’altro suscettibile di applicazione ben più vasta.
Come dianzi argomentato, ai sensi dell’art. 7 l. 11.2.1992, n. 157 lo Stato ha il compito di
vigilare sull’operato dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, che a sua volta ha la funzione di
gestire la sopravvivenza e la conservazione della fauna selvatica.
Ne consegue che, anche al di fuori di specifici rapporti concessori tra lo Stato e alcune sezioni
della federazione nazionale della caccia, lo Stato ha il compito – mediante la vigilanza sull’operato
dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica – di garantire la conservazione e la sopravvivenza della
fauna, di guisa che deve ritenersi che il danno arrecato alla fauna selvatica vada quantificato
tenendo conto della necessità di fare fronte a tutti gli esborsi necessari per la conservazione e la
sopravvivenza faunistica in parola.
Una simile impostazione rende evidente che la quantificazione del danno può variare
sensibilmente non soltanto in relazione alla quantità degli animali feriti, catturati o abbattuti, ma
anche e soprattutto in relazione alla specie di essi, al luogo ed al periodo dell’anno in cui l’attività
illecita viene posta in essere.
La circostanza per cui al risarcimento dei danni in parola presiedono i generali princìpi posti
dagli artt. 2043 e seguenti c.c. consente di ritenere che il danneggiato – lo Stato o il concessionario
– possa anche agire richiedendo il risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 2058 c.c.
Tale forma di risarcimento, come è noto, può venire accordata esclusivamente se
naturalisticamente possibile, e salvo il potere del giudice di denegarla qualora risulti eccessivamente
onerosa per il debitore.
Il risarcimento in forma specifica si pone quale forma di recepimento, da parte del codice
civile italiano, della restitutio in integrum, tecnica riparatoria consistente nella integrale
obliterazione dalla realtà del danno e degli effetti di esso mediante l’integrale restituzione in pristino
dello status quo antecedente alla determinazione del danno.
Ne consegue che qualora l’esemplare di fauna selvatica sia stato non già ucciso ma solo
catturato e/o ferito, il danneggiato può richiedere la restituzione dell’esemplare medesimo e/o la
corresponsione di tutte le spese necessarie per provvedere alle cure necessarie ed al successivo
reinserimento nell’ecosistema.
In tale ipotesi, per verificare che il risarcimento in forma specifica non sia eccessivamente
oneroso per il debitore rispetto al risarcimento per equivalente, il giudice dovrà fare riferimento alla
quantificazione del danno astrattamente calcolabile per consentire al danneggiato di provvedere per
26
altra via – diversa dalla cura dell’animale ferito – alla reintegrazione del patrimonio faunistico
violato dall’evento illecito dannoso.
In proposito, è bene precisare che il potere del giudice di denegare il risarcimento in forma
specifica qualora questo si riveli eccessivamente oneroso per il debitore resta un potere e non già un
dovere.
La norma infatti non prevede che il giudice dispone né che deve disporre che il risarcimento
avvenga solo per equivalente in caso di eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica, ma
si limita a stabilire che il giudice può disporre in tal senso. Ne consegue che il giudice, laddove
ravvisi l’eccessiva onerosità, resta titolare del potere di accordare o denegare il risarcimento in
forma specifica, avuto riguardo alle circostanze concrete del fatto, alla gravità della condotta e del
danno arrecato, al comportamento anche processuale delle parti.
2.3. Il danno alla fauna selvatica quale danno all’ambiente.
Legislazione Cost. 117 – c.c. 2043 – l. 11.2.1992, n. 157 1; 2. – l. 8.7.1986, n. 349. – l. Cost. 18.10.2001, n. 3.
Come sopra argomentato, la fauna selvatica va qualificata come uno degli elementi
costitutivi dell’insieme che configura il concetto integrato di ambiente in senso giuridico,
valore costituzionalmente protetto.
L’ambiente, in tale accezione, costituisce una entità ontologicamente autonoma rispetto al
complesso degli elementi che ne compongono l’insieme. Ne consegue che l’ambiente in senso
giuridico non deve intendersi come una mera sommatoria di elementi, ma come una sinergia di
aspetti, dotato di propria autonomia in quanto complessivamente dotato di una sorta di valore
aggiunto rispetto all’insieme che lo compone e che in esso si fonde e si riduce ad unità.
La tutela della fauna selvatica, come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza del
20.12.2002 n. 536, si inscrive nella tutela dell’ecosistema, direttamente connessa alla tutela del
valore costituzionale della tutela dell’ambiente, nei cui confronti anche interventi di scarsa entità
intrinseca possono e devono ritenersi idonei a cagionare un significativo detrimento del bene
giuridico protetto.
Nell’àmbito di tali coordinate ordinamentali, è agevole sostenere dunque che il danno arrecato
alla fauna selvatica assuma rilievo – oltre che, come sopra argomentato, in ordine alla fauna di per
sé considerata – anche nell’ottica della causazione di un danno all’ambiente.
La nozione legale di danno ambientale, come è noto, è contenuta nell’art. 18 l. 8.7.1986, n.
349, a norma del quale “qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizione di legge o di
provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno,
27
alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al
risarcimento nei confronti dello Stato”.
Se dunque la fauna selvatica costituisce uno degli elementi costitutivi dell’ecosistema e del
complesso concetto di ambiente in senso giuridico, il danno alla fauna selvatica deve logicamente
ritenersi idoneo, in astratto, a refluire sull’ambiente, traducendosi di fatto in un danno cagionato
anche all’ambiente naturale costituzionalmente tutelato.
Una tale petizione di principio – che peraltro appare assolutamente coerente con il dettato
costituzionale come esplicitato dalla Corte Costituzionale e deriva dall’analisi comparata della
normativa vigente – va naturalmente sottoposta all’analisi esegetica onde saggiarne la reale portata
giuridica concreta.
Se infatti sotto il profilo logico-giuridico deve ritenersi corretta la configurabilità del danno
all’ambiente a sèguito del danno cagionato alla fauna selvatica, deve verificarsi quali siano i limiti
di una simile affermazione, ed in particolare a quali condizioni il danno alla fauna selvatica in
quanto tale possa ritenersi di per sé produttivo di danno anche per l’ambiente.
Altro, è agevole sostenere, è il danno alla fauna selvatica costituito dal genocidio di una intera
specie animale (si immagini la condotta di colui che abbatta tutti o quasi gli esemplari viventi di
muflone sardo), dal quale con ogni evidenza deriva una significativa alterazione dell’ecosistema –
dovuta all’obliterazione di una intera popolazione – e correlativamente un vulnus all’integrità
dell’ambiente giuridicamente inteso, ed altro è l’abbattimento di un singolo esemplare appartenente
di una specie non a rischio di estinzione eseguito con mezzi non consentiti o in periodi di silenzio
venatorio o al di fuori dei luoghi consentiti.
La macroscopica differenza tra le due condotte, e tra l’entità delle due diverse tipologie di
danno arrecato alla fauna selvatica, rende evidente la necessità di accertare quali siano le
condizioni, le soglie giuridiche varcate le quali il danno alla fauna estende i propri effetti al danno
all’ambiente.
Dal punto di vista giuridico-concettuale, il fatto che l’ambiente – come già argomentato –
costituisca un valore complessivo che racchiude in sé ma supera nell’insieme, acquisendo una
propria autonomia, gli elementi e gli aspetti che lo compongono, consente di sostenere, in punto di
logica, che dunque il danno ad un elemento costitutivo – come la fauna selvatica – non possa
ritenersi in sé e per sé autonomamente, necessariamente ed automaticamente coincidente con la
causazione di un danno all’ambiente nel suo complesso.
Nel momento in cui si assume che l’ambiente costituisca un valore complessivo che trascende
la mera sommatoria degli elementi che lo compongono, appare logicamente fondata l’asserzione per
28
cui il danno all’elemento costitutivo non implichi necessariamente il danno per il valore
complessivo.
2.3.1. Danno all’esemplare e danno alla fauna. Coincidenza.
Legislazione Cost. 117 – c.c. 2043 – l. 11.2.1992, n. 157 1; 2. – l. 8.7.1986, n. 349. – l. Cost. 18.10.2001, n. 3.
Aderendo ad una simile impostazione, dovrebbe ritenersi che il danno alla fauna selvatica
debba ritenersi produttivo anche di danno all’ambiente esclusivamente nei casi in cui esso sia di tale
entità da refluire effettivamente sull’ambiente nel suo complesso, determinandone in concreto una
variazione in negativo, una diminuzione, un deterioramento.
In tema di smaltimento di rifiuti, la tutela dell'interesse diffuso all'ambiente fa capo all'ente territoriale,
preposto al controllo ed alla gestione nel settore ecologico. L'azione di risarcimento del danno puo'
essere promossa soltanto quando sussista un pregiudizio concreto alla qualita' della vita della
collettivita', sotto il profilo dell'alterazione, del deterioramento o della distruzione, in tutto o in parte,
dell'ambiente. Non danno luogo a risarcimento – di regola
-
violazioni
meramente formali. La
stessa lesione dell'immagine dell'ente, il quale, dalla commissione di reati vede compromesso il
prestigio derivante dall'affidamento di compiti di controllo
o
gestione,
costituisce
danno non
risarcibile autonomamente. In tal caso il risarcimento deve essere riconosciuto soltanto quando sia
stato concretamente accertato il suddetto danno ambientale, al quale sia collegata, come aspetto non
patrimoniale, la menomazione del rilievo istituzionale dell'ente.
(Cass. 25.5.1992, n. 6297, MCP, riv. 190778)
La verificazione dell’effettiva produzione di un danno all’ambiente dovrebbe, per questa via,
essere rimessa all’accertamento giurisdizionale eseguito caso per caso, mediante l’osservazione
anche tecnica delle conseguenze sull’ambiente del danno arrecato alla fauna selvatica, dal momento
che non sussiste alcun canone legislativo o regolamentare al quale possa farsi riferimento come
parametro per l’individuazione della soglia oltre la quale il danno alla fauna implica danno
all’ambiente.
L’analisi della disciplina positiva, anche alla luce della motivazone della sentenza della Corte
Costituzionale n. 536 del 20.12.2002 che, in quanto tale, non può ritenersi alla stregua di una
intepretazione giurisprudenziale ma deve considerarsi alla pari di un dettato legislativo, può
condurre l’interprete a conclusioni differenti.
Si è osservato in precedenza, nel definire il concetto di danno alla fauna selvatica, che
l’abbattimento, il ferimento o la cattura illegali, anche di un solo esemplare, anche non appartenente
a specie in via di estinzione, di fauna selvatica costituisce danno alla fauna selvatica nel suo
29
complesso, dal momento che il legislatore ha voluto individuare regole minime di tutela della fauna
selvatica la cui violazione è sanzionata – anche penalmente – proprio perché ogni condotta tenuta in
violazione di tali regole costituisce di per sé, indipendentemente dalla gravità della violazione, un
comportamento di per sé idoneo a porre in pericolo la sopravvivenza della fauna selvatica.
Il concetto giuridico di condotta posta in violazione della normativa di tutela della fauna
selvatica coincide pertanto perfettamente con il concetto di danno arrecato alla fauna
selvatica nel suo complesso, indipendentemente dalla gravità della violazione, perché le regole
normative di cautela costituiscono la soglia minima di garanzia della sopravvivenza della fauna
medesima, sicchè ogni violazione è di per sé sola giuridicamente automaticamente idonea a porre in
pericolo la sopravvivenza medesima, cagionando un danno alla fauna selvatica nel suo complesso.
In tale ottica si muove anche la citata sentenza della Corte Costituzionale, laddove precisa che
la tutela dell’ambiente costituzionalmente attribuita allo Stato si traduce, con riferimento alla tutela
della fauna selvatica, nella predisposizione proprio di standards minimi di tutela, di guisa che deve
ritenersi che anche a giudizio della Corte Costituzionale ogni condotta tenuta in violazione di tali
soglie minime si traduce in un danno per la fauna selvatica nel suo complesso.
Deve pertanto ritenersi che non trovino diritto di cittadinanza giuridica nel nostro ordinamento
diversi tipi di danno alla fauna selvatica, ma sussistano esclusivamente danni di diversa natura –
suscettibili di dare luogo a responsabilità patrimoniale di varia entità secondo i criteri di
quantificazione sopra indicati – arrecati alla fauna selvatica, ma sempre alla fauna selvatica nel suo
complesso. Non può dunque configurarsi il danno all’esemplare come concetto giuridico distinto
dal danno alla fauna, dovendo ritenersi configurabile esclusivamente il danno alla fauna nel suo
complesso, che può consistere nel danno al singolo esemplare, all’intera popolazione, al gruppo di
esemplari, e ad ogni altro caso di violazione della normativa vincolistica.
Una simile conclusione rende necessario riconsiderare, alla luce dunque del dato normativo
positivo, l’asserzione sopra offerta circa la necessità di individuare, caso per caso, soglie concrete di
sconfinamento del danno alla fauna in danno all’ambiente.
Pur prendendo le mosse dal medesimo concetto integrato di ambiente in senso giuridico,
qualificando dunque l’ambiente come un complesso di aspetti autonomo rispetto ai propri elementi
costitutivi, deve riconoscersi che laddove si accolga la concezione unitaria del danno alla fauna
testé proposta come dato normativo positivo, viene posta in dubbio la configurabilità di una
distinzione tra il danno alla fauna ambientalmente irrilevante ed il danno alla fauna produttivo di
danno ambientale.
Se il concetto giuridico positivo, ricavato dalla normativa vigente, di danno alla fauna esclude
la configurabilità di un danno al singolo esemplare distino dal danno alla fauna, e riconosce
30
esclusivamente la sussistenza del danno alla fauna ogni qual volta sia violata la normativa di tutela,
appare complesso ricostruire giuridicamente la sussistenza di un danno alla fauna ambientalmente
irrilevante distinto da un danno alla fauna che produca danno ambientale.
Il perno logico della distinzione concettuale tra danno alla fauna ambientalmente irrilevante e
danno alla fauna ambientalmente dannoso risiede nel presupposto che sussistano condotte dannose
che, per la loro levità, danneggino la fauna in modo sì insignificante da non refluire sull’ecosistema
e sull’ambiente nel suo complesso.
Di conseguenza, nel momento in cui si esclude la configurabilità di diverse tipologie di danno
a seconda della gravità della condotta illecita, e si dichiara ope legis che qualsiasi comportamento
tenuto in violazione della normativa di tutela costituisce ipso facto danno alla fauna selvatica nel
suo complesso, deve concludersi che ogni condotta dannosa reca danno all’intera fauna
selvatica, e pertanto compromette, pone in pericolo, l’intero ecosistema, vuoi in concreto, vuoi
per fictio legis ispirata a tecnica legislativa di profilassi preventiva.
Partendo da questi diversi presupposti, deve verificarsi se sia possibile, in tale differente
quadro normativo e giuridico-concettuale di riferimento, ritenere comunque giuridicamente
sussistente la distinzione tra danno alla fauna ambientalmente irrilevante e danno alla fauna
ambientalmente dannoso.
In senso favorevole alla configurabilità della distinzione, e dunque in definitiva alla
configurabilità del danno alla fauna ambientalmente irrilevante, milita l’osservazione per cui
l’autonomia dell’ambiente in senso giuridico rispetto agli elementi che lo costituiscono impone
comunque, anche di fronte alla causazione di un danno all’integrità complessiva di uno degli
elementi costitutivi, la verificazione caso per caso della refluenza effettiva sull’ambiente del danno
in parola.
Tuttavia l’analisi del concreto atteggiarsi della disciplina positiva che si ricava dall’adesione a
tale orientamento pone in risalto una evidente aporìa.
Non è infatti dato comprendere, in concreto, quali criteri dovrebbero presiedere
all’accertamento caso per caso della sussistenza di un danno all’ambiente.
Se infatti si assume che l’ambiente è valore e concetto talmente autonomo dagli elementi che
lo costituiscono da potere restare illeso anche in presenza di compromissione dell’integrità di uno
degli elementi costitutivi, è difficilmente individuabile un complesso di criteri, un quadro
parametrico al quale fare riferimento per verificare, in concreto, se il danno alla fauna selvatica nel
suo complesso abbia cagionato danno all’ambiente nel suo complesso.
Per questa via, in assenza di criteri di valutazione – anche ricavati dalla comune esperienza,
ma comunque oggettivi ed attendibili, che in tale ottica non appaiono sussistere – circa la
31
sussistenza del danno all’ambiente nel suo complesso si procede in direzione della produzione di
due effetti nell’applicazione concreta della normativa vincolistica.
In primo luogo, così opinando il concetto di ambiente in senso giuridico rischia di diventare,
in concreto, del tutto impalpabile, indefinito, diafano, fino a scomparire. Se infatti è vero che
l’ambiente è autonomo rispetto agli elementi che lo costituiscono, ritenere che possa ritenersi non
danneggiato dalla compromissione dell’integrità complessiva di uno o più degli elementi medesimi
coincide con lo svuotamento del contenuto del concetto di ambiente.
In secondo luogo, tale orientamento finisce per lasciare alla discrezionalità del giudice uno
spazio sì vasto che, in assenza di oggettivi criteri di riferimento, finisce per sconfinare nell’arbitrio,
sì da rimettere sostanzialmente alla valutazione del giudice l’individuazione stessa del contenuto del
concetto di ambiente in senso giuridico.
Entrambe le prospettive applicative appaiono contrastanti con il dettato costituzionale, e
pertanto appaiono da scartare.
In senso contrario alla configurabilità della distinzione tra danno alla fauna
ambientalmente irrilevante e danno alla fauna ambientalmente dannoso, e dunque in definitiva in
senso contrario alla configurabilità del danno alla fauna ambientalmente irrilevante, assumono
rilievo diverse osservazioni.
In primo luogo, rileva il fatto che le conseguenze concrete del primo orientamento siano,
come testé argomentato, contrastanti con il dettato costituzionale, sicchè l’impianto teorico,
condivisibile o no che sia sotto il profilo dogmatico, appare incompatibile con il complesso del
sistema ordinamentale.
In secondo luogo, deve osservarsi come, una volta accertato che in virtù del dato normativo
positivo il danno alla fauna è sempre cagionato alla fauna nel suo complesso, non sembra revocabile
in dubbio che ogni condotta dannosa per la fauna compromette l’integrità stessa di un elemento
costitutivo del complesso concettuale di ambiente. A tali condizioni, sembra potersi escludere, in
punto di logica, che l’ambiente possa non essere danneggiato nel suo complesso dal danno alla
fauna selvatica. In tale ottica depone senz’altro la motivazione, più volte richiamata, della sentenza
della Corte Costituzionale n. 536 del 20.12.2002.
Così ricostruito il dato normativo e tratteggiate le coordinate ordinamentali di riferimento,
pare potersi concludere affermando che ogni condotta posta in essere in violazione della
normativa di tutela della fauna selvatica cagiona di per sé stessa, oltre che un danno alla
fauna selvatica nel suo complesso, anche al valore costituzionalmente protetto dell’ambiente
in senso giuridico.
32
In concreto, del resto, non può non osservarsi come effettivamente l’equilibrio dell’ecosistema
sia così delicato, nella società industriale dell’età atomica, da doversi effettivamente ritenere
danneggiato e seriamente compromesso da qualsivoglia attività di aggressione alla fauna selvatica
che non sia strettamente rispettosa delle regole minime di tutela imposte dalla legge – peraltro
spesso non ingenerose nei confronti dei cacciatori. L’interpretazione offerta, pertanto, oltre che
strettamente agganciata al dato normativo positivo ordinario e costituzionale, coglie senz’altro lo
spirito della legge e l’obiettivo della tutela costituzionale dell’ambiente.
Ai fini della esistenza di un danno ambientale, la legge 8 luglio 1986, n. 349 contempla anche l'ipotesi
della semplice alterazione in una delle componenti ambientali, sicuramente riscontrabile nel caso di
immissione in un corpo ricettore di inquinanti chimici oltre la soglia ritenuta pericolosa dalla legge,
tale da giustificare addirittura la sanzione penale. (Nella specie la S.C. ha osservato che per i ripetuti
scarichi, alcuni contenenti perfino mercurio, un danno ambientale era stato accertato e giustamente ne
erano stati considerati destinatari lo Stato e gli Enti territoriali).
(Cass. 19.1.1994, n. 439, MCP, riv. 197042)
2.3.2. La risarcibilità dei danni all’ambiente.
Legislazione c.c. 2043 – l. 8.7.1986, n. 349 18.
La tematica del danno all’ambiente presenta numerose sfaccettature, che potranno essere
affrontate solo per la parte che attiene all’oggetto di questo breve contributo.
Ai sensi del citato art. 18 l. 8.7.1986, n. 349, il danno all’ambiente obbliga l’autore del fatto a
risarcire il danno. La norma precisa, tuttavia, come titolare del diritto al risarcimento siano
esclusivamente lo Stato e “gli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo”.
La nozione legale di danno ambientale risarcibile individua tassativamente anche i destinatari
del risarcimento, così lasciando intendere che il contenuto patrimoniale del diritto all’ambiente sia
aspetto correlato esclusivamente allo stanziamento da parte dello Stato e degli enti territoriali dei
fondi necessari alla preservazione dell’ambiente medesimo, sicchè ogni danno all’ambiente è
risarcibile perché impone l’esborso da parte dello Stato e degli enti territoriali per il ripristino delle
condizioni ambientali alterate dall’atto illecito.
L’elaborazione giurisprudenziale, costituzionalmente orientata, della tematica del danno
all’ambiente, ha individuato una nozione di danno ambientale maggiormente estesa sotto il profilo
del contenuto del danno.
Il danno ambientale presenta una triplice dimensione: personale (quale lesione del diritto fondamentale
all’ambiente di ogni uomo); sociale (quale lesione del diritto fondamentale all’ambiente nelle formazioni
sociali in cui si sviluppa la personalità umana, art. 2 Cost.); pubblica (quale lesione del diritto-dovere
pubblico delle istituzioni centrali e periferiche con specifiche competenze ambientali).
33
(Cass. 19.1.1994, n. 439, MCP, riv. 197044).
L’individuazione del danno all’ambiente come lesione del diritto all’ambiente di ogni uomo
nonché quale lesione del diritto all’ambiente delle formazioni sociali rappresentative di interessi
diffusi non comporta, di per sé sola, il riconoscimento della generale risarcibilità di tali danni.
La limitazione legale della risarcibilità del danno ambientale allo Stato ed agli enti territoriali,
prevista dall’art. 18 l. 8.7.1986, n. 349, impone di verificare la risarcibilità del danno al diritto
personale e diffuso all’ambiente secondo i canoni ordinari del risarcimento del danno, previsti dagli
artt. 2043 e seguenti del codice civile.
2.3.2.1. Il danno da reato ambientale.
Legislazione Cost. 2; 32. – c.c. 2043; 2059. – l. 8.7.1986, n. 349 10; 18.
Muovendo dal presupposto per cui il danno arrecato al diritto all’ambiente dei singoli e delle
formazioni sociali rappresentative di interessi diffusi abbia contenuto non patrimoniale – dal
momento che la funzione di preservazione e ripristino del bene pubblico costituzionalmente protetto
costituito dall’ambiente è rimessa allo Stato ed agli enti territoriali, nelle rispettive sfere di
competenza – dovrebbe concludersi che la risarcibilità del danno al diritto singolare e collettivo
all’ambiente vada vagliata alla stregua dei principi civilistici che presiedono alla disciplina del
risarcimento del danno non patrimoniale.
La risarcibilità del danno morale soggettivo a sèguito di disastro ambientale colposo è condizionata alla
menomazione dell’integrità psico-fisica o di altro evento produttivo di danno patrimoniale.
(Cass. 24.5.1997, n. 4631, MCC, riv. ).
E’ noto, in proposito, che l’art. 2059 c.c. consente il risarcimento del danno non patrimoniale
esclusivamente nei casi determinati dalla legge.
Comune interpretazione di tale principio è che il danno non patrimoniale sia tra l’altro
certamente conseguente alla condotta, lesiva di un diritto, che costituisca reato. L’orientamento,
ormai pietrificato, non trova pronunzie difformi nemmeno in data recente.
Il danno patrimoniale, che per il combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen., e'
risarcibile nel caso in cui derivi da un fatto illecito costituente reato e consistente in un turbamento
ingiusto dello stato d'animo o in uno squilibrio o riduzione delle capacita' intellettive della
vittima, comprende anche le sofferenze fisiche e morali da questa sopportate in stato di incoscienza.
(Cass. 24.5.2001, n. 7075, MCC, riv. 546937).
E’ certamente risarcibile pertanto la lesione del diritto non patrimoniale all’ambiente
allorchè la condotta lesiva costituisca reato.
34
Tale conclusione è pacifica in giurisprudenza per quanto attiene al diritto al risarcimento del
danno a favore delle formazioni sociali rappresentative di interessi diffusi.
In tema di legittimazione degli enti e delle associazioni ecologistiche a costituirsi parte civile,
deve ritenersi che quando l'interesse diffuso alla tutela dell'ambiente non e' astrattamente connotato, ma
si concretizza in una determinata realta' storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo, diventando la
ragione e, percio', elemento costitutivo di esso, e' ammissibile la costituzione di parte civile di
tale ente, sempre che dal reato sia derivata una lesione di un diritto soggettivo inerente allo scopo
specifico perseguito. Pertanto e', "in primis", configurabile, in capo alle associazioni ecologistiche, la
titolarita' di un diritto soggettivo e di un danno risarcibile, individuabile nella salubrita' dell'ambiente,
sempre che una articolazione territoriale colleghi le associazioni medesime ai beni lesi, sicche' esse
sono legittimate all'azione "aquiliana" per la difesa del proprio diritto soggettivo alla tutela dell'interesse
collettivo alla salubrita' dell'ambiente; e', inoltre, ipotizzabile la lesione del diritto della personalita'
dell'ente e la conseguente facolta' delle associazioni di protezione ambientale di agire per il risarcimento
dei danni morali e materiali relativi all'offesa, diretta ed immediata, dello "scopo sociale", che
costituisce la finalita' propria del sodalizio. ( Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'associazione Lega
ambiente ( ente esponenziale della comunita' in cui trovasi il bene collettivo oggetto di lesione ed
avente a scopo la salvaguardia degli interessi lesi dal reato ) era legittimata a costituirsi parte civile, ai
sensi degli artt. 185 cod.pen. e 74 cod.proc.pen., sia per la tutela del diritto collettivo all'ambiente
salubre sia per la protezione del diritto della personalita' in conseguenza del discredito derivante alla
propria sfera funzionale dalla condotta illecita ).
(Cass. 26.9.1996, n. 8699, MCP, riv. 209096).
Se dunque si conviene con la giurisprudenza di legittimità sopra citata nell’affermazione – che
peraltro appare strettamente rispettosa del dettato costituzionale, vieppiù alla luce della novella del
2001 – per cui l’ambiente è un momento di sviluppo della persona umana e dunque, ai sensi degli
artt. 2 e 32 Cost., è diritto soggettivo fondamentale di ciasuna persona umana il diritto all’integrità
dell’ambiente, deve riconoscersi tale diritto ad ogni singola persona.
Ne consegue che qualora il diritto all’ambiente della singola persona venga leso da una
condotta costituente reato, essa singola persona ha diritto al risarcimento del danno non
patrimoniale. Sarà poi compito del giudice, caso per caso, evitare eccessi e speculazioni da parte
della persona che si assume danneggiata.
Il danno ambientale non consiste solo in una “compromissione dell’ambiente” in violazione delle leggi
ambientali, ma anche contestualmente in una “offesa della persona umana nella sua dimensione
individuale e sociale”. Pertanto, proprio perché nel danno ambientale è inscindibile l’offesa ai valori
naturali e culturali e la contestuale lesione dei valori umani e sociali di ogni persona, la legittimazione
processuale non spetta solo ai soggetti pubblici, come Stato, Regione, Province, Comuni, Enti autonomi,
Parchi Nazionali ecc. (in nome dell’ambiente come interesse pubblico) ma anche alla persona singola od
associata (in nome dell’ambiente come diritto soggettivo fondamentale di ogni uomo): le associazioni di
protezione dell’ambiente, ivi comprese quelle a carattere locale non riconosciute esx art. 13 della legge 8
luglio 1986 n. 349, possono intervenire nel processo e costituirsi parti civili, in quanto abbiano dato prova
di continuità della loro azione, aderenza al territorio, rilevanza del loro contributo, ma soprattutto perché
formazioni sociali nelle quali si svolge dinamicamente la personalità di ogni uomo, titolare del diritto
umano all’ambiente.
(Cass. 19.11.1996, n. 9837, MCP, riv. 206473).
35
2.3.2.2. Gli interessi diffusi.
Legislazione Cost. 2; 32. – c.c. 2043; 2059. – l. 8.7.1986, n. 349 10; 18.
Alla conferma della condivisibilità di tale conclusione concorrono, del resto, altre
osservazioni.
In primo luogo, va osservato come le formazioni sociali rappresentative di interessi diffusi
vengano ritenute titolari del diritto al risarcimento del danno al proprio diritto all’ambiente non già
in quanto enti riconosciuti, ma esclusivamente in quanto formazioni rappresentative di un
complesso di interessi personali coincidenti e convergenti nella volontà di tutela di un medesimo
bene, che è l’ambiente.
L’argomento è del resto testuale. Mentre gli artt. 10 e 18 l. 8.7.1986, n. 349, attribuiscono il
potere di intervento in giudizio e di ricorso giurisdizionale amministrativo esclusivamente alle
associazioni rappresentative di interessi diffusi che siano riconosciute con apposito decreto del
ministro dell’ambiente, la giurisprudenza riconosce il diritto al risarcimento del danno a tutte le
formazioni sociali, indipendentemente da qualsivoglia riconoscimento, che rappresentino
effettivamente (e cioè con una storia di positiva attività di attenzione e tutela dell’interesse protetto)
un interesse diffuso condiviso da tutti i partecipanti alla formazione sociale medesima.
In tale ottica, appare di tutta evidenza – come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza citata
– che la formazione sociale non ripete la propria legittimazione attiva da un atto autoritativo o da
una disposizione di legge, ma esclusivamente dal fatto che il diritto all’ambiente è personale e
ciascuna delle persone che partecipano alla formazione sociale ne è titolare ed ha diritto di tutelarlo
in giudizio. La formazione sociale, dunque, trae il proprio diritto al risarcimento del danno al diritto
non patrimoniale all’ambiente non dalla qualità di formazione sociale in sé e per sé, ma dal diritto di
tutti i partecipanti alla formazione alla tutela del proprio diritto personale, privato e singolare,
riconosciuto dagli artt. 2 e 32 Cost.
Nel quadro di tali coordinate ermeneutiche, appare di tutta evidenza che laddove il diritto della
formazione sociale – riconosciuto esplicitamente in giurisprudenza – al risarcimento del danno in
parola trae origine dal diritto personale dei singoli partecipanti, deve a fortiori ritenersi risarcibile il
danno arrecato al diritto personale del singolo individuo, anche al di fuori della partecipazione di lui
ad alcuna formazione sociale rappresentativa di interessi diffusi.
In secondo luogo, l’osservazione della realtà effettuale consente di ritenere ingiustificato il
riconoscimento del diritto al risarcimento in oggetto esclusivamente alle formazioni sociali
rappresentative di interessi diffusi e non anche ai singoli titolari del diritto all’ambiente.
36
Dall’un lato, è agevole osservare come le formazioni sociali, proprio in quanto formazioni
spontanee ed eventuali, non necessariamente sussistono in ciascuna porzione del territorio dello
Stato, ed anche ove sussistenti non necessariamente tutelano tutte le porzioni con la medesima
attenzione ed il medesimo scrupolo. Ne consegue che sarebbe del tutto ingiustificato che, ad
esempio, per l’inesistenza o l’inattività di una formazione sociale locale rappresentativa di interesse
diffuso, il pastore dell’Aspromonte o del Gennargentu debba assistere impotente allo scempio
dell’ecosistema del proprio ambiente di vita, senza potere ottenere il risarcimento del proprio diritto
all’integrità dell’ambiente naturale. Una simile conclusione, oltre che evidentemente incompatibile
con il dettato costituzionale e con l’interpretazione che di esso offre la giurisprudenza di legittimità,
finirebbe per attribuire alle formazioni sociali spontanee rappresentative di interessi diffusi una
sorta di diritto di privativa decisamente non previsto per legge, almeno a questi fini.
Dall’altro lato, non può non osservarsi come il danno non patrimoniale, e dunque il danno
morale, possa essere e sia normalmente cagionato senz’altro, al privato, dalla commissione di fatti
penalmente rilevanti che cagionino danno all’ambiente. Si pensi, ad esempio, alla persona che
tragga sfogo alle proprie ansie e riposo alle proprie fatiche, o ispirazione per le proprie creazioni
artistiche, da consuete lunghe passeggiate presso una riserva naturale orientata, e che dopo avere
goduto per anni di un simile ristoro si trovi improvvisamente, a metà strada, la riserva rovinata dallo
sversamento abusivo di tonnellate di rifiuti maleodoranti, il ruscello inquinato da scarichi abusivi di
residui chimici, la flora contaminata dalla abusiva liberazione in atmosfera di sostanze pesticide.
Non appare revocabile in dubbio che il diritto personale all’ambiente fosse sussistente,
effettivo, goduto, attinente allo sviluppo della persona umana ed alla sua salute fisica e
mentale, e sia stato gravemente compromesso e danneggiato dalla condotta illecita costituente
reato.
Non si vede dunque per quale motivo non dovrebbe venire risarcito.
2.3.2.3. Il danno non patrimoniale.
Legislazione Cost. 2; 32. – c.c. 2043; 2059. – l. 8.7.1986, n. 349 10; 18.
Parte della giurisprudenza ha poi riconosciuto la sussistenza di un danno non patrimoniale
risarcibile anche in capo allo Stato ed agli enti territoriali quali enti esponenziali degli interessi
delle comunità che rappresentano.
Sussiste la legittimazione del comune, quale ente esponenziale degli interessi collettivi della comunita', a
costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati urbanistici.
(Cass. 12.6.1982, n. 5882, MCP, riv. 154209)
37
Laddove il reato leda l’interesse della comunità alla tutela del territorio, ritiene la
giurisprudenza citata che l’ente territoriale, quale esponente degli interessi dei consociati, sia
titolare del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato dal reato medesimo.
Il Comune puo' essere considerato danneggiato dal delitto di associazione per delinquere di tipo
mafioso, in quanto tale reato certamente cagiona un pregiudizio, di carattere patrimoniale e non, almeno
all'immagine della citta' ed allo sviluppo del turismo e delle attivita' produttive di essa, con
conseguente lesione di interessi propri, giuridicamente tutelati, dell'ente che della collettivita'
danneggiata ha la rappresentanza.
(Cass. 24.7.1992, n. 8381, MCP, riv. 191448)
La ritenuta risarcibilità di tale danno non patrimoniale pone diversi problemi.
In primo luogo, dovrebbe accertarsi se tale danno rientri tra i danni risarcibili nei confronti
dello Stato e degli enti territoriali ai sensi dell’art. 18 l. 8.7.1986, n. 349.
Dall’un lato, l’argomento testuale sembrerebbe includere tali danni, dal momento che nessuna
distinzione è operata tra il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale, limitandosi la norma ad
imporre il risarcimento del danno ambientale a favore dello Stato e degli enti territoriali.
D’altro canto, lo spirito della disposizione appare – come opinato dalla giurisprudenza sopra
citata – fondato sul rilievo per cui lo Stato e gli enti territoriali subiscono un danno patrimoniale dal
danno ambientale a cagione dell’obbligo, cui sono tenuti per legge, di ripristinare l’ambiente
naturale alterato, stanziando i relativi fondi.
In secondo luogo, ed in diretta connessione con le precedenti osservazioni, si pone un
problema di parità di trattamento. Se infatti dovesse riconoscersi allo stato il diritto al risarcimento
del danno non patrimoniale indipendentemente dalla penale rilevanza della condotta lesiva, si
istituirebbe una indebita disparità di trattamento tra il danno non patrimoniale per lesione del diritto
all’ambiente dello Stato e degli enti territoriali quali enti rappresentativi degli interessi dei singoli –
sempre risarcibile – e il danno non patrimoniale per lesione del diritto all’ambiente dei singoli e
delle formazioni sociali rappresentative di interessi diffusi – risarcibile esclusivamente ai sensi
dell’art. 2059 c.c., quando la condotta lesiva sia penalmente rilevante.
Una simile disparità di trattamento, del tutto ingiustificata, appare costituzionalmente
illegittima, sicchè deve scartarsi l’interpretazione giuridica che la sottende.
E’ poi interessante notare, in limine, come potrebbero agire per il risarcimento del danno,
contemporaneamente, l’ente territoriale, una formazione sociale rappresentativa di interessi diffusi
locale ed una rilevante quantità di persone residenti nel territorio, uti singuli; in tal caso, sarebbe
interessante verificare la soluzione giurisprudenziale, che dovrebbe tenere conto del fatto che il
risarcimento del danno, riconosciuto uti singuli ai soggetti individualmente aventi diritto, dovrebbe
proporzionalmente ridurre il diritto al risarcimento delle formazioni sociali e degli enti territoriali
che quegli stessi interessi, autonomamente azionati in giudizio, pretendono di tutelare e dai quali
38
ripetono la propria legittimazione processuale ed il proprio diritto al risarcimento del danno non
patrimoniale.
Il danno non patrimoniale per lesione del diritto all’ambiente, in definitiva, può essere
riconosciuto anche allo Stato ed agli enti territoriali, ma esclusivamente ai sensi dell’art. 2059 c.c.
2.3.2.4. Profili di risarcibilità del danno ambientale non derivante da reato.
Legislazione c.c. 2043. – l. 8.7.1986, n. 349 18.
Si è accennato, in precedenza, alla qualificazione del diritto all’ambiente come diritto avente
contenuto non patrimoniale, sicchè il danno arrecato a tale diritto dovrebbe ritenersi un danno non
patrimoniale, come tale ricadente sotto l’imperio dell’art. 2059 c.c. e dunque risarcibile
esclusivamente qualora la condotta lesiva sia penalmente rilevante.
Laddove il contenuto patrimoniale del diritto, e dunque la patrimonialità del danno, venga
intesa in senso tradizionale, deve riconoscersi che la lesione del diritto personale e collettivo
all’ambiente vada ricompresa nella categoria del danno non patrimoniale, limitandosi il
riconoscimento legale della patrimonialità del danno ambientale esclusivamente al danno arrecato
allo Stato ed agli enti territoriali secondo la previsione dell’art. 18 l. 8.7.1986, n. 349.
Per accertare la condivisibilità di una tale premessa, appare necessario verificare se il diritto
personale e collettivo all’ambiente sia effettivamente ontologicamente privo di contenuto
patrimoniale.
L’osservazione della realtà consente di notare diversi esempi in cui al danno all’ambiente si
correla concretamente un danno a contenuto patrimoniale.
Si pensi ad esempio all’ipotesi dell’artista (un pittore, un poeta) che si veda privare
dell’ambiente naturale dal quale durante tutta la vita ha tratto ispirazione (la mente corre, del resto,
al sentiero sulla collina di Heidelberg ove Hegel elaborò interamente il proprio pensiero filosofico,
fino alla creazione dell’appercezione trascendentale, l’io penso); al caso del titolare di un’impresa
agrituristica o di un lido balneare che perda gran parte della affezionata clientela a causa di un grave
dànno cagionato all’ambiente naturale del sito, che attirava i turisti; al soggetto che abbia acquistato
un immobile nell’unico sito naturale in cui il figlio, malato di mente, trovi riposo alle proprie crisi, e
se lo veda alterare; e molti altri casi, che la realtà, più ancora che la fantasia, offre all’esame.
Muovendo dal presupposto per cui in tali casi la condotta lesiva non costituisca reato
(circostanza non solo senz’altro possibile, vista la vasta tipologia di danni all’ambiente e la tassativa
e meno vasta tipologia di condotte incriminate – di recente peraltro sensibilmente ridotta, in
particolare in tema di smaltimento di rifiuti – ma anche necessaria alla trattazione, perché altrimenti
39
non vi è dubbio circa la risarcibilità del danno ai sensi dell’art. 2059 c.c.), appare evidente la diretta
ed immediata refluenza negativa del danno ambientale sul patrimonio del soggetto privato.
E’ noto, in proposito, come la giurisprudenza, pronunziandosi in materia di danno biologico,
abbia individuato e separato il concetto di danno-evento dal concetto di danno-conseguenza,
distinguendo il regime risarcitorio dell’uno e dell’altro.
In relazione alla distinzione tra il danno alla salute, inteso come menomazione dell’integrità psicofisica
della persona in sé considerata, e il danno derivante dal medesimo evento lesivo che incide, riducendo la
capacità lavorativa, sulla produzione di reddito, non è censurabile la decisione del giudice di merito che
in relazione alla invalidità permanente conseguente all’infortunio determini l’entità del pregiudizio
complessivamente riguardante l’integrità fisica del soggetto, distinguendo poi in tale ambito, ai fini della
liquidazione, il profilo che attiene direttamente alla capacità reddituale (al quale va riferita la copertura
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) e il danno che risulta indipendente da tali
riflessi sulla sfera patrimoniale; per questo secondo aspetto è necessario tuttavia uno specifico
accertamento in ordine alle conseguenze dell’evento lesivo sulla sfera non patrimoniale di estrinsecazione
dei valori personali vitali.
(Cass. 2.3.1999, n. 1751, GCM, 1999, 472).
Il danno-evento, costituito dalla lesione del diritto della persona, ha natura non patrimoniale e
deve quantificarsi avendo riguardo alla gravità della lesione dei beni della vita del danneggiato; il
danno-conseguenza, costituito dalla diminuzione della sfera patrimoniale del danneggiato, segue gli
ordinari criteri di liquidazione.
Nella liquidazione del danno patrimoniale alla persona il giudice deve accertare in base alle prove fornite
dall’attore danneggiato ed avvalendosi anche delle presunzioni semplici per il danno da invalidità
permanente (che si proietta nel futuro) in quale misura la menomazione fisica o psichica abbia inciso
sulla capacità di svolgimento della capacità lavorativa specifica e questa a sua volta sulla capacità di
guadagno (e quindi di produrre ricchezza). Ne deriva che il danno patrimoniale alla persona può essere
liquidato soltanto quando si accerti, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il singolo soggetto
danneggiato, che agisce per il risarcimento per effetto del fatto lesivo alla sua integrità psico-fisica, subirà
una perdita della sua specifica capacità futura di guadagno.
(Cass. 3.5.1999, n. 4385, GCM, 1999, 996).
La perdita della futura capacità di guadagno è l’aspetto fondamentale che viene in rilievo in
materia di quantificazione del danno-conseguenza.
La riduzione della cosiddetta capacità lavorativa specifica non costituisce danno in sé (danno-evento), ma
rappresenta invece una causa del dano da riduzione di reddito (danno-conseguenza). Pertanto, una volta
provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente
provata l’esistenza di un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per
mezzo di presunzioni semplici, l’esistenza di una conseguente riduzione della capacità di guadagno.
(Cass. 21.4.1999, n. 3961, GCM, 1999, 897).
E’ agevolmente istituibile un parallelo tra la distinzione danno-evento/danno-conseguenza in
relazione al danno biologico ed in relazione al danno all’ambiente.
Il risarcimento del danno biologico tende a risarcire la violazione del diritto soggettivo
individuale costituzionalmente tutelato alla salute (art. 32 Cost.); il risarcimento del danno
ambientale tende a risarcire la violazione del diritto soggettivo individuale costituzionalmente
tutelato all’integrità dell’ambiente (artt. 9, 32 e 1172 lett. s) Cost.).
40
Il danno biologico in quanto tale costituisce danno-evento a contenuto non patrimoniale ed è
risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c., mentre la riduzione della capacità di produrre reddito
conseguente al danno biologico costituisce danno-conseguenza ed è risarcibile ai sensi dell’art.
2043 c.c.; il danno all’ambiente in quanto tale costituisce danno-evento a contenuto non
patrimoniale ed è risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c., mentre ogni danno emergente o lucro
cessante immediatamente conseguente al danno all’ambiente costituisce danno-conseguenza ed è
risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c.
In tale ottica, deve ritenersi che le ipotesi sopra esemplificativamente proposte in materia di
refluenza patrimoniale del danno all’ambiente vadano qualificate, in accordo con la giurisprudenza
prevalente, non già come ipotesi di danno all’ambiente a contenuto patrimoniale, ma come ipotesi
di danno patrimoniale conseguente al danno ambientale.
Ne consegue che, pur restando la lesione del diritto soggettivo individuale all’ambiente in
quanto tale priva di contenuto patrimoniale e dunque risarcibile esclusivamente ai sensi dell’art.
2059 c.c., ogni riflesso patrimoniale negativo sulla sfera giuridica del singolo direttamente
derivante dal danno ambientale, anche non costituente reato, è autonomamente risarcibile ai
sensi dell’art. 2043 c.c.
Diversa questione, che eccede i limiti del presente contributo e meriterebbe trattazione
autonoma, è l’attualità della disciplina dell’art. 2059 c.c., che impedisce il risarcimento per la
lesione non costituente reato di diritti costituzionalmente garantiti – in un sistema ove sono risarcite,
indipendentemente dalla rilevanza penale della condotta, ormai numerosissime ipotesi, sempre in
aumento, di interessi privati non costituzionalmente considerati – sol perché non ne riconosce un
contenuto patrimoniale immediatamente apprezzabile. Come se la lesione – penalmente irrilevante,
ma pur sempre lesione – di un diritto della persona, di un bene della vita così rilevante per l’essere
umano da essere garantito dalla Costituzione possa ritenersi immeritevole di risarcimento sol perché
la sua lesione non determina una diminuzione delle mere potenzialità reddituali del soggetto leso.
Si tratta di una impostazione ideologica decisamente da riconsiderare nell’ottica dell’assetto
costituzionale e ordinario della disciplina del risarcimento del danno alle soglie del terzo millennio.
2.3.2.5. Criteri di quantificazione del danno ambientale. La restitutio in integrum.
Legislazione c.c. 1223; 1226; 2043; 2058; 2059. – l. 8.7.1986, n. 349 18. – l. 28.2.1985 n. 47 7. – l. 2.2.1974 n. 64 23. –
d.p.r. 6.6.2001 n. 380 31. – d.l. 29.10.1999 n. 490 163. – d.l. 5.2.1997 n. 22 51; 51 bis. – l. 6.12.1991 n.
394 30. – d.l. 11.5.1999 n. 152 58.
Una volta accertato che il danno alla fauna selvatica costituisce danno all’ambiente, e che tale
danno è risarcibile autonomamente nei confronti dello Stato e degli enti territoriali in forza dell’art.
41
18 l. 8.7.1986, n. 349 ed è altresì risarcibile nei confronti dei singoli e delle formazioni sociali
rappresentative di interessi diffusi, direttamente qualora consegua a condotta penalmente rilevante,
solo in quanto sussista eventuale danno-conseguenza negli altri casi, mette conto soffermarsi
brevemente sui criteri di quantificazione del danno medesimo.
Per quanto riguarda lo Stato e gli enti territoriali, il fatto che il risarcimento del danno sia loro
riconosciuto per legge principalmente in quanto tenuti a ripristinare l’ambiente naturale alterato
dalla illecita violazione consente di ritenere che il danno vada quantificato con riferimento al
complesso delle spese necessarie per il ripristino medesimo, da valutarsi tecnicamente caso per caso
dal giudice e dai suoi ausiliari.
Una simile conclusione deve tuttavia essere coordinata con altre norme vigenti in materia.
L’art. 188 della l. 8.7.1986, n. 349 prevede che il giudice che riconosca il convenuto
responsabile di danno ambientale, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino
dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
La l. 28.2.1985 n. 47 – norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie – prevede, all’ultimo comma dell’art. 7, che “per
le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui
all’articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dal successivo
articolo 20 della presente legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata
altrimenti eseguita”.
La l. 2.2.1974 n. 64 – provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche – prevede, all’ultimo comma dell’art.23, che “con il decreto o con la sentenza di condanna
il pretore ordina la demolizione delle opereo delle parti di essecostruitein difformità alle norme
della presente legge o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 3, ovvero impartisce le
prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo
termine”.
Il DPR 6.6.2001 n. 380 – testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia – prevede, all’ultimo comma dell’art. 31, che “per le opere abusive di cui al presente
articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44, ordina la
demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita”, ed inoltre, all’art. 983,
che “con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o
delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali
di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere
conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine”.
42
Il Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490 – testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali ed ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997 n. 352 – prevede,
al secondo comma dell’art. 163, che “con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in
pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato”.
Il Decreto Legislativo 5.2.1997 n. 22 – attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio – prevede, al
terzo comma dell’art. 51, che “alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla quale è
realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli
obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”, ed al primo comma dell’art. 51 bis, che
“chiunque cagiona l’inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento previsto
dall’articolo 17, comma 2, è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda
da euro 2.582 a euro 25.822 se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui
all’articolo 17”.
La legge 6.12.1991 n. 394 – legge quadro sulle aree protette – prevede, al terzo comma
dell’art. 30, che “in caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli artt. 733 e
734 c.p. può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l’aggravamento o la
continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell’area protetta, il sequestro di quanto
adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla
riduzione in pristino dell’area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del
danno”.
Il Decreto Legislativo 11.5.1999 n. 152 – disposizioni sulla tutela delle acque
dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – prevede, al primo comma dell’art. 58, che “chi
con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del presente
decreto provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero
determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a
proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree
inquinate e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai
sensi e secondo il procedimento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22”.
La previsione legislativa dell’obbligatorietà della condanna al ripristino dello stato dei luoghi
a spese del responsabile impone di verificare quale sia il limite del criterio di quantificazione del
danno sopra indicato.
43
Se infatti si è sostenuto che la quantificazione del danno in favore dello Stato e degli enti
territoriali va effettuata tenendo conto delle spese necessarie per il ripristino dell’ambiente, è
evidente che laddove sia prevista la condanna del responsabile al ripristino a proprie spese, la
condanna del medesimo responsabile anche al danno secondo il predetto criterio sfocerebbe in una
indebita duplicazione del risarcimento.
Deve dunque ritenersi che il criterio di quantificazione del danno nei confronti dello Stato e
degli enti territoriali sia, in presenza di condanna al ripristino a spese del responsabile, da rinvenirsi
negli ordinari criteri posti dagli artt. 1223 e 1226 c.c.
Pertanto, laddove lo Stato o l’ente territoriale danneggiato possa provare di avere subìto un
danno diverso da quello derivante dal mero obbligo di ripristino, quale ad esempio la
sopravvenuta impossibilità di situare un centro per disabili o una riserva o un centro di ricerca nel
sito ambientalmente rilevante, o il danno a strutture già esistenti, la quantificazione del danno
avverrà secondo i criteri del danno emergente e del lucro cessante. Altrimenti, dovrà procedersi alla
liquidazione secondo equità.
Con riferimento al danno arrecato al diritto individuale all’ambiente dei singoli soggetti e
delle formazioni sociali rappresentative di interessi diffusi, il discorso assume una duplice veste.
Il danno patrimoniale – il danno-conseguenza sopra commentato – va risarcito secondo i
medesimi criteri posti dagli artt. 1223 e 1226 c.c.
Il danno non patrimoniale – ove risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c. – va invece risarcito
tenendo conto, mediante indagine da eseguirsi nel caso concreto, delle effettive sofferenze, dei reali
patimenti sofferti dal singolo o dal gruppo di soggetti in conseguenza del danno all’ambiente, e
pertanto in via equitativa. Il giudice dovrà dare conto, nella motivazione della sentenza, dei criteri
adottati e dovrà procedere ad una quantificazione che non si riduca ad un simulacro di risarcimento
ma costituisca una effettiva equa riparazione del danno subìto.
In tale ipotesi, deve riconoscersi come i criteri di liquidazione equitativa del danno debbano
ricollegarsi strettamente alla tematica del riflesso sulla persona umana dell’equilibrio ambientale.
Come sopra esemplificato, l’equilibrio ambientale rappresenta per la persona umana – in
diversa misura – un centro di riposo per le proprie ansie, di ispirazione per la propria sensibilità
artistica, di ripristino delle proprie capacità compromesse dal periodo lavorativo, di
ricongiungimento con i propri affetti.
Si pensi all’ipotesi della persona che riconosca in un certo ambiente naturale le tracce della
propria infanzia, che un determinato sito sia l’unico sistema al mondo che gli permetta di rientrare
in contatto con il proprio passato di ricordare i propri genitori, i propri affetti del passato, i propri
momenti di crescita.
44
Si tratta di momenti spiccatamente significativi per lo sviluppo, la crescita e l’equilibrio della
persona umana, sicchè nella valutazione equitativa del danno vanno tenuti in gran conto.
E’ evidente che l’alterazione definitiva o abbisognevole di lungo tempo per il ripristino
dell’ambiente naturale cagiona la perdita definitiva o quasi totale di questa forma di godimento
dell’ecosistema che contribuisce in misura notevole allo sviluppo della personalità umana, sicchè la
quantificazione del danno in via equitativa, per non sfociare in un mero simulacro di riparazione,
deve consistere nell’attribuzione al danneggiato di quanto necessario per ritrovare aliunde lo stesso
genere di godimento.
Dovranno pertanto ricomprendersi nella quantificazione del danno le spese necessarie per
accedere ad altro ambiente naturale analogo o per attingere in altro modo le medesime forme di
sviluppo della persona.
In caso di condanna al ripristino dell’ambiente a spese del responsabile, appare inapplicabile
l’art. 2058 c.c., dal momento che il risarcimento in forma specifica, coincidente con il ripristino
dello status quo ante, viene autonomamente ordinato dal giudice.
Qualora invece si versi in ipotesi in cui la condotta non ricada in alcuno degli àmbiti normativi
che contemplano il dovere del giudice di ordinare con la sentenza di condanna il ripristino
medesimo, deve ritenersi che il danneggiato nel proprio diritto all’ambiente possa legittimamente
richiedere al giudice di pronunziare il risarcimento in forma specifica, costituito dal ripristino
dell’ambiente naturale, a cura e spese del responsabile. In tale ipotesi, il giudice potrà denegare il
risarcimento in forma specifica esclusivamente ove lo ritenga eccessivamente oneroso per il
debitore rispetto al risarcimento per equivalente.
3. I danni cagionati dalla fauna selvatica.
Legislazione c.c. 2043; 2052 – l. 11.2.1992, n. 157.
La fauna selvatica, consistendo in popolazioni di animali in istato di naturale libertà, può in
talune ipotesi arrecare danni patrimoniali.
L’ipotesi tipica e maggiormente ricorrente di danni cagionati dalla fauna selvatica consiste nel
danno ai terreni ed alle colture, di proprietà di privati, causati dal passaggio o dalla sosta di animali
selvatici sugli stessi. Ricorre inoltre il caso in cui gli animali arrechino danni ai veicoli in transito.
La realtà offre poi altri esempi meno frequenti.
Che si tratti di danni patrimoniali, risarcibili ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del codice
civile non appare revocabile in dubbio, dal momento che il diritto assoluto di proprietà sui terreni e
sulle eventuali colture ha contenuto indiscutibilmente patrimoniale.
45
3.1. I soggetti obbligati al risarcimento.
Legislazione c.c. 2043; 2052 – l. 11.2.1992, n. 157.
Deve pertanto preliminarmente verificarsi l’identità dei soggetti titolari dell’obbligo del
risarcimento, titolari della legittimazione passiva rispetto all’azione di risarcimento del danno.
Poiche' a norma degli artt. 5, 6, e 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 968 le regioni esercitano le
funzioni amministrative in materia di caccia, predispongono piani annuali o pluriennali che prevedano,
tra l'altro, oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione, ed alla sosta della fauna
selvatica, nonche', provvedono alla gestione sociale del territorio, passivamente legittimata rispetto
all'azione di risarcimento dei danni derivanti a terzi dalla violazione delle norme relative alla istituzione
delle oasi di protezione della fauna selvatica, e' la regione, anche se abbia delegato i relativi poteri
alla provincia, in quanto delega non fa venir meno la titolarita' di tali poteri e deve essere esercitata
nell'ambito delle direttive dell'ente delegante.
(Cass. 1.8.1991, n. 8470, MCC, riv. 473354).
La Regione assume dunque anche la titolarità dell’obbligo in quanto effettiva titolare del
potere-dovere di gestione.
Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992
n. 157 affida alle Regioni i poteri di gestione, tutela e controllo di essa. Ne consegue che la Regione, in
quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni
a terzi, e' responsabile ex art. 2043 cod. civ. dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli
in circolazione.
(Cass. 13.12.1999, n. 13956, MCC, riv. 532111).
E’ agevole notare come la Suprema Corte privilegi, rispetto alla proprietà della fauna selvatica
nel suo complesso – che come in precedenza argomentato costituisce bene patrimoniale
indisponibile di proprietà dello Stato –, il profilo concessorio, osservando come una volta delegata
alla Regione la gestione della fauna sia quest’ultima, e non più lo Stato proprietario, a rispondere
dei danni da essa arrecati a terzi.
L’orientamento della Suprema Corte appare istituire una deroga al generale principio che
informa la disciplina degli artt. 2048, 2049, 2054 e 2055 c.c., in virtù del quale dovrebbe ritenersi
che lo Stato, proprietario della fauna, e la Regione, concessionario della gestione, rispondano in
solido dei danni arrecati a terzi dalla fauna medesima, salvo il diritto dello Stato, che abbia pagato o
il cui patrimonio sia stato comunque escusso dal creditore, al regresso nei confronti della Regione
inadempiente.
La questione assume tuttavia scarso rilievo pratico, dal momento che la Regione, al pari dello
Stato, è normalmente un debitore solvibile.
3.2. I privati titolari del potere-dovere di gestione della fauna selvatica.
Legislazione c.c. 2043; 2052 – l. 11.2.1992, n. 157.
46
L’orientamento in parola assume poi rilevanza in relazione a terzi occasionalmente titolari
del potere-dovere di gestione di gruppi di esemplari di fauna selvatica.
In tema di responsabilita' civile, il titolare di un'azienda faunistica venatoria nella regione
Umbria non e' tenuto al risarcimento dei danni causati alle colture in atto all'interno del territorio
dell'azienda dalla presenza di selvaggina - nella specie cinghiali - non immessavi dallo stesso, ma
autonomamente presente sul territorio, essendo il concessionario dell'azienda tenuto, in base al
sistema normativo ricavabile dagli artt. 2, 8, 15 e 25 della legge regionale dell'Umbria 2 luglio 1986 n.
21, a rispondere per i danni arrecati dalla selvaggina oggetto della concessione e non da quella
estranea, giacche' solo sul proliferare della prima egli mantiene specifiche possibilita' di intervento.
(Cass. 28.3.1997, n. 2809, MCC, riv. 503395).
Il titolare dell’azienda faunistico-venatoria, deve intendersi dalla lettura a contrariis del
principio posto dalla giurisprudenza, è invece responsabile dei danni arrecati a terzi dalla fauna
oggetto della concessione.
Anche in tal caso, pertanto, la soluzione privilegiata dalla Suprema Corte non è già quella
della solidarietà passiva, ma bensì della responsabilità esclusiva del titolare dell’azienda faunistica
per la fauna concessagli in gestione.
Il concetto, che costituisce il fil rouge che pervade l’orientamento giurisprudenziale in
discorso, secondo il quale la responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica grava sul
soggetto che ne sia il formale gestore, ha posto il dubbio circa la norma applicabile al risarcimento
del danno, dal momento che l’art. 2052 c.c. prevede la responsabilità del proprietario o dell’usuario
dell’animale per i danni da questo cagionati, anche in caso di smarrimento o fuga di esso, salvo il
caso fortuito.
La giurisprudenza ha negato la condivisibilità di una simile ricostruzione.
Il danno cagionato dalla fauna selvatica, che ai sensi della legge 27
dicembre 1977 n. 968
appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, non e' risarcibile in base alla
presunzione stabilita nell'art. 2052 cod. civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici,
ma solamente alla stregua
dei principi generali della responsabilita' extracontrattuale di cui
all'art. 2043 cod. civ., anche in tema di onere della prova.
(Cass. 15.3.1996, n. 2192, MCC, riv. 496375).
Il fulcro della questione risiede nella oggettiva materiale impossibilità per il proprietario della
fauna selvatica di gestirla e controllarla alla stregua di un animale in custodia.
Il danno cagionato dalla fauna selvatica, che ai sensi della legge 27 dicembre 1977 n. 968 appartiene
alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, non e' risarcibile in base alla presunzione
stabilita nell'art. 2052 cod. civ., inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di liberta' e'
incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma
solamente alla stregua dei principi generali della responsabilita' extracontrattuale di cui all'art. 2043
cod. civ., anche in tema di onere della prova.
(Cass. 14.2.2000, n. 1638, MCC, riv. 533850).
47
La Suprema Corte ha ancora una volta eseguito un distinguo nei confronti della pubblica
amministrazione rispetto alle generali categorie giuridiche che presiedono al risarcimento dei danni,
osservando come, per il peculiare stato di libertà che contraddistingue per definizione la fauna
selvatica, nessun obbligo di custodia può ritenersi sussistente a carico della pubblica
amministrazione, sicchè non trova applicazione la disciplina di cui all’art. 2052 c.c.
La pubblica amministrazione, in tale materia, ha una posizione di fatto singolare.
Il proprietario pubblico della fauna selvatica non risponde dei danni da essa arrecati in solido
con il gestore. Il gestore-concessionario pubblico, a sua volta, non risponde in solido con colui al
quale abbia affidato la gestione di alcuni gruppi o categorie di esemplari. Tutti questi soggetti,
comunque, non rispondono ai sensi della generali disciplina del danno cagionato da animali dal
momento che, pur essendone rispettivamente proprietari e gestori, non ne hanno l’obbligo di
custodia.
E’ evidente che l’orientamento giurisprudenziale si spiega avendo riguardo alla necessità di
tutelare la fauna selvatica – ascrivendone la proprietà allo Stato e la gestione alla Regione e,
quatenus opus, agli altri enti territoriali – senza per ciò determinare, per converso, l’insorgere di
conseguenze eccessivamente negative nei confronti della pubblica amministrazione proprietaria e
addetta alla gestione della fauna medesima. Vero è, d’altronde, che in concreto la naturale libertà
che deve contraddistinguere la fauna selvatica è concettualmente incompatibile con l’obbligo di
custodirne gli esemplari, sicchè appare condivisibile la responsabilità patrimoniale correlata al mero
obbligo di buona gestione della fauna nel suo complesso da parte del soggetto, pubblico o privato,
che di tale obbligo sia formalmente investito.
Si è poi lungamente dibattuto in giurisprudenza circa la natura di diritto o di interesse
legittimo della posizione soggettiva del titolare del fondo danneggiato dalla fauna selvatica.
Nella disciplina dei Parchi nazionali (nella specie, quella del Parco d'Abruzzo, di cui alla legge n.
1511 del 1923 ed al relativo regolamento di cui al Regio Decreto n. 2124 del 1923, estesa al Parco
dei Monti Sibillini con legge n. 67 del 1988), avente, tra l'altro, la funzione di migliorare e tutelare la
fauna, costituendo il territorio dei parchi a riserva di caccia e di pesca, la posizione del
proprietario di un fondo incluso in detto territorio, per i danni che riceva dal moltiplicarsi degli animali
selvatici non suscettibili di abbattimento, non ha natura di diritto soggettivo e non e', quindi, tutelabile
con azione risarcitoria davanti al giudice ordinario, con la conseguenza che le controversie aventi ad
oggetto
la compensabilita' (non risarcibilita') dell'indicato pregiudizio
rientrano
nella
giurisdizione del giudice amministrativo.
(Cass. SS.UU. 23.11.1995, n. 12106, MCC, riv. 494770).
Diversa impostazione ermeneutica ha seguito altra giurisprudenza.
La qualificazione come diritto soggettivo o interesse legittimo delle posizioni giuridiche
configurabili a favore degli interessati relativamente ai ristori conseguibili per i pregiudizi arrecati
dalla fauna selvatica alle colture agricole non e' automaticamente correlata alla ubicazione - all'esterno
o all'interno delle zone di protezione - dei fondi danneggiati, e deve invece attribuirsi essenziale
rilievo al concreto atteggiarsi della disciplina positiva. In applicazione di tale criterio, deve
riconoscersi la natura di diritto soggettivo - comportante la giurisdizione del giudice ordinario - alla
48
pretesa al risarcimento dei danni provocati alle coltivazioni dalla fauna selvatica nell'ambito del
Parco lombardo della Valle del Ticino, fondata sull'art. 15 della "legge - quadro" sulle aree protette n.
394 del 1991, che prevede, senza margini
di
discrezionalita',
l'obbligo dell'ente parco di
indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco nel termine di novanta giorni dal loro
verificarsi; ne' portata diversa e' attribuibile all'art. 22, comma sesto, della legge regionale della
Lombardia n. 33 del 1980 (norme di attuazione del piano territoriale di coordinamento del parco
del Ticino), che, nel disciplinare l'aspetto di finanza pubblica (prevedendo finanziamenti regionali),
ribadisce l'obbligo del Consorzio di risarcire i danni arrecati dalla selvaggina alle colture all'interno
della fascia di silenzio venatorio.
(Cass. SS.UU. 30.12.1998, n. 12901, MCC, riv. 521975).
Così pure si è ritenuto in materia di indennizzo concesso da leggi regionali.
L'art. 5, primo comma, della legge regionale del Piemonte 24 Aprile 1985, n. 46, novellando l'art. 6
della precedente legge regionale 4 Giugno 1975, n. 43 - il quale prevedeva che le leggi istitutive dei
parchi e delle riserve naturali avrebbero fissato "la misura e le modalita' degli indennizzi ai
proprietari delle aree soggette a vincolo" - ha lasciato alle predette leggi solo la disciplina del
procedimento amministrativo di liquidazione delle indennita' , ed ha individuato direttamente il
parametro di tale liquidazione, per tutti i vincoli imposti, nel ristoro dell'effettivo danno subito. Ne
consegue che il diritto soggettivo dei proprietari dei terreni inclusi nella riserva, all'indennizzo e',
alla stregua della nuova disciplina, immediatamente azionabile (a differenza che nel regime previgente,
nel cui vigore esso era condizionato alla determinazione dei parametri di ristoro), restando solamente
da accertare se, per effetto dei predetti vincoli, il fondo incluso, con riguardo alle utilita' da esso
ritratte o ragionevolmente ritrattabili, abbia effettivamente subito un decremento del valore venale
che aveva precedentemente alla inclusione nella riserva, e di quale entita'.
(Cass. SS.UU. 7.4.1999, n. 3346, MCC, riv. 525001).
Ma anche tale orientamento è suscettibile di diverse letture.
In applicazione della legge Regione Puglia 15 giugno 1994, n. 20, attuativa della legge statale 11
febbraio 1992, n. 157, e dell'art. 49 legge Regione Puglia 27 febbraio 1984 (richiamato dalla legge n. 20
del 1994) - il quale tra l'altro dispone che ciascuna provincia istituisce un fondo al fine di indennizzare
i conduttori di aziende agricole che ne facciano richiesta documentata, e che il consiglio regionale
regolamenta l'utilizzazione ed il funzionamento dei fondi stessi -, le erogazioni in favore dei
proprietari dei fondi danneggiati dalla fauna selvatica costituiscono "indennizzo" e non "risarcimento
del danno". Pertanto la posizione del proprietario che fa valere l'esistenza di un danno ha consistenza
di interesse legittimo, con la conseguente giurisdizione sulla controversia del giudice amministrativo.
(Cass. SS.UU. 10.8.2000, n. 559, MCC, riv. 539389).
Indipendentemente dalla individuazione della maggiore o minore condivisibilità dell’uno o
dell’altro orientamento (il fatto che il regolamento di giurisdizione sia rimesso per legge alle
Sezioni Unite della Suprema Corte determina la conseguenza per cui tutte le sentenze che si
occupano della qualificazione della posizione soggetti azionata in giudizio come diritto soggettivo
od interesse legittimo sono tutte pronunziate dalle Sezioni Unite, di guisa che è complesso
individuare un criterio di prevalenza, se non ricorrendo alla maggiore frequenza e prossimità
cronologica dell’uno o dell’altro orientamento), la questione dovrebbe ritenersi superata dalla
pronunzia, nel 1999, della sentenza n. 500 delle Sezioni Unite della Suprema Corte.
La normativa sulla responsabilita' aquiliana ex art. 2043 cod. civ. ha la funzione di consentire il
risarcimento del danno ingiusto, intendendosi come tale il danno arrecato "non iure", il danno, cioe',
inferto in assenza di una causa giustificativa, che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per
l'ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale, ed, in particolare, senza che assuma
rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo. Peraltro, avuto riguardo al carattere
atipico del fatto illecito delineato dall'art. 2043 cod. civ., non e' possibile individuare in via
preventiva gli interessi meritevoli di tutela: spetta, pertanto, al giudice, attraverso un giudizio di
49
comparazione tra gli interessi in conflitto, accertare se, e con quale
intensita',
l'ordinamento
appresta tutela risarcitoria all'interesse
del danneggiato, ovvero comunque lo prende in
considerazione sotto altri profili, manifestando, in tal modo, una esigenza di protezione. Ne consegue
che anche la lesione di un interesse legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro
interesse giuridicamente rilevante, puo' essere fonte di responsabilita' aquiliana, e, quindi, dar luogo
a risarcimento del danno ingiusto, a condizione che risulti danneggiato, per effetto dell'attivita'
illegittima della P.A., l'interesse al bene della vita al quale il primo si correla, e che detto interesse
risulti meritevole di tutela alla stregua del diritto positivo.
(Cass. SS.UU. 22.7.1999, n. 500, MCC, riv. 530553).
La Suprema Corte ha pertanto precisato, in una sentenza che coscientemente e
deliberatamente (come leggesi nella motivazione, non pedissequamente qui trascrivibile) opera una
vera e propria rivoluzione copernicana rispetto al precedente orientamento delle Sezioni Unite, che
nel moderno assetto della disciplina del risarcimento del danno, laddove il riparto di giurisdizione
tra il giudice ordinario ed il giudice amministrativo non è più fondato sulla tipologia della posizione
giuridica soggettiva attivata, ma sulla materia del contendere, non può più trovare cittadinanza
alcun dubbio circa la risarcibilità dell’interesse legittimo o di altro interesse non qualificabile come
diritto soggettivo ma ciononostante riconosciuto come rilevante e tutelato dall’ordinamento.
La Suprema Corte ha dunque statuito, con motivazione tanto più apprezzabile e convincente
in quanto articolata e congrua rispetto ai motivi del mutamento di orientamento in relazione alle
diffuse argomentazioni della dottrina ed alla situazione di fatto della legislazione in materia di
risarcimento delle varie tipologie di anno offerte dall’esame della realtà e tutelate dall’ordinamento,
che la lesione di qualsivoglia interesse, purchè riconosciuto e tutelato dall’ordinamento –
circostanza in ordine alla quale il giudice ha il dovere di eseguire approfondita e puntuale indagine
caso per caso –, è suscettibile di dare luogo ad un danno ingiusto, in quanto non iure, contrario al
diritto oggettivo, indipendentemente dalla qualificazione soggettiva che la posizione soggettiva
violata dalla condotta dannosa assuma.
In tale ottica, perde significato il dibattito circa la natura di diritto soggettivo od interesse
legittimo dell’interesse del proprietario del fondo danneggiato dalla fauna selvatica ad ottenere il
risarcimento del danno.
Altra e diversa questione, naturalmente, si pone nel caso in cui il proprietario del fondo agisca
non già per ottenere il risarcimento del danno, ma bensì per richiedere un indennizzo previsto dalla
legge, nel qual caso è di tutta evidenza che l’azione non va qualificata come azione di risarcimento
danni ma come domanda rivolta alla pubblica amministrazione per il riconoscimento di un
emolumento previsto per legge, nel qual caso si verte senz’altro in tema di interesse legittimo, ma
non di lesione dell’interesse legittimo medesimo, di guisa che la vicenda è del tutto estranea alla
materia del risarcimento del danno.
50
In relazione alla quantificazione del danno cagionato dalla fauna selvatica, sono applicabili
ordinariamente le norme che presiedono alla disciplina civilistica del risarcimento del danno.
51