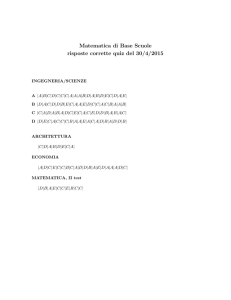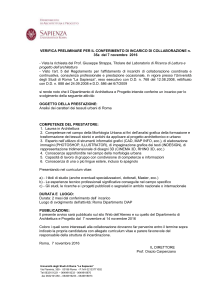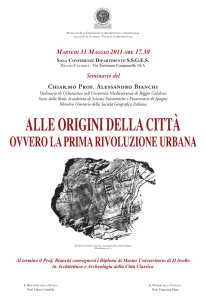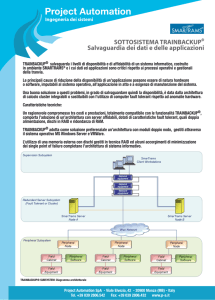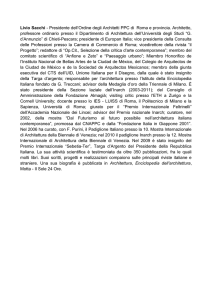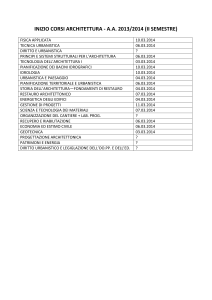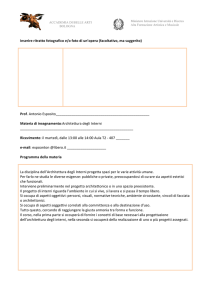EDITORIALE
Una rivista allestita da un Dottorato non può non essere, anche nella propria organizzazione, del tutto
sperimentale. Oltretutto, appena al secondo numero, sia la struttura grafica che i contenuti, appaiono essere
necessariamente ancora ad uno stato grezzo. Ciò è in parte voluto. Nel senso che, pensata con una cadenza
trimestrale, a metà tra i tempi dell’attualità e quelli più lunghi, meditativi, del saggio breve, la rivista, anche per
aprirsi ai contributi esterni, dispone alternativamente i numeri su un argomento monografico ovvero sull’assoluta
libertà dei temi, nell’intenzione di sfuggire sia il tono paludato dell’accademia che quello più superficiale della
cronaca . Il primo numero era così dedicato all’architettura italiana, mentre in questo sono pubblicati gli scritti
liberamente redatti. Se il primo numero rivelava l’ingenuità delle letture, quindi, il secondo può apparire
estemporaneo, con giudizi contradditori tra i diversi testi, ripetizioni, vocazioni teoriche contratte. E’ sperabile
che i pochi lettori siano benevoli. Il nostro sforzo è nell’allestire un luogo di confronto libero cui il lettore
medesimo possa partecipare. Naturalmente ce la metteremo tutta per migliorare e per offrire un prodotto sempre
più definito.
la redazione
I CRISTALLI DI GIO PONTI E IL JUNKSPACE DI KOOLHAAS
Rosario Di Petta
Nel multiforme panorama internazionale che segna le complesse vicende dell’architettura contemporanea è sin
troppo agevole notare come, sempre più spesso, si stiano perdendo dei riferimenti importanti per la messa a punto
di opere che, a ragione, possano iscriversi nell’alveo della difficile arte architettonica; e come l’ansietà della
novità ad ogni costo e l’ostentazione di vuote complicazioni formali e tecnologiche troppo spesso abbiano preso il
posto della riflessione e della capacità di ascolto, prerogative ineludibili per chi è preposto alla creazione degli
spazi in cui trovano significato le vicende umane.
Tra quei libri che abbracciano la profondità delle tematiche della composizione architettonica uno dei più intensi,
affascinanti e sempre utili resta sicuramente quello pubblicato da Gio Ponti nel lontano 1957 dal titolo più che
mai significativo “Amate l’architettura”. Nella premessa l’autore precisa che il libro avrebbe potuto avere anche
altri titoli, ovvero “Perorazione sull’architettura”, “Ideario d’architettura”, “Amate gli architetti”, ed infine
“L’architettura è un cristallo”. La metafora del cristallo serviva evidentemente ad esprimere un ideale di
essenzialità, purezza, ordine, perennità, silenzio, <<di forme chiuse, dove tutto fosse consumato nel rigore dei
volumi e d’un pensiero>>. Riflettendo sulle architetture di ogni tempo, dai recinti ipostili degli egizi fino a
giungere alla Crown Hall di Mies, è facile verificare quanta corrispondenza vi sia tra le architetture e le parole di
Ponti.
Per tutti noi è altresì evidente come l’architettura in ogni epoca debba porsi il non facile obiettivo di un
superamento di molte convenzioni oramai consolidate ed evitare così facili cristallizzazioni dell'ambito
disciplinare. In fondo,è stata proprio questa la principale battaglia culturale combattuta con veemenza da Bruno
Zevi. Questo difficile sforzo verso cui sono protesi da sempre i migliori architetti non può tuttavia trasformarsi in
una sin troppo comoda scorciatoia tendente ad annullare un patrimonio di conquiste formali che dovrebbero,
invece, essere la base da cui partire per poter giungere a formulazioni senz'altro nuove, ma al contempo cariche di
quella sapienza compositiva emanata da chi ci ha preceduto nell’atto del comporre, e dalla quale inevitabilmente
siamo partiti, dal momento che, anche in architettura, niente proviene dal nulla.
Detto ciò, stupisce non poco la posizione assunta da Rem Koolhaas a proposito dell’architettura del XX secolo. In
un suo recente saggio l’architetto olandese, con il cinismo che puntualmente contraddistingue i suoi enunciati,
sostiene addirittura che l’obsolescenza dei modelli architettonici del Novecento produce Junkspace, ovvero
spazio spazzatura: <<Secondo un nuovo Vangelo della bruttezza, c’è già molto più Junkspace in costruzione nel
XXI secolo di quanto ne sia sopravvissuto dal XX… Inventare l’architettura moderna, nel XX secolo, è stato un
errore. Nel XX secolo l’architettura è scomparsa; abbiamo speso il nostro tempo a leggere al microscopio una
nota a piè di pagina sperando che si trasformasse in un romanzo; la nostra preoccupazione per le masse ci ha reso
ciechi all’Architettura della Gente. Il Junkspace sembra un’aberrazione, ma è l’essenza, ciò che conta…>>. La
riflessione dell'autore, come nota Massimo Ilardi, è inchiodata agli anni Novanta del Novecento e da lì non si
muove. Quindi Junkspace non è un libro sul presente, perché si ferma a quella coincidenza tra spazio socialmente
percepito come significativo e superficie dell'intero mondo e che era al centro del primo passaggio della
rivoluzione prodotta dal mercato, ma che oggi non basta per spiegare la complessità dei rapporti che si sono man
mano stabiliti tra spazio e soggettività sociali.
Tra le prese di posizione ideologiche dell’architetto olandese troviamo anche quella relativa alla Bigness, ovvero
all’architettura estrema. Koolhaas sostiene, con una serie di esempi adatti ad avvalorare le sue tesi, che quando un
edificio supera una certa massa critica non può essere controllato da un solo gesto architettonico, e quindi tale
impossibilità annulla e svuota il repertorio classico dell’architettura. In definitiva, l’arte dell’architettura diventa
inutile nella Bigness. L’errore koolhaasiano sta nell’aver dimenticato paradossalmente che proprio perché la
priorità del dato visivo è innegabile, nessun segno che troviamo nel paesaggio urbano può essere definito
insignificante, perché esprime sempre qualcosa dell’uomo. E’ indispensabile, pertanto, considerare sempre il
nostro lavoro di architetti come lavoro sugli insiemi ambientali a tutte le scale dimensionali. Del resto, Vittorio
Gregotti fa notare come <<…una parte importante dell’architettura dei nostri anni si muove nello sforzo di
rappresentare (più o meno consciamente) nel modo più coerente lo stato di presa del potere della globalizzazione.
E ciò può essere fatto ovviamente con diversi livelli di qualità…,esaltandone i principi di omogeneità dei
comportamenti e di delocalizzazione globale (Koolhaas)>>.
Vale la pena, a questo punto, di ricordare gli esordi di Koolhaas, i suoi riferimenti presi in prestito dai “Radical”,
ma spesso interpretati in maniera approssimativa; se il gruppo fiorentino degli anni Settanta sognava l’utopia
silenziosa di un mondo senza oggetti, soprattutto sulla scorta del Situazionismo di Constant e di Debord,
l’architetto olandese sembra rovesciare tutto ciò, prefigurando un mondo in cui contano solo le merci griffate
delle èlite dominanti. A tal proposito, Francois Burkhardt nel suo intervento a X Media Conference del 2002 ha
parlato di Rem Koolhaas come di un abile stratega del consumismo subliminale.
Anche Franco Purini si domanda perché <<…l’unica voce legittimata a parlare della città contemporanea (sia)
Rem Koolhaas, alla cui architettura intenzionale si rivolgono anche in Italia molte scuole, prima fra tutte quella
pescarese. L’architetto olandese accetta per un verso le logiche del mercato teorizzando nello shopping l’unica
autentica azione urbana; per l’altro accenna a potenziali eversioni linguistiche di questo stesso universo del
consumo, eversioni che rimangono comunque ampiamente inespresse>>. E’ altresì evidente, a tal riguardo, come
la qualità architettonica delle opere di Koolhaas, a dispetto delle tante prese di posizione teoriche, non sempre
raggiunga risultati eccellenti. Già dalla stesura di S,M,L,XL (descritto come un romanzo sull’architettura, il libro
combina fotografie, piani, narrativa, vignette, composizioni e pensieri casuali con il lavoro prodotto per l’OMA)
l’architetto olandese si interroga sui fenomeni legati allo sviluppo globale delle società occidentali, e sui
conseguenti effetti che questi finiscono con l’avere sulla condizione urbana del pianeta. Egli stesso si traveste,
quindi, da reporter e scatta dall’automobile una sequenza di fotografie sfocate di un anonimo paesaggio urbano a
Singapore, a cui fa seguire il testo della Città Generica. Una città in cui, a sua detta, è possibile un’unica attività:
quella dello shopping, e il cui ideale è quello della densità nell’isolamento.
Nel suo bel libro, dal tagliente titolo “Contro l'architettura”, Franco La Cecla si chiede il perchè a Rem Koolhaas
venga consentito di mettere le mani su una cosa seria come la città, visto che egli dimostra di più una conoscenza
da aeroporti e jet-set. In fondo, dice l’architetto antropologo, che ne sa lui delle città e di come la gente ci vive e
dà significato ai propri spazi, se per l'archistar le città sono un prodotto? In altri termini, per l’architetto olandese
la forza dell’economia può annientare qualsiasi contenuto architettonico – “business can invade any
architecture”- fino a condizionare qualsiasi scelta abitativa ed in definitiva il destino delle nostre città.
E’ del tutto evidente come tali riflessioni contengano un fondamento di verità, ma è altresì palese che in tale resa
al reale Koolhaas riesce ad annullare in un colpo mortale quella carica utopica, ideale, sulla cui base l’architettura
di ogni epoca ha potuto compiere qualche progresso, sempre contro le costrizioni della realtà e del presente.
Quello che più stupisce è vedere come le posizioni teoriche dell’architetto olandese trovino grande seguito anche
in Italia, soprattutto presso la generazione più giovane di progettisti, sempre più frequentemente protesa verso
modelli figurativi tipici dell’architettura olandese contemporanea. Un’architettura ‘alla moda’ che sembra non
ricercare un proprio ‘modo’ di affrontare e trovare soluzione al problema del progetto architettonico e che, cosa
ancor più grave, non coltiva più alcun atteggiamento di distanza critica dal reale.
COME INTERPRETARE UNA LEZIONE SUL TEMPO
Andrea Carbonara
In un interessante scritto Pierre Alain Croset inquadra la lezione di un architetto come Rafael Moneo
sull’importanza di perseguire un’architettura della “durata”, all’interno di una visione complessiva della realtà
contemporanea, che si fonda sull’impossibilità di interpretare il tempo in riferimento ad un modello di sviluppo
lineare. Introduce, in relazione a ciò, il pensiero formulato dallo scrittore tedesco Hans Magnus Enzensberger
sulla necessità di dover accettare, come conseguenza inevitabile della velocità con la quale i cambiamenti e le
novità si susseguono nella realtà attuale, la produzione diffusa di condizioni di anacronismo culturale, di spazi di
non contemporaneità nei quali si vengono a trovare gruppi di individui progressivamente più estesi. Cioè la
rapidità con cui si manifestano le trasformazioni produce scarti, di volta, in volta più ampi, tra coloro che sono
nella posizione opportuna per poter partecipare ed essere coinvolti in esse, ed «una schiera sempre più folta di
ritardatari» (Hans Magnus Enzensberger) che rimane a quelle stesse trasformazioni completamente estranea.
Questa compresenza di strati culturali differentemente ‘sincronizzati’, nei quali la società si articola, rende tanto
più incomprensibile agli occhi di Enzensberger e - sembra suggerire Croset – anche a quelli di Moneo,
quell’ossessiva ricerca del “nuovo” che viene continuamente praticata da molti – non ultimi gli architetti –
nell’ambito del proprio specifico campo di attività. Una ricerca sempre meno giustificabile - nelle sue premesse
quanto nelle finalità - perché tutta volta al soddisfacimento di attese riferibili a “strati” della società molto
limitati; in grado di produrre, dunque, fenomeni di esclusione piuttosto che l’effettivo ed ampio coinvolgimento
della società in un processo di rinnovamento reale e condiviso.
Enzensberger interpreta in questo modo la realtà contemporanea alla luce di una concezione generale secondo la
quale è possibile rappresentare il tempo attraverso un modello matematico detto della “pasta sfoglia”; secondo il
quale quei modi di vita, identificabili di volta in volta come manifestazione più concreta di un “presente ultimo”,
non rappresentano altro che un sottile strato che emerge in superficie trai tanti che sono ad esso compresenti.
Strati, questi ultimi, che divengono espressione di altrettante posizioni di anacronismo culturale solo se si
pretende di identificare quanto di “nuovo” appare e viene prodotto ad un ritmo incessante e sempre più frenetico,
come ciò che è in grado di fornire una rappresentazione - nella realtà distorta e falsante - di una contemporaneità
che, come detto, si presenta molto più complessa.
Pierre Alain Croset sembra trovare in questa prospettiva la possibilità di interpretare alcuni aspetti della strategia
di Rafael Moneo - ma il discorso potrebbe essere allargato ad altre figure del panorama architettonico
internazionale – riferibili a quella predisposizione dell’architetto spagnolo ad includere nel progetto elementi
eterogenei; una predisposizione che si traduce in un sostanziale rifiuto di distinguere, nelle condizioni descritte,
ciò che appartiene definitivamente al passato, e che quindi deve essere consegnato alla storia, da ciò che invece si
presume debba avere cittadinanza all’interno della disciplina perché accompagnato da una specie di ‘marchio’
che ne garantisca della sufficiente modernità.
Certamente l’uso della memoria come strumento, come materiale di progetto, elemento caratterizzante il modo
di operare di un architetto come Moneo – la sua capacità di interpretare il passato per scoprire quanto spazio ci
sia ancora per esso nel presente e nel futuro - trova una sua ragione fondamentale nella necessità di tenere conto
del complesso sistema di forze inerziali e propulsive che interessa un ambito come quello dell’architettura, e nella
volontà di confrontarsi con tale sistema senza chiudersi in questioni legate al linguaggio; di evitare cioè il
perpetuarsi della riproduzione di scarti sempre più ampi rispetto alle «finalità abitative dell’architettura, che si
presentano per necessità come inerziali in quanto incorporano categorie a lentissima trasformazione» (F. Purini).
Ciò che appare evidente, però, è che, se da un lato la prospettiva offerta da Croset fornisce una interpretazione
plausibile dell’orientamento di Moneo, dall’altro, alcune considerazioni fanno ritenere che il modello stratificato
di società sulla quale essa, riprendendo le riflessioni di Enzensberger, si fonda, sia messo in discussione da alcune
evidenze desumibili dalla realtà a noi più prossima, almeno con riferimento al campo più propriamente
architettonico. Bisogna, infatti, osservare che quanto viene prodotto di “nuovo” in architettura - anche e
soprattutto attraverso l’innovazione dei mezzi di produzione e di comunicazione - non solo convive – come
ovvio che sia se si pensa alla produzione artistica nella storia delle nostre civiltà – con quello che viene tenuto in
vita del passato; ma di tale convivenza parallela appare difficile rintracciare le ragioni culturali, sociali etc. che
possono essere messe in relazione all’emergere - in determinati contesti - di un linguaggio del nuovo o, invece in altri - di un linguaggio volto al recupero di elementi riconducibili alla tradizione. Cioè a differenza di quanto
sostiene Enzensberger in rapporto a considerazioni di respiro più generale, in un ambito come quello
dell’architettura, sempre più connesso a quello della moda, la compresenza di elementi di permanenza e di
cambiamento non sembra collegabile ad una articolazione del tessuto sociale in strati rappresentativi – per così
dire - di posizioni culturali più o meno permeabili alle trasformazione. Sembra altresì motivato da un
generalizzato livello di omogeneità culturale all’interno del quale opera, come forza unificante, una
predisposizione ad includere e ad assorbire tutta la produzione architettonica contemporanea con un ‘sentimento’
– per così dire - di sostanziale indifferenza rispetto al segno, qualunque esso sia, che essa può assumere. La
ragione di tale ‘indifferente disponibilità’ probabilmente si esplicita con maggiore evidenza nel paradosso,
continuamente verificabile, secondo cui quanto più l’architettura diviene oggetto dell’interesse mediatico, tanto
più sembra perdere rilevanza nel mondo reale.
Non è il caso di soffermarci sulle ragioni di ciò: fiumi di inchiostro sono stati impiegati per determinare le cause
e profetizzare gli effetti di questo impoverimento del ruolo cui l’architettura - intesa come entità che
materialmente definisce un modo di vivere, utilizzare e percepire lo spazio fisico - sembra destinata, nella società
contemporanea. Non si può però non osservare che anche il tentativo di architetti come Moneo di rileggere in
modo problematico il patrimonio - appartenente ad un passato più o meno lontano - che l’architettura mette a
disposizione, come strumento la cui interpretazione è utile a cogliere temi sostanziali che si ripropongono, anche
se in forme diverse, nella contemporaneità; corre il rischio di essere vanificato di fronte ad una tendenza
fortemente pervasiva a ridurre l’architettura ad una delle tante manifestazioni immediatamente consumabili
attraverso la loro immagine. Come i vestiti, come le acconciature.
Peter Eisenman in un recente articolo su Casabella parla della produzione architettonica contemporanea come
produzione di icone la cui immediata comprensibilità non rimanda che al processo informatico che sta alla base
della loro costruzione. Parla di tali icone come i nuovi duck di venturiana memoria, senza però che l’immagine
rimandi alla funzione alla quale l’edificio (Eisenman riporta l’esempio del chiosco per la vendita degli hot-dog) è
destinato. Icone, in qualche modo, vuote; interessanti solo per la loro capacità di registrare i procedimenti più o
meno originali che stanno alla base della loro forma, ma di «scarso significato e dai limitati riferimenti culturali»
(Peter Eisenman). Ad esse sono affiancabili altre icone, consumabili con altrettanta immediatezza, in grado di
rimandare ad un passato spogliato dei propri contenuti, ridotto a caricatura.
Tuttavia, il segno che tale tendenza stia prevalendo - come accennato - non è rintracciabile tanto nella
caratterizzazione iconica di queste architetture, ma soprattutto nella disponibilità delle persone, degli stessi
architetti, ad accettare senza il minimo problema, che una accanto all’altra possano ‘convivere pacificamente’
opere tra loro diversissime. E che questo possa accadere in ragione del fatto che tanto diverse tra loro esse
appaiono, quanto più simili in realtà sono nella premessa concettuale dalla quale, in definitiva, muovono: quella
secondo cui l’architettura deve limitarsi ad essere la traduzione letterale ed esplicita di un’idea o di un
procedimento; e che tale traduzione debba avvenire nel modo più facile e meno mediato possibile. Si tratta di un
fenomeno simile a quello riprodotto quotidianamente nei palinsesti - dotati di una certa fortuna mediatica - che i
canali televisivi tematici (che trattano di architettura(?) e di design(?)) propongono; nei quali vengono
indifferentemente veicolate immagini di architetture “extra-contemporanee”, insieme ad altre immagini di
consolatorie ambientazioni, prodotto, più o meno simulato, di epoche e scenari passati. Il tutto ridotto, ad opera di
sorridenti conduttori, agli aspetti, dell’una o dell’altra ‘tendenza’, più agevolmente consumabili.
Credo si possa concludere dicendo che la profondità della lezione di architetti come Moneo, ma pur con le
evidenti differenze, di una personalità come Eisenman, tesa giustamente a reclamare una condizione di autonomia
dell’architettura rispetto alle esigenze immediate di consumo della sua immagine, debba inevitabilmente essere
individuata nel tentativo di collegare il fare architettura a contenuti più complessi e stabili rispetto ai quali trovare
il senso del proprio operare. Un operare che certamente rimane inevitabilmente un fare artistico, ma che deve
ammettere la necessità, se vuole conservare la ragione della propria esistenza, di includere trai materiali rispetto
ai quali definire la forma, contenuti più profondi di quelli immediatamente collegabili alla ricerca delle
potenzialità iconiche che l’edificio deve possedere: contenuti, cioè che non andrebbero definiti con troppo
anticipo e con atteggiamento troppo poco critico, perché legati al tema, al luogo e al tempo in riferimento ai quali
il progetto dovrebbe pazientemente ricercare la propria identità formale..
LE CASE DIETRO AGLI ALBERI
Gianluigi Freda
Percorrendo la recente storia della critica d’architettura s’incrociano infinite rivoluzioni, annunciate affinché risaltassero quegli spostamenti di prospettiva, rispetto ai linguaggi, alle tecniche, alla poetica, che disegnano il
tempio di un’architettura imprescindibile, inattaccabile.
È il nostro universo teorico di riferimento in cui vaghiamo disorientati; chi poi, innamorato del proprio istinto di
critico d’avanguardia, ne cerca altri, di riferimenti, ci costringe a rassegnarci anche di fronte a questi ultimi, come
se quasi non potessimo lottare contro le tendenze che ci costruiscono sopra la testa.
A guardare lontano, però, non ci si guarda intorno e la critica ignora una architettura che scorre sottotraccia senza clamori, ma che fa grandi cose: costruisce case, edifici pubblici, città; i luoghi della vita.
Accade in ogni parte del mondo, continuamente.
È accaduto in Israele, con l’opera di un architetto vero: Zvi Melzer la cui storia professionale ed umana
s’incrocia con quella di uno dei più importanti architetti israeliani - e non solo- del novecento, Dov Carmi.
Melzer presto s’innamora del mestiere dell’architetto e giovanissimo, dopo il liceo, viene introdotto nello studio
di Dov Carmi, a Tel Aviv, per imparare l’architettura, nell’esercizio concreto del progetto, prima ancora di dedicarsi agli studi universitari.
Il lungo apprendistato professionale ed umano, accanto a Carmi, gli basterà tanto da indurlo a rinunciare agli studi universitari: il titolo di architetto gli verrà poi riconosciuto per i suoi meriti professionali, per le opere costruite…
Tel Aviv era, negli anni ’30 e ‘40, il cantiere degli ideali architettonici del novecento e degli ideali politici e sociali che sottendevano al nascente Stato d’Israele. Il fervore e lo spirito modernista che pervadeva la città si conciliava sorprendentemente con la laboriosa dignità con cui gli architetti compivano il loro mestiere concorrendo
ad un ideale collettivo. Melzer lavora accanto a Carmi, raccogliendone quella sua raffinata cifra personale, anche
lontana dal diffuso spirito bauhaus della Tel Aviv di quegli anni.
La sua esperienza professionale approda alla formazione dello studio Carmi-Melzer-Carmi, con Dov ed il figlio
Ram. È lo studio che firma decine di progetti a Tel Aviv e non solo, che si occupa di edifici residenziali e di
grandi edifici pubblici, che vince nel 1961, il concorso per il Parlamento della Sierra Leone. Da solo, Melzer, parte per l’Africa con i rotoli dei disegni sotto il braccio per dirigere i lavori che porteranno, in meno di un anno, alla
costruzione del Parlamento a Freetown. Lì, poi, apprenderà la notizia della scomparsa di Dov Carmi, perdendo,
come lui stesso racconta, non solo un maestro ma anche un padre.
Sono piani che non si possono separare, quello umano e quello professionale: la biografia e l’opera sono entrambi elementi indispensabili all’indagine critica. Melzer racconta che, ad ogni nuovo progetto, partiva con Carmi per andare nel mondo a studiare le opere che potevano aiutarli ad affrontare al meglio la progettazione, concentrandosi soprattutto sugli aspetti funzionali. Di ritorno da uno di questi viaggi, Carmi decise che il suo studio
doveva diventare una famiglia, senza capi o patriarchi, probabilmente impressionato dalla infruttuosa tendenza
europea a gerarchizzare le dinamiche, convinto che tale tendenza non potesse che nuocere all’architettura stessa.
Melzer si forma dunque all’insegna di questo spirito, la sua architettura ed il suo atteggiamento progettuale ne restano definitivamente permeati.
L’architettura di Melzer si concentra sulla soluzione del problema, sull’equilibrio della forma e della struttura:
non ci sono verità nascoste, ogni elemento rappresenta se stesso ed esiste in quanto necessario all’obiettivo unico
dell’edificio di funzionare, inseguendo sì un preciso ideale estetico, ma che da questo non si lascia mai incantare.
Il disegno si ferma di fronte all’inconciliabilità con il problema ed ha il coraggio di fare un passo indietro, se necessario.
I temi di cui si fanno carico i suoi progetti sono, dunque, proprio le soluzioni ai quesiti che pone il progetto, al di
là di dogmi e retoriche. Nell’edificio per abitazioni in via Arlozorov, a Tel Aviv, il tema è il rapporto con la strada, la ventilazione dell’edificio per via delle alte temperature ed il modo con cui questo aspetto possa conciliarsi
con la distribuzione interna tra zona giorno e zona notte.
L’edificio è disposto lungo l’asse nord-sud e si compone di due blocchi: uno sul fronte strada che ospita i living
esposto ad ovest, l’altro ad est con la zona notte ed i servizi
I due ambiti insistono a quote diverse con un funzionamento simile ad un duplex, ma la scala che li collega è al
centro dei due blocchi, cosicché sia garantita attraverso questa separazione, una naturale ventilazione
dell’edificio. I volumi che ospitano le diverse funzioni sono collegati tra loro da scale ricavate nei tagli ottenendo
così una ricca articolazione spaziale.
Questo articolato svolgersi dello spazio interno dell’edificio, inoltre, risulta essere una naturale continuazione
del rapporto che l’edificio stesso ha con l’esterno. Questa, infatti, era tra i propositi di Melzer una priorità.
All’edificio si accede attraverso una rampa di scale disposta parallelamente alla strada, lungo il marciapiede, rendendo naturale, a chi cammina lungo quest’ultimo, accedere allo spazio antistante l’edificio, mentre le scale che
disimpegnano gli appartamenti sono disposte con grande naturalezza in continuità con il percorso esterno. Il dislivello guadagnato con la rampa di scale di accesso consente all’architetto di alzare ulteriormente rispetto alla
quota della strada, il fronte dei living che insiste sugli alti e robusti pilastri in cemento faccia a vista, creando uno
spazio fluido che coinvolge dinamicamente lo spazio pubblico e quello privato. La struttura è sempre denunciata
con l’austera essenzialità del cemento faccia a vista, mentre le tompagnature in mattoni alleggeriscono la massività, già scomposta in più parti, dell’intero volume.
Progettato e costruito nel 1959, l’edificio racconta la nuda essenzialità propria della modernità in cui
l’equilibrio delle misure e gli elementi, che fondano il progetto, denunciano una sensibilità formatasi su riferimenti lecorbuseriani misurati sulle geometrie, sullo stendersi lungo tutta la facciata delle finestre a nastro (qui nascoste dagli scuri in legno per proteggere l’interno dal caldo), fino a sembrare riferirsi, nella rampa di scale
d’accesso al piano d’ingresso, a Villa Stein. Il filo poetico che lega Melzer a Le Corbusier lo porta a definire la
ruvida materialità dell’intera struttura, come nella ricerca sulla Unitè di Habitation di non molti anni precedenti.
Qui tutto, però, è riportato ad una dimensione umana: l’edificio riesce a far sfumare il lirismo delle suggestioni
nella concretezza del progetto, nelle risoluzione del rapporto dell’edificio con ciò che lo circonda e con se stesso.
Melzer ha disegnato ogni cosa: ogni dettaglio è stato concepito e seguito con la dedizione di chi ne fa un valore
imprescindibile.
Tornano, dunque, anche i valori della Bauhaus, che permeano l’architettura di tutta Tel Aviv, ma proprio questo
edificio non si allinea agli altri della White City: scompaiono le superfici bianche e la curva dolce, rinunciando
così ad un’aulica omologazione per riferirsi soltanto alla propria poetica ed alle necessità del progetto e raccontando, con grande trasparenza dialettica, un’architettura colta, sapiente e vera.
In cerca di Dov Carmi, a Tel Aviv, ho avuto il privilegio di incontrare l’architetto Melzer. Abbiamo trascorso
insieme un’intera mattina in cui i suoi racconti sull’architettura di Carmi s’intersecavano senza pudori o reticenze
ai sentimenti di una vita trascorsa ad amare l’architettura con gentilezza, essenzialità, umiltà: una lezione per tutti
noi, sommersi dal rumore, dal pressappochismo, dal cinismo vile delle archistar che condizionano l’immaginario
degli architetti più giovani ed inesperti, salvo poi ritrattare qualunque posizione pur di mantener saldo il proprio
piedistallo di vate.
Una lezione contro tutta l’architettura della superficie, la contrarchitettura, la transarchitettura, la nonarchitettura e via andare.
Una lezione, infine, sulla necessità di amare il proprio mestiere: finita la lunga conversazione, l’architetto Melzer mi ha spontaneamente condotto a visitare l’edificio di cui si parla in questo articolo e di cui si sentiva molto
orgoglioso a distanza di cinquant’anni. Sorridendo, lungo il tragitto, mi ha insegnato un proverbio diffuso tra gli
architetti israeliani: “uno dei regali più grandi che Dio può fare agli architetti sono gli alberi, per nascondere i loro
disastri”.
Ho pensato a quanti alberi dovrebbero crescere di questi tempi… poi siamo arrivati davanti alla casa che stavamo cercando e ho scoperto che lì davanti, nel tempo, di alberi non ne sono cresciuti.
Schizzo originale di Zvi Melzer
L’ARCHITETTURA DI PAOLO ZERMANI
METAFISICA DEL PAESAGGIO
Francesco Sorrentino
Lo stato attuale delle nostre città è indicativo di una crisi profonda che segna il declino di un’architettura incapace di
confrontarsi con la realtà che la circonda. La città sembra vivere di frammenti, ultimi avanzi alla rapacità distruttiva del
paesaggio contemporaneo; tra un frammento e l’altro vi sono la dispersione della periferia che oggi è condizione esistenziale, l’alterazione della campagna e del paesaggio rurale, che appaiono come ibridi indistinguibili, tra speculazione edilizia e alienazione del residuo territorio agricolo. Tutto questo processo di sovrascrittura del nulla sull’edificato della memoria procede con una rapidità impressionante, tanto più ora che l’architettura è vista, nella miopia dei nostri politici, come esclusivo strumento economico e non come pratica volta alla ricomposizione di una profonda lacerazione del territorio
destinato all’uomo.
L’architettura, nelle sue varie forme, sembra aver perso ogni attenzione nei confronti del costruito, a favore di una visione che la costringe a determinarsi come prodotto e in quanto tale a seguire le logiche del mercato e della moda.
L’attenzione smodata verso il linguaggio ed i suoi improbabili funambolismi, la concentrazione di tutti gli sforzi compositivi sulla pelle o meglio sull’abito dell’edificio, come mezzo di attrazione commerciale e di marketing architettonico, sono
tutti elementi indicativi della direzione verso cui l’architettura oggi si muove.
All’interno di questo panorama ci sono figure che si muovono controcorrente e l’architetto Paolo Zermani è senz’altro
una di queste.
Attraverso l’osservazione del paesaggio contemporaneo Zermani ci introduce al concetto di distanza, come metro attraverso il quale misurare lo spazio e il tempo della città. Egli intende la distanza come quello spazio fisico e concettuale che
si frappone tra gli elementi significativi del paesaggio e l’uomo. Nelle nostre città lo spazio di interrelazione tra i monumenti è cambiato e di conseguenza anche la percezione che noi stessi abbiamo dello spazio urbano. La dimensione temporale diventa fondamentale per capire l’alterazione percettiva di cui Zermani parla, la velocità degli spostamenti e la stessa
dimensione dinamica urbana portano ad una contrazione dello spazio, il quale conduce, così, su una scala differente i rapporti percettivi tra l’uomo e il paesaggio di cui è parte integrante.
L’architettura di Zermani trova il suo principio, la sua essenza nel ritorno al paesaggio, quale spazio che l’uomo si è dato
per vivere, modificando quello naturale. Tale spazio, in cui è possibile il vivere comune, manifestato in una specifica
forma o societas, è forse l’archetipo più adatto a rappresentare l’architettura. Essa nel ritornare al paesaggio si ricongiunge con il suo significato originario, simbolo dell’abitare, memoria dell’esser-ci dell’uomo sulla terra.
In una tale visione il paesaggio assume un valore assolutizzante, in quanto punto di partenza e di arrivo del progetto, esso assurge a principio essenziale dell’architettura. Si genera, così, una metafisica dell’architettura quale processo attraverso il quale giungere all’identità stessa dell’architettura, sottraendola alla moltiplicazione formale a cui essa si concede.
Il paesaggio, in quanto archetipo, più che predisporsi come forma pre-determinata, rappresenta una possibilità di forma,
una disposizione a rappresentare l’esperienza spaziale Prima, compiuta dall’uomo all’origine dello sviluppo della sua coscienza. A tale metafisica non appartengono categorie formali, non vi è un ipostasi di forme e materie precostituite, ne deriva da ciò che la metodologia operativa di Zermani non può essere accostata al contestualismo, che è un modo di alludere
dell’architettura, attraverso forme e materiali, al paesaggio, piuttosto la sua architettura tende ad essere essa stessa paesaggio.
Il risultato formale, al quale l’attività compositiva deve pur tuttavia giungere, non è dato quindi dalla messa in atto di invarianti compositive prese a prestito dal contesto, ma esso è stretta conseguenza del processo di identificazione con il paesaggio.
La modalità in cui la forma si appropria di tale processo identificativo è essenzialmente quella del percorso: come
l’uomo ha percezione dell’ambiente in cui vive percorrendolo, così l’architettura si riappropria del paesaggio attraverso
un percorso, che nelle architetture di Zermani costituisce la matrice generativa del progetto.
Nel progetto del Municipio di Noceto (figura 1) il percorso è costituito dallo scalone centrale al quale si aggrappano i
volumi che costituiscono gli ambienti dell’edificio. Il processo di organizzazione formale è diretta conseguenza della linearità del percorso, che funge anche da elemento distributivo dell’edificio. Lo scalone centrale segna un asse che congiunge i due estremi costituiti da un lato dall’ingresso, posto in corrispondenza dell’abitato storico di Noceto, e dall’altro
dalla sala civica, posizionata nella direzione che guarda al paesaggio agrario del comune. L’asse che congiunge città (ingresso) e campagna (sala civica) è una metafora della rigorosa organizzazione territoriale delle città emiliane, che vedevano in questo dualismo l’essenza del loro paesaggio. L’edificio tenta un ideale ripristino di tale dualismo, oggi irrimediabilmente compromesso. La finestra della sala civica, posta in asse con lo scalone, apre la vista su un frammento di
campagna, costituito da un edificio rurale porticato, elemento che marca la riconoscibilità del paesaggio agrario
dell’Emilia. Lungi da un nostalgico rimpianto di un passato non più rievocabile, il Municipio di Noceto, nel suo carattere
istituzionale, ci spinge alla riflessione, sulle nostre origini e sul senso profondo dello spazio che noi abitiamo e trasformiamo.
Il progetto della Cappella-Museo della Madonna del Parto (figura 2) a Monterchi si pone come uno spazio dalla duplice
veste sia museale che religiosa. Anche in questa opera l’architettura diventa un percorso attraverso il quale giungere alla
contemplazione del paesaggio e il frammento di paesaggio, al quale Zermani vuole legare l’opera, nasce da un’attenta lettura del contesto in cui l’affresco della Madonna del Parto era originariamente collocato. Piero della Francesca collocò
l’opera sulla parete di fondo dell’altare maggiore della chiesa di Santa Maria di Momentana, che sorgeva in una località
alle pendici della collina di Monterchi, totalmente immersa nella campagna aretina e distante dal centro abitato. A seguito
di un terremoto, che distrusse la cappella nel 1785, l’affresco fu staccato e collocato in una nuova chiesa.
Con il progetto della Cappella-Museo Zermani intende ricollocare l’opera all’interno del paesaggio, ripristinando così
l’ambiente nel quale Piero della Francesca l’aveva pensata. La cappella-museo è composta da quattro spazi che corrispondo a quattro momenti differenti del percorso. Dall’ingresso, che conduce il visitatore da una condizione di luce ad
una di penombra, si accede alla sala di maggiore ampiezza, generando una pausa all’interno del percorso, un momento di
preparazione all’atto contemplativo dell’immagine sacra. L’affresco, visibile sin dall’ingresso, è posto in un’ulteriore spazio, una cella nella quale la luce piove dall’alto ad illuminare l’opera, attraverso una copertura trasparente; ai due lati della cella si intravede la luce proveniente dal quarto ambiente, posto alle spalle della cella, che riconduce il visitatore, attraverso un affaccio sulla campagna toscana, al paesaggio e alla luce.
Con questo progetto Zermani inscena un rito, codificato in una liturgia rigorosa costituita dal percorso. La contemplazione del paesaggio diventa contemplazione della “creatio divinae”, e l’architettura, ricomponendo il senso perduto
dell’opera di Piero della Francesca, lo strumento per l’uomo per perpetuare il suo millenario dialogo con il sacro.
L’architettura di Zermani risponde ad un’estetica per cui l’arte è portatrice di idee e generatrice di conoscenza. Non vi è,
in essa, l’attuale abbandono al puro piacere visivo della forma, non più mezzo attraverso il quale manifestare l’idea e la
visione del mondo, ma essa stessa oggetto della propria indagine. L’architettura di Zermani rimanda sempre ad un altrove, il paesaggio, come luogo dell’abitare e come destino del costruire.
1. Cappella-Museo della Madonna del Parto
2. Municipio di Noceto
GIOVANI ARCHITETTI ITALIANI: SILVIO D’ASCIA E LA STAZIONE DI MONTESANTO
A NAPOLI
Francesca Buonincontri
All'interno di una immagine dell'architettura complessa e contraddittoria, ma comunque in evoluzione, nella
seconda metà degli anni Novanta comincia ad operare una nuova generazione di architetti identificata come
“generazione Erasmus” in quanto parte della loro formazione e della loro esperienza professionale è avvenuta
all'estero.
Questi giovani architetti hanno assistito direttamente alla nascita del decostruttivismo e alle straordinarie
architetture di Gehry, Nouvel, Libeskind, Hadid, Koolhaas, Eisenman, Fuksas. Tutte architetture disegnate
integralmente al computer, con cui è possibile superare le forme legate agli schemi dello spazio cartesiano e
trasformare i plastici di studio del progetto in formule matematiche. Hanno imparato, dall'inizio dei loro studi, ad
utilizzare il digitale che permette di rappresentare con rapidità un’idea architettonica e di visualizzarla come se
già esistesse nel mondo reale, costruendo, grazie ai modelli informatici, il progetto in parallelo tra interno ed
esterno e trasformandolo continuamente. Utilizzano il computer non solo per sviluppare un’idea già nata nella
mente del progettista ma anche per generare idee nuove, consapevoli però del pericolo di essere coinvolti nella
‘ubriacatura digitale’.
Gli architetti di questa generazione si servono con facilità delle nuove reti di comunicazione interagendo a
distanza, moltiplicando all’infinito le modalità di interazione tra individui, riuscendo a superare il limite fisico
dello spazio. Trasferendo le esperienze in una dimensione astratta e virtuale sanno però che possono correre il
rischio, come teorizza il filosofo e architetto delle nuove tecnologie, Paul Virilio, della perdita di realtà, « nel
senso che l'impatto delle nuove tecnologie e della realtà virtuale potrebbero assumere un'importanza tale da farci
perdere i nostri punti di riferimento nello spazio reale», sanno di vivere un tempo che non ha equivalenti nel
passato, "un tempo mondiale" che è diverso dal tempo fino ad oggi vissuto, che è stato un tempo locale, di un
paese, di una regione.« La storia di domani, la storia che oggi comincia, si fa in un tempo unico, il tempo
mondiale, il tempo dell'immediatezza, quello che si chiama live, ‘tempo reale’.
Questo comporta un trauma...il tempo reale, il tempo mondiale ha il sopravvento sullo spazio reale, sullo spazio
tempo locale, sullo spazio-tempo della storia...La situazione presente finirà, o meglio già sta finendo nel caos,
nell'inquinamento dell'informazione, nella mancanza di controllo, nella deregulation ....L'uomo non sa più dov'è.
Il vicino e il lontano si confondono.... Oggi, dinanzi all’affermazione delle nuove tecnologie, si rischia di perdere
la realtà, di precipitare nel disordine, di arrivare a uno sdoppiamento dell’identità del reale.»
Dopo l'abbattimento delle Twin Towers, l'11 settembre del 2001, questi architetti sembrano meno coinvolti dalla
passione per l’high tech, aumenta in loro la voglia di lavorare con mezzi più semplici, cominciano a nutrire seri
dubbi sul modello globalizzante proposto dallo Star System consolidatosi negli anni Novanta. Nasce un nuovo
interesse per le correnti eco-costruttive, di utilizzo consapevole di una sostenibilità ecologica.
Si incomincia a ricapire il valore etico dell'architettura, in un'intervista Silvio D'Ascia scrive che : « non si puo'
pensare che fare architettura, ieri come oggi e domani e ancor più di fronte ai rischi di una deriva nel virtuale e
nello star system, non sia un atto etico di primaria importanza e di responsabilità enorme, che coinvolge spesso
un gran numero di persone e di generazioni nello spazio e nel tempo. »
La generazione di questi giovani architetti è abituata alla commistione dei linguaggi avendo vissuto in un più
aperto clima culturale, favorito da Internet, dai voli a basso costo, dalla diffusione di riviste internazionali di
architettura. Hanno letto i filosofi Derrida, Virilio, Deleuze e Guattari, il guru dell' informatica Negroponte,
l'antropologo Augé, ma conoscono anche Loos, Le Corbusier, Tafuri, Zevi, Purini. Sanno che « operando in un
contesto storico e culturale è necessaria la presa di coscienza dell’importanza dell’esistente, come materiale
strutturale e non come semplice sfondo, all’interno del processo di progettazione. »
Queste conoscenze e consapevolezze guidano, a mio parere, Silvio D'Ascia nel progetto di riammodernamento e
completamento della ottocentesca stazione di Montesanto a Napoli. Il progetto della trasformazione e
rifunzionalizzazione dell'intera struttura in Polo di Scambio
polifunzionale a scala urbana, regionale e
territoriale risponde anche al ruolo che D’Ascia affida alle stazioni, una volta definite come non luoghi, oggi
trasformate in spazi pubblici polifunzionali, sempre aperti al quartiere, espressioni evidenti della trasformazione
della città europea del XXI secolo.(5) La stazione è progettata come « luogo nel quale si reinventa la città
moderna, in quanto luogo d’interazione e d’incrocio di grandi folle e di tutti i trasporti meccanizzati del nostro
secolo: treni, linee regionali, metropolitana, funicolare, bus, tram, automobili, taxi».
L’integrazione tra antico e moderno è favorita dall’uso del vetro e dalla valorizzazione della preesistenza storico.
D'Ascia recupera infatti, con un fedele restauro stilistico, il portico centrale con il loggiato superiore in ghisa, e i
due torrini laterali in tufo, elementi caratterizzanti la valenza storica ed estetica dell'edificio, demolisce le
strutture aggiunte nel XX secolo, interviene con opere di consolidamento statico ed infine aggiunge «elementi
architettonici peculiari che ne rendono evidente e riconoscibile la loro identità contemporanea in continuità
storica e tipo-morfologica con il modello della stazione ottocentesca, rinnovato dall'esigenza funzionale
dell'intermodalità, dall'integrazione polifunzionale di servizi urbani e dalla innovazione tecnologica».
Integra funzionalmente e fisicamente le due stazioni di Sepsa e funicolare, precedentemente separate, ottimizza i
sistemi degli ingressi e dei flussi interni con scale, scale mobili, ascensori, scale di sicurezza e con un'ampia hall
vetrata, ottenuta ripetendo tre volte la restaurata loggia liberty, terrazza su piazza Montesanto.
Risolve il problema della mancanza di luce, propria delle stazioni delle metropolitane urbane, utilizzando la
copertura vetrata per portare la luce naturale fino ai percorsi sotterranei.
Un grande tetto piano di vetro, tenuto sospeso da una struttura di acciaio reticolare, ricopre quattro piattaforme
per i treni. Sospeso tra i due torrini, un volume ponte, rivestito in acciaio e chiuso da cristallo, è un vasto open
space aperto verso la piazza e, dalla parte opposta, verso la copertura trasparente della stazione. La copertura
della hall e del fascio dei binari è ottenuta con pannelli in vetro e metallo dotati di cellule fotovoltaiche, il
progetto propone la luce, la vegetazione, la natura e l’uso dell’energia solare come fonte di energia alternativa.
Nella hall di accesso sono raggruppati i servizi legati alle ferrovie Cumana e Circumflegrea e alla funicolare e
una serie di negozi utili anche alla vita del quartiere perchè, spiega il progettista, « i nodi di scambio oggi vanno
intesi come luoghi di una nuova urbanità....Abbiamo ripensato l’antica stazione non solo come nodo
d’interconnessione tra le diverse modalità di trasporto, ma anche come luogo di vita che riesca a risanare lo stato
di degrado del quartiere e faccia da catalizzatore di un possibile sviluppo.» L’impianto della funicolare è stato
collegato con il sistema ferroviario attraverso l’allungamento della corsa delle carrozze della funicolare verso
valle; il nuovo volume esterno, in struttura d'acciaio schermato da lamelle di vetro autopulente che ripropongono
il ritmo orizzontale imposto dal bugnato del torrino settentrionale, segue la risalita del fianco nord delle mura
vicereali verso la collina del Vomero.
Il progetto ripropone «i temi storici dell'immagine urbana della Stazione Porta della Città, della Halle, come
spazio aperto pubblico coperto da una grande struttura vetrata, e dei binari come presenza formale qualificante lo
spazio semi-interno della stazione, alla luce della necessità di interconnessione tra le diverse modalità di
trasporto, della polifunzionalità necessaria ed implicita nell'idea stessa di polo di scambio, delle nuove tecnologie
costruttive e dei moderni materiali » la riqualificazione della stazione, diventa funzionale anche alla
riqualificazione urbana di Montesanto con l'edificio che diventa testa di ponte per un potenziale dispositivo
culturale della soprastante collina del Vomero che comprende i complessi di Trinità delle Monache, Certosa di
San Martino e Castel Sant'Elmo.
LE CORBUSIER: IDEA E PROGETTO DELL’ABITARE.
Daniela Conte
Nel corso degli anni sono diventato un cittadino del mondo.Ho viaggiato attraverso i continenti.
Ma non ho che un legame profondo: il Mediterraneo.
Io mi sento mediterraneo, profondamente. Mediterraneo, regno di forme e di luce.
Nelle significative parole citate è nascosto lo spirito dei progetti di abitazioni di uno dei maestri dell’architettura
del secolo scoro: Le Corbusier.
Agli inizi della sua carriera, negli anni ’20, Le Corbusier pone il problema della casa come quello di «una
macchina da abitare», un problema cui tenta di dare una risposta con i mezzi a disposizione della sua epoca. Egli
vuole definire uno standard costruttivo che sia il prodotto del nuovo spirito scientifico industriale moderno, e
definisce una teoria fondata su cinque punti di una nuova architettura: i pilotis, la pianta libera, la facciata libera,
la finestra in lunghezza, il tetto giardino.
In realtà, l’obiettivo principale dei cinque punti non è solo quello di risolvere un problema strutturale e pratico,
ma è soprattutto quello di isolare gli elementi strutturali dell’architettura per ridurli a forme geometriche pure ed
essenziali, così da elevarli al grado di ‘struttura ideale’.
Nell’utilizzo che Le Corbusier fa dei pilotis in alcuni dei suoi primi progetti come in Maison La Roche, non c’è
alcuna ragione pratica bensì una finalità teorica e simbolica, quella di evidenziare il pilastro e la sua natura
strutturale nel modo più semplice ed esplicito. Anche gli altri quattro punti rivelano il desiderio di isolare e di
astrarre gli elementi strutturali dell’architettura ed evidenziarne il carattere ideale: la pianta libera consente libertà
di organizzazione spaziale interna, la facciata libera e la finestra a nastro, rispondono alla funzione simbolica ed
estetica di evidenziare l’indipendenza della struttura rispetto ai muri, la rampa è l’elemento cristallizzato in forma
ideale pura intorno alla quale è possibile articolare una promenade d’architecture.
Le prime ville di Le Corbusier sono l’espressione più compiuta di questa nuova architettura moderna, del
pensiero illuminista e progressista fiducioso delle capacità della tecnologia e della scienza, ma sono anche il
frutto della formazione intrisa d'idealismo filosofico di un’artista colto, che vuole realizzare “macchine per fare in
modo che gli occhi vedano”. (P.V. Turner)
Nella villa Savoye a Poissy la struttura puntuale dei pilotis sostiene un parallelepipedo bianco compatto
all’interno del quale intorno alla rampa si articolano una successione di imprevedibili accadimenti pensati per far
guardare un determinato scorcio paesaggistico; nella piccola casa sul lago Lemano a Ginevra un’intera facciata di
undici metri diventa la finestra continua della casa e il paesaggio esterno s'inscrive come orizzonte all’interno del
taglio orizzontale nel muro; nell’attico Beistégui sugli Champs-Elysées la vista di Parigi è possibile solo
attraverso un periscopio, elemento surrealista che media il rapporto tra l’abitazione e la città, e, giunti sul tetto
nella «camera a cielo aperto», i parapetti e le aperture sono studiate in maniera tale da incorniciare solo alcuni
episodi significativi della città, la Torre Eiffel o la sommità dell’Arco di trionfo, che isolati dalla loro realtà
contingente diventano «oggetti a reazione poetica». (M. Tafuri)
La finestra in lunghezza introduce nella casa il paesaggio così com'è, imponendo i suoi tempi e i suoi ritmi,
seguendo un principio di oggettività caro al movimento moderno e al purismo, quindi svela il trascorrere del
tempo durante l’arco della giornata e porta all’interno, insieme al paesaggio, anche la luce. La casa è un
trasformatore d'intensità luminose e grandezze spaziali tra l’ambiente intimo interno e quello pubblico esterno. La
luce è ovunque, le pareti fungono da riflettori della luce ed ogni oggetto è svelato nella sua concretezza perdendo
quell’alone di mistero che le cose hanno quando sono avvolte nella penombra. Si perde il carattere d'intimità ed
esclusività che deriva dalla tradizionale finestra verticale e dalla sua specificità antropomorfa.
Al IV Congresso CIAM di Atene Le Corbusier afferma che le città in cui si può ritrovare la gioia della vita, sono
quelle in cui nel verde degli alberi e l’azzurro del cielo s'insediano le moderne costruzioni di acciaio e cemento.
Infatti, Le Corbusier nel tetto giardino delle sue ville, dove non c'è alcuna necessità pratica, gioca con forme
curve e articolate sulle quali la luce modula ricchi effetti chiaroscurali, esprimendo tutta la sua sensibilità di
pittore e scultore. Qui il colore diventa protagonista assoluto: in contrapposizione alle monocromatiche bianche
facciate esterne, espressione di una rigida operazione morale, risplendono vibranti interni policromi in cui il
colore assorbe diversamente la luce, rendendola ora più intensa e accecante, ora più fredda, ora calda e diffusa.
Questa sensibilità deriva a Le Corbusier dal suo sentirsi profondamente mediterraneo: dagli anni ’30 agli anni ’40
egli realizza una serie di residenze locali con le quali esplora materiali, caratteristiche climatiche, tipologiche e
costruttive della regione in cui opera, il Mediterraneo.
Il desiderio di confrontarsi con i valori locali non gli fa abbandonare le regole e i risultati perseguiti negli anni
precedenti, ma gli consente di combinare e comporre regole universali e necessità locali.
Nella villa Le Sextant a La Palmare-Les Mathes, in Francia (1935) Le Corbusier affronta un incarico con un
budget molto ridotto, tanto che non può eseguire sopralluoghi, non può trasportare materiali da Parigi, non può
assumere personale specializzato. Eppure risponde perfettamente alle richieste del committente di possedere una
casa per le vacanze che duri nel tempo. Mentre in altre abitazioni di questo periodo, come la villa Melene de
Mandrot a Toulon, combina la pietra tradizionale locale per le strutture portanti verticali con il cemento armato
per le coperture orizzontali, qui, si trova costretto a utilizzare esclusivamente materiali locali la cui lavorazione
sia nota al costruttore. Così associa un'organizzazione funzionale e spaziale moderna a modelli e tecniche
tradizionali locali. L’impianto della villa attinge a un prototipo del mediterraneo: la stoa. Gli spazi sono articolati
in sequenza lineare come nelle case contadine, rinunciando ai percorsi tortuosi della promenade, e il blocco
rettangolare contenente l’alloggio si apre da un lato su una veranda che funge da loggia e che con la sua
profondità, assicura l’ombra e la ventilazione necessarie per controllare la qualità del microclima della casa. La
casa è realizzata interamente con pietra locale e legno secondo la tradizione vernacolare mediterranea. La pietra è
usata per le pareti, il legno è utilizzato per le opere di rifinitura e per costruire un tetto a doppia falda inclinato
verso il centro che distingue i due ambiti, quello dell’alloggio e quello della veranda. Sulla veranda si apre una
parete vetrata continua policroma e trasparente, mentre nella facciata principale il muro compatto in pietra è
forato da piccole aperture strombate lungo lo spessore murario per filtrare una luce troppo forte.
Quando lavora in India Le Corbusier tenta di applicare i principi dell’architettura moderna entro i vincoli
regionali, climatici, tradizionali e culturali di un paese tropicale.
Villa Shodan ad Ahmedabad (1954-57) ha una pianta che ricorda quella di Villa Savoye, sia nell’impianto
compatto quadrato, sia nell’articolazione degli spazi intorno alla rampa, e nell’indipendenza della distribuzione
interna dal sistema portante, ma recupera alcuni elementi tipici locali derivanti dalle condizioni climatiche del
luogo. La struttura è in calcestruzzo a vista gettato in casseforme di legno per le parti verticali e in casseforme di
lamiere per i soffitti, trattati con colori diversi e accesi. Questa struttura combina la sua semplicità con un'enorme
plasticità, dovuta non solo a forma e dimensioni degli ambienti, ma soprattutto alle ombre generate sulle facciate
dai frangisole e dal tetto parasole. Sebbene l’idea del frangisole nasca in Francia per il condominio Molitor a
Parigi, nel cui attico Le Corbusier vive e lavora per parecchi anni della sua vita, in India il tetto parasole e il
frangisole sono un omaggio allo spirito del paese e cercano di dare una soluzione ai vincoli climatici. Le aperture
hanno bisogno di una schermatura che protegga gli ambienti interni dal forte irraggiamento solare, quindi si
utilizza il brise-soleil, che conserva il calore d’inverno e filtra i raggi solari d’estate. Così, partendo dalla
necessità di produrre l’ombra, Le Corbusier estende il concetto di brise-soleil dalla finestra all’intera facciata e ne
decide l’orientamento in relazione al corso del sole e alla latitudine del luogo nel quale costruisce.
Col trascorrere degli anni Le Corbusier da spirito anarchico, stabilisce con la realtà un rapporto a distanza e
l’unico legame con la realtà è il racconto poetico della propria solitudine svelato nella sua arte. Dal 1945 in poi
nelle sue opere Le Corbusier denuncia palesemente questa contraddizione interiore, iniziando un discorso
autobiografico che attraversa tutti i suoi progetti più importanti.
Nell'Unitè d’habitation di Marsiglia (1945), realizza l’ideale di casa collettiva autosufficiente, applicando a
grande scala gli studi iniziati con la casa Citrohan e sperimentati nelle ville isolate, nell'immeuble-ville, nei piani
urbanistici. L’unitè è realizzata rispettando perfettamente i cinque punti della nuova architettura e, piante
prospetti e sezioni, sono studiati in base ai tracciati regolatori e al Modulor.
L’Unitè ospita 337 appartamenti distinti in ventitré tipologie diverse, ai quali si accede da corridoi definiti come
vere e proprie ‘strade interne’. Le cellule sono costituite da alloggi duplex, dotati di loggia frangisole, spazio a
sua volta agibile, che protegge la casa dall'intensa luce mediterranea.
Anche nell’Unitè come nelle sue opere precedenti, Le Corbusier attinge le soluzioni progettuali dal proprio
bagaglio culturale grazie alla sua acuta capacità di reinterpretare e riutilizzare le proprie conoscenze. I precedenti
sono la capanna su palafitte dei primi insediamenti svizzeri e l’acquedotto romano che attraversa il paesaggio, la
cantina dove riporre le bottiglie, il ponte dei transatlantici per il tetto. «Vivere un edificio è come abitare un
piroscafo» è la metafora dell’Unitè, la metafora della vita umana che si esprime in una composizione di oggetti a
reazione poetica: la palafitta, la grossa scala antincendio, la gabbia colorata, il ponte, il tetto con le sue sculture,
sono tutti oggetti desunti da realtà differenti, che, associati, suscitano riflessioni e forti emozioni. (A. Tzonis)
D’altra parte l’Unitè è costruita subito dopo il conflitto mondiale e non può che esprimere la disillusione, la
solitudine e l’angoscia della vita quotidiana.
Essa esprime l’obiettivo irraggiungibile di vivere l’intero paesaggio urbano e naturale: nella parete occidentale
cieca, che sembra tagliare un organismo vivo, nei corridoi interni che aspirano a essere strade urbane, nel
passaggio al piano terra su pilotis che simula il comportamento di un'infrastruttura urbana, e nelle forme scultoree
e surrealistiche del tetto, che esprimono la frammentarietà e la disomogeneità dello spazio.
L’unitè d’habitation è un gigantesco frammento di un'idea di città che esiste soltanto nella memoria del suo
artefice, il quale, alla fine della sua ricca esperienza artistica, si sente libero di esprimere un proprio linguaggio
architettonico che ritorna alle origini, un linguaggio autoriflessivo sul proprio ruolo all’interno della società
moderna, un linguaggio che comunica uno stato di malessere, di emarginazione dalla realtà metropolitana nella
quale l’artista in principio sperava di potersi integrare.
VIRUS E DELIRI
L’architettura tra Derrida e Koolhaas
Alberto Cuomo
Antiarchitettura e demolizione è il titolo del volume di Nikos Salingaros, tradotto di recente, subito divenuto, se
non la bibbia, un vademecum per gli antidecostruzionisti nostrani, i quali hanno ospitato lo studioso nelle diverse
facoltà di architettura italiane. Salingaros è un matematico, ed insegna questa disciplina nell’Università del Texas di San Antonio. Egli è pero stato anche collaboratore di Christopher Alexander, e questa esperienza lo ha
condotto a ricoprire incarichi di docenza nelle discipline urbanistiche in giro per il mondo, a Deft, in Olanda, o
nel Messico, o negli stessi States. La tesi singolare di Salingaros si articola intorno all’opinione che il cosiddetto
decostruttivismo architettonico, con l’uso dell’elettronica nella progettazione di edifici e luoghi urbani, sia in
continuità con il modernismo, essendo entrambi i movimenti rivolti a distruggere i sistemi connettivi storici propri alla città e, quindi, le stesse relazioni tra gli uomini, dal momento che tali sistemi, e la relazionalità da cui sono sottesi, sarebbero propri all’umano. Chi ha memoria delle proposte urbanistiche di Alexander ricorda come
esse si fondassero appunto sulle complesse connessioni tra le diverse funzioni urbane interpretate attraverso la
matematica combinatoria ed informatica. Paradossalmente, dopo aver egli stesso introdotto l’uso dell’elaboratore
nel gioco delle infinite combinazioni relazionali proprie all’urbano, Salingaros ne denuncia l’utilizzazione proposta dai decostruttivisti rivolta a polverizzare, ed in definitiva a distruggere, la forma dell’architettura, quella
della città e la vita sociale che vi si svolge. Nel contrastare la nuova architettura elettronica egli demolisce altresì
lo stesso fondamento culturale, o, meglio, l’assenza di fondamento culturale negli architetti che la propongono,
accusati di non conoscere neppure i dispositivi che utilizzano, la logica ed il senso dell’aritmetica modulare e dei
“frattali”, di cui essi dicono o tentano di fare uso, sì che sarebbe proprio la loro ignoranza a determinare applicazioni errate nel campo della (de)formalizzazione architettonica colpevoli della fine dell’architettura e della città.
In proposito lo stesso Salingaros non esita a tacciare se stesso di ignoranza, riferendosi alla filosofia, che non
comprende, particolarmente quella dei presunti ispiratori della decostruzione, Foucault, Derrida, Baudrillard, Deleuze, impropriamente assimilati in un’unica corrente, nella confessione, non solo di non averne conoscenza,
quanto di non volerne avere, o meglio, di non voler «perdere tempo» con le loro inutili astruserie. Tra gli architetti afferma di privilegiare Ungers, il quale a propria volta ricambia con il suo giudizio positivo sul new urbanism, ovvero la progettazione di nuove strutture urbane secondo criteri storici, dall’uso delle tipologie tradizionali ai parametri quantitativi riguardanti il numero di abitanti, le proporzioni degli standards, le distanze tra gli interventi ecc. Qualche divisione tra i due insorge a proposito dei grattacieli i quali, del tutto bocciati da Salingeros, sono accettati dall’architetto tedesco, che pure ne ha progettato qualcuno, qualora non eccedano misure tali
da richiedere contorsioni impiantistiche. Nella ammessa scarsa conoscenza di Derrida, verificando l’affezione
verso il suo pensiero da parte dei progettisti che maggiormente sono rivolti alla demolizione della forma e con
essa a quella della città, ritenendo forse di esprimere un giudizio negativo sul filosofo, reo di aver instillato
nell’architettura il germe della malattia, egli attribuisce agli architetti decostruttivisti un «virus-derrida», una infezione virale cioè interna al loro fare che, come è per i morbi contratti attraverso le ultime generazioni di virus,
appare essere mortale: l’architettura sarebbe finita o starebbe per finire a causa del virus letale «derrida». Salingaros finge di non sapere, o forse veramente non sa, che, utilizzando tale definizione, egli incontra proprio il
pensiero di Derrida, il quale denomina se stesso un virus e la decostruzione una attività destabilizzante di natura
virale. Nella metafora morbosa infatti, il filosofo assimila sia lo scompenso informatico che quello immunitario,
determinati dai virus, ad una necessaria destabilizzazione la quale, provocando l’alterazione dei sistemi comunicativi, dello stabilito ordine dell’universo informatizzato e di quello biologico, aspira a costruire nuovi sistemi
convenzionali, a rifondare il senso delle definizioni e delle cose, come è in fondo per la reintegrazione della
struttura fisiologica attraverso i vaccini. Ed è per questo motivo che, superando l’aspetto «contemplativo» della
riflessione filosofica in Heidegger, nella medesima accusa mossa da Annah Harendt, egli ne riprende
l’attenzione al linguaggio riportato, invece che al risalimento ermeneutico verso l’essere, allo scavo verso il nucleo logico, eidetico, del prodursi dei significati nella coscienza cui Husserl si dedica, sì che, riconoscendo il
nocciolo da cui si promana il senso in quel luogo primo di animalità ed umanità insieme, di fusione e distinzione,
la Khora, in quello in cui il primo gesto della scrittura si fa traccia insieme del soggetto e dell’altro, egli intende
la decostruzione in una dimensione politica, modo di interrogare le definizioni, i sistemi convenzionali del signi-
ficato, per ritrovare la mancanza originaria comune (il noi husserliano), il centro vuoto da cui si diparte ogni organizzazione umana. E’ da questo aspetto ‘politico’ che muove allora anche l’attenzione di Derrida verso
l’attività costruttiva, cui offrire la propria «incompetenza» quale possibile apertura all’architettura che antecede
ogni architettonica. Se Salingaros invece che professarsi ignorante rispetto alla decostruzione si fosse inoltrato
nel suo metodo, nei suoi procedimenti, forse avrebbe scoperto il tratto contradditorio, per niente decostruzionista, degli architetti, Tschumi, Eisenmann, Libeskind, che pure si ispirano a Derrida, verso i quali questi si rivolge
spesso interrogativamente, chiedendo ragione della loro affermata «presenza dell’assenza», del loro Dio assente.
La lettura dei testi di Derrida sull’architettura, pure pubblicati recentemente a cura di Francesco Vitale, lascia
emergere infatti la continua volontà di riportare gli architetti “decostruttivisti”, cui pure dedica la propria riflessione, al primo incontro, ad un territorio iniziale cioè in cui il “decostruttivismo architettonico” non si è ancora
determinato come nuovo sistema, occlusivo del senso e dell’abitare, fondato oltretutto, ancora sulla linea della
metafisica, su una affermata originaria assenza, su un presupposto Nulla. Certo l’umanesimo salingarosiano non
troverebbe riscontro nel pensiero virale, e si direbbe animale, di Derrida, e tuttavia la professata ignoranza del
metodo e della filosofia decostruzionista non sembra centrare il giudizio critico sul decostruttivismo degli architetti, semplicemente negato a partire da un punto di vista solo apparentemente diverso, potendosi rilevare in entrambe le proposte circa l’architettura e la città un atteggiamento ideologico, metafisico, in definitiva comune,
fondato, nel caso di Salingaros, sulla centralità dell’uomo, dell’ente, e, nel caso dei decostruttivisti, sulla centralità del ni-ente. Del resto, a voler inoltrare la critica all’architettura decostruttivista sin verso Derrida, verrebbe
semmai da chiedere se il virus decostruzionista sia veramente tale, se cioè esso mini veramente la costituzione
del Soggetto, o non sia ancora un suo strumento. Se esso rompa i sistemi di potere o non sia invece l’arma di un
più occulto e terreo potere, come mostrano gli esiti fascisti di tutte le rivoluzioni che si proclamino permanenti.
Se il gioco dello scombinamento e della ricombinazione dei pezzi che la sua affezione produce non sia piuttosto
quello di un superprogetto che tende a prevedere ogni cosa, il caso stesso, da parte di un supersoggetto, un soggetto “eletto” posto oltre i sistemi con cui giocare.
E’ noto come alcuni virus, attaccando il sistema nervoso centrale provochino deliri. Ed a leggere Delirious New
York di Koolhaas, sembra che il gigantismo oltreurbano della città sia stato prodotto proprio da una affezione virale che con la malattia avrebbe generato anche nuova vita. Giornalista, Koolhas sembra offrirci un resoconto
della crescita di New York, tra la fine dell’ottocento e gli inizi del novecento, secondo la scrittura tipica di quotidiani e Magazine, attraverso storie singolari, aneddoti, pettegolezzi persino, particolari, che, quali pezzi di un
puzzle, finiscono per comporre un quadro in cui è restituita, più che la realtà della città, il suo lato oscuro, quello
della scalata verso il cielo del cosiddetto manhattanismo, che non rende le ragioni del suo sviluppo, determinatosi, secondo il cronista postumo, da una visione delirante, una nascosta utopia, il cui manifesto viene ricostruito
retroattivamente. Scritto oltre trent’anni or sono il testo di Koolhaas ebbe immediato successo. E non poteva essere altrimenti, data la scrittura accattivante ed aggressiva insieme, in cui il fluido eloquio lascia intravedere una
intenzione teorica mai espressa, interrotta, con la rottura degli schemi consolidati dell’analisi urbana, tale da invogliare curiosità ed attenzione verso una tesi lasciata sempre sospesa e mai detta. Un testo che, a dispetto del
giudizio di Marco Biraghi, è solo un testo di piacere, un testo sterile, celibe, esaurito in se stesso, nelle immagini
che propone, affascinanti, certo, ma inutili alla ricostruzione della storia e delle stesse intenzioni poeticoculturali, che diedero vita alla città. Un testo d’evasione, da leggere (come feci) su una spiaggia di periferia, tra
un sonnellino ed una cocacola, con nelle orecchie il vociare della folla, il battere delle palline sui tamburelli o
dei piedi e delle mani sul pallone, il grido del venditore di cocco ed il sorriso di un vucunprà che ti distoglie dalla
lettura per proporti la sua povera e colorata merce. Un testo, come è per tutti i testi giornalistici, del tutto privo di
scientificità, del tutto singolare, destinato alla quotidianità, alla cronaca, privo della possibilità di assurgere alla
letteratura, e rivolto ad ingiallire, come il corsivo di un quotidiano conservato in un libro, nella memoria, per essere forse ripreso, come talvolta si fa con un giornale dimenticato in uno scaffale, ed essere riletto, ma subito
cancellato con un sorriso. Dopo questo scritto Koolhaas naturalmente ha scritto altri testi, essi pure privi di vocazioni teoriche o letterarie. S,M,L,XL è il successivo volume nel quale, occultando la volontà agiografica,
l’architetto olandese presenta i proprio progetti, secondo le diverse taglie, quasi ad offrirli ad un possibile
shopping. Seguiranno quindi testi in riviste e libri, quali Bigness, La città generica, Junkspace, tutti apparentemente rivolti a definire una possibile teoria dell’urbano e tutti invece risolti in una scrittura non lineare, brillante,
graffiante anzi, provocatoria, principalmente intesa ad offrire valore ai gracili progetti redatti nel tempo i quali,
sostenuti dal continuo battage di trovate editoriali, pubblicitarie e grafiche, finiscono per accreditare Koolhaas
internazionale archistar, cui giunge alfine il sospirato premio Pritzker. Gabriella Lo Ricco e Silvia Micheli, alle
quali si deve il conio del termine archistar, mettono in luce, nel loro volume Lo spettacolo dell’architettura, come nei suoi scritti e nel suo propagandarsi, l’architetto, se retroattivamente conduce la storia alla cronaca, tenda
all’inverso ad offrire il proprio presente, l’immedesimarsi dei propri progetti nel presente, quello transeunte del
mercato e della moda, allo spessore della storia. L’uso di foto in bianco e nero, il suo posare con personaggi con-
segnati alla fama globale, il tono encomiastico verso i propri prodotti, aspirano cioè a determinare a sé ed ai lavori elaborati dall’OMA, lo studio fondato con Elia Zenghelis, una distanza dal presente in cui sono immersi, secondo una sorta di presbiopia del tempo, di spostamento di là dell’odierno, pure esibito, in un’aura storicizzante,
che corrisponde, sul piano spaziale, alla vocazione dei progetti di attuare possibili dislocazioni rispetto all’ordine
urbano o, anche, al disordine suburbano e metropolitano in cui si inseriscono. E’, come è palese, il gioco del
marketing, l’offerta di prodotti che, fingendo di proporre in immagini insolite un futuro, ammiccano di fatto a
determinare solo la moda presente, fondandola comunque su consolatori e rassicuranti riferimenti a modelli del
passato. Oltre le discutibili realizzazioni dell’architetto infatti, a leggere gli scritti di accompagnamento ai progetti ed i suoi sapienti disegni appare facile riscontrare il tono profetico, un glamour avveniristico, ed insieme il
ricorso, con annotazioni banalmente quotidiane, a forme trascorse, in un mix tipico della moda e delle strategie
di mercato. E’ noto come il fare di Koolhaas affondi le radici nelle esperienze dell’architettura “radicale” degli
anni sessanta, ovvero nell’arte new dada successiva alla pop art. Andy Warhol, con le sue performances tra moda e cultura, appare quindi essere il vero mentore dell’architetto, dal quale egli ha assunto, non solo
l’atteggiamento spregiudicato e dissacratorio nei confronti del reale, quanto l’idea della possibile conversione dei
modi e dei prodotti più vili dell’industria, del consumo e del mercato metropolitano e mondiale, attraverso l’arte,
in valore. Ed è qui, se si vuole, una delle palesi contraddizioni di Koolhaas. Nel fatto cioè che mentre Warhol
gioca insieme mondo quotidiano e sistema istituzionale artistico, opera-critico-galleria-mercato, per dare loro
scacco, smontare la struttura culturale, sociale, economica che li sostiene, offrendo valore al disvalore e svalorizzando i valori consolidati all’interno dell’universo autonomo, si direbbe separato, dell’arte, Koolhaas sembra invece non accorgersi che il medesimo gioco, giocato con il costruire sulla scacchiera della città, polis o megalopolis che sia, e della vita cui il costruire si dedica, conduce piuttosto l’architettura allo scacco, alla valorizzazione
speculativa cioè di suoli e parti urbane che si avvantaggia dell’oggetto ‘artistico’ costruito per fagocitarlo nelle
sue logiche. Ed invero neppure dovrebbe parlarsi di contraddizione, quanto di un destino accettato, cercato, attraverso il quale Koolhaas si conduce sul palcoscenico spettacolare della globalizzazione ergendosi sulle rovine
dell’architettura che egli contribuisce a determinare (a Napoli sarebbe detto “il gallo sull’immondizia”). Non è
stato infatti Koolhaas ad indicare come lo stesso coacervo funzionale metropolitano, i mali della megalopoli, il
suo junkspace, siano piuttosto i contenuti cui l’architettura deve uniformarsi aderendo, oltre ogni progetto ed ogni utopia, realisticamente alle questioni presenti? E non è stato ancora Koohlaas a proporre una architettura rivolta alla composizione della complessità megafunzionale dei grandi contenitori metropolitani fuori dalle aspirazioni alla forma? Non è stato quindi lo stesso Koohlaas ad invitare all’abbandono del progetto delle avanguardie,
a sciogliere la tensione del progettare rivolto al sociale, verso la soluzione delle problematiche momentanee, circoscritte, poste dalla committenza all’architettura, la quale finisce in tal modo con l’assumere solo il ruolo di agente Real Estate? Appare pertanto del tutto paradossale che Marco Biraghi interpreti Koohlaas in continuità con
Manfredo Tafuri, confinando quest’ultimo nella prospettiva e nella logica, ed anzi nella «ideologia del moderno», per elevare l’architetto olandese a campione del postmoderno, non inteso questo in una caratterizzazione stilistica quanto in una nuova modernità più eterogenea ed instabile. Se infatti è già del tutto falsante indicare in
Tafuri, il quale ha sottoposto a critica proprio l’ideologia del moderno ed ogni ideologia architettonica, la stessa
architettura quale luogo ideologico, un epigono del moderno, sicuramente appare una offesa all’intelligenza sostenere che «Koolhaas prende le mosse dove Tafuri si arresta». Citando Nietzsche, senza averlo evidentemente
compreso (senza averne compreso il tratto metafisico illustrato dai suoi esegeti, da Heidegger a Severino, Cacciari) Biraghi sostiene infatti che, Al di là del bene e del male, Koolhaas agisce la crisi, lavora la crisi, quella
stessa lucidamente diagnosticata da Tafuri all’architettura, ormai inutile e superfluo orpello alle stringenti logiche economiche che determinano lo sviluppo urbano, operando nella aporeticità della nostra realtà con lo strumento della contraddizione. Che il gioco della contraddizione sia tutto interno ai sistemi comunicativi, linguistici
e sovrastrutturali, tale da confermare la possibile critica tafuriana alla sua ideologia, neppure sfiora la maldestra
analisi di Biraghi, e tantomeno l’architetto olandese. Del resto, se l’appropriazione di Nietzsche non può non far
riconoscere con il filosofo che il mondo, da tempo, è divenuto favola, quale realtà muove Koolhaas? Quale il suo
affermato realismo? Solo il realismo della adesione alla esposta irrealtà! Non certo quella dei sogni delle avanguardie che appunto Tafuri ha demitizzato, quanto gli incubi stravolti di un avanguardismo di ritorno, farsesco, il
quale, aspirando ad offrirsi immediatamente al mondo reale, vi si immette, consapevolmente, attraverso il mercimonio, a pena coperto dai fatui divertissement costruttivi ed editoriali inscenati. Basterebbe, a segnare la clamorosa distanza tra Tafuri e Koolhaas, leggere in controluce i rispettivi testi sulla città americana! Mentre infatti
Tafuri ci illumina sulle dinamiche concrete, non solo economiche, strutturali, ma anche politiche, culturali, sociali, che innescarono il processo di sviluppo metropolitano nel quale il mondo del “boss” annegò lasciando emergere la nuova classe finanziaria, Koolhaas ci offre una serie di quadri cinematografici, con possibili intrecci
nazional-popolari, in un sociologismo di terz’ordine buono per uno scadente film hollywoodiano. L’architetto ci
ripropone in termini nuovi, del resto, analisi del tutto inoriginali, tratte da Simmel, Sombart, Spengler, se si vuo-
le, Mumford, tutta la letteratura critica verso la grande città, per capovolgere il giudizio negativo e leggere i mali
additati, alla maniera di Augé, in termini positivi. Certo, anche Tafuri svolge la propria critica alla ideologia postnietzschiana dei citati ‘filosofi-antimetropoli’, ma non certo per ribaltarne il giudizio ed operare una inversione
dei valori come fa Koolhaas. Vale a dire che, mentre Tafuri denuncia la falsa coscienza delle ideologie storiche
per mantenere vivo il proprio atteggiamento critico nei confronti del presente, assumendo criticamente gli stessi
«occhiali» che si offre per acquisire una distanza dalla realtà in cui si immerge, Koolhas si impasta nella realtà
odierna senza alcuna protezione allo sguardo, finendo per confonderne i piani e ritenere che la propria visione sia
quella vera, quella rivoluzionaria, quella più aderente al mondo in cui si cala. In definitiva, proprio Tafuri ha
scritto, en passant, di Koolhaas, rilevando il «gioco cinico» dei suoi disegni e progetti e, nella «distesa di simulacri» dell’architettura attuale, i suoi «scherzi». Opportunamente il compianto maestro, onde non mescolare i baloccamenti con la storia con cui l’architetto olandese si trastulla, alle più pensose combinazioni stilistiche di Piranesi, non usa il termine «capriccio», essendo propriamente lo «scherzo» solo uno sberleffo buffo, che, contro il
parere di Biraghi, non muove alcuna contraddizione, il tiro di un buffone, di un pagliaccio, etimologicamente, un
gesto privo serietà analogo allo scherno. E che Koolhaas non riesca a rivolgersi, seriamente, né alla storia, né al
presente, è emerso di recente nella sua sorprendente esaltazione del Corviale a Roma e delle Vele di Scampia a
Napoli, non celebrati a partire dai loro presunti esiti negativi, la eccessiva condensazione del risiedere intesa
promotrice di socialità e non solo di fenomeni delinquenziali, così come egli è solito fare, quanto proprio per i
contenuti sociali e le poetiche compositive da cui sono retti. Intuendo la fine della ri-creazione promossa dal fantasmatico mondo dell’economia finanziaria, cui ha fatto da sfondo la fantasmagorica architettura delle archistar,
Koolhaas si è lasciando andare al positivo giudizio dei due quartieri, quasi a riproporne gli assunti sociologici e
formali, riprendendo l’elogio pasoliniano della periferia. Ma, anche qui, solo uno «scherzo» che ignora del tutto
il tragico che condusse alla scelta della loro realizzazione e che tende ad esaltare solo la vuota crisalide della loro
forma decomposta. Uno «scherzo cinico», ancora tutto ideologico, che fa del sociologismo stesso conservato nella organizzazione dei due quartieri un prodotto da shopping, onde giocare forse sul mercato futuro le azioni, oggi
acquistate a poco prezzo, dell’architettura impegnata. Che le dichiarazioni di Koolhaas annuncino il riproporsi
del vecchio virus dell’ideologia dell’impegno nelle nuove vesti indotte dal mercato? Potrebbe essere vero. Del
resto non si presentano i virus ciclicamente?
FORMA E STILE NELLA COMPOSIZIONE DEL PAESAGGIO CONTEMPORANEO
Gaetana Laezza
L’architettura ha sempre descritto se stessa attraverso uno stile, un insieme morfologico che caratterizza un
determinato periodo storico. Il legame con le altre epoche veniva documentato attraverso una serie di elementi
formali quali lesene, timpani, modanature, catene d’acque, parterre, fontane, quindi attraverso l’uso
dell’ornamento. Con la morte dell’ornamento (Loos) l’architettura si è indirizzata alla ricerca di un nuovo stile: si
tratta di uno stile non più identificabile, in una serie di codici descritti e storicizzati, uno stile che ha perso
gradualmente il suo valore di codice identificativo di una determinata epoca.
La forma, che può essere percepita indipendentemente dal significato, ha cominciato a prescindere dallo stile
fino a coincidere con esso: la forma come ricerca degli elementi primari, del rifiuto accademico e storico. In
precedenza la composizione era dettata dalle istanze della rinnovazione estetica e sociale della contemporaneità;
invece, oggi la forma non identifica più uno stile. Lo stile è riconoscibile attraverso le sue forme tipiche, che
riflettono architetture come quelle di Siza, Moneo, Souto de Moura, Eisenman, eredi del Movimento Moderno.
Questa perdita della forma e dello stile sembrano essere definiti dall’abbandono dei legami con la tradizione e
con il recupero di elementi morfologici tradizionali che invece decodificavano i momenti storici passati.
La ricerca parte dalle definizione di forma e stile, ad opera di autori come Purini che in “Comporre
l’Architettura” da una prima definizione di forma. “Comporre vuol dire mettere insieme. Si tratta di un
meccanismo presente in molte attività dell’uomo. Comporre significa costruire la forma che è il principale
obiettivo della progettazione architettonica. Il Progetto viene quindi visto come un atto di conoscenza della realtà.
L’esito del processo conoscitivo è l’opera architettonica cioè un oggetto d’arte perché comunica un significato”.
Questa perdita del legame tra l’architettura e gli stili sembra partire con la nascita delle Avanguardie, con la crisi
dell’ornamento e con il fenomeno dell’industrializzazione, fenomeno che ha investito anche la progettazione del
paesaggio.
Analizzando alcuni progetti di parchi e giardini contemporanei è, forse, possibile affermare arbitrariamente che
lo stile non è più presente. Nelle architetture così come nei parchi si può riconoscere l’assenza di elementi
morfologici che possono permetterci di decodificare lo stile contemporaneo e metterlo a confronto con altre
architetture contemporanee. Infatti, in molte di queste opere la forma si identifica con lo stile, che diviene lo stile
del suo autore e non lo stile rappresentativo di un’epoca.
IL PAESAGGIO STORICO
Spesso i parchi e giardini sono considerati elementi indipendenti dalle architetture, ma nell’epoca
contemporanea con la nascita dei dibattiti per la valorizzazione e la salvaguardia dei giardini storici, è stato
evidenziato il rapporto tra la natura e l’ambiente costruito. E’, quindi, necessario che nell’analizzare il giardino
storico questo sia messo in relazione con l’architettura di cui fa parte. Con il passare dei secoli il parco ha
modificato il suo rapporto con l’architettura. Nei secoli scorsi la realizzazione dei giardini era molto spesso
condizionata dal committente che con la costruzione dei giardini, di solito annessi alla villa, manifestavano la
propria posizione politica e sociale.
In passato il giardino nasceva con una motivazione utilitaristica, principalmente come area agricola, e la sua
architettura era di carattere religioso. In Grecia dal giardino degli orti fertili, di veste prettamente agricola, si
passa al kepos, area coltivata protetta da recinzione. A Roma, sotto l'influenza della cultura alessandrina, il cui
punto d'unione è Bisanzio, si intrecciano rapporti con le due civiltà per porre le basi di una nuova formazione
europea. Nel Medioevo, si comincia a notare l'influenza della cultura del giardino islamico; la presenza dell'acqua
come elemento di preziosismo e di raffinatezza orientale aggiunge sensazioni di piacere al giardino. L’area viene
recintata verso l’esterno, mentre all’interno si disegnano le aiuole per le piantumazioni.
Nel XV secolo, con l’invenzione della stampa, si modifica il rapporto uomo-natura-architettura; vengono poste
le basi per la definizione del giardino moderno, che comincia ad abbellirsi nelle sue forme con giochi d’acqua,
con i terrazzamenti ed i parterre, caratterizzato dalla struttura geometrica con l’uso dell’ars topiaria. Il giardino,
considerato fino ad ora come hortus conclusus, acquista un’immagine idilliaco: è il giardino dei sentimenti. Nel
passaggio dalla città medioevale a quella rinascimentale, il giardino borghese diventa sempre più ricco di
elementi di architettura che lo impreziosiscono, sempre più relazionato a palazzi e ville, pur conservando le
produzioni delle grandi aziende agricole.
Siamo nell’epoca della realizzazione di grandi progetti di giardini che diventano parte integrante
dell’architettura attraverso l’uso di molti elementi decorativi: le scalinate, i terrazzamenti, le fontane, i ninfei e
l’utilizzazione delle specie sempreverdi. Emerge il senso di un giardino dove l’architettura si fonde con la natura
in una simbiosi artistica che fa da sfondo alla vita e ai momenti più importanti dell'uomo.
Il giardino italiano nel XVII secolo continua a evolversi tra manierismo e barocco; si diffonde in Europa con
esempi di schemi cinquecenteschi. Grandi cambiamenti si avranno con il francese André Le Nôtre che, verso la
fine della prima metà del Seicento, propone progetti di giardini organizzati lungo gli assi principali dell’edificio,
quali elementi di riferimento di tutto il complesso. La poetica di Le Nôtre si diffonde rapidamente in tutta Europa,
eccetto in Inghilterra in cui è forte il legame della sensibilità romantica. Infatti, siamo negli anni della
affermazione, nella prima metà del XVIII secolo, del giardino paesaggistico. In pieno Illuminismo, si iniziano a
realizzare i primi parchi pubblici, tutto questo dovuto essenzialmente al mutare della società e dell'architettura.
I parchi e giardini realizzati nell’Europa dell’Ottocento sembrano rappresentare i desideri luoghi della nuova
classe. Verso la fine del secolo, con l'avvento dell’era industriale, i giardini vengono aperti alla città, ma nello
stesso tempo si riducono notevolmente per dar luogo alle nuove esigenze della vita meccanizzata.
I primi giardini risalenti al periodo classico, ci sono stati riportati esclusivamente attraverso le miniature, le
rappresentazioni pittoriche o attraverso le descrizioni letterarie. Uno dei primi giardini viene descritto anche da
Omero. Si trattava, nella maggior parte dei casi, di giardini recintati da muri e che avevano come scopo
fondamentale la produzione agricola o di piante officinali. Infatti, i giardini di epoca medioevale erano di solito
giardini monastici nati per il sostentamento dei monaci. Esempi significativi sono la Certosa di Padula o i giardini
dei chiostri quali Santa Chiara.
In epoca rinascimentale il significato del giardino si modifica. La maggior parte dei progetti nascono come
completamento delle grandi ville e palazzi signorili. Tra gli architetti di cui conserviamo esempi rappresentativi
vi sono personaggi come Bramante, Vignola, Pirro Logorio, … Uno di questi progetti è Villa Lante a Bagnaia in
cui sono evidenti i caratteri tipici del giardino all’italiana di epoca rinascimentale. Il giardino viene realizzato su
di un’area in pendenza (circa 16 metri). Secondo lo schema rinascimentale l’asse principale è rappresentato dal
corso d’acqua ed è suddiviso in tre ripiani.
Nel periodo seicentesco l’architettura dei giardini si modifica rispetto all’epoca rinascimentale. Il parco si apre
verso l’esterno, non è più chiuso verso il panorama, verso il paesaggio circostante. La Reggia di Versailles
costituisce uno degli esempi più importanti. Le Nôtre disegna un grande asse centrale in cui sono sistemati
parterre, boschetti e nastri d’acqua.
IL PAESAGGIO CONTEMPORANEO
Con il XX secolo, ed in seguito agli eventi bellici della prima guerra mondiale, il mondo dell’architettura
comincia a dirigere il suo interesse verso il ruolo di parco urbano. Questa necessità viene evidenziata già con il
Movimento Moderno in cui la progettazione del giardino assume un significato innovativo. Infatti, rispetto
all’Ottocento ed ai primi decenni del Novecento, nella progettazione delle nuove aree metropolitane ma anche
nella riqualificazione delle vecchie città, il parco pubblico appare come l’elemento innovativo che abbia in sé la
capacità di determinare la trasformazione qualitativa del modello di vita degli abitanti attraverso la realizzazione
di spazi pubblici. Tali spazi hanno assunto in questi ultimi decenni aspetti formali completamente differenti nei
paesi europei ma anche in quelli americani.
Analizzando alcuni progetti è possibile cercare di definire il ruolo che, oggi, riveste il parco pubblico nelle città
contemporanee. Lo stesso concetto di parco, dall’Ottocento al Novecento, si è modificato radicalmente. Quindi
sembra fondamentale cercare di definire quale possa essere il modello progettuale del futuro parco
contemporaneo. Ma per arrivare a definire il nuovo modo di progettare i parchi è necessario analizzare il
paesaggio storico. Si ritiene utile una lettura storica, valutando i notevoli cambiamenti che questa disciplina ha
subito nel giro di pochi decenni.
Tra i rappresentanti più significativi dell’architettura contemporanea si possono citare il pittore brasiliano
Roberto Burle Marx, lo scultore nippo-americano Isamu Noguchi, l’architetto messicano Luis Barragàn, a cui si
aggiunsero negli anni Cinquanta molti altri architetti paesaggisti quali tra gli altri Daniel Urban Kiley, Garrett
Eckbo, Geoffrey Jellicoe, Russel Page, Pietro Porcinai. Tra questi Roberto Burle Marx viene definito il “poeta del
paesaggio”. Si forma in Germania sotto l’influenza della scuola del Bauhaus.
I suoi progetti partono da una stretta relazione con l’ambiente circostante attraverso una lettura della storia e del
significato dei luoghi. Infatti, è evidente il legame con il sito che viene ad essere rivalorizzato con spazi destinati
all’uomo che non rinunciano allo sviluppo tecnologico del Novecento.
Figura contemporanea è il paesaggista francese Bernard Lassus che utilizza il colore e la luce nella
trasformazione del paesaggio. Da una presentazione di Laura Capone per una conferenza alla Provincia di
Salerno: “il punto di partenza è lo sguardo che aiuta a proporre una pratica sistemazione dei luoghi: esso incontra
gli oggetti e le loro relazioni, ne studia contesti e collocazioni, presupponendo il superamento di abitudini e
luoghi comuni e considerando soprattutto spazi e ambienti. Tra i suoi progetti più rappresentativi, e che mostrano
come il campo di applicazione dell’architettura del paesaggio sia cambiato rispetto ai secoli scorsi, vi è l’Area di
Sosta La Pierre de Crazannes, A837 (Autoroutes du Sud de la France) a Crazannes, Francia (1995).
Il progetto occupa un’ex cava in disuso, nei cui pressi passa l’autostrada del sud della Francia. Il progetto ha
previsto un’area di sosta, a servizio dell’autostrada, e una serie di percorsi che si integrano con l’ex funzione
dell’area e mirano a stabilire un rapporto con il paesaggio naturale. Oltre alla messa in sicurezza e conservazione
della cava, il progetto ha previsto di preservare il bosco di felci, elementi che rendono il paesaggio sorprendente.
Il dialogo tra l’ex cava e l’infrastruttura autostradale è stato garantito dalla creazione di punti di vista
paesaggistici verso questa area di servizio.
Per sottolineare il carattere specifico dell’area sono state evidenziate alcune funzioni che consentono
all’automobilista di conoscere il significato tipico del luogo, lungo il percorso stradale. Si ha una nuova
concezione del sistema autostradale determinando nuovi modi di percepire il viaggio e di usufruire delle aree di
sosta, ma anche un nuovo modo per riutilizzare le aree di risulta delle grandi infrastrutture e delle aree dismesse.
ARCHITETTURA E MODA,
IL RITORNO ALL’EDONISMO DEGLI ANNI ‘80
Raffaele Nappo
L’architettura è moda, una necessità Post Credit Crunch o semplice sviluppo del Modernismo?
L’Italia, paese della moda per eccellenza, come risponde a questi interrogativi e soprattutto accetta
questa associazione?
L’undicesima Biennale di Venezia ed il Credit Crunch sono due avvenimenti legati da coincidenza temporale
ma che adducono a diverse posizioni: uno verso la totale aderenza al sistema moda seppure con la fine di alcune
“linee” considerate “fuori moda” e “fuori mercato” e l’altra verso il ritorno all’ordine del costruire, riattivazione
dell’architettura del sociale, architettura nella continuità della tradizione. Posizioni divergenti e legittimate dal
confondere i valori dell’architettura ‘eterna’, stabile, duratura della cultura europea con i valori del Real Estate
della tradizione anglo-americana, tutto basato sulla rendita e sulla massimizzazione dell’investimento in un tempo
programmato. Quindi il vendere (mutui) su valori stabili e poi al consuntivo notare che la fluttuazione di mercato
ha ridotto il valore del bene ha procurato il crollo del sistema con il conseguente fallimento delle banche. Solo in
Inghilterra tale tracollo ha generato in un anno un aumento del 750% di architetti disoccupati ed, oltre agli impressionanti effetti occupazionali, il dato rilevante che emerge è l’incapacità del sistema economico di acquisire
valori su lunghi periodi. Un ulteriore effetto della crisi lo si riscontra con il cambio d’identità di Koolhaas, degno
seguace di P. Jhonson nel XXI sec., il quale con la lecture The Architecture of Difference al Renaissance Theater di Berlino il 1 aprile del 2009 ha annunciato un nuovo slogan: Generic Architecture. ‘L’ architettura generica’
riscopre la funzione, una semplicità frutto del momento, Koolhaas rinnega se stesso in un’azione delirante di chi
ha la consapevolezza di aver esaurito il suo dire. Forse inconsapevolmente Aaron Betsky, curatore della Biennale
veneziana, ha cercato di individuare una soluzione alla crisi, provocando la capitale della Serenissima con un ‘virus’ “Out there: Architecture Beyond Bulding”. L’idea di Betsky, oltre l’architettura, ha acceso una dura polemica e contestazione, come emerge dalle parole di F. Dal Co: «Totale ignoranza! Diseduca la gente poiché è solo un
riuso delle avanguardie degli anni ‘20 e non c’è nulla di nuovo» e ciò ha delineato in modo netto due fronti, due
visioni del progredire dell’architettura. Il curatore, definito “Teorico senza Architettura”, pone la questione sul
desiderio dell’architettura, tralasciando il nesso con il costruito. Esaltazione dell’architettura desiderata come costruzione sociale, un modello per superare la crisi, egli proietta l’architettura esplicitamente al sistema Moda. Il
nesso desiderio-società dichiarato alla mostra, prima ancora di Betsky, fu posto dal filosofo Jeremy Bentham con
il pensiero utilitaristico: “La natura ha posto l’umanità sotto il governo di due sovrani:la pena e il piacere”
quindi l’uomo ha adeguati motivi solo per seguire i propri interessi verso la ricerca del piacere in tutte le scelte
consapevoli. L’idea quindi di una società edonistica sviluppa il sociale ed ha trovato rapida trasposizione in Architettura, infatti lo stesso filosofo progetta il carcere Panoptico, un esempio di progettazione basato sul rapporto
desiderio \ utilità e controllore \ controllato, sistema adottato in parte negli interventi politici economici della M.
Thatcher e R. Reagan durante gli anni ‘80 fin da coniare il termine giornalistico “edonismo reganiano”. Non è un
caso che con la mostra Deconstructivist Architecture del 1988 al MOMA di New York, P. Jhonson lancia
l’architettura della ‘moda dei desideri’ basata su una zelante comunicazione e su valori consumistici. L’aderenza
al sistema moda dell’architettura sembrerebbe essere un’ imposizione del mercato ma forse è solo l’evoluzione
del Modernismo. Il passaggio dalla funzione al segno, avvenuto negli anni ‘50-’60, legittima l’attuale aderenza
alla logica della moda. L’arbitrarietà del postulato funzionalista “per ogni forma e per ogni oggetto esiste un significato oggettivo determinabile: la sua funzione” argomentato da J. Baudrillard adduce allo scioglimento del
legame oggetto-funzione e fa si che l’oggetto non sia legato al bisogno ma ceda al campo dei Desideri. L’oggetto
predisposto al consumo dialoga con il consumante attraverso un tempo sospeso tra consumo e desiderio. Il processo è riproducibile all’infinito e quindi il sistema capitalistico lo ha inserito all’interno di esso, mediante la
pubblicità come azione desiderante. Con tale logica si costruisce la città, mediante individui e singoli edifici, non
più ricercando una metafisica organicità di essa, un disegno unico nel rispetto della tradizione e stereotipati valori
etici ma architetture singole, sciolte, desiderate e consumate da un numero sempre più grande di «Prigionieri Volontari» . La città cosi diventa produzione e consumo nel medesimo tempo, accettando logiche speculative
(l’uomo è speculativo) e trasportando gli edifici in un ciclo produttivo non più legato all’eternità. Una prima
smentita è che l’architettura “edonistica” non annulla il sociale ma lo fortifica e lo potenzia. L’architettura come
moda, oltre ad estetizzare forme e luoghi, giunge a condizionare quartieri e città intere. Pensiamo a tutti i luoghi
d’incontro, di socializzazione accanto ai negozi più glamour: un esempio è Carnaby Street a Londra dove i negozi
sono contemporaneamente esposizioni temporanee di artisti emergenti ed attività commerciali. Le vetrine espongono merce sotto forma di arte o arte sotto forma di merce, creando con le pubblicità il design, uno spettacolo da
consumare a tutte le ore. N. Firket e M. Schaefer nel testo Content di Koolhaas descrivono il Prada Store in Broadway come «non più un negozio ma una linea del tempo di produzione di eventi e media. Prada non è un cliente
ma un collaboratore, una fonte di contenuti»). La logica della Sensory Street, come descritta dal sociologo W.
White, si presenta come un messaggio prevalentemente culturale e sociale attraverso la decodifica del testo (immagini) in desideri, ambizioni, interazione sociale. Tale logica risponde esaustivamente a chi invoca, come il
Prof. Arch. R. Nicolini che «l’architettura ritorni ad occuparsi di sociale») o come Botta che denuncia la totale
assenza della carica etica morale dell’architettura, sostenendo che dal Rinascimento in poi l’utilizzo della pietra e
del mattone è stato inteso per costruire la vita, la città e non edifici autoreferenziali. Inoltre sottolinea come sia
aberrante vedere la città europea estromessa della sua identità, adducendo che il mondo dell’architettura abbia
trovato nella ludoteca dell’arte contemporanea una forma di consumo e di divertimento per il pubblico di massa.
Riprendendo le parole di F. Dal Co è chiaro che l’architettura odierna è solo un effetto della “Morte
dell’architettura” espressa da Tafuri, individuando una destabilizzazione dell’organicità già all’interno del Campo
Marzio di Piranesi. Nel sistema Moda e Architettura si nota come le tecniche dell’una si ritrovino anche nell’altra
come per esempio il drappeggio, la piegatura, la stiratura, oggi supportate da medesimi software che conferiscono
alte potenzialità creative e quindi progettare con Nurbs un abito, un paralume o una copertura dell’auditorium di
Los Angeles di Gehry lo si fa con lo stesso procedimento, con le stesse macchine a controllo numerico. Tale
confluenza
di elementi illustrati è stata esaustivamente esposta da Bradley Quinn, curatore della mostra The Fashion of Architecture alla Deluxe Gallery di Londra nel 2004 e poi al Centre for Architecture di New York nel 2006, comparando il lavoro di certi architetti con quello di certi stilisti, dall'olandese Winka Dubbeldam al giapponese Shigeru
Ban, passando per l'angloirachena Zaha Hadid fino a Yohji Yamamoto e a Martin Margiela. Il vestire un consequenziale ed entrambi estetizzano gusti e tendenze dei desideri della società. Tale adesione è fortemente criticata
e definita da V. Gregotti “scenografie” e non architettura, ponendo ontologicamente dei limiti nell’operare nella
società. Da Jeremy Bentham, Georg Simmel a Jean Baudrillard, da Ortega y Gasset a Paul Virilio in tanti hanno
individuato, seppure con sfumature diverse, nel sistema moda la creazione, il consumo, l’appartenenza dei desideri della società ed in nome di questi si sviluppa, evolve e migliora «l’intero universo visibile che altro non è
che un repertorio di immagini e segni in cui l’immaginazione assegnerà posto e valore relativo; è una sorta di
nutrimento che l’immaginazione deve dirigere e trasformare» . L’architettura è legata al sistema moda ed è connessa imprescindibilmente al costruire con i relativi tempi lunghi. Un’associazione frutto dell’evoluzione del
Modernismo che conduce l’architettura alle esigenze contemporanee, una condizione imprescindibile, in particolare per i giovani architetti per generare risposte attuali alla crisi mediante soluzioni innovative, low cost, utilizzando anche la storia come fonte d’ispirazione, il tutto al passo con i desideri della società. In parte il fare di Palladio, nell’inventare una nuova Venezia attraverso il tema delle ville dopo il crollo economico del regno del doge
dovuto allo spostamento dei traffici mercantili obbligati dalla scoperta dell’America, è più di un suggerimento ma
è un ritorno al Modernismo. Ad ogni modo l’architettura ha compimento dai desideri della società, rinnegando la
soluzione banale alla crisi proposta dal critico del Times Nikolai Ouroussoff cioè quella di «un’ architettura in
culotte spogliata delle inutili paillettes». In tempi di magra i desideri si rafforzano e non diminuiscono.
ARCHITETTURA E CRISI GLOBALI
Tomaso Garigliano
Il carattere virtuale della crisi economica che sta attraversando il nostro sistema finanziario in questo periodo è
l’espressione di un atteggiamento di spregiudicatezza che ha caratterizzato molte attività umane negli ultimi venti
anni. In nome di una deregulation iniziata con stimoli alla liberalizzazione o al laissez faire (letteralmente “lasciar fare”), inventato da una classe politica Thatcheriana, egemone negli anni ottanta, improntata su un individualismo opportunista e reazionario travestito da libertà d’iniziativa hanno creato un sistema economico estremamente fragile. Questa crisi, ha colpito finora interi settori ed enti della finanza mondiale, provocando fallimenti o nazionalizzazioni di banche, istituti di credito, agenzie immobiliari ed altre strutture che basano la loro esistenza non su oggetti tangibili, ma su debiti, interessi, cedole, mutui, e altre forme di denaro virtuale.
Il risultato di questa visione del liberismo ha causato l’allargamento del divario sociale, in quanto sempre più la
ricchezza è divenuta virtuale, gonfiata e sgonfiata con estrema rapidità dal sistema borsistico, accessibile solo a
chi ha una base di beni reali tangibili atti a garantire la porzione di ricchezza volatile.
Le conseguenze innescate da questi comportamenti investono ovviamente tutti i settori, da quelli di base come
l'occupazione, ad altri meno evidenti come i beni paesaggistici ed artistici, che - vale la pena ricordarlo - sono per
l'Italia l'unica autentica materia prima.
Sulle iniziative con cui l'attuale amministrazione dello Stato affronta questi argomenti è meglio stendere un velo
pietoso, mentre è invece interessante approfondire, anche se in linea ipotetica, un aspetto storico-morale che si sta
già da alcuni mesi diffondendo tra gli architetti e gli studiosi d'architettura: la crisi economica avrebbe infatti determinato la drammatica e repentina fine della discussa tendenza decostruttivista, che da un paio di decenni almeno genera furiose liti d'opinione tra archistar, critici, pubblico ed amministratori.
Vittorio Gregotti e Franco La Cecla, storici nemici delle pazzie di Frank Gehry e soci, sono stati tra i primi a sostenere che il decostruttivismo doveva scoppiare. Una bolla architettonica, molto simile alla bolla economica che
decretò la fine della folle corsa all’acquisto delle azioni della new economy che avvenne nel 1998, e che era un
chiaro invito al ritorno ad una economia di beni reali più che di immagine, invito purtroppo non raccolto, colposamente, da una vorace classe economica che ci ha portati alla situazione odierna.
L’inutile copiosità di alcune architetture di quel periodo, sono infatti il punto di arrivo di una deriva architettonico - ideologica lunga 40 anni che, dal mantra form follows function, è giunta a quello di form follows fashion, di
fatto svuotando della prerogativa funzione sociale l’attività architettonica, e trincerandosi negli angusti confini di
forma d’arte, figurativa, come si è potuto constatare da molte proposte dell’ultima biennale. Questo in parte è dovuto anche alla politica, che, avallando la progressiva privatizzazione della cultura e dei servizi, ha permesso alle
fondazioni e alle strutture private di autorappresentarsi attraverso architetture che puntano tutto sulla retorica e
non sull’efficacia e la sensibilità verso il contesto.
Ma, questa biennale ha, nonostante o grazie ai suoi contenuti, aperto gli occhi alla critica, mettendo in risalto
che non è più tempo di retorica e sprechi, che le speculazioni intellettuali o sperimentazioni formali sono appunto
beyond architecture, e quindi non vadano costruite, a maggior ragione adesso che non ci sono più i soldi (ma non
c’erano neanche prima, in quanto erano virtuali).
Si è risvegliata una corrente critica che sta diradando l’atmosfera da bulimia filosofico - formale che ha caratterizzato scuole come l’AA o Sci - Arch, le quali, come dicono molti loro ex allievi degli anni settanta e ottanta,
sono divenute elitarie, troppo salottiere, poco interessate se non infastidite dai bisogni immanenti della gente comune.
Ogni recessione ha avuto i suoi lutti ma anche i suoi contraccolpi positivi. La crisi petrolifera globale del ’74
concluse, contraendo il mercato immobiliare privato, la stagione brutalista e modernista. In seguito, gli architetti
si riorganizzarono e reagirono con il postmoderno, ma di nuovo, la strada novissima fu già il canto del cigno di
quel pensiero. Lo slogan di Venturi “less is bore” (il meno è noia) fu subito messo da parte quando finirono i
soldi dei privati e si dovette pensare a come spendere efficacemente ed eticamente il denaro dei contribuenti costretti a fare la settimana corta per non sacrificare posti di lavoro.
Questo pulsare dell’economia con cadenza cronica e prevedibile, è in qualche modo anche la garanzia del rinnovamento; l’alternanza consumismo – austerity, creatività ed entusiasmo degli investimenti privati - sobrietà del
pubblico, ha la funzione di mitigare e filtrare i migliori risultati, incanalare gli investimenti pubblici in opere etiche e necessarie, potare i rami sterili e fini a sé stessi.
Quello che la politica internazionale e italiana stanno cercando di fare, infatti è fare ripartire e gli investimenti
pubblici e arginare il pessimismo. Lo stimulus di Obama ha previsto miliardi di dollari per l'architettura e per le
infrastrutture, intese come attività concrete di investimento economico. E, come si sa, lo stimulus nel suo complesso vuole essere un intervento etico più che finanziario, concreto appunto e non creativo.
Morte del decostruttivismo allora? Morte forse di un'idea di architettura, anche se potremmo certamente considerare un peccato, la perdita di tanta capacità inventiva: si vedano i risultati comunque straordinari dal punto di
vista artistico di certe follie progettuali, come gli affollatissimi musei progettati da Gehry, da Hadid, da Libeskind. Ma dove collocare architetti come Toyo Ito e SANAA che, pur annoverati tra le archistar, hanno fatto invece della sobrietà un segno di riconoscimento? La loro ricerca, veramente orientata verso un’efficacia moderna e
l’inclusione in modo non esibizionistico delle nuove tecnologie e del virtuale, dovrebbe sopravvivere a questo
contraccolpo, anche grazie alla innegabile maggiore sostenibilità economica dell’orsogril di SANAA rispetto al
titanio di Gehry.
E su queste ipotesi, che ci attendiamo un sincero e condiviso ritorno all’etica in architettura, ecco un profilo
schematico dei motivi che, secondo noi, animeranno questi cambiamenti imminenti.
a) La prima ragione è economica.
Se come guida si pone l'economia, ne seguono la fine degli sprechi, perlomeno in tutti quegli ambiti dove la
rappresentatività è superflua, e l'inizio del risparmio energetico esteso alle caratteristiche formali. Ad esempio, se
l'obbligo di dotarsi di pannelli solari corrisponde a una funzionalità, l'aspetto del pannello che sostituisce la copertura deve diventare un elemento formale forte. L'utilizzo di materiali non dispersivi, di intercapedini, di tamponamenti efficaci, sarà da un lato utile dall'altro determinante nell'aspetto esterno. La bio-architettura si occupa
da tempo di questi temi, ma in modo – se vogliamo – quasi artigianale, mentre qui ci si aspetta uno sviluppo massiccio ed industriale dei sistemi nuovi, costruiti e risolti dalle tecnologie informatiche, in modo tale da ingenerare
una rivoluzione edilizia simile a quella portata dal cemento armato cento anni fa.
b) Viene poi la ragione ecologica.
Si è appena sottolineato come l'aspetto economico comporti l'assenza di sprechi, e in architettura gli sprechi nascono non solo da ciò che si spende per costruire, ma anche in seguito per mantenere. Per ecologico invece
s’intende un edificio che rispetti l'ambiente nel suo complesso, e che quindi – come per l'organicismo di Wright e
per la citata bioarchitettura di oggi – appartenga in modo naturale al luogo in cui si trova ad essere costruito. Un
museo a Bilbao e un teatro dell'opera a Los Angeles non possono essere uguali per materiali, forma, proporzioni.
c) C'è infine una ragione democratica.
La diffusa committenza privata che ha caratterizzato gli ultimi trent’anni di liberismo, ha posto l’accento su
un’architettura dagli altissimi costi e prevista per un’utenza dalle ampie possibilità economiche in modo da fare
quadrare gli investimenti, vedi Dubai. Questa architettura neo-aristocratica, non dovendo badare a spese, non
sempre si cura di ottimizzare i due punti esposti in precedenza: economia ed ecologia, usandoli il più delle volte
come dei pretesti per farne un’immagine pubblicitaria dalla dubbia efficacia. Il ritorno all’attenzione su questi tre
principi: economia, ecologia e democrazia, dovrebbe essere la chiave di volta della risoluzione della crisi, adottando a posteriori il suggerimento dell’ultima biennale del secolo scorso che recitava: “Less aesthetics, More ethics”.
VIAGGIO IN ERITREA,
DICEMBRE 2002 - GENNAIO 2003
Per le strade di Asmara itinerario
architettonico modernista
Regina Bandiera
1.Villa Roma, esempio di architettura coloniale
della fine del XIX secolo.
2. Piano della città di Asmara 1938
3 Antonio Vitaliti, Villa Grazia, 173-10
Street, Asmara, 1942
Asmara,
capitale
dell’Eritrea,
ubicata
sull’altipiano eritreo (2400 m slm ca.), gode di
una buona posizione geografica e di un clima
temperato pur trovandosi in una latitudine
compresa tra il tropico del cancro e l’equatore.
La prima impressione che si ha visitando
Asmara è quella di trovarsi in una città europea;
l’impianto regolare, definito da chiare gerarchie
tra gli spazi urbani, denuncia un disegno urbano
preciso dove gli edifici diversi per funzione
(Aree di servizio, Cinema, Edifici d’abitazione,
Fabbriche, Hotel, Ville, Fontane, Uffici,
Ministeri), ricoprono diversi ruoli nella
definizione dello spazio della città: alcuni
fungono da elementi riconoscibili della struttura
urbana, altri “costruiscono” la “forma della
città”stessa.
La compresenza dei tipi edilizi tradizionali e dei
tipi edilizi di modello europeo determinano una
netta divisione tra la parte pianificata della città e
le parti che sono cresciute intorno al centro in
maniera spontanea.
Seppure all’interno della parte “europea” della
città coesistono edifici dai caratteri più disparati
(architetture “retoriche”- architetture dall’aspetto
“futurista”- architetture caratterizzate da forme
geometriche pure), in tutti gli edifici della città si
può riscontrare un diverso grado di assimilazione
del movimento razionalista sviluppatosi in
ambito europeo.
Colonia italiana dal 1895 al 1941, Asmara
possiede una grande concentrazione di alcune tra
le più avanzate architetture del 1930.
La città di Asmara è stata, sin dall’arrivo degli
Italiani, plasmata secondo due indirizzi
fondamentali - la residenza e il commercio - con
edifici che rapidamente sostituirono gli
stanziamenti militari.
Ben presto fu evidente la necessità di regolare la
crescita della città, prevedendo la costituzione di
due quartieri residenziali, uno riservato alla
comunità europea, l’altro alle popolazioni
autoctone, separati dalla zona amministrativa
della città; nella periferia dell’agglomerato
urbano era prevista l’ubicazione delle industrie.
I piani che si sono avvicendati nella costruzione
della città hanno sempre considerato la
progettazione dello spazio pubblico come
elemento qualificante.
Il quartiere residenziale europeo, è costituito
essenzialmente da ville con giardino, dal
carattere eclettico in stile neogotico, neoclassico,
moresco, romanico (figura 1).
Il quartiere amministrativo e la cintura costituita
dalle fabbriche, sono state le zone della città più
soggette a cambiamenti, ristrutturazioni, nuove
edificazioni.
Gli esempi di architettura dei questo periodo
sono tra i più pregevoli della città: dal carattere
retorico,
neo-futurista
o
razionalista,
rappresentano una importante parte della ricerca
architettonica italiana e internazionale.
Le architetture “retoriche”
In questo primo caso, il linguaggio
dell’architettura razionale è ridottissimo se non
assente; alla retorica della facciata è delegato il
messaggio principale che deve trasmette
l’architettura (proporzioni, uso dell’ordine
gigante, utilizzo del repertorio formale della
tradizione classica italiana, posizione strategica e
visibile nella città, sistemazioni dell’intorno).
Alcuni esempi di questo tipo di architetture sono
dati da Villa Grazia di Antonio Vitaliti, un
edificio per abitazione completato nel 1942 (rif.
mappa 1), dal Cinema Impero di Mario
Messina, costruito nel 1937 (rif. mappa 5), dal
Cinema Roma di Roberto Cappellano e Bruno
Sclafani, realizzato tra il 1937 e il 1944 (rif.
mappa 14) e dal Ministero dell’istruzione, ex
Casa del Fascio, di Bruno Sclafani, del 1928 (rif.
mappa 9).
4.Mario Messina, Cinema Impero, Harnet
avenue, 176-21 street, Asmara, 1937
costituita da un grande riquadro marmoreo entro
il quale grandi lettere in metallo, disposte in
corrispondenza di quattro finestre quadrate,
scandiscono il nome ‘Roma’.
5.Roberto Cappellano, Bruno Sclafani,
Cinema Roma, Sematat Avenue, Asmara, 1937-44
6. Bruno Sclafani, Ministero dell’istruzione,
ex Casa del Fascio, Harnet Avenue/Keskese Street,
Asmara, 1928-1940
Il primo edificio presenta quella commistione di
elementi del repertorio formale dell’architettura
moderna (corpi arrotondati, aperture orizzontali,
superfici lisce) e dell’architettura classica e
tradizionale (archi a tutto sesto, superfici in
mattoni a vista) che caratterizza larga parte della
ricerca architettonica italiana tra le due guerre
(Mazzoni, Ponti, Vaccaro).
Il secondo edificio è caratterizzato, all’esterno,
da una pensilina che aggetta al primo livello e dal
paramento murario di colore rosso bruno sul
quale, ai suoi lati, si stagliano, disposte in
verticale, le lettere che scandiscono il nome del
cinema. Nella superficie superiore si ritagliano
tre nicchie disposte in corrispondenza delle
aperture al livello inferiore; queste, al loro
interno, sono articolate dalla presenza di finestre
a nastro intervallate a file di lampade di forma
circolare.
Il terzo edificio è forse il più austero di Asmara:
la ex Casa del Fascio è un esempio di architettura
monumentale fascista.
Anche l’ultimo edificio è caratterizzato dalla
presenza di colonne e modanature, una scalinata
della dimensione pari a quella occupata dagli
ingressi, dove la fascia superiore del fronte è
architetture “futuriste”
Nel secondo caso gli edifici sono ispirati
formalmente all’architettura “futurista” in cui si
può notare come il linguaggio del movimento
moderno viene sperimentato all’interno di schemi
compositivi che sono strettamente legati alla
tradizione classica. La componente che risulta
più evidente è l’utilizzo dello stile razionalista
insieme alle peculiari specificità dell’architettura
italiana; la costruzione dello spazio pubblico
risulta così integrata nella progettazione di ogni
singolo edificio, raggiungendo una qualità pari a
quella delle migliori produzioni del movimento
moderno.
Alcuni degli esempi più interessanti di questo
tipo di edifici sono: la Fontana Mai Jha–Jha,
autore sconosciuto, 1938 (rif. mappa 3), il
Cinema Capitol di Ruppert Saviele, 1938,
ricostruito nel 1944 (rif. mappa 10), l’Area di
servizio Tagliero di Giuseppe Pettazzi, 1938 (rif.
mappa 12) e la Fabbrica della gomma, ex
Agenzia Lancia, di Carlo Mancini e Carlo
Montalbetti, 1938 (rif. mappa 13).
In tutti gli edifici le proporzioni, la
composizione, il linguaggio utilizzato dai
progettisti hanno un riferimento chiaro al
repertorio formale dell’architettura del secondo
futurismo ispirandosi esplicitamente ai disegni di
Sant’Elia.
architetture caratterizzate da forme geometriche
pure
Il terzo ed ultimo caso trattato è quello degli
edifici “razionalisti”, nei quali sono sperimentati
i temi e i materiali della nuova architettura con
chiari riferimenti all’architettura espressionista e
moderna sviluppatasi in ambito europeo. Questi
caratteri riscontrabili in edifici come Palazzo
Mutton di Antonio Vitaliti, costruito nel 1944
(rif. mappa 4), il Ministero del Turismo, ex
Edificio dei Lloyds, autore sconosciuto, 1938 ca.
(rif. mappa 6), Palazzo Mazzetti di Aldo
Buzzagli, 1939 (rif. mappa 7) e Palazzo
Lazzarini di Roberto Cappellano, 1937 (rif.
mappa 8).
Il primo edificio, nel progetto originario,
chiaramente ispirato al Novocomum di Terragni,
prevedeva sei elevazioni, delle quali solo due
realizzate.
Nel secondo la caratterizzazione formale è
affidata a due elementi: il volume angolare
arrotondato e smaterializzato dalla presenza di
grandi aperture vetrate che definisce l’incrocio
tra le due strade e le logge (concepite come veri e
propri brise-soleil sovrapposti al paramento
murario) che lo racchiudono evidenziandone la
verticalità.
Il terzo edificio, composto da due volumi
affiancati di diversa altezza, è ulteriormente
articolato dalla presenza di logge sovrapposte al
paramento murario del volume angolare. La
soluzione d’angolo, evitando la divisione tra i
due prospetti ortogonali, mette in scena l’idea di
continuità tra le due superfici.
Nell’ultimo caso, la realizzazione dell’edificio
presenta delle variazioni rispetto alla proposta di
progetto che nelle sue diverse versioni prevede
l’utilizzo di finestre a nastro e un gioco di volumi
puri.
Gli edifici presentati in questo breve scritto
esprimono più liberamente alcuni dei caratteri
esplorati dall’architettura italiana nei primi anni
del Novecento.
In concomitanza con l’affermarsi dei caratteri
dell’architettura moderna in Europa e in Italia,
con le sue varie declinazioni, l’occasione offerta
dalla fondazione (rifondazione nel caso specifico
di Asmara) delle nuove città, in patria e nelle
colonie, durante il Ventennio fascista permette di
mettere in pratica, pur portandosi dietro la
dicotomia tradizione-moderno, i nuovi principi
architettonici unitamente alle nuove tecniche
costruttive (ibridandole talvolta con gli elementi
e i materiali del luogo, come ad esempio accade
in molti edifici costruiti nella città di Massawa),
senza tralasciare la lunga tradizione di
costruzione di spazi urbani dalla figura
riconoscibile.
Il riflesso della ricerca architettonica svolta in
Italia dal MIAR il Movimento Italiano per
l’Architettura Razionale (che coinvolse, tra gli
altri, Edoardo Persico, Ignazio Gardella,
Giovanni Michelucci, Franco Albini e i BBPR
(Banfi, Belgiojoso, Peresutti, Rogers), e dalla
“scuola romana” (che trova in Marcello
Piacentini l’esponente principale), è ben visibile
nelle realizzazioni d’oltremare, dove la strada del
monumentalismo e della “tradizione” corre
parallelamente alla ricerca architettonica
“moderna” con risultati che superano alle volte le
realizzazioni in patria.
7. Progettista sconosciuto, Fontana Mai Jha
–Jha, Marsa Teklay street/173-18 Street, Asmara, 1938
11. Antonio Vitaliti, Palazzo Mutton, strada
per Ginda, Asmara 1944
8. Ruppert Saviele, Cinema Capitol, Denden
street, Asmara, 1938
12. Giuseppe Terragni, Novocomum, Como,1927-29.
9. Giuseppe Pettazzi, Area di servizio
Tagliero, Emperor Teohsofos Square, Asmara, 1938
15. Roberto Cappellano, Palazzo Lazzarini,
edificio per abitazione e commercio, strada per
Segeneyti Asmara, 1937
13. Progettista sconosciuto, Ministero del
Turismo, ex Edificio dei Lloyds, Harnet Avenue,
Mata street, Asmara, 1938 ca.
Nel
dicembre
del
2002-2003
grazie
all’esperienza lavorativa e di studio in Eritrea di
due colleghi e amici, Sabina Branciamore e
Filippo Amara, ho potuto conoscere l’immenso
patrimonio architettonico della città di Asmara,
cosa che mi ha permesso di studiare e
approfondire la conoscenza dell’architettura
coloniale italiana in generale.
10. Mancini e Carlo Montalbetti, Fabbrica
della gomma, ex Agenzia Lancia, Tegadelti street,
Asmara, 1938
14. Aldo Buzzagli, Palazzo Mazzetti, Harnet
Avenue/Denkel street, Asmara, 1939
Fonti iconografiche
Annali dell’Africa Iitaliana, Roma, 19.
Le Capitali del mondo, Milano, 1925.
Collezione privata, Famiglia Matteo da Reviglio.
Eritrean Cinema Administretion, Asmara.
Eritrean studies centre, Asmara.
Guerra Itali-Abissina documentata e illustrata, Milano 1896.
E. Denison, G.YU Ren, N. Gebremedhin, Asmara’s Secret
Modernist City, London-New York, 2003.
E. Denison, G.YU Ren, N. Gebremedhin, Asmara, A guide
to the built environment, the cultural assets rehabilitation
project, Asmara, 2003.
Viaggio in Eritrea, Dic 2002 - Gen 2003
LA VISIBILITÀ DELL’ARCHITETTURA COME TEMA PER L’ALLOGGIO CONTEMPORANEO
Luca Romano
Oltre una certa massa critica ogni struttura diviene un monumento, o quanto meno suscita tale aspettativa
semplicemente con la propria dimensione, anche se l’insieme o la natura delle singole attività che accoglie non
prevederebbero un’espressione monumentale.
Questo tipo di monumento determina uno strappo radicale e moralmente traumatico per le convenzioni
simboliche: la sua manifestazione fisica non rappresenta un ideale astratto, un’istituzione di importanza
eccezionale, un’articolazione tridimensionale e comprensibile di una gerarchia sociale, una commemorazione;
esso è semplicemente se stesso e, a causa del suo volume, non può evitare di diventare un simbolo – magari
vuoto, disponibile ad accogliere significati allo stesso modo in cui un tabellone pubblicitario accoglie i manifesti.
E’ un solipsismo che celebra soltanto la propria esistenza sproporzionata e la sfrontatezza del proprio processo
creativo.
Il monumento del XX secolo è un Automonumento, e il Grattacielo ne è l’espressione più pura.
Rem Koolhaas
(cit. da Delirious New York, 1978, ed. it. a cura di M. Biraghi, Delirious New York. Un manifesto retroattivo per Manhattan, Electa,
Milano, 2001, pp. 92-93).
La lettura dell’architettura non è quasi mai frutto di una intenzione ma rientra in una condizione distratta, di
benjaminiana memoria; spesso la si vede in modo inavvertibile, subliminale e, quasi sempre, in relazione ad altri
manufatti che interferiscono nella sua percezione che avviene per sequenze parziali, dettagli, scorci, rendendo la
sua presenza nell’esperienza della città un evento incidentale. Alcuni rifiutano questa caratteristica componendo
deliberatamente (ed indifferentemente rispetto alla diversità dei contesti) un’architettura che sia figurativamente
eccezionale, formalmente e dimensionalmente dirompente, tale da non passare inosservata, gerarchicamente
superiore (nel caso specifico dei centri storici) rispetto alla messe di edifici che invece si piegano ad una
conformità tipo-morfologica, a una tonalità ambientale diffusa. O viceversa concentrano i segni in una estrema e
rigorosa economia di mezzi espressivi perseguendo, in ogni caso, come obiettivo fondante del comporre la
visibilità dell’opera (operazione condivisibile quando si interviene nelle periferie moderne e post-moderne,
territori dagli ampi orizzonti ma dai pochi segni architettonici significativi, che si prestano alla realizzazione
necessaria di landmark).
Prerogativa di questi anni è, da un lato, come sottolinea De Michelis, l’oggetto architettonico trasparente,
traslucente e leggero e, dall’altro, la predilezione per le configurazioni scultoree, isolate e conchiuse rispetto al
contesto circostante –monolitiche, impenetrabili- partorite da autori che prediligono indifferentemente l’una e
l’altra maniera (Herzog & De Meuron, Koolhaas, Nouvel, …), perché il problema di fondo è in realtà il rapporto
tra manufatto architettonico e struttura urbana ed il tentativo di condensare in una figura conchiusa quella risposta
al luogo che un approccio analitico-tipologico non riesce più a formulare. Infatti, la dissoluzione della città come
manufatto perfettamente concluso, intelligibile, priva l’architettura dell’oggetto del suo progetto conoscitivo e
della possibilità di dedurne quei “tipi” ai quali erano affidate l’autenticità e le certezze della sua pratica. “La
perdita crescente di significato dello spazio urbano, la sua crescente indistinta anonimità, i caratteri di
drammatica discontinuità […] hanno sollecitato gli architetti a condensare nel perimetro chiuso dell’edificio la
pulsante complessità di funzioni e di attività un tempo propria degli spazi urbani.” L’ibridazione tipologica
diventa così pressoché la norma.
Si tratta di condensatori sociali che soddisfano e alimentano i bisogni ancora vivi di vita collettiva. Concentrano
indifferentemente in una estrema e rigorosa economia di mezzi espressivi o, al contrario, in elaborate
performance plastiche, il loro carattere di segnali nel panorama urbano, di “accumulatori di significato”.
Con riferimento agli accennati bisogni di vita associata e di spazi a questa deputati possiamo affermare che se,
in passato, nella città europea il dualismo pubblico-privato aveva l’evidenza di cose realizzate e fisicamente
separate, oggi ci si pone l’interrogativo se si può pensare ad “uno spazio pubblico concepito nella pluralità: non,
cioè, come un solo spazio, un solo luogo, ma tale da definirsi nel molteplice, in una sorta di deriva, o di
esplosione.” Tenendo conto della labilità di confine tra ciò che oggi è privato e ciò che è pubblico (le ‘piazze’
telematiche lo confermano), della caduta del tradizionale concetto di pubblico, come sinonimo di ‘esterno’, e
viceversa, privato come ‘interno’, chiuso, ci si può interrogare sulla qualità delle intersezioni, delle ‘zone grigie’
che coinvolgono necessariamente anche lo spazio domestico, aprendolo spesso a contatti con l’esterno finora
inediti (ad esempio, soddisfacendo tra le esigenze dei suoi fruitori anche quelle produttive). Non è su questo che
qui si vuole riflettere ma su un problema di ordine generale che riguarda la composizione degli edifici, al di là
della funzione e del dove.
Sia che si progetti per la città storica sia che lo si faccia per la periferia, come già lucidamente rilevava Branzi
negli anni ottanta quando il fenomeno era agli albori, non è più il costruire l’atto centrale del progetto ma il
comunicare pubblicamente la costruzione. Si registra il progressivo e definitivo distacco dall’era delle tecnologie
meccaniche –l’estetica macchinista della modernità- quando la comunicazione avveniva per movimento di masse,
rotazione e scorrimento di corpi, per accostarsi ad una nuova estetica –post-moderna- legata alla leggera
bidimensionalità immateriale delle tecnologie informatiche, all’architettura dell’immagine. L’aspetto negativo
della vicenda è la frequente deriva formalista cui si assiste quando l’architettura non nasce più dalla teoria ma
dall’istantaneità di un gesto grafico, che non rimanda ad altro che a se stesso, o dalla supina adesione alla ‘moda’,
diventando maniera.
In pratica l’architettura è diventata oggi un’arte pura, gratuita, da dare in mano a grandi artisti e non agli
storici; essa non corrisponde più infatti alla soluzione di problemi costruttivi in maniera artistica, ma piuttosto
all’invenzione, in maniera artistica, di nuovi problemi costruttivi.
Questa libertà pone finalmente l’architetto davanti alle sue responsabilità di artista e non di costruttore, nel
senso che la costruzione è solo una premessa remota, come tutti i materiali rispetto all’arte. Muratori che sanno il
latino (come diceva Adolf Loos) non servono più; questa sorta di ricatto non funziona, nel senso che costruire
non è oggi un problema, e sapere il latino non è detto che serva a realizzare linguaggi di massa efficienti, né case
calde di intimità [il corsivo è nostro, NdA].
Del resto, il dibattito teorico e le posizioni operative nella nostra disciplina sono quanto mai plurali. Non manca
chi persegue una ricerca di tutt’altro indirizzo, opposta all’accettazione dell’atopia fatta espressione assoluta
senza tuttavia rinunciare né alla riconoscibilità individuale, subendo oltre misura la ‘dittatura’ del luogo che
diventa automatismo e mimesi formale, né alla scala umana come parametro di controllo dell’atto progettuale. Di
questo si parlerà a breve.
Negli anni Settanta, alcuni artisti minimalisti, fra cui Donald Judd, Robert Morris, Carl Andre e Richard Long,
lavorarono ripetutamente su elementi tridimensionali semplici (ma anche su lastre), realizzati in vari materiali e
caratterizzati da una forte essenzialità tendente a escludere “qualsiasi tipo di esplicito rimando contenutistico o di
rapporto relazionale con lo spazio circostante”.
Il rigore formale che l’uso di un solido elementare comporta, al limite dell’assenza assoluta di espressività, nelle
tendenze attuali dell’architettura domestica italiana che positivamente attingono a questo serbatoio teorico ed
iconografico, viene contrastato da una ricca articolazione della superficie, riprendendo in qualche modo e
consapevolmente motivi cari alla ricerca italiana degli anni cinquanta sull’abitazione. E’ ormai esaurita
l’esperienza figurativa moderna della scacchiera o griglia che Le Corbusier vedeva applicate esemplarmente nei
prospetti delle fabbriche americane e che, ripetuta in maniera ossessiva ed approssimata nelle nostre città, ha
portato all’impoverimento dell’immagine urbana; la volontà di imprimerle un’appagante varietà – riannodando il
filo con quelle esperienze su menzionate colpevolmente interrotte- si sposa alla necessità di superare l’idea
dell’edificio per appartamenti come monotona ripetizione in altezza del medesimo piano-tipo, recuperando la
compiutezza formale dall’archetipo del palazzo. In definitiva, viene contrastata la staticità peculiare della purezza
stereometrica (una staticità che è necessaria base di partenza proprio perchè si presta ad innumerevoli
manipolazioni) e si attinge ad un’altra tradizione estetica diametralmente opposta al razionalismo: il pittoresco.
Ricordando che il tema residenziale circoscrive le possibilità di sperimentare liberamente -ci sono delle ‘regole’
bene o male da rispettare (per quanto tempo ancora?): “i piani sono orizzontali, le pareti sono verticali. Le
condizioni per elaborare un’architettura scultorea, neorganica, vengono meno. C’è la profondità del corpo di
fabbrica, una inevitabile serialità.” - il problema compositivo che viene affrontato nel progetto dell’edificio per
appartamenti, oggetto di queste note, è il rapporto tra l’enumerazione dell’elemento interpiano-finestra e la sua
scala generale.
Se gli edifici alti per uffici presentano un rivestimento ed un impaginato dei prospetti indifferenziato che li fa
assurgere ad una condizione totemica di grande oggetto continuo (di un’altezza teoricamente infinita),
dall’immagine uniforme (si pensi alle Twin Towers), la cui riconoscibilità è fondata sulla ingombrante presenza
fisica, il landmark residenziale esprime una certa riluttanza per la ripetitività. Si introducono elementi con un
preciso ruolo figurativo che è quello di cancellare l’interpiano o la figura della finestra consueta, rendendo la
superficie verticale porosa e capace di conferire un peso ad ogni appartamento nel disegno complessivo dei
prospetti. Questi si mostrano disponibili alla sottrazione di volume o viceversa all’aggiunta di aggetti come
terrazze e balconi oppure ad un lavoro pittorico esercitato sulla ripetizione/negazione del ritmo/alterazione scalare
delle finestre. Il progetto di Cino Zucchi per uno dei grossi isolati riconvertiti a destinazione residenziale,
realizzato nei primi anni duemila nell’ambito del piano di recupero redatto da Gino Valle per la ex zona
industriale Alfa Romeo del Portello a Milano, con le sue case in linea, a bordare i confini sulle strade esistenti,
alternate a torri aperte a lunghe vedute sul paesaggio (ed esse stesse punti di riferimento nello spazio
indeterminato della periferia, fig. 1), ben esemplifica quanto detto fin qui.
La sensibilità nel cogliere la vocazione dei luoghi fa sì che l’atto compositivo venga modulato in maniera
differente rimanendo tuttavia chiaramente riconducibile alla medesima fonte, sia che si tratti degli edifici costruiti
a Milano – elementi snelli che si stagliano sullo sky line metropolitano, figg. 2-4 - sia della palazzina realizzata,
nello stesso periodo, all’isola della Giudecca a Venezia (fabbrica massiccia inserita dentro un tessuto ordinatore,
figg. 6-8). Anche in quell’occasione, l’intervento nel delicato ‘interno’ urbano qual è lo spazio compatto di una
città storica viene ispirato da un approccio dialogico: la condizione fortemente stratificata di significati e rimandi
simbolici non è un macigno ma consente di poter sperimentare un proprio codice espressivo, sebbene in maniera
più cauta (a cominciare dall’impatto volumetrico). La variegata figurazione delle bucature e dei prospetti
naturalmente non è slegata da precise operazioni di raccordo tra edificio e suolo e da una complessiva concezione
dello spazio non riducibile esclusivamente a quell’aspetto del comporre. Quello che qui interessa sottoporre
all’attenzione del lettore è la discrezione nell’uso di certi ‘meccanismi’ che non rimangono tali se vengono
opportunamente declinati.
Fonti iconografiche
http://www.zucchiarchitetti.com/home.html
Lotus international 120, 2004
Costruire in laterizio 88, luglio/agosto 2002
L’ACQUA AL VICO DELLE FATE
Conoscenza/narrazione/costruzione
Antonio Franco Mariniello
Mentre leggevo le bozze di stampa del testo di Italo Ferraro, Atlante della Città Storica, (VI vol.,
edizioni oikòs, Napoli 2008) fantasticai che sarebbe molto piaciuto a uno scrittore come Borges, questo
Atlante, e chissà quante volte l’avrebbe compulsato, se gli fosse mai capitato di scrivere di Napoli: è
noto quanto fascino esercitasse sul grande Argentino tutto ciò che sapesse di onnicomprensivo, di
enciclopedico, di vertiginosa -ma quasi tangibile – metafisica sprigionante dalla materialità del fatto o
della cosa più banali.
Prodotto laborioso di rilevamento e disegno, e di autentiche investigazioni, di indagine filologica ma
anche di “scrittura”, l’apparente, umile e fredda neutralità del titolo prelude in realtà ad un latente -ma
spesso evidente- significato letterario, al senso di vicenda e di avventura che esso contiene. E’questo
che ne potenzia – proprio perché la umanizza - la funzione “scientifica” di strumento di conoscenza
storica della città per un progetto di esistenza della città stessa.
A mio avviso, tre peculiari condizioni intellettuali rendono possibile a Ferraro quest’impresa di lunga
durata: la prima, è una specie di negazione dell’ansia (una sorta di calma mentale e intellettuale che
sfida la concitazione “moderna” del tempo della vita e del tempo del mondo) che consente una capacità
di visione nel tempo lungo dei fenomeni urbani e insieme della forma dell’opera che li rappresenterà.
La seconda condizione è una certa forma di “identità narrativa” che somiglia molto a ciò che Paul
Ricoeur chiama itinerranza, come una integrazione tra “erranza” e “spirito domestico”, fra dimensione
urbanistica e architettura del singolo edificio. Ciò gli consente di muoversi in un tempo segnato dalla
possibilità del perdersi e del ritrovarsi, di “avventurarsi” nell’esplorazione di parti vaste e luoghi
inconosciuti con la calma familiarità di chi sta viaggiando dentro e intorno alla propria città, come un de
Maistre “intorno alla propria stanza”.
La terza condizione è la “precisione imprecisa” dell’architetto, aperta –nell’analisi- all’accoglienza
dell’ambiguità, dell’ibrido, dell’imprevisto e dell’inatteso, portati specifici dell’esistenza conflittuale e
tormentata di ogni città: certamente, lo sguardo scettico e obiettivo di un cartografo che -lungi dal
“perdersi” modernamente – accoglie ed ordina i dati nuovi che trova , ma anche l’occhio emozionato di
un vedutista che immagina di poter spostare, cancellare, o deformare, sicchè la mappa possa divenire
sempre più ricca e inclusiva, potendo alimentare il racconto urbano all’infinito. Così la città “si spiega”
nel narrarsi.
E’ possibile, così, che la forma più propria in cui può essere “pensata” e rappresentata Napoli come
città sia proprio un atlante. Questo genere di elaborazione, ancorchè individuale, concorre tra l’altro a
costruire l’epica di una grande “narrazione urbana”, nel senso mostrato da Franco Purini (in Parametro,
n.268, dedicato a questo tema). Egli nota che le narrazioni urbane non si limitano a restituire ciò che è
accaduto, ma in qualche modo “creano” esse stesse le cose, gli avvenimenti e le persone che
trasferiscono nella sfera della rappresentazione. “Le narrazioni urbane –scrive Purini- sono dispositivi di
trasformazione immaginifica di tutto ciò che produce e alimenta la città, superando il loro oggetto per
esprimere gli elementi fondamentali della vita che generazioni di esseri umani hanno trascorso in essa.
In effetti, che le cose esistano e che i fatti avvengano non è di per sé rilevante. Le cose esistono per
davvero solo quando esse sono descritte e ordinate, così come i fatti diventano significativi e degni di
memoria non direttamente , a causa della loro effettiva portata, ma a condizione che siano collocati in
una certa organizzazione tematica e in una determinata tessitura discorsiva. In una parola, c’è bisogno di
una narrazione perché le cose e i fatti si rendano non solo visibili ma anche capaci di essere condivisi”.
Dunque, descrizione e conoscenza, sono -oltre che per documenti- possibili mediante immaginazione e
memoria, che sempre costituiscono "storie" (narrazioni) di città e di loro architetture, di luoghi
memorabili e decisivi della vicenda umana nelle città.
Vi è un piano parallelo di lettura dell’Atlante che potrebbe rendere ragione di tante aporìe urbanistiche
che – a partire dal Novecento- fanno di questa città una singolare testimonianza di incredibile resistenza
alla modernizzazione e all’omologazione globale contemporanea che pervade ormai altre grandi città.
Perciò leggo, guardo e “ascolto” questo Atlante come una sorta di autoanalisi che possa risalire nella
coscienza urbana per rimetterci di fronte alla “scena primaria” dell’origine: l’acqua che scorre e
apparecchia la scena per la forma urbis. E in questo risalire si de-scrivono e si dipanano intrecci e
stratificazioni di intrecci, un racconto di racconti, storie che si scoprono dentro altre storie come nelle
“Mille e una notte”, dove l’immaginario produce il reale e viceversa: così l’Atlante registra anche
filologicamente una pluralità irriducibile di “scritture” con cui, nel tempo, la città parla di se stessa. In
particolare nelle parti indagate in questo volume, da San Carlo all’Arena a Sant’Antonio Abate a
Capodimonte, all’Arenaccia, che segnano già lo sfrangiarsi delle trame misurate del corpo antico, alla
ricerca di una proiezione territoriale nelle contrade di uno spazio più “duro”, già tormentato da acque
selvagge, più malinconico e misterioso, asservito a funzioni necessarie e difficili, da tenere lontano dalle
amenità del centro marino.
E’ anche questa acutezza di sguardo che rende “vertiginoso” lo spazio urbano di Napoli : come
accade al paesaggio della Valle delle Cave, sotto il ciglio meridionale del Palazzo Miradois, che – tra i
quattro paesaggi riconosciuti da Ferraro ai bordi di Via di Capodimonte – “…costituisce il paesaggio
più inquietante e inafferrabile, dirupo e campagna, antro e galleria, buio pesto e luce sfolgorante, sopra
e dentro la terra.” Gli altri tre paesaggi –segnati dall’area della masseria del principe di Alessandria,
dall’Osservatorio Astronomico al centro del fondo Miradois, e da Via dei Ponti Rossi e l’ampio
quartiere residenziale del Moiariello- sono compresenti lungo via di Capodimonte, la quale
“..distribuisce una complessità formale che l’urbanistica moderna non solo ignora, ma è del tutto
incapace di portare a progetto.” Napoli, qui resiste più che altrove alla “razionalizzazione” del piano
moderno : “… ci troviamo ai confini dell’urbano e del tempo formale, e molto possiamo vedere e
guardare, ma non inserire in un ragionevole assetto di città.” Questo atlante, dunque, registra e narrando
giudica l’in-componibilità di queste quattro figure urbano-paesistiche paradigmatiche “ ..presenti nella
loro autonomia e separata individualità formale e d’uso, senza alcuna prospettiva di rimodellazione in
struttura relazionata di paesaggio: rappresentano forme, culture, tempi differenti della costruzione della
città resistenti nella loro separatezza guadagnata nell’uso e nella destinazione che spesso non
corrispondono, anzi contraddicono forma e ruolo urbano.”
Più a valle e verso oriente, una cartografia “sentimentale” contemporanea mostrerebbe i luoghi
emblematici dell' oblìo, dell' incertezza, dell' estraneità , e vedute straniate della precarietà e dell'
arroganza del paesaggio dell' esistenza contemporanea porrebbero davanti all' occhio distratto e ansioso
un ritratto enciclopedico, diremmo "scientifico", di un pianeta urbano abusato, frastagliato di spaesate
aree industriali dismesse, di campagne più ingombranti e tollerate che curate, di passages desertificati
nel cuore della città, di fabbriche , di antiche stazioni o di alvei morti.
Qui l’atlante svela luoghi e architetture come "paesaggi di transito" del tempo, concrezioni di passato
e di adesso, quasi epifanìe di deja vu , davanti ai quali si spalanca lo stupore di un ricordo o di uno
sguardo che ne rivela la permanente letargìa di luoghi cancellati o inaffrancati, ancora "servi" della
prepotente quotidianità del vitalismo della metropoli, scovati nelle pieghe della omologazione urbana
moderna, illusa di velocità e di efficienze virtuali.
I custodi più gelosi e supponenti di una "identità" urbana (ma quante identità ha Napoli?) – che, se
lasciata ai conservatori del pittoresco, rischia di scivolare sempre più nella caricatura di se stessa - non
troveranno in questi luoghi se non l'inquietante rappresentazione-memoria di una funzione (residenza,
fabbrica, magazzino, cimitero, caserma…) o di una attività ( di una vita ) che già furono necessarie alla
costruzione di valori economici e sociali, o -a volte - di natura.
In una struttura urbana complicata dall’orografia, manufatti smisurati, ancorchè incompiuti o
scomparsi, riverberano ancora, non solo nell’immaginario, la propria potenza attiva persino sulla forma
urbis avvenire. Si descrivono qui -tra gli altri- i Granili di Ferdinando Fuga, al Ponte della Maddalena :
una architettura-mondo straordinaria - non soltanto per la sua mole - ormai sottratta alla scena urbana e
alla nostra esperienza sensibile. Per il “ colosso” dei Granili (che furono anche una casa), più che da
vedute e disegni e mappe urbane, dal racconto-inchiesta di Annamaria Ortese ( III e IV Granili, in Il
mare non bagna Napoli, 1953) oggi possiamo “ sapere” della vastità inusitata delle sue finestre, della
luce eccessiva che doveva inondarlo prima che una pietosa penombra ne avvolgesse l’inquietante
formicolìo di esistenze e miserie che quegli spazi dovettero da ultimo accogliere, per ricovero e
protezione di inestinguibili volontà di vita.
Le architetture/macchine “porose” di Fuga, ( oltre all’Albergo dei Poveri, segnatamente il Cimitero e i
Granili) sembrano interpretare un carattere originario e costitutivo della città di Napoli. La natura
vulcanica del suolo, la varietà tormentata della sua geomorfologia mostrano una irriducibile
ambivalenza tra ordine solare (apollineo) in superficie e “disordine” oscuro e misterioso (dionisiaco)
nel sottosuolo, dove la formazione geologica ha prodotto caverne, antri, vuoti di aria e di fuoco aperti
nel corpo tellurico. I Cavoni e i Cimiteri ipogei, le Cupe e le Insule e le Ville, splendide nei loro
giardini, appartengono legittimamente insieme a questa ambigua identità.
Lungo i millenni, persino l’identità figurale e visuale della città si è materialmente alimentata di questa
doppiezza metamorfica, che l’ha sempre resa resistente e imprendibile alla regola pre-vedibile di
qualsiasi Piano razionale, e che ripropone costantemente l’implosione dentro se stessa (nel suo corpo
oscuro di spugna) dell’ im-prevedibilità delle sue epifanìe più luminose e armoniose ( le “ vedute” ) nel
soprasuolo.
< Perciò Napoli è un “terreno fenomenico”, terra labile che continuamente muta forma generando
“inganno e spavento”. “Qui dove c’è la putrida Chiaia, stanotte stesso può sostituirsi il mare; e là
dove vedi il Vesuvio, possono domani riapparire i Greci, con le loro famiglie e i giuochi. Lauro si può
trasformare in un pino”. Un atto di stregoneria è sempre possibile come l’interpretazione miracolante
dei fatti. Una strada con lavori in corso, assume “ l’aspetto di un torrente in piena, le torbide acque,
precipitose e oblique, improvvisamente drizzate e pietrificate”.> (così Giulio Cattaneo, citando la
Ortese in una prefazione al famoso libro).
Di tale identità plurima, questa “mappa” intende segnalare il significato storico (ed estetico) di
materiale visuale reale e immaginario, diremmo anamnèstico, per consegnarlo ad una attiva
immaginazione urbana contemporanea non nostalgica, capace tuttavia di restituire a questi luoghi il
senso di una loro ancora attuale necessità nel ciclo di riproduzione della città. Non può darsi forma urbis
comprensibile (abitabile) se non vi è capacità di pre-figurazione, configurazione e ri-figurazione come
“costruzione”. Conoscere questa costruzione temporale della totalità urbana e raccontarla è l’atto
rifondativo necessario per la costruzione nuova.
Da questi punti di vista, l’Atlante dispone di una energia progettuale potenziale, offrendo una solida e
generosa risorsa per un progetto di Architettura radicato nella Località.
LA VICENDA “ITALIANA” DI UN’ARCHITETTURA ITALIANA
Claudio Roseti
Nella ricerca di un’opera da recensire nella rubrica che ho inserito nella rivista del Dipartimento AACM della
Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria cui appartengo, mi sono imbattuto nella
“piazza-fontana” realizzata a Polistena, centro popoloso della piana di Gioia Tauro, su progetto dell’Arch. Marina
Tornatora, ricercatrice in Composizione Architettonica della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria, uno spazio pubblico posto all’incrocio di via Santa Marina con il viale Rivoluzione d’Ottobre corrispondente alla copertura del torrente Ieropotamo che divide il nucleo antico da quello recente. Avendo potuto subito riscontrare
l’apprezzabile qualità e l’attualità dell’opera, mi ero offerto di redigere comunque un saggio critico che è subito
divenuto irrecusabile quando ho saputo della vicenda in cui questa era implicata ed alla quale non riuscivo a credere finché non ne ho constatato di persona il compimento.
La sinistra conservatrice giunta al potere di recente a Polistena, per sfregio politico verso l’Amministrazione
Comunale precedente, rifiutando al tempo stesso la modernità dell’opera, ne ha programmato ed attuato la demolizione (i lavori sono stati intrapresi il 19/3/09), nell’ambito di un pretestuoso progetto generale di riassetto viario,
prevedendo in sua vece una rotatoria stradale che non supplisce comunque l’architettura sottratta al luogo. La vicenda ha dell’incredibile già solo per come si possa aver permesso un tale spreco di denaro pubblico (considerando la spesa vanificata dell’opera demolita di 90.000 euro a cui sono da aggiungere il costo della demolizione e
della nuova opera) ed infatti pare che tale deliberazione sia stata emanata da Sindaco e Giunta escludendo il Consiglio Comunale. A riprova delle qualità della piazza e dell’assurdità della decisione politica sta il fatto che questa
architettura aveva avuto una notevole serie di riconoscimenti e che inoltre, al preannuncio di demolizione, erano
stati emessi da vari enti dei veri e propri appelli per la sua conservazione.
Andando infine all’annunciata esegesi di questa piazza, resa ancor più celebre da tale vicenda, la prima cosa che
si evidenzia, nonostante la limitata entità, è l’appartenenza all’architettura a pieno titolo. Ben lontana dall’arredo
urbano d’accatto, tematizzato nello spazio pubblico, e spesso limitato a banali decori pavimentali e qualche aiola,
oltre alle immancabili panchine prodotte industrialmente e utilizzate poi a qualunque latitudine e in qualunque
contesto, l’architettura è riconoscibile per il grado di coinvolgimento spaziale, per l’interessamento delle tre dimensioni anche alla scala di spazio aperto e per il rapporto col contesto.
Nella piazza di Marina Tornatora l’invaso è composto da un sobrio pavimento in mattonelle quadrate di monostrato vulcanico che è perimetrato da un bordo in pietra di Trani (il secondo materiale usato, il terzo è l’acqua e
non vi è altro) che, da gradone d’ingresso posto a monte, con un movimento a spirale, si eleva conformando una
seduta in tal modo architettonicamente compresa nell’insieme; diviene poi gradonata per dare l’accesso da valle
dando luogo infine, nel vertice esterno di monte, alla fontana che occupa una superficie di poco inferiore ad un
sesto dell’insieme. In tale proporzione, assolutamente esatta nei confronti dell’invaso e del perimetro complessivo, la fontana connota la piazza entro un rapporto simbiotico conformandosi a partire dal bordo che si eleva e si
ispessisce andando a perimetrare la vasca che poi si raccorda col lato di valle attraverso il bordo-seduta. L’acqua
si segnala all’esterno con una serie di zampilli verticali mentre la vasca è proiettata lateralmente in contropendenza rispetto alla strada con un profilo triangolare vagamente libeskindiano. La fontana si sdoppia infine lungo il
bordo di monte in una vasca ulteriore che lascia scorrere una sottile “cascata” lineare proveniente dalla vasca
principale. La vasca così dislocata decostruisce l’opposizione dialettica esterno/interno creando un esterno secondo che evidenzia per contro l’internità dello spazio perimetrato dando luogo a una gerarchia di esterni entro uno
spazio di per sé aperto e che in tal modo perviene a quella complessità che è propria della vera architettura. La
fontana infine al suo interno è ulteriormente rapportata all’invaso attraverso un percorso che la penetra per alcuni
metri ad assecondare un contatto fisico ancora più diretto con l’acqua. E l’acqua, componente ontologica, essenziale e vitale non solo dell’architettura, sospinta dal suo suono gioioso rende inoltre quest’architettura viva, parlante in relazione dialogica col contesto, memoria e riflesso del torrente sottostante.
E la privazione del luogo di questa componente primaria e vitale aggrava la responsabilità dell’Amministrazione
Comunale che ha negato alla popolazione uno spazio che, se pure, forse, non del tutto compreso nelle sue più elevate qualità architettoniche, era piacevolmente utilizzato per la sosta, maggiormente attratta dalla gradevolezza
dell’insieme, che resterà comunque nella storia (difficile) dell’architettura di questi luoghi, vittima di una politica
malgestita, e di fatto autolesionista, cui tuttavia l’architettura, per la sua inescludibile componente sociale, non
può inevitabilmente sottrarsi.
IL PROGETTO ARCHITETTONICO E
L’ IDENTITÀ DEI LUOGHI
Carmine Lo Conte
Molto spesso siamo portati ad osservare un luogo e ad
associare allo stesso delle sensazioni. Cioè
identifichiamo quell’immagine associandola a delle
particolari emozioni prettamente personali, ma nello
stesso tempo estrinsechiamo le stesse mediante dei
giudizi più o meno oggettivi; ora da queste semplici
considerazioni ci si rende conto che l’identità di un
luogo, le valenze sia esse di natura paesaggistica che di
natura linguistico architettonico, possono essere
interpretate a seconda della capacità e dell’inventiva
dell’artista, una sorta di capacità di andare oltre il reale,
creando quello che a detta del Bontempelli viene
chiamato “magico realismo”.
Giuseppe Terragni,
protagonista di mezzo secolo di architettura italiana a
cavallo dei due conflitti mondiali, affronta il “senso
dell’abitare” facendone emergere lo stato di crisi in cui si
trova, e chiaramente affronta il progetto di architettura
ritrovandone i principi del linguaggio costruttivo
architettonico, ma soprattutto tenta l’operazione di
ritrovare un linguaggio comune ai vari linguaggi
costruttivo-architettonici. Molto emblematica è la ricerca
che il Terragni effettua quando fa scaturire dallo spazio
dei luoghi la forma dell’abitare; una sorta di quadro in
cui le figure in primo piano sono pienamente sorrette dal
paesaggio in lontananza. E’ importante, perseguire
l’obiettivo di salvaguardare e recuperare la qualità
urbana, spesso influenzata da comportamenti sociali e
individuali, facendo scomparire i cosiddetti “luoghi di
confronto e di incontro”. La città “moderna”, oggi
raccoglie come in un grande bacino, tutti quegli edifici
che, in un tempo oramai trascorso, venivano giustamente
definiti monumenti e che oggi barbaramente vengono
definiti infrastrutture; cosi facendo si va ad annullare
qualsiasi collocazione sia essa spaziale, quale momento
di scelta compositiva del tessuto urbano, che
architettonica, quasi a volersi sottrarre ad un giudizio di
qualità progettuale. Oggi il professionista che elabora
progetti per la costruzione di nuovi edifici o il restauro di
quelli esistenti, finisce con l’essere pariteticamente
definito anche “architetto”, dimenticandoci l’origine
greca, per poi addivenire mediante il latino alla parola
composta da “archè” e cioè il “principio” o “l’origine”
delle cose e il secondo “téktuu=téktòn” che indica
l’artista o meglio l’artefice. Ma tralasciando la questione
filosofica ed etimologica, e ricercando nella realtà di
oggi bisogna stabilire il perseguimento della qualità
negli interventi di trasformazione del territorio e del
paesaggio ed è rilevante in tutto questo il ruolo della
Committenza Pubblica, innanzi tutto, ma anche di quella
privata, e non meno lo è quello del progettista, sul quale
va spesa qualche parola. Mai come adesso l’architettura
è di moda. Nelle riviste, ma come anche in televisione le
cosiddette “archistar” sono oggetto di notevole
attenzione e suscitano spesso molta più curiosità di
quanto non lo facciano le loro stesse opere.
Paradossalmente se da un lato assistiamo a questa
mercificazione dell’arte dall’altro osserviamo che
l’architettura è lontana dall’interesse pubblico: incide
poco e male sul miglioramento della vita del cosiddetto
capitale sociale. Nella lettura della globale
trasformazione ci si rende conto che l’architettura è
diventata un gioco autoreferenziale, tutto incentrato sulla
“firma”, sulla creatività del singolo architetto, creatività
che raggiunge l’apice del suo declino nel momento in
cui è quotata come la “moda”, al pari di un qualunque
altro bene di puro consumo. Il progetto architettonico
non può e non deve sottrarsi dalla responsabilità delle
trasformazioni di pezzi di città, che spesso con
incompetenza, superficialità e convinti che si tratti di un
gioco formale, gli architetti si rifugiano in un’artisticità
che li allontana dallo spirito di appartenenza dei luoghi e
dello spazio che questi ultimi rappresentano. La città è
sede sia dei principi di appartenenza che dei conflitti,
questi ultimi spesso ignorati o affidati a puri esercizi
mentali, con il risultato oramai ben noto, di generare
emergenza in cui l’ambiente costruito spesso ci si
identifica. Credo che il progetto architettonico debba
essere guidato da una memoria storica e selettiva dei
luoghi, tuttavia pensando ad un architettura che non si
limiti solo a darci paradigmi su come usarla, ma bensì
ripensare all’architettura delle forme, armonie e
disarmonie, che quindi non sia il prodotto di un
‹‹costruire case che raccontino l’impossibilità di avere
dimora›› (M. Tafuri). La reintegrazione del progetto
architettonico all’identità dei luoghi esprime il carattere
insieme pubblico ed ecologico dell’atto progettuale, con
buona pace di tutti i grammatici che vorrebbero pensare
al manufatto edilizio come un oggetto in se e per se
compiuto. Progettare senza conoscere il luogo, le
persone, ma soprattutto la storia si corre il rischio di un
fallimento. E’ fondamentale l’analisi del contesto,
conoscere il luogo in cui realizzare la propria opera,
rifuggendo dalle tentazioni fortissime della modularità e
del facile guadagno che le moderne tecnologie
favoriscono ulteriormente. Bruno Zevi sosteneva che
l'architettura contemporanea dovesse rifuggire da regole
e dogmi e se proprio a qualche principio avesse dovuto
rifarsi era quello delle antiregole. Allontanarsi quanto
più da virtuosismi tecnologici e "rumorosità" formali,
adottando un'architettura semplice, senza apparente
retorica, ci rende ricercatori di "un'autenticità" dove
risulta palese l'assenza di qualsiasi moda.
L’IDENTITÀ PERDUTA DEI LUOGHI
Massimo Squillaro
I luoghi hanno un’anima, dice Hillman nel suo ultimo
libro”L’anima dei luoghi”. Il nostro compito è di
scoprirla. Esattamente come accade per la persona
umana. Un tempo, nell’antichità, le potenze apparivano
in luoghi specifici: sotto un albero, presso una sorgente,
un pozzo, su una montagna, in un pianoro, all’ingresso
della tana di un serpente. Gli uomini circondavano il
luogo di pietre: per proteggere la sua interiorità.
Nascevano i templi; consacrati a queste divinità: gli
Àuguri ritualizzando il Genius loci fondavano le città.
Oggi, il funzionalismo razionalistico cela l’interiorità dei
luoghi. Vediamo ciò che appare, le facciate dei palazzi,
il manto urbano, i campi pianificati a giardino o
monocoltura e dimentichiamo che là sotto c’è una
topografia dinamica, interiore, fatta di sentimenti e
memorie, figure e forze, fantasie e pensieri.
Un luogo è per prima cosa uno spazio contrassegnato
dall’identità di chi vi abita, ma è anche uno spazio in
grado di individuare i reciproci rapporti tra i soggetti in
funzione di una loro comune appartenenza, un luogo è
inoltre storico per le sue capacità di rammentare le
proprie radici a chi vi risiede.
Ci si chiede allora se la nostra società non stia
progressivamente smarrendo e distruggendo il concetto
di luogo avvicinandosi sempre più alla creazione di spazi
carenti delle caratteristiche di cui si è fatto cenno, come
spazi addetti al trasporto e al transito delle persone ma
anche centri commerciali o centri per il tempo libero e lo
svago.
Si tratta di spazi per lo più estranianti e autonomi, spazi
fatti di standard tecnologici in grado di garantire le più
alte comodità, dove tutto è esattamente calcolato e nulla
è lasciato al caso.
L’individuo diviene allora un "uomo generico"
contrassegnato da un passaporto che possa conferirgli la
possibilità di prendere parte ad un sistema che necessita
del rispetto di alcune regole dalle quali non si può
decidere di astenersi.
Un processo di disindividualizzazione si compie,
l’identificazione è resa possibile grazie ad un
riconoscimento sociale attraverso il quale siamo tutti
cellule riconducibili ad un comune e indistinto
organismo in grado di racchiudere in se non solo la città
di appartenenza ma l’intero globo.
La ripetizione di strutture simili in ogni dove annulla le
particolarità di uno specifico luogo in un continuo e
ostinato processo di omologazione.
Tutti attraversano questi spazi, ma nessuno li abita.
Viene dunque da domandarsi quali possano essere, nella
città contemporanea, i luoghi realmente abitati, in grado
di racchiudere in se quelle caratteristiche proprie di un
luogo.
Addentrandosi allora in quei luoghi reconditi, quei
luoghi apparentemente vuoti e lasciati a se stessi si
possono trovare spazi in attesa di essere scoperti e essere
vestiti da identità desiderose di parlare e dialogare,
desiderose di appartenere ad un luogo che parli di loro.
Si cerca un rifugio che lo stesso inconscio richiede per
poterlo riempire di forze, presenze e domini diversi.
E quando quei luoghi progettati per mettere insieme
numerosi volti senza nome terminano il loro compito,
sfumando in una solitudine senza fine, proprio quel
vuoto che sembrava non avere alcuna possibilità di
esistere, si carica di corrispondenze e metafore tangibili
uniche in grado di raccontare.
Questa realtà sta modificando la visione della metropoli
contemporanea e può essere rintracciata in quei luoghi
chiamati periferici.
Ma di cosa si parla esattamente quando si decide di
nominare un luogo periferia?
Il significato etimologico della parola ha subito
numerosi cambiamenti nel corso della storia, questa
nasce inizialmente come entità edilizia disseminata ed
addossata ad un centro urbano costituendone il confine.
Ma alla luce di sempre più discusse osservazioni
riguardanti la città contemporanea quella che poteva
inizialmente rivestire un ruolo di marginalità spaziale
sembra con il passare del tempo acquisire un’importanza
intrinseca alla sua costituzione.
Nei luoghi comuni la periferia può definirsi mediante un
insieme di negazioni che ne garantiscono il
raggiungimento spaziale - temporale, essa non è città ma
neppure campagna, bensì localizzata in quella via di
mezzo che la priva di una corretta definizione.
Eppure nonostante la negativa attribuzione di significato
essa entra a far parte di quelle opzioni che conferiscono
all’uomo la possibilità di scegliere un luogo a cui
appartenere, un luogo dove poter svolgere le proprie
attività quotidiane.
Osservazioni di questo tipo portano allora a conseguenti
ed inevitabili domande relative ad una scelta che ci porta
a rivalutare quel complesso e fondamentale ruolo che la
città riveste.
Questa nebulosa urbana è per definizione un luogo
ibrido, dove è apparentemente impossibile orientarsi,
dove tutti gli oggetti appaiono privi di senso in una
organizzazione schizofrenica del suolo. Lo spazio
esterno da vuoto diviene improvvisamente terra di
nessuno, un pulviscolo di piccoli edifici ammassati con
il loro brusio invadono il territorio e si diramano verso
quella concettualmente così distante città nel tentativo di
portare con se quel senso di appartenenza altrimenti non
possibile.
Eppure la moltitudine non è caos. L’organizzazione che
vi risiede è denuncia di quel comune senso dell’abitare
assicurato dalla percezione e intima comprensione del
proprio spazio.
Quella continua esposizione a luoghi indifferenti così
simili fra loro, perennemente sottoposti ad immagini
pubblicitarie mediante le quali tutto diviene rapidamente
oggetto di scambio, conducono ad un comune
disorientamento che non offre appigli ad un intimo
coinvolgimento.
Industria, mercato e tecnologie divengono input
associativi di entità destinate a perdere il proprio nome.
L’individuale capacità di apprendimento spaziale di
fronte ad un luogo indifferenziato si annulla, un black
out dei sensi non rende più possibile quel chiaro
processo di identificazione con lo spazio che si occupa.
É impossibile apprezzare esteticamente uno spazio come
se il tempo non fosse sufficiente per attivare quei
meccanismi sensoriali e percettivi che rendono possibile
la relazione tra l’ambiente e la presenza in esso. Una
progressiva e sempre più evidente eliminazione di
differenza tra luoghi dovrebbe, sulle basi dell’edilizia
moderna, distribuire un nuovo tipo di uniformità
ambientale in cui il cittadino non deve perdere tempo in
una inutile e complessa relazione con il proprio ambiente
ma deve e può usufruire di uno spazio funzionante sotto
ogni punto di vista, in primo luogo igienico, che possa
garantire una facile mobilità lavorativa e relazionale con
l’individuo prossimo.
L’ambiente diviene un contorno di cui usufruire e che
non deve per questo necessariamente coinvolgere
l’intima sfera dell’uomo, la fisicità dei rapporti si dirada
in favore di sempre più efficienti operazioni di scambio
in cui l’immagine riveste l’unica e giustificabile
importanza.
Questa messa insieme di funzionalismi perfetti all’uomo
si rivela ben presto un fallimento quando allontanandosi
dalla progettata maglia urbana si passa in quei luoghi
abitati da persone provenienti da altri paesi che per
indole e natura hanno tentato di ristabilire quella
connessione all’ambiente circostante unica a loro nota.
Proprio in questi spazi ci si rende conto di come le
differenti personalità e culture necessitino di differenti
approcci al proprio contesto anche modificando, se
necessario, le proprie modalità insediative ma sempre
secondo individuali attitudini non dettabili a priori.
Lo spazio è una condizione necessaria alla ormai
annientata identità e all’interno di ogni singolo individuo
questo impulso si manifesta ogni giorno seppur in modo
differente, lo stesso perdersi tra le vie della propria città
è testimonianza di uno smarrimento dovuto alla
mancanza di quelle differenti densità e domini che
dovrebbero costituire i differenti spazi.
L’attuale edificato delle periferie urbane si descrive
attraverso un perenne stato di non finito garantendo
quella continua mutazione quotidiana dettata da esigenze
e cure che non sono in grado di consolidarsi mai in
un’unica definizione.
Quella flessibilità adattabile alle molteplici esigenze
dell’individuo è rintracciabile proprio in quei luoghi
apparentemente non progettati e per questo esigenti di un
imminente piano.
La soluzione non è dunque quella finora adottata di
inglobamento degli spazi nella creazione di una città
generica fatta di automi che vagano per le strade
estraniati e completamente risucchiati da un contesto
meccanico e ripetitivo, ma dovrebbe accingersi ad una
riconsiderazione di quegli spazi ormai privi di identità
mediante un maggiore avvicinamento a quel naturale
coinvolgimento tra l’uomo e l’ambiente.
Sperimentare quelle nuove e sorprendenti associazioni
verso una fluidità spaziale, volgere sempre più spesso lo
sguardo a questi spazi creati dall’immaginazione
pragmatica di utenti allo stesso tempo gestori delle loro
stesse esigenze. La premessa progettuale dovrebbe
basarsi su di uno studio delle attitudini ed esigenze
abitative nel tentativo di risolverle mediante una
trasformabilità che possa garantirne il perpetuo
soddisfacimento anche in seguito ad un repentino
cambiamento.
Il compito del progettista dovrebbe allora essere quello
di andare a recuperare e ripensare quei margini ormai
fortemente segnati garantendo quei criteri di accessibilità
che siano in grado di condurre ad una complessità
urbana alla quale non si può rinunciare. Sostanziare il
patto fra diversi della città contemporanea e rendere
possibile quella ormai necessaria integrazione attraverso
uno spazio fatto di relazioni.