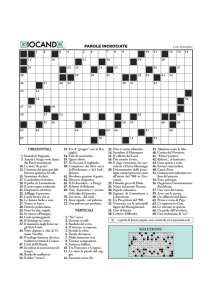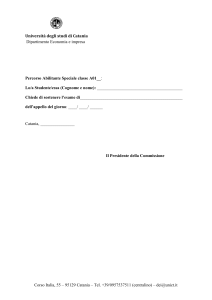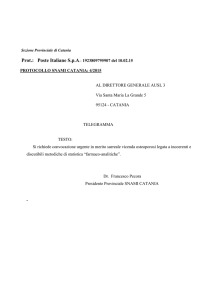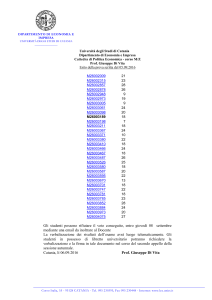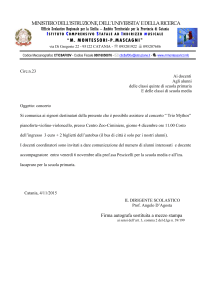LibertàEdizioni
Piero Isgrò
L’OROLOGIO DI CELLULOIDE
I ragazzi dal vestito grigio che amavano il cinema
LibertàEdizioni
Alla memoria dei miei amatissimi genitori
e di mio nipote.
Che la terra gli sia leggera.
Chi crede che il presente
sia l’unica cosa presente,
non sa nulla dell’epoca in cui vive.
Oscar Wilde, Il critico come artista.
Se niente può far sì
che si rinnovi all’erba il suo splendore
e che riviva il fiore
della sorte funesta non ci dorremo
ma ancor più saldi in petto
godremo di quel che resta.
William Wordsworth,
dall’ode Intuizioni di immortalità nei ricordi dell’infanzia, 1807
L’OROLOGIO DI CELLULOIDE
I ragazzi dal vestito grigio che amavano il cinema
La famiglia Isgrò: da sinistra l’autore, la madre con il fratellino,
il padre, la sorella
Introduzione
L’orologio di celluloide scandisce idealmente il
tempo dell’Autore che nella sua vita professionale si è
occupato di teatro, letteratura, musica e soprattutto
cinema. Le lancette cominciano a scorrere dalla
mezzanotte. Sul quadrante splendono come lontane
stelle Greta Garbo e Marlene Dietrich; un’ora dopo
s’accendono Jean Harlow, Claudette Colbert, Vivien
Leigh; alle due, Ingrid Bergman, Katharine Hepburn,
Joan Crawford, Bette Davis e poi, alle prime luci del
mattino, Rita Hayworth, Lauren Bacall, Lana Turner e
tante altre fino a raggiungere, a giorno concluso, Grace
Kelly, Marilyn Monroe, Liz Taylor. In tutto,
quarantadue ritratti femminili che vanno dagli anni ’30
ai ’50 e che hanno reso immortale il cinema americano.
Accanto a questi personaggi scorre la vita
dell’Autore, dall’infanzia alla maturità, una vita che
appartiene un po’ a tutti i bambini, poi ragazzi, poi
adulti che sono cresciuti nella società povera degli anni
Cinquanta ma con un cuore forte e che mai si sono
arresi. Ragazzi dal vestito grigio, senza i colori della
rivoluzione, apparentati in qualche misura ai giovani
americani descritti da Sloan Wilson, estranei al
consumismo. Ragazzi che hanno amato il cinema e i
libri, ragazzi che nelle feste di Natale mettevano sotto il
piatto di papà la letterina con la quale promettevano di
essere più buoni e studiosi, ragazzi che scrivevano
dichiarazioni d’amore alle ragazze che amavano e si
disperavano per i loro rifiuti, ragazzi che non hanno
conosciuto le lusinghe terribili della droga, che hanno
spinto con gli occhi la propria età acerba col piccolo
sogno di raggiungere presto l’emancipazione
indossando i calzoni lunghi, la giacca e la cravatta,
presentarsi al botteghino senza arrossire se il film era
vietato ai minori e restringersi nel cerchio mistico della
loro avventura umana. Quelle dei ragazzi di allora
erano vite semplici e percorribili, non artificiali, vuote e
9
ingannevoli.
Poi, un giorno, l’incanto s’è spezzato. Crescendo si
sono accorti che la loro amata Catania cominciava ad
essere percepita come un impasto di sicilianismo e di
folklore dozzinale, una città produttrice di semilavorati
intellettuali destinati all’emigrazione. Quando all’alba
degli anni Novanta l’autore si trasferisce a Roma, al
TG1, è anche lui un “prodotto semilavorato”, pur
avendo i suoi anni e la sua formazione professionale,
ma era a un bivio: crescere o tornare indietro. La città
era giunta a un punto morto, anzi, stava precipitando
nel suo provincialismo di maniera, nei suoi club
culturali inutili e paesani, nelle sue mafie bianche e
nelle sue mafie nere, nella sua editoria da strenna, nel
saccheggio del denaro pubblico, nei tanti Thénardier
impegnati a fare sottocultura strizzando l’occhio a
questo e a quel politico di turno… insomma, la città, al
pari di tutte le città meridionali, stava svendendo i
propri sogni e gli stessi giovani che di quei sogni
s’erano alimentati.
10
Città di visioni e di scena
C’era una volta a Catania, antica città del
Mediterraneo, al numero 72 di via Luigi Capuana, non
molto distante dal teatro dei pupi di Nino Insanguine, un
cinematografo di 132 posti. In realtà, era un dopolavoro
frequentato da operai e impiegati delle Ferrovie dello
Stato e dell’Azienda municipale trasporti. In questo
locale, una sorta di garage stretto e lungo dove il
biglietto costava venticinque lire, m’innamorai
perdutamente del cinema americano e delle sue dive.
Non avevo nemmeno quattordici anni, l’età dello
stupore, l’età che si approssima alla giovinezza, quella
condizione “dolorosa, limpida e disinteressata”, come la
descrive Sándor Márai nelle Confessioni di un borghese,
alla quale non si può resistere. Del resto, come poteva
un ragazzino resistere al cinema in cui l’apparenza è più
seducente della realtà? Basta indossare una parrucca per
smettere d’essere calvo o recitare un copione per
diventare ciò che non si è: eroe, scienziato, tombeur de
femmes, milionario. Quale regno meraviglioso di
travestimenti, dunque, per uno che aveva appena
sbirciato nella vita e intendeva piegarla, per ciò che
poteva, alla sua dimensione fantastica?
Correva la metà degli anni Cinquanta in quella Catania che Brancati negli Anni perduti ribattezzò Natàca
come a disegnare un fossato tra realtà e fantasia, quasi a
mettersi al riparo dalla reazione degli “inquisiti” o dai
processi ingannevoli della memoria; oppure, semplicemente, per confondere le acque. Se non faccio mia
l’astuzia è perché il mio tempo malinconico e fanciullo
non vedeva separazioni tra lo schermo del cinema e
quello della vita.
I film erano divisi per lo più in tre tempi perché la
pellicola da proiettare arrivava in distribuzione custodita
in tre grosse bobine (se le bobine erano quattro il film
veniva suddiviso di conseguenza). Gli intervalli tra un
tempo e l’altro servivano all’operatore di cabina per sca11
ricare il rullo e mettere in macchina il successivo. Una
volta che l’occhio del proiettore tornava a bucare la nuvola di fumo della sala, illuminando lo schermo con la
magia delle immagini, l’operatore riavvolgeva la bobina, appena utilizzata, per l’altra proiezione. Molti uomini, poiché il locale non era riscaldato, rimanevano a capo coperto sicché quelli che stavano dietro, dopo oscillazioni varie del busto e contorsioni del collo, si rassegnavano a uscire dalla timidezza e pregavano i maleducati di scoprirsi. Qualcuno, però, più duro del polpo,
non capiva o fingeva di non capire e allora la sala tutta
si metteva in movimento e imprecava, “u cappeddu!”,
“a coppula!”, e addio film. Il proiezionista bloccava la
bobina, accendeva le luci in sala e, come d’incanto,
cappelli e berretti sparivano.
Non era solo questione di freddo alla testa, era anche
una forma di cultura imitativa. Molti film mostravano i
protagonisti col cappello che non levavano nemmeno in
casa d’altri, in ufficio o di fronte alle signore. I
maleducati per eccellenza erano i poliziotti in borghese
e gli investigatori privati; anzi, il cappello era il loro
segno distintivo, la loro cifra intellettiva. Di norma, nei
film western i buoni indossavano il cappello bianco, i
cattivi quello nero. Ma la varietà delle fogge e dei colori
apparteneva un po’ a tutti i personaggi dei film
americani.
Si entrava anche a spettacolo cominciato. Non c’era
la preoccupazione di perdere qualche scena o di non
afferrare subito la trama perché il film veniva visto una
seconda volta, in tutto o in parte; altrimenti c’erano le
domande bisbigliate ai vicini di posto per capire, dopo
aver capito, la dimensione della propria inettitudine.
Sembrava che la gente non avesse nulla da fare, che
trascinasse la vita da uno spettacolo all’altro, quasi a
drogarsi dell’invenzione della vita stessa. Pagava il
biglietto pure se non c’erano posti a sedere. Si sistemava
in piedi, lungo i corridoi, appoggiandosi alla parete e
aspettando che qualcuno si alzasse. Non era in fila per il
pane o l’acqua, che s’attingeva con bidoni e bottiglie
12
alla fontana, era in fila per l’effimero, per dimenticare
ciò che stava all’esterno di quelle quinte di celluloide.
Formidabile epoca di speranze, di linee rette verso il
futuro indistinto, di passi faticosi verso il benessere a
lungo accarezzato, di pericolosi inciampi anche perché
si correva con la testa tra le nuvole, senza guardare a
terra, perché troppo a lungo s’era guardato nelle fosse
dei bombardamenti, nelle rovine dei palazzi, negli
anfratti della sofferenza e del bisogno. Fuori c’era una
città che s’ingegnava a inventarsi il lavoro, a dare un
senso di bellezza alle cose minute, alle cose povere e
necessarie, per renderle accettabili. Anche questo era un
auto-inganno. Ma la città cercava di guardare con
ottimismo al proprio futuro, dimenticare la guerra, la
sua tragedia, i suoi lutti e tentare di costruire qualcosa
che assomigliasse a un mondo edenico.
Il pubblico, sistemato nei sedili di legno che a fine
spettacolo rendevano quadrati gli ossuti mappamondi,
assisteva alle imprese dei divi con infantile passione.
Spesso la visione del film era cadenzata da fragorosi
ciàk che a intervalli regolari fumatori e masticatori di
tabacco sputavano a terra con indifferenza. Il disgusto di
noi giovani era lo stesso del signorino Maletti di
gaddiana definizione. Quando il film stava per finire,
cominciava il controllo degli orologi. Faticoso controllo,
in verità, perché non era tempo d’orologi quello.
Costavano troppo e non servivano a calcolare lo
sfruttamento. Le ore fluivano lente e potevi misurarle a
grandi linee sui quadranti arrugginiti delle chiese e degli
edifici pubblici, sul sole che tracciava l’arco del giorno.
E allora si domandava ai vicini, ai fortunati, non per
scappare via ma per calcolare quanto ancora restasse
dell’incanto. Era come trovarsi alle ultime pagine di un
romanzo appassionante e cercare di rallentarne la lettura
rimandando per quanto possibile il finale che poi ti
lasciava per alcuni minuti inchiodato al tuo silenzioso
carnefice di legno. Passata l’emozione, le rialzate erano
lente e faticose, in uno sbattere di sedute e di luci che
trafiggevano gli occhi.
13
I film erano parrocchiali, innocui e raramente
sconsigliati o vietati, non certo per disciplina clericale
ma per antico pudore e alla fine per ristrettezze
(culturali) di mercato. Le scene d’amore si fermavano
alle soglie delle camere da letto e i baci erano dati a
labbra serrate, non come nei film d’oggi in cui l’uomo
sembra strappare le tonsille alla donna. Tutto era
suggerito, appena mostrato, intravisto; a non dire degli
occhiuti censori che tagliavano con l’accetta le
situazioni scabrose al punto da compromettere la
comprensibilità della vicenda. Memorabile la scena del
parroco in Nuovo cinema Paradiso che a ogni bacio
eterodosso scampanella per avvisare il proiezionista di
tagliare.
Il giorno dedicato al cinema era il sabato pomeriggio
e tutta la famiglia vi partecipava con entusiasmo: mio
padre, mia madre, mia sorella di un anno più grande,
mio fratello di cinque anni più piccolo, naturalmente io,
che stavo in mezzo. La nostra abitudine assomigliava a
migliaia d’altre abitudini. I cinema erano sempre pieni,
sempre colmi di promesse consolatorie. Il dopolavoro si
trovava a due passi da casa nostra. Abitavamo in via
Giuseppe Verdi, alla confluenza con via Vecchia
Ognina, all’ultimo piano di un palazzotto grigio,
naturalmente senza ascensore e con tutta la scomodità
del tempo: freddo in inverno, caldo in estate. Mio padre
dirigeva un’industria farmaceutica che aveva sede in
fondo al Corso Italia, poco prima delle sciare Borgetti,
in una magnifica villa ottocentesca disegnata
dall’architetto Carlo Sada. Mia madre faceva la
casalinga. Nel pomeriggio era impegnata in lavori di
cucito o di rammendo e a badare a mio fratello. Ogni
tanto cantava filastrocche dolci e ripetitive… “c’era una
volta un piccolo naviglio, che non voleva non voleva
navigar…” come tutte le mamme del tempo, sagge e
attente, che cercavano in quelle cantilene un ritaglio di
serenità. Cantilene e canzoni napoletane. Struggenti,
spesso insensate per le motivazioni personali che le
accompagnavano.
14
Sarà stato il Regno delle Due Sicilie ma le società
meridionali, di qua e di là del Faro, hanno tessuto un
linguaggio comune sin dal Settecento, e forse anche
prima. Fino a qualche anno fa le sceneggiate di Mario
Merola avevano grande successo a Catania e grande
successo hanno tuttora le canzoni partenopee,
salmodiate più che cantate. Maestri del ramo sono i
muratori, ovviamente senza grembiule, che impastano
calce e costruiscono muri di mattoni al canto di Anema e
core, oppure, al passaggio di una bella ragazza,
ripescano dal canzoniere paterno l’immortale invito di
Claudio Villa: “Vieni, c’è una strada nel bosco, il suo
nome conosco, vuoi conoscerlo tu?…” Le ragazze non
alzano lo sguardo, camminano dritte, solo crespi di
sorrisi agli angoli della bocca, mentre la canzone rompe
la severità del tempo... “Vieni, è la strada del cuore dove
nasce l’amore…” Tutti intonati e scostumati i muratori.
Mai sconci o volgari però. Sempre sul limite
dell’alcova, sulla linea narrativa delle parole, del dire e
non dire. Poi, alla pausa pranzo, con la faccia scura
bruciata dal sole e dal vento, aprono il sacco del pane e
delle olive, e qualche acciuga e pezzo di formaggio e,
smozzicando, continuano a scherzare e sognare.
Tornando a casa, i più giovani troveranno mogli
bambine alle quali porteranno arance, come il siciliano
incontrato sul traghetto da Vittorini, e tenteranno di
convincerle che si può star bene senza arricchire.
Una canzone napoletana è un’opera lirica in piccolo,
uno struggimento, un’impossibilità di amare, una nenia
di dolore; spesso è un addio, una lontananza, un modo
di coltivare un ricordo che accompagna l’emigrante
verso “terre assai luntane”. Le terre erano quelle delle
Americhe, che tra il 1880 e il 1920 accolsero oltre
quattro milioni di italiani alla ricerca di un lavoro e di
un’esistenza migliore. In quegli “anni di pellicola”,
quelli della mia infanzia e giovinezza, Napoli e Genova
aprivano il loro mare antico alle ultime navi della
speranza con una massiccia ondata d’emigranti diretti
negli Stati Uniti, in Argentina, in Colombia, in
15
Venezuela. Da lì, dopo qualche anno, sarebbero arrivati
soldi, lettere e malinconici canti. “E nce ne costa
lacreme st’America a nuje napulitane! Pe’ nuje ca ce
chiagnimmo ’o cielo ’e Napule, comm’è amaro stu
ppane!”
Anche mia sorella faceva lo stesso. Le filastrocche la
allontanavano dal rigore dei compiti e della lettura per
immergerla nelle regioni del cuore e della fantasia.
Seduta accanto a mia madre, che ogni tanto le misurava
sul braccio o sulle spalle la maglia di lana che stava
lavorando ai ferri, masticava la matita, tornava a usarla
sul quaderno, piegando la testa da un lato e, più per
liberazione che per infantilismo, completava la
filastrocca: “e dopo una due tre quattro settimane, il
piccolo naviglio riprese a navigar…”
“Che fai, esci?” La domanda di mamma era, al
solito, retorica. Lei sapeva benissimo che sarei andato al
cinema: in realtà, uno strappo infrasettimanale alla
regola del sabato. Ne avevamo parlato a tavola e
commentato il film che avrei visto, ma quella mia
individuale avventura cinematografica un poco
l’infastidiva. Lei, con la sua arte del preoccuparsi,
avrebbe voluto vedermi sempre accanto a sé, seduto a
studiare o a leggere, a brano a brano, e ripetere le poesie
da mandare a memoria. Il cinema andava bene, era
l’unico edonismo che potevamo permetterci, ma doveva
essere un rito collettivo, di famiglia, non un gusto
solitario che le sapeva di “vizio”. Oltretutto, era
convinta che non avessi l’età. Ma poi osservava i miei
occhi scintillanti e la delusione pronta a esplodere e mi
dava il permesso con una domanda altrettanto retorica:
“I compiti?” La mia risposta era sempre la stessa, fuori
tono: “Mi porto le chiavi?” Lei non rispondeva, si
limitava a oltrepassarmi con lo sguardo. E le chiavi
restavano sulla piccola consolle dell’ingresso.
Ero un bambino buono, penso, felice del margine
scarno della vita; un bambino come tanti; un bambino
col suo cappottino corto, gli occhi sgranati sul mondo, il
vestito rivoltato; un bambino mai con le scarpe slacciate
16
(come Adriano Sofri da piccolo) o i calzini arrotolati
alle caviglie, e se ciò accadeva si chinava subito a
sistemare le stringhe o gli elastici, per fastidio più che
per disciplina; un bambino che aspettava il giorno dei
morti con ansia febbrile e se talvolta restava a mani
vuote la delusione del mancato regalo non lo spingeva
al pianto ma a occupare gli angoli appartati della casa,
in solitaria infinita malinconia. Le lacrime avrebbero
sancito la rivolta a un’ingiustizia. Ma quale ingiustizia
potevo rimproverare ai miei genitori che si facevano in
quattro per noi figli non riservando per sé che sacrifici e
dolore? Forse quella di avere rimandato a un tempo
migliore l’acquisto di un giocattolo costoso? Ero maturo
abbastanza da capire il limite tra il superfluo e il
necessario. Non avere trovato, un anno dei pochi, la
pistola a fulminanti fu una mazzata che smaltii
immaginando di salvare, con l’indice e il pollice in
evidenza, un gruppo di coloni attaccati dai pellirosse sui
versanti nevosi dell’Etna. Un mio compagno di banco
alle medie, Peppino Siracusa, possedeva un fortilizio di
legno attorno al quale, dopo i compiti, condizionati dai
film di John Ford, inventavamo assalti d’indiani e
cruente battaglie con i soldati blu. Di fronte alla
seduzione del gioco quei combattenti di plastica
acquistavano l’anima, la foga, la bizzarria di chi li
muoveva, diventavano proiezione del nostro
temperamento. E guardate come questo lontano ricordo
mi conduca oggi a innestarvi memorie adulte e in
qualche misura drammatiche.
La redazione del TG1 a Saxa Rubra dava su una
collinetta erbosa. All’imbrunire, qualche ora prima della
messa in onda del telegiornale, la guardavo perdendomi
nei suoi alberi e arbusti e immaginavo che dalla vetta da
un momento all’altro si sarebbe affacciato un gruppo di
pellirosse a cavallo pronti a scendere e a battagliare.
Attraverso quella suggestione infantile si stava
determinando in me il distacco e il conseguente ritorno
a casa, nella casa di un tempo, nella casa in cui i
pellirosse mantenevano ancora i loro accampamenti, le
17
loro frecce e i loro piumaggi, pronti a scontrarsi col
Settimo cavalleggeri. Era un ricordo che potrei definire
borderline, al limite della saviezza, ricostruito su
disarmonie di film e filmetti ma anche su disagi reali,
inseriti a loro volta in memorie di carillon, profumi
dimenticati, dolcezze familiari che risalivano
rapidamente dalla profondità degli anni per
rammentarmi che il tempo stava tornando indietro a
proteggermi. In realtà, sostituivo il ricordo con la sua
illusione per affrontare meglio le paure e i disagi
romani.
Mi sarei ammalato, anche fisicamente intendo, se
avessi continuato a lottare, senza farmene una ragione,
contro le vellutate prepotenze in Rai e il variopinto
mondo delle raccomandazioni, contro le manovre della
gran parte dei colleghi che a ogni cambio di
maggioranza fuori e dentro il palazzo dell’informazione
pubblica facevano come Angelo Musco... Una volta il
grande attore catanese fu ricevuto da Mussolini a
Palazzo Venezia. Dopo i convenevoli d’uso, il Duce gli
sparò la domanda che faceva un po’ a tutti: “Musco,
siete voi fascista?” L’ospite prese tempo, sorrise. La
risposta, assolutamente spiazzante, fu questa:
“Eccellenza, marinaru sugnu”. Allo sguardo perplesso
del duce, precisò: “Vado dove mi porta il vento”. Lo
stesso avrebbe detto il capitano Renault all’amico Rick
Blaine in Casablanca: “Seguo il vento che tira, e in
questo momento tira un forte vento di Vichy”.
Un giorno Rodolfo Brancoli, da poco direttore del
TG1, si fece due lunghi corridoi per venire nella mia
stanza a farmi i complimenti per un servizio (sulla
formula segreta, se non ricordo male, della Coca Cola)
che avevo realizzato per l’edizione delle 13.30. Disse:
“Poiché le mie parole ogni volta cadono nel vuoto, sono
venuto personalmente a congratularmi con te”. Aveva
capito che il mio caporedattore, col quale talvolta
entravo in conflitto, non mi trasmetteva i suoi elogi,
semmai comunicava quelli rivolti agli altri, amici e
sodali, che potevano aiutarlo politicamente. Che
18
finezza. Una volta, per protesta contro un collega che
aveva osato criticarlo, questo britannico caporedattore
alla rovescia buttò in aria le cassette-video che portava
con sé, si allungò sul pavimento e cominciò a battere
ripetutamente i piedi a terra. Come i bambini. La
scenetta si divertiva a raccontarla quella malalingua di
Enrico Mentana, giornalista brillante e con una marcia
in più rispetto alle mezzecalzette che affollavano il
servizio pubblico. E l’avrebbe dimostrato non solo
fondando il Tg5, che sarebbe diventato un pericoloso
concorrente del Tg1, ma risuscitando il TgLa7 che in
mano ad Antonello Piroso stava pressoché sparendo.
Nel lasciare la direzione del telegiornale Piroso si
paragonò a Lay Gaga e attribuì a Mentana il ruolo di
Madonna. Come dire, il nuovo (Lay Gaga) veniva
sostituito dal vecchio (Madonna). A parte
l’incongruenza del ragionamento, il piccolo e patetico
Piroso dimenticava che in 30 anni la regina della disco
music, così come ha fatto “mitraglia” Mentana con
molti e più autorevoli colleghi, ha triturato parecchie
Lay Gaga.
Brancoli durò pochi mesi. Mi confessò che passava
più tempo a correggere i pezzi dei colleghi che a
dirigere il giornale: “Non posso accettare che in un testo
di dieci righe una parola sia ripetuta sette volte!”
Portava con sé il rigore della carta stampata e della
buona scrittura, e aveva un vezzo per me
incomprensibile: indossava sempre un pullover blu,
abbottonato sul davanti, con smagliature ai gomiti. Altri
direttori c’erano stati e altri sarebbero venuti. In dieci
anni ne ho sperimentati nove. Ma Brancoli fu fatto fuori
perché era un osso duro, perché aveva idee precise sulla
professione, perché era allergico alle pressioni della
politica. Il giornalismo, era solito dire, deve imparare a
essere indipendente dal potere politico, deve imparare a
controllarlo, a incalzarlo, senza però assumere un altro
punto di vista ma restando in una prospettiva distaccata.
Figurarsi. Nel teatrino politicizzato della Rai, in cui
tutti, a gara e a turno, giudicano re e reucci, pur nudi,
19
riccamente vestiti, era come spostare l’Etna al largo dello
Jonio.
Un pomeriggio di primavera tornai di corsa da Parigi
dove avevo intervistato Johnny Depp. Il pezzo era
previsto per l’edizione delle venti, tuttavia, controllando
la scaletta definitiva del telegiornale, mi accorsi che era
stato depennato a favore di un servizio di Vincenzo
Mollica, confezionato in redazione e che riguardava il
lancio di un disco di Enrico Ruggeri. Montai in bestia,
per la soperchieria e per il fatto di non essere stato
informato del cambiamento. Non avevo protezioni,
essendo politicamente apolide, ma per difendere la mia
dignità ero disposto a tutto, anche a licenziarmi. Entrai
come una furia nella stanza di Marcello Sorgi che mi
guardò sorpreso. Di solito i giornalisti entravano con il
cappello in mano anche se non l’avevano. Era un
direttore piccolo di statura, giovane e di poche parole.
Figlio di un noto avvocato di Palermo, aveva fatto
carriera alla Stampa con la sua aria di bravo ragazzo che
tanto piaceva all’avvocato Agnelli. Fronte alta, occhiali
a stanghetta, camminava radente i muri non guardando
in faccia nessuno e aggiustandosi continuamente la
giacca per mantenerne l’appiombo. Conservò il suo
punto di vista ma il servizio sul cantante Ruggeri non
andò in onda. Sui giornalisti della carta stampata e su
quelli televisivi aveva una sua teoria. Ai primi basta la
bravura, diceva, ai secondi è necessario che siano anche
“personaggi”. In altre parole, i giornalisti televisivi
devono saper “recitare” le notizie, essere in grado di
colpire la fantasia del pubblico col loro stile attoriale, la
loro presenza fisica, i loro tic, insomma l’estetica è più
importante del contenuto. Se ripenso ai suoi telegiornali
non mi padre che la teoria avesse trovato importanti
applicazioni. In verità, egli giocava coi pupi di creta che
aveva o che gli spedivano per corriere espresso. Alcuni
erano fisicamente e professionalmente impresentabili.
Ma chiuse un occhio. Poi chiuse l’altro. Anni dopo lo
incontrai a Catania. Presentava un libro nella terrazza
del museo diocesano. Fu contento di rivedermi. Ed era
20
sincero. Lontano dalle lusinghe e dai corrompimenti
della Rai aveva ritrovato il senso della professione e dei
rapporti umani.
Alla fine ero stanco, deluso, sfiduciato. Sarei tornato
nella mia città, a pezzi. Ma di questo avrò modo di
parlare più avanti. Posso qui aggiungere che i direttori
che mi mostrarono simpatia e considerazione furono in
particolare Nuccio Fava e Bruno Vespa, ambedue
democristiani: l’uno moroteo, l’altro espressione del
famoso CAF (Craxi, Andreotti, Forlani). Non posso che
ringraziarli. Il tanto vituperato Vespa fu un buon
direttore, nonostante tutto; difese sempre la redazione,
ebbe il coraggio di entrare in conflitto con l’allora
presidente della Repubblica, il bizzarro Francesco
Cossiga, e alla fine da molti colleghi, me compreso,
venne abbandonato e affossato. Di ciò mi porto un
rimorso, appena bilanciato da qualche attenuante, che
ogni tanto affiora e mi fa male. In realtà, Vespa fu
costretto a dimettersi non tanto per il voto contrario
della maggioranza della redazione, che storicamente si è
sempre riconosciuta nella sinistra, quanto per il mancato
sostegno del direttore generale, il democristiano
Pasquarelli, che per altro gli aveva “suggerito”
l’assunzione come giornalista dell’istruttore di tennis
della figlia. Per quel voltafaccia si sentì pugnalato alle
spalle, lui che aveva simpatizzato da sempre per la
Democrazia Cristiana fino a definirla “editore di
riferimento”. Definizione fin troppo sincera, che scatenò
il putiferio ma che fotografava una situazione reale: il
TG1 saldamente in mano alla DC, il TG2 in mano al
PSI e il TG3 (teleKabul) in mano al PCI. Queste erano
le zite, le fidanzate. Fu un dramma che visse male e che
in seguito condizionò e inasprì il suo carattere e le sue
scelte politiche. In tempi più recenti s’è lasciato
affascinare dalla sirena berlusconiana senza capire che
quel canto gli ha fatto perdere equilibrio, saggezza e
l’ha rovinosamente allontanato dal grande sogno che
nutriva da ragazzo: assomigliare a Walter Cronkite,
scomparso alcuni anni fa, icona mondiale del
21
giornalismo televisivo, l’uomo che la gente ammirava
perché era onesto, autorevole, inflessibile. La cronaca
del defenestramento apparve nell’edizione serale del
telegiornale e fui io a occuparmene. Lo feci, credo, con
scrupolo e onestà. Ma l’avere tributato al collega
sconfitto l’onore delle armi non mi fu perdonato, e
questo l’avrei capito molti anni dopo.
Il maggiore difetto di Bruno Vespa? A parte la
durezza del carattere e l’ossessiva puntigliosità nel
ribattere alle critiche, anche quelle giuste, egli ha una
visione conservatrice del mondo ed è un governativo per
cultura e formazione provinciale, com’eravamo
governativi noi de La Sicilia di Catania che mai ci
saremmo sognati di andare contro le istituzioni e le
maggioranze espresse dal voto popolare. Vespa viene
dall’Abruzzo, terra dura e drammatica, e forse porta con
sé l’arco di quelle montagne battute dal gelo e dal vento,
com’io mi porto appresso le sciare fredde dell’Etna che
rendono insicuri i pensieri e stravolgono lo spirito. Con
gli anni Bruno s’è meritato elogi e critiche ma è
diventato un personaggio al punto da finire in cronaca
per le notizie più banali. E nessuno ricorda più la
spettacolare intervista che fece a Bagdad a Saddam
Hussein. Unico al mondo. Lo intervistò in perfetto
inglese. E nessuno sapeva che quella lingua conoscesse.
Lasciandogli il testimone, Nuccio Fava trovò parole
di grande nobiltà. Riporto fedelmente il brano del
discorso che tenne alla redazione: “Il nuovo direttore, il
collega Bruno Vespa, voi lo conoscete benissimo. Posso
solo aggiungere che io con Bruno Vespa, quasi
vent’anni fa, ho fatto una selezione e poi un concorso
per radio telecronisti, assieme a altri colleghi: Frajese,
Angela Buttiglione, Bruno Pizzul, tutti nomi a voi noti.
Ebbene, Bruno Vespa – questo molti di voi non lo sanno
– a quel concorso risultò primo. Il mio augurio è che
come nuovo direttore del Tg1 risulti anche il direttore
migliore”. Altri tempi, altro stile.
Tornando all’infanzia, ricordo con precisione il
primo giorno di scuola di mia sorella. Non avevo ancora
22
l’età e tuttavia volevo andare con lei, avere i miei libri, i
quaderni delle cartiere Pigna con la copertina illustrata, i
pennini Presbitero, l’astuccio di legno col coperchio
scorrevole, la gomma per cancellare Staedtler, le matite
Fila e i gessetti colorati della Fim Torino; insomma,
tutto ciò che stava nella cartella magicamente misteriosa
di mia sorella, magicamente profumata di cuoio e
cancelleria. E piansi, oh quanto piansi! L’altro giorno
mi sono rivisto, in un lampo, nella figura di un bambino
di sei-sette anni che all’uscita di un supermercato teneva
tra le braccia, quasi più grande di lui, un vaso pieno di
fiori. Era fiero e felice. La mamma che l’accompagnava
fece il gesto di aiutarlo, ma lui rifiutò. Doveva piacergli
un sacco quel vaso. Se la madre glielo avesse tolto gli
avrebbe rubato il mondo, il suo mondo vivo di colori.
Oh, piccolo bambino che non sarai più, piccolo bambino
che crescerai e dimenticherai quel forte sentimento di
gioioso possesso che ho colto nei tuoi occhi e che un
tempo lontano mi apparteneva!
La finzione del cinema la respiravo attraverso la
finzione della città, da sempre divisa tra il martirio
cristiano di Sant’Agata e quello pagano di Eliodoro,
bruciato vivo dal santo vescovo Leone che lo tenne
“fermo dentro una fornace, senza riportare lui stesso –
miracolosamente – la minima scottatura”, come ricorda
in un bellissimo saggio postumo lo storico Antonino
Recupero. La finzione e la magia di Eliodoro, intendo,
che una volta per scommessa fece spogliare alcune
donne creando l’illusione d’una fiumana d’acqua che le
investiva. Forse per questo Catania è una città che si
auto-rappresenta nelle sue quinte di palazzi barocchi,
che recita i ruoli della vergine e della baldracca e poi
s’addormenta dentro il suo “teatro”, nella misera realtà
di ciò che sta nascosto, invisibile. Città di visioni e di
scena, dunque, di attori che imparano dalla vita e si
perfezionano nella finzione “tecnica” del teatro e del
cinema. Città di supplizi, di simbologie estreme, di fede
e laicità, di santificazione e ludibrio. Ed è questa
contrapposizione che la rende complessa e inafferrabile.
23
In questo libro parlo della mia vita, delle mie
esperienze umane e professionali, delle vittorie e delle
sconfitte ma tutto questo non è solo mio, appartiene a
tutta una generazione nata durante la guerra ma che la
guerra non ha conosciuto, appartiene a tutti quei
bambini, poi ragazzi, poi adulti che sono cresciuti nella
società povera degli anni Cinquanta ma con un cuore
forte e che mai si sono arresi. Ragazzi vestiti di grigio,
senza i colori della rivoluzione, apparentati in qualche
misura ai giovani americani descritti da Sloan Wilson,
estranei al consumismo. Ragazzi che hanno amato il
cinema e i libri, che nelle feste di Natale mettevano
sotto il piatto di papà la letterina con la quale
promettevano di essere più buoni e studiosi, che
scrivevano dichiarazioni d’amore alle ragazze e si
disperavano per i loro rifiuti, ragazzi che non hanno
conosciuto le lusinghe terribili della droga, che hanno
spinto con gli occhi la propria età acerba magari col
piccolo sogno di raggiungere presto l’emancipazione
indossando i calzoni lunghi, la giacca e la cravatta,
presentarsi al botteghino senza arrossire se il film era
vietato ai minori e restringersi nel cerchio mistico della
loro avventura umana. La volontà di crescere era ed è di
tutti i ragazzi com’è naturale ma a quei tempi, come
scrive Ian McEwan in Chesil Beach, “essere giovani
costituiva un ingombro sociale”.
Quelle di allora erano vite semplici e percorribili,
non vite artificiali, vuote e ingannevoli. I padri, che
avevano combattuto due guerre e cercato di costruire un
avvenire migliore, non hanno mai ingannato i loro figli.
Pur riempiendoli d’amore e di tenerezza, li hanno
costantemente messi di fronte alle responsabilità e alle
durezze della vita. Così anche le madri. E sono stati
ascoltati non perché erano “genitori”, non perché come
tali avevano il diritto di sbagliare e di essere assolti
sempre e comunque, ma perché avevano le carte in
regola, avevano l’autorevolezza dei comportamenti.
Dunque, i figli non sarebbero stati capaci, come John
March, di vivere al di fuori del proprio destino,
24
aspettando o temendo chissà cosa e nel frattempo
allungarsi gli anni senza accorgersi per esempio
dell’amore puro e disinteressato di May Bartram. Quei
ragazzi avevano troppe cose da fare, troppo cammino da
percorrere per fermarsi a contemplare il proprio
ombelico. Ragazzi con infanzie di pietra, precocemente
adulti, ragazzi che si distinguevano dai grandi solo per
l’altezza. Per rendere spiritosamente l’idea, ricordo un
fulminante
dialogo
cinematografico.
Sabrina,
protagonista dell’omonimo film di Billy Wilder,
domanda al padre, autista dei ricchi e potenti Larrabee:
“Com’era Linus da bambino?” Risposta: “Più basso”.
Per dire che il più grande dei fratelli Larrabee era stato
sempre vecchio, sempre serio, senza giochi e senza
infanzia. Poi l’incanto s’è spezzato. Crescendo ci siamo
accorti che la nostra amata città, per dirla ancora con
Nino Recupero, cominciò a essere percepita come “un
impasto ripugnante di sicilianismo e di folklore
dozzinale”, una città non finita, violentata dalla
speculazione edilizia, una città produttrice di
semilavorati intellettuali destinati all’emigrazione.
Quando all’alba degli anni Novanta mi trasferii a
Roma ero anch’io un “prodotto semilavorato”, pur
avendo i miei anni e la mia formazione professionale,
ma mi trovavo a un bivio: crescere o tornare indietro. E
poi mi sentivo “come uno chiuso in un sommergibile
affondato”, secondo il giudizio di Andrea Camilleri
intervistato da Sebastiano Messina su la Repubblica,
uno che deve uscire per forza a respirare all’aperto, pena
l’asfissia. Catania era giunta a un punto morto, anzi,
stava precipitando nel suo provincialismo di maniera,
nei suoi club culturali paesani e inutili, nelle sue mafie
bianche e nelle sue mafie nere, nella sua editoria da
strenna, nel saccheggio del denaro pubblico, nei tanti
Thénardier impegnati a fare sottocultura strizzando
l’occhio a questo o a quel politico di turno… insomma,
Catania stava svendendo i propri sogni e noi stessi che
di quei sogni c’eravamo alimentati. Poi l’incanto è
tornato a rompersi per quella legge invisibile che rende i
25
siciliani deplacierten, fuori posto o fuori luogo,
nell’isola, nelle penisole, nei continenti, come sostiene il
prof. Tino Vittorio scopritore di letture ardue e di
scrittori appartati, a volte appannati, come l’ebreo
tedesco Kurt Tucholsky che del suo essere deplacierten
fece una condizione drammatica di vita.
Un po’ tutti, di questo mestiere del vivere e dello
scrivere dolente, siamo andati e tornati, siamo ancora
risaliti per le colline e le pianure delle palme (non
ancora devastate dal punteruolo rosso) e abbiamo rifatto
il viaggio all’incontrario, finalmente per dormire, dopo
tanta fatica, nelle nostre poltrone di velluto. Abbiamo
fatto i pendolari dello spirito, sempre delusi, sempre alla
ricerca di noi stessi, sempre sradicati, attraversando e
riattraversando lo Stretto come hanno fatto generazioni
prima di noi, ben più salde nel talento. Parlo delle
migliaia di professionisti che hanno lasciato gli
orizzonti illuminati dell’infanzia per radicarsi nei paesi
della Luna e ogni tanto dimenticarli volgendo lo
sguardo ai paesi del Sole fino a farsi prendere dal
rimorso. A quel punto basta una vecchia canzone, un
film in bianco e nero, una foto, e magari il sapore
dimenticato di un frutto a spingerti a rifare la valigia e a
tornare laddove Giovanni Percolla si fece cullare
dall’affetto ossessivo delle zie. Mortale decisione, come
molti sanno. Perché nulla è cambiato, né può cambiare,
nelle paludi siciliane che restano luogo ideale degli
uccelli migratori. Come sopravvivere dunque? Abitando
non in città ma a casa propria, e portando sugli antichi
altari la propria malinconia.
È da un pezzo che intendo scavare nel mio
giardinetto una profonda buca, come ha scritto Paolo
Giordano, non per nascondermi – sono nascosto
abbastanza – ma per costruire una cisterna d’acqua. Lo
scopo recondito, però, è di scoprire, smassando lo strato
lavico che sta sotto la terra che nutre alberi e fiori, una
casa di campagna sepolta dalle antiche colate. Ce ne
sono tante di queste piccole e grandi masserie sulle
falde dell’Etna, e alcune sono state anche trovate:
26
affumicate, diroccate, più o meno intatte persino.
Immagino allora di calarmi in questo luogo segreto,
come in una tomba di sovrani egizi, e scoprire il passato
della gente che vi abitava e che doveva condurre una
vita onesta prima d’essere tragica. Aprire cassetti alla
ricerca di impossibili foto, diari, quaderni risparmiati
dal calore, aprire quel mondo antico e portarlo alla luce,
alla verità. Alla fine realizzare lì il mio studio e la mia
biblioteca. Per nascondermi meglio e pensare meglio
utilizzando quel ritrovato filo di memorie fulminate.
È un libro di ricordi, ma che non vuole inserirsi nella
“letteratura della memoria”, in quel filone di
manierismo narrativo che sotto il fascismo prese vigore
sia per la censura che limitava la libertà espressiva sia
per l’influenza potente che esercitò La recherche di
Proust sugli scrittori del tempo. È invece, come scrisse
Giansiro Ferrata nella prefazione al libro fortemente
evocativo di Lalla Romano, La penombra che abbiamo
attraversato, un rendere onore o comunque
testimonianza “a un determinato intreccio fondamentale
di passato che merita singolarmente attenzione,
interesse e consenso d’onesto tipo storico-poetico, oltre
che trascinante e indefinibile solidarietà affettiva”.
Senza cadere nella trappola della nostalgia, questo libro
vuole ripristinare anche il senso politico di quegli anni
lontani, l’orgoglio di una patria oggi nemmeno divisa
ma polverizzata, vuole insomma riscoprire il senso
comune delle cose, la rigidità persino dei concetti, dei
valori, perché nell’oggi vedo solo fumo e smarrimento,
vedo uno Stato che si lascia ricattare dalle bande del
Nord e del Sud e non sa nemmeno ricordare il suo
secolo e mezzo di vita.
La piccola patria che era la mia città di gelsomini è
ancora salda nel mio cuore, pur con i necessari
distinguo, ma non mi ha mai forzato a mitizzarne i
luoghi, le persone, i sentimenti. Se forzatura c’è stata
questa riguarda il cinema, la sua capacità incantatrice, la
sua forza di tracciare un percorso spirituale, il cinema
ultraromantico in definitiva, il cinema incline all’enfasi
27
melodrammatica per dirla con Vittorio Spinazzola nel
momento in cui descrive l’universo poetico e letterario
di Grazia Deledda che in gioventù si nutrì di disordinate
letture ora nobili ora mediocri.
È il cinema il protagonista del libro. La mia vicenda
personale vi si mescola per renderla più affascinante e
raccontabile. L’orologio che ha segnato il mio tempo di
ragazzo è stato un orologio di celluloide. Al posto dei
numeri c’erano le dive del cinema americano. Alle
dodici, Greta Garbo e Marlene Dietrich; all’una,
Claudette Colbert e Vivien Leigh; alle due, Ingrid
Bergman e Jennifer Jones; alle tre, Katharine Hepburn e
Rita Hayworth… In definitiva, se la vita non sempre
accompagna la grandezza del pensiero, il cinema
completa il pensiero con la suggestione, il sentimento, il
mito e paradossalmente lo rende meno astratto e più
vero.
28
UNO
Greta Garbo, Marlene Dietrich
Nel cinema di poveri di via Capuana, gestito dal
signor Matteo Lombardo, e che ci era possibile
frequentare grazie a uno zio materno, funzionario delle
ferrovie, si proiettavano film di terza visione ma
soprattutto film del passato. L’industria cinematografica
stava rialzandosi a fatica dalla tragedia della guerra e
dunque si era costretti a ripescare dal magazzino le
opere censurate nel Ventennio fascista oppure quelle
che mantenevano ancora fascino e interesse. Ricordo La
regina Cristina di Rouben Mamoulian, con Greta Garbo
e John Gilbert, girato nel 1933 ma che nei primi anni
Cinquanta riuscì a parlare al cuore di tutti, a quello dei
padri e a quello dei figli, a due generazioni diverse ma
che dividevano lo stesso orizzonte di speranza.
Struggente la scena finale. La protagonista, sulla prua
della nave che la porta in esilio, guarda dolente davanti
a sé e ripensa al suo amore impossibile: nel film è
l’ambasciatore di Spagna, nella realtà l’affascinante
dama di corte Ebba Sparre. La censura, nei Trenta come
nei Cinquanta, funzionava a pieno regime (fascista
prima democristiano dopo). Più semplice allora sarebbe
stato attribuire alla Divina un’indole criminale piuttosto
che una vocazione sessualmente imbarazzante.
Mio padre era innamorato di Greta Garbo. Il film
l’aveva visto a vent’anni e n’era rimasto folgorato
(quella
folgore
si
allungò,
per
naturale
“indottrinamento”, fino al mio tempo fanciullo). Mio
padre. Si trasferì a Catania dal segmento etneo AdranoBronte-Maletto-Randazzo proprio quando la “città
tentacolare” si stava allontanando dal suo grande
vecchio che l’aveva intrisa, e nobilitata, con la sua arte
verista. (Negli ultimi anni Giovanni Verga se ne stava
seduto, solitario e malinconico, davanti al Circolo
Unione “col bastone tra le gambe e le mani appoggiate
29
sopra il manico”, come ce lo descrive Ercole Patti,
simbolo rispettabile ma superato di una società dalla
quale occorreva prendere congedo). Mio padre, dicevo,
copia conforme di James Mason in Operazione Cicero,
approdò nell’era brancatiana degli anni Trenta, nel
risvolto ingannevole del fascismo al quale più o meno
tutti s’inchinarono, compreso il giovane Vitaliano
Brancati, che tentò di farsi raccomandare da Mussolini
per avere la direzione di un giornale, e compreso mio
padre che sgomitò tra la folla, nel ’37, per stringere la
mano al duce venuto a inaugurare l’apertura del cantiere
del nuovo Palazzo di Giustizia. Senza contropartite,
però, armato solo della sua giovinezza e del suo
entusiasmo. Del resto, lui e la gran parte degli italiani
erano in eccellente compagnia: Ezra Pound in primo
luogo e poi Rainer Maria Rilke che ammirò Mussolini
per avere imposto l’ordine della dittatura al disordine
della democrazia.
Se ne avesse avuto il modo, mio padre, avrebbe
sottoscritto le parole di Brancati: “Sono nato in
un’epoca d’asfissia. Ricordo che non c’era nulla da fare;
che sedevo, bambino, in un mondo ove tutto pareva
finito; e il dubbio di vivere era così grande da togliere
anche il pensiero della morte”. Le avrebbe sottoscritte
perché a soli otto anni aveva perduto la madre: una
“spagnola” fulminante se l’era portata via nel 1918.
Oltrepassando tuttavia la sua linea d’ombra, non fu tra
quelli come Giovanni Centorbi che a mo’ di manifesto
generazionale scrisse: “Noi fummo gli inquieti del Sud,
i giovanotti irsuti che avevano fretta di scappare lontano
dall’odore delle sardelle fritte”. In realtà, quei giovani
con la retina in testa e le giacche rivoltate, nati a ridosso
del Novecento, sentivano la “necessità di uscire da un
mondo persecutorio di costrizioni morali”. Eppure, il
piccolo orfano che fu mio padre avrebbe di certo
agognato inebriarsi di sardelle fritte e persino di
“costrizioni morali” perché tutto ciò avrebbe significato
l’esistenza di una famiglia non di un suo surrogato.
Problemi familiari a parte, mio padre apparteneva al
30
periodo drammatico con efficacia descritto da Ferenc
Körmendi nel suo libro più conosciuto e amato, La
generazione felice, che felice non era affatto: due guerre
mondiali, dittature sanguinarie, grande depressione,
paura, incerto futuro.
Negli anni che separano le due guerre mondiali,
mentre l’eco dell’Inutile Strage andava affievolendosi e
il fascismo si esercitava con goliardiche parate e fucili
di legno, mio padre frequentò i caffè letterari in cui
artisti di vario peso e provincialismo si riunivano per
parlare di arte e letteratura. Il caffè di punta era
Caviezel, che sorge tra piazza Duomo e piazza
Università. Freschi di barba e capelli, solitari o in
gruppo, arrivavano Francesco Guglielmino, Giuseppe
Villaroel, Antonio Aniante, don Antonio Corsaro,
Antonio Prestinenza (poi direttore de La Sicilia),
Gesualdo Manzella Frontini e Titomanlio Manzella
padre del giornalista e inviato de La Stampa Igor Man,
scomparso alcuni anni fa, che una collega del TG1
credendo fosse un giornalista americano ribattezzò
Aigor Men. Come l’amico di Proust, Bloch, incontrato a
Balbec, che diceva laift invece che lift e Venaice invece
che Venice.
D’estate, quando lo scirocco avviliva il corpo e la
mente, allungavano il passo verso i due chioschi di
piazza Università, posti come garitte l’uno di fronte
all’altro, e si facevano servire acqua e zammù, acqua
seltz limone e sale (che chiamavano “completo”) e vari
scialacore a base di sciroppo di menta, mandarino,
amarena. E lentamente i pensieri tornavano a librarsi,
piccoli o grandi che fossero. C’erano poi Ottavio
Profeta, Giacomo Etna, Vitaliano Brancati, Ercole Patti,
M. M. Lazzaro, Arcangelo Blandini, Sebastiano
Addamo, Vito Mar Nicolosi (padre del capo cronista
storico de La Sicilia Turi Nicolosi), Giuseppe Patanè,
Concetto Marchesi, i giovani Fiore Torrisi e Manlio
Sgalambro.
“Villaroel, con il suo tocco garbato e faunesco”,
raccontava Corsaro “cercava di attirarmi nel suo giro,
31
ma soprattutto voleva che mi accorgessi della presenza
di Dio nel suo canto”. Don Antonio Corsaro era amico
di mio padre e di Fiore Torrisi, “poeta cittadino” come
lo definì il premio Nobel della letteratura Salvatore
Quasimodo. Era amico dello stesso Quasimodo col
quale s’azzuffava sulla paternità dell’ermetismo. “Sono
stato io, non Ungaretti, a fondarlo”, sosteneva con foga
il cantore di Acque e terre. “Va a leggerti le riviste e
non i manuali di storia letteraria, va a confrontare le
date! Non ripetere a orecchio quello che ti dicono i
toscani che ci odiano, noi siciliani. Quelli, i Luzi, i
Bigongiari, non sono poeti, fanno letteratura!” Antonio
Corsaro non lo amava molto, non amava il suo carattere
ombroso e saccente che lo aveva reso inviso a buona
parte dell’intellighenzia italiana. Non stimava nemmeno
i poeti siciliani, provinciali e ignoranti, a parte Fiore
Torrisi. Il suo giudizio era tranchant, come lo era quello
di Carlo Muscetta che rivoluzionò l’insegnamento della
letteratura italiana nella nostra università giudicata
provinciale, polverosa, inadeguata.
Il sette maggio del 1924, durante la sua prima visita
a Catania, Mussolini pose un dubbio amletico: che cos’è
meglio, disse in sostanza, il passato intriso di brumose
teorie antivitali e antistoriche oppure il presente che si
rifà alla gloria dell’impero romano e che “affronta la
vita come un combattimento”... punto interrogativo. La
folla osannante scelse la lotta, senza capire che si
trattava di un paralogismo, senza capire che non
sceglieva il presente ma il passato prossimo, quello
retorico e confuso di Mario Rapisardi che Victor Hugo
si sventurò a definire un “precursore” e non era che un
mediocre e pomposo poeta di provincia. A confondere
le acque, qualche decennio dopo, ci si mise pure
Edmondo De Amicis, cuore sanguinante, che del Vate
catanese tracciò questo panegirico: “È una figura
elegante e fiera di poeta romantico del secolo scorso…
Cessa di sorridere, però, e s’oscura in viso e fa vibrare
lo sdegno della parola profetando che la viltà della
borghesia liberale, clericaleggiante per timore dello
32
spettro rosso, finirà col dar l’Italia nelle mani del partito
cattolico, il quale vi rifarà la rivoluzione a rovescio”. Il
clero cittadino si vendicherà facendo marcire il corpo
del Rapisardi nei depositi del cimitero per dieci anni.
Molti esponenti della sinistra catanese, prima di
confluire nel partito del “compagno” Mussolini,
s’inchinarono al “profeta” laico; e mio padre, socialista
per vocazione, non fu da meno procurandosene l’opera
omnia. Insomma, quella generazione preferì Venezia a
Belmont, preferì il mondo borghese (d’affari e di
commercio) a quell’altro (favoloso, antico, cortese). Poi
la guerra fece giustizia di tutto.
Il 25 luglio del 1943, dopo il famoso colloquio tra il
re e il duce a Villa Savoia, un maggiore dei carabinieri
scattò sull’attenti davanti a un Mussolini allucinato e
stravolto e disse: “Eccellenza, per ordine di Sua Maestà
il Re dovete seguirci”. E la storia cambiò. L’ufficiale
era Paolo Vigneri che a guerra finita si sarebbe rimesso
a studiare, sarebbe diventato notaio e si sarebbe
trasferito a Catania. Oggi il figlio Giorgio ha ereditato lo
studio, mentre l’altro figlio, Riccardo, è un ricercatore
medico di fama mondiale.
La modernità post-verghiana aveva come referenti
Pirandello e Martoglio, si colorava dei film americani e
dei suoi divi: Greta Garbo, stella del mattino e della
sera, Ramon Novarro, Douglas Fairbanks, Mary
Pickford, Gloria Swanson, Norma Shearer, Lupe Velez,
Conrad Nagel che aveva amato sullo schermo ottanta
stelle. Nagel veniva da una cittadina dell’Iowa, suo
padre era musicista, sua madre cantante. Era un
bell’uomo (alto, biondo, occhi azzurri), un marito
esemplare e un pezzo grosso della chiesa americana.
Nei primi tempi i giornali tentarono di attribuirgli
qualche scappatella immaginandolo una sorta di dottor
Jekill nella vita privata e di mister Hyde nella vita
professionale. Trovarono solo dive di celluloide: Alice
Brady, che allora era una mezza regina del muto, Bessie
Lowe, Norma Talmadge, Renée Adorée, e in seguito
Joan Crawford, Dolores Costello, Elena Hyams. Si
33
sposò tre volte, ebbe due figli e girò, tra muti e sonori,
oltre cento film: il primo fu Piccole donne (1918),
l’ultimo Secondo amore (1955).
Nei sogni faticosi di quella generazione di reduci e di
sperduti della vita c’erano anche le nostre Isa Miranda,
Clara Calamai, Assia Noris, Luisa Ferida, Vittorio De
Sica, Osvaldo Valenti, Amedeo Nazzari. Su questo
domestico fronte cinematografico italiano il fascismo
mise un filo spinato così come sull’informazione, i
cinegiornali, la radio. L’intento era di separare il Paese
vero da quello falso e di rappresentarlo come operoso,
onesto, benestante, quasi inventato.
Il flusso della letteratura e del cinema, ma anche del
pettegolezzo e della goliardia, scorreva sulla strada
maestra, la via Etnea, che De Roberto definì il “salotto
di Catania”. In questa strada dell’ironia e dello
sberleffo, dell’indolenza e del chiacchiericcio, si è
svolta buona parte della storia cittadina, tutto ciò che
merita di essere ricordato. In questo salotto, che la gente
frequenta solo per recarsi da qualche parte mentre prima
andava meticolosamente a zonzo, si faceva flanella e si
discuteva di calcio, di ragazze, di film che venivano
scelti in base ai cartelloni affissi all’ingresso dei
cinematografi.
Negli anni dei caffè letterari i manifesti erano
capolavori d’arte pubblicitaria, un poco veri un poco
fasulli ma suggestivi e talvolta commoventi. Come
quello del film Una romantica avventura di Mario
Camerini, 1940, che ritrae in primo piano una dolente
Assia Noris con sullo sfondo un uomo in frac e una
carrozza che aspetta. L’idea che il manifesto vuole
trasmettere è la rottura della relazione tra la ragazza, di
modeste condizioni, e il giovane elegante che si
allontana per sempre dalla sua vita. Preciso e
inquietante il manifesto del Testimone, primo film di
Germi, 1946. Sopra il titolo sono disegnati i protagonisti
della storia, Marina Berti e Roldano Lupi,
disperatamente abbracciati. Su di loro incombe una
sorta di fantasma rosso con le mani sporche di sangue.
34
Anche stavolta l’idea è quella di un amore infelice.
Si potrebbero scrivere romanzi sui manifesti del
cinema, tanto è ricca la loro iconografia, la potenza del
disegno, la sapiente combinazione delle immagini.
Accanto alla loro storia, però, che sottende quella del
cinema, si potrebbe anche raccontare la vita di una
comunità che quelle immagini ha amato ed elaborato
come un nastro di fotogrammi muti eppure parlanti, una
comunità ossessionata dal confronto tra la grande e ricca
America e la piccola e povera Italia, l’America di
Cappello a cilindro e l’Italia del Feroce Saladino in cui
un’esordiente Alida Valli tenta con molta ingenuità di
rubare qualche scintilla di grandezza a Ginger Rogers.
Il regime fascista, intanto, andava concentrandosi
sulla morale e sui costumi degli italiani. Esaltando la
“maschia gioventù”, mise mano al bastone per castigare
gli omosessuali che il nazismo aveva equiparato, in
quanto “razza”, agli ebrei e ai negri. Secondo i rapporti
dei prefetti e dei questori, le città prese di mira furono
Venezia, Firenze, Salerno e Catania. La città etnea,
forse unico caso nell’Italia dell’epoca, ospitava una
comunità gay organizzata e consapevole, con le sue vie,
i suoi luoghi d’incontro, i suoi locali, da tutti tollerati
tranne dalla polizia, naturalmente, che in una nota
riservata al duce ne denunciò il comportamento con
queste parole: “Vivono la loro condizione a viso aperto,
adescando la gioventù in pieno centro e in pieno
giorno”. Delle 90 condanne al confino “politico”,
inflitte agli omosessuali tra il 1936 e il 1939, ben 42
furono opera del questore di Catania, Molina. Questo
solerte funzionario dello Stato, espressione cieca di
quella Catania che Brancati avrebbe descritto come
centro del gallismo e della maschia virilità, fu preciso
fino alla pignoleria, vessatorio e crudele.
Il primo vero film di Greta Garbo, La leggenda di
Gösta Berling, diretto nel 1924 da Mauritz Stiller a
Stoccolma, curiosamente l’ho visto per ultimo, in casa
d’un appassionato cinefilo del cinema muto, Gioacchino
35
Russo, che aveva una collezione pazzesca di quei film
che andavano da La nascita di una nazione a Settimo
cielo. Anche le dive di quel tempo erano entusiasmanti
per bellezza e intensità espressiva, a partire da Mary
Pickford e Louise Brooks per finire alle sorelle
Talmadge e alle nostre Lyda Borelli e Francesca Bertini,
e nulla avevano da invidiare alle attrici che sarebbero
venute dopo, col sonoro. Gioacchino, che quelle attrici
“possedeva” nei loro silenziosi scrigni, abitava nel
centro storico, nelle memorie del passato: libri rilegati
in pelle, divani damascati, tappeti persiani, ceramiche di
Caltagirone, foto d’antenati, silenzio lucente, profumo
di colonie fuori commercio. Al centro di questo
Ottocento velato ma palpitante troneggiava un
apparecchio radio degli anni Trenta, ancora funzionante
pur con gli inevitabili gracchiamenti. Dopo averlo
acceso bisognava aspettare che le valvole si
riscaldassero prima che Radio Londra, sotto la guerra,
facesse da controcanto alle notizie dell’Eiar diramate da
Forges Davanzati e poi da Mario Appelius. La Voce del
nemico era quella del colonnello Stevens ed era
preceduta dalle prime quattro battute della Quinta
sinfonia di Beethoven: ta-ta-ta-tan. Nell’idea del
ministero della propaganda inglese corrispondevano ai
tre punti e una linea dell’alfabeto Morse, cioè a dire alla
lettera V come Vittoria. La figlia di Harold Stevens,
Betty, fu compagna dell’industriale farmaceutico
catanese Ciccio Gorgone, uomo di grande simpatia e
intelligenza che per anni frequentò Eleonora Rossi
Drago prima che l’attrice sposasse il nobiluomo
palermitano Mimì La Cavera. La leggenda narra che la
fortuna di Gorgone la fecero due ricchi americani,
incontrati per caso sull’aereo, che volevano impiantare
in Sicilia un’industria di farmaci.
Radiogiornali, radiodrammi, concerti, canzoni,
collegamenti, cabaret… questo componeva l’avaro
tempo libero degli italiani brava gente che sognavano e
cercavano di diventare migliori immaginando dietro la
rete dell’altoparlante il mondo del futuro, un poco
36
casalingo e un poco avventuroso. Nel dopoguerra, sul
riflesso del vetro, dove erano segnate le stazioni radio,
talvolta mi attardavo a rimirarmi e a fantasticare che
quel “trono” di legno, vetro e fili, acquistato da mio
padre “a violino”, potesse un giorno diventare non solo
voce ma anche immagine.
Qualche anno prima della Leggenda, siamo intorno
al Duemila, avevo visitato a Mårbacka nel Wärmland,
quasi al confine con la Norvegia, la casa natale della
scrittrice svedese Selma Lagerlöf, premio Nobel nel
1909 e autrice del romanzo che avrebbe ispirato il film
con la Garbo. È una villa immersa nel bosco, vicino al
lago Fryken, ampia e luminosa, luogo insostituibile per
raccogliere il silenzio e il suo immaginare. Qui la
solitudine diventa specchio e nutrimento della fantasia.
Orizzonte. In questo spazio verde e azzurro la piccola
Selma ascoltò, e se ne nutrì nel profondo, i racconti
della nonna paterna sulle saghe del Wärmland e ancora
qui si ammalò di una forma di poliomielite, che allora
era definita paralisi infantile, finché un giorno si alzò
improvvisamente dalla sedia per seguire il volo di un
uccello dai colori fantastici, mai visto. Era guarita, come
d’incanto, senza cure o stregonerie. Solo la volontà di
raggiungere quel piccolo alato sogno.
Lasciando la dimora fatata il visitatore viene
catturato da un pensiero inevitabile: solo quelle terre di
fiumi e di laghi hanno potuto ispirare le saghe, le
leggende metastoriche delle popolazioni nordiche, i
racconti di Gösta e dei bizzarri Cavalieri di Ekeby.
Selma era una viaggiatrice instancabile e attenta. Alla
fine dell’Ottocento visitò la Sicilia e ne fu tanto
impressionata da ricavarne un libro, I miracoli
dell’Anticristo, in cui il popolo siciliano avrebbe potuto
superare la propria miserevole condizione a patto di
coniugare i valori evangelici (il Cristo) con la speranza
di riscatto del socialismo (l’Anticristo).
Greta Lovisa Gustafsson era figlia di un netturbino e
di una contadina di origine lappone. Alla morte del
padre era stata costretta, appena quattordicenne, ad
37
abbandonare la scuola e a lavorare prima in una bottega
di barbiere poi come commessa in un grande
magazzino. Storia comune a molte attrici del tempo che
venivano per lo più da famiglie operaie e che nel cinema
trovarono, prima che i soldi, orgoglio e riscatto sociale.
In qualche caso trovarono la pazzia. Come quella che
colse la brava e sprovveduta Daniela Rocca tirata fuori
da un quartiere popolare catanese e catapultata a Roma,
la capitale del cinema, dove girò alcuni film storici, che
ne esaltarono la bruna avvenenza meridionale, fino al
capolavoro Divorzio all’italiana, di Pietro Germi, che la
impose all’attenzione del pubblico internazionale. Poi,
più nulla. Se introduci una contadinotta in un salone
sfavillante di luci e poi la metti a fare la sguattera in
cucina crei in lei una dissociazione che può farle
smarrire la ragione. Daniela si lasciò ingannare dai finti
scenari di Cinecittà fino al degrado, fino a che confuse
la realtà con le sue illusioni. S’innamorò perdutamente,
e invano, del regista Germi senza capire che dietro il
cinema non c’era solo il cinema ma qualcosa di peggio,
c’era la vanità, l’ignoranza, il vizio, l’invidia, la
violenza, la bugia. Morirà nel 1995, in una clinica
psichiatrica di Siracusa, folle d’amore e di solitudine.
La romantica Greta fu una grande attrice perché
grande era stata la sua umiliazione. E questo il pubblico
del dopolavoro ferroviario, ignorante e semplice ma
vicino al dolore e alle privazioni della gente umile, lo
capiva perfettamente. L’occasione decisiva arrivò la
mattina del 15 ottobre 1921. La giovane Greta lavorava
da un anno ai grandi magazzini PUB con un salario
settimanale di 35 corone e il suo reparto era diventato
meta di curiosi e ammiratori. La sua figura alta e
slanciata, il portamento, il viso bellissimo dal “pallore
raggiante” non potevano passare inosservati. Qualcosa
di simile avvenne alla Rinascente di Catania, negli anni
Sessanta, dove al reparto profumeria lavorava una
commessa alta e bionda, occhi azzurri, figura da
mannequin. Non era cosa nostra, naturalmente. Veniva
dalla Svizzera e non ci rimase molto in quel reparto che
38
doveva essere frequentato da donne ma i cui clienti
abituali erano soprattutto uomini. Dopo qualche anno
convolò a giuste nozze con un imprenditore che la fece
sparire dai luoghi santi del passio e dall’allupamento
degli sguardi. Forse il marito, che doveva avere
ascendenze mussulmane, si comportò come il
personaggio pirandelliano Ciampa: la chiuse in casa e
non se ne parlò più.
Quel giorno fu proprio Olaf Bergstroms,
amministratore della Paul U. Bergstroms Aktiebolag, a
chiamare la giovane Greta, a offrirle la promozione a
indossatrice e un aumento di 15 corone. Greta, non
ancora Garbo, dapprima cominciò con alcuni
reklamfilm per la società stessa poi fu scritturata per una
piccola parte nel film comico Peter il vagabondo, in
realtà il suo primo vero impegno cinematografico anche
se La leggenda di Gösta Berling fu quello che la
consacrò come attrice vera.
In Anna Karenina di Clarence Brown, 1935, l’attrice
diventa mirabilmente il corpo e l’anima dell’eroina
tragica di Tolstoj. Molti anni più tardi, dopo aver letto il
romanzo del vecchio Lev, e già m’ero in qualche modo
svezzato dall’infatuazione, mi feci un’idea diversa della
protagonista: non la vidi più con la faccia della Garbo,
per
la
verità
eccessivamente
svenevole
e
melodrammatica, ma con quella di altre attrici che
s’erano cimentate nello stesso ruolo. In primo luogo
Tatjana Samojlova, la dolente protagonista di Quando
volano le cicogne di Kalatozov, poi Sophie Marceau,
quindi Vivien Leigh, una delle poche a salvarsi dalla
mediocre riduzione di Duvivier. Ma a quattordici anni
l’amore per la Garbo, gelida bellezza senza tempo, non
conobbe rivali.
In un libro di Alfredo De Sanctis, Caleidoscopio
glorioso, pubblicato nel 1946 dall’editore fiorentino
Giannini, la bellezza dell’attrice viene in qualche modo
messa in discussione. “Ella possiede in primo luogo”,
sostiene l’autore “il misterioso segreto di rendere
interessanti i suoi stessi difetti fisici, poiché, esaminata
39
un poco, non si può dire che sia bella”. Giudizio
sghembo, ambiguo, che si esplicita in sostanziale
avversione quando l’attrice mostra di volere
impersonare Eleonora Duse: “Respingete questa
tentazione. L’Arte mondiale ve ne sarà riconoscente e
risparmierete a voi stessa, signora, una prova certamente
negativa e biasimevole”.
Forse non sarebbe stato un cattivo affare per la
memoria di Eleonora Duse se la Garbo si fosse
cimentata nel difficile confronto ma in quel tempo
l’attrice italiana, che aveva perduto la testa per Gabriele
D’Annunzio fino al degrado, era per il pubblico italiano
una sorta di sacra effigie, l’interprete d’eccellenza del
teatro europeo, una delle poche in grado di dare sangue
e anima ai personaggi di Henrik Ibsen, il grande padre
della scena europea.
Quando mia cognata dirigeva l’ambasciata italiana a
Oslo mi raccontò una curiosa storia sulla Duse che i
norvegesi si tramandano da generazioni. In un gelido
mattino di maggio del 1906 Henrik Ibsen si stava
spegnendo nella sua abitazione di Oslo. I giornali della
vecchia Europa e del Nuovo Mondo avevano parlato
con commossi accenti e rispetto della sua lenta agonia,
del suo umile congedarsi dalla vita che aveva vissuto
come per raccontarla, come ha fatto Gabito Márquez
con la propria autobiografia. Ma mentre lui se ne
andava, a vegliarlo sotto casa c’era proprio lei, Eleonora
Duse, che s’era partita dall’Italia per rendergli omaggio.
Pur bussando ripetutamente alla sua porta, l’attrice
italiana, che se la batteva solo con Sarah Bernhardt, non
era stata ricevuta, forse per innata ritrosia del
drammaturgo o forse perché questi, già in deliquio,
viaggiava verso la luce immortale. E così l’attrice, che il
pubblico europeo aveva acclamato come interprete
divina ancor prima della Garbo, s’accomodò sul
marciapiede di fronte, col freddo che scendeva dal
profondo Nord, appena mitigato dalle correnti
primaverili di quel giorno infausto, e aspettò che il
destino si compisse. La gente che passava non fece caso
40
a quel monumento vivente del teatro mondiale, e forse
nella sua testa s’articolò lo stesso pensiero del
funzionario della Universal mandato alla stazione di Los
Angeles a ricevere Bette Davis e che se ne tornò negli
studi di Hollywood confessando ai dirigenti di non aver
visto “alcuna donna che assomigliasse a un’attrice”.
Particolare era la voce italiana della Garbo, lo
sfacciato birignao di Tina Lattanzi colmo d’irritanti
anapesti eppure così caldo e riconoscibile come un
marchio di fabbrica che garantisce la qualità del
prodotto. Del resto, la voce originale della Garbo aveva
toni e inflessioni non comuni, come raccontò una volta
al Maurizio Costanzo Show la celebre doppiatrice,
morta alla fine del secolo scorso a 95 anni. Greta Garbo
era solita allungare le vocali e strascicare le parole.
Maria Walewska, per esempio, non lo pronunciava
come normalmente si pronuncia, diceva: “Mariaa
Walewskaa…” Di conseguenza, la vecchia Tina cercava
di fare del suo meglio per adattarsi all’originale pur
mantenendo la sua affascinante impronta sonora che
sapeva di polvere, ninnoli, ventagli ricamati e fruscio di
seta. Dopo avere visto la versione italiana di Margherita
Gauthier, la Garbo confessò che sarebbe stata migliore
interprete se avesse avuto la voce di Tina Lattanzi. La
“regina delle voci” ha reso la parola anche a altre grandi
attrici come Marlene Dietrich, Joan Crawford, Bette
Davis, Greer Garson, Myrna Loy, Rita Hayworth. Dagli
anni Trenta ai Sessanta, assieme a Rina Morelli,
Andreina Pagnani e Lidia Simoneschi, ha costituito il
quadrunvirato femminile del doppiaggio.
Dopo il fiasco di Non tradirmi con me di George
Cukor, l’attrice abbandona la luce della sua vita d’artista
per entrare nella grande ombra della vita privata. “In
questo crudo nuovo mondo”, disse “non c’è più posto
per me”. Era il 1941. Gli Stati Uniti entrano in guerra,
tutto il mondo entra in guerra. “La storia della mia vita”,
confessa nella biografia scritta da Barry Paris “è la
storia di uscite secondarie e ascensori segreti e altri
modi di seminare la gente che mi infastidisce perché mi
41
ha riconosciuta”. E però, lasciando il cinema, si consola
con un’altra eccitante avventura: lo spionaggio. A
rivelarlo è lo scrittore americano Charles Ingham nel
libro Un uomo chiamato Intrepido in cui sostiene che
l’attrice, dopo avere lasciato il set, fu reclutata
dall’Intelligence Service britannico e mandata prima
alle Bahamas, per controllare un milionario svedese in
odore di nazismo, e poi a Stoccolma, per collaborare
alla creazione di una rete di informatori scandinavi.
In Danimarca prese contatto con il famoso fisico
Niels Bohr, prima che questi espatriasse in Inghilterra;
mentre in Norvegia, nelle cui fredde montagne i
tedeschi distillavano l’acqua pesante per la costruzione
della bomba atomica, tentò di sabotare il progetto
nucleare che avrebbe reso il nazismo padrone del
mondo. Che tutto questo fosse vero e certificato è un
altro paio di maniche. Ingham è uno scrittore che lavora
con molta fantasia e pochi documenti. È suo per altro il
libro sui coniugi Windsor e le loro imbarazzanti
simpatie per il Terzo Reich. Il ritratto che l’autore fa di
Wallis Simpson è agghiacciante. La descrive come
un’arrampicatrice sociale dai muscoli d’acciaio e
un’abile spia sessuale al soldo dei nazisti. Secondo
Ingham avrebbe potuto dare la vittoria a Hitler e un
nuovo ordine all’Europa se non fosse incorsa
nell’implacabile ostilità degli ambienti di corte, a
cominciare dalla Regina Madre che non le perdonò
d’essere stata definita con il nomignolo di Cookie.
Spionaggio a parte, il dopo è una lunga e noiosa
fuga. Ipocondriaca, avara e ricchissima, Greta passò il
resto della vita (quasi mezzo secolo) camminando.
Come testimoniano le immagini del fotografo asiaticoamericano, Ted Leyson, che negli ultimi anni l’assediò
senza alcun rispetto della sua privacy. Viveva in una
casa modesta, sulla 52ma Strada, a New York, arredata
male e con l’unica compagnia di due gatti che aveva
battezzato Litrozzo e Mezzolitro: nomi italiani, anzi
siciliani, appresi durante i soggiorni a Taormina. Per
altro, “litrozzo” viene da “litruzzu” (di vino) che gli osti
42
le servivano nelle trattorie alla buona, senza sapere che
dietro quella donna trasandata si nascondeva il più
grande mito della storia del cinema. Un mito reso tale
anche dalla sua caparbia volontà di astrarsi dalla vita
reale, d’essere di celluloide più che di carne. Una volta
Jean Cocteau diede questo consiglio a Yul Brynner:
“Ricordati, mon cher, che quando sarai un divo il
pubblico non deve pensare che vai al gabinetto”.
Marlene Dietrich, di quattro anni più vecchia, fu
diva, anzi divissima, anche lei; una giornalista la definì
“antifascista per decenza e lesbica per vocazione”. Più
che amarli, uomini e donne, li colonizzava. Come fece
Isabel Burton con suo marito. Lo amò tanto che lo
distrusse. Chiaramente, della sua omosessualità noi
ragazzi degli anni Cinquanta poco o nulla sapevamo ma
anche se l’avessimo saputo o solo intuito non
l’avremmo compresa, e certo ci sarebbe caduto il
mondo addosso se avessimo appreso che quell’amore
distorto trovava una precisa consonanza proprio nella
divina Greta Garbo.
Il lesbismo di Marlene emerse sin dalla prima
giovinezza. Tra il 1925 e il 1929, a Berlino, prima di
essere scoperta dal pubblico come l’Angelo azzurro,
aveva messo su un teatro-cabaret molto equivoco, ed era
amica di Claire Waldoff, lesbica dichiarata e popolare
interprete di operette e riviste, che per altro le insegnò a
cantare. Fu il film di Josef von Sternberg del 1930 a
lanciarla nel firmamento internazionale, un film
pressoché perfetto, apologo della disperazione
dell’umanità in generale e, in particolare, della
borghesia della Repubblica di Weimar. La storia del
professor Unrath che s’innamora perdutamente della
cantante Lola-Lola catapultò il pubblico più giovane, a
quel tempo acerbo e per nulla smaliziato, in un mondo
di contrasti insanabili: da un canto non capì la passione
di un vecchio per una donna giovane e fantastica,
dall’altro criticò il cinismo della ragazza, la sua
strafottenza, il suo dare e non dare, il suo apparire e
43
scomparire di fronte alla disperazione di un uomo che
per amore perdeva ogni dignità.
Mezzo secolo dopo ho rivisto in teatro, al
Metropolitan di Catania, la drammatica vicenda del
professore Unrath interpretata da Giorgio Albertazzi e
dalla soubrette Valeria Marini. Alla fine del primo
tempo ci siamo guardati con mia moglie, ci siamo alzati
e ce ne siamo tornati a casa. Una performance, quella
dell’attrice bambolona, assolutamente irritante. Il mito
deve restare nella sua dolce oscurità, non farsi
strapazzare gratuitamente da attrici che non sanno
nemmeno dove stanno di casa. Ricordo il momento in
cui, nell’Angelo azzurro, Marlene, con voce rauca e
atteggiamento volgare, seduta su una botte, canta “Dalla
testa ai piedi sono fatta per l’amore”. Il pubblico del
dopolavoro restò incollato alla sedia, incapace di
esprimere una qualsiasi emozione. Non capiva le parole,
ovviamente, ma sentiva potente il flusso erotico che
emanavano la figura e la voce della diva. Poi, in una
nube di fumo da nevrosi, esplose in un applauso
interminabile.
Nei successivi film, Marlene Dietrich venne
spogliata della sua carnalità berlinese e ridefinita all’uso
hollywoodiano. I maghi della Paramount, alla ricerca di
un’attrice da contrapporre alla Garbo, allora sotto
contratto alla Metro, riuscirono nell’intento. Alla
rarefatta femminilità della svedese contrapposero il
sublime erotismo della tedesca. “Già con la sola voce
potrebbe spezzarti il cuore”, scrisse Ernest Hemingway
“ma possiede anche un corpo stupendo e il volto d’una
bellezza senza tempo”. L’altro grande della letteratura
americana, William Faulkner, si espresse così: “Non ce
ne voglia la divina Garbo se per un attimo ci inchiniamo
al fascino di un’altra bellezza europea”.
Fu questa femminilità equivoca, dura e aggressiva, a
farci preferire, a noi ragazzi di frastorno, la Garbo alla
Dietrich, la moglie all’amante, per così dire. Era questo
il nostro sentire circoscritto, il nostro vedere senza
capire, appena agitato dalla giovinezza irrisolta. Ma c’è
44
dell’altro. C’è che i ragazzi, ieri come oggi,
preferiscono la forma alla sostanza, lo spirito alla
materia, la chiarezza all’ambiguità; perché i ragazzi
amano le favole e i personaggi delle favole, amano ciò
che è semplice non ciò che è complesso, preferiscono i
fumetti ai libri, le figure ben delineate e colorate a
quelle imprecise e sfumate, amano Harry Potter non
Raskolnikov, il tormentato protagonista di Delitto e
castigo, l’uomo che uccide per debolezza e si redime
per amore; in definitiva, vivono come immersi in una
realtà a due dimensioni; diventeranno adulti nel
momento in cui riconosceranno la terza dimensione: la
profondità.
Negli anni Sessanta Greta e Marlene furono a
Taormina. Ce lo ricorda il giornalista Gaetano
Saglimbeni che scriveva per La Gazzetta del Sud, il
quotidiano di Messina, e che di quel mondo di
celluloide sapeva molte cose. Camminava con la pipa
tra i denti e un foulard al collo alla maniera degli ultimi
dandy di periferia che cercavano, secondo i canoni
estetici di Oscar Wilde, di essere all’altezza delle loro
porcellane. Forse il collega Saglimbeni immaginava di
recitare la parte del latin lover Rossano Brazzi che in
Tempo d’estate, di David Lean, corteggia la matura
turista americana, Katharine Hepburn, in una Venezia
da cartolina illustrata. Stando ai suoi ricordi, Greta
Garbo trascorreva le vacanze, sotto falso nome (si
faceva chiamare Harriet Brown), nella villa del
dietologo Gayelord Hauser che si era fatto i soldi
prescrivendo alle dive di Hollywood carote e sedani
crudi. Percorreva le straduzze taorminesi indossando
ampi cappelli, occhiali scuri, vestiti comuni, guanti per
nascondere le brutte mani e scarpe di foggia maschile,
comode e “vaste”… i suoi piedi non erano proprio
quelli di Cenerentola. Il concetto dei piedi piccoli come
espressione di bellezza fu contestato da García Márquez
prendendo a difesa proprio i piedoni della Garbo. In
Scritti costieri 1948-1952 egli scrive: “Nelle
occupazioni della vita moderna, una donna che abbia di
45
che reggersi in piedi è un problema di equilibrio
domestico. Una che calzi dal trentanove in su, è una
garanzia di laboriosità e azione”. Spiritoso gioco
concettuale che tuttavia portò lo scrittore latinoamericano ad ammettere alla fine che la Garbo, per
come si vestiva e camminava, era una donna senza garbo.
A quei tempi si conoscevano i suoi amori ortodossi.
In primo luogo, Mauritz Stiller, che l’aveva tirata fuori
dallo sgabuzzino dove lavorava a Stoccolma e l’aveva
resa immortale. Lei se ne dimenticò presto e alla morte
prematura di lui, per elefantiasi, restò impassibile. Forse
le lacrime le avrebbero rovinato il trucco. Poi John
Gilbert, che stava per sposare nel municipio di Santa
Ana, in Messico. Ma non se ne fece niente perché la
diva, pochi minuti prima del fatidico “sì”, chiese di
andare alla toilette e non tornò più. La storia, forse una
storiella, assomiglia molto a quella che si raccontava a
Catania negli anni Cinquanta: un tizio dice alla moglie
di allontanarsi un momento per andare a comperare le
sigarette e scompare per sempre. Lo stesso Hauser, che
le fu amico e l’ospitava nella sua villa sulla rotabile per
Castelmola, programmò di sposarla. Per fatto
pubblicitario, naturalmente, perché lui era gay e lei
incapace di amare qualsiasi uomo. Come ricorda
Saglimbeni, Gayelord si mise d’accordo con un’agenzia
giornalistica, che preparò in anticipo la notizia e la
congelò in attesa dello “sta bene” degli sposi, e partì con
la “fidanzata” per Nassau, dove si sarebbero dovute
celebrare le nozze. L’agenzia attese invano la telefonata
di conferma.
La divina Garbo, che nel privato non frequentava
certo altari di celluloide, nutrì amori saffici di assoluto
rilievo. Tra alti e bassi ebbe una lunga relazione, 45
anni!, con la baronessa miliardaria Olga de Rothschild;
poi s’invaghì in maniera furente e spropositata di
Marlene Dietrich che la sedusse, appena diciannovenne,
nei camerini della compagnia di Max Reinhardt “usando
solo la bocca”, come ha scritto Richard Newbury in un
articolo apparso sul Corriere della Sera. E poiché
46
Marlene era perfida e sfrontata mise in giro la voce,
sempre per giudizio di Newbury, che la Garbo “era
grande lì sotto” e che portava biancheria poco pulita.
L’anticonformismo della Dietrich si legava con ogni
probabilità al conformismo del padre, ufficiale di polizia
prussiano, con tanto di monocolo e baffi attorcigliati,
che alla piccola Marlene dovette sembrare una sorta di
caricatura che metteva conto imitare, certo per gioco,
ma che finì con l’irretirla. Diversamente dalle bimbe
che calzano le scarpe della mamma per sembrare adulte
e si pavoneggiano davanti allo specchio, la futura diva
berlinese sostituì i tacchi con gli scarponi del genitore
per imitarne la maschia marzialità. E fu lì che alle
bambole preferì le sciabole di legno e i soldatini di
piombo.
I curatori del Fernsehmuseum di Berlino dedicano
alla Dietrich un’attenzione speciale. Le sale del museo
sono ospitate al terzo piano d’uno dei grattacieli di
Potsdamer Platz che sembrano ispirati alle scenografie
di Metropolis. Forse era questa l’idea degli architetti
chiamati dal governo tedesco a dare una sistemazione
moderna e dinamica a quella vasta piazza di confine
diventata con la guerra una landa desolata e che fino alla
caduta del Muro divideva il comunismo dalla
democrazia. Renzo Piano, a capo del progetto, e con lui
Christoph Kohlbecker, Richard Rogers, Arata Isozaki,
Helmut Jahn in cuor loro hanno detto grazie agli
scenografi e disegnatori impressionisti del celebre film
di Fritz Lang. C’è un’intera sala dedicata alla diva
tedesca che Hitler cercò invano di far rientrare dagli
Stati Uniti per spenderla sul tavolo delle pubbliche
relazioni. Agli angoli della stanza sono sistemati in
bacheca i magnifici costumi che l’attrice indossò in
Marocco, Disonorata, Desiderio, Il giardino di Allah
ma che appesi alle grucce sembrano pezze; né lo
splendore dell’immaginazione riesce a renderli veri e
raccontabili. Il resto è meraviglioso e dolente: lei che
canta fumando, che trafigge lo spettatore con lo sguardo
di ghiaccio, che incede tra la folla mentre se la spolpa
47
con gli occhi… e via di fotogramma in fotogramma a
ripristinare un tempo memorabile.
Marlene Dietrich, nei suoi rapidi soggiorni
taorminesi, era ancora sulla breccia e si guardava bene
dal camuffarsi. Era sempre all’altezza della sua fama,
affrontava con intelligenza le situazioni più difficili, le
domande più imbarazzanti della stampa. Al casinò di
Taormina, anno 1963, fasciata di satin nero, cantò da
par suo molte delle canzoni che l’avevano resa celebre
nel mondo. Cantò e fece piangere, come aveva fatto con
i soldati sui fronti alleati di guerra, Lili Marleen, che in
Germania era stata portata al successo da Lale Andersen
mentre sul fronte opposto sarebbe diventata il simbolo
della Resistenza.
“Vor der Kaserne/ vor dem grossen Tor/ stand eine
Lanterne/ und stehet sie noch davor…” Bastavano le
prime note, con queste struggenti parole, trasmesse dalla
radio militare tedesca, perché i soldati del Terzo Reich
si abbandonassero alla nostalgia della casa lontana e
degli affetti. Non solo loro ma anche i combattenti
angloamericani nel momento in cui riuscivano a
sintonizzarsi sulle frequenze nemiche. La politica
aggressiva di Berlino però non poteva tollerare a lungo
le lacrime dei suoi guerrieri e così Goebbels in persona,
quale ministro della propaganda, ordinò che non venisse
più trasmessa. Infiacchiva i combattenti. Marlene
Dietrich, invece, al riparo della democrazia, ne fece un
cavallo di battaglia. Al seguito delle truppe alleate la
cantò in Nordafrica, in Sicilia, in Inghilterra, ovunque
suscitando ammirazione e commozione.
Marlene dava alla canzone una profondità da café
chantant, come se la interpretasse di fronte a un
pubblico di civili e di soldati in licenza mentre bevono
birra, piangono e si augurano che la guerra finisca al più
presto. La Andersen invece era come se la cantasse nel
cortile d’una caserma, col risultato però che la marcetta,
messa dagli arrangiatori per dare un tono guerresco alla
canzone, finiva con l’essere ugualmente fagocitata dal
leit-motiv in sé struggente e malinconico. Né migliore
48
fortuna ebbero Willy Fritsch, con la sua voce a mezzo
registro tra tenore e soprano; Mimi Thoma, che
scimmiottava la Andersen; e persino i granatieri della
divisione Panzer e le Camicie Brune che cantavano il
motivo marciando e tirando su col naso. In Italia fu
portata al successo da Lina Termini, una cantante di
Agrigento, che la interpretò tenendo a mente più la
versione di Lale Andersen che di Marlene Dietrich.
Anche lei fece piangere battaglioni di militi al fronte e
negli ospedali. Il compito di imitare la Dietrich se lo
assunse Milly, la soubrette dalla voce notturna che fece
innamorare, nell’ordine: il principe Umberto, Cesare
Pavese e Mario Soldati. In Francia, regina incontrastata
fu Juliette Greco, la musa degli esistenzialisti, che di
Lili Marleen fece un sussurro nostalgico: assottigliando
la voce e rendendola un filo di spada arrivò diritta al
cuore degli ascoltatori.
A guerra finita, dopo essere stata perseguitata e
imprigionata dai tedeschi per disfattismo, Lale
Andersen venne accusata dagli alleati, al processo di
Norimberga, di propaganda nazista per avere cantato
quella canzone. La salvò il maresciallo Montgomery con
una sorprendente dichiarazione: “Propaganda nazista
quella di Lale Andersen? State scherzando, spero. Nel
tempo in cui, io e i miei soldati, nel deserto, davamo la
caccia a Rommel, dopo una giornata di fatiche,
battaglie, pericoli, la sera trovavamo conforto con quella
voce, con quella canzone!” In Italia fu tradotta così:
“Tutte le sere, sotto quel fanal/ presso la caserma ti
stavo a aspettar./ Anche stasera aspetterò/ e tutto il
mondo scorderò./ Con te, Lili Marleen,/ con te, Lili
Marleen”.
Lili Marleen non fu l’unica canzone a essere amata
durante la seconda guerra mondiale. Le fece una forte
concorrenza I’ll be seeing you, scritta da Sammy Fain e
interpretata dall’allora popolarissima Vera Lynn. Le
prime quattro battute sono ispirate all’ultimo
movimento della sinfonia n.3 di Mahler. Musica
struggente e parole struggenti. “…and when the night is
49
new, I’ll be looking at the moon, but I’ll be seeing
you…” E non c’era fidanzato o fidanzata cui non
tremassero le gambe. Sul fronte dell’Armata Rossa
c’erano le bellissime Kalinka e Katjusha.
Marlene aveva avuto una vita straordinariamente
interessante, sopra le righe, sopra ogni linea mediana,
una donna dal “fascino leggendario”, per usare la
definizione di Patrick Dennis. Nel 1923 sposa il regista
Rudolf Sieber. Un matrimonio aperto, senza
convivenza, dal quale nasce l’unica figlia dell’attrice:
Maria, che nel 1993 scriverà una piccante biografia
della madre, amori saffici compresi. Secondo Greta
Garbo, però, Sieber era un uomo di paglia. Il vero
marito era il regista teatrale Otto Katz, una spia
addestrata a Mosca e poi spedita a Hollywood a dirigere
il fronte stalinista della Lega Anti-Nazi sotto il falso
nome di Rudolph Breda. Otto Katz si sarebbe convinto a
collaborare quando i sovietici minacciarono di rapirgli
la figlia. Il segreto fu utilizzato dalla Garbo per bloccare
le maldicenze dell’attrice tedesca sul loro rapporto
lesbico. E forse, se l’avesse saputo, avrebbe sfruttato
l’altro grande e meglio nascosto segreto della Dietrich:
l’esistenza di una sorella maggiore che gestiva col
marito, a due passi dal campo di concentramento di
Bergen-Belsen, un piccolo ristorante frequentato dalle
SS. Marlene e il vero marito servirono più di un
padrone: prima i sovietici, poi gli inglesi, infine gli
americani. Otto Katz fu arrestato nel 1952 a Praga e
impiccato come spia. Fu l’unica volta in cui la corazza
di cinismo della Dietrich parve incrinarsi.
Dopo l’accondiscendente Rudolf Sieber, è la volta
dell’altro regista e pigmalione Josef von Sternberg, in
sospetto di omosessualità. In realtà, molti furono
rapporti di copertura (lavender marriages) allo scopo di
aggirare il codice Hays, del 1929, che metteva al bando
l’immoralità dilagante sullo schermo. Numerose attrici,
sceneggiatrici e registe lesbiche furono costrette a
riunirsi in “circoli di cucito”, come li definì
ironicamente la grande attrice del teatro ibseniano Alla
50
Nazimova, omosessuale anche lei e amica intima della
Dietrich nonché della scatenata Tallulah Bankhea, figlia
di un senatore dell’Alabama, la quale era solita dire:
“Papà mi ha detto di stare attenta ai ragazzi e all’alcol,
non alle ragazze e alle droghe”. La Nazimova aveva
avuto un’infanzia e una giovinezza drammatiche. Nata a
Yalta nel 1879, sin da piccola venne picchiata dal padre
e poi, trasferitasi in Svizzera, più volte violentata dal
figlio della donna che la ospitava. Tornata in Russia, a
Odessa, i compagni di collegio si presero gioco di lei
chiamandola “barile”, “orso” e soprannomi simili, lei
che sarebbe diventata così gracile e minuta! Più tardi a
Mosca, per pagarsi la scuola di recitazione, si prostituì
per le strade.
Nella rete della maliarda berlinese finirono Claudette
Colbert; Dolores Del Rio, che amava presentarsi ai
party in abito da sposa accanto a Marlene in smoking;
Lili Damita, prima moglie di Errol Flynn; Mercedes de
Acosta, che per lei tradì la Garbo. È la stessa Mercedes
a raccontarlo in un’intervista impossibile a Liberaeva.
“Incontrai Marlene a un ricevimento, nella cucina della
casa dove m’ero rifugiata piangendo. Greta a quel
tempo mi faceva soffrire e lei carinamente mi consolò.
Dopo pochi giorni mi riempì di orchidee ed io le scrissi
lettere d’amore. Cominciavano con tesoro mio e
finivano con il tuo principe bianco”. Mercedes
proveniva da una benestante famiglia cubana di origini
spagnole. Il padre perse tutto il patrimonio e si suicidò
gettandosi da un ponte, anche il fratello Hennie si uccise
e la madre, che si vantava di discendere dal Duca
d’Alba, morì poco dopo assieme a una figlia. La
relazione con Marlene non fu salda e appassionata come
quella con la Garbo. “Le scrivevo poemi d’amore”,
confessò una volta, ormai in miseria e costretta a
vendere le lettere ricevute dall’attrice svedese, “e in
cambio ricevevo le richieste più prosaiche: che le
comperassi le scarpe, che le ordinassi i vestiti, che le
trovassi una domestica…” Il rapporto andò avanti per
trent’anni e s’incrinò nel 1960, l’anno in cui Mercedes
51
pubblicò un’autobiografia con le foto a seno nudo di
Greta.
L’Angelo azzurro invece passava da un sesso
all’altro con disinvoltura. Amò Gary Cooper, lo stallone
di Hollywood, che le fu partner in Marocco e Desiderio;
amò Ernest Hemingway e il miliardario Joe Kennedy,
padre del futuro presidente degli Stati Uniti e
femminaro incallito come il figlio; amò Erich Maria
Remarque col quale ebbe una appassionata
corrispondenza epistolare (peccato che le lettere di lei
siano state distrutte dall’ultima moglie dello scrittore
tedesco, l’attrice Paulette Goddard). Sul letto di morte
Marlene gli fece recapitare questo telegramma: “Ti
mando tutto il mio cuore”. E il vecchio innamorato
chiuse gli occhi felice. Amò Gérard Philippe e
soprattutto Jean Gabin. Scrive Saglimbeni: “Jean, tre
anni meno di lei, aveva moglie e figli. All’arrivo delle
truppe tedesche lasciò precipitosamente la Francia per
l’America e fu Marlene a ospitarlo nella sua villa di
Hollywood, in attesa di trovargli casa. Lo coccolava
come un bambino e ogni sera gli preparava la cena”. Il
ménage non durò molto. All’attore francese vennero gli
scrupoli. “Non voglio passare per un codardo”, disse. E
riattraversò l’Atlantico per combattere il nazifascismo.
Partì anche Marlene, in divisa di soldato americano, e
sui fronti di guerra cantò la versione inglese di Lili
Marleen.
Se queste erano le parole che riempivano il cuore dei
combattenti lungo le linee contrapposte della guerra, le
sfortunate campagne italiane in Africa e in Russia
venivano accompagnate da un’altra canzone, scritta nel
1936 da Nino Rastelli e musicata da Dino Olivieri,
Tornerai. Il motivo, ispirato al Coro a bocca chiusa
dalla Madama Butterfly di Puccini, era interpretato dal
Trio Lescano e dal Quartetto Funaro. Il refrain faceva
così: “Tornerai da me/ perché l’unico sogno sei/ del mio
cuor./ Tornerai/ tu perché/ senza i tuoi baci languidi/
non vivrò./ Ho qui dentro ognor/ la tua voce che dice/
tremando ‘Amor’./ Tornerò/ perché tuo è il mio cuor!”
52
In Francia, a parte Suzy Solidor, Jean Sablon e Tino
Rossi, la interpretava magnificamente Rina Ketty,
cantante di origine italiana (in realtà si chiamava
Cesarina Picchetto, nome impossibile per un’artista). Il
titolo era J’attendrai e il testo, di Louis Poterat, riscritto
durante la guerra, si adattava meglio alla situazione dei
soldati che combattevano al fronte mentre le loro madri,
mogli e fidanzate ne attendevano con ansia il ritorno.
“J’attendrai/ le jour et la nuit/ j’attendrai toujours/ ton
retour...”
Moltissimi soldati italiani non sarebbero più tornati,
morti assiderati o sopravvissuti sotto le coperte di altri
letti; e molti di loro, mandati a combattere sulla neve coi
ferrivecchi della Grande Guerra, di certo sognavano le
dive del momento, Greta e Marlene, le cui foto tenevano
nel tascapane. Dovevano esserci anche in quelli dei 77
italiani “di modeste pretese e d’infinita pazienza
precipitati nel peggior mattatoio della seconda guerra
mondiale”, per come ce la racconta Alfio Caruso nel bel
libro della Longanesi Noi moriamo a Stalingrado.
L’incipit è da ricordare: “Il più vecchio andava per i
trentacinque anni, il più giovane ne aveva venti. La
moneta volò in aria, da una parte c’era scritto morte,
dall’altra vita. Uscì morte”. Quell’inferno coltivava
assurdamente un sogno, una voce: “Tornerai da me…” e
il giovane soldato, ancora imberbe, col cuore che gli
diventava di cartone, come le scarpe che non riuscivano
a ripararlo dall’abisso del freddo, volgeva lo sguardo al
cielo di marmo e ripeteva: “perché l’unico sogno sei del
mio cuor”. Poi, a mano a mano che la morte stampata
sul verso della moneta si avvicinava, raccoglieva le
forze per l’ultimo desiderio: l’immagine della madre,
del padre, dei fratelli… l’immagine, folle e consolatoria,
della “fidanzata” Greta o Marlene.
Il mito è come l’acqua del fiume che scorre, limpida
e veloce, ma che prima di arrivare al mare si raccoglie
in stagnanti insenature cambiando colore e profumo.
Marlene Dietrich, alla fine della sua vita, era talmente
squattrinata che si ridusse a cantare al telefono per soldi.
53
Lo confidò una volta la figlia all’ex direttore di Vanity
Fair, Leo Lerman. A pagarla fu un ammiratore che la
chiamava dall’America e voleva raggiungerla a Parigi
dove la diva si trovava in quel periodo. Al rifiuto di lei,
l’uomo entrò in depressione e cominciò a spendere
molti soldi in analisi. Marlene seppe dello “spreco” e gli
propose di dare a lei, anziché allo psicanalista, il denaro.
In compenso, l’avrebbe “curato” per telefono cantando.
La voce fu il propellente per mandare in orbita
d’amore un mio collega stenografo che pigiava sui tasti
d’una vecchia Olivetti M20 a rullo mobile alla velocità
di centoquaranta battute al minuto. La stessa velocità di
mio padre marconista dell’esercito quando aveva
vent’anni… tre punti tre linee tre punti, ti-ti-ti ta-ta-ta titi-ti, S.O.S. Save Our Soul, Salvate le nostre anime!
Uno spettacolo vederlo lavorare su quel gioiello
meccanico per il quale negli anni Venti era necessaria
una settimana per costruirlo. Ovviamente era un
modello antiquato rispetto alla Lexikon 80, già da vari
anni in uso, ma così scorrevole e robusto che non
temeva confronti. Ed era soprattutto uno spettacolo per
me che pestavo con due dita sulla mia gloriosa Lettera
22 azzurro polvere che mi è stata compagna fedele per
decenni come lo fu per lo scrittore Corman McCarthy
che di recente l’ha messa all’asta per ventimila dollari.
L’aveva acquistata, come me, nel 1963 ed era azzurra.
La mia riposa tra vecchi libri. Ogni tanto la guardo,
l’accarezzo, penso alla mia giovinezza e penso che non
diventerò mai un Corman McCarthy, l’autore di Non è
un paese per vecchi portato sullo schermo dai fratelli
Joel ed Ethan Coen.
Poiché per il suo lavoro era in contatto con le
centraliniste, che gli smistavano le telefonate degli
inviati, questo collega, di carnagione olivastra e
piuttosto alto, s’innamorò perdutamente della voce
d’una di queste ragazze. Parla oggi parla domani nacque
una forte simpatia che presto sfociò in un
appuntamento. La ragazza era una brava ragazza,
stampo anni Cinquanta per capire, ma di una bruttezza
54
assoluta. Una persona “scumutulidda”, avrebbero detto
le nostre madri. Al collega stenografo tremarono le
gambe, chiuse gli occhi per capire se era la stessa
persona ma la voce, melodiosa e vellutata, glielo
confermò. Passò giorni e giorni totalmente frastornato
finché quella voce, che continuava a solleticargli il
cuore, ebbe il sopravvento. Con gli anni il mio collega
fece il callo all’attributo fisico e continuò a farsi sedurre
dalla parola, dal suono; si fece cullare dall’immateriale
e dallo spirito che c’è in ogni persona, anche la più
sgradevole.
55
DUE
Jean Harlow, Claudette Colbert
A Catania “fare cinema” significa camuffarsi,
recitare, per gioco o per necessità. Come i bambini, in
fondo. Anche loro fanno cinema nel senso che fanno
storie: inventano racconti per convincere i genitori a
passarla liscia oppure improvvisano pianti e stanchezze
per farsi prendere in braccio o per ritardare l’ora di
andare a letto o ancora per non mangiare un certo cibo. I
grandi, invece, fanno cinema in ufficio per farsi
perdonare il ritardo o per coprire la propria incapacità, a
casa per contrastare il buon senso del coniuge, nei
negozi per ottenere uno sconto o per non farlo, coi figli
quando non sanno le risposte. Insomma, fare cinema
vuol dire ingannare. Personalmente, facevo cinema nel
cinema, nel senso che m’immedesimavo negli attori, nei
protagonisti delle tante storie credibili o incredibili che
popolavano il grande schermo, li affiancavo e li
sostituivo.
I film del passato erano il mio presente. Molti erano
fondi di magazzino che i noleggiatori affittavano a
basso costo all’esercente del dopolavoro ferroviario ma
che emotivamente mi coinvolgevano come se fossero
stati appena girati. Vivevo in differita, insomma. Il
cinematografo del signor Lombardo era come una
biblioteca in cui potevano leggersi solo libri antichi.
Sembrava uno svantaggio, un vivere avulso, ma per me
era pur sempre un dono, un riflettere sulle passioni della
vita, una girandola di emozioni seducenti.
Il lunedì mattina, durante la ricreazione e anche
all’uscita di scuola, noi studenti di provincia, indomiti e
confusionari, parlavamo dell’ultimo film visto ma
soprattutto litigavamo sul calcio, divisi com’eravamo tra
juventini, interisti, milanisti. Le altre squadre raramente
ci scaldavano il cuore, tranne quella del Catania che
aveva un posto a parte e tuttavia stava un gradino più
56
sotto rispetto ai grandi club del Nord. Il 23 maggio del
1954 i rossazzurri, pareggiando fuori casa col Como,
zero a zero, conquistarono per la prima volta la serie A.
La partita decisiva fu vinta con questa formazione:
Pattini, Baccarini, Bravetti; Bearzot, Santamaria,
Seveso; Pirola, Manenti, Quoiani, Bassetti, Micheloni.
Il mio idolo era Santamaria, una roccia. Anche Quoiani
era bravo ma erano più i gol mangiati che quelli messi a
segno. Mio padre, pur essendo uomo di letture e di
impegno sociale, amava tutti gli sport,anche la boxe di
cui era arbitro federale. Mi ricordo che una volta,
durante un incontro amichevole al cine-teatro Sangiorgi
feci, per gioco, il “secondo” al pugile Giuseppe
D’Augusta. Gli asciugavo il viso, gli davo l’acqua, lo
ventilavo, gli sorridevo. Qualche anno più tardi
D’Augusta incontrò per il titolo italiano dei pesi gallo il
sordomuto Mario D’Agata. Ma il mio amico, che faceva
il magazziniere alla Fidap, dove lavorava mio padre, e
mi portava un regalo dopo ogni incontro in Continente,
perse la sfida perché l’avversario, come dissero i
catanesi, non “sentiva” i colpi.
La domenica, se il Catania giocava in casa, io e mio
padre mangiavamo in fretta e varcavamo i cancelli del
Cibali a stadio ormai pieno. Per non pagare nemmeno il
biglietto ridotto mi piegavo sulle ginocchia, fino alla
misura consentita, e passavo, emozionato e felice, forse
nella voluta disattenzione del controllore. Prima che i
giocatori scendessero in campo veniva trasmessa dagli
altoparlanti la pubblicità. Il caffé Torrisi viaggiava
sull’onda di un motivetto banale ma che mi riempiva
d’inesprimibili e dolci sentimenti di attesa: “Torrisi
supermiscela, un dolce mistero in te si cela…”
All’annuncio della formazione delle squadre un
silenzio irreale s’impadroniva del pubblico e si rompeva
solo sull’ultimo dei nomi dei giocatori rossazzurri. Poi
cominciavano a volare sul campo pacchi di sale contro
il malocchio mentre le bandiere con al centro ’u liotru
ondeggiavano al vento e Natalino Otto, con la canzone
Forza Catania!, trasmessa a tutto volume, spronava
57
l’entusiasmo dei tifosi già in delirio. “Dalla mezzala al
centro con mezza rovesciata ed una cannonata in porta
arriva già. Fugge veloce l’ala, scocca un bel traversone
ed ecco che il pallone la rete sfonderà. Goal. Forza
Catania, forza Catania!” C’era la tribuna A, dove si
pagava di più, e la tribuna B dalla quale lo spettacolo si
condivideva con il sole in faccia. Più tardi furono
costruiti i gradoni, dietro le porte del campo, a Nord e a
Sud, in cui si raccolse la tifoseria dei quartieri popolari
la cui massima trasgressione furono fischi e invettive
all’“arbitro cornuto”.
Tempi di “Clamoroso al Cibali!” coniato dal
radiocronista Sandro Ciotti che puntualmente si
meravigliava ogniqualvolta il Catania riusciva ad
affondare in casa una corazzata del Nord. Quel
“clamoroso” sanciva la nostra provincia, il nostro
Mezzogiorno profondo e distante, le nostre arretratezze
sportive e sociali; eppure, fu inteso come orgoglio,
coraggio, abilità. Insomma, ripercorrendo indietro di
secoli la storia degli uomini, qualcosa di simile dovette
esplodere nella Valle di Elah testimone di un evento
altrettanto prodigioso: il colpo di fionda col quale il
giovane Davide abbatte il gigante Golia. Gli ultras
arrivarono, con la loro violenta follia, nell’epoca in cui
la città si allargò oltre le colline, il cemento soffocò il
profumo della zagara e i giovani capirono che tutto
quello che c’era da imparare veniva dalla televisione.
Restammo in serie A solo un anno perché a fine
campionato ci riempimmo di vergogna. Il 7 agosto del
1955 il Catania fu processato per corruzione sportiva e
condannato, assieme all’Udinese, alla retrocessione in
serie B. Uno dei responsabili dell’imbroglio fu Giulio
Sterlini, allora corrispondente de La Gazzetta dello
Sport. Fece da tramite tra il Club Calcio Catania e
l’arbitro romano Scaramella che per addomesticare le
partite col Genoa e l’Atalanta chiese la cifra pazzesca di
mezzo milione di lire.
Giulio era figlio della mia maestra alle elementari di
via Giordano Bruno, che frequentai per due anni prima
58
di iscrivermi al collegio Leonardo da Vinci retto dai
fratelli delle scuole cristiane. Suo cugino, per parte di
madre, era Warner Bentivegna, l’attore che ebbe grande
successo in TV e in teatro negli anni Sessanta. La
famiglia Sterlini abitava di fronte a mio nonno materno,
le porte d’ingresso davano sullo stesso pianerottolo di
un palazzo che si affaccia su piazza Angelo Majorana e
via Ventimiglia. Giulio me lo ricordo come un giovane
fantastico, alto, sportivo, cordiale; lui e i suoi fratelli,
nonché il giovane Bentivegna, biondo e secco come un
chiodo, morto alla fine del 2008. Possedevano un
teatrino di legno e passavano interi pomeriggi a farvi
recitare pupazzi di stoffa. Più tardi, anch’io me ne
costruii uno e vi persi l’esistenza.
Un pomeriggio, con mio padre, feci visita alla
signora maestra: stava poco bene ed erano alcuni giorni
che non veniva a scuola. Ci ricevette in camera da letto.
Non s’era rimessa del tutto. Indossava una liseuse
bianca di lana, nella mano stringeva un libro, con
l’indice infilato tra le pagine per non perdere il segno,
mentre con le dita dell’altra seguiva l’ordito della
sovraccoperta di cotone. Sopra la testiera del letto una
copia della Madonna col bambino di Raffaello, che
avevo ammirato anche in casa di zio Lorenzo, fratello di
mia madre, che aveva un laboratorio di sedie in via
Marchese di Casalotto. Era come entrare in un sacrario,
un luogo spirituale, e forse per questo ne conservo
memoria. Era una signora anziana, o almeno così mi
parve allora, con un che di aristocratico nei modi e nella
voce. Mi accarezzò i capelli, parlammo della scuola, dei
miei progressi e disse cose che inorgoglirono mio padre.
A quel tempo frequentavo la seconda elementare, scuola
pubblica, maschi e femmine. Poi, passai alla scuola
cattolica, come ho detto, fino al quinto ginnasio:
signorino tra signorini che non vedevano al di sotto di
un certo livello sociale, come il principe di Henry
James, ragazzi con la puzza sotto il naso, piramidi di
libri, cartelle di cuoio, tonache nere e facciole bianche,
passi silenziosi, terrore per i corridoi infiniti e
59
misteriosi, incenso, preghiere…
Tornando da scuola avevo l’abitudine con altri
compagni di scalciare pietre, a mo’ di pallone, e non
c’erano scarpe che regnassero. Qualche volta facevo la
strada con Giampiero Mughini, una classe avanti, che
abitava con la madre e la nonna vicino casa mia.
Discutevamo di pallone, di professori carogne e di
religiosi maniaci. L’unica comune ammirazione era per
Ciccio, il portiere. Intramontabile istituzione del
Leonardo, “pietra d’angolo” come l’ha definita in un
articolo di ricordi l’ex alunno Francesco Li Destri. Un
giorno, come lui stesso racconterà in un articolo su
Panorama per ricordare i vent’anni della rivolta
studentesca del ’68, Giampiero fu convocato dal
vicedirettore che gli comunicò di avere saputo su di lui
cose abiette, che aveva poi constatato personalmente,
praticate nel cortile della scuola. Giampiero, che in quel
cortile giocava a pallone o a tamburelli, come tutti noi,
non seppe mai quali fossero le “cose abiette” di cui s’era
macchiato. Ricorderà, come ferite brucianti nella carne,
i due schiaffoni subiti, a freddo, con la mano destra e la
sinistra, la perquisizione della cartella e il sequestro di
alcuni francobolli da collezione, “corpi di non so quale
reato”. Più oltre, nell’articolo, inquadrando l’episodio
nella cultura pedagogica intollerante di allora, scriverà:
“Non si capisce nulla dello scatto originario del
Sessantotto italiano se non lo si spiega come la reazione
e l’esplosione di massa contro tante piccole carognerie
premoderne, nelle scuole come negli uffici, nelle
fabbriche come nei giornali, nella vita quotidiana
innanzitutto. Tanto che la rivoluzione di quegli anni fu
la rivoluzione del costume: il non consentire mai più a
nessuno di prenderti a schiaffi solo perché ha una
qualche autorità su di te”.
Anch’io fui preso a schiaffi da un professore. Si
chiamava fratel Natalino e insegnava matematica. Era
pressoché infallibile nel lanciare sugli alunni disattenti
la spugnetta della lavagna e aveva un modo speciale di
comminare la punizione: azionava la mano con
60
impressionante velocità, sia di palmo che di dorso, fino
a farti piangere per l’umiliazione e il dolore. Khaled
Hosseini in Mille splendidi soli ricorda qualcosa del
genere. Ricorda di un insegnante, che a Kabul
chiamavano “il pittore”, il quale puniva gli alunni
“spennellando” sulle loro facce la mano in un verso e
nell’altro. Miserabile perversione che segna, per vie
lontane e misteriose, insospettabili legami “culturali” tra
Occidente e Oriente.
La mia “abiezione” era stata quella di avere
suggerito. E non era neanche vero. Non dissi niente a
casa. Mio padre l’avrebbe rivoltato come un calzino.
Giampiero, anche a volerlo fare, non aveva a chi
rivolgersi. E anch’io ebbi una sgradevole esperienza col
sequestratore di francobolli. Con la scusa di farmi
sapere in anticipo i voti degli esami di terza media, un
pomeriggio mi convocò nel suo studio e tentò qualche
incerta carezza. Avvertii un confuso disagio, una sorta
d’inesprimibile angoscia e delusione, come se l’eroe
d’una storia edificante si fosse messo a fare cose
insensate, lontanissime dalla sua nobile e austera figura.
Non sapevo nulla di pedofilia, avvertivo solo
un’anomalia, una discrasia tra l’ordine delle cose, nelle
quali ero stato educato, e il disordine che stava al di là,
nascosto, ancora da capire. Fece subito marcia indietro.
Forse avvertì il mio istintivo irrigidimento o il mio
probabile esplodere in una fuga che si sarebbe rivelata
per lui molto imbarazzante. In quarto ginnasio non lo
vidi più.
Una triste vicenda che avevo dimenticato ma che è
emersa qualche anno fa vedendo il film di Pedro
Almodóvar, La mala educación. È la storia di due
bambini, Ignacio ed Enrique, che studiano in un istituto
religioso e scoprono, accanto all’amicizia, all’amore, al
cinema, la turpitudine dei grandi: uno dei due subisce
abusi sessuali da padre Manolo, direttore della scuola. Il
film, autobiografico, non vuole essere un regolamento
di conti con i preti, che hanno male educato Almodóvar,
ma, come ha scritto il critico de El Pais, “l’immensa
61
metafora del mistero del male, l’enigma della perversità,
l’inferno come dimora naturale di questo mondo”.
Personalmente, al di là del barocchismo concettuale, ho
visto l’innocenza calpestata proprio da chi quel
sentimento doveva tutelare. Solo di recente la Chiesa
ha fatto mea culpa per i tanti casi di pedofilia del suo
clero.
A quei tempi Mughini era uno sportivo. Superbo nel
gioco del calcio, del ping-pong e nella ginnastica
artistica. Impareggiabile alla sbarra fissa e al corpo
libero. Io me la cavavo agli anelli e al cavallo con
maniglie. Il più bravo però era Franco Malerba, d’una
decina d’anni più grande. Era l’unico a saper fare, dopo
una strabiliante rondata, il doppio salto mortale
all’indietro, detto flic flac, e il terzo senza l’appoggio
delle mani. Morirà ancora giovane, per una banale
caduta, durante un’escursione sull’Etna: lui, che
vorticava nell’aria come un funambolo, che arrivava in
palestra con l’aura del guerriero invincibile e che mai
avresti immaginato spegnersi nel più stupido e assurdo
dei modi. Giampiero solo dopo la maturità classica si
gettò con tutta l’anima sul cinema e sui libri. Per i
ragazzi della mia generazione fu come lo Svedese per
Nathan Zuckerman, in versione etnea, naturalmente, con
quel tanto di impreciso e ribelle che può esserci in un
giovane di provincia, per altro difficilmente imitabile da
chi se ne stava accucciato in famiglia e il cui peggiore
reato era quello di masticare gomma americana.
Aveva un modo sonoro e prepotente di stare con gli
amici, mettersi al centro del gruppo e incantarlo col suo
linguaggio forbito, le sue estreme passioni. Si iscrisse in
legge, come me, ma poi l’abbandonò per la facoltà di
lettere. Fu lui, con altri giovani ammalati di cinema, a
ridare slancio al glorioso Cuc, il centro universitario
cinematografico, che frequentai con una certa assiduità.
Anche lì risplendeva il passato, in specie attraverso le
grandi opere del cinema sovietico. La corazzata
Potemkin, che Paolo Villaggio avrebbe definito “una
boiata pazzesca”, ancora me la ricordo. Film epico,
62
ideologicamente forte ma noioso, di una noia mortale,
che però non si poteva dire per non correre il rischio di
passare agli occhi degli impegnati per uno sprovveduto.
Ma i tempi per uscire dal coro del conformismo della
sinistra ideologizzata, i tempi del re nudo, sarebbero
venuti molto più tardi, negli anni in cui sarei riuscito a
chiamare le cose con il loro vero nome, quando avrei
tranquillamente bocciato, come ha fatto Edmondo
Berselli in Venerati maestri, alcuni film “di sinistra”
praticamente invedibili, quando avrei messo nello stesso
mazzo selvaggio i molti libri abbaglianti e illeggibili
della Einaudi, di quella casa editrice torinese il cui
proprietario si comportava come un principe
rinascimentale mentre i suoi impiegati giravano l’Italia
in terza classe, malvestiti e con poche lire in tasca.
Gianni Agnelli, l’Avvocato, che lo conosceva piuttosto
bene, una volta sottolineò questa contraddizione:
“Rimprovera i comunisti di non essere abbastanza di
sinistra ma nello stesso tempo indulge a squisite
raffinatezze. Mah!”
Il Cuc era considerato il fronte anarcoide e avanzato
della gioventù studentesca catanese, contraddistinto da
un insopportabile narcisismo collettivo grazie al quale i
suoi protagonisti si sentivano lucidi, impegnati,
intelligenti. Si mangiavano il cervello a ogni ora del
giorno. Lavoravano al ciclostile, distribuivano
manifesti, organizzavano cortei di protesta e
immaginavano d’essere il sale della terra in attesa di
prendere il potere che anche dopo il ’68 spostava
sempre più in alto l’asticella. E dunque i rivoluzionari
mai arrivarono a una conclusione certa… “mentre
sarebbe ora di cominciare a concludere”, avrebbe
scritto, negli anni Novanta, il prof. Tino Vittorio in una
raccolta di saggi dal titolo Formicolii. Concludere nel
senso di “andare al potere senza immaginazione, senza
passione, ma con un forte senso di responsabilità verso
le cose, le leggi di mercato e della natura, verso gli
uomini”.
L’altro fronte, quietamente sovversivo e manesco,
63
era riassunto dal Cus, il Centro universitario sportivo.
Due mondi opposti, ideologicamente diversi: nel primo
si discuteva, si leggevano libri e si pensava a come
cambiare la società, sia pure in modo fumoso; nel
secondo si faceva sport, si sognava il posto fisso e il
matrimonio. Ovviamente fu questo mondo a essere
corteggiato dalle gerarchie accademiche mentre i
dirigenti del Cuc erano visti come pericolosi sovversivi.
“Il quotidiano locale”, ricorderà Nino Recupero “ci
dedicava… grandi silenzi, e in più occasioni ci attaccò.
Un attacco particolarmente virulento ci venne da
Antonio Lombardo, allora emergente in Ordine nuovo
(non ancora fuorilegge), che fece stampare manifesti
murali contro di noi. La battaglia era dura”. Il Cus,
collocato ideologicamente a destra, fu a onor del vero
palestra di lealtà, vigore, impegno, sacrificio. Gli atleti,
sempre a corto di soldi, viaggiavano in “terza di legno”
e di notte si sdraiavano a terra o sulle reticelle del
bagagliaio. Vincevano, perdevano, mangiavano panini
con la mortadella, corteggiavano le ragazze e tornavano
sempre con i sorrisi larghi della giovinezza.
Ricordandone i sessant’anni della nascita, in un libro
curato da Nino Urzì, Candido Cannavò, giovanissimo
“pugno d’ossa” che correva per i campi sportivi d’Italia
con qualche buon risultato, scriverà: “Ogni tanto spunta
fuori da misteriosi nascondigli la foto di una squadra di
rugby schierata sul campo di Merano. È il Cus Catania,
con i suoi colossi del tempo, ragazzi che avevano avuto
la fortuna di mangiare bene dopo la guerra, quando per
molte famiglie come la mia i tempi erano molto difficili.
Facevamo cure di arance non esportabili e scoprivamo il
sapore avvincente delle insalate di limoni. In mezzo a
quella squadra c’è un ometto, con un doppiopetto forse
rivoltato. Ero io…”
Al Centro universitario cinematografico (che ebbe
sede prima al cinema Corsaro e poi al cinema Ariston)
si proiettavano film d’autore e alla fine della proiezione
si discutevano col pubblico. I referenti colti e adulti
erano Santino Mirabella, Vito Librando e Santi
64
Bonaccorsi. Vito Librando scriveva di arte su La Sicilia
e quando portava il suo articolo si fermava nella mia
redazione. Godeva di un certo prestigio in campo
accademico ma al giornale pareva un poco sperduto,
sebbene mascherasse il disagio con ironia. Si sentiva
però un po’ carciofo. Racconta Silvano Nigro, allora
giovane assistente di Muscetta, che un giorno entrò per
sbaglio nella stanza di Librando e questi con aria tra il
sorpreso e lo scandalizzato lo apostrofò: “Come ha fatto
ad arrivare fin qui?” Manco fosse stato il Papa,
commenta il brillante studioso che fino a qualche anno
fa ha insegnato alla Normale. Quando la notizia-bomba
del suo trasferimento arrivò a Catania i colleghi,
increduli e invidiosi, telefonarono a Pisa e chiesero
informazioni al portiere! Quello, che ancora nulla
sapeva, cadde dalle nuvole. Al che il povero docente,
per la verità un po’ bizzarro e stravagante, passò per
mitomane. A notizia confermata però i colleghi si
mangiarono le ossa col sale. Racconta ancora Nigro che
molti anni fa gli telefonò il boss Nitto Santapaola per
raccomandargli una nipote. Finito l’esame, la
studentessa, che non aveva saputo rispondere alle
domande più elementari, si trovò scritto sul libretto tre e
lode. “La lode è per lo zio”, precisò Silvano Nigro. Il
giorno dopo il boss gli telefonò e si fece una grossa
risata. Ma forse questa è una balla.
I collaboratori d’avventura di Vito Librando, accanto
a Nino Recupero, erano Vittorio Campione, Piero
Leotta, Miriam Campanella, Silvana Cirrone, Gaetano
Leo, mio compagno di classe al Leonardo, naturalmente
Francesco Mannino, musicista e musicologo, scomparso
anche lui prematuramente e che aveva sposato Bice
Marotta, una bella ragazza da molti corteggiata e ora
docente universitaria. Bice piaceva anche a Mughini che
una volta le scrisse una lettera. Giampiero aspettò
invano la risposta ma non seppe mai che la lettera,
rimasta alcuni giorni nella buca delle lettere mentre
imperversava la pioggia, arrivò nelle mani della ragazza
pressoché scolorita. Vi si leggevano appena alcune frasi
65
galanti ma non la firma né le parti che avrebbero potuto
identificare il mittente. Non potendolo immaginare
Mughini ci rimase malissimo. Ancora oggi non sa.
Francesco Mannino aveva una sorella, Lucia,
seconda moglie di Nino Milazzo, donna gentile e colta.
In gioventù era stata una brava pittrice, allieva di
Roberto Rimini. Peccato che abbia smesso. Su tutti però
la considerazione di Librando era per Giampiero
Mughini, mito per molti ragazzi del tempo, soprattutto
quando sulle barricate del ’68 a Parigi si ruppe un
braccio. Chi non lo conosce può farsi influenzare
negativamente dal suo atteggiamento sopra le righe e
dal modo di vestire bizzarro, dai suoi anelli, dal colore
degli occhiali, dal modo di stare “scivolato” sulla sedia.
Ma è un uomo di sentimento e di lotta, vigoroso e colto,
mai banale, sempre in prima fila a beccarsi i fischi o gli
applausi. Per dare l’idea. Mughini è come quel soldato,
tante volte descritto da Emilio Lussu in Un anno
sull’Altipiano, che esce dalla trincea mentre fischiano le
pallottole e se un compagno cade si ferma a raccoglierlo
e a portarlo in salvo. Come fa John Wayne coi suoi
commilitoni nel film Iwo Jima, deserto di fuoco.
Giampiero l’ho rivisto alcuni anni fa a Cortina,
intervistato da Gigi Moncalvo al Pala Lexus dove il
collega Enrico Cisnetto e sua moglie Iole organizzavano
ogni anno, con efficienza e profitto, incontri culturali
con personaggi di spicco della scena nazionale.
Cancellato dall’Ordine dei giornalisti, per avere fatto
pubblicità dietro compenso a una marca di telefonini,
doveva difendersi da questo “reato” deontologico. E lo
ha fatto a modo suo. Ancor prima di essere presentato al
pubblico è salito sul palco, ha teso le braccia al cielo,
fatto gioco di nocche, misurato a larghi passi il “ring”
per stemperare la tensione e la rabbia che gli
esplodevano dentro. Poi si è tuffato nella lotta. Ha
vomitato accuse contro l’Ordine e i suoi sepolcri
imbiancati che molto spesso mostrano uno strabismo
intollerabile. Nessun dubbio. È stato all’altezza del suo
personaggio: ironico, a volte eccessivo, quasi spietato
66
ma, in ultima analisi per ciò che ha detto, ampiamente
condivisibile.
Moncalvo, giornalista d’ordine, lo ha rintuzzato con
fermezza pelosa quando qualche giorno prima,
intervistando Vittorio Feltri, allora direttore di Libero,
gli aveva fatto da tappetino consentendogli battute al
vetriolo ai nemici e teneri rimbrotti agli amici. Quello
stesso Feltri che da lì a qualche anno avrebbe pubblicato
in prima pagina le foto a seno nudo di Veronica Lario
quand’era una giovane attrice non ancora moglie di
Silvio Berlusconi. Sopra le foto questo titolo: La velina
ingrata. A giudizio di Feltri la signora Veronica in
quanto ex soubrette non aveva titoli per chiedere il
divorzio per il solo fatto che il marito si era reso
responsabile di “frequentare minorenni” (si riferiva
all’imbarazzante amicizia del premier con la
giovanissima Noemi Letizia che lo chiamava “papi”) e
di aver messo in lista per le elezioni europee del 2009
un gruppo di belle ragazze del mondo dello spettacolo.
La signora Lario non poteva strapparsi di dosso la
lettera scarlatta del suo passato, ammesso che questo
fosse di vergognoso ricordo, ma doveva restare legata
per sempre alla sua “infamia” di soubrette, senza
possibilità di riscatto, senza possibilità di protestare e di
reclamare dignità. Una mezza persona, insomma.
Dimenticando che quella donna “lebbrosa” era stata per
trent’anni moglie e madre esemplare.
Giampiero Mughini è stato anche il fondatore e
animatore di Giovane Critica, la rivista legata al Cuc e
oggi considerata, come ha ricordato Nino Recupero in
uno dei suoi ultimi articoli, “una delle esperienze
letterarie italiane più vive di quegli anni”. A trovarle il
nome fu Francesco Mannino e la veste grafica, molto
innovativa, Roberto Laganà e poi Giuseppe Pagnano.
Oggi Pagnano è architetto e insegna all’Università.
Anche con lui eravamo compagni di scuola, anzi di
classe, al Leonardo. In quinta elementare, credo, perse
la madre e noi andammo al funerale. Più o meno
commossi, più o meno felici di avere saltato le lezioni e
67
le interrogazioni. Poi l’insegnante ci condusse
all’ospizio di via Asilo S. Agata. Un appuntamento
annuale, quello, coi vecchietti dell’istituto, che
rendemmo felici coi nostri regali: sigari toscani e dolci.
Anni dopo, nel settembre del 1959, fui testimone di un
altro lutto. Marcello Zammataro rimase orfano del
padre, che era un ottimo professore di matematica e
grande amico di mio padre. La grave perdita gli ispirò
una bella poesia, pubblicata nell’annuario dell’istituto:
“La tragedia è compiuta/ o padre amato./ E su immobili
stelle è il tuo sorriso./ E su ceri d’altari il dolce
sguardo./ E su te e sul mio viso/ son cadute le lacrime
celate,/ mentre un cielo di marmo soffocava/ tra il
fragore di nubi…”
Santino Bonaccorsi lavorava a La Sicilia, in cronaca.
In quel giornale patriarcale e conservatore era
soprannominato il “maoista”. Mi ricordo che
minacciarono di licenziarlo per avere donato qualche
soldo a Il manifesto. Non gli perdonavano il tradimento
della sua passata fede fascista. Era un romantico e un
illuso. Riusciva a parlare con pochissimi colleghi e con
me, da maoista a maoista… sia pure in Porsche. Per il
mio matrimonio mi regalò le opere complete di Bertolt
Brecht, un cofanetto in due volumi della Einaudi che
tengo tra le cose più care. Qualche estate fa io e mia
moglie siamo tornati a Berlino. C’eravamo stati prima
della caduta del muro e ci ricordavamo, più che una
città, un clima tetro e insopportabile. Tutto cambiato. In
meglio, naturalmente. Una sera siamo andati a mangiare
al numero 125 di Chausseestrasse, dove al primo piano
abitava Brecht con la moglie, l’attrice Helen Weigel. Il
ristorante si vanta di cucinare gli stessi piatti che Helen
preparava per il marito. La casa è attaccata al piccolo
cimitero di
Oranienburger, alla
fine
della
Friedrichstrasse, dove sono sepolti i filosofi Hegel,
Fichte e Marcuse, l’architetto Schinkel e, naturalmente,
Brecht con la moglie. Una tomba semplice, la loro,
coperta di edera e di fiori come quella di Gérard
Philippe e Nicole Navoux a Ramatuelle, sulle colline di
68
Saint Tropez. Nicole ricorderà gli ultimi mesi di vita del
celebre marito in un delicato e intenso libro dal titolo
Breve come un sospiro… “La dolcezza dell’aria mi fa
sognare ciò che è stato e ciò che sarebbe se tu fossi
vivo. So che questo sogno prova la mia incapacità di
vivere il presente”. La tomba di Herbert Marcuse invece
è minuscola, quasi insignificante, la incocci per caso.
Ricorda quella di Proust al Père Lachaise. Una piccola
lapide per un grande nome.
Con Santino si discuteva di politica, di rivoluzione
cinese che era diventata il suo nuovo amore dopo la
delusione sovietica. Era convinto che mai e poi mai
Pechino si sarebbe lasciata corrompere dall’Occidente,
dal mercato, dal guadagno. Di certo, non avrebbe mai
immaginato che all’inizio del Terzo Millennio la Cina
avrebbe tolto Mao dai libri di scuola, sostituendolo col
mondo che cammina (meno materialismo dialettico e
più Bill Gates), né che un presidente cinese, Hu Jintao,
avrebbe denunciato alla pubblica opinione la corruzione
e la dissolutezza di molti funzionari di partito accusati
di avere preso tangenti dagli imprenditori per
mantenersi nel lusso e regalare appartamenti e gioielli
alle concubine; né che il governo avrebbe lanciato una
campagna di buone maniere contro la maleducazione,
dal momento che molti cinesi sputano per terra nei
ristoranti e persino negli aerei, ruttano, si puliscono i
denti con le dita e al cinema tengono il cellulare acceso
e rispondono come se si trovassero a casa loro. Le icone
sono difficili da scalzare. L’ologramma cinese a quei
tempi era il sorriso dei bambini in divisa, il libretto
rosso, le marce ordinate, i fiori, la gentilezza.
Santino spostava sempre più in là il confine della
scelta. Verso i gruppi extraparlamentari, i movimenti
giovanili, la rivoluzione permanente. Un modo, il suo,
per sentirsi giovane. Non conosceva le mezze misure.
Nelle cose si buttava a peso morto. Così come aveva
fatto con la Repubblica sociale e poi con l’Urss e la
Cina. Sempre scegliendo, però, il momento sbagliato, il
fronte di battaglia più scomodo. Era questo che me lo
69
faceva apprezzare, questa sua incoerente coerenza. Una
volta mi fece leggere una sua commedia, La berretta di
papà, se ricordo correttamente il titolo. Divertente e ben
scritta. La berretta era il mezzo col quale un ragazzo e
una ragazza si scambiavano biglietti d’amore
all’insaputa dei genitori. Scriveva anche poesie. Molto
belle. Amava i giovani. Amava le donne. Come Tony
Zermo, l’ultimo dei vecchi leoni de La Sicilia,
ostinatamente legato alla sua terra di sole, sempre restio
a lasciare il giornale, a navigare in mare aperto, a
confrontarsi, e forse a rischiare, come fecero molti
colleghi della sua generazione: Santi Petringa, Nenè
Columba, Enzo Magrì, Candido Cannavò, Nino
Milazzo…
Tenendosi stretta la sua terra, Tony è rimasto un
vecchio ragazzo. Quando si sposò, quarant’anni fa, con
una simpatica ragazza di Scanzano, Carlotta, i colleghi
del giornale gli fecero uno scherzo atroce. Antefatto. Per
risparmiare i soldi del ricevimento, destinati all’acquisto
dei mobili, Tony decise di sposarsi a Pompei. Una
decina di invitati in tutto. Ma fu punito perché a
Venezia, dov’era andato in viaggio di nozze, si giocò
tutto al casinò. La mattina dopo il rientro a Catania
trovò, come sempre, una copia del giornale e la notizia
del suo matrimonio. Solo che la notizia era stata riscritta
e ribattuta in unico esemplare per suo uso e consumo.
Scritta a più mani, registrava la tirchieria dello sposo e
altre notizie più o meno vere e più o meno inventate.
Credendo che l’articolo fosse di pubblico dominio ci
rimase malissimo, lui e l’innocente Carlotta. A
chiarimento avvenuto, tirò un forte sospiro di sollievo e
ce ne disse di tutti i colori.
Compiuti gli 80 anni una rotellina del suo
fiammeggiante cervello s’è ingrippata. Stava scrivendo
l’ennesimo articolo per La Sicilia quando si accorse che
il cervello non distribuiva più i comandi giusti alle dita.
Allora fece una cosa semplicissima. Si mise in
macchina e andò difilato al pronto soccorso
dell’ospedale Cannizzaro, un ottimo ospedale, dove gli
70
diagnosticarono un ictus. Una settimana di ricovero e lo
rimisero a posto. Appena dimesso ne scrisse sul
giornale, come se parlasse di un altro, come se il conto
non fosse suo. Un bellissimo articolo.
Jean Harlow, all’anagrafe Harlean Carpenter, figlia
di un dentista e di un’aspirante attrice, bionda che più
bionda non si può, si assunse l’arduo compito di
mettersi in competizione con la Garbo e la Dietrich.
Non riuscì a spodestarle ma tenne una buona posizione.
Non era assolutamente rispettabile, anzi, impersonò la
figura della sgualdrina vestita da principessa, un angelo
corrotto come lo era Marlene ma più disinibita e con
maggiore spirito. Morì a ventisei anni per una grave
disfunzione renale ma fece in tempo a sposarsi quattro
volte, a diventare uno strepitoso simbolo sexy, a
collezionare disgrazie, dissolutezze varie e a entrare
nella storia del cinema con buoni film, molti girati in
coppia con Clark Gable.
Com’era stata la sua infanzia? La risposta possiamo
rubarla a Clint Eastwood che al compagno di prigione
che glielo domanda, nel film Fuga da Alcatraz di Don
Siegel, dice laconico: “Breve”. Come brevi sono le vite
dei personaggi di Jim Thompson che a Hollywood
lavorò come soggettista e sceneggiatore dopo
un’esaltante esperienza con Kubrick (Rapina a mano
armata e Orizzonti di gloria). Nel romanzo giallo di
Thompson, Tornerò per farti fuori, il protagonista
Tommy Carter sentenzia: “Nel Paese dove si coltiva il
cotone si cresce presto o non si cresce affatto”. E Jean
Harlow era cresciuta in fretta, troppo in fretta: genitori
presto divisi, un patrigno interessato più a lei che alla
madre, un matrimonio bruciato a sedici anni e durato
un sospiro…
Sui mari della Cina di Tay Garnett, del 1935, è il
film che ricordo con maggiore precisione. Divertente e
avventuroso, si avvale di un cast di primo livello:
accanto a Jean Harlow e Clark Gable figurano Wallace
Beery, Rosalind Russel, Akim Tamiroff. In lei vedevo
71
una bella principessa di celluloide con occhi di gatto e
un fare innocente e comico che me la rendeva simpatica.
All’uscita dal cinema mio padre ci raccontò la storia di
questa diva sfortunata e della sua improvvisa morte
mentre stava girando Saratoga di Jack Conway. Fu
grazie a una controfigura che il film fu completato e
nessuno si accorse della manipolazione.
Morì nel ’37, lo stesso anno della scomparsa di
Angelo Musco che i catanesi adorano come un santo, e
santo non era davvero. Il grande attore comico si
trovava a Milano, in tournèe. Alla fine dello spettacolo
salì nella sua camera d’albergo assieme a una prostituta.
Più tardi il commissario di polizia interrogò la donnina
che rispose piangendo: “Era sopra di me, appassionato e
felice, e mi stava dicendo: Ora vengo, ora vengo… e se
n’è andato”. Anni dopo, Vitaliano Brancati ne avrebbe
utilizzato la vicenda per l’epilogo del suo Bell’Antonio:
il padre del protagonista, per difendere il buon nome
della famiglia, muore in un casino, proprio “sul
cavallo”. Analoga, ma più castigata morte, viene
immaginata da Don Ameche in Il Cielo può attendere di
cui dirò in un altro capitolo. L’attore, ormai vecchio ma
impenitente dongiovanni che mai s’arrende, sogna di
varcare l’eterno confine nel momento in cui una bella
infermiera gli mette il termometro in bocca.
Jean Harlow era rimasta scioccata dalla morte del
marito, il produttore Paul Bern, di ventidue anni più
grande. Appena due mesi dopo il loro matrimonio s’era
sparato un colpo alla testa dopo avere scritto un biglietto
di scuse alla giovane moglie. Dagospia sostiene che si
fosse suicidato per vergogna. La sera prima aveva
cercato di fare l’amore con la moglie usando un fallo di
gomma.
Verso la metà degli anni Trenta l’attrice attraversò
un altro periodo difficile: altri matrimoni falliti e la
cocente delusione di essere stata abbandonata da
William Powell che lei amava perdutamente. Strepitose
erano le sue battute, battute quasi muschiane, certo
meno raffinate di quelle della Dietrich ma che
72
suscitavano divertiti commenti.
Claudette Colbert s’impose con Accadde una notte,
capolavoro di Frank Capra, e il pubblico se ne innamorò
seduta stante. Il film lo vidi a scoppio ritardato, come
sempre, e con me buona parte della generazione
inespressa, definibile col “quasi”: quasi ribelle, quasi
edotta, quasi matura. Viso dolce, occhi profondi e
seducenti, corporatura minuta, gambe perfette, ricca e
capricciosa, Ellie Andrews (il personaggio interpretato
da Claudette) aveva tutto per piacere. Il film, premiato
con cinque Oscar, racconta la storia di una ragazza che
scappa di casa per protestare contro il padre che non
gradisce il suo fidanzamento con un cacciatore di dote.
Sull’autobus incontra l’uomo del destino, il giornalista
Peter Warne, un eccellente Clark Gable. L’uomo la
riconosce e tenta di sfruttarne la vicenda per una notizia
di prima pagina. Ma col passare dei giorni finisce con
l’innamorarsi della giovane Ellie e col rinunciare allo
scoop.
Amore casto, naturalmente, come voleva la morale
del tempo, la morale degli anni Trenta, quando il film
uscì la prima volta, e quella degli anni Cinquanta, a
guerra finita e a fascismo travolto. Gli aspiranti
fidanzati passano due notti insieme senza nemmeno
sfiorarsi, anzi, affidano la privacy a una coperta messa a
frammezzo tra i lettini… il cosiddetto “muro di Gerico”
che cadrà solo a matrimonio avvenuto. Prima di allora ci
saranno battibecchi, incerte tenerezze, finte liti.
L’ultima notte dei sospiri, lui le parla di un’isola felice e
lei lo ascolta rapita e sta per cedere al sentimento che
l’attanaglia ma lui ha già preso la strada del sonno.
Finale, ante litteram, come nel Laureato: lei davanti
all’altare lascia il fidanzato per correre tra le braccia di
Peter Warne. Ancora una volta l’eterna favola
dell’amore si consacra in un finale edificante,
prudentemente trasgressivo, ma materia formidabile per
la nostra personale e sconclusionata elaborazione
sentimentale, per il sognare a occhi aperti, sia al cinema
73
sia davanti alle pagine di un libro, sia che le fanciulle
avessero il sorriso di Claudette o quello immaginato di
Matilde de La Mole o della Sanseverina.
Nulla è superfluo in Accadde una notte: anche il più
piccolo avvenimento, ogni frase o gesto restano inseriti
perfettamente nel mosaico narrativo. Ma la scena che
caratterizza il film, e ne diventa quasi il simbolo, è
quella dell’autostop. Ellie e Peter sono all’asciutto, non
hanno soldi per mangiare, non hanno soldi per
viaggiare, niente di niente, tranne l’intraprendenza di
lui. Con la sua aria di spacca e lassa raggiunge il bordo
della strada, alza il pollice e dice alla ragazza che il
segreto sta tutto nel movimento del polso. Passa una
macchina, passano due macchine, passano tante
macchine. Nessuna si ferma. Scoraggiato, rinuncia.
Allora la timida Ellie chiede di prendere il suo posto. Si
mette in posizione, alza la gonna oltre il ginocchio,
distende la gamba e uno stridio di freni quasi immediato
fa capire quanto il “pelo di femmina” di martogliana
memoria non abbia mai avuto rivali.
L’autostop è nella storia dell’America, nei suoi
racconti e nei suoi film, ma è anche nella storia europea.
Fino agli anni Sessanta i giovani viaggiavano così, a
pollice alzato. Come ha scritto Andrea Rocco sul
Manifesto, l’autostop nasce come sottoprodotto della
motorizzazione di massa negli anni ’30 ed è stato per
un’intera generazione uno dei mezzi per conoscere il
mondo.
Una mattina d’estate, avevo 18 anni, io e un mio
amico, di quattro-cinque anni più grande, Lucio Zappoli
(suo padre aveva un laboratorio di marmi), ce ne
andammo all’avventura, a Taormina, con la sua
Seicento multipla, orribile antenata delle vetture
monovolume ma assai comoda per il petting. Anche se
l’hitch-hiking era praticato sulle nostre strade
soprattutto dai turisti stranieri, non incontrammo
nessuna albionica o teutonica bellezza. Tutti maschi. Ci
guardammo bene dal dargli un passaggio. L’unica
bandiera nostrana sventolò dalle parti di Giarre. Era uno
74
strano tipetto coi baffi che tentava inutilmente, a braccio
alzato, la faticosa risalita dello Stivale. Nessuna pietà.
Nemmeno per lui, nemmeno per la categoria degli
sfigati siciliani.
Accadde una notte influì anche sul costume
nazionale americano. Molti giovani, di fronte a Clark
Gable che si toglieva la camicia restando a torso nudo,
entrarono in crisi, abituati com’erano a indossare la
maglietta della salute, sia d’estate sia d’inverno.
Cominciarono a litigare con i genitori e a buscarsi
inevitabili raffreddori. In Italia andò peggio perché il
freddo non lo si combatteva con un’alimentazione
adeguata ma con pullover di lana a quattro capi e, di
notte, con montagne di coperte e cappotti. Ma furono in
molti, ragazzi di pomata e bellimbusti di periferia, a
gettare alle ortiche la canottiera, ritenuta ormai volgare,
e a indossare camicie attillate che mettevano in mostra i
muscoli. Come Clark Gable.
Tutto questo però arriverà col piccolo benessere
degli anni Cinquanta, con la Seicento, il Galletto, la
Lambretta, la mitica Vespa disegnata nel ’46
dall’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio e forse
ispirata a quello stranissimo scooter che si vede in una
rapida scena del film di Stevens, Un evaso ha bussato
alla mia porta, anno 1942, con Cary Grant, Jean Arthur
e Ronald Colman. La rivoluzione comincerà quando i
giovani indosseranno il trench di Humphrey Bogart e
masticheranno chewing-gum, quando sogneranno la
nuova frontiera dei cavalieri solitari e ne adotteranno gli
atteggiamenti e il linguaggio, quel linguaggio che
diventerà farfuglio “mericano” con Alberto Sordi.
Davvero indimenticabile la scena di Un giorno in
pretura quando il protagonista si lancia nel fiume per
uccidere un tronco d’albero, che funge da coccodrillo,
sotto gli occhi divertiti di un gruppo di ragazzini.
“Americà, facce Tarzan!” L’amore del personaggio
Nando Mericoni per gli Stati Uniti diventa idolatria in
Un americano a Roma: Sordi, jeans e maglietta bianca,
disdegna gli spaghetti per una più adeguata dieta alla
75
Kansas City, salvo poi pentirsene e abboffarsi del
volgare ma più soddisfacente cibo italico. “Maccarone,
m’hai provocato e io te distruggo, maccarone! Io me te
magno!”
C’è un motivo personale che mi rende caro quel film
come, del resto, molti film di Frank Capra. Estate 1977.
Il mio giornale mi manda a Bisacquino, un paesino
sperduto tra le montagne del Palermitano, per raccontare
i festeggiamenti a Frank Capra che tornava al paese
natale dopo 74 anni. Il regista della grande promessa, il
regista che veniva da una famiglia poverissima emigrata
per disperazione in California all’alba del secolo scorso,
il regista che non sapeva né leggere né scrivere e che
diventerà ingegnere chimico e poi uno dei più grandi
artisti del cinema mondiale, il regista che con i suoi film
ha combattuto la corruzione e l’affarismo politico ed
economico, lo raggiunsi mentre percorreva le stradine
del centro di Bisacquino cercando di ricostruire la
propria infanzia. Piccolo di statura, una grande testa,
occhi vivi e malinconici, guardava di qua e di là, stretto
nella morsa d’affetto dei suoi ex compaesani che gli
parlavano in dialetto, per marcare una comune
appartenenza, e lui non capiva e sorrideva.
Al termine della sua grande avventura umana e
cinematografica era tornato in Sicilia per “prendere una
bella boccata di coraggio contadino”. Poi l’hanno
condotto alla casa natale, rimasta miracolosamente
intatta nella sua mirabile povertà, non ancora fagocitata
dal calcestruzzo e dalle orrende strutture di alluminio
anodizzato. E qui ha mostrato di ricordare qualcosa,
soprattutto la chiesa, che sorge accanto, e i gradini dove
da piccolo si sedeva, così disse, sognando la vita
meravigliosa che forse l’attendeva di là dell’oceano,
sognando di disfarsi dell’unica proprietà che la famiglia
possedeva: i pidocchi. Ignazio Silone in Fontamara
racconta: “Allora il papa si sentì afflitto nel più
profondo del cuore, prese dalla bisaccia una nuvola di
pidocchi di una nuova specie e li lanciò sulle case dei
poveri dicendo: Prendete, o figli amatissimi, prendete e
76
grattatevi. Così nei momenti di ozio, qualche cosa vi
distrarrà dai pensieri del peccato”. Bisacquino come
Fontamara, o forse peggio. Paese di montagna l’uno,
paese di montagna l’altro. Cafoni senza scuola da una
parte, cafoni illetterati dall’altra. Tutti senza nemmeno
gli occhi per piangere, avviliti dalla miseria e asserviti
alla prepotenza dei ricchi. Luoghi dell’infanzia infelice.
Come quelli dell’Irlanda umida e povera descritti da
Frank McCourt in Le ceneri di Angela, sconvolgenti
non meno di Limerick dove il piccolo Frank, con la
faccia e i capelli di presbiteriano del Nord, racconta le
sue paure all’angelo del settimo scalino e prega perché
il padre, disoccupato incallito, non si beva il sussidio nei
pub della città.
In ogni film del maestro, in ogni fotogramma e
battuta c’è sempre un pezzo di quel grande piccolo
cuore che batteva su quei gradini di pietra levigati dalla
miseria e dal dolore, sferzati dal vento e dalla solitudine,
eppure saldi e immortali per avere cullato la speranza di
un ragazzino apparentemente senza speranza. E se ne
sarebbe ricordato, il vecchio Frank, di quell’angolo
siciliano di preghiera e di umiltà, e lo avrebbe messo a
sigillo della sua opera. Molti personaggi dei suoi film
nei momenti di difficoltà volgono lo sguardo al cielo per
trovare la forza di continuare a lottare. Lo fa James
Stewart in La vita è meravigliosa, lo fa Gary Cooper in
È arrivata la felicità, lo fa May Robson in Signora per
un giorno, lo fa Ronald Colman in Orizzonte perduto.
Dopo la fede la grande risorsa è il Popolo che il regista
guarda con simpatia e rispetto e lo descrive sempre
vittorioso sui politici corrotti. In I Dominatori della
Metropoli indimenticabile è la battuta finale di James
Gleason, nei panni di un direttore di giornale, rivolta a
Edward Arnold, che interpreta il politicante Norton: “Lo
vede, Norton, il popolo? Non lo sconfiggerà mai!” E
sembrava uno di quegli onesti agitatori politici adusi a
salire sulle soap-box e arringare la folla.
Come mio padre, stranamente, ma forse non tanto,
Frank Capra era solito dire che “nessun uomo è un
77
fallito se ha amici, e se ne ha tanti è un uomo ricco”. Ma
la molla del grande ottimismo di Frank Capra sta in
un’altra memorabile frase: “Amico, tu sei un impasto
divino di fango e polvere di stelle. Allora datti da fare:
se le porte si sono aperte per me, si possono aprire
anche per te”. Che poi è la grande lezione americana, il
mito della nuova frontiera senza il quale non sarebbe
esistito il cinema western e contro il quale è andata a
sbattere purtroppo l’illusione dei tantissimi emigranti a
sud del Rio Bravo spazzati via dalla Border Patrol a
colpi di proiettili di gomma irritanti.
78
TRE
Vivien Leigh, Hedy Lamarr, Ingrid Bergman
I cimiteri sono luoghi che mettono paura ai ragazzi.
Entrai in quello di Catania, i “Tre cancelli”, molti anni
dopo la morte di mio nonno materno, l’unico dei nonni
che ho conosciuto. Si chiamava Carmelo.Piccolo di
statura, assomigliava, per come lo ricordo io, a James
Cagney in Ragtime. Poco prima di morire mi regalò
un’Aurora 88 col pennino e il cappuccio dorati.
Augurio, forse, d’una carriera di lettere. Analogo regalo
avrebbe fatto il libraio Sempere, in L’ombra del vento di
Zafón, al figlio Daniel: una Montblanc Meinsterstück
che il venditore diceva fosse appartenuta a Victor Hugo.
La tenni tra le cose più care, come una reliquia, poi, non
ricordo come, la persi. Di recente, ne ho acquistata una,
uguale, all’asta eBay, e il passato è tornato forte e
splendente. La stessa emozione ho provato con l’album
delle figurine degli animali. Anche questo prezioso
cimelio della mia fanciullezza era andato smarrito. Ne
ho miracolosamente ripescati due uguali, sempre
attraverso il grande mercato online. Uno era incompleto,
ma in discrete condizioni. Stava tra le vecchie cose di
un signore di Sesto San Giovanni. L’altro aveva tutte e
600 le figurine ma alcune pagine erano rovinate.
Proveniva da Arpaia, un piccolo centro vicino a
Benevento. Li ho portati dal mio legatore di fiducia,
Rosario Napoli, e gli ho detto di fare una paziente
operazione di rimescolamento e ricucitura. Li ho presi
tutti e due per meno di 50 euro. Ma li avrei pagati molto
di più.
La prima edizione di questo mitico album, sulla cui
copertina sono disegnati due koala, madre e figlio, uscì
nel 1950 per conto della casa editrice milanese Astra,
diventata poi Lampo. Le seicento figurine che
compongono la raccolta sono grandi come francobolli
(tre centimetri e mezzo per lato) e dei francobolli hanno
79
le dentature, ma così nitide e colorate da affascinare e
immettere in un mondo misterioso e magico un
ragazzino di quel tempo lontano, di un tempo acerbo,
legato alla retorica dell’anteguerra, al libro Cuore e ai
suoi racconti eroici e improbabili. Come quello della
piccola vedetta lombarda che muore per un dovere che
spetta ai grandi, ai soldati. Sono loro, anzi, a spedirlo in
cima a un “frassino altissimo e sottile” (astuzia becera
di Edmondo De Amicis) da dove il ragazzo cadrà
colpito da una pallottola austriaca. Per completare
l’album mi ci volle un anno. Ricordo l’ultima figurina
mancante, la numero 382, che raffigurava l’eloderma,
un rettile velenoso che vive nell’Arizona e nel Messico.
La mia passione, ancora tenace, per il mondo degli
animali nacque da lì, da quelle figurine che erano un po’
come fotogrammi di un film. Sfogliando l’album, dopo
oltre mezzo secolo, ho ripescato lo stesso stupore e
incanto di allora ma anche le stesse perplessità per
alcune figurine che mi parevano, e mi paiono,
disomogenee rispetto alle altre. Strano davvero come
certi giudizi si mantengano vivi dopo decenni di letture,
esperienze, maturazioni, confronti, educazione del
gusto.
La figuromania era esplosa sotto il regime fascista ed
ebbe grande fortuna anche nel dopoguerra perché le
figurine costituivano il film privato dei ragazzi d’allora,
il loro rifugio fantastico, l’unico svago accessibile nella
graduatoria dei bisogni d’una famiglia in cui il gioco
occupava l’ultimo rigo nel quaderno delle spese. La
fortuna cessò con l’introduzione del superfluo, della
televisione di massa, dei videogames e dei giochi di
plastica che i bambini scartano con curiosità e subito
abbandonano senza neppure tentarne una timida
animazione. Di recente, uno studioso americano,
Richard Louv, ha definito questo comportamento
“disturbo da deficit di natura”. I ragazzi, cioè, stanno
troppe ore incollati alla Tv, si ubriacano di pc e
playstation, si nevrotizzano con giochi elettronici che
insegnano loro competizione e violenza quando invece
80
dovrebbero dedicare più tempo alla scoperta della
natura. Anzi, prima dei 12 anni dovrebbero imparare,
per esempio, ad arrampicarsi sugli alberi, a camminare
in equilibrio su un tronco caduto, a mangiare una mela
appena colta, a fare volare un aquilone, a rotolarsi
sull’erba, insomma a fare tutte quelle cose “pazze” che
si facevano una volta all’aria aperta.
Il termine “figuromania” è di Enrico Morbelli, che
ho perduto di vista dopo avere fatto con lui all’inizio
degli anni Settanta, assieme a altri colleghi, un viaggio
in macchina da Roma a Sanremo, per il festival della
canzone. Enrico è figlio di Riccardo Morbelli,
giornalista, scrittore radiofonico e televisivo nonché
autore di popolari motivi come Ba’ ba’ baciami piccina,
Sulla carrozzella, La canzone del boscaiolo. Enrico lo
citava per nome e cognome, come fanno i figli coi
genitori che hanno guadagnato tanto successo da
trascendere la parentela. Ne era orgoglioso ma con
misura e ironia. “La Liebig”, secondo il suo spiritoso
giudizio “era più famosa per i suoi artistici cartoncini
che per i dadi da cucina”. Personalmente ne ricordo di
bellissimi, nel dopoguerra, a tema etnico, storico,
religioso, sui quali imbastivo mirabolanti sogni di
cartone. Nel 1932 anche la Perugina si lanciò a testa
bassa nel promettente mercato cominciando ad abbinare
ai prodotti le figurine di Italo Balbo per la “crociera del
decennale”. Poi, sull’innocua mania, come ricorda
ancora Morbelli, “s’innestò la speculazione e qualcuno
fece anche i quattrini”.
All’uscita di scuola i giovani balilla davano vita a un
commercio inesausto. Si dannavano l’anima per
l’introvabile Feroce Saladino (che in Sardegna, a quanto
padre, era trovabilissimo), che segnò un’epoca al punto
da renderla riconoscibile attraverso la sua immagine
fantasticamente feroce e che ancora oggi si trascina nei
modi di dire e nelle ironiche storpiature: il “Feroce
Salatino” è quello che stava per strozzare il presidente
George W. Bush mentre guardava la televisione
mangiando junk food. C’erano poi gli accaparratori che
81
cercavano di farsi la Topolino attraverso il
completamento di 250 album. Il fotografo Gastone
Bosio ne completò 750, una follia, ma alla fine ci
guadagnò l’automobile e mille lire. Le mille lire della
canzone cantata nel ’39 da Gilberto Mazzi con
l’orchestra di Pippo Barzizza. Una cifra per quel tempo:
chi guadagnava tremila lire l’anno era considerato un
buon partito. “Se potessi avere mille lire al mese, senza
esagerare sarei certo di trovar tutta la felicità”. Fu
talmente popolare che il regista Max Neufeld ne trasse
un musicarello con Alida Valli, Osvaldo Valenti e
Umberto Melnati. La figuromania scatenò una corsa al
collezionismo più sfrenato al punto che il governo fu
costretto a vietarlo e a nulla valsero le proteste di
Giovanni Buitoni, responsabile della campagna
pubblicitaria e magna pars della Perugina.
Poco fa ho ricordato il cimitero. L’ho fatto perché
parlando di principesse di celluloide mi sono ricordato
d’una ideale epigrafe dedicata a Vivian Mary Hartley:
“1913-1967. Impossibilmente bella e superbamente
seducente, fu Rossella in Via col vento e la moglie di
Laurence Olivier nella vita. Finché la follia e la
depressione non la rapirono al mondo dei vivi”. Vivien
Leigh era così bella e misteriosa, ovale delicato, occhi
verdi, sorriso disarmante, che nel 1938 il regista
Alexander Korda fece una follia firmandole un contratto
di 50mila sterline. L’anno successivo ottenne la parte di
Rossella O’Hara, l’eroina del romanzo di Margaret
Mitchell, Via col vento, più letto, a quanto si disse, della
Bibbia. E il film sarebbe stato il più visto e fortunato
nella storia del cinema.
Verso la fine degli anni Cinquanta alla Plaia, forse al
lido dei ferrovieri o al lido Trinacria, non ricordo bene,
venne come ospite d’onore Mike Bongiorno, reduce dai
successi di Lascia o raddoppia? e autentica star
nazionale. Poiché era un presentatore di quiz, e solo
questo sapeva fare, organizzò su due piedi un gioco di
domande e risposte. Roba da asilo infantile. Poi
82
s’inerpicò in una domanda più difficile: “Chi scrisse il
romanzo che ispirò il film Via col vento?” Mio padre
sapeva la risposta ma non voleva esibirsi in quello
stupido gioco. Lo mettemmo in croce finché fu costretto
ad alzarsi e a dire: “Margaret Mitchell!” Gli regalarono
una spilla, che mia madre conservò gelosamente.
Mike era un mito. Viaggiava come un missile nel
gradimento del pubblico e vi viaggiava grazie alla sua
mediocrità. Luciano Bianciardi scrisse una volta: “I
nostri presentatori della televisione avevano successo, e
lo hanno, in quanto riassumono ed esprimono certi
difetti, certe tare nazionali. Mike Bongiorno ne
riassumeva più di tutti, ed ecco perché lo possiamo
stimare il più mediocre, quindi il più bravo”. Lo stesso
concetto, qualche anno dopo, avrebbe espresso Umberto
Eco: “Idolatrato da milioni di persone, quest’uomo deve
il suo successo al fatto che in ogni atto e in ogni parola
del personaggio cui dà vita davanti alle telecamere,
traspare una mediocrità assoluta”.
Il film lo vidi con la mia famiglia al cinema Lo Po,
in via Etnea, che sorge quasi di fronte alla Rinascente,
dove una volta c’era il cinema Sala Roma. Altri locali
sarebbero stati chiusi col tempo, come il Diana, in via
Umberto, che ospitava anche spettacoli di varietà, o il
Reale, in via Francesco Crispi. Al loro posto ci sono
negozi di abbigliamento (uno dei pochi veri affari della
città, spesso luoghi di copertura della mafia assieme a
caffè e rosticcerie), rutilanti botteghe nelle quali gli
abiti, spacciati per alta sartoria, vengono acquistati
all’ingrosso a Misterbianco, rilanciati sul mercato vip a
prezzi triplicati e con le etichette cambiate; cose così,
cose volte a gabbare i borghesi arricchiti (gli
arripudduti) che bevono dalle tazzine col mignolo alzato
e magari credono che il Darfur sia una marca di
caramelle o un sistema di mangiare veloce, che Caino
sia il figlio di Isacco, che parlano di cose che non sanno,
come molti parlamentari d’oggi, che sconoscono le
concordanze e credono che il vocabolario italiano
registri parole come scatolo e unghio. Non si sa come
83
difendersi da questi esseri bizzarri di marca kitsch che
parlano come le massaie di via Gambino e dicono, senza
tema di essere arrestati, cotone idrofobo e lupare a mare,
e credono altresì che il congiuntivo sia una malattia
degli occhi. Non si comportavano diversamente molti
celebri produttori di Hollywood che dicevano
ginecologico invece di genealogico e aromatico invece
di reumatico.
Via col vento era suddiviso in quattro tempi, ma
avrei voluto rivederlo ancora una volta, stare lì fino a
notte fonda. La strada del ritorno fu un ciarlare
ossessivo di questo e di quel personaggio. Innanzitutto
Vivien Leigh, premiata con l’Oscar, e Clark Gable, ma
anche Olivia de Havilland e la “saponetta” Leslie
Howard, Thomas Mitchell e la bravissima Attie
McDaniel, che è la brontolona balia Mamy e che per
quella parte si meritò l’Oscar come migliore attrice non
protagonista, il primo assegnato a una persona di colore.
E fu un atto coraggioso quello dal momento che i negri,
come racconta Sinclair Lewis in Sangue reale, venivano
con disprezzo definiti darkies, boogies, dinges, smokes,
zigs.
Tutti scomparsi i protagonisti, grandi e piccoli. A
lasciare per ultima il grande sogno è stata Evelyn Keyes
che nel film è la sorella minore di Rossella O’Hara,
Suellen. È morta, a novantun anni, nel luglio del 2008.
Nella sua carriera non si ricordano interpretazioni
memorabili, nella sua vita si ricordano i matrimoni con
John Huston e Artie Shaw. Ritirandosi dalle scene diede
alle stampe la propria autobiografia dal titolo
(immancabile) La Sorella Minore di Rossella O’Hara.
Il finale del film è una scudisciata. Rossella, che solo
alla fine capisce di amare Rhett, dopo averlo mortificato
e ingelosito per tutta la durata del film, cerca di
fermarlo: “So solo che ti amo”. E lui, implacabile:
“Questa è la tua disgrazia”. Rossella lo incalza:
“Aspetta… Rhett. Rhett, se te ne vai che ne sarà di me,
che farò?” “Francamente, me ne infischio”. La folla
resta muta, sconvolta… La notte mi ripassai il volto e la
84
figura di Vivien che misi subito in testa alla classifica
delle mie “fidanzate”. E in quel posto ci rimase a lungo,
prima di essere scalzata da altre dive che dirò dopo.
Il matrimonio con Sir Laurence durò vent’anni, ma
non conobbe la passione che c’era stata nei quattro anni
precedenti quando lei era sposata con Leigh Holman e
lui con Jill Esmond, “timidamente lesbica” come si
disse. L’attrice, affetta da sindrome maniaco-depressiva,
avrebbe distrutto lentamente il rapporto col marito e
avrebbe distrutto anche se stessa. All’epoca dei suoi
impegni teatrali londinesi, famosi erano i vagabondaggi
notturni per i boschi, anche con la pioggia, finché se ne
tornava a casa, sporca e irriconoscibile, dopo avere
avuto rapporti sessuali con sconosciuti.
Che cos’era quel bisogno di sesso degradato?
Solitudine, disperazione, follia? Verso la fine degli anni
Cinquanta, durante una cena a Notley Abbey, alla quale
partecipavano Burt Lancaster, Kirk Douglas e George
Sanders, a un tratto disse al marito: “Larry, perché non
mi scopi più?” L’imbarazzo di tutti fu alleggerito dalla
pronta battuta di Sanders: “Oh, Vivien, basta! Fra un
attimo anche mia moglie comincerà a farmi la stessa
domanda”. Dopo il divorzio da sua maestà Laurence,
Vivien si legò “per comparsa” all’attore John Merivale
ma continuò ad amare, “follemente”, il marito e non lo
dimenticò fino alla morte, scivolando sempre più
nell’alcol e nella depressione. Quattro anni prima di
morire ricevette nella sua casa del Sussex una visita
puramente amichevole di Laurence che forse non aveva
del tutto superato il rimorso di averla abbandonata. Il
giorno dopo confessò a John Gielgud: “Forse non ci
crederai, ma sono ancora disperatamente innamorata di
lui”.
Il ponte di Waterloo, girato nel 1940 da Mervyn
LeRoy, avrebbero dovuto chiamarlo “Il ponte sul fiume
delle lacrime”. Impossibile vederlo a ciglio asciutto. Per
tre quarti di film Vivien Leigh piange e si dispera e con
lei piange e si dispera il pubblico. All’uscita dal
dopolavoro ferroviario di via Luigi Capuana non
85
avevamo fazzoletti asciutti, tranne mio fratello, il più
piccolo e scapestrato del gruppo. Restai depresso per
l’intera serata, fino a che mia madre venne nella mia
stanza, mi rimboccò le coperte e mi disse: “Non fare il
bambino”. Ma io ero un bambino!... più o meno.
Avendolo visto negli anni Cinquanta, conoscevo a
memoria le parole del Valzer delle candele, la
bellissima melodia d’origine scozzese Auld lang syne, Il
(bel) tempo passato, scritta da Robert Burns, che fa da
colonna sonora al film e che in Italia fu lanciata da
Carla Dupont. Non sapevo allora che portasse sfortuna.
La mente mi si aprì alla “scuola” del giornale La
Sicilia, dove imparai a dire qualche timida malaparola.
Bastava che si accennasse al titolo perché Livio
Messina, un collega anziano molto bravo e lavoratore
instancabile, prendesse le contromisure scaminando
nella tasca dei pantaloni. La leggenda vuole che fosse il
valzer che l’orchestrina suonava sul ponte del Titanic,
anche se alcuni superstiti del disastro raccontarono che
il motivo eseguito dagli orchestrali, mentre
l’inaffondabile transatlantico affondava nell’Oceano
Atlantico, era lo struggente Nearer, my God, to thee,
Vicino a te, mio Dio. Per fortuna, la struggente melodia
ha resistito alla superstizione. Da tempo viene eseguita
nelle feste di fine anno, non appena scatta la mezzanotte
e tutti brindano e si abbracciano commossi. Molti non
conoscono le parole, ma in questo caso è la musica a
guidarli nel sentimento che li agita, a metà tra il
rimpianto del passato e la promessa del futuro. “Domani
tu mi lascerai/ e più non tornerai/ domani tutti i sogni
miei/ li porterai con te./ La fiamma dell’amor/ che un dì
provai/ invan per te/ è un lume di candela che/ già si
spegne piano pian”.
Alla boa del millennio ero a Londra con mio fratello
e le rispettive mogli. Confesso che mi sono venute le
lacrime… anche pensando, per una strana ma forse non
tanto strana associazione di idee, alla tragica vicenda
della ballerina Myra che s’innamora del tenente Roy e si
uccide sul ponte di Waterloo per vergogna. “Should
86
auld acquaintance be forgot/ and never brought to
mind?… / And days of auld lang syne , my dear/ And
days of auld lang syne…” Robert Taylor e Vivien Leigh
ballano il valzer triste e a ogni giro di danza uno degli
orchestrali spegne la candela che illumina il suo
spartito, fino alla fine della partitura, fino a che tutti i
ballerini restano in penombra, nell’angoscia della guerra
che incombe.
Nel cinema ci sono voluti cinquant’anni perché in
Harry ti presento Sally, il magnifico film di Rob Reiner,
quel valzer suffragasse un amore finalmente felice:
quello tra Meg Ryan e Billy Crystal. Nella mia vita c’è
voluto un tempo uguale per passare dalla tetra
malinconia di ragazzo a quella serena e distaccata di
uomo maturo. Sull’Auld lang syne misuravo, nella
forzata allegria dei Capodanni, una speranza tenace di
superiori traguardi e un’uguale frustrazione dovuta al
mio intramontabile pessimismo.
Non ricordo, nella giovinezza ma anche oltre, un
Capodanno senza malinconia, quello stato d’animo
particolare al confine tra la felicità e il dolore, “una vaga
tristezza”, come ha scritto Daniela D’Angelo nella
rivista Silmarillon, “da cui non si guarisce, da cui a
volte non si tenta nemmeno di guarire per via di un
dolce compiacimento che l’accompagna”. Precipitare in
uno stato malinconico significa perdersi senza però
affondare nella disperazione, insomma un lutto senza la
morte. Come vedere un film romantico, in definitiva,
come farsi cullare dal suo sogno sapendo di non poterlo
rivivere sull’oggi ma illudendosi di afferrarlo in un
domani migliore, sempre possibile. Oppure cadenzare la
dolce morte sulle note del Secondo valzer di Dmitri
Shostakovich o del Danubio blu di Johann Strauss e
immaginare la principessa Sissi, col volto di Romy
Schneider, ballare col suo Franz nel salone sfavillante di
luci del castello di Schönbrunn.
In realtà, noi della generazione postbellica la
principessa delle favole l’abbiamo coltivata con
l’inganno del cuore più che con la saggezza della mente.
87
In lei abbiamo visto un’icona non una persona, una
bellezza convenzionale, una di quelle visioni splendenti
e verginali, come scrive Michael Cunningham, che
attraversano in lungo e in largo la giovinezza dei timidi,
delle persone un passo indietro. Viso d’angelo, occhi
azzuri, capelli biondi e lucenti: era questo il nostro
ideale, il mito da conservare nella tempesta della vita,
un rifugio, una piccola chiesa in cui pregare e
addormentarsi. Le bellezze fiere e spavalde, dal naso
aquilino e dagli occhi selvaggi e penetranti, ci
intimorivano, non erano per noi perché non avevamo la
maturità necessaria per capirle e affrontarle.
Per i malinconici di quel tempo acerbo le feste di
fine anno non si collocavano nel presente, oscillavano
tra il passato e il futuro, tra quanto s’era fatto e quanto
s’intendeva fare. Il presente era un noioso rumore di
risate in cui tutto era ravissant, fantastico, meraviglioso,
un esplodere di tappi di spumante, uno stridore di
trombette che s’allungavano come nasi-pinocchio, un
circuito di musica frastornante, di amanti del ballo a
ogni costo che s’intruppano in trenini ridicoli
coinvolgendo anche chi vorrebbe starsene per i fatti suoi
a farsi cullare da un pensiero d’oasi, un pensiero
cinematografico di sorrisi timidi alla Claudette Colbert
o sfrontati alla Vivien Leigh, un pensiero di ragazze
azzurre che corrono incontro al loro magnifico destino
su litorali di sabbia dorata sempre situati dalla parte
opposta alla nostra.
Come la brigata di ragazze belle e sfrontate che
Marcel incontrò un giorno d’estate sul litorale di
Balbec. Procedevano come “luminosa cometa”
costringendo le persone a scostarsi per non farsi
investire e si guardavano ridendo “se qualche vecchio
signore, di cui esse non ammettevano l’esistenza e di cui
respingevano il contatto, era fuggito con moti timorosi o
furenti, ma precipitosi e ridicoli”.
Nella piccola sala del dopolavoro ferroviario
eravamo tutti rigorosamente maschi. Anche se i grandi
88
mi consideravano, giustamente, “mucco”, neonato,
avannotto, che deve ancora crescere insomma. Le donne
erano rimaste a casa. Troppo scandaloso il film. Alla
scena culminante, quella che vede Hedy Lamarr
aggirarsi nuda nel bosco, volavano battaglioni di
mosche maleducate. Una sequenza breve, in verità,
sicuramente tagliata dall’esercente per non incorrere
nella censura, a quel tempo ancora severa. Ma tanto
bastò a mettere il pepe in testa a quel pubblico inibito e
provinciale. Tanto bastò a frastornarmi e a farmi
desiderare per sempre quella bellissima dea. Se fossi
stato un calzino mi sarei trovato con le cuciture a
rovescio, istupidito dalla forza del peccato che quel
corpo riassumeva. Forse i piaceri solitari cominciarono
quel giorno, forse quello fu il momento del passaggio
dall’aspirazione al rimorso, che noi ragazzi tacitavamo
andando dal confessore più vecchio e sordo del collegio.
E ancora non sapevamo che la masturbazione, secondo
l’idea del regista Paolo Franchi, fosse un “gesto
anarchico”. A noi pareva un ripiego necessario per
mancanza di materia prima. L’idea comunque ha il suo
fascino perché è la rivincita degli ultimi sui primi, degli
sfigati sui fortunati, dei visionari che si portano a letto
una come Jessica Biel mentre i terra-terra, adoratori del
Reale, prosaicamente ma utilmente si spupazzano le più
belle e conturbanti tra le indigene che non mangiano
chiacchiere se uno si presenta con un romantico
mazzolino di fiori ma senza macchina e biglietti da
mille al seguito. Anni dopo Woody Allen ci avrebbe
ampiamente riscattati. Nel film Anything else dice di
appartenere alla categoria dei visionari, degli incalliti
masturbatori: “Ieri sera mi sono messo su una cosetta a
tre: io, Marilyn Monroe e Sophia Loren. Credo, tra
l’altro, che fosse la prima volta che le due grandi attrici
apparivano insieme”.
Hedy Lamarr, nata a Vienna nel 1916, aveva gli
occhi verdi di Vivien Leigh, lo stesso ovale e gli stessi
capelli. Come la diva inglese era bellissima, sensuale
ma con uno sguardo stupito e venato di malinconia.
89
L’esordio cinematografico avvenne con Estasi, girato
nel 1933 sotto la direzione di Gustav Macathy. A quel
tempo si chiamava Hedwig Eva Maria Kiesler. Il film le
diede grande notorietà ma anche grande amarezza,
essendo stato proibito in molti Paesi, tra cui
naturalmente l’Italia fascista, e mutilato delle scene osé
in altri. Il suo primo marito, il miliardario Fritz Mandl,
fabbricante d’armi e amico dei nazisti, cercò invano di
acquistarne le copie per toglierle dalla circolazione.
Presentato alla mostra di Venezia, nel 1934, che
inutilmente lo premiò, il film si attirò i fulmini della
Chiesa e la curiosità di Mussolini, che se lo fece
proiettare in privato. Il duce si disse estasiato ma anche
deluso del piccolo seno dell’attrice. A lui piacevano le
donne magre con le tette grosse, come quelle di Claretta
Petacci. La scena del nudo, Hedy Lamarr la girò sotto
ricatto. “Se non fai questa scena”, la minacciò Gustav
Machaty “il film sarà rovinato e noi ci rifaremo delle
perdite su di te”. La girò con una certa riluttanza,
soprattutto la sequenza della fellatio che il regista rese
maggiormente espressiva pungendo con uno spillo le
natiche dell’attrice. Esagerarono, perché il produttore fu
costretto a tagliare 76mila metri di pellicola, destinando
al rogo le scene d’amore più realistiche. Un vero delitto.
Lo scandalo spinse l’attrice ad abbandonare il
cinema e l’Europa, ma sulla nave che la portava in
America, incontrò Louis B. Mayer che le fece un
contratto di sette anni senza chiederle la misura del
reggipetto. Le cambiò anche il nome in omaggio al sexsymbol del cinema muto Barbara La Marr definita
“troppo bella per rimanere sola in una grande città”. La
giovane Hedy si gettò a capofitto nel lavoro
interpretando con successo personaggi di donne
sentimentali, e a volte un po’ perverse, accanto ai grandi
divi dell’epoca: Robert Taylor, Clark Gable, Spencer
Tracy, Walter Pidgeon. Ma il film che le portò maggiore
fortuna fu il kolossal Sansone e Dalila di Cecil De
Mille, girato nel 1949 accanto al muscoloso e ormai
bollito Victor Mature, l’immortale Doc Holliday di
90
Sfida infernale di John Ford. Il grande Groucho Marx si
rifiutò di assistere alla proiezione perché “non sarebbe
mai andato a vedere un film in cui il petto del
protagonista risultava più grande di quello della
protagonista”. La celebre battuta condì per anni le
minestre riscaldate di molti critici americani ed europei
al punto che il povero Victor prese a scivolare verso
l’indifferenza del pubblico, lui e i suoi imbarazzanti
pettorali. Il film vinse due Oscar minori: il colore e i
costumi, davvero magnifici. Ma non poteva avere altre
chances, se non quelle che gli assicuravano i ragazzi
come me, avidi di avventure e di coraggio ma anche
vibranti di confuse pulsioni erotiche. Quell’anno, il
1950, erano in lizza giganti come Eva contro Eva, Viale
del tramonto, Nata ieri, Le miniere di re Salomone.
“Non è difficile diventare una grande diva”, era
solita dire, “basta restare immobile e recitare la parte
dell’oca.” Ma se sullo schermo, a volte, giocava il ruolo
della sprovveduta, nella vita era molto intelligente, tanto
intelligente da inventare nel 1942, assieme al
compositore George Antheil, un sistema di
comunicazione in codice basato sui nastri perforati della
pianola. L’idea l’era venuta ascoltando in patria le
conversazioni del marito Fritz coi generali tedeschi sul
controllo delle armi a distanza. L’esercito americano le
rispose che sarebbe stata più utile a Hollywood.
Sebbene delusa, provò ugualmente a dare una mano alla
patria offrendo un bacio a chi avesse sottoscritto almeno
25 mila dollari di obbligazioni per la lotta al nazismo.
Le cronache mondane dell’epoca scrissero che la
conturbante Hedy riuscì a raccogliere in una sola serata
sette milioni di dollari. Vent’anni dopo il Pentagono
dovette scusarsi perché il brevetto della diva più bella
del mondo trovò applicazione sulle navi impegnate nel
blocco di Cuba. E finalmente, nel 1997, tre anni prima
di morire, Hedy Lamarr, l’attrice sposata sei volte, e
quasi sempre con miliardari, e che qualche anno prima
la polizia aveva pizzicato per un furto in un grande
magazzino di Los Angeles, La Electronic Frontier
91
Foundation le attribuì il prestigioso premio Pioneer. Il
brevetto non le fruttò nemmeno un dollaro.
Era un’invenzione sorprendente per una diva che
spesso recitava la parte della stupida, sorprendente
soprattutto per noi ragazzi di provincia meridionali
educati a coniugare l’intelligenza femminile soltanto
con gambe a piede di tavolino e seni a fico secco. Come
ci saremmo sentiti, noi maschietti di antica formazione
musulmana, se una “femmina” si fosse rivelata più
arguta? Meglio, dunque, nascondersi dietro quel
comodo pregiudizio.
In quarto ginnasio, durante l’ora di geografia, tenuta
da un professore fessacchiotto e senza polso, facevamo
girare sottobanco cartoline di donnine nude risalenti
all’inizio del secolo e che circolavano nei club privati e
nei bordelli di lusso. La più ammirata, e consumata, era
la foto di una ragazza sdraiata a pancia in giù con le
tette“a coppa di champagne” e un sedere a mandolino
riflesso per meglio ammirarlo su una serie di specchi ad
angolature diverse. Se l’euforia superava la barriera del
suono della cattedra il professore domandava allarmato:
“Che c’è?” Risate soffocate. “Allora?” Allora niente.
Succedeva che l’indiziato speciale Pippo Ciavola, che
sapeva suonare il pianoforte e che adesso fa l’avvocato
a Torino, autore di straordinari concerti ottenuti
infilzando pezzi di lametta nel banco e pizzicandoli in
sequenze armoniche, veniva sistematicamente invitato a
lasciare la classe. Alcune volte lo seguiva Marcello
Zammataro, ex primario di medicina interna
all’ospedale Garibaldi. Aveva un’abilità straordinaria
nel fare la caricatura di questo insegnante che aveva la
faccia lunga e spigolosa, come Totò, e che da giovane
aveva fatto il marinaio in un sommergibile. Fu la sua
disgrazia perché prendemmo a sfotterlo senza pietà.
Marcello lo ritraeva spesso in divisa di marinaretto
mentre scrutava al periscopio la classe. Straordinario
davvero. I foglietti giravano e nella foga qualcuno finiva
nelle mani del sempre più frastornato docente. Un
92
giorno, esasperato, lasciò la cattedra e corse a protestare
dal direttore, Orazio Testa, che diceva sempre,
all’indirizzo degli alunni indisciplinati: “Scusi, ma lei
paga le tasse per essere scemo?” Veniva una volta al
mese a leggere le pagelle. Si piazzava al centro della
classe, dava un colpo secco con le mani, invitandoci a
lasciare i banchi e a metterci su due file, e liberava il
suo sadismo e la nostra apprensione. Arrivato a
Giuseppe Maiorana, della stirpe culturalmente nobile
dei Maiorana, faceva sempre lo stesso commento: “Il
ceppo si va tarlando!” Anni dopo ripescai dalla spirale
di nebbia di Prisco lo stesso concetto riformulato in
interrogativo: “È sempre l’ultimo della classe?”. Nonno
Sangermano, il Maiorana del racconto letterario, non
sapeva darsi pace che il nipote Fabrizio restasse ai
margini della famiglia che era ricca, potente, rispettata.
Alla battuta del direttore Testa, che era piccolo e
rotondo ma che allora ci pareva immenso, Nuccio
Sorbello, futuro procuratore della Repubblica ad Asti,
scoppiava in una incontenibile risata. “Sorbello, si
accomodi fuori, per favore”. Le risate continuavano nel
corridoio. Nuccio, che per molti anni ha ostentato una
bella barba bionda alla Abramo Lincoln, quand’era
giudice istruttore a Torino provocò notti insonni al PCI
e alla Fiat per un presunto affare di appalti e tangenti. In
altre parole, dichiarò guerra, senza battere ciglio, al più
grande partito comunista d’Occidente e alla più grande
fabbrica automobilistica del Paese. Non poteva
assolutamente vincere.
Tornando a Marcello Zammataro tanta sapienza e
abilità di caricaturista, unita a una passione direi
fanciullesca per la cucina, non potevano non approdare
alla scrittura, a un libro inusuale, ricco e sapiente, un
libro meticcio nel quale confluiscono tante cose: dai
ricordi dell’infanzia, alle amicizie, ai cibi, alle
riflessioni sull’esistenza. Un libro che è un percorso
“nel sapore della Sicilia”, un libro di pensieri
gastronomici direi, ma anche un viaggio nel tempo,
nella storia e nei suoi personaggi, fino alle rovine della
93
città perduta di Casmene, la colonia greca che sorgeva
nelle campagne di Buscemi. Perché non potendo
immaginare il futuro ogni cosa torna al passato, al mito,
alla madre Terra che diventa Cibele, Demetra, ma anche
la Madonna e persino Sant’Agata grande ispiratrice di
devozione e di dolci.
Forse non a caso l’abitazione di Marcello, situata nel
magnifico centro storico cittadino, riflette la personalità
dell’autore e in qualche modo di questo libro. Una casa
antica e moderna, una casa di oggetti e di memorie, di
scale e incastri, di finestre e terrazzini affacciati sui tetti
e sulle cupole d’una città quasi perduta e di cui puoi
immaginarne la bellezza solamente da lontano. E poiché
libri, racconti, e immagini finiscono sempre nella gloria
d’una tavola imbandita ecco che la dimora di Marcello,
in bilico tra la potenza e l’atto, si apre come le pagine di
questo bel volume edito da Bonanno. Formaggi e miele,
lardo di Colonnata, salame di Brolo, olive conzate, pasta
con le sarde, falsomagro (come lo preparava mia
madre), insalate, vini bianchi e rossi. Insomma, una
pagina del “Ritorno a Casmene” illustrata ai
commensali.
L’amaro del Capo o la grappa prime uve puoi
gustarli tornando a ammirare la casa, i quadri, gli
scaffali, la libreria. Ed è qui che accade un miracolo di
suggestione. Ecco che la libreria si trasforma in quella
dei golosi di Grimond de la Reynière: accanto ai libri
trovi prosciutti, liquori, formaggi, frutta sotto spirito,
salumi, paté. E se per sbaglio afferri un libro di filosofia
non trovi più il mito della caverna ma il mito di un
Platone ghiotto di fichi secchi e olive, di un Aristotele
feticista di pentole e di un Pitagora rigorosamente
vegetariano che odiava la triglia e il cuore degli animali.
Il nostro margine di dissenso, di noi studenti acerbi,
praticamente non esisteva. I professori comminavano
punizioni anche a cuor leggero senza che nessuno di noi
osasse protestare o portare la protesta oltre le mura della
scuola. E se anche lo avessimo fatto i nostri genitori
avrebbero parteggiato, per principio, chi più chi meno,
94
con gli insegnanti. Erano tosti gli insegnanti di allora,
tosti e maneschi, tosti e talvolta stupidi. Resta saldo
nella memoria di Saretto Spampinato, amico caro
dell’ultimo tempo, un episodio legato alla sua infanzia.
Il primo giorno d’asilo, la maestra volle sapere i nomi
dei suoi genitori. Il bambino rispose prontamente e
timidamente: “Spampinato.” “E la mamma?”
“Spampinato” precisò. “Non può essere!” Il bambino,
allora, umiliato perché non era stato creduto, si mise a
piangere. “Spampinato” ripeté inghiottendo le lacrime.
Il giorno dopo i genitori, che portavano lo stesso
cognome, vennero a scuola e chiarirono quello che era
già chiaro, ma non nella piccola testa dell’insegnante.
Abisso culturale e pedagogico con l’oggi, comunque.
È finita sulle prime pagine dei giornali la vicenda della
maestra che ha imposto a un alunno di scrivere sul
quaderno cento volte la frase “Sono un deficiente”
perché il bulletto aveva deriso un compagno
definendolo gay. Apriti cielo. I genitori del ragazzo
hanno denunciato l’insegnante che ha rischiato un
processo per abuso di potere. Questo accade nelle
scuole italiane odierne dove i ragazzi usano spesso il
telefonino durante le lezioni e se i professori si
permettono di riprenderli o di sequestrare i cellulari si
vedono immediatamente denunciati dai genitori. Mi
sono sentito meno solo quando uno scrittore tollerante e
impegnato come Claudio Magris ha auspicato la
punizione degli studenti maleducati e riottosi come
imprescindibile metodo educativo. “L’autentica
educazione”, ha detto, “quella che influisce su di noi, ha
qualcosa in comune con la poesia, perché ci fa sentire il
bene e il male e, rispettivamente, la dignità o la penosa
balordaggine del nostro comportamento”.
“You must remember this/ a kiss is just a kiss/ a sigh
is just a sigh/ the fundamental things apply/ as time goes
by”. Anno 1941. A Casablanca, mentre il tempo passa,
mentre l’Europa è sconvolta e distrutta dalla guerra,
Rick Blaine, un americano dal passato misterioso,
95
gestisce un locale che è il punto d’incontro di agenti
francesi e tedeschi, di avventurieri, affaristi, fuggiaschi,
molti dei quali sperano di entrare in possesso delle carte
di transito per raggiungere l’America via Lisbona. Una
sera, nel locale, entra un dirigente del fronte clandestino
antinazista, Laszlo, con la moglie Ilsa: anche loro
vogliono lasciare l’Europa per continuare la lotta dagli
Stati Uniti e sperano di trovare i documenti necessari.
Ilsa è una vecchia fiamma di Rick: i due si erano
conosciuti a Parigi e poi persi di vista per l’incalzare
degli avvenimenti bellici. Si riaccende l’amore e dopo
alterne vicende Rick capisce che il posto di Ilsa è
accanto al marito.
“Suona la nostra canzone, Sam”, dice Ilsa al pianista
che è stato testimone del suo grande amore per Rick.
Sam, che ha l’ordine di non suonarla, resiste, dice di
non ricordarla. E lei gliene accenna il motivo… “laranlaran-laran…” Il primo piano di Ingrid Bergman, che
ascolta Mentre il tempo passa, il suo sorriso, la sua
malinconica dolcezza sono rimasti nel cuore di milioni
di spettatori che della diva, per vero, hanno molto altro
da ricordare, come la battuta al bacio Perugina in Io ti
salverò: “Non potrei amarlo tanto, se fosse malvagio”.
L’intuito femminile qui diventa più forte della scienza
psichiatrica ma lei, con quel viso e quel fascino, rende
credibile l’incredibile e letteratura il fotoromanzo.
Alcuni anni fa realizzai per Telecolor-Video3 uno
speciale su via Etnea, il centro mondano e culturale di
Catania, sul quale s’affacciano i palazzetti del potere,
l’università, magnifiche chiese, negozi, caffè, il cinema
Lo Po trasformato in multisala e un tempo, assieme
all’Odeon, uno dei locali d’eccellenza cittadini. Di
questa “strada diritta”, come la chiamano i catanesi, ne
raccontai la storia, tra passato e presente, parlando dei
personaggi, degli uomini illustri, delle macchiette che la
popolavano, parlando di Pippo Pernacchia, per esempio,
che, alla maniera di Eduardo De Filippo ne L’oro di
Napoli, ridimensionava, a pagamento, l’alterigia dei
malcapitati col suo inimitabile sberleffo sonoro. E
96
parlando del cinema di un tempo non potevo
dimenticare Casablanca di cui utilizzai la scena del
caffè appena descritta, con una piccola manipolazione.
Mentre Sam suona il famoso motivo, Rick piomba sul
pianista per rimproverarlo per il patto non rispettato ma
Sam gli indica con un leggero movimento della testa la
donna che gli sta dietro. Sul volto di Rick passano lo
smarrimento, la commozione, la felicità, il tempo
perduto e in un lampo ritrovato. A quel punto bloccai la
sequenza e in sottofondo feci scorrere le note della
canzone Tu che mi fai piangere, interpretata da Vittorio
De Sica… “Tu che mi fai piangere/ tu che mi fai
fremere/ tu col tuo perfido amor/ hai lacerato il mio
cuor/ eppur sei tu, soltanto tu/ ch’io bramo”. Il fermo
immagine, accoppiato alla bellissima canzone scritta nel
’37 da Mascheroni e Marf, esaltò la tempesta di
sentimenti che in quel momento agitavano il cuore di
Rick.
Come e più del viso della Garbo, quello di Ingrid era
una sintesi perfetta della bellezza. Il mistero della donna
qui non acquista suggestioni ambigue, come in altre
sequenze di altre pur famose e bellissime dive, ma
diventa puro spirito, “primo piano” per eccellenza,
secondo il leggendario dettame di Griffith. Mai avrei
potuto immaginarla come le donnine ritratte nelle foto
osé che ci passavamo sottobanco e che avevano
deliziato i soldati al fronte. Gioco, questo, o mania di
tutti i ragazzi della mia generazione che hanno avuto
l’età non appena hanno abolito le case chiuse, che poi
erano aperte.
Ci furono battaglie e ipocrisie sulla legge Merlin,
approvata nel febbraio del 1958, che nella sua intima
sostanza era volta non tanto a punire il Vizio, come
auspicavano i settori conservatori della società, quanto a
liberare le prostitute dal loro stato di schiavitù. Alla
Mostra di Venezia, l’anno in cui fu presentato il film di
Antonio Pietrangeli, Adua e le compagne, storia di ex
prostitute che cercano di riabilitarsi aprendo un
ristorante, la senatrice Lina Merlin dichiarò che il suo
97
scopo non era stato la moralizzazione dell’antico
mestiere ma di far cessare l’assurdità di uno Stato che
esercitava ufficialmente lo sfruttamento della
prostituzione. Quelli erano gli anni in cui Indro
Montanelli, in un pamphlet intitolato Addio Wanda!,
scriveva che in Italia un colpo di piccone alle case
chiuse avrebbe fatto crollare l’intero edificio basato su
tre fondamentali puntelli: la Fede cattolica, la Patria, la
Famiglia… “perché è nei cosiddetti postriboli che
queste tre istituzioni trovano la più sicura garanzia”. Nel
romanzo Il Gattopardo il principe Salina frequenta i
casini palermitani per sfogare la propria esuberanza
maschile (perché certe cose con le mogli non si fanno!),
per mettersi al riparo d’ogni tentazione divorzista e
continuare a obbedire con serena coscienza alle ferree
leggi di Santa Romana Chiesa e dello Stato monarchico.
Il mondo dei casini era un mondo misterioso per noi
ragazzi senza età specifica, circoscritto in un quartiere
malfamato, fatto di viuzze umide e buie, “una vera selva
di costruzioni bizzarre e piena di nascondigli dove il
male poteva nascondersi facilmente e vegetare
tranquillo in barba a tutte le leggi e i poliziotti”, secondo
il giudizio della piccola e acuta Goliarda Sapienza.
Insomma, era un mondo frequentato soprattutto da
uomini e marinai senza volto: non ne avevano perché
evitavamo di guardarli per l’irrazionale paura di essere
trascinati nei loro peccati. Un mondo violento, sporco,
marcio; questo era ciò che credevamo e incomprensibile
era il solo pensare che una persona normale potesse
entrare in quelle spelonche dell’abiezione abitate da
“fimmini tinti”, cattive, come le definivano le donne
oneste, le donne di calza e chiesa. Negli anni adulti,
negli anni del disincanto, e nel risvolto della conoscenza
specifica del fenomeno, giudicai quel mondo né bello né
brutto, solo necessario. E posi maggiore attenzione alle
storie che circolavano sulle “lucciole vagabonde” e che
m’erano sembrate inventate, come quella sul timido
signore, sfortunato con le donne, che un giorno
s’innamorò perdutamente d’una bellissima prostituta, se
98
la sposò, le diede un nome rispettabile e se la portò in
giro per via Etnea a fare la “dannazza” a tutte quelle che
lo avevano disprezzato. E quelle a girarsi e a
commentare, a dire che lui non era poi tanto male, che
forse possedeva doti nascoste e soldi da palate, che
magari era intelligente, anche se a loro non era parso, e
che insomma erano state un poco avventate ad
archiviarlo a quella maniera. In definitiva, fu il trionfo
del sembrare, del rimorso pirandelliano, della certezza
incerta.
La più famosa delle prostitute, allora, era Anna
Accupo. Il cognome era un soprannome: Accupo da
accupare, in italiano, soffocare. Si chiamava così perché
le sue doti amatorie erano talmente seducenti da
“soffocare” il cliente. Ed è probabile che questi,
nell’atto supremo dell’amplesso, esclamasse: “Anna,
accupo!” Di piacere, ovviamente. Poi c’era Maria la
Pazza, pazza sul serio si diceva. Era solita vestirsi da
marinaretto per stimolare la libido dei clienti che
s’illudevano di fare all’amore con una ragazzina. E
dunque tanto pazza non doveva essere. Per non dire di
un travestito che faceva girare la testa a viziosi e no,
come nel film La moglie del soldato di Neil Jordan. Per
la somiglianza con Rita Hayworth era soprannominato
Gilda. Talvolta, verso le due o le tre del mattino,
s’affacciava al bar dei fratelli D’Agata, a Ognina,
frequentato dal popolo della notte e da giornalisti che vi
andavano a prendere l’aperitivo dopo la chiusura del
giornale. Della comitiva dei redattori senza pinzeri di
casa facevano parte Renzo Di Stefano, Nino Milazzo,
Tony Zermo, Ciccio Siclari, Giancarlo Bonaccorsi ed io,
non ancora sposato. All’alzata dei bicchieri si brindava
puntualmente “alla morte di Gigi”, che era il collega
Luigi Prestinenza. Il primo ad alzare il calice e dare
l’avvio alla sbentata, più affettuosa che cattiva, era Di
Stefano, da poco nominato caporedattore al termine di
una battaglia con due accaniti concorrenti: Turi
Nicolosi, capocronista, e Gigi Prestinenza, caposervizio
della redazione sportiva. Ma se Nicolosi vantava buoni
99
titoli professionali lo stesso non poteva dirsi di
Prestinenza, ottimo professionista senza però grandi
capacità organizzative e di lavoro. Il suo merito
maggiore era quello d’essere nipote dell’ex direttore de
La Sicilia Antonio Prestinenza. Da qui l’irritazione. Ma
a ogni brindisi, al quale si associava uno dei titolari, il
giovane Roberto D’Agata, erano anni che gli
crescevano. Il povero Renzo morirà ancora giovane,
appena qualche anno prima della figlia Marina, cara,
intelligente, sfortunata ragazza. Dicevo di Gilda. Pareva
una donna tale e quale: alta, slanciata, viso di
porcellana. Un miracolo vivente. La trasgressione (di
puro intelletto) era d’obbligo.
Candidato a otto premi Oscar, Casablanca ne vinse
tre: film, regia, sceneggiatura. Humphrey Bogart
dovette soccombere a Paul Lukas (Quando il giorno
verrà) e Ingrid Bergman, che concorreva non per
Casablanca ma per il film Per chi suona la campana,
dovette cedere il passo a Jennifer Jones, magnifica
interprete in verità del personaggio Bernadette
dell’omonimo film di Henry King.
Verso la fine degli anni Novanta ricevetti dall’agente
di Isabella Rossellini una telefonata di ringraziamento
per un servizio andato in onda nell’edizione delle venti
del TG1. La figlia della Bergman aveva partecipato due
giorni prima a una manifestazione a Napoli, accanto a
Lucio Dalla e alla sua band, e si era messa pure a ballare
durante l’esecuzione di Attenti al lupo. Era vestita di
nero e portava i capelli molto corti, come la madre nel
film Per chi suona la campana in cui interpretava il
ruolo della partigiana spagnola Maria che s’innamora di
Gary Cooper. Impressionato dalla somiglianza tra
madre e figlia mi procurai le sequenze dei primi piani
della Bergman nel film di Sam Wood e le misi a
confronto con quelle della Rossellini. Davvero un
miracolo. Sembrava che la madre si fosse incarnata
nella figlia e viceversa. La telefonata mi fece piacere
perché ero riuscito a trasmettere ciò che volevo dire, ciò
che il mio cuore voleva esprimere. Era un dono alla
100
Rossellini ma era soprattutto un dono alla Bergman.
“And when two lovers woo/ they still say, ‘I love
you’./ On that you can rely/ no matter what the future
brings/ as time goes by”. Sam l’ha suonata e cantata per
Ilsa ma adesso non vuole farlo per Rick che se ne sta
appoggiato coi gomiti sul tavolo, mezzo ubriaco,
nell’appartamento sopra al Rich’s café américain.
“Suonala ancora Sam!” Dieci anni prima l’aveva
interpretata Rudy Vallée, sassofonista, attore, primo
crooner nella storia della canzone americana,
zuccheroso e intollerabile per Bob Dylan.
“A questa storia”, dice Rick “manca ancora il
finale”. Ma quali sarebbero state le possibili conclusioni
della storia? Michael Curtiz e il suo sceneggiatore Julius
Epstein ebbero a disposizione quattro possibili finali.
Primo finale. Ilsa torna da Rick, suo grande amore, e
lascia il marito Victor. Ma fu abbandonato perché la
censura non avrebbe permesso che una donna sposata
lasciasse il marito, per giunta eroe della Resistenza, per
correre tra le braccia dell’amante. Secondo finale. Rick
viene ucciso all’aeroporto dal comandante tedesco nel
tentativo di aiutare Ilsa e Victor a fuggire. Anche questo
fu bocciato. Non piaceva a Bogart. Terzo finale. È
Victor a morire dando così modo a Ilsa e a Rick di
tornare insieme. Venne tenuto in caldo sino alla fine. La
scelta però cadde sulla quarta opzione, la più difficile da
digerire ma la più saggia e la più romantica. Rick aiuta
Ilsa e Victor a prendere l'aereo per Lisbona e resta con il
capitano Renault. Oltretutto la conclusione permise a
Epstein e al produttore Hal Wallis di piazzare le due
battute più belle del film: “Fermate i soliti sospetti” e
“Louis, forse noi oggi inauguriamo una bella amicizia”.
Film magnifico, anche se non privo d’incongruenze.
Nel flashback ambientato alla stazione di Parigi Rick
viene sorpreso dal maltempo mentre legge il biglietto di
Ilsa, che scolorisce sotto la pioggia. Ma appena sale sul
treno, l’impermeabile che indossa s’è miracolosamente
asciugato. Differenze anche tra l’originale e la versione
italiana. All’arrivo del maggiore Strasser all’aeroporto
101
di Casablanca un certo capitano Tonelli si presenta
all’ufficiale tedesco e gli dice: “L’esercito italiano è ai
suoi ordini!” Quello neppure gli bada. La scena,
ovviamente, manca nella versione italiana. Per esigenze
di budget l’aereo che appare nell’ultima sequenza è una
sagoma in formato ridotto. Per farlo apparire più grande
gli addetti al rifornimento furono interpretati da nani.
Girato nel caos più totale, come ha scritto un critico, il
successo di Casablanca è dovuto all’equilibrio dei suoi
elementi, un po’ presi a casaccio tra gli stereotipi tipici
del genere, ma che danno al film un fascino misterioso e
intramontabile. Ha scritto Umberto Eco: “Quando tutti
gli archetipi irrompono senza decenza si raggiungono
profondità omeriche. Due cliché fanno ridere. Cento
commuovono. Perché si avverte oscuramente che i
cliché stanno parlando tra di loro e celebrano una festa
di ritrovamento”.
L’anno in cui Ingrid Bergman s’innamorò di Roberto
Rossellini e si stabilì in Italia il pubblico americano non
le perdonò la scelta che assomigliava a una fuga e
nemmeno il pubblico italiano la perdonò. In realtà,
doveva essere orgoglioso che la diva più amata del
momento si fosse sposata con un italiano, e invece no. Il
nostro pubblico fu contrario per senso estetico. Lei era
un mito, bellissima e inarrivabile, lui aveva la pancetta
ed era piuttosto insignificante come uomo: la figlia
Isabella quand’era piccola credeva che fosse incinto.
“Non avevo mai visto una donna così bella”, confessò
Federico Fellini. “Per noi italiani era come se la Vergine
Maria fosse discesa dal cielo, direttamente da
Disneyland.” Per lei, Rossellini, si beccò la sfuriata di
Anna Magnani. La sanguigna attrice italiana, avendo
capito di essere stata scaricata per quella dea di
celluloide, che per la verità aveva un cervello e un alto
sentire, scaricò a sua volta sulla testa del regista un
fumante piatto di spaghetti.
Siracusa, 1967. Il regista di Roma città aperta era
venuto per la premiazione dei vincitori del festival del
film industriale al quale partecipavo come giurato. Si
102
trattava di una rassegna di documentari piuttosto noiosi
che l’inviato de Il Resto del Carlino Sandro Delli Ponti
definì, tra un bicchiere e l’altro, “cazzate furibonde”.
Tra gli autori in competizione c’era Dore Modesti,
marito di Gabriella Farinon e padre di Barbara con la
quale avrei lavorato al TG1. Rossellini era un uomo
gentile e delicato, parlava poco e sapeva ascoltare…
persino me che ero poco più di un ragazzo e che in
quella occasione s’era lanciato in un’appassionata
esibizione di “muscoli” cinematografici. Parlare dei
miei sogni a un geniale costruttore di sogni fu il
massimo dei privilegi. Per fare bella figura mostrai di
conoscere tutti i suoi film, compresi quelli che non
aveva girato.
Danny Selznick, figlio del grande produttore,
descrisse Rossellini come una persona fortemente
carismatica. “Possedeva un’energia primordiale”,
precisò. “Quando entrava in una stanza c’era come
un’esplosione di testosterone. Mio padre era una
persona del genere ed era famoso per questo. Ma nulla
di confrontabile con Roberto Rossellini.” Eppure, quella
volta mi sembrò perdersi nella sua stessa grandezza, nei
suoi anni ormai crepuscolari. Aveva 61 anni, neppure
vecchio in realtà, ma una vita intensa alle spalle, il
matrimonio con Ingrid finito, i suoi grandi film nelle
cineteche, lui stesso in cineteca. Gli sarebbe rimasto il
fiato per grandiose – noiose? – produzioni televisive.
In Italia Ingrid Bergman girò alcune pellicole
sbagliate e alla fine, dopo anni di matrimonio più o
meno felice, più o meno rassegnato, se ne tornò negli
Stati Uniti. Ma ormai la giovinezza era passata e il
marito s’era risposato con una ragazza indiana, Sonali
Das Gupta. Al confronto, una racchia di proporzioni
cosmiche. E fummo in molti, allora, a odiare l’intrusa e,
soprattutto, a odiare lui che aveva gettato una perla per
raccogliere una ghianda. Eppure, gli incalliti sostenitori
del regista si esercitarono a trovare il pelo nell’uovo,
cominciando col dire, per esempio, che i piedi della
Bergman non erano proprio di misura gentile. Il già
103
citato Márquez ci sovviene a darci il suo spirito per
potere controbattere: “È vero che lei, come la sua
compatriota e collega Greta Garbo, non potrà infilare il
delicato piede in una scarpetta di numero inferiore al
quarantuno – debitamente misurato – ma tale
circostanza, in fin dei conti, porta solo a concludere che
le attrici svedesi sono in grado di conoscere, meglio di
chiunque altro, le condizioni del terreno su cui
camminano”.
Salvatore Ferragamo, che a Hollywood fece fortuna
fabbricando per attori e comparse stivali da cowboy e
sandali romani, ha consegnato alla storia della sua
azienda una versione leggermente diversa. La misura
esatta della Garbo era il 39 e mezzo, pianta stretta. Fu
nel 1927 che la diva mise per la prima volta i suoi piedi
nelle mani del giovane avellinese che diventerà il suo
scarparo di fiducia, così come di molti altri attori e
attrici del cinema.
104
QUATTRO
Jennifer Jones, Maria Montez
La terra di Ingrid, la terra di Greta. Era nei sogni
della mia generazione perché era la terra del sesso
facile, delle ragazze bionde belle e disinibite con le
quali, se avevi fortuna e faccia tosta, potevi costruire
una breve storia d’amore per poi tornartene nelle tue
lande desolate a ricordarla tante di quelle volte fino a
farla diventare magnifica e improbabile. Peccato, allora,
non avere i soldi per soddisfare quelle radiose
aspirazioni che in Sicilia potevi coltivare nel chiuso
della tua immaginazione perché se volevi fare sesso con
una ragazza dovevi sposarla. Quanti matrimoni falliti,
pur restando ancorati alla forma, in quel tempo casto e
ipocrita!
Alla fine di febbraio del 1995 Stoccolma mi si
presentò ormai fredda e lontana – la giovinezza è un
raggio verde che brilla e rapido scompare – ma
moralmente e culturalmente vicina. Il governo svedese
aveva accettato, unico Paese europeo, di ospitare, e
proteggere, la scrittrice e poetessa Taslima Nasreen che
i fondamentalisti islamici del suo Paese, il Bangladesh,
avevano condannato a morte in quanto nemica
dell’Islam. Che cosa aveva fatto Taslima di tanto grave
da meritare un castigo così spaventoso? Semplicemente
aveva scritto un libro, Lajja, in Italia pubblicato dalla
Mondadori col titolo Vergogna, col quale denunciava
ogni integralismo, fanatismo e settarismo religioso.
Andai a intervistarla per il TG1, assieme a alcuni
colleghi di giornali e settimanali. Il porto di Stoccolma
era in parte gelato e un vento polare consentiva appena
rapidi spostamenti a piedi. Accompagnata dal padre e da
agenti in borghese, lei arrivò in tutta segretezza
nell’albergo dov’eravamo alloggiati. Era una giovane
donna bruna, come tante nostre siciliane, d’una bellezza
discreta. Indossava il tradizionale costume del suo Paese
105
e rispose alle nostre domande con pacata fermezza e
semplicità.
Nell’introduzione al libro aveva scritto: “Lajja è
stato pubblicato in Banglaesh nel febbraio del 1993; ha
venduto 60.000 copie e, dopo cinque mesi, è stato
vietato dal governo perché accusato di fomentare la
sommossa. Nel settembre dello stesso anno
un’organizzazione fondamentalista ha pronunciato
contro di me una fatwa e ha messo una taglia sulla mia
testa. Nelle strade di Dacca si sono svolte marce in cui
veniva invocata la mia morte. Ma niente può scuotere la
mia determinazione a continuare la lotta contro la
persecuzione religiosa, il genocidio, il settarismo
comunitario”. Alla mia domanda se, nonostante tutto,
amasse ancora il suo Paese rispose: “Il Banglaesh è la
mia patria. Tutti noi abbiamo pagato la conquista
dell’indipendenza dal Pakistan con tre milioni di morti.
Tradiremmo il loro sacrificio se accettassimo di farci
dominare dall’estremismo religioso”. Poi ci fu il rituale
delle foto e delle dediche sui libri. Sulla mia copia
scrisse: “With respect and best wishes”. Da parte di una
che rischiava la vita, quel “respect”, espresso a uno che
al massimo aveva patito qualche raffreddore e scritto
nulla di importante, mi fece capire la sua profonda
semplicità e grandezza d’animo. Da alcuni anni vive in
India. Qualche anno fa un gruppo musulmano indiano
ha posto una taglia di mezzo milione di rupie per la sua
decapitazione.
Da piccoli, io e mia sorella, facevamo un gioco:
percorrere al buio il corridoio di casa, entrare nella
stanza in fondo, che era il salotto-studio, e, sempre al
buio, restarci fino a che il coraggio veniva spazzato via
dall’angoscia. Vinceva chi resisteva di più. Era un modo
per sconfiggere la nictofobia che c’è in ogni bambino.
Raccontando la sua vita, nel bel romanzo La terrazza
proibita, la studiosa e scrittrice marocchina Fatema
Mernissi confessa che da bambina era solita nascondersi
nella giara delle olive per allenarsi, in quella oscurità, a
106
vincere le grandi paure del futuro. Forse anche il nostro
gioco era un allenamento, inconsapevole certo, per
diventare adulti e non una bravata fine a se stessa. In
verità, come sostengono psicologi e pedagoghi, la
ricerca della paura è un modo per superarla.
Cappuccetto Rosso che vaga nel bosco era per noi
bambini una fonte inesauribile di scanto (spavento) che
tuttavia morbosamente ci attirava e, grazie al lieto fine,
ci fortificava. In realtà, quel restare al buio era lo stesso
che starsene chiusi nella giara, immaginare mostri che ti
afferrano per i piedi e poi liberarsi della paura
guardando la goccia di cielo che ti sta sopra la testa.
L’abitudine, Fatema, l’aveva presa ascoltando la storia
di una vecchia domestica che da piccola era stata rapita
da un mercante di schiavi che l’aveva calata in un pozzo
buio e profondo e lei era riuscita a sopravvivere
pensando a come uscirne. Solo allora “il fondo, il buco
nero”, diceva “diventa un trampolino da cui si può
saltare così in alto da battere la testa contro una nuvola”.
La mia tecnica era diversa ma il principio era lo stesso.
Attraversavo di corsa il corridoio, entravo nel salottostudio, chiudevo gli occhi, immaginavo che la stanza
fosse illuminata a giorno, contavo fino a che il cuore mi
reggeva e scappavo via.
Negli anni Cinquanta si risparmiava su tutto: sulla
luce, che occorreva spegnere quando si passava da una
stanza all’altra; sull’acqua, che si faceva scorrere dal
rubinetto a filo; sulla carta da regalo, che veniva stirata
e utilizzata per usi collaterali; sulle calze di seta, che
erano mandate alle sarcitrici per il rammendo; sulle
pentole, che se erano bucate si portavano dallo stagnino
o si tappavano provvisoriamente col sapone; sul
dentifricio, che non bisognava spalmare per intero sullo
spazzolino; e su tante cose che componevano la vita
misurata, difficile, della gente. Non era come ora che i
ragazzi lasciano tutto acceso e i rubinetti aperti come se
lo spreco servisse all’igiene. Così il buio, segno del
bisogno, diventava un compagno silenzioso e
inquietante e l’acqua un prezioso liquido al pari del
107
petrolio che si utilizzava per tante cose: per i lumi, per
pulire i pavimenti, persino per rinforzare e rendere
lucidi i capelli. L’acqua è come l’argento, dicevano gli
anziani, e il sapone come l’oro. Oggi la parsimonia si
pratica per avarizia, per malattia; come fa la regina
Elisabetta, che ricicla la carta dei pacchi-regalo, o come
Sean Connery e Bruce Willis che non danno mai la
mancia ai camerieri.
Il gioco lo sospendemmo di buon grado dopo aver
visto, sempre nell’affumicato cinema dei ferrovieri, Il
ritratto di Jennie di William Dieterle, con Jennifer
Jones e Joseph Cotten. Un film girato nel 1948 e che ho
rivisto solo di recente, in dvd, e quindi con la possibilità
di bloccare i fotogrammi, trascrivere le frasi e,
soprattutto, i versi di Keats, posti in sovrimpressione
dopo i titoli di testa: “La bellezza è verità, la verità
bellezza, questo è tutto ciò che voi sapete in terra e tutto
ciò che vi occorre sapere”. Grande invenzione
l’elettronica! Permette di fermare il tempo e ingrandire
l’intelligenza, espanderla fino a individuare il
frammento, il cuneo delle immagini e delle parole che ti
servono. All’inizio del film il regista si affida a una
frase per rendere credibile una storia che non sta in piedi
ma che ti vortica nel cervello come una sega circolare,
come mi vorticò allora, mezzo secolo fa, nel momento
in cui vidi la protagonista trasformarsi da ragazza in
signorina in poco tempo per poi tornarsene
improvvisamente nel regno dell’indistinto: “La scienza
insegna che nulla muore ma solo si trasforma, che il
tempo stesso non trascorre ma s’incurva attorno a noi e
passato e futuro ci sono accanto, assieme, per sempre,
oltre i limiti estremi di ogni conoscenza…” Insomma,
c’era di che confondere la mente di un ragazzo che a
fatica cerca di raggiungere le proprie sicurezze
cartesiane.
Il film racconta la storia di un pittore squattrinato,
Eben Aams, ossessionato dalla figura di una ragazza,
Jennie, incontrata in una brumosa serata d’inverno al
108
Central Park, a New York. L’uomo non riesce a
dimenticarla. Quella sera stessa ne ha fatto uno schizzo
che poi è costretto a vendere per 12 dollari a una
galleria d’arte. Finalmente, dopo qualche tempo, la
rivede e le esprime tutto il suo turbamento. Anche
Jennie non si mostra insensibile. Cominciano a
frequentarsi, sia pure a scappa e fuggi, e lui le fa un
ritratto-capolavoro. Ma a quel punto, misteriosamente,
Jennie non si fa più viva. Eben prova a cercarla.
Ripercorre più volte, invano, i passi del delirio amoroso,
i luoghi, le memorie… finché una vecchia suora
(interpretata dalla grande diva del cinema muto Lillian
Gish), che ancora dirige il collegio frequentato molti
anni prima da Jennie, le rivela che la ragazza è morta
durante una gita in barca al faro di Punta Scura. Brivido
lungo la schiena del protagonista e degli spettatori. Chi
era allora la ragazza del ritratto, la dolce fanciulla di cui
il pittore si è innamorato?
Confuso e smarrito, il pittore corre al faro maledetto,
convinto di trovarla e di salvarla. E, infatti, mentre
infuria la tempesta, egli la rivede. Si abbracciano. Lui
non vuole più lasciarla, ma lei non può, non può tornare
a vivere in una dimensione che non è più la sua, e così
scompare tra le onde, come quella volta. Anche Eben,
nel tentativo estremo di salvarla, di fermare il tempo e
ricondurlo alla propria dimensione, rischia di annegare.
Lo salvano alcuni pescatori, mentre Jennie si avvia
rapidamente verso la profondità dei cieli, laddove ben
presto arriverà anche il cuore di lui, in unione perfetta
tra ciò che vive e ciò che muore. In un’altra epigrafe del
film il regista ricorda l’interrogativo di Euripide: “Chi
sa se morire non sia vivere, e se ciò che i mortali
chiamano vita non sia morte?” Scrive Morando
Morandini nel suo dizionario dei film: “Uno dei più
squisiti film fantastici nella storia di Hollywood. Un po’
velleitario come riflessione (vita, morte, amore, arte),
ma figurativamente suggestivo”. Fu molto amato da
Luis Buñuel per la sua magica combinazione di favola e
di amour fou e soprattutto per i suoi incantesimi
109
figurativi affidati all’estro di Joseph August che fu a un
passo dal vincere l’Oscar.
Tornando a casa, quella sera, cercai con la banalità
del dettaglio (delle scene, degli attori, delle battute) di
superare la paura che mi serrava il cuore. Una morta
vivente! Non ci dormii la notte. Me la vedevo
camminare per la stanza, toccare i libri, sfogliarne
alcuni, sorridermi, e infine sedersi sul bordo del letto. E
più mettevo la testa sotto le coperte più lei s’incaponiva
a parlarmi, a dirmi che l’amore è senza tempo e che
richiede sacrifici, a dirmi che veniva da un posto
sconosciuto e che andava dove tutte le cose vanno. Uno
spavento serio, come quello che capitò, su altri registri e
incubi, a Jean-Paul Sartre. Lo scrittore e filosofo
esistenzialista stava preparando un saggio sulla
immaginazione, ed era arrivato a un punto morto,
quando un amico medico, che doveva avere Stevenson
fritto nel cervello, gli consigliò di farsi iniettare della
mescalina allo scopo di osservare su se stesso il
fenomeno allucinatorio e poterne scrivere a ragion
veduta. Per lungo tempo Sartre venne inseguito dalle
aragoste.
Nel film c’è una storia d’amore parallela, nascosta,
certo non precisamente afferrabile da un ragazzo che
corre per approssimazioni, incanti e fumetti. Ed è la
storia che coinvolge, a margine di quella principale e su
tonalità, come dire?, in mi bemolle, il pittore e la sua
anziana gallerista (la sempre straordinaria Ethel
Barrymore) che ha gli occhi melanconici della
protagonista e l’età che Jenny avrebbe avuto se non
fosse morta. Dunque, accanto all’impossibile amore tra
il pittore e la donna fantasma corre un altro amore, di
puro intelletto, tra lo stesso pittore e la gallerista, anche
questo impossibile seppure reale, realissimo. Ed è qui
che il vero e l’apparente si fondono nel molteplice.
Nel 1969 scrissi per la terza pagina del mio giornale
alcuni elzeviri. Oggi non si usano più. Erano articoli di
argomento letterario stampati con un carattere
particolarmente elegante, l’elzeviro appunto, attraverso i
110
quali generazioni di romanzieri hanno imparato a
scrivere. Provando e riprovando alla fine uno ci azzecca.
Più o meno. In uno degli elzeviri m’inventai una favola,
a pensarci bene molto affine a un racconto di Giuseppe
Tomasi di Lampedusa, che però a quel tempo non
conoscevo e, soprattutto, a Il ritratto di Jennie. Era la
storia di un amore tra un ragazzo e una sirena, sbocciato
in riva al mare della Plaia, finché lei scompare per
sempre. Anche gli altri racconti correvano su questa
linea ambigua, tra la vita e lo schermo.
Molti dei film interpretati da Jennifer Jones sono
capolavori, a cominciare da Duello al sole di King
Vidor, stesso anno de Il ritratto di Jennie (qui l’attrice,
nel ruolo di Perla, focosa e appassionata meticcia, è
superba per bellezza e bravura), e continuare con Gli
occhi che non sorrisero di William Wyler, girato nel
1952. Tratto dal romanzo di Theodore Dreiser, Sister
Carrie, il film si avvale non solo di una straordinaria
Jennifer ma di un Laurence Olivier al massimo delle
possibilità espressive. Memorabile la scena del
protagonista, ridotto in miseria per amore, che,
disperato, mentre è in strada, tra la gente, esclama: “Ho
fame!” e uno gli risponde: “Lo dice a me o al cielo?” La
sua ex amante, ignara di tutto, è a teatro a raccogliere
l’applauso. Solo un grande scrittore come il norvegese
Knut Hamsun ha saputo cogliere tanta disperazione.
Ma il film capolavoro di Jennifer, per il quale vinse
l’Oscar, è Bernadette in cui l’attrice, pur avendo i suoi
anni, 24, interpreta con maestria il personaggio di
Berndaette Soubirous, la ragazzina che parlava con la
Madonna nella grotta di Lourdes. Uno che non crede a
niente, meno che meno ai Santi e alla Vergine Maria,
dopo aver visto il film non può fare a meno di
interrogarsi sul mistero del Creato, sulla fede
nell’invisibile, sul mistero stesso della propria
commozione. Frutto di sapienza narrativa, certo. Ma
non è solo questo. C’è qualcosa di più. È come se il film
fosse riuscito a sollevare un velo, un velo che avvolge il
divino e lo svela. Perché non è possibile commuoversi,
111
e persino da adulti piangere, con la stessa intensità dopo
averlo visto una decina di volte.
L’amore è una cosa meravigliosa di Henry King, del
1955, è un quasi polpettone strappalacrime ma a me
piacque moltissimo. Per molto tempo, nei momenti
malinconici, ne ho canticchiato il motivo: “Sì questo
amore è splendido/ come il sole più del sole tutti ci
illumina/ è qualcosa di reale che incatena i nostri cuor/
amore meraviglioso amor…” L’autore della strepitosa
canzone, Sammy Fain (le parole erano di Paul Francis
Webster), vinse l’Oscar. Quante lacrime sul ciglio di
quegli anni d’argilla! Mezzo secolo più tardi, a dire che
l’età torna sempre su se stessa, le lacrime si sono
riaffacciate prepotenti sulle note del concerto in re
maggiore n.35 per violino e orchestra di Čajkovskij nel
superbo film di Rau Mihaileanu Il concerto, lo stesso
regista franco-romeno che mi aveva sorpreso e incantato
con Train de vie. Quando la commozione fa bene al
cuore e si prende la rivincita sulla durezza della
maturità! magari riacciuffando sensazioni e immagini
scollegate e in apparenza perdute.
Dopo essersi sposata con l’attore Robert Walker, dal
quale ha due figli, Jennifer s’innamora perdutamente del
produttore David O. Selznick che la lancia nel
firmamento internazionale con alcuni dei film ricordati.
Un matrimonio felice, tanto felice che alla morte di
David, nel 1960, l’attrice tenta il suicidio. Lentamente si
riprende e comincia a occuparsi di questioni di salute
mentale. Incontra il collezionista d’arte Norton Simon,
che sposa nel 1971. Torna a lavorare. Una piccola parte
in L’Inferno di cristallo. Ma la tragedia è ancora in
agguato. La figlia Mary Jennifer, avuta da Selznick, si
ammazza gettandosi da un grattacielo di Los Angeles.
Anche il figlio di Simon si uccide. All’attrice non resta
che abbandonare tutto. Mette su una fondazione per la
cura delle malattie mentali, e sul logo utilizza i nomi
della figlia Jennifer, di suo marito Simon e suo. È morta
il 17 dicembre del 2009 nella sua casa di Malibu in
California. Aveva novant’anni. È stata l’ultima grande
112
attrice del cinema immortale di Hollywood.
La follia ha avuto colori meno forti, grigi più che
neri, fondali da operetta più che da opera lirica nella
Catania della mia infanzia. Mi ricordo di un signore che
passeggiava per le vie del centro col fez in testa e diceva
a tutti che si era fatto “turco” per non pagare le tasse;
oppure di Gioacchino Di Stefano, sovrintendente del
Teatro Massimo Bellini, che il direttore di La Sicilia
Antonio Prestinenza definì pazzo per avere messo in
cartellone La vedova allegra di Franz Lehàr. Parve
scandaloso a Prestinenza che l’inventore della “piccola
lirica”, che aveva cominciato a dirigere una banda
militare nel regno di Francesco Giuseppe, potesse
figurare accanto agli artisti della grande lirica, accanto a
Vincenzo Bellini e a Giuseppe Verdi. E pazzi furono
giudicati tutti coloro che scambiarono per dischi volanti
i palloni del servizio meteorologico dell’Aeronautica.
Pazzo infine, pazzo vero, Salvatore Scalia (omonimo
del mio amico scrittore Turi Scalia) che perse la ragione
per amore. Era un bravo studente, ma dopo essere stato
rifiutato dalla baronessina Elena Paternò Castello, della
quale s’era innamorato, abbandonò lo studio, rifiutò il
cibo e diede segni di squilibrio. “Io sono il capitano
Morgan!” diceva ai genitori e li accusava di volerlo
derubare del suo tesoro. Per vent’anni fu tenuto
segregato in una stanzetta. Enzo Asciolla, il giornalista
del caso Gallo, lo scoprì che era ridotto pelle e ossa, un
morto vivente, pazzo tra genitori più pazzi di lui per
averlo trattato come una bestia.
L’anno dell’Amore splendido è anche l’anno del mio
primo piccolo amore, naturalmente infelice. Lei era
incuriosita delle mie parole e di qualche libro che
leggevo. A quell’età il sentimento dei ragazzi si nutre di
spirito più che di ragione, bada alla voce del cuore non
alle strutture della mente, bada alla gentilezza, al saper
dire e magari non saper fare; a quell’età… quando si
comincia a essere feriti dalla realtà, come canta Dalida
in Mamy blue. Al pari della moglie di Benjamin Button,
era bella come il peccato. La pensavo anche la notte ma
113
non avevo il coraggio di dichiararmi. La stessa viltà di
James Stewart, in La vita è meravigliosa di Frank
Capra, che all’amata Donna Reed, anche lei innamorata
cotta, parla di lune, tramonti, fiori senza trovare
l’audacia minima di fare un passo avanti al punto che un
signore, che ha assistito dal terrazzo di casa alla scenetta
zucchero e miele, non gli grida indispettito (cito a
memoria): “Invece di parlare, baciala, stupido!”
La dichiarazione la fece al mio posto un amico, per
farmi un favore… “visto che non ti decidi”. Lei ascoltò
ed io negai con molto imbarazzo e rossore. Il mio
sentimento era talmente grande che mi faceva paura. E
lei disse: “Non ti preoccupadre, lo so”. E invece non
sapeva niente; anzi, sapeva il contrario, solo che
l’apparente diniego in realtà le serviva per agevolare la
sua stessa fuga. Eppure, se avessi colto nei suoi occhi la
scintilla d’amore che divorava il cuore di Donna Reed
forse avrei trovato il coraggio di strapazzarla, un poco, e
di stamparle un bacio comme il faut, un bacio alla Cary
Grant, il bacio immortale che l’attore dà a Ingrid
Bergman in Notorious. Coraggio cinematografico,
perché fino a quel tempo le uniche ragazze che avevo
baciato erano le dive di Hollywood.
Era d’estate. Lido Trinacria. Tempo di amori acerbi à
la boum, di ragazzette alla Sophie Marceau avanti
lettera, di albe caste e spossanti sugli arenili, di sguardi
languidi che ti riempivano la vita, di notti umide e
laceranti nelle quali sognavi impossibili amori, come
quello tra Eben e Jenny, che diventavano reali nel buio
solitario della notte e si spegnevano al canto mattutino
delle onde che andavano a frangersi dolcemente
sull’arenile. Tempo di musica americana. Modugno si
accingeva a raggiungere il suo Nel blu dipinto di blu e le
canzoni di Claudio Villa e Achille Togliani ci parevano
troppo volgari per metterle a commento dei nostri
furori. Ci saremmo vergognati come ladri persino a
ascoltare Buongiorno tristezza e La luna si veste
d’argento.
Tempo di Frank Sinatra e Pat Boone, Paul Anka e
114
Perry Como ma soprattutto degli scatenati Little
Richard, Bill Haley, Elvis Presley un passo avanti
rispetto ai grandi crooners Rudy Vallée, Tony Bennett,
Bing Crosby che avevano furoreggiato tra la fine dei
Trenta e l’inizio dei Quaranta, anni in cui s’impose tra
le donne la grandissima Billie Holiday (The man I love,
Strange fruit, God bless the child), che fu tra le prime
cantanti nere a esibirsiassieme a musicisti bianchi. Un
paio di gradini più sotto stava Alice Faye (You’ll never
know), per altro buona interprete di fortunati musical e
che lasciò la carriera cinematografica al culmine del
successo.
Tempo dei Platters e delle loro bellissime canzoni:
You’ll never know, diversamente arrangiata, The great
pretender, Unchained melody, Twilight time e la
celeberrima e dolcissima Only you… “Only you can
make this world seem right…” “Solo tu puoi rendere
questo mondo giusto, solo tu puoi rendere l’oscurità
brillante, solo tu e solo tu, puoi entusiasmarmi come sai
fare, e riempire il mio cuore di amore…” Parole non
banali. Ma chi sapeva tradurle, chi capirle? Ci si
lasciava sedurre dal loro suono e dal profumo di lavanda
della ragazza che ci stava accanto e che portava ancora
scarpe basse, calze corte e gonna a campana.
Quelle seduzioni sembravano possedere la forza
dell’amore di Natalie Wood per Warren Beatty in
Splendore nell’erba senza però finali distruttivi perché
tutto si ricomponeva in una dimensione casalinga da
caffè e latte e bacetti della mamma… “Se niente può far
sì, che si rinnovi all’erba il suo splendore, e che riviva il
fiore, della sorte funesta non ci dorremo, ma ancor più
saldi in petto, godremo di quel che resta…” Sono i versi
del poeta inglese William Wordsworth che ispirarono a
Elia Kazan il titolo del suo bellissimo film e che
vengono recitati da una voce fuori campo mentre
Natalie, ancora ardente di feu sacré, si allontana per
sempre dal suo adorato Warren. Passione monumentale,
che rasenta la follia, in un’opera profetica: l’attrice,
vent’anni dopo, morirà al largo dell’isola di Santa
115
Catalina mentre faceva il bagno. Suicidio o malore? La
versione più accreditata fu che l’attrice si lasciò andare,
come in una drammatica sequenza del film appena
ricordato. A poche bracciate da lei c’erano il marito
Robert Wagner e Christopher Walken, rimasti a godersi
il sole sul panfilo. Non si accorsero di nulla (!).
Splendore nell’erba entrò nel circuito delle mie pulsioni
profonde e lì rimase per affiorare quarant’anni dopo,
senza che me ne rendessi conto, nella trama del mio
romanzo Il vulcano spento di cui dirò in seguito. La
memoria seppellisce ma non distrugge. La memoria
delle piccole e delle grandi cose. Il risveglio si compie
per percorsi misteriosi e si definisce all’improvviso, per
lo più dopo acuti dolori e bisogno di raggiungere la
serenità.
E c’era Bruno Martino, il cantante confidenziale che
riuscì a crearsi una nicchia italiana in quella lunga estate
degli anni Cinquanta. La sua voce calda e nel contempo
nervosa fu lo sfondo del nostro sentimento di ragazzi
cresciuti senza nutella e nel ricordo del dopoguerra
difficile, dei rifugi antiaerei appena diroccati, dei tram
che scintillavano lungo le rotaie, della spiaggia
sterminata della Plaia, dei lidi balneari, del gioco dei
tamburelli nelle faticose arene di sabbia o del Monòpoli
le cui finte compravendite di terreni e case ci rendevano
aspiranti teppisti da capitalismo garibaldino, per non
dire dei baci immaginati o al più soffiati sul palmo della
mano. Eravamo felici? Sì, lo eravamo. Felici del nostro
orizzonte culturale appena sopra la sufficienza, delle
nostre visioni ristrette della vita e del mondo che
vedevamo con gli occhi di Douglas Sirk e dei suoi filmconfetto, attraverso la memoria dei nostri padri che
magnificavano il tempo andato, il tempo dei film in
bianco e nero, di Fred Astaire e Ginger Rogers. Bruno
Martino era la promessa e la conferma che la vita
sarebbe stata ardua ma senza sorprese, dentro la cerchia
degli ideali messi in campo dalla generazione
precedente e questa da quella ancora prima, così
replicando un tempo e una speranza. Eravamo felici e
116
blindati, sicuri che la nostra esistenza sarebbe stata
migliore. Felici e fanciulli anche a vent’anni, anche se il
tempo stringeva per altre responsabilità. Bruno Martino
era anche il nostro Ottocento, perché la nostra cultura
veniva da lì, veniva da Edmondo De Amicis, da
Giovanni Pascoli, da Giosuè Carducci. Le nostre letture
erano sempre e comunque “ottocentesche”, i sentimenti
eroici e sognati erano nelle battaglie per l’indipendenza
più che nelle due guerre mondiali che neppure
studiavamo e di cui poco sapevamo.
Il tempo di Bruno Martino era il tempo delle nostre
gelosie, dei nostri rancori, dei piccoli sogni che a noi
parevano titanici. Cos’hai trovato in lui “di tanto bello
non so...” La cantavamo fino alla smemoratezza. E la
chiamano estate “questa estate senza te...” Follie,
giovani follie, che il tempo ha conservato delicatamente
fino al 1968, l’anno che divise il Novecento
dall’Ottocento, che spezzò la carriera di Bruno Martino
relegandola nelle balere di periferia, lontano dalle
nascenti discoteche, dai rumori sapienti della discomusic. Egli era cantante di night club, di piccole pedane
e pochi orchestrali, di atmosfere ovattate, di champagne
a basso costo più che di bloody mary e di gin and tonic.
Non poteva sopravvivere. Di lui è però rimasta la
luminescenza di un ricordo di quegli anni lontani, quasi
mezzo secolo fa, gli anni delle promesse e dell’avvenire
stampato sulle bandiere, delle lunghe estati trascorse
sulla sabbia ad aspettare il sole che nasceva sulla linea
dell’orizzonte. Ed era magnifico vederlo questo sole di
carta sollevarsi lento e maestoso, vederlo salire con i
nostri furori e le nostre speranze, vederlo brillare sulle
note di un cantante che amavamo senza saperlo, senza
capire cioè che era lui il nostro simbolo, la nostra
certezza del passato. L’incognita del futuro e la sua
difficoltà l’avremmo riconosciute molto tempo dopo.
Quella ragazza azzurra sposò un giocatore di calcio,
alto bello e famoso. Non l’ho più veduta da quella
stagione incantata. Solo di recente l’ho immaginata
illuminarsi nella notte, congelata nei suoi anni giovanili,
117
bella da togliere il fiato a uno come me che ha troppe
cose ormai da raccontare. Come nel finale del film di
Sergio Leone, C’era una volta in America, mi sono
immaginato nei panni di Robert De Niro che incontra
dopo molti anni l’ex ragazza, Elizabeth McGovern. Lui
è invecchiato, l’aria dissipata di chi ha dormito troppo a
lungo sui tavolacci, radi capelli grigi, un cappotto
acquistato ai magazzini generali e una tristezza infinita
che smargina dagli occhi stanchi. Lei invece è la stessa,
fresca e splendente, cinica e dura, come se avesse fatto
un patto d’eterna giovinezza con Mefistofele.
Naturalmente non era lei, non era la ragazza che mi
aveva tolto il sonno e il respiro come può farlo solo il
primo amore. Magicamente e misteriosamente ne era
una reincarnazione. “La zia abita in un’altra città” disse.
Altri amori sarebbero arrivati, teneri e appassionati,
avventurosi e fasulli, tutti comunque “cinematografici”
per come li alimentavo dentro di me, per come li
soffrivo e li facevo crescere, per come m’illudevo che
fossero definitivi e non lo erano. Le vecchie fiamme,
sentenzia un personaggio di The Family Man, sono
come le vecchie dichiarazioni dei redditi: le metti in fila
nell’armadio per tre anni e poi te ne liberi; oppure sono
come la posta che si accumula sulla scrivania e ti
macera il plesso solare soltanto se ti lasci ingannare
dalla sua elementare urgenza. Molte, in effetti, le ho
dimenticate, altre sono rimaste sullo sfondo,
inoffensive, come lettere sigillate, appunto: le apri nelle
appassite stagioni e ti accorgi della loro sostanziale
inutilità.
La memoria mi suggerisce il volto d’una ragazzina,
copia spiccicata di Dayle Haddon, che aveva fili bianchi
tra i capelli neri e ricci ed era volubile come il vento.
Distesi sulla sabbia, separati dagli altri, tra di noi
c’erano più sguardi che parole, e qualche nascosta
carezza che il più intransigente dei confessori ci avrebbe
volentieri perdonato. A fine estate s’allontanò dalla mia
piccola vita. Era troppo matura per inamidarsi in quella
balbuzie d’amore e troppo giovane per allontanarsene.
118
Eppure bruciò i tempi e divenne adulta anzitempo.
Come scrive Stephen Carter nel prologo di Bianco
americano vantava “sedici anni anagrafici e cinquanta
effettivi”. Ma la sua vita non sarebbe stata per molto
tempo felice. Avrebbe lottato con due malattie terribili,
una dopo l’altra, senza tuttavia farsene abbattere,
cercando con tutte le forze di arginare ciò che di crudele
e irrazionale c’è in ogni male che deturpa la Bellezza.
Il ricordo coglie il sentimento per una fanciulla con
la treccia bionda e gli occhi chiari che amava La
canzone di Marinella ed era timida e sognante. Mi
salutò un giorno di primavera. Attraversai il marciapiedi
di fronte, a passo svelto. Lei stava correndo verso casa.
Si fermò un momento, parlammo. Il sole precipitò
all’improvviso, oscurato dall’ombra di un altro ragazzo.
“Se le cose stanno così…” dissi, e mi avviai a chiudere
il sipario, come nella canzone di Sergio Endrigo… “fra
noi più niente da dire”. Tutto si rappresentò e si risolse
come tra Marcel e Gilberte. Anni dopo il sentimento
tornò ad attivarsi per una ragazza fragile e paurosa che
avrebbe trovato, anche lei, la sicurezza in un solido
matrimonio finito tragicamente per la morte improvvisa
di lui. Aveva lo sguardo smarrito di Betty Field ne Il
grande Gatsby di Elliott Nugent. Ci lasciammo, con una
pena infinita nel cuore, davanti all’università. C’erano
troppi pregiudizi da scalare, troppi valori e disvalori da
mettere insieme. Le scrissi una lettera appassionata e
malinconica, che non ebbi l’audacia di spedirle, nella
quale spiegavo la forza del mio risentito amore. Per anni
confusi le responsabilità, le diedi tutti gli alibi di questo
mondo, gli appigli più inverosimili, ma la verità era
d’una semplicità imbarazzante. Il mio sentimento era
astratto, confuso e ingenuo per poter competere con la
paura. Lei voleva volare sul trapezio ma aveva bisogno
della rete di sicurezza per evitare rischi inutili.
Altri minori pensieri riguardano altri minori affetti:
quello per una ragazza dieci e lode che inseguii per un
anno e alla fine conquistai e poi lasciai per una delle
“fiamme” appena ricordate; quello per una piccola
119
vamp che si allenava a diventare zoccola, e che forse
cercava in me la “redenzione”; quello per una
tormentata divoratrice d’uomini segnata da un destino
infame: era bella, vanitosa, bugiarda, strafottente.
Adesso che non ci penso più ringrazio l’angelo custode
per avermi messo in quegli anni acerbi la mano sulla
testa e posto al riparo da quelle distruttive esperienze
garantendomi alla fine una solida realtà sentimentale. Il
sentimento definitivo ha il viso di Leslie Caron, la luce
d’argento di Vivien Leigh, l’educazione di Gene
Tierney, il carattere di Joan Fontaine, la simpatia di
Doris Day, la dolcezza di Jeanne Crain…
Talvolta mi ritrovo a pensare all’io narrante in Il
Giardino dei Finzi-Contini innamorato perso di Micòl e
alle parole del padre di lui: “Ti passerà, e molto più
presto di quanto tu non creda… Nella vita, se uno vuol
capire, capire sul serio come stanno le cose di questo
mondo, deve morire almeno una volta. E allora, dato
che la legge è questa, meglio morire da giovani, quando
uno ha ancora tanto tempo davanti a sé per tirarsi su e
risuscitare…” Tutti i giovani del mondo muoiono tante
volte ma tante volte rinascono. Le antiche fiamme
restano comunque sullo sfondo. Restano nella nebbia
della memoria, inattive, inespresse. Poi ascolti una
canzone legata a quel tempo, senti un profumo
dimenticato, guardi una foto ingiallita, nemmeno
accuratamente conservata, solo un frammento tra i tanti
che compongono il mosaico della tua vita, e i ricordi
affiorano dal pozzo del tempo. Ma raramente arrivano
con la forza e la bellezza del passato.
Qualche tempo fa, ascoltando musica, tracce
melodiche degli anni Trenta e Quaranta, come We’ll
meet again di Vera Lynn o Summertime di Billie
Holiday, nel fiume prodigioso di Internet ho trovato la
foto, e mi sono ricordato d’una diva dimenticata, bella
più che brava, sensuale, esotica: la straordinaria María
Montez che Hollywood soprannominò il “ciclone dei
Caraibi”, essendo nata nella repubblica dominicana,
120
secondogenita di dieci figli del viceconsole onorario di
Spagna. La foto la ritrae, distesa su cuscini orientali
accanto all’atletico Jon Hall, in una scena
dell’avventuroso film di Arthur Lubin Alì Babà e i
quaranta ladroni. Un film, girato nel 1944, che mi
rimase impresso per molti anni e che guidò i fantastici
giochi dei ragazzi di strada che utilizzavano il
linguaggio, le frasi magiche, l’Apriti Sesamo della
vicenda, e imitavano il galoppo dei cavalli dei quaranta
ladroni col rumore della bocca e su manici di scopa.
Aveva un nome lunghissimo e affascinante: Maria
Antonia Africa Gracia Vidal di Sacro Silas. Ma una
volta approdata alla Mecca del cinema cambiò in María
Montez in onore di Lola Montez, la ballerina che fu
l’amante di Ludwig I, capricciosa e insolente, e che una
sera, a Monaco, gettò dal balcone della sua villa
cioccolata calda e vino ghiacciato sulla folla urlante che
ne contestava la deleteria influenza sul sovrano.
Maria diede vita a un sogno colorato in un mondo
che cadeva a pezzi e moriva di fame: un sogno esotico e
conturbante, una vera e propria abbuffata kitsch di
harem e veli, di fughe avventurose sui tetti di Baghdad,
la metropoli del divertimento non ancora revisionata a
capitale d’estremismi religiosi e guerreschi, che Dolores
Gray, la star di Broadway, tutta vestita d’oro, con la sua
bella voce di contralto inneggiava: “Baghdad, Baghdad,
that irresistible town!”
La fonte ispiratrice era la favola di Shaharazad, la
bella e intelligente protagonista de Le mille e una notte,
ovviamente rivisitata e banalizzata dal mercato
americano secondo l’epopea western. In realtà, i
guerrieri dell’Islam erano cowboy a cavallo e le loro
donne pioniere velate che nulla chiedevano se non di
fare felici i loro uomini. Vista così l’avventura orientale
non poteva non far breccia nelle platee dello stesso
Oriente che, seppur non amasse il cinema per la sua
connaturata iconoclastia, vide in quel rapporto uomodonna un coranico sigillo. Ma si faceva torto alla grande
lezione della favola orientale, la lezione di Shaharazad,
121
la donna che combatte la verità sacra (la sharia) con
l’immaginazione.
Partendo da questa lezione Fatema Mernissi ha posto
un interrogativo inquietante: “Si può ipotizzare che
l’attuale violenza contro le donne, nel mondo
musulmano, sia dovuta al fatto che si attribuisce loro un
cervello funzionante e che in Occidente le cose siano
più tranquille perché le donne sono ritenute incapaci di
pensare se i loro imam hanno bisogno di ritualizzare
questa illusione?” Detta così sembra che le donne
occidentali, nella migliore delle ipotesi, siano ipocrite e
quelle orientali, nella peggiore delle ipotesi, siano
pavide. Il problema non è mettere Shaharazad in testa
alla classifica delle eroine occidentali ma di farne un
simbolo concreto di riscatto per le donne orientali che
ancora portano il burka e si fanno trattare da schiave.
María Montez era una diva a tutto tondo, non
distingueva la realtà dalla finzione, sul set come nella
vita privata dava numeri entusiasmanti. Girava con un
codazzo di giornalisti che ne registravano capricci e
umori. Con lei ci scappava sempre una notizia o una
foto da prima pagina. Se i direttori dei giornali erano a
corto di fatti e di idee mandavano i loro cronisti da lei,
la famosa piantagrane. “Andate a Beverly Hills”,
dicevano “e vedete che cosa sta facendo la Montez”.
Non li deluse nemmeno per la notizia estrema. Il 7
settembre 1951, a Parigi, le sorelle Ada e Teresita la
trovarono
affogata
nella
vasca
da
bagno,
presumibilmente colpita da un attacco cardiaco. Aveva
39 anni. Anche Lola Montez morì giovane, a 40 anni,
dopo una vita giocata sul filo del rasoio, amata e odiata
da principi e artisti di mezza Europa. Un nome, un
destino. Nella Repubblica dominicana fu indetto il lutto
nazionale e cambiato il nome del corso principale con
quello di María Montez. Per un decennio rivaleggiò con
le colleghe a stelle e strisce, girò film bellissimi e
improbabili, si sposò con l’attore francese Jean-Pierre
Aumont, ne ebbe una figlia, Tina Aumont, che conobbe
un discreto successo in Italia come attrice, e uscì di
122
scena in modo cinematografico perfetto, seppur lontano
dal sogno rassicurante che aveva regalato ai suoi
ammiratori.
123
CINQUE
Katharine Hepburn, Joan Crawford, Bette Davis
La mattina di domenica 2 giugno 1946 mio padre e
mia madre andarono a sostenere la Repubblica. Mio
padre sembrava un lord: pantaloni grigi, giacca beige
con righe a grandi intervalli leggermente più scure,
scarpe all’inglese con la suola spessa, camicia bianca,
cravatta marrone scuro. Il suo sarto si chiamava Billotta
e abitava in via De Felice. Mia madre indossava un
vestito di georgette blu con fiori di magnolia chiari e
scarpe bianche tipo Chanel, aperte in punta. Una
perfetta coppia cinematografica che andava a fare il suo
dovere dopo secoli di teste coronate e teste d’altro tipo.
Mio padre avrebbe dato punti a Vittorio De Sica (stessa
“magrezza stellare”, direbbe Daria Bignardi, seppure col
volto di James Mason) e mia madre non avrebbe
sfigurato di fronte a Lya Franca, la timida protagonista,
accanto a Vittorio De Sica, dell’incantevole film di
Mario Camerini Gli uomini, che mascalzoni… Dopo il
voto erano tornati subito a casa. Non erano
perfettamente tranquilli perché mio fratello aveva sei
mesi ed io e mia sorella mettevamo insieme appena
dieci anni. Per maggiore sicurezza mia madre, prima di
uscire, aveva legato con lo spago le maniglie della
porta-finestra che dava sul terrazzo. Ma noi eravamo
stati buoni e attenti. Mi ricordo ancora la carezza di
papà. Mia madre ci aveva aiutato a metterci i vestiti
della festa, pettinarci e con mio fratello nella carrozzina
eravamo andati tutti e cinque a passeggiare al giardino
Bellini dove c’eravamo fatti immortalare con sullo
sfondo la vasca, i cigni (che a Catania chiamano
papere), l’orologio e la data. Quel ricordo oggi sta
appeso nel mio studio e mi parla con tenerezza mentre
tento di ordinare la mente imprecisa. La storica giornata
si concluse con un film: Scandalo a Filadelfia di
George Cukor con Katharine Hepburn, Cary Grant e
124
James Stewart, capolavoro della commedia sofisticata
che più tardi avrebbe avuto un remake con Alta società.
Noi bambini quel giorno fummo depositati dagli zii.
Katharine Hepburn, l’attrice più anticonformista di
Hollywood, ha attraversato l’intero Novecento con tutto
il fiato, la classe, l’intelligenza delle persone speciali: a
volte opponendosi alle dure contraddizioni e violenze
dell’epoca a volte incarnandone i vertiginosi progressi.
Lei cresceva e l’Europa veniva squassata dalla prima
guerra mondiale, lei recitava al college e il fascismo
prima e il nazismo dopo violentavano il vecchio
continente, lei conquistava i primi Oscar e la seconda
guerra mondiale annichiliva il mondo intero, lei
diventava un’icona del femminismo americano e il suo
Paese si lasciava risucchiare in cento guerre imperiali
inutili e dannose, lei raggiungeva lo splendore del mito
e il comunismo crollava col muro a Berlino. Nello
stesso tempo, mentre lei diventava l’antidiva per
eccellenza e la leggenda del cinema internazionale, le
società evolute producevano di più, debellavano le
malattie e rendevano la vita meno faticosa.
Era nata poco più di un secolo fa, nel 1907, a
Hartford, nel Connecticut. Il padre era uno dei più
famosi urologi d’America e discendeva da una famiglia
scozzese che vantava tra gli antenati un James Hepburn
conte di Bothwal, amante della regina Maria Stuarda. La
madre, cugina di un ambasciatore, era stata in gioventù
un’accesa suffragetta e amica intima di Margaret
Sanger, uno dei personaggi più controversi della storia
del femminismo americano per le sue teorie sul
controllo delle nascite che rasentavano l’eugenetica (e
tuttavia la rivista Time una volta la mise nel mazzo dei
migliori cento leader e rivoluzionari del Novecento).
Ironia della sorte, nel 1936 Katharine, in un film di John
Ford, avrebbe interpretato il ruolo della regina che era
stata l’amante del suo antenato paterno. Il suo
coefficiente sociale era dunque altissimo, se solo lo
confrontiamo con quello di Joan Crawford, per esempio,
che era figlia di una lavandaia, oppure con quello di
125
Lana Turner, il cui padre lavorava nelle miniere
d’argento di Wallace e aveva il vizio delle carte e del
bere. Le si poteva accostare solo Anne Baxter, nipote
del grande architetto Frank Lloyd Wright, oppure Gloria
Grahame, il cui padre discendeva da Edoardo III e la
madre era imparentata coi sovrani di Scozia.
Per una curiosa astrale premonizione il 1907 è l’anno
in cui William Selig, un artista di vaudeville dell’East
Coast, folgorato sulla via dei fratelli Lumière, e che in
breve tempo sarà imitato da David Griffith e Cecil De
Mille, scoprì Hollywood (Bosco di agrifoglio) come
luogo adatto per girarvi film: il clima era eccellente, il
paesaggio straordinario e i terreni, abitati da conigli,
scoiattoli e coyotes, logicamente costavano pochissimo.
Il 1907 è l’anno di tante cose. In Finlandia, primo paese
al mondo, viene riconosciuto alle donne il diritto di
voto, in Italia Maria Montessori apre la sua prima scuola
e Pio X dichiara guerra al modernismo. Ma è anche
l’anno in cui, nel suo piccolo, nasce un’altra attrice che
contenderà alla Hepburn se non il primato artistico
quello della longevità: Argentina Brunetti, morta a
Roma a 98 anni. Era figlia della bravissima Mimì
Aguglia, che lavorò con le compagnie di Nino
Martoglio e Giovanni Grasso e fu soprannominata la
Duse siciliana. Argentina, bella e aristocratica,
interpretò una sessantina di film. I più famosi, nei quali
ricoprì ruoli di comprimaria, sono La vita è
meravigliosa di Frank Capra e Gilda con Rita Hayworth
e Glenn Ford.
Katharine aveva tutto, tranne la precisione del
destino. Il nonno materno morì suicida, uno zio paterno
si gettò dalla finestra e un prozio si sparò un colpo di
pistola, finché un giorno il fratello Tom s’impiccò senza
apparente motivo nella soffitta di casa, a 15 anni.
“Sapeva che sarebbe stata sua sorella a trovarne il
cadavere” sostiene Christopher Andersen nella biografia
scritta per i novant’anni dell’attrice. La tragedia peserà
per sempre sulla Hepburn, e forse il tremolio del labbro,
che ne contraddistinse a un tempo la fragilità e la forza
126
espressiva, l’assalì proprio davanti al corpo senza vita
dell’amato fratello.
L’anno del suo ingresso nel mondo cinico e
abbagliante di Hollywood, dopo alcune ottime
prestazioni sui palcoscenici di Broadway, è il 1932.
L’anno della vittoria del democratico Franklin Delano
Roosevelt alla presidenza degli Stati Uniti e, per
contrappasso, del dittatore Salazar in Portogallo che al
potere resterà abbarbicato per 35 lunghissimi inverni.
Katharine entra dalla porta principale grazie al raffinato
regista George Cukor che la sceglie e la dirige in Febbre
d’amore accanto all’inarrivabile e per questo molto
presuntuoso John Barrymore. Sul set i rapporti tra i due
non furono dei più facili. Verso la fine delle riprese la
giovane Hepburn sbottò: “Non so se reciterò ancora con
lei”. E il grande John, indiscusso profilo da medaglia,
attore romantico per eccellenza, alcolista e sfrenato
narcisista, replicò gelido: “Perché, l’ha mai fatto?”
Tuttavia, in un libro dedicato alla diva, Alvin Marill
scriverà: “L’interpretazione di Barrymore è brillante ma
il film è dominato dalla luminosa personalità di
Katharine Hepburn”. Il film racconta la storia di una
ragazza che vive nell’angoscia di essere fisicamente
tarata nel momento in cui apprende che il padre è
rinchiuso in una clinica psichiatrica. Lei, che aveva del
suo in quella vicenda cinematografica, considerato che
parte della famiglia era stata segnata dalla follia, mise
nel ruolo un’autenticità che nessuna attrice avrebbe
potuto raggiungere. Da piccola era stata talmente
ossessionata dalla paura di perdere la ragione che il set
fu una sorta di doloroso recupero del passato, ma riuscì
a guarirne dopo l’accoglienza del pubblico e, cosa che
non guasta, i 1.500 dollari la settimana che guadagnò
durante le riprese, a fronte degli ottanta dollari che le
davano gli impresari a teatro.
Un film con la Hepburn fu il degno coronamento di
quel 2 giugno, festoso e senza più paura, che vedeva le
donne votare per la prima volta in Italia. La Turchia,
l’arretrata Turchia, il Paese che in Italia evocava scenari
127
catastrofici al grido di “mamma li turchi!”, quel diritto
aveva concesso nel 1932 per mano del suo grande
presidente, Atatürk. Katharine, con il suo abbigliamento
non precisamente femminile e l’atteggiamento ribelle e
indipendente fu una bandiera dell’emancipazione delle
donne in America e nel mondo. Non era il tipo alla Gail
Russell per intenderci, l’attrice che finì alcolizzata per
timidezza e che a soli 37 anni fu trovata morta nel suo
appartamento, stroncata da una sbornia. E neppure alla
Vera Ellen, la cantante ballerina, minuta e sorridente,
che per tre anni fu fatta passare come la fidanzata di
Rock Hudson, omosessuale sotto stretta copertura. No.
Kate Hepburn aveva la coscienza e la dignità della sua
appartenenza, senza svenevolezze ma neppure le
durezze di una Bette Davis.
La prima volta che incontrò Spencer Tracy, l’uomo
della sua vita, lo squadrò dalla testa ai piedi e gli disse
con disprezzo: “Troppo basso”. Il vecchio Spencer la
guardò a sua volta e rispose: “Se sarai brava ti porterò
alla mia altezza”. Parlava di centimetri artistici
naturalmente. La battuta servì a smontare l’alterigia
dell’attrice e a farla innamorare di un uomo che si
sarebbe rivelato depresso, infedele e alcolizzato, e che
tuttavia lei avrebbe amato per 25 anni, fino alla morte di
lui. Prima di incontrarla, Spencer Tracy aveva avuto
relazioni con Joan Crawford, Judy Garland e Loretta
Young. Sempre nella biografia, Andersen racconta che
l’attore si mostrò sensibile anche al fascino delle sue
colleghe, come Ingrid Bergman e Grace Kelly, e che la
Hepburn fu particolarmente ferita per il tradimento con
la Bergman. Fedele al vecchio detto di Oscar Wilde,
Spencer sapeva resistere a tutto tranne che alle
tentazioni. Insomma, cercava di guadagnare il tempo
perduto da giovane quando le donne non se lo filavano
per niente perché era d’una povertà assoluta. Per sua
stessa ammissione aveva attraversato periodi in cui il
fondo dei suoi pantaloni era così sottile che poteva
sedersi su un nichelino e indovinare se era testa o croce.
Raggiunta la ricchezza guadagnò la follia. A volte si
128
chiudeva in una stanza d’albergo, si sdraiava nella vasca
da bagno e dava fondo per giorni agli alcolici che si era
portato appresso. Nel momento in cui la crisi si
aggravava, Kate lo legava al letto e lo liberava solo
quando era sicura che non potesse più farsi del male. Fu
meglio e più di una compagna, eppure Spencer Tracy,
ipocritamente cattolico, non ebbe mai il coraggio di
lasciare la moglie per lei; né lo stesso coraggio trovò
John Ford, sposato, che con la Hepburn aveva avuto una
lunga relazione.
A quei tempi gli alcolizzati erano chiamati ubriaconi.
Me li ricordo affollare le putie, che erano botteghe del
vino trasformate a poco a poco in trattorie minime dove
col mezzo litro venivano di norma serviti piatti di
legumi, polpette al sugo, uova sode. In questi miseri
locali gli avventori arrivavano a gambe salde e ne
uscivano traballanti, talvolta venivano “prelevati” dalle
mogli con rosari d’urla e lamentazioni. Ma il rientro, per
solito, si concludeva a suon di botte che per alcuni
giorni rifinivano le facce delle povere donne già
ammaccate dalla fatica dei lavori domestici e costrette
spesso a subire il “debito coniugale”, una sorta di tacito
diritto dei mariti a pretendere da loro rapporti sessuali
controvoglia. Insomma, oggi chiameremmo quel
“debito” semplicemente stupro. Come meravigliarsi,
quindi, se a Kabul l’imbelle Karzai legittima i mariti a
stuprare le mogli? Nelle putie si giocava a carte, si
discuteva di calcio, di femmine e ci si lasciava andare al
dolce inganno del rimpianto, del come si era e del come
si sognava di essere, del denaro che si contava in
moneta e raramente in cartamoneta, dei figli che
soffocavano l’esistenza e delle mogli che erano
diventate troppo vecchie per essere ancora desiderabili.
E così annegavano i dispiaceri nel vino, normalmente
guasto o annacquato, e se ne tornavano a casa cantando
e limando gli angoli dei palazzi.
Nei fumi dell’alcol ridavano fiato alle storie poco
prima raccontate, tra un bicchiere e l’altro. Le più
appassionanti erano quelle su Angelo Grasso… Una
129
volta la moglie del puparo, che aveva mangiato ricotta
in abbondanza, si trovò a dare voce alla bella Angelica
intercalando le battute con fastidiosi e comici
singhiozzi. Al che il marito, come racconta Emilio
Greco nella sua autobiografia, per salvare lo spettacolo
fece dire al pupo Orlando, che stava manovrando,
questa battuta: “Bottana di bordello, se mangi più ricotta
ti spacco ‘a fissa in quattro comu n’accia” (la fissa, in
Sicilia, è l’organo genitale femminile e l’accia è il
sedano). Il pubblico andò in delirio e cominciò a
scagliare contro i due burattini di legno, a mo’ di
gradimento, sedani e finocchi che di solito masticavano
e sputavano rumorosamente durante lo spettacolo.
Mondo magico, misterioso, quello dei pupi; il mondo
del commendatore Insanguine che scolpiva le mani a
pugno dei suoi pupi, dame o guerrieri che fossero, nello
stesso modo: le mani d’una fanciulla che l’aveva
folgorato d’amore tanti anni prima.
Kate Hepburn è morta il 29 giugno 2003 all’età di
novantasei anni, dopo avere collezionato quattro Oscar e
dodici nominations, sempre come migliore attrice
protagonista, ed essere stata l’affascinante rompiballe
del cinema internazionale, colei che ruppe il cliché delle
donne fatali e vaporose, che non si fece mai mettere la
saliva sul naso (’a sputazza ’nto nasu) dagli uomini,
grigi o potenti che fossero.
Il 2003 segna anche la scomparsa di Gregory Peck,
che, giovanissimo, recitò con lei in Piccole donne di
Cukor, e di altri grandi attori italiani come Alberto Sordi
e Massimo Girotti. Ma quell’anno segna anche la
scoperta di un pianeta fuori dal sistema solare e che
dista dalla Terra cinquemila anni luce. È il pianeta più
lontano che l’uomo abbia mai individuato nello spazio.
Solo pensando all’immortalità e alla bellezza di
Katharine è possibile non smarrirsi di fronte
all’insondabile profondità dell’universo e coltivare le
poche illusioni necessarie.
Nel 1998 Kate si ammalò gravemente. Ricoverata in
ospedale, per settimane si temette per la sua vita.
130
Preparai il “coccodrillo”, l’articolo che sarebbe servito
in caso di decesso. Il pezzo le portò bene perché rimase
congelato in redazione per otto anni.
Nella vita ci vuole fortuna. Lo dice spesso mia madre
di fronte alle difficoltà dell’esistenza. Ma se col
pensiero torna indietro negli anni il suo unico cruccio è
quello di avere perduto il marito troppo presto. Poi si
consola con la “riuscita” dei figli, anche se mia sorella
non è dello stesso avviso. Lei voleva fare la ballerina. A
16 anni, dopo avere dato prove eccellenti nella
ginnastica artistica, sotto la direzione del professore
Montalto, entrò nella scuola di ballo di Franca
Bartolomei, che teneva le lezioni dietro il cine-teatro
Metropolitan. Dopo tre mesi aveva sbaragliato le allieve
di tutti i corsi. Era un fenomeno. Ancora oggi conserva
la figura di Kate e il viso di Audrey: le due grandi
Hepburn del cinema americano. Una primavera di non
so quale anno, l’accompagnai allo stadio Cibali per
assistere ai campionati studenteschi. Alla fine della
manifestazione scese in campo e tentò qualche
sgambata. Al primo tentativo del salto in lungo, che non
aveva mai fatto, stabilì il record regionale femminile. La
professoressa Rizzo cercò di non farsela scappare e di
convincerla a abbandonare la ginnastica per l’atletica.
Ne nacque quasi un incidente diplomatico con Montalto.
Ma mia sorella scelse la danza. A diciotto anni non
aveva più niente da imparare, allora la Bartolomei, che
aveva un’altra scuola a Roma, la invitò a perfezionarsi
nella capitale. Doveva trasferirsi. Mio padre, spaventato,
disse no; mia madre, ancora più spaventata, disse no.
Chissà come sarebbe cambiata la sua vita se i miei
genitori avessero avuto meno paura. C’è un bel film del
1977, di Herbert Ross, Due vite, una svolta che in
qualche modo tenta una risposta. È la storia di due
amiche, Anne Bancroft e Shirley MacLaine, che
s’incontrano dopo tanti anni: la prima è diventata una
stella della danza internazionale, l’altra, pur essendo
stata in gioventù anche lei una bravissima ballerina, è
131
diventata invece una madre di famiglia. Parlando delle
loro vite, tuttavia, ognuna rimpiange quello che non ha:
la Bancroft la famiglia, la MacLaine la danza.
Il 1977 è l’anno della scomparsa di Lucille LeSueur,
ottima ballerina anche lei (soprattutto di charleston) e
poi grande attrice col nome di Joan Crawford. Quello
che Katharine aveva per educazione e cultura familiari,
Joan lo conquistò con tenace volontà. Era di umili
origini, sua madre lavorava in una lavanderia, e per
questo fece di tutto per dimenticarsele. Cominciò a
corteggiare Douglas Fairbanks jr. e ben presto riuscì a
sposarlo contro il parere del vecchio Fairbanks e di sua
moglie Mary Pickford che per la verità a sedici anni era
scappata con Owen Moore, un attore spiantato e
ubriacone. Ragazzina ribelle, non ancora convertita al
conformismo della ricchezza, Mary aveva avuto una
sola passione: quella per la sua mula che chiamava
Maddalena e giudicava l’essere più intelligente del
mondo, naturalmente dopo di lei. Douglas e Mary erano
così popolari che nessuno si occupava di loro. Erano
personaggi troppo per bene, troppo catalogati e ben
serviti perché i giornali ne tirassero fuori storie
appetibili o trasgressive. Abitavano in cima alle colline
di Beverly, in una lussuosa dimora in stile spagnolo,
battezzata Pick-Fair, che tutti ambivano frequentare
perché significava promozione sociale. Nel maggio del
1928 vi era stato ricevuto il principe Giorgio
d’Inghilterra con gli alti ufficiali dell’incrociatore
Durban. Fu una festa memorabile. Per l’occasione, la
piccola grande Mary, che sullo schermo interpretava
ruoli di mendicante, sfoggiò una collana con una grande
croce tempestata di smeraldi e un anello sormontato da
un impressionante smeraldo. I gioielli provenivano dal
tesoro degli zar.
La Crawford fu un osso duro perché era ambiziosa e
scaltra, una donna che in poco tempo riuscì a migliorare
il proprio stile di vita, la recitazione legnosa, a costruirsi
un nuovo personaggio avendo cura di sottolineare le
132
labbra carnose con abbondante rossetto, a truccare gli
splendidi occhi in modo da farli risultare ancora più
grandi, a rendere il resto del volto simile a una maschera
classica. Così combinata, appoggiata e determinata,
Joan Crawford andò alla conquista di Hollywood. Del
resto, era la stessa strada intrapresa anni prima dalla
suocera che era figlia di un commesso di bordo prima di
diventare una delle donne più famose e ricche
d’America.
Una carriera prestigiosa quella della Crawford che
mostrò di possedere, accanto alla seconda parte del
cognome, il carattere forte della Pickford e la stessa
ambizione. Film memorabili i suoi, a parte un Oscar,
due nominations e quattro mariti importanti. Dopo
Fairbanks jr. sposò l’attore Franchot Tone (molto
popolare negli anni Trenta e Quaranta e che
personalmente ricordo nel bel film di Frank Lloyd La
tragedia del Bounty accanto a Charles Laughton e Clark
Gable), poi l’altro attore americano Philip Terry e infine
Alfred Steel, dirigente della Pepsi Cola nel cui consiglio
di amministrazione la diva entrerà dopo la morte del
marito. Non ebbe figli ma ne adottò quattro, un maschio
e tre femmine, tra cui Christine che scriverà uno spietato
libro di memorie, dal titolo Mammina cara, che le
costerà l’eredità. Il libro, da cui sarà tratto un film con
Faye Dunaway, descrive la Crawford come una donna
nevrotica, alcolizzata, a volte isterica a volte paranoica,
che scatena sui figli le sue collere al limite del sadismo.
Nel 1932 girò Grand Hotel di Edmund Goulding con
un cast di attori che avrebbe intimorito chiunque: Greta
Garbo, John e Lionel Barrymore, Lewis Stone, Wallace
Beery. Il primo giorno delle riprese la divina Greta la
guardò con attenzione, incuriosita. Il secondo giorno
avvertì come un campanello d’allarme, flebile ma
comunque tollerabile. Il terzo giorno cominciò a
preoccuparsi. Il quarto le tolse il saluto. La grande
Garbo aveva
capito che
quella
ragazzetta
apparentemente innocua sarebbe passata sul cadavere
della madre pur di arrivare al successo. “L’amore è un
133
fuoco”, diceva spesso la Crawford “ma non saprai mai
se scalderà il tuo cuore o brucerà la tua casa”. Violenta,
eccessiva, arrampicatrice sociale, non conosceva mezze
misure, ma possedeva un talento smisurato che la
porterà all’Oscar nel 1945. Il film è Il romanzo di
Mildred, di Michael Curtiz, in cui interpreta la parte di
una madre ambiziosa ma vulnerabile. Una delle figlie, la
snob e violenta Veda, è la cantante Ann Blyth che per
questo ruolo guadagnerà una nomination.
Sarebbe stata una perfetta “belva friulana” se il
cinema si fosse interessato alla terribile storia di Rina
Fort, la donna che per amore sterminò a Milano la
famiglia del suo amante, Giuseppe Ricciardi, un
commerciante catanese di stoffe “magro, alto, olivastro,
rugoso e intrallazzista”, come lo descrive Salvatore
Nicolosi nel suo bel libro Uno splendido ventennio (il
ventennio non è quello fascista ma quello che Catania
visse tra il 1944 e il 1964). La famiglia di Ricciardi
aveva lasciato da poco Catania e s’era trasferita nella
capitale lombarda. Rina Fort, abbandonata dall’amante,
in un raptus omicida uccide a colpi di spranga di ferro
Franca Pappalardo e i suoi tre figli, Giovanni, Pinuccia
e Antoniuccio, rispettivamente di sette, di cinque anni e
di otto mesi. Una settimana dopo la strage, incalzata
dagli interrogatori della polizia, pronuncia, come
un’attrice tragica, queste parole: “Alle vostre metodiche
e continue domande, sento il dovere di fronte a Dio, per
la pace che accoglierà nelle tombe le salme degli
innocenti e della madre dei bimbi, vi dico che, spinta da
una morbosa passione e da un folle amore, ho ucciso”.
Poi scoppia in singhiozzi ed esclama: “Non posso
proseguire, vedo troppo sangue davanti ai miei occhi”.
Alla stazione di Catania le salme furono accolte da una
folla commossa e furente. “Se piangono i milanesi”,
gridò una donna “noi di Catania che cosa dobbiamo
fare?” Come ricorda Nicolosi, sul vagone piombato
stava attaccato un foglio con su scritto: “Quattro salme”.
Sotto, a matita copiativa, era stato aggiunto:
“Assassinate a Milano dalla Ford”.
134
Nel momento in cui cominciai a rendermi conto della
dimensione della tragedia, di questa come d’altre, e
compresi che la vita non era la favola più o meno bella
che mi avevano insegnato il cinema e i libri della Salani,
divorati al ritmo di quasi uno al giorno, di quel brutale
eccidio mi restò, in modo irrazionale e fanciullesco, la
distribuzione degli anni e dei sessi dei tre bambini
uccisi: il numero e la distanza d’età era pressappoco la
stessa tra me e i miei fratelli. Questo per dire che il male
non vive appartato, ma può riguardare chiunque, può di
colpo distruggere, per altre e impensabili vie, la famiglia
più fortunata, quella comunità d’affetti e di gioia così
mirabilmente dipinta in un quadro di Percy Tarrant,
Living for school.
“Play the guitar, play it again, my Johnny/ maybe
you’re cold, but you’re so warm inside/ I was always a
fool for my Johnny/ for the one they call Johnny guitar.”
La struggente canzone di Victor Young e Peggy Lee
traccia il successo dell’insolito western di Nicholas Ray,
il regista “ambidestro” o bisessuale che dir si voglia, e
consolida la fama e la bravura di Joan Crawford. Ma in
Johnny Guitar l’attrice ha acquisito un’altra faccia,
meno femminile e più cavallina, niente a che vedere con
la bella e disinvolta stenografa Flaemmchen, che si
lascia corteggiare dal ladro John Barrymore, o con
l’intraprendente giornalista Bonnie Jordan di La via del
male. Nel mio ricordo la Crawford resta un’interprete
eccezionale, vigorosa, combattente nella vita e nello
schermo, resta come amore di celluloide solo nella parte
che ebbe in Grand Hotel, più brava persino della Garbo,
ma dopo diventa insopportabile perché l’interna
aggressività pare raggiungere con l’età le fattezze del
viso, irrigidendole. La vecchia Joan sarebbe stata
perfetta anche nel ruolo di Betsy Trotwood, l’eccentrica
zia di David Copperfield che nell’omonimo film di
George Cukor è interpretata da Edna May Oliver.
L’ultimo vero film la Crawford lo interpreta accanto alla
rivale Bette Davis, Che fine ha fatto Baby Jane?, del
1962, di Robert Aldrich. Magistrali davvero le due
135
attrici, l’una nella parte d’una paralitica l’altra in quella
della sorella vessatrice.
Bette Davis odiava Joan Crawford. Forse perché vi si
vedeva riflessa: stesso carattere forte e ribelle, stessa
bravura, stesso destino “estetico”. La odiava dello stesso
sentimento che Mark Twain provò per la vedova di
Thomas Bailey Aldrich: “Non credo che imparerei mai
a gradirla, a meno di trovarmi con lei in mare su una
zattera senza altre provviste”. Da giovane, era
abbastanza carina, piena di fascino e di personalità. Con
gli anni però quei suoi grandi occhi diventarono bovini,
il viso le si appesantì e la bocca si atteggiò a perenne
disgusto. Dopo avere studiato recitazione con Katharine
Hepburn e Lucille Ball, ed essersi esibita a Broadway in
due spettacoli, tentò la carta del cinema. Il 3 dicembre
1930 giunse alla stazione di Los Angeles ma non trovò
nessun rappresentante dell’Universal a riceverla. In
verità, qualcuno era andato alla stazione ma se n’era
tornato deluso e ai dirigenti della casa cinematografica
aveva detto di “non avere visto nessuna donna che
assomigliasse a un’attrice”. Le affidarono film di poco
conto che non riscossero alcun successo al botteghino.
Dopo due anni l’Universal stracciò il contratto. Samuel
Goldwyn, il potente produttore della M.G.M. che aveva
rifiutato di scritturarla, in tempi non sospetti aveva
detto: “Troppo brutta per recitare”.
Mentre stava preparando i bagagli per tornarsene a
New York ricevette la telefonata di Murray Kinnell, un
attore della Warner Brothers che aveva lavorato con lei
in The menace e che la riteneva adatta per un film che
lui stesso doveva interpretare: The man who played
God. Firmandole il contratto, David Warner le disse:
“Hai il fascino di Stanlio e Ollio messi assieme, ma ti
prendo per il tuo talento”. Non si conosce la risposta
dell’attrice ma si sa che per anni diede filo da torcere al
produttore e agli attori che recitarono con lei. Non ci
pensò due volte a prendere di petto Humphrey Bogart
che puzzava di alcol già dal mattino e di rifiutare il
136
ruolo di Rossella O’Hara per non recitare accanto a
Errol Flynn destinato in un primo momento alla parte di
Rhett. Pentitasi amaramente dell’avventata decisione si
fece costruire su misura il ruolo d’una testarda donna
del Sud nel film La figlia del vento di William Wyler
che le valse il secondo Oscar. Il primo l’aveva vinto nel
1936 con Paura d’amare di Alfred Green. Una donna
così, meglio perderla che trovarla. L’attore e
commediografo Sasha Guitry avrebbe detto: “Se uno ti
porta via la moglie (quella moglie!) la migliore vendetta
è lasciargliela”. Il 1939 è il suo anno magico. Infila
quattro film di ottima caratura: Il grande amore, Il
conquistatore del Messico, Il conte di Essex e,
soprattutto, Tramonto per la cui interpretazione il
magazine Time scrisse: “Se fosse un’automobile sarebbe
una Rolls-Royce con tutti i migliori accessori”.
Il 1962 è l’anno della riconciliazione con la vecchia
nemica Joan Crawford. Erano stati anni oscuri, dopo i
successi degli anni Trenta e Quaranta, tanto che a un
certo punto decise di mettere un annuncio su una rivista
cinematografica: “Madre di tre bambini di dieci, undici
e quindici anni, divorziata, americana, trent’anni di
esperienza come attrice cinematografica, versatile e più
affabile di quanto si dica, cerca impiego stabile a
Hollywood”. Ma l’arco splendente della sua carriera
stava ormai raggiungendo la punta più bassa, laddove il
sole si perde nella luce invisibile che l’aspetta. Un
giorno si guardò allo specchio e improvvisamente capì
di essere diventata vecchia, triste e sola: quattro
matrimoni in fumo, un aborto per non interrompere le
riprese di un film, una figlia che le si rivolta contro,
un’osteomielite, un tumore al seno, un ictus e un infarto.
Bette Davis è morta a Parigi nel 1989. Pochi giorni
prima, al festival di San Sebastiano, aveva ritirato un
premio alla carriera.
Nel 1952 mio nonno Carmelo si spense dopo anni di
malattia e disagi. Le piccole cose che ricordo di
quest’uomo, che parlava poco e ascoltava molto, le cose
137
che mi appartengono, sono la penna stilografica, che ho
ricordato, e La capanna dello zio Tom, il romanzo di
Harriet Beecher Stowe che La Sicilia pubblicò come
feuilleton in prima pagina e che lui raccolse, puntata
dopo puntata, e rilegò personalmente. Dopo più di un
secolo e mezzo dai fatti descritti dalla Stowe la Capanna
diventerà monumento dello Stato del Maryland. Il
modesto edificio, con l’adiacente villa in stile coloniale,
che si trova a Rockville, è stato acquistato per un
milione di dollari dalle autorità statali. Nel celeberrimo
tugurio visse il protagonista del romanzo, Joshua
Henson, che per trent’anni era stato schiavo d’una
famiglia di agricoltori prima di essere venduto e
mandato nel Kentucky. Incapace di comprarsi la libertà
fuggì in Canada con moglie e figli.
Quel giorno di lutto ci fu proibito a noi ragazzi di
accompagnare il feretro ai Tre Cancelli. “No, i bambini
s’impressionano”, disse mio padre. I bambini eravamo
io, mia sorella, mio fratello e alcuni cugini. Fu zio
Michele, il ferroviere, a tenerci per il tempo necessario a
casa sua. Ci fece mangiare e riposare. Chiusi gli occhi e
feci un sogno guidato. Nonno Carmelo lo sognai con la
faccia di Spencer Tracy in Joe il pilota di Victor
Fleming. Il film, del 1943, racconta la storia di un pilota
che muore in combattimento e che torna sulla terra,
invisibile agli altri ma non all’amata compagna e al
pubblico. Immaginai il nonno che mi sorrideva, mi
prendeva per mano e mi accompagnava a fare una
passeggiata in un campo d’erbe alte. La sera fummo
invitati a casa d’una famiglia di piccoli costruttori,
molto amici, ma mia madre rimase con le sorelle e i
fratelli a raccontarsi il dolore. Fummo rimpinzati di
dolci e soffocati d’attenzioni. Al rientro, nella non
grande casa di via Giuseppe Verdi, la mamma aveva gli
occhi stanchi. La notte non riuscii ad addormentarmi.
Vidi il nonno che passeggiava instancabile e mi diceva:
“Sono qua, sono tornato, non ti spaventare”.
Il cimitero è rientrato nella mia vita, più volte.
L’ultima ne fui frastornato. Non è più un luogo di
138
preghiera e di raccoglimento, è un’appendice
agghiacciante della città: file di auto come nelle ore di
punta, intasamenti, clacson, nervosismo, imprecazioni.
Una signora, giustamente scandalizzata, non riuscì a
tenersi il commento. “Un cimitero perso!”
Il coraggio, sostiene Don Abbondio nei Promessi
sposi, uno non se lo può dare. Eppure, il coraggio è
frutto di educazione, di parole e di silenzi “che parlano”,
segnano e scavano, ed è anche un clima che si vive e si
respira. Attraversare corridoi oscuri e stare nel buio
come in apnea, con il cuore che ti sta per scoppiare, è un
modo di darsi coraggio, certo in maniera empirica ed
elementare, ma in qualche modo con un suo
insegnamento. Il coraggio è quello di andare contro
corrente, di essere soli, di patire le conseguenze
dell’esclusione dal gruppo. Il coraggio di restare fedele
a un’idea, anche sbagliata.
Il coraggio di Enzo Trantino, per esempio, avvocato
vulcanico, ex parlamentare di Alleanza nazionale e
formidabile battutista. Una volta, intervenendo a una
lectio sul Don Chisciotte di Cervantes, tenuta nella
cappella Bonaiuto dall’attore e regista Michele Branca,
figlio di Orlando Branca che del mondo delle Tv locali è
un esperto, cominciò a parlare da par suo restando però
seduto. A un certo punto uno del pubblico, anche per
ascoltare meglio l’intervento, esclamò: “Si alzi, per
favore!” Al che Enzo Trantino, che non si fa prendere in
castagna neanche dal Padreterno, continuando a stare
seduto replicò: “Ma io sono alzato!” Lui non è stato mai
fascista, lui era monarchico, una persona d’altri tempi,
che accarezzava i ricordi, che viveva nel passato
romantico come fece Joseph Roth che per tutta la vita
rimpianse l’Austria Felix e il suo re, Cecco Peppe. Molti
della sua generazione si fecero corrompere dal potere,
dalle prebende, dai ministeri, ma lui è rimasto fedele ai
suoi ideali. Più volte gli rimproverai quella “prigionia” e
scherzando gli dissi che se fosse diventato
democristiano ci avrebbe guadagnato in onori e potere.
Ma davanti alla porta del suo destino sta un inflessibile
139
guardiano: la Coerenza.
Sentimento difficile la coerenza. E tuttavia gli amici
della mia generazione, anche quelli che non frequento o
non sento da anni ma che al primo squillo di telefono
sono pronti a rinnovare l’amicizia intangibile di sempre,
non l’hanno perduta la coerenza, che è innanzitutto
amore per la lotta e per l’onestà, e che magari non si
traduce, come in Enzo Trantino, in uno specifico assetto
ideologico ma la cui componente essenziale è la
capacità di indignarsi. Sempre e comunque.
Noi, della generazione postbellica, cresciuti in una
sorta di pastorale siciliana, siamo stati fortunati perché
le nostre esperienze, spesso dolorose, non ci hanno
risucchiato nella disperazione d’una contro-pastorale
che è quella, mi pare, che ha accompagnato la
generazione degli anni Settanta, a credere almeno alle
confessioni del cantante e attore Paride Acacia che nella
sua autobiografia, I sogni finiscono all’imbrunire,
scrive: “Nessuna sacra passione ha benedetto la nostra
gioventù, nessun fuoco vivo ha bruciato i nostri anni
migliori. Abbiamo vissuto anestetizzati e sterilizzati
nella nostra vita ordinaria, scortati dal regime delle
nostre madri… mai un pianto per un sogno infranto, mai
un dubbio, nessuna via Crucis, nessun errare nel deserto
per redimersi e realizzarsi… abbiamo spiato la vita
attraverso le finestre con le persiane rigorosamente
socchiuse, in penombra, senza mai affacciarci”.
Il lucido, dolente pessimismo di Paride Acacia segna
una distanza vera tra passato remoto e passato prossimo,
tra consumo e pre-consumo, tra Gregory Peck, per
buttarla in celluloide, e Paul Newman, tra L’uomo dal
vestito grigio e La gatta sul tetto che scotta. “Le nostre
mani” scrive ancora l’artista siciliano, nato a Messina
nel 1971, “non hanno impugnato né molotov, né libretti
rossi ma stupidi cocktail e chitarre scordate. Ci siamo
limitati a glorificare un passato che le leggende
narravano essere stato mitico, ed abbiamo vissuto in un
eterno presente sterile”.
Enzo Trantino è un uomo di dubbi. Sta qui,
140
probabilmente, la differenza tra la generazione degli
anni Quaranta-Cinquanta e quella di Paride Acacia. Non
a caso un bel libro di dodici racconti di Trantino
s’intitola Certi del dubbio. “Toglieteci tutto” scrive
l’autore nella prefazione, “ma non il dubbio, che in
Francia è elegante indecisione mentre da noi è
condimento obbligato del pane e del tempo”. In altre
parole, se in Cartesio il dubbio è metodologico, nel
senso che non ha un valore assoluto in sé ma serve a
raggiungere l’evidenza, nei siciliani il dubbio è
strutturale, la via maestra all’acquisizione del dubbio
stesso. I dodici racconti descrivono in qualche modo
un’autobiografia, non solo quella dell’autore ma anche
di molti siciliani, catanesi, ex giovani leoni che sono
cresciuti nella certezza del dubbio non nella certezza
della verità. Di verità rivelate ce n’erano state troppe
prima della guerra, gridate dai balconi e dai pulpiti di un
Paese gloriosamente immaturo e credulone.
Della categoria dei dubbiosi e dei coerenti è
Giuseppe Gennaro, ex presidente dell’Associazione
nazionale magistrati, col quale da giovane misuravo i
passi perduti di corso Italia, parlando di filosofia, di
futuro, di ragazze… “parlare” di ragazze, perché la vita
di provincia, come sostiene Balzac nelle Illusioni
perdute, è stranamente contraria alle soddisfazioni
dell’amore e favorisce invece i dibattiti intellettuali
della passione. Anche lui è rimasto legato alla
luminosità della giovinezza, all’incanto della parlata,
alla famiglia come principio e sentimento, ai libri e allo
sport, alla politica non politicante ma strumento di
riscatto delle classi deboli. Allora avevamo “l’età
metafisica”, come dice Simone de Beauvoir, nel senso
che la vita esisteva sotto forma di idee e quindi era
luminosa, incantata e astratta, come scritta nelle pagine
di un libro.
Dubbioso di rango anche Carlo Paterniti, ordinario di
diritto penale all’università e avvocato, eterno deluso
come me di questa terra irredimibile e tuttavia sempre lì
a combattere per ciò che si può; e poi Puccio Maimone,
141
sportivo di classe, uno che non si arrende mai e che s’è
inventato una casa editrice in una città che è palude di
se stessa; Laura Boemi, insegnante di lettere e mia
compagna di classe al Cutelli, la più brava, la più
attenta. Per i vent’anni della maturità organizzò un
incontro con i compagni di classe. Ci ritrovammo in
pochi, quasi estranei, a rimestare vecchi ricordi, vecchie
battute, a riscoprire ciò che non si era, ciò che si voleva
dimenticare. Eravamo come i sopravvissuti di Varlam
Šalamov riuniti non dall’amicizia ma dal bisogno e che
dopo il “lager” tornavano a salutarsi di malavoglia.
Accanto a Laura c’era Enzo Serpotta, procuratore
aggiunto a Catania, bravo anche lui a scuola, e Nino Di
Giovanni, irreprensibile per moralità nonché ottimo
giocatore dilettante di calcio. Come me, come tutti,
sognava di sposare una straniera, una tedesca, una del
Nord profondo, bionda e con gli occhi azzurri. Ha
sposato una brava ragazza bruna. Hanno due figli, due
ragazzi che vivono in punta di piedi, come il padre, e
come il padre hanno i capelli irlandesi, i capelli rossi.
Più vicini nel tempo debbo ricordare Alfio Caruso,
per gli amici Fredi, giornalista e scrittore di rango, a
Milano da una vita, sposato con una catanese, Chiara,
scrittrice anche lei, che gli ha dato tre figli, uno di
questi, Giuseppe, scrive su l’Unità e ha pubblicato un
libro dal curioso titolo, Chi ha ucciso Berlusconi, che
naturalmente ha suscitato un pandemonio in Italia e in
Europa. Nel 1993, Fredi, per avere scritto su La
Gazzetta dello Sport alcuni articoli non precisamente
amichevoli sulla vicenda del Catania calcio, radiato per
fallimento e precipitato dal girone B di serie C1 (che per
la verità non era gran cosa) alla categoria dilettanti, fu
minacciato di morte da alcuni esagitati tifosi etnei e
costretto per circa un anno a spostarsi con la scorta. Lui
e Candido Cannavò. Furono giudicati traditori. E non
solo dalle tifoserie della curva nord, pronte a mobilitarsi
e a calpestare il codice penale al primo soffio ostile del
vento, ma anche da buona parte dell’establishment
cittadino. Davvero momenti drammatici che porteranno
142
i due bravi colleghi a staccarsi sempre di più dalla loro
città natale.
Ora, si può rischiare la vita per un paio di articoli
sportivi? A Catania, evidentemente, sì. A Catania può
succedere che un ispettore di polizia, Filippo Raciti, ci
lasci la pelle per mano di un gruppo di tifosi delinquenti
che lo bastonano a sangue con i tubi divelti dai bagni
dello stadio. Può accadere che la festa di Sant’Agata,
dopo la tragedia, nonostante la vibrata protesta di Pippo
Baudo al Papa, continui a svolgersi come se niente fosse
e che i cordoni del fercolo vengano trainati, al grido di
“Cittadini, viva Sant’Agata!” dagli stessi esagitati ultras
che hanno dato la caccia alle forze dell’ordine, per puro
spirito criminale.
Sulla “parata”, istituzionale e politica, ai funerali in
cattedrale del poliziotto ucciso valgono le parole di
Francesco Merlo su la Repubblica: “C’era molto più
Cristo nel dolore di quella figlia rimasta senza padre,
nella sua faccia intensa e generosa, nel suo sguardo
straziato e sincero, che in tutta la demagogia
devozionale di una delle feste religiose più pagane
dell’Occidente”. Che la festa di Sant’Agata, sia
diventata una sorta di rito pagano, con tempi e modalità
che nulla o pochissimo hanno di religioso, è da tempo
opinione diffusa. Che sia finita in mano alla criminalità
organizzata, che sfrutta per far soldi la devozione e la
colpevole distrazione della Chiesa locale, è argomento
di molti salotti cittadini che la sera del cinque febbraio
organizzano fastosi ricevimenti alessandrini e altrettante
fastose chiacchiere. Ma nessuno ha mai spiegato
chiaramente perché ogni anno la Santa rientri così tardi,
perché il percorso del fercolo sia assurdamente e
pericolosamente stracolmo di bancarelle, paninerie,
rosticcerie, persino barbecue sistemati sui marciapiedi
per arrostirvi carne di cavallo, polpette e salsicce…
senza per altro provocare proteste significative sia per
tale arabo guazzabuglio sia per le strade e le piazze rese
sdrucciolevoli dallo sgocciolare incessante dei ceri
grossi come tronchi d’albero e portati a spalla da
143
giovani fondamentalisti. Ai primi di febbraio del 2008,
la magistratura catanese, svegliatasi dalla letargia nella
quale di tanto in tanto scivola, ha chiarito ufficialmente
la faccenda e messo le mani sui responsabili: la famiglia
Santapaola-Ercolano e alcuni suoi addentellati. La festa
diventa sempre più lunga e pletorica perché dà modo
alla consorteria navigante attorno a Sant’Agata di
gestire: primo, le candelore e le corporazioni annesse;
secondo, le commesse per i fuochi d’artificio; terzo, il
flusso delle candele che vengono ammassate sul fercolo
e di volta in volta scaricate intonse sui camion che sono
serviti a trasportarle (una sorta di partita di giro); quarto,
le soste della processione con relative offerte in denaro;
quinto, le scommesse sul rientro in cattedrale della
patrona; sesto, i posti di ristoro… e altro ancora.
Una strada lunga quella della santa patrona, lunga e
pericolosa. Durante la guerra del Golfo, Papa Wojtyla
invitò le diocesi a non celebrare per quell’anno feste
religiose. L’arcivescovo di Catania, Luigi Bommarito,
accolse subito la preghiera e convinse a fare altrettanto
anche il sindaco, che per legge presiede i festeggiamenti
agatini e che allora era Guido Ziccone. Quando però si
sparse la voce che la festa sarebbe saltata la mafia
minacciò di morte il sindaco. E ci sarebbe riuscita a
levarlo di mezzo se il prof. Ziccone, il giorno
dell’attentato, mentre si trovava tra un gruppo di fedeli
davanti alla gradinata della chiesa di San Biagio, non si
fosse accorto del killer e prontamente non avesse
trovato riparo nell’auto di servizio. Furono giorni
drammatici, con nuove pressioni e minacce, finché il
cavaliere Luigi Maina, presidente da sempre delle
celebrazioni agatine (esattamente dal 1952, quando
Elisabetta diventò regina) suggerì al sindaco una via di
mezzo: festa sì ma ridotta. E fu così che Guido Ziccone
salvò la pelle mentre l’arcivescovo, che mise
prontamente il capello sulla festa, attribuendosi il merito
dell’escamotage, trovò il modo di ringraziare il primo
cittadino baciandogli le mani.
Dopo la morte dell’ispettore Raciti fu deciso che
144
negli stadi privi di garanzie di sicurezza le partite
venissero disputate senza pubblico. Ma i presidenti delle
società calcistiche ebbero il coraggio di protestare. I più
sofisticati parlarono di “silenzio irreale” senza capire
che in quel momento era invece un grido di dolore
contro le aberrazioni dello sport, era “la cosa più
pulita”, e giusta, come scrisse sul Corriere della Sera
Aldo Grasso, per onorare la memoria del poliziotto
Raciti e cominciare finalmente un discorso di
responsabilità.
Da ragazzi giocavamo a pallone in campetti
improvvisati in terra battuta e non c’era che il silenzio a
guidare la nostra gioia. Proprio in quella pace c’era
l’intimo sentire nostro: il cuore che batteva forte a ogni
goal realizzato, a ogni azione ben fatta; oppure il rossore
che colorava il nostro disappunto per un rigore sbagliato
o una palla persa. Ed era sempre il silenzio a
accompagnarci nelle sale cinematografiche, a fare
spazio alla mente perché del film catturasse ogni parola,
ogni immagine, ogni sfumatura, ogni verità.
Nemmeno nella storia più antica e selvaggia della
città è possibile riscontrare quelle aberrazioni. Vorrà
dire pur qualcosa se il ministro dell’Interno Amato,
dopo la tragedia Raciti, definì Catania una sorta di
Bronx in mano alla violenza dei disoccupati e alla
criminalità organizzata. Ma forse la Catania del fare e
del dire, la Catania del teatro e dell’ironia, del cuore e
dell’istinto è esistita solo per parentesi brevi e lontane,
forse sta solo nei depliant turistici, nelle compiacenti
ricostruzioni storiche. Forse più reale e vera è la Catania
del sottosuolo, della delinquenza minorile, della mafia e
della violenza, la Catania degli affari e del tornaconto,
dei politici sbruffoni e incapaci, la Catania degli ultrà
che menano le mani e dopo avere messo a soqquadro un
quartiere se ne vanno a casa a guardare i cartoni animati
in Tv e a dormire sotto coperte dipinte coi colori della
squadra del cuore. Tutto questo nell’affettuosa cecità dei
genitori che osservano e non capiscono, non capiscono
145
che non è del tutto normale che un figlio, alla soglia
della maturità, passi il proprio tempo in una stanza piena
di bandiere rossazzurre e di trofei calcistici, pesi cento
chili e venga deriso dai compagni. E lui, figlio buono,
diventa cattivo per emulazione, per riprendersi un poco
della stima dei propri dileggiatori, che poi sono peggio
di lui per quel grammo superfluo di “spirtizza” in più
che vantano.
Noi, a quell’età, nella cameretta condivisa con il
fratello tenevamo i poster del “Che” Guevara e di
Marilyn Monroe, accanto ai libri di Giulio Verne,
Salgari, Defoe, Stevenson, Swift. La memoria del tempo
antico in cui scivolava la mia fanciullezza
probabilmente è imprigionata nella favola, ma i fatti
dell’oggi sono quelli appena ricordati, i fatti di ieri sono
quelli che mi sforzo di raccontare con onestà. Che poi
allora ci fosse meno democrazia e capacità di
interpretare i fatti, che la pasta non tenesse la cottura e
diventasse strumento di scambio di voto, che i bambini
del sottoproletariato urbano avessero scarpe scalcagnate
e vestiti rattoppati, che la DC distruggesse in blocco le
città meridionali con una colossale speculazione edilizia
mai avvenuta a memoria d’uomo, è un discorso vero ma
che non serve a giustificare la violenza di questo tempo,
la sua stupidità, gli anni che crescono su se stessi senza
memoria, inafferrabili come menti alienate che
s’aggirano nei verdi recinti a bocca spalancata. Né può
consolare il fatto che il fronte del malessere si allunghi
fino al ricco e orgoglioso Nord non più immune dalle
infiltrazioni mafiose e delinquenziali. Drammatica ma
precisa la canzone di Franco Battiato, Povera patria “…
schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che
non sa cos’è il pudore”.
Dicevo della fanciullezza, della favola, del mito. A
volte, come sosteneva Oscar Wilde, “essere immaturi
significa essere perfetti”. Naturalmente, l’immaturità
“adulta”, quella che misura sui valori il proprio
distinguo, la capacità di restare ancorati al proprio stile e
alla propria indignazione; oppure l’incapacità di
146
corrompersi per cinismo o per vanità salottiera, di
abbracciare le mode e gli inganni del potere, di giocare
allo scavalco delle ideologie, di comprare libri e non
leggerli, di ostentare titoli superflui o imbarazzanti…
Eppure, un giorno di fine inverno, poche settimane
dopo la “caccia al poliziotto” e la festa agatina, mutilata
soltanto dei suoi fuochi d’artificio, avvenne un piccolo
miracolo al Teatro Massimo Bellini. La folla dei
melomani, a fine concerto, si raccolse attorno al maestro
Riccardo Muti, e alla sua Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini, e lo subissò d’applausi, dieci minuti buoni, e
lui, dopo la standing ovation, disse di ricordare la città
di un tempo, la città degli anni Sessanta dove esordì
come direttore d’orchestra e alla quale erano legate
memorie di simpatia e di stima. Raccontò come quella
volta il portiere del teatro avesse condiviso con lui la
birra che stava bevendo e come il primo violoncello,
durante le prove della sinfonia Dal nuovo mondo di
Dvorak, travolto dalla passione del giovane maestro,
così promettente, già così bravo, si fosse alzato
d’impeto e lo avesse affiancato in una sorta di direzione
binaria. Raccontò anche del profumo della città, il
profumo della zagara, raccontò del calore umano
ricevuto, dei vecchi orchestrali ormai morti o in
pensione dei quali ricordava i nomi. A distanza di
quarant’anni, in quella Catania, che aveva letto sui
giornali come di una città diventata violenta, disse di
avere ritrovato l’antica gentilezza e ricordò come alle
prove centinaia di ragazzi del liceo musicale fossero
entrati in punta di piedi, avessero ascoltato in religioso
silenzio e fossero andati via con la stessa delicatezza. A
conclusione, mentre il pubblico sottolineava con
applausi scroscianti ogni passo della narrazione, il
maestro Muti regalò un bis: il secondo entr’acte del
Rosamunde di Franz Schubert. Un capolavoro, dolce e
profondo. Quel giorno mi riconciliai con la mia città che
pensavo avesse messo definitivamente una pietra al
posto del cuore. Nessuno è mai così cattivo come spesso
ci suggerisce il nostro risentimento, la nostra rabbia che
147
comunque è una forma di amore. E poi quei ragazzi, che
ascoltavano Schubert e Beethoven, davano un peso
nobile e straordinario alla città e facevano dimenticare
di colpo i mille teppisti dello stadio; ragazzi magari
sportivi anche loro ma non adusi a dormire sotto coperte
rossazzurre, forse “immaturi”, come lo eravamo noi
negli anni Cinquanta, ma di sicuro perfetti.
Questa “perfezione” tuttavia è spesso un artificio, un
sentimento di esclusività più vicino al sogno che alla
realtà, un sentimento cinematografico, per dirla con la
filosofia di questo racconto sentimentale. Noi catanesi
crediamo che la nostra città sia il compendio d’ogni
virtù e bellezza, per la sua storia, la sua cultura, il suo
clima, e quindi restiamo delusi, atrocemente delusi,
quando scopriamo che è come le altre, né bella né
buona, né sublime né speciale, solo comune, solo
sperduta in fondo allo Stivale, solo mediocre come
mediocri sono diventate le città meridionali, le città
plebee dell’ex Regno delle Due Sicilie. Di questa
delusione s’è fatto portavoce ancora una volta Pippo
Baudo sulla prima pagina de La Sicilia stigmatizzando il
“gran calcio” che l’allenatore etneo Silvio Baldini aveva
sferrato al collega Di Carlo dopo la partita ParmaCatania. “Noi siciliani siamo abituati a farci del male da
soli”, ha scritto il presentatore televisivo “con i nostri
comportamenti facciamo in modo che il nome della
Sicilia venga spesso infangato, anche se tutto quello che
si scrive e si dice non rappresenta mai l’intera civiltà
siciliana…”
Baudo, forse senza volerlo, ricalca la retorica
siciliana del minimizzare le colpe e ingigantire le
innocenze. Ma a furia di sorvolare non si fa che il gioco
dei furbi e dei criminali che proprio di quella antica
civiltà isolana si fanno scudo e vi si mimetizzano.
Ormai, molta parte di questa “civiltà siciliana” sta solo
nei libri, anche se i siciliani non hanno smesso di
credere d’essere il sale della terra, gli dei dell’ultimo
incanto, e quindi reagiscono con durezza a tutto ciò che
stride con quella supposta perfezione. La conseguenza è
148
di camminare con la testa tra le nuvole, incantati e
ciechi, senza vedere il burrone che s’apre lì a due passi.
Da anni molti rifiutano di riconoscere Catania come una
città soffocata dalla mafia perché ne hanno un’idea
sentimentale, da pubblicità progresso. Molto spesso
l’assolvono per astuzia dialettica perché assolvendola
assolvono se stessi, ripescano l’alibi del passato
splendente per minimizzare le colpe del presente. Ben
più appropriato il commento conclusivo del Pippo
nazionale: “Caro Silvio Baldini per il bene della squadra
e della città si tolga dai piedi”. Saggio consiglio non
tanto per un ritrovato “complesso di superiorità” ma per
una civiltà di rapporti o quanto meno per semplice
educazione. Il signor Baldini, che a tutti ha chiesto
scusa tranne all’offeso, avrebbe meritato, lui sì, un
solenne metaforico calcio nel sedere.
Un altrettanto (non metaforico) calcio nel sedere
avrebbe meritato il senatore di Alleanza nazionale, Nino
Strano. Nel gennaio del 2008, poco prima che si
determinasse la sconfitta del centro-sinistra, si scagliò
con linguaggio da suburbio contro un collega
dell’Udeur, Cusumano, reo di non avere accettato la
consegna di far cadere il governo Prodi. Nel suo
editoriale della domenica, su la Repubblica, Eugenio
Scalfari commentò l’episodio con queste parole: “Mi ha
dato un senso di vera tristezza assistere dagli schermi
televisivi a quella seduta che non esito a definire
drammatica, anzi tragica, per la sguaiataggine da
bordello in cui è precipitata l’aula del Senato al
momento delle votazioni. Le aggressioni fisiche, la
rissa, gli sputi, gli svenimenti e quello spregevole
buffone che dai banchi missini, col pullover rosso
annodato al collo, gli occhiali neri e una bottiglia di
spumante in mano, lanciava sconcezze e innaffiava di
spuma i banchi e i senatori che vi erano seduti. Ha fatto
il giro del mondo quell’immagine”. Il grande giornalista
dimenticò di aggiungere che il senatore Nino Strano, da
Catania, mentre si esibiva in quel fuori programma da
suburbio, mangiava a bocca aperta mortadella
149
(trasparente l’allusione al premier Prodi dagli avversari
soprannominato Mortadella). Ma non fu solo Scalfari e
la stampa tutta a stigmatizzare l’accaduto, anche
moltissimi catanesi sulle pagine de La Sicilia
mostrarono di vergognarsi di avere un siffatto
concittadino, un siffatto “spregevole buffone”. Al punto
che lo stesso Strano, sinceramente spaventato per il suo
futuro di parlamentare, chiese scusa a tutti sulle pagine
del quotidiano cittadino. Conosco Nino Strano. È un
ragazzo (si fa per dire) sveglio, trasgressivo e
assolutamente privo di freni inibitori. Ma non mi sarei
mai aspettato che scendesse a quel livello. Qualche
giorno dopo essere stato eletto, mi confessò: “Ma tu ci
pensi? Io, senatore della Repubblica!” Chi glielo doveva
dire, insomma. L’autoironia gli faceva onore. Ora, non
so che pensare. Il potere è un cancro che lentamente si
mangia tutto: l’onore, la dignità, l’equilibrio, il rispetto
del prossimo, il cuore. Tutto.
Dopo Fredi Caruso, Francesco Merlo, citato poco fa,
tra i grandi giornalisti italiani. Dopo il mio passaggio
alla Rai, prese il mio posto a La Sicilia. Ma non era
contento di occuparsi di spettacoli. La sua mente già
allora viaggiava oltre i recinti tecnici della cultura e le
barriere sin troppo visibili del giornale di provincia.
Non volle laurearsi. “A che mi serve?” Era, comunque,
un passo avanti nel capire i fatti e raccontarli. Il 15
novembre del 1976, stavo ancora a La Sicilia,
arrivarono due importanti notizie: la morte di Jean
Gabin e quella di Ercole Patti. Poiché erano di mia
competenza mi attivai, con l’aiuto delle agenzie, per
mettere insieme due oneste biografie. Patti era uno
scrittore catanese di un certo nome e collaboratore del
giornale, che per altro avevo conosciuto ed ero stato
anche ospite in casa sua (una villetta immersa in una
piccola campagna di ulivi vicino al mare di Pozzillo), e
quindi non ebbi dubbi nel dargli il rilievo maggiore.
Francesco, che si trovava in quel momento in redazione,
non fu dello stesso avviso. Ai suoi limpidi e ancor
giovani occhi il grande attore francese era più
150
importante del romanziere etneo. Debbo riconoscere che
aveva ragione. La ragione di Arbasino, per dire, quella
che suggerì allo scrittore di occuparsi del fenomeno
rock’ n’ roll anziché del laburismo per il quale era stato
mandato a Londra. La preferenza egli l’accordò al
costume anziché alla cronachetta politica che pure in
quel momento sembrava più importante.
Le sue letture escludevano i romanzi. Detestava la
letteratura francese. “La solita solfa” mi diceva. “Il
protagonista lascia la provincia e corre a Parigi a fare
fortuna. E allora?” Eppure, quel viaggio dal piccolo al
grande universo è stato, ironia della sorte, la metafora
della sua vita. Per molti anni ha vissuto proprio a Parigi
con una bella moglie inglese e tre affascinanti monelli.
John Elkann lo voleva alla direzione de La Stampa. Un
giorno venne a prenderlo col suo aereo personale, lo
portò a Torino, gli fece vedere il giornale, la casa che
avrebbe abitato, si mise d’accordo sullo stipendio, poi
accadde ciò che non doveva accadere. La notizia,
riservata, arrivò alle orecchie di Prodi e di Berlusconi
che diffidavano del suo libero pensiero. Fecero muro e
la famiglia Agnelli si spaventò. L’azienda navigava in
cattive acque e aveva bisogno della politica.
L’Avvocato, ne sono certo, avrebbe mantenuto il punto.
Qualche anno fa Torino ha ricordato Gianni Agnelli
con una mostra fotografica sulla sua vita e sul secolo da
lui attraversato con splendore e charme. La mostra,
dopo l’inaugurazione romana al Vittoriano, era stata
allestita lungo la rampa della Mole Antonelliana, in
qualche modo sovrapponendosi, ma anche esaltandolo,
al museo del cinema. Anzi, ne era una prosecuzione
logica, una sequenza filmica non solo per l’iconografia
che definisce la straordinaria esistenza dell’Avvocato
ma soprattutto per ciò che suscita nel cuore dei
visitatori: l’idea di un uomo fortunato, intelligente,
ricchissimo, a suo agio coi potenti e con gli umili, tutto
sommato un divo senza volontà di esserlo, e quindi un
uomo meritevole d’essere proiettato con la sua vicenda
umana sul grande schermo del mondo. Per essere
151
ammirato, amato, ma anche, se si vuole, criticato. “Sono
trascorsi cinque anni dalla sua morte”, ha ricordato Luca
Cordero di Montezemolo che ne ha ereditato il ruolo
non certo la classe “ma in realtà sono molti di più”.
Torino, dopo le Olimpiadi invernali, è cambiata, dice.
Prima era grigia, polverosa, assopita, che faceva
difficoltà a mettersi in mostra, adesso è una città del
futuro.
All’apertura della mostra ero con mia moglie tra i
tanti italiani curiosi di capire fino al dettaglio la
magnifica rappresentazione regale che è stata la vita
degli Agnelli. Mancavo da Torino da un quarantennio.
Ricordo che il mio primo reportage su La Sicilia lo
scrissi sulle suggestioni sabaude, sui salotti di pietra e i
caffè che mostrano con orgoglio i loro arredamenti fine
Ottocento, i gianduiotti, i gelati, l’alterezza della gente
che in quegli anni rifiutava di dare alloggio ai nostri
emigranti, anche ai giovani meridionali che studiavano
al Politecnico. In questo senso, Torino è cambiata. Basta
passeggiare il sabato pomeriggio per le vie del centro,
fino a piazza Castello, per assistere a uno spettacolo
rumoroso e gioioso di giovani che assomigliano ai nostri
giovani, di signore che sono le nostre signore, vanitose e
indaffarate, a parte i cagnolini che si portano appresso,
di uomini che sono i nostri uomini, firmati grandi
magazzini, di auto che sono le nostre auto, piccole
grandi o lussuose che siano. Sì, l’omologazione sembra
completa.
Eppure, Torino suggerisce anche un altro percorso
che è sempre lì, che dice quanto la città nonostante tutto
sia rimasta fedele a se stessa, alla sua storia, al suo
Risorgimento, alla Fiat del Lingotto e di Mirafiori, alla
dinastia regale dei Savoia e alla dinastia laica degli
Agnelli. La mostra sul secolo dell’Avvocato, pur
evocando scenari diversi e colorati, è una continuità
logica di fondali mai estinti, mai tirati giù. S’è detto che
Gianni Agnelli ricordava nei modi e nelle fattezze un
principe rinascimentale. Vero e non vero. In verità, era
un re sabaudo senza corona, anzi, meglio di un re
152
sabaudo, un sovrano austriaco con ascendenze francesi e
anglosassoni, un incrocio fantastico di quanto di meglio
potesse vantare l’aristocrazia europea, compresa l’erre
moscia. “Mettigli un elmo in testa, mettilo a cavallo, ha
la faccia di un re”, diceva di lui Federico Fellini.
Nell’Italia degli anni Venti, assieme ai fratelli, era
stato allevato da Miss Parker nel più rigoroso british
style. Vestiva sempre alla marinara, come per altro
avrebbe ricordato in un libro rievocativo la sorella
Susanna: blu in inverno, bianco e blu nella mezza
stagione, completamente bianco in estate. Ma col tempo
egli avrebbe modificato, fino all’eccentricità, il proprio
abbigliamento: l’orologio sul polsino, la cravatta fuori
del pullover, gli scarponcini Tods sotto l’abito elegante,
le camicie col colletto botton down. Perché egli non
possedeva la banalità del sangue blu (semmai l’aveva
azzurro), la costrizione della dinastia e tutte le balle che
si legano al “dovere” di un re. Egli era libero come un
sogno.
Dice Valerio Castronovo, uno che gli Agnelli ha
conosciuto molto bene: “Il rapporto che l’Avvocato
aveva con Torino andava oltre le vicende e le persone
che concernevano la Fiat; si estendeva alla storia e alla
cultura della città. Nelle sue peregrinazioni cittadine
qualche volta la mattina andava al museo del
Risorgimento. Gli piaceva soffermarsi nell’aula del
Parlamento…” Gianni Agnelli amava la sua azienda, al
punto da mettere sull’ideale stemma di famiglia
l’espressione da lui più volte usata “Siamo nati
meccanici”, ma il passato regale della sua città gli
restava dentro come una seconda anima. Un passato
dinamico in verità, una radice forte che doveva servire a
alimentare il nuovo. “Per essere italiani nel mondo”,
soleva dire “dobbiamo innanzitutto essere europei in
Italia”. E questa modernità si alimentava di ciò che
Torino aveva saputo esprimere nella cultura, nelle idee e
nei valori civili di uomini come Norberto Bobbio,
Massimo Mila, Alessandro Galante Garrone e di altri
esponenti della Torino azionista. Non disdegnando però
153
“l’altra parte”: l’Ordine Nuovo di Gramsci,
l’aristocrazia operaia di Gobetti, la casa editrice di
Giulio Einaudi.
È impressionante quanti uomini illustri conoscesse e
frequentasse. Con i Kennedy era di casa, così pure con
Bush padre e coi Clinton; l’ex segretario di Stato
americano Kissinger era suo intimo amico e le volte che
veniva in Italia se lo portava allo stadio a vedere la sua
amata Juventus; Kruscev, Tito, Gorbaciov, Gerald Ford,
Ronald Reagan, i reali inglesi e quelli d’Olanda lo
stimavano, così pure l’Aga Khan, Juan Carlos e Ranieri
di Monaco; per non dire di Fidel Castro, De Gaulle,
Chirac, Shimon Peres, Arafat e dei presidenti della
Repubblica italiana e dei massimi politici nostrani. Le
250 foto del percorso, curato da Marcello Sorgi su
progetto espositivo di Cynthia Sgarallino, testimoniano
una vita mai vissuta con lentezza ma sempre a tavoletta,
spinta al massimo come una Ferrari. Dall’infanzia
“dorata ma breve” al matrimonio con Marella
Caracciolo nel ’53, dalla trentennale esperienza alla
guida della Fiat ai viaggi nel mondo e alle grandi
passioni sportive: l’automobile, lo sci, la vela.
Un uomo così, un uomo che ha avuto tutto dalla vita
e che si è posto accanto e sopra la grande aristocrazia
europea, alla quale era più o meno imparentato, che ha
spesso dettato l’agenda politica e industriale italiana,
che ha vissuto dentro e fuori i confini nazionali,
naturalmente anche dentro gli argini della sua Torino,
un poco italiana e un poco mitteleuropea, un uomo così
che ha posto l’asticella della propria esistenza sempre
più in alto, e ogni volta superandola senza sforzo, non
poteva non conoscere il risvolto amaro della vita, il
dolore che stringe i deboli e i forti, il dolore che
polverizza ogni umano privilegio, ogni umana fortuna.
Perde il padre, ancora giovane, in un incidente aereo;
perde il figlio Edoardo, l’erede, che non riesce a uscire
dal tunnel della droga e che un giorno si butta da un
cavalcavia; perde il nipote Giovannino, figlio del
fratello Umberto, che aveva designato a succedergli,
154
fulminato da una rara forma di tumore. Perde, insomma,
l’invincibilità.
Lo incontravi e ti domandavi quale fosse il suo
segreto, il segreto di stregare il prossimo, il segreto di
farsi perdonare la ricchezza e talvolta il capriccio, e
sulle prime non sapevi dare una riposta convincente.
Perché il fascino d’una persona risiede dentro di noi,
dentro la nostra debolezza, dentro il nostro essere niente
ma che tuttavia reclama la propria immortalità. Una
volta, mentre passeggiavo con amici sul lungolago di
Saint Moritz, lo vidi seduto su una panchina mentre
conversava tranquillamente con Jas Gawronski e con un
signore anziano. Incapace di bloccare la mia vanità, lo
salutai di slancio, senza conoscerlo. Gesto importuno
ma irresistibile, come segnarsi davanti all’effigie del
santo patrono o come imitare i fans che si mettono in
prima fila, vicino alla transenna, nella speranza di
toccare l’attore o il cantante di successo. E lui rispose
con garbo al saluto. Essendo restio a un comportamento
così infantile mi stupii di me stesso ma in seguito capii
che a dettarlo era stata la mia invisibilità.
Più tardi uscii dal mio mistero ma non ebbi
occasione di incontrarlo per lavoro. Tuttavia, mi
divertivo a ascoltare gli aneddoti del collega Marco
Franzelli che lo conosceva attraverso Luca Cordero di
Montezemolo. Era il tempo in cui la “tedesca” Lilli
Gruber nell’annunciare un servizio su Schumacher ne
pronunciava il nome con esasperante correttezza,
mentre gli altri colleghi si affannavano sugli accenti e
sulle aspirate quasi sempre sbagliandoli. E così
l’Avvocato, che ogni sera seguiva il Tg1 delle 20,
affascinato da cotanta ostentata sapienza, mise in giro la
storiella che se uno avesse voluto pronunciare
correttamente il nome del pilota tedesco avrebbe dovuto
telefonare prima alla Gruber e farsi spiegare.
Non amava essere adulato e si annoiava facilmente, a
meno che l’interlocutore non lo sorprendesse con
l’insolito. Avendo molto visto e molto vissuto era una
miniera di aneddoti e battute fulminanti. Il giorno in cui
155
seppe che il pentito Buscetta era tifoso della Juve se ne
uscì con questo commentò: “Se lo incontrate ditegli che
è la sola cosa di cui non potrà mai pentirsi”. E se
qualcuno gli domandava delle sue avventure galanti
rispondeva con ironica saggezza: “Ci si innamora a
vent’anni. Dopo si innamorano soltanto le cameriere”.
Quando è morto, Torino ha perso il suo presidente,
l’Italia il suo figlio più prestigioso e il mondo l’uomo
che seppe farsi re a monarchia passata di moda.
Dicevo del silenzio, l’attivo silenzio degli anni
Cinquanta. Solo in quello spazio luminoso potevano
attivarsi le risorse migliori del pensiero, come in una
bolla di vetro in cui cade, dopo averla rovesciata, la
finta neve che va a coprire leggera icone e santuari,
figure e monumenti di latta colorata; come nella storia
dell’angelo custode Cary Grant che si muove in una
cittadina d’insignificanti problemi e scopre il paradiso
negli occhi e nel sorriso della moglie del vescovo
protestante. Ricordo la pace del silenzio nelle chiese
velate di penombra, nelle biblioteche foderate
d’incunaboli e antichi ritratti, nelle operose botteghe
artigiane dove i necessari sgrusci erano più che altro
musica. Ricordo i vicoli illuminati dall’allegria delle
lavandaie e dai giochi dei monelli, che allora mi
parevano “chiasso” ed erano invece canto.
Era tutta la città che cantava, e se ne riusciva a
cogliere il fraseggio perché attorno regnava il silenzio: il
silenzio del giardino Bellini, del viale degli uomini
illustri senza naso (storico sberleffo e monelleria), delle
coppiette infrascate senza il minimo successo, dei cigni
che beccavano dalle mani dei bambini spaventati e
felici, dei piccoli truffatori del tre-oro-vince-tre-oroperde, dei fotografi che nascondevano la testa dietro
enormi macchine di legno e scattavano ritratti
immortali, degli omini che ti consegnavano il futuro, la
“prineta”, dopo averlo fatto pescare, in una massa di
foglietti inutili, da un onesto pappagallino verde. Era il
Concerto per pianoforte n. 21 di Mozart e l’Eroica di
Beethoven, la Toccata e fuga in re minore di Bach e la
156
Ciaccona, era Chopin e Debussy, Bellini e Rossini…
oggi è una composizione dodecafonica, che certo ha il
suo posto nella storia della musica ma che io non
ascolto, e non ascolto perché non mi piace. È come
vedere Robocop uno, due e tre oppure Rambo uno, due e
tre. Meglio essere stupidi con Perdutamente tua che con
Rocky uno, due, tre, quattro e cinque, meglio restare
serenamente “immaturi” e serenamente disinformati.
157
SEI
Rita Hayworth, Joan Fontaine, Lauren Bacall
Nella primavera del 1946 la marina americana
ordinò l’evacuazione dei 167 abitanti dell’atollo di
Bikini nelle isole Marshall. A operazione conclusa, sulla
piccola isola furono costruiti bunker d’osservazione e
trasferite 5.400 cavie (ratti, capre, maiali) per studiare
gli effetti delle radiazioni che si sarebbero sprigionate
da lì a pochi mesi col lancio di due bombe atomiche.
All’inizio dell’estate venne dislocata nella grande
laguna di Bikini una flotta di 246 navi, più o meno in
disarmo, compresa la portaerei Saratoga, sfuggita
all’attacco di Pearl Harbour, e la corazzata Nagato,
sequestrata ai giapponesi e a bordo della quale
l’ammiraglio Yamamoto aveva dato l’ordine di
attaccare la base americana delle Hawaii. Con quel
massiccio trasferimento di mezzi gli alti comandi
statunitensi intendevano testare la potenza degli
spaventosi ordigni nucleari su precisi obiettivi militari.
La prima delle bombe, “inaugurate” l’anno prima sulle
popolazioni di Hiroshima e Nagasaki, fu sganciata il 2
luglio sul ponte di una corazzata, dipinto di rosso per
farlo individuare meglio dall’alto. Ma l’aereo non centrò
il bersaglio e l’ordigno fece relativamente pochi danni.
La seconda bomba venne fatta esplodere il 26 luglio
all’interno di un sommergibile piazzato al centro della
flotta. L’effetto stavolta fu devastante. Decine di navi
vennero polverizzate e la Saratoga, di oltre 48mila
tonnellate, fu risucchiata all’interno del fungo atomico e
poi scaraventata nei fondali marini, dove ancora giace
per il divertimento degli amanti delle immersioni e dei
relitti sommersi.
La prima delle due bombe fu battezzata col nome di
Gilda, in omaggio a Rita Hayworth che stava
furoreggiando in America col film di Charles Vidor, che
alla prima uscita aveva già incassato tre milioni di
158
dollari. Iniziativa, per la verità, di dubbio gusto (pare
fosse venuta in mente ai dirigenti della Columbia) che
l’attrice non mancò di sottolineare e di amareggiarsene.
L’atomica Gilda, dunque, esplose due volte: prima tra il
pubblico, poi su quello sperduto angolo del Pacifico. E
la rossa, conturbante Rita sarà per sempre Gilda, anche
interpretando ruoli diversi e contrastanti come quello
della Signora di Shangai girato accanto al marito Orson
Welles. Una volta, cercando le ragioni del fallimento dei
suoi matrimoni, confessò: “Sposavano tutti Gilda ma la
mattina dopo si svegliavano con me”.
“Non c’è mai stata una donna come Gilda”,
annunciavano i manifesti del film. In effetti, la
Hayworth riassumeva in sé due dive: Greta Garbo per la
purezza, Marlene Dietrich per il peccato. Una fortunata
sintesi di donna di malaffare e dea dell’amore romantico
che rispecchiava in pieno i gusti e i desideri del
pubblico che con la guerra aveva perso la fiducia nelle
istituzioni e negli ideali tradizionali. Per raggiungere
quella perfetta sintesi degli opposti, i tecnici lavorarono
sodo. Innanzitutto sul nome. Via quel Margarita Carmen
Cansino che faceva rima con troppe cose. Meglio il
cognome della madre, Haworth, che era stata una
ballerina di Ziegfeld, al quale aggiunsero una Y. E via
anche quel colore nero di capelli e quella leggera
pinguedine che la rendevano troppo ragazza della porta
accanto. Dopodiché le allargarono la fronte rasando un
centimetro buono di capelli, le incapsularono i denti
troppo laschi, le ritoccarono gli zigomi e gli occhi ma
per un errore del chirurgo plastico, come ricorda
Antonia Bonomi, “una palpebra resterà abbassata e sarà
costretta a portare sempre ciglia finte per mimetizzare il
difetto, mentre l’occhio lacrimerà perennemente”.
Il film mostrava come le donne, stanche di fare le
fidanzatine o le casalinghe, avessero ormai conquistato
l’indipendenza sessuale e dimostrato come il mito
dell’onesto lavoro naufragasse di fronte al desiderio
della ricchezza facile. La rispettabilità era messa in
gioco e il passato giudicato un insieme di menzogne
159
sulle quali si basava la coesione d’una società
sostanzialmente corrotta. Se questi erano i desideri e le
scelte della società americana, in Italia soffiavano
impetuosi altri venti. L’ordine borghese s’incarnava per
grandi linee nel matrimonio indissolubile, nella prima
comunione, nel liceo classico e nel latino, nelle classi
separate, nell’educazione fisica separata, e persino nelle
tende alle finestre, nel reggiseno, nel costume da bagno
intero, nello smoking e nella musica classica. Anna
Tonelli, in Politica e amore, ricorda come la Chiesa
custodisse con fermezza i sacri principi della morale.
Numerosi erano i manuali cattolici che invitavano le
donne a sottomettersi all’uomo. In Amore di sposa, M.
Mazzel scrive: “La donna non meni troppo la lingua
facendo a ogni tratto osservazioni su quanto il marito
ordina e dispone nell’andamento della vita domestica,
ma si lasci guidare sottomettendosi al giudizio e al
modo di vivere del proprio sposo”. A un ragazzo che
voleva sposarsi, l’amico consigliava: “Non scegliere tua
moglie tra le giovinette troppo brillanti, perché hanno il
giudizio ancor più corto delle sottane e hanno ancor
meno idee in capo che stoffa sulle spalle o sulle
braccia”.
A casa mia il matrimonio era visto come il
coronamento del vero amore e la verginità era giudicata
ancora un valore, magari non nelle forme estreme
teorizzate da Pio XI nell’enciclica Casti connubii del
1931. “Dritta a casa”, diceva mia madre a mia sorella
che, per vocazione e non per sciocca obbedienza,
fendeva la folla come se avesse inghiottito un manico di
scopa. Dopo il collegio Sacro Cuore di via Martino
Cilestri frequentò l’istituto commerciale De Felice, in
piazza Roma. Classe mista. Credo che molti compagni
di scuola ne fossero innamorati. Inutilmente innamorati.
La sua regola era cattolica ma non bigotta, anche perché
non avrebbe mai tollerato ingiuste imposizioni maritali
o consigli aberranti come da manuale (filoarabo):
“Cerchi di non far mai nulla senza aver chiesto il
consenso o il parere del marito, quando si tratti di uscire
160
di casa, di fare una compera, di iniziare una pratica e via
dicendo”. Sembra di ascoltare le aberranti regole delle
case mussulmane in cui le donne se ne stanno appartate
a ricamare, a deprimersi e come unica trasgressione
quella di salire sulla terrazza per sognare sugli orizzonti
liberi che si aprono davanti ai loro occhi, tenuti per lo
più socchiusi nelle penombre delle stanze e serrati nei
talami nuziali nel momento in cui arriva il turno di
dispensare eros al marito-signore. Mio cognato è un
uomo onesto e silenzioso, e la severità la impone a se
stesso più che alla famiglia. Fino ad alcuni anni fa
dirigeva la sezione medica di un’industria farmaceutica
nella zona industriale di Catania, la Cyanamid, e prima
ancora lo stesso lavoro aveva svolto a Milano, alla
Boehringer-Ingelheim. Suo padre aveva alcune
proprietà nelle campagne di Centuripe e suo zio, fratello
della madre, era Giuseppe Saitta, filosofo e storico della
filosofia. Aveva tenuto le cattedre di filosofia morale e
filosofia teoretica all’università di Bologna. Ex
sacerdote, allievo di Gentile a Palermo, il suo idealismo
si distaccava da quello del maestro per un più radicale
immanentismo ed un’accentuata polemica antireligiosa.
“Amado mio/ love me forever/ and let forever begin
tonight...” La canzone di Doris Fisher e Allan Roberts,
che Rita Hayworth canta con la voce di Anita Ellis, è
una parte importante del film, definito da Kate
Cameron, sul Daily News di New York, “spazzatura
d’alta classe”. E tale, probabilmente, sarebbe passata
alla storia se a nobilitarla e a renderla immortale non ci
fosse stato il fascino della diva. Ruth Waterbury sul Los
Angeles Examiner scrisse: “Rita Hayworth si rivela una
intelligente donna di spettacolo. Per non parlare della
sua bellezza. Il risultato è un melodramma fastoso e
affascinante. Se la storia è inverosimile, potete
tranquillamente
ignorarla
concentrandovi
sulla
protagonista”. Accanto a Amado mio è da ricordare Put
the Blame on Mame. Rita la interpreta mentre si sfila il
lungo guanto nero e lo fa vorticare prima di lanciarlo
agli ammiratori. Al cinema dei ferrovieri cadde il
161
soffitto.
Le canzoni ma anche le immagini e le parole. Come
lo schiaffo di Glenn Ford alla Hayworth e la battuta di
lei: “Ti odio a tal punto che forse un giorno ne morirò,
Johnny”. Quello schiaffo, che in realtà è la cifra
autentica del film, restò sonoro e senza lacrime. Non
conobbe i risvolti drammatici che coinvolsero Renée
Faure durante le riprese del film La vipera del deserto di
Serge de Poligny. L’attrice francese doveva girare una
scena nella quale era previsto che dovesse piangere. Per
una che aveva girato La conversa di Belfort non doveva
essere un problema. Ma per quanto si sforzasse non le
riuscì di farlo. Allora, su suggerimento del regista, il
partner Georges Marchal provò ripetutamente a
schiaffeggiarla, sul serio. Ancora una volta senza
risultato. Alla fine, nel momento in cui la sua faccia
rischiava di gonfiarsi seriamente, i suoi occhi
distillarono alcune lacrime e il ciack, per disperazione,
fu dato per buono. Solo quando rientrò nel suo camerino
l’attrice scoppiò in inutili singhiozzi. Due ore dopo si
calmò. L’anno successivo, impegnata nel film di
Christian-Jaque La certosa di Parma, si guardò bene
dall’avere problemi.
Rita Hayworth muore nel 1987 a sessantanove anni,
distrutta dall’alcol e dall’alzheimer. Il suo ultimo
sorriso, un’inebetita smorfia, fu raccolto dalla figlia
Yasmine che ne aveva la tutela da sette anni, dal
momento in cui l’attrice era stata giudicata incapace
d’intendere e di volere. Il vizio della bottiglia glielo
aveva attaccato Ernest Hemingway che l’amò come
tanti nella sua vita. Si sposò cinque volte ma due furono
i grandi amori: Orson Welles, troppo intelligente, e il
principe Alì Khan, troppo ricco. Nella sua carriera girò
60 film, non tutti da ricordare, ma è stata uno dei grandi
miti del cinema americano. Una volta, al festival di
Taormina (siamo alla fine degli anni Ottanta), Glenn
Ford, ospite d’onore e ormai avanti negli anni, alla
domanda di Lello Bersani quali fossero state le persone
che più avevano contato nella sua vita rispose: John
162
Wayne e Rita Hayworth.
Lello Bersani lo incontravo al festival del cinema di
Taormina. Era un bravo cronista televisivo, vaporoso,
leggero e sessualmente chiacchierato. Eppure, una volta
mi confessò di avere avuto in gioventù una love story
con Anna Maria Pierangeli, l’attrice che amò Kirk
Douglas e James Dean prima di sposarsi col cantante
Vic Damone. Ma l’amore del giovane cronista per la
bella e giovane attrice naufragò di fronte al no deciso
della signora Pierangeli. Parafrasando la celebre frase
del presidente Fumaroli, che mise alla porta l’imberbe
Bellini innamorato pazzo di Maddalena, disse: “Non do
mia figlia a uno spiantato!” Parole analoghe dovette
pronunciare la madre di Mary Pickford di fronte alla
caparbia volontà della figlia, avviata a una splendida
carriera, di sposare l’attore irlandese Owen Moore,
ricordato poco fa. Quando seppe che Mary, a bordo del
piroscafo Texas, stava scappando con l’innamorato alla
volta di Cuba, noleggiò un motoscafo e tentò
l’abbordaggio in prossimità delle coste cubane. Niente
da fare. Mary, che aveva appena sedici anni ed era
innamorata persa, tenne duro e lei fu costretta a
masticare amaro rinunciando al proposito di fare
arrestare il futuro genero per ratto di minorenne.
Diventata una stella di prima grandezza, Mary mise fine
a quel matrimonio avventuroso. Owen Moore, per
invidia o debolezza, era scivolato nella follia
dell’alcool.
Dall’unione con Vic Damone, che era figlio di
immigrati italiani e si chiamava Vito Rocco Farinola,
nacque un figlio, Perry, che per poco rischiò di non
venire al mondo. Oriana Fallaci, nel suo libro I sette
peccati di Hollywood, la racconta così: “Pier, come la
chiamavano gli intimi, era al terzo mese e andava in
vacanza a Palm Springs. Prese l’aereo e durante il
viaggio si chiuse un momento nella toilette. La hostess
dimenticò di chiamarla perché mettesse la cintura di
sicurezza mentre l’aereo ballava e Pier cadde con una
gamba dentro il water closet trascinandosi addosso uno
163
specchio. La trovarono, all’arrivo, col ventre e la faccia
pieni di schegge di vetro, la gamba e il bacino
fratturati”.
Due anni dopo Amado mio uscì in Italia
Addormentarmi così di Mascheroni-Biri nel cui
arrangiamento il maestro Pippo Barzizza, re dello swing
all’italiana, sottolineava le magiche atmosfere di Amado
mio, adatte per altro a un testo che insiste sul contatto
“bocca a bocca” e sulla voluttà di “morire insieme”,
“labbra sulle labbra”. Interprete della canzone era una
giovane cantante, Lidia Martorana, che l’anno prima era
stata tra i vincitori di un concorso per voci nuove indetto
dal Radiocorriere. Aveva una voce morbida e sensuale.
Durante la guerra aveva fatto parte, assieme a Claudia
Dell’Aglio e Pina Garduzio, del Trio Aurora, rivale del
Trio Lescano. Fu fatta fuori dalla Rai all’alba degli anni
Cinquanta e il suo posto fu preso da Carla Boni.
È tempo di musica nuova. Accanto al jazz,
mortificato dal regime fascista in quanto musica afroamericana, accanto al tango e alle melodie di Frank
Sinatra, Bing Crosby e Cole Porter, irrompono nuovi
ritmi: rumba, raspa, bajon, beguine, bolero. Le feste da
ballo, per lo più, si svolgono nelle case private. La
musica è affidata a un giradischi al quale bisogna
cambiare spesso la puntina. I dischi sono a 78 giri e se
cadono si spezzano e se vengono usati troppo i solchi si
allargano e la musica comincia a raschiare, saltare,
ripetersi. Le feste sono di solito circoscritte in saloni
molto illuminati e circondati da sedie occupate dalle
madri, dalle nonne e dalle zie delle ragazze, sentinelle
incorruttibili che si convincono a chiudere un occhio
solo se i ragazzi rappresentano una buona sistemazione.
In questo caso, basta un cenno e la ragazza, che per tutta
la serata ha ficcato l’avambraccio nel petto del cavaliere
per non farsi sfiorare le tette, allenta la difesa. Feste da
oratorio, tutto sommato, eppure il fascismo aveva
cercato di combattere quel “paganesimo”, o “autunno
spirituale”, che altro non era che semplice sussulto di
164
modernità, di rapporto più libero tra i sessi.
Con la Liberazione il testimone passa più
incisivamente alla Chiesa e alla Democrazia Cristiana,
ma non scherzano neppure sull’altro fronte, se è vero
che il PCI invita i compagni di fede a rispettare nel ballo
i “limiti della decenza” evitando di abbracciare troppo le
ragazze e di “abbandonarsi a lascivi toccamenti”. A
parte le indicazioni di partito o di parrocchia, le pulsioni
erotiche dei ragazzi restano comunque inespresse. I
sacri confini, gli hudùd di cultura araba, esistevano
anche da noi, nell’Occidente laico. I confini che
separavano gli uomini dalle donne, erano ovunque: nelle
scuole, negli stabilimenti balneari, nelle palestre, nei
partiti, nei giochi. Fino a pochi anni fa, nei piccoli centri
dell’entroterra siciliano, le piazze erano competenza dei
maschi, dei loro pensieri arditi, dei loro sguardi e osceni
sorrisi se una “straniera”, che magari veniva da
Messina, attraversava quello stretto dominio. Nessuna
delle donne si salvava, annoverate tutte nella categoria
delle buttane, tranne le madri e le sorelle. Le terrazze
per le siciliane erano i balconi da dove si intessevano
sospiri e pettegolezzi, si lanciavano bigliettini agli
innamorati, che passavano sotto e magari cercavano di
sbirciare nelle gonne tenute strette coi ginocchi. Da quei
balconi venivano stese, perché tutti potessero vederle e
apprezzarle, le lenzuola macchiate di sangue dopo la
prima notte di nozze: sancivano la perdita della
verginità della ragazza. Ma se c’era qualche problema si
rimediava con salsa di pomodoro, o sangue di piccione
come racconta il film di Naine Labaki, Caramel,
ambientato nella Beirut d’oggi che della Sicilia di allora
sembra uno specchio fedele.
I ragazzi, con la complicità delle ragazze, davano
fondo alla loro immaginazione pur di raggiungere le
loro innamorate, farsi promettere o al più dare un casto
bacio, guardarsi negli occhi, scambiarsi pegni d’amore.
Nel 1957 il musicista Eduardo Alfieri ottiene un grande
successo con una canzone, A sonnambula, ispirata a
quei sotterfugi d’amore. Mirabile il testo di Gigi Pisano:
165
“Carmela è na bambola/ e fa ’ammore cu me./ Ma a
mamma è terribile,/ nun m’a vo’ fa’ vedè…/ Allora
aggio truvato/ nu bellu ritruvatu./ Carmela fa ‘a
sonnambula,/ pe’ mme venì a truvà…/ e fa scema a
mammà!” Il regista Gianni Puccini ne avrebbe tratto un
musicarello, Carmela è una bambola, con Marisa
Allasio e Nino Manfredi.
È tempo di poesia. Ogni ragazzo, giudicato inabile
alla visita di leva, ogni ragazzo chino sui libri e non sui
fumetti o sui giornali sportivi, ogni ragazzo stretto di
petto che tratta l’amore per conto d’altri e arrossisce al
solo sguardo d’una donna, pianeta misterioso e
insondabile, scrive versi all’innamorata, per lo più
immaginaria o al di fuori della sua portata. Versi
immaturi, pieni di confusa sofferenza, di sentimenti
tanto grandi quanto astratti, versi che nascono da
povertà di linguaggio e di tecnica, come nelle poesie dei
popoli bambini. Componimenti che scaturiscono dalla
vanità e dal bisogno di mostrarsi, di esistere, di
controbilanciare l’incapacità di farsi valere nella società.
Cattivi poeti, in definitiva, che nell’impossibilità di
esprimersi in forme letterarie complesse si affidano al
verso perché formalmente più semplice e vicino alla
loro ignoranza.
Il palazzo dove ho abitato fino a diciotto anni divide
due strade: via Vecchia Ognina e via Giuseppe Verdi,
diventata poi da quel tratto in poi via Pietro Mascagni.
In uno dei palazzi di questa strada abitava una ragazza
bionda, con gli occhi azzurri e le trecce. Aveva un viso
dolce e delicato, con un che di malinconico e di
inafferrabile che mi richiamava alla mente Olivia de
Havilland innamorata di Errol Flynn nella Leggenda di
Robin Hood. L’ho vista crescere accanto ai miei anni,
camminare con le sorelle più piccole che teneva per
mano: una specie di famiglia March del quartiere Bovio.
Facevano tutto in fretta, sia che andassero a scuola sia
che ne tornassero, come folletti allegri e spensierati. La
domenica andavano a passeggio mentre con mio
166
fratello, dalla terrazza, lanciavo apparecchi di carta.
Quando scomparivano dietro l’angolo di via Francesco
Crispi smettevo di fare il balordo e cominciavo a
pensare al futuro. A cinque anni, osservando il lavoro
delle maestranze impegnate a costruire proprio il
palazzo di Olivia de Havilland, volevo fare il muratore
ma a dieci anni, ascoltando alla radio il maestro Cinico
Angelini, avevo cambiato idea: meglio il direttore
d’orchestra, meno faticoso e più gratificante. Nel
frattempo, davo sfogo alla mia esuberanza giocando col
sole: ne catturavo i raggi su uno specchietto e li
rilanciavo sul viso dei passanti, là sotto, dove giacevano
i relitti degli aeroplani di carta. Oppure usavo la fionda
per stendere, sempre dal terrazzo di casa, i colombi
dalla cacca assassina. Facevo come tutti i bambini del
mondo, come Hassan, il cacciatore di aquiloni a Kabul,
il ragazzo hazara che con gli altri della sua etnia veniva
represso con inaudita violenza dai pashtun.
L’idea del giornalismo mi si radicò nella mente nel
momento in cui seppi che a trenta metri da casa mia
abitava il direttore de La Sicilia, Antonio Prestinenza,
un uomo piccolo, piuttosto brutto ma di grande
intelligenza e bontà, che era sposato con una bellissima
donna. Di fronte al mio portone, in un appartamento al
piano rialzato, abitava invece una vecchia amica di
Domenico Sanfilippo, l’editore del giornale. “Zio
Domenico”, rotondo nella figura e con gli occhi che
sprizzavano ironia, l’andava a trovare di tanto in tanto.
Indossava un doppiopetto, che teneva sempre
sbottonato, e immaginavo quanto la sua vita dovesse
essere interessante e straordinariamente felice. Era una
sorta di signor Matuscek, il protagonista del film di
Ernst Lubitsch Scrivimi fermo posta, del 1940, con
James Stewart e Margareth Sullavan. Come quel
personaggio, rude e bonario, che dirigeva un negozio di
pelletteria alla vecchia maniera e trattava gli impiegati
come figli, anche il vecchio Micio (guai però a
chiamarlo vecchio! per vanità, imponeva ai redattori di
non usarla mai quella parola; per anni le cronache del
167
suo giornale parlarono sempre di persone “anziane”),
anche zio Micio, dicevo, trattava la redazione come una
famiglia. E La Sicilia, allora, era una grande famiglia.
Non c’era bisogno che suonasse, perché la figlia
della signora stava sempre affacciata al balcone, e
quando lo vedeva arrivare gli andava a aprire per poi
tornarsene a controllare il traffico degli umani. Mi
faceva impressione perché la ragazza, piuttosto bruttina,
era perennemente imbacuccata, sia d’estate sia
d’inverno e, logicamente, sempre raffreddata. Non mi
sarei meravigliato se la madre le metteva anche del
cotone idrofilo tra collo e maglia per evitarle il minimo
alito di vento. Cercarono di maritarla, inutilmente, con
Antonio B. Lombardo, un assicuratore che collaborava
col giornale. Una brava persona: buona, gentile,
generosa. Se l’avesse sposata l’avrebbero assunto in
pianta stabile al giornale. Rinunciò. Il sacrificio era
troppo grosso. Si accompagnava con donne stupende,
che tutti gli invidiavamo, ma dopo un poco le mollava
senza ragione. La B, che non era proprio un
complimento, inserita tra nome e cognome, fu un’idea
del caporedattore del giornale, Renzo Di Stefano, per
distinguere la firma da quella di un altro collaboratore,
professore universitario che da giovane aveva fatto parte
di Ordine nuovo, l’organizzazione neofascista fondata
nel 1956 da una scissione a destra del MSI. “Ordine
nuovo” aveva come simbolo l’ascia bipenne e il motto
era lo stesso delle SS: “Il nostro onore si chiama
fedeltà”. Si ispirava alle dottrine razziste e
nazionalsocialiste del barone Julius Evola, il filosofo
dell’idealismo mistico, autore nel 1937 del libro Il mito
del sangue. Trent’anni dopo Evola trovò ancora il
delirante coraggio di rimproverare Almirante di non
organizzare apertamente squadre d’azione per
“distruggere i centri della sovversione” e “stroncare gli
scioperi”.
A quel tempo, Antonio Lombardo (quello senza B), a
quanto si diceva, girava con una catena in macchina per
picchiare gli odiati comunisti. Ma come avrebbe potuto
168
farlo non si capiva, era talmente magro e fragile! Anche
di lui ero amico. La sorella Silvana sposò Giuseppe Las
Casas, fratello di Barbaro e figlio del notaio Antonio,
che frequentai per qualche tempo, ad Acitrezza, assieme
a un gruppo di altri ragazzi e ragazze coi quali s’andava
a fare il bagno nel Canalone, un tratto di mare che
divideva l’isola Lachea dal più grande dei faraglioni.
C’erano Angelo Arcidiacono, futuro campione olimpico
che già allora tirava di scherma; le sorelle Mattina,
buone e sempre allegre; i fratelli Modica e i fratelli
Reitano; Gigliola Paternò, simpatica ribelle, che troverà
assurda morte nelle acque della Grecia; Egle Corvaja,
figlia del direttore della Banca d’Italia a Catania, la cui
bellezza c’intimidiva; Giovanna Rasario, pittrice di
talento, il suo rosso ricordava il rosso Matisse; Aldalisa
Cantone, silenziosa e osservatrice; e altri nomi e facce
che non rammento. Una bella stagione di ricordi
delicati, di giochi, di amori fragili, di promesse e
amarezze. Talvolta nel Canalone facevo il bagno con il
collega Renzo Di Stefano. Ci cambiavamo nella casa di
una vecchina, che l’affittava per poche lire, e poi un
pescatore ci trasbordava con la sua barca da piazza
Marina all’isola Lachea. Il mare era trasparente.
Rammento che Renzo beveva sempre un poco d’acqua
salata. “Fa bene allo stomaco”, diceva. Una volta provai
a fare la stessa cosa ma vomitai l’anima. Più tardi in
quello specchio d’acqua il preside Arturo Mannino, che
frequentava il giornale e aveva un difficile rapporto col
figlio, fu ucciso dall’elica di un motoscafo che non
poteva attraversare quel tratto di mare riservato ai
bagnanti. Il responsabile, un uomo che a me sembrava
fatuo, se la cavò con niente.
Da ragazzo non leggevo giornali. Era mio padre a
farlo, dopo pranzo. Ci leggeva gli articoli pubblicati
sulla terza pagina del Corriere della Sera e tutta la
famiglia stava ad ascoltarlo. Mi ricordo alcune
prestigiose firme: Giovanni Papini, Alberto Savinio,
naturalmente Indro Montanelli, Guido Piovene, Dino
Buzzati, Orio Vergani, scrittori che hanno segnato la
169
storia della letteratura del Novecento. Amavamo molto
Giovanni Papini, l’ateo per eccellenza diventato poi
cattolico di uguale eccellenza; ma non tanto per ciò che
scriveva (noi ragazzi non potevamo capirlo bene) ma
per il suo essere quasi cieco e l’affidarsi per la lettura
alla nipote Ilaria Occhini che gli prestava occhi e voce.
Forse nacque da lì la vocazione d’attrice della giovane
Ilaria.
Il mio “giornale” era la strada, che “leggevo” dalla
terrazza; erano le pettegole fantasie di Giovanna, la
persona di servizio dei nostri padroni di casa; erano i
racconti di mia madre che conosceva ogni cosa del
quartiere pur standosene a casa a lavorare. Era
un’osservatrice nata, mia madre. In ciò assomigliava
alla zia di Proust, Léonie, che ogni mattina spalancava
la finestra su via dello Spirito Santo, a Combray, come
per aprire il giornale, e si tuffava avida nella folla e ne
scrutava ogni passo ed espressione. E da lì capiva tutto,
o quasi, ricostruiva e inventava e non si dava pace se
qualcosa alla fine non quadrava. Per fortuna c’era
l’affezionata cameriera Françoise che al ritorno dalle
commissioni le raccontava e perfezionava le sue
puntuali immaginazioni. Tale facilità di osservazione e
infantile ricostruzione proveniva dalla controllabilità dei
confini del quartiere, sia quello di Combray, dal quale si
diramavano le opposte strade della tenuta di Swann e di
Guermantes, sia quello di Catania, il Bovio, che prende
nome dalla piazza intitolata al filosofo napoletano e
ideologo repubblicano Giovanni Bovio. Bastava
stabilire un punto di controllo e le persone, che la
limitatezza dello spazio rendeva abitudinarie, le trovavi
e le ritrovavi a ore più o meno stabilite, perché lì era il
loro centro di interesse e di necessità, lì facevano la
spesa,
chiacchieravano,
andavano
a
messa,
comperavano i giornali, osservavano e venivano
osservate. Non c’era bisogno di telefono per comunicare
o sapere le cose, bastava il “telegrafo irlandese”, come
lo chiamava Frank McCourt, che diffondeva le notizie
porta a porta, persiana a persiana, ringhiera a ringhiera,
170
con imprecisione scanzonata.
Mia madre era una casalinga come tante nel
dopoguerra. Rassettava, faceva la spesa, cucinava,
lavava, stirava e, nei lunghi pomeriggi, con i figli che le
si raccoglievano intorno a fare compiti e domande sul
mistero del mondo che magicamente si apriva, trovava
il tempo di rammendare e cucire. Diciotto ore all’in
piedi. Al servizio degli altri. Per sé, un ritaglio di lettura,
un minimo spazio di riflessione, a parte il cinema che la
coinvolgeva come tutti noi. Il filo ha legato la sua vita.
Il filo dell’ago e quello del pensiero, in un metodico
andirivieni, strumento dell’operare e del ragionare,
come acutamente osserva Francesca Rigotti in un
originale saggio in cui si contestano per altro arcaici
pregiudizi, come quello del letterato francese della metà
dell’Ottocento, Frédéric Solulié, il quale osservava che
“le donne tengono in mano la penna come un ferro da
calza e scrivono come rammendassero mutande”. E
invece le donne, armate di quei due fili intrecciati,
hanno dato saggezza al mondo, coi loro libri e la loro
filosofia delle piccole cose, del lavoro silenzioso,
dell’accumulo, dell’ordine e della disciplina. Già in quel
conservare ossessivo negli armadi tutto l’apparente
inutile possibile, i vestiti fuori moda, le lane e gli
scampoli, c’è una grandezza che trascende l’atto in sé.
Mia madre non buttava mai niente, come da antica
saggezza popolare: conserva la pezza per quando viene
il buco. Mia madre conservava tutto: la bomboniera del
mio matrimonio, le medaglie d’oro e d’argento del
Leonardo, le cravatte, gli abiti di mio padre, ordinati e
puliti come se si dovesse ancora indossarli… le riviste
di cinema…
Non appena mio fratello fu in età di seguire per
un’ora e mezzo un film, senza distruggere il sedile e
disturbare gli spettatori, mia madre prese l’abitudine di
condurci allo Spadaro, di pomeriggio, una volta la
settimana. E poiché quelle ore d’incanto non dovevano
sovrapporsi ai compiti e ai lavori domestici, con mia
sorella ci mettevamo subito a studiare, appena alzati da
171
tavola, e poi ad aiutare mamma a lavare i piatti e le
stoviglie, asciugarli, pulire la cucina… in tempo per
cogliere la suggestione del grande schermo. Gli altri
giorni accumulavano l’attesa di altri film. Ma il tempo
passava in fretta perché c’erano tanti sogni da elaborare,
tanti libri da leggere, tanti racconti da ascoltare da
nostra madre mentre concepiva l’ennesimo modello di
vestito per mia sorella. Sul tavolo da pranzo stendeva la
stoffa, acquistata da Matteo Ventimiglia, in via
Umberto, o da Caflish, in via Etnea, la segnava col
gessetto, seguendo le linee del cartamodello, e poi
tagliava, imbastiva e rifiniva alla macchina per cucire,
una Diamant a pedali.
Joan Fontaine, ragazza senza nome, nel 1940 entra a
piccoli passi nella scena di Rebecca, la prima moglie e
la occupa con la forza della sua fragilità. Tratto dal
romanzo di Daphne Du Maurier, il film è uno dei
capolavori di Alfred Hitchcock, alla sua prima
esperienza americana. Opera gotica, senza sorriso e
piena di suspence, che ottiene un grandissimo successo
grazie all’interpretazione della timida e smarrita Joan,
finalmente al meglio delle sue possibilità dopo alcuni
film insignificanti.
L’anno dopo ripete il successo, e conquista l’Oscar
per la migliore interpretazione, con Il sospetto, sempre
del maestro Hitchcock che l’ha presa a ben volere. Al
posto dell’enigmatico Laurence Olivier stavolta c’è
Cary Grant, anche lui ambiguo e inquietante. Vedere il
film e uscirne senza avere lasciato il cuore a Lina
McLaidlaw è pressoché impossibile. Se in Rebecca Joan
Fontaine lotta col fantasma di una donna, in questo
mirabile secondo film combatte col fantasma di un
uomo malvagio che lei sospetta sia il lato oscuro e
terribile del marito. Nella famosa scena in cui Cary
Grant porta alla moglie un bicchiere di latte,
presumibilmente avvelenato, il regista, per focalizzare
l’attenzione del pubblico sul bicchiere, lo illumina
dall’interno con una lampadina. Per decidere il finale
172
del film, poi, organizza un sondaggio tra la gente: il
protagonista deve risultare colpevole o innocente? La
risposta è inequivocabile: il bel Cary Grant non può
essere un assassino.
Ma il finale risulta appiccicato e contrasta con
l’andamento del film. Il passaggio di un Cary Grant da
malvagio a vittima delle circostanze risulta, infatti, poco
credibile. Il finale non piaceva nemmeno a Hitchcock
che avrebbe voluto girarne uno diverso, come confessò
a François Truffaut nel famoso libro-intervista. E il
finale è questo: Cary Grant porta il bicchiere di latte
avvelenato, realmente avvelenato, a Joan Fontaine che
ha appena finito di scrivere una lettera alla madre in cui
confessa che il marito vuole ucciderla. Poi la donna
prende il bicchiere ma prima di berlo, e di morire, dice
al marito: “Caro, per favore, vuoi spedire questa lettera
alla mamma per me?” Dissolvenza, apertura, breve
scena. Cary Grant arriva fischiettando, apre la buca
delle lettere e butta dentro la lettera che lo inchioderà.
Infine, la terza grande interpretazione di Joan
Fontaine: Lettera da una sconosciuta (1948) dell’altro
maestro del cinema Max Ophüls. Anche stavolta
l’eroina lotta con un fantasma di cui si è perdutamente
innamorata: un pianista (Louis Jourdan) che promette
grandi cose ma che poi si perde nell’abulia, nella
smemoratezza e nel rimpianto del talento sprecato. Nella
lettera, Jean scriverà all’amato Louis questa frase
indimenticabile: “Ora so che mai niente accade per
caso: ogni istante ha il suo peso, fino a che anche la
morte appartiene al passato”. Ancora oggi non mi
stanco di vederlo. Il soggetto del film è di Stefan Zweig,
lo scrittore ebreo che nel suo capolavoro Il mondo di
ieri racconta di una generazione, quella dell’Austria
Felix, avviata alla catastrofe morale e politica, così
come aveva fatto, su più alti registri, Joseph Roth. Il
libro, che venne pubblicato postumo, dopo il suicidio
dell’autore, lo lessi a quindici anni e ne feci una tesina
per il professore di storia e filosofia. Allora mi sembrò
una cosa immensa: il libro… e il mio scritto.
173
Se Joan Fontaine era la foglia che trema nel vento,
Lauren Bacall era l’albero. Energica, volitiva, coi piedi
ben piantati a terra, questo era la leggendaria moglie di
Humphrey Bogart. In Acque del Sud, di Howard Hawks,
il film galeotto che la legò al destino del vecchio
Humphrey, lei è semplicemente spettacolosa. Da allora
in poi per il pubblico è stata lo Sguardo. Quando nei
panni di Marie Browing, detta Slim, col suo elegante
completo a zampa di pollo entra nella stanza dell’ex
capitano Harry Morgan e gli chiede un fiammifero
capisci che stai entrando nel vertiginoso mistero della
donna. Lo capisce soprattutto il protagonista che decide
di trasformare la finzione in realtà. Si sposeranno alla
fine delle riprese, nonostante la differenza d’età: lei 20
anni, lui il doppio; lei al primo matrimonio, lui al
quarto. In una conversazione con William Powell, nel
film Come sposare un milionario, Lauren riassumerà il
proprio personaggio, che in quel caso collimava con
quello reale, con questa battuta: “Deve credermi, mi
sono sempre piaciuti gli uomini maturi: metta un
Roosevelt, un Churchill… e quel tardone di Humphrey
Bogart dove lo mette?” Sarà un’unione felice, di quelle
“finché morte non vi separi”. Nasceranno due figli:
Stephen e Leslie, in onore di Leslie Howard, al cui
ricordo Bogart era particolarmente legato: grazie a lui
nel 1936 aveva ottenuto la parte di protagonista in La
foresta pietrificata. L’esangue e romantico Hashley di
Via col vento morirà tragicamente nel 1943 mentre
tornava a Londra in aereo dopo una missione segreta a
Lisbona.
Howard Hawks, di fronte all’amore travolgente di
Lauren e Bogey sul set, che si sovrapponeva alla
sceneggiatura e in parte la condizionava, fu costretto a
rifare alcune scene del film che era ispirato al romanzo
di Ernest Hemingway, Avere e non avere. Le rifece a
malincuore perché anche lui s’era invaghito della
bellissima esordiente pur avendo già una relazione con
Dolores Moran, l’altra protagonista del film. Del resto,
174
del romanzo di Hemingway era rimasto ben poco.
Artefice della manipolazione era stato William Faulkner
che spostò l’ambientazione da Cuba (considerata dal
presidente Roosevelt amica, e quindi intoccabile) alla
Martinica (in mano al governo di Vichy, e quindi
toccabilissima), eliminò vari episodi del romanzo, altri
ne scrisse di sana pianta, modificò alcuni personaggi e li
mise sotto uno stesso tetto, l’hotel Marquis. Tutto in una
settimana.
Gelosia a parte, Volpe grigia, com’era
soprannominato Hawks, impressionato dall’amore
incomprimibile che si andava sviluppando tra Lauren,
ragazza ebrea del Bronx, e Humphrey, uomo del secolo
precedente, riuscì a dare alla finzione scenica una
miracolosa autenticità. Per meglio dire, non fece nulla
per offuscare la passione tra i due protagonisti e li lasciò
liberi di esprimersi. Esprimersi in un film la cui
intelaiatura richiamava il più celebre Casablanca. Come
nella storia raccontata da Michael Curtiz anche qui
Bogart è un personaggio apparentemente cinico e
politicamente disimpegnato, un personaggio che bada
soprattutto al proprio tornaconto ma che sotto sotto è un
romantico, leale con gli amici, tenero con la persona che
ama, e che alla fine rischia tutto per l’idea che gli arde
dentro.
Prima di assumere il cognome della nonna, Bacall, e
approdare da New York a Hollywood, la giovane
Lauren, il cui vero nome era Betty Perske, aveva
ottenuto qualche particina a Broadway ed era stata
fotografata come modella per alcune riviste. A scoprirla
fu la moglie di Hawks, “Acciuga” Gross, impressionata
dagli occhi della ragazza che ammiccava dalla copertina
di Harper’s Bazaar. Anche il marito rimase stregato da
quello sguardo sensuale e capì che di quella ragazza
avrebbe potuto fare una diva. La convocò per un
provino e la scelse, nonostante le perplessità dei suoi
collaboratori, come protagonista di Acque del Sud.
La formazione vincente, regista-attori, si ripropose
due anni dopo con Il grande sonno tratto dall’omonimo
175
romanzo di Raymond Chandler, lo scrittore che diede
vita a uno dei personaggi più affascinanti dell’hardboiled, Philip Marlowe. Il film, “inestricabilmente
complicato”, secondo il giudizio di Morando Morandini,
resta tuttavia una delle vette insuperate del cinema nero
“per la misura di suspence, erotismo e ironia” che
possiede. I due strepitosi attori furono ancora insieme
nel 1947, La fuga di Delmer Daves, e nel 1948, L’isola
di corallo di John Huston. Quest’ultimo film è tratto da
un dramma di James Maxwell Anderson, Key Largo, del
’39. Ma Houston manipolò per ragioni patriottiche il
testo trasformando il protagonista da disertore in
valoroso reduce. Nella parte finale il regista si ispirò al
romanzo di Hemingway, Avere e non avere, pubblicato
due anni prima e che aveva fornito, come s’è visto,
l’intelaiatura ad Acque del Sud. Il maggiore McCloud,
protagonista del film, assomiglia molto al capitano
Morgan, specie quando questi trasporta un gruppo di
gangster dalla Florida a Cuba e poi se ne sbarazza
durante la traversata: le situazioni sono pressoché
identiche. La differenza sostanziale è che nel romanzo
lui muore mentre nel film raggiunge la salvezza e la
ragazza di cui s’è innamorato.
Di questa coppia d’eccellenza, dentro e fuori lo
schermo, il cui amore sembrava eterno come i ponti di
Cesare, fu amico Frank Sinatra. Peccato che dopo la
morte di Humphrey il grande cantante, generoso,
altruista ma terribilmente cinico e amorale, circuì la
vedova, la illuse, se la portò a letto e poi l’abbandonò.
Fece anche di peggio, l’accusò di opportunismo. E non
era vero. A rimetterci, naturalmente, fu solo lei. Perse la
corona di vedova inconsolabile e finì nel tritacarne
implacabile di Beverly Hills.
Oggi Lauren Bacall, nonostante le ottanta primavere
e passa, è una donna energica e combattiva. Alla
conferenza stampa del 2004 a Vienna, tenuta in
occasione della Viennale, sparò a zero contro il cinema
spazzatura e contro George W. Bush definito “il
peggiore presidente che l’America abbia mai avuto”. E
176
ancora non sapeva che alla fine del suo mandato
l’ineffabile Bush avrebbe ammesso che la guerra in Iraq
era stata il suo più grosso errore. Alla faccia del
caciocavallo direbbe Totò. Le scuse non hanno alcun
valore se riposano su migliaia di morti.
Il festival del cinema austriaco le dedicò una
personale di 10 pellicole. “Ormai i film”, disse
l’immortale Lauren “sono girati da uomini d’affari che
mirano al guadagno e non da chi ama davvero il
cinema”. Alla domanda se si riteneva una leggenda
rispose: “Per parlare di leggenda bisogna essere morti”.
Lo stesso giorno, in un’intervista a Time Magazine,
sparò a zero contro Tom Cruise: “Non credo sia un
grande attore”. Ne criticò soprattutto l’ostentazione
degli amori privati, “per farsi pubblicità”, e
l’appartenenza a Scientology, la setta religiosa fondata
da Ron Hubbard. Sull’ex moglie Nicole Kidman
confezionò un aforisma al vetriolo: “A parte l’essere
morti, per diventare una leggenda occorre un passato”.
Nel 1997, la casa editrice Polillo, che si accingeva a
lanciare in Italia il romanzo di Stephen Bogart Suonala
ancora, organizzò un incontro tra l’autore e la stampa.
L’occasione era ghiotta non tanto per il libro quanto per
Stephen Bogart, figlio del grande Bogey e
dell’affascinante Lauren Bacall. Lo incontrai con la
troupe del TG1 all’hotel Trinità dei Monti, in via
Sistina, accanto a Villa Hassler. Era con la moglie che,
curiosamente, somigliava alla suocera: stessa altezza,
magrezza, distinzione. Lui aveva un po’ la faccia del
padre, ma meno tenebrosa, e il sorriso della madre; non
aveva bisogno di mettersi le scarpe col sopratacco,
come faceva l’illustre genitore nel momento in cui sulla
scena doveva abbracciare la moglie (e come fa oggi
Berlusconi); inoltre non fumava e non beveva. Mi disse
che Bogey poteva vivere anche in una stanza, purché
fosse adeguatamente fornita di alcolici e sigarette.
Per non fare la solita intervista seduta, ce ne
andammo giù per la scalinata di Trinità dei Monti.
Pregai anche la moglie di accompagnarci. Volevo come
177
ripristinare il sogno che mi aveva turbato da ragazzo,
ripercorrerlo fino in fondo, capire quanto la realtà
potesse ancora ingannarmi. Era una bella mattinata di
primavera e le azalee erano al massimo della fioritura.
Stavo camminando col figlio di una leggenda.
Parlammo del romanzo, una sorta di noir alla Chandler e
alla Hammett, e di come avesse voluto rendere omaggio
al padre intitolandolo con la sua celeberrima battuta:
“Suonala ancora”. E l’amico Sam nell’appartamento
sopra il Rich’s café di Casablanca cominciò a suonare
As time goes by. Mi parlò dei suoi figli, del suo lavoro
di produttore televisivo, della sua casa nel New Jersey e
dei tanti, non tantissimi, ricordi che lo legavano al
vecchio Bogey. Mentre li salutavo ho pensato alla
fumosa saletta del dopolavoro ferroviario dove per la
prima volta vidi Acque del Sud e m’innamorai della
giovane Slim. Immortale la scena del fiammifero,
immortale l’ancheggiamento finale con cui lei
raggiunge lui e insieme lasciano per sempre l’hotel
Marquis della Martinica.
178
SETTE
Merle Oberon, Veronica Lake, Myrna Loy,
Loretta Young
Quand’ero al ginnasio seguivo le lezioni con i gomiti
appoggiati sul banco, le mani intrecciate a preghiera e
immaginavo, magari sotto l’influsso di un film storico
appena visto, comparazioni interessanti tra il passato e il
passato prossimo, tra la grandezza dell’Impero romano e
la piccolezza del fascismo che a quel mito glorioso
pretendeva ispirarsi. Papà ne parlava spesso. Metteva i
due problemi a confronto, li passava al setaccio e dopo
avervi dato una robusta scrollata ciò che restava
impigliato nelle maglie del suo ragionamento erano lo
jus civitatis e lo jus gentium; e ciò che finiva diritto
nella pattumiera erano le corporazioni, Mussolini e
Sciaboletta, il re che scappò in Egitto lasciando la figlia
Mafalda in mano ai nazisti che la spedirono nel campo
di concentramento di Buchenwald dove morì. Ma queste
erano idee un pochino sovversive per quel tempo.
Catania aveva votato monarchia al referendum e il
fascismo continuava ad essere una nostalgia. Non
avendo conosciuto le lotte partigiane, la protesta dei
cittadini spesso si colorava di nero: il nero delle
camicie, il nero dei pensieri, il nero dei portali dei
palazzi barocchi. Alle elezioni nazionali del 1971 il MSI
si piazzò al secondo posto, con quattro deputati. La DC
ne ebbe solo uno in più. “I voti neri erano maturati”,
scrisse l’inviato del Corriere della Sera Alfonso Madeo
“in un clima di generale disperazione, di frustrazione
popolare, di caotici squilibri sociali. La corruzione,
l’abuso, il clientelismo avevano tolto credibilità alle
strutture stesse dell’organizzazione civile”. Furono
quegli abusi e quella corruzione che travolsero l’onesto,
anche se bizzarro, ingegnere Giuseppe Mignemi che
scontò trentasei giorni di carcere per un’accusa ridicola
che poi cadde al processo, grazie alla difesa
179
dell’avvocato Trantino. Lo andarono a prelevare e gli
misero ai polsi manette nuove di zecca, manette
all’americana, talmente nuove che ebbero difficoltà ad
aprirle. Durante la prigionia scrisse un diario che
nascondeva nel rotolo della carta igienica. Riflessioni,
ricordi, accuse tracciati sui bordi bianchi dei giornali
perché non gli fornivano la carta per scrivere. All’uscita
di prigione, il superiore si mostrò scandalizzato: “E che,
ingegnere, si porta via anche la carta igienica?” La
risposta fu all’altezza del personaggio: “È di un tipo
speciale. Intendo regalarla agli amici che hanno avuto
paura di difendermi”. Tre anni dopo lo storico 1971, al
referendum sul divorzio, i catanesi votarono come la
maggioranza degli italiani. Se ne infischiarono di
Fanfani e di Almirante, alleati di ferro, e lasciarono ai
baciapile il rimorso di non averli capiti.
Ma il Paese restava diviso tra fascisti e comunisti.
Cantore della separazione ideologica, vista tuttavia con
occhio bonario e paternalistico, fu Giovannino
Guareschi che di sé diceva: “Nel mio vocabolario, avrò
sì e no duecento parole… quindi niente letteratura o
altra mercanzia del genere”. Con quelle duecento
parole, però, che magari saranno state quattrocento,
inventava storie di cronaca talmente verosimili che poi,
a suo dire, si ripetevano nella realtà. Il miracolo della
popolarità di Guareschi, scrittore di fede monarchica
odiato sia a destra sia a sinistra, stava proprio in questa
aurea mediocritas oraziana, in questo discendere nelle
parole povere e mediocri dell’inferno per salire in quelle
pure e splendenti del paradiso.
Da uomo tutto d’un pezzo, bastian contrario fino
all’autodistruzione, riuscì nella sua vita a scontentare
tutti. Nel 1942 fu arrestato per offese a Mussolini,
l’anno dopo finì nei lager nazisti per essersi rifiutato di
aderire alla Repubblica di Salò, nel dopoguerra venne
condannato due volte: la prima per avere offeso il
presidente Einaudi, la seconda per avere diffamato De
Gasperi. Questo secondo processo fu particolarmente
odioso per la gravità delle accuse. Sul settimanale
180
Candido Guareschi aveva pubblicato due lettere,
risultate false, con le quali il futuro presidente del
consiglio chiedeva nel 1944 agli alleati anglo-americani
di bombardare la periferia di Roma allo scopo di
demoralizzare i collaboratori dei tedeschi. Condannato
in prima istanza, avrebbe potuto evitare il carcere se si
fosse convinto di ricorrere in appello, e in questo senso
si adoperò il ministro Scelba. Ma Guareschi era
Guareschi e quindi, per coerenza, rifiutò quella “via di
fuga”. Guareschi come l’ultimo dei moicani, insomma,
l’ultimo esemplare di un mondo la cui complessità a
volte gli sfuggiva perché era onesto fino alla grazia e al
candore, perché riusciva a inventare storie che non
sempre si perpetuavano nella realtà e nella verità della
vita.
Con appena duecento parole, o quelle che sono,
Giovannino Guareschi è riuscito a creare due
formidabili personaggi, don Camillo e Peppone, e a
vendere in tutto il mondo 20 milioni di libri. Due
personaggi che saranno rilanciati nel cinema da
Fernandel e Gino Cervi e che hanno divertito e
affascinato generazioni di democristiani e comunisti.
Perché questo era lo scrittore, al di là delle durezze
ideologiche: un artista nel mezzo della corrente, un
uomo che ha sempre cercato di non farsi travolgere,
anche se non sempre si è salvato. Di fronte a questa
scommessa vinta cade tutto. Cade l’ideologia, cade il
risentimento, crolla il pregiudizio. Duecento parole!
Messe in fila non arrivano a definire quasi niente di ciò
che ci angoscia “in questo mondo di ladri”, come canta
Antonello Venditti, ma precisano in maniera mirabile la
terra di provincia in cui viviamo, il paese che adoriamo,
la gente con la quale ci piace parlare e magari litigare.
Se Leopardi ha descritto l’infinito, Guareschi ha messo
il cannocchiale a rovescio e ci ha fatto vedere l’infinito
all’incontrario, il mondo piccolo che non ha bisogno di
grandi e spesso astrusi concetti ma di valori veri che
puoi ricordare, e fartene cullare, alla fine d’una giornata
di lavoro, chiudendo gli occhi e ringraziando chi c’è da
181
ringraziare.
In fondo, il prete e il comunista rispecchiano l’onesta
ambiguità del controverso scrittore. Gene Gnocchi
avrebbe detto che la tonaca nera e il fazzoletto rosso
sono stati il ventricolo destro e quello sinistro di
Guareschi che fu, in ogni caso, monarchico di cuore e
ribelle di mente. E fa impressione rileggere certi articoli
maramaldeschi che furoreggiarono all’epoca delle note
vicende giudiziarie. Azione giovanile, rivista della
Gioventù italiana di Azione cattolica, titolò un’intera
pagina con queste parole: “Guareschi ovvero lo
scarafaggio”. Quei cattolici avevano dimenticato, per
risentimento personale, quanto lo scrittore aveva fatto
per la vittoria democristiana nel 1948. Memorabili e
fantasiosi erano stati i suoi slogan contro i comunisti
“trinariciuti”, come li definì: la terza narice serviva a
fare uscire il cervello dei militanti per portarlo
all’ammasso del Partito che aveva il compito di
“pensare” per loro. Graffianti e geniali erano quelle
fulminanti trovate: “Nel segreto dell’urna Dio ti vede,
Stalin no”, “Mamma, votagli contro anche per me”… il
voto era reclamato dallo scheletro di un soldato italiano
dietro reticolati sovietici. Alle parole vili e volgari del
periodico cattolico Giovannino Guareschi rispose a
modo suo, come s’è visto, entrando nel carcere di San
Francesco, a Parma, per trascorrervi 14 lunghi mesi di
rivolte spirituali e rimorsi. Lasciando la prigione,
ricorda Enzo Biagi, portò con sé tre sacchi di lettere,
speditegli dai suoi lettori, e una profonda amarezza. Poi
la grande confessione: “Mi sono sbagliato. De Gasperi,
se ci ripenso, era il migliore. Se ne andò, quand’ero in
prigione, e me ne dispiacque”.
Non è vero che il mondo resti lo stesso, non è vero
che siamo tutti uguali. Oggi Guareschi avrebbe fatto sue
le parole di Giorgio Gaber, “Io non mi sento
italiano…”, lui che italiano era fino al midollo, che
amava la sua provincia, che era fatto per le cose
semplici e buone, ma che a vedere il Paese ridotto
com’è alla rappresentazione televisiva di se stesso
182
avrebbe di sicuro cominciato a cantare: “Mi scusi
Presidente/ non è per colpa mia/ ma questa nostra
Patria/ non so che cosa sia…” Guareschi aveva pagato
per le sue idee, a volte conformistiche a volte ribelli,
aveva lottato per costruire un mondo migliore ma quel
mondo aveva cominciato a corrompersi. I funerali di
questo grande ribelle senza patria ma che la patria aveva
amato moltissimo furono celebrati sotto lo stemma
sabaudo (ma forse lui restò monarchico “perché non
c’era più il re”). Le uniche persone degne del nome che
vi parteciparono furono Enzo Biagi ed Enzo Ferrari. Si
scoprirono il capo e pregarono, perché erano fieri di
essere stati amici di una persona che aveva pagato per le
sue idee e per i suoi sbagli. Quel giorno il Potere, che
Guareschi aveva sempre sbeffeggiato, si nascose. Non
trovò nemmeno una scintilla d’umana pietà per dargli
l’ultimo saluto. Talvolta, parafrasando Giulio Verne, è
più difficile trovare persone perbene nel nostro infelice
Paese che in un penitenziario del Bengala.
Alla fine di tutto, che cosa possiamo dire di
Giovannino Guareschi? Che fu un clericale e un piccolo
borghese? Fu un cattolico, profondo e impegnato, non
un clericale. In lui, come disse una volta il cardinale
Carlo Caffarra, arcivescovo di Bologna, c’era la sintesi
della sapienza cristiana e della sapienza umana. Fu un
borghese, certo, ma piccolo soltanto di tasca e grande di
cuore. In definitiva, fu un uomo di difficili costumi.
Se il professore faceva una domanda, non puntavo
l’indice in aria, non lo facevo per timidezza, anche se
conoscevo la risposta. Odiavo i fanfaroni della sapienza
illustrata, i fasulli ben vestiti e pettinati come ometti che
giocavano a fare gli ometti. I docenti, di solito,
cadevano nella trappola, e non cercavano altre risposte
nella categoria degli acquattati. Se la domanda
deflagrava nelle retrovie, dove di solito stavano seduti
gli ultimi della classe, erano scene penose di “non
ricordo” e di appelli disperati con lo sguardo ai
compagni vicini. Mi rammento di un ragazzo con vari
183
problemi irrisolti che se ne stava rintanato tra le braccia
e ogni tanto, per sciocca emulazione, alzava la mano
anche se non sapeva la risposta. Si alzava, esprimeva un
timido sorriso circolare e faceva scena muta. Incalzato
dal professore diceva: “Ce l’ho sulla punta della
lingua”. Tornava a sedersi, dapprima confuso poi
soddisfatto perché pensava che il professore e gli stessi
compagni fossero caduti nella trappola, si fossero cioè
convinti che soltanto la timidezza gli avesse impedito di
rispondere. Di recente, in Gran Bretagna, il ministero
dell’Istruzione ha suggerito agli insegnanti delle scuole
elementari di scegliere loro chi interrogare perché di
norma gli scolari timidi si fanno travolgere
dall’esuberanza dei più intraprendenti che scalpitano dai
banchi per mettersi in mostra e rendono invisibili i
compagni passivi e insicuri ma non meno bravi.
Bambino invisibile, dunque, avevo come unico e
perverso alleato un batticuore ossessivo e paralizzante.
Spesso me ne stavo nascosto nella mia nebulosa
sognante, cercando, se la lezione era di tutto riposo, una
trama di racconto per i miei amori di celluloide. Me ne
strappavo solo quando un mio compagno, di abissale
svogliatezza, interrogato dal professore, si alzava e
ripeteva, ogni volta: “Francamente, non mi sento
preparato”. All’ennesima franchezza il professore non
ebbe dubbi: “Francamente non ti credo. Due meno
meno”. Era un alunno che “scaldava il banco”, come si
usava dire per i ragazzi svogliati. Nelle scuole pubbliche
però erano i banchi a scaldare gli alunni: le aule erano
gelate e i ragazzi, che normalmente tiravano su col naso
in mancanza di fazzoletti, indossavano vestiti che se ne
infischiavano delle stagioni perché possedevano la
perfetta coerenza della miseria.
Il giorno dopo avere visto La voce nella tempesta mi
feci un lungo viaggio nelle brughiere dello Yorkshire
mentre il professore di religione tentava un accordo
impossibile tra il Vecchio Testamento e la mia
disattenzione. Certo, il povero Isacco non aveva armi
184
possibili contro Merle Oberon e la sua passione
disperata e intermittente per Laurence Olivier.
Impossibile accordo per me, impossibile per i miei
compagni impegnati anch’essi a elaborare il loro cinema
privato, che ovviamente era anche il mio: le ragazze del
Sacro Cuore, per esempio, che studiavano nell’istituto
accanto al nostro, oppure la partita della nazionale che
la radio avrebbe trasmesso nel pomeriggio.
La domanda è: può una persona che non ha mai
conosciuto l’amore, che ha vissuto sempre in casa, che
ha seguito l’avvicendarsi delle stagioni sperando sempre
che qualcuno bussi alla porta e la conducavia, che ha
consumato la mente nella lettura e il cuore nella
speranza, può questa persona essere in grado di scrivere
una storia d’amore immortale? La risposta è no, se
parliamo di persone comuni. La risposta è sì se parliamo
di Emily Brontë, l’autrice d’uno dei romanzi più belli
della letteratura romantica di tutti i tempi, Cime
tempestose. Il film, girato da William Wyler nel 1939,
tradisce il libro ma in qualche modo lo esalta. Il finale
non è quello immaginato dalla scrittrice. La passione
che divora il protagonista Heathcliff per la ribelle Cathy
va oltre la morte di lei e si traduce visivamente nel
viaggio della coppia maledetta verso un improbabile
aldilà di nuvole e di sogni. Ma questa soluzione dà una
forza simbolica così convincente al film da condizionare
il romanzo stesso.
Chi ha visto prima il film di Wyler e poi ha letto il
libro si trova a percorrere una strada obbligata, a leggere
una specie di fotoromanzo, perché le immagini di Merle
Oberon e di Laurence Olivier non lasciano spazio
all’immaginazione ma obbligano il lettore a sovrapporle
a quelle dei protagonisti del romanzo. Un po’ come
accade con il Nerone di Peter Ustinov. L’attore era
talmente perfetto nella parte che da lì in avanti
l’imperatore incendiario non avrebbe avuto, nel
pensiero dei lettori, che la sua faccia e la sua
corpulenza.
Merle Oberon aveva una bellezza insolita e
185
misteriosa. Era nata in Tasmania (suo padre era ufficiale
dell’esercito inglese) ed aveva studiato a Calcutta. Con
Laurence Olivier aveva girato l’anno prima in
Inghilterra un filmetto a colori appena sopra la banalità,
L’avventura di Lay X, di Tim Whelan. Al ruolo di Cathy
aspirava Vivien Leigh che in quegli anni, sebbene
sposata, s’era perdutamente innamorata di Laurence
Olivier e voleva stargli accanto nella trasferta
americana. Ma Wyler fu di diverso avviso. Di certo,
però, la bella e volitiva Vivien, recitando accanto
all’amante, avrebbe saputo rendere al meglio quel misto
di passione selvaggia e di ambiguità che c’è nella
protagonista del romanzo. Fu una buona scelta,
comunque, perché Merle Oberon riuscì a entrare
nell’anima del personaggio con intelligenza e a sancire
lo straordinario successo del film. L’ottimo risultato
però fu ottenuto a costo di gravi tensioni durante la
lavorazione perché Laurence prese a strapazzarla per il
solo fatto di essere stata preferita all’amata Vivien. La
volta che Merle Oberon, come racconta Donald Spoto
nella biografia dedicata a Sir Laurence, si lamentò che
durante una scena particolarmente intensa le erano
arrivati gli spruzzi di saliva dell’esagitato partner,
l’attore si infuriò: “Puttanella dilettante! Per l’amor di
Dio, che cosa vuoi che sia un po’ di saliva, tra attori!
Piccola idiota!” Episodio a parte, Laurence continuò a
trattarla come “una conquista da quattro soldi di
Korda”. Alludeva al regista Alexander Korda che, ironia
del caso, era stato anche l’amante di Vivien Leigh
quando l’attrice era scivolata nel suo letto per entrare
meglio in quello del grande Olivier. Di quelle furibonde
liti sul set nulla traspare nel film.
Chiuso tra le pagine del libro della Garzanti, che sta
nella biblioteca di mio padre, c’è il fotogramma di una
scena nella quale i due attori guardano sognanti le cime
tempestose della brughiera, le Wuthering Heights.
Un’immagine superba, ritagliata da una rivista, che
legittima l’Oscar a Gregg Toland per la migliore
fotografia. All’inizio degli anni Cinquanta la Garzanti,
186
riallacciandosi alla tradizione dei Fratelli Treves, lanciò
sul mercato una nuova collana, Amena (Attraente), che
raccoglieva le migliori opere della narrativa
contemporanea e del passato, tra cui Cime tempestose.
Nella seconda di copertina del romanzo della Brontë c’è
scritto tra l’altro, in un italiano faticoso: “Tra le molte
opere ormai pubblicate, tutti possono trovare una lettura
piacevole, che solleva lo spirito nelle ore del riposo e,
ciò che pure ha il suo peso, che costa la metà di un
biglietto d’ingresso al cinema”. Il conflitto tra cinema e
letteratura è già evidente. Il pubblico comincia a
preferire l’incanto dello schermo a quello della pagina
scritta. Più tardi il cinema, che ha messo in ginocchio i
libri, con l’avvento della televisione subirà la stessa
legge del contrappasso. Il libro in oggetto costava 500
lire, ed era un Oscar Mondadori ante litteram. Sulla
copertina c’è la foto a colori di Merle Oberon e
Laurence Olivier, ma meno bella di quella appena
descritta, mentre sul frontespizio è segnata a matita una
frase: “Non posso vivere senza la mia vita, non posso
vivere senza la mia anima”.
Il giorno in cui caddero le prime bombe a Catania,
che fecero strage di civili, mio padre era al lavoro, nella
farmacia di Spadaro Ventura, e mia madre, a casa, stava
lavorando a maglia. Uno dei micidiali ordigni, che
potevano pesare fino a una tonnellata, cadde in via
Ventimiglia, a due passi dalla nostra abitazione. Senza
pensarci due volte, mia madre afferrò me e mia sorella,
appena in grado di camminare, e a piedi corse alla
stazione, seguita da zia Sara, la sorella maggiore, che
aveva con sé una valigia in cui aveva stipato vestiti e un
poco di biancheria. Correndo verso piazza dei Martiri si
ricordò del marito. Non gli aveva lasciato nemmeno un
biglietto. Pensò di tornare, ma ormai era troppo tardi, le
Fortezze Volanti potevano rifare il giro e sganciare un
altro carico di morte. Pazienza. Mio padre avrebbe
capito. Da qualche mese, infatti, si pensava di
raggiungere uno dei paesini dell’Etna che cominciavano
187
a raccogliere un numero sempre crescente di sfollati. Il
treno ci fermò a Giarre e da lì prendemmo la corriera
per Sant’Alfio, dove arrivammo in un pomeriggio di
sole spento e di paura rasserenata. Mio padre giunse a
tarda sera, in bicicletta. Trenta chilometri di pedalate
tutte in salita. Furono più lacrime che abbracci. Che
fatica allora. Per due mesi mio padre fece quella mala
vita. Scendeva la mattina, aiutato da tutti i santi del
paradiso, e saliva la sera, sempre in bicicletta, nel
disinteresse degli stessi santi che s’erano impegnati a
spingerlo nella discesa verso Catania. Uno di quei
lunghi giorni di angoscia e affanni stava per concludersi
in modo tragico. Mio padre era andato a procurare un
sacco di farina in un mulino vicino a Randazzo, lo
aveva sistemato sul portapacchi della ruota posteriore e
stava tornandosene soddisfatto a Sant’Alfio quando si
accorse improvvisamente che da una parte all’altra della
strada era stato steso un filo di acciaio. Fu un attimo.
Lanciò la bicicletta in avanti e si gettò a terra. Salvo per
miracolo, di riflessi. Quel filo avrebbe potuto tranciargli
la testa. Arrivò a casa lazzariato, ma contento di avere
salvato la farina. “Per una settimana siamo a posto”,
disse scaricando il pesante sacco sul tavolo della cucina.
Mia madre per poco non svenne. Lo medicò con cura,
gli scrostò il terriccio rimasto attaccato alle ferite e,
piangendo, disse: “Non so come avrei fatto”.
Il nostro padrone di casa, a Sant’Alfio, aveva un
cugino americano, figlio di un fratello del padre
emigrato negli Stati Uniti ai tempi della fillossera, un
micidiale parassita delle piante che distrusse alla fine
dell’Ottocento in Europa milioni di ettari coltivati a
vigneto mandando sul lastrico un numero
impressionante di famiglie. Questo cugino faceva
l’operatore di cabina in un cinematografo di Los
Angeles e per darsi un tono si vantava di conoscere
personalmente molti divi di Hollywood le cui foto,
accompagnate da lettere mirabolanti, spediva al parente
siciliano. E questi le mostrava con orgoglio al popolo
degli sfollati che imparavano a sognare quel mondo di
188
celluloide che il regime fascista aveva cercato di
appannare. Alcune delle “figurine”, quali erano in realtà,
furono regalate a mio padre e con gli anni finirono nella
mia scatola del Plasmon piena delle meraviglie
dell’infanzia: biglie colorate, un coltellino, una bilancia
fatta con i coperchi del lucido da scarpe Brill, lamette,
monete antiche, una fionda. La più bella, forse, era
quella di Veronica Lake, la diva bionda coi capelli “a
nascondino”, che negli anni dei bombardamenti sulla
Sicilia aveva girato film come I dimenticati, La chiave
di vetro, Il fuorilegge e il divertente e raffinato Ho
sposato una strega di René Clair, che avremmo visto
negli anni Cinquanta.
Molte altre cose avremmo saputo dell’attrice che con
Alan Ladd, il piccoletto dalla faccia romantica, tentò di
rifare il verso alla più celebre e collaudata coppia del
cinema di quel tempo: Humphrey Bogart e Lauren
Bacall. Alan Ladd era poco più alto di Mino Maccari e
Leo Longanesi sui quali al tempo del Fascio circolava
questa fulminante battuta: quando non riescono a
prendere sonno passeggiano nervosamente sotto il letto.
In minimis maximus Deus? Stavano bene insieme, Alan
e Veronica, non fosse altro che per l’altezza. Lei appena
sopra il metro e mezzo. Una minidiva, insomma, per
altro con poco seno e stretta di spalle, ma che reggeva il
primo piano alla grande, anche se l’attrice diceva di non
essere mai stata un sex symbol ma un sex zombie.
Eppure il suo viso era di una bellezza entusiasmante. Il
taglio di capelli, detto peek-a-boo, che le nascondeva
mezza faccia, fece impazzire le americane al punto che
molte fabbriche, per evitare incidenti sul lavoro,
obbligarono le operaie a lavorare coi capelli raccolti
dietro la nuca. Una delle sue fans sarebbe stata decenni
più tardi l’attrice Miriam Bertolini, che avrebbe
cambiato il suo nome in Veronica, Veronica Lario, oggi
seconda e battagliera ex moglie di Silvio Berlusconi.
Prima di separarsi ha avuto il coraggio e la dignità di
condannare l’esuberanza extramaritale del marito e certe
sue scelte politiche.
189
La vita di Veronica Lake fu più che infelice. La
prima volta si sposò con l’art director John Stewart
Detlie, un uomo solido, intelligente, che aveva
disegnato chiese e palazzi del centro di Honolulu.
Nonostante fosse al sesto mese di gravidanza girò I
dimenticati di Preston Sturges, anno 1942.
Fortunatamente la bambina, Elaine, nacque senza
problemi, ma il secondo figlio, William, concepito e
portato avanti durante le riprese di un altro film, Un’ora
prima dell’alba di Frank Tutle, morì sette giorni dopo
avere visto la luce anzitempo. Era nato prematuro
perché la madre, mentre stava girando una scena,
calpestò inavvertitamente un cavo elettrico. Alla fine di
quell’anno, il 1944, il matrimonio si concluse con un
divorzio. E Veronica cominciò a bere.
Si sposò una seconda volta, con André de Toth. Ebbe
due figli, Michael e Diana, poi scomparve dalle scene,
dopo un processo per bancarotta, sostenuto col marito.
Inevitabile il divorzio. Ogni tanto un titolo di giornale
riportava la notizia di un suo arresto per ubriachezza,
fino a che un giornalista, ed erano passati dieci anni, la
scovò in un locale dove lavorava come barista (forse
perché le bottiglie erano a portata di mano). Non ancora
cinquantenne si riprese, tornò faticosamente al lavoro.
Piccole parti. Si sposò una terza volta, con un musicista,
e una quarta, con un capitano di marina inglese dal
quale non fece in tempo a divorziare perché un’epatite
fulminante la trascinò nella tomba.
Non era scaltra, Veronica Lake, forse non era
nemmeno perspicace come molte sue colleghe che per
restare a galla pagavano gli elogi, come dice Balzac, e le
più abili pagavano le critiche. Ma pagare spesso non
basta. Non era una donna pratica, insomma. Non era
come Ingrid Bergman, per dire. Quando Rossellini,
dopo il divorzio, andava a trovare i figli, le volte che si
trovavano con la madre all’hotel Raphael, a Parigi,
come racconta Charlotte Chandler nella biografia
dedicata a Ingrid Bergman, e portava loro regali
incredibili, come un cucciolo di canguro o una
190
scimmietta, l’attrice svedese se ne lamentava: “Ma
perché ai bambini non porti mai vestiti e scarpe?”
Sic transit gloria mundi. Lo diceva spesso mio padre
nel suo limpido sforzo di educarci al rispetto degli altri e
di noi stessi, nel suo incessante ammonirci che senza
sacrificio e impegno non c’è futuro, perché la vita non
regala nulla e si vendica se non fai il tuo dovere.
Nessuno di noi figli ha mai fumato una sigaretta perché
da piccoli eravamo bombardati dalle sue requisitorie sui
pericoli del fumo. E noi l’ascoltavamo con attenzione e
rispetto perché aveva l’autorità per dirci quelle cose.
Lui, come del resto mia madre, non aveva mai fumato.
E non ho mai guardato con invidia o complessi di sorta i
miei compagni che già al liceo tiravano qualche Alfa o
Nazionale Esportazione per darsi un tono e fare colpo
sulle ragazze. Più tardi, la rappresentazione di quella
supposta maturità si sarebbe trasformata in vizio, che
incatramava i polmoni, sporcava i denti e rendeva l’alito
insopportabile. In compenso, sono stato un accanito
fumatore passivo.
Quand’ero a La Sicilia, la redazione Interni-Esteri,
dove lavoravo, diventava dopo alcune ore una fumeria.
Allora mi alzavo, spalancavo e cominciavano le
proteste. Ero troppo giovane per meritare la mia piccola
libertà. La giovinezza mi veniva invidiata e
rimproverata, talvolta diventava paradossale pretesto per
non farmi “crescere”, per farmi restare nell’età
dell’eterna attesa… di promozioni, aumenti di stipendio,
viaggi. Un collega particolarmente freddoloso, Orazio
Francica Nava, che sentiva spifferi fastidiosi anche in
pieno agosto, una volta mi propose scherzosamente:
“Perché non impari a fumare anche tu?” Fantastico. Il
vecchio Orazio (i lettori ricorderanno i suoi servizi di
medicina su Antenna Sicilia) non aveva rivali nel dettare
le notizie “a braccio”, senza averle cioè prima maturate
e poi scritte. Era corrispondente del Giornale di Sicilia e
quando i colleghi della redazione Cronaca
l’informavano di una grossa notizia di nera, lui si faceva
191
raccontare per sommi capi, si attaccava al telefono e
trasmetteva il pezzo a Palermo. Non meno di una
colonna. Un mostro. Costruiva la notizia davanti a noi,
con particolari del tutto inventati ma verosimili, e ogni
tanto sorrideva facendo ruotare il braccio libero come
per dirci: “Minchiate comu ’i trona!” Quell’abilità era
comune a molti giornalisti costretti ad allungare il brodo
delle notizie per puro calcolo economico. Prima della
guerra e subito dopo, infatti, gli articoli venivano pagati
secondo la lunghezza. Il che, per molti anni, renderà i
giornali di provincia prolissi e illeggibili, ripetitivi e
adulatori. Per solito, la critica ha bisogno di meno
parole e maggiore intelligenza per esprimersi, mentre
l’elogio cresce su se stesso e affoga negli aggettivi.
Orazio, che vantava nobili natali, veniva a lavorare in
giacca e cravatta. Inappuntabile. Solo la domenica
indossava maglioni naviganti e pantaloni sformati ai
ginocchi. Lo faceva per distinguersi dagli operai che per
tutta la settimana lavoravano in tuta e solo la domenica
potevano permettersi di indossare l’abito dei signori.
Un vecchio collega, ormai scomparso, Massimo
Caporlingua, sosteneva che la notizia sta tutta nelle
prime cinque righe, il resto è accademia. Il resto era la
simpatica logorrea del barone Orazio, discendente dalla
famiglia del cardinale Giuseppe Francica Nava, che
dettava per fatti e “ricami”, sperando che gli eventuali
tagli non compromettessero troppo l’entità del
guadagno. Se n’è andato dopo una lunga tenace
malattia. Enzo Trantino, su La Sicilia, lo ha ricordato da
par suo: “Pensando al garbo, al sorriso intelligente, alla
grazia discreta… pensando all’interesse per l’altro…
pensando a tanta innocente delibera di entusiasmo senza
eccessi, rendo onore a Orazio, di professione ‘signore’,
senza pause, senza ostentazioni”.
Nel giro d’una settimana, nel mese di agosto del
2007, assieme al giovane vecchio Orazio partirono per il
regno delle ombre Giancarlo Bonaccorsi, archivista de
La Sicilia, eterno vinto di se stesso, che un giorno di
tanti anni fa fece con me una scommessa: suonare per
192
intero al pianoforte, di cui era un discreto esecutore, il
concerto di Varsavia di Addinsell (non vinse la
scommessa ma vinse la mia completa amicizia); e Tony
Barlesi, compagno di scuola al Leonardo da Vinci, buon
cronista, ragazzo ironico e per bene, che ha ispirato al
collega Tony Zermo questo finale: i giornalisti non
muoiono, semplicemente scompaiono.
“La vita non è un avere e un prendere, ma un essere
e diventare”. Parola di Myrna Loy, “la regina di
Hollywood”, l’attrice elegante colta e ironica che
voleva diventare infermiera e occuparsi di bambini
prima di restare folgorata dalla magica atmosfera del
palcoscenico di celluloide. Il critico Pietro Bianchi ha
raccontato che da giovane, a Parma, aveva visto tutti i
suoi film perché n’era perdutamente innamorato. E un
altro ha confessato la strana mania di indossare l’abito
della domenica a ogni prima di un film con la diva e di
lasciare alla fine dello spettacolo un bouquet di violette
sulla poltrona dove stava seduto. Strana feticistica
mania. Non ricordo di avere visto, nel caro e mai
dimenticato dopolavoro ferroviario, i film de L’uomo
ombra, con Nora e Nick, che sancirono il successo
dell’attrice. Molte di quelle pellicole, girate in coppia
con William Powell, le ho viste in anni più recenti e
solo in TV. Allora furono un grande successo. Oggi
accusano gli anni, come una vecchia signora che si
ostina a restare giovane camuffandosi con creme e
belletti. Soprattutto William Powell è un detective Nick
che sa di brillantina e fatuità. Ma lei, la sofisticata
Myrna, resiste con classe all’usura del tempo.
Molto spesso nelle televisioni locali viene mandata
in onda La casa dei nostri sogni, di Henry C. Potter,
1948, ed io sono lì, puntuale, a seguire la vicenda del
pubblicitario di New York e della sua famiglia che
s’indebita per comperare e ristrutturare una villa nella
campagna del Connecticut. I protagonisti sono in gran
forma: Myrna Loy, Cary Grant e Melvyn Douglas. La
famiglia americana assume in questo film la
193
meravigliosa simbologia di se stessa: felice senza
eccessi, serena con qualche nube, unita nelle difficoltà
della vita. Un po’ come dieci anni prima nel film di
Michael Curtiz, Quattro figlie, con le sorelle Lane
(Rosemary, Priscilla, Lola) e Gale Page. Film per
famiglia, che rispecchiavano l’etica di una società
puritana e tradizionalista. E su questa falsariga
Hollywood scatenerà i suoi migliori talenti:
l’antesignana Mary Pickford, Shirley Temple, Judy
Garland, Deanna Durbin.
In fondo, era la rappresentazione, in piccolo, della
mia famiglia: né ricca né povera, né originale né scialba,
né illusa né disincantata. Al calar della sera, l’unico
svago era la radio, un Allocchiobacchini a valvole che
troneggiava nel salotto e che avevamo acquistato a
violino (a rate). Ascoltavamo l’orchestra del maestro
Cinico Angelini e quella del maestro rivale Pippo
Barzizza. Una rivalità per modo di dire perché i due
artisti si rispettavano. Ma l’Italia del tempo si divideva
su tutto: su Coppi e Bartali, democristiani e comunisti,
laici e cattolici, Nord e Sud, polentoni e terroni… (mi
sono scordato com’è la situazione oggi). Angelini aveva
avuto il merito di rilanciare nel dopoguerra Nilla Pizzi,
allontanata dalla radio nel 1942 perché il regime fascista
riteneva la sua voce troppo sensuale. La cantante rientrò
a guerra finita e cominciò a riscuotere i primi successi
con Dopo di te, Che si fa?, Bongo bongo, Avanti e indrè
e O mama mama. Canzoni allegre in cui la sensualità
aveva margini molto stretti. Fu il festival di Sanremo,
inaugurato nel 1951, a dare lustro al maestro Cinico
Angelini e a Nilla Pizzi che vinse il primo e il secondo
premio rispettivamente con Grazie dei fiori e La Luna si
veste d’argento. Con gli anni Cinquanta si apriva la
voce calda e morbida della nuova regina della canzone
italiana. “Grazie dei fior/ fra tutti gli altri li ho
riconosciuti/ mi han fatto male eppure li ho graditi/ Son
rose rosse e parlano d’amor…” Sul finale di
quell’amore ormai estinto partiva la commozione: “…
addio/ per sempre addio/ senza/ rancor”.
194
L’anno dopo è un trionfo ancora più grande. Vince il
primo, il secondo e il terzo posto: Vola colomba (che
accompagna il ritorno di Trieste all’Italia), Papaveri e
papere(che viene tradotta in 40 lingue e adottata dal
partito comunista per i manifesti della campagna
elettorale di quell’anno), Una donna prega. Sempre nel
1952 nasce il festival di Napoli che lei vince
regolarmente con Desiderio ’e sole, piazzandosi anche
al terzo posto con Mergellina. Una cosa mai vista. Al
vertice della popolarità, incide decine di dischi che
diventano altrettanti successi. Poi il lento declino tra
amori contrastati: Gino Latilla, che si è innamorato di
lei, tenta il suicidio, e il maestro Angelini, dopo un
rapporto durato anni, la lascia. Si può dire che la sua
sfolgorante carriera si arresti davanti alla modernità, di
fronte al volo fantastico di un omino dipinto di blu che
arriva al cuore della gente grazie anche alla televisione.
Rievocando su la Repubblica i quarant’anni di
Volare, Edmondo Berselli scriveva: “Vola Modugno, si
solleva sugli anni Cinquanta, si sporge sul decennio
successivo… e il suo librarsi in volo, autentico ‘angelus
novus’ della canzone, rivela la consapevolezza di
un’Italia diversa, che ci è già cambiata sotto il naso”.
Sei anni prima, profeticamente, una delle più belle
canzoni di Nilla Pizzi, Vola colomba, parla di una donna
che vorrebbe volare verso il suo amore. Di solito
cominciava mia sorella. “Dio del ciel se fossi una
colomba/ vorrei volar laggiù dov’è il mio amor,/ che
inginocchiato a San Giusto/ prega con l’animo mesto:/
fa che il mio amore torni/ ma torni presto…”
Sanremo vuol dire anche Sicilia. Palermitano era
Nunzio Filogamo, che inaugurò la rassegna nel ’51, con
quella sua vocina ibrida e metallica (Miei cari amici
vicini e lontani, buonasera! Buonasera ovunque voi
siate), e catanese Pippo Baudo (tredici edizioni) che il
festival se l’è cucito addosso e ancora non si trova
nessuno in grado di rimpiazzarlo come si deve. Ma tra il
principio e la fine ci sono stati altri personaggi che a
Sanremo hanno dato dignità come il presentatore
195
Nuccio Costa (due edizioni: nel ’69 in coppia con
Gabriella Farinon e l’anno successivo con Enrico Maria
Salerno e Ira Fuerstemberg), i cantanti Marcella Bella e
suo fratello Gianni, Carmen Consoli e Gerardina
Trovato, Giusy Romeo (che diventerà Giuni Russo) e
Corrado Lojacono (grasso e leggero come le figure di
Botero), per non dire del sottosegretario Francesco
Turnaturi che, come ricorda Sergio Buonadonna, scrisse
il testo della canzone Io credo portata in finale nel ’75
da Nico dei Gabbiani. “I miei pezzi migliori”,
confesserà “li ho sempre scritti sui banchi di
Montecitorio”.
Febbraio 1970. Ventennale del festival. Di solito,
l’avvenimento era seguito dal collega Sandro Delli
Ponti de Il Resto del Carlino (in allarmante sospetto di
iettatore) che mandava l’articolo in copia anche a noi.
Ma quell’anno il quotidiano bolognese pensò di
riprendersi l’esclusiva e così improvvisamente ci
trovammo scoperti. Non si poteva tuttavia lasciare
cadere la cosa sia per l’importanza dell’avvenimento sia
perché Nuccio Costa premeva che ci fosse un giornalista
siciliano a scrivere del festival e di conseguenza della
sua prestazione. Nuccio per altro era amico del
condirettore Piero Corigliano nonché della redazione e
quindi gli fu facile convincere la direzione a spendere
qualche soldo. E così dall’oggi al domani toccò a me
occuparmi del festival.
Non ero ancora giornalista professionista ma ne
scrissi con impegno e passione, e un poco frastornato
per essere in mezzo al gotha della musica leggera
italiana e tra tanti colleghi blasonati. Ho ancora negli
occhi la figura di Enzo Tortora chino sulla macchina per
scrivere mentre costruisce il suo pezzo per La Nazione
di Firenze. Era stato da pochi mesi licenziato dalla Rai
perché aveva paragonato l’azienda, in una intervista al
settimanale Oggi, a “un jet supersonico pilotato da un
gruppo di boy-scout che litigano ai comandi rischiando
di mandarlo a schiantarsi sulle montagne”.
C’erano quasi tutti i big della canzone, nomi che
196
contavano e ancora contano a distanza di quarant’anni,
nomi che farebbero la fortuna di almeno dieci festival
dei giorni nostri. Cito a caso, come mi vengono:
Adriano Celentano, Rita Pavone, Tony Renis, Pino
Donaggio, Rosanna Fratello, Ornella Vanoni, Fausto
Leali, Carmen Villani, i Camaleonti, i Dik Dik, Gianni
Nazzaro, Marisa Sannia, Nicola di Bari, i Ricchi e
Poveri (al loro esordio), Iva Zanicchi, Sergio Endrigo,
Patty Pravo, Little Tony, Renato Rascel, Dori Ghezzi
(ancora la ricordo: dolce, timida, bellissima, seduta su
uno dei gradini che portano alla sala stampa ed io che
l’ascolto con la testa annebbiata), Rosalino Cellamare
(che si sarebbe chiamato Ron), Caterina Caselli,
Gigliola Cinquetti, Bobby Solo, Nada (giovanissima ma
con l’ambizione di una star), Nino Ferrer, Claudio Villa,
Luciano Tajoli, Mal, Anna Identici, Antoine, Mario
Tessuto, Orietta Berti. E non dico degli sconosciuti.
Allora il festival era una cosa seria.
La ventesima edizione, che si svolse nel salone delle
feste del Casino municipale, prima di approdare nel ’72
al teatro Ariston, fu vinta da Celentano in coppia con la
moglie Claudia Mori con la canzone Chi non lavora non
fa l’amore. La vittoria si portò appresso un’infinità di
polemiche perché il testo sembrò un favore ai padroni,
com’erano definiti, non agli operai… “arrabbiata lei mi
grida che ho scioperato due giorni su tre, coi soldi che le
do non ce la fa più ed ha deciso che, lei fa lo sciopero
contro di me!” I sindacati non potevano apprezzare e
nemmeno il partito comunista, meno che mai i giovani
(si stava aprendo un decennio terribile) che accusarono
Celentano di essere un reazionario e un sorpassato. Non
immaginavano che un giorno sarebbe diventato un
predicatore civilmente impegnato, quasi “de sinistra”.
Tornai a Sanremo nei tre anni successivi, poi mi stancai.
Dietro le quinte il mondo della canzonetta è noioso,
banale, povero di linguaggio. Per essere accettato ha
bisogno della finzione del video, delle riviste patinate,
degli inganni della cronaca rosa, della intermediazione
del sogno.
197
Loretta Young emerse, per la prima volta, dal
“sipario” dei capelli biondi di Jean Harlow. Aveva un
ruolo di rincalzo ma significativo in La donna di platino
che il maestro Frank Capra diresse nel 1931, prima cioè
dei suoi grandi film. È una leggera e divertente satira
del mondo del giornalismo americano. La bruna Loretta
vi interpreta la parte di una giornalista innamorata del
collega Robert Williams che in un primo momento le
preferisce la ricca ereditiera Harlow. Le due donne si
contrappongono a distanza, e alla fine il bruno prevale
sul biondo, la sconosciuta sulla diva affermata, la
discrezione sull’abbaglio. Il film l’ho pescato in un
negozio di DVD, all’angolo tra via Etnea e viale XX
Settembre, oggi scomparso. Il peso degli anni si sente
ma diventa leggero solo guardando gli occhi sgranati sul
mondo di Loretta Young, l’attrice elegante e sofisticata
che entrava nella testa degli spettatori a ridosso del The
End, al commento delle emozioni provate, al giudizio
sulla bravura degli interpreti in cui si cerca di
riannodare i fili della vicenda. Lei era come un prezioso
quadro d’autore che si apprezza col tempo: quando gli
stereotipi si svelano, ci si stanca delle prospettive e dei
colori fasulli e si va alla profondità delle cose.
La sua vita professionale fu impeccabile, per
impegno e bravura, ma quella privata fu un mezzo
disastro. A diciassette anni scappò con un ubriacone,
Grant Withers, che aveva conosciuto sul set del musical
La rivista delle nazioni di John Adolfi. Era il 1929.
Quell’anno Loretta girò sette film, in ruoli abbastanza
marginali. Il rapporto con Grant durò otto mesi.
Withers, belloccio e accattivante, era un buon
caratterista (oltre cento film al suo attivo, tra cui Sfida
infernale di Ford) ma quando beveva diventava
aggressivo e manesco. Il divorzio, che arrivò nel 1931,
fu chiesto da Loretta stanca di dover pagare, a
matrimonio praticamente finito, i conti di quel
perdigiorno e alcolista di marito. Ironia della sorte,
quell’anno l’attrice girò un film proprio accanto a Grant,
198
To young to married, Troppo giovane per sposarsi. Anni
dopo si legò a Clark Gable, il re di Hollywood, allora
sposato con la ricca e pluridivorziata Rhea Langham.
Clark non amava la moglie, più vecchia di lui di 17
anni; le era solo riconoscente per avergli aperto le porte
del successo e dato l’immagine decisiva. Assieme alla
MGM, Rhea aveva lavorato sodo per sistemargli le
orecchie a sventola e i denti troppo laschi. Ma il vero
amore di Clark Gable non sarà Loretta Young ma Carol
Lombard, la regina della screwball comedy, scomparsa
in un incidente aereo. Amore o no, verso la fine del
1935 dall’unione tra Clark e Loretta nacque una
bambina, Judy, che venne nascosta per non suscitare
scandalo. Nessuno seppe nulla, tranne la madre di lei
che programmò l’imbroglio nei minimi particolari:
prima accompagnò la figlia in Europa, affinché
partorisse in gran segreto, poi nascose la nipotina in un
brefotrofio.
Quando la piccola compì due anni,Loretta finse di
adottarla e in seguito le diede il nome dell’uomo che
aveva sposato, il magnate Thomas Lewis. La verità, la
piccola “orfana”, l’avrebbe appresa molto più tardi,
esattamente 35 anni dopo la nascita. Il rapporto con la
madre ovviamente entrò in crisi e lei fu costretta a
rivolgersi a uno psicanalista. Ma dopo un po’ nella casa
della sognante e ben educata Loretta riapparve il sereno,
e Judy tornò al suo mestiere di attrice e produttrice
televisiva. Ma fu sempre ossessionata dai ricordi
dell’infanzia. Poiché aveva ereditato le orecchie a
sventola del vero padre, la madre gliele nascondeva
sotto un berretto di foggia maschile finché, compiuti
sette anni, con un’operazione pin-back un chirurgo non
le eliminò l’imbarazzante certificazione genetica. E i
rumors furono messi a tacere, seppure la bimba, che
capiva e non capiva, restò col dubbio d’una paternità
fantastica.
La stessa illusione coltivò la piccola Marilyn, allora
Norma Jean Baker, che per molto tempo fantasticò che
lo sconosciuto padre fosse proprio Mister Baffetti, il
199
seducente Rhett Butler di Via col vento. La madre glielo
fece credere e lei tenne la foto del presunto padre
segreto sul comodino mostrandola alle amiche per
confondere la vera imbarazzante paternità con lo
splendore di un nome altisonante.
Nel cuore di Loretta restò sempre quel lontano
rimorso e forse fu per questo che cominciò a andare a
messa ogni mattina alle sei, a tenere il rosario appeso al
parabrezza dell’automobile e a impiegare in giaculatorie
il tempo perduto ai semafori.
Queste cose accadevano nel mondo del cinema.
Queste cose accadevano in Sicilia dove le ragazze che
partorivano figli al di fuori del matrimonio erano
considerate perdute. In un libro-inchiesta di Lietta
Harrison sui rapporti sessuali in Sicilia, Le svergognate,
del 1963, alla domanda: “Preferirebbe avere per sorella
una ragazza madre o un’assassina per onore”, la risposta
dell’intervistato era inequivocabile: “Un’assassina”. Le
“svergognate” riacquistavano l’onore solo col
matrimonio, anche se erano state stuprate. Il barbaro
costume cambiò nel 1965, l’anno in cui una
diciassettenne di Alcamo, Franca Viola, che era stata
rapita dal proprio spasimante per indurla al matrimonio,
trovò il coraggio di ribellarsi. Per quel gesto fu ricevuta
da Paolo VI e l’Italia tutta le si strinse attorno. Una
vicenda che trovò attenzione anche nel cinema. La parte
di Franca Viola, nel film La moglie più bella di
Damiano Damiani, fu interpretata da un’attrice allora
sconosciuta ma bella come il sole e sensuale da togliere
il sonno, Ornella Muti. Per trovarne una simile
dobbiamo arrivare alla conturbante Scarlett Johansson:
figura piena nei punti giusti, seni da sballo, labbra
peccaminose, sguardo innocente e perverso. Prima di
sbocciare con questi maestosi attributi “la ragazza con
l’orecchino di perla” aveva ricoperto numerosi ruoli di
bambina dolente e sfortunata.
Quelli erano gli anni in cui il Paese si divideva sul
delitto d’onore, che fu abolito dopo l’assassinio del
professore Francesco Speranza. Questo docente, che
200
insegnava geografia al Magistero di Catania, e il cui
unico figlio è mio amico, la sera del 20 ottobre 1964 fu
ammazzato, mentre stava facendo esami, da un maestro
elementare di Piazza Armerina, Gaetano Furnari, che gli
sparò cinque colpi di pistola per vendicare l’onore della
figlia. Ovviamente, al processo gran parte dell’opinione
pubblica catanese si schierò con l’assassino e diede
l’intera colpa al professore e alla ragazza, Maria Catena,
rea di avere avuto una relazione con il galante docente.
Al maestro Furnari furono concesse le attenuanti
previste dall’articolo 587 del codice penale, relativo al
delitto d’onore, e pertanto venne condannato a soli due
anni e undici mesi di reclusione. Non gli diedero di più
per non precludergli l’insegnamento! Maria Catena, che
aveva vent’anni ed era solo una provinciale
sprovveduta, oltre al ludibrio della pubblica opinione si
beccò, in piena udienza, uno schiaffo di Mimmo
Speranza che col padre aveva perduto affetto e avvenire.
201
OTTO
Ginger Rogers, Barbara Stanwyck, Gloria Grahame
Nel palazzo dove abitava mio nonno si accedeva
attraverso un grande portone che dava in uno stretto e
lungo cortile sul quale si affacciavano i ballatoi di due
costruzioni parallele. A sinistra c’erano le abitazioni di
nonno Carmelo, della signora Sterlini e di altre famiglie
che non ricordo; a destra quelle delle famiglie Piazza,
Motta e Fallica. Quest’ultima era imparentata con Pippo
Baudo, che avrei conosciuto molti anni dopo a La
Sicilia e frequentato a Roma, sempre per ragioni di
lavoro. Mia sorella se lo ricorda alle feste danzanti in
casa degli zii. Aveva più capelli e, ovviamente, era
secco e lungo come uno stecco. Suonava il pianoforte e
incantava le ragazze. La musica si diffondeva nel
cortile, sbatteva sui panni stesi da un balcone all’altro e
finiva nella mia testa sognante. Accanto alle canzoni di
Cherubini, D’Anza e Bixio c’erano quelle di Cole
Porter, Jerome Kern, Gershwin, Irving Berlin, le
canzoni che attraverso i musical avevano esaltato il
cuore e l’immaginazione del mondo. E con quella
musica, melodica o ritmata, arrivò anche il tip-tap di
Fred Astaire e di sua sorella Adele, prima che il il
cantante-attore-ballerino approdasse tra le braccia di
Ginger Rogers, la stella.
La danza, Virginia Katherine McMath, l’aveva
“tecnicamente” nel sangue. “Ha cominciato a ballare
ancor prima di nascere”, dirà la madre. “Sentivo i suoi
piedini tamburellare per mesi dentro di me”. La vecchia
Ginger era nata per avere successo. Quando dico “la
vecchia Ginger” (così come per altri attori) prendo in
prestito l’affettuosa definizione del giovane Holden che
chiama vecchia, cioè più matura di lui, la sorellina
Phoebe. Nel momento in cui incominciò a lavorare con
Fred Astaire era pressoché sconosciuta ma possedeva
una volontà di ferro che l’avrebbe portata a interpretare
202
una miriade di film d’ogni genere guadagnando anche
un meritato Oscar per un’opera drammatica, Kitty Foyle
(1940). Ma fu in coppia con Fred Astaire che entrò nella
leggenda di Hollywood. Una coppia litigiosa e felice
sullo schermo ma nella vita privata ognuno per la sua
strada, anzi, i due si detestavano al punto che i rari baci,
che per esigenze di copione avrebbero dovuto darsi
davanti alla cinepresa, furono finti, opportunamente
mascherati o elusi.
“Heaven, I’m in Heaven…” Indimenticabile la
canzone di Irving Berlin, indimenticabile Cappello a
cilindro di Mark Sandrich, anno 1935. Fred era esile e
leggero, sembrava senza corpo; Ginger era bionda e
piumosa, con le sue forme perfette pareva uscita fresca
da un salone di bellezza. Lui, in frac e top hat,
rappresentava uno dei massimi “disegni” del
Novecento; lei, vestita di satin e di luce, era il desiderio
allo stato puro. Ma è soprattutto la canzone che li
sostiene e li avvolge, una melodia scritta da un autore
che non sapeva leggere la musica e suonava il
pianoforte come un bambino alle prese con lo spartito
del Piccolo montanaro di Zimacki. Irving usava solo i
tasti neri e per questo si fece costruire uno strumento
speciale con pedali che consentivano di cambiare
tonalità. Un assistente si occupava poi di trascrivere gli
spartiti. Jerome Kern, altro mostro sacro, disse una
volta: “Irving Berlin non ha un posto nella musica
americana. Lui è la musica americana”. Gli Stati Uniti
gli debbono molto, gli debbono White Christmas e, su
tutte, God bless America, una delle canzoni patriottiche
più amate dagli americani, quasi un secondo inno
nazionale. Indimenticabile la versione della cantante
Kate Smith che accompagnò l’America forte e generosa
sui fronti della seconda guerra mondiale. Nell’ascoltarla
non c’era soldato o civile che non portasse la mano al
cuore e ne seguisse con commozione le parole. “God
bless America/ land that I love…”
Interessante la vita di Irving Berlin, geniale
compositore che morirà a centouno anni dopo avere
203
composto quanto di più bello, prezioso e affascinante ci
sia nella musica leggera del secolo scorso. Nel 1926
sposò in seconde nozze Ellin McKay, di quindici anni
più giovane. Il matrimonio destò scalpore non per la
differenza d’età o per il diverso credo religioso (lui
ebreo, lei cattolica), ma per la diversa estrazione sociale
(lui figlio di poveri immigrati russi, lei figlia di un
magnate delle telecomunicazioni). Il padre di Ellin,
furiosamente contrario alle nozze, arrivò a diseredare la
figlia ma Berlin, in risposta, assegnò alla moglie i diritti
d’autore della canzone Always. Fu un’unione solida e
lunghissima, 62 anni, che si interruppe solo con la morte
di lei, nel 1988. L’anno dopo morirà anche il vecchio
Irving. Aveva aperto gli occhi nella Russia degli zar e
sarebbe morto nell’America del petroliere George Bush
mentre in Europa cadeva il muro di Berlino. Non
sappiamo come finì la storia col suocero, se questi si
mangiò le mani o restò nella sua follia denigratoria.
La storia di Irving Berlin ricorda in piccolo quella di
Nino Lombardo. Anche Nino suonava a orecchio. Me lo
confessò lui stesso, dopo anni che aveva accompagnato
con la sua orchestrina la giovinezza della mia
generazione. Imparava dai dischi. Bastava che li
ascoltasse un paio di volte per mettersi al pianoforte ed
eseguire le canzoni con precisione. Gli anni Sessanta a
Catania sono stati narrati dalla sua band, dal suo stile di
velluto, mai aggressivo, che conciliava i balli della
mattonella con un rock da piccola balera mentre nel
cielo splendeva la Luna immaginaria di Fred
Buscaglione e quella rossa di Claudio Villa. Le note del
suo complessino risuonavano soprattutto nel mitico
Lido dei Ciclopi, il fantastico giardino equatoriale
affacciato sul mare che da sempre divide Acicastello da
Acitrezza, luogo di ricordi e di privilegio, inattaccabile
dal buon senso ma lucente come un diamante. Fu lui,
Nino il Sorridente, il responsabile dei tanti amori nati,
spezzati, raramente sopravvissuti sulla pista da ballo dei
Ciclopi e tra le fronde degli alberi diventati sentinelle di
204
confine e alibi formidabile per non togliere dai piedi
quel Lido di ricchi e di raccomandati, quel Lido in cui
teppistelli e vagabondi di buona famiglia per non pagare
il biglietto delle serate chic s’ingegnavano a sbarcare dal
mare facendosi beffe dell’inflessibile guardiano, il
signor Belfiore. Questi era un omino votato anima e
corpo al suo vecchio panama e alle sue scarpe bicolori,
al bon ton e al servilismo. Quando al Lido veniva in
visita la Duchessa di Misterbianco, la Proprietaria!,
vestita come una dama Liberty, bianca e svolazzante
d’affettati sorrisi, egli si sprofondava in inchini
imbarazzanti e allontanava, con un ampio e risoluto
gesto del braccio, i curiosi bagnanti che si facevano
legittime domande su quell’apparizione fuori tempo
massimo.
Fred Astaire fu inventato durante la depressione
economica degli anni Trenta, e lui, bravo soldatino di
celluloide, in coppia con la bella, imbronciata e
sorridente Ginger, diede una mano a superare quel
momento, con semplicità e intelligenza, distraendo e
divertendo; perché con le finte soluzioni dei suoi film,
luminosi coriandoli nei cieli brumosi dell’America,
disossava i problemi. Gli americani, che lavoravano
sodo e facevano sacrifici, la sera andavano al cinema
per vederlo, per ubriacarsi nelle sue fastose quinte di
cartapesta e il giorno dopo tornavano a lavorare più
sereni. Che cosa facevano in fondo gli stessi spettatori
del dopolavoro se non ubriacarsi d’illusioni? Anche per
loro la vita era dura, la vita del dopoguerra, scarsa di
cibo e di vestiario, ma un sorriso di Ginger e un tip-tap
di Fred erano come una bevuta all’osteria sotto casa.
Eppure, quel sogno fu a un passo (di danza) dall’essere
estinto. Al suo primo provino Fred si sentì gelare il
sangue: “Non sa recitare, non sa cantare, ha una calvizie
incipiente e riesce a malapena a mettere insieme quattro
passi di danza”.
Ginger e Fred hanno fatto nove film insieme, tutti
più o meno simili, tutti con un lui che s’innamora e con
205
una lei che prima resiste e poi gli cede. Un lungo
improbabile sogno firmato RKO. Fu una coppia
professionalmente
perfetta
e
romanticamente
improbabile: lui pareva il padre di lei e lei sembrava la
figlia di lui, che scappa di casa per rifarsi una vita
lontano dalla famiglia. Anche se in cartellone il nome di
Fred Astaire occhieggiava dall’alto quello di Ginger
Rogers le parti in commedia erano perfettamente uguali.
Alla richiesta se le donne potevano ottenere gli stessi
risultati degli uomini, molte femministe americane
utilizzavano, senza capirla, la celebre battuta dell’ex
ambasciatrice americana in Svizzera, Faith Whittlesey:
“Fred Astaire era considerato un eccellente ballerino,
ma anche Ginger Rogers era in grado di ballare
altrettanto bene. Peccato che lo facesse all’indietro e
con i tacchi a spillo”. L’osservazione della signora Faith
era una osservazione della stessa Ginger Rogers fatta
per rimarcare un concetto esattamente opposto. “Sulla
scena”, confessò una volta “facevo tutto quello che
faceva Fred Astaire, e per di più lo facevo all’indietro e
sui tacchi alti”. Difficile immaginare Fred col cilindro e
i tacchi a spillo.
Cappello a cilindro è il capolavoro della celebre
coppia che girerà con Mark Sandrich altri film
entusiasmanti: Seguendo la flotta (con le melodie
immortali di Irving Berlin), Voglio danzare con te (le
musiche, premiate con l’Oscar, portano la firma di
George Gershwin), Girandola (sempre con le canzoni
firmate da Berlin). Utilizzando lo stesso canovaccio, gli
stessi attori, la stessa conclusione, le stesse danze di
mirabile armonia e bellezza, questi film diventavano,
per mistero e incanto, fasulli e autentici allo stesso
tempo. Insomma, erano come le favole che sai inventate
e tuttavia stanno ancora lì, dopo secoli, ad appassionare
grandi e piccini; come le storie di Tartarino di
Tarascona che Daudet scrisse per vere e che i lettori
gradirono lo stesso pur sapendole inventate. È una fiaba
vera Follie d’inverno, diretto nel 1936 da George
Stevens, con un piccolo rovesciamento di ruoli: stavolta
206
è Ginger Rogers a inseguire Fred Astaire. La canzone
che fa da filo conduttore è di Jerome Kern, The way you
look tonight, che quell’anno vinse l’Oscar. Splendido il
motivo, come il primo piano di Ginger coi capelli
impastati di shampoo, che in verità era panna montata,
l’unica che durante le riprese non colasse negli occhi.
Film di cartapesta anche questo, ma capace di
trascendersi e di farsi leggero come una nuvola; e tu mai
crederesti che la sequenza del ballo finale, sull’onda del
motivo Never gonna dance, richiese ben 47 ciak. Alla
fine, alla povera Ginger sanguinavano i piedi.
Ho conosciuto il più grande ballerino classico della
storia, Rudolf Nureyev. L’ho intervistato nel suo
camerino, al teatro antico di Taormina, mentre aspettava
che il linoleum dove avrebbe dovuto danzare si
asciugasse: l’umidità della sera lo aveva reso scivoloso.
Non ricordo se restò seduto quando entrai con la troupe
del TG3, credo di sì, ricordo che ci guardò dall’alto in
basso, pur standosene stravaccato nella sua poltroncina
mentre noi eravamo intenti ad allestire il set per la
ripresa televisiva. Sul costume di scena indossava una
specie di kimono che lo faceva assomigliare a un
principe orientale; ai suoi piedi c’era una grande sacca
zeppa di scarpe da ballo. Come i veri artisti, e lui era
davvero il più grande, rispondeva alle domande senza
guardare. Piccolo di statura (forse per questo non si
scollò dalla sedia), mascelle forti, labbra carnose, aveva
occhi profondi e malinconici come se custodissero la
provvisorietà della sua giovinezza, l’essere nato nello
scompartimento di un treno, l’avere patito la violenza
del regime comunista. Nessuno è riuscito a eguagliarlo,
nessuno è stato in grado di librarsi nell’aria come lui
e“posarsi”sulle tavole del palcoscenico, senza sforzo
apparente, senza tradire il minimo fiato. Stava lì, in aria,
come Pelè quando si staccò da terra e insaccò di testa il
pallone e poi “scese” tranquillamente lasciando di sasso
il povero Burgnich. È morto di Aids a Parigi, il 6
gennaio del 1993, come il suo compagno Freddie
207
Mercury, omosessuale anche lui. Eppure, stando alla
recente biografia di Julie Kavanagh, Nureyev fu sedotto
dalla sorella di Jackie Kennedy ed ebbe rapporti anche
con la moglie del suo insegnante e con una ballerina
cubana.
Molti film hanno contenuti ideologici. Fred Astaire
che spende tutto il suo tempo a inseguire la bella Ginger
Rogers per mari e per monti, come fa in Cappello a
cilindro, fino a raggiungerla in un’improbabile Venezia
di cartone con le gondole che navigano in mezzo metro
d’acqua, trasmette un preciso messaggio: l’uomo è
cacciatore, la donna preda. Non a caso in Cappello a
cilindro lei fa la parte d’una mannequin, Dale Tramont,
che si guadagna la vita sfilando per un celebre stilista di
moda che la fa vivere nel lusso ma che poi “le presenta
il conto”, per usare il pettegolezzo di un personaggio di
contorno, ovviamente censurato dal fascismo e
ripristinato nel dopoguerra. Non erano tempi, quelli
italiani, di porre al centro della fiaba una mantenuta.
Meglio lasciarla nell’ambiguità, tenerla sul filo della
simpatia, che metterla sotto i riflettori della verità, e
pazienza se alcune situazioni diventavano forzate e
incomprensibili.
Lo stesso accade per Cerco il mio amore, secondo
film girato da Sandrich nel ’34 con la celebre coppia,
dove la protagonista Mimi Glossop da sposata viene
retrocessa a fidanzata, perché solo così può aspirare a un
nuovo amore. La moglie, per definizione e propaganda
politico-religiosa, era allora madre e angelo del
focolare. Il film non è all’altezza degli altri, ma si fa
valere, oltre che per l’abilità dei due protagonisti, per
l’intramontabile canzone Night and day di Cole Porter e
per la performance della sconosciuta diciottenne Betty
Grable che si esibisce in un simpatico numero di danza
con Edward Everett Horton, la celebre “spalla” di Fred
Astaire. Altri non si reggono in piedi, per dire, ma
mantengono la sottile perversione della piccola realtà
che s’incunea nella fiaba e ne esce trasformata, come La
208
magnifica avventura di George Stevens, girato da Fred
Astaire nel ’37 senza Ginger Rogers e “talmente brutto
che non si sa da dove cominciare a criticarlo”, come
avrebbe detto il critico inglese Tom Milne. E tuttavia
stai lì a farti catturare dalle musiche di George
Gershwin, dalle scemenze di Gracie Allen,
incredibilmente scritte da Wodehouse, dai passi stentati
di Joan Fontaine (comunque bella e credibile) e dalle
coreografie di Hermes Pan che quella volta vinse
l’Oscar.
Riesci a digerire persino lo scialbo Non ti posso
dimenticare di Edward H. Griffith del ’43 con la bella
Joan Leslie che tenta drammaticamente il tip-tap con il
funambolo Fred ma che poi si riscatta cantando My
shining hour. Joan Leslie, che va tranquillamente per i
novanta, all’inizio della carriera girò tre film di tutto
rispetto: Una pallottola per Roy di Raoul Walsh (1941)
con Humphrey Bogart, Il sergente York di Howard
Hawks (dello stesso anno) con Gary Cooper, Ribalta di
gloria di Michael Curtiz (1942) accanto a uno
straordinario James Cagney. Se a quest’attrice dagli
occhioni azzurri sgranati sul mondo davi una canzone
lei la interpretava con ogni sacramento (bravissima in
Goodnight, sweet dreams), se le affidavi una parte
drammatica o brillante che fosse se la cavava senza
difficoltà, se però la costringevi a ballare non andava
più in là d’una brutta copia di Ginger Rogers.
Film scacciapensieri, dunque, quelli di Ginger e
Fred. Ma anche film ideologicamente rassicuranti, tesi a
consolidare ruoli e assetti sociali. La housewife (non
desperate) che traffica in cucina, come nelle pellicole
per famiglie degli anni Quaranta e Cinquanta, ha un
compito ben definito: convincere le donne a stare a casa
e a fare la calza. Del resto, che cosa fa Biancaneve nella
casa dei sette nani? Si mette a riordinarla. Ci vorranno
anni perché le donne capiscano che la pulizia della casa
non è tutto, che la vita domestica spesso è un inferno,
che la rispettabilità del marito talvolta è un inganno, che
ricamare e contemplare la luna e le stelle non è il
209
massimo dell’impegno civile. Lo capiranno leggendo La
mistica della femminilità di Betty Friedan. Capiranno
che l’essere donna è lo stesso che essere uomo, con gli
stessi diritti cioè, le stesse opportunità, e che possono
guidare la macchina, farsi belle, magari civettare,
lèggere i giornali, mandare il marito a fare la spesa e
ogni tanto appioppargli i figli. Insomma, una vita da
maschi, da divi maschi che nei film non prendono
l’autobus perché l’auto sportiva è il loro destino: la
velocità, il rischio, il sorriso Colgate come simbolo del
sentirsi soddisfatti.
Sarà stato questo lontano invisibile filo pubblicitario
di stupido benessere a convogliare le mie poche risorse
su una Mini Minor verde col cambio sul pianale che era
una bellezza. Non so quante cambiali firmate e pagate
grazie alla collaborazione, come critico televisivo, col
settimanale Lo Specchio di Giorgio Nelson Page: un
settimanale di destra che utilizzava le “farfalle” del Sifar
per i suoi scoop giornalistici. Avevo ventiquattro anni
ed ero laureato da poco. Voglio dire che ero un poco
addormentato. Di sicuro per immaturità e ignoranza,
forse anche per comodo. O forse, forse, per me vale il
giudizio scanzonato di Edmondo Berselli su Guccini:
“In realtà lui poeticamente era un carducciano e
politicamente un mezzo socialdemocratico, molto
moderato e tendenzialmente governativo, gradualista,
avanti con le riforme, senza avventure”. Non gradirono
la firma nel momento in cui elogiai il comportamento di
don Renzo Mazzi, il parroco dell’Isolotto, rimosso
dall’allora vescovo di Firenze, cardinale Ermenegildo
Florit, e poi processato con la falsa accusa di avere
impedito, assieme ai fedeli, di celebrare messa
all’inviato del cardinale. Il direttore mi telefonò e mi
disse: “Noi le diamo ampia libertà, ma schierarsi con un
prete comunista!”
Accanto ai messaggi pubblicitari, più o meno
evidenti, c’erano quelli subliminali: ti entravano nel
210
cervello a tua insaputa. Nel 1958, in America, furono
inserite nel film di Joshua Logan, Picnic, con William
Holden e Kim Novak, le scritte Coca-Cola e Pop-Corn.
Nessuno spettatore si accorse di niente. Tuttavia il
consumo di quei prodotti durante la proiezione aumentò
del 58 per cento. Ma forse la ragione fu un’altra. La
ragione fu l’esplosiva Kim Novak, ultimo prodotto
hollywoodiano uscito dalle mani del fabbricatore di
stelle Ely Levi. Kim non sapeva recitare, aveva le
gambe grosse e la faccia a pagnotta, inoltre era
ignorante come una capra. “Quando un uomo mi
baciava la mano” confessò una volta, “lo lasciavo fare e
poi gliela baciavo anch’io”. Ma Ely fece il miracolo: le
aggiustò i denti, gli occhi, i capelli e per tre mesi, per
farla dimagrire, le fece mangiare sedani crudi e bere
succo di pomodoro.
Nella famosa scatola del Plasmon, che racchiudeva
la mia infanzia, c’era anche la figurina di Barbara
Stanwyck, uno schiaffo di sette consonanti e una vocale.
Il suo nome di ragazza era Ruby Stevens ma la futura
dark lady del cinema americano pensò di cambiarlo il
giorno in cui s’imbatté nel poster di un dramma teatrale
di William Clyde Fitch, Barbara Fietchie, con Jane
Stanwyck. Ne fu talmente suggestionata che si
ribattezzò seduta stante prendendo in prestito il nome di
battesimo dell’eroina del titolo e il cognome dell’attrice
protagonista.
Cominciò a lavorare in una compagnia telefonica a
14 dollari la settimana. Vent’anni dopo, quando ormai la
chiamavano “La Regina”, il governo l’avrebbe inserita
nella lista delle donne più pagate d’America. Si sposò
due volte, con Frank Fay e con Robert Taylor. Il primo
matrimonio si ruppe il giorno in cui il marito, ubriaco
fradicio, gettò nella piscina il figlio adottivo Dion. Fay
era un po’ di tutto: produttore, attore, scrittore,
paroliere. Dopo il divorzio finì tra le braccia d’una testa
matta, l’attrice di musical Frances White, che alla fine
lo prosciugò con una richiesta esagerata d’alimenti. Il
211
secondo matrimonio cominciò malissimo per Barbara.
La possessiva madre del divo coi baffetti pretese che la
prima notte di nozze il figlio restasse con lei in casa.
L’affascinante protagonista de La Signora delle camelie
e Il ponte di Waterloo era piuttosto chiacchierato a quei
tempi. I rumours lo consideravano gay, sia pure a
corrente alternata, e non risparmiavano nemmeno la
glaciale Stanwyck finita, a quanto pare, nella rete di
Marlene Dietrich e Joan Crawford. Ma per questo
secondo marito, Barbara ebbe grande affetto e
tenerezza. Già vecchia d’anni e di ricordi provò un
cocente dolore quando le lettere d’amore che Robert
Taylor le aveva scritto andarono perdute nell’incendio
della propria casa.
Lo strano amore di Marta Ivers, Il terrore corre sul
filo, Il romanzo di Thelma Jordon furono i tre grandi
film di Barbara, ma la più convincente interpretazione
l’attrice la fornì in La fiamma del peccato, di Billy
Wilder, accanto a Fred MacMurray ed Edward G.
Robinson. Anno 1944. Tratto dal romanzo Double
indemnity di James M. Cain, l’autore di Il postino suona
sempre due volte, il film fu sceneggiato da Raymond
Chandler. “Ho ucciso per denaro e per una donna”, dice
il protagonista Walter Neff alla fine della storia “e non
ho preso il denaro e non ho preso neanche la donna.
Bell’affare”. L’assicuratore Walter Neff scivola ignaro
nella trappola della bella e sensuale Phyllis Dietrichson
che lo usa per assassinare il marito. Prima però i due,
diventati amanti, concordano una assicurazione sulla
vita della vittima che prevede, in caso di morte per
incidente ferroviario, un doppio risarcimento (double
indemnity), centomila dollari. Quindi l’ignaro signor
Dietrichson deve assolutamente cadere dal treno in
corsa. Il piano è geniale. Dietrichson viene ammazzato
in macchina da Neff, che si è nascosto nel sedile
posteriore, mentre la moglie lo accompagna alla
stazione. Neff prende il suo posto e, al momento
opportuno, salta dal treno, raggiunge l’auto dell’amante,
recupera il cadavere e lo abbandona sui binari.
212
Non potranno però godersi i soldi perché un collega
di Neff, Barton Keyes, magnificamente interpretato da
Edward G. Robinson, scopre la macchinazione grazie
anche alla testimonianza di un passeggero, un certo
signor Jackson, cui dà volto e voce il grande caratterista
Porter Hall, che ha visto Neff proprio sul treno.
Convocato nell’ufficio di Barton Keyes, mister Jackson
dà vita a un numero entusiasmante: “Sono di Melford,
Oregon! Se lo dico lo penso e se lo penso posso
giurarlo”. Prima di essere congedato concorda un
rimborso spese che prevede una piccola maggiorazione.
Come facevano molti inviati di giornale che inserivano
nelle note spese la voce “l’uomo non è di legno”. Cioè a
dire, giornalisti e commessi viaggiatori hanno diritto a
qualche scappatella extraconiugale. La situazione
precipita. Walter Neff capisce di essere stato usato
dall’amante, che vuole solo il denaro dell’assicurazione,
e decide di eliminarla. Lei intuisce il piano e gli spara
ferendolo gravemente, ma non ha il coraggio di finirlo.
“Sono guasta dentro”, gli confessa “non ti ho mai
amato, né te né nessun altro, ma ora sento che è
diverso”. Lui non le crede e la uccide. Allo stremo delle
forze si reca in ufficio per registrare al magnetofono la
confessione dei due delitti.
Il film è angosciante, terribile; ti resta nelle ossa per
giorni e giorni. “Non sentivo più i miei passi”, dice Neff
nella confessione. “I miei erano i passi di un morto”.
Straordinario lui, Fred MacMurray; straordinaria
soprattutto lei, Barbara Stanwyck, con gli occhi sgranati
sulla propria follia omicida, con la sua sottile e perfida
carica sexy. La fiamma del peccato resta la cifra della
carriera di questa inarrivabile attrice noir. È morta il 20
gennaio del 1990 a Santa Monica, all’età di 83 anni.
Non ci sono stati funerali solenni. Il suo corpo è stato
cremato e le ceneri sono state sparse a Lone Pine,
California. Ai piedi di un pino solitario, oggi
irrimediabilmente perduto, riposano anche le ceneri di
Luigi Pirandello. Barbara sarebbe stata un’eccellente
interprete pirandelliana.
213
Barbara Stanwyck e Fred MacMurray sono i
prototipi di sangue e passione di Eva Kant e Diabolik, la
celebre coppia dark creata nel 1962 dalle sorelle Angela
e Luciana Giussani. Un fumetto che non sono mai
riuscito a leggere. Nell’anno d’esordio ero già al
secondo anno di università e i miei orizzonti s’erano un
pochino allargati. Ma credo che le gesta di quell’eroe di
carta non mi avrebbero appassionato. Conservavo nel
cuore la mia infanzia costruita su Il Corriere dei piccoli
e sui libri della Salani. Il Corrierino, uscito per la prima
volta nel dicembre del 1908 come supplemento del
Corriere della Sera, stabiliva un nesso ideale tra il mio
incanto di bambino e il disincanto di mio padre,
accanito lettore del Corrierone. Non entrava altro
fumetto in casa nostra; nemmeno Topolino, giudicato
non perfettamente educativo. Nel saggio In trappola col
topo, Antonio Faeti cerca di decifrare e “assolvere”
l’ambiguo Mickey Mouse ma, nonostante la buona
volontà, Topolino resta un personaggio troppo asettico
per essere vero, troppo convenzionale per essere amato,
troppo amico dei potenti e dell’ordine per essere preso a
modello. Mi piacevano invece le avventure del signor
Bonaventura, di Bibì e Bibò, di Arcibaldo e Petronilla.
Mi piacevano quei fumetti senza fumetto (la nuvoletta
con dentro le scritte), le cui vignette erano spiegate in
calce con versi a rima baciata o alternata… “e così
finisce l’avventura/ del signor Bonaventura”. Col senno
del poi dico che quel giornaletto non era poi tanto
innocente: insinuava nei piccoli lettori una carica
anarcoide, di insofferenza rispetto agli schemi del
tempo. Ma questo era un bene. Altro che Topolino!
A differenza di quelle del cinema, le dark ladies di
carta partivano cattive e diventavano buone. Come
Modesty Blaise, che aveva un suo codice d’onore; o
Dragon Lay, la supercattiva di Terry; o Breathless
Mahoney, la donna perduta di Dick Tracy; infine Narda,
la principessa che prima tenta di uccidere Mandrake e
poi se ne innamora. Come, tutto sommato, fa Gloria
214
Grahame che ne Il grande caldo s’innamora del
poliziotto Glenn Ford e lascia il gangster Lee Marvin.
Gloria Grahame, nata Hallward, oggi dice poco o
niente, ma aveva un grande talento. La famiglia del
padre discendeva da Eduardo III mentre la madre era
imparentata con i sovrani scozzesi. Si racconta che il
nonno diede a Oscar Wilde l’idea per il romanzo Il
ritratto di Dorian Gray. Si sposò due volte (con l’attore
Stanley Clements e col regista Nicholas Ray) ed ebbe
quattro figli.
Il grande caldo, girato nel 1953 sotto la direzione di
Fritz Lang, resta il suo film migliore, come La fiamma
del peccato per la Stanwyck. Anche qui l’atmosfera è
cupa, disperata. Dal romanzo di William P. McGivern,
il film racconta la storia del sergente Dave Bannion
(Glenn Ford) che vuole fare luce sul misterioso suicidio
di un collega. Le indagini lo conducono a una spietata
organizzazione criminale capeggiata da Mike Lagana,
un uomo all’apparenza rispettabile ma che tiene sotto
schiaffo un’intera comunità col ricatto e l’omicidio.
Bannion non si lascia intimidire, va avanti e per tutta
risposta gli mettono una bomba in macchina ma
finiscono con l’ammazzargli la moglie.
A quel punto entra in scena Debbie Marsh (Gloria
Grahame), la pupa del gangster Vince Stone (Lee
Marvin), a sua volta braccio destro di Lagana. Debbie è
una strana ragazza, a due facce, la buona e la cattiva.
Quando Stone le deturpa il viso, lanciandole in uno
scatto d’ira un caffè bollente, lei prende coscienza,
recupera la dignità (la faccia buona) e aiuta il poliziotto
Bannion a incastrare Lagana e la sua gang. Tragico il
finale. Nel personaggio di Glenn Ford in lotta con un
mondo che lo sovrasta, può leggersi in filigrana la
vicenda personale di Fritz Lang che a quel tempo era
stato inserito nella lista nera dei presunti comunisti di
Hollywood.
Lo scrittore e giornalista John Kleeves, in un
capitolo del saggio Divi di Stato, affronta a modo suo e
senza peli sulla lingua la questione delle black list e del
215
maccartismo. L’asservimento di Hollywood alle
esigenze della propaganda di Stato, sostiene, è una
storia
documentata.
Agli
inizi
l’industria
cinematografica crebbe in pace e autonomia (non si
aveva ancora idea della sua formidabile importanza
politica), ma poi cominciò ad attirare l’attenzione del
governo quando produsse alcune pellicole di contenuto
sociale. La tendenza fu acuita con l’arrivo negli Stati
Uniti, a partire dal 1936, di molti intellettuali tedeschi
progressisti, che fuggivano dal nazismo, come Bertolt
Brecht, Thomas Mann, Erich Fromm, Theodor Adorno,
Herbert Marcuse, Fritz Lang, Billy Wilder. Ebbe così
inizio la stagione dei film “comunisti”, secondo l’accusa
dell’establishment americano. Ma non erano film
comunisti, erano semplicemente opere che trattavano
problemi reali della gente: reinserimento dei reduci,
odio razziale, situazione carceraria, malattie psichiche.
Ma era proprio questo il problema.
Hollywood andava posta sotto controllo. Non doveva
più produrre film del genere, problematici e disfattisti.
A guardare bene, l’accusa di comunismo era un
pretesto, un alibi per nascondere la più sconcertante
delle censure di Stato. Accusando Hollywood di
comunismo il governo non faceva altro che comportarsi
come il regime dittatoriale sovietico che voleva
sconfiggere. Come ulteriore avvertimento trasversale, le
banche di New York, che finanziavano i produttori
californiani, furono invitate a restringere il credito. Ma i
danni maggiori, gli intellettuali, che erano stati inseriti
nelle liste nere, li ebbero dalla gente comune, dai vicini
di casa, dai conoscenti. Furono create associazioni
“ultramericane”, tra cui l’American Legion forte di tre
milioni di iscritti e un milione di simpatizzanti: si
occupava di tenere vivo il risentimento nei confronti dei
“deviati”, e picchettava anche gli ingressi dei cinema in
cui si proiettavano film all’indice o nei cui titoli di coda
compariva un personaggio della lista nera. Tutti o quasi
tutti si piegarono. Non ebbero problemi invece, sempre
secondo la “verità” di Kleeves, John Wayne, per
216
esempio, che era un delatore abituale dell’FBI, ed Elvis
Presley, che aveva addirittura un nome in codice,
“Colonel Burrows”. Ma non furono pochi gli attori che
durante la guerra lavorarono per i servizi segreti del loro
Paese. In una recente biografia su Laurence Olivier,
scritta da Michael Munn, si apprende che il grande
attore inglese lavorò per l’intelligence di Sua Maestà
allo scopo di convincere la scettica America a entrare in
guerra contro la Germania nazista.
217
Tony Curtis e la moglie Janet Leigh
Janet Leigh in Psycho
Audrey Hepburn in Vacanze romane
Greer Garson tra Walter Pidgeon e Richard Ney in
La signora Miniver
Glora Grahame e James Stewart in La vita è meravigliosa
Bette Davis e Francot Tone in Paura d’amare
Barbara Stanwyck e Henry Fonda in Lady Eva
Claudette Colbert e Clark Gable in Accadde una notte
Doris Day e John Gavin in Merletto di mezzanotte
Greta Garbo in La regina Cristina
Susan Hayward in David e Betsabea
Ginger Rogers e Fred Astaire in Cappello a cilindro
Ginger Rogers e Fred Astaire in Cerco il mio amore
Jeanne Fontaine e Cary Grant in Il sospetto
Ava Gardner e Burt Lancaster in I gangsters
Ingrid Bergman in Casablanca
Jeanne Crain in Femmina folle
Jean Simmons in Androclo e il leone
Hady Lamarr in Ecstasy
Joan Crawford e John Barrymore in Grand hotel
Joan Crawford, Conrad Veidt e Melvyn Douglas in
Volto di donna
Katharine Hepburn e Spencer Tracy in Lo stato
dell’Unione
Gene Tierney e Don Ameche in Il cielo può attendere
Lana Turner in Dottor Jekyll e mister Hyde
Anne Baxter in Eva contro Eva
Marlene Dietrich in L’angelo azzurro
Maria Montez
Marilyn Monroe in A qualcuno piace caldo
Veronica Lake in I dimenticati
Merle Oberon e Lawrence Olivier in La voce nella tempesta
Maureen O’Hara e Tyrone Pwer in Il cigno nero
Rita Hayworth in Gilda
RhondaFleming e Arlene Dahl in Veneri rosse
Virginia Mayo e Paul Newman in Il calice d'argento
Lauren Bacall e Humphrey Bogart in Acque del sud
Lauren Bacall e Humphrey Bogart in Il grande sonno
Vivien Leigh e Clark Gable in Via col vento
Myrna Loy e Cary Grant in L’indimenticabile signor Dick
Loretta Young e Joseph Cotten in Mi svegliai signora
Elizabeth Taylor e Paul Newman in La gatta sul tetto che
scotta
Jean Simmons e Laurence Olivier in Amleto
Deborah Kerr e Robert Taylor in Quo vadis?
June Allison
Grace Kelly e Gary Cooper in Mezzogiorno di fuoco
Jennifer Jones in Duello al sole
Jennifer Jones in Bernadette
Jean Harlow e Clark Gable in L’uomo
che voglio
Katharine Hepburn con Cary Grant e James Stewart in
Scandalo a Filadelfia
Linda Darnell in Ambra
Ingrid Bergman e Humphrey Bogart in Casablanca
Grace Kelly e Frank Sinatra in Alta società
NOVE
Greer Garson, Gene Tierney, Virginia Mayo
Piazza Angelo Majorana è stata il mio posto delle
fragole, la culla dell’infanzia, ma raramente testimone
dei miei giochi. Ammiravo le prove di coraggio dei
ragazzi di strada, i loro passatempi poveri e fantasiosi,
ma me ne stavo in disparte, pensando che quel mondo
non mi appartenesse compiutamente. A volte mi
lasciavo andare, ma per sentirmi estraneo ancora di più
e talvolta rifiutato dagli occasionali compagni. Ero una
specie di Tom Sawyer in mezzo a una banda di monelli
alla Huckleberry Finn. La piazza, che si affaccia su via
San Giuliano e su un ex carcere borbonico, adesso sede
della polizia amministrativa, era come il Mississippi di
Mark Twain, il fiume dell’avventura e del mistero, lo
spazio verde di un quartiere vibrante di umanità sul
quale le radio a tutto volume riversavano note
romantiche e d’allegria assieme alle voci dei banditori e
degli ambulanti, ai rumori operosi degli artigiani, alle
grida festose dei ragazzi che si rincorrevano e
battagliavano a cavallo di manici di scopa, mentre
all’Angelus le campane distinguevano il confine del
sacro.
Una vita semplice e a suo modo meravigliosa, una
vita alla Frank Capra, popolare, autentica. Il quartiere
dopo i lutti della guerra era diventato, in Sicilia come
altrove, una sorta di fortilizio sicuro, un luogo in cui i
figli, per convinzione comune, sarebbero scampati alla
miseria, all’ignoranza, alle malattie, all’oppressione,
“alla intimidazione sociale e, soprattutto, alla
mediocrità”, come scrive Philip Roth nella Pastorale
americana. Insomma, c’era grande fiducia nella vita e
nel futuro di quei ragazzi “inesorabilmente pilotati verso
il successo”. Anche se nell’ombra c’era chi lavorava in
silenzio per presentare il conto di tutte quelle gioie, di
tutto quell’amoreggiare con la vita.
218
Geoffrey Lucy nel 1963 ricorderà, in un numero di
Selezione del Reader Digest, il disagio di molti giovani
occidentali che spesso sfociava nella noia, nella
disperazione, nel nichilismo. Fece impressione la storia
di quattro ragazzine francesi che tirarono a sorte quattro
bigliettini e vi si conformarono. Nel primo c’era scritto
“Mi ucciderò”, nel secondo “Ruberò”, nel terzo “Farò la
brava ragazza”, nel quarto “Mi prenderò un amante”.
Una settimana dopo, Isabelle si tagliò le vene dei polsi,
Marie rubò una giacchetta, Janine si comportò da brava
ragazza, Annie fece l’autostop e si dette a sei
automobilisti. Insomma, si affidarono al caso e
diventarono sante o peccatrici per gioco.
Il mio quartiere, a sud della Civita, pur collocato alla
periferia della periferia del Grande Impero, sembrava
anch’esso segnato da un destino di progresso, senza
rotture distruttive col passato. Anche quei giovani
correvano verso il futuro senza abbandonare l’esempio
dei genitori perché ciò che impediva le loro possibili (o
inevitabili) ribellioni era, stando sempre al giudizio
dello scrittore ebreo americano, “la rettitudine
dell’epoca” e “l’abnegazione dei genitori” vissute come
ideologia vigente. La trasmissione delle regole
s’interruppe quando il quartiere non bastò più, quando i
ragazzi diventati adulti si accorsero che la “rettitudine”
era stata svenduta nei palazzi e palazzetti del potere. E
allora fecero la rivoluzione pur sapendola impossibile,
secondo il giudizio di Alberto Ronchey. Ma il concetto
appartiene ad Albert Einstein: “Analizzando ogni giorno
tutte le idee, ho capito che spesso tutti sono convinti che
una cosa sia impossibile, finché arriva uno sprovveduto
che non lo sa e la realizza”. Insomma, i ragazzi del ’68
erano gli “sprovveduti” di Einstein e i loro padri, per cui
l’impossibile era una matematica incertezza, non
potevano capirli. Fu la sconfitta d’ogni sicurezza, la
notte buia e inesorabile, la perdita della luce che aveva
alimentato per tutta la vita Seymour Levov (e la sua
monumentale normalità) e che di fronte alla figlia
diventata prima terrorista e poi giaina non gli resta che
219
piangere. Inutilmente piangere. E morire.
Dopo verranno i figli “inerti” degli anni Settanta, i
“bamboccioni” come li avrebbe definiti il ministro
dell’economia del governo Prodi, Tommaso Padoa
Schioppa, postmoderni e antideologici, quelli della
generazione di Paride Acacia, per dire, che nella citata
autobiografia scrive: “Il futuro non ci ha mai
spaventato, né tanto meno incuriosito; il nostro
‘domani’ era il giorno seguente, poi ancora quello dopo,
in un susseguirsi di ‘atti’ sempre uguali… il virus del
fare lo abbiamo debellato con un cocktail di farmaci
scaduti… in un mondo che pretendeva il diritto al
lavoro noi riaffermavamo il nostro diritto a non fare un
cazzo…” Insomma, come scrive Andrea G. Pinketts,
cercavano di ammazzare il tempo prima che il tempo
ammazzasse loro. E tuttavia come dargli torto se sono
nati nel decennio più lungo del secolo breve, se sono
cresciuti nell’esempio di padri ribelli per rabbia e
conformisti per stanchezza? Come non capire che gli
anni di piombo (Brigate rosse, rapimento e uccisione di
Aldo Moro, stragi, morte di P.P. Pasolini) hanno reso
inerte una società incapace di risveglio? Quegli anni non
sono stati rivoluzionari sono stati velleitari, hanno
provocato lutti, dolore e messo una generazione nella
condizione di smarrirsi: prima nel benessere poi nella
frustrazione. Il mondo non stava andando più avanti. Il
mondo correva tra le braccia delle Charlie’s Angels, del
pensiero debole e del tormentone di Roberto
D’Agostino in Quelli della notte: “Lo diceva Neruda
che di giorno si suda, ma la notte no…”
Catania fino all’immediato dopoguerra era una città
del suono e del canto, una città dove potevano
distinguersi la musica degli organini, le zampogne
natalizie, le litigate un po’ vere un po’ finte delle
massaie ai carrettini degli ambulanti, il comperare a
credito nelle botteghe del perdono il cui stento
guadagno si calcolava sulle ristrettezze economiche
della gente. E questa, se a fine mese non riusciva a
onorare il debito, non usciva di casa, vergognosa di farsi
220
vedere in giro, e si liberava del rimorso solo quando
tornava a varcare la soglia delle rivendite con larghi
sorrisi e la mano nel borsellino. “Quantu c’hai a dari?”
Catania era anche una città dei profumi che scendevano
dalla Montagna, della zagara delle campagne vicine e
del gelsomino che pendeva dai balconi e dai muriccioli
e la cui fragranza si spandeva nelle stanze ombrate dalle
tende e dalla malinconia. Di questa Catania, di questa
paragrafia nostalgica e umorale, mirabilmente descritta
da Goliarda Sapienza nel suo libro postumo Io, Jean
Gabin, non resta che l’infanzia dei ragazzi di quel
tempo, non resta che il ricordo, non restano che le pietre
e gli edifici nobiliari: insomma, ciò che la furia
distruttiva dei palazzinari non è riuscita a profanare, ciò
che il frastuono delle automobili non può seppellire.
Quando si parla di Catania, del suo fulgore e dei suoi
personaggi, della sua musica e della sua letteratura, si
parla quasi sempre al passato, al già visto e immortalato,
non potendo il presente consolarci più di quanto faccia
l’oggi nelle altre città del Meridione, non potendo il
futuro rappresentarsi, qui e altrove, in una qualche alta
misura afferrabile. E così questa città ci rende nostalgici
e retorici di un passato che risplende anche nelle sue
zone d’ombra, nella fatica e nel limitato orizzonte.
Risplende perché quel passato non aveva fretta, era
come immerso nello spirito, era riassunto da una
comunità d’ingegni prodigiosi ancorché legati a un
tempo acerbo e povero.
Catania non era preclusa al suo mare. Gli edifici
della cattedrale, il sontuoso palazzo Biscari, fino a
piazza dei Martiri, erano affacciati alla marina dove i
pescatori arrivavano con le barche a vela, vendevano il
pesce ai rigattieri, e si riposavano pulendo e rassettando
gli scafi, riparando le reti, raccontandosi storie di bufere
e di vento, di calme piatte e di pescate miserabili o
miracolose. Catania non era separata nemmeno dalla sua
Montagna, seppure di faticoso accesso, non come ora
che il cemento le contende ogni bellezza e stupore.
L’inverno era dedicato allo sport degli sci e delle slitte,
221
ma dall’oggi distinguendosi per quel senso d’avventura
che accompagnava gitanti e sportivi. A conclusione
della giornata, e alle prime ombre della sera, i pullman
facevano tappa nei paesini etnei per l’ultima fragorosa
necessità: ballare a scarponi pesanti in uno sfiorarsi di
sguardi e talvolta di corpi che mandavano in delirio il
desiderio delle coppie. Nelle fredde primavere, che
assicurano ancora oggi la neve alle alte quote, era come
scendere dal Kilimangiaro e ritrovare dabbasso la
savana e le palme del deserto, la macchia mediterranea
che lega l’isola al Magreb, gli ulivi e gli oleandri, le
facce scure della gente meticcia, il sorriso e la
responsabilità.
Quand’è cambiata Catania, quando la sua provincia?
Volendo utilizzare la metafora delle lucciole di Pasolini,
direi che la trasformazione è avvenuta nel momento in
cui sono scomparsi gli organini dalle strade e dalle
piazze. Il passaggio dalla dolcezza all’inquietudine è
stato segnato dal rombo delle auto e delle motociclette,
come ricorda Saverio Fiducia nelle Passeggiate
sentimentali; un rumore complesso che ha coperto il
suono degli organini e reso vani i gesti delle donne
zingare, quasi sempre accompagnate da ragazzini tristi,
che mettevano in moto la manovella e “andavano da un
marciapiedi all’altro offrendo la stampa delle canzoni in
voga, ma la gente né il pianino udiva né la donna
vedeva, e se questa fermava qualcuno con occhi
imploranti, il supplicato sfuggiva”. Quell’immagine ce
l’ho negli occhi, come una sequenza cinematografica,
lungo il viale XX Settembre, nel tratto compreso tra
piazza Trento e via Grotte Bianche. Lei era colorata e
frusciante, d’età indefinita, e il ragazzino era come
preso in prestito, affittato alla bisogna. E nessuno
sentiva e nessuno comperava. Era cominciato il grande
inganno, la grande disattenzione. C’era un altro suono
che s’imponeva oltre allo strepito del traffico: l’agitarsi
melodrammatico della gente, il “rumore” del primo
benessere; il vivere meno controllato, il lento ma
inesorabile distacco dal sociale. La città non diventava
222
più incontro ma separazione, spostava il suo asse a sudest, verso il mare, verso orizzonti di fuga, d’altre
immaginazioni e retoriche.
Poveri organini. Se si guastavano il loro “medico”
era don Saru Porto, della ditta in commercio Rosario
Porto e Figli, fabbricante di fisarmoniche e poi di
chitarre e mandolini, padre di due autentiche celebrità,
suonatori di fisarmonica appunto. “Don Saru”, il ricordo
è sempre del Fiducia, “dopo che l’ultimo organino era
partito e lui, con orecchio infallibile, lo aveva udito
perdersi nei meandri di San Berillo e del Massarello,
soddisfatto della giornata scendeva la scaletta della
fabbrica, si sedeva sull’ultimo gradino e ordinava ‘A
mùstica!” Che era ’u bummulu, l’orciolo di terra di
Lentini che serviva a tenere fresca l’acqua. Beveva a
lunghe sorsate e alla fine, dopo essersi asciugate le
labbra con la manica della camicia, si guardava intorno
e cominciava a cantare. “Ti passau ’u pitittu?” gli diceva
la moglie cominciando ad apparecchiare per il pranzo.
Lui arrivava caracollando, mangiava e poi si metteva a
dormire. Un’ora di sonno disturbato, dalle mosche e
dalle moschitte.
Se don Saru avesse saltato la pennica e si fosse
avventurato alla ricerca del suono dell’organino, laggiù
dove le acque dell’Amenano s’affacciano raspose in
piazza Duomo per poi rituffarsi nel sottosuolo, avrebbe
di sicuro incontrato il caffettiere girovago per l’ultima
mescita del suo portentoso caffè. E dopo di lui,
l’acquaiolo e il venditore di cicoria, raccolta all’alba
nelle vicine campagne. Alla fine, lo avrebbe trovato
l’organino a manovella e ne avrebbe ascoltato ancora
una volta il canto malinconico “che serve a spezzare e
fugare la solitudine, cioè l’intima pena segreta di essere
al mondo”. Le virgolette racchiudono ancora una volta
un pensiero di Saverio Fiducia che ricordo nella vecchia
sede de La Sicilia, in via Santa Maria del Rosario. Era
un uomo piccolo e severo, con i capelli e i baffi alla
Verga, candidi come la neve. Portava al suo amico
Antonio Prestinenza gli articoli per la terza pagina che il
223
direttore curava personalmente. In quel vecchio
convento, trasformato in tumultuosa e profanatrice
redazione, si muoveva in punta di piedi, gentile e
sommesso, inchinandosi da vecchio gentiluomo a ogni
passaggio di giornalista, amico o sconosciuto che fosse.
Questa era Catania, questi erano i suoi personaggi.
Una città che ha perduto l’innocenza e la rettitudine con
l’irrompere furente della mafia e dei politici
d’avanspettacolo, una città che fino alla rasoiata del ’68
era stata legata all’Ottocento come dicevo nel capitolo
quattro, alla sua innocua retorica, ma che da quella
rivoluzione studentesca, poi atrocemente corrottasi, è
rimasta assente, sperduta, incapace di coglierne i
migliori frutti. E dunque quella Catania resta nel mio
cuore come una stagione smarrita.
La famigerata American Legion, ricordata nell’altro
capitolo, non diede problemi a Greer Garson, la signora
Miniver di celluloide, l’attrice che più d’ogni altra
interpretò il ruolo della brava moglie e della madre
esemplare, il simbolo dell’America puritana, patriottica,
coraggiosa. Con la sua “nasca all’aria”, lo sguardo fiero
e appassionato, il temperamento forte, fu un’attrice che
non raggiunse il glamour di altre e forse meno titolate
colleghe ma che negli anni Quaranta s’impose con
classe all’attenzione del pubblico. Aveva alle spalle una
solida esperienza teatrale e ben trentacinque primavere
quando approdò al cinema. La convinse il magnate della
MGM, Louis Mayer, che a Londra la vide recitare e
subito s’innamorò della sua calda voce e del portamento
aristocratico. In un primo momento lei si mostrò restia,
ma alla vista dei molti zeri sul contratto “alluciò”, come
direbbero dalle mie parti. Il primo film doveva essere Il
paradiso delle fanciulle dedicato ai fasti di Ziegfeld, ma
l’attrice dovette rinunciarvi per una caduta da cavallo
che le provocò la lesione della spina dorsale. Fu
sostituita da Luise Rainer che per quel ruolo vinse
l’Oscar come migliore attrice protagonista, che doppiò
l’anno successivo con La buona terra. Rimessasi su, e
224
stanca di aspettare la grande occasione, Greer accettò
una piccola parte in Addio, Mr. Chips! di Sam Wood,
che girò nel ’39. Non pienamente soddisfatta della
prova, stava per tornarsene nella natia Londra quando
apprese che non solo il film era candidato all’Oscar ma
che anche il suo nome era stato inserito nelle
nominations come migliore attrice protagonista. La
statuetta andrà a Vivien Leigh per Via col vento ma fu
comunque una vittoria essere entrata in lizza con artiste
del calibro di Greta Garbo, Bette Davis, Irene Dunne e
della magica Vivien.
Lo stesso anno la MGM le confezionò una storia che
per la verità non stava in piedi, Una donna dimenticata,
accanto a Robert Taylor. Per sua fortuna non ebbe il
tempo di meditare sull’empasse perché finalmente
arrivò l’anno buono, il 1940. Il film è Orgoglio e
pregiudizio, tratto dal capolavoro di Jane Austen, e il
ruolo è quello di Elizabeth, una delle cinque figlie da
marito dei coniugi Bennet. Forse per la parte era un po’
anziana (più adatta senza dubbio Keira Knightley nel
remake del 2005) ma il risultato fu spettacolare. Al suo
fianco c’era Laurence Olivier, mostro sacro del teatro
inglese e che a Hollywood aveva sfondato l’anno prima
con La voce nella tempesta. L’attore trovò pane per i
suoi denti e spesso venne travolto dalla partner,
dilettante di lusso sul set ma che era stata un’ottima
professionista sul palcoscenico. L’anno dopo, Greer
Garson sfiora ancora l’Oscar con il film Fiori nella
polvere, di Mervyn LeRoy, basato sulla vita di Edna
Glaney, la donna che fondò i primi orfanotrofi nel Texas
e lottò affinché la parola “illegittimo” venisse tolta dal
certificato di nascita dei bambini abbandonati. Grazie al
technicolor, il pubblico poté ammirare per la prima
volta il rosso ardente dei capelli della protagonista che
con quel film darà vita al fortunato sodalizio con Walter
Pidgeon che le sarà marito in La signora Miniver di
William Wyler e in Addio signora Miniver di Henry
Potter. Il primo film, girato in pieno conflitto mondiale
e che frutterà all’attrice l’Oscar per la migliore
225
interpretazione, sarà elogiato, e raccomandato al
pubblico, dal presidente Roosevelt e da Winston
Churchill. E piacque anche a Goebbels, ministro della
propaganda del Terzo Reich, perché la storia raccontata
dal film, la storia d’una famiglia inglese che affronta i
dolori della guerra, poteva essere anche una storia
tedesca, di coraggio e sacrificio. Ambedue le pellicole,
intense e commoventi, consegnano l’attrice alla storia
del cinema, anche se lei in un primo momento non
voleva calarsi nei panni di una donna sposata e madre di
un figlio già all’università. Ma dovette subire la legge
del contrappasso: se prima era stata una sin troppo
vecchia Elizabeth Bennett adesso era una sin troppo
giovane Kay Miniver.
Greer Garson mise subito gli occhi sul giovane e
belloccio “figlio”, l’attore Richard Ney di quindici anni
più giovane, e poco dopo la fine delle riprese lo sposò.
Fu un matrimonio sbagliato, come il precedente del
resto, trascinatosi per anni ma già finito durante la luna
di miele. Il primo marito, Alec Snelson, era un
compagno d’infanzia: geloso, possessivo, nettamente al
di sotto della cifra intellettuale della moglie e,
soprattutto, della suocera, l’attrice Nina Ross, che
vedeva in quel ragazzo una zavorra per la carriera della
figlia. Inadeguato anche il giovane Richard, alla fine,
soprattutto per l’immagine pubblica che la Garson dava
di sé: seria, responsabile, affidabile. Finì anche quel
matrimonio. Definitivo sarà il terzo, con Elijah
Fogelson, che aveva fatto i soldi col bestiame e
possedeva un ranch spettacoloso nel Nuovo Messico.
Sarà l’uomo della sua vita. Lo sposerà nel 1949, quasi
alla fine della carriera cinematografica e prima di
inventarsi come attrice televisiva. Un’unione felice,
tenera… “alla signora Miniver”.
Fiori nella polvere c’erano, naturalmente, anche a
Catania. Fiori coltivati, più o meno distrattamente, ’o
cummittu, l’ospizio di beneficenza di via dei Crociferi
che raccoglieva i derelitti, i bambini senza famiglia, i
226
bambini che camminavano in fila per due nelle strade
del centro storico con la testa rapata a zero, per evitare
l’annido dei pidocchi, e a occhi bassi perché il luminoso
mondo circostante non era il loro, perché imparassero a
farsi una ragione della loro sfortuna. Talvolta uno dei
bambini, vestiti di grigio, il colore della loro esistenza,
in quella passeggiata che assomigliava all’ora di svago
dei carcerati, alzava lo sguardo oltre la fila, su qualche
fortunato coetaneo che gli passava accanto, vestito
d’altri colori e sorrisi, e lo seguiva per un buon tratto,
con la testa girata, e capiva che la città era
inesorabilmente divisa a metà. A vederli, il cuore mi si
stringeva in una morsa inesplicabile di disagio;
guardavo mio padre che mi spronava a meritarmi il
privilegio d’essere nato in una famiglia normale. La
miseria era il luogo al confine della mia vita borghese,
come dice Orhan Pamuk nel suo bel romanzo Neve: mio
padre dirigente, mia madre casalinga, mia sorella e mio
fratello, i mobili, la radio, le tende, la casa… l’altro
mondo restava fuori.
Mio padre considerava speciali i suoi figli, sia pure
con pudore. Eravamo talmente speciali che un giorno di
primavera, io e mia sorella (mio fratello gattonava
appena) attirammo in un tranello un piccione vagabondo
e gli tagliammo le ali perché non tornasse più al nido e
restasse a giocare con noi in terrazza. Lo mettemmo in
una scatola e cercammo di rimpinzarlo col resto del
granoturco che era servito da esca. Ma non mangiò nulla
finché non arrivò un altro colombo, che si fece catturare
senza opporre resistenza. Era il compagno, o la
compagna, del prigioniero. Tagliammo anche a lui, o a
lei, le ali e mettemmo in croce papà perché ci
procurasse una piccionaia. E questa arrivò la settimana
successiva. Non era una piccionaia qualsiasi ma un
albergo a cinque stelle per colombi viaggiatori. Si
trovarono bene nei nuovi alloggi, al punto che
concepirono un figlio, che purtroppo visse poco. Non
ricordo come finì la storia. Forse ai colombi ricrebbero
le ali e guadagnarono la libertà oppure finirono in
227
pentola. Eravamo bambini speciali, l’ho detto, nel primo
come nel secondo caso. Io, mia sorella, mio fratello, che
allora era occupato a svegliare il quartiere coi suoi
pianti o le sue grida di gioia.
Colombi a parte, a quell’epoca ero timido e confuso,
uno che a scuola scriveva i temi sentendoseli scorrere
dentro, nel suono delle parole, prima che nella
razionalità dei concetti, uno che stava sempre un passo
indietro prima di convincere se stesso a lanciarsi nella
mischia, uno che parlava poco per timore di sbagliare e
se lo faceva il cuore gli batteva forte, uno che giudicava
la vita con sentimento, che credeva nelle persone, che
guardava alla realtà con la magia del dover essere, della
felicità, degli affetti. La vita, insomma, era per me una
nebulosa di stelle invisibili ma con un nucleo forte
dentro, con una razionalità interiore che alla fine si
sarebbe svelata nella sua purezza assoluta, come un
diamante chiuso nella roccia o un cuore di ghiaccio
incontaminato caduto dallo spazio e sepolto al Polo
Nord, come racconta Peter Høeg nel finale del suo
complesso romanzo Il senso di Smilla per la neve. Per
spiegare ancora: la vita di un ragazzo sta chiusa nella
crisalide prima di diventare un essere compiuto e
spiccare il volo verso liberi e compiuti orizzonti. Il
cinema però, lungi dall’essere una prigione, un inganno
o un incantamento, era un fuoco, un motore che
spingeva la mia adolescenza e quella della mia
generazione verso la maturità, senza pericolosi salti
però, senza delusioni precoci, ma col compito preciso di
preparare il passaggio del confine, grado a grado.
Talvolta l’immedesimazione raggiungeva vette
suggestive e favolistiche come quelle conosciute dal
personaggio Giosuè descritto da Giuseppe Bonaviri in
uno dei suoi racconti. Un giorno Giosuè va al cinema
Olimpia, a Catania, a vedere un film di cappa e spada
con Tyrone Power. Sennonché la suggestione è tale che
alla fine della proiezione si vede rimbalzare il divo dallo
schermo in sala e da qui nella vicina piazza Stesicoro
dove immagina di seguirlo, magari per misurare la
228
propria supposta abilità di spadaccino. Fu la
suggestione, per altro, di Goliarda Sapienza quando,
ragazzina innamorata di Jean Gabin, immaginava di
seguire il suo eroe francese nelle stradine di San Berillo
a Catania pensando ai vicoli della Casbah di Pépé le
Moko.
Tornando ai bambini senza nome poteva accadere
che uno di quei fiori si staccasse dalla polvere e trovasse
i suoi meritati prati assolati. Giuseppe De Felice fu tra
questi. Nato nel 1859 da umile famiglia, e rimasto ben
presto orfano di padre, trascorse gli anni della
fanciullezza o’ cummittu, ma proprio in quel luogo
derelitto trovò la forza di emergere, studiare, laurearsi e
diventare un grande oratore e un politico di rango, il più
autorevole e stimato esponente delle idee socialiste a
Catania. Forse sulla sua strdaa trovò una signora Glaney
che l’aiutò a guardarsi intorno, ad alzare lo sguardo sul
mondo che era di tutti e non solo dei signorini lavati e
profumati di fresco che ai genitori chiedevano questo e
quello. Altra cosa erano i collegi gestiti dalle suore,
come ci racconta Emma La Spina nel suo libro-denuncia
Il suono di mille silenzi. Alle trovatelle, e l’autrice era
una di queste, veniva lesinato il cibo e persino l’acqua
che le bambine, la cui unica “colpa” era quella di essere
figlie abbandonate, erano costrette a rubare dagli
sciacquoni dei water. “Ho scritto tutto questo”, ha
confessato l’autrice “per le mie compagne, che ancora
vivono nel profondo timore di parlare delle loro
sofferenze, quasi ne siano state le carnefici e non le
vittime. Ho scritto tutto questo per spalancare porte che
per troppo tempo sono rimaste chiuse, per illuminare
camere buie, per far crollare muri cementati con
l’indifferenza e l’ipocrisia. Ma, soprattutto, ho scritto
tutto questo perché non sono mai riuscita a urlarlo
prima. Sono una delle mille bambine in silenzio nelle
grandi stanze di un istituto”.
Oleg Cassini era il marito di Gene Tierney, la più
bella donna della storia del cinema, secondo il giudizio
229
di Darryl F. Zanuck, fondatore della 20th Century Fox.
Il matrimonio, durato undici anni (dal 1941 al 1952),
naufragò per l’incapacità dell’attrice di accettare le
contrarietà della vita. Uscì di testa e fu ricoverata in un
ospedale specializzato per malattie depressive. La più
giovane delle due figlie, Daria, nacque mentalmente
ritardata. La causa, a quanto pare, fu dovuta al fatto che
l’attrice, mentre girava uno dei suoi migliori film, Il
cielo può attendere di Ernst Lubitsch, anno 1943,
contrasse la rosolia. Non riuscì a farsene una ragione.
Durante il suo primo film, Il vendicatore di Jess il
bandito di Fritz Lang, 1940, scoprì di avere la voce
troppo sottile. Per renderla più robusta si mise a fumare.
Morirà a settantuno anni di enfisema polmonare.
Oleg Cassini apparteneva alla high life di
Washington. Il padre era un conte russo la madre una
nobile fiorentina. Alto, intelligente, pieno di charme, si
trasferì in America per cogliere la fortuna che bussava
con prepotenza alla sua porta. A fare il disegnatore di
moda cominciò per passatempo ma poiché aveva una
marcia in più rispetto agli altri sbaragliò il campo e ben
presto trasformò la moglie Gene nelle dieci donne più
eleganti d’America. Poi arrivò la tragedia della figlia
Daria e tutto precipitò. Gene si smarrì, Oleg si smarrì. Lei
rimase prigioniera del suo dolore, lui, che a Hollywood
era arrivato a bordo di una MG rossa e senza una valigia,
tornò nella costa orientale e cominciò a frequentare
bellissime modelle. Oriana Fallaci, nel già citato I sette
peccati di Hollywood, ne descrive i percorsi con quel
misto di distacco e di umana partecipazione che erano la
cifra del suo talento. Questa grande giornalista e scrittrice
il 19 settembre 1993 mi mandò un biglietto di
ringraziamento per un servizio che avevo realizzato per il
Tg1 sul suo fortunato e toccante libro Lettera a un
bambino mai nato diventato un audiolibro di altrettanto
successo. Con la sua calligrafia chiara e rotonda scrisse:
“Caro Piero Isgrò, ha fatto un pezzo proprio bello sul mio
libro parlato. Io la ringrazio affettuosamente”. Il
sottolineato era suo. Perché ricordo questo episodio? Per
230
orgoglio, sicuro. Ma per dire anche che la gentilezza
alberga soprattutto nel cuore delle persone speciali. E
Oriana Fallaci era una persona veramente speciale.
Vittorio Feltri, quando è a corto di idee, prende uno dei
tanti libri o articoli splendenti di Oriana, ne legge qualche
pagina e trova lo spunto decisivo per i suoi articoli.
Il cielo può attendere fu uno dei primi film a colori
che ricordo. Il “picciotto” era Don Ameche. Si
chiamava Domenico Felice Amici ed era uno degli otto
figli di un barista che si era trasferito nel Wisconsin dal
lontano Abruzzo. Il cognome lo prese in prestito dalla
marca di un telefono che allora andava per la maggiore.
La “picciotta” era Gene Tierney, la raffinata attrice che
era stata educata in Svizzera e nelle migliori scuole
dell’East Coast di New York. Il film è la storia di un
impenitente dongiovanni, Henry Van Cleve, legato però
moltissimo alla moglie e al figlio. Dopo morto racconta
la sua vita al diavolo, convinto di finire all’inferno per
le numerose scappatelle. Ma Mefistofele, dopo averlo
ascoltato, non lo ritiene “degno” di finire tra i dannati e
lo dirotta in paradiso. Entrando in ascensore, per salire
nel regno dei beati, Henry incontra una bella donna che
invece sta per scendere agli inferi. Da peccatore
incallito, allora, rinuncia all’insperato premio e insegue
l’ennesima e ultima “preda” dicendo a se stesso: Il cielo
può attendere. Solo che la scena venne tagliata per
pruderie hollywoodiana e il finale fu diverso, meno
laico e più accomodante, per cui il significato del titolo
si perse nelle cattive intenzioni dei censori.
Mark Twain diceva di preferire il paradiso per il
clima e l’inferno per la compagnia, anche se alcuni
teologi moderni sostengono la sostanziale inutilità
dell’inferno dal momento che nessuno ne ha mai varcato
la soglia. Forse l’“utilità” serve alla Chiesa per dare un
senso al proprio insegnamento e un ordine sociale alla
comunità dei fedeli. Con uguale convinzione molti
scrittori laici rovesciano il discorso e sottolineano la
noia immortale che deve serrare i cuori dei beati del
paradiso. Uno di questi fu George Orwell che scrisse:
231
“Sappiamo bene che il paradiso cristiano, com’è di
solito rappresentato, non attrarrebbe nessuno”. Troppa
estasi e beatitudine, insomma, che alla fine possono
diventare incubi. Ma se è vero, come dice Tertulliano,
che una delle maggiori gioie del paradiso è di guardare
le torture dei dannati ecco che il problema si ripropone.
Forse il più saggio si rivela il dongiovanni Henry: prima di
qua, tra le donne, e poi di là, a riprendersi dalle fatiche.
Durante il suo regno di celluloide, Gene Tierney,
oltre ai due mariti (Oleg Cassini e Howard Lee, che era
stato uno dei mariti di Hedy Lamarr) collezionò amanti
di prima grandezza, a cominciare da John F. Kennedy,
incontrato nel 1946 sul set di Il castello di Dragonwyck
di Joseph Mankiewicz, per finire con Tyrone Power e il
principe Alì Khan che l’abbandonò provocandole un
fortissimo esaurimento nervoso che la spinse sulla
soglia della follia. Nel 1979 pubblicò l’autobiografia,
Autoritratto, in cui mise a nudo la sua tormentata
personalità, perennemente in bilico tra la severa
educazione d’alta classe, ricevuta da ragazza, e il fatuo
mondo del cinema. Una donna di terra che diventa
donna di mare, in definitiva, che rovescia la lezione del
grande Henrik Ibsen; una signora speciale che distrugge
la realtà per il sogno e con questo per sempre si
addormenta. A pensarci bene, la storia assomiglia a
quella raccontata da John M. Sthal in Femmina folle in
cui la protagonista, Gene Tierney appunto, interpreta il
ruolo di una donna possessiva che per eccesso d’amore
distrugge quanti le stanno attorno, fino al tragico finale.
Proprio nelle parti di “cattiva” Gene riscosse i maggiori
successi così come avevano fatto Margaret Lockwood
(L’uomo in grigio, La bella avventuriera, Bedelia),
Tallulah Bankhea e Gale Sondergaard.
La stagione del dopolavoro ferroviario volgeva al
termine. Gli ultimi anni, prima del definitivo
abbandono, alternammo l’angusta sala di via Luigi
Capuana con il cinema Spadaro, in via Sabotino, non
lontano da casa. Era un locale nuovo, ampio, 540 posti
232
tra platea e tribuna. La platea era per operai e piccoli
borghesi, la tribuna per chi aveva fatto qualche soldo e
cercava di distinguersi anche a costo di respirare il fumo
che saliva dal basso. Era un vero cinematografo,
insomma. Rispecchiava la società imperfetta che andava
consolidandosi col primo timido benessere. Entravi e
già ti batteva il cuore, come se ti trovassi in un tempio
di misteriose meraviglie, ancora prima di vederle.
Anche i cinegiornali, che precedevano la proiezione dei
film, erano da noi accettati non tanto come
“informazione”, c’erano i quotidiani per quello, ma
come assaggi della torta che da lì a poco avremmo
consumato. Ne ricordo il logo: un mappamondo, col
David di Michelangelo accanto, fasciato dalla scritta
“La settimana Incom”. Questa era l’informazione
“televisiva” di allora. Era stata fondata da Sandro
Pallavicini nel 1938 e si era affermata nella nascente
Repubblica. Sul piano politico questo cinegiornale, che
entrò in concorrenza con quello dell’istituto Luce, per
poi sostituirlo, si mantenne vicino al governo ma non
trascurò l’opposizione. Fu messo definitivamente in
crisi dalla TV, nel 1965.
L’incontro con Virginia Mayo, che un critico definì
“la prova vivente dell’esistenza di Dio”, avvenne al
cinema Spadaro. Era bella e saggia, Virginia Mayo. Si
sposò una sola volta, con l’attore Michael O’Shea, ebbe
una sola figlia, Mary Catherine O’Shea, e visse sempre
alle Mille Querce, California: come a tracciare un
analogo destino con Tara di Via col vento. La ricordo
nella Leggenda dell’arciere di fuoco di Jacques
Tourneur, 1950, con Burt Lancaster nel ruolo di un
coraggioso cacciatore, Dardo, che organizza in
Lombardia la rivolta contro il conte Hess, luogotenente
del Barbarossa, che per altro gli ha rubato la moglie e il
figlioletto. Virginia Mayo è messa in ombra dalle gesta
e dai funambolismi di Lancaster ma la sua grazia rifulge
come i dardi fiammanti scoccati dal marito contro la
prepotenza del conte Hess. Va meglio l’anno dopo con
233
Le avventure del capitano Hornblower di Raoul Walsh,
con Gregory Peck. Il film, tratto da un romanzo di Cecil
Scott Forester, scrittore britannico specializzato in
avventure di mare, racconta la storia di un capitano di
goletta inglese che combatte in Nicaragua e in Francia
per il suo Paese, pensando sempre a Lady Barbara,
sorella del duca di Wellington, ma che è sposata
all’ammiraglio Leighton. Dopo un’ultima missione
vittoriosa, Hornblower torna in patria e scopre di essere
rimasto vedovo. Il cordoglio per il lutto dura però un
momento. Il capitano coraggioso incontra da lì a poco
l’innamorata, fresca anche lei di vedovanza (guarda
caso), la fissa negli occhi, la stringe tra le braccia, la
bacia … “e si ficiru ’i ficu”, secondo il commento d’uso
della platea del cinema Spadaro nelle storie d’amore.
Variante colorita e popolaresca, questa, del “vissero
felici e contenti”, come nelle fiabe ascoltate accanto alla
conca, il braciere della mia infanzia, il fuoco sacro che
riscaldava il salotto di nonno Carmelo, attorno al quale
si raccoglievano i suoi figli e le loro storie.
Il terzo film che ricordo è Il calice d’argento di
Victor Faville, 1954. È un improbabile racconto storicoreligioso che allora mi affascinò ma che rivisto anni
dopo risultò un polpettone indigesto. Paul Newman, al
suo esordio, si pentì di averlo girato e per circa due
anni, dalla radiofonica BBS, chiese perdono ai suoi
fans. Resta però la bellezza di Virginia Mayo che
andava assomigliando sempre più alle pin-ups di Gil
Elvgren e Ren Wicks, i disegnatori delle ragazze-spillo
che andavano a finire nei calendari profumati dei
barbieri negli anni Cinquanta. Resta la celebre “s”
romagnola della sua doppiatrice Dhia Cristiani, restano i
suoi occhi azzurri, le sue labbra carnose, la sua incantata
visione della vita, restano i suoi film musicali accanto a
Danny Kaye, rigorosamente doppiati, e quelli
drammatici: La furia umana di Raoul Walsh, del 1949,
e I migliori anni della nostra vita di William Wyler, del
1946, dove interpreta il ruolo della giovane moglie
infedele (errant young wife) di un reduce di guerra.
234
DIECI
Linda Darnell, Rhonda
O’Hara, Deborah Kerr
Fleming,
Maureen
I calendari profumati con le donnine seminude mi
riportano alla mente l’innocente sadismo dei barbieri.
Starmene seduto per mezz’ora, senza muovere un
muscolo, sotto l’azione della macchinetta, impegnata a
strapparmi più che a tagliarmi i capelli sopra le
orecchie, è stata una delle esperienze più sconvolgenti
della mia vita di bambino. Quando saltavo giù dal
cavallino, rapato a zero, le gambe le muovevo appena e
il collo mi faceva male. A quel punto il tagliatore di
teste, camuffato da lavorante, mi dava un affettuoso
scappellotto e diceva che ero stato bravo. Mio padre
sorrideva e mi conduceva via. Il martirio finì quando
l’aguzzino passò alle forbici e al rasoio. A continuare a
sconvolgermi tuttavia restava l’unghia esagerata del suo
mignolo che gli serviva per scavarsi il naso o togliersi i
tappi di cerume dalle orecchie.
In origine lo spaventoso artiglio aveva una funzione
simbolica: sanciva la raggiunta professionalità del
barbiere che da preparatore di saponate, spazzolatore
d’abiti e pulitore di pavimenti diventava finalmente
“mastro”, magari dopo svariati e faticosi esercizi di
rasatura dei palloncini. Più ne faceva scoppiare più si
allontanava la promozione. I barbieri non erano solo
abili tagliatori di barba e capelli o massaggiatori di visi,
spalmatori di creme e applicatori di pannicelli caldi,
erano dispensatori di saggezza e d’informazione. Nelle
loro botteghe si parlava di sport e di politica, di donne e
di cinema, si scambiavano pettegolezzi, vanterie, storie
incredibili e inconfessabili. In tempi più antichi
venivano chiamati anche per radere i morti e vestirli
(usanza orientale per altro, come racconta il film del
giapponese Yojiro Takita, Departures), salassare i
clienti, incidere bubboni, curare malattie della pelle,
235
cavare denti, ospitare complessi di mandolini e chitarre,
costruire in ultima analisi una socialità primitiva basata
sulla gerarchia del “ragazzo, spazzola!”, su
l’apprendista e lo stregone, sul giovane e il vecchio, su
chi sta sotto e chi sta sopra. In Sicilia allora c’erano più
sarti e barbieri che professori, più pettinatori di pensieri
che insegnanti d’ortografia.
Uno degli artisti più blasonati dei calendarietti di
Brown&Bigelow, che gli uomini conservavano come
reliquie nel portafogli, era il vecchio Gil che alla figura
femminile riuscì a dare un’immagine di prosperità,
ironia e sensualità. I soggetti erano in gran parte
stupende donnine con la bocca di rosa e le gonne che
s’impigliavano sempre in qualcosa (nella pompa
dell’acqua, nella scala, nella palizzata, nel remo della
barca) e scoprivano gambe, reggicalze e curve callipigie
mozzafiato. Per non dire dei seni maestosi che
scoppiavano dai vestiti aderenti o che s’intravedevano
dalle trasparenze dei babydoll. Lascio immaginare a
cosa servissero quei disegni di puro sesso al quadrato.
Accanto a Gil Elvgren, che per venticinque anni fu il
disegnatore ufficiale della Coca-Cola, c’era uno stuolo
di artisti niente male, a partire da Rolf Armstrong e
finire a Earl Moran, Art Frahm, Walter Otto. Fu dopo la
Grande Depressione che questi geniali cartoonist
s’impegnarono a ridare all’America il suo fiato, a dare
consistenza alla leggenda americana attraverso
l’opulenza della forma di cui dicevo.
Anche Linda Darnell, l’attrice dal viso perfetto, entrò
nelle loro sapienti tessiture di colori e pennelli.
Possiamo immaginarla nel disegno, olio su tela,
intitolato Vento di poppa di Gil Elvgren: una bellissima
bruna tenta, senza molto successo, di trattenere il
cappello e il vestito giallo che si solleva al passaggio di
un aereo al decollo. Ha la sua faccia anche la ragazza
sul cavallo a dondolo, sempre di Gil, mentre mostra
magnifiche gambe inguainate in calze di seta.
La madre di Linda Darnell doveva essere come la
236
protagonista del film di Luchino Visconti, Anna
Magnani, che cerca disperatamente di costruire un
futuro d’artista alla propria figlioletta. A undici anni la
lanciò come modella e a tredici le fece fare
un’audizione cinematografica, sempre dichiarando età
anagrafiche giuridicamente ineccepibili. Il talent scout
vide quella meraviglia terrestre, una specie di Dolores
Haze nei panni di Lolita, che dimostrava non meno di
diciotto anni, e se la portò a Hollywood, ma appena si
accorse che era minorenne si spaventò e la rimandò
indietro. La signora Darnell non si scoraggiò. Era una di
quelle donne che avrebbero messo le figlie nel letto di
Barbablù pur di farle diventare star.
Hollywood Babilonia è una miniera di nefandezze.
Molti produttori per il provino sceglievano direttamente
il sofà del loro studio. “Lo fanno tutte” confesserà una
Marilyn Monroe alle prime armi, “e se tu non vuoi ce ne
sono altre venti, cinquanta, cento dietro la porta, pronte
a farlo”. Come del resto fecero Joan Crawford, Lana
Turner, Betty Hutton, Hedy Lamarr, Jane Russell.
“Eravamo gentaglia, noi del cinema, una banda di
farabutti, ammalati di sesso, rozzi e volgari, viziosi,
cinici, ignobili” confessò una volta uno dei pionieri di
Hollywood, specializzato in film biblici, Cecil B. de
Mille. Anni dopo, Veronique Passani, la moglie
francese di Gregory Peck, disse la stessa cosa ma in
modo spiritoso: “Tutto quello che trovi di utile a
Hollywood sono i distributori di benzina”.
Per Linda Darnell la grande occasione arrivò nel
1939 (aveva appena sedici anni) con Hotel for women,
un filmetto di Gregory Ratoff che lo stesso anno la
diresse anche in Moglie di giorno. Linda, che aveva
sangue cherokee nelle vene, girò 46 film, più o meno
passabili, ma il suo nome resta legato al personaggio di
Ambra, dall’omonimo film di Otto Preminger, del 1947.
Un film profetico. Nell’Inghilterra di Carlo II,
l’avventuriera Ambra, generosa ma un poco bitch, ama
un soldato di ventura, lo salva dalla peste ma poi lo
perde di vista. Sempre pensando a lui, diventa l’amante
237
di un brigante, poi di un capitano delle guardie e infine
dello stesso re. Un giorno torna l’antico innamorato, ma
ormai è troppo tardi. Nella storia entrano disgrazie a non
finire, piaghe, pestilenze e, soprattutto, il grande
incendio che distrusse Londra nel 1666. Tre secoli dopo,
esattamente la notte del 9 aprile del 1965, Linda
Darnell, che aveva da poco finito di girare Lo sperone
nero di Robert Springsteen, stava dormendo in casa
della sua vecchia segretaria, a Chicago, quando fu
svegliata da un fumo soffocante. La camera da letto era
al piano di sopra. Si precipitò verso le scale, ma non
fece in tempo a scappare perché le fiamme la
imprigionarono coprendola di ustioni per il 90 per
cento. Morì il giorno dopo, in ospedale, soffrendo le
pene dell’inferno. La sera, prima di andare a dormire,
aveva visto in TV un suo vecchio film, Star Dust,
Polvere di stelle. Sedici anni prima analoga sorte era
toccata all’attrice russa Maria Ouspenskaya, che ne Il
ponte di Waterloo è l’austera direttrice di ballo Olga
Kirowa. Mentre era a letto e stava fumando fu colpita da
un ictus e non trovò la forza di fuggire. Le fiamme,
rapidamente sviluppatesi a causa della sigaretta, le
provocarono ustioni mortali.
Linda Darnell non fu una grande attrice ma un sex
symbol e come tale visse in balia delle tensioni
dell’esistenza, d’ogni suo sommovimento. Incapace di
ancorare la bellezza a un solido talento, annegò i
dispiaceri (tre matrimoni falliti) nell’alcol. Morì tra le
fiamme che, simbolicamente, l’assediarono per tutta la
vita. Ma, a ben ricordare, la morte cominciò ad
affacciarsi il giorno in cui imparò a sdraiarsi sui sofà.
Queste “debolezze” il pubblico le conosceva, a volte
rammaricandosene a volte godendo a rovistare nella
spazzatura di celluloide. Le storie sono tante, lontane e
recenti, perché Hollywood non cambia né può cambiare.
Qualche anno fa abbiamo letto che Marlon Brando
passava con facilità da un sesso all’altro e che aveva
amato indifferentemente Burt Lancaster e Rita
238
Hayworth, Tyrone Power e Anna Magnani,
Montgomery Clift e Ingrid Bergman. Di recente, i soliti
biografi post mortem hanno innescato e fatto esplodere
un’altra bomba: Paul Newman, due mogli e sei figli, sex
symbol assoluto del cinema internazionale, pare abbia
avuto anche lui rapporti omosessuali. Lo ha rivelato
Darwin Porter in The man behind the baby blues.
L’attore, che incantava il pubblico femminile con il solo
sguardo, cominciò con Marlon Brando, poi passò a Sal
Mineo (gay incallito), quindi ebbe rapporti con James
Dean, Anthony Perkins, Montgomery Clift, Steve
McQueen, Robert Wagner. Per non dire delle
frequentazioni alle orge bisex di Tyrone Power (dove
apprese che Tyrone ed Errol Flynn erano amanti) e a
quelle (etero) di Sinatra. “Non sarai mica frocio? Girano
strane voci su di te”, gli disse Frank. Tutto ciò che
Hollywood toccava diventava il rovescio dell’oro.
A parte i biografi, scrupolosi e no, c’erano poi le
grandi pettegole di Hollywood, come Hedda Hopper e
Louella Parsons che si divertivano a distruggere persino
quel poco di buono che c’era nello star system. Erano
ricchissime e molto corteggiate dai divi che ne
temevano i gossip al fiele. La prima, figlia di un
macellaio, si diede al giornalismo dopo aver girato 141
film inutili. La sua religione era: “Non risparmiare
nessuno. Dire, sempre, male di tutti. Compiacersi
d’essere definita una vipera”. La seconda, scrittrice e
sceneggiatrice, più che l’inchiostro usava anche lei
l’arsenico. Visse fino a 91 anni nonostante che mezzo
secolo prima i medici, per una forma di tubercolosi, le
avessero concesso sei mesi di vita. Evidentemente, a
essere buoni, la salute non ci guadagna. E c’erano poi la
cattivissima Elsa Maxwell, che cominciò come pianista
e finì come ruffiana, e Sheilah Graham, modesta attrice
di teatro e di music-hall, che aveva avuto una relazione
con Scott Fitzgerald. Sheilah in realtà si chiamava Lily
Sheil e veniva dall’East End di Londra. Era una strana
ragazza ma di cuore. Fu lei ad aiutare l’infelice e ormai
alcolista scrittore dopo che la moglie di lui, Zelda, era
239
finita in manicomio.
E poi c’erano i mille giornalisti, maldicenti per
vocazione e necessità, che lavoravano inseguendo, 24
ore su 24, i “peccatori” di Sunset Strip e Sunset
Boulevard, di Ciro’s, Mocambo e dei ristoranti della
Cienega che dal cuore di Hollywood arriva alla
downtown di Los Angeles. Tanti chilometri e tanta
fatica per dare in pasto al pubblico storie di scandali in
celluloide più o meno veri, più o meno inventati. Se
Lana Turner dormiva in pigiama felpato l’indomani
venivano a saperlo anche i minatori dell’Idaho e se dai
banchi della chiesa cattolica di Beverly Hills Van
Johnson si allargava il colletto per il caldo l’occhiuta
Louella Parsons, che aveva assistito alla scena russando
dalle ultime file, lo faceva sapere ai suoi quattro milioni
di lettori.
Di converso, Warren Beatty, fratello minore di
Shirley MacLaine, in una biografia non autorizzata
confessò di avere sedotto circa tredicimila donne,
famose e no. Tra le famose: Jane Fonda, Leslie Caron,
Julie Christie, Diane Keaton, Madonna, Isabelle Adjani.
Tra le “vittime” c’era anche Jane Collins, costretta a
lasciarlo per evitare di essere distrutta. L’aitante Warren
pretendeva di fare l’amore fino a sei-sette volte al
giorno. Insomma, solo i dongiovanni etnei avrebbero
potuto (a parole) tenergli testa.
Rhonda Fleming, con i suoi capelli rossi e gli occhi
verdi, la carnagione color crema e la voce suadente, fu
trasformata in oggetto del desiderio mentre nella vita
privata l’attrice continuò ad andare in chiesa, a
occuparsi di istituzioni benefiche e a cambiare mariti lo
stretto necessario. La sua bellezza era talmente squisita
che riusciva a “incantare” persino la cinepresa. Si
racconta che un giorno un operatore, irritato dalla sua
eccessiva avvenenza, si mise d’impegno nel riprenderla
nel peggiore dei modi. Restò di stucco quando si
accorse che le immagini erano ancora più splendenti di
quelle girate con scrupolo. Sembra una stupidaggine, e
240
forse lo è.
Rhonda, come tutte le dive che allineano parecchi
zeri sul cachet, godeva d’ogni privilegio. In L’arma
della gloria, diretto da Roy Rowland nel 1957, la
produzione assunse una delle più celebri stunt woman di
Hollywood, Martha Crawford, che per meno di
cinquemila dollari non tentava manco una caduta dalla
sedia. Martha era una bella ragazza, forte e coraggiosa,
con Rhonda fece subito amicizia. Per farle un favore
cadde da cavallo in maniera così tumultuosa e veridica
che la povera bestia si spezzò le zampe e una volta, a
causa degli schiaffi che prese al suo posto, finì in
ospedale con la faccia tumefatta. Martha era sposata con
un fantino di origine italiana, John Cantarini: talmente
spericolato che in California il suo nome era diventato
sinonimo di crazy kid.
Magnifico il cammeo d’esordio in Io ti salverò di
Hitchcock in cui Rhonda interpreta Mary Carmichael,
una paziente di Green Manors, la clinica psichiatrica del
Vermont dove si dipana la vicenda e l’amour fou di
Ingrid Bergman per Gregory Peck ingiustamente
accusato di omicidio. Ma ancora più convincente è nel
film Out of the past di Jacques Tourneur, che nell’Italia
del 1947 venne scioccamente tradotto in Le catene della
colpa che lasciava immaginare un film con Amedeo
Nazzari e Yvonne Sanson e invece si trattava di una
delle opere noir più importanti del cinema americano.
Protagonisti Robert Mitchum, Jane Greer (eccellente
dark lay dal viso d’angelo), Kirk Douglas e Rhonda
Fleming, appunto, che gareggia in cattiveria e
perversione con la Greer senza però riuscirci.
Di questo fascino che bucava lo schermo anch’io fui
(giovane) testimone. Se non ricordo male, il film, che
vidi nella piccola sala del dopolavoro ferroviario, era La
cortigiana di Babilonia, girato in Italia da Carlo
Ludovico Bragaglia, con Tamara Lee, Roldano Lupi e
Ricardo Montalban. Il seno di Rhonda era maestoso.
Rividi il film due volte, proprio per quel seno ribelle che
infuriò nella mia testa per molto tempo. Queste erano le
241
occasioni per “peccare”, per poi darsi un giro di vite e
correre dal confessore che pareva non aspettasse altro.
Questo era l’arco del desiderio e della penitenza in
quegli anni siciliani acerbi, anni di calendarietti
profumati, di confessionali, di pedinamenti delle
ragazze, di passeggiate sotto i balconi, di gelsomini e di
canzoni.
Il 21 marzo 1953, nella chiesa parrocchiale del
Pantheon, a Siracusa, padre Bruno celebrò le nozze tra
Angelo Iannuso e Antonietta Giusto, due giovani
innocenti e poveri. Una cerimonia semplice e un
ricevimento ancora più semplice. La coppia andò ad
abitare al numero 11 d’una casetta al pianterreno di via
degli Orti di San Giorgio, arredata con poche cose: un
letto, un armadio, un tavolo, quattro sedie, un fornello,
poche pentole e stoviglie. Come capezzale, unico
oggetto superfluo e necessario, un bassorilievo di gesso
che raffigurava il Cuore Immacolato di Maria, regalo
d’una cognata che l’aveva comperato per 3.500 lire in
un emporio del centro della città. Quattro mesi dopo, il
29 agosto, alle 8.30 del mattino, Antonietta, che portava
una gravidanza difficile, al punto che talvolta le si
annebbiava la vista, si accorse che la sua Madonnina
stava piangendo. Asciugò le sue notturne lacrime, per
meglio osservare lo sconvolgente fenomeno, e si
accorse che dalle pupille inanimate della Santa Madre
scorreva uno strano liquido: lo toccò, lo portò
meccanicamente alle labbra e lanciò un grido al marito
che stava in cucina. “Ha perso il bambino”, pensò il
poveruomo precipitandosi in camera da letto. Anche lui,
come San Tommaso e come la moglie, mise il dito e
assaggiò. Non c’erano dubbi. Allora si lasciò cadere in
ginocchio davanti al capezzale miracoloso, e così fece la
moglie. Pregarono un tempo eterno fino a quando la
piccola stanza dei sogni impossibili si riempì di persone.
Il fenomeno durò quattro giorni e fece il giro del
mondo. Per settimane e settimane, per mesi e mesi, in
quella strada, tracciata ai confini dell’Italia, si
242
riversarono migliaia di fedeli e di curiosi, si gridò al
miracolo e si fecero buoni affari.
Me la ricordo quella notizia che ci mise, a noi
siciliani, in cima alla curiosità della gente e mi ricordo
pure le balle di cotone nei magazzini della Fidap,
l’industria farmaceutica diretta da mio padre, alte
quanto me, in attesa di essere spedite ai commercianti di
Siracusa, che le riducevano in piccoli fiocchi imbevuti
d’acqua salata e venduti ai fedeli come testimonianza
autentica delle lacrime della Madonna. Se fossero state
le lacrime del miracolo la piccola immagine di gesso
avrebbe dovuto lacrimare come un rubinetto aperto
giorno e notte. Un mese più tardi il mio quartiere fu
svegliato da un altro “miracolo”. Una donna, che
abitava anch’essa al pianterreno, vide un’ombra
disegnarsi sulla parete e immaginò che assomigliasse
alla Madonna di Lourdes. Si formò una processione di
gente che si mise a pregare e a cantare inni alla Santa
Vergine. Le apparizioni durarono qualche giorno, con
cospicue offerte alla “vedente”, finché si scoprì che
l’ombra non era quella della Madonna ma
dell’ascensore del palazzo accanto. Verso la fine degli
anni Novanta, a Riesi, un paesino del Nisseno che odora
di vino e di mafia, si gridò al prodigio per molto meno.
Sull’intonaco ancora fresco della facciata di un
palazzotto l’umido aveva lasciato una macchia simile a
una forma umana. Una donna la vide e le parve di
individuarvi la faccia del Cristo della Sindone. Passò la
voce e dopo un po’ la strada si intasò di fedeli disposti a
credere a tutto. Finché la macchia fu asciugata dal sole.
Il 1953 è l’anno della morte di Giuseppe Stalin, al
quale dedicai, pur comprendendone vagamente i
crimini, un “Eterno riposo”… se mai si fosse svegliato.
È anche l’anno della legge truffa, dei “forchettoni” e di
Un uomo tranquillo di John Ford, con Maureen O’Hara,
l’irlandese dai capelli rossi e dai grandi occhi verdi, che
fa la parte della fidanzata e poi della sposa di John
Wayne. Lo scenario del film è proprio l’Irlanda, il Paese
243
natale dell’attrice, il paese duro e selvaggio della sua
giovinezza prima che Charles Laughton la notasse e
l’imponesse allo star system hollywoodiano. Il quiet
man è il grande e robusto John Wayne nel ruolo di un ex
pugile che torna nella sua vecchia patria per dimenticare
la brutta avventura di un incontro finito in tragedia e per
rifarsi una vita. Qui incontra la ribelle Maureen ed è
amore a prima vista. Ma i due debbono vedersela con il
fratello di lei, il possente e altrettanto magnifico Victor
McLaglen, che contrasta le nozze per timore di dover
dare la dote alla sorella. Ne nasce una storica scazzottata
che dura mezzo film e che è una delle cose più
divertenti dell’opera. Lui, John Wayne, avrebbe fatto a
meno della dote ma lei, la focosa Maureen, pretende ciò
che le spetta, anche a costo di mandare all’aria il
matrimonio. Una questione di principio, insomma.
Una questione comune alle nostre genti del
Meridione, del resto. La dote, un tempo, era la dote;
giuridicamente disciplinata, punto ineliminabile d’ogni
avvio di contratto matrimoniale, punto d’orgoglio col
quale si misuravano le rispettive potenze, o impotenze,
familiari. E se l’amore dei promessi sposi non era saldo
andava tutto all’aria. L’unico antidoto alla “malattia”
del denaro e al compromesso dei sentimenti era la
fuitina. I due giovani innamorati, stanchi di tutte quelle
speciose difficoltà, mettevano i rispettivi genitori di
fronte al fatto compiuto: fuggivano di casa e se ne
andavano a consumare il “peccato” in albergo o in casa
di amici compiacenti. A quel punto i genitori, per
salvare l’onore, erano costretti a calare le corna e a dare
il consenso al matrimonio riparatore.
Forse non fu un caso che in quei giorni mi misi a
imitare il vecchio John, allenandomi contro il vento e
meritandomi gli sberleffi di mio fratello, bambino
dall’ombra d’oro, bambino che ne ha passate tante e che
non può morire, come il protagonista del bel romanzo di
Alessandro Baricco, Questa storia. Aveva otto mesi
quando un acetone rischiò di portarselo all’altro mondo.
Furono giorni molto tristi. Venne pure il prete a
244
battezzarlo. I miei avevano ritardato la cerimonia perché
volevano fare una bella festa. E venne pure il pediatra,
un professore secco e lungo come la sua scienza medica.
Disse un paio di papalate che mio padre cercò
timidamente di contestare. Al che l’illustre medico, che
a Catania passava per la maggiore, rispose infastidito:
“Lo cura lei o lo curo io?” Lo curò così bene che una
notte mia madre, che si coricava accanto il suo piccolo
figlio per controllarlo e magari alitargli un poco del suo
calore, svegliò mio padre e gli disse: “Pino, ’u
picciriddu è freddo come la morte”. E cominciò a
strofinargli le manine e a cullarlo.
Quella scena m’è venuta incontro di recente con tutto
il suo lontano dolore assistendo alla proiezione del film
di Griffith, Agonia sui ghiacci, con una superba Lillian
Gish, al Centro Zo di Catania. Non si può capire. Nel
momento in cui la protagonista, spinta dalla
disperazione e non avendo nessuno a cui rivolgersi,
decide essa stessa, irrazionalmente, di battezzare il
figlioletto, che le sta morendo di stenti, perché
altrimenti non andrebbe in Paradiso, mi sono ricordato
del battesimo di mio fratello nella camera da letto dei
miei genitori. Sette persone in tutto: mio fratello, mio
padre, mia madre, il padrino, il sacerdote, io, mia
sorella. E due candele accese per parvenza di chiesa. Il
ricordo s’è fatto straziante allorché Lillian Gish, nel
tentativo di rianimare il suo piccolo gli strofina più volte
le manine fino a che il medico non le dice che è tutto
inutile: il bambino è morto.
Mio padre balzò dal letto, armò una siringa gigante e
gli fece un’iniezione di dieci centimetri cubici di
soluzione alcalina. Passò mezzora e gliene fece un’altra,
della stessa portata. Ma mio fratello respirava appena.
Se ne stava andando con la benedizione del grande
pediatra. Mia madre allora cominciò a piangere in
silenzio e a pregare. Quando il gallo annunciò l’alba,
che poteva rivelarsi tragica, mio padre non sapeva più
dove fare le iniezioni. Il suo era un azzardo disperato.
Ma fu alla fine di quell’azzardo d’amore che mio
245
fratello riprese colorito. Era salvo. Mio padre l’aveva
salvato perché gli aveva fatto scorrere nelle vene un
fiume di bicarbonato che sciolse il suo male.
Maureen O’Hara aveva tutto: prestanza fisica,
bellezza, intelligenza, bravura e una calda voce di
contralto. Era considerata una delle cinque donne più
belle del mondo. Si sposò tre volte. Una prima con
George H. Brown (1939-1941), ma il matrimonio fu
annullato; una seconda con Will Price (1941-1953); una
terza (1968-1978) con un generale d’aviazione, Charles
Blair, vecchio amico di famiglia. Blair fu nella realtà
quello che Wayne fu nella finzione: coraggioso, leale,
testardo. Era un ottimo pilota. Dopo avere prestato
servizio nell’Air Force, passò alla Pan American; quindi
gestì con la moglie una compagnia aerea, Antilles
Airboats.
La carriera di Maureen può dividersi in due periodi:
il bianco e nero di Com’era verde la mia valle di John
Ford e di Notre Dame di William Dieterle, e il
technicolor di Un uomo tranquillo e di La lunga linea
grigia, ambedue di John Ford. In mezzo, film di poco
conto in cui tuttavia rifulge la forte personalità
dell’attrice. In Il Cigno nero di Henry King, 1942, dopo
avere tenuto sulla corda un intraprendente Tyrone
Power alla fine lo stuzzica con questa frase da
femminista ante litteram: “Io assaggio sempre una
bottiglia di vino prima di comperarla”. Al che il pirata
Henry Morgan, che assiste alla scena, commenta
avvilito: “Questa è la fine dei Caraibi”.
Lei è stata la donna ideale del cowboy, la compagna
forte e coraggiosa che gli sta a fianco mantenendo
intatta la propria dignità e fierezza, lei è la donna che
rifulge nel tramonto infuocato mentre il suo cavaliere
d’argento cavalca nell’orizzonte della Monument
Valley. In una bella e nostalgica canzone degli anni
Settanta, gli Statler Brothers lamentano la demolizione
dello Strand Theatre, il cinema della loro infanzia, luogo
dei loro primi incontri col cinema western, e ricordano
246
“i cowboy d’argento che cavalcavano sullo schermo
d’argento”.
Magnifica espressione, questa, che è proprio quella
della mia giovinezza, del piccolo cinema di via Luigi
Capuana che diventerà un sacco di stupide cose, come il
Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore,
demolito e ricostruito per farne un posteggio. Lo
studioso Charles Silver, introducendo un suo libro sui
film western, dove per la verità ci sono più foto che
notizie, parla anche lui del suo cinema dell’infanzia,
l’Elmora, a Elizabeth, nel New Jersey. Scrive: “Erano
rare le mattine di sabato e domenica, tra la fine degli
anni Quaranta e l’inizio dei Cinquanta, che non mi
vedessero seduto in platea, al mio solito posto. Vedevo
di tutto, storie d’amore, i musical di Ester Williams, ma
soltanto John Wayne, Randolph Scott e i tipi come loro
riuscivano veramente a entusiasmarmi”. Il sorriso della
Williams non l’avrei barattato per nulla al mondo,
nemmeno con il Winchester del colonnello Kirby in Rio
Bravo di John Ford. L’antica fabbrica di William Wirt
Winchester, fondata nel 1857 a New Haven, rischia di
chiudere. Poche commesse. Una sorta di maledizione
che viene da lontano. La ricchezza non portò fortuna a
William e a sua moglie Sarah: persero l’unico figlio alla
nascita, lui si ammalò e morì ancora in giovane età, lei
si trasferì in California dove per un ventennio si dedicò
alla costruzione di un palazzo che andò distrutto nel
terremoto di San Francisco nel 1906.
Nata in un villaggio a sud di Dublino, Maureen
O’Hara, rossa di capelli, carnagione lattea come tante
sue connazionali, riassumeva la contraddizione storica e
irriducibile dell’Irlanda essendo figlia di un cattolico e
di una protestante: una miscela esplosiva che la
fiammante attrice mise a frutto in Un uomo tranquillo. Il
film fu girato nella cittadina di Cong, a ridosso del
parco nazionale del Connemara, un luogo che esprime
bene il carattere dell’isola, la tenacia, l’intelligenza del
suo popolo forte e paziente che ha donato all’umanità
scrittori e poeti del calibro di Swift, Yeats, Wilde,
247
Shaw, Joyce, Beckett. Forse è la durezza dell’Irlanda, la
sua storia drammatica, la sua antica povertà, la sua
innocenza più volte tradita e offesa, a rendere possibile
una tale potente fioritura di talenti così com’è stata
possibile, in piccolo, quella siciliana che nel suo lungo
soffrire ha espresso scrittori come Verga, Pirandello,
Sciascia, Brancati.
Non conoscevo l’Irlanda. L’amavo per le commedie
di Bernard Shaw e Oscar Wilde, per il “flusso
interiore” dell’Ulisse di James Joyce, per l’Aspettando
Godot di Samuel Beckett (la cui prima rappresentazione
vidi, ragazzo, nell’aula magna del Liceo Cutelli
trasformata in teatro e che per la verità mi frastornò).
L’amavo per il film appena citato, per le bevute
ciclopiche di birra scura (l’amara impossibile fantastica
Guinness) dei suoi abitanti sempre sul filo di un’allegra
fragorosa ubriachezza, per la sua musica malinconica e
luminosa, per il piccolo Freddie Bartholomew
indimenticabile interprete di Capitani coraggiosi, per
George Brent e Barry Fitzgerald, per Maureen
O’Sullivan che fu una dolce Jane accanto al Tarzan di
Johnny Weissmuller, per Peter O’Toole e Richard
Todd… e guardate quanti altri talenti ha prodotto questa
verde culla d’antiche speranze frustrate. L’amavo,
dunque, senza conoscerla. A entrarci, dentro, nelle sue
città e nei suoi villaggi, è come riscoprire dal vivo un
lungo film di parole forti e sequenze folgoranti che ti sei
covato dentro e che collimandole, oggi, con la realtà
non trovi spazi di confine incolmabili o separatezze. Un
miracolo. Perché l’Irlanda, caso più unico che raro, è
come appare e come te l’immagini. Così come
t’immagini il suo cielo: “un oceano di nuvole e luce”
che “ti annega di verde e ti copre di blu”, come nella
bella canzone interpretata da Fiorella Mannoia.
Veniva dal Nord Europa anche Deborah Kerr.
Precisamente dalla Scozia. “Il suo nome fa rima con
star”, dissero i produttori dopo alcune sue prove
memorabili. Fu candidata all’Oscar sei volte, ma non
248
vinse mai. Venne risarcita nel 1993 con un Oscar alla
carriera. Nessuna è riuscita a battere questo record
all’incontrario. La prima volta gareggia con Edoardo
mio figlio di George Cukor, del 1949. Ma è battuta da
Olivia de Havilland con L’ereditiera di William Wyler.
Ottimo film, per la verità, in cui Olivia da timida e
ingenua ragazza innamorata diventa la spietata punitrice
del suo spasimante, il fasullo e arrampicatore sociale
Montgomery Clift. La seconda volta si presenta con Da
qui all’eternità di Fred Zinnemann, 1953. Il film ottiene
ben otto statuette, compresa quella a Donna Reed,
migliore attrice non protagonista. Lei, niente. Le viene
preferita Audrey Hepburn, protagonista di Vacanze
romane di William Wyler. Il film di Zinnemann ebbe un
andamento travagliato. In un primo momento la parte
della moglie adultera, che si innamora del sergente Burt
Lancaster, doveva andare a Joan Crawford, ma l’attrice
rinunciò. Non le piacevano i costumi. La figlia della
lavandaia era piuttosto pretenziosa. Nel camerino e sul
set non tollerava temperature diverse dai 20 gradi. E se
il termometro superava sia pure di un grado o due quel
limite non si presentava.
La Kerr fu scelta per caso e senza troppa
convinzione. Anche il ruolo dell’ex pugile Clift, che
rifiuta di entrare nella squadra di boxe della sua
compagnia, doveva essere di un altro attore, Robert
Mitchum, certamente più adatto, quanto meno per
prestanza fisica. Ci si mise pure la censura, ma Joseph
E. Breen, che pure era a capo d’una commissione che
doveva far rispettare il famigerato Codice Hays, fu di
manica larga. E così passarono le carognate di certi
caporali e ufficiali americani e passò pure il bacio a pelo
d’acqua, sulla spiaggia, tra Deborah e Burt. Alla fine
della cerimonia, Frank Sinatra, premiato come migliore
attore non protagonista, lasciò a piedi il teatro e venne
fermato dalla polizia che gli contestò il possesso della
statuetta d’oro.
La terza volta concorre con Il re ed io di Walter
Lang, 1956. È un successo travolgente al botteghino. Il
249
partner Yul Brynner vince l’Oscar come migliore attore
protagonista. Lei deve cedere il passo a Ingrid Bergman
che si impone con Anastasia di Anatole Litvak. Nello
spazio di un mattino Yul Brynner diventa un divo e un
sex symbol. Le donne lo trovano irresistibile, i ragazzi
lo imitano. A Des Moines, nello Iowa, quattordici liceali
vengono sospesi per essersi rasati a zero i capelli come
lui. È un attore maschio che perfeziona il carisma con
dichiarazioni come questa: “Non sono come quegli
attori che tirano calci alle lattine e ostentano la t-shirt
strappata. Ci sono pochi veri uomini nei film di questi
tempi”. Il riferimento a James Dean, e anche a Marlon
Brando, è trasparente.
La quarta volta è sicura di farcela. Interpreta il ruolo
di una suora in un’isola deserta, accanto al marine
Robert Mitchum, in L’anima e la carne di John Huston,
1957. Ma quell’anno deve vedersela con un gruppo di
attrici niente male: Anna Magnani, Elizabeth Taylor,
Lana Turner e Joanne Woodward che alla fine vince con
La donna dai tre volti di Nunnally Johnson. Al quinto
tentativo partecipa con Tavole separate di Delbert
Mann, 1958. È una timida zitella che conquista David
Niven, ma non l’Oscar che va a Susan Hayward per Non
voglio morire di Robert Wise.
La sesta e ultima volta viene battuta dal destino. Si
presenta con il fiacco I nomadi di Fred Zinnemann,
1960. Considerato che ha bussato inutilmente alla porta
degli Oscar per cinque volte, il rituale risarcitorio di
Hollywood potrebbe stavolta premiarla. E invece no.
Sulla sua strada si mette di traverso Liz Taylor con
Venere in visone, un film mediocre di Daniel Mann,
interpretato accanto a Laurence Harvey inguaribile
omosessuale che una volta s’innamorò perdutamente, e
inutilmente, del segretario-cameriere di Frank Sinatra, il
nero George Jacobs che darà alle stampe un’onesta
biografia del cantante.
La diva dagli occhi viola la batte sul filo di lana,
anche per via di una sapiente orchestrazione mediatica
dei produttori che amplificano la voce su Liz molto
250
malata, addirittura in fin di vita. Lo scandalo della love
story con Eddie Fischer, che per lei ha abbandonato
Debbie Reynolds, le viene perdonato. Anche Deborah
Kerr, assieme alle altre candidate, fa quadrato attorno
alla collega sofferente e invia dalla Svizzera un
telegramma che tuttavia è un capolavoro di perfidia. “La
Taylor merita di vincere” scrive, “non perché è malata
ma perché la sua interpretazione è superba”. Shirley
MacLaine telefona dal Giappone e propone alla
moribonda diva di accettare, eventualmente, il premio al
suo posto. Anni dopo la brava Shirley, che quell’anno
gareggiava con il delizioso L’appartamento di Billy
Wilder, confesserà ai giornalisti: “Ho perso l’Oscar per
una tracheotomia”.
La bella raffinata elegante Deborah morirà nel 2007,
a 86 anni, dopo lunghe sofferenze a causa del morbo di
Parkinson che ne aveva devastato la bellezza e
l’alterezza. Pensarla insicura e tremante, lei che
dominava la scena, fa male al cuore, fa male
all’illusione che i divi non muoiano mai e che non
possano mai corrompersi.
Ho parlato dei sei film per i quali fu inutilmente
candidata all’Oscar ma ne voglio ricordare un altro, Un
amore splendido, 1957, in cui dà vita, assieme a Cary
Grant, a una delle scene più commoventi della
cinematografia mondiale. Lei è una cantante, lui un play
boy che vive alle spalle delle ricche amanti pur essendo
stato in passato un pittore di talento. Fanno amicizia,
durante una crociera nel Mediterraneo, s’innamorano e
si danno appuntamento, da lì a sei mesi, in cima
all’Empire State Building. Vogliono capire, in quel
lasso di tempo, se il sentimento che li lega sarà ancora
forte. Ma l’impegno non può essere mantenuto perché
lei, proprio quel giorno, ha un incidente d’auto per cui
resta paralizzata alle gambe. Lui crede di essere stato
dimenticato e cerca di dare un senso alla propria vita
spezzata ricominciando a dipingere. Una sera
s’incontrano casualmente a teatro, si salutano in maniera
formale, si lasciano senza che lei abbia il coraggio di
251
dirgli la verità. Il giorno dopo lui, che non sa e non può
dimenticarla, va a trovarla a casa. Quando si accorge
della grave infermità scattano le lacrime. Cary e
Deborah sono superbi, e superba è la musica di Harry
Warren, An affair to remember, che quell’anno sfiorò
l’Oscar. Ma non ce la poteva fare contro All the way.
Il transatlantico, dove nasce l’idillio, sembrava un
parente stretto dell’Achille Lauro, la sfortunata nave
italiana che nell’ottobre del 1986, appena salpata da
Alessandria d’Egitto, venne sequestrata da un
commando palestinese agli ordini di Abu Abbas. I
terroristi presero in ostaggio 450 passeggeri e
l’equipaggio chiedendo in cambio la liberazione di 32
palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Le trattative,
delicate e difficili, ebbero subito una svolta drammatica
perché il commando uccise a sangue freddo un cittadino
americano, Leòn Klinghoffer, costretto a muoversi sulla
sedia a rotelle. Lo buttarono giù senza pietà. Il mondo
ne fu inorridito. Il giorno dopo i terroristi si arresero.
Più tardi, mentre venivano trasportati in Tunisia, l’aereo
venne dirottato da quattro caccia americani su Sigonella.
Qui fu chiesto ai militari italiani di consegnare i
terroristi ma l’allora presidente del Consiglio Craxi si
oppose. Furono giorni infuocati.
La cronaca radiotelevisiva, allora c’era solo la Rai,
venne affidata alla redazione di Catania. Me ne occupai
solo io, lavorando diciotto ore al giorno e coprendo tutte
le testate nazionali. Il capo della redazione era in
vacanza e in vacanza rimase, due miei colleghi se la
videro dalla finestra. Quando i passeggeri dell’Achille
Lauro tornarono in Italia feci noleggiare per conto del
TG1 un elicottero, con a bordo il nostro operatore, Enzo
Martinez, che riprese le immagini del commovente
rientro in patria. La gente alla vista di quel pezzo
d’Italia che gli andava incontro dal cielo si mise a
piangere e ad agitare i fazzoletti.
Deborah Kerr, bella, raffinata, dolce, era il prototipo
delle ragazze per bene, quelle che frequentavano i
252
college e si scandalizzavano d’ogni volgarità, e che a
quindici anni erano ancora alle prese con un dubbio
amletico: i bambini nascono sotto i cavoli o li porta la
cicogna? E invano scrutavano il cielo alla ricerca dei
trampolieri con l’improbabile fardello nel becco. “Ma
allora com’è il fatto?” si domandavano tra di loro,
finché la più sperta della comitiva riusciva a
entusiasmarle con la “perdizione”. A quei tempi,
correva l’anno 1963 e collaboravo a La Sicilia come
critico televisivo, avevo preso a seguire una di queste
signorine Kerr con la puzza sotto il naso e la
convinzione che il sesso ce lo avessero di traverso. Ci
misi una settimana prima di fermarla. Era perfetta,
tranne i ginocchi che parevano quelli di un terzino.
Portava una minigonna di pelle rossa e una treccia
bionda che le oscillava maliziosamente. Mi squadrò
dalla testa ai piedi e fece cadere una mazzata del tipo:
“Quelli come te non li calcolo nemmeno”. Forse la frase
fu meno brutale, fatto sta che mi lasciò senza respiro,
senza risposte superbe per metterla in riga. “Ma come si
permette!” pensai “Sono un giornalista…”
Ero solo uno stronzetto che veniva pagato mille lire a
pezzo, con la ritenuta d’acconto, e si confrontava con le
servitù prediali e il contratto di baliatico… Anni dopo,
alla caserma Castro Pretorio (dicembre 1967), il
capitano della compagnia ai soldati messi in riga
domandò quali fossero i loro mestieri. Eravamo tutti
soldati semplici e quindi ai suoi occhi potevamo
praticare solo mestieri semplici. Quando risposi, senza
esclamativo e quasi vergognandomi, “Sono un
giornalista”, lui, squadrandomi dalla testa ai piedi,
commentò ironico: “Giornalista o giornalaio?” Gli avrei
volentieri sparato. Sia pure con quel catenaccio di 91-38
che avevo in dotazione.
253
UNDICI
Jean Simmons, June Allyson
Il primo ruolo di Jean Simmons fu quello della
piccola Estella in Grandi speranze, film girato nel 1946
da David Lean e tratto dall’omonimo romanzo di
Charles Dickens. Un anno dopo, per sapienza di trucco
e di fotografia, diventa la maliziosa e ribelle Kanchi in
Narciso nero della ditta Michael Powell & Emeric
Pressburger, appetibile come “un paniere di frutta dolce,
deliziosa, pronta a essere mangiata”, secondo le parole
della scrittrice Rumer Godden che ispirò il film. Prima
di girare, ogni mattina, per scurirle la pelle la
sottoponevano a un’ora e mezza di makeup. Ancora un
anno dopo indossa i panni di Ofelia nell’Amleto di
Shakespeare, trascritto per il cinema da Laurence
Olivier che ne è anche il protagonista. Per quella parte
sfiora l’Oscar come attrice non protagonista. Glielo
soffia Claire Trevor con L’isola di corallo di John
Huston. Ma si consola al festival di Venezia con il
premio per la migliore interpretazione.
L’unico Oscar che le fanno appena sfiorare è quello
che ritira nel 1957 per conto di Alec Guinness, premiato
per Il ponte sul fiume Kwai. L’attore inglese è
impegnato nella lavorazione del film La bocca della
verità di Ronald Neame e quindi non può essere
presente alla cerimonia. La notizia dell’importante
riconoscimento gliela dà l’autista, mentre si sta recando
sul set. “Sir, alla radio hanno detto che lei ha vinto
quella cosa che gli americani chiamano Oscar”. Grande
attore e grande snob il vecchio Alec. Nel libro di
memorie, Blessing in Disguise, racconta come nel luglio
del ’43, allora tenente della Royal Navy, sbarcò in
Sicilia con un certo anticipo rispetto alla data fissata
dagli alti comandi alleati e che occupò il suo tempo
facendo il bagno nelle acque purissime di Capo Passero.
Jean Simmons si sposò due volte: con l’attore
254
Stewart Granger, che la portò dalla natia Londra a
Hollywood (ebbero un figlio); e col regista Richard
Brooks. È lei, più di ogni altra diva, che segna il
passaggio dal dopolavoro ferroviario al cinema Spadaro,
dal bianco e nero al colore. La ricordo nei film in
costume La tunica di Henry Koster e La regina vergine
di George Sidney (1953), Sinuhe l’egiziano di Michael
Curtiz, I gladiatori di Delmer Daves e Désirée di Henry
Koster (1954). Infine, Spartacus di Stanley Kubrick del
1960 in cui interpreta la coraggiosa compagna del
gladiatore rivoluzionario Kirk Douglas.
È morta nel gennaio del 2010 nella sua casa di Santa
Monica in California. Aveva quasi 81 anni. Come ha
scritto Maurizio Porri sul Corriere, la sua è stata la
classica carriera hollywoodiana, nel segno tuttavia del
due: due matrimoni, due figli, due divorzi, due gatti, due
whisky in più. Aggiungerei due anime: quella dolce di
Ofelia e quella ambigua di sorella Sharon, anche se fu
simbolo soprattutto di candore e di delicato sex appeal.
Ma a chi assomigliava Jean Simmons? A un sacco di
“persone” che conoscevo e non avevo mai incontrato. A
Lucia Mondella, la promessa sposa di Renzo
Tramaglino, per esempio. Quando in quinta ginnasio il
professore di lettere commentava l’ottavo capitolo del
capolavoro manzoniano, la Lucia seduta nel fondo della
barca, che posa sul braccio la fronte, come per dormire,
e piange segretamente, non è più Lucia ma Jean
Simmons che si allontana dai suoi amati… “monti
sorgenti dalle acque, ed elevati al cielo; cime inuguali,
note a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua
mente…” Ho riletto più volte I promessi sposi, ogni
volta commuovendomi e pensando alla mia immaturità
ginnasiale che me li faceva quasi odiare, fagocitato
com’ero dai romanzi della Biblioteca dei miei ragazzi
della Salani.
Jean Simmons assomigliava pure a Barbara Puglisi,
anche se nella memoria di molti c’è il magnifico volto
di Claudia Cardinale. Sì, la dolce e ignara moglie del
255
bell’Antonio Magnano, la ragazza che prende coscienza
del suo matrimonio rato ma non consumato e, dietro
suggerimento dell’arcivescovo, abbandona il marito per
sposarsi col duca di Bronte, grasso ma che ha fatto una
cura dimagrante a Parigi spendendo un milione di lire.
Sarebbe stata una bella gara tra lei e la nostra diva,
anche se la Simmons avrebbe dato al personaggio di
Barbara una migliore tensione emotiva e una più dolente
risolutezza. Di certo, Vitaliano Brancati avrebbe scelto
la moglie, Anna Proclemer, per quel ruolo, tanto più che
a lei aveva dedicato il romanzo dell’amore impossibile.
Rapporto infelice quello tra lo scrittore e l’attrice: lei
d’uno splendore non offuscabile, lui piccolo e
insignificante. Né valeva la genialità a compensare la
voragine estetica che li separava.
Corrado Brancati era suo fratello. Alto funzionario
della prefettura di Catania, era anche il critico
cinematografico de La Sicilia. Quando capitava in
redazione raccontava sempre una barzelletta. Con garbo
ed eleganza. Inarrivabile. In un libro dedicato a
Vitaliano ricorda, tra l’altro, quando lo scrittore
siciliano partì per essere operato a Torino. “Io e mio
padre l’accompagnammo alla stazione di Catania e
l’ultimo suo sguardo verso di noi, dal finestrino del
vagone-letto, era pieno di malinconia”. Era triste per
l’intervento chirurgico, che lo avrebbe ucciso a soli
quarantasette anni, era triste per il suo matrimonio a
pezzi, era triste per tante cose. Ma a Torino Anna
Proclemer lo raggiunse. La sera prima dell’intervento
andarono al cinema a vedere un film con Marlon
Brando, The man. La storia di un reduce che ha perso
l’uso delle gambe. Quando Corrado Brancati andò in
pensione cercò di sistemare al giornale la figlia più
piccola. C’erano precedenze da rispettare e gli dissero di
no. Ci rimase malissimo.
Alla fine di settembre del 1968 stavo per completare
il servizio militare, come dirò più avanti. Il giornale mi
mandò a seguire i lavori del Premio Brancati che
proprio quell’anno era stato fondato da Moravia,
256
Pasolini, Corsaro, Ronsisvalle e altri. Chiesi il permesso
in caserma e mi misi in borghese. Conservo una foto
che mi è molto cara e che mi ritrae accanto a Pier Paolo
Pasolini e ad Elsa Morante, vincitrice di quella prima
edizione con Il mondo salvato dai ragazzini. Due
persone che mi parvero solari e gentili. Nell’ambito del
Premio Brancati venne allestita nella scuola elementare
di Zafferana un’opera teatrale di Vanni Ronsisvalle, dal
titolo Onan, che si ispirava al personaggio biblico al
quale si fa risalire la prima pratica di sesso solitario. Ora
a me sembrò profanatorio che un dramma di quel tipo
venisse rappresentato in una scuola per bambini e perciò
ne scrissi di conseguenza. Annoverai l’autore, che
sarebbe diventato mio amico, tra i “pasolinidi”, tra
coloro i quali cercavano di imitare il genio e la
sregolatezza di Pasolini. Ne venne fuori un putiferio.
Quello, purtroppo, era ancora un tempo acerbo, per me
soprattutto che assorbivo l’indignazione conservatrice
del giornale e che volavo in un cielo basso e dal limitato
orizzonte.
A questo punto vorrei ricordare la già accennata
Biblioteca dei miei ragazzi della Salani che ha
accompagnato e segnato la mia giovinezza. Quando non
avevo poesie da mandare a memoria o non ero
impegnato a giocare la mia partita cinematografica al
dopolavoro ferroviario mi immergevo nella lettura di
questi romanzetti che prendevo in prestito dalla
biblioteca di classe. Erano quasi tutte traduzioni di libri
della Bibliothèque de Suzette, a loro volta pubblicati a
puntate, negli anni Venti, sulla Semaine de Suzette, il
settimanale per bambine dell’editore GautierLanguereau. E, infatti, i romanzi erano firmati per lo più
da donne. Così come ho fatto con la penna e l’album
delle figurine li ho acquistati al mercato online. Oggi li
possiedo quasi tutti tranne sei, difficili da trovare. Prima
di raccoglierli, con pazienza, volume dopo volume, il
mio amico libraio, Carmelo Volpe, me ne aveva
procurati una dozzina della Salani Nostalgia. Erano solo
ristampe ma quando le vidi la fitta al cuore fu da “prima
257
copia”. E la vecchia Volpe commentò: “Ora cchi fai, ti
leggi tutti?” Ma non sono un feticista. Concordo con
Henry Miller quando smonta l’ossessione del possedere
dei bibliofili al punto da sostenere che i libri letti vanno
regalati perché si perpetui negli altri l’incanto della
lettura… con buona pace del mio amico Mughini che
alla sua mania di prime copie, raccolte negli anni con
pazienza e dispendio economico, ha dedicato un
volume, La collezione, al solito bello e interessante per
come egli racconta, ricorda, incanta. Ma se ho fatto
un’eccezione è perché i libri della Salani sono legati a
una stagione forte della mia vita ma che aveva bisogno
d’essere “verificata”. A volte ne guardo le copertine,
leggo qualche brano, mi fermo a pensare, a ricordare.
A ricordare Carmelo Volpe, libraio dei librai
catanesi, amico degli studenti senza un soldo ma che lui
riforniva di saggi e romanzi quasi sempre pagati “a
babbo morto” e cioè mai. La sua libreria di piazza
Umberto era un cenacolo, un centro di scambi culturali,
di programmi e immaginazione non ancora uccisi dal
cinismo e dalla malapolitica. Costretto a chiuderla per la
spietata concorrenza dei centri commerciali s’era
ritagliato un piccolo angolo a due passi da lì. E ce
l’avrebbe fatta a risalire la china se un ictus non l’avesse
messo fuori combattimento. Il Natale scorso sono
andato a trovarlo con Nino Milazzo. Gli ho portato in
dono l’ultimo mio libro, Il Musicista e l’Imperatore, con
una dedica appropriata che l’ha fatto piangere. “È ca
non mi pozzu mòviri!” disse.
Il primo della lista della Biblioteca dei miei ragazzi è
stato Il circo Barletta di Miryam Catalany con le belle
illustrazioni di Henry Morin e la copertina di Maria
Augusta Cavalieri che m’era rimasta impressa dagli
anni Cinquanta; poi Un Pierrot e tre bambine di Berta
Bernage con i disegni sempre di Henry Morin e la
copertina della bravissima Cavalieri; a seguire La
piccola pantofola d’argento di Miryam de Carnac e i
disegni di René Giffey e Per l’onore di Roccabruna di
Marguerite Bourcet, illustrato da Ferdinand Raffin.
258
Come scrive Beatrice Solinas Donghi, che
all’argomento ha dedicato uno studio ben documentato,
queste scrittrici erano nella media “brave artigiane” che
misero a punto “un genere di romanzo giovanile misto
d’intimismo e di avventura, con caratteristiche in parte
nuove”. Dulcis in fundo, La teleferica misteriosa di
Aldo Franco Pessina, con i disegni di Fiorenzo Faorzi, e
l’intramontabile, tenero, struggente I ragazzi della via
Paal di Ferencz Molnar con le illustrazioni dello stesso
Faorzi. Più che la scrittura ciò che mi ha colpito sono
state le illustrazioni, minuscoli mondi grafici che sono
affiorati di prepotenza dalla laguna del tempo a
ricordarmi ancora una volta che il fanciullo che c’era in
me non è mai scomparso, s’è solo ingrigito e
immalinconito. Grafica a parte, i libri sono edificanti e
consolatori, moderatamente ribelli, rigorosamente
classisti e in qualche caso anticomunisti. Bourcet,
Giraud, Péronnet, Bruyère, Rosmer, Duché, Verdat,
Bernage, Otis, Goudareau, De Kérany, Rivière danno
della vita una visione pacata, senza scosse,
radiosamente motivata dal rispetto delle leggi e delle
convenzioni sociali, dalla serena accettazione della
ricchezza e della povertà.
Questi erano i miei libri. I fumetti mi annoiavano,
tranne Il Corriere dei Piccoli come ho già accennato.
Ma il mio primo ricordo dell’affascinante giornalino
segna un giorno di dolore. Cinque maggio 1949. Ero
appena tornato da scuola e con mia madre e i miei
fratelli stavo aspettando il ritorno di mio padre dal
lavoro. Ancora non avevo l’età delle notizie, della
capacità cioè di capirle ed elaborarle correttamente
dentro di me. Avevo sette anni e in quel tempo fanciullo
erano sette vagiti. La tragedia di Superga, avvenuta nel
tardo pomeriggio del giorno precedente, non si era
ancora materializzata nella mia casa. Forse la radio ne
parlò, ma sul tardi e a quell’ora noi bambini eravamo a
letto. La mattina dopo qualcosa si percepì nell’aria ma
venne sopraffatto dalla corsa verso i doveri del lavoro e
della scuola. E non ricordo se il mio insegnante unico, al
259
Leonardo, ne avesse accennato in classe. Forse lo fece e
io non lo rammento. Ciò che però ricordo con precisione
è la faccia di mio padre quando, alla solita ora del
pranzo, rientrò a casa. Né mai dimenticai le sue parole:
“Poveri ragazzi”.
I nomi li conoscevo a memoria. Bacigalupo (il
portiere che se avesse voluto con uno scatto di reni
poteva saltare sulla traversa e sedersi tranquillamente ad
assistere alla partita), Ballarin, Maroso (praticamente un
muro), Grezar, Rigamonti, Castigliano (una sicurezza),
Menti, Loik, Gabetto, Mazzola, Ossola (non ce n’era per
nessuno). Se ne continuò a parlare, mentre mia madre
controllava la cottura della pasta (“prima che diventi
colla per manifesti”), a precisare i particolari strazianti,
il lutto dei familiari, dei tifosi, della gente comune, il
cordoglio delle squadre avversarie che al Grande Torino
riconoscevano l’indiscusso valore. Quel giorno, come
d’abitudine, non ci fu la lettura della terza pagina del
Corriere della Sera. Di solito, a fine pranzo, mio padre
con la sua bella voce ci faceva entrare nel mondo adulto
e incantato di Papini e Savinio, Piovene, Montanelli,
Buzzati, Vergani e noi stavamo a ascoltarlo, attenti e
affascinati per ciò che potevamo capire. Quel 5 maggio,
giorno di un altro lutto storico, ci narrò invece i
particolari dell’aereo schiantatosi nella nebbia contro il
muraglione del terrapieno posteriore della basilica di
Superga, ci parlò dei calciatori imbattuti sul campo e
sconfitti dall’infame destino, ci parlò d’una nazione
attonita, sconvolta, e di tante cose terribili, mentre io
cominciavo a pensare al Corriere dei Piccoli che ancora
non avevo finito di leggere, credendo, irrazionalmente,
di trovarvi una traccia di quell’abisso di dolore.
Il mio ricordo del supplemento del Corriere
comincia quel giorno. Un giorno complicato, come s’è
visto, complicato per un bambino di sette anni alle prese
con le tabelline, le fiabe di Perrault e dei fratelli Grimm,
gli astucci e i pennini, le dita macchiate d’inchiostro, la
carta assorbente, il fiocco azzurro (che sempre si
scioglieva) sul grembiule nero e l’incontenibile voglia
260
di crescere, nonché il terrore della pagella e del sette in
condotta. Aspettavo l’uscita del Corrierino con
maniacale impazienza. Aspettavo di immergermi nelle
avventure del Signor Bonaventura, di Bibì e Bibò, di
Fortunello e di Arcibaldo e Petronilla prototipi dei
borghesi arricchiti. Ne guardavo i disegni colorati con
rapimento, li scorrevo d’un fiato per poi seguirne con
attenzione la trama attraverso le didascalie scritte sotto
ogni vignetta.
Era il settimanale dei ragazzini delle famiglie medie,
il giornalino che veniva dal passato, dall’Italietta di
Giolitti e dal fascismo, era un ponte non ancora distrutto
dalla guerra ma che continuava a legare rispecchiandole
le abitudini, l’educazione, la formazione di due
generazioni di giovanissimi. Due generazioni che
ascoltavano le mamme raccontare fiabe nelle sere
d’inverno, che portavano la fascia nera al braccio per la
morte di un parente stretto, e di quel lutto
s’inorgoglivano per l’attenzione commiserevole della
gente, che si facevano il segno della croce davanti alle
chiese e alle icone, che avevano una idea vaga su come
si veniva al mondo e pensavano che le donne incinte
fossero semplicemente grasse. Due generazioni di
bambini-bambini educati nella semplicità del bene,
cresciuti nello scrupolo misterico dei primi nove venerdì
del mese, dei fioretti alla Madonna nel mese di maggio,
del rituale severo del venerdì santo: specchi velati nelle
case, simulacri avvolti in panni viola nei luoghi di culto,
candele accese, offerte, acqua benedetta. Bambini pieni
di fervore religioso come nelle madrase islamiche,
attenti a non bere nemmeno un goccio d’acqua prima
della comunione, a chinare la testa quando il sacerdote
compie la magia inesplicabile di trasformare il pane e il
vino in corpo e sangue di Cristo, a serrare gli occhi
quando l’ostia si scioglie in bocca e guadagnare il banco
in silenzio e a mani giunte mentre il cuore si gonfia
nell’ascoltare i canti gregoriani. Bambini senza Tv e con
giocattoli inventati, con le calze rattoppate e i geloni
nelle mani, bambini che mangiano pane cotto e macco
261
fritto e quando in tavola c’è una gallina vecchia fanno
salti di gioia. Bambini.
Domanda: Di tutte le religioni note qual è la vera?
Risposta: La religione cristiana, il cui autore è Gesù
Cristo. Domanda: Chi fu Abramo? Risposta: Colui il
quale Dio promise che i suoi discendenti si sarebbero
moltiplicati come le stelle del cielo. Domanda: Quante
mogli ebbe? Risposta: Due, Sara, la padrona di casa; e
Agar, la serva. E qui il bambino cominciava a traballare.
Il Corriere dei Piccoli, la cui testata era stata
disegnata da Antonio Rubino, era uno degli arredi
necessari per un quadro domestico di quegli anni,
accanto ai ferri del lavoro a maglia, al braciere, ai libri
della Salani, alla sedia a dondolo della vecchia zia, ai
quaderni con la copertina nera, alla radio a valvole che
gracchiava… eterno ripetersi d’una nostalgia o necessità
che veniva dal secolo precedente, come in un ritratto
esemplare di Mary Cassat o di Berthe Morisot. Del
resto, sul Corriere dei Piccoli aveva passato l’infanzia
anche mio padre: le stesse vignette senza fumetto, gli
stessi personaggi, colori, emozioni, la stessa educazione.
Perché poco o nulla di significativo, fino al secondo
dopoguerra,
era
avvenuto
nella
pedagogia
risorgimentale, nessuno strappo decisivo, solo un eterno
presente di parole edificanti, di sorrisi, di dolori e
speranze… “u megghiu tempu veni appressu”.
Esemplare, in tal senso, era il personaggio disegnato
da Sergio Tofano, Bonaventura, con marsina e bombetta
rossa, pantaloni bianchi due misure più larghe e il fido
cane bassotto, personaggio bislacco insomma che
partiva squattrinato e diventava dopo strampalate
avventure milionario… “Qui comincia l’avventura del
Signor Bonaventura”. Me lo ricordo quel milione,
sventolato nell’ultima vignetta, che negli anni del boom
economico diventò un miliardo e che, nell’accumulo
settimanale, rese il protagonista “ricco ormai da far
paura”. Quel denaro facile facile me lo ricordo come
speranza, quasi come filosofia di vita, perché nella testa
della gente, dopo i traumi di due guerre mondiali, c’era
262
la convinzione che “il mondo va comunque avanti”.
Mio padre ne utilizzava la variante politica, pur essendo
un moderato, “il mondo va a sinistra”.
Le mamme utilizzavano le vecchie nenie per
addormentare i bambini, e quando lavoravano ai ferri o
all’uncinetto canticchiavano le canzoni di Norma Bruni
e Luciana Dolliver, Tiola Silenzi e Delia Lodi, i padri si
cimentavano con Alberto Rabagliati, Carlo Buti,
Ernesto Bonino, i nonni ricordavano le gesta di Cavour
e Garibaldi, e i figli leggevano Il giornalino di Gian
Burrasca e Le avventure di Pinocchio sognando sulle
illustrazioni di Enrico Mazzanti, Carlo Chiostri, Attilio
Mussino, Piero Bernardini. Leggevano, naturalmente, Il
Corriere dei Piccoli che restava saldo alle sue vecchie
abitudini, al suo impianto pre-moderno. Anche i
Sussidiari e i Fior da fiore si perpetuavano con le loro
poesie immortali: Pianto antico “… l’albero a cui
tendevi la pargoletta mano”, La cavallina storna “…
che portava colui che non ritorna”, Che cosa è Dio? “…
Nell’ora che nel bruno firmamento comincia un
tremolio di punti d’oro”, Il Cinque maggio “… Ei fu.
Siccome immobile, dato il mortal sospiro…”
Per non dire di Cuore, il libro dei libri, il libro di
Edmondo De Amicis che legò dello stesso sentimento il
profondo sentire di mio nonno, di mio padre e mio. Fu
uno strumento utile dell’unificazione italiana, una sorta
di televisione della parola, di catechismo laico che ha
tessuto in un’unica trama il Nord e il Sud, che ha
esaltato la patria, la famiglia, il dovere, ma soprattutto
l’istruzione. Proprio in quegli anni s’andava attivando
nel Paese un conflitto d’opinioni tra ottimisti e
pessimisti: gli uni attribuivano alla scuola “un
miracoloso progresso della società”, i secondi le
addebitavano ogni malanno. Per altro, nel dicembre del
1880 l’assessore all’istruzione del Comune di Torino si
opponeva in consiglio ad aumenti di stipendi ai maestri
accreditando i sospetti dell’opposizione: “Teniamoli
poveri se li vogliamo umili”. Lo stesso discorso, benché
Dio regnasse ancora, facevano i razzisti americani sulla
263
gente di colore: “Se vogliamo che non alzino la cresta
dobbiamo escluderli dall’istruzione superiore”.
Miserie a parte, fu la scuola a togliere i ragazzi dalla
strada, a evitare che venissero venduti e adibiti
all’accattonaggio o sfruttati come giocolieri, danzatori o
suonatori ambulanti. Un secolo e passa dopo, il figlio
del regista Gillo Pontecorvo firmerà un film, Parada,
ambientato in Romania, il cui protagonista, un clown
mezzo arabo e mezzo francese, salva dall’abiezione dei
vicoli un gruppo di ragazzini facendoli diventare clown.
I bambini di Bucarest oggi hanno superato i confini del
tempo, sono tornati indietro, alla Londra di Charles
Dickens, si sono imbucati nel ventre molle delle città,
disperati e affamati, come i cani che contendono gli ossi
alla povera gente, ed hanno conosciuto ogni sorta di
violenza. Meglio dunque continuare a vivere nelle
strade periferiche dell’ex impero sovietico con un
mezzo sorriso anziché con l’intera disperazione negli
occhi, meglio un pasto caldo e un posto sicuro per
dormire anziché vivere nel sottosuolo in compagnia dei
topi e della notte che non finisce. E pazienza se per
ottenere questo minimo vitale debbono divertire i
passanti, magari più disperati di loro, tingendosi la
faccia e costruendo piramidi umane. La scuola può
aspettare. La scuola di due secoli fa, la scuola di
Edmondo De Amicis che tentava di dare un futuro ai
nostri progenitori, è addirittura un sogno per i bambini
romeni del Duemila. E per i bambini degli slum di
Mumbay, come ce li descrive Danny Boyle nel crudo e
complesso The millionaire. Davvero impressionante
capire che parte del mondo che ci appartiene resta
ancorato a ciò che si muoveva prima di Precossi e
Garrone, del muratorino e della maestrina della penna
rossa, ancor prima della piccola vedetta lombarda e del
piccolo scrivano fiorentino.
Jean Simmons fu la ragazza della porta accanto ma
in quel ruolo la sopravanzò June Allyson, l’attrice nata
nel Bronx da una famiglia povera e che passò l’infanzia
264
in un busto ortopedico per una brutta caduta dalla
bicicletta. Di sé amava dire: “Ho i denti grandi, parlo
con la lingua di pezza, quando rido gli occhi spariscono,
non canto come Judy Garland né ballo come Cyd
Charisse, ma gli uomini mi portano a casa e mi
presentano alle loro madri”. Sullo schermo fu la ragazza
acqua e sapone per eccellenza, sempre sorridente, pur
con i suoi occhi micciosi, fedele e coraggiosa. Si gettava
nella mischia e vinceva anche se mai avresti scommesso
sulle sue capacità seduttive.
La svolta della sua vita fu un film con Fred Astaire e
Ginger Rogers. Li vide ballare e decise di imitarli. Andò
a scuola di danza, fece nuoto ed esercizi fisici logoranti
per ridare energia e flessibilità alla spina dorsale e alla
fine riuscì ad approdare a Broadway nel musical Sing
out the news. Ma il ruolo che più risplende nella sua
carriera è Piccole donne di Mervyn LeRoy in cui
impersona Jo, una delle quattro sorelle March. Le altre
sono impersonate da Elizabeth Taylor, Janet Leigh e
Margaret O’Brien. La saga di Piccole donne, cui
seguirono Piccoli uomini e I figli di Jo, descrive la vita
della sua autrice, Louisa May Alcott che, come nel
romanzo, aveva tre sorelle, trascorse un’infanzia
difficile, e si diede ben presto alla letteratura. È stato
uno dei libri della mia infanzia ma anche quello dei miei
genitori, allegro e drammatico, ironico e romantico,
anche se oggi può apparire superato. In un recente
sondaggio, alla domanda: Quale delle quattro sorelle
March viene apprezzata di più, la risposta è stata
pressoché unanime: Jo. Come non essere d’accordo!
Come non amare la vulcanica e generosa Jo, la più
intelligente e la più ribelle, quella che sa vedere oltre
l’orizzonte domestico della sua famiglia povera e
benpensante! La forza di Jo sta proprio in questo
coraggio, in questa determinazione a spezzare le
abitudini borghesi e rassicuranti della società in cui è
vissuta anche se dovrà rinunciare a un sicuro e ricco
matrimonio.
Se questo era il sogno, se questo era il romanzo, il
265
mio tempo borghese, a parte le rivoluzionarie
aspirazioni, non determinava sorprese. I codici venivano
rispettati, la vita procedeva in un solco ideale già
tracciato, le parole e le idee non avevano un senso
ambiguo. La ragazza della porta accanto era la ragazza
per bene, assennata e dolce, la proiezione perfetta della
madre, casa e chiesa. Era l’immagine di June Allyson,
non quella del film di Luke Greenfield, The girl next
door, che ha un passato da pornostar. Quest’imbroglio
comincia da lontano, col padre di Playboy, Hugh
Hefner, che nella sua rivista per soli uomini vorrà sì la
ragazza della porta accanto ma senza vestiti addosso e,
per colmo di perversione, con la faccia di Shirley
Temple e le misure esagerate di Jane Mansfield, l’attrice
che mise da parte il cervello perché “in una ragazza
glamour è sempre stato un elemento di disturbo”. Si
capisce, dunque, perché i ragazzi di allora preferissero
presentare alle madri una come June Allyson invece di
una come Lana Turner o Rita Hayworth, una che
quando rideva le si stringevano gli occhi a fessura ma
che aveva un modo onesto di dire e di comportarsi.
Almeno nei film.
Le vicende private furono altra cosa. Il primo marito,
Dick Powell, lo sposò nel 1945. Il matrimonio durerà
fino alla morte di lui, nel 1963, ma con pochi alti e molti
bassi per il carattere incontenibile di lei. Gli amori
extraconiugali di June furono brevi ma intensi. La prima
volta s’innamorò di Alan Ladd, incontrato sul set di Una
tigre in cielo. Ma il piccoletto di Hollywood era sposato
e la relazione finì su un binario morto. Powell la
perdonò ma da lì a qualche anno l’attrice s’invaghì d’un
altro partner, Jack Lemmon. Passione travolgente anche
questa che naufragò di fronte al puritanesimo del
pubblico che nell’attrice identificava la moglie per
eccellenza, l’angelo del focolare. June fu costretta a
rientrare nei ranghi, anche stavolta col perdono del
marito. Il proposito durò poco. Incontrò Jeff Richards e
pensò di divorziare. Ci fu l’ennesima rivolta dei
benpensanti e l’attrice ancora una volta scelse la carriera
266
all’amore. Due anni dopo la morte di Powell (dalla cui
unione era nato un figlio, Dick Powell jr; la figlia
femmina, Pamela, sarebbe stata adottata) la ragazza
della porta accanto, sempre più acqua cheta che rompe i
ponti, sposerà il parrucchiere del marito, Glenn
Maxwell, ma sarà un matrimonio di comodo perché
l’attrice si legò per lungo tempo allo scrittore e
produttore cinematografico Dirk Wayne Summers. Il
terzo marito sarà un dentista, David Askrow. Al
confronto, Zsa Zsa Gábor, pur con i suoi nove
matrimoni, era una dilettante perché non riuscì a
collezionare quel numero impressionante di scappatelle
e infedeltà.
Fu un film a determinare la scelta della mia tesi di
laurea. Era il 1962 ed avevo appena visto Vincitori e
vinti di Stanley Kramer con Spencer Tracy, Marlene
Dietrich, Burt Lancaster, Richard Widmark, Maximilian
Schell e uno stuolo di altri grandi attori impegnati in
ruoli secondari. Il film mi marchiò a fuoco. Acquistai e
lessi La storia del Terzo Reich di William Shirer, un
utilissimo “mattone” di mille e duecento pagine, mi
documentai sui massacri nei campi di concentramento e
sui processi che misero alla sbarra i criminali nazisti a
Norimberga e alla fine mi presentai al professore di
diritto internazionale. Come fu la mia tesi di laurea?
Diligente e ammantata di furba bibliografia. Nella foga
di esaltare “il processo di Norimberga” e di condannare
i responsabili dei massacri di tanta gente inerme finii col
giustificare le bombe di Hiroshima e Nagasaki,
argomentando che le atomiche americane erano state
sganciate per porre fine alla guerra mentre l’uccisione di
sei milioni di ebrei era stata frutto di una “politica”, di
un programma di sterminio durato anni, senza scopo e
senza resipiscenze, senza giustificazione se non la difesa
della razza, l’eugenetica, le ruberie, il dominio del
mondo. Rifiutai di condividere l’idea che quei processi
al nazifascismo fossero stati in buona sostanza una
vendetta dei vincitori sui vinti. Come sempre è accaduto
267
e accade. La scelta dell’argomento della tesi entrò nella
mia testa dunque non per letture e pandette, o per
speculazioni giuridiche e dottrinarie, vi entrò per
suggestione cinematografica. Difficile dimenticare la
scena del giudice Ernst Janning (un formidabile Burt
Lancaster) che si alza dal banco degli imputati e
rimprovera il suo difensore, l’ottimo Maximilian Shell,
che sta strapazzando una scomoda testimone:
“Ricadiamo nella stessa ignominia?” Magistrale anche
la figura di Spencer Tracy che è il presidente del
tribunale, Dan Haywood, che rifiuta le logiche politiche
del momento e firma quattro condanne esemplari,
compresa quella del giurista Janning, onesto ma cieco.
Nel 1948 i sovietici cercarono di isolare Berlino dal
mondo occidentale. Washington, per mantenere la
propria influenza nella regione, cercò in ogni modo
l’appoggio del popolo tedesco. Ecco perché una dura
condanna a Norimberga avrebbe potuto compromettere
la simpatia tedesca verso gli Stati Uniti e quindi la
politica di contenimento dell’espansionismo di Mosca.
Eppure, nonostante le pressioni dello Stato Maggiore,
Haywood fece il suo dovere fino in fondo.
268
DODICI
Ava Gardner, Susan Hayward
Wilma Montesi aveva ventun anni quando il nove
aprile del 1953 venne trovata morta sulla spiaggia di
Torvaianica, a pochi chilometri da Roma. La polizia,
dopo le prime indagini, piuttosto confuse e sbrigative,
archiviò il caso. Si è trattato, disse, di un banale
incidente dovuto a “un improvvido pediluvio”. In
sostanza, la ragazza, in una giornata romana grigia e
piovosa, anziché recarsi al cinema con la madre e la
sorella, aveva preso la corriera per Torvaianica ed era
andata a lavarsi i piedi a mare. Qui era sopraggiunto un
malore improvviso ed era annegata. Punto. La verità
senza colpevoli verrà qualche tempo dopo e trasformerà
l’“incidente” in un appassionante giallo e poi in un
clamoroso caso politico. Per la pubblica accusa Wilma
era stata abbandonata sulla spiaggia dopo un festino a
base di sesso e droga in cui avrebbero avuto una parte
rilevante Piero Piccioni, figlio del ministro degli Esteri,
e Ugo Montagna, un nobile dal passato oscuro. Dopo un
processo durato tre anni, e che farà rotolare le teste di un
ministro, di un questore e di un numero imprecisato di
testimoni in mala fede, i presunti colpevoli vennero
assolti con formula piena.
Ma il caso Montesi è molto di più, come ha scritto il
giornalista della redazione romana de La Stampa,
Francesco Grignetti, che al misterioso caso ha dedicato
un libro. “È un fenomeno di costume, un vorticoso
impazzare di pettegolezzi, un folle gioco di dietrologie,
l’uso politico della giustizia, l’irrompere del morboso
nei timorati anni Cinquanta. Morte, sesso, droga, gioco
d’azzardo: d’improvviso i vizi dell’alta borghesia e le
debolezze dell’aristocrazia diventano ghiotti materiali
per la stampa”. Ed è polemica rovente tra quotidiani di
opposto schieramento politico, come il duello tra
L’Unità e Momento Sera. “Il giornale comunista”,
269
scrive Norma Rangeri “impugna la bandiera della
questione morale e sfrutta il delitto per affondare il
coltello nella DC”. Per tutta risposta Momento Sera
pubblica la foto del comunista Giuseppe Sotgiu,
presidente della provincia di Roma, “mentre esce con la
moglie da un palazzo noto per ospitare la più famosa
casa d’appuntamenti della capitale. Una battaglia
politica senza esclusione di colpi e una lotta giudiziaria
senza prove che si conclude con la clamorosa
testimonianza di Alida Valli che scagiona il principale
accusato, Piero Piccioni, suo fidanzato”. Insomma, quel
tempo s’ingegnava a perpetuarsi.
Il caso Montesi lancia il fenomeno dei paparazzi, i
fotoreporter romani fastidiosi come pappataci e veloci
come razzi. Ma il nome “paparazzo”, a quanto pare, lo
inventò Federico Fellini sul set di La dolce vita.
Ricordandosi di un invadente compagno di scuola che si
chiamava Paparazzo, il regista battezzò sul campo con
quel nomignolo il principe dei “fotografi di strada” di
allora, Tazio Secchiaroli. L’intraprendente fotografo,
che dava la caccia alle sue “prede” servendosi di una
Lambretta, con la quale poi scappava con il prezioso
rullino, s’era fatto le ossa proprio col caso Montesi di
cui seguì la fase investigativa e processuale fino allo
scoop della foto che ritraeva insieme Piero Piccioni e
Ugo Montagna al Foro Italico. Tazio Secchiaroli, come
pure Giuseppe Palmas e più tardi Rino Barillari e
Massimo Sestini, era una specie di rapinatore dello
scatto. Rapido nell’esecuzione, e altrettanto veloce nel
sottrarsi all’ira dei malcapitati, riusciva sempre a portare
a casa il “malloppo”, anche a costo di buscarle di santa
ragione. Come quella volta al Cafè de Paris, che fu
preso per il collo dall’ex re d’Egitto Farouk per averlo
immortalato tra due conturbanti ragazze; oppure al Brik
Top, dove ingaggiò una memorabile scazzottata con
Anthony Franciosa sorpreso in compagnia di Ava
Gardner.
Roba preistorica rispetto all’oggi, rispetto al
270
verminaio di “vallettopoli” scoperto dal magistrato di
Potenza Woodcock e del quale s’è mostrato
protagonista l’agente fotografico Fabrizio Corona che
ho visto crescere e di cui ricordavo il carattere buono e
affettuoso e mai avrei pensato, minimamente pensato,
di un suo coinvolgimento in simili scandali aberranti,
proprio in quella orgogliosa Milano un tempo capitale
morale d’Italia. Forse mi fa velo l’antico affetto ma la
spaventosa campagna mediatica di cui è stato oggetto
questo ragazzo, cresciuto in una famiglia normale e
perbene, mi è parsa sproporzionata e ingiusta, non per i
reati di cui è stato accusato ma per il fatto di essere stato
messo a capro espiatorio di un mondo marcio di cui era
solo un modesto attore se non una vittima. M’è
sembrata una semplificazione eccessiva e di comodo,
quasi che, tagliata la testa al “mostro”, tutto di sarebbe
ricomposto come prima, come se nulla fosse. Troppo
facile, troppo comodo. Fabrizio è la punta visibile di un
iceberg molto profondo, d’una società degli inganni,
corrotta e irresponsabile, che attraverso i mass media
trova la propria legittimazione. Nel film di Gabriele
Muccino, Ricordati di me, la massima aspirazione del
personaggio Valentina è quella di diventare “velina”.
Per raggiungere lo scopo arriva a compromessi
inevitabili e degradanti, senza che la famiglia mostri di
accorgersene, anzi, quando la vede in Tv affiancare
come valletta il presentatore, che per altro l’ha
concupita, è tutta contenta e applaude. Fabrizio Corona
ha navigato in queste acque melmose, a volte se n’è
fatto sommergere, spesso ha smarrito il limite tra bene e
male, ma il suo comportamento nasce paradossalmente
dal disprezzo per questa società malata che si pone a
modello con le proprie ipocrite virtù mentre all’interno è
bacata e piena di vizi. Lui ha socchiuso il vaso di
Pandora, ha visto cosa c’era dentro e si è illuso di
farsene custode, senza capire che non si può tenere
compressa a lungo una molla senza che questa ti scoppi
in faccia; senza capire, soprattutto, che non si può
dominare il male senza farsene irretire e compromettere,
271
anche se dichiari a te stesso, alla tua famiglia, agli
amici, che prima o poi darai un taglio netto a questo
schifo e te ne andrai con tua moglie e tuo figlio in
America, aprire un ristorante e vivere, finalmente, di
onesto lavoro. Sembra un film americano già visto, un
fumetto già letto. Ma non si può interpretare la vita con
questi strumenti intellettuali e morali. Fabrizio Corona è
diventato un eroe del nostro tempo, nel senso
lermontoviano della frase, un giovane che per odio, o
anche per debolezza o invidia, ha creato il male degli
altri e alla fine di se stesso.
A quei tempi, la “contessa scalza” era protagonista
indiscussa delle notti romane. Ballava, beveva e faceva
all’amore. Senza misura. Si era innamorata di Walter
Chiari, il comico-mitraglia che nella sua vita riuscirà a
sprecare tutto, compreso il talento. L’attore italiano
l’aveva conosciuto sul set di La capannina di Mark
Robson, un film che l’attrice, rievocandolo anni dopo,
nella quiete londinese della sua casa, mostrerà di volere
dimenticare. Walter Chiari era al top del successo
artistico e mondano in quel momento. Ava Gardner sarà
la conquista più esaltante. Altre c’erano state, altre
sarebbero venute: Silvana Pampanini, Sylva Koscina,
Lucia Bosè, Anita Ekberg, Mina. Anche lui litigò con
Secchiaroli per averlo colto in dolce intimità con la
bella Ava.
L’ho conosciuto al Cantagiro del 1967, ospite
d’onore,
assieme
a
Paola
Quattrini,
della
manifestazione. La prima tappa dello spettacolo si
svolse allo stadio Cibali di Catania. Ricordo che alle
porte di Palermo la carovana dei cantanti attraversò due
ali di folla festante. Io viaggiavo con la collega Maria
Pia Fusco, bionda, carina. A un certo punto, un gruppo
di ragazzi si avvicinò al nostro finestrino e le gridò:
“Buttana!” Maria Pia ne fu visibilmente colpita.
“Perché?” La risposta mi competeva come siciliano doc.
“Perché questi scapestrati”, provai a chiarire
“restringono il concetto di onorabilità solo alle loro
272
madri e sorelle, oneste per definizione”. Lei non lo era
perché veniva dal Continente, era truccata e ben vestita,
apparteneva al mondo dello spettacolo e quindi al
mondo del peccato. Credo che se oggi nelle strade del
Magreb girasse una donna occidentale, senza veli e con
corte vesti, il giudizio sarebbe lo stesso, lo stesso di quei
ragazzi siciliani di quarantacinque anni fa.
Fu a Carpi, credo, che entrai in confidenza con
Walter Chiari. Quella sera, al termine dello spettacolo,
che aveva visto ancora una volta furoreggiare nel girone
degli esordienti Massimo Ranieri con Pietà per chi ti
ama, si avvicinò al tavolo dei giornalisti, sfoderò un
paio di battute, coniugò, come fosse un verbo, il futuro
semplice del mio cognome e si mise a discutere di
letteratura. Lo invitai a parlare de I Buddenbrook di
Thomas Mann e lui mi citò, come capolavoro dello
scrittore tedesco, La montagna incantata. Chapeau.
Questo era Walter Chiari, che tre anni dopo finirà in
galera per uso di stupefacenti. A distanza di trentasette
anni Tatti Sanguineti, biografo dell’attore, ha sostenuto,
in una puntata del programma televisivo La storia siamo
noi, che Walter fu messo in prigione perché lo Stato
aveva bisogno di un diversivo ideologico (e mediatico)
per coprire la propria incapacità di reagire alle stragi
degli anni ’60-’70.
Di quel Cantagiro ho ricordi piacevoli e, in qualche
modo, “storici”. Strinsi amicizia con Virgilio Crocco e
Fabrizio Zampa, due colleghi de Il Messaggero.
Fabrizio era figlio di Luigi Zampa, il regista che nel
1975 avrebbe diretto il film Gente di rispetto, con James
Mason, tratto dall’omonimo romanzo di Pippo Fava. Un
brutto film. In Versilia, Virgilio e Fabrizio preferirono
saltare lo spettacolo, che ogni sera concludeva le tappe
del Cantagiro, per andare alla Bussola di Marina di
Pietrasanta dove si esibiva Mina. Non ricordo se per
soldi o per altro ma li lasciai correre da soli verso ciò
che allora appariva l’ideale artistico e femminile degli
italiani. Per altro, Fabrizio conosceva Mina e aveva
promesso al collega di presentargliela. Fu il colpo di
273
fulmine. Il giorno dopo Virgilio fece recapitare alla
cantante un mazzo di rose rosse.
Mina veniva da esperienze tormentate. Quattro anni
prima aveva avuto un figlio da Corrado Pani,
Massimiliano, suscitando scandalo alla Rai che le aveva
improvvisamente chiuso le porte perché l’attore era
sposato. Poi il rapporto era finito e n’era cominciato un
altro col musicista Augusto Martelli. Finito anche
quello. Il matrimonio con Virgilio Crocco, celebrato nel
1970, durò tre anni. Due mondi inconciliabili. Lui si
guadagnava la vita scrivendo, lei cantando. Lui viveva
nell’ombra onesta della sua professione, lei in quella
ricca e luminosa dello spettacolo. Fecero in tempo a fare
una figlia, Benedetta, e a separarsi con civiltà… finché
lui, che amava l’America come una seconda patria, che
non conosceva, trovò la morte proprio in quel sognato
paradiso, travolto da un pirata della strada. Era un bel
ragazzo, alto, intelligente, onesto. Chissà che cosa passa
nella mente di una diva del canto, che pure ho amato
con spreco di aggettivi nelle mie cronache televisive su
La Sicilia, al punto da averne il rimbrotto di alcuni
lettori che al moderno che s’avanzava preferivano il
rassicurante passato di Claudio Villa e Jula De Palma.
“Ma non le sembra di esagerare troppo con Mina?” mi
scrisse un signore, alquanto seccato, “severamente”
seccato, perché avevo definito “eccelsa” la cantante.
Quell’anno la Rai, per l’ennesima volta, si coprì di
ridicolo. Nel girone C, quello dei gruppi, gareggiavano i
Nomadi con una bellissima canzone, Dio è morto, di
Francesco Guccini. Una canzone profondamente
religiosa, come scrive Christian Calabrese, perché
parlava di una società “senza cuore e ideali” in cui Dio
necessariamente è destinato a morire. “Dio è morto, nei
bordi delle strade, nelle auto prese a rate, nei miti
dell’estate… nei campi di sterminio, nei miti della
razza, con gli odi di partito Dio è morto…” Ma le
parole, ispirate a una poesia di Ginsberg, L’urlo, alla
fine erano di grande speranza: “Se Dio è morto è per tre
giorni, poi risorge”. Eppure, uno di quei funzionari che
274
hanno fatto la storia della Tv a rovescio, durante le
riprese di una delle tappe, ritenne la canzone irriverente,
se non blasfema, e non la trasmise. Gli ordini di
massima
venivano
dall’alto,
naturalmente,
dall’onnipotente direttore generale Ettore Bernabei,
fanfaniano di ferro, che in quegli anni, prima della
rivoluzione del ’68, “taglia, censura, sminuzza tutti i
servizi di Tv7 che non vanno bene”, come si legge nel
libro inchiesta di Fabrizio Carbone allegato al
settimanale Panorama del 18 febbraio 1985. La canzone
Dio è morto era tanto irriverente che Radio Vaticana la
trasmise per tutta l’estate e i Nomai vennero ricevuti in
udienza privata da Paolo VI che non la finì più di
complimentarsi.
Ava Gardner, come dicono le biografie, era ritenuta
la più bella attrice della storia di Hollywood. Ancora
oggi, descrivendone la bellezza, la definiscono
“notturna e dolente”. Perché nonostante tutto non riuscì
mai a essere felice, perché nonostante tutto non riuscì a
dimenticare la provvisorietà della sua infanzia, laggiù
nel Nord Carolina, in un paesino chiamato Brogden,
ultima di sette figli, con un padre contadino che di bello
le trasmise solo il verde degli occhi. A vent’anni, al suo
primo film, conosce Mickey Rooney, il quasi nano
prodigio di Hollywood, e si lascia irretire dalla sua
esuberanza e dai suoi consigli. Al crepuscolo della vita,
ricordando quello sfortunato matrimonio durato undici
mesi, dirà: “Michey era simpatico e pirotecnico, come
nei film, quanto al resto… stenderei un velo pietoso”.
Lasciò perdere anche Artie Shaw, il mago del clarinetto,
che le insegnò a allargare la propria cultura e ad amare
Hemingway. Lo sposò nel 1945. Lui veniva da sette
mesi d’inferno con Lana Turner ed era considerato un
grande talento oltre che un bell’uomo. Insieme con
Benny Goodman (odiato rivale), Tommy Dorsey e
Glenn Miller, è stato uno dei padri fondatori della
musica swing. È morto a novantaquattro anni. Era del
1910, come mio padre. Ma il viaggio di mio padre nel
275
Novecento, breve e intenso, è finito molto prima.
Mio padre veniva dalla provincia. Era nato a Maletto
e aveva studiato al Capizzi di Bronte, uno dei collegi
più prestigiosi del Meridione. Aveva una memoria
prodigiosa e i suoi temi d’italiano venivano affissi in
bacheca. Interruppe gli studi perché fu costretto a
lavorare, come commesso di farmacia, e la sua vita
cambiò. Prese la maturità quando era già sposato e
padre di due figli piccoli. In sei mesi imparò il greco, il
latino, la matematica e tutte le materie che non aveva
fatto o approfondito a scuola. La commissione d’esami
ne fu sbalordita. Studiava la sera, dopo cena, talvolta
fino a notte fonda, in compagnia del vento che batteva
alle finestre e al lamento dei cani randagi. Mia madre gli
portava una coperta e gliela metteva sulle spalle. Non
voleva né poteva arrendersi. Lo aveva giurato a se
stesso, lo aveva giurato a suo padre mentre gli spirava
tra le braccia, lo aveva giurato a tutte le persone che
credevano in lui e che già lo chiamavano “dottore”. Si
alzava al mattino presto e se ne tornava al lavoro, in
bicicletta. Sempre sorridente, felice di un altro giorno
che si apriva alla speranza. Affacciati dalla terrazza lo
vedevamo fermarsi all’angolo della strada, salutarci con
un ampio gesto della mano e sparire.
Di quella sapienza ne approfittai alle medie, quando
il professore di latino ci dava le versioni da tradurre in
casa e le frasi più ostiche le lasciavo in bianco a mio
padre che poi me le traduceva all’impronta. Talvolta
rientrava molto tardi ed io gliele mettevo in bella
evidenza sulla scrivania, prima di andare a letto. Al
mattino le trovavo genialmente completate. Si laureò in
chimica-farmaceutica già avanti negli anni, lavorando e
studiando, leggendo ed educandoci al rigore, al
sacrificio, al rispetto. “Adesso”, disse “non dovrò più
vergognarmi se mi chiameranno dottore”. Nella sua vita
non entrò mai in un bar a prendere il caffè. Non fumava,
non beveva, in pratica non aveva vizi. Era ottimista e
generoso, e non mi diede mai uno schiaffo: bastava il
276
suo sguardo, dolce e profondo; bastava la sua
malinconia.
Mio padre era anche la sua voce, calda e bellissima;
era le canzoni che cantava e che noi stavamo a ascoltare
come favole musicali, trame d’amori perduti, di
signorinelle pallide e snelle, di piogge battenti, di
stanzette all’ultimo piano e di rondinelle forestiere. Sul
refrain di La signora di 30 anni fa il nostro entusiasmo
saliva alle stelle: “Nel millenovecentodiciannove,
vestita di voile e di chiffon, io v’ho incontrata non
ricordo dove, nel corso oppure a un ballo-cotillon…”
“Papà, ancora!” Mentre nelle nostre menti bambine
vorticavano parole come ballo-cotillon, matite blu e
amori eterni. Entusiasmante era La piccinina che mio
padre cantava meglio di Carlo Buti. “Oh bella piccinina,
che passi ogni mattina, sgambettando lieta tra la gente,
canticchiando sempre allegramente…” Ma il suo
cavallo di battaglia era Addio sogni di gloria. La
interpretava con accesa nostalgia pensando, forse, alla
sua vita in qualche modo spezzata e rincollata. “Addio
sogni di gloria, addio castelli in aria… meglio tacer le
memorie o vecchio cuor mio”.
All’inizio degli anni Settanta scoprii che quell’abilità
di canto, soprattutto di memoria di testi, l’aveva anche
Enzo Biagi. Di questo grande maestro di giornalismo,
scomparso alla fine del 2007, voglio raccontare un
episodio. Proprio in quegli anni era stato invitato dal
Lyceum di Catania a tenere una conferenza. Venne con
la moglie e all’incontro incantò le signore del sodalizio
con le sue battute e la sua arguzia, incantò soprattutto
me, da poco giornalista professionista, incantò i miei più
autorevoli colleghi Nino Milazzo e il caporedattore
Renzo Di Stefano che mi aveva affidato l’incarico di
redigere la cronaca dell’incontro. Mi dirà l’amico Renzo
che Enzo Biagi apprezzò il mio articolo e che lo lesse
due volte. La qualcosa, come si può facilmente
immaginare, mi esaltò e mi fece venire il desiderio
cocente di essere assunto, un giorno, al Corriere della
Sera. E il sogno si sarebbe potuto avverare, penso, se
277
Nino Milazzo, appena assunto al giornale di via
Solferino, non se ne fosse tornato subito in Sicilia vinto
dalla nostalgia di casa e degli amici. Questo avvenne la
prima volta. Dopo alcuni anni, Nino, pentitosi
dell’avventata decisione, tornò a Milano e fu riaccolto a
braccia aperte. Dopo qualche tempo alla porta della sua
stanza di vicedirettore bussò Francesco Merlo, come
avevo fatto anch’io nella prima metà degli anni Settanta.
Al Corriere Francesco sarebbe rimasto una ventina
d’anni e l’avrebbe illuminato con la sua ironia e la
complessità del suo pensiero. Poi se ne andò perché il
direttore Stefano Folli, uomo d’apparato e ragioniere più
che ragionatore delle cronache politiche, pensò di
ingabbiarlo nella propria mediocrità. Ma sto divagando.
Il giorno dopo la conferenza organizzammo per
Biagi e la moglie un viaggio alla Ducea di Bronte dove
gli ospiti furono accolti con calorosa simpatia dall’allora
amministratore, mister King. Fu una giornata
memorabile. Pensai quanto fossi distante dalla sapienza
e bravura dell’illustre ospite, quanto fossi piccolo e
inadeguato anche se Biagi parlava come un papà dolce e
comprensivo. Dopo pranzo cominciò la gara delle
canzonette. E qui Biagi si mostrò imbattibile.
Conosceva tutti i testi delle canzoni che avevano
accompagnato la sua giovinezza. Incredibile. Bastava
che si accennasse a una strofa perché lui la completasse.
Nino Milazzo attaccava: “Quel menestrello d’amor,
piccola bimba del cuor…” E lui: “Io vorrei nell’estasi
sospirar chino ai tuoi piè, ogni segreto dolor scorderò
sol per te”. Poi, tutti in coro: “Solo per te Lucia va la
canzone mia come in un sogno di passion tu sei l’eterna
mia vision…”
Le canzoni interpretate dal Trio Lescano erano il suo
cavallo di battaglia: Maramao perché sei morto, Ma le
gambe, Pippo non lo sa, Tulipan. Mai avrei immaginato
che dietro quel monumento di sapienza si celasse una
così fantastica competenza. Su quelle canzoni anch’io
me la battevo ma lui mi staccava alla grande e mi stese
quando narrò la storia del Trio Lescano composto da tre
278
sorelle olandesi che in seguito presero la cittadinanza
italiana ma che nel ’43 vennero cancellate dai
programmi radiofonici perché la loro madre era di
origini ebraiche e poi furono arrestate per spionaggio.
Le autorità fasciste pensavano che le tre ragazze
attraverso le canzoni mandassero messaggi in codice al
nemico. Ha ragione Carlo M. Cipolla che sulla stupidità
ha scritto nel 1988 un delizioso pamphlet: “La persona
intelligente sa di essere intelligente. Il bandito è
cosciente di essere un bandito. Lo sprovveduto è
penosamente pervaso dal senso della propria
sprovvedutezza. Al contrario di tutti questi personaggi,
lo stupido non sa di essere stupido. Ciò contribuisce
potentemente a dare maggiore forza, incidenza ed
efficacia alla sua azione devastatrice”.
Il mio incontro con Enzo Biagi finì lì, non lo vidi
più, tranne una volta, di sfuggita, in via Teulada, al
quarto piano dove c’erano le salette di montaggio.
Venticinque anni dopo il caporedattore della redazione
cultura del TG1, Giuseppe Sicari, che era andato in
Siria, mi pare, a intervistarlo, mi disse che Biagi aveva
voluto sapere i nomi dei giornalisti che lavoravano con
lui e che arrivato al mio nome mostrò di ricordarsi…
quel giorno siciliano di sole e di profumi, quel giorno
che gli fece amare la Sicilia al punto da fargli venire il
desiderio di acquistarvi una casa. Lo stesso inappagato
desiderio di Tennessee Williams che voleva comperarsi
un piccolo podere dalle parti di Taormina.
La grandezza di Enzo Biagi era anche questa, la sua
prodigiosa memoria, il ricordarsi le cose e le persone
anche insignificanti, il mettere la sua umanità a filtro
d’ogni rapporto, il vedere il re nudo quando gli altri, per
servilismo, lo ritengono adorno di ricche vesti, lo stare
sempre dalla parte della verità e della giustizia senza
farsi corrompere dal potere, dalla politica. Ah, la
politica! Enzo Biagi cominciò a morire il giorno in cui
fu in pratica cacciato dalla Rai, quando solerti
funzionari dell’azienda di Stato fecero proprio l’editto
bulgaro di Berlusconi che aveva accusato il più grande e
279
onesto giornalista italiano di fare un uso “criminoso”
della televisione. Dopo la sua morte, Berlusconi negò di
averlo detto. Ma se così era, perché non impedì al
consiglio di amministrazione della Rai, di sua
ispirazione, di mandarlo via? Perché consentì tutta
quella manfrina (di orari, spostamenti, compensi) che
aveva il solo scopo di avvilirlo e di spingerlo alle
dimissioni? Il solo scopo di minarne la dignità? Furono
anni duri, durissimi: la morte della moglie, che ricordo
con
simpatia;
il
sostanziale
licenziamento,
sostanzialmente voluto anche da chi gli era stato amico;
la morte della figlia piccola… un grido lacerante, il
crollo sul pavimento, l’inutile corsa in ospedale. E quali
sono stati gli anni duri dei berlusconidi che hanno
gestito la Rai cercando di non disturbare troppo la
concorrenza? Quali sono stati gli anni duri del
successivo governo Prodi che non mise mai un dito
nell’acqua calda per non farselo scottare?
Nel 1948 Ava Gardner si sposò per l’ultima volta,
con Frank Sinatra, prima di darsi alla sistematica
distruzione di se stessa. Il matrimonio durò circa dieci
anni e fu abbastanza tempestoso. Sinatra, che per lei
aveva lasciato la moglie Nancy Barbato e i tre figli,
dopo i primi anni di convivenza più o meno serena,
diventò irascibile. La sua stella si stava appannando
mentre quella della moglie brillava fastidiosamente. Nel
1952, come ricorda Dario Salvatori, toccò il fondo. I
suoi dischi non si vendevano, le apparizioni televisive
diventavano sempre più rare e il cinema lo aveva
praticamente abbandonato. Inoltre, doveva centomila
dollari al fisco. Quell’anno non fece altro che azzuffarsi
negli aeroporti e negli hotel di tutto il mondo con la
moglie e con i fotoreporter decisi a immortale la diva
sempre più famosa e il marito sempre più incazzato, e
sempre più mister Gardner.
La dissestata unione praticamente finì con la perdita
del bambino che la coppia stava aspettando. Era il 1953
e Ava Gardner era impegnata in Africa nelle riprese del
280
film di John Ford, Mogambo, accanto a Clark Gable e
Grace Kelly. I soliti bene informati giurano che fu lei ad
abortire. Non voleva un figlio da un uomo che non
amava più. Eppure, quell’uomo, quando lei restò
immobilizzata a letto, distrutta dall’alcol e dagli uomini
e senza un soldo, pagò fino all’ultimo le cure mediche e
il funerale.
Davvero un cuore d’oro il vecchio Frank, amato
come artista e tollerato come “mafioso”. Sebbene su
questo aspetto molte biografie sorvolino, la figlia
Nancy, nel libro dedicato al padre, Frank Sinatra, una
leggenda americana, rivela di essere cresciuta con
“quella strana gente” intorno. Jimmy Roselli, altro
cantante di origine italiana, si vantava invece di avere
sempre contrastato quelle scomode amicizie. Nella
biografia, scritta da David Evanier, a un certo punto
dice: “Quando cominciai a diventare famoso, i mafiosi
erano sempre nelle prime file dei teatri con il loro sigaro
in bocca. Mi amavano anche se volevano ammazzarmi
perché non stavo al loro gioco. Erano le loro madri e le
loro sorelle che glielo impedivano”. Eppure, cantò al
matrimonio di John Gotti, fu ospite di Carlo Gambino e
Larry Gallo che si fece seppellire stringendo tra le mani
un suo disco al posto del rosario. Nessuno sarebbe
entrato nel circuito di serie A dei night club senza la
simpatia della mafia. Il pianista Chico Scimone, che più
volte si esibì per Frank Costello e Willy Moretti, una
volta fu ingaggiato, verso il 1938, da Costello per un
compito inusuale: accompagnare al pianoforte un
giovane cantante durante un’audizione. Il ragazzo era
Frank Sinatra.
“La mafia può creare una carriera o semplicemente
distruggerla”, commentò Chico, anche lui in sospetto di
amicizie compromettenti. Ma su questo baldanzoso
gigantesco e simpatico vecchio, morto a novantaquattro
anni nella sua amata Taormina, dove negli ultimi anni
suonava tutte le sere il pianoforte al San Domenico, non
è mai stata provata alcuna collusione mafiosa. Quando
281
emigrò negli Stati Uniti, ricorda su Repubblica
Giuseppe Videtti, con la prima delle cinque mogli,
l’attrice spagnola Aurora De Alba, e cominciò a esibirsi
nei locali alla moda di Chicago e New York, fu di certo
aiutato dagli “amici”. “I boss siculo-americani”, ammise
“erano tutti nostalgici della loro terra, venivano ai
concerti, li incontravo anche nelle navi da crociera in
cui mi capitava di suonare…” ma tutto finiva lì in una
sorta di innocente rimpatriata tra siciliani.
Fu amico di attori e attrici che frequentarono, a
Taormina, il suo locale, La Giara, messo su col fratello
Egisto nel 1953. Ospiti fissi furono Ava Gardner (alla
quale, di certo, raccontò l’episodio dell’ audizione
dell’ex marito), Liz Taylor e Richard Burton, Gregory
Peck, Peter Ustinov e Peter O’ Toole. Non solo divi,
anche qualche ragguardevole boss di Cosa Nostra come
Lucky Luciano al tempo del suo esilio in Italia. Ma la
gente perdonava il vulcanico Chico che sul finale di
partita, quando tutti i pezzi sulla scacchiera della vita
sono stati “mangiati” e resta solo il re a difendersi e a
attaccare, fu protagonista d’una trasmissione televisiva
catanese nella quale suonava al piano, su richiesta,
motivi del suo splendente passato. Il pubblico lo
ammirava anche per le sue “scalate” dell’Empire State
Building di New York. Il record personale lo stabilì a
settantadue anni: 21 minuti e 13 secondi per salire i
1576 gradini dello storico grattacielo. Voleva campare
fino a centoventi anni per continuare a stupire il mondo
con le sue tenere e stravaganti gesta. Ma non aveva la
ricetta del premier Berlusconi.
Verso la fine del 2008 Alfio Caruso, ispirandosi alla
fantastica storia di Chico Scimone, ha scritto un
romanzo diviso in due parti, Willy Melodia e L’arte di
una vita inutile, paradossalmente più vero del vero: per
la precisione dei personaggi descritti, per l’ampiezza e
la minuzia dei fatti raccontati, per il linguaggio asciutto,
alla James Ellroy, e per i sentimenti forti e terribili che
vi sono espressi. Se la vicenda umana di Scimone, pur
vera, appare ammantata di leggenda lo si deve
282
probabilmente all’imprecisione, forse voluta, nella quale
il protagonista ha sempre inserito la sua movimentata
esistenza. Di converso, l’alter ego Willy Melodia
sembra più credibile perché l’ambiente in cui agisce è
descritto con rigore storico e sapienza letteraria.
Diversamente da Scimone, che nacque a Boston, Willy
Melodia vede la luce nella Catania povera e miserabile
dell’inizio del Novecento ma al pari del suo “prototipo”
possiede l’orecchio assoluto, quella capacità
straordinaria di ascoltare la musica e riproporla senza
leggere lo spartito. Le pagine dedicate ai quartieri etnei,
ricchi d’umanità e sfasolati di fresco, sono magistrali.
Propongono la lettura di una città non completamente
innocente. Già da allora. Una città appesa al bisogno e
alla sopraffazione, alla malavita e al gioco d’azzardo in
cui il giovane protagonista impara la vita a rovescio, che
lo accompagnerà fino all’età adulta, tra rimorsi e
ripensamenti ma senza mai avere la forza e il coraggio
di rompere con le cattive amicizie. Comincia a suonare
in un bordello cittadino quando non ha ancora l’età per
affacciarsi in quel mondo adulto e impara ad amare ciò
che non può essere amato a lungo senza corrompersi. E
questa sarà la sua cifra umana, il bisogno di conoscere
attraverso il piacere, che lo porterà al fallimento di
marito, di padre e di uomo. Ma Willy Melodia non è
solo un gaudente, un ragazzo “leggero”. Sarebbe
un’interpretazione riduttiva del personaggio. Egli è
soprattutto una vittima della miseria e della paura. È per
bisogno che scivola negli ambienti della malavita locale
così come il padre che deve mantenere una numerosa
famiglia. È per bisogno e paura che entra in confidenza
con i boss della mafia italo-americana e se ne fa tappeto,
senza ribellarsi, coprendosi occhi e orecchie per quieto
vivere, per qualche dollaro in più. Eppure Willy
Melodia è un personaggio che ispira simpatia, perché
ogni cosa che fa, ogni cosa che sbaglia, la fa con
innocenza, con generosità. Egli non è mai meschino,
aiuta chi ha bisogno (perché c’è sempre uno più
disperato di lui), non prevarica, accetta pregi e difetti
283
degli altri, ama con tenerezza i due figli avuti da
relazioni diverse, mette sempre del denaro nelle lettere
che invia alla madre, insomma sarebbe, “formalmente”,
una brava persona se la vita non l’avesse traviato.
Sembra la maledizione di Hollywood. Il cinema ti
lusinga, ti fa ricco, ti mette sul piedistallo e poi ti
presenta un conto che non puoi pagare. Nella sua
autobiografia, Ava: my story, consegnata a un
giornalista poco prima di morire, Ava Gardner scrive:
“Avrei dovuto avere più orgoglio, più ambizione. Avrei
dovuto imparare a recitare, ma non è stato possibile. Per
diciassette anni sono stata schiava della Metro Goldwyn
Mayer. Il contratto era più pesante d’una catena. Ti
dicevano: fa’ questo, e tu dovevi farlo. Se disubbidivi ti
toglievano lo stipendio, restavi senza soldi, senza
lavoro. Quando pensavi di essere ormai una star, ti
davano apposta particine umilianti, e se le rifiutavi ti
sospendevano di nuovo. Dovevi appartenere a loro,
anima e corpo, ubbidire sempre: la rivolta degli schiavi
non era prevista né tollerata”. Tentò di rifarsi con la
vita, ma fu anche peggio: tre matrimoni falliti e una
serie
spaventosa
di
amanti,
a
cominciare
dall’ipocondriaco e folle Howard Hughes per finire con
Walter Chiari e Luis Miguel Dominguin (futuro marito
di Lucia Bosè) che Pablo Picasso, prima di diventargli
amico, una volta definì “un torero della Place
Vendome”.
Ava Gardner è stata una buona attrice, basti ricordare
Pandora di Albert Lewin (1951), Voglio essere tua di
Robert Stevenson (stesso anno), Le nevi del
Kilimangiaro di Henry King (1952), Sangue misto di
George Cukor (1956). Ciò che ricordo di lei è la fossetta
sul mento, lo sguardo ardente e profondo, l’incedere
sicuro e, come scrisse Piero Di Domenico, “le spalle da
regina, i gesti larghi del mostrarsi, l’ostentazione dei
bellissimi piedi molto piccoli, i sospiri sapienti della
voce”… la voce di Rosetta Calavetta che sarà anche la
doppiatrice del cartoon Biancaneve, di Lana Turner,
284
Doris Day, Veronica Lake, Kim Novak e di Marilyn
Monroe. Dove Ava è davvero magnifica è in Pandora
che è una rivisitazione di due leggende: quella nordica
de L’olandese volante e quella cattolica de L’ebreo
errante. Nel film il protagonista maschile, James
Mason, è condannato a errare per secoli su una nave
fantasma per espiare l’uccisione della moglie, ritenuta a
torto infedele. La sua pena di vivere cesserà allorquando
una donna si innamorerà di lui fino a sacrificargli la
vita. Questa donna, ovviamente, sarà Ava-Pandora. La
prima volta che lo vidi avevo suppergiù dodici anni anni
e ne rimasi folgorato. James Mason, verso la fine del
film, viene ucciso da un rivale in amore. L’assassino,
che è un famoso torero, pensa di avere così risolto i suoi
problemi di cuore. L’indomani si esibisce nella plaza de
toros davanti all’amata Pandora ma proprio quando sta
per dare la stoccata finale si accorge che il rivale che ha
ucciso a coltellate è in tribuna, vivo e vegeto. Ha un
attimo di smarrimento che gli sarà fatale: il toro lo
infilza in modo irreparabile. Amore, morte,
resurrezione! Che cosa poteva pensare un ragazzo degli
anni Cinquanta in una città di provincia che viveva una
vita fanciulla, colma di fantasticherie e incapace di
disegnare realisticamente il proprio futuro? Per giorni e
giorni vagai dentro di me nell’illusione di percorrere
l’immortalità, l’esistenza accanita e disperata dell’ebreo
errante che allora vedevo non come maledizione ma
come infinita opportunità. Rivedendolo dopo oltre
mezzo secolo l’ho giudicato verboso e pretenzioso…
ma la bellezza di Ava Gardner sconfigge il tempo, resta
un’icona laica splendente.
Nel 1954 una commessa di Catania, Eugenia Bonino,
fu eletta miss Italia. I catanesi impazzirono di gioia,
soprattutto il padre della ragazza che sul biglietto da
visita si fece stampare: “Padre di Miss Italia”. Il sindaco
La Ferlita, l’uomo che non sorrideva mai, nemmeno di
fronte a un bilancio comunale ben fatto, la ricevette in
pompa magna in municipio e trovò anche la forza di
285
sorridere. Era carina e buona come il pane di casa, come
si diceva allora, la classica moglie insomma. Sparì dopo
essere stata invitata a un paio di feste danzanti e a
alcune cerimonie pubbliche e dopo avere preso parte a
due film che nessuno ricorda più: Un palco all’opera di
Siro Marcellini e I vagabondi delle stelle di Nino Stresa,
anno 1956. Qui faceva la parte della servetta del
padrone d’una pensione dove alloggiavano tre allegri
studenti: Mario Girotti, Vincenzo Musolino e Riccardo
Fellini. Per qualche anno ci siamo riempiti la bocca col
suo nome e gli occhi con la sua bellezza di periferia. Nel
mio ricordo ha un posto insignificante, ancora più
piccolo di quello di Jean Peters o di Joi Lansing, per
esempio, modesti ceri di sagrestia che il pubblico
accende senza memoria ma che brillano nella penombra
delle navate. Eugenia Bonino era piccola e rotondetta,
con grandi occhi bruni e un sorriso dolce. Era il simbolo
della bellezza siciliana e assomigliava a un sacco di
ragazze che conoscevo, di vista. Era una di quelle che
bisognava immaginarsele nude perché ti restassero nella
memoria o ti accendessero di desiderio; una di quelle
che i ragazzi, d’estate, vedevano spogliarsi attraverso le
sconnessure dei tavolati o i buchi praticati nel retro delle
cabine. Non era certo il tipo alla Susan Hayward che ti
restava nella testa col semplice tremore delle labbra.
Era, insomma, una di quelle ragazze anni Cinquanta che
correvano in prendisole a fiori sulla sabbia col foulard
in mano e si sedevano sul mezzo deretano per poi con le
amiche intessere capricci sentimentali, pettegolezzi,
mentre i ragazzi mostravano i bicipiti e risucchiavano la
pancia per essere all’altezza di quelle piccole maestà di
perversione. Ma tutto restava lì, sulla sabbia, negli
sguardi, nell’orizzonte del mare. Le ragazze erano come
sirene sdraiate e difficilmente avresti potuto
immaginarle correre nel deserto dietro il loro grande
amore, come fa Marlene Dietrich nella sequenza finale
di Marocco. Il suo Gary Cooper, semplice legionario,
vale più di un bracciale di diamanti, più di una bella
sistemazione con l’azzimato inutile Adolphe Menjou.
286
Anche Susan Hayward si portò appresso un’infanzia
dolorosa. Amava moltissimo la madre, ma la madre
amava moltissimo l’altra figlia. Richard Widmarck una
volta disse: “È una donna che è stata plasmata in un
blocco d’argilla”. Dopo il fallimento del primo
matrimonio con l’attore Jess Barker, durato dieci anni,
tentò il suicidio quando seppe che la commissione di
giustizia civile le aveva tolto la custodia dei due figli.
Era il 1955 ed era impegnata nelle riprese del film
Piangerò domani di Daniel Mann. Prima di svuotare il
tubetto del sonnifero telefonò alla madre: “Non
preoccuparti, d’ora in avanti non dovrai più prenderti
cura di me”. La madre telefonò alla polizia e la salvò.
L’anno dopo girò nel deserto dello Utah, quasi
certamente contaminato dagli esperimenti nucleari, il
film Il conquistatore di Dick Powell. Oltre metà della
troupe, compreso il regista e il protagonista John
Wayne, morirono nei trent’anni successivi. Powell morì
nel 1963; Wayne, di più forte fibra, nel 1979; Susan nel
1975. Tutti e tre per un cancro al polmone, che, nel caso
dell’attrice, contaminò anche il cervello. Due anni
prima, ormai distrutta dal male e pressoché
irriconoscibile, alla premiazione degli Oscar il pubblico
eviterà di guardarla. Era stata chiamata per annunciare
la vittoria di Glenda Jackson (Un tocco di classe) che
neppure verrà a ritirare il premio. Penoso, penosissimo
annuncio mentre Charlton Heston la sorregge e alcuni
tra gli spettatori trovano la forza di guardare e di
piangere.
Negli anni Cinquanta le atomiche si sprecavano. Sia
quelle che esplodevano negli atolli del Pacifico o nei
deserti americani e sovietici, sia quelle che deflagravano
nella testa del pubblico maschile. Non so le misure degli
ordigni nucleari e termonucleari, ma ricordo bene quelle
delle dive insaccate nei costumi elasticizzati: 90, 60, 90.
Novanta di bacino, sessanta di vita e novanta di petto.
Un violoncello perfetto. Era la fame della guerra che
aveva inventato quella terna vincente sulle ruote del
287
mondo. Bisognava voltare pagina, dimenticare le tessere
annonarie e dare l’immagine d’una prosperità che prima
o poi avrebbe riguardato tutti. Il prima, però,
apparteneva al cinema, alle dive con le quali riempirsi
gli occhi e ingannare lo stomaco. Alle elezioni di Miss
Italia del 1947 partecipò un quintetto niente male: Lucia
Bosè, Gina Lollobrigida, Silvana Mangano, Eleonora
Rossi Drago e Gianna Maria Canale. In pratica, il futuro
star system del cinema nazionale. Vinse Lucia Bosè che
sognava una carriera d’attrice e un matrimonio con un
famoso torero (allora i sogni avevano tanto sofferto che
potevano persino realizzarsi). Ma chiunque delle cinque
avrebbe potuto indossare la sciarpa e la corona. Erano
perfettamente scomponibili e componibili tra di loro in
modo da ricavare comunque un ideale di bellezza. Tre
anni dopo fa la sua prima mala comparsa Sofia Loren,
che viene battuta da Anna Maria Bugliari. Chi era
costei? Forse una raccomandata. O forse la giuria, con
in testa Orio Vergani, si spaventò delle misure
eccessive, non convenzionali, della candidata che,
almeno di petto, arrivava al metro. Non si poteva
esagerare.
L’idea di mettere in tavola un pollo la settimana
restava ancora una speranza, che partiva da lontano, se
si vuole, visto che Mussolini era stato il primo a
parlarne, ma ancora non c’erano le reali premesse.
Ancora nelle case degli italiani arrivavano gli indumenti
smessi dei civili americani e il loro cibo in scatola. Al
mercato di piazza Carlo Alberto spedivano di tutto:
abiti, coperte, divise, paracaute. Con una coperta
militare, che poi immerse nella tintura blu, mia madre
mi confezionò un cappotto e dalla seta dei paracaute
ricavò eleganti camicie. Non c’era da vergognarsi. Le
famiglie si rialzavano a fatica e il loro onore lo
misuravano su altre cose: sul lavoro, sul sacrificio, sullo
studio, sul futuro che non poteva tardare. Io lo misuravo
sui libri e sul cinema.
Susan Hayward era una perdente. Nella vita e nel
288
cinema. Dopo cinque tentativi vinse l’Oscar nel 1958
con Non voglio morire di Robert Wise. “Desideravo
questo premio da vent’anni”, disse. “Ora posso
dedicarmi a fare la moglie a tempo pieno”. Il film era
ispirato a una storia vera: quella di Barbara Graham, una
prostituta condannata a morte per un omicidio che disse
di non avere commesso e che alla fine venne giustiziata
nella camera a gas di San Quentin. Per pubblicizzare il
film, il produttore scomodò lo scrittore francese Albert
Camus e lo coinvolse in una dichiarazione contro la
pena di morte. Lacrime a non finire anche con Piangerò
domani e una nomination che rimase tale perché l’Oscar
quell’anno venne dato a Anna Magnani per La rosa
tatuata di Daniel Mann. La nostra attrice, sanguigna ed
eccessiva, nel pianto come nel riso, s’impose anche su
Jennifer Jones (L’amore è una cosa meravigliosa), su
Katharine Hepburn (Tempo d’estate) e su Eleanor
Parker (Oltre il destino). Potenza delle suggestioni!
Questi sono gli anni del mio passaggio dalla scuola
cattolica alla scuola statale. Un passaggio difficile,
tormentato, ma alla fine liberatorio. Che cosa avevo
imparato dai discendenti di San Giovanni Battista de La
Salle, il fondatore della scuola dei poveri che diventerà
la scuola dei ricchi? Avevo imparato a studiare. Ogni
mese ci davano la pagella e ci interrogavano ogni 15
giorni; il tempo passava più a interrogare che a spiegare
(il contrario del Cutelli: pagella trimestrale e, talvolta,
anche l’interrogazione). Ci davano un sacco di compiti
per casa e un sacco di poesie da mandare a memoria.
Anche se i professori non erano un granché, il loro
metodo d’insegnamento era pignolo, stressante ma
proficuo. C’era un grosso problema, però, un vizio in re,
che controbilanciava pesantemente lo sforzo pedagogico
e mnemonico. E questo lo avrei capito tempo dopo. Il
problema era la quasi assoluta mortificazione dello
spirito critico. La cattedra era l’altare, il docente
l’officiante, gli studenti i fedeli. Così come avveniva
nella cappella dell’istituto (mezzora al giorno di Santa
Messa) e in classe (un’altra mezzora, questa
289
obbligatoria, di religione). Nessuno poteva batterci sui
grandi personaggi della Bibbia, e tutti potevano
umiliarci sui grandi personaggi dell’umana sapienza.
L’ipse dixit, di aristotelica memoria, era come incarnato
nelle lezioni e fortemente simboleggiato dalla tonaca del
professore. Questi mica era un docente qualsiasi, era
anche questo si capisce, ma era soprattutto l’Oracolo,
colui che parlava per verità rivelata. Questo è stato il
grande equivoco della scuola cattolica di allora. Se ne
rese conto mio padre, sollecitato anche dall’eccessivo
peso delle rette trimestrali. Si rese conto che sarei
cresciuto come uno stronzetto figlio di papà e non come
una persona normale che deve affrontare le difficoltà
della vita. E queste poteva insegnarmele solo la scuola
laica, la scuola del libero pensiero, la scuola che
assomigliava alla mia famiglia.
Avevo quindici anni quando misi piede per la prima
volta in una classe mista. Primo liceo, sezione I.
Ovviamente, i docenti erano veri professionisti, vincitori
di concorso, non religiosi, per lo più senza vocazione e
senza laurea, che indossavano la tonaca per togliersi
dalla miseria d’origine, studiare, insegnare ciò che
potevano e darsi un futuro. Dei docenti laici il più bravo
era l’insegnante di storia e filosofia che odiava i preti e
la scuola cattolica. Mi dichiarò guerra subito, e mi odiò
quando qualcuno gli riferì che ero venuto al liceo
Cutelli per conoscere i figli del popolo, o qualcosa del
genere. Al primo trimestre riuscii a collezionare
l’insufficienza in quasi tutte le materie. Mio padre si
allarmò ed io non seppi che cosa rispondere. Diventai
rosso e scappai nell’altra stanza a piangere
tranquillamente. L’indomani andò a parlare coi
professori, per capire. Suo figlio era stato
complessivamente bravo e non riusciva a capacitarsi.
Possibile che il cambio di scuola avesse determinato il
disastro? Impossibile. Il professore di storia e filosofia,
il sacerdote del libero pensiero, l’uomo che abitava in
una bellissima casa ottocentesca e possedeva
un’automobile di lusso, l’uomo che detestava i ricchi e
290
amava i poveri, cambiò da così a così. Conosceva mio
padre per averlo incontrato alle conferenze di Santino
Caramella, professore ordinario di pedagogia
all’università di Palermo e autore di un trattato di
filosofia per studenti sul quale aveva studiato un’intera
generazione di siciliani. L’equivoco fu chiarito, io non
mi sentii più un estraneo e alla fine dell’anno venni
promosso a pieni voti. Eppure, restò come una ruggine
sottile tra di noi, tra chi conosceva la vita e chi la
immaginava, tra un uomo di oltre quarant’anni e un
ragazzo di quindici, tra la sapienza e l’ignoranza.
Quarantacinque anni dopo ricevetti una sua telefonata.
Voleva congratularsi per un mio intervento su
Telecolor-Video3. “Ti ho telefonato perché so che ti
avrebbe fatto piacere”. Un immenso piacere.
Finalmente, ai suoi occhi, avevo superato l’esame. Caro
vecchio, duro e scorbutico professore che odiava la
retorica e amava il soggettivismo. Tranne quella volta,
alla festa conviviale della maturità, quando il cameriere,
su nostro suggerimento, gli portò una minestra
salatissima: “Questa roba è immangiabile” esclamò.
Già, oggettivamente immangiabile.
Pur con qualche limite caratteriale, quel professore
fu un maestro. Alla maniera di Francesco Guglielmino
che ha forgiato generazioni di studenti attraverso la sua
lunga e operosa vita: 1872-1962. Novant’anni esatti.
Quasi un secolo ma che per la storia vissuta e per i
personaggi grandi e piccoli incontrati e conosciuti fanno
due secoli di esperienza. Nasce proprio quando muore
Giuseppe Mazzini, uno dei personaggi che conteranno
nella sua formazione ideale, e muore quando nasce il
Concilio Vaticano II che porta la Chiesa a immergersi
nei principi democratici della rivoluzione francese. Ha
conosciuto la monarchia di Vittorio Emanuele II, di
Umberto I, di Vittorio Emanuele III, ha conosciuto
l’Italietta di Cavour, di Giolitti, il fascismo e la
repubblica. Nel cielo ha visto solcare le rondini, i
dirigibili e gli aeroplani. Ha visto la Catania dei grandi
contrasti, quella della borghesia rampante della seconda
291
metà dell’Ottocento coi suoi palazzi magnifici, e quella
degli operai alloggiati nelle casupole con le fogne a
cielo aperto di San Berillo e della Civita, ha visto la
ricostruzione del secondo dopoguerra e la civiltà rissosa
dei condomini, ha visto la campagna sparire a poco a
poco nel cemento dei palazzi democristiani, ha
conosciuto ciò che c’era da conoscere, ha camminato
per le strade fangose delle periferie etnee con un occhio
al cielo e l’altro alle miserie del mondo, sempre amando
e tollerando, ma sempre facendo sentire alta la sua voce
di uomo severo e giusto. Come mister Chips, nel film di
Sam Wood, al quale assomigliava persino fisicamente.
Il ritratto che una volta ne fece Sciascia è il ritratto di
Robert Donat nei panni del prof. Chips. “Era quasi
totalmente sordo” scrive Sciascia, “ogni volta che
aprivo bocca per dire qualcosa mi trovavo piantata
davanti, a dieci centimetri, la nera scatoletta-microfono:
inutile per lui, inibitoria per me. Ma capitava raramente,
poiché amavo ascoltarlo... Arrivava al caffè
puntualissimo: il bastone sottobraccio, come se ci
tenesse a non appoggiarvisi. Sedeva, tirava fuori un
libro da una tasca della giacca; la pipa, il tabacco e i
fiammiferi da un’altra. E cominciava a parlare... ”
Parlava di Verga, di De Roberto che aveva
conosciuto molto bene, di Martoglio e di Tempio,
parlava di Brancati e dei suoi affanni, parlava dei suoi
tempi e dei suoi anni. Aveva visto tutto, come ho detto.
Era nato nel silenzio dell’Ottocento e si era ritrovato nel
rumore del fascismo e del Novecento, due guerre
mondiali nella sua esperienza, aveva ammirato le donne
in crinolina e le aveva viste nelle corte vesti della Belle
Epoque. È stato un punto di riferimento vitale per
generazioni di studenti, a scuola e all’università, ed è
stato anche il perno di una stagione letteraria irripetibile
a Catania, come ho ricordato in altra parte del libro.
Guglielmino nutriva un senso doloroso del vivere, come
Leopardi. Il senso della caducità gli era sempre
presente, e lo vide per altro, intristendosene, negli occhi
velati di Giovanni Verga, rudere ormai di se stesso,
292
senza più scintille creative; lo vide nel volto pallido di
Mario Rapisardi, negli ultimi anni della sua vita, malato
e dimenticato nella casa di via Etnea, morto si può dire
come lo avrebbero voluto già dal secolo precedente i
suoi tanti nemici. Forse pensò allora a una
identificazione. Professore Rapisardi, professore lui;
poeta Rapisardi, poeta lui stesso. Ma Guglielmino
sopravanza come docente l’illustre Vate e come poeta i
suoi “fiori” valgono dieci palingenesi. Il vecchio
professore di Acicatena ci ha lasciato avari patrimoni di
libri, anche se grande era il suo talento, ma generazioni
di studenti, di scrittori, di uomini d’ingegno lo ricordano
come un maestro di pensiero, una bussola nella
tempesta della vita.
293
TREDICI
Lana Turner, Doris Day
Il padre di Lana Turner lavorava nelle miniere
d’argento di Wallace, nel Nord dell’Idaho, ed aveva la
passione del gioco. Quando la miniera non aveva
bisogno di lui, s’ingegnava a sbarcare il lunario con le
carte. Una sera, a San Francisco, dove s’era trasferito
con la famiglia, vinse una grossa somma ma sulla via
del ritorno a casa venne rapinato e ucciso. La famiglia
tirò avanti alla meno peggio finché la quattordicenne
Lana, che ancora si chiamava Julia Jean ed era
bellissima, mentre sorseggiava un frappé alla fragola, in
un bar nei pressi di Hollywood, fu notata da un
fotografo dell’Hollywood Reporter che la presentò a
Mervyn Le Roy. Il regista le cambiò il nome e se la
portò in giro per gli studios. Probabilmente, la lasciò al
suo destino quando seppe che aveva solo quattordici
anni, oppure non riuscì a piazzarla per la paura dei
produttori di finire in galera. Fatto sta che la giovane
Lana, un anno dopo, stava ancora aspettando la grande
occasione… marinando la scuola, studiando poco,
bazzicando nel sottobosco (d’agrifoglio) del cinema.
Una Lolita avanti lettera, che dello strepitoso
personaggio inventato da Nabokov aveva tutto ciò che
poteva distruggere un uomo: bellezza, candore, acerbo e
malizioso sentire, sfrontatezza, disponibilità e insieme
ritrosia, insomma, un demonio vestito d’angelo, una
ragazzetta che, guardandola, non potevi fare a meno di
peccare. Erotismo allo stato puro. Fu Zeppo Marx, uno
dei celebri fratelli, che sbloccò la situazione
insegnandole a mentire. Da quel giorno, Lana Turner
diventò maggiorenne, guadagnò una comparsata nel
film di Wellman, È nata una stella, e una particina in
Vendetta di Mervyn LeRoy, in cui recitò con un
pullover d’una misura più piccola perché le facesse
risaltare il piccolo seno. Da allora, e per molti anni,
294
verrà intesa come “la ragazza del pullover”, ma anche
come “la ragazza senza sopracciglia”, dopo che le sue,
rasate per esigenze di copione, non erano più ricresciute.
A ventisei anni, avendo all’attivo pochi film di rilievo,
tra cui Il postino suona sempre due volte, di Tay
Garnett, tratto dall’omonimo romanzo di James Cain,
era già tra le dieci attrici più pagate di Hollywood.
Sembrava uscita dai pennelli di Gil Elvgren. La
ragazza con l’ombrellino sul risciò, o quella che
imbraccia l’arco o mostra di aver confezionato la fionda
con l’elastico del reggicalze, ha la sua bocca e i suoi
capelli. Una magnificenza terrestre. Una donna dalla
vita scapestrata, eccessiva in tutto, negli amori e nelle
infedeltà, nei matrimoni (sette) e negli scandali. Dopo
Artie Shaw sposa l’attore-ristoratore Steve Crane.
Hanno una figlia, Cheryl, che alla nascita subisce il
ricambio del sangue per via d’una incompatibilità con
quello della madre. Poi è la volta del milionario Henry
J. Topping jr. “L’uomo di successo è colui che
guadagna più denaro di quanto sua moglie possa
spendere. Una donna di successo è quella che trova un
uomo così”. Questa era la filosofia di Lana Turner,
figlia del minatore che amava il gioco d’azzardo e che
spesso non aveva i soldi per pagarsi da bere. Come ha
scritto Giuseppe Marotta in Visti e perduti, nascere bella
fu la sua tragedia. Il cinema non le disse: “Vieni, ti
educo”, le disse: “Vieni, ti fotografo”. E lei si fece
fotografare perché era “una popolana ignorante e
scema”. Nella sua rete ammaliatrice cadono come
passeri Lex Barker, il Tarzan che tenta di ricalcare lo
straordinario successo di John Weissmuller, l’allevatore
Fred May, l’uomo d’affari Robert Eaton e infine
l’illusionista Ronald Dante. Una tirata di fiato per
aggiungere alla lista alcuni amanti e amici: Tyrone
Power, forse l’unico amato veramente; Frank Sinatra,
Robert Taylor, Cary Grant, Howard Hughes, Victor
Mature, Fernando Lamas. Il bel Fernando era stato suo
partner nella Vedova allegra di Curtis Bernhardt (1952)
e non s’era vergognato di insidiarle la figlia Cheryl.
295
Fernando Lamas sarà il terzo marito di Ester Williams,
la diva che nei movies nuotava tra cascate e zampilli
d’acqua e recitava con molta buona volontà, la diva che
incontrai al festival di Taormina, ormai grassa e stanca e
che dell’antico splendore manteneva il sorriso. Mi disse
che il suo vero e unico amore era stato Fernando Lamas,
morto qualche anno prima. Si perdonano tante cose
dalle parti di Hollywood.
E poi avvenne il fattaccio che le rovinò la vita. La
sera del 4 aprile 1958, nella grande casa coloniale di
Bedford Drive, a Beverly Hills, la figlia Cheryl, dopo
avere assistito all’ennesimo litigio tra la madre e il suo
amante, il malavitoso Johnny Stompanato, corre in
cucina, afferra un coltellaccio e lo pianta nelle spalle del
giovanotto che cade in una pozza di sangue. Lana tenta
di fargli la respirazione bocca a bocca. Niente da fare.
L’ex guardia del corpo del gangster Michey Cohen, il
gigolò mostruosamente dotato, arrogante e manesco, è
già in viaggio per l’inferno. Avevano litigato per una
questione di soldi. L’attrice era stanca di pagargli i
debiti di gioco e glielo aveva gridato in faccia, lui
l’aveva minacciata come aveva fatto altre volte. “Se ti
dico salta, tu salti; se ti dico balla, tu balli”. E poi
ancora: “Ridurrò la tua faccia a un punto tale che dovrai
nasconderti per tutta la vita, tanto sarai schifosa”. Il
trattamento lo aveva esteso anche alla madre di lei e alla
figlia Cheryl. Che cosa doveva fare una ragazzina di
quattordici anni che ascoltava terrorizzata dietro la
porta? Mettersi a piangere oppure comportarsi come in
una sequenza cinematografica? Scelse la seconda
opzione e per lei cominciò un lungo calvario
psicologico che la portò a odiare gli uomini e ad amare
le donne.
Approdo inevitabile, del resto, dopo che uno dei
mariti della madre, Lex Barker, tentò di molestarla così
come avrebbe fatto Fernando Lamas. Fu assolta per
legittima difesa. Tutta l’America insorse contro l’attrice,
definita madre dissoluta e snaturata, e fu sul punto di
scendere in piazza quando vennero pubblicate le lettere
296
d’amore scritte all’amante. Di quell’uomo violento,
Lana, non sapeva fare a meno, era un’ossessione. E non
fu il solo a picchiarla. Tra i pochi, si provò a difenderla
il celebre columnist Walter Winchell ma si ebbe
l’immediato rimbrotto della vecchia e acida diva del
cinema muto, Gloria Swanson: “Per me è disgustoso
che tu cerchi di rifare una verginità a Lana. L’unica cosa
vera che hai detto sul suo conto è che dorme con la
camicia da notte di flanella”.
Johnny Stompanato, alias Johnny Valentine, in fondo
era un vile, uno che picchiava le donne e le sfruttava.
Quello che valeva si capì il giorno in cui capitò sul set
del film Estasi d’amore, di Lewis Allen, che l’attrice
stava girando in Gran Bretagna con l’allora sconosciuto,
giovane e aitante Sean Connery. Il bullo Johnny si
avvicinò all’attore, gli puntò la pistola e gli disse di
stare alla larga dalla sua donna. Connery gli sorrise e gli
mollò un cazzotto che lo stese a terra. Poi, lo denunciò e
con l’aiuto di Scotland Yard lo fece cacciare via dal
Paese. Il futuro agente 007 cominciava a allenarsi.
Nel 1966 Lana Turner diede il meglio di sé
interpretando se stessa. Il film, Madame X, racconta di
una donna che uccide per proteggere la propria famiglia,
al termine d’una vicenda complicata e melodrammatica
ma di grande impatto emotivo. Davvero memorabile
l’incontro in cella tra la protagonista e il figlio che la
difende dall’accusa di omicidio. Rivedendolo oggi la
commozione mi assale, come un tempo, lacrime
comprese. Piangere a una ragguardevole età è come
ammettere di avere conservato il tempo non di averlo
consumato, di averne congelato la favola, l’incanto; è
come dire d’essere rimasto prigioniero del passato, di
non avere percorso per intero la disillusione, la crudeltà
del mondo, l’ipocrisia. E si è così, candidamente e
razionalmente
sprovveduti,
soprattutto
nella
commozione e nel dolore. Insomma, come direbbe Lidia
Ravera, io e molti altri siamo diventati “angeli vecchi”.
Mi illudono le parole di Francesco De Gregori: “La
storia siamo noi… siamo noi queste onde nel mare,
297
questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio
così duro da masticare. E poi ti dicono ‘Tutti sono
uguali, tutti rubano alla stessa maniera’. Ma è solo un
modo per convincerti a restare chiuso dentro casa
quando viene la sera…”
A quel tempo, per me, per quelli come me, la mafia
era quella del cinema, la mafia americana,
l’organizzazione dei gangster che uccidevano altri
gangster e poi soffiavano sulle pistole fumanti. La mafia
di Bugsy Siegel, per esempio, che costruì a Las Vegas il
più grande hotel-casinò degli Stati Uniti, il Flamingo,
autentico monumento al kitsch; o la mafia di Michey
Cohen, il gangster di origine ebraica che tentò di rifare
il verso a Dutch Schultz, quello del Cotton club
all’epoca del proibizionismo. E ancora: la grande mafia
di Al Capone, che viaggiava su una limousine corazzata
del peso di sette tonnellate, fumava sigari habana e finì
in galera non per i tanti delitti commessi ma per
evasione fiscale; la grande mafia di Lucky Luciano e di
Albert Anastasia, il famigerato capo dell’Anonima
Assassini, che fu ucciso nel salone da barba dello
Sheraton a New York su ordine di Vito Genovese; la
grande mafia di Carlo Gambino, che cominciò la
carriera falsificando le tessere di razionamento; e di
John Gotti, che allargò gli interessi dei clan mafiosi in
settori divenuti strategici come la droga e il traffico
delle armi.
La mafia siciliana invece era una sorta di mistero
teatrale, una rappresentazione incerta, imprecisa; e
comunque un affare che riguardava solo Palermo. Noi
eravamo di qua, nell’Oriente siciliano dove sorge il sole
prima di annegarsi nel lontano Occidente. Due terre
distanti, che riuscivano a svelarsi dopo cinque ore di
viaggio, in macchina o in treno. Era più facile prendere
l’aereo e raggiungere New York. Ma noi, a Catania,
“non ci capivamo niente” come scrive Tino Vittorio
nella prefazione al libro di Giuseppe Lazzaro Danzuso
dedicato alla nascita della prima televisione catanese,
“Teletna”. “A Catania la delinquenza ubiquitaria dei
298
quartieri”, ricorda l’amico Vittorio “stava trovando il
suo posto di eccellenza nella mafia. Uno l’aveva capito,
ma noi non avevamo capito che Giuseppe Fava l’aveva
capito. Ci pareva fosse una trovata teatrale,
un’esagerazione da cui distogliere attenzione e energie,
indirizzate, invece, nei laboratori rivoluzionari”.
Insomma, quella nostra generazione era lontana da casa
e dalla mafia ma era di casa nella guerra del Kippur, nel
Cile di Allende, nelle stragi in massa organizzate da Pol
Pot e nella Spagna senza Francisco Franco. “Eravamo in
ogni luogo”, precisa Tino Vittorio “tranne che a
Catania”. Confortati, per altro, da una stampa anch’essa
altrove, anch’essa confusa, illusa. Come ricorda
Giuseppe Lazzaro Danzuso, nel libro appena citato, “il
problema non era quello di pubblicare le notizie, quanto
di connettere tra di loro i fatti apparentemente lontani, di
metterli insieme come tasselli di un puzzle per cercare
di comprendere quale fosse la nuova realtà che si
andava creando”.
La percezione che Catania avesse perso la propria
innocenza si ebbe la sera del 5 gennaio 1984 quando
Maurizio Avola, a capo di un commando assoldato da
Nitto Santapaola e da suo nipote Aldo Ercolano (ma
questo si saprà dopo), sparò a Pippo Fava: cinque colpi
di pistola alla nuca. Una vera inequivocabile esecuzione
mafiosa. In seguito, il killer avrebbe scritto un libro con
questo titolo: Mi chiamo Maurizio, sono un bravo
ragazzo, ho ucciso ottanta persone. Il giornalista e
scrittore aveva appena spento il motore della sua
macchina, una Renault 5 rossa, dopo averla posteggiata
in via De Cosmi, all’angolo con via dello Stadio, e si
accingeva a raggiungere il Teatro Verga, dove si stava
rappresentando una sua opera teatrale dal titolo
profetico L’ultima violenza, quando fu raggiunto e
ucciso dal killer. Una settimana prima lo avevo
intervistato per il TG3. Mi aveva parlato, in toni lucidi e
appassionati, di quel lavoro che riprendeva, su temi più
vasti, il precedente La violenza. Pippo si esprimeva, e
scriveva, con uno stile immaginifico, barocco, ma
299
sempre innestato nella verità delle cose e degli uomini.
Conservo una foto che ci ritrae, assieme a Tony
Zermo, al club della Stampa, d’estate. Era una persona
coraggiosa, onesta e per bene. A quei tempi era l’anima
e il cervello di Espresso Sera, il quotidiano del
pomeriggio diretto dallo scialbo, ma con un’alta
considerazione di sé, Girolamo Damigella, imparentato
con la famiglia Simili proprietaria del giornale assieme
a Domenico Sanfilippo. Pur desiderandolo ardentemente
non riuscì mai a dirigerlo perché di lui non si fidavano.
Mi ricordo che un’estate il mio giornale mi propose di
dare una mano ai colleghi di Espresso Sera. Pattuimmo
un compenso. Centotrentamila lire per un mese di
sostituzioni. Lavorai al fianco di Pippo Fava e imparai a
stimarlo ancora di più e a volergli bene. Al termine
dell’impegno di lavoro (davvero massacrante perché al
mattino lavoravo per il giornale della sera, e la sera per
il giornale del mattino) feci un salto in amministrazione.
Il direttore amministrativo a quel tempo era uno dei
fratelli di Damigella. Fece preparare i soldi e me li
consegnò. Centomila lire. Gli feci osservare che
l’impegno era diverso e lui mi rispose con un’alzata di
spalle. Gli lasciai i soldi sul tavolo e me ne andai. La
sera stessa, mentre mi trovavo in tipografia, arrivò
Pippo Fava. Si scusò e mi diede il denaro pattuito. “Gli
ho fatto una cazziata che se la ricorderà finché campa”,
mi disse con un sorriso. A rifletterci, oggi, forse la
differenza ce la mise di tasca propria. Magari per un
caffè ti faceva stirare il collo, ma sulle cose importanti,
sui sentimenti, sulla generosità maiuscola, stava sempre
in prima fila. A parte mio padre non ho mai conosciuto
una persona come lui, uomo giusto e ribelle, in una città
che non lo capiva, né poteva capirlo.
Aveva cominciato a scrivere libri e commedie di
successo. Era una penna magnifica e prolifica. Una vera
miniera per un giornale. Eppure, quando cercò di
passare a La Sicilia, la Proprietà, come si diceva una
volta, gli sbarrò le porte, probabilmente per non
sconvolgere gli assetti redazionali interni e anche per
300
l’azione sotterranea di alcuni colleghi che ne temevano
la forte personalità e l’indubbio valore. E allora, dopo
una breve parentesi romana, se ne andò a dirigere Il
Giornale del Sud, un quotidiano nuovo di zecca, fondato
dal cavaliere Recca, che presto finì nelle mani di
politicanti e maneggioni che si illudevano di fare la
concorrenza a La Sicilia. Fu licenziato nel momento in
cui quegli aspiranti e mediocri editori capirono che non
era addomesticabile e che avrebbe denunciato piuttosto
che coperto i loro interessi. La successiva stagione dei
Siciliani determinò la sua fine. Furono le battaglie
contro i cavalieri dell’Apocalisse, contro la mafia,
contro tutto e tutti che lo portarono all’isolamento e alla
tragedia. Magari fece qualche sbaglio, ma l’averlo, di
fatto, allontanato da La Sicilia e costretto, di fatto, a
intraprendere una strada senza ritorno fu un errore.
Certo, è il senno del poi che oggi mi rende “perspicace”.
Allora nessuno, al giornale e negli ambienti che
contano, avrebbe potuto immaginare, soltanto
immaginare, le tragiche conseguenze di quel diniego. La
“perspicacia” dell’oggi mi fa dire ancora che non era
impossibile trovare una soluzione, un qualche
compromesso, un modo per non offendere le aspettative
dei colleghi o mortificarne le posizioni di comando.
Non era impossibile sottrarsi alle loro recriminazioni e
ai loro calcoli di bottega. Ex post, aggiungo che fu una
mancanza di carattere editoriale e di lungimiranza.
Pippo s’impaniò nella sua rabbia e nel suo forte
desiderio di rivalsa. Alzò il limite della denuncia a
un’altezza tale che l’establishment, quello opaco e
nascosto, quello che si arricchiva senza togliersi i
guanti, non poté sopportare. Il potere cittadino non era
preparato, non era maturo, non era intelligente, non era
furbo. Era semplicemente stupido e arrogante. Il potere
mafioso, quello dell’argot etneo del parlare fumoso e
per metafora (’a baccagghiu), gli correva parallelo.
Seppure sussidiario ai neo-vicerè “di spade, di mazze, di
coppe e di oro”, secondo l’arguzia di Tino Vittorio,
aveva già i suoi capibastone e il suo programma
301
d’Oriente.
Catania apprese la notizia con sgomento, il giorno
dell’Epifania, ma poi si convinse che non poteva essere
un omicidio mafioso e se ne convinse per paura. A quel
punto cominciò a scorrere nelle sue vene il sangue
guasto della maldicenza. Si disse che il giornalista era
stato ammazzato per “questione di femmine”; anzi,
qualcuno precisò che di mezzo c’era la donna di un
malavitoso. Si scavò nella sua vita, furono setacciati il
suo povero conto in banca, quello dei familiari e dei
suoi collaboratori; si fece di tutto per seppellire la verità,
semplice e tragica, con una montagna di crudeli ipotesi,
chiacchiere, disonestà. Perché quella verità metteva a
nudo una città più complessa e misteriosa di quanto si
credesse, una città del sottosuolo ben più articolata e
labirintica, crudele e spietata, rispetto alla città del sole
e delle stelle, dell’arguzia e della intelligenza, che i
catanesi erano abituati a vedere e a vantare. Fu dunque
più comodo chiudere gli occhi e concentrarsi su un
uomo solo, e alla fine abbatterlo, anziché guardare
nell’abisso che si era aperto. Meglio la semplificazione
della realtà che la sua mefitica articolazione, meglio
passeggiare per via Etnea, andare al cinema, inorgoglirsi
della fatuità della vita che andare dietro le quinte del
palcoscenico e finalmente “vedere!”
I catanesi, invece, secondo il giudizio dell’attuale
vicedirettore di La Sicilia, Domenico Tempio,
“continuarono a distogliere lo sguardo”. Analogo
giudizio avrebbe espresso Alfio Caruso nel suo libro
Perché non possiamo non dirci mafiosi: “Ma esistono i
catanesi per bene? Sì, tutti noi siamo per bene, ma
quante volte ci siamo dovuti voltare dall’altro lato o
quante volte abbiamo dovuto far finta di non vedere”. In
altre parole, Catania nulla sapeva ma nulla voleva
sapere. In un articolo pubblicato sul Corriere della Sera
qualche settimana dopo il brutale assassinio, Alfonso
Madeo tentò un ritratto di Catania e del clima
“malsano” e “avvelenato” che vi si respirava. Parole
come pietre. A un certo punto un giovane magistrato,
302
intervistato dal giornalista, disse: “Viviamo nel più alto
tasso di illegalità”. E un altro, meno giovane ma non
meno sconsolato, aggiunse: “Il tasso di corruzione ha
raggiunto in questa città indici inimmaginabili”. Dopo
quasi vent’anni dalla selvaggia esecuzione mafiosa, la
Cassazione ha confermato in via definitiva le condanne
inflitte agli esecutori: ergastolo per Nitto Santapaola e
Aldo Ercolano, sette anni “patteggiati” per Maurizio
Avola. Nulla a che vedere con le denunce televisive di
Report, tutto sommato innocue e sopportabili, che
hanno strapazzato nel marzo del 2009 l’amministrazione
municipale e il direttore de La Sicilia, Mario Ciancio, al
quale mi legano amicizia e antica riconoscenza, ma che
tale debito non può impedirmi di cogliere la
contraddizione tra il suo ruolo di direttore, e proprietario
dei mass media etnei, e quello di imprenditore. Per il
servizio di Report i suoi avvocati avevano chiesto alla
Rai una secca e ripetuta smentita nonché dieci milioni di
risarcimento danni (da devolvere in beneficenza). I
giudici di primo grado gli hanno dato torto e l’hanno
condannato alle spese legali: trentamila euro.
Di recente sono andato a rileggermi il libro di
Claudio Fava dedicato al padre. A un certo punto, con la
mente limpida e onniveggente di chi ha molto sofferto,
con amore e rabbia, egli dice: “Loro, i mafiosi, vivono
sempre di parole brevi, azioni essenziali. Noi di pensieri
troppo alti. Loro hanno imparato a conoscere e a
governare i dettagli. Noi ci siamo lasciati sedurre dalle
coreografie, dai fondali colorati. Pochi, in questi anni,
hanno compreso la geometria di quei pensieri minimi: e
sono stati puniti con la morte, tutti”. Il crimine è
manifestazione bestiale ed ha scuri fondali, l’onestà ha
quinte di colori abbaglianti perché appartiene al
ragionamento e alla giusta azione. Quale poi sia la
Giusta Azione, che può concepire nell’intimo ognuno di
noi, non è facile dire. Si potrebbe rispondere partendo
dal celebre monologo di Amleto Essere o non essere:
“… così la coscienza ci fa tutti vili, e così la tinta nativa
della risoluzione è resa malsana dalla pallida cera del
303
pensiero, e imprese di grande altezza e importanza per
questo scrupolo deviano le loro correnti e perdono il
nome di azione”. Non perdere l’Azione dunque ma
agire recuperando la giusta coscienza. Non con la
vendetta come fa Amleto, che spezza le catene del
dubbio e vendica il padre, ma con la razionalità della
denuncia. In fondo, l’azione politica e morale di Claudio
Fava mi pare una Giusta Azione. Per essa ha pagato un
altro durissimo prezzo: l’isolamento. Non riferirò le
cattiverie gratuite di molti benpensanti, che nulla nella
loro vita hanno rischiato se non qualche linea di febbre,
e i loro giudizi approssimativi e ingenerosi su un
ragazzo che chiedeva solo la verità: non la verità
filosofica, sulla quale tutti siamo pronti a concionare,
ma la verità semplice e terribile sulla morte del proprio
padre. Massacrato lui, massacrata la sorella Elena,
ragazza buona e intelligente, che era cresciuta nello
stupore del mondo ed è finita per raccoglierne il dolore.
Il libro che ho citato s’intitola Nel nome del padre
che è il titolo del bellissimo film di Jim Sheridan uscito
nel 1993 e accolto con grande favore dai critici e dal
pubblico: Orso d’oro a Berlino e David di Donatello a
Roma nel ’94. È la storia di un giovane irlandese, Jerry
Conlon, che viene accusato ingiustamente di un
attentato e condannato con prove prefabbricate. Il padre
Giuseppe fa di tutto per dimostrare l’innocenza del
figlio ma viene anche lui condannato per
favoreggiamento. I bui, dolorosi, angoscianti anni di
carcere vedono rinsaldarsi i rapporti tra padre e figlio e
segnano la parte più alta e commovente del film.
Quando il padre muore, per le dure condizioni
carcerarie, Jerry ritrova la forza di continuare a lottare
per l’innocenza del padre e quella propria. Alla fine,
grazie a un’avvocatessa, ottiene giustizia e libertà.
L’esempio di Jerry Conlon, che si batte come un leone
per ridare onore al nome del padre Giuseppe (altra
coincidenza), credo sia stato per Claudio Fava alimento
e conforto per non arrendersi di fronte al muro di
gomma e di sabbia d’una società assente e miope. La
304
vita ha strani percorsi che talvolta s’intrecciano col
cinema, spesso in un rimando continuo di riflessi e di
esperienze. Claudio Fava non poteva non intitolare
l’omaggio al suo illustre e battagliero genitore come il
film di Sheridan, Nel nome del padre, In the Name of
the Father.
Quella di Pippo Fava fu una battaglia giusta perché
aprì scenari malavitosi fino a quel momento
impensabili, perché rivoluzionò e contribuì a ripulire
l’economia d’una città basata in rilevante misura
sull’intrallazzo, su collusioni criminali, sul quieto
vivere, sulla viltà. Fu una battaglia giusta perché ci
svegliò dal letargo e ci mise di fronte alle nostre
responsabilità. Spero che la terra gli sia leggera, per
riprendere una celebre battuta di Erich Von Stroheim
ne La grande illusione di Jean Renoir, il film che il
presidente Roosevelt elogiò con queste parole: “Tutti i
democratici del mondo devono vederlo”.
“Que serà, serà/ whatever will be, will be/ the
future’s not ours to see/ que serà, serà/ what will be, will
be…” “Quel che sarà, sarà. Non ci è concesso di vedere
il futuro. Quel che sarà, sarà”. La bellissima canzone,
che magicamente, e misteriosamente, si collega a
quanto appena detto, era il marchio di fabbrica di Doris
Day. La cantava ne L’uomo che sapeva troppo di
Hitchcock, anno 1956. Non se la cavò male in quel film,
anche se lo girò col pensiero costante che il regista
l’avesse scelta come cantante e non come attrice e che al
suo posto rimpiangesse Grace Kelly, appena diventata
principessa di “sangue irreale”.
Se Lana Turner era la donna del peccato, lei era la
donna della redenzione. Antonia Bonomi ne fa un
ritratto perfetto: “Bella ma non da turbare il sonno,
moglie ideale per lui, modello per tante signorine di
buona famiglia che si vedevano padrone di casa come
lei, indaffarate e perfette, magari anche canterine e
magari con un marito bello come i suoi splendidi
partner”. Per anni il suo nome è stato garanzia di
305
successo, anche se le storie raccontate nei film erano più
o meno le stesse e lei, al centro di vaporose scenografie
e finti drammi, immancabilmente prometteva la propria
virtù soltanto a chi l’avesse sposata. Quando le
proposero la parte di Mrs. Robinson, l’amante del
giovane
“laureato”
Dustin
Hoffman,
rifiutò
scandalizzata: “Questo film offende i miei valori
morali”. Aveva una bella voce, calda e romantica. La
canzone Que serà, serà di Jay Livingston e Ray Evans
vinse l’Oscar battendo quell’altro bellissimo motivo di
Cole Porter, True love, cantanta da Bing Crosby e Grace
Kelly in Alta società di Charles Walters. Tre anni prima,
l’attrice aveva portato al successo dell’Oscar un’altra
bella canzone, Secret love di Sammy Fain. Il film è Non
sparare, baciami! di David Butler.
Fu il marito manager, Marty Melcher, a
amministrare i suoi beni e a impedirle di uscire dai
consueti ruoli caramellosi che la rendevano sì una
bambola di carne fin troppo perfetta per essere vera ma
che le assicuravano alti profitti. Quando Marty morì,
però, Doris si accorse che il marito le aveva dilapidato il
patrimonio, stimato in parecchi milioni di dollari. Una
volta soltanto, nel 1955, lasciò l’ampia gonna e i tacchi
alti, i capelli freschi di parrucchiere e il sorriso
stereotipato per entrare nella parte di una cantante degli
anni Venti, fatale e volgare, che viene strapazzata dal
gangster sciancato e crudele James Gagney. Il film,
Amami o lasciami, era firmato da Charles Vidor e prese
solo l’Oscar per la sceneggiatura. Alla cerimonia di
premiazione c’era il piccolo e cagnesco James. Dal
palco, Jerry Lewis, in veste di presentatore, lo vide e
finse di rimproverarlo: “Con Joan Crawford si può fare,
con Doris no”. Il pubblico si divertì molto. Strapazzare
Doris Day era come strapazzare l’idea stessa della
donna americana, perfetta in cucina e a letto, madre e
moglie esemplare, cotonata e sorridente, irreprensibile e
devota… anche quando il marito le mangia la dote e
magari la tradisce.
306
C’era una ragazza a Catania che in qualche modo le
assomigliava. Come Doris era bionda, come Doris
portava gonne a campana e come Doris era molto
corteggiata. Aveva una sorella più piccola e più alta,
bruna e simpatica. Se debbo misurare quelle strepitose
premesse con ciò che le accadde dopo debbo dire che il
suo futuro fu assai modesto. Si sposò con una brava
persona, credo, ma insignificante, si armò un negozietto
di oggettistica al corso Italia e forse pensò che tutto
sommato era stata fortunata. Poteva accadere che me la
sognassi di notte, e poteva accadere che me la sognassi
anche di giorno mentre viaggiavo con altri disperati alla
volta dell’Etna innevato, mentre lei, nelle prime file,
cantava con voce argentina: “Quel mazzolin di fiori…”
e gli altri rispondevano in coro: “Che vien dalla
montagna…” E poi, lei, sempre con la sua voce di
zucchero filato, continuava: “E bada ben che non si
bagna che lo voglio regalar.” Sorrideva a questo e a
quello, soprattutto a quello, che era un ragazzo alto e
scuro, con gli occhiali, che le faceva disperatamente la
corte e disperatamente finì che le strappò un bacio e una
promessa. È morto da un sacco di anni. Allora mi parve
il ragazzo più fortunato del mondo.
307
QUATTORDICI
Janet Leigh, Jeanne Crain, Anne Baxter
Si può entrare nella storia in 45 secondi? Il 45 è un
numero magico e terribile. Ci vogliono 45 secondi
perché il sodio pentotal e il cloruro di potassio facciano
il loro effetto sul corpo del condannato a morte. E 45
secondi furono calcolati perché l’Enola Gay, dopo avere
scaricato la bomba atomica, avesse il tempo di
allontanarsi dal campo della tragedia di Hiroshima. Di
solito, i messaggi pubblicitari hanno bisogno di 45
secondi per raggiungere il loro effetto persuasivo. Vedi
lo spot del Comune di Napoli contro le estorsioni (“Il
racket è un cancro che ti soffoca”) o quello anti-pirateria
rivolto soprattutto ai giovani (“Chi usa un dvd pirata è
uno sfigato”). 45 secondi durava la scena della doccia
nel film di Hitchcock, Psycho, con la quale Janet Leigh
entrò nella storia del cinema. Ecco la risposta. E se
appena rammento che la lavorazione della breve
sequenza fu realizzata in sette giorni, entriamo nel
mistero della cabala. Perché sette è il numero biblico
della creazione, sette è la cadenza dei giorni della
settimana, sette sono le grandi religioni e sette le
meraviglie del mondo… insomma, in questo numero c’è
come il moto circolare della perfezione.
Realizzata dal 17 al 23 dicembre 1959, la sequenza
dell’omicidio nel bagno consta di 70 inquadrature per le
quali Janet, come ricorda Tullio Kezich, dovette
restarsene a lungo sotto la doccia mentre i ponti dello
studio rigurgitavano di guardoni. Ma l’attrice non era
nuda. Indossava una tuta color carne con pezzi di
fustagno nelle zone proibite e per le sequenze scabrose
c’era una controfigura: la rossa ballerina Marli Renfro,
pagata 500 dollari per il disturbo. La scansione
incalzante del montaggio, il bianco e nero duro e
realistico (Hitchcock lo preferì al colore per evitare che
il rosso del sangue impressionasse troppo il pubblico),
308
le musiche di Bernard Hermann e l’urlo sconvolgente di
Janet Leigh, che muore sotto le selvagge pugnalate di
mamma Perkins, resero indimenticabile la scena. Il
“suono” delle pugnalate fu ottenuto infilzando
ripetutamente un’anguria. Dopo quei sette giorni di
incubo, durante i quali il regista s’impegnò a
spaventarla, perché entrasse meglio nella parte
dell’assassinata, l’attrice non mise più piede in una
doccia. Preferì la vasca da bagno. Il film fu un grande
successo (costo: 800mila dollari, incasso: 13 milioni di
dollari) ma fu anche un problema per la dolce e timida
Janet perché fu tempestata di telefonate di sporcaccioni
e maniaci che le promettevano di assassinarla nella
doccia. Fu costretta a rivolgersi all’FBI. Anche
Hitchcock ebbe la sua parte. Ricevette varie lettere di
protesta. La più dura fu quella di un padre infuriato
perché la propria figlia, come Janet, dopo avere visto il
film si spaventava a farsi la doccia. Era un problema
perché la ragazza da anni evitava anche di entrare nella
vasca da bagno. Diceva di avere negli occhi un’altra
scena agghiacciante: quella dell’affogato che emerge
dall’acqua nel film I diabolici. Si racconta che il regista
trovò il coraggio d’una risposta spiritosa: “Mandi sua
figlia in una lavanderia a secco.”
In Psycho, Janet è Marion Craine, una giovane donna
che ruba i soldi al principale e nella fuga si ferma in uno
sperduto motel, vicino a Phoenix, gestito da un giovane
strano e gentile. Il tempo di sistemare il bagaglio, di
entrare nella doccia… e di finire uccisa sotto i colpi
forsennati d’una figura, che resterà sconosciuta fino al
colpo di scena finale. In pratica, l’attrice entra nella
pellicola e scompare quasi subito, eppure, per la scena
della doccia, si merita una nomination all’Oscar che
purtroppo le verrà soffiato da Shirley Jones per Il figlio
di Giuda, quella stessa Jones che era stata scartata da
Hitchcock per la parte di Marion Craine.
Quarantacinque secondi, dunque, che misurano una
carriera che pure non era stata banale. Ma il pubblico la
ricorda anche per la dolcezza del suo sguardo azzurro:
309
lo sguardo di Meg in Piccole donne, il film di Mervyn
Le Roy, del 1949, in cui recita accanto a Liz Taylor,
June Allyson e Margaret O’Brien; lo sguardo di Aline
de Gavrillac in Scaramouche di George Sidney del
1952; lo sguardo di Bess nel Mago Houdini di George
Marshall del 1953, girato accanto al marito Tony Curtis.
Un matrimonio durato undici anni e allietato dalla
nascita di due figlie, che saranno d’arte: Kelly e Jamie
Lee Curtis. Anche la seconda moglie, l’attrice austriaca
Christine Kaufmann, darà a Curtis due figlie, mentre i
due figli maschi, uno morto per overdose, li avrà da
Leslie Allen. Poco prima di morire l’attore ha fatto
parlare di sé per avere rivelato, in una ennesima
biografia, che Marilyn Monroe, conosciuta e amata
durante le riprese del film A qualcuno piace caldo,
aspettava un figlio da lui e che il bambino sarebbe
morto prima di venire alla luce. A naso, sembra una
delle tante balle confezionate da Tony Curtis nella sua
carriera che s’innestavano, con molta probabilità, su
altre balle raccontate su molti suoi film.
Di Tony Curtis ricordo un episodio. Festival di
Taormina, 1986. Volevo intervistarlo per la Rai-Tv
nazionale e concordammo col suo agente l’incontro al
San Domenico, anziché nel caotico palazzo dei
congressi. Ci mettemmo in macchina: lui e l’autista in
quella fornitagli dagli organizzatori, io in quella
dell’azienda. C’erano con me, se non ricordo male,
l’operatore Giovanni Tomarchio e il suo specializzato di
ripresa. Loro avanti, noi dietro. Ma per raggiungere
l’albergo impiegammo non so quanto tempo perché
l’attore non fece nulla per starsene buono in macchina
ma da questa, anzi, continuamente si sbracciava e
sorrideva col risultato che venne bloccato e festeggiato
dalla gente a ogni svolta di strada. Indossava una giacca
di lino bianca su una camicia di seta blu e un foulard
marrone a mo’ di cravatta: un pezzo di Hollywood
chiassoso e sonoro catapultato nelle viuzze taorminesi
che pure avevano conosciuto ben altre stravaganze,
310
come quelle del pittore Ottone Géleng e del barone
Wilhelm von Glöden che Taormina inventarono e resero
famosa nel mondo.
A un certo punto, si affacciò dalla portafinestra della
propria abitazione una bella donna. Probabilmente
voleva rendersi conto di quanto stava succedendo: si
era, infatti, formata una lunga fila di auto festosamente
strombazzanti in mezzo a nugoli di ragazzine che
strillavano e chiedevano l’autografo. Vedendola, e
soppesandola con occhio d’intenditore e di incallito play
boy, fece fermare la macchina e andò a salutarla, con
calore. La donna, naturalmente, non si sottrasse
all’abbraccio e l’invitò a entrare. Solo un momento. E fu
davvero un momento perché lo strepito dei clacson e il
rumoreggiare delle persone stava trasformandosi in un
problema di ordine pubblico. Fu cordiale e spiritoso,
con quella sua faccia di eterno ragazzo, i capelli bianchi,
l’espressione a un tempo divertita e perplessa che aveva
caratterizzato molti suoi personaggi, a partire da Harry
Houdini, il grande prestigiatore al quale Sarah
Bernhardt chiese una volta se poteva farle ricrescere la
gamba amputata e la cui fama, per giudizio di Bernard
Shaw, era paragonabile a quella di Gesù Cristo. Donnamito, la vecchia Sarah, donna idolatrata da sterminate
platee di fanatici e da un giovanissimo Oscar Wilde che
quando la vide per la prima volta a Londra stese ai suoi
piedi un tappeto di gigli bianchi.
Janet Leigh sarebbe stata perfetta nella parte di
Maddalena Fumaroli, la ragazza amata da Vincenzo
Bellini quando studiava a Napoli. Un amore sfortunato:
dapprima osteggiato dal padre di lei (“non do mia figlia
a un suonatore di cembalo!”), poi declassato dallo stesso
musicista a passatempo, dopo che era stato chiamato a
più alti destini, infine spentosi dolorosamente con la
morte della ragazza. Quando scrissi per il Teatro Stabile
di Catania una commedia sulla vita di Vincenzo Bellini
il ruolo di Maddalena fu interpretato da Mariella Lo
Giudice, scelta per quel ruolo dal regista Sandro Sequi,
311
chiamato da Mario Giusti, allora direttore artistico, per
mettere in scena la mia commedia. Mariella, che la
morte troppo presto ha rapito, fu dolce, tenera, delicata.
In una parola, bravissima.
Il lavoro teatrale, rappresentato nel 1986, prima alla
sala Musco e poi al Verga, sul finire della stagione,
registrò successi di pubblico e di critica, anche se
l’amico Domenico Danzuso sul giornale La Sicilia non
sprecò gli aggettivi. Di certo, gli aggettivi li avrebbe
sprecati il drammaturgo Pippo Fava, se mani assassine
non ne avessero reciso la vita ribollente di generosità e
passione. Di certo li sprecarono i critici del TG1 e del
TG2, scesi appositamente per vedere lo spettacolo (ma
lì giocavo in casa), e quelli de La Stampa e del Corriere
della Sera. Un ottimo servizio realizzò anche il collega
Salvatore Cusimano per il TG3 Sicilia. Dopo avere visto
lo spettacolo confessò di essersi riletta la tesi di laurea
per dimostrare a se stesso di possedere strumenti
letterari adeguati. Qualche mese dopo Danzuso, sia
detto a suo onore, rimediò con un ottimo articolo,
corredato di foto di scena a colori, pubblicato sulla
rivista della Scala di Milano.
Per la parte di Bellini fu scelto un giovane attore,
Massimo Popolizio, da poco diplomatosi all’accademia
d’arte drammatica Silvio D’Amico e che aveva lavorato
con Luca Ronconi. La mia commedia gli portò fortuna,
sia sul piano sentimentale, perché si legò a un’attrice del
cast, Elisabetta Piccolomini, discendente dell’antica e
nobile famiglia senese, sia su quello professionale
perché da lì a qualche anno sarebbe diventato un attore
di primo piano, in teatro e nel cinema. Ricordo su tutti
lo spettacolo Copenaghen di Michael Frayn recitato
accanto a Giuliana Lojodice e Umberto Orsini e che ho
visto nel maggio del 2009 al Teatro Ambasciatori di
Catania. Davvero perfetto, Popolizio, nel ruolo dello
scienziato tedesco Werner Heisenberg che si rammarica,
per vanità, di non essere arrivato per primo a scoprire la
bomba atomica. Ma poi si consola pensando all’ipotesi,
non tutta peregrina, che sarebbe potuta finire in mano ai
312
nazisti. Per il ruolo di Pacini fu scritturato Maurizio
Gueli, un buon attore che per molti anni vivrà nel
ricordo di quel ruolo, mentre per quello di Giuditta
Cantù, l’altro grande amore del musicista, la scelta
cadde su Luciana Negrini (il padre e la madre di lei
furono interpretati da Enzo Tarascio e Anna Malvica).
Elisabetta Piccolomini faceva due parti: la contessa
Giuseppina Appiani e la principessa Cristina Trivulzio
di Belgioioso.
I motivi dominanti della commedia sono due: il
destino d’emigrante del musicista, che deve lasciare
Catania se vuole dare un senso al proprio talento, così
come avrebbero fatto Verga, Brancati, Aniante; e il
contrasto tra Bellini e Pacini, sulla falsariga di quello tra
Mozart e Salieri.Ecco che cosa scrivevo nella prefazione
al libro della commedia pubblicatomi dall’editore
Giuseppe Maimone: “Il concetto dell’emigrante è uno
dei fili sottili che s’intrecciano in questo Bellini in
qualche modo apparentato all’Amadeus di Peter
Schaffer che tanto successo ha ottenuto nei teatri e nei
cinema di mezzo mondo. Un filo che lega, tra l’altro, il
passato al presente e che resta un’incredibile costante
della storia cittadina catanese”. In realtà, Catania,
nonostante i secoli, è rimasta in fondo allo Stivale,
fedele alla sua marginalità storica e sociale, ancorata al
suo Ottocento borbonico e assistenzialistico. Che cosa
offriva la città a un giovane di solide e romantiche
speranze? Nel caso più fortunato, un posto di maestro di
cappella e concerti nei salotti paesani della città.
Sarebbe stato un vero peccato. Ma che cosa offre ancora
oggi, qui come in tutto il Sud, a vocazione ormai
colombiana, a chi ha talento da vendere e rifiuta di
vendersi alla politica?
Jeanne Crain, l’interprete di molte commedie
romantiche negli anni Quaranta e Cinquanta, l’attrice
che meglio d’ogni altra interpretò la figura della
“ragazza della porta accanto”, sarebbe stata un’ottima
Giuditta Cantù. La ricordo ne Il jolly è impazzito di
313
Charles Vidor, 1957, al fianco di Frank Sinatra. Il film
racconta la storia, romanzata, di Joe E. Lewis, un
cantante famoso in America negli anni Venti. Lei è
Letty Page, grande amore di Joe, che finisce con lo
sposare un altro quando il cantante, schiavo sempre più
dell’alcol, la lascia per timore di rovinarle la vita. C’è
una scena ad alta intensità drammatica. Lui è tornato
dalla guerra, guarito e deciso a ricominciare, anche se la
voce non è più la stessa. La sequenza si apre in un
locale notturno con Joe che diverte il pubblico con
battute come questa: “Io nego che i liquori siano
dannosi. Mio zio ha bevuto un quarto di whisky al
giorno per tutta la vita, e ha vissuto 28 anni”. Poi,
comincia a cantare. All the way. Un motivo struggente,
bellissimo, di Sammy Cahn e Johnny van Heusen.
“When somebody loves you/ it’s no good unless he
loves you – all the way/ happy to be near you/ when you
need someone to cheer you – all the way…” Sulla frase
“all the way” la voce si sgrana e lei, Letty Page, venuta
a ascoltarlo col marito, trema di commozione. Lui la
vede, si ferma smarrito, trova la forza di continuare…
“Taller than the tallest treee is/ that’s…” ma non ce la
fa, si blocca di nuovo. Lei con gli occhi pieni di lacrime
non resiste, si alza e va via. E il pubblico del cinema
Spadaro quella volta tirò fuori i fazzoletti. Nella
particina di un faccendiere, obeso, calvo, ripugnante, c’è
Jackie Coogan, il delizioso bambino che tirava sassi ai
vetri ne Il monello di Charlie Chaplin, e che al grande
Peppino Marotta avrebbe ispirato questa indimenticabile
frase: “Vieni qui, Tempo, ho una rosa e una coltellata
per te”.
Undici anni prima Jeanne Crain era stata Margie,
nell’omonimo film di Henry King. Interpretava due
ruoli: quello della madre, che racconta alla figlia Joyce
la propria giovinezza; e quello di lei ragazza ribelle, che
perde sempre le mutandine (come negli spiritosi disegni
delle pin-ups di Art Frahm) e s’innamora
dell’insegnante di francese. Un personaggio fresco,
allegro, in linea con la morale del tempo, grazie al quale
314
diventerà la fidanzatina ideale degli adolescenti
americani. Le sono accanto Ann Todd, nella parte di
Joyce, che il pubblico ricorderà nel film Intermezzo (era
la piccola allieva di Ingrid Bergman, nonché figlia di
Leslie Howard), e la bellissima Lynn Bari. Questa
attrice, che si chiamava Margaret Schuyler Fisher, un
giorno, durante la lavorazione del film Shock di Alfred
Werkel, con Vincent Price, si vantò con la collega
Anabel Shaw di discendere, per parte di madre, dal
famoso eroe di guerra Alexander Hamilton. Al che
Anabel, battuta per battuta, replicò che anche lei aveva
un antenato famoso: Aaron Burr, l’uomo che uccise
Hamilton in duello.
I film migliori di Jeanne Crain sono antecedenti a Il
jolly è impazzito. Nel 1949 gira tre film: Pinky, la negra
bianca di Elia Kazan (una nomination), Il ventaglio di
Otto Preminger e il delizioso Lettera a tre mogli di
Joseph Mankiewicz che la dirigerà nel 1951 anche in La
gente mormora. Tra un film e l’altro troverà il tempo di
fare sette figli, quattro maschi e tre femmine, con Paul
Brooks con quale stipulerà un accordo formale di
“divorzio interlocutorio” in base al quale ciascuno dei
due riconosceva di essere stato infedele. Undici anni
dopo quel bizzarro contratto faranno pace, e resteranno
insieme fino alla fine. Il primo e l’ultimo dei figli,
Michael e Christopher, moriranno prima di loro.
La commedia mi fruttò la Giara d’argento, che non
volevo, ma l’organizzatore Alfio Di Maria si mise
talmente a lima sorda che fui costretto ad accettare. Me
la consegnò Pippo Baudo, nel corso d’una cerimonia in
un albergo di Giardini Naxos. Fu molto carino ed io
molto laconico. In quel momento il cervello mi stava
fumando dalle orecchie e non capivo niente.
Il 25 novembre del 2006, invitato a un convegno su
Bellini, organizzato nel foyer del Teatro Massimo
dall’assessorato alla cultura di Catania, ricordai il
ritorno del musicista siciliano nella città natale avvenuto
il 2 marzo del 1832, tre anni prima di morire. Se n’era
315
andato a diciotto anni, con una borsa di studio del
Decurionato etneo, per iscriversi al reale collegio di
musica San Sebastiano di Napoli e apprendere ciò che il
nonno e il padre, musicisti anche loro, non potevano più
insegnargli. Rientra dunque nella sua città dopo tredici
anni, amato e ammirato in Italia e in Europa per avere
scritto capolavori immortali come Il pirata, La
sonnambula, Norma. Ed è un trionfo per ciò che la città
riesce a accroccare nell’eterna limitatezza dei mezzi. Il
soggiorno si protrae per oltre un mese e durante questo
periodo i salotti cittadini se lo contendono per curiosità
e orgoglio, per sentirsi idealmente vicini alla grandezza
di un uomo che avevano visto crescere e magari ne
avevano criticato la povertà ma che adesso innalzano
senza sforzo sui loro modesti altari pensando che un
poco di quella gloria appartenga anche a loro, quanto
meno per diritto di cittadinanza.
La città, al solito, è disorganizzata. Se a Messina il
musicista è stato festeggiato con una dignitosa
rappresentazione de Il pirata al teatro La Munizione, a
Catania non si riesce a trovare una compagnia di canto
che si faccia onore. La ragione è semplice: la stagione
lirica, quell’anno, è stata annullata per mancanza di un
direttore artistico. Quello che c’era, Pietro Antonio
Coppola, se n’è andato, stanco della provincia e magari
del facile applauso. Che cosa fa allora il comitato dei
festeggiamenti? Prende una via traversa. Organizza al
teatro comunale una rappresentazione di un dramma a
forti tinte, Atreo, scritto da un avvocato, un certo
Gioacchino Fernandez, con il recondito scopo di
convincere Bellini a musicarlo. L’omaggio musicale è
previsto di sguincio, tra un atto e l’altro. Lo storico di
queste giornate belliniane che sanno di strapaese, il
Menza, non lo dice, ma il musicista si sarà annoiato
mortalmente e di certo si sarà fatto confortare dal
ricordo della bella amante, Giuditta Cantù, lasciata a
Napoli per l’occhio sociale. Giuditta era sposata e non
poteva accompagnare lo scapolo musicista nella Catania
del 1832. Per la verità, lei avrebbe voluto ma Bellini,
316
che già pensava alla madre e al padre, ai fratelli e agli
amici, agli ambienti clericali, aristocratici e borghesi,
che certo non brillavano per ampiezza di vedute, si
oppose risolutamente.
Alcuni giorni dopo, in municipio, le più alte autorità
cittadine lo subissano di discorsi lunghi, appassionati e
sconclusionati, più per mettere in mostra se stesse che
per lodare l’ospite. L’unico discorso serio, a giudizio di
Francesco Pastura, lo fa a nome dell’università il prof.
Mario Musumeci che però ha l’imprudenza di
preannunciare il conio d’una medaglia d’oro a ricordo
della storica visita, da donare a Bellini. Il Decurionato
se ne dimentica e il musicista ci rimane molto male.
Nei salotti catanesi si parla di musica, ovviamente, di
donne, di sovrani e di principi, ma si parla anche
dell’isola Ferdinandea sorta come per incanto al largo
del mare di Sciacca e sprofondata dopo appena cinque
mesi, lasciando di stucco le tre grandi potenze (Francia,
Inghilterra e Regno delle due Sicilie) che ne avevano
conteso il dominio. L’isola, in realtà un piccolo vulcano
in eruzione, che adesso giace spento a pochi metri
sott’acqua, era emersa il 5 luglio dell’anno prima e si
era inabissata in dicembre. Dunque, la notizia è ancora
fresca e i particolari certo impressionano Bellini che è
superstizioso. Lui, che si definisce “un isolano isolato”,
vede come un sinistro presagio quell’isola che sorge e
sprofonda, un’isola che non c’è più, un’isola (la Sicilia)
che forse non tornerà più a rivedere. Noi che sappiamo
la storia, per facile sapienza di posteri, possiamo dire
che quel presagio si rivelò esatto e funesto.
Bellini non è solo la sua musica. Certo, è soprattutto
questo: melodia, canto, impegno, sapienza… per cui i
catanesi doc ogni volta che ne parlano lo immortalano
con questo concetto. “A chissu ci ’a ponu annacari”
(non traduco, ma nella sua volgarità è un complimento).
Tuttavia Bellini è anche la sua vita, la sua fine, le sue
donne, le sue manie. Nel gilè teneva un corno di corallo
che toccava continuamente. Lo tormentò, fino a non
sentirlo più tra le dita, quando il poeta tedesco Heine per
317
cieca gelosia gli preannunciò una morte prematura. “I
geni muoiono presto”, disse “e voi, non c’è dubbio, siete
un genio!” Alcune settimane dopo il musicista si spegne
in perfetta solitudine, sprofonda, è il caso di dirlo, in
quella sorta di isola periferica che allora era Puteaux, un
sobborgo di Parigi dove adesso sorge il moderno
quartiere Défense. Sprofonda vicino alla Senna, come
l’isola Ferdinandea: un pezzo di terra che s’inabissa
nell’anonimia del mare, misterioso e fragile, quasi fosse
un’apparizione, come in fondo era stata la vita di
Vincenzo Bellini.
Bellini tornò per sempre nella sua città natale
quarantaquattro anni dopo, coi piedi in avanti e con tutte
le sue opere, che includevano naturalmente Beatrice di
Tenda e I puritani scritte tra il 1833 e il 1835 anno della
morte. A leggere le cronache di Antonino Amore sulla
traslazione del feretro del musicista dal cimitero Père
Lachaise alla cattedrale di Catania si ha il segno preciso
dell’idolatria del popolo catanese per Bellini. Ma le
onoranze funebri furono grandiose non solo perché si
dava finalmente degna sepoltura a un figlio illustre ma
perché si rimediava a una sorta di rimorso collettivo. La
notizia della morte del musicista era arrivata in città
come una frustata. Incredibile, dolorosa, annichilente.
La gente s’immaginava il suo Vincenzo tra le braccia
delle sue dame, cosa che ai catanesi fa sempre piacere,
lo credeva nell’applauso del pubblico europeo, nei
salotti che contano, immerso nel lusso, nella ricchezza e
nell’ammirazione. L’avere saputo che era spirato in
perfetta solitudine, vegliato da un giardiniere, mentre i
padroni di casa se n’erano fuggiti a rotta di collo, forse
temendo un contagio di colera, li fece sentire di pezza.
Come se avessero potuto ritessere il filo del suo destino,
ancorarlo magari alla loro sana mediocrità per non
vederlo spezzarsi. Ancora oggi se parlate con le persone
minute, quelle che più lo amano, magari non
conoscendo perfettamente le sue opere, vi diranno:
“Povero figlio!”
E povero figlio potrebbero dire i critici più esigenti
318
quando vedono le opere del maestro rappresentate quasi
sempre da compagnie mediocri, a volte nemmeno
dignitose, quando Bellini, nella sua città, meriterebbe il
meglio del meglio. Il meglio mondiale, cioè, il meglio
che offre la piazza. Ma si dice sempre che non ci sono
soldi, che lo Stato è avaro, la Regione pure e il Comune
anche. E non parliamo dei privati. Ben sapendo che si fa
grandemente torto a un musicista che aveva una
preoccupazione maniacale per l’esecuzione delle sue
opere, pretendeva che venissero interpretate dai migliori
artisti perché lui quei drammi li aveva scritti su alte e
impegnative tonalità. Le opere di Bellini sono difficili
perché si basano più sulla voce che sullo strumento, e se
i cantanti non hanno ugole d’acciaio e morbidezza di
colori è meglio non metterle in scena.
Ora, considerato che i soldi sono sempre pochi, che
pubblico e privato sono santi che non sudano, né
probabilmente si può indurli a sudare, non sarebbe più
onesto mettere in cartellone una sola opera belliniana e
farne un evento mondiale, anziché vivere di rimessa,
accontentarsi delle briciole, allestire stagioni altisonanti
di nome e scarse di contenuto? Se proprio si vuole
allestire un cartellone canonico, con le classiche opere
di repertorio, qualche novità come Il sasso pagano (m’è
rimasto in mente e non l’ho più scordato: una noia
immortale)… se proprio si deve fare, se proprio
dobbiamo accontentare i patiti del balletto, del “Vesti la
giubba”, di “Quella pira”, di “Una furtiva lacrima”, del
“Coro muto” e di “Un filo di fumo”, allora bisogna
anche qui avere il coraggio di rompere col passato, con
il finto impegno, con le scelte comode e senza rischio.
Occorrerebbe cioè affidare le opere di repertorio ai
giovani, a quelli ancora freschi di studio, andare in giro
per i conservatori di mezzo mondo e scritturare le voci
più promettenti, allestire un cartellone soltanto per loro.
Qualcuno prenderà una stecca o non avrà il fiato
sufficiente? Pazienza. Sono giovani. Lo sappiamo. E lo
diciamo. Ma investiamo su di loro, non sui finti
professionisti, non su quelli che sembrano e non sono.
319
Anziché mettere in scena una Traviata che ci trafigge il
cuore all’acuto del solito soprano di serie C, che con
mestiere cerca di mascherare la propria incapacità,
lasciamo che sia la giovane esordiente a farci sorridere,
e magari potrebbe accadere che l’applauso di
incoraggiamento si trasformi in ovazione. E invece no.
Le novità che si imbastiscono sono goliardiche più che
culturali.
Durante il carnevale del 2008 il sovrintendente di
fresca nomina, Antonio Fiumefreddo, trasformò il teatro
in sala da ballo per il divertimento di alcune centinaia di
sfaccendati. Catania stava affondando nei debiti, strade
e piazze erano al buio, la disoccupazione si mangiava le
cronache locali e l’avvocato Fiumefreddo, messo a quel
posto perché da ragazzo suo padre lo portava ad
assistere agli spettacoli lirici, si fece venire la bella
pensata di organizzare un ballo in maschera per
rincuorare la città. Un anno dopo, stanco (con qualche
motivo) degli storici ostruzionismi in seno al teatro,
minacciò di dimettersi, più volte. Alla fine, visto che
nulla cambiava e con un rosso di bilancio preoccupante,
trasformò le dimissioni “revocabili”, in verità piuttosto
comiche per il loro imbarazzante numero, in dimissioni
“irrevocabili”. Per pentirsene, però, subito dopo. Il
sindaco Stancanelli, irritato e indispettito per quella
mancanza di serietà, mise fine alla telenovela. Cambiò
le chiavi dell’ufficio e proibì all’ex sovrintendente di
avvicinarsi. Storia finita si dirà. Macché. Fiumefreddo,
politicamente sostenuto in un primo momento dal
dominus Lombardo, ricorse al Tar che gli diede ragione
rimettendolo in sella ma con ciò provocando l’ira degli
orchestrali, tacciati di “mafiosità”, che hanno protestato
e reso impossibile la vita del teatro. Alla fine,
Fiumefreddo s’è convinto a lasciare.
La provincia è la nostra dimensione, la provincia
dove tutto è semplice e senza rischi, dove le porte si
aprono con qualche pubblicità ben piazzata e nessun
critico si azzarda a parlare o scrivere male di uno
spettacolo. E siamo al concetto di prima. Tutto è bello e
320
magnifico. Perché siamo tutti amici, perché più o meno
direttamente ci guadagniamo qualcosa, perché ci
dispiace, perché la provincia ci opprime con le sue leggi
sociali. Noi ce la cantiamo e noi ce la suoniamo. A
volte, sembriamo tanti bambini che si mettono di fronte
allo specchio e si dicono le bugie per non affrontare la
realtà. Catania assomiglia a una città di orecchianti e di
lamentatori. Nessuno che stia al posto giusto, nessuno
che faccia il lavoro per il quale abbia le competenze.
Siamo una città di vanagloriosi e di pettegoli. Non
rispettiamo i figli che abbiamo ma solo quelli che
trovano rispetto altrove. Beninteso, sempre che questo
non costi nulla, non costi cioè più dei sorrisi e delle
belle parole, non costi nulla alla politica e ai suoi
maneggi.
Il 1876 non è solo l’anno della traslazione del corpo
di Bellini è anche l’anno dell’inchiesta sulla Sicilia di
Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino. Erano trascorsi
appena quindici anni dall’unità d’Italia e i due inviati
del governo videro una terra bellissima, di fiori e di
frutti, ma anche una terra di mistero. Nel momento del
massimo orgoglio cittadino, proprio quando l’isola
festeggiava il rientro dell’amato artista nella città natale,
la miseria, il degrado sociale, la delinquenza, la
corruzione costituivano il reale sostrato della società, al
di là delle sue feste e delle sue luminarie. Forse da quel
tempo lontano la Sicilia è diventata metafora dell’isola
Ferdinandea, l’isola che sorge e sprofonda, l’isola che
non c’è più. Isole che sorgono e scompaiono, dunque,
isole che si legano tra di loro, isole vicine e lontane.
ISOLE.
Nell’estate del 1925 il futuro premio Nobel della
letteratura, Halldòr Kiljan Laxness, venne in vacanza a
Taormina. Aveva ventitre anni e un acuto desiderio di
conoscere l’altra faccia dell’Islanda, la faccia assolata e
povera della Sicilia, l’isola del sole, l’isola che dalla sua
fredda patria egli vedeva come la terra del mito, la terra
di Ulisse e del ciclope Polifemo, di Aci e Galatea, di
321
Aretusa e della Fata Morgana. Scese alla pensione Riis,
a due passi da corso Umberto, e misurò l’orizzonte del
caldo mare di Naxos con quello del Nord Atlantico, al
confine del Circolo polare artico. E pensò che non ci
fosse poi tanta differenza.
In fondo: due isole, due difficoltà, forse un destino
comune. Il pensiero gli si radicò nella mente quando
entrò in contatto con la cultura siciliana, quando, con
ogni probabilità, conobbe i romanzi di Giovanni Verga,
da poco scomparso, che aveva raccontato il dolore del
mondo facendone un’epica immortale. E il giovane
Laxness, che voleva diventare un grande romanziere
anche lui, in poco meno di un anno imparò, cantando, la
lingua italiana ed entrò in sintonia con gli uomini di
mare e quelli di terra dello scrittore verista siciliano.
Quella gente era maledettamente simile alla sua: uguale
la miseria, uguali le privazioni e le speranze, l’orgoglio
e la cocciutaggine, la volontà indomita di sopravvivere
alle avversità. Quando tornò in patria definì il suo
destino di scrittore. Scrisse Salka Valka, che può essere
avvicinato a I Malavoglia, alla vita oscura e miserabile
dei pescatori di Trezza; e scrisse Gente indipendente il
cui protagonista, il contadino Bjartur di Sumarhús, ha la
stessa cieca ostinazione di Mastro-don Gesualdo.
Questa idea mi ha accompagnato fino a Reykjavik, la
capitale d’Islanda, dove nel maggio del 2007 sono
andato a raccogliere un antico sogno, il sogno bambino
di vedere le balene e gli uomini aggrappati a quello
scoglio ancora più lontano dell’immaginazione, di
camminare sul ghiacciaio più grande d’Europa e di
ammirare i fiumi che scorrono moltiplicati all’infinito,
di tuffarmi nelle calde acque della Laguna Blu e da lì
godermi la visione del freddo. Ma tutte queste cose non
ho visto e non ho fatto. Eppure, ho attraversato lo stesso
la mia infanzia. L’Islanda è come l’Etna alle alte quote.
La sabbia nera che si distende nelle periferie della
capitale è la sabbia dei vulcani spenti di Nicolosi e di
Linguaglossa, le fumarole di Strokkur sono come i
nostri hornitos che sprigionano vapore e zolfo alla base
322
del cratere centrale, la vegetazione stenta assomiglia ai
licheni di quota duemila, e il vento, il vento ossessivo
che pettina la neve eterna di Vatnajökull e penetra nelle
ossa, è il vento che flagella la nostra inquieta Montagna.
E la gente? Com’è la gente di quest’isola di
ghiaccio? È come ce la descrive Laxness? Forse sì, a
patto che prendiamo per buone della nostra gente anche
le descrizioni di Verga. Due popoli forti, senza dubbio,
temprati lassù dal gelo e dal mare in burrasca e quaggiù
dal sole che spacca le pietre e dallo scirocco che non
redime. Lassù una volta c’erano le famiglie povere di
Oseyri, nel fiordo nebbioso di Axlar, e quelle della
brughiera di Gunnvör; quaggiù c’erano le famiglie dei
pescatori di Trezza, sferzate dalla miseria e dalla
sfortuna, e quelle delle campagne di Vizzini,
condannate al duro lavoro dei campi, senza speranza di
migliorare, senza speranza comunque. Eppure, se
dovessimo paragonare il cammino di quelle famiglie,
distribuite in paralleli così distanti, affacciarci all’oggi,
ai pronipoti, diremmo che no, non siamo proprio uguali.
Siamo partiti dalla stessa povertà è vero ma siamo
approdati su lidi diversi. Come se il freddo lassù avesse
tracciato, come dire?, la linea del tulipano e qui, da noi,
fossimo rimasti inchiodati alla linea irredimibile della
palma, secondo la definizione di Leonardo Sciascia.
Tutto ciò che vive al di là di quel fiore olandese
s’innerva di solitudine e di freddo, ma esprime una
ricchezza e una civiltà che noi del Sud profondo certo
invidiamo, forse perché la Sicilia ha conosciuto la
complessità del barocco e l’Islanda la semplicità delle
lamiere di ferro ondulato che ricoprono le sue case di
legno. Noi, per approdare a una faticosa modernità,
abbiamo impiegato secoli di dottrina; loro sono
piombati nel benessere in cinquant’anni, grazie alla
geotermia e al fatto che tutti insieme non raggiungono la
popolazione di Catania. Alla domanda se nell’isola non
facesse troppo freddo per vivere felici, una volta lo
scrittore Thor Vilhjalmsson rispose: “Noi islandesi
abbiamo la fortuna di camminare con i piedi al caldo:
323
sotto la terra scorre il fuoco… mentre la corrente del
golfo addolcisce il clima”.
A girarla, l’Islanda, ti serra il cuore per la luce
accanita che in primavera s’attarda fino alle soglie della
notte che non è mai notte, solo un chiarore stanco, e per
il vento che s’alza dal mare e dalla terra e non ha
scrupoli di un povero siciliano che s’incammina per le
stradine colorate della capitale imbacuccato come nel
film Totò, Peppino e la malafemmina mentre i ragazzi
girano in maglietta. Ti serra il cuore e ti ammalia
quando scendi fino a Selfoss e visiti il villaggio di
Stokkseyri dove agli inizi dell’Ottocento visse Thurídur
Einarsdottír, una donna che per tutta la vita lavorò nei
pescherecci e fu processata perché indossava abiti
maschili, allora proibiti. Ed è a questa donna ribelle che
Laxnesss’ispirò per il magnifico personaggio di Salka
Valka. E la immaginò scrutare la burrasca dal piccolo
molo insicuro come le donne dei pescatori di Trezza, le
donne de La terra trema di Visconti, e le diede una casa
angusta, come la casa del Nespolo, e le diede anche un
sogno, il sogno di padre ‘Ntoni che s’azzardò a ribellarsi
al destino e finì col perdere la barca e un figlio. Se
appena t’inoltri nei campi di lava, fin sotto i ghiacciai,
nella brughiera, dove ora sorgono efficienti solitarie
fattorie, vedi nel fumetto che ti sei disegnato nella
mente leggendo Gente indipendente i contadini di
Laxness, la gente che nasce e muore mangiando pesce
di scarto, allevando pecore in cambio di un’assurda idea
di speranza, come i contadini di Verga, mentre la
piccola borghesia si arricchisce scremando quella
squallida miseria. E mai come in questa somiglianza di
dolore vedi un solido legame tra le due isole.
Ma la vera anima dell’Islanda, l’anima vichinga che
la possiede, si trova nel parco nazionale di Þingvellir,
nella parte più fantastica e terribile dell’isola, al confine
tra la zolla europea e quella nordamericana. Lì nel
lontanissimo 930, quando l’Europa era in preda
all’intolleranza più cieca, sorse l’Alþing, l’assemblea
nazionale islandese, considerata dagli storici il primo
324
parlamento al mondo. Un’assemblea all’aperto dove si
varavano le leggi, si componevano le dispute legali e si
facevano affari. Questa era, questa è, l’Islanda del
merluzzo e delle balene, delle aringhe e dei pulcinella di
mare, l’isola della discussione e dell’orgoglio, l’isola
che non c’è per tutti i paralleli dove si producono più
discariche illegali che idee. Il ricordo che ti porti
lasciando questo Paese straordinario, pulito come l’aria
che vi si respira, più caldo del suo clima, meno austero
di quanto farebbero supporre i suoi panorami terribili e
profondi, è una sorta di rinnovamento, e ritrovamento,
dello spirito. Un ricordo e due immagini che si saldano
alla nostra storia siciliana, anch’essa magnifica e antica:
l’immagine di un pescatore, nella cui faccia puoi
leggere la fatica e la bellezza della vita, e l’immagine di
un contadino-pastore che a schiena curva conduce il suo
gregge alla capanna. In simboli come questi ho ritrovato
la mia cara, amata, anche se talvolta intollerabile,
Sicilia. Terra impareggiabile la giudicò Halldòr Laxness
che dal suo alberghetto taorminese poteva
tranquillamente ammirare la maestà dell’Etna, le sue
nevi e il suo lento ribollire, e affermare che quello
spettacolo era anche un pezzo della sua patria lontana.
Ma è tempo di tornare alle mie dive.
Dicevo poco fa della Giara d’argento che mi fu
consegnata a Giardini. In quella cittadina, una
quindicina d’anni prima, avevo condotto per il mio
giornale un’inchiesta sullo scempio edilizio portato
avanti da una giunta comunale corrotta e meschina. Mi
ricordo che in una notte furono approvate oltre 500
licenze edilizie, nemmeno il tempo di dare una scorsa ai
documenti. Il litorale di Naxos, l’antico insediamento
greco, un posto di una bellezza incomparabile, fu
deturpato orribilmente: decine di condomìni vennero
costruiti sul demanio e le strade tracciate secondo criteri
nemmeno borbonici. Niente fognature, niente spazi
verdi, niente di niente. Pura speculazione, puro
vergognoso arricchimento. L’articolo fece scalpore.
325
Qualche giorno dopo, mentre mi trovavo in un ristorante
del golfo di Giardini, assieme al corrispondente locale,
Giuseppe Di Bernardo, oggi purtroppo scomparso, fui
avvicinato dall’ex sindaco della città, tra i responsabili
dello scempio. Dapprima fu cortese poi se ne uscì con
questa frase: “Ma a lei nessuno mai ha promesso una
bella legnata?” Per la verità disse: “‘Na bedda sugghiata
di vastunati”. Avrei potuto denunciarlo. Ma mi fece
pena. La cosa che non mi aveva perdonato non era tanto
l’accusa di avere contribuito a rovinare un intero litorale
quanto quella di avere scritto che i libri della sua
biblioteca erano più o meno chiusi nel cellophane, e
quindi non letti. Passava per l’intellettuale del paese.
Quell’orrendo grumo di palazzi, ville e alberghi
diventerà una sorta di Los Angeles dei poveri, secondo
il giudizio dell’amico Vittorio Corona, allora direttore di
Moda e King, morto qualche anno fa a Milano. Di lui ci
restano il talento, un’urna cineraria e il dolore della
moglie e dei tre figli maschi che lui definiva “i miei
moschettieri”. Orrendo grumo urbanistico, dunque. Se il
grande architetto americano Frank Lloyd Wright
l’avesse visto lo avrebbe definito un immondezzaio.
L’architettura ideale di Wright, detta “organica”, era
tagliata su misura per l’uomo, pratica ed essenziale;
doveva essere disegnata per l’individuo e crescere
attorno a lui come se fosse il suo corpo. A Giardini
Naxos di “organico” c’erano solo i rifiuti urbani che
trovavano allegramente la via del mare, nell’ampia
distesa marina dove i proprietari dei nuovi condomini di
sabbia andavano tranquillamente a fare il bagno.
Frank Lloyd Wright, forse il più grande architetto del
Novecento, era il nonno di Anne Baxter, l’attrice che il
critico Andrew Sarris giudicò una di quelle donne che
brillano d’una luce speciale dalla mezzanotte alle cinque
del mattino. Se dovessi definirla con un’espressione
siciliana direi che Anne Baxter, con quel suo viso
angelico e con quei suoi occhi freddi era la tipica donna
che allunga la gamba per far ruzzolare l’avversario dalle
326
scale e prontamente la ritira; poi magari si precipita a
soccorrere la vittima. Del resto, in Eva contro Eva di
Joseph Mankiewicz, del 1950, è ciò che fa a Bette
Davis. Allunga la gamba per mettere fuori
combattimento la grande diva che pure l’ha accolta con
fiducia e lanciata nel mondo del teatro. Grande attrice,
Anne Baxter. È grande in Il filo del rasoio di Edmund
Goulding (1946), col quale ottiene il suo primo Oscar
come attrice non protagonista; è grande in L’orgoglio
degli Amberson di Orson Welles (1942); è grande in Io
confesso di Hitchcock (1953)… fino a quando non se ne
va col secondo marito, Randolph Galt, ad allevare
bestiame in una landa desolata dell’Australia. Poi torna.
Qualche film, qualche lavoro in TV, una vita di madre,
una vita noiosa, una vita da reduce del cinema. Ha avuto
tre figlie: la prima, Katrina, dal primo marito, l’attore
John Hodiak; le altre due, Melissa e Marginel, da Galt.
Katrina, dopo qualche esperienza nel cinema, si è
ritirata e vive felicemente col marito e i figli. Melissa
sta ad Atlanta e fa la disegnatrice di interni, l’unica che
in qualche modo ha cercato di seguire le orme del
bisnonno. Marginel è una suora cattolica e vive a Roma.
Anne Baxter è morta nel 1985 a New York per
aneurisma cerebrale. Aveva sessantadue anni.
Quale ruolo avrebbe potuto ricoprire Anne Baxter
nella mia commedia? Continuando il gioco, avrebbe
potuto essere madame Olivier, che sulla scena siciliana
ebbe il volto e la parola di Berta Ceglie. Madame
Olivier era la compagna del faccendiere ebreo Lewis
nella cui casa d’affitto Bellini trascorse gli ultimi mesi
di vita. Una coppia d’imbroglioni, madame e mister
Lewis, che misero nel sacco il povero musicista
fregandogli i soldi e lasciandolo morire come un
disperato. Nessun rimorso ebbe madame Olivier, che
pure tante volte era scivolata nel suo letto, ad
abbandonarlo quando immaginò che stesse morendo di
colera. Anne Baxter avrebbe dato alla signora Olivier,
dal passato poco rispettabile, un diverso e più profondo
spessore, oltre all’ambiguità e all’insospettabile
327
ipocrisia che l’attrice aveva
magnificamente
sperimentato nel ruolo di Eva Harrington nel già citato
film di Mankiewicz.
Fu un momento magico quello del mio debutto
teatrale. Per circa il mese e mezzo di rappresentazioni
vissi una felice stagione di autostima, che fino allora
non conoscevo, e che raramente avrei provato in
seguito. Mio padre ne sarebbe stato felice. Avrebbe
avuto finalmente la prova provata che suo figlio era ciò
che lui pensava, un figlio speciale, un figlio di cui
andare fieri. In verità, ero solo un figlio attento, un
figlio che ha preso la vita sul serio, senza concedersi un
momento di trasgressione, di follia. Uno cheha lavorato,
insomma, e che forse avrebbe dovuto impegnarsi ancora
di più. Di certo, mio padre sarebbe stato contento del
mio trasferimento al TG1, nel telegiornale più visto e
autorevole del Paese, e si sarebbe commosso nel vedere
i miei servizi, nell’ascoltare la mia voce che tanto gli
assomigliava. Avrebbe pensato alla sua solitaria
esperienza romana alla Icar Leo, una grossa industria
farmaceutica di proprietà del conte Auletta Armenise, e
ai suoi vagabondaggi nelle chiese di Roma e nelle
redazioni dei giornali per fare leggere ai critici letterari
le mie poesie. Fu lui ad aprirmi le porte del giornalismo.
Un suo vecchio amico e collaboratore, Andrea Avondo,
conosceva il caporedattore de La Sicilia, Piero
Corigliano. Un giorno di febbraio del 1963 andarono a
parlargli e mio padre si portò appresso un paio di
poesie. Corigliano le lesse, le giudicò degne di
pubblicazione e mi mise alla prova, come critico
televisivo. Era una figura professionale nuova, quella,
che cominciava a fare capolino nei giornali nazionali.
Dopo tre mesi di “compiti” pubblicò il mio primo
articolo. Ogni tanto vado a trovarlo il vecchio Piero. Ha
94 anni ed è lucido come un tempo. Una memoria
d’elefante. Parliamo del giornale, parliamo di mio padre
e del suo amico, prematuramente scomparso, Andrea,
che era un pezzo d’uomo alto un metro e 96 e per
spostarsi in città usava una Fiat Cinquecento. Quando
328
apriva lo sportello e faticosamente usciva dall’abitacolo
la gente si fermava a guardarlo e gli domandava
immancabilmente: “Nisciu tuttu?” Piero Corigliano
talvolta l’ospitava a casa sua ma era costretto a
allungargli il letto con uno strapuntino.
Povero caro papà. Fu un uomo intelligente e onesto,
un genitore amorevole e nobile, comprensivo e
moderno. Se avesse potuto mi avrebbe mandato a
studiare in Inghilterra (oltre quarant’anni fa!) dove
hanno studiato i miei nipoti, Francesco (medicina) e
Giuseppe (scienze politiche, alla London School of
Economics), figli d’una sorella di mia moglie, Rosanna,
che dal febbraio 2006 al maggio 2010 ha diretto
l’ambasciata italiana a Oslo. Spesso mi trovo a
passeggiare per le strade di Catania con gli occhi e i
passi di mio padre. E se c’è il sole mi ricordo le sue
parole: “Fuori è una bella giornata”. Me lo diceva la
mattina, verso le dieci, portandomi il caffè a letto. Prima
di quell’ora la casa si autosospendeva d’ogni attività e
rumore. Di solito, rientravo dal giornale a notte fonda.
Trovavo la cena pronta e, se c’era da scaldare la
minestra, i fiammiferi sopra il coperchio della pentola:
amorevole suggerimento e sprone per la mia lagnusia.
Anche la frutta trovavo sbucciata. Talvolta lui si alzava,
dava una scorsa al giornale, che portavo fresco di
stampa, scambiavamo qualche parola e se ne tornava a
dormire. Ricordando questi particolari inesprimibile
oggi è la commozione.
A mio padre ho dedicato Il vulcano spento, una
storia d’amore ambientata nella Catania del dopoguerra.
A mio padre e alla mia famiglia. Doverosamente e
amorevolmente anche a mia moglie. Direi che quel
romanzo è una sorta di “assaggio” di questo libro.
Scrivendone su La Sicilia, Sergio Sciacca mi ha definito
“giornalista di rango e scrittore di stile”. Ma, di là degli
elogi, Sciacca mostra di avere colto il significato del
romanzo laddove mette a confronto l’ieri con l’oggi.
“Cosa manca a questi nostri anni”, si domanda il
recensore “che c’era nei poverissimi anni ’50 e nei
329
poveri ma belli anni ’60? La consapevolezza dei ruoli.
Allora c’erano i padri che sapevano agire e parlare con i
figli. Erano la loro guida ideale. I ragazzi vedevano nei
padri chi sapeva intervenire nella vita. Oggi i padri sono
esitanti e sanno di esserlo”. Perfetto. E perfette, e
profetiche per ciò che scrivo in questo Orologio di
celluloide, sono state le parole di Salvatore Scalia sullo
stesso giornale: “Il racconto risente fortemente della
passione di Isgrò per il cinema e i personaggi
cinematografici, che sono un filtro attraverso cui egli è
abituato a osservare il mondo e le marionette che in esso
agiscono, in un’osmosi che va dalla strada allo schermo
e viceversa”.
Di recente Il vulcano spento è stato ripubblicato da
un’altra casa editrice, l’Arkadia, con un diverso titolo,
La bambina francese, e l’aggiunta d’una quarta parte. È
un libro che amo molto e che nella nuova versione e
veste editoriale ha trovato un migliore equilibrio.
330
QUINDICI
Grace Kelly, Audrey Hepburn
Nella tarda serata del 25 luglio 1956 Gastone Biffoli,
giovane ventenne in viaggio verso il sogno americano,
bussò alla cabina di una gentile dama, che aveva
conosciuto e corteggiato durante la traversata da
Genova a New York. La mattina dopo sarebbe arrivato a
destinazione e dunque quello era il momento giusto, se
voleva dare un senso a quell’amore sbocciato
all’improvviso nel lusso e nella noia della crociera. La
porta si aprì e Gastone diede fondo al suo desiderio o,
almeno, immagino che lo fece, dal momento che sul
particolare egli signorilmente sorvola, così pure sul
nome della donna. Raccontando l’episodio, dopo mezzo
secolo, ci fa sapere che all’improvviso gli oggetti del
comodino si diedero appuntamento sul pavimento e la
cabina cominciò a oscillare. Nella foga dell’amplesso
non avevano sentito, lui e la graziosa signora o
signorina, il grande botto all’origine del parapiglia,
come “un gran colpo di piatti fracassati”, secondo la
testimonianza del direttore d’orchestra Dino Messina
che poco prima della collisione stava suonando
Arrivederci Roma. La nave si inclinò di 30 gradi per
scomparire in fondo all’oceano Atlantico, nei pressi
dell’ isola di Nantucket, dopo 11 ore di agonia. Finiva
così, al 51mo viaggio, il sogno dell’Andrea Doria,
orgoglio della Marina mercantile italiana, transatlantico
arredato oltre ogni superflua misura e costruito, forse,
un pochino al risparmio, come sostennero gli svedesi
che attribuirono l’affondamento a un difetto strutturale.
La prua a doppio rinforzo d’acciaio della motonave
svedese Stockholm squarciò la fiancata anteriore destra
della nave italiana demolendo parzialmente i ponti
passeggeri A, B, C e distruggendo le cabine dal numero
202 al numero 238 del ponte A e le cabine dal numero
424 al numero 432 del ponte B. Oltre al garage della
331
nave. Persero la vita 46 persone sull’Andrea Doria, su
un totale di 1088 passeggeri; e 5 sulla Stockholm.
Mentre il capitano Piero Calamai lanciava l’SOS, e
non si capacitava come la nebbia avesse potuto avere
ragione del suo gioiello, Gastone Biffoli, Dino Messina
e altri giovani volenterosi cominciarono a bussare a ogni
cabina e a chiedere “Nobody in? Nobody in?” Tra i
passeggeri c’era l’attrice Ruth Roman e sua figlia
Dickie Hall, tre anni appena (diventata grande, e
ricordando quel dramma, dirà della madre: “Sembrava
che stesse andando a un picnic”). Mentre tutti
scappavano come pazzi, alla ricerca d’una scialuppa, lei
fece tutto con calma. Lei e la collega Betsy Drake,
moglie di Cary Grant. Probabilmente, per farsi coraggio
avevano immaginato che quello fosse il set di un film.
Finirono, con gli altri, nelle braccia dei marinai francesi
dell’Île de France prontamente accorsa sul luogo del
naufragio.
Ricordo ancora la prima pagina del Corriere della
Sera con la foto della nave inclinata sul fianco, sul
punto di affondare. Ricordo la commozione della mia
famiglia e l’indifferenza dei miei compagni di gioco che
stavano organizzando una partita a tamburelli, sulla
sabbia del lido Arcobaleno, e non avevano testa che per
quella. Anch’io mi tuffai nell’agone sportivo senza
eccessivi rimorsi, a fronte bassa, coi miei quattordici
anni di cristallo pronti a spezzarsi alla prima
indifferenza della ragazzina che assomigliava ad
Alessandra Panaro e che della giovane interprete di
Poveri ma belli aveva il biondo dei capelli e l’azzurro
degli occhi. Ma forse gli occhi non erano azzurri, forse
azzurri sono i miei ricordi, questi ricordi: le rincorse
sull’arenile prima di inzuccare le onde e nuotare verso il
largo, alzarsi all’alba e assistere alla tirata delle reti e
all’apertura della sacca coi pesci guizzanti, raccogliere
telline scavando nella sabbia bagnata, vagare nelle
campagne a ridosso dei lidi immaginando di trovare il
misterioso tesoro del capitano Kidd, mangiare uva
acerba e pinoli, arrampicarsi sui pini resinosi, graffiarsi,
332
incidere sul tronco, con un coltellino, le iniziali del
proprio sogno.
La Plaia era un grande mistero, uno spazio
sconfinato in cui mettere in scena le avventure di
Salgari, vestire i panni dei pirati della Malesia, di
Sandokan e Tremal-Naik. La strada arrivava poco più
oltre il Faro Biscari e il glorioso Lido Spampinato.
Accanto c’era il Lido del cavaliere Casabianca il cui il
figlio, Angelo, avrei conosciuto al giornale. Angelo
giocava benissimo a tamburelli. Doveva inchinarsi solo
alla classe di Puccio Maimone, davvero imbattibile in
coppia con Benenati, di Nuccio Pellegrino e Nino
Borina, di Saretto Spampinato e Salvo Arnaud, di
Massimo e Siro Sardo. Lavorava allo sport, accanto a
Luigi Prestinenza, Candido Cannavò e Giuseppe
Garozzo. Si occupava dei risultati e delle classifiche
nonché dei collegamenti con i collaboratori sportivi
delle province. Un lavoro ingrato ma prezioso, che
svolgeva con scrupolo. Uno di questi collaboratori della
domenica era l’ex presidente della provincia di Catania
e deputato europeo Nello Musumeci, allora studente.
Veniva da Militello Val di Catania, il paese natale di
Pippo Baudo. Era un giovane serio e brillante. Mai avrei
sospettato che avesse simpatie per il Movimento
Sociale. I missini, al giornale, erano i benvenuti, non i
beceri e i picchiatori ma i missini alla Nino Buttafuoco,
zio dell’astro nascente del giornalismo nazionale
Pietrangelo Buttafuoco autore di un romanzo, Le uova
del drago, pubblicato dalla Mondadori e che ha avuto
un ottimo successo. Poi ne ha scritto un altro, L’ultima
del diavolo, non all’altezza del primo, e altri due senza
storia.
Con la nomina a presidente del Teatro Stabile di
Catania, Pietrangelo, intellettuale ribelle della destra
italiana, si è alquanto ammansito. Quando la città,
sommersa dai debiti e non in grado di pagare l’Enel, è
rimasta per mesi al buio, lui, a quanto raccontano i
giornali, se n’è uscito con una frase talmente ironica e
raffinata che nessuno l’ha capita, anzi, i responsabili del
333
disastro l’hanno presa per una sorta di consolatoria
assoluzione. Ma che cosa aveva detto di tanto
memorabile da incuriosire i salotti cittadini? Aveva
detto che il buio dava alle strade un romantico “effetto
abat-jour”. Forse il suo segreto sta nel dire una cosa
pensandone un’altra, pensandola però di sghimbescio, in
maniera di stare a mezzo. Così facendo dice cose
inverosimili che in apparenza sembrano vere ma che in
realtà sono false. Quando il sindaco di Catania,
Stancanelli, gli ha consegnato la Candelora d’oro non ha
avuto dubbi. Ha detto: “È come ricevere l’Ambrogino
d’oro. Con una differenza, però. Catania è più chic di
Milano”. Catania più chic di Milano è come dire che il
princisbecco è meglio dell’oro ma il giudizio, che non
sta né in cielo né in terra, è stato preso per buono.
Nessuno resiste alle lusinghe. Ora è proprio in questo
margine ambiguo che si inserisce la scaltrezza di
Buttafuoco. Da narcisista e intellettuale di rango egli
può sempre dire ai provveduti e agli scettici: stavo
scherzando.
Nino Buttafuoco era allegro e scoppiettante, amico
dei giornalisti e dotato di senso dell’umorismo. Durante
un comizio in piazza Università, siamo negli anni
Cinquanta, un collega missino, brava persona ma
retorico e teatrale, descrisse in termini patetici la storia
di una madre che aveva mandato al figlio emigrato in
Belgio una maglia affinché lo riparasse dal freddo. La
vicenda, raccontata con tutti gli accenti del vittimismo
meridionale, finiva col grido di dolore del collega
deputato che non si dava pace, per la povera madre e per
il figlio di lei assiderato, perché il dono non era arrivato
a destinazione. “Camerati, amici cari! grande fu il
dolore di quella povera donna, di quella povera madre
nell’apprendere che la maglia, con tanto amore lavorata
ai ferri, non avrebbe difeso dal freddo straniero le gracili
membra del figlio!” E dicendolo, il deputato missino
aveva fatto finta di asciugarsi una lacrima. Qualche
tempo dopo, incontrandolo, Nino Buttafuoco, al quale
avevano raccontato la storia, lo tranquillizzò: “Non ti
334
preoccupare, la maglia l’hanno trovata!” Poiché dalle
sue parti aveva una torrefazione, la Bu.Ni Caffè,
raramente si presentava a mani vuote. Essendo io
giovane e ultima nobile ruota del carro mi toccavano i
suoi entusiasmanti sorrisi che però non sapevano di
torrefazione. Aveva un cuore di fanciullo, come scrisse
Gaetano La Terza, un fanciullo “che serba negli occhi la
pungente nostalgia dell’aquilone smarrito nel gorgo del
vento”.
La strada della Plaia fu allungata oltre il Faro Biscari
di circa un chilometro quando sorsero il lido Azzurro
(che poi si sdoppiò dando vita al lido La Pineta),
l’Arcobaleno, il Trinacria e il lido dei ferrovieri che
chiudeva la fila. Lì si arrestava la strada, con uno slargo
per dare modo agli autobus e ai filobus di girare. Più
oltre, c’era il lido dell’Aeronautica. Quell’anno mio
fratello, attraversando il confine, ben protetto dal filo
spinato, col lido balneare vicino, si rigò a sangue la
schiena. Lo portammo al pronto soccorso dove lo
medicarono e gli fecero l’antitetanica. Mio padre
minacciò di denunciare i proprietari dei lidi che avevano
alzato quella sorta di cortina di ferro. Era illegale,
infatti, recintare le zone demaniali e impedire ai
bagnanti di passeggiare lungo gli arenili che sono di
proprietà dello Stato. Addirittura i reticolati, per
bloccare gli sconfinamenti, venivano allungati per un
buon tratto di mare, fin dove non si toccava. Assurdo e
criminale. Oltretutto, il ferro al contatto con l’acqua
arrugginisce e diventa ancora più pericoloso. Eppure,
quegli abusi erano accettati come fossero legali. Questa,
purtroppo, era la mentalità in quel tempo acerbo di
diritti e florido di più o meno sottili prepotenze, quel
tempo che ha scandito la mia infanzia e la mia
giovinezza senza farmi troppo capire, imprigionandomi
anzi nella sua dolce prepotenza. Ma ciò era il meno
rispetto agli anni che sarebbero venuti dopo, anni di
piombo speciali, nemmeno nobilitati da folli ideologie
ma intrisi di mafia, subdola e spietata, che provocava
335
cento morti l’anno.
Il 1956 è anche l’anno di un sogno che finisce e di
uno che sta per cominciare, l’anno de Il cigno di Charles
Vidor, penultimo film di Grace Kelly (l’ultimo, sempre
di quell’anno, sarà Alta società di Charles Walters)
prima di salire sul trono di cartapesta del Principato di
Monaco. Film profetico, in verità, poiché la futura
moglie del principe Ranieri III vi interpreta il ruolo di
una bella ragazza che sta per diventare regina. Ranieri la
conosce sul set di Caccia al ladro di Alfred Hitchcock,
col quale l’attrice aveva girato in precedenza altri due
splendidi film: Delitto perfetto e La finestra sul cortile.
Per lei dimentica l’attrice francese Gisèle Pascal, con la
quale è stato fidanzato per sei anni e che comunque non
avrebbe potuto sposare, visto che la ragazza, dopo
un’accurata visita ginecologica, era risultata sterile. Non
avere eredi significava cedere alla Francia, come da
storici accordi, quel Principato da operetta che Somerset
Maugham descriveva come “un posto pieno di sole per
personaggi pieni di ombra”. Operetta o non operetta
fruttava un bel po’ di quattrini con le case da gioco e il
turismo d’alto bordo. Forte del suo nome, che per la
verità era un poco snobbato dalle vere teste coronate
d’Europa, Ranieri III vola a Filadelfia, nel regno laico
dei Kelly, e chiede la mano della bellissima e altera
Grace Kelly.
Prima di indossare per sempre le vesti della
principessa reale, Grace era definita dai partner, coi
quali aveva lavorato e con i quali era stata puntualmente
a letto, “ghiaccio bollente”. Era il suo algido sex appeal
a intrigare maggiormente Hitchcock. Nella famosa e già
citata intervista concessa a Truffaut, il mago del brivido
confessò di preferire le donne bionde e sofisticate, tipo
Grace, alle donne latine, francesi o italiane, perché a
letto diventano puttane. E per far capire meglio il
concetto del sesso gelido fece un esempio: “La povera
Marilyn Monroe aveva il sesso stampato su ogni angolo
del viso, come Brigitte Bardot, e questo non è molto
336
fine. Il sesso non deve farsi notare. Una ragazza inglese,
per esempio, con la sua aria da maestrina è capace di
salire su un taxi con lei e, con sua grande sorpresa, di
aprirle i pantaloni”.
La comitiva degli amanti di miss Kelly, più o meno
occasionali e più o meno maturi, era stata numerosa:
Clark Gable, Ray Milland, Cary Grant, Bing Crosby,
Gary Cooper, William Holden, Jean-Pierre Aumont,
Oleg Cassini. Di quest’ultimo s’era incapricciata e
l’aveva presentato ai genitori, così come aveva fatto,
inutilmente, con William Holden che per la verità era
sposato con Brenda Marchall dalla quale divorzierà nel
1971 dopo 30 anni di matrimonio. Ma i genitori, ricchi e
cattolici, si opposero al pur brillante Oleg perché anche
lui sposato, sebbene papà Jack, che prima di diventare
milionario aveva fatto il muratore, tradiva la moglie
senza battere ciglio, più e più volte, e la domenica si
lavava la coscienza andando regolarmente in chiesa.
Insomma, come tutti i puttanieri rispettava il
matrimonio – perché era un sacramento! – ma nella
pratica se lo metteva sotto i piedi. Lui e la moglie, una
tedesca dal carattere di ferro che aveva trasmesso alla
figlia la straordinaria bellezza, dissero invece di sì a
quel giovane principe pacioccone e belloccio che si
portava appresso una corona di latta ma pur sempre una
corona.
Le nozze furono celebrate col rito civile il 18 aprile
del 1956 e il giorno dopo col rito religioso, nella
cattedrale di San Nicola, sullo sperone più caro e
affollato del Principato. Furono definite le nozze del
secolo, al pari di quelle tra Carlo Magno ed Ermengarda
oppure tra Napoleone Bonaparte e Maria Luisa
d’Austria. Ma nessuna delle altezze reali ci andò, forse
per timore di confondersi con le “bassezze reali”
frequentate da miss Kelly negli Stati Uniti. Enzo
Grimaldi, principe di Nixima, che vantava per altro
un’indefinita parentela con lo sposo, era talmente sicuro
di essere invitato che non badò a spese pur di fare bella
figura con gli altolocati parenti (che forse non erano
337
nemmeno a conoscenza della sua esistenza).
Direttamente dalla fabbrica di Detroit si fece spedire a
Catania una Chevrolet nera Bel Air: costosa,
ingombrante auto di lusso che le ragazze sbavavano al
solo vederla passare per via Etnea. Pensava di mostrarla,
e di mostrarsi, al regale consesso. Ma nessun invito, né
per posta né per telefono, giunse mai al suo indirizzo. Di
recente, quella meraviglia di archeologia industriale è
stata vista, inerme e pietosa, nel capannone di uno
sfasciacarrozze in via Ventimiglia a Catania.
Al loro posto le teste coronate d’Europa mandarono i
maggiordomi, per così dire, che si confusero con i
miliardari e i divi di Hollywood. Ma lei, Sua Altezza
Serenissima Gracia Patrizia di Monaco, fece la sua bella
figura. Trenta milioni di persone seguirono le nozze per
televisione, un numero impressionante per quei tempi.
Lei indossava un vestito bianco realizzato con 23 metri
di taffettà e 92 di rete di seta. “Ghiaccio bollente”
espulse dal soprannome l’aggettivo, mortificò
l’ossimoro e divenne una delle mogli più irreprensibili
della storia dell’aristocrazia europea, tanto che padre
Pietro Pintus, monegasco, parroco della chiesa di Santa
Maria in Lucina, a Roma, propose alla sua morte di
innalzarla all’onore degli altari. Ma poi in Vaticano si
ricordarono di un certo James Spada, che aveva scritto
sull’ex attrice un’imbarazzante biografia, e la proposta
fu lasciata cadere.
Non ero mai stato a Montecarlo. Ci andai con mia
moglie e una coppia di amici (Domenico Tempio e sua
moglie Francesca) a metà degli anni Ottanta proprio per
visitare la tomba di Grace Kelly. Fu un lungo viaggio in
macchina. Avevo da poco acquistato di seconda mano
una Porsche Targa color visone. Quella macchina m’era
rimasta nel cuore. La prima l’avevo comperata nel 1972,
bianca, fiammante, bellissima. Quattro milioni e 900
mila lire. Due milioni me li regalò mio padre. Era
l’invidia di tutti, dei miei colleghi soprattutto che
cominciarono a chiamarmi “il maoista in Porsche”. Non
338
che fossi realmente “maoista” ma le carogne dei miei
colleghi presero gusto a sottolineare, ed esasperare, le
mie giovanili contraddizioni. Dicevano di non
capacitarsi come uno che votava socialista, e prendeva
spesso posizioni distanti dalla linea liberale del giornale,
potesse viaggiare a bordo di quella meraviglia sportiva.
La diedi via per l’anticipo della casa e il soprannome
cessò di colpo.
Ovviamente, non alloggiammo nel Principato,
perché ci avrebbero spennati, ma a Diano Marina, sulla
Riviera di Ponente, dove ci aspettavano Nino De Agrò,
direttore amministrativo del giornale, e sua moglie. Un
posto di mare che d’estate diventa peggio della Plaia o
della spiaggia di Casablanca. Arrivati davanti al Palazzo
del Casinò posteggiai l’auto dell’orgoglio accanto a un
paio di Rolls-Royce e mi sentii un pezzente. Nel vicino
Café de Paris suonavano romantiche canzoni francesi
mentre gli ospiti sorseggiavano champagne e a bocca
stretta mangiavano pasticcini. Pareva un pezzo di Belle
Époque congelato nel tempo. Gli uomini indossavano lo
smoking e fumavano sigarette con nonchalance, il fumo
saliva in volute leggere nell’aria morbida della sera e le
donne portavano guanti di pizzo e sorridevano con
grazia. Una pagina di letteratura, anche. Rubata alla
fantasia di Colette, la scrittrice bisessuale che André
Obey definì “un grand’uomo”. Raggiungemmo l’interno
della casa da gioco e ci facemmo passare la collera con
le slot machine. Per la visita alla cattedrale era tardi.
Non puntammo alla roulette come quella volta a
Malta, settembre 1976, quando il giornale mi inviò per
le elezioni generali, vinte poi dal laburista Dom Mintoff.
Quella volta mia moglie puntò decisa sul numero 6, il
giorno del nostro matrimonio, e fu l’en plein. Puntammo
su altri numeri, sul bianco e sul nero, sul cavallo e su
altre combinazioni. Fummo saggi e ci alzammo con una
piccola vincita. Una simpatica esperienza, a parte lo
scarafaggio che trovai nel consommé. Il maître
dell’hotel Verdala a cinque stelle, appena inaugurato, si
profuse in mille scuse e mi portò un nuovo passato di
339
verdure, stesso colore stessa intensità, che mi guardai
bene dall’assaggiare. Il sospetto che fosse la pietanza di
prima, deprivata dell’insetto, fu troppo forte.
Il giorno dopo salimmo al castello. La tomba di
Grace si trova nella navata laterale sinistra, poco lontana
dall’abside, nella cattedrale di San Nicola. Una semplice
lastra di marmo avorio sistemata sul pavimento. Quel
giorno era coperta di fiori bianchi. L’usanza di
seppellire le proprie glorie sotto i pavimenti delle chiese
significa non volersene distaccare, ritenerle ancora vive,
presenti, come accadeva nell’ottavo millennio avanti
Cristo, a Gerico: le famiglie seppellivano i morti in casa
non perché mancasse lo spazio ma perché così facendo
continuavano a coabitare con loro. Gli esperti dicono
che l’uomo neolitico si comportava in quel modo perché
non percepiva la morte come separazione dalla vita
bensì come cambiamento di forma. Inarrivabile
saggezza, idea pre-religiosa di assoluta modernità.
Tanto è vero che fino all’Ottocento i morti venivano
tumulati nelle chiese. Ma se i fedeli ne calpestavano le
lapidi ecco pronta la spiegazione freudiana:
conflittualità emotiva verso i defunti. In altre parole, il
calpestare e il pregare rappresentano un equilibrio tra
pulsione aggressiva e pulsione affettuosa. Mah! Meglio
l’idea neolitica.
Una preghiera laica, fatta per lo più di ricordi
cinematografici, e giù nelle stradine profumate di fiori
che si aprono a reticolo davanti al Palazzo del Principe
in cui regnava la Principessa per eccellenza, la donna
che mise in ginocchio Maria Callas e sfrattò il troppo
ingombrante Aristotile Onassis. Nelle curve del ritorno,
lungo la Moyenne Corniche, seguimmo il ricordo della
tragedia. Un ictus, mentre era alla guida della sua
Rover, una fuga oltre il gomito d’asfalto che si apriva
nell’orizzonte privo di nubi, uno schianto poco più
sotto, e la Principessa volò nell’azzurro del cielo. 14
settembre 1982. Addio alla sua carriera, che in coda a
quell’ultima stagione aveva conosciuto una timida
ripresa, addio al regno, al marito, ai figli: Carolina,
340
Alberto e Stefania che le stava accanto e che se la cavò
per miracolo. Al confine, ci restavano negli occhi le
curve assassine, la tomba, le slot machine, gli ospiti del
Café de Paris, e il ricordo di Sidonie-Gabrielle Colette,
il mito francese, l’attrice a petto nudo in palcoscenico e
modella conturbante negli studi fotografici alla moda,
colei che amò uomini e donne con lo stesso slancio e
diede ai posteri una cinquantina di libri dimenticati. Tra
questi, Gigi, il suo capolavoro, scritto, come gli altri, su
carta celeste, con una batteria di penne stilografiche
sottomano e alla luce d’una lampada velata d’azzurro.
Dopo la guerra la Francia le alzò un monumento di
medaglie e diplomi. Morì che pesava 90 chili. Era il 3
agosto 1954.
Fu proprio Colette, nel 1951, a notare Audrey
Hepburn. La famosa scrittrice stava cercando
l’interprete ideale di Gigi, trascritta per il palcoscenico
da Anita Loos. Le piacque subito quella ragazza
filiforme che si muoveva come una regina. Audrey, che
allora aveva 21 anni, si chiamava Edda Kathleen Van
Heemstra Hepburn-Ruston, ed era figlia di un banchiere
inglese e di una baronessa olandese. Ma dopo
un’infanzia dorata le si aprì la voragine della miseria. La
madre divorziò e se ne tornò coi figli in Olanda dove,
allo scoppio della guerra, i nazisti le confiscarono ogni
cosa. Audrey soffriva d’asma e anemia. A tre settimane
dalla nascita ebbe un attacco di pertosse che stava
portandola all’altro mondo se la baronessa Van
Heemstra non l’avesse sculacciata a dovere facendole
tornare il colorito.
Mentre la piccola Anna Frank stava nascosta a
Amsterdam, e scriveva il suo diario; Audrey, che aveva
la stessa età, si trovava a un’ottantina di chilometri dalla
capitale, ad Arnhem. Trascorreva il tempo a leggere,
sdraiata a letto, per non sentire i morsi della fame. Ogni
tanto, spostandosi in bicicletta, consegnava ai partigiani
messaggi segreti che nascondeva nella suola delle
scarpe. Non fu mai realmente in pericolo, però. Forse la
341
proteggeva la fama del padre, arrestato a Londra per
simpatie nazifasciste. Per anni mangiò coi fratelli e la
madre biscotti per cani e pane fatto con farina di piselli.
Il 2 settembre del 1944, quando Anna Frank fu arrestata
coi genitori e la sorella Margot, nel nascondiglio
ricavato sopra il laboratorio di spezie della Opekta, al
numero 263 della Prinsengracht, e avviata al campo di
concentramento di Bergen-Belsen, dove morirà di tifo
sei mesi dopo, Audrey Hepburn continuava a leggere e a
consegnare messaggi. Ma gli Alleati erano già alle
porte.
Nell’ottobre del 1998 la Walt Disney mi invitò alla
prima mondiale del cartoon Mulan che si teneva ad
Amsterdam. Il film era tratto da una fiaba cinese che ha
per protagonista una giovane donna che si traveste da
uomo, prende il posto del padre malato nelle armate
dell’imperatore e combatte valorosamente il nemico.
Avevo letto anni prima il diario di Anna Frank, e mi ero
profondamente commosso, senza sapere che c’erano
alcune parti censurate dal padre di lei, Otto, laddove la
giovanissima ragazza manifestava una qualche timida
tendenza omosessuale. Avevo anche visto il film, che ne
raccontava la storia, di George Stevens del 1959,
bellissimo, ed ero perciò curioso di entrare nel mistero
di quel rifugio, respirare il chiuso delle sue stanzette,
guardare oltre la finestra, sul retro, il castagno più volte
citato dalla piccola scrittrice, immaginare la vita sepolta
della ragazzina mentre l’acerbo della sua vita andava
lentamente maturando, e spegnendosi, il giorno in cui fu
brutalmente presa e mandata a morire per il solo fatto di
essere ebrea. L’Olanda mi regalò una mattinata di sole,
dopo due giorni di freddo accanito, e me ne andai alla
scoperta della casa dell’angoscia, della speranza e della
morte. Dal 1960 è diventata museo ed ogni anno è
visitata da un numero impressionante di turisti. Non mi
ricordo i personaggi ma sulla parete dov’è il lettino di
Anna Frank sono attaccati piccoli ritagli di giornale con
foto e notizie di attori dello schermo. Erano i suoi
342
minuscoli poster del desiderio. Aggirandoti per quegli
spazi angusti non puoi non provare un’infinita pena, e
dolore, per la sorte ingiusta toccata a una ragazzina di
quindici anni che sognava di diventare scrittrice. E non
puoi nemmeno impedirti di provare un brivido,
all’uscita dell’ultima stanza, di fronte alla gigantografia
del signor Otto Frank, unico sopravvissuto, che sembra
salutarti e ringraziarti per la visita e nella cui
espressione cogli uno smarrimento indicibile.
Audrey Hepburn aveva la stessa altezza di mia
sorella, gli stessi zigomi alti, i capelli tagliati corti con la
frangetta o raccolti dietro con l’elastico, la stessa taglia
e lo stesso peso, credo, e undici anni di più. L’una
poteva essere la controfigura dell’altra. Andare a vedere
i suoi film era quasi un obbligo di famiglia, come
recarsi al Metropolitan per il saggio di fine anno in cui
mia sorella si alzava sulle punte e giganteggiava, per
grazia e bravura, sulle altre allieve. Nelle vene di
Audrey scorreva il sangue blu dell’aristocrazia e quello
rosso della sofferenza. Il primo sfolgorante successo lo
coglie, da principessa, nelle strade di Roma, seduta sul
sellino della Vespa guidata da Gregoy Peck. Il suo
personaggio, in fuga dalla corte e in giro turistico per la
città eterna, è delizioso.
Vacanze romane di William Wyler, è questo il film,
anno 1953, le fa guadagnare l’Oscar come migliore
attrice protagonista. Gregory Peck era stato buon profeta
quando pretese che il nome della giovane partner
figurasse nei titoli di testa accanto al suo: “Sono
abbastanza intelligente da capire che questa ragazza
vincerà l’Oscar con questo suo primo film”. L’anno
dopo è Sabrina nell’omonimo film di Billy Wilder. Fa la
parte della figlia di un autista che ha tutti i numeri, di
grazia e intelligenza, per mettere al guinzaglio l’asfittica
nobiltà del denaro rappresentata da Humphrey Bogart e
William Holden. Del giovane e aitante William
s’innamora anche nella realtà, ma poi lo lascia quando
viene a sapere che non può avere figli. Per lei diventare
343
madre veniva prima di tutto.
Si consola con Mel Ferrer, presentatole dallo stesso
Holden. Si sposano a Buoche, in Svizzera, e l’attrice
aspetta quasi subito un figlio, che tuttavia perde a causa
di un aborto spontaneo. Nel 1957, dopo una serie di
successi, come Guerra e pace di King Vidor e Arianna
di Billy Wilder, resta di nuovo incinta. Stessa storia di
prima. Nel 1959, mentre lavora con Burt Lancaster nel
western Gli inesorabili di John Huston, scopre di essere
incinta per la terza volta, ma una caduta da cavallo
provoca l’ennesimo aborto. Nel film, nella parte della
madre, le è accanto la diva del cinema muto, Lillian
Gish, che ho ricordato prima, superba e splendente
attrice, morta nel 1993 all’età di cento anni. A quel
punto, Audrey capisce che se vuole avere veramente un
figlio deve annullare ogni impegno, starsene buona,
serena e aspettare. E così fa. Si ritira nel suo chalet
alpino di Burgenstock e finalmente porta a compimento
la quarta gravidanza. Nasce il primogenito Sean.
Padrino d’eccezione è lo scrittore A. J. Cronin. Nel
1965 il quarto aborto. Martoriata nel corpo e nello
spirito, entra in depressione, così pure il matrimonio con
Mel Ferrer. I due si separano nel 1968. L’anno
successivo Audrey conosce a una festa un giovane
psichiatra romano, Andrea Dotti, più giovane di dieci
anni, se ne innamora e ci fa subito un figlio, Luca, che
nasce con le modalità del primo: in Svizzera e nel più
assoluto riposo.
Abbandonato il cinema, e ottenuto il divorzio dallo
psichiatra italiano (che l’aveva più volte cornificata e
che morirà nell’ottobre del 2007 dopo un banale
intervento chirurgico), si lega a Robert Wolders, da
poco vedovo di Merle Oberon. Con lui comincia a
girare il mondo dedicandosi, come ambasciatrice
speciale per l’Unicef, a migliorare le condizioni dei
bambini bisognosi e delle loro famiglie nei Paesi del
Terzo Mondo. Compito che assolve alla grande grazie
alla conoscenza delle lingue. Oltre all’inglese parlava
correntemente il francese, l’italiano, l’olandese e lo
344
spagnolo. Va in Vietnam, in India, in Africa. Finché al
ritorno da un terribile viaggio in Somalia le viene
diagnosticato un cancro al colon. Troppo tardi perché
l’operazione, in una delle migliori cliniche di Los
Angeles, abbia buon esito.
L’amico di sempre, Hubert de Givenchy, che aveva
disegnato i suoi costumi per il film Colazione da
Tiffany, le mette a disposizionel’aereo personale perché
possa chiudere gli occhi tra le montagne dell’amata
Svizzera. Muore il 20 gennaio 1993. Sul TG1 il suo
ricordo portava la mia firma. “Moon river, wilder than a
mile,/ I’m crossing you in style someday,/ oh, dream
maker, you heartbreaker,/ wherever you’re going,/ I’m
goin’ your way…” Le parole sono di Johnny Mercer, la
musica è di Henry Mancini. La canzone, che è parte
importante del film Colazione da Tiffany di Blake
Edwards, vinse un Oscar nel 1961. Non potevo non
utilizzarla, come dolce sottofondo, nel servizio che
chiuse il telegiornale e che fu visto da dieci milioni di
telespettatori. Il pubblico amava Audrey Hepburn, e
l’ama ancora oggi. Un recente sondaggio della rivista
inglese The New Magazine Woman la piazza al primo
posto tra le cento donne più belle di tutti i tempi. In
seconda posizione, Grace Kelly, per magnifica e
misteriosa coincidenza. Due bellezze senza tempo, alte,
magre, dolcissime e rasserenanti.
345
SEDICI
Marilyn Monroe
La scrittrice Anna Colombo, classe 1909,
presentando il libro della sua vita, Gli ebrei hanno sei
dita, ha raccontato un aneddoto che spiega lo strano
titolo: “Quand’ero in quinta ginnasiale, ad Alessandria,
una mia compagna, avendo saputo che ero ebrea, mi
disse che non ci credeva perché la mia mano aveva solo
cinque dita”. La superstizione della ragazza nasceva
dalla diffusa convinzione che gli ebrei non fossero
persone come le altre ma appartenessero a una razza
particolare e per questo dotate di una fisicità mostruosa
che ne sottolineava la diversità. Nella religione,
l’esadattilia simboleggia il diavolo, che il Tiepolo
dipinge proprio con sei dita. Naturalmente le cose,
metaforicamente espresse, sono più complicate e meno
nette di quanto sembri. In una chiesetta di
Pontechianale, vicino Cuneo, c’è un singolare ciclo di
affreschi del Seicento in cui i piedi e le mani dei santi
sono raffigurati con sei dita. L’anomalia, a quanto pare,
veniva usata per fini apotropaici. Il santo con sei dita,
cioè, avvicinandosi fisicamente al Maligno, poteva
contrastarne meglio l’influsso negativo. Del resto, anche
alcune divinità sumere sono esadattili. Da questa
commistione nasce una confusione simbolica che si
estende anche ai personaggi del nostro tempo. In un
francobollo
commemorativo
Franklin
Delano
Roosevelt, il presidente del New Deal e della ripresa
economica americana dopo il tracollo del 1929, è
disegnato con sei dita, e la divina Marilyn Monroe, in
alcune foto di Joseph Jasgur, pubblicate nel 1946,
mostra la stessa diversità. Insomma, tutto ciò che è
eccessivo, fuori misura, singolare, improprio, a volte
distingue e accomuna il Bene e il Male. Le religioni
pagane erano piene di idoli fisicamente mostruosi, buoni
o cattivi che fossero: Diana ha molti seni, Kalì molte
346
braccia, Bes, il dio egizio della fecondità, è
rappresentato come un quadro di Picasso: la testa e gli
occhi nel petto, il cuore e il cervello in un comune
sistema cardiocircolatorio, e alcuni gatti di Hemingway,
che stavano nella villa del grande scrittore a Key West,
avevano sei dita.
Marilyn era un’anomalia vivente. Se Aristotele
l’avesse conosciuta avrebbe di certo rivisto il capitolo
quinto dell’Etica Nicomachea: in medio stat virtus. La
virtù dell’attrice era proprio quella di non stare nel
mezzo e nemmeno da una parte, ma essere al di sopra,
riassumere come una dea vivente l’eccesso e il difetto
del mondo. Per questo non poté diventare la sposa del
principe Ranieri III di Monaco, che le preferì Grace
Kelly, simbolo perfetto dell’ipocrisia di Hollywood e
della medietà aristotelica. Chissà che cosa avrebbe
combinato a corte, la scombinata Marilyn! Meglio non
rischiare. Non a caso, l’attrice, a vent’anni, vinse il
concorso di bellezza per Miss Carciofo. Lo stesso Billy
Wilder, che pur ne ammirava il talento, dopo averla
diretta nel film Quando la moglie è in vacanza, del
1955, disse: “Ha un seno di granito e un cervello di
groviera”. Forse fu per questo che Marilyn, nella celebre
sequenza della gonna sollevata dall’aria calda della
metropolitana, su consiglio del marito Joe Di Maggio,
indossò due paia di slip bianchi per impedire al regista
di ammirare e rimirare la scena in sede di montaggio. La
celebre sequenza, la più imitata nella storia del cinema,
fu girata il 14 settembre del 1954 e paralizzò il traffico a
New York, in Lexington Avenue, di fronte al Lux
Theatre. Benché fosse passata la mezzanotte la folla non
volle perdersi lo spettacolo.
Il film obbedisce a uno stereotipo di successo.
Modugno scriverà una canzone sui mariti in città e le
mogli al mare, le mogli che talvolta si consolano coi
bagnini e i mariti con le cameriere. Ma nessuno,
ovviamente, potrà mai sperare di trovare, mentre la
moglie è in vacanza, una vicina di casa come Marilyn
Monroe che si presenta alla porta in abito scollato, un
347
ventilatore in mano e la richiesta di aiuto perché il filo
le si è impigliato. Potrà solo sognare. Potrà desiderare di
mettersi nei panni di Billy Wilder quando prima di un
ciak suggerì all’attrice di togliersi il reggiseno sotto la
camicia da notte. Al che Marilyn, afferrando la mano
del regista e portandosela al petto, rispose: “Quale
reggiseno?”.
Marilyn Monroe entra nell’immaginario siciliano
nella prima metà degli anni Cinquanta. A Catania
circolano le prime Vespe e molti ragazzini dei quartieri
popolari camminano ancora a piedi scalzi. Il Paese cerca
di dimenticare le sofferenze e la fame della guerra
sognando l’abbondanza. E il cinema italiano ne riflette
lo spirito lanciando le cosiddette maggiorate fisiche,
cresciute a forza di farinacei e legumi. Ma quando sugli
schermi compare la bionda Marilyn le nostre dive
ridiventano pallide ombre. Sono tre i film che
avvolgono lo spettatore in una nuvola di desiderio:
Niagara di Henry Hathaway, Gli uomini preferiscono le
bionde di Howard Hawks, Come sposare un milionario
di Jean Negulesco, l’eccentrico regista che aveva un
guardaroba degno di un re: ottocento vestiti, tremila
cravatte, novecento paia di scarpe, cento panciotti. I tre
film erano stati girati nel 1953. Un anno davvero
speciale. In Niagara, il glamour dell’attrice sta nella
camminata orizzontale, una sorta di ancheggiamento al
rallentatore pressoché inimitabile, che assieme al vestito
rosso attillato fanno la cifra del film e suggeriscono al
regista di inserire nella sceneggiatura la fulminante
battuta raccolta durante le riprese: “Ce l’avranno qui un
estintore?”
Marilyn diventa un modello in tutto: nella risucchiata
della pancia per tenere alto il petto, nel modo di
truccarsi e di vestirsi, nel modo di parlare e di cantare,
nel modo di essere altra da sé, sciocca e giuliva, pur
tenendo diari appassionati e covando arditi pensieri. Via
Etnea cambia colore, il bruno fa posto al biondo
ossigenato mentre i ragazzi mettono nei portafogli di
348
plastica, con lo specchietto e il pettinino, una foto della
diva, dolce e burrosa, senza complicazioni intellettuali,
spiritosa e vaneggiante. La mettono nel portafogli e
nelle discussioni, come i vitelloni di Fellini. “Ma tu, se
venisse adesso Jane Russell e ti dicesse: dài, pianta tutto
e vieni con me, ci andresti? Ostia se ci andrei!”Più
vicini al loro gergo, i catanesi avrebbero sostituito Jane
con Marilyn e al posto dell’ostia avrebbero utilizzato
l’immortale definitoria espressione: minchia!
I giovani catanesi di allora, a parte l’inguaribile
orgoglio di sentirsi diversi e comunque più “sperti” dei
giovani che vivono al di là della cinta daziaria, definiti
zaurdi o zampirri, in realtà sono come tutti gli altri:
spacconi, provinciali, ignoranti. Solo la linea gotica
segna un modo diverso di esprimersi, di abbigliarsi, di
sognare e di sperare. Oggi invece l’appiattimento ha
varcato i confini nazionali. L’omologazione è totale.
Roma riflette in maniera precisa, quasi fotografica, le
capitali europee, e non solo. Per le vie del centro scorre
la stessa variopinta umanità che vediamo a Berlino, a
Londra, a Bruxelles, a Vienna, a Parigi. Stessi tic,
piercing, risate, stessa solitudine camuffata. Tanto vale,
ti chiedi, startene in riva al tuo mare, sotto il tuo sole e
le tue stelle, e magari leggere un libro su quelle capitali
che ami da prospettive lontane, perché a osservarle da
vicino la delusione è fatale. La Tv, internet, google,
facebook, twitter, myspace, youtube, i cellulari, gli sms,
le e-mail, tutto questo mondo tecnologico, affascinante
e ingannevole, ha distrutto il Reale, ha polverizzato
l’identità delle persone, ha frullato le loro anime e
creato una realtà parallela, virtuale, dove tutto è uguale
e indefinito. Si arriva al paradosso di perdere il gusto
del viaggiare, la curiosità di vedere altri posti, sognare
altri orizzonti, perché il mondo ce l’hai già in casa, sullo
schermo, magnifico e astratto come un paradiso
ritoccato con sapienza. Insomma, meglio la copia che
l’opaco originale, meglio il non-luogo che il luogo. Per
conseguenza, ciò che muove l’interesse non è più la
diversità e la bellezza, ormai inafferrabili in sé, ciò che
349
intriga, dopo avere visto di sfuggita l’ennesimo
monumento ed essersi annoiati a guardare l’ennesimo
quadro di scuola italiana o fiamminga, è correre al
ristorante vicino, possibilmente italiano, e finalmente
rilassarsi, ritrovare il gusto della propria mediocrità. Ma
allora perché mai questa umanità, che non legge, che
non sa raccontare ciò che ha visto, che si ubriaca di
comode astrattezze, che riesce al massimo a esprimere
concetti generici di ammirazione, va in posti così
lontani per essere poi così vicini al proprio quartiere?
Lo fa per vanità, per noia, per mostrarsi agli altri, per
dire cose che ha capito solo attraverso i documentari e le
riviste patinate.
Che cosa occorre, dunque, per rompere il cerchio dei
mirabolanti teoremi da cortile mediatico? Niente.
Svenarsi di solitudine. Armarsi di libri, di guide, di film
veri e non calligrafici per capire che le pietre non
sempre sono semplici pietre e che le immagini, a prima
“scansione” piatte e deludenti, nascondono particolari
interessanti, come la foto del delitto in Blow up. In ogni
caso, mai mettere a sipario le proprie glorie patriottiche,
mai confrontare il loro con il nostro ma accostarsi con
animo puro e disinteressato alle diverse patrie che
sembrano le stesse ma non lo sono. E quando si entra
nei musei non bisognerebbe correre ma camminare,
lento pede, ammirare i capolavori senza pensare alla
pizzeria o al kish kebab, e farsi spiegare perché un
dipinto è così importante, perché la ronda di notte di
Rembrandt è tra le cose più belle di Amsterdam, perché
uno degli autoritratti del ribelle Van Gogh manca di un
orecchio e perché migliaia di critici d’arte non sanno
compiutamente spiegare il sorriso della Gioconda. In
verità, l’unico modo per capire è discendere nell’Ade,
nelle biblioteche e nelle cineteche d’essai, nel regno
delle ombre, parlare ai morti che però sono vivi perché è
lì che trovi, accanto al passato nobile e immortale,
l’anima di un popolo, la sua diversità.
Marilyn Monroe, Betty Grable, Lauren Bacall. Un
formidabile trio di arrampicatrici sociali che nel film
350
Come sposare un milionario tentano di accalappiare un
tycoon e finiscono tra le braccia di bravi e spiantati
giovanotti. Il mito di Cenerentola si rinnova a ogni
generazione. Le ragazze dei bassi o dei piani rialzati,
con la testa nei romanzi rosa di Liala, Delly e Barbara
Cartland, cercano di colmare il divario sociale
valorizzando tette e deretani mentre la gran parte dei
ragazzi, eterni appiedati e sfasolati freschi, non potendo
aspirare al mito della favola, essendo al più principi
poveri, tentano di rimediare nelle ultime file dei
cinematografi. Per solito, rimediano racchie o disperate.
Le migliori se le spupazzano i figli di papà, i principi
veri, accessoriati con macchine e denaro sonante, anche
se a cervello, per giudizio degli appiedati, stanno messi
male. Di solito, questi giovanotti high cost provengono
da accessoriate famiglie che hanno due di tutto: una
casa in città e una in campagna, un doppio conto in
banca, un doppio visone lei, un doppio cappotto lui, due
bagni, due camere da pranzo, due auto, due cani, senza
contare il doppio mento e l’odio per le tasse e i
comunisti. Rosina Anselmi, che in una commedia di
Martoglio si vantava di avere a casa sua “uno di tutto”,
era una poveraccia.
Nell’anno del boom, in piccola parte, le cose
cambiano. Le Fiat Cinquecento diventano veri e propri
boudoir viaggianti. Molti cominciano col petting, in
modo che i fiati appannino i vetri; altri però, più
meticolosi e pazienti, tappezzano prima l’abitacolo con
fogli di giornale fissati con lo scotch e quando hanno
finito, sudati e stremati, tentano l’affondo. Ma le vittorie
sono poche, sofferte e stressanti. Basti pensare alla
manopola del cambio, piantato sul pianale, che
t’impedisce ogni onesto peccato. Per non dire del tutore
dell’ordine (morale) che talvolta bussa al finestrino e,
tra l’imbarazzo del cavaliere e la vergogna della dama,
chiede i documenti, non si sa per quale reato dal
momento che su quelle strade solitarie e in quell’ora di
lupi non passeggiano nemmeno i lupi. Ma, si sa, la
legge è legge, anche se a farla rispettare è qualche
351
sporcaccione vestito da questurino.
Marilyn era anche un’attrice spiritosa. Davvero
fantastico il numero della guardarobiera in Follie
dell’anno. L’attrice, che vuole fare l’attrice, cerca di
esprimersi con tutti i verbi e gli aggettivi a posto, ma
rovina in una specie di parlata martogliana irresistibile.
Le ragazze degli anni Cinquanta, le nostre ragazze, la
imitavano benissimo. Quando a scuola o in società
parlavano in italiano, perché a casa la lingua ufficiale
era ancora il dialetto, raddoppiavano o scambiavano le
consonanti. Erano utili tentativi di promozione sociale
ma certo rappresentavano rovinosi esercizi di fonetica.
In quegli anni la lingua italiana, il parlare corretto,
rappresentava un modo per farsi accettare a un livello
sociale più alto. Chi parlava in dialetto era figlio di
poveri, chi invece si esprimeva in italiano era figlio di
ricchi.
Prima di girare Orchidea bionda, del 1948, Marilyn
ha dovuto essere gentile con una quantità
impressionante di uomini: giornalisti, produttori, attori,
registi, mitomani, sfruttatori, malavitosi. Molti fotografi
confessavano che, non appena posavano la macchina
fotografica, l’attrice, per riconoscenza, guardava verso
la superficie orizzontale più vicina come a una
conclusione logica del lavoro. In Il sofà del produttore i
giornalisti inglesi Alan Selwyn e Derek Ford dedicano
all’attrice un capitolo, dopo avere spettegolato su tutta
la crème delle dive di Hollywood. Louise Brooks, per
esempio, attrice degli anni Venti, un giorno andò da un
produttore per avere una parte in un film, ma questi
senza mezzi termini le domandò: “Che cosa le fa
pensare di avere le qualità necessarie per diventare
un’attrice cinematografica?” Al che Louise, che intanto
si era spogliata, rispose adagiandosi con eleganza sul
sofà: “Va bene così, tanto per cominciare?” Louise era
una flapper, una maschietta come Clara Gordon Bow,
l’attrice lanciata dalla scrittrice Elinor Glyn e che il
pubblico amò per quel suo “certo non so che”, l’attrice
352
dal viso d’angelo nata da una madre schizofrenica e da
un padre che abusava di lei.
In quel periodo Marilyn aveva subito una dozzina di
aborti. E in questo chemin de fer cercava di
perfezionarsi: recitazione, dizione, ginnastica, letture.
Non era molto alta, un metro e 66, né possedeva forme
strepitose, ma aveva un sex appeal irresistibile. Nel
1949 il chirurgo estetico più quotato di Beverly Hills le
ritoccò il naso, le mascelle e i denti. Il risultato fu
esplosivo.
La magnifica preda fu l’unico western girato da
Marilyn, ma l’attrice lo reputò un film di “serie zeta”.
Forse non perdonò al regista, Otto Preminger, che non
fece un buon lavoro, la feroce battuta: “Dirigere
Marilyn Monroe è come dirigere Lassie, occorrono
troppi ciak prima di ottenere che abbai nel modo
giusto”. Nel film, lei è Kay Weston, una cantante di
saloon; lui, Robert Mitchum, è Matt Calder, un
agricoltore rozzo ma coraggioso, che alla fine la
conquista. La scena finale è una di quelle che sono
entrate nella leggenda del cinema: Kay si toglie le
scarpette rosse da artista del varietà e le getta nella
polvere mentre il carro di Matt la conduce verso una
nuova vita. I due attori si erano conosciuti una decina
d’anni prima, quando lavoravano come operai in uno
stabilimento che fabbricava paracaute per conto
dell’aviazione. Non meno suggestiva la sequenza che
precede il lancio delle scarpette: Marilyn, seduta tra i
rudi lavoratori delle miniere d’argento dell’Idaho, che
canta la bellissima Il fiume del non ritorno. “There is a
river called The river of no return/ sometimes it’s
peaceful and sometimes wild and free!…” Alla fine
della canzone uno pensa: adesso mi getto ai suoi piedi e
faccio come il professor Unrath.
Il film arrivò nelle sale cinematografiche catanesi nel
1955 e molte ragazze, immedesimandosi nel ruolo della
bella e desiderabile Kay, rispolverarono l’antico segno
di disponibilità al matrimonio allungando la sottana di
353
qualche centimetro. Era un tecnica che s’usava nel
popolino. Le ragazze, non ancora maritate o fidanzate,
utilizzavano quella civetteria per catturare le “prede”.
Una volta messe nel sacco, badavano a nascondere le
sottane. Guai se le avessero lasciate occhieggiare dagli
orli, sarebbero state definite “tappinare”, donne allegre
cioè, donne disponibili all’avventura, donne che stanno
per lo più in casa, in vestaglia e con le tappine, le
pantofole, pronte all’uso… dell’amore. Le donne
sposate, invece, le donne che tenevano alla reputazione,
prima di uscire di casa controllavano che i merletti non
spuntassero sfacciatamente dalle gonne.
La vita di Marilyn Monroe non stabilisce un confine
tra pubblico e privato, la vita dell’attrice è un copione
drammatico e misterioso. Come la sua fine. Molti
scrittori e giornalisti hanno provato a raccontare la sua
storia, la storia di un’infanzia infelice, la storia di una
starlet che riesce a separare con suprema innocenza il
corpo dall’anima, la storia di una diva esplosiva e di
un’attrice formidabile, la storia di una morte “utile”.
Tutti sono riusciti a cogliere uno o più aspetti della sua
personalità, ma tutti o quasi si sono arenati di fronte alla
sua fine: suicidio, fatalità oppure omicidio? Era nata
nella città degli angeli il primo giugno 1926. Si
chiamava Norma Jean Mortensen. Sua madre montava i
negativi in un’industria cinematografica ed era
psichicamente instabile. Il padre se n’era andato prima
che lei nascesse. Passò l’infanzia tra orfanotrofi e
famiglie adottive fino a quando trovò il suo passaporto
in Jim Dougherty, un bravo ragazzo che la sposò nel
1942. Scrivono Selwyn e Ford. “Goffa e grassoccia
rallegrava se stessa e il suo giovane sposo aspettando che
tornasse a casa, la sera, distesa, nuda, sul pavimento
dell’anticamera”. Quella vita domestica finì quando suo
marito partì per la guerra e lei si impiegò nella fabbrica
di paracadute. Cominciò allora a posare per alcuni
fotografi e a tradire il combattente Jim. Quando il
combattente Jim tornò pieno di gloria e di speranza
354
Norma Jean aveva già fatto le valigie per il successo:
una serie di calendari e un paio di comparsate (Giungla
d’asfalto ed Eva contro Eva).
Nel 1954 sposa Joe Di Maggio, il re del baseball, che
ha appena smesso di giocare ma che è ancora una
leggenda. Il matrimonio dura poco. L’italo-americano è
geloso. “Non è divertente”, dice “essere sposato con una
luce elettrica”. Si lasciano con dolore. Ma restano amici.
Per anni l’attrice si rivolgerà al suo campione nei
momenti di difficoltà. Specie dopo il divorzio dal terzo
marito, Arthur Miller, il popolare commediografo nella
cui ombra tentò di vivere e di nascondersi. Ma Miller
era un grand’uomo alla rovescia, meschino e crudele.
Combatté ogni sopruso e ingiustizia, si fece paladino dei
perseguitati dal maccartismo, fu simbolo di democrazia
e rigore, ma quando dalla terza moglie, Inge Morath,
ebbe un figlio down, Daniel, lo cancellò dalla sua
esistenza. E su questo povero figlio infelice imperversò
anche dopo la morte. Quando capì che non c’era più
niente da fare, che la Vecchia Signora aspettava da un
pezzo sull’uscio, il Grand’Uomo diede ordine ai parenti
e agli amici più stretti che il figlio Daniel non
partecipasse ai funerali. Sarebbe stata una vergogna, per
lui che pensava di sopravvivere alla morte! Con le sue
opere di cartapesta non poteva, infatti, permettersi uno
scandalo. Vecchio cinico pazzo, artista sopravvalutato,
marito incapace di capire, uomo a mezzo servizio,
ipocrita e piccolo borghese. La congiura del silenzio fu
mantenuta. Solo di recente Vanity Fair e The New York
Times hanno scoperto gli altarini e capito perché la vena
di Miller dopo quel drammatico evento si fosse
improvvisamente inaridita. Forse il rimorso aveva
bussato con successo alla sua porta e gli aveva tolto la
capacità di pensare e di esprimersi. Forse.
La vita di Marilyn nasce e muore come un
fotoromanzo: bianco e nero, candore e malizia, luce e
tenebra. Una ghiotta preda per i settimanali rosa, che le
donne italiane divorano senza complessi. L’Italia
registra primati europei in questo genere di letture. Gli
355
uomini invece leggono poco, al più quotidiani sportivi.
E sognano la donna, come faceva Vitaliano Brancati, la
sognano al cinema e se la portano in tasca, profumata,
sensuale, distribuita in calendario dai barbieri.
In Fermata d’autobus è Cherie, un personaggio da
tre soldi. Ma Marilyn riesce a renderlo intenso e
credibile. Al confronto, gli altri attori scompaiono, a
cominciare da Don Murray al suo esordio
cinematografico, legnoso ed eccessivo. Anche questo
film registra i ritardi e i capricci dell’attrice. Con il
regista, Joshua Logan, Marilyn aprì le ostilità
cominciando a esigere che Hope Lange non avesse i
capelli biondi come i suoi. La verità era che l’attrice
aveva bisogno costantemente di essere rassicurata. Era
insicura, testarda, capricciosa. Tutto serviva a farle
rimandare il momento in cui avrebbe dovuto affrontare
il mondo come Marilyn Monroe. Lo schermo la
spaventava, il set la spaventava. In Fermata d’autobus
non riuscì a completare una scena con Hope Lange. Si
confondeva e ripeteva gli stessi errori al punto che
Logan fu costretto a risolvere il problema in sede di
montaggio, giuntando abilmente gli spezzoni del
dialogo. Pressappoco a quell’epoca Marilyn cominciò a
frequentare i sexy-parties organizzati da Peter Lawford,
cognato di John Kennedy, per avere sposato una sorella
di lui, e che Joyce Carol Oates nel suo monumentale
Blonde definisce il ruffiano del presidente.
Nel già citato libro, Selwyn e Ford scrivono:
“Marilyn cominciò a avere paura di vivere, paura di
addormentarsi e paura di svegliarsi. Si abituò ai
sonniferi e all’alcol e diventò sempre più inquieta”.
Lasciò il set per due anni, tentando, inutilmente, di
diventare madre, la sua indomita aspirazione. Ma i
numerosi aborti, ai quali si era sottoposta quando era
una starlet, e si dava via per una foto o due righe su un
giornale, oppure s’inginocchiava sulla moquette davanti
ai produttori, avevano minato il suo fisico, anche se non
irrimediabilmente, come vedremo. Riprese a lavorare. A
qualcuno piace caldo riuscì a girarlo grazie alla tenacia
356
di Billy Wilder. Ma l’attrice andava sempre più spesso
fuori di testa. Ritardi mostruosi, scene rifatte infinite
volte. La sequenza del bacio con Tony Curtis sullo
yacht fu ripetuta 47 volte. Alla fine, l’attore commentò
sfinito: “È stato come baciare Hitler”. Al termine della
lavorazione lo stesso Wilder disse: “Ho ripreso a
mangiare, non ho più il mal di schiena e guardo mia
moglie senza volerla picchiare per il semplice fatto che
è una donna”. Solo il successo di cassetta del film riuscì
a salvare la carriera di Marilyn. Ma ormai il sipario
stava calando rapidamente sulla sua vita.
L’incontro con Yves Montand sul set di Facciamo
l’amore determinò il crollo. Si era innamorata del bel
francese, ma Yves il seduttore, dopo essersela spassata,
preferì restare accanto alla moglie di ferro Simone
Signoret. Fu allora che l’attrice, come raccontano
Selwyn e Ford, “cominciò a comportarsi come se, per
disperazione, volesse dimostrare a tutti i costi di essere
amata e desiderata. Invitava nel suo letto chiunque le
mostrasse un minimo interesse, fattorini, operai che
lavoravano nella casa che aveva appena comprato, attori
che incontrava alle serate in casa di Peter Lawford”. Al
confronto, Jane Digby, l’aristocratica dama inglese che
vantava una lista di amanti lunga quanto l’Almanacco
Gotha, era una dilettante. Come prima più di prima,
dunque. Una rovinosa caduta negli inferi della
depressione, e forse della pazzia. Quando il presidente
Kennedy, a una di quelle feste, notò Marilyn e chiese al
cognato di portargliela “nel capanno laggiù”, Peter
Lawford tracciò della diva un ritratto terrificante:
“Quella là, ha avuto decine di aborti, tira cocaina, si
spara in vena Benzedrina e Luminal e ha tentato
numerose volte il suicidio. Non credo che ti convenga”.
Nel 1960 gira nel deserto del Nevada, accanto a
Clark Gable, Montgomery Clift ed Eli Wallach, il suo
film più complesso e difficile, Gli spostati, scritto dal
marito, Arthur Miller, e diretto da John Huston.
L’attrice qui è grande perché grande è la sua infelicità.
Il film è la metafora della sua vita: una donna sola che
357
ha paura di vivere nel deserto dell’esistenza e che cerca,
disperatamente, di salvarsi. Il film successivo,
Something’s Got to Give, non riuscirà a finirlo. Eppure,
fisicamente, era tornata quella di prima. C’è una
sequenza, quella del bagno in piscina, che la mostra nel
suo antico splendore, dolce e desiderabile, e con un seno
all’altezza della situazione. Purtroppo, era la testa che
non funzionava più.
E siamo al grande mistero della morte. Marilyn fu
trovata esanime, nuda nel suo letto, la notte tra il 4 e il 5
agosto del 1962. Secondo la versione ufficiale la causa
del decesso fu dovuta a un’overdose di Nembutal, lo
psicofarmaco che l’attrice prendeva abitualmente. Ma
anche se è giusto il referto dell’autopsia restano aperte
le tre ipotesi: errore, suicidio, omicidio. La seconda
congettura è la più accreditata ma molti preferiscono
l’ipotesi di Alan Selwyn e Derek Ford ne Il sofà del
produttore. Due mesi prima di morire, Marilyn fu
prelevata da casa e portata in volo in Messico per essere
sottoposta, contro la sua volontà, a un aborto. Il
bambino era di Robert Kennedy al quale il grande
fratello John aveva “passato” l’attrice. Marilyn voleva
quel bambino ma la famiglia Kennedy temeva che
l’attrice, se il piccolo fosse nato, avrebbe svelato prima
o poi la paternità di quel figlio. Da qui la decisione di
uccidere il bambino. Furono due mesi di pianti e
disperazione. Marilyn diventò un fantasma. Sul set non
si presentava, accampava scuse, era depressa, beveva e
si drogava. Ora se quella notte, tra il 4 e il 5 agosto,
l’attrice decise di farla finita oppure se i Kennedy,
timorosi di uno scandalo sempre possibile, l’avessero
fatta ammazzare con un’iniezione di Nembutal liquido,
come sostiene la scrittrice Carol Oates, non sembra più
importante. Marilyn Monroe era stata uccisa
moralmente due mesi prima e poi spinta a morire a causa
di quell’infame aborto.
Il regista e sceneggiatore Donald Wolfe nella
biografia dedicata all’attrice dice qualcosa di più.
Sostiene che Marilyn fu uccisa alla presenza di Bob
358
Kennedy, arrivato in tutta segretezza nell’ abitazione
dell’amante, con una dose di barbiturici sufficiente a
uccidere quindici persone. Poi la casa fu messa
sottosopra alla ricerca di documenti, foto, diari che
potessero rovinare la già traballante reputazione dei
Kennedy. Una settimana prima Marilyn era stata
imbarcata nell’aereo personale di Frank Sinatra e
condotta nel più assoluto riserbo a Lake Tahore, tra le
montagne dell’Alta Sierra, a trecento chilometri da San
Francisco, e ospitata al Cal-Neva Lodge, l’albergo che
Sinatra possedeva col mafioso Sam Giancana. Qui la
diva fu drogata, costretta a avere rapporti con più
uomini e fotografata. Evidentemente quelle foto non
furono sufficienti a mettere al riparo Bob e John dalla
“pazzia” della Monroe. La tesi dell’omicidio fu per altro
sostenuta anche da Norman Mayler in un’altra biografia
al vetriolo messa sotto tutela dall’FBI.
Per accreditare la loro tesi, Selwyn e Ford
raccontano un fatto forse decisivo. Ventidue anni dopo
la morte dell’attrice i due scrittori, che lavoravano come
sceneggiatori e produttori a Hollywood, su incarico di
una casa cinematografica italiana, andarono a trovare
Peter Lawford, ormai vecchio e dimenticato, per fargli
una proposta di lavoro. Lawford naturalmente accettò di
corsa ma quando cominciarono a spiegargli la trama del
film impallidì. Si trattava della storia di una donna che
si vendica di un uomo molto potente. E più i due
giornalisti scendevano nei particolari più l’anziano
attore impallidiva. “Nel momento in cui si accorge che
aspetta un bambino”, raccontarono Selwyn e Ford “la
donna minaccia di farlo sapere a tutti, e minaccia di
dimostrarlo con l’analisi del sangue del bambino,
quando sarà nato, che è proprio figlio dell’uomo
potente. Lui allora la fa rapire e la costringe a un aborto,
perché non ci siano prove”. Lawford a quel punto si
alzò di scatto, tremante, era fuori di sé. “Voi siete
pazzi!” esclamò “Qui ci ammazzano tutti”. Era molto
strano che un attore ormai dimenticato e ridotto quasi
alla carità rifiutasse un’offerta di lavoro e se ne uscisse
359
con quella tremenda frase.
Povera Marilyn. Al compleanno di John Kennedy
indossò un vestito vertiginoso che aveva pagato con i
soldi che non aveva. Ma per il suo presidente voleva
fare bella figura, mostrarsi all’altezza di quel
grand’uomo che non era. Felice compleanno Mister
President. E auguri Mister Fratello. Diciannove maggio
1962. Due settimane più tardi l’aborto in Messico, poi la
morte nella sua casa in stile messicano di Brentwood,
California. Sette anni prima, il 30 marzo 1955, Marilyn,
a una festa di beneficenza, organizzata dal Circo delle
celebrità al Madison Square Garden di New York, si
presentò in groppa a un elefante dipinto di rosa e per
oltre 20 minuti rimase nell’arena salutata dalla folla in
delirio. C’è però da aggiungere che la diva fu costretta a
sorridere suo malgrado, durante quegli eterni minuti,
perché aveva uno spillo conficcato in un gluteo.
Distrazione imperdonabile della sarta.
Alla fine, questa è stata la vita vera di Marilyn
Monroe: uno stupido spillo dimenticato tra perline e
voile di un costume di scena. E tuttavia la sua
immagine, per dirla con Jean Cocteau a proposito di
Proust, continua a vivere come gli orologi al polso dei
soldati morti. Continua a vivere nell’immaginario
collettivo d’America se è vero che una signora di
Beverly Hills qualche anno fa ha messo all’asta la
tomba del marito, che sovrasta quella dell’attrice, con
questo slogan: “Trascorrere l’eternità direttamente sopra
Marilyn”. Come scrive Oriana Fallaci, sempre ne I sette
peccati di Hollywood, il ricordo della morte è bandito
dal cimitero di Forestlawn. “Bella ragazza, non ti
piacerebbe dormire nei secoli accanto a Bing Crosby?
Ho un posticino che va proprio bene per te”.
360
DICIASSETTE
Elizabeth Taylor
La storia di Hollywood sarebbe incompleta senza i
bambini prodigio, i gifted, molti dei quali si sono persi
per strada. Shirley Temple, soprannominata “riccioli
d’oro”, fu una miniera per i genitori. C’era un che di
finto e di irritante nella sua recitazione ma il pubblico,
sempre avido di storie edificanti e di figli assennati,
correva a vederla. Divenuta adulta lasciò saggiamente il
cinema, si sposò con un uomo d’affari californiano,
Charles Black, che le aveva candidamente confessato di
non averla mai vista recitare, e si buttò in politica. Prima
di lei c’era stata Mary Pickford, la ragazzina ingenua e
spiritosa, anche lei coi capelli biondi inanellati, che
cominciò a recitare in teatro a quattro anni accanto alla
madre prima di approdare al cinema con ruoli di
derelitta e diventare la “fidanzatina d’America”. Era una
donna spregiudicata che seppe imporsi con abilità e
astuzia nel mondo artistico così come in quello degli
affari. Baby Peggy, invece, cominciò a recitare a
diciannove mesi. A tre anni era già apparsa in 150 film a
due rulli. Continuò ad affascinare il pubblico, nei
lungometraggi, fino alla fine degli anni Venti, poi subì il
destino inevitabile delle artiste bambine: diventò adulta.
Dean Stockwell, “il ragazzo dai capelli verdi” scoperto
da Losey, continuò a recitare anche da grande ma senza
smalto; così pure Freddie Bartholomew, eccellente
interprete di Capitani coraggiosi di Victor Fleming,
accanto a Spencer Tracy.
In tempi recenti, tra i divi bambini che hanno
oltrepassato senza danni la linea d’ombra c’è da
ricordare Jodie Foster, la più popolare, la più brava.
Cominciò a tre anni con la reclame della crema
abbronzante Coppertone (famoso il manifesto di lei col
cane che le scopre mezzo sederino) per poi approdare al
ruolo della giovanissima prostituta, redenta da Robert
361
De Niro, in Taxi driver. E poi c’è Drew Barrymore,
pronipote di Lionel Barrymore che con il fratello John e
la sorella Ethel diede vita negli anni Trenta e Quaranta
alla cosiddetta Famiglia reale di Hollywood. Anche lei
diventò famosa con uno spot pubblicitario, addirittura a
undici mesi, prima di impersonare il ruolo della piccola
Gertie in E.T. di Steven Spielberg. A nove anni era una
stella di prima grandezza e a dieci aveva sperimentato la
dipendenza dall’alcol e dalla droga. Storia vera,
purtroppo, non come quella che la giovane e
spregiudicata giornalista Janet Cooke del Washington
Post che nel 1981 s’inventò di sana pianta sul bambino
di otto anni assuefatto all’eroina: per quella bufala vinse
il Premio Pulitzer. Nikka Costa, quando aveva ancora i
boccoli, accompagnata con la chitarra dal padre, il
celebre musicista Don Costa, incantò il pubblico con la
canzone On my own. In tempi recenti, Laura Esquivel,
la quindicenne brasiliana, protagonista di una popolare
telenovela, Il mondo di Patty, è stata eletta loro paladina
dai teenagers di mezzo mondo. E lei, Patito Feo, il
brutto anatroccolo come da titolo originale, mostra
un’insospettabile saggezza: “I genitori devono aiutare i
loro figli a comprendere che la vera bellezza è ciò che
hai nel cuore”.
I bambini prodigio, nel cinema come nella realtà,
sono terrificanti. Ma ancora più terrificanti sono i loro
genitori. Justin era un ragazzo americano piuttosto
sveglio per la sua età ma la madre non dormiva la notte,
dunque ancora più sveglia di lui, per farlo riconoscere
come un bambino eccezionale. Per raggiungere lo scopo
si rivolge a istituti specializzati nell’istruzione di
bambini prodigio, e li informa, via Internet, che il figlio,
a soli tre anni, ha superato i test d’intelligenza per
adulti. Una volta ammesso ai corsi, Justin, sempre via
Internet, a cinque anni finisce le medie, a sei si diploma
al liceo Cambridge Accademy e a sette si iscrive
all’università di Rochester, nello Stato di New York. La
madre, come ci informa Ugo Bosetti nella rivista
dell’Associazione Prodigio Onlus di Trento, apre anche
362
un sito Internet intitolato: “Benvenuti nella casa del
bambino più intelligente del mondo”. La fama del
piccolo genio dilaga, Justin diventa ricco con le
donazioni e le offerte di istituti specializzati, finché la
genialità del ragazzino viene messa a dura prova dal
confronto con studenti e professori veri. Dopo le prime
lezioni universitarie, Justin non segue i corsi, vaneggia,
si nasconde sotto i banchi, scoppia in pianti e urli,
prende a calci i muri e i tavoli, rifiuta di mangiare,
vomita in classe. Visitato da uno psichiatra, ne viene
fuori una diagnosi terribile: Justin è un bambino
sconvolto, terrorizzato, quasi psicotico. Se non verrà
sottratto subito alla madre diventerà clinicamente pazzo.
E allora, tutti quei test, quei diplomi e attestati? Truffe,
semplicemente truffe! La madre aveva sostenuto per lui
gli esami, approfittando dell’anonimato di Internet e
della credulità delle scuole. Quando le prove erano
diventate troppo difficili anche per lei, aveva scaricato
via computer i test fatti dai più brillanti studenti del
Paese, li aveva riprodotti, manipolati e attribuiti al suo
Justin.
Nella mia scuola cattolica c’erano ragazzi lenti,
addummisciuti, e ragazzi svegli, come in tutte le scuole
della Repubblica. I ragazzi addormentati avevano la
testa tra le nuvole, forse perché un poco stupidi forse
perché un poco immaturi o romantici, mentre i ragazzi
svegli avevano i piedi a terra, forse perché più
intelligenti o convenzionali. I ragazzi svegli prendevano
buoni voti e alcuni di loro ottimi. Ricordo che ce
n’erano due, bravi ragazzi in verità, che passavano uno
per “latinista” e l’altro per “grecista”. Personalmente li
ammiravo e cercavo di misurarmi con loro pur nella
ristrettezza dei miei mezzi culturali. Anni e anni dopo,
venni a sapere, da uno degli stessi protagonisti, una
verità sconcertante. Il professore di latino e greco, che a
me pareva intransigente e incorruttibile, gli dava lezioni
private. Per i miei genitori era impensabile mandare i
figli a ripetizione, impensabile pagare due volte un
363
servizio già costoso, impensabile che un docente si
prestasse a simili scorrettezze. Evidentemente, a quel
docente sfuggiva un elementare ragionamento: se un
alunno non sta al passo con gli altri tu insegnante hai il
dovere di rimetterlo in carreggiata, se non sei in grao di
farlo, cambia mestiere; ma non puoi sfruttare la
svogliatezza del ragazzo (o la sua limitatezza) per
arrotondare lo stipendio. Il tempio dell’educazione è
uno. Se poi i ragazzi messi a ripetizione diventano i più
bravi della classe il discorso si fa ancora più odioso,
perché l’eccellenza va assicurata a tutti. Non può essere
considerata un extra a pagamento. Ma era così poco
seria la scuola allora! Bastava che il padre di un alunno
possedesse una bella automobile, e ogni tanto la
prestasse all’istituto, perché all’alunno, magari scecco,
magari svogliato, venissero assicurati buoni voti.
Elizabeth Rosemond Taylor era una bambina
prodigio. Spaventosamente bella e sfortunata. Molti
critici aggiungono: inquietante, sensuale, tenebrosa. La
sua vita è stata a dir poco turbolenta, segnata da sette
mariti e otto matrimoni (con Richard Burton si è sposata
due volte), tossicodipendenza, bulimia, malattie,
capricci. Insomma, alla diva è mancata una stagione, è
mancata la primavera. È stata lanciata direttamente
nell’estate, nell’abbaglio della frivolezza e delle
insonnie, per declinare verso l’autunno e infine
approdare nell’inverno più freddo… “dolcissima la
foglia s’abbandona al puro gelo” (Montale). Nel 1945, a
soli tredici anni, gira Torna a casa Lassie di Fred
Wilcox. Ed è un successo mondiale. La storia del cane,
che dopo varie peripezie ritorna dalla padroncina,
commuove grandi e piccini. L’anno dopo si aggiunge un
altro successo importante, Gran premio, in cui
interpreta una ragazzina che si allena con impegno per
portare alla vittoria il cavallo vinto a una lotteria. Le è
accanto Michey Rooney, il “lascerei perdere” ex marito
di Ava Gardner. La leggenda vuole che il regista non
volesse affidarle il ruolo perché troppo piccola di
364
statura. Ma in tre mesi, a forza di cibo, vitamine ed
esercizi, riuscirà a crescere di otto centimetri e ad avere
la parte. Una sorta di pollo in batteria, insomma,
ingozzato con mangimi renforcé e pronto per essere
servito a un pubblico affamato di novità.
A quindici anni è la figlia modello in Vita col padre
di Michael Curtiz, ed è famosa in tutto il mondo,
guadagna mille dollari la settimana e per far fronte ai
numerosi impegni è costretta a lasciare la scuola. Come
la catanese Melissa P. che abbandona il liceo e si
trasferisce a Roma dal fidanzato per promozionare il
super letto Cento colpi di spazzola e scrivere un
secondo romanzetto ancora più inutile del primo. Il
titolo del trasgressivo (o porno?) primo romanzo sembra
copiato da una frase di Fleur Jaeggy (I beati anni del
castigo) e da un’altra di Hemingway (Avere e non
avere) laddove un minore personaggio dell’Avere dà “ai
capelli i primi colpi di spazzola dei cento
regolamentari” prima di andare a letto, prendere il
luminal e addormentarsi avendo cura di non dormire
“con la faccia sul cuscino” per non sciuparla. La stessa
abitudine aveva la giovane Nancy Clutter prima di
essere uccisa a sangue freddo con tutta la famiglia nella
fattoria di Holcomb nel Kansas occidentale. Spazzolare
i capelli serve a ossigenarli e serve anche a pensare, a
interrogarsi, a riassumere la giornata trascorsa, a tentare
di programmare quella che viene, come mi padre faccia
la lolita siciliana nel suo unico momento serio della
giornata.
A diciotto anni, ricca viziata ignorante, dopo
fidanzamenti vari, Elizabeth si sposa per la prima volta:
il prescelto è Conrad Nicholas Hilton, figlio del
presidente dell’omonima catena di alberghi di lusso. “Il
cuore sa quando incontri l’uomo giusto”, dice l’attrice.
Ma dopo otto mesi burrascosi lo lascia. Anni dopo
rivelerà di avere perso un figlio per le botte ricevute.
L’anno del divorzio è l’anno dell’immortale Un posto
al sole di George Stevens. Il film racconta la storia di
un piccolo impiegato di provincia che s’innamora
365
perdutamente di una deliziosa ragazza dell’alta società e
per sposarla pensa di sbarazzarsi della fidanzata, che
pure aspetta un figlio da lui. Per quel pensiero, che si
traduce in un tragico incidente, verrà condannato a
morte. Poche attrici, di quelle che hanno attraversato
idealmente la vita di molti ragazzi di allora, hanno avuto
una così intensa, quasi spietata, influenza. Perché lei in
quel film è bellissima, fragile, elegante, appassionata.
Perché riassume magnificamente le eroine dei romanzi
di Jane Austen e delle sorelle Brontë. Perché lei è
insieme Marianne Dashwood ed Elizabeth Bennett, Jane
Eyre e Catherine Earnshaw. Perché è la storia di un
amore impossibile. Perché lei lo amerà per sempre, e lui
scomparirà per sempre. Perché si piange e ci si dispera,
come nei grandi drammi d’amore, come nell’altro
romantico film Lord Brummel di Curtis Bernhardt,
1954, con la solita strepitosa Liz e uno Stewart Granger,
manierato e dolente, nella parte di Beau Brummel, colui
che insegnò agli inglesi e al mondo a curare l’igiene
personale e a vestirsi con eleganza. Assolutamente
magica in questo film la scena di lui che prende le
distanze dal suo protettore, il principe di Galles, mentre
lei, che gli era stata ostile perché lo riteneva un
opportunista, si scioglie d’amore. E tu, ragazzo di vetro,
non potevi non coltivare quella storia e quella bellezza
dentro di te, dentro i tuoi anni acerbi, non potevi non
coltivare quella giustizia amorosa che trionfava sulle
convenzioni sociali, sulle rigidità di classe e di denaro.
Quel sentimento trovò lacrime e magoni in un altro
film immortale, L’ultima volta che vidi Parigi, di
Richard Brooks,1954, in cui Liz, bella da togliere il
fiato, recita accanto a un bravissimo Van Johnson, che
assomigliava spiccicato a un mio vecchio collega della
Rai, Orazio Ferrara. L’attore, rosso di capelli e di fronte
ampia, interprete di molti film di successo, tra cui
L’ammutinamento del Caine e 23 passi dal delitto, è
morto alla fine del 2008 all’età di 92 anni. La notizia è
stata ignorata da molti giornali. Il Corriere gli ha dato
l’evidenza che si dà alle notizie a fascio, cinque righe.
366
Lo stesso giorno, sulla stessa pagina, campeggiava la
morte di Bettie Page, la regina delle pin-up. Ricordando
il film di Brooks, personalmente avrei rovesciato
l’importanza del lutto.
La storia di L’ultima volta che vidi Parigi s’ispira a
un racconto di Francis Scott Fitzgerald. Lo scrittore ne
realizzò anche la sceneggiatura per un film finanziato
dal produttore indipendente Lester Cowan. Ma non se
ne fece niente, come del resto era avvenuto per quasi
tutti gli script del grande autore americano che non
riuscì mai a sfondare a Hollywood, troppo fatua,
perversa e superficiale per il suo talento. L’ennesimo
rifiuto fu però il colpo di grazia. Scott abbandonò la
carriera di sceneggiatore e tornò al romanzo ma da lì a
poco, il 21 dicembre del 1940, dopo avere lavorato a un
articolo sulla squadra di football di Princeton, a un tratto
si alzò dalla sedia, si aggrappò per un attimo alla
mensola del caminetto e cadde a terra morto. Tra i pochi
amici venuti a rendergli l’ultimo saluto ci fu Dorothy
Parker che era tutto: pianista, poetessa, scrittrice,
giornalista. Si raccolse in silenzio e prima di lasciarlo lo
salutò con queste parole: “Povero bastardo”. Le stesse
parole pronunciate ai funerali del grande Gatsby.
Quattordici
anni
dopo,
la
sceneggiatura,
rimaneggiata da Budd Schulberg, approderà sul grande
schermo con gli attori appena ricordati. Il vecchio Scott
aveva creduto, secondo il giudizio di Cinzia Suglia, di
poter vivere per sempre sotto le luci della ribalta, a
ritmo di jazz. Morirà a 44 anni, quasi caduto nell’oblio.
Davvero drammatica la sorte degli scrittori di talento
che hanno lavorato per il cinema. Raymond Chandler,
che di queste cose s’intendeva, definì la produzione
hollywoodiana di assoluto rigore commerciale e
sommamente lucrativa. Molti di quei film, secondo il
giudizio del grande scrittore di pulp fiction, erano
veicolo esclusivo “per esibire qualche bel tocco di
figliola con due battute e diciotto cambi d’abito, oppure
l’idolo maschile di qualche milione di beceri in doposbronza permanente con il fisico di un bagnino e la
367
mentalità di un ammazza galline”. E tuttavia perché
molti scrittori di talento si piegarono alla logica
mercantile, perché accettarono rapporti di lavoro
umilianti? Pier Vittorio Tondelli non aveva dubbi: “Una
villa con piscina a Bel Air, una moglie in visone, stuoli
di domestici e tanti dollari”.
Dicevo di Un posto al sole. Liz e Monty torneranno
a recitare insieme nel 1959 in un film di Joseph
Mankiewicz tratto da un dramma di Tennessee
Williams, Improvvisamente l’estate scorsa. Niente di
che. Williams lo conobbi nell’estate del 1982, a
Taormina, nella casa dell’antiquario Carlo Panarello.
Parlava un italiano stento ma comprensibile. Era
allegro, cordiale, simpatico con quella faccia da
contadino del Deep South. Lo accompagnava il pittore
Henry Faulkner, omosessuale come lui e amico
inseparabile. La prima volta che arrivò in Sicilia, nel
1948, fu per le riprese di La terra trema di Luchino
Visconti. Lo aveva invitato Franco Zeffirelli che del
film, tratto dal capolavoro di Giovanni Verga, era
l’aiuto regista. Zeffirelli nella sua autobiografia racconta
lo stato penoso in cui lo scrittore giunse dopo il viaggio
in aereo. Per tutta la durata del volo, per paura, s’era
ubriacato, aveva gridato e se l’era fatta addosso. Ma fu a
Roma, come ricorda Ranieri Polese sul Corriere della
Sera, che Williams trovò il suo paradiso: “una festa di
Priapo” con due ragazzi incontrati qualche giorno
prima. Il paradiso, probabilmente, lo trovò anche a
Taormina, visto che vi soggiornava spesso. Nel 1958
accompagnò Anna Magnani, premiata col David di
Donatello, dando vita ai soliti eccessi, come arrivare in
ritardo, ubriacarsi e vantarsi di avere scritto La divina
commedia. Un giornalista di Paese Sera gli dedicò un
articolo al vetriolo nel quale, al limite del buon gusto,
scrisse che Williams aveva le mani unte e pelose come
chi “è abituato a frugare tra la biancheria maschile
sporca”. Lo scrittore non sporse querela. “Il fatto che sia
uscito su un giornale comunista”, disse “diminuisce
368
l’efficacia del danno, e poi è così tanto cattivo da essere
ridicolo”.
Gli feci tante domande alle quali rispose con garbo e
intelligenza. Gli chiesi che valore avesse per lui la
provocazione. Mi rispose che la provocazione era
l’unica strada per arrivare alla verità. Poi mi disse che
amava gli italiani del Sud per il loro calore… “perché
dopo la morte si ha tutto il tempo per essere freddi”.
Quando gli domandai chi fosse il più grande
drammaturgo americano, naturalmente dopo di lui, mi
allargò un sorriso senza risposta. Provai a incalzarlo.
Eugene O’Neill? Per altro, premio Nobel nel 1936. Lui
mi fissò con i suoi occhi azzurri, che avevano la
profondità e la tristezza del vecchio Mississippi, si
guardò in giro, tornò a fissarmi e disse abbassando la
voce: “Eugene O’Neill non sapeva scrivere!” Poi
scoppiò in una fragorosa risata. E allora chi è il più
grande? Diventò serio. “Harold Pinter è il più grande
drammaturgo vivente”. Un lusinghiero, e condivisibile,
giudizio su Pinter è stato di recente espresso dal premio
Nobel per la letteratura sir V.S. Naipaul, che per la
verità ha demolito molti scrittori di talento, a partire da
Jane Austen e finire a Hemingway e Dickens. Forse un
po’ più di rispetto per quegli autori, che hanno
affascinato intere generazioni e l’hanno piegate alla
riflessione e alla comprensione dell’invisibile che sta
sotto gli occhi, avrebbe accresciuto il suo prestigio di
romanziere non ancora sancito dalla storia. Quando il
conservatore e aristocratico Naipaul sarà in grado di
scrivere un romanzo come Addio alle armi allora
soltanto, forse, potrà dire di Hemingway che “era così
occupato ad essere americano che non sapeva nemmeno
dove stava”. Ferma restando l’insopportabilità della
battuta.
Hemingway l’ho amato per la sua scrittura di
apparente semplicità, per la forza dei suoi personaggi,
per la sua vita ribelle, perché ha ispirato film immortali
come Addio alle armi (nelle due versioni), Per chi
suona la campana, Le nevi del Kilimangiaro, Il sole
369
sorgerà ancora, Il vecchio e il mare, perché ha amato
Venezia e il suo mistero, i cocktail del Caffè Florian,
sotto i portici di piazza San Marco, e i piatti straordinari
dell’Harry’s Bar di Cipriani (la cui figlia, bella e
altezzosa ma con qualche numero professionale, fu per
breve tempo mia collega al TG1) e perché lì, nella
Laguna tra Caorle e Bibione, Hemingway ha trovato
uno dei suoi grandi amori, la figlia del barone
Raimondo Nanuk Franchetti, che diventerà l’eroina del
romanzo Al di là del fiume e tra gli alberi.
Al festival di Taormina del 1967, tre mesi prima che
partissi per il servizio militare, furono invitati per la
“notte delle stelle” al teatro antico Elizabeth Taylor e
Richard Burton, allora la coppia più famosa del cinema
internazionale. Erano innamoratissimi, si tenevano per
mano, si scambiavano sorrisi e tenerezze, ma litigavano
dalla mattina alla sera. Lei lo chiamava “sporco gallese
ubriacone” (Burton, che negli ultimi anni beveva due
bottiglie di whisky e una di gin al giorno, morirà di
cirrosi epatica), lui replicava con epiteti non meno
ingiuriosi: “palla di lardo”, “bambola senz’anima”. Si
erano conosciuti in Italia, nel 1963, sul set di Cleopatra,
il kolossal di Joseph Mankievicz che porterà alla rovina
la Fox. Lei era sposata con Eddie Fisher, letteralmente
rubato all’amica Debbie Reynolds, lui era sposato con
Sybil Williams. Creò scandalo quello scippo d’amore.
Debbie Reynolds era un’attrice di piccole aspirazioni e
di grande garbo. La ricordo in Tammy, fiore selvaggio,
una storiella agreste, diretta da Joseph Pevney nel 1957,
il cui dolce leit-motiv è interpretato dall’attrice con
romantica freschezza e che valse agli autori, Ray Evans
e Jay Livingston, una nomination all’Oscar. Restò per
mesi nella classifica dei dischi più venduti e ascoltati
negli Stati Uniti.
La maggiore vittima del divorzio Fischer-Reynolds
fu la figlia Carrie, futura principessa Leila in Guerre
stellari. Di recente, l’attrice, notevolmente ingrassata e
con due matrimoni falliti alle spalle, s’è definita come
370
“il tragico prodotto dell’incestuosità hollywoodiana”.
Per dire che fuori del set tutto si combina e si definisce
nell’assoluto disprezzo dei sentimenti, delle regole
valoriali, dell’amore per i più deboli e indifesi. Tammy,
fiore selvaggio la cantavo con mia sorella affidando il
rigore del testo alle prime battute… “Tammy…
Tammy… Tammy’s in love…” il resto era il solito nanà, na-nà, na-nà che accomodava la nostra ignoranza
anche su altre bellissime canzoni come Wonderful,
wonderful day interpretata da Jane Powell in Sette spose
per sette fratelli, True love di Cole Porter avendo in
mente la versione di Bing Crosby e Grace Kelly in Alta
società, San Francisco trillata da Jeanette MacDonald
nell’omonimo film, Be my love che Mario Lanza
cantava con la superba Kathryn Grayson, Somewhere
over the rainbow che amavamo attraverso le voci di
Judy Garland e Rosemary Clooney, zia di George, e
così via cantando e fantasticando.
L’amore tra Liz e Richard divampò con grave
scandalo del Vaticano che vide maturare l’unione
infedele sotto le proprie mura. Ottenuti i rispettivi
divorzi, si sposarono l’anno dopo e per dieci anni si
amarono e se le diedero di santa ragione. Ma non
potevano fare a meno l’una dell’altro. “Se mi lasci mi
uccido”, le scrisse una volta Richard. “Non vivo senza
di te”. Prima di morire le mandò un’ultima lettera,
contraddittoria e confusa, ma l’ultima frase fu questa:
“Ti amo e ti amerò per sempre”. Entrarono nel salone
del San Domenico come due regnanti senza corona. La
folla non li faceva respirare. Mi passarono accanto e fu
una delusione. Avevo nel pensiero Angela Vickers ed
Helen Ellswirth, le protagoniste di Un posto al Sole e
L’ultima volta che vidi Parigi. Mi trovai davanti una
donna piccola di statura, un po’ in carne e
bamboleggiante. Più simpatico lui, l’ubriacone,
dodicesimo figlio di un minatore del Galles, attore
shakespeariano per eccellenza, sorriso aperto, carisma
indiscusso. Furono accolti da un’orchestrina a plettro
composta di simpatici vecchietti. L’atmosfera era quella
371
giusta: musiche siciliane, long drink, bourbon per
Richard, limonata per Liz, very well, ammirazione per il
mare, il sole e il folclore siciliano dei tamburelli e delle
coppole di velluto. Poi ancora folla di curiosi, latin lover
e aspiranti starlet, autografi, noia, fili di sguardi
annodati e sciolti… finché Liz si alzò di scatto dalla
poltrona, nella quale forse intendeva appartarsi, strappò
di mano la chitarra a uno degli orchestrali e la fracassò
in testa al marito, reo di fissare troppo una biondona non
indifferente al suo fascino. Alcuni anni prima Richard il
tenebroso le aveva regalato un diamante a forma di pera
di circa 70 carati.
Partii per il militare il giorno del mio compleanno.
Mio padre e mia madre mi accompagnarono alla
stazione. Avevo il cuore piccolo, ma una speranza: la
parola di Mario Ciancio che al mio ritorno sarei stato
assunto e messo in regola. Cosa che avvenne
puntualmente. Il mio posto, alla terza pagina e agli
spettacoli, fu provvisoriamente occupato da Saretto
Magrì, un collega di Espresso Sera, che per un anno e
mezzo fece la malavita che io avevo fatto per un mese.
Fu bravo e leale. Qualche anno dopo passò in modo
definitivo a La Sicilia. Allora tutti i redattori del
giornale del pomeriggio aspiravano al quotidiano del
mattino, più prestigioso ed economicamente sicuro. A
La Sicilia non sarebbe mai avvenuto che i giornalisti
venissero pagati in ritardo o con surrogati come accadde
ai dipendenti del monarchico e ormai asfittico Giornale
dell’Isola del duca di Misterbianco che una volta
ricevettero a mo’ di acconto una tessera d’ingresso al
Lido dei Ciclopi di proprietà dell’editore.
Purtroppo i due giornali erano costretti a subire
l’imperio della SPI, la società che procurava la
pubblicità e quindi buona parte dei loro introiti. Ciò
significava che gli articoli non potevano contenere nomi
di aziende, titoli di film, marchi di fabbrica e tutto ciò
che poteva essere sfruttato in modo pubblicitario.
Insomma, i giornalisti dovevano contraddire se stessi,
372
essere cioè generici, impersonali, servili alla SPI e alla
Proprietà. Come ricorda Melo Timpanaro nel suo bel
libro “Senza titolo”, nel quale ripercorre la sua
straordinaria avventura umana, non si potè più scrivere
“Gli scioperanti si radunarono in via Etnea davanti
all’Eden Bar” ma semplicemente “si radunarono in via
Etnea davanti a un bar”. Di fronte a queste censure
preventive, talvolta comiche talvolta imbarazzanti,
l’unica strada era svicolare, inventare, ricostruire, darsi
alla letteratura. Una volta il collega Annibale Giordani
del Corriere di Sicilia affrontando un fatto di cronaca
scrisse: “Aiutai il soccorritore a tirare il cadavere dalla
scarpata. Presolo per le spalle, il morto girò il capo
dall’altra parte: forse non gli era piaciuta la mia cravatta
rossa a palline gialle”. Dashiell Hammett non avrebbe
saputo dire meglio.
Mia madre tirò fuori il fazzoletto, mio padre serrò le
mascelle, ma in fondo era contento che suo figlio
andasse a fare il militare. I colleghi della mia
generazione, e anche di quella precedente, si evitarono
la seccatura con raccomandazioni e imbrogli. Un
collega si fece passare per pazzo perché alla visita di
leva mostrò di avere bisogno di lavarsi continuamente le
mani. Ovviamente, i “militi esenti” glorificavano le
virtù del coraggio, della fiamma tricolore,
dell’agonismo, del rugby… e alcuni di loro menavano
vanto di non avere mai letto un libro in vita loro.
Dopo un mese e mezzo di Car, Centro addestramento
reclute, alla caserma Scianna di Palermo, fui trasferito
all’Ufficio Propaganda e Documentazione dell’Esercito
di via XX Settembre a Roma. Una pacchia, a parte
l’alzata alle cinque del mattino col termometro che
scendeva sotto lo zero. Fu un inverno terribile quello.
Andavo a letto col pigiama di felpa e il pullover. Le
coperte le mettevo in doppio e vi aggiungevo il
cappotto. La mia branda era vicina alla finestra, le cui
imposte erano sconnesse e non furono mai aggiustate
nonostante le mie rispettose proteste. Mi tenni gli
spifferi gelidi della notte e il disappunto. I soldati
373
dovevano soffrire. Solo così, dicevano gli alti comandi e
la retorica militare, la vita nelle caserme aveva un senso.
Comunque, rose e fiori rispetto a certi film
sull’addestramento militare americano. Penso a
Ufficiale e gentiluomo di Taylor Hackford del 1982 con
uno strepitoso Richard Gere e un’altrettanto strepitosa
Debra Winger, penso a Storia di un soldato di Norman
Jewison del 1984 e al terribile Full metal jacket di
Stanley Kubrick.
Al confronto, la vita nelle caserme italiane era una
passeggiata. Al più potevi misurarti, se ne avevi la
personalità, col nonnismo degli anziani i quali, per la
verità, di fronte a un aggettivo ben piazzato restavano a
bocca aperta. Più volte, ricordando quel tempo
“ordinato”, mi sono venute in mente le parole di Sándor
Márai quando nell’autobiografia Confessioni di un
borghese mette a confronto l’ordine tedesco con
l’ordine francese: “Mi ci vollero anni per rendermi
conto di che cosa fosse veramente l’‘ordine’, per
comprendere che nelle menti dei francesi, anche se da
loro la polvere la si faceva scomparire sotto gli armadi,
regnavano un ordine splendente e una chiarezza
immacolata”.
Il mio lavoro consisteva nel leggere i giornali,
ritagliare gli articoli che riguardavano l’esercito, riunirli
e mettere in evidenza i più importanti. Alle undici del
mattino, con altri due commilitoni, avevo finito. Mi
restava il tempo per avvilirmi e pensare alla mia terra. Il
sabato sera mi mettevo in borghese e con un mio caro
amico, Emanuele Pluchino, che lavorava alla Banca
d’Italia, me ne andavo a ballare. Tornai a Catania alcuni
mesi dopo. Caserma Sommaruga. Battaglione II/5.
Avevo trovato una strada. Uno dei colonnelli di stanza
al Presidio collaborava al giornale. La telefonata gliela
fece Vittorio Consoli, allora vice-capocronista. La
mattina lavoravo in amministrazione (l’ufficio era retto
da un maresciallo di Noto, grasso, simpatico e
pasticcione) e talvolta chiacchieravo con un altro
carissimo amico, Peppino Siracusa, che stava al reparto
374
Genio e che era stato mio compagno di banco alle
elementari e alle medie, ora è professore universitario di
chimica. Il pomeriggio facevo un salto al giornale a dare
una mano, a respirare l’aria della redazione che sapeva
di carta, inchiostro e intramontabile goliardia. Era il
mio mondo. Con pazienza sopportavo lo sfottò dei
colleghi, per lo più riformati e che del servizio militare
avevano un’idea cinematografica. Eppure, del
linguaggio da caserma erano appassionati cultori, come
tutti gli orecchianti, come tutti quelli che amano la
disciplina nelle case d’altri e mai nelle proprie. Il 1968,
l’anno del terremoto del Belice e del terremoto sociale
in Italia e in Europa, lo passai incolonnando cifre e
preparando gli stipendi agli ufficiali. La mia dècimala
regalavo a un soldato che non aveva nemmeno il sale
della saliera.
Le turbolenze della città mi arrivavano filtrate. Non
potevo affacciarmi su quel mondo in presa diretta.
Avevo la divisa e la toglievo di nascosto solo per andare
in redazione. Ma gli anziani, che assieme agli studenti
occuparono l’università, li conoscevo più o meno tutti.
Ricorda Tino Vittorio: “Sbattemmo la porta in faccia ai
fascisti, fracassando la caviglia a un compagno che non
aveva fatto in tempo a ritrarre il piede, incastrato tra il
battente e il portone del Palazzo Centrale”. Una scena
addirittura comica, perché il comico si affaccia sempre
nei risvolti del dramma. Sennonché quel ragazzo,
qualche anno dopo, “in seguito e forse a causa di quel
trauma osseo”, morì nella totale indifferenza. “L’unica
vittima del ’68 a Catania”. Chi se ne ricorda? Perché da
noi la tragedia talvolta scolora nella farsa o nell’eroismo
di maniera, superficiale e inconcludente, scolora nello
slogan, nella passione che parte sparata e arriva
boccheggiante al traguardo, semmai ci arriva, perché
noi figli di papà ci stanchiamo presto, perché dopo un
atto straordinario pensiamo subito alla mamma e
cerchiamo di nasconderci per evitare altre tensioni e
responsabilità: la rivoluzione va bene ma a piccole dosi,
tra un cappuccino e l’altro, e con le assemblee è meglio
375
non esagerare, meglio affiggere un cartello, “Torniamo
subito!” e andare a passeggio o a dormire. Chissà quante
risate per quel ragazzo, occhialuto e fragile,
protagonista, a loro vedere, di una gag più che di un
dramma. Questo moto collettivo, ora pulsante ora
assente, me lo sono perso, impegnato com’ero a rifarmi
ogni sera e ogni mattina il “cubo”, a dire “signorsì” e a
pensare che la vita, tolte le mostrine, sarebbe stata bella.
Il 1968 è anche l’anno di due film di Liz Taylor
girati con il grande regista inglese Joseph Losey: La
scogliera dei desideri, ignorato dal pubblico e dalla
critica nonostante la superba interpretazione dell’attrice,
e Cerimonia segreta, altro film difficile e comunque
estraneo alla luminescente vetrina tayloriana. Se il 1968
fu il colpo di rasoio che divise il Novecento
dall’Ottocento, per la diva dagli occhi viola fu il confine
tra la giovinezza e la maturità, il limite oltre il quale
finisce l’ascesa e comincia il declino. Prima erano i
tempi di Piccole donne, Il padre della sposa, Ivanhoe,
La pista degli elefanti, L’albero della vita, Venere in
visone…
alcuni
artisticamente
mediocri
ma
indimenticabili per la smagliante bellezza dell’attrice,
per il suo temperamento drammatico, per la sua capacità
di stregare milioni di spettatori, di farli sognare, renderli
vibranti di commozione e amore. Dopo saranno i tempi
di Mercoledì delle ceneri, A un’ora della notte, Il
giardino della felicità… dimenticare, dimenticare,
dimenticare.
La cadenza del verbo mi ricorda un lungo viaggio in
treno: da Catania a Kiel, la città tedesca del Baltico,
testimone di una storica malacomparsa siciliana. Due
giorni e mezzo assieme agli orchestrali, al coro e alla
dirigenza del Teatro Massimo Bellini in tournée in
Germania. Due giorni e mezzo di sofferenze, anche
perché dividevo lo scompartimento con un anziano
collega al quale puzzavano i piedi. Alla fine, l’approdo
nella fredda cittadina tedesca di vento e di mare. È il 27
376
settembre 1970. Il borgomastro della città riceve il
sindaco di Catania, venuto comodamente in aereo,
riceve i rappresentanti della stampa, i cantanti,
l’orchestra e il suo direttore.
Il giorno dopo, nel teatro comunale, sarà
rappresentato il capolavoro di Vincenzo Bellini, Norma,
sotto la direzione del vecchio maestro Oliviero De
Fabritiis e l’interpretazione principale del soprano greco
Elena Suliotis, definita l’erede della Callas. Veniamo
ricevuti in pompa magna. Siamo allegri e disinvolti. A
un certo punto una signora, che il sindaco di Catania ha
presentato al borgomastro come la moglie, mi vede, mi
viene incontro e mi abbraccia. È una ragazza che
talvolta incontravo allo Yachting club (bionda, carina,
sciocchina) e che mi era stata raccomandata da una
collega della Rai siciliana, Bianca Cordaro, all’epoca
una bellissima ragazza. “Che ci fai qui?” mi domanda
con l’aria di portare vasi a Samo. “Faccio il mio lavoro”
rispondo. “E tu?” “Sto col sindaco”. Il sindaco assiste
da lontano alla scena, si avvicina, mi prende
sottobraccio e si raccomanda alla mia discrezione.
Mantenni l’impegno ma per non mentire evitai di citarlo
nelle corrispondenze. La notizia tuttavia filtrò e fu data
in pasto all’opinione pubblica perché un mio collega da
buon giornalista fece esplodere lo scandalo sul Tempo,
di cui era corrispondente. Il sindaco rischiò il posto e
non mi perdonò mai. Lo scandalo tedesco segnò la fine
della sua carriera politica. È passato alla storia per avere
assetato il Pigno, un quartiere abusivo a sud della città:
“Il Pigno ha sete e Micale se ne fotte”. L’anno dopo,
alle elezioni amministrative, Catania voltò le spalle a
quel sindaco democristiano che in lista figurava col
numero 36. I cittadini che l’avevano sullo stomaco
fecero affiggere sui muri della città un altro manifesto:
“Siccome me ne fotto voto 38”. Anche la DC prese una
sonora batosta. La città preferì mettersi in testa il
cappello nero dei missini, lutto o rigore che fosse, e
cominciò a guardare indietro.
Ho concluso questa modesta biografia, scandita
377
dall’orologio di celluloide, con Elizabeth Taylor perché
è stata l’ultima diva dei nostri cuori acerbi, l’ultima diva
che ha attraversato il regno delle ombre. Ai suoi funerali
c’erano i quattro figli, gli otto nipoti e i quattro
pronipoti. Pare che avesse disposto di arrivare in chiesa
con quindici minuti di ritardo. Una piccola leggenda,
come le tante che hanno assediato la sua vita
tumultuosa. Mi fermo sul suo stesso crinale. Dopo
saranno altri anni, altri incontri, altre esperienze, altri
sogni e delusioni. Mi fermo alle proiezioni del
Dopolavoro ferroviario e dello Spadaro, i miei cinema
Paradiso, i luoghi dove sono cresciuto accanto ai libri,
dove ho imparato a raccontare le storie e le avventure
della mia vita, dove ho costruito la persona che sono
oggi, la persona che si è felicemente sposata, che non ha
avuto figli e che ha maturato dentro di sé il dolore degli
altri. C’è una bellissima scena nel film di Giuseppe
Tornatore. Il protagonista, dopo avere ricordato la sua
vita di ragazzo trascorsa nella cabina di proiezione del
cinema Paradiso, accanto ai racconti del vecchio amico
operatore Philippe Noiret, scopre che questi prima di
morire gli ha lasciato un regalo: una bobina con le
rapide sequenze dei baci censurati. Se volessi ripetere
quel finale potrei mettere in sequenza alcune scene
memorabili. Comincerei dalla regina Greta Garbo sulla
prua della nave che la porta in esilio; proseguirei con
Marlene Dietrich, seduta su una botte, che canta Ich bin
von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt; con Vivien
Leigh, in lacrime, dopo avere pronunciato la
celeberrima frase “Domani è un altro giorno”; con Rita
Hayworth, che si sfila il lungo guanto di raso nero. Poi
passerei a Ingrid Bergman (“Suona la nostra canzone,
Sam”), a Grace Kelly (sui tornanti di Montecarlo in
Caccia al ladro), a Audrey Hepburn che in Vacanze
romane si sfila una scarpa mentre viene presentata al
corpo diplomatico.
In una foto-ricordo, scattata durante una pausa della
lavorazione di quest’ultimo film e pubblicata nel 1954
dal settimanale “Oggi”, accanto all’attrice stanno due
378
autentiche nobildonne romane: Virginia Ruspoli e
Flaminia Torlonia. Al confronto sembrano due signore,
piuttosto anzianotte, che il regista ha preso direttamente
dalla strada, le ha agghindate a festa e le ha messe al
fianco della principessa di celluloide Audrey nel cui
sangue, per altro, scorreva lo stesso sangue blu delle sue
smarrite dame di compagnia. Non potrei scordare Janet
Leigh (nella scena della doccia mortale) e Marilyn
Monroe (nel saloon, mentre canta The river of no
return). Chiuderei con Elizabeth Taylor, nel momento
in cui va a trovare Montgomery Clift in prigione, prima
di essere giustiziato. La vita e la morte, lo splendore e
l’abisso sono colti in quell’ultima scena non nella
separazione che li renderebbe convenzionali, come in un
cartellone pubblicitario, ma insieme mescolati
drammaticamente.
379
Finale di partita
Moltissime cose non ho raccontato della mia vita, un
po’ per autocensura e un po’ perché non erano
funzionali al discorso o semplicemente perché non me
le sono ricordate. Spero soltanto d’essere riuscito a
trasformare gli episodi trascurabili della mia esistenza in
una rappresentazione, seppur minima, della mia
generazione che era vestita di grigio, che amava il
cinema e la sua illusione.
All’alba del Duemila, o giù di lì, è cominciato
l’autunno. Il dormiveglia della giovinezza, “quello stato
di innocenza e suscettibilità”, come lo definisce Márai, è
morto e sepolto. Anche se talvolta mi sorprendo a
scoprirlo come un’insospettabile lontana risonanza. Non
mi pento di avere lasciato anzitempo il Tg1. Non c’era
futuro in quel telegiornale di raccomandati, d’intrecci
politici, di uomini mediocri e ambigui. Ne ricordo uno,
in particolare, che ha fatto un’ottima carriera. Oltre i
suoi meriti. Disprezzava i poveri. Se Dio non li avesse
voluti – diceva – non li avrebbe creati. Ed era, fino agli
anni Cinquanta e Sessanta, il ragionamento dei bianchi
d’America sulla popolazione nera: il Signore ha fatto i
niggers, con quel colore disgustoso, per essere servi dei
bianchi. Ogni sera questo distinto signore wops,
rigorosamente cattolico, batteva a macchina, e non al
computer, per non lasciare tracce immagino, una specie
di documento informativo, non saprei a chi diretto. A
quel tempo, radio fante diceva che aveva rapporti con i
servizi segreti. Spesso, a tarda sera, veniva a trovarlo un
misterioso amico, un certo Roberto se ben ricordo.
Forse quelle note erano a lui destinate. Alla luce delle
vicende che hanno posto al disonore della cronaca il
direttore di Libero, Renato Farina, adesso deputato del
PdL, che collaborava col Sismi, quel lontano sospetto
può avere qualche fondamento… o forse è tutta una
storia di apparenze. E poi m’ero stancato di fare il
380
pendolare.
Il cielo di Catania, che mi piangevo quand’ero triste
e solo nell’azzurro trasteverino (come nella bellissima
canzone, Napoletana), m’è venuto incontro un
pomeriggio di primavera, tenebroso e foriero di pioggia,
senza profondità e colore. Il cielo di sempre, il cielo
privo d’illusione. Negli anni Settanta c’era un detto che
circolava nel capoluogo siciliano, come ricorda Matteo
Collura: “Quando Dio vuole fregare qualcuno lo fa
nascere a Palermo”. In realtà, nascere in Sicilia è stata
sempre una fregatura, sin dai tempi della civiltà araba
che ci insegnò la poesia e il modo di coltivare la terra
ma costrinse i nativi a portare segni distintivi per evitare
che si confondessero coi dominatori, come avrebbero
fatto dieci secoli dopo i nazisti con gli ebrei. Una
fregatura, per altro, sottolineata in molte commedie
all’italiana nelle quali il dialetto siciliano diventa
sinonimo di arretratezza culturale se non di stupidità.
Memorabile, ne I soliti ignoti di Monicelli, la figura di
Tiberio Murgia che per gelosia tiene sotto chiave la
bella sorella Claudia Cardinale oppure la battuta del
figlio soldato di Peppino De Filippo, nel film
Arrangiatevi! di Bolognini, che per protesta contro la
famiglia pensa di farsi trasferire in un luogo sperduto,
lontano, “a Catania!”
In fondo, ho scritto questo libro per delusione e per
bisogno. La delusione di una città ritrovata diversa, o
forse dovrei dire “giudicata” diversa, mi ha spinto a
recuperare la memoria del tempo perduto, il tempo dove
si colloca lo spazio immortale della giovinezza, Il
giardino dei Finzi-Contini di Bassani. Per dire. E così
ho cominciato a scrivere. Per pensare meglio,
recuperare il passato e allontanare la morte, la sua
angoscia. Insomma, ho cercato di vivere la vita acerba
perché la vita matura, come dice un poeta del Trecento,
Cecco d’Ascoli, si raggiunge nell’aldilà. A riflettere, la
“vita matura” è un mito, una rappresentazione
(consolatoria) di ciò che non possiamo raggiungere
perché a noi è dato percorrere e raccontare solo la vita
381
che non si definisce, la vita che non culmina nella
perfezione, nel suo completamento, perché noi stessi
siamo imperfetti. Se la vita appare necessariamente
immatura nell’infanzia e nella giovinezza, perché
l’esperienza del mondo è ancora limitata, e comunque di
là da venire, non è però vero che con gli anni essa
raggiunga la pienezza. La vita è fatta di segmenti,
ciascuno dei quali è per forza di cose incompleto, ma la
somma dei segmenti non compone una linea definitiva,
non stabilisce una “maturità” completa, assoluta. Al
termine del percorso c’è sempre un altro segmento che
potrebbe rischiararci ulteriormente il cammino, darci la
misura totale della retta. Ma se ciò non accade è perché
sopraggiunge la morte. Da qui l’intuizione di Cecco
d’Ascoli. E si capisce meglio la battuta di Raymond
Chandler: “Alla fine sapeva veramente tutto, ma solo
quello”. Che cosa, allora, rende seducente il passato?
Che cosa spinge l’uomo a tuffarsi in quel gorgo
impreciso? Andando indietro negli anni, sempre più
indietro, fino alla radice, la ricerca della felicità o della
sua illusione si trasforma in ricerca del sacro, ricerca di
un ricongiungimento con la parola nel suo formarsi, con
i concetti primordiali, con l’universo intuito nel ventre
materno e mai afferrato. Un’illusione, indubbiamente.
Come un muoversi d’ombre su un grande telone bianco.
Ha proprio ragione Oscar Wilde: “Essere immaturi
significa essere perfetti. Anzi, innocenti. Come bambini
appena nati”.
L’innocenza paga sempre. È rimasta nelle battute di
corso Umberto, ad Acireale, dove un tempo il
marciapiede di destra era riservato agli uomini e quello
di sinistra alle donne, l’ingegnosa trovata di un
candidato alle elezioni municipali, un certo Giuseppe
Nicolosi, detto Pippo Gel, di Alleanza nazionale, che
aveva fatto tappezzare i muri di manifesti con la foto di
lui bambino di tre mesi, l’espressione imbronciata, gli
occhi spalancati, le dita grassottelle, un amore di bimbo
insomma. Sopra, la scritta: “Un’idea che viene da
lontano”. Pippo Gel, come la gran parte dei suoi
382
colleghi, non potendo garantire altro esibiva l’unica
innocenza possibile, quella dell’infanzia. Nessuno gli
fece osservare che un bebé appena nato non può avere
idee.
Di recente, nel blog di uno studente, ho letto questa
riflessione: “Io amo Catania. Non la cambierei con
nessun’altra città. Eppure in questi ultimi tempi non
sembra più la città accogliente, festosa, romantica che
era una volta. E provo un’immensa nostalgia. Adesso è
cambiata, è sporca, immersa nel caos, pullula di
delinquenti e prostitute. Ovunque. Vorrei che tornasse
come quella che descrive la canzone di Castiglia. Vorrei
che tornasse a splendere il sole a Catania…” La canzone
di Giuseppe Castiglia, quello che racconta barzellette
nelle televisioni locali, immagino, è intitolata Catania,
figghiozza do Patri Eternu. Il verso finale fa così:
“Catania da guerra, Catania urricata,/ distrutta e pi setti
voti rinata/ non c’éntrunu i sordi, non c’entra ’a furtuna/
Catania ’ndo munnu ci n’è sulu una”. Ma se i problemi
della città fossero solo caos, delinquenti e prostitute
diremmo solo una parte di verità, la più semplice, la più
visibile. Ci sono ben altri problemi, sotterranei, che
contraddistinguono non solo Catania ma un po’ tutte le
città meridionali. Problemi che attengono ai poteri forti,
nascosti, legati alle massonerie, alle zone d’ombra che
rendono confuse legalità e illegalità. Altro che
prostituzione! Tutto questo ha spinto molta gente in
gamba a lasciare, andare via. Perché la città, come dice
Antonio Di Grado, “solitamente immemore, è avvezza a
divorare i suoi figli migliori (nel migliore dei casi, a
espellerli) che non ad onorarne la grandezza o, quanto
meno, a sfruttarne le competenze”.
Eppure, Catania nella prima metà del secolo scorso e
subito dopo la guerra, pur scontando l’arretratezza
politica e sociale che ha riguardato il Mezzogiorno nel
suo complesso, aveva conosciuto modelli culturali e
imprenditoriali che l’avevano resa diversa dal resto
dell’isola e in qualche modo avvicinata al Nord. Lo
stesso giornale in cui sono cresciuto aveva come stella
383
polare il Corriere della Sera e sin dalla fondazione si
era legato all’unità del Paese non alla sua dissoluzione.
Memorabili furono le battaglie contro il movimento
indipendentista che voleva scorporare la Sicilia per
farne una stella americana. Oggi, ci siamo tristemente
omologati verso il basso, verso le pulsioni meno nobili e
più vili della società. Un’omologazione distruttiva in cui
la parola ha perduto la sua efficacia, in cui la ricerca di
senso del vivente non coglie alcuna verità. È come se
l’uomo (a Catania come altrove naturalmente) si
trovasse di fronte non a uno spazio aperto in cui
collocare il suo confine, sempre mobile, ma davanti a
uno specchio che lo riflette senza possibilità di
alternative o di altre profondità.
Non molto tempo fa la “vocazione” indipendentista
siciliana ha conosciuto rigurgiti, e risvolti, comici. A
Palazzo Madama, dove si celebravano i duecento anni
della nascita di Garibaldi, l’ineffabile senatore Calderoli
(quello che ha definito “una porcata” la legge elettorale
che portava la sua firma) ha detto: “Lui (Garibaldi) e i
Savoia hanno fatto il male della Padania e del
Mezzogiorno”. La polemica ha raggiunto toni epici con
il presidente dell’Assemblea siciliana, Gianfranco
Miccichè, che ha detto: “È giunto il momento che anche
questa falsità storica cessi di occupare i libri sui quali
studiano i nostri figli. Cominciamo a prendere
seriamente in considerazione l’ipotesi di intitolare più
piazze a Federico II che a Garibaldi”.
Federico II? Che cosa c’entra con Garibaldi? Tra i
due personaggi corrono sei secoli di storia non tutti
precisamente limpidi. In mezzo ci sono gli Angioini, gli
Spagnoli e i Borboni che hanno reso la Sicilia una
colonia che più colonia non si può. Garibaldi mise in
crisi il regno borbonico mica quello illuminato di
Federico II, detto Stupor mundi. Tutta questa storia
puzza di borbonismo e di furbizia; così come l’attacco
al movimento partigiano di qualche anno fa puzzava di
fascismo: mentre i partigiani da tutti eroi passavano a
tutti delinquenti Mussolini veniva in qualche misura
384
rivalutato. Confesso che, a una prima lettura, l’assurdità
dell’implicito paragone mi aveva fatto traballare gli
occhi: anziché Federico II avevo letto Ferdinando II
che, a rigore di logica, si collega meglio a Garibaldi. E
m’era venuto facilissimo contestare il presunto assunto
dell’on. Miccichè, ricordando innanzitutto le vicende di
Ferdinando I che mangiava i maccheroni al sugo con le
mani, sconcicava le contadinotte durante la caccia e
lasciava la politica alla moglie, perché lui aveva cose
più serie da fare. M’era venuto facile ricordare anche Re
Bomba, che si mise sotto i piedi i siciliani, e suo figlio
Franceschiello che il padre chiamava Lasagna per via
dello smodato amore per il cibo.
Invece no. L’on. Miccichè non è uno sprovveduto.
Sa che la razza dei Ferdinando e dei Francesco è
impresentabile e così ha tirato fuori dal cilindro il nome
presentabile, anzi presentabilissimo, di Federico II. Che
scoperta! Solo che con Garibaldi non c’azzecca per
niente, come direbbe Di Pietro. Sarebbe come
contestare Vittorio Emanuele II mettendolo a confronto
con Giulio Cesare. Senza capire, in definitiva, o forse
capendolo perfettamente, che criticando Garibaldi, e
annoverandolo nella categoria dei delinquenti, rivaluta
implicitamente la monarchia borbonica che ancora oggi
trova convinti estimatori. Forse gli antigaribaldini
farebbero un migliore servizio alla verità guardando
meglio in casa propria, alla fallimentare politica
autonomistica di Palazzo d’Orléans, ai parlamentari
siciliani, autostipendiati di lusso, che qualche anno fa
furono “costretti” a prolungare le ferie di Natale fino al
carnevale per mancanza di leggi da approvare.
Chiamare in causa Garibaldi, addossandogli ogni
nefandezza politica e persino militare, prendendo per
buone le diffamazioni dei servizi segreti borbonici
durante la campagna di Sicilia, per giustificare le colpe
non tanto della Repubblica italiana (che sono scontate)
ma quelle (incommensurabili) della “repubblica”
siciliana è operazione miope e truffaldina. Purtroppo, è
il giudizio di Giorgio Bocca, “il ritorno dilagante delle
385
retoriche, delle menzogne sta oscurando il cielo”.
Come diceva il mio professore di storia e filosofia al
liceo, la storia non si fa coi se, come pretenderebbero
leghisti e autonomisti siciliani. La storia ha il suo corso
immodificabile e ogni ipotesi contraria acquisterebbe il
sapore di un paradosso: se Napoleone non fosse stato
sconfitto a Waterloo, se i soldati italiani non avessero
ricacciato gli austriaci oltre il Piave, se Garibaldi fosse
stato ucciso nelle campagne di Salemi… a quest’ora noi
siciliani vivremmo nel paese di Bengodi dove, come
scrive Boccaccio, le vigne si legano con le salsicce e nei
fiumi al posto dell’acqua scorre il vino; un Paese senza
mafia e senza disoccupati, insomma, ricco e felice. Ma
mi faccia il piacere! Avrebbe detto Totò.
L’orologio di celluloide spesso si ferma. Mi
dimentico di dargli la corda. Ogni tanto incontro per
strada persone sconosciute che mi riconoscono per via
d’una rubrica domenicale che ho tenuto per sei anni su
Telecolor-Video3. Mi fermano, mi chiedono scusa, si
rammaricano del mio silenzio. Ma il mio silenzio è stata
una scelta dolorosa e necessaria dopo che Nino Milazzo,
allora direttore di Telecolor-Video3 fu costretto alle
dimissioni. Nino, che è un vecchio e valoroso collega,
mi dava ampia libertà e nemmeno leggeva i miei pezzi
per scomodi che fossero. Andato via lui non potevo
sottostare alla direzione di un altro. E di quale calibro
professionale fosse l’altro si vide qualche mese dopo.
Né Mario Ciancio mi invitò a restare né raccolse
alternative possibili e naturali. Un giorno uno di quegli
“ammiratori” mi disse: “Non si preoccupi, se c’è da
difenderla noi la difenderemo”. Quelle parole avevano
un senso morale alto ma indefinito, come ogni
testimonianza di solidarietà. Ne fui contento e
confortato. Ora che i miei sermoni domenicali non
segnano più alcun appuntamento mi convinco che
niente è più illusorio della stima. La stima è come un
sorriso a lungo manifestato: dopo un po’ fa male alle
mascelle e occorre tornare a chiudere la bocca.
Comunque, non mi sembra di essere solo. C’è una
386
pattuglia di uomini in grigio alle mie spalle, ci sono
amici che stimo. L’altro giorno ne ho sentito uno al
telefono. Mi ha detto: “Ti voglio bene. Te lo dico anche
se ciò ti annoia”. Mi sono commosso. Ho pensato a
molte delle persone che hanno attraversato la mia vita,
nella gioia e nel dolore. Alcune non ci sono più, sepolte
dalla vita o dalla morte. Molte sono andate via, molte
sono rimaste, per viltà o per scelta, come ne La camera
verde di Truffaut in cui il protagonista resta in provincia
a custodire le memorie dei suoi morti… come in un
campo lungo alla fine di un film. Immagino Henry
Fonda che si allontana al galoppo da Cathy Downs sulla
scia musicale di My darling Clementine. L’identica
scena rivedo ne Il cavaliere della valle solitaria con
Alan Ladd, magnifico Shane, che lascia, dopo averla
difesa, una famiglia di coloni del Wyoming per
continuare ad errare nelle praterie della sua solitudine.
Viceversa, vedo Glenn Ford, ne La pistola sepolta, che
sceglie di restare nella cittadina dove ha trovato amore e
serenità accanto alla dolce Jeanne Crain. Allo stesso
modo si comporta Horst Buchholz ne I magnifici sette:
dopo la sanguinosa battaglia, per liberare un villaggio
messicano dalle scorrerie del bandito Calvera,
abbandona la colt per gli occhi e il sorriso d’una ragazza
del luogo. Del resto, la vita di ciascuno di noi, modesta
o superba che sia, può entrare in un film; non solo
perché i film s’ispirano alla realtà ma perché questa
realtà i film ce la rimandano con un contorno di piccola
leggenda o di piccolo mito che serve a consolarci e a
non farci smarrire, a cullarci in realtà, ad addormentarci
quando la disillusione è troppo forte. Ma anche quando
ti arriva come un pugno nello stomaco e non ti permette
di respirare ti consente almeno di riflettere.
Penso a Nino Milazzo, che porta con sé il pudore
della provincia e l’amarezza d’una lontana vita privata
non precisamente felice. Era il collega che sollecitava i
miei articoli in prima pagina al posto di altri che
giudicava mediocri. Un uomo elegante, schivo, colto,
complesso, mai pago dei successi ottenuti. Di recente ha
387
pubblicato un libro autobiografico, Un italiano di
Sicilia, che aveva fatto stampare in poche copie per gli
amici più intimi. Nella prefazione, Francesco Merlo lo
definisce perfettamente, e con lui tutti quelli apparentati
dal tormento: “Ragazzi dotati di una luce particolare,
sono diventati diversi e fragili questi nostri giovani
Holden etnei che possono approdare a nulla o alla
letteratura, al comunismo o alla malinconia, alla musica,
alla religione, alla normalità delle professioni liberali o
al più alto codice del giornalismo come è accaduto a
Nino. Ma sempre quel rodìo dentro li renderà pronti a
una nuova fuga, a un nuovo ritorno”.
Penso ad Aldo Motta, vecchio gentiluomo di
provincia, conservatore illuminato, scrittore ed editore,
anagraficamente ricco di ben quattro nomi, “alcuni
bellissimi”, confessa “eppure mia madre mi chiamava
sempre Disgraziato”. Anni fa venne in possesso di
vecchie foto della famiglia dell’imprenditore inglese
Robert Trewella, arrivato in Sicilia con la massoneria e
che alla fine dell’Ottocento costruì per il governo le
ferrovie a scartamento ridotto, compresa la
Circumetnea. Trewella aveva una bellissima moglie,
Margriet, che per anni tenne salotto in una delle
splendide ville del viale Regina Margherita, a Catania,
frequentata da artisti e scrittori tra cui Martoglio,
Rapisardi, Capuana, Verga, De Roberto. Affascinato da
questa signora d’altri tempi, colta e spiritosa, Aldo
pensò di inventarne la storia utilizzando la tecnica del
diario. Maturò l’idea per mesi poi un giorno si decise a
mettere nero su bianco. Per entrare meglio nella
psicologia della protagonista si vestì da donna con un
abito prestatogli dalla sorella, “ad eccezione delle scarpe
che non mi entravano”. Cinque giorni di lavoro alla
scrivania con pochissime interruzioni. La mattina del
primo giorno, tuttavia, il portiere, che nulla sapeva,
suonò per la posta. Aldo gli aprì senza imbarazzo e
l’uomo non poté trattenersi dal commentare: “Prufissuri,
macari lei?” Uno dei bersagli preferiti di Margriet era il
precettore dei figli, giudicato moralista e parruccone.
388
Ecco un saggio della prosa immaginifica di Aldo: “Sono
certa che non godo di sua stima perché penza che io ho
tanti amanti, e non può essere che così perché esco sola,
guido auto, fumo sigarette e bevo the corretto con
alcool. E ho sempre Andrea a canto anche cuando non
ci è il mio sposo. E io faccio a posta e dico a Andrea:
metti tua mano su spalla mia cuando viene il
rompicoglioni”. Aldo Motta è una miniera di aneddoti.
Ha frequentato fino all’ultimo la libreria “La Cultura” di
Carmelo Volpe dove spesso lo incontravo. L’ultima
volta mi ha raccontato del matrimonio del padre che
spostò la data della cerimonia perché il mandolinista
Gioviale, artista di fama mondiale, si trovava in quel
momento all’estero e quindi non avrebbe potuto
eseguire l’Ave Maria di Schubert. Rientrato, suonò in
modo talmente divino che “anche i santi si misero a
piangere”.
Penso a Giacomo Alessi, il ceramista più raffinato
della Sicilia. Quando ho visto le sue creazioni, e le ho
confrontate con le porcellane alla moda che
troneggiavano orgogliose sui cassettoni e le consolle di
casa mia, ho capito quanto mi fossi allontanato da me
stesso, dal piccolo mondo antico dei miei nonni e dei
miei genitori, dal mio essere siciliano meticcio, come
tutti, come quelli che abitano una terra violentata dalle
dominazioni straniere, solare e infelice, eppure salda nel
suo essere zattera del mare Nostrum. Così ho infranto la
lastra di ghiaccio che mi divideva dalla fanciullezza e
sono entrato in maniera irreversibile nella caverna di Alì
Babà, che è il laboratorio di Alessi, nel luogo magico
dove prendono forma e vita le cose che non contano più
pur contando moltissimo. Ho così rivisto, tangibilmente,
gli oggetti del mio passato, le lucerne antropomorfe, per
esempio, che i miei nonni portarono in dote come cimeli
preziosi di anni ancora più lontani. Erano state
acquistate alla fine dell’Ottocento a Caltagirone, la
“città dei cantri” come la definivano i catanesi che, di
rimando, subivano la giusta reazione dei calatini:
“Catanisi che corna tisi”. Mia madre, quando il buio
389
perdurava, accendeva quelle lucerne parlanti piene
d’olio, piene di sentimento e di splendore. Ed era come
un tuffo nelle crinoline, nei valzer e nei ventagli, nei
baciamano e negli sguardi senza sguardo. Mai lucerne
sono state a un passo dal trasformarsi anch’esse, come
in un film di Walt Disney, in oggetti petulanti e
danzanti, così come i candelabri a tre o a cinque bracci
appoggiati sui comò, oppure i lampadari di legno o di
cristallo che una volta, al posto delle lampadine,
avevano le candele, destinate, se non si stava attenti, a
sgocciolare sul pavimento.
Penso a Puccio Corona e a Mario Petrina, colleghi a
La Sicilia e poi alla Rai. Quando decisi di lasciare il
TG1, Puccio mi pregò di non farlo. Era sinceramente
dispiaciuto. Mario mi seguì da lì a poco e utilizzò la
liquidazione per aiutare un fratello in cattive acque e il
genero allora disoccupato. Penso a Gaetano Caprino,
avvocato con studi a Catania, Milano e Roma.
Dividevamo le spese di un “pensatoio” attaccato alla
timpa di Acireale. Vi partecipava anche Vittorio
Corona. Penso a Bruno Vespa che perfezionò il
trasferimento e mi diede anche la promozione: un arco
perfetto che partiva da sinistra e arrivava al centro e a
destra. Ma fu solo una irripetibile congiuntura perché in
seguito patii sulla pelle la dura legge della lottizzazione.
Non avendo una forte connotazione politica (leggasi un
decisivo appoggio di partito, di curia o di salotto) fui
sistematicamente escluso d’ogni avanzamento di
carriera e aumento di merito. Quando c’era la destra al
comando mi consideravano di sinistra e quando al
potere saliva la sinistra mi gettavano tra le braccia della
destra, dei perdenti di turno.
Demetrio Volcic, già corrispondente da Mosca, fu un
direttore autorevole, colto, professionale, con una vita
piena di esperienze e storie da raccontare ma anche lui
aveva il piombo nelle ali e non riuscì a superare i muri
ardui della politica. Si complimentava per i miei servizi,
apprezzandone la misura e (bontà sua) l’eleganza, per
come organizzavo il lavoro, ma altri erano i nomi che
390
gli venivano suggeriti dalle segreterie di partito. Allo
stesso modo, sul versante opposto, si comportò Carlo
Rossella, che lo sostituì. Vestiti di buon taglio, scarpe a
suola alta, cravatte Marinella, vanesio, furbo, fece di
tutto per essere all’altezza del predecessore. Se ne
distinse sdoganando Bruno Vespa che era stato cacciato
via dal direttore generale con l’aiuto di buona parte
della redazione. Ricordo che a una riunione di
sommario, alla proposta di un collega di affidare a
Vespa il commento di una notizia importante, Volcic
rispose che non era il caso perché la presenza dell’ex
direttore, che tante polemiche aveva suscitato, avrebbe
compromesso, cito a memoria, l’immagine stessa del
TG1. Giudizio che mi colpì e che mi parve eccessivo.
Fu benzina sul fuoco del risentimento di Vespa. Durante
le riunioni, Carlo Rossella spesso si faceva passare le
telefonate dall’estero e faceva sfoggio del suo inglese.
Forse, come le avrebbe definite Angelo Musco, erano
telefonate “senza lastra”, senza pellicola cioè, fasulle,
senza interlocutore all’altro capo del filo, eppure
l’effetto era magnifico. Il suo era un giornalismo frou
frou, da rivista patinata, non da quotidiano ruvido e
coraggioso. Sarebbe stato un ottimo direttore di riviste
femminili e di pettegolezzo. Quando al TG1 diede una
“sterzata rosa” fu soprannominato Rossella O’Hara.
Particolarmente odioso fu il comportamento di
Giulio Borrelli. Eravamo amici. Per qualche anno
avevamo lavorato in cronaca. Buon professionista,
aveva una buona capacità di organizzare strategie
demolitorie contro i direttori “nemici”, in odore cioè di
sacrestia, e fu lui uno dei capi della rivolta anti-Vespa.
Nominato direttore si comportò con un cinismo degno
del KGB. Ed io fui costretto a lasciare il TG1 e a
riprendere la via del ritorno che assomigliava a un altro
esilio. Come direttore ebbe l’abilità di farsi fuori da sé.
Era ammalato di cesarismo. Deludente, in
quell’occasione, fu anche Lamberto Sposini col quale
avevo un buon rapporto. La sua prima preoccupazione
fu quella di fare il consigliere del principe e non capì il
391
disagio dei colleghi senza patria, dei colleghi come me
che lavoravano in trincea, attenti a non farsi colpire dal
fuoco amico. Adesso, dopo che un ictus, poco prima di
“andare in scena”, l’ha spezzato come una marionetta,
cerca di trovare un senso alla sua menomazione. Questo
mi addolora molto. Di altri non mette conto parlare.
Mediocri, opportunisti, marinai, professionisti del nulla
insomma. Per dirla con Francesco Alberoni, più erano
agitatori e ribelli più pensavano alla carriera. Duro ma
esemplare il giudizio di Francesco Merlo espresso nel
suo sulfureo e graffiante pamphlet Faq Italia: “La Rai è
gestita da funzionari e direttori di telegiornali che sono
sempre e comunque emissari governativi travestiti da
giornalisti, ‘camerati’ e ‘camerlenghi’ – quasi sempre
bravi, per carità! – che hanno l’invidiatissimo privilegio
di entrare nella camera del re e di pulirgli il sedere”.
Mi restano buoni ricordi di Giuseppe De Carli
(ahimè scomparso anzitempo), Cesare Pucci, Marco
Varvello, Lilli Gruber, Laura Cason, Francesco
Giorgino, Dino Cerri, Carlo Pilieci, Tiziana Ferrario,
Marco Frittella, Maria Rosaria Gianni (una calabrese
tosta e, naturalmente, cocciuta). E abbiamo finito. Anzi,
no. Affettuoso fu il comportamento del personale non
giornalistico. Dopo il mio rientro a Catania alcuni
colleghi sono morti improvvisamente. Rispetto a altri,
che restano incistati nei loro privilegi di soldi e di
potere, hanno pagato un prezzo che andrebbe imputato
al Cielo se la giustizia divina non seguisse
imperscrutabili sentieri di salvezza e dannazione. I loro
volti talvolta li metto a fuoco, talvolta non ne ricordo i
nomi. Allora mi sembravano invincibili, e forse lo
erano, come Paolo Frajese, cronista dal carattere
impossibile, democristiano di destra che per farsi
mandare a Parigi come corrispondente si fece
raccomandare dalla sinistra; come Willy Molco, che
teneva il cellulare acceso anche di notte nel caso il
direttore Borrelli avesse avuto bisogno di lui; come
Federico Scianò, cattolico di sinistra, punto di
riferimento di molti colleghi coi quali s’incontrava nel
392
chiuso della sua stanzetta e parlava parlava; come Bruno
Palmieri, segretario di redazione, intimo amico di
Nuccio Fava, elegante, aria di padreterno,
morbidamente cinico, sostanzialmente superfluo; come
Paolo Giuntella, anche lui cattolico di sinistra ed
esponente di spicco del comitato di redazione, amava
andare al lavoro in scooter, alla maniera di Nanni
Moretti, e vestire come un intellettuale impegnato:
diventato presbite e fremendo per farsi vedere con gli
occhiali se li mise anche per focalizzare da lontano, e si
rovinò anzitempo la vista.
A Gregorio Zappi voglio rendere onore estraendolo
dal mazzo del cordoglio comune. Lavorava con me,
fianco a fianco, nella redazione cultura. Era un grande
competente di musica classica, lirica e sinfonica, e di
musica leggera. Era mezzo scombinato, allegro,
sciupafemmine, a volte inaffidabile… ma che persona!
Non portava rancore a nessuno, nemmeno al suo
caporedattore che lo bistrattava spesso e volentieri; era
generoso, buono, irriverente, mai servile, sempre a
schiena dritta. È morto così. Non so bene come. Ero
lontano. È morto forse perché la sua molla, sempre tesa
e rimbalzante, s’è d’improvviso spezzata. Aveva gravi
problemi familiari che confidava solo a me e che teneva
rigidamente separati dal lavoro. Roma spesso mi manca.
Gregorio Zappi sempre mi manca. Paragonato agli altri
era un gigante. Non amava il compromesso, non amava
la politica, non amava i mestatori, non amava niente di
niente di ciò che oggi fa piccola e ancor più governativa
la Rai.
I miei dieci anni romani, pur difficili, non sono stati
perduti; sono stati anni di crescita, di distacco dalla
provincia,
come
abitudine
e
mentalità,
di
consapevolezza dei problemi della società nazionale.
Sono stati utili per superare “la mentalità da isola”, che
Hitchcock rimproverava agli inglesi, una mentalità che
molto spesso stringe i siciliani in un cappio ossessivo di
inconcludente superbia.
Tornando al ricordo degli amici, penso a Giovanni
393
D’Angelo, magistrato di Cassazione, che come me ama
il cinema e i libri. Presentando Il vulcano spento è
riuscito a cogliere, come pochi, il senso del romanzo, la
sua “leggerezza francese”, il linguaggio che risuona a
volte dell’antica parlata siciliana, granitica ed
espressiva, che purtroppo va scomparendo per essere
sostituita da una sorta di argot tecnologico, improprio e
meschino.
Penso a Silvia Ventimiglia, ultima arrivata tra gli
amici ma già così presente e spiazzante. Un vero
caterpillar. Lavora come giornalista in una radio locale e
le sue interviste sono amabilmente graffianti, ti spolpa
vivo e alla fine la ringrazi pure. È la sorella piccola di
un mio compagno di classe al Leonardo, Mario,
bravissimo e attento. La domenica mattina indossava
una magnifica tunica rossa con cotta liturgica bianca e
serviva messa scampanellando ch’era un piacere
(talvolta lo affiancava Filippo Cosentino). E noi
compagni, ridotti allo stato laicale, gli facevamo piovere
sul capo fulminanti invidie, per pentircene alla
consacrazione: mani giunte, testa al petto, confuse
richieste di perdono mentre il sacerdote ostentava l’ostia
ai fedeli. I Ventimiglia abitavano di fronte alla scuola, al
primo piano di un palazzo ingrigito dagli anni. Mario
aveva vari fratelli che con gli anni sarebbero diventati
sette. Ma aveva soprattutto due sorelle più grandi che ci
facevano girare tecnicamente la testa. Loro passavano e
noi, incrociandole, senza osare di guardarle o
minimamente salutarle, davamo loro un tempo
ragionevole per allontanarsi e poi ci giravamo di scatto.
Qualche anno fa Silvia per fare contenti alcuni nipoti,
che volevano un cucciolo di razza non comune, prese il
volo per Venezia, nelle cui vicinanze c’era un
allevamento di Corgi Pemproke, meglio conosciuti
come i cani della regina, noleggiò un’auto e se ne tornò
col cagnolino, avendo cura di pagare un secondo
biglietto per non farlo stare nella stiva dell’aereo.
Giunta a Catania i nipotini, come tutti i nipotini d’oggi
che hanno il sederino pieno, come diceva mia madre,
394
squadrarono la magnificenza canina e spararono
l’odioso commento: “Meglio il Jack Russell”.
Penso a Emanuele Milano, addetto al montaggio dei
servizi televisivi Rai a Catania. Il più bravo, il più
fantasioso, il più rompiballe. Era sposato con una brava
ragazza, aveva tre splendidi figli, era felice. Un giorno
se la pensò, abbandonò la famiglia, lasciandole però in
vitalizio quasi tutto lo stipendio, e partì per un posto
lontano. Vive a Lima, in Perù. Ha una nuova compagna,
ha lo stesso orizzonte del mare dove brilla inquieto il
silenzio.
La parentesi del dolore è ancora più lunga, la mia
personale Spoon River. Penso a Candido Cannavò, alla
sua saggezza e al suo coraggio, all’amore per la madre,
alla tormentata infanzia, agli alti traguardi raggiunti con
forza e determinazione, e che ha avuto la cortesia di
citarmi nella sua autobiografia, Una vita in rosa. È
morto tra le braccia del figlio Alessandro e l’Italia
sportiva, e non solo, l’ha pianto a lacrime calde.
Candido era un vincente. Lo diventò una mattina
d’estate in cui caddero le prime bombe a Catania. Si
salvò per miracolo, lui e la madre. Avendo visto la
morte con gli occhi, promise a se stesso di afferrare la
vita, non di sfiorarla o di starle semplicemente accanto,
e di guidarla verso i pascoli fioriti dell’impegno, della
lotta, del sacrificio, della lealtà e alla fine del successo.
A lui vanno affiancati altri amici e colleghi che hanno
inciso nella mia vita.
Penso a padre Corsaro, poeta vicino ai simbolisti
francesi e all’ermetismo, che pubblicò i miei primi versi
sulla rivista Incidenza e che abitava all’ultimo piano di
un palazzo senza ascensore ma pieno di luce e di libri.
Nella stanza grande, che fungeva da biblioteca e salotto,
non c’erano crocifissi alle pareti. Si respirava religiosità
non fanatismo. Le pareti, allattate di bianco, appena
spolverate dal grigio degli anni, rispecchiavano un
Ottocento letterario, intimamente siciliano, come i
pavimenti di cemento colorati e intrecciati a mo’ di
tappeto che correvano per l’abitazione, come l’odore di
395
carta e d’inchiostro, come il senso del passato che
voleva dialogare col presente, come la solitudine
nascosta come un fantasma col quale è doveroso
confrontarsi. La solitudine del sacerdote, aggiungerei,
che alla fine di una giornata operosa di parole e di
insegnamento vuole tornare a discutere col mistero e
l’invisibile. E magari il solitario poeta talvolta tornava a
affacciarsi, in una tiepida sera d’estate, dal suo balcone
incantato pensando ai versi che quella pace gli
suggeriva. “Perduto nella notte stellata, rapito dalle
fiamme aeree/ guardo i fiori celesti/ guardo un Dio che
splende, rapito in un bosco d’oro,/ perduto tra le foglie,/
nella notte piena d’occhi, nel cupo mare di perle,
guardo/ un Dio acclamato”. Uomo di Chiesa, uomo del
passato liturgico ma non del suo cerimoniale, uomo
antico ma anche moderno, persino anticonformista.
Aveva un vezzo padre Corsaro. Portava i capelli lunghi.
Non era uno scherzo per quei tempi. Non solo la
Diocesi ma anche i benpensanti, e ce n’erano tanti, lo
guardavano con sospetto ed avevano forti dubbi sulla
sua ortodossia di parrino. Ma lui se ne fregava, forte
della sua indomita coscienza. Se ne fregava anche a
dispetto dell’estetica. Verso gli anni Ottanta, quei
capelli grigi volti al bianco, lo facevano assomigliare a
una vecchia signora. Al suo ottantesimo compleanno gli
chiesi che cosa significasse essere poeti. “Essere poeti”,
rispose “significa essere chiamati a una follia e a una
saggezza incredibile, spesso indecifrabile”.
Penso a Nino Minissale per oltre 50 anni sacerdote.
Aveva studiato esegesi biblica all’università gregoriana
di Roma, all’università ebraica di Gerusalemme, alle
facoltà di teologia evangelica di Gottinga e Heidelberg e
alla facolta di teologia cattolica di Münster. A lui si
devono gli studi più importanti sul Siracide, uno dei
libri del Vecchio Testamento, tradotto e commentato
dall’aramaico. Lo conobbi a Praga, un anno dopo
l’invasione delle truppe del patto di Varsavia. Era lì con
altri giovani a ricordare la primavera politica,
timidamente democratica, di quel grande e nobile Paese,
396
soffocata nel sangue. Mi ricordo il giorno, 20 luglio
1969. Me lo ricordo perché in quelle ore l’equipaggio
dell’Apollo 11 stava rapidamente avvicinandosi alla
Luna dove il comandante Armstrong, seguito dal
collega Aldrin, avrebbe lasciato la propria impronta alle
2 e 56, ora di Greenwich. Eravamo rimasti amici. Dopo
avere girato mezzo mondo per i suoi studi, e con un
cursus honorum invidiabile, aveva scelto di vivere nella
sua Catania. Intelligente, timido, di fulminante ironia,
amava definirsi “una capra”, l’animale che la storia ha
consegnato all’ignoranza ma che ha dimenticato di
annoverarne le doti di ostinazione e curiosità. È morto
nel sonno, tra le braccia del Dio sconosciuto che aveva
tanto studiato.
Penso a Gerardo Farkas, capo delle province, uomo
del silenzio e dal carattere ombroso ma dotato di
fulminante ironia. Talvolta andavo a trovarlo nella sua
redazione, che teneva pressoché al buio per mantenere
la concentrazione sul lavoro, e parlavamo di cinema e di
arte. Imponeva la sua autorità col semplice sguardo e la
voce cavernosa e imperiosa. Penso a Giuseppe
Catalano, capo della redazione Interni-Esteri. Un
signore. Scriveva le corrispondenze per Il Giorno con
una calligrafia larga e per me illeggibile: un concetto
ogni pagina. Come Orio Vergani. Penso a Salvatore
Nicolosi, capocronista, detto Turi Nick, uomo dal
carattere spigoloso e difficile ma intelligente e colto. Ai
giovani che gli portavano i comunicati stampa del
Comune e di altri enti pubblici o privati raccomandava
sempre: “Il comunicato si manda prima, poi, se c’è il
morto, si telefona”. Parlava a raffica e raccontava storie
magnifiche. È morto in solitudine, confortato
dall’affetto dei suoi, della figlia Miranda soprattutto. Ai
funerali c’erano pochissime persone: qualche vecchio
collega e nessuno dei potenti che in vita lo avevano
temuto e blandito.
Penso a Giuliano Consoli, collega brillante,
assolutamente déraciné dalla famiglia e da se stesso,
gaudente, sottaniere e sfasolato fresco. Quand’era in
397
trasferta alloggiava in alberghetti di terza categoria
portandosi appresso una valigia di cartone con dentro
vecchi giornali. La mattina presto, per non pagare il
conto, fuggiva dalla finestra lasciando, come pegno
beffardo, il vecchio bagaglio che la sera prima, non
avendo presentato la carta d’identità, gli era servito per
rassicurare il locandiere. Analoga fuga, da comica
finale, la fece una volta in compagnia di Mario Giusti
che in quel campo non gli era secondo. Della stessa
pasta era fatto Totò Musumeci, tipografo, suonatore di
violino al Teatro Massimo, strepitoso barzellettiere e
uomo di assoluta simpatia. Aveva trovato il modo per
non pagare al cinema. Entrava con cipiglio e durezza
d’espressione e alla maschera, toccandosi il bavero della
giacca, diceva: “Forza”. E quella lo faceva entrare senza
obiezioni. Una volta il proprietario del locale, avendo
assistito per caso alla curiosa scenetta, chiese
chiarimenti. “Un pezzo grosso della forza pubblica”.
Non convinto della spiegazione dell’impiegato, aspettò
la fine della proiezione e quando lo vide uscire,
trottorellante e felice, gli chiese i documenti. “Ma quale
polizia!”, esclamò Totò Musumeci. “Dico sempre ai
suoi ragazzi Forza nel senso di farsi coraggio perché la
serata è lunga”. Una variante era il pacco dei giornali
che affidava alla maschera. “Mi raccomando, tienilo
d’occhio. Lo riprendo all’uscita”. Lo scopo era quello di
confondere l’impiegato facendolo concentrare sui
giornali anziché sul biglietto. Siamo in piena commedia
all’italiana, a Totò e Peppino, a Sordi e Tognazzi, a
Gassman e Manfredi, con uno spolverio di teatro
dialettale, muschiano e martogliano, che fa la cifra dei
catanesi di un tempo, quei catanesi che non abitavano
nelle loro case di pietra con gli ammezzati ma
direttamente nelle piazze e nelle strade cittadine,
nell’agorà simbolica di una città che non s’era fatta
ancora sopraffare dalla mafia e dalla volgarità.
Erano tanti i personaggi di allora, assimilabili in
qualche modo a Chaplin e ai comici della Keystone di
Mack Sennett: litigiosi, irriverenti, coraggiosi e vili allo
398
stesso tempo. Ne ricordo uno che consigliava agli amici
di calzare scarpe di una misura più piccola per
assaporare il piacere a fine giornata di togliersele e
massaggiarsi i piedi con voluttà dopo tanto supplizio. Il
consiglio lo estendeva, rovesciandolo, ai vestiti:
scegliere due taglie più grandi per farsi poi dire quanto
s’era dimagriti. E a non parlare degli scherzi che
popolavano le fantasie acerbe di quei ragazzi, muscolosi
e beffardi, come il muro costruito nottetempo davanti al
portone di casa di una delle tante vittime ritenute
“soggette” (a Catania un “tipo soggetto” è uno che è
facile mettere in soggezione, alla berlina; senza
cattiveria, però, solamente per il gusto della derisione,
dello sberleffo goliardico, della violenza infantile e
cialtronesca). E quello, il “soggetto”, ch’era stato in
vacanza, di fronte al muro improvviso, a non capacitarsi
e a cercare altre strade, altri sbocchi e numeri civici per
individuare la propria abitazione.
Penso a Luigi Arcidiacono, già preside della facoltà
di legge, ai suoi sogni giovanili, a come li ha
compiutamente realizzati, pur nelle difficoltà della vita e
a Roberto Morrione, autentico guerriero del giornalismo
televisivo, che mi accolse con stima e amicizia nella
redazione cronaca del TG1. Un male incurabile li ha
trascinati entrambi nel regno delle ombre.
Penso a Stefano Paternò, ragazzo pieno di vita, bravo
nello studio e nello sport, ucciso da una fulminante
leucemia alle soglie della maturità classica. Sono passati
cinquant’anni. Gli anni che non ha vissuto, gli anni che
lo tengono, per mistero divino, nella terra fredda e negra
di carducciana memoria. Penso a Nuccio Saitta, un
compagno di scuola, bravissimo in italiano, che non
prese nemmeno la maturità e finì con l’impiegarsi come
contabile nella ditta Costanzo e che un giorno andò a
contemplare il mare in tempesta, alla Scogliera, e si
buttò giù, come Martin Eden, lasciandosi annegare.
Penso a Stefano Giunta, perseguitato dal sogno di un
amore impossibile, nato tra i banchi del Cutelli, e morto
d’infarto dopo che la moglie, qualche anno prima, era
399
volata giù dal balcone di casa. Penso ad Alfio Sapienza,
esagerato in tutto, nel cuore e nella bocca, anche lui
ucciso da un infarto. Amava la vita, le donne, le carte, il
cinema. Penso a don Antonino, il contadino che veniva
di tanto in tanto a curare il giardino di casa mia e che
una volta, parlando di fede e di credenze religiose, mi
disse: “Quand’ero piccolo e avevo una fame che mi
sarei mangiato anche le pietre il Signore non l’ho mai
incontrato”. Anche lui un giorno se ne andò a fare una
passeggiata lungo il molo di Santa Maria La Scala e si
buttò in mare. Quando lo ripescarono aveva gli occhi
aperti e uno strano sorriso. Penso a Nino Marchese,
proprietario assieme al fratello della trattoria Don Saro
di viale Libertà, una volta ritrovo di attori, vip e
sfaccendati. Si è accasciato al suolo, una mattina
d’autunno, davanti all’edicola dove aveva appena
comperato il giornale. È morto senza un lamento, in
mezzo alla gente, alla sua gente che gli voleva bene.
Penso a un compagno di studi all’università, ragazzo
acuto e brillante. Colpito da ictus cerebrale, fu lasciato
dalla moglie, proprio quando aveva più bisogno di lei,
come un sacco vuoto. E allora lui,incapace di reagire e
di farsi una ragione del suo male e dell’abbandono,
trovò la forza e il coraggio di uccidersi buttandosi dalla
finestra. Con questo mio compagno, diventato
funzionario della Dogana al porto di Catania, nei
momenti di pausa dallo studio, parlavamo di ragazze, di
lavoro, di matrimonio, di figli. E questo futuro
immaginato si disegnava nei suoi occhi brillanti e
speranzosi. Anche lui sognava il grande amore, senza
poter immaginare che questo si sarebbe polverizzato su
mezze parole sciancate, su passi disarticolati, su occhi
imploranti. Si può essere così crudeli?
Penso a Marcello Zingales, compagno di classe al
Leonardo, intelligente, serio, ottima carriera
amministrativa al Senato, lunga e penosa malattia. Se
pongo mente agli anni del ginnasio, agli scherzi già
ricordati, mi viene un magone che mi precipita nello
smarrimento. Penso a Saro Pogliese, morto sul lettino
400
per un difficile trapianto di polmoni. Suonava la chitarra
ed aveva una madre che sapeva leggere nel cuore delle
persone. Una volta, mentre noi ragazzi ammiravamo
l’auto nuova di un ex compagno di classe, mi disse:
“Arriverà il tuo tempo”. Non avevo detto o manifestato
alcunché ma lei aveva letto nel mio pensiero. Il tempo
sarebbe arrivato ed io qui voglio ricordare l’acume e la
bontà di questa donna che amava teneramente il figlio e
gli amici del figlio. Penso a Lello Giardina,
appassionato di vela, lavoratore instancabile: un infarto
gli ha spaccato il cuore. Pochi secondi per rendersi
conto che lasciava una moglie innamorata e due figli
ancora giovani. Penso a Pippo Costa e a Vito Di Marco,
l’uno farmacista l’altro medico, amici inseparabili.
Nella vita, e nella morte. Penso a Manoli Rimini, nipote
del pittore Roberto, tra i pochissimi costruttori che non
si sono mai arricchiti. Solo alla fine della professione
riuscì a comperarsi una casa.
Penso a Rino Nicolosi, per sette anni presidente della
Regione siciliana, finito nei guai con la giustizia ma che
aveva un’intelligenza politica di prim’ordine. Si dissero
tante cose sul suo conto: che possedeva palazzi a Parigi
e tenute in Canada e in Brasile. Una volta,
incontrandomi in aeroporto, mi confessò: “Tu non ci
crederai, ma ho seri problemi economici”. Circolarono
anche strane voci sulla sua malattia che lo avrebbe
portato alla morte prematura. Forse raccogliendo queste
voci, la commissione antimafia andò a trovarlo a casa
per verificare. Si trovò di fronte un uomo che era
l’ombra di se stesso e che a stento si reggeva in piedi.
Erano i suoi ultimi mesi di vita. Uscendo dalla sua
abitazione, Ottaviano Del Turco disse: “È stato uno
sbaglio”. Penso a Angelo Arcidiacono, ragazzo di luce,
bello come il sole, sciabola d’oro ai Giochi olimpici di
Los Angeles, che ho conosciuto ad Acitrezza nel fulgore
degli anni e che è morto mentre stava per dare un senso
compiuto alla sua vita. Era rimasto orfano a dodici anni
e sperava che i suoi figli non avrebbero dovuto mai
patire la privazione del padre. Ho pensato a mio padre e
401
a mio nipote “così pieno di vita e di energia da essere in
continuo pericolo di esaurire le proprie forze” (riadatto
le parole che Mark Twain usò per la morte della figlia
Jean).
Penso a mio suocero, Francesco Coniglio, ex
presidente della Regione siciliana, tra i pochissimi
politici italiani, e forse europei, che con la politica si
sono impoveriti. È morto invocando “Gesù mio”. Di lui,
nel suo I vice vicerè, Gaetano La Terza scrisse: “Nelle
cronache parlamentari il suo nome resta consacrato a
una rettitudine che può indicarsi a non comune esempio.
Discutilo, se credi: ma rispettalo. Egli si impone al tuo
intelletto e alla tua coscienza”.
La vita a volte corre più veloce delle lancette.
Quando mi fermo a osservarne il moto mi sorprende il
più banale dei luoghi comuni: gli anni sono volati via e
non me ne sono accorto. Ma non attribuisco al mio stato
ragioni metafisiche, né ricerco più l’assoluto. Più
realisticamente, penso che la vita, come dice ne L’età
forte Simone de Beauvoir, “racchiuda due verità tra le
quali non si può scegliere e che bisogna affrontare
insieme: la gioia di esistere e l’orrore di finire”.
Penso a Ennio Romano, medico di valore,
combattente nella Decima Mas della Regia Marina
italiana, uomo di destra, come ben si può immaginare,
ma onesto e leale. Per un lungo periodo si trasferì con la
moglie in California dove fece amicizia con molti reduci
della seconda guerra mondiale che ad Anzio avevano
combattuto contro di lui. Eppure, lo accolsero senza
pregiudizi e una volta lo fecero sfilare accanto a loro
durante la festa nazionale del quattro luglio. Era un ex
nemico, senza ombra di dubbio, ma era un soldato che
aveva lottato per la sua patria e la sua bandiera e quindi
era degno di onore e di rispetto. Non oso immaginare
che cosa sarebbe accaduto in Italia.
Penso a Emanuele Cardiel, farmacista colto e
perbene, intelligente e acuto, amante del cinema e delle
buone letture. Un giorno andò a Milano per farsi curare
una sorta di sciatica e non tornò più. La moglie, ancora
402
oggi, non sa darsi pace. S’è chiusa in un mutismo
assoluto perché, come scrive Varlam Šalamov ne I
racconti della Kolyma “un dolore non è veramente
acuto né profondo se lo si può condividere con degli
amici”. Ogni volta che lo penso ne ascolto con intima
commozione la voce che sale dal mare di Acicastello
nei cui fondali riposano le sue ceneri.
Penso a Dino D’Amico che visse nel ricordo e nel
prestigio del padre, celebre avvocato e politico liberale.
Ma lui, figlio devoto e riconoscente, ne era
massimamente all’altezza. Amava la sua Catania, la
Civita, i quartieri antichi e popolari, amava la gente, la
loro storia, la loro arguzia. Viveva un tempo passato più
che presente. Ed aveva coraggio, molto coraggio.
Quando un male irreversibile lo colpi nella sua forza
vitale non si perse d’animo e diede agli amici ciò che
non poteva più avere, la speranza.
Qualche tempo fa Pietro Barcellona, già titolare della
cattedra di filosofia del diritto all’università di Catania,
annotava su La Sicilia un’esemplare riflessione:
“Nell’uomo la vita è diventata sapere della vita, vita che
pensa se stessa e che di fronte all’abisso del nulla sa
costruire piramidi e poemi, storie e religioni, sa
pronunciare parole che vincono il silenzio del tempo”.
Nelle storie e nei poemi, vorrei aggiungere, merita il suo
spazio specifico il cinema, memoria visionaria, luogo
della parola e dell’immagine, di ciò che contrasta
mirabilmente il silenzio del tempo. E forse non a caso il
mio ricordo dei vivi e dei morti, degli amici che mi
hanno accompagnato nel cammino della vita e lo hanno
reso ricco di storie minime e grandiose, ma pur sempre
storie che rompono (o ingannano) il silenzio del tempo,
ha a che fare in qualche modo col cinema, col suo
eterno presente che si nutre di passato e di futuro, con la
magia delle immagini in movimento che si fanno
racconto, ricordo, suggestione, testimonianza.
Alla fine di questo discorso che s’apparenta alla
malinconia e alla delusione, s’impone il problema della
“coscienza infelice”, rilanciato da Pietro Barcellona nel
403
saggio Il suicidio dell’Europa. Questa coscienza che
genera infelicità, e che Hegel identificava nel servo che
acquista la libertà ma che in bocca ha ancora il sapore
della schiavitù, lo studioso catanese l’aggiorna al mondo
d’oggi. Non più dialettica tra servo e padrone bensì tra
le grandi verità delle eminenze grigie e le piccole
questioni dell’uomo comune. Se capisco bene il senso,
oggi la coscienza infelice nasce dallo scontro tra
l’astrattezza, in cui spesso si nascondono la menzogna e
il privilegio, e la concretezza; tra la vita esteriore e la
vita interiore; tra un sapere fagocitato sempre più dalla
tecnica e l’ignoranza, come dire?, tecnologica. Ma la
scienza non è sempre e comunque una buona cosa, una
frontiera di progresso e di libertà, la scienza nasconde
anche molte mostruosità che possono distruggere
l’uomo. E quindi il problema si supera agganciando
l’efficienza del nuovo sapere alla sua efficacia. Solo in
tal modo, avverte Barcellona, la tecnica può essere
governata. Non basta costruire un’auto a sei ruote se
prima non si dimostra che le due ruote in più servono a
migliorare il veicolo. Io dico che la coscienza infelice
non può essere del tutto sconfitta perché è parte
inscindibile dell’uomo, della sua imperfezione, del suo
egoismo, della sua vanità. Si può solo alleviarla, con la
parola, l’amicizia, il coraggio, la dirittura morale… con
la musica e coi libri, col teatro, la televisione, il cinema.
Il cinema è stato la grande favola della mia
generazione, un lungo racconto scritto a più mani. Di
questi sapienti tessitori del sogno voglio ricordare Frank
Capra, John Ford, William Wyler, Mark Sandrich, Billy
Wilder, Aldred Hitchcock… Anche se l’infatuazione
varcò l’età della giovinezza, per assestarsi su una linea
mediana di critica accettazione, c’è da dire che il cinema
in sé, con le sue storie più o meno vere o improbabili,
con i suoi divi fatti per essere imitati e amati, rimase nel
nostro cuore a irretirci. Ben sapendo che il cinema è
rappresentazione e finzione della realtà, naturalmente, e
che i suoi divi sono maschere.
La mia “ossessione” per i poemi di celluloide
404
s’apparenta, in senso letterario e simbolico,
all’ossessione
donchisciottesca
per
i
poemi
cavallereschi, le insane letture “cortesi” che portano
l’eroe di Cervantes alla pazzia, a scindersi tra coscienza
e vita. In gioventù anch’io, partendo dal consumo
accanito di film e vicende d’eroi, finii talvolta per
naufragare nel magma informe della favola e
dell’invenzione diventando in definitiva “pazzo”,
amante del cuore più che del cervello. Eppure, come
sostiene Pascal, “il cuore ha le sue ragioni che la
ragione non conosce”. Tutto serve, tutto confluisce nella
verità: la storia e il romanzo, la realtà e la possibilità.
Diceva Sciascia che per capire nel profondo la sconfitta
di Napoleone a Mosca è più utile leggere Guerra e pace
che dieci trattati di storia. Del resto, è una tesi che
viaggia sin dalla Poetica di Aristotele. Jean Chapelain
alla fine del 1646 scriveva che dalle narrazioni di
finzione si possono trarre testimonianze sfuggenti ma
preziose. Le cronache, precisava, ci dicono soltanto che
un principe è nato, che un principe è morto; elencano gli
eventi più importanti dei loro regni, e tutto finisce lì.
Attraverso un romanzo (un film) invece diventiamo
amici intimi di quei personaggi fino a cogliere l’essenza
stessa delle loro anime. In verità, come argomenta
Lionello Sozzi in Il paese delle chimere, volontà e
intelligenza, ragione e immaginazione hanno bisogno le
une delle altre: la ragione presa in assoluto uccide,
mentre l’immaginazione dona la vita. In ultimo, storici
del calibro di François Furet e Jacques Le Goff
sostengono che la storia stessa si basa al 50 per cento
sui fatti e per l’altro 50 per cento sull’intuizione.
C’è di più. Mario Vargas Llosa nelle Lettere a un
aspirante romanziere avverte che il gioco della
letteratura, il gioco dell’invenzione, non è mai innocuo:
“Colui che attraverso la letteratura vive una grande
finzione torna alla vita reale con una sensibilità molto
più vigile di fronte ai suoi limiti e alle sue
imperfezioni”, e una volta capito che “il mondo reale, la
vita vissuta, sono infinitamente più mediocri della vita
405
inventata dai romanzieri”, diventa inquieto fino ad
assumere un atteggiamento di ribellione nei confronti
dell’autorità e delle istituzioni. La finzione letteraria,
quindi, acquista una verità metastorica essenziale. Per
spostare l’attenzione al tema cinematografico,
utilizzando gli stessi strumenti logici, appare indubbio
che anche il gioco del cinema produce nei suoi
appassionati fruitori una sensibilità che li porta più degli
altri a assumere atteggiamenti critici nei confronti della
realtà, del potere. “Sotto un’apparenza inoffensiva”,
scrive ancora Llosa “inventare finzioni è un modo di
esercitare la libertà e di porsi contro coloro – religiosi o
laici – che vorrebbero abolirla.
Non avessi fatto il giornalista, non avessi cioè
“calmierato” l’ingannevole nobiltà del sogno
cinematografico con la ragionevole umiltà della vita,
sarei stato un magnifico uomo d’ombra e un pessimo
uomo di luce. Ma quel sogno m’è servito a calibrare la
durezza dell’esistere con l’illusione dell’immaginare. È
come se il cinema avesse mantenuto il mio spirito in
uno stato di grazia permanente. Una specie di
suggestione autoprotettiva, un chiudere gli occhi quando
la realtà diventa sgradevole. Solo per un momento,
naturalmente, solo per il tempo necessario di fare un
salto nell’archivio della memoria, frugarvi, prendere il
giusto film, lo spirito migliore e tornare a lottare. La
migliore medicina per continuare a stupirsi… e per non
essere solo “un resto di speranza perduto tra la gente”,
come nella bella canzone di Roberto Carlos.
406
INDICE DEI NOMI
Abbas Abu, p. 252
Acacia Paride, pp. 140, 141, 220
Addinsell Richard, p. 193
Addamo Sebastiano, p. 31
Adjani Isabelle, p. 240
Adolfi John, p. 198
Adorée Renée, p. 33
Adorno Theodor, p. 216
Agata santa, pp. 23, 94, 143-144
Agnelli Edoardo, p. 154
Agnelli Gianni, pp. 20, 63, 151-153
Agnelli Giovannino, p. 154
Agnelli Susanna, p. 153
Agnelli Umberto, p. 154
Aguglia Mimì, p. 126
Allasio Marisa, p. 166
Alberoni Francesco, p. 392
Alberto di Monaco, p. 341
Albertazzi Giorgio, p. 44
Alcott Louisa May, p. 265
Aldrich Robert, p. 135
Aldrich Thomas Bailey, p. 136
Aldrin Buzz, p. 397
Alessi Giacomo, p. 389
Alfieri Eduardo, p. 165
Allen Gracie, p. 209
Allen Leslie, p. 310
Allen Lewis, p. 297
Allen Woody, p. 89
Allyson June, pp. 254, 264, 266, 310
Almirante Giorgio, pp. 168, 180
Almodóvar Pedro, p. 61
Amato Giuliano, p. 145
Ameche Don, pp. 72, 231
Amore Antonino, p. 318
Anastasia Albert, p. 298
Andersen Christopher, pp. 126, 128
407
Andersen Lale, pp. 48-49
Anderson Maxwell James, p. 176
Andreotti Giulio, p. 21
Angelini Cinico, pp. 167, 194-195
Anka Paul, p. 114
Aniante Antonio, pp. 31, 313
Anselmi Rosina, p. 351
Antheil George, p. 91
Antoine, p. 194
Antonino signore, p. 400
Appelius Mario, p. 36
Appiani Giuseppina, p. 313
Arafat Yasser, p. 154
Arbasino Alberto, p. 151
Arcidiacono Angelo, pp. 169, 401
Arcidiacono Luigi, p. 299
Aristotele, pp. 94, 347
Armenise Auletta, p. 328
Armstrong Neil, p. 397
Armstrong Rolf, p. 236
Arnaud Salvo, p. 333
Arnold Edward, p. 77
Arthur Jean, p. 75
Asciolla Enzo, p. 113
Askrow David, p. 267
Astaire Adele, p. 202
Astaire Fred, pp. 116, 202-203, 205-209, 265, 297
Atatürk Mustafa Kemal, p. 128
August Joseph, p. 110
Aumont Jean-Pierre, pp. 122, 337
Aumont Tina, p. 122
Austen Jane, pp. 225, 366, 369
Avola Maurizio, pp. 299, 303
Avondo Andrea, p. 328
Bacall Lauren, pp. 9, 158, 174-177, 189, 350
Baccarini Carlo, p. 57
Bacigalupo Valerio, p. 260
Balbo Italo, p. 81
Baldini Silvio, p.148
Ball Lucille, p. 136
Ballarin Aldo, p. 260
Balzac Honoré de, pp. 141, 190
Bancroft Anne, p. 131-132
408
Bankhea Tallulah, pp. 51, 232
Barbato Nancy, p. 280
Barcellona Pietro, pp. 403-404
Bardot Brigitte, p. 337
Bari Lynn, p. 315
Baricco Alessandro, p. 244
Barillari Rino, p. 270
Barker Jess, p. 287
Barker Lex, pp. 295-296
Barlesi Tony, p. 193
Bartali Gino, p. 194
Bartholomew Freddie, pp. 248, 361
Bartolomei Franca, p. 131
Barrymore Drew, p. 362
Barrymore Ethel, pp. 110, 362
Barrymore John, p. 127, 133, 135, 362
Barrymore Lionel, pp. 133, 362
Barzizza Pippo, pp. 82, 164, 194
Bassani Giorgio, p. 381
Bassetti Franco, p. 57
Battiato Franco, p. 146
Baudo Pippo, pp. 148, 195, 202, 315, 333
Baxter Ann, pp. 126, 308, 326-327
Bearzot Enzo, p. 57
Beatty Warren, pp. 115, 240
Beckett Samuel, pp. 248
Beery Wallace, pp. 71, 133
Beethoven Ludwig van, pp. 36, 148, 156
Belfiore signore, p. 205
Bellini Vincenzo, pp. 311-313, 315-319, 321, 327, 377
Benenati signore, p. 333
Bennett Tony, p. 115
Bentivegna Warner, p. 59
Bergman Ingrid, pp. 9, 28, 79, 96, 100-103, 114, 128, 190,
239, 241, 250, 315, 378
Bergstroms Olaf, p. 39
Berlin Irving, pp. 202-204, 206
Berlusconi Silvio, pp. 67, 142, 151, 177, 189, 279-280, 282
Bern Paul, p. 72
Bernabei Ettore, p. 275
Bernage Berta, pp. 258-259
Bernardini Piero, p. 263
Bernhardt Curtis, pp. 295, 366
409
Bernhardt Sarah, pp. 40, 311
Bersani Lello, p. 162
Berselli Edmondo, pp. 63, 195, 210,
Berti Marina, p. 34
Berti Orietta, p. 197
Bianciardi Luciano, p. 83
Biagi Enzo, pp. 182-183, 277-279
Bianchi Pietro, p. 193
Biel Jessica, p. 89
Biffoli Gastone, pp. 331-332
Bignardi Daria, p. 124
Bixio, p. 202
Black Charles, p. 361
Blair Charles, p. 246
Blandini Arcangelo, p. 31
Blyth Ann, p. 134
Bobbio Norberto, p. 153
Bocca Giorgio, p. 385
Boccaccio Giovanni, p. 386
Boemi Laura, p. 142
Bogart Humphrey, pp. 75, 100-101, 136, 174-175, 177, 189,
209, 343
Bogart Stephen, pp. 177
Bohr Niels, p. 42
Bolognini Mauro, p. 381
Bonaccorsi Giancarlo, pp. 99, 192
Bonaccorsi Santino, pp. 64, 68
Bonaparte Napoleone, pp. 337, 386, 405
Bongiorno Mike, pp. 82-83
Boni Carla, p. 164
Bonino Ernesto, p. 263
Bonino Eugenia, pp. 285-286
Bonomi Antonia, pp. 159, 305
Boone Pat, p. 114
Borina Nino, p. 333
Borrelli Giulio, pp. 391-392
Bosè Lucia, pp. 272, 284, 288
Bosetti Ugo, p. 362
Bosio Gastone, p. 82
Botero Fernando, p. 196
Bourcet Marguerite, pp. 258-259
Bovio Giovanni, p. 170
Boyle Danny, p. 264
410
Bow Gordon Clara, p. 352
Brady Alice, p. 33
Bragaglia Carlo L., p. 241
Branca Michele, p. 139
Branca Orlando, p. 139
Brancati Corrado, p. 256
Brancati Vitaliano, pp. 11, 30-31, 35, 72, 248, 256, 313, 356
Brancoli Rodolfo, pp. 18-19
Brando Marlon, pp. 238-239, 250, 256
Bravetti Varo, p. 57
Brazzi Rossano, p 45
Brecht Bertolt, pp. 68, 216
Breen Joseph E., p. 249
Brent George, p. 248
Brönte Emily, p. 185
Brönte sorelle, p. 366
Brooks Louise, pp. 36, 352
Brooks Paul, p. 315
Brooks Richard, pp. 255, 366-367
Brown Clarence, p. 39
Brown George H., p. 366
Brummel Beau, p. 423
Brunetti Argentina, p. 126
Bruni Norma, p. 263
Bruno padre, p. 242
Brynner Yul, pp. 43, 250
Bucholz Horst, p. 387
Bugliari Anna M., p. 288
Buñuel Luis, p. 109
Buonadonna Sergio, p. 196
Burgnich Tarcisio, p. 207
Burns Robert, p. 86
Burr Aaaron, p. 315
Burton Isabel, p. 43
Burton Richard, pp. 282, 364, 370
Buscaglione Fred, p. 204
Buscetta Tommaso, p. 156
Bush George pp. 154, 204
Bush George W., pp. 81, 176-177
Buti Carlo, pp. 263, 277
Butler David, p. 306
Buttafuoco Nino, pp. 333-335
Buttafuoco Pietrangelo, pp. 333
411
Button Benjamin, p. 113
Buzzati Dino, pp. 169, 260
Caffarra Carlo, p. 183
Cagney James, pp. 79, 209
Cahn Sammy, p. 314
Cain James M., pp. 212, 295
Čajkovskij, Pëtr, p. 112
Calabrese Christian, p. 274
Calamai Clara, p. 34
Calamai Piero, p. 332
Calavetta Rosetta, p. 284
Calderoli Roberto, p. 384
Callas Maria, pp. 340, 377
Camerini Mario, pp. 34, 124
Camilleri Andrea, p. 25
Cameron Kate, p. 161
Campanella Miriam, p. 65
Campione Vittorio, p. 65
Camus Albert, p. 289
Canale Gianna M., p. 288
Cannavò Alessandro, p. 395
Cannavò Candido, pp. 64, 70, 142, 333, 395,
Cantarini John, p. 241
Cantù Giuditta, pp. 313, 316
Capone Al, p. 298
Caporlingua Massimo, p. 192
Capra Frank, pp. 73, 76-78, 114, 126, 198, 218, 404
Caprino Gaetano, p. 390
Capuana Luigi, p. 388
Caracciolo Marella, p. 154
Caramella Santino, p. 291
Carbone Fabrizio, p. 275
Cardiel Emanuele, p. 402
Cardinale Claudia, pp. 255, 381
Carducci Giosuè, p. 117
Carlo Magno, p. 337
Carlo II, p. 237
Carlos Roberto, p. 406
Carolina di Monaco, p. 341
Caron Leslie, pp. 120, 240
Carter Stephen, p. 119
Cartesio, p. 141
Cartland Barbara, p. 351
412
Caruso Alfio, pp. 53, 142, 150, 282, 382
Caruso Giuseppe, p. 142
Casabianca Angelo, p. 333
Casabianca cavaliere, p. 333
Caselli Caterina, p. 197
Cason Laura, p. 392
Cassat Mary, p. 262
Cassini Daria, p. 230
Cassini Oleg, pp. 229-230, 232, 337
Castiglia Giuseppe, p. 383
Castigliano Eusebio, p. 260
Castro Fidel, p. 154
Castronovo Valerio, p. 153
Catalano Giuseppe, p. 397
Catalany Miryam, p. 258
Catena Maria, p. 201
Cavalieri Maria A., p. 258
Cavour Camillo B., pp. 263, 291
Cecco d’Ascoli, pp. 381-382
Ceglie Berta, p. 327
Celentano Ariano, p. 197
Centorbi Giovanni, p. 30
Cerri Dino, p. 392
Cervantes Miguel de, pp. 139, 405
Cervi Gino, p. 181
Chandler Charlotte, p. 190
Chandler Raymond, pp. 176, 178, 212, 367, 382
Chapelain Jean, p. 405
Chaplin Charles, pp. 314, 398
Charisse Cyd, p. 265
Che Guevara, p. 146
Cherubini, p. 202
Chiari Walter, pp. 272-273, 284
Chirac Jacques, p. 154
Chiostri Carlo, p. 263
Chopin Fryderyk, p. 157
Christian-Jaque, p. 162
Christie Julie, p. 240
Churchill Winston, pp. 174, 226
Ciancio Mario, pp. 303, 372
Ciavola Pippo, p. 92
Cinquetti Gigliola, p. 197
Ciotti Sandro, p. 58
413
Cipolla Carlo M., p. 279
Cirrone Silvana, p. 65
Cisnetto Enrico, p. 66
Cisnetto Iole, p. 66
Clair René, p. 189
Clements Stanley, p. 215
Clift Montgomery, pp. 239, 249, 357, 379
Clinton famiglia, p. 154
Clooney George, p. 371
Clooney Rosemary, p. 371
Clyde Fitch William, p. 211
Coen Joel ed Ethan, p. 54
Cocteau Jean, p. 360
Cohen Michey, pp. 296, 298
Colbert Claudette, pp. 9, 28, 51, 56, 73, 88
Colette, pp. 339, 341
Collura Matteo, p. 381
Colman Ronald, pp. 75, 77
Colombo Anna, p. 346
Columba Nenè, p. 70
Como Perry, p. 115
Coniglio Francesco, p. 402
Connery Sean, pp. 108, 297
Consoli Carmen, p. 196
Consoli Giuliano, p. 397
Consoli Vittorio, p. 374
Conway Jack, p. 72
Coogan Jackie, p. 314
Cooke Janet, p. 362
Cooper Gary, pp. 52, 77, 100, 209, 286, 337
Coppi Fausto, p. 194
Coppola Pietro A., p. 316
Cordaro Bianca, p. 377
Cordero di Montezemolo Luca, pp. 152, 155
Corigliano Piero, pp. 196, 328-329
Corona Fabrizio, pp. 271-272
Corona Puccio, p. 390
Corona Vittorio, pp. 326, 390
Corsaro Antonio, don, pp. 31-32, 257, 395-396
Corvaja Egle, p. 169
Cosentino Filippo, p. 394
Cossiga Francesco, p. 21
Costa Don, p. 362
414
Costa Nikka, p. 362
Costa Nuccio, pp. 195-196
Costa Pippo, p. 401
Costello Dolores, p. 33
Costello Frank, p 281
Cotten Joseph, p. 108
Cowan Lester, p. 367
Crain Jeanne, pp. 120, 308, 313-315, 387
Crane Cheryl, pp. 295-296
Crane Steve, p. 295
Crawford Christine, p. 133
Crawford Joan, pp. 9, 33, 41, 124-125, 128, 132-137, 212,
237, 249, 306
Crawford Martha, p. 241
Craxi Bettino, pp. 21, 252
Cristiani Dhia, p. 234
Crocco Benedetta, p. 273
Crocco Virgilio, pp. 273-274
Cronin Archibald J., p. 344
Cronkite Walter, p. 21
Crosby Bing, pp. 115, 164, 306, 337, 360, 371
Cruise Tom, p. 177
Crystal Billy, p. 84
Cukor George, pp. 41, 124, 127, 130, 135, 249, 284
Cunningham Michael, p. 88
Curtis Jamie L., p. 310
Curtis Kelly, p. 310
Curtis Tony, pp. 310, 357
Curtiz Michael, pp. 101, 134, 175, 194, 209, 255, 365
Cusimano Salvatore, p. 312
Cusumano Stefano, p. 149
D’Agata Mario, p. 57
D’Agata Roberto, p. 100
D’Agostino Roberto, p. 220
D’Angelo Daniela, p. 87
D’Angelo Giovanni, p. 394
D’Anza Silvio, p. 202
D’Annunzio Gabriele, p. 40
D’Ascanio Corradino, p. 75
D’Augusta Giuseppe, p. 57
Dalida, p. 113
Dalla Lucio, p. 100
D’Amico Dino, p. 403
415
Damigella Girolamo, p. 300
Damita Lili, p. 51
Damone Vic, p. 163
Dante Ronald, p. 295
Danzuso Domenico, p. 312
Darnell Linda, pp. 235-238
Das Gupta Sonali, p. 103
Daudet Alphonse, p. 206
Davanzati Forges, p. 36
Daves Delmer, pp. 176, 255
Davis Bette, pp. 9, 41, 124, 128, 135, 137, 225, 327
Day Doris, pp. 120, 285, 294, 305-306
De Acosta Hennie, p. 51
De Acosta Mercedes, p. 51
De Alba Aurora, p. 282
De Amicis Edmondo, pp. 32, 80, 117, 263-264
De Agrò Nino, p. 339
De Beauvoir Simone, pp. 141, 402
De Carli Giuseppe, p. 392
De Carnac Miryam, p. 258
De Fabritiis Oliviero, p. 377
De Felice Giuseppe, p. 229
De Filippo Eduardo, p. 96
De Filippo Peppino, p. 381
De Gasperi Alcide, pp. 180, 182
De Gaulle Charles, p. 154
De Givenchy Hubert, p. 345
De Gregori Francesco, p. 297
De Havilland Olivia, pp. 84, 166-167, 249
De la Reynière Grimond, p. 94
De Mille Cecil B., pp. 90, 126, 237
De Niro Robert, pp. 118, 362
De Palma Jula, p. 274
De Poligny Serge, p. 162
De Roberto Federico, pp. 34, 292, 388
De Sanctis Alfredo, p. 39
De Sica Vittorio, pp. 34, 97, 124,
De Toth André, p. 190
De Toth Diana, p. 190
De Toth Michael, p. 190
Dean James, pp. 163, 239, 250
Debussy Claude, p. 157
Defoe Daniel, p. 146
416
Del Rio Dolores, p. 51
Del Turco Ottaviano, p. 401
Deledda Grazia, p. 28
Dell’Aglio Claudia, p. 164
Delli Ponti Sandro, pp. 103, 196
Delly, p. 351
Dennis Patrick, p. 50
Depp Johnny, p. 20
Detlie Elaine, p. 206
Detlie John Stewart, p. 190
Detlie William, p. 190
Di Bernardo Giuseppe, p. 326
Di Domenico Piero, p. 284
Dieterle William, pp. 108, 246
Di Giovanni Nino, p. 142
Di Grado Antonio, p. 383
Di Maggio Joe, pp. 347, 355
Di Marco Vito, p. 401
Di Maria Alfio, p. 315
Di Pietro Antonio, p. 385
Di Stefano Gioacchino, p. 113
Di Stefano Marina, p. 100
Di Stefano Renzo, pp. 99-100, 168-169, 277
Dickens Charles, pp. 254, 264, 369
Dietrich Marlene, pp. 9, 28-29, 41-44, 46-51, 53, 71-72, 159,
212, 267, 286, 378
Digby Jane, p. 357
Disney Walt, pp. 342, 390
Dolliver Luciana, p. 263
Dominguin Luis Miguel, p. 284
Dorsey Tommy, p. 275
Dotti Andrea, p. 344
Dougherty Jim, p. 354
Douglas Kirk, pp. 85, 163, 241, 255
Douglas Melvyn, p. 193
Downs Cathy, p. 387
Drake Betsy, p. 382
Du Maurier Daphne, p. 172
Duca d’Alba, p. 51
Dunaway Faye, p. 133
Dunne Irene, p. 225
Dupont Carla, p. 86
Durbin Deanna, p. 194
417
Duse Eleonora, p. 40
Duvivier Julien, p. 39
Dylan Bob, p. 101
Eastwood Clint, p. 71
Eaton Robert, p. 295
Eco Umberto, pp. 83, 102
Edoardo III, p. 126, 215
Edwards Blake, p. 345
Einarsdottír Thurídur, p. 324
Einaudi Giulio, p. 154
Einaudi Luigi, p. 180
Einstein Albert, p. 219
Ekberg Anita, p. 272
Ellis Anita, p. 161
Eliodoro, p. 23
Elisabetta II, p. 144
Elkann John, p. 151
Ellen Vera, p. 128
Ellroy James, p. 282
Elvgren Gil, pp. 234, 236, 295
Endrigo Sergio, pp. 119, 197
Epstein Julius, p. 101
Ercolano Aldo, pp. 299, 303
Ermengarda regina, p. 337
Esmond Jill, p. 85
Esquivel Laura, p. 362
Etna Giacomo, p. 31
Euripide, p. 109
Evanier David, p. 281
Evans Ray, pp. 306, 370
Evola Julius, p. 168
Faeti Antonio, p. 214
Fain Sammy, pp. 49, 112, 306
Fairbanks Douglas, pp. 33, 132
Fairbanks Douglas jr, pp. 132-133
Fallaci Oriana, pp. 163, 230-231, 360
Fallica famiglia, p. 202
Fanfani Amintore, p. 180
Faorzi Fiorenzo, p. 259
Farina Renato, p. 380
Farinon Gabriella, pp. 103, 196
Farkas Gerardo, p. 397
Farouk I, p. 270
418
Faulkner Henry, p. 368
Faulkner William, pp. 44, 175
Faure Renée, p. 162
Fava Claudio, pp. 303-305
Fava Elena, p. 304
Fava Giuseppe, pp. 273, 299-300, 305, 312
Fava Nuccio, pp. 21-22, 393
Faville Victor, p. 234
Fay Dion, p. 211
Fay Frank, p. 211
Faye Alice, p. 115
Federico Barbarossa, p. 233
Federico II, pp. 384-385
Fellini Federico, pp. 102, 153, 270, 349
Fellini Riccardo, p. 286
Feltri Vittorio, pp. 67, 231
Ferdinando I, p. 385
Ferdinando II, p. 385
Ferida Luisa, p. 34
Fernandel, p. 181
Fernandez Gioacchino, p. 316
Ferragamo Salvatore, p. 104
Ferrara Orazio, p. 366
Ferrari Enzo, p. 183
Ferrario Tiziana, p. 392
Ferrata Giansiro, p. 27
Ferrer Mel, p. 344
Ferrer Nino, p. 197
Ferrer Sean, p. 344
Fichte Johann G., p. 68
Fiducia Saverio, pp. 222-223
Field Betty, p. 119
Filogamo Nunzio, p. 195
Fischer Carrie, p. 370
Fischer Eddie, pp. 251
Fitzgerald Barry, p. 248
Fiumefreddo Antonio, p. 320
Fleming Rhonda, pp. 235, 240-241
Fleming Victor, pp. 138, 361
Florit Ermenegildo, p. 210
Flynn Errol, pp. 51, 137, 166, 239
Fogelson Elijah, p. 226
Folli Stefano, p. 278
419
Fonda Henry, p. 387
Fonda Jane, p. 240
Fontaine Joan, pp. 120, 158, 172-174, 209
Ford Derek, pp. 352, 354, 356-359
Ford Gerald, p. 154
Ford Glenn, pp. 126, 162, 215, 387
Ford John, pp. 17, 91, 125, 129, 198, 243, 246-247, 281, 404
Forlani Arnaldo, p. 21
Fort Rina, p. 134
Foster Jodie, p. 361
Frahm Art, pp. 236, 314
Frajese Paolo, p. 22, 392
Francesco Giuseppe, pp. 113
Franchetti Leopoldo, p. 321
Franchetti Raimondo N., p. 370
Franchi Paolo, p. 89
Francica Nava Giuseppe, p. 192
Francica Nava Orazio, pp. 191-192
Franciosa Anthony, p. 270
Franco Francisco, p. 299
Frank Anna, pp. 341-342
Frank Margot, p. 342
Frank Otto, p. 343
Franzelli Marco, p. 155
Frayn Michael, p. 312
Friedan Betty, p. 210
Fritsch Willy, p. 49
Frittella Marco, p. 392
Fromm Erich, p. 216
Fuerstemberg Ira, p. 196
Fumaroli Maddalena, p. 311
Furet François, p. 405
Furnari Gaetano, p. 201
Fusco Maria Pia, p. 272
Gaber Giorgio, p. 182
Gabetto Guglielmo, p. 260
Gabin Jean, pp. 52, 150, 256, 229
Gable Clark, pp. 71, 73, 75, 84, 90, 133, 199, 281, 337, 357
Gábor Zsa Zsa, p. 267
Gagney James, p. 306
Galante Garrone Alessandro, p. 153
Gallo Larry, p. 281
Galt Marginel, p. 327
420
Galt Melissa, p. 327
Galt Randolph, p. 327
Gambino Carlo, pp. 281, 298
Garbo Greta, pp. 9, 28-29, 33, 35, 37, 39-41, 43-47, 50-51,
71, 97, 104, 133, 135, 159, 225, 378
Gardner Ava, pp. 269-270, 272, 275, 280, 282, 284- 285, 364
Garduzio Pina, p. 164
Garibaldi Giuseppe, pp. 263, 384- 386
Garland Judy, pp. 128, 194, 265, 371
Garnett Tay, pp. 71, 295
Garozzo Giuseppe, p. 333
Garson Greer, pp. 41, 218, 224-226
Gassman Vittorio, p. 328
Gates Bill, p. 69
Gawronski Jas, p. 155
Géleng Ottone, p. 311
Gennaro Giuseppe, p. 141
Genovese Vito, p. 298
Gere Richard, p. 374
Germi Pietro, p. 38
Gershwin George, pp. 202, 206, 209
Giancana Sam, p. 359
Gianni Maria R., p. 392
Giardina Lello, p. 401
Giarrizzo Giuseppe, p. 409
Gielgud John, p. 85
Giffey René, p. 258
Gilbert John, pp. 29, 46
Ginsberg Allen, p. 274
Giolitti Giovanni, pp. 261, 291
Giordani Annibale, p. 373
Giordano Paolo, p. 26
Giorgino Francesco, p. 392
Giorgio principe, p. 132
Gioviale Giovanni, p. 389
Girotti Massimo, p. 130
Girotti Mario, p. 286
Gish Lillian, pp. 109, 245, 344
Giulio Cesare, p. 385
Giunta Stefano, p. 399
Giuntella Paolo, p. 393
Giussani Angela, p. 214
Giussani Luciana, p. 214
421
Giusti Mario, pp. 312, 398
Giusto Antonietta, p. 242
Glaney Edna, pp. 225, 229
Glyn Elinor, p. 352
Gnocchi Gene, p. 182
Gobetti Piero, p. 154
Goddard Paulette, p. 52
Godden Rumer, p. 254
Goebbels Paul Joseph, pp. 48, 226
Goldwyn Samuel, p. 136
Goodman Benny, p. 275
Gorbaciov Michail, p. 154
Gorgone Ciccio, p. 36
Gotti John, pp. 281, 298
Goulding Edmund, pp. 133, 327
Grable Betty, pp. 208, 350
Graham Barbara, p. 289
Graham Sheilah, p. 239
Grahame Gloria, pp. 126, 202, 215
Gramsci Antonio, p. 154
Granger Stewart, pp. 255, 366
Grant Cary, pp. 75, 114, 124, 156, 172-173, 193, 251, 295,
332, 337
Grasso Aldo, p. 145
Grasso Angelo, p. 129
Grasso Giovanni, p. 126
Gray Dolores, p. 121
Grayson Kathryn, p. 371
Greco Emilio, p 130
Greco Juliette, p. 49
Green Alfred, p. 137
Greenfield Luke, p. 266
Greer Jane, p. 241
Grezar Giuseppe, p. 260
Griffith David W., pp. 97, 126, 245
Griffith H. Edward, p. 209
Grignetti Francesco, p. 269
Grimaldi Enzo, p. 337
Grimm fratelli, p. 260
Gruber Lilli, pp. 155, 392
Guareschi Giovannino, pp. 180-183
Guccini Francesco, pp. 210, 274
Gueli Maurizio, p. 313
422
Guglielmino Francesco, pp. 31, 291-293
Guinness Alec, p. 254
Guitry Sasha, p. 137
Hackford Taylor, p. 374
Haley Bill, p. 115
Hall Dickie, p. 332
Hall Jon, p. 121
Hall Porter, p. 213
Hammett Dashiell, pp. 178, 373
Hamsun Knut, p. 111
Harlow Jean, pp. 9, 56, 71-72, 198
Harrison Lietta, p. 200
Harvey Laurence, p. 250
Hathaway Henry, p. 348
Hauser Gayelord, pp. 45-46
Havilland de Olivia, pp. 84, 166-167, 249
Hawks Howard, pp. 174-175, 209, 348
Hayward Susan, pp. 250, 269, 286-288
Hayworth Rita, pp. 9, 26, 41, 99, 126, 158-159, 161-163, 239,
266, 378
Haze Dolores, p. 237
Hefner Hugh, p. 266
Hegel Georg W.F., pp. 68, 404
Heine Heinrich, p. 317
Heisenberg Werner, p. 312
Hemingway Ernest, pp. 44, 52, 162, 174-176, 275, 347, 365,
369-370
Hepburn Audrey, pp. 249, 331, 341-343, 345, 378
Hepburn Katharine, pp. 9, 28, 45, 124-131, 136, 289
Hepburn Tom, p. 126
Hepburn James, p. 125
Hermann Bernard, p. 309
Heston Charlton, p. 287
Hilton Conrad N., p. 365
Hitchcock Alfred, pp. 172-173, 241, 305, 308-309, 327, 336,
393, 404
Hitler Adolf, pp. 42, 47, 357
Hodiak John, p. 327
Hodiak Katrina, p. 327
Høeg Peter, p. 228
Hoffman Dustin, p. 306
Holden William, pp. 211, 337, 343-344, 388
Holiday Billie, pp. 115, 120
423
Holman Leigh, p. 85
Hopper Hedda, p. 329
Horton Edward Everett, p. 208
Hosseini Khaled, p. 61
Houdini Harry, p. 311
Howard Leslie, pp. 84, 174, 315
Hubbard Ron, p. 177
Hudson Rock, p. 128
Hugo Victor, pp. 32, 79
Hughes Howard, pp. 284, 295
Huston John, pp. 84, 176, 250, 254, 344, 357
Hutton Betty, p. 237
Hyams Elena, p. 33
Iannuso Angelo, p. 242
Ibsen Henrik, pp. 40, 232
Identici Anna, p. 197
Ingham Charles, p. 42
Insanguine Nino, pp. 11, 130
Isozaki Arata, p. 47
Jackson Glenda,
Jacobs George, p. 250
Jaeggy Fleur, p. 365
Jahn Helmut, p. 47
James Henry, p. 59
Jasgur Joseph, p. 346
Jewison Norman, p. 374
Johansson Scarlett, p. 200
Johnson Nunnally, p. 250
Jintao Hu, p. 69
Johnson Van, pp. 240, 366
Jones Jennifer, pp. 28, 100, 105, 108, 111, 289
Jones Shirley, p. 309
Jordan Neil, p. 99
Jourdan Louis, p. 173
Joyce James, p. 248
Juan Carlos, p. 154
Justin, pp. 362-363
Katz Otto, p. 50
Kalatozov Mikhail, p. 39
Karzai Hamid, p. 129
Kaufmann Christine, p. 310
Kavanagh Julie, p. 208
Kaye Danny, p. 234
424
Kazan Elia, pp. 115, 315
Keaton Diane, p. 240
Keats John, p. 108
Kelly Grace, pp. 9, 128, 281, 305-306, 310, 331, 336-338,
345, 347, 371, 378
Kennedy famiglia, pp. 154, 358-359
Kennedy Jackie, p. 208
Kennedy Joe, p. 52
Kennedy John F., pp. 232, 356-357, 360
Kennedy Robert, pp. 358-359
Kern Jerome, pp. 202-203, 207
Kerr Deborah, pp. 235, 248-249, 251-253
Ketty Rina, p. 53
Keyes Evelyn, p. 84
Kezich Tullio, p. 308
Khan Alì, pp. 154, 162, 232
Kidman Nicole, p. 177
Kinnel Murray, p. 136
King Henry, pp. 100, 112, 246, 284, 314
King mister, p. 278
Kissinger Henry, p. 154
Kleeves John, pp. 215-216
Klinghoffer Leòn, p. 252
Knightley Keira, p. 225
Kohlbecker Christoph, p. 47
Korda Alexander, pp. 82, 186
Körmendi Ferenc, p. 31
Koscina Sylva, p. 272
Koster Henry, p. 255
Kramer Stanley, p. 267
Kruscev Nikita, p. 154
Kubrick Stanley, pp. 71, 255, 374
La Cavera Mimì, p. 36
La Ferlita sindaco, p. 285
La Marr Barbara, p. 90
La Spina Emma, p. 229
La Terza Gaetano, pp. 335, 402
Labaki Naine, p. 165
Ladd Alan, pp. 189, 266, 387
Laganà Roberto, p. 67
Lagerlöf Selma, p. 37
Lake Veronica, pp. 179, 189-190, 285
Lamarr Hedy, pp. 79, 89-91, 232, 237
425
Lamas Fernando, pp. 295-296
Lancaster Burt, pp. 85, 233, 238, 249, 267-268, 344
Lane Lola, p. 194
Lane Priscilla, p. 194
Lane Rosemary, p. 194
Lang Fritz , pp. 47, 215-216, 230
Lang Walter, p. 249
Lange Hope, p. 356
Langham Rhea, p. 199
Lansing Joi, p. 286
Lanza Mario, p. 371
Lario Veronica, pp. 67, 189
Las Casas Antonio, p. 169
Las Casas Barbaro, p. 169
Las Casas Giovanni, p. 169
Lattanzi Tina, p. 41
Latilla Gino, p. 195
Laughton Charles, pp. 133, 244
Lawford Peter, pp. 356-357, 359
Laxness Halldòr K., pp. 321-325
Lazzaro Danzuso Giuseppe, pp. 298-299
Lazzaro M.M., p. 31
Le Goff Jacques, p. 405
Lean David, pp. 45, 254
Lee Howard, p. 232
Lee Peggy, p. 135
Lee Tamara, p. 241
Lehàr Franz, p. 113
Leigh Janet, pp. 265, 308-309, 311
Leigh Vivien, pp. 9, 28, 39, 79, 82, 84-85, 85, 88-89, 120,
186, 225, 378-379
Lemmon Jack, p. 266
Leo Gaetano, p. 65
Leone santo, p. 23
Leone Sergio, p. 118
Leopardi Giacomo, pp. 181, 292
Leotta Piero, p. 65
Lerman Leo, p. 54
LeRoy Mervyn, pp. 85, 225, 265, 294
Leslie Joan, p. 209
Letizia Noemi, p. 67
Lewin Albert, p. 284
Lewis Jerry, p. 306
426
Lewis Joe E., p. 314
Lewis Judy, p. 216
Lewis signore, p. 327
Lewis Sinclair, p. 84
Lewis Thomas, p. 199
Li Destri Francesco, p. 60
Liala, p. 351
Librando Vito, pp. 64-66
Lincoln Abraham, p. 93
Litvak Anatole, p. 250
Livingston Jay, pp. 306, 370
Lloyd Frank, p. 133
Lloyd Wright Frank, pp. 126, 326
Lo Giudice Mariella, p. 311
Lodi Delia, p. 263
Logan Joshua, pp. 211, 356
Loik Ezio, p. 260
Lojacono Corrado, p. 196
Lojodice Giuliana, p. 312
Lollobrigida Gina, p. 288
Lombard Carol, p. 199
Lombardo Antonio, pp. 64, 168
Lombardo Antonio B., p. 168
Lombardo Matteo, p. 29, 56
Lombardo Nino, p. 204
Lombardo Silvana, p. 169
Longanesi Leo, p. 189
Loos Anita, p. 341
Loren Sofia, pp. 89, 288
Losey Joseph, pp. 361, 376
Louv Richard, p. 80
Loy Myrna, pp. 41, 179, 193
Lowe Bessie, p. 33
Lubin Arthur, p. 121
Lubitsch Ernst, pp. 167, 230
Luciano Lucky, pp. 282, 298
Lucy Geoffrey, p. 219
Ludwig I, p. 121
Lukas Paul, p. 100
Lumière fratelli, p. 428
Lupi Roldano, pp. 34, 241
Lussu Emilio, p. 66
Luzi Mario, p. 32
427
Lya Franca, p. 124
Lynn Vera, pp. 49, 120
Macathy Gustav, p. 90
Maccari Mino, p. 189
MacDonald Jeanette, p. 371
MacLaine Shirley, pp. 131, 240, 251
MacMurray Fred, pp. 212-214
Madeo Alfonso, pp. 179, 302
Madonna, pp. 19, 240
Mafalda di Savoia, p.179
Magnani Anna, pp. 102, 237, 239, 250, 289, 368
Magrì Enzo, p. 70
Magrì Saretto, p. 372
Magris Claudio, pp. 95
Mahler Gustav, p. 49
Maimone Giuseppe, pp. 141, 313, 333
Maiorana Giuseppe, p. 93
Mal, p. 197
Malerba Franco, p. 62
Malvica Anna, p. 313
Mamoulian Rouben, p. 29
Man Igor, p. 31
Mancini Henry, p. 345
Mandl Fritz, p. 90
Manenti Michele, p. 57
Manfredi Nino, pp. 166, 398
Mangano Silvana, p. 288
Mankiewicz Joseph, pp. 232, 315, 327-328, 368
Mann Daniel, pp. 250, 287, 289
Mann Delbert, p. 250
Mann Thomas, pp. 216, 273
Mannino Arturo, p. 169
Mannino Francesco, pp. 65-67
Mannino Lucia, p. 66
Mannoia Fiorella, p. 248
Manzella Titomanlio, p. 31
Manzella Frontini Gesualdo, p. 31
Márai Sándor, pp. 11, 374, 380
Marceau Sophie, pp. 39, 114
Marcellini Siro, p. 286
Marchese Nino, p. 400
Marcuse Herbert, pp. 68-69, 216
Marf, p. 97
428
Marill Alvin, p. 127
Marchesi Concetto, p. 31
Maria Luisa d’Austria, p. 337
Maria Stuarda, p. 125
Marini Valeria, p. 44
Maroso Virgilio, p. 260
Marotta Bice, p. 65
Marotta Giuseppe, pp. 295, 314
Márquez Gabriel G., pp. 40, 45, 104
Marchal Georges, p. 162
Marchall Brenda, p. 337
Marshall George, p. 310
Martelli Augusto, p. 274
Martinez Enzo, p. 252
Martino Bruno, pp. 116-117
Martorana Lidia, p. 164
Martoglio Nino, pp. 33, 126, 292, 351, 388
Marvin Lee, p. 215
Marx Groucho, p. 91
Marx Zeppo, p. 294
Mascheroni Vittorio, pp. 97, 164
Mason James, pp. 30, 124, 273, 285
Matisse Henri, p. 169
Mattina sorelle, p. 169
Mature Victor, pp. 90, 295
Maxwell Elsa, p. 239
Maxwell Glenn, p. 267
May Fred, p. 295
Mayer Louis B., pp. 90, 224
Mayler Norman, p. 359
Mayo Virginia, pp. 218, 233-234
Mazzanti Enrico, p. 263
Mazzel Massimiliano, p. 160
Mazzi Gilberto, p. 82
Mazzi Renzo don, p. 210
Mazzini Giuseppe, p. 291
Mazzola Valentino, p. 260
McCarthy Corman, p. 54
McCourt Frank, pp. 77, 170
McDaniel Attie, p. 84
McEwan Ian, p. 24
McGivern William P., p. 215
McGovern Elizabeth, p. 118
429
McKay Ellin, p. 204
McLaglen Victor, pp. 244
McQueen Steve, p. 239
Melcher Marty, p. 306
Melissa P., p. 365
Melnati Umberto, p. 82
Menjou Adolphe, p. 286
Mentana Enrico, p. 19
Menti Romeo, p. 260
Mercer Johnny, p. 345
Mercury Freddie, p. 208
Merivale John, p. 85
Merlin Lina, p. 97
Merlo Francesco, pp. 143, 150, 278, 388, 392
Mernissi Fatema, pp. 106, 122
Merola Mario, p. 15
Messina Dino, pp. 331-332
Messina Livio, p. 86
Messina Sebastiano, p. 25
Miccichè Gianfranco, pp. 384-385
Michelangelo Buonarroti, p. 233
Micheloni Bruno p. 57
Mignemi Giuseppe, p. 179
Mihaileanu Rau, p. 112
Mila Massimo, p. 153
Milano Emanuele, p. 395
Milazzo Nino, pp. 66, 70, 99, 258, 277-278, 386-387
Milland Ray, p. 337
Miller Arthur, p. 355, 357
Miller Daniel, p. 355
Miller Glenn, p. 275
Miller Henry, p. 258
Milne Tom, p. 209
Mina, pp. 272-274
Mineo Sal, p. 239
Minissale Nino, p. 396
Mintoff Dom, p. 339
Miranda Isa, p. 34
Mirabella Santino, p. 64
Misterbianco duca, p. 372
Misterbianco duchessa, p. 205
Mitchell Margaret, pp. 82-83
Mitchell Thomas, p. 84
430
Mitchum Robert, pp. 241, 249, 250, 353
Modesti Dore, p. 103
Modesti Barbara, p. 103
Modica fratelli, p. 169
Modugno Domenico, pp. 114, 195, 347
Molco Willy, p. 392
Molina Alfonso, p. 35
Mollica Vicenzo, p. 20
Molnar Ferencz, p. 259
Moncalvo Gigi, pp. 66-67
Monicelli Mario, p. 381
Monroe Marilyn, pp. 9, 89, 146, 237, 285, 310, 336, 346-348,
350, 353-354, 356, 358-360, 379
Montagna Ugo, pp.269-270
Montalban Ricardo, p. 241
Montalto professore, p. 131
Montand Yves, p. 357
Montanelli Indro, pp. 98, 169, 260
Montesi Wilma, pp. 269-270
Montessori Maria, p. 126
Montez Lola, pp. 121-122
Montez María, pp. 105, 120-122
Montgomery Bernard Law, p. 49
Moore Owen, pp. 132, 163
Moran Dolores, p. 174
Moran Earl, p. 236
Morandini Morando, pp. 109, 176
Morante Elsa, p. 257
Morath Inge, p. 355
Moravia Alberto, p. 256
Morbelli Enrico, p. 81
Morbelli Riccardo, p. 81
Morelli Rina, p. 41
Moretti Nanni, p. 393
Moretti Willy, p. 281
Mori Claudia, p. 197
Morin Henry, p. 258
Morisot Berthe, p. 262
Moro Aldo, p. 223
Morrione Roberto, p. 399
Motta Aldo, pp. 388-389
Motta famiglia, p. 202
Mozart Wolfgang A., pp. 156, 313
431
Muccino Gabriele, p. 271
Mughini Giampiero, pp. 60, 62, 65-67, 258
Munn Michael, p. 217
Murray Don, p. 356
Muscetta Carlo, pp. 32, 65
Musco Angelo, pp. 18, 72, 391
Musolino Vincenzo, p. 286
Mussino Attilio, p. 263
Mussolini Benito, pp. 18, 30, 32-33, 90, 179-180, 288, 384
Musumeci Mario, p. 317
Musumeci Nello, p. 333
Musumeci Totò, p. 398
Muti Ornella, p. 200
Muti Riccardo, p. 147
Nabokov Vladimir, p. 294
Nada, p. 197
Nagel Conrad, p. 33
Naipaul Vidiahar S., p. 369
Napoli Rosario, p. 79
Nasreen Talisma, p. 105
Natalino fratello, p. 60
Navoux Nicole, p. 68
Nazimova Alla, p. 51
Nazzari Amedeo, pp. 34, 241
Neame Roland, p. 254
Negrini Luciana, p. 313
Negulesco Jean, p. 348
Nerone imperatore, p. 185
Neruda Pablo, p. 220
Neufeld Max, p. 82
Newbury Richard, pp. 46-47
Newman Paul, pp. 140, 234, 239
Ney Richard, p. 226
Nico, p. 196
Nicolosi Giuseppe, p. 382
Nicolosi Miranda, p. 397
Nicolosi Rino, p. 401
Nicolosi Salvatore, pp. 31, 99, 134, 397
Nicolosi Vito Mar, p. 31
Nigro Silvano, p. 65
Niven David, p. 250
Noiret Philippe, p. 378
Nomadi, p. 274
432
Noris Assia, p. 34
Norton Simon, p. 112
Novak Kim, pp. 211, 285
Novarro Ramon, p. 33
Nugent Elliott, p. 119
Nureyev Rudolf, pp. 207-208
O’Brien Margaret, pp. 265, 310
O’Hara Maureen, pp. 235, 243, 246-247
O’Neill Eugene, p. 369
O’Shea Mary C., p. 233
O’Shea Michael, p. 233
O’Sullivan Maureen, p. 248
O’Toole Peter, p. 248
Oates Joyce C., pp. 356, 358
Oberon Merle, pp. 179, 185-187, 344
Obey André, p. 339
Occhini Ilaria, p. 170
Oliver Edna May, p. 135
Olivier Laurence, pp. 82, 111, 172, 185-187, 217, 225, 254
Olivier madame, p. 327
Olivieri Dino, p. 52
Onassis Aristotile, p. 340
Ophüls Max, p. 173
Orsini Umberto, p. 312
Orwell George, p. 231
Ossola Franco, p. 260
Otto Natalino, p. 57
Otto Walter, p. 236
Ouspenskaya Maria, p. 238
Pacini Giovanni, p. 313
Padoa Schioppa Tommaso, p. 220
Page Bettie, p. 367
Page Gale, p. 194
Page Giorgio N., p. 210
Page Letty, p. 314
Pagnani Andreina, p. 41
Pagnano Giuseppe, p. 67
Pallavicini Sandro, p.233
Palmas Giuseppe, p. 270
Palmieri Bruno, p. 393
Pampanini Silvana, p. 272
Pamuk Orhan, p. 227
Pan Hermes, p. 209
433
Panarello Carlo, p. 368
Panaro Alessandra, p. 332
Pani Corrado, p. 274
Pani Massimiliano, p. 274
Paolo VI, pp. 200, 275
Papini Giovanni, pp. 169-170, 260
Pappalardo Franca, p. 134
Paris Barry, p. 41
Parker Dorothy, p. 367
Parker Eleanor, p. 289
Parsons Louella, pp. 239-240
Pascal Blaise, p. 405
Pascal Gisèle, p. 336
Pascoli Giovanni, p. 117
Pasolini Pier P., pp. 220, 222, 257
Pasquarelli Giacomo, p. 21
Pastura Francesco, p. 317
Patanè Giuseppe, p. 31
Paterniti Carlo, p. 141
Paternò Castello Elena, p. 113
Paternò Gigliola, p. 169
Paternò Stefano, p. 399
Patti Ercole, pp. 30-31, 150
Pattini Giano, p. 57
Pavese Cesare, p. 49
Peck Gregory, pp. 130, 140, 234, 237, 241, 282, 343
Pelè, p. 207
Pellegrino Nuccio, p. 333
Peres Shimon, p. 154
Perkins Anthony, pp. 239, 309
Perrault Charles, p. 260
Pessina Aldo F., p. 259
Petacci Claretta, p. 90
Peters Jean, p. 286
Petrina Mario, p. 390
Petringa Santi, p. 70
Pevney Jospeh, p. 370
Philippe Gérard, pp. 52, 68
Piano Renzo, p. 47
Piazza famiglia, p. 202
Picasso Pablo, pp. 284, 347
Piccioni Piero, pp. 269-270
Pickford Mary, pp. 33, 36, 132-133, 163, 194, 361
434
Piccolomini Elisabetta, pp. 312-313
Pidgeon Walter, pp. 90, 225
Pierangeli Anna Maria, p. 163
Pietrangeli Antonio, p. 97
Pilieci Carlo, p. 392
Pinketts Andrea G., p. 220
Pinter Harold, p. 369
Pintus Pietro, p. 338
Pio X, p. 126
Pio XI, p. 160
Piovene Guido, pp. 169, 260
Pirandello Luigi, pp. 33, 213, 248
Pirola Araldo, p. 57
Pisano Gigi, p. 165
Pizzi Nilla, pp. 194-195
Platone, p. 94
Pluchino Emanuele, p. 374
Pogliese Saro, p. 400
Polese Ranieri, p. 368
Pontecorvo Gillo, p. 264
Pontecorvo Marco, p. 264
Popolizio Massimo, p. 312
Porri Maurizio, p. 255
Porter Cole, pp. 164, 202, 208, 306, 371
Porter Darwin, p. 239
Porto Rosario, p. 223
Poterat Louis, p. 53
Potter Henry C., pp. 193, 225
Pound Ezra, p. 30
Powell Dick, pp. 266-267, 287
Powell Dick jr., p. 267
Powell Jane, p. 371
Powell Michael, p. 254
Powell Pamela, p. 267
Powell William, pp. 72, 174, 193
Power Tyrone, pp. 228, 232, 239, 246, 295
Preminger Otto, pp. 237, 315, 353
Presley Elvis, pp. 115, 217
Pressburger Emeric, p. 254
Prestinenza Antonio, pp. 31, 100, 113, 167, 223
Prestinenza Luigi, pp. 99-100, 333
Price Vincent, p. 315
Price Will, p. 246
435
Prisco Michele, p. 93
Proclemer Anna, p. 256
Prodi Romano, pp. 149-151, 220, 280
Profeta Ottavio, p. 31
Proust Marcel, pp. 27, 31, 69, 170, 360
Pucci Cesare, p. 392
Puccini Gianni, pp. 52, 166
Quasimodo Salvatore, p. 32
Quattrini Paola, p. 272
Quoiani Alessandro, p. 57
Rabagliati Alberto, p. 263
Raciti Filippo, pp. 143-145
Raffaello Sanzio, p. 59
Raffin Ferdinand, p. 258
Rainer Luise, p. 224
Rangeri Norma, p. 270
Ranieri III, pp. 154, 336, 347
Ranieri Massimo, p. 273
Rapisardi Mario, pp. 32-33, 293, 388
Rasario Giovanna, p. 169
Rastelli Nino, p. 52
Ratoff Gregory, p. 237
Ravera Lidia, p. 297
Ray Nicholas, pp. 135, 215
Reagan Ronald, p. 154
Recca cavaliere, p. 301
Recupero Antonino, pp. 23, 25, 64-65, 67
Reed Donna, pp. 114, 249
Reiner Rob, p. 87
Reinhardt Max, p. 46
Reitano fratelli, p. 169
Remarque Erich M., p. 52
Rembrandt H. Van Rijn, p. 350
Renfro Marli, p. 308
Renoir Jean, p. 305
Reynolds Debbie, pp. 251, 370
Richard Little, p. 115
Ricciardi Antoniuccio, p. 134
Ricciardi Giuseppe, p. 134
Ricciardi Giovanni, p. 134
Ricciardi Pinuccia, p. 134
Richard Jeff, p. 266
Rigamonti Mario, p. 260
436
Rigotti Francesca, p. 171
Rilke Rainer M., p. 30
Rimini Manoli, p. 401
Rimini Roberto, p. 66, 401
Rizzo professoressa, p. 131
Roberts Allan, p. 161
Robinson Edward G., pp. 212-213
Robson Mark, p. 272
Robson May, p. 77
Rocca Daniela, p. 38
Rogers Ginger, pp. 35, 116, 202, 206-209, 265
Rogers Richard, p. 47
Roman Ruth, p. 332
Romano Ennio, p. 402
Romano Lalla, p. 27
Rommel Erwin, p. 49
Ron, p. 197
Ronchey Alberto, p. 219
Ronconi Luca, p. 312
Ronsisvalle Vanni, p. 257
Rooney Mickey, pp. 275, 364
Roosevelt Franklin D., pp. 127, 174-175, 226, 305, 346
Roselli Jimmy, p. 281
Ross Herbert, p. 131
Ross Nina, p. 226
Rossella Carlo, p. 391
Rossellini Isabella, pp. 100-101
Rossellini Roberto, pp. 102-103, 190
Rossi Tino, p. 53
Rossi Drago Eleonora, pp. 36, 288
Rossini Gioacchino, p. 157
Roth Joseph, pp. 139, 173
Roth Philip, p. 218
Rothschild Olga de, p. 46
Rowland Roy, p. 241
Rubino Antonio, p. 262
Ruggeri Enrico, p. 20
Ruspoli Virginia, p. 379
Russel Gail, p. 128
Russel Jane, pp. 237, 349
Russel Rosalind, p. 71
Russo Gioacchino, p. 35
Russo Giuni, p. 196
437
Ryan Meg, p. 87
Sablon Jean, p. 53
Sada Carlo, p. 14
Saglimbeni Gaetano, pp. 45-46, 52
Saitta Giuseppe, 161
Saitta Nuccio, p. 399
Šalamov Varlam, pp. 142, 403
Salazar António de Oliveira, p. 127
Salerno Enrico Maria, p. 196
Salgari Emilio, pp. 146, 333
Salieri Antonio, p. 313
Salvatori Dario, p. 280
Samojlova Tatjana, p. 39
Sanders George, p. 85
Sandrich Mark, pp. 203, 206, 208, 404
Sanfilippo Domenico, pp. 167, 300
Sanger Margaret, p. 125
Sanguineti Tatti, p. 273
Santamaria Ferruccio, p. 57
Santapaola-Ercolano famiglia, p. 144
Santapaola Nitto, pp. 65, 299, 303
Sapienza Alfio, p. 400
Sapienza Goliarda, pp. 98, 221, 229
Sardo Massimo, p. 333
Sardo Siro, p. 333
Sarris Andrew, p. 326
Sartre Jean Paul, p. 110
Savinio Alberto, pp. 169, 260
Scalfari Eugenio, pp. 149-150
Scalia Salvatore, p. 113
Scalia Turi, pp. 113, 330
Scaramella Mario, p. 58
Scelba Mario, p. 181
Schaffer Peter, p. 313
Schell Maximilian, p. 68
Schinkel Karl F., p. 414
Schneider Romy, p. 87
Schubert Franz, pp. 147-148, 389
Schulberg Budd, p. 367
Schultz Dutch, p. 298
Schumacher Michael, p. 155
Sciacca Sergio, p. 329
Scianò Federico, p. 392
438
Sciascia Leonardo, pp. 248, 292, 323, 405
Scimone Chico, pp. 281-283
Scimone Egisto, p. 282
Scott Fitzgerald Francis, p. 239, 367
Scott Forester Cecil, p. 234
Scott Randolph, p. 247
Secchiaroli Tazio, pp. 270, 272
Selig William, p. 126
Selwyn Alan, pp. 352, 354, 356-359
Selznick Danny, pp. 103
Selznick David O., p. 112
Selznick Mary Jennifer, p. 112
Sennett Mack, p. 398
Sequi Sandro, p. 311
Serpotta Enzo, p. 142
Sestini Massimo, p. 270
Seveso Antonio, p. 57
Sgalambro Mario, p. 31
Sgarallino Cynthia, p. 154
Shakespeare William, p. 254
Shaw Anabel, p. 315
Shaw Artie, pp. 84, 275, 295
Shaw Bernard G., pp. 247, 311
Shearer Norma, p. 33
Sheridan Jim, pp. 304-305
Shirer William, p. 267
Shostakovich Dmitri, p. 87
Sicari Giuseppe, p. 279
Siclari Ciccio, p. 99
Sidney George, pp. 255, 310
Sieber Maria E., p. 60
Sieber Rudolph, p. 50
Siegel Bugsy, p. 298
Siegel Don, p. 71
Signoret Simone, p. 357
Silone Ignazio, p. 76
Silver Charles, p. 247
Simili famiglia, p. 300
Simmons Jean, pp. 254-256, 264
Simoneschi Lidia, p. 41
Simpson Wallis, p. 42
Sinatra Frank, pp. 114, 164, 176, 239, 249-250, 280-281, 295,
314, 359
439
Sinatra Nancy, p. 281
Siracusa Peppino, pp. 17, 374
Sirk Douglas, p. 116
Smith Kate, p. 203
Snelson Alec, p. 226
Sofri Ariano, p. 17
Soldati Mario, p. 49
Solidor Suzy, p. 53
Solinas Donghi Beatrice, p. 259
Solo Bobby, p. 197
Solulié Frédéric, p. 171
Somerset Maugham William, p. 336
Sondergaard Gale, p. 232
Sonnino Sidney, p. 321
Sorbello Nuccio, p. 93
Sordi Alberto, pp. 75, 130, 398
Sorgi Marcello, pp. 20, 154
Sotgiu Giuseppe, p. 270
Sozzi Lionello, p. 405
Spada James, p. 338
Spampinato Saretto, pp. 95, 333
Sparre Ebba, p. 29
Speranza Francesco, p. 200
Speranza Mimmo, p. 201
Spielberg Steven, p. 362
Spinazzola Vittorio, p. 28
Sposini Lamberto, p. 391
Spoto Donald, p. 186
Springsteen Robert, p. 238
Stalin Josip, pp. 182, 243
Stancanelli sindaco, pp. 320, 334
Stanwyck Barbara, pp. 202, 211-215
Stanwyck Jane, p. 211
Statler Brothers, p. 246
Steel Alfred, p. 133
Stefania di Monaco, p. 341
Sterlini Giulio, p. 58
Sterlini famiglia, p. 59
Sterlini signora, p. 202
Sternberg von Josef, pp. 43, 50
Stevens Betty, p. 36
Stevens George, pp. 75, 206, 209, 342, 365
Stevens Harold, p. 36
440
Stevenson Robert L., pp. 110, 146
Stevenson Robert, p. 284
Stewart James, pp. 77, 114, 125, 167, 190
Sthal John M., p. 232
Stiller Mauritz, pp. 35, 46
Stockwell Dean, p. 361
Stompanato Johnny, pp. 296-297
Stowe Harriet Beecher, p. 138
Strano Nino, pp. 149-150
Strauss Johann, p. 87
Stresa Nino, p. 286
Suglia Cinzia, p. 367
Suliotis Elena, p. 377
Sullavan Margareth, p. 167
Summers Dirk W., p. 267
Swanson Gloria, pp. 33, 297
Swift Jonathan, pp. 146, 247
Tajoli Luciano, p. 197
Takita Yojiro, p. 235
Talmadge Norma, pp. 33, 36
Talmadge sorelle, p. 36
Tamiroff Akim, p. 71
Tarascio Enzo, p. 313
Tarrant Percy, p. 135
Taylor Elizabeth, pp. 9, 250-251, 265, 282, 310, 361, 364,
370, 376, 378, 379
Taylor Robert, pp. 87, 90, 211-212, 225, 295
Tempio Domenico, pp. 302, 338
Tempio Domenico poeta, p. 292
Tempio Francesca, p. 338
Temple Shirley, pp. 194, 266, 361
Termini Lina, p. 49
Terry Philip. P. 133
Tertulliano, p. 232
Tessuto Mario, p. 197
Testa Orazio, p. 93
The Platters, p. 115
Thoma Mimi, p. 49
Thompson Jim, p. 71
Tiepolo Giambattista, p. 336
Tierney Gene, pp. 120, 218, 229, 231-232
Timpanaro Melo, p. 373
Tito, p. 154
441
Todd Ann, p. 315
Todd Richard, p. 248
Tofano Sergio, p. 262
Togliani Achille, p. 114
Tognazzi Ugo, p. 398
Toland Gregg, p. 186
Tolstoj Lev N., p. 39
Tomarchio Giovanni, p. 310
Tomasi di Lampedusa Giuseppe, p. 111
Tommaso santo, p. 242
Tondelli Pier V., p. 368
Tone Franchot, p. 133
Tonelli Anna, p. 160
Topping Henry J. jr., p. 295
Tornatore Giuseppe, pp. 247, 378
Torrisi Fiore, pp. 31-32
Torlonia Flaminia, p. 379
Tortora Enzo, p. 196
Totò, pp. 92, 177, 386, 398
Tourneur Jacques, pp. 233, 241
Tracy Spencer, pp. 90, 128-129, 138, 267-268, 361
Trantino Enzo, pp. 139-141, 180, 192
Trevor Claire, p. 254
Trewella Margriet, p. 388
Trewella Robert, p. 388
Trio Lescano, pp. 52, 164, 278
Trivulzio Cristina, p. 313
Truffaut François, pp. 173, 336, 387
Trovato Gerardina, p. 196
Tucholsky Kurt, p. 26
Turnaturi Francesco, p. 196
Turner Lana, pp. 9, 126, 237, 240, 250, 266, 275, 284, 294295, 297, 305
Tutle Frank, p. 190
Twain Jean, p. 402
Twain Mark, pp. 136, 218, 231, 402
Umberto I, p. 291
Umberto II, p. 49
Ungaretti Giuseppe, p. 32
Urzì Nino, p. 64
Ustinov Peter, pp. 185, 282
Valenti Osvaldo, pp. 34, 82
Vallée Rudy, pp. 101, 105
442
Valli Alida, pp. 35, 82, 270
Van Gogh Vincent, p. 350
Van Heemstra baronessa, p. 341
Van Heusen Johnny, p. 314
Vargas Llosa Mario, pp. 405-406
Varvello Marco, p. 392
Velez Lupe, p. 33
Venditti Antonello, p. 181
Ventimiglia Mario, p. 394
Ventimiglia Silvia, p. 394
Verdi Giuseppe, p. 113
Verga Giovanni, pp. 29, 223, 248, 292, 313, 322-324, 368,
388
Vergani Orio, pp. 169, 260, 288, 397
Verne Jules, pp. 146, 183
Vespa Bruno, pp. 21-22, 390-391
Videtti Giuseppe, p. 282
Vidor Charles, pp. 158, 306, 314, 336
Vidor King, pp. 111, 344
Vigneri Giorgio, p. 33
Vigneri Paolo, p. 33
Vigneri Riccardo, p. 33
Villa Claudio, pp. 15, 114, 197, 204, 274
Villaggio Paolo, p. 62
Villani Carmen, 197
Villaroel Giuseppe, p. 31
Vilhjalmsson Thor, p. 323
Viola Franca, p. 200
Visconti Luchino, pp. 237, 324, 368
Vittorini Elio, p. 15
Vittorio Emanuele II, pp. 291, 385
Vittorio Emanuele III, p. 291
Vittorio Tino, pp. 26, 63, 298-299, 301, 375
Volcic Demetrio, pp. 390-391
Volpe Carmelo, pp. 257-258, 389
Von Glöden Wilhelm, p. 311
Von Stroheim Erich, p. 305
Wagner Robert, pp. 116, 239
Waldoff Claire, p. 43
Walken Christopher, p. 116
Walker Robert, p. 112
Wallach Eli, p. 357
Wallis Hal, p. 101
443
Walsh Raoul, pp. 209, 234
Walters Charles, pp. 306, 336
Warner David, p. 136
Waterbury Ruth, p. 161
Wayne John, pp. 66, 162, 216, 243-244, 246-247, 287
Webster Paul Francis, p. 112
Weigel Helen, p. 68
Weissmuller John, p. 248, 295
Welles Orson, pp. 159, 162, 327
Werkel Alfred, p. 315
Whelan Tim, p. 186
White Frances, p. 211
Wicks Ren, p. 234
Widmarck Richard, p. 287
Wilcox Fred, p. 364
Wilde Oscar, pp. 45, 128, 146, 215, 247-248, 311, 382
Wilder Billy, pp. 25, 212, 216, 251, 343-344, 347-348, 357,
404
Williams Ester, pp. 247, 296
Williams Robert, p. 198
Williams Sybil, p. 370
Williams Tennessee, pp. 279, 368
Willis Bruce, p. 108
Wilson Sloan, pp. 9, 24
Winchell Walter, p. 297
Winchester Sarah, p. 247
Winchester William W., p. 247
Winger Debra, p. 374
Wise Robert, pp. 250, 289
Withers Grant, p. 198
Wodehouse Pelham G., p. 209
Wolders Robert, p. 344
Wolfe Donald, p. 358
Wood Natalie, p. 115
Wood Sam, pp. 100, 225, 292
Woodcock Henry J., p. 271
Woodward Joanne, p. 250
Wordsworth William, p. 115
Wright Frank Lloyd, pp. 126, 326
Wyler William, pp. 111, 137, 185-186, 225, 234, 249, 343,
404
Yeats William B., p. 247
Young Loretta, pp. 128, 179, 198-199
444
Young Victor, p. 135
Zafón Ruiz Carlos, p. 79
Zammataro Marcello, pp. 68, 92-93
Zampa Fabrizio, p. 273
Zampa Luigi, p. 273
Zanuck Darryl F., p. 230
Zappi Gregorio, p. 393
Zappoli Lucio, p. 74
Zeffirelli Franco, p. 368
Zermo Carlotta, p. 70
Zermo Tony, pp. 70, 99, 193, 300
Zimacki A.L., p. 203
Zingales Marcello, p. 400
Zinnemann Fred, pp. 249-250
Zuckerman Nathan, p. 62
Zweig Stefan, p. 173
445
INDICE
9 Introduzione
11 Città di visioni e di scena
29 Uno
56 Due
79 Tre
105 Quattro
124 Cinque
158 Sei
179 Sette
202 Otto
218 Nove
235 Dieci
254 Undici
269 Dodici
294 Tredici
308 Quattordici
331 Quindici
346 Sedici
361 Diciassette
380 Finale di partita
407 Indice dei nomi
Pubblicato nel febbraio 2013
da
LibertàEdizioni